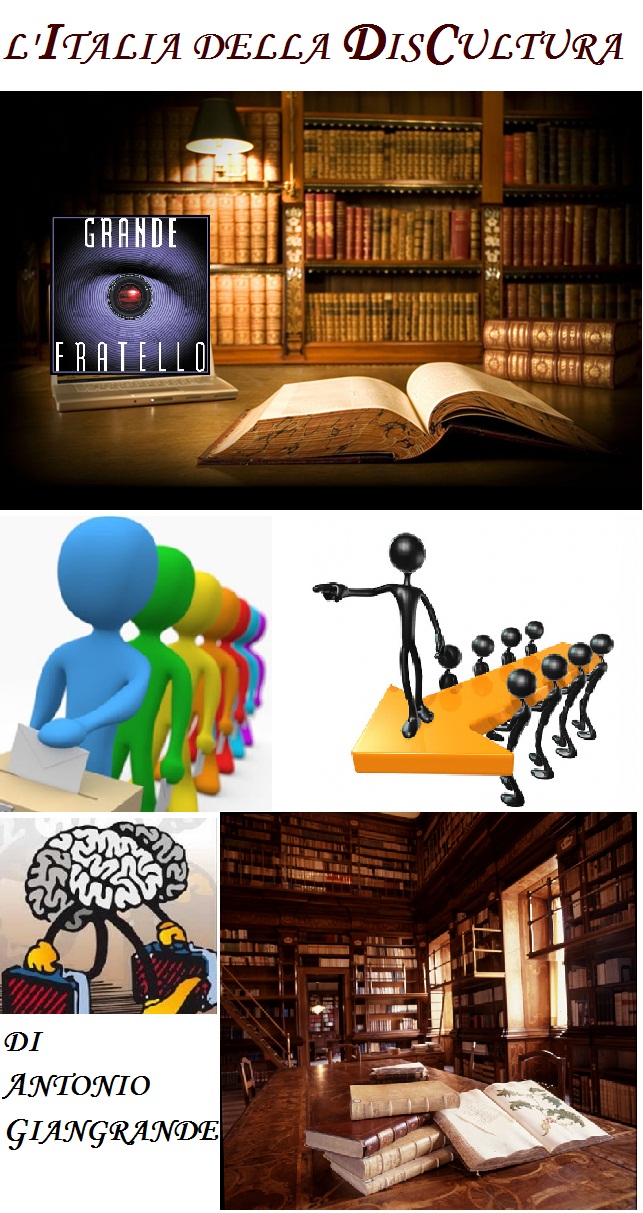Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
CULTUROPOLI
SECONDA PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE
SECONDA
PARTE
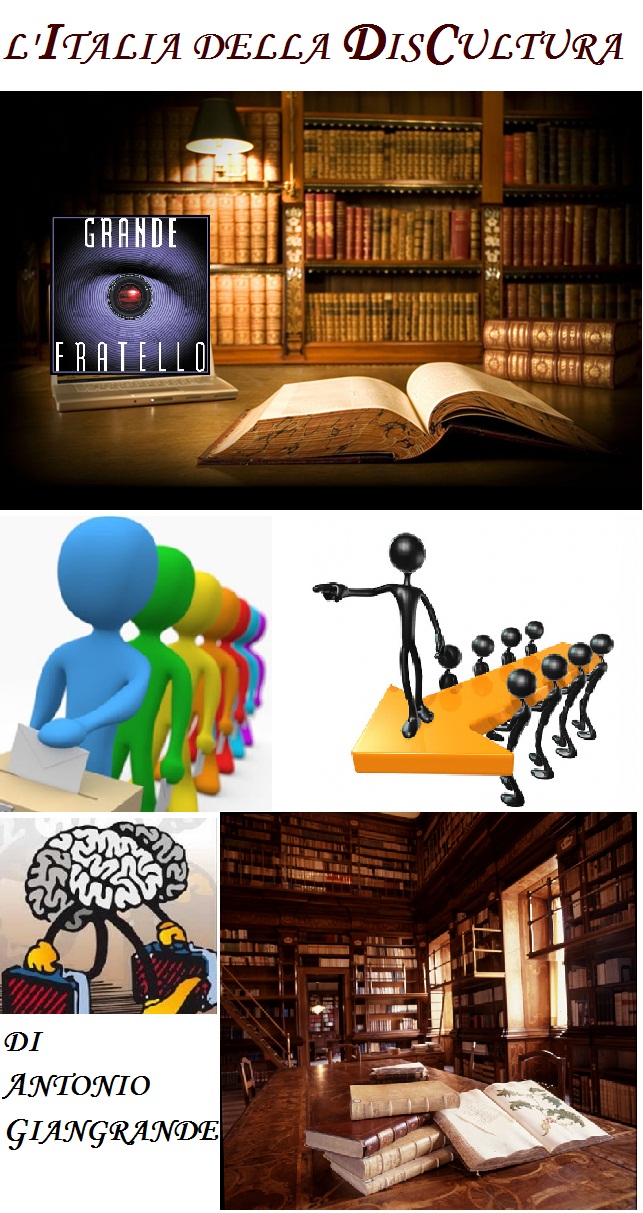
L’ITALIA
DELLA DISCULTURA
"L’Italia
fondata sul lavoro, che non c’è, fatto salvo per i mantenuti e i raccomandati.
L’Italia dove il potere è nelle mani di caste, lobbies, mafie e massonerie. La
raccomandazione nel pubblico impiego è la negazione della meritocrazia e
dell'efficienza, oltre ad essere un reato impunito e sottaciuto, dato che sono
gli stessi raccomandati ad occuparsene. Cultura e scienza in mani improprie.
Le scuole non
mi invitano, in quanto il motto "La mafia siamo noi" non è accettato dai
professori di Diritto, che sono anche, spesso, avvocati e/o giudici di pace e/o
amministratori pubblici, sentendosi così chiamati in causa per corresponsabilità
del dissesto morale e culturale del paese. Ognuno pensa che le disgrazie
colpiscano solo gli altri, senza tener conto che gli altri siamo anche noi. Solo
allora ci accorgiamo quanto il sistema non funzioni. Ma le istituzioni colluse,
i media omertosi e i cittadini codardi fanno sì che nulla cambi".
di Antonio
Giangrande
CULTUROPOLI
L'ITALIA DELLA DISCULTURA
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
«Ecco perchè ci sono tanti
"coglioni" in giro, se poveretti non hanno nulla da imparare!»
Dr Antonio Giangrande
TIRANNIDE
indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto
alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle,
impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E
quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o
legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza
effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è
tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
SOMMARIO PRIMA PARTE
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA NUOVA IDEOLOGIA.
CERVELLI IN FUGA.
ITALIA. PAESE DI SANTI,
NAVIGATORI E...POETI.
ITALIA PAESE DI SCRITTORI
CHE NESSUNO LEGGE.
LA SCUOLA AL FRONTE.
ITALIANI: POPOLO DI
IGNORANTI LAUREATI.
L'ITALIANO: LINGUA MORTA,
ANZI, NO!
ADDIO AL CONGIUNTIVO.
POPULISMO. KITSCH, TRASH E
CATTIVO GUSTO.
I NOBEL D’ITALIA.
PARLIAMO DELL'ITALIA
"MODAIOLA".
FENOMENOLOGIA DEL
TRADIMENTO E DELLA RINNEGAZIONE.
FENOMENOLOGIA RANCOROSA
DELL’INGRATITUDINE.
SANTA INQUISIZIONE: COME LA
RELIGIONE COMUNISTA CAMBIA LA STORIA.
ELOGIO DEL PLAGIO. CHI,
COME, E PERCHÉ IL “COPIA E INCOLLA” È LA BASE – NASCOSTA – DELLA LETTERATURA.
GLI SCRITTORI DEL REALE IN
TRINCEA CONTRO MEDIA ED ISTITUZIONI.
BIBLIOGRAFIA ED OSSESSIONE.
LE ULTIME PAROLE FAMOSE:
GLI ADDII DEL SUICIDIO.
ITALIANI CONFORMISTI:
FASCISTI DENTRO.
GLI ITALIANI: TRA I POPOLI
PIU’ IGNORANTI.
IGNORANTI PIU’ CHE
RAZZISTI.
"PADRI DELLA PATRIA"
VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
L’INTELLIGENZA E’ DI
SINISTRA?
GLI INTOCCABILI E LA
SOCIETA’ DELLE CASTE.
MAFIA: LE
CONTRO VERITA’ CENSURATE.
FALCONE, FALCE E MARTELLO. IL FILO ROSSO SULLA MORTE DI FALCONE E
BORSELLINO E LA NASCITA DEL MONOPOLIO ROSSO DELL’ANTIMAFIA.
IL CORTO CIRCUITO.
L'EREDITA' DI FALCONE: LE SPECULAZIONI DELL'ANTIMAFIA.
L'ANTIPOLITICA E
L'ASTENSIONISMO.
L’ANTIPOLITICA E LE SUE
VITTIME. IL PACIFISMO.
IL PARTITO INVISIBILE.
ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA DEMOCRAZIA
INESISTENTE.
LA LIBERTA'.
LA DEMOCRAZIA E' PASSATA DI
MODA?
CHI TRADI' LE BRIGATE
ROSSE? I ROSSI!
OWENS: ROOSEVELT PIU’ RAZZISTA DI HITLER.
A PROPOSITO DI TIRANNIDE.
COME E QUANDO E' MORTO HITLER?
RISCRIVERE PER DOMINARE. LA
STORIA COME ARMA DEI REGIMI.
BELLA CIAO….UN′ENNESIMO
FALSO STORICO.
FEMMINISMO COME DERIVA
CULTURALE.
PLAGIO E VERITA’. LA
CRONACA PUO’ DIVENTARE STORIA?
LE PALE
EOLICHE. IL PROGRESSO IDEOLOGICO E LA DISTRUZIONE DI UNA CIVILTA’. L’ISIS COME
LA SINISTRA.
E’ STATO LA MAFIA!
LEZIONE DI MAFIA.
GLI ANTIFASCISTI MILITANTI?
SONO FASCISTI.
SVEGLIATI ITALIA E LAVORA
CON IL TURISMO.
IGNORANTI E LAUREATI. COLPA
DELLA SCUOLA? APPELLO DEI GENITORI: NON BOCCIATE I NOSTRI FIGLI.
TITOLATI SI’, TITOLATI NO!
E’ TUTTA QUESTIONE DI
COSCIENZA.
IL MONDO DIVISO TRA COLTI
ED IGNORANTI.
L’IGNORANZA DELLE PERSONE
COLTE.
BENEDETTO SIA ZALONE.
I MEDIA ED I LORO PECCATI:
DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
PER UNA LETTURA UTILE E
CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA, GIUSTIZIA ED
INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE
MANETTE.
TUTTI DENTRO CAZZO!
VADEMECUM DEL CONCORSO
TRUCCATO.
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER
TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’
E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’
IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA.
QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA
MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE
GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’
TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA,
INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE
A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO
CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA
CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE
COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI
TORTURARE ED UCCIDERE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA.
CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
27 NOVEMBRE 2013. LA
DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI
DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI
PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI.
NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE
PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA
MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60
MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI
DI GIUSTIZIA.
LOTTA
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO
STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO.
LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI
STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA
ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA
DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN ITALIA…
DIRITTO E GIUSTIZIA. I
TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI
A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE
UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
IL SUD TARTASSATO.
ITALIANI. LA CASTA DEI
"COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
SOMMARIO SECONDA PARTE
A PROPOSITO DELLE
FIERE-MOSTRE DEL LIBRO E LE BIBLIODIVERSITA’. LA LOBBY ROSSA DELLA CULTURA.
L'AGIT-PROP, OSSIA,
"L'AGITAZIONE E LA PROPAGANDA".
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI
DEI GOVERNI.
GLI INFLUENCER.
GLI INTELLETTUALI ITALIANI.
NON SOLO CULTURAME.
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DA
TENCO A PASOLINI, DA TOTO’ A BONCOMPAGNI.
CLAUDIO BAGLIONI E LE
SOLITE CANZONETTE.
MAI NULLA CAMBIA. 1968:
TRAGICA ILLUSIONE.
1977: LA RIVOLUZIONE
ANTICOMUNISTA.
A COSA SERVONO...
LE FAKE NEWS CHE GIRANO IN
RETE.
L’HA DETTO LA TELEVISIONE!
LE FAKE NEWS DI STATO.
LA VERITA' E' FALSA.
LE FAKE NEWS DEL
CONTRO-REGIME.
LE SOLITE FAKE NEWS DEI
MEDIA DI REGIME.
IL POLITICAMENTE CORRETTO.
LA NUOVA RELIGIONE DELLA SINISTRA.
GLI ESTREMISTI DELLE NOSTRE
VITE.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
ESSERE LIBERALI OD ESSERE
DI SINISTRA?
25 APRILE 2015. 70 ANNI
DALLA LIBERAZIONE. L'ALTRA RESISTENZA CONTRO IL RITO DELL'ANTIFASCISMO UN PO’
FASCISTA.
NON APRITE QUELL’AZIENDA.
PER ESEMPIO UNA CASA EDITRICE. LA BUROCRAZIA VI UCCIDERA’.
VUOI CANTARE? IL CONCORSO
E' TRUCCATO.
POVIA ED I MORALIZZATORI.
EPPURE CHE GUEVARA ERA
CONTRO I GAY.
LA PICCOLA EGUAGLIANZA, IL
POPULISMO E LA CADUTA PARZIALE DEGLI DEI (I MAGISTRATI).
ALTRO CHE RIVOLUZIONE: E'
L'ITALIA DEI FESTIVAL!
LA CONTROSTORIA DELLE CASE
EDITRICI ALTERNATIVE.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI
STAVA PEGGIO.
CONCORSI ED ESAMI. LE
PROVE. TRUCCO CON I TEST; TRUCCO CON GLI ELABORATI.
VA TUTTO BEN MADAMA LA
MARCHESA. INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO E LAVAGGIO DEL CERVELLO.
BELLA CIAO: INNO COMUNISTA
E DI LIBERTA’ DI SINISTRA.
LIBERTA'. TERMINE VACUO.
PATRIA, ORDINE E LEGGE: SLOGAN CHE UNISCE DESTRA E SINISTRA.
OMOFOBIA E CACCIA ALLE
STREGHE. CARLO TAORMINA. QUANDO L’OPINIONE E’ DISCRIMINATA.
LA SCUOLA
DELL'INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO.
L’ISLAM NON SI TOCCA.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO.
E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
INCOSCIENTI DA SALVARE?
COME SI FINANZIA IL TERRORISMO ISLAMICO.
LE CROCIATE: ORGOGLIO
CRISTIANO!
COS'E' IL TERRORISMO?
TERRORISTI E FIANCHEGGIATORI.
L’ISLAM, LA SINISTRA E LA
SOTTOMISSIONE.
IL NATALE COME TRADIZIONE E
CULTURA: GENESI ED EVOLUZIONE.
IL TERRORISMO ISLAMICO CHE
VIENE DA LONTANO. QUANDO NEW YORK E PARIGI ERAVAMO NOI.
LA DIFFERENZA TRA
RELIGIONI.
INTELLETTUALI A SCARTAMENTO
RIDOTTO.
COSA NON VORREMMO PIU'
VEDERE IN TV.
COME TI COSTRUISCO UNA
BUFALA SUL WEB.
FAMILISMO AMORALE. LE
GUERRE PER L'EREDITA' DEGLI ARTISTI.
NEOREALISMO E MODA.
CHE QUALCUNO LA RACCONTI
GIUSTA! LA STORIA NON SIAMO NOI……
L’ITALIA DEGLI IPOCRITI.
GLI INCHINI E LA FEDE CRIMINALE.
PREMIO STREGA ED
AUTOCITAZIONI. LO SCRITTORE NON E’ MAI AUTORE.
ATTORI E REGISTI: UNA CASTA
DI IDIOTI DI SINISTRA RACCOMANDATI.
SI CENSURA, MA NON SI DICE.
BERLINGUERISMO. I MITI
DELLA SINISTRA.
SIAMO TUTTI
PUTTANE.
LA PALUDE DEGLI SCRITTORI.
LE VESTI STRACCIATE E LA LAVATA IN PUBBLICO DEI PANNI SPORCHI DEGLI (A LORO
DIRE) INTELLETTUALI.
EDITORIA E CENSURA. SARAH
SCAZZI ED I CASI DI CRONACA NERA. QUELLO CHE NON SI DEVE DIRE.
LA SOTTOCULTURA IDIOTA
DELL'ANTIFASCISMO MILITANTE. L'OSTRACISMO ARTISTICO A DANNO DEI MUSSOLINI.
SESSO E CIVILTA’. IL COMUNE
SENSO DEL PUDORE: QUANTO E’ COMUNE E QUANTO E’ IMPOSTO?
LE FOIBE E LA CULTURA ROSSO
SANGUE DELLA SINISTRA COMUNISTA.
WIKIPEDIA DEI ROSSI E
L’EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA.
SIAM TUTTI FIGLI DI
FASCISTI. I VOLTAGABBANA E L’INTELLETTUALE COLLETTIVO.
CIAK. SI TRUFFA E SI
FLOPPA. IL CINEMA IN ITALIA.
CULTURA, INFORMAZIONE E
SOCIETA’. A PROPOSITO DI WIKIPEDIA. L’ENCICLOPEDIA CENSORIA.
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED
EDITORI.
PROMOZIONE DELL'ITALIA? NO
GRAZIE!
PARLIAMO DI PRODOTTI
EDITORIALI E LORO DISTRIBUZIONE.
LA CASTA DEGLI EDITORI: LA
CENSURA OCCULTA.
PARLIAMO DI
SCRITTORI E PREMI LETTERARI.
LA TRUFFA DELLE CLASSIFICHE
DEI LIBRI.
UN RISCOSSORE
MUSICALE ALLA PORTA.
SIAE: LA STORIA.
SECONDA
PARTE
A PROPOSITO DELLE
FIERE-MOSTRE DEL LIBRO E LE BIBLIODIVERSITA’. LA LOBBY ROSSA DELLA CULTURA.
Se la lobby rossa della
cultura non rappresenta più nessuno,
scrive Luigi Mascheroni, Venerdì 11/05/2018, su "Il Giornale". L' incipit è
folgorante, con quelle lunghe code ai cancelli, appesantite da controlli
lentissimi. Che sarà un successo - quanti saranno alla fine della settimana:
150mila come l'anno scorso, di più? - si capiva già ieri mattina, primo di
cinque affollatissimi giorni di carta e di kermesse, tutti a respirare l'aria
buona, quella che sa di inchiostro, di cellulosa, di cellulari, tablet, libri,
stand, lectio (magistrale quella di apertura, sull'Europa, di Javier Cercas),
reading e presentazioni. Signori lettori, vi presentiamo: la 31ª edizione del
Salone del libro di Torino, la prima dopo la pace scoppiata fra Lingotto e
grandi editori. Alla fine sono tutti qui: mega-gruppi, piccoli, minuscoli.
Quest'anno hanno aperto un mini-padiglione supplementare, là in fondo, per non
lasciare fuori nessuno. E non mancava nessuno, ieri mattina nella Sala gialla,
cerimonia d'apertura del Salone, sempre così impeccabile, organizzato,
ricchissimo di appuntamenti, sempre così uguale a se stesso mentre tutto fuori
cambia. Dentro, ecco i protagonisti della passerella istituzionale. Inizia
Massimiliano Bray, presidente del Salone, e sembra una beffa che il ministro del
governo più odiato della seconda Repubblica sia il volto della manifestazione
più amata d'Italia. Parla, parla, parla... Nel passaggio più provocatorio evoca
il Salone come una «narrazione inclusiva, non divisiva». Cita la Fiera del libro
di Teheran, appena conclusa, ma tace che là erano esposti persino i libri anti
islam della Fallaci, in nome della non divisione. Qui a Torino, programma alla
mano, non esiste un evento/presentazione/ospite che non ricada sotto la cupola
dell'unica area politica, senza più voti, che continua a governare la cultura.
Leggete (provate, vi prego) i cinque Percorsi giornalieri del Salone. Invitati:
Mario Calabresi, Carlo Petrini, Zagrebelsky, Littizzetto, Concita De Gregorio,
Augias, Floris, Calabresi (ancora), Odifreddi, Vecchioni, Erri De Luca, Andrea
Scanzi (?!), Oscar Farinetti, Ilvo Diamanti, Walter Siti, Gramellini, Calabresi
(ancora), Travaglio, Laura Morante, Volo, Saviano, Serena Dandini, Michela
Murgia, Michele Serra... Qualcosa fra il colophon di Repubblica, i palinsesti di
Raitre e la lista degli ospiti di Otto e mezzo. La linea editoriale del network
unico del pensiero: Repubblica-Espresso-Feltrinelli, La7. Un giorno, tutto
questo farà parlare. Silenzio, parla Roberto Fico, presidente della Camera a 5
Stelle ma senza cravatta, atto di vera cafoneria. E ben ci sta. Ridevamo delle
canottiere di Bossi. La stoffa, sciatta e populista, è la stessa. Viene voglia
di alzarsi. Ma lo ascoltiamo: parla di bibliodiversità. Che sarebbe un valore,
se vi corrispondesse una pluralità di idee. Il Salone è un'orchestra di cento
elementi. Ma suona un'unica nota. Ecco, sul palco, il direttore: Nicola Lagioia,
primus fra dieci amici che formano la squadra dei consulenti. Nomi sinistramente
noti: Parrella, Culicchia, Carmignani, Bajani, Lipperini... Il pluralismo
declinato sull'asse ideologico Fahrenheit-minimum fax- salotti romani-Einaudi
Stile libero. Lagioia riedita in pubblico il discorso pubblicato al mattino in
forma semi-privata sulla Stampa. Si loda, e imbroda un po'. Presenta un'edizione
stellare del Salone, e ha ragione, ma glissa sul fatto che il liquidatore stia
mettendo all'asta il marchio del Salone per provare a ripianare il debito della
Fondazione del libro, che ammonta, al netto delle code di visitatori, a qualche
milione di euro. Dice che l'appuntamento di Torino è il luogo per un
«ragionamento comune» per la cultura italiana, il posto giusto per coloro che
hanno «il coraggio del non conformismo». La realtà è che il Salone, bellissima
fiera, anche del conformismo, va sempre accuratamente a sinistra. Che andrebbe
benissimo, se - come è stato fino alle passate edizioni dei dioscuri
Picchioni-Ferrero - anche il Paese andasse lì. Ma l'Italia, per politica, voti e
costume, va un po' a destra, un po' a Nord, un po' a Sud. Nessuno vede più
Raitre, la Bignardi ha fallito, Einaudi vendicchia, Fazio non fa neppure più
ascolti record, minimum fax è scavalcata da Sur, e quelli che sfogliano Robinson
sono meno dei lettori dei giornali di destra messi insieme. Eppure, il Salone,
la più grande manifestazione culturale del Paese (e pubblica: non come il
festival di Mantova, che coi finanziamenti degli sponsor privati fa quello che
meglio crede) vive in una prorogatio eterna di quel ristretto ceto colto,
espressione residuale delle professoresse con le scarpe basse e gli alti ideali
democratici. Un gruppo di intellettuali, col lapsus di Pasolini, che non
rappresenta più l'Italia, un Paese che è tutto fuorché di sinistra, e che non
rappresenta più neppure la sinistra, mai stata così in crisi d'identità. Ma che
si (autorap)presenta benissimo. Per il resto, buon Salone a tutti (e da domani,
promessa, parliamo solo di libri).
Il libro sul Forteto
escluso dal Salone del libro di Torino.
La casa editrice del libro "Setta di Stato - Il caso Forteto" non ha ricevuto
l'autorizzazione della Regione Toscana a partecipare al Salone del libro di
Torino, scrive Francesco Curridori, Domenica 02/04/2017 su "Il Giornale".
"La Regione Toscana rimedi alla gaffe e ripensi alla decisione di negare
all'editore "AB" la richiesta di portare e presentare al salone del libro di
Torino "Setta di Stato - Il caso Forteto" dei giornalisti Francesco Pini e
Duccio Tronci. Una scelta grave che ci lascia sconcertati: chiediamo spiegazioni
su quale sia il motivo del diniego ricevuto". A chiederlo sono i membri della
Commissione d'inchiesta regionale sul Forteto, i consiglieri toscani: Paolo
Bambagioni del Pd, Giovanni Donzelli di FdI, il pentastellato Andrea Quartini,
il leghista Jacopo Alberti, il forzista Stefano Mugnai e Paolo Sarti di "Sì -
Toscana a Sinistra". "Non potremmo in alcun modo accettare ancora una volta una
censura su una vicenda che ha così pesantemente scosso la nostra regione",
attaccano i consiglieri regionali dopo che la Regione ha negato agli
organizzatori di Toscanalibri, l'associazione che avrà un suo spazio al Salone
del libro di Torino, che il libro sul caso Forteto sia presentato all'importante
manifestazione editoriale. "Dopo la costituzione di parte civile da parte della
Regione Toscana, dopo il prezioso lavoro portato avanti dalle due commissioni
regionali d'inchiesta e dal Consiglio regionale, non può esserci un solo motivo
valido per chiudere le porte ad un libro che aiuta a capire, raccontando fatti e
pubblicando documenti ufficiali, cos'è stato Il Forteto: il compito della
Regione non può che essere quello di far conoscere a tutti cos'è successo in
quella realtà. Non possiamo più accettare alcuna ambiguità - concludono i
consiglieri - metteremo in campo tutte le azioni necessarie alla diffusione
questa terribile vicenda e far proliferare gli anticorpi per scongiurare che
casi del genere possano accadere di nuovo".
L'AGIT-PROP, OSSIA,
"L'AGITAZIONE E LA PROPAGANDA".
Per affermare la propria
opinione, o essere strumento inconsapevole della volontà del leader, si arriva
ad annientare il nemico, nel suo modo di pensare e di essere.
Quanti di noi hanno
assistito agli atteggiamenti di prevaricazione di esagitati guastatori durante
le fasi delle elezioni, sia durante la campagna elettorale Porta a Porta o nei
comizi elettorali dei candidati avversi, sia nei seggi delle votazioni, invasi
da rappresentanti di lista a fare propaganda ed a impedire la convalida delle
schede opposte.
Quanti di noi hanno
assistito alla demonizzazione mediatica degli avversari politici attraverso la
stampa partigiana e quanti di noi hanno subito inconsciamente il lavaggio del
cervello di un pseudo cultura fatta passare per arte nella saggistica, nel
teatro, nel cinema e nei programmi e spettacoli di intrattenimento.
Si può fare giornalismo
sbeffeggiando la verità? Sempre più spesso i giornali offrono ai lettori non
delle notizie, ma dei commenti fondati sul ribaltamento delle notizie,
scrive Piero Sansonetti il 31 Marzo 2018 su "Il Dubbio". È giusto chiedere che
tra il giornalismo e i fatti realmente accaduti ci sia un qualche collegamento?
O è una fisima da vecchi, legata a un’idea novecentesca e sorpassata di
informazione? Ieri ho dato un’occhiata ai giornali – diciamo così – populisti,
quelli più vicini, cioè, alla probabile nuova maggioranza di governo, e ho avuto
l’impressione di una scelta fredda e consapevole: separiamo i fatti dalle
opinioni – come dicevano gli inglesi – ma separiamoli in modo definitivo:
cancellando i fatti, e permettendo alle opinioni di vivere in una propria piena
e assoluta autonomia dalla realtà.
Trascrivo alcuni di questi
titoli, pubblicati in prima pagina a caratteri cubitali.
Libero: «Scoprono solo ora che
siamo pieni di terroristi bastardi». (Sopratitolo, piccolino: “Retata di
musulmani violenti”). La Verità, titolo simile: «Così importiamo terroristi».
Sopratitolo: “Presi i complici di Anis Amri». Fermiamoci un momento qui. Qual è
il fatto al quale ci si riferisce? La cattura, da parte delle autorità italiane,
di una serie di persone di origine nordafricana sospettate di essere legate al
terrorismo. Noi non sappiamo se effettivamente queste persone siano colpevoli.
Ogni tanto – sapete bene vengono arrestati, o inquisiti, anche degli innocenti.
E’ successo appena una settimana fa a un tunisino, che è stato linciato (dai
mass media) lui e la famiglia prima che si scoprisse che non c’entrava niente.
Ma ora non è questo il punto. Proviamo a capire quali sono le cose certe in
questa vicenda. Che i servizi segreti italiani, o la polizia, hanno trovato dei
sospetti terroristi. Che è in corso una operazione volta a sventare attentati.
Che finora l’Italia è l’unico grande paese europeo che non è stato colpito da
attentati. Che l’Italia è l’unico paese che ha catturato diversi sospetti
terroristi. Che, tra l’altro, l’Italia è il paese che ha preso quel famoso Anis
Amri (del quale parla La Verità) e cioè l’uomo accusato di una strage in
Germania. E’ sfuggito alla polizia e agli 007 tedeschi ma non ai nostri. Punto.
Traduzione in lingua
giornalistica dell’arresto di Amri e di alcuni suoi probabili complici?
“Importiamo terroristi”. Voi penserete: li importiamo dal mondo arabo. No, dalla
Germania. In Germania loro sono liberi, qui vengono fermati.
Traduzione Invece dell’azione
del governo, degli 007 e della polizia per fermare il terrorismo arabo (che ci
fa invidiare da tutti gli altri europei): «Scoprono solo ora che siamo pieni di
bastardi islamici». C’è una barzelletta famosa, che qualche anno fa fu
polemicamente raccontata ai giornalisti da Mitterrand, il presidente francese, e
qualche anno dopo da Clinton (cambiando il protagonista). In mare c’è un ragazzo
che sta affogando. Mitterrand lo vede e inizia a camminare sul pelo dell’acqua,
arriva fino a lui ormai allo stremo, con un braccio lo tira su, se lo carica
sulle spalle e lo riporta a riva. Salvandogli la vita. Tutto ciò, come avete
capito, lo fa camminando sull’acqua, e non nuotando. Il giorno dopo i giornali
francesi titolano: «Mitterrand non sa nuotare».
Mi pare che la barzelletta
calzi bene e possa essere riferita ai titoli di Libero e della Verità Il
Fatto invece non si occupa dei terroristi ma del Pd (il grado di ossessione
di Libero e Verità per i terroristi, che, come è noto, negli ultimi vent’anni
hanno messo a ferro e fuoco l’Italia, è simile al grado di ossessione
del Fatto per il Pd). Titola: «Rivolta anti- Renzi: “Basta Aventino vogliamo
giocare”». La parola giocare è usata in senso positivo: partecipare, essere
attivi. La rivolta in corso sarebbe stata avviata da Franceschini e Orlando. In
cosa consisterebbe? Nel chiedere un atteggiamento amichevole del Pd verso i 5
Stelle, in contrasto con Renzi che invece vuole che il Pd resti all’opposizione.
Dopodiché uno legge l’articolo del direttore, cioè di Travaglio, e scopre che
Orlando e Franceschini se ne stanno in realtà zitti zitti e rintanati. E per
questo Travaglio li rimprovera. Cioè li rimprovera proprio per non aver dato il
via ad alcuna rivolta, che invece servirebbe. E servirebbe allo scopo di
bloccare l’Aventino e di spingere il Pd ad una scelta simile a quella dei
socialdemocratici tedeschi, i quali hanno chiamato i loro elettori ad un
referendum interno per avere il permesso di collaborare con la Merkel. Travaglio
dice che il Pd deve fare la stessa cosa. Però ci sono due imprecisioni, nel
ragionamento. La prima è che il Pd non ha scelto l’Aventino, ma l’opposizione.
Sono due cose molto, molto diverse. L’Aventino (cioè il ritiro dei propri
deputati dal Parlamento) fu scelto dai socialisti e dai liberali, dopo
l’assassinio di Matteotti (segretario del Psi). Socialisti e liberali, guidati
da Giovanni Amendola, decisero di disertare il parlamento per delegittimarlo e
dunque delegittimare il fascismo. I comunisti (guidati da Gramsci) fecero una
scelta diversa. Dissero: restiamo dentro a combattere. Cioè rifiutarono
l’Aventino e scelsero l’opposizione. In realtà andò male a tutti e due: il
fascismo non fu delegittimato da Amendola e Turati né fermato da Gramsci, e finì
per fare arrestare sia i socialisti sia i comunisti. Ma che c’entra tutto questo
con l’attuale situazione? Niente. Qualcuno forse pensa – o ha detto che il
Parlamento non è legittimo, e che le elezioni non valgono, e che i vincitori non
sono legittimati a governare? Hanno detto tutti l’esatto contrario.
Quanto all’alleanza tra Merkel
e Spd è una alleanza che è impossibile paragonare a una possibile alleanza tra 5
Stelle e Pd. La Spd ha accettato di sostenere la Merkel esattamente con l’idea
opposta a quella di Travaglio: e cioè per sbarrare la strada ai populisti. La
Merkel e i socialdemocratici hanno già governato insieme e dunque non solo
affatto incompatibili. Ma lasciamo stare la polemica politica, nella quale,
effettivamente, è ovvio che le opinioni prevalgano su tutto. Restiamo nel campo
del giornalismo. La domanda che mi tormenta è sempre la stessa: il giornalismo
moderno ha bisogno dei fatti, delle notizie vere, delle verifiche, della
somiglianza con la realtà, o invece si è trasformato in una specie di nuovo
genere letterario, basato sulla fantasia, e volto esclusivamente a costruire
polemiche politiche o culturali e ad influenzare, indirizzare, spostare
l’opinione pubblica?
Naturalmente nel giornalismo
c’è stata sempre questa componente e questa aspirazione: di influenzare lo
spirito pubblico. In tutte le attività culturali c’è questa aspirazione. Anche
nella pittura, anche nel cinema. Però, fino a qualche anno fa, il giornalismo
aveva – come la fotografia – la caratteristica di essere una attività
intellettuale legata strettamente alla realtà, e il cui grado di autorevolezza
si misurava esclusivamente valutando la sua vicinanza alla verità. Sempre meno è
così. I giornali populisti vengono confezionati con un metodo che si fonda sul
disprezzo per la realtà. La loro forza è direttamente proporzionale alla
lontananza dalla realtà. Gli altri giornali oscillano, tentati dai vecchi valori
e dai vecchi schemi del giornalismo europeo e americano, ma alla fine rassegnati
a inseguire Vittorio Feltri. In dieci anni – cifra approssimativa – il
giornalismo italiano ha completamente cambiato faccia. E le possibilità per i
cittadini di essere informati si è enormemente ridotta. Dobbiamo prenderne atto
e basta? Cioè considerare il divorzio tra giornalismo e verità e la sua
trasformazione in genere letterario fantasioso, come un’inevitabile conseguenza
della modernità? Se è così però bisognerà trovare qualche altro modo per
informare e informarsi. La ricerca di questo nuovo modo dovrebbe essere la
preoccupazione principale dei politici e degli intellettuali. E anche dei
tantissimi giornalisti che sono stati tagliati fuori da questa nuova tendenza.
La preoccupazione principale: perché nessuna democrazia può sopravvivere, senza
una informazione decente.
Le parole degli agit- prop,
scrive Piero Sansonetti il 2 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Molti di voi non
sapranno neanche che vuol dire quella parolina che ho scritto nel titolo:
«agitprop». Era il modo nel quale, nel partito comunista, si chiamavano gli
attivisti che si occupavano delle campagne elettorali e in genere dell’attività
di propaganda del partito. Agit- prop era l’abbreviazione di “agitazione e
propaganda”, e “agitazione e propaganda” era la denominazione di un
dipartimento, molto importante, che aveva una sua struttura nazionale e poi
nelle singole regioni, nei Comuni, e in tutte le sezioni di partito. Il
dirigente che aveva il compito di coordinare questo dipartimento era uno dei
personaggi che più contavano nel partito. I capi nazionali degli agit- prop sono
stati nomi molto famosi nel Pci, a partire da Amendola e Pajetta e in tempi più
recenti il giovanissimo Veltroni. Mi è venuto in mente questo termine perché mi
sembra che torni attuale. Questa campagna elettorale ricorda un po’ le origini,
gli anni 40 e 50. Molta agitazione e molta propaganda. E non nel senso migliore
di questi due termini. Tutta la campagna elettorale si è sviluppata su due
direttrici: la prima è stata quella del fango sugli avversari, azione condotta
con la partecipazione attiva, o addirittura sotto la guida di alcuni giornali.
La seconda, quella della presentazione di programmi, o addirittura di risultati,
del tutto improbabili o forse anche impossibili. Proviamo a dare un’occhiata
alle parole chiave di questa campagna elettorale.
Cinque Stelle. Il partito
nuovo, o se volete il movimento, non ha dato grande importanza al suo programma
elettorale. Che in buona parte, peraltro, ha copiato un po’ dal Pd, un po’ da
Wikipedia, un po’ dai giornali. L’unica proposta comprensibile è stata il
reddito minimo garantito, ma i 5 Stelle non hanno spiegato come renderlo
possibile, anche perché il reddito minimo è immaginabile solo aumentando la
pressione fiscale, e questa è una cosa che – salvo la Bonino – nessuno osa
prospettare. I Cinque Stelle hanno puntato tutto sulla squadra di governo. Che
hanno presentato ieri, cioè quasi alla fine della battaglia, ed è composta
interamente da nomi assolutamente sconosciuti all’elettorato (e non solo) tranne
un nuotatore un po’ più famoso degli altri. Il problema però non è la qualità
della squadra (che nessuno, nemmeno Di Maio, è in grado di valutare) ma la
assoluta certezza che nessuno, o quasi nessuno, di quei nomi farà parte del
futuro governo. Per la semplice ragione che il futuro governo sarà di coalizione
e dunque andrà negoziato da vari partiti e i nomi dei ministri dovranno
rappresentare diversi partiti. Compresi, eventualmente, i 5 Stelle. Diciamo pure
che anche questa trovata della squadra di governo è un po’ una presa in giro. La
squadra di governo la si può presentare in un sistema politico presidenziale,
come quello americano. Non certo in un paese dove Costituzione e legge
elettorale prevedono che sia il Presidente della Repubblica a scegliere il
premier e a concordare con lui una coalizione in grado di sostenerlo.
Inciucio. La seconda grande
bugia. Che accomuna tutti. Tutti dicono: l’inciucio mai. Inciucio – lo abbiamo
scritto qualche settimana fa – è un modo dispregiativo per indicare un’intesa
politica tra forze distinte. Cioè è la base della democrazia parlamentare
italiana. L’inciucio fu inaugurato nel 1943, dopo l’armistizio, da
democristiani, socialisti, comunisti e liberali, e poi è proseguito senza
soluzione di continuità, escluso il breve periodo del bipolarismo, nel quale un
sistema elettorale maggioritario, o a premio di maggioranza, permise il governo
di uno solo dei due schieramenti. La fine del sistema a premio di maggioranza,
la sconfitta di Renzi al referendum, e la nascita del tripolarismo, hanno reso
di nuovo indispensabile una intesa tra forze diverse, cioè l’inciucio. Tutti i
partiti ne sono consapevoli, e tutti fingono di essere fieramente contrari.
Immigrazione. È stato il tema
chiave della battaglia politica. I partiti del fronte populista (in particolare
la Lega e Fdi, un po’ meno i 5Stelle), ne hanno fatto il loro cavallo di
battaglia. Il centrodestra moderato è stato costretto, almeno in parte, a
inseguire o ad adattarsi. Il centrosinistra ha trattato il tema con più
prudenza, ma comunque senza denunciare la falsità del problema. Tanto che, alla
vigilia delle elezioni, si è rifiutato di approvare lo Ius Soli, e ancora in
questi giorni (per le stesse ragioni, e cioè il timore della propaganda
populista) ha rinviato la riforma dell’ordinamento carcerario. Il ritornello dei
populisti è stato: «È in corso un’invasione, la quantità di immigrati sta
aumentando in modo esponenziale, l’immigrazione porta delinquenza e questo è il
motivo dell’aumento continuo della criminalità. Fermiamo l’immigrazione,
cacciamo i clandestini, riprendiamoci l’Italia, impediamo la
“sostituzione etnica”». Non è vero che è in corso un’invasione, visto che gli
immigrati sono ancora largamente al di sotto del 10 per cento della popolazione.
L’immigrazione è in aumento ma è assolutamente sotto controllo. Non è vero che
la delinquenza è in aumento, anzi da quindici anni è in continua e progressiva
diminuzione. Tanto che gli omicidi sono scesi, dalla fine degli anni novanta,
dalla cifra di quasi 2000 a meno di 400 all’anno. E non è vero neanche che
l’aumento dell’immigrazione aumenta la criminalità. I detenuti stranieri nel
2007 erano il 32 per cento della popolazione carceraria. Oggi sono ancora il 32
per cento, sebbene il numero degli immigrati sia quasi raddoppiato. L’uso della
paura dell’immigrato come strumento di campagna elettorale ha prodotto una
gigantesca disinformazione di massa. Giornali e Tv si sono sottomessi. Sarà
difficilissimo correggere questa disinformazione.
Economia. Di economia si è
parlato pochissimo. I partiti di opposizione non ne hanno voluto parlare
soprattutto perché i dati ultimi sono positivi per l’economia italiana. Il
partito di governo ne ha parlato di sfuggita, forse perché non ha molte proposte
concrete per intervenire. Forza Italia è l’unica che si è occupata della
questione, ma con la proposta della Flat Tax e cioè di una soluzione che nessun
grande paese occidentale ha mai adottato, e che anzi, tutti, hanno considerato
irrealizzabile.
La Giustizia. È stata la
grande assente. Nessuno osa parlare di giustizia. Lega e 5Stelle hanno in serbo
un programma di stretta e di riduzione drastica dello Stato di diritto. Non
hanno mai nascosto di considerare lo Stato di diritto un orpello ottocentesco.
Però in campagna elettorale hanno evitato di parlarne troppo. Persino Il
Fatto ha messo la sordina. Forza Italia e Pd, partiti più garantisti, non hanno
trovato il coraggio di porre seriamente la questione sul tappeto, perché temono
di perdere voti. Mi fermo qui. Credo di avere spiegato perché questa campagna
elettorale mi porta al tempo degli agit-prop. Con una differenza: allora i
partiti avevano anche dei programmi politici, ed erano programmi politici
alternativi e chiari. Oggi no.
La faida Renzi-D'Alema è
l'omicidio-suicidio che ha ucciso gli ex Pci.
La sinistra italiana è la più debole d'Europa dopo quella francese: è la
vendetta di Baffino, scrive Roberto Scafuri, Martedì 06/03/2018, su "Il
Giornale". Parlandone da vivi, i due s'assomigliavano come gocce d'acqua.
Correva la primavera 2009 e in un'accaldata sala di militanti il presidente
della Provincia fiorentina, Matteo Renzi, ancora si rivolgeva al «caro Massimo,
punto di riferimento del passato, del presente e del futuro». Il caro Massimo,
lì da presso, mani giunte a mo' di preghiera, era assorto come inseguendo
sfuggenti presagi. Renzi è uno di quei giovani - ebbe a dire benedicendone
l'approdo a Palazzo Vecchio - «dei quali ci si può chiedere solo se batterà il
record della pista oppure no». Sorrisi, applausi. Ma anche cordialità pelosa:
diffidenza a pelle, senza motivo, tra animali che fiutano il pericolo. Il
partito (ancora) c'era, la sinistra italiana non era, come oggi, la seconda più
debole d'Europa dopo quella francese (studio Cise-Luiss). Che cosa inquietava
D'Alema? Gli avevano già parlato di Matteo, il fiorentino. In particolare Lapo
Pistelli, che l'aveva portato a Roma come portaborse nel '99, fatto promuovere
segretario provinciale e, tre anni dopo, accompagnato nella scalata alla
presidenza della Provincia. Qui il capo della segreteria di Matteo sarà Marco
Carrai; i suoi cugini Paolo e Leonardo pezzi grossi della ciellina Compagnia
delle opere. Ce n'è quanto basta e avanza per alimentare la diffidenza di
chiunque, figurarsi D'Alema. Alle primarie per sindaco, nel febbraio '09, il
giovanotto ha surclassato Pistelli (40% contro 26), poi ha infierito con un
foglio di sfottò lasciatogli sulla porta di casa. L'ambizione sbandierata di
Matteo è ciò che stuzzica il vecchio, la mancanza di buon gusto ciò che lo
repelle. L'omicidio perfetto di Renzi giungerà a maturazione qualche anno dopo;
dopo gli anni buoni da sindaco, quando l'ambizione incontrollabile (più sponsor
influenti) suggeriscono che il partito erede della tradizione catto-com può
essere scalato. Occorre un «simbolo», il gesto eclatante e dimostrativo, il
parricidio che renda dirompente il cambio di stagione. È la nascita della
«rottamazione»: D'Alema si vede tirato in ballo a ogni pie' sospinto, sempre più
attonito di fronte a quella rottura imprevista delle vigenti regole di bon ton.
L'attacco alla classe dirigente berlingueriana è scientifico, ma si concentra
molto sul togliattiano D'Alema per salvare il prodiano Veltroni («il più
comunista di tutti noi», ha detto di recente Bettini). D'Alema reagisce come
elefante ferito. Quando Renzi gli farà lo sgarbo definitivo, facendogli credere
prima di poterlo sostenere come commissario alla politica estera Ue per poi
umiliarlo nominando l'inesperta Mogherini, l'ex leader è pugnalato al cuore. La
vendetta è pietanza fredda, però. Di fronte alle pulsioni suicide di Renzi,
plateali durante la roulette russa del referendum, D'Alema torna ad annusare il
buon sapore della vendetta. La minoranza bersaniana, dopo anni di derisioni e
umiliazioni, è ormai cotta a puntino. Gianni Cuperlo, che ben conosce
l'insidiosa persuasività di quel Grillo parlante che li convince uno a uno, non
riesce a trattenere la diga. Ultimo dei sedotti Bersani, per il quale l'uscita
dalla ditta di una vita è un evento tragico. La sgangherata parabola di Mdp e
Leu è sotto i nostri occhi, quella del Pd storia che finalmente s'azzera. Ma
Berlusconi dovrebbe ripartirne i meriti dando a Cesare ciò che è di Cesare. Se
Renzi ha fatto fuori i comunisti, l'ultimo martire dell'orgoglio comunista non
ha esitato a sacrificarsi nel vecchio bunker di Nardò pur di vedere l'usurpatore
schiacciato dal macigno del 18% dei voti. Per poi cadere a sua volta trafitto da
10.552 schede pietose: il 3,9 per cento. Più che una percentuale, un epitaffio.
La sinistra cadavere,
scrive il 5 marzo 2018 Augusto Bassi su "Il Giornale". Seguire la maratona
Elezioni 2018 di Enrico Mentana a volume alzato è stato superfluo. Si sarebbe
rivelato sufficiente osservare i volti del ricco parterre per comprendere con
vividezza l’andamento degli exit poll. Già torvi e un po’ scrofolosi per natura,
si facevano tesi, poi allarmati, quindi sconsolati, infine sepolcrali. Il
pensiero levogiro, antiorario al senno, testimone in diretta della propria
morte. Che macabra pagina di televisione verità! E via via che i dati si
facevano indiscutibili, i malcapitati sono stati chiamati a riconoscerne il
cadavere. Gente che ha sempre capito nulla, per lustri e fino a pochi minuti
prima dei risultati elettorali, come Annunziata, Giannini, Sorgi, Cerasa, in
diretta a commentare il trapasso delle proprie stesse sentenze. Ma se il piglio
di Mentana – in grandissima forma per tutta la nottata, fino a dragare la
venustà della Dragotto con aria da stracciamutande emerito – si è mantenuto
friccicarello malgrado il cordoglio in studio, il volume è servito per
intercettare i flebili aliti dei traumatizzati ospiti. La chiacchiera tremolante
di Giannini, fino a ieri sprezzante verso i populismi, intraprende l’operazione
di riabilitazione dell’insulto, affrancandolo in «popolarismi»; Marco Damilano,
aggrappato a una conversione pro-sistema dei 5Stelle, si dichiara sorpreso
dall’avanzare della Lega nelle periferie metropolitane; Sorgi scompare
inghiottito dal suo tablet, per poi riemergere con il titolo «Vince Di Maio,
Italia ingovernabile». Cazzullo, dall’inflessione sua, ci ricorda dell’esistenza
dei mercati, della grande Europa, mentre gli elettori italiani hanno appena
risposto con meno Europa e un eloquente sticazzi! dei mercati. Per il bene della
stabilità, gli scambisti non vorrebbero si votasse; malauguratamente per loro,
una volta ogni tanto anche da noi si va alle urne… e può succedere che un
pernacchione elettorale li destabilizzi. Irriverente Benedetto Della Vedova,
intervenuto a commentare la sciagura della Bonino, che si vende come coraggioso
ambasciatore anti-mainstream. Irresistibile osservare l’Annunziata che prende
appunti con il lapis sull’agendina di una disfatta scolpita nella pietra con una
verga di boro, e imperterrita commenta con il tono di chi la spiega. Lucia
bacchetta addirittura Marine Le Pen, festante su Twitter per una consultazione
italiana aculeo nel culo flaccido di Bruxelles, suggerendole di star buona
perché trombata a casa propria e aggiungendo: «Ci vorrebbe un po’ di sale in
zucca sulle previsioni e chi le fa». Se l’inclemente conduttrice applicasse a se
stessa i parametri che riserva agli altri, oggi venderebbe carciofi e zucchine a
Osci e Sanniti. Per fortuna arriva Alessandra Sardoni, in diretta dalla sede del
Partito Democratico, che sembra balbettare in un regime di quarantena,
coraggiosa inviata sulla scena di una terrificante pandemia. «Siamo un grande
partito», «A Renzi e alla classe dirigente del PD non c’è alternativa credibile
per gli italiani», erano soliti tuonare da quelle stanze e dalle testate
assoldatine. Mecojoni! Il Bomba, futuro senatore del Senato che voleva abolire,
dopo aver accusato gli avversari di scappare dal confronto, assorbe con il
medesimo ardimento il tracollo, arrivando per commentare a caldo la sconfitta
con la baldanza di un coniglio palomino. L’indispensabile, la necessaria classe
dirigente – dei Gentiloni, dei Minniti, dei Gori, dei Franceschini, dei Rosato,
dei Martina, dei Poletti, delle Fedeli – è stata trattata dai votanti come
pattume pronto per l’inceneritore. L’eredità culturale dell’assemblea
costituente ha uno scatto d’orgoglio solo nel padre nobile del partito,
nell’immarcescibile campione della sinistra di governo, Pier Ferdinando Casini,
che trionfa disdegnoso nella sua Bologna. Nel frattempo, la marea nera che
doveva investire l’Italia, gli inquietanti rigurgiti neofascisti pronti a
deflagrare, i temibilissimi blitz di Forza Nuova e Casa Pound raccontati sulla
stampa dai GEDI, via radio da Vittorio Zucconi e in tv da Corrado Formigli,
stanno sotto l’1%: perché “la realtà è la loro passione”. Di Stefano si vede per
la prima volta in un salotto di Mentana, benché in collegamento, e si lamenta di
essere stato trascurato dai media durante tutta la campagna elettorale. Risposte
piccate in studio, specie da una Lucia molto indispettita. I sobillatori di
mestiere che hanno tirato la volata ai propri campioncini di triciclo fino a un
traguardo di paracarri, oracoleggiano ora sui futuri scenari, sugli equilibri di
domani, sulla temperie a venire, smarcandosi dalla putrefazione con guizzi alla
Margheritoni. E sempre indietro come la coda del maiale. In chiusura, un minuto
di silenzio per Morti e uguali, come anticipato l’11 febbraio in questi
quaderni. Boldrini, Bersani, D’Alema, Grasso… dal regno della pace e della
serenità veglieranno sui propri cari.
D’Alema è la causa della
crisi Pd. Il Dio della politica lo ha punito,
scrive Sergio Carli il 5 marzo 2018 su "Blitz Quotidiano”. D’Alema è la causa
principale della crisi del Pd. Il Dio della Politica, o il Dio che atterra e
suscita di Manzoni, insomma proprio quel Dio là, l’ha severamente e giustamente
punito. La punizione divina si è manifestata con la clamorosa sconfitta nel suo
collegio di casa, in Puglia, dove non ha raccolto nemmeno il 4 per cento dei
voti e è arrivato ultimo in graduatoria. Così cade chi peccò di superbia. E dire
che motivò la sua candidatura come la risposta a un imperativo categorico, una
richiesta che saliva dalla piazza italiana che lo voleva ancora in politica,
impegnato a salvare l’Italia. Quella bella Italia di pseudo sinistra che pensa
ai poveri invece che alla crescita, a ridistribuire quello che non è stato
accumulato, a proteggere i privilegi della casta, di cui lui e i suoi compagni
di partito sono colonna. Come nella Unione Sovietica, che lui frequentò da
ragazzo come pioniere. Giusto che questa sinistra, un po’ salottiera e un po’
saccente, sia finita come è finita, sotto il 4 per cento, altro che il 10. Come
l’Unione Sovietica, appunto. Fu Massimo D’Alema a fermare Matteo Renzi sulla
strada delle riforme. Fu lui il grande vecchio che orchestrò la campana contro
il referendum costituzionale, scatenando i suoi agit prop. È stato lui la mente
della scissione a sinistra del Pd che è finita come è finita ma che, nel
processo, ha trascinato quasi nel baratro il Pd stesso. Il Pd è una forma di
miracolo italiana. L’unico caso al mondo di un partito comunista che, attraverso
successive mutazioni nonché lo sterminio di avversari a catena (Psi, Dc, Forza
Italia e Craxi e Berlusconi), è riuscito a sopravvivere alla caduto del muro di
Berlino e ottenere, quasi 30 anni dopo, un bel quasi 20 per cento dei voti. Ma
quel vizietto tutto comunista che consentì la vittoria di Franco grazie alla
strage operata nella sinistra non comunista, alla fine ha prevalso. Così D’Alema
e il suo gregario Pierluigi Bersani non hanno resistito e hanno portato al
disastro. C’è una forma di perversità crudele nel Destino dell’ex Pci,
manifestazione tangibile della volontà divina. Nella sua prima mutazione, il Pds
guidato prima da Achille Occhetto e poi soprattutto da Massimo D’Alema, guidò la
lotta a Bettino Craxi e al Psi e alla Dc. Il risultato fu che all’Italia fu
riservato il regalo di essere guidata da Silvio Berlusconi. Poi il Pd, nuova
mutazione, guidò la guerra senza quartiere a Berlusconi. Il risultato fu Beppe
Grillo. In questi 20 anni che tanti hanno definito età Berlusconiana, in realtà
l’Italia è diventata sempre più un paese di Socialismo reale. Metà di noi non
pagano tasse, non perché evasori ma perché esonerati dalla legge. La propaganda
pauperistica del Pd, accompagnata dai disastrosi errori di Mario Monti e
l’inefficacia delle sue poche iniziative positive (pensate al ritardo biblico
dei pagamenti della PA) hanno fornito argomenti e brodo di cultura alla protesta
grillina. Se non sarà ripescato per qualche miracolosa procedura. D’Alema
finalmente uscirà di scena. Finalmente, ma forse troppo tardi.
Agit-Prop.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Agitprop è l'acronimo di
отдел агитации и
пропаганды (otdel agitatsii i propagandy), ossia Dipartimento per l'agitazione e
la propaganda, organo del comitato centrale e regionale del Partito comunista
dell'Unione sovietica il quale fu in seguito rinominato
«Dipartimento ideologico».
Nella lingua russa il termine «propaganda» non presentava nessuna connotazione
negativa, come in francese o inglese, significava «diffusione, disseminazione,
d'idee ». Attività e obbiettivi dell'Agitprop erano diffondere idee del
marxismo-leninismo, e spiegazioni della politica attuata dal partito unico,
oltre che in differenti contesti diffondere tutti i tipi di saperi utili, come
per esempio le metodologie agronome. L'«agitazione» consisteva invece nello
spingere le persone ad agire conformemente alle progettualità d'azione dei
dirigenti sovietici.
Forme. Durante la Guerra
civile russa l'Agitprop ha assunto diverse forme:
La censura della stampa: la
strategia bolscevica fin dall'inizio è stata quella di introdurre la censura nel
primo mezzo di comunicazione per importanza, ovvero il giornale. Il governo
provvisorio, nato dalla rivoluzione di marzo contro il regime zarista, abolì la
pratica secolare della censura della stampa. Questo creò dei giornali gratuiti,
che sono sopravvissuti con il loro proprio reddito.
La rete di agitazione orale:
la leadership bolscevica capì che per costruire un regime che sarebbe durato,
avrebbero avuto bisogno di ottenere il sostegno della popolazione russa
contadina. Per farlo, Lenin organizzò una festa comunista che attirò i soldati
smobilitati (tra gli altri) ad assumere un'ideologia e un comportamento
bolscevico. Questa forma si sviluppò soprattutto nelle zone rurali e isolate
della Russia.
L'agitazione di treni e navi:
per espandere la portata della rete di agitazione orale, i bolscevichi usarono i
mezzi moderni per raggiungere più in profondità la Russia. I treni e le navi
effettuarono agitazioni armate di volantini, manifesti e altre varie forme di
agitprop. I treni ampliarono la portata di agitazione in Europa orientale, e
permisero la creazione di stazioni di agitprop, composte da librerie di
materiale di propaganda. I treni furono inoltre dotati di radio e di una propria
macchina da stampa, in modo da poter riferire a Mosca il clima politico di una
determinata regione, e di ricevere istruzioni su come sfruttare al meglio ogni
giorno la propaganda.
Campagna di alfabetizzazione:
Lenin capì che, al fine di aumentare l'efficacia della sua propaganda, avrebbe
dovuto aumentare il livello culturale del popolo russo, facendo scendere il
tasso di analfabetismo.
L'AGIT-PROP. Questa pagina è
tratta da: La Turbopolitica, sessant'anni di comunicazione politica e di scena
pubblica in Italia: 1945/2005 (riassunto) di Anna Carla Russo. L’agit-prop
(Agitazione e Propaganda). I militanti costituiscono l’esercito dei partiti di
massa e le caratteristiche del militante sono la spinta ideologica, dedizione
alla causa, rispetto della disciplina interna, ampia disponibilità e proprio su
questo si fonda l’organizzazione e la sua presenza sul territorio, vivacità e
visibilità. L’attività del militante è molto preziosa, ma non ha un prezzo il
militante infatti dedica la sua esistenza alla causa politica ed è sempre attivo
in qualsiasi luogo, è l’anima dell’organizzazione e delle associazioni, circoli,
polisportive, dopolavori, insomma tutto ciò che coinvolge la vita dell’iscritto.
La campagna elettorale per le elezioni del 1948 trasforma i partiti in giganti
macchine propagandistiche che coinvolgono migliaia di militanti; la Dc mobilita
tutte le province giungendo a 90. Attivisti; più estesa è la macchina
propagandista dei Comitati civici che coinvolgono anche i fedeli arrivando a
300.000 volontari, anche Pci e Psi uniti nel Fronte democratico popolare nel
1948 hanno oltre due milioni di iscritti al partito di Togliatti organizzati in
10.000 sezioni che sovrintendono oltre 52.000 cellule; anche i numeri del Psi
sono notevoli, il partito infatti si afferma nel 1946 con oltre quattro milioni
e mezzo di voti come secondo partito italiano e primo nel Nord-Italia. Secondo
il Pci la crescita politica deve procedere di pari passo con la crescita
dell’individuo e con il raggiungimento di un suo maggior livello di istruzione e
quindi lo sforzo educativo- organizzativo del partito richiede modalità diverse,
tra il 1945 e il 1950 coinvolgono 52.713 partecipanti. Anche per i socialisti
e le organizzazioni cattoliche i militanti devono crescere sia nel numero che
nella preparazione; nel 1948 i Comitati civici improvvisano un corso per
migliaia di volontari e dieci anni dopo nasce l’Unione Nazionale degli Attivisti
Civici ossia una rete ben organizzata che nel 1958 raduna a Roma 1500
responsabili di una capillare attività di formazione svolta mediante corsi
zonali e rurali. I corsi sono tenuti da Dirigenti della URA Campania che
sviluppano argomenti quali: l’antimarxismo; al dottrina sociale della Chiesa:
gli enti di Previdenza e Assistenza in Italia e la struttura e l’inserimento
nella vita italiana del Comitato Civico. La stessa Azione cattolica intensifica
l’opera di apostolato e formazione dando vita in tutta Italia a missioni
religioso-sociali i cui responsabili vengono preparati in tre corsi nazionale di
aggiornamento. Anche la Dc si occupa di formare i militanti organizzando 31
corsi provinciali; secondo Fanfani i contatti instaurati tramite le sezioni non
erano efficaci quanto il colloquio personale, la riunione familiare o il
dibattito amichevole al circolo e quindi il contatto personale e l’azione
assidua dei militanti ricopriva un ruolo centrale. Alla metà degli anni ’60 i
militanti dei due fronti sono coloro che dedicano tempo ed energie
all’animazione del partito e aderiscono a un ideale politico applicandosi per la
sua realizzazione. Le basi militanti cattolica e comunista differiscono per il
significato che attribuiscono alla militanza e nel loro gradi di
politicizzazione. Per gli attivisti del Pci la partecipazione militante
coinvolge l’intera sfera degli interessi e delle attività individuali; per gli
attivisti democristiani l’integrazione con il partito coinvolge solo in parte la
vita privata del singolo; il militante comunista basa la sua azione sulla
fedeltà al partito e non esistono al di fuori del partito altre autorità se non
sovranazionali, mentre l’azione del militante democristiano è sostenuta dalla
convinzione di essere l’unico depositario di una verità a cui gli altri si
devono convertire e oltre al partito esistono altre sorgenti autoritarie a cui
fare riferimento. Ci sono differenze profonde che vedono un Pci più attivo. Anna
Carla Russo
Agit-Prop.
Scrive Massimo Lizzi il 24 ottobre 2015. Agit-prop: Dipartimento per
l’agitazione e la propaganda, organo del comitato centrale del partito comunista
dell’Urss. In russo, dice Wikipedia, propaganda, significa diffusione di idee e
di saperi utili, senza la connotazione negativa che ha in francese, inglese e in
italiano; una connotazione che credo influenzi molto la percezione di sé dei
nostri propagandisti. Agit-prop definisce bene un certo modo di fare opinione e
informazione al servizio di un leader, un partito, uno stato, una chiesa, una
causa. Fabrizio Rondolino, nel confronto con Marco Travaglio, da Lilli Gruber,
ha definito agit-prop il Fatto Quotidiano, giornale allarmista per una
democrazia sempre messa in pericolo e per una politica sempre corrotta e
impunita. Ha ragione. I toni del Fatto erano, secondo me, adeguati contro Silvio
Berlusconi, non solo capo, ma padrone del centrodestra, non solo leader e
premier, ma padrone della TV commerciale, disposto a commettere reati, ad usare
la politica per tutelarsi da inchieste e processi, a delegittimare la
magistratura e la stampa. Oltre e dopo Berlusconi, il Fatto si è
rivelato monocorde. Stessi toni nei confronti dei leader del centrosinistra e
dei successori al governo del cavaliere. Toni che consistono nel rappresentare i
politici avversari come dei disonesti o degli imbecilli, o entrambi. Più la
simpatia per Beppe Grillo. Agit-prop definisce bene anche il giornalismo
di Fabrizio Rondolino. Poco importa che abbia cambiato riferimenti nel corso
della sua carriera professionale, da D’Alema, a Mediaset, al Giornale, ad Europa
e ora all’Unità a sostegno di Renzi, perché si può cambiare idea o mantenere la
stessa idea e vederla di volta in volta incarnata in soggetti diversi. Conta
lo stile che si mantiene uguale: l’enfasi con cui sostiene il suo leader, la
violenza con cui contrasta gli avversari del suo leader. Tweet oltre il limite
della provocazione contro i meridionali, perché il rapporto Svimez mette in
difficoltà il governo, o contro le insegnanti, per le proteste contro la riforma
della scuola; un blogper bastonare la minoranza PD; una rubrica sull’Unità per
dileggiare il Fatto tutti i giorni. Anche Rondolino in fondo dice dei suoi
avversari che sono dei disonesti o degli imbecilli. A me piace il conflitto, lo
scontro, la polemica, però resto perplesso di fronte ad un modo di
confliggere che nega alla controparte rispetto, autorevolezza, valore, e conduce
una dissacrazione totale e permanente nei confronti di chiunque sia fuori linea:
politici, giornalisti, magistrati, costituzionalisti, intellettuali. Lilli
Gruber ha chiesto conto a Marco Travaglio di una didascalia molto evidente a
lato di una foto di Maria Elena Boschi, pubblicata sul Fatto. “La scollatura di
Maria Elena Boschi è sempre tollerata. Magari non il giorno della legge che
porta il suo nome e stravolge la Costituzione”. Travaglio non ha saputo darne
una giustificazione sensata e ha riproposto il solito ritornello, per cui non si
può criticare una donna senza essere accusati di misoginia, per poi aggiungere
che se una donna si veste in un certo modo, non deve lamentarsi dei commenti che
riceve. Come se la critica ad una scollatura sia pertinente con la critica
all’attività di una donna in politica e come se l’abbigliamento di una donna sia
di certo concepito per compiacere lo sguardo maschile, sempre autorizzato a
commentare, anche a sproposito. Rondolino ha paragonato Travaglio ai personaggi
di Lino Banfi, che guardano nelle scollature, come a dargli dello sfigato, ma
quella didascalia per la quale Lillì Gruber ha manifestato il suo fastidio, non
è solo sfigata, è anche molesta e viene pubblicata su un giornale che ha nel
sessismo il suo più importante punto debole.
ItaliaOggi. Numero
231 pag. 6 del 29/09/2009. Diego Gabutti: Non è il pluralismo che riesce a
garantire l'obiettività. L'opinione pubblica, cara a tutti, è stata
liquidata col colpo alla nuca della propaganda. Non è libertà di stampa e
d'opinione, e non è neppure disinformazione (ci mancherebbe) ma pura e semplice
indifferenza per la realtà, quella che ha corso da noi, nell'Italia delle risse
da pollaio tra direttori di giornale, del conflitto d'interesse e di Michele
Santoro che, credendosi un santo, si porta in processione da solo (i ceri li
paga Pantalone). È una libertà di stampa in stile agit-prop: votata, in via
esclusiva, all'agitazione e alla propaganda. Apposta è stata coniata
l'espressione «pluralismo»: voce da dizionario neolinguistico se ce n'è mai
stata una. Con «pluralismo», parola rotonda, non s'intende l'obiettività famosa
(sempre che esista e c'è da dubitarne). Il «pluralismo dell'informazione» non
garantisce l'informazione ma soltanto il «pluralismo». Vale a dire unicamente il
diritto, assicurato a tutte le parti politiche, d'esprimersi liberamente e senza
rete attraverso stampa e tivù. Non è in questione, col «pluralismo», la qualità
dell'informazione, se cioè l'informazione sia attendibile e non manipolata,
ovvero falsa o vera, ma soltanto la sua spartizione, affinché a tutte i racket
politici sia riconosciuto il privilegio di lanciare messaggi a proprio
vantaggio. Come in una satira illuminista, la libertà di stampa s'identifica con
la libertà di dedicarsi anima e corpo alla propaganda: una specie d'otto per
mille da pagare a tutte le chiese, sia a Bruno Vespa che a Marco Travaglio. È un
concetto stravagante, ma più ancora grottesco e deforme: il «pluralismo»
complicato e trapezistico sta alla libertà di stampa propriamente detta come la
donna barbuta e l'uomo con due teste del luna park stanno a Naomi Campbell e a
Brad Pitt. Non allarga il raggio delle opinioni ma è un guinzaglio corto che
lascia campo libero soltanto alle idee fisse. Attraverso il «pluralismo» si
stabilisce inoltre il principio dadaista che la sola informazione che conta è
quella politica. Tutto il resto è pattume e tempo sprecato: l'occhio del
giornalista, sempre più addomesticato e deferente, s'illumina soltanto quando il
discorso finalmente cade sulle dichiarazioni del capopartito o sulle paturnie
dell'opinion maker, cioè sul niente. È in onore del niente che da noi si
esaltano le virtù del «pluralismo». Se ne vantano i meriti, lo si loda, e presto
forse lo si canterà negli stadi sulle note dell'Inno di Mameli, o di Va'
pensiero, come se davvero l'opinione pubblica fosse la somma di due o più
opinioni private, utili a questo o quel potentato economico, a questa o quella
segreteria di partito. Ascoltate con pazienza tutte le campane, ci dicono i
maestri di «pluralismo», quindi fatevi un'opinione vostra, scegliendo l'una o
l'altra tra quelle che vi abbiamo suonato tra capo e collo, nella presunzione
che non ci sia altra opinione oltre a quelle scampanate per lungo e per largo
dai signori della politica e dell'economia. Suprema virtù dell'informazione è
diventata così l'equidistanza: l'idea, cioè, che il buon giornalismo illustri
senza prendere partito tutte le opinioni lecite, e che non ne abbia mai una
propria, diversa da quelle angelicate. In ciò consisterebbe, secondo chi se ne
vanta interprete e campione, l'opinione pubblica famosa, il cui fantasma viene
evocato ogni giorno (esclusivamente per amore della frase a effetto) proprio da
chi l'ha liquidata col colpo alla nuca della propaganda e dell'agitazione di
parte e di partito: gl'intellettuali snob che celebrano messa nelle diverse
parrocchie ideologiche, le star miliardarie dei talk show, i fogli di destra e
di sinistra che hanno preso a modello la «Pravda» (e, per non farsi mancare
niente, anche la stampa scandalistica inglese).
Il falso allarme
antifascismo: l'onda nera è una pozzanghera,
scrive Francesco Maria Del Vigo, Martedì 06/03/2018, su "Il Giornale". Più che
un'onda alla fine si è capito che era una pozzanghera. Quella nera. Vi ricordate
la campagna ossessiva che per quasi un anno ci ha tambureggiato nelle orecchie?
«All'armi tornano i fascisti!». Giornali e media di sinistra avevano scoperto un
filone sempreverde, garanzia di perenne polemica: cioè terrorizzare l'opinione
pubblica convincendola del ritorno delle squadracce di Benito Mussolini. Ora,
per smontare questa fake news, sarebbe bastato un po' di buon senso. Non sembra
che negli ultimi anni si siano impennate le vendite di orbace, fez, manganelli e
olio di ricino. Certo, come coraggiosamente svelato da Repubblica, in Veneto
c'era un bagnino che aveva tappezzato il suo stabilimento di cimeli (di pessimo
gusto) del Ventennio. Ma anche in questo caso il buonsenso non è stato reperito.
Fino a quando un giudice ha derubricato l'episodio all'innocua categoria del
folclore. E poi, decine e decine di accorati articoli sull'irresistibile ascesa
delle tartarughe di Casapound e sui camerati di Forza Nuova. Sociologi e
psicologi in campo per spiegare questo ritorno al passato: disagio sociale,
periferie, mancata scolarizzazione, emarginazione. Persino la stampa estera -
abbindolata da quella nostrana - si era interessata allo strano morbo passatista
che sembrava aver infettato lo Stivale, nella memoria del celeberrimo portatore
di stivali rigorosamente neri. Ecco, ora possiamo dire che dove non è arrivato
il buonsenso sono arrivate le urne. Perché se ci fosse stata una proporzione tra
lo spazio mediatico concesso al «pericolo fascista» e il successo elettorale
dello stesso, Casapound sarebbe dovuta essere almeno il terzo partito in
Parlamento e Simone Di Stefano avrebbe dovuto stappare bottiglie di autarchico
prosecco. E invece, la maiuscola deriva mussoliniana si è scoperta soffrire di
nanismo. Con il suo 0,9 per cento di preferenze raccolte, Casa Pound smonta la
più grande balla della campagna elettorale. Una manciata di mani tese si sono
abbassate per infilare la loro scheda nell'urna. Si sgonfia e precipita
l'aerostato, pompato ad arte, della marea nera. Il ritorno del fascismo era solo
un maldestro tentativo di tenere insieme una sinistra fratturata e scomposta. Il
babau non esiste. O, quanto meno, esiste ma non è certo una marea. Si è trattato
solo di un procurato allarme. Il paradosso è che a questo giro non solo non sono
entrati in Parlamento i nipotini del Duce, ma non è entrato nemmeno un partito
che porti la parola sinistra nel nome e nella ragione sociale. Uno scherzo della
storia. Un bello scherzo.
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI
DEI GOVERNI.
Dr. Facebook e Mr. Hide,
scrive il 24 marzo 2018 Roberto Sommella (Direttore Relazioni Esterne Autorità
Antitrust, fondatore de La Nuova Europa) su "Il Corriere del Giorno". Le
relazioni digitali sarebbero quindi “legate a una minore depressione, a una
ridotta ansia e a un maggior grado di soddisfazione alla propria vita”. Quando
su Facebook si ricordano i 50 milioni di morti della seconda guerra mondiale e
qualcuno grida alla propaganda invece di ripassare la storia, emerge con
nettezza qual è il vero problema dell’abuso dei social network: la perdita della
memoria collettiva e l’avvento di un nuovo senso delle cose. C’entra poco per
chi si vota e come si può essere influenzati dall’uso distorto dei dati
personali che si regalano ogni secondo alla rete. È stato ormai dimostrato come
il web amplifichi i propri pregiudizi, piuttosto che sfatarli. Se uno
nasce trumpiano difficilmente diventa democratico a colpi di “like”. Forse va
più volentieri alle urne, ma non cambia idea. Piuttosto le ultimissime ricerche
in questo campo del mondo di mezzo, tra il reale e il virtuale, si sono
concentrate sulla modifica della percezione di se stessi, un aspetto molto più
importante perché costituisce la base della società in tutte le manifestazioni
della vita quotidiana. Per questo, fatte le dovute verifiche sul reale
utilizzo dei 50 milioni di profili effettuato dalla Cambridge Analytica, che
avrebbe influenzato le elezioni americane, la Brexit, forse anche le
consultazioni italiane, e incassate le previste scuse del patron del gigante
blu, Mark Zuckerberg, terrorizzato di veder sgonfiare il suo mondo dorato a
colpi di ”delete”, occorre spostare il tema su almeno tre piani, relativi alla
riservatezza dei propri profili, agli aspetti psicanalitici e a quelli
economici.
Dal punto di vista della
privacy, come ha sottolineato un esperto del settore quale Claudio Giua, per
quanto riguarda l’Italia e l’Europa, il nodo da affrontare e sciogliere è la
mancata applicazione da parte di Facebook di adeguate misure di sicurezza emersa
dalla vicenda, “che nulla ha a che fare con la completezza finanche eccessiva
dei dati personali raccolti”. C’è da chiedersi se a ribaltare la situazione
basterà l’applicazione, prevista per il 25 maggio, della GDPR, la General Data
Protection Regulation, il complesso di norme messe a punto dall’Unione
Europea al fine di garantire un quadro entro il quale i dati degli utenti siano
immagazzinati in modalità corrette e trattati nel rispetto della volontà delle
parti coinvolte. Il regolamento comunitario rafforza le informative per la
raccolta dei consensi, limita il trattamento automatizzato dei dati personali,
stabilisce nuovi criteri sul loro trasferimento fuori dell’Unione e,
soprattutto, colpisce le violazioni. In sostanza pone le basi per il
riconoscimento di una sorta di diritto d’autore sui Big Data. Sarebbe un passo
decisivo, perché risulta difficile accusare qualcuno di aver utilizzato la
propria auto come un taxi, intascando i profitti, senza poter dimostrare la
proprietà del mezzo. È proprio quello che sta accadendo con il “caso Datagate”,
che potrebbe risolversi in un nulla di fatto e solo qualche scossone in borsa.
Se davvero passerà una simile interpretazione, per la prima volta, queste norme
sulla tutela dei dati personali nell’Unione Europea, che ha progettato anche una
web tax sul fatturato, saranno pienamente valide anche per chi ha sede
extracomunitaria, come Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple, cui risulterà
più difficile eludere le responsabilità finora solo formalmente assunte nei
confronti degli utenti.
Per quanto riguarda il secondo
punto di vista che si deve affrontare, viene in aiuto una recentissima
pubblicazione di una neuro scienziata, ricercatrice al Lincoln College
dell’Università di Oxford, Susan Grenfield. In “Cambiamento mentale” appena
tradotto in italiano, questa baronessa premiata con la bellezza di 31 lauree
honoris causa in mezzo mondo, esamina come le tecnologie digitali stiano
modificando il cervello. E a proposito dei social network, Grenfield scrive:
‘‘gli utilizzatori di Facebook sono più soddisfatti delle proprie vite quando
pensano che i propri amici di Facebook siano un pubblico personale a cui
trasmettere unilateralmente informazioni, rispetto a quando hanno scambi
reciproci o più relazioni offline con contatti ottenuti online”.
Le relazioni digitali
sarebbero quindi “legate a una minore depressione, a una ridotta ansia e a un
maggior grado di soddisfazione alla propria vita”. Esattamente quello che
intendeva Zuckerberg quando stilò il suo Manifesto, dove parlava della
possibilità di governare gli effetti nefasti della globalizzazione attraverso la
rete, esaltando le relazioni personalivirtuali: “Tutte le soluzioni non
arriveranno solo da Facebook ma noi credo che potremo giocare un ruolo”. Un po’
quello che temeva George Orwell in 1984. Il problema è capire che ruolo ha la
rete nei disturbi della personalità.
Nel campo della salute
mentale, secondo lo psichiatra Massimo Ammaniti, si tende a valorizzare l’uso
dei Big Data in quanto offrono nuove opportunità per la ricerca data, l’ampiezza
sconfinata dei campioni, ma allo stesso tempo vengono sollevate perplessità
sulla “veracity” e sulla “unreliability” delle informazioni provenienti da varie
fonti. Riguardo alla “veracity”, la “veridicità”, ci si chiede se i dati
raccolti senza una prospettiva di ricerca possano essere utilizzabili. Avere un
valore in quanto fonte di informazioni rilevanti come pesa sull’immagine di sé e
sulla propria autostima?
Non ci si valuta come persona,
ma come “informant” che serve al mercato, non ci si valuta per quello che si è
ma per quello che ognuno vale. Quando si entra in un data base fornendo le
proprie informazioni personali – per esempio come quello di Cambridge Analytica
– si accede a un universo di categorie che verranno definite. Forse ci si potrà
chiedere che uso verrà fatto delle informazioni che ci riguardano e chi saranno
coloro che utilizzeranno questi dati per pianificare le nostre vite. Può
prendere corpo uno scenario appunto orwelliano, un mondo distopico, in cui si è
costretti a vivere dove viene meno il senso agente di sé perché qualcun altro
decide del nostro futuro senza che ne abbiamo consapevolezza. In campo
psichiatrico per descrivere l’esperienza di spersonalizzazione vissuta dai
malati mentali si è fatto riferimento al concetto di “pseudo comunità
paranoide”, nella quale ci si sente preda di cospirazioni e raggiri senza sapere
chi siano gli attori e i protagonisti, per cui è impossibile riuscire ad
orientarsi e difendersi. Un articolo dell’American Journal of Epidemiology,
citato in un’inchiesta della London Review of Books, ha sostenuto che a un
aumento dell’1% dei like su Facebook, dei click e degli
aggiornamenti corrisponde un peggioramento dal 5 all’8% della salute mentale.
Difficile pensare che tutte queste informazioni possano servire a sovvertire i
regimi democratici, magari si vende più pubblicità.
La domanda più pragmatica da
porsi è perciò un’altra. Se cambia la personalità usando internet, cambiano
anche le scelte commerciali?
Questa è la terza frontiera
che si deve analizzare. Oggi si conosce cosa accade in sessanta secondi sul web.
In un giro di lancette, si effettuano 900.000 login su Facebook, si
inviano 452.000 “cinguettii” su Twitter, si vedono 4,1 milioni di video
su YouTube, si effettuano 3,5 milioni di ricerche su Google, si postano 1,8
milioni di foto su Snapchat, si inviano 16 milioni di messaggi.
I calcoli del World Economic
Forum fanno riflettere ma non dicono quanto di se stessi si lascia nel momento
in cui si riversano nell’agorà digitale inclinazioni, paure, desideri. Una
risposta l’ha fornita proprio l’ex socio di Mark Zuckerberg, Sean Parker, ben
prima che scoppiasse il Datagate: Facebook sarebbe un loop di “validazione
sociale basato su una vulnerabilità psicologica umana che cambia letteralmente
la relazione di un individuo con la società e con gli altri’‘. Proprio quello
che sostengono luminari come Grenfield e Ammaniti. È del tutto evidente che non
esiste quindi soltanto il problema di come trattare e proteggere i dati
personali ma anche di valutarne a questo punto l’affidabilità e la veridicità in
tutti i gesti quotidiani. Quando si acquista un bene e si viene profilati,
quando si esprime un parere e ci si sottopone al giudizio del pubblico virtuale,
quando si esercita la massima espressione delle libertà personali in democrazia,
il voto. Se dietro a tutte queste manifestazioni c’è ormai una sagoma sbiadita
di un’identità, qualcosa la cui verosimiglianza è a rischio, il lavoro
controverso e criticato di Cambridge Analytica e di chissà quante altre società,
diventa solido come un castello di carte. La fake news saremo noi.
Ma Cambridge Analytica e
Facebook non hanno eletto Trump.
Le manipolazioni e l'uso dei
dati del social non è detto siano così efficaci politicamente. E non dovrebbero
diventare un alibi per le difficoltà elettorali del liberalismo e dei difensori
delle società aperte, scrive Luigi Gavazzi il 21 marzo 2018 su "Panorama". È il
caso di ribadirlo. Donald Trump e la Brexit non dovrebbero essere
spiegati solo con la manipolazione dei dati sottratti a Facebookda Cambridge
Analytica (CA). L'azione di quest'ultima, sicuramente preoccupante per la
democrazia e le libertà individuali, compreso l'incubo per l'abuso dei
dati conferiti a Facebook dagli utenti, difficilmente è stata davvero
efficace come sostengono sia i dirigenti di CA, sia Christopher Wylie, il
whistleblower che ha rivelato all'Observer e al New York Times il lavoro fatto
per Steve Bannon - stratega della campagna elettorale 2016 di Donald Trump - e
per il Leave in Gran Bretagna. Indagare e scoprire violazioni di legge
e pericoli politici di questa attività è doveroso. Sarebbe meglio però non
venisse usata da partiti, gruppi sociali e culturali sconfitti da Trump e dalla
Brexit come alibi per ignorare le proprie debolezze e l'inefficacia degli
argomentiusati a favore della società aperta e del liberalismo. Insomma,
evitiamo di rispondere alle minacce e alle sfide del populismo parlando solo di
social network.
Se Cambridge Analytica fosse
inefficiente e avesse venduto fumo. I signori di CA da anni - come ricorda David
Graham su The Atlantic - cercavano di piazzare i propri servizi, dicendo che
avrebbero fatto cose miracolose. Nel 2015 Sasha Issenberg di Bloomberg scrisse
di CA e delle promesse della loro profilazione “psicografica”, oggi alla
ribalta, con una certo scetticismo, per esempio perché il profilo ricavato dal
test sullo stesso Issenberg era risultato molto diverso da quello prodotto
dal Psychometrics Centre dell’Università di Cambridge (il test originale sul
quale si basava l'app di usata da Aleksandr Kogan per raccogliere i dati per
Ca). Del resto, Cambridge Analytica, era stata ingaggiata nel 2015 sia da Ted
Cruz che da Ben Carson, due candidati repubblicani alla nomination per le
elezioni presidenziali. Ebbene, il contributo di CA è risultato nullo, e le
campagne hanno avuto esiti disastrosi. Le persone che dirigevano quella di Cruz
hanno ben presto deciso di lasciar perdere il contributo di CA, perché
irrilevante. Nel comunicare la decisione si lamentarono del fatto che stessero
pagando un servizio che non esisteva neppure. C’è poi il fatto che dietro CA ci
fosse, come investitore, Robert Mercer e la sua famiglia, fra i principali
sostenitori e finanziatori dei repubblicani. Per Cruz era importante avere i
soldi di Mercer, a costo di ingaggiare la creatura CA che Mercer finanziava.
Mercer, come noto, passò poi a
Trump, convinto anche da Bannon e da Breitbart. La cosa interessante è che,
d’altra parte, la stessa campagna di Trump, dopo aver abbracciato CA, l’ha
successivamente abbandonata. A sostegno della tesi di Cambridge Analytica come
un bluff che ha venduto più che altro fumo, ci sarebbe anche il video registrato
dai reporter di Channel 4, presentati sotto la falsa identità di politici dello
Sri Lanka interessati a comprare i servizi dell'azienda. Ebbene, se questi
servizi fossero così efficaci come i manager di CA sostengono, che bisogno ci
sarebbe stato, per venderli ai politici interessati, di proporre anche manovre
per intrappolare gli avversari di questi ultimi, screditandoli con possibili
scandali sessuali, sospetti di corruzione e cose del genere? Più in generale,
gli osservatori citati da Graham sono da tempo assai dubbiosi dell’efficacia di
queste tecniche “psicometriche”, fino a qualche anno fa chiamate di
“microtargeting”.
La democrazia liberale deve
comunicare meglio i pregi della società aperta. Detto questo, i democratici
negli Stati Uniti, chi voleva che il Regno Unito restasse nell'Unione Europea, i
partiti sconfitti dall'onda populista in Italia, chi teme l'autoritarismo
sovranista e illiberale di Ungheria e Polonia, dunque, tutti coloro ai quali sta
a cuore la democrazia liberale e la società aperta dovrebbero concentrarsi più
sugli argomenti politici, i linguaggi, le proposte, la comunicazione per
convincere gli elettori. In questo modo sarebbe più facile e probabile rendere
innocuo chi cerca di manipolare le opinioni pubbliche in questi paesi, siano
manovratori nell'ombra, gli hacker di Putin o di chi altro (che, vale la pena
ricordarlo, sono comunque preoccupanti per la democrazia).
Facebook, ecco come
Obama violò la privacy degli americani,
scrive il 22 marzo 2018 Giampaolo Rossi su "Gli Occhi della Guerra" su "Il
Giornale". Carol Davidsen è stata il capo Dipartimento “Media Targeting” dello
staff di Obama nelle elezioni del 2012 ed è considerata un’esperta di campagne
elettorali online in America. In una conferenza pubblica, tre anni dopo
l’elezione di Obama, rivelò qualcosa che allora passò sotto silenzio ma che oggi
è dirompente alla luce dello scandalo Cambridge Analityca: “Noi siamo stati
capaci di ingerire l’intero social network degli Stati Uniti su Facebook”. Nello
stesso intervento affermò che i democratici acquisirono arbitrariamente i dati
dei cittadini americani a cui i Repubblicani non avevano accesso; e questo
avvenne con la complicità dell’azienda americana che lo consentì tanto che la
Davidsen è costretta ad ammettere che “ci fu uno squilibrio di acquisizione
informazioni ingiusto” (nel video dal minuto 19:48). Nei giorni scorsi su
Twitter, la Davidsen è tornata sulla questione confermando che a Facebook furono
sorpresi quando si accorsero che lo staff di Obama aveva “succhiato l’intero
social graph” (vale a dire il sistema di connessioni tra gli utenti) “ma non ce
lo impedirono una volta capito cosa stavamo facendo”. In altre parole Facebook
consentì ad Obama di rubare i dati dei cittadini americani e di utilizzarli per
la sua campagna presidenziale, in quanto azienda schierata dalla parte dei
democratici. D’altro canto già nel 2012, sul Time, un lungo articolo di Michael
Scherer spiegava come Obama si era impossessato dei dati degli americani su
Facebook con lo scopo d’intercettare l’elettorato giovanile. Esattamente nello
stesso modo in cui lo ha fatto Cambrdige Analytica per la campagna di Trump:
attraverso un app che carpì i dati non solo di chi aveva autorizzato, ma anche
della rete di amicizie su Facebook ignare di avere la propria privacy
violata. Solo che allora la cosa fu salutata come uno dei nuovi orizzonti
delle politica online e descritta da Teddy Goff, il capo digital della campagna
di Obama, “il più innovativo strumento tecnologico” della nuove campagne
elettorali.
Zuckerberg e democratici. La
stretta connessione tra Facebook e il Partito Democratico Usa è continuata anche
nelle ultime elezioni come rivelano in maniera implacabile le mail di John
Podesta, il potente capo della campagna elettorale di Hillary Clinton,
pubblicate da Wikileaks. È il 2 gennaio del 2016, quando Sheryl Sandberg,
Direttore esecutivo di Facebook e di fatto numero due dell’Azienda, scrive a
Podesta una mail di augurio di Buon Anno, affermando: “Sono elettrizzata dai
progressi che sta facendo Hillary”. È il periodo in cui si stanno completando i
preparativi per la designazione alla primarie del Partito democratico che
partiranno a febbraio; e la risposta del Capo Staff di Hillary non lascia adito
a dubbi: “Non vedo l’ora di lavorare con te per eleggere la prima donna
presidente degli Stati Uniti”.
Sheryl Sandberg (oggi una
delle dirigenti Facebook al centro dello scandalo) è la donna che Zuckerberg
volle fortemente nella sua azienda strappandola nel 2008 al diretto concorrente
Google. La manager, da sempre democratica, aveva lavorato nell’amministrazione
di Bill Clinton come capo staff di Larry Summers il Segretario del Tesoro,
voluto proprio dal marito di Hillary. Il rapporto tra Podesta e la Sandberg è di
vecchia data. Nell’agosto del 2015 lei scrive a lui per chiedergli se fosse
disposto ad incontrare direttamente Mark Zuckerberg. Il grande capo di Facebook
è interessato ad incontrare persone che “lo aiutino a capire come fare la
differenza sulle questioni di politica a cui lui tiene maggiormente” e
“comprendere le operazioni politiche efficaci per far avanzare gli obiettivi”
tematici a cui lui tiene, come “immigrazione, istruzione e ricerca scientifica”.
E chi avrebbe potuto farlo meglio del guru della campagna elettorale di colei
che erano tutti convinti, sarebbe diventata il successivo presidente degli Stati
Uniti?
Conclusione. Lo scandalo
Cambridge Analytica che doveva essere l’ennesimo attacco contro Trump e la sua
elezione si sta trasformando in un boomerang per Democratici e sopratutto per
Facebook; l’azienda è oggi al centro del mirino delle polemiche per un modello
di business che si fonda proprio sull’accaparramento e la cessione dei nostri
dati di privacy che possiede nel momento in cui noi inseriamo la nostra vita, le
nostre immagini, le amicizie e la nostra identità all’interno del social media.
Ma la questione è sopratutto politica: quello che oggi è scandalo perché fatto
per la campagna elettorale di Trump, fu ritenuta una grande innovazione quando
lo fece Obama. Con in più un particolare di non poco conto: che nel caso di
Obama, Facebook ne era a conoscenza e consentì la depredazione dei dati degli
americani. Forse, all’interno del suo “mea culpa”, è di questo che Zuckerberg e
i vertici di Facebook dovrebbero rispondere all’opinione pubblica.
Cambridge Analytica gate:
il dito e la luna,
scrive Guido Scorza il 21 marzo 2018 su "L'Espresso". Se esisteva ancora
qualcuno al mondo che non conosceva Facebook ora lo conosce certamente. Lo
scandalo che ha travolto il più popolare social network della storia
dell’umanità è, da giorni, sulle prime pagine dei media di tutto il mondo. Il
“diavolo” è nudo. Se non è già avvenuto, presto qualcuno titolerà così uno dei
tanti feroci j’accuse all’indirizzo di Zuckerberg. Ma si commetterebbe uno dei
tanti errori dei quali la narrazione mediatica globale – in alcuni Paesi tra i
quali il nostro più che in altri – è piena zeppa. Vale la pena, quindi, di
mettere nero su bianco qualche punto fermo in questa vicenda e provare anche a
trarne qualche insegnamento senza rischiare di perder tempo a fissare il dito,
lasciando correre via la luna. La prima necessaria considerazione è che nessuno
ha rubato né a Facebook, né a nessun altro i dati personali dei famosi 50
milioni di utenti. Non in questa vicenda. Quei dati – stando a quanto sin qui
noto – sono stati acquisiti direttamente da 270 mila utenti che hanno
deliberatamente – per quanto, naturalmente, si possa discutere del livello di
reale consapevolezza – scelto di renderli disponibile al produttore di una delle
centinaia di migliaia di app che ciclicamente ci offrono la possibilità di
velocizzare il processo di attivazione e autenticazione a fronte del nostro “ok”
a che utilizzino a tal fine i dati da noi caricati su Facebook e a che – già che
ci sono – si “aspirino” una quantità più o meno importante di altri dati dalla
nostra vita su Facebook. Basta andare su Facebook, cliccare su “impostazioni” –
in alto a destra – e, quindi, su “app” per rendersi conto di quanto ampio,
variegato e affollato sia il club dei gestori di app ai quali, dalle origini del
nostro ingresso sul social network a oggi abbiamo dato un permesso,
probabilmente, in tutto e per tutto analogo se non identico a quello che i 270
mila ignari protagonisti della vicenda hanno, a suo tempo, dato al gestore
dell’app “This is Your Digital Life”. E basta cliccare sull’icona di una
qualsiasi delle app in questione per avere un elenco, più o meno lungo, delle
categorie di dati che, a suo tempo, abbiamo accettato di condividere con il suo
fornitore. E’ tutto li, a portata di click, anche se per aver voglia di arrivare
a sfogliare le pagine in questione, forse, è stato necessario che scoppiasse uno
scandalo planetario perché, altrimenti, nel quotidiano la nostra navigazione su
Facebook sarebbe proseguita si altri lidi, come accaduto sino a ieri e,
probabilmente, come succederà nelle prossime settimane. La seconda
considerazione – direttamente correlata alla prima – è che Facebook non è stata
vittima di nessun breach, nessuna violazione dell’apparato di sicurezza che
protegge i propri sistemi, nessun attacco informatico di nessun genere. Non in
questa vicenda, almeno. Sin qui, quindi, tanto per correggere il tiro rispetto a
quello che si legge sulle prime di centinaia di giornali, nessun furto, nessuno
scasso, nessun furto con scasso.
E allora? Come ci è finito
Facebook sul banco degli imputati del maxi processo più imponente e severo della
sua storia?
La risposta è di disarmante
semplicità anche se difficile da conciliare con quanto letto e sentito sin qui
decine di volte. Facebook viene portato alla sbarra proprio perché non ha subito
nessun furto scasso e questa vicenda ha semplicemente confermato – non certo per
la prima volta – che la sua attività – che è la stessa di milioni di altre
imprese di minor successo in tutto il mondo – è pericolosa ed espone ad un
naturale e ineliminabile rischio alcuni tra i diritti più fondamentali degli
uomini e dei cittadini. Attenzione, però: espone a un rischio tali diritti ma
non li viola. Al massimo, come accaduto nel Cambridge Analytica gate, facilita
l’azione di chi tali diritti voglia consapevolmente violare. Ed è esattamente
questo che accaduto nella vicenda in questione: una banda di sicari delle
libertà – perché ogni definizione diversa non renderebbe giustizia al profilo
dei veri protagonisti negativi della vicenda – assoldati da mandanti nemici
dell’A,B,C della democrazia ha furbescamente approfittato della debolezza del
sistema Facebook a proprio profitto e in danno della privacy e, forse, della
libertà di coscienza di milioni di persone.
E’ la debolezza del suo
ecosistema la principale colpa di Facebook. L’aver reso possibile una tragedia
democratica che – ammesso che le ipotesi possano trovare una conferma
scientifica – ha condizionato l’esito delle elezioni negli Stati Uniti d’America
e il referendum che ha portata l’Inghilterra fuori dall’Unione Europea. E guai a
dimenticare che sono queste ipotetiche conseguenze ad aver reso una vicenda che
in realtà non fa altro che confermare che un uovo sodo ammaccato a una delle due
estremità può stare in piedi da solo. Il famoso uovo di Colombo. Perché se la
stessa tecnica – egualmente fraudolenta ed egualmente figlia dell’intrinseca
debolezza dell’ecosistema Facebook – fosse stata utilizzata, come sarà stata
utilizzata milioni di volte, per vendere qualche milione di aspirapolveri, oggi,
evidentemente, non saremmo qui a parlarne e non sarebbe accaduto che le Autorità
di mezzo mondo si siano messe in fila davanti alla porta di Menlo Park, bussando
per chiedere audizioni e ispezioni, rappresentando possibili sanzioni e
conseguenze salate. Guai a dire tanto rumore per nulla. E guai anche a suggerire
l’assoluzione di Facebook che, tra le sue colpe, ha – ed è forse la più grave –
quella di esser stato a conoscenza da anni dei rischi che 50 milioni di propri
utenti stavano correndo ma di aver scelto di non informarli. Ma, ad un tempo, se
si vuole evitare di lasciarsi trascinare e travolgere dall’onda lunga della
sassaiola mediatica val la pena di trovare il coraggio di fissare in mente
questa manciata di considerazioni di buon senso prima che di diritto. Anche
perché, a condizione di trovare la necessaria serenità di giudizio e una buona
dose di obiettività, da questa vicenda c’è, comunque, molto da imparare.
Bisogna, però, esser pronti a non far sconti a nessuno, a mettersi in
discussione in prima persona e resistere alla tentazione di dare addosso a
Facebook con l’approssimazione emotiva che connota la più parte degli attacchi
che si leggono in queste ore. In questa prospettiva sul banco degli imputati,
accanto a Facebook, dovrebbe salirci un sistema di regole che, evidentemente, ha
fallito, ha mancato l’obiettivo e si è rivelato inefficace: è quello a tutela
dei consumatori, degli interessati, degli utenti basato sugli obblighi di
informazione e sulle dozzine di flag, checkbox e tasti negoziali. Le lenzuolate
di informazioni che Facebook – e naturalmente non solo Facebook – da, per legge,
ai suoi miliardi di utenti non servono a nulla o, almeno, non sono abbastanza
perché questa vicenda dimostra plasticamente che gli utenti cliccano “ok” e
tappano flag senza acquisire alcuna consapevolezza sulla portata e sulle
conseguenze delle loro scelte. Anzi, a volercela dire tutta, questo arcaico e
primitivo sistema regolamentare produce un risultato diametralmente opposto a
quello che vorrebbe produrre: anziché tutelare la parte debole del rapporto
finisce con il garantire alla parte forte una prova forte e inoppugnabile di
aver agito dopo aver informato a norma di legge la parte debole ed aver raccolto
il suo consenso.
Così non funziona. E’ urgente
cambiare rotta. Basta obblighi di informativa chilometrici e doppi, tripli e
quadrupli flag su improbabili check box apposti quasi alla cieca, su schermi
sempre più piccoli e mossi, esclusivamente, dalla ferma di volontà di iniziare a
usare il prima possibile il servizio di turno. Servono soluzioni più di
sostanza. Servono meno parole e più disegni. Servono meno codici e più codice
ovvero informazioni capaci di esser lette direttamente dai nostri smartphone e
magari tradotte visivamente in indici di rischiosità, attenzione e cautela.
La vicenda in questione è una
storia di hackeraggio negoziale. Se si vuole per davvero evitare il rischio che
si ripeta è in questa prospettiva che occorre leggerla. E sul banco degli
imputati assieme a Facebook dovrebbe, egualmente, salire chi, sin qui, ha
sistematicamente e scientificamente ridimensionato il diritto alla privacy fino
a bollarlo come un inutile adempimento formale, un ostacolo al business o un
freno al progresso. Perché non ci si può ricordare che la privacy è pietra
angolare delle nostre democrazie solo quando, violandola, qualcuno – a
prescindere dal fatto che riesca o fallisca nell’impresa – si mette in testa di
condizionare delle consultazioni elettorali o referendarie. In caso contrario le
conseguenze sono quelle che oggi sono sotto gli occhi di tutti: utenti che
considerano la loro privacy tanto poco da fare il permesso a chicchessia di fare
carne da macello dei propri dati personali, disponendone con una leggerezza con
la quale non disporrebbero delle chiavi del loro motorino, della loro auto o del
loro portafogli e Autorità di protezione dei dati personali con le armi spuntate
e costrette a registrare episodi di questo genere leggendo i giornali quando non
i buoi ma i dati personali di decine di milioni di utenti sono ormai lontani dai
recinti.
Anche qui bisogna cambiare
strada e cambiarla in fretta. E’ urgente tracciare una linea di confine netta,
profonda invalicabile tra una porzione del diritto alla protezione dei dati
personali che è giusto e indispensabile che resti appannaggio del mercato e una
porzione che, invece, meriterebbe di entrare a far parte dei diritti
indisponibili dell’uomo come lo sono le parti del corpo umano, sottratta, per
legge, al commercio, agli scambi e al mercato a prescindere dalla volontà dei
singoli utenti. Ed è urgente investire sulle nostre Autorità di protezione dei
dati personali perché non si può, al tempo stesso, scandalizzarsi di episodi
come quello della Cambridge Analytica e pretendere che un’Autorità di poche
decine di professionisti e finanziata con una percentuale infinitesimale del
bilancio dei nostri Stati garantisca protezione, regolamentazione e vigilanza su
quello che è ormai diventato il più grande, proficuo e per questo attaccabile
mercato globale. Facciamo tesoro di quello che è accaduto. Leggiamo i fatti con
obiettività e, soprattutto, facciamo quanto possibile per cambiare rotta perché
il problema non è Facebook e, in assenza di correttivi importanti, se anche
domani la borsa condannasse Facebook all’estinzione, non avremmo affatto risolto
il problema.
Dal Lago: «La
disinformazione è diventata un’arma per vincere in politica»,
scrive Giulia Merlo il 22 Marzo 2018 su "Il Dubbio". «I social ci condizionano
come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono diventati uno
strumento decisivo sul piano della propaganda politica». «I social ci
condizionano come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono
diventati uno strumento decisivo sul piano della propaganda politica». Per
Alessandro Dal Lago, sociologo e studioso dei fenomeni del web, lo scandalo che
ha investito Facebook ha fatto venire alla luce lo sfruttamento illegale di
informazioni che, però, già da tempo sono diventate uno strumento politico.
L’inchiesta contro
Cambridge Analytica ha aperto il vaso di Pandora del lato oscuro dei social?
«Ha
rivelato che i nostri dati, sia pubblici che privati come le reti di amicizia su
Facebook, possono essere usate per campagne di profilazione e per la creazione
di modelli di utenza. In seguito, questa mole di informazioni può essere usata
per campagne di marketing e di propaganda politica. Così, il cittadino della
lower class americana esasperato dalla mancanza di lavoro e che odia i vicini di
casa neri diventa personaggio medio, utilizzabile come modello per studiare una
propaganda mirata. Considerando che i dati analizzati hanno permesso alla
Cambridge Analytica di profilare 50 milioni di utenti, si capisce la portata del
fenomeno».
E questo quali problemi
solleva?
«Da
una parte c’è il tema della tutela della privacy e le ipotesi sono due: o
Facebook sapeva dell’indebita profilazione e dunque è connivente, oppure non
sapeva e questo significa che il sistema è penetrabile. Tutto sommato, questa
seconda prospettiva mi sembra la più grave».
I dati sono stati usati per
fare campagne politiche.
«Il
rilievo politico della vicenda porta in primo piano l’esistenza di società di
big data, che puntano a controllare l’opinione pubblica e che fanno parte di un
mondo pressochè sconosciuto alla collettività. Basti pensare che, prima di
qualche giorno fa, nessuno conosceva Cambridge Analytica, e come questa esistono
altre centinaia di società analoghe. Senza complottismi, è evidente come
esistano ambienti che, attraverso la consulenza strategica, sono interessati a
orientale la politica globale. Altro dato, la presenza nell’inchiesta di Steve
Bannon – noto suprematista bianco e stratega di Trump – mostra come la capacità
di influenzare l’opinione pubblica attraverso la manipolazione dei dati sul web
è più forte nella destra globale che non nella sinistra».
Davvero un post
pubblicitario su Facebook è in grado di condizionare l’elettorato fino a questo
punto?
«E’
più che normale che sia in grado di farlo. La comunicazione si è evoluta:
partiamo dal manifesto elettorale, e penso alla geniale trovata di propaganda
anticomunista della Dc del 1948, con il manifesto dei cosacchi che si abbeverano
a una fontana davanti a una chiesa. Poi sono arrivati i media generalisti come
la televisione e la stampa, in cui la propaganda si faceva attraverso i modelli
culturali. Penso alla Rai, in cui si propagandava un modello familiare che
indirettamente finiva per legittimare la Dc. Oggi la propaganda è molto
cambiata: il web e i social creano un pubblico universale, che accede alla
stessa sfera comunicativa. Questo permette ai manipolatori intelligenti di
arrivare istantaneamente a un pubblico enorme, influenzandoli a un livello
impensabile solo fino a qualche anno fa».
In Italia esistono fenomeni
simili di sfruttamento del web?
«La
Casaleggio Associati è un esempio di questo. La società gestisce un’enorme rete
di pagine Facebook e siti collegati al blog delle Stelle e indirettamente a
quello di Beppe Grillo».
E come funziona,
praticamente, il meccanismo?
«Le
faccio un esempio. Esiste una pagina appartenente a questa galassia che si
chiama “Alessandro Di Battista presidente del consiglio”, che contiene messaggi
di propaganda in stile mussoliniano del tenore di: «Ringraziamo il guerriero Di
Battista, eroe nazionale». Ora, si puo dire che queste parole suonino ridicole,
ma bisogna leggerle in chiave social e in base al target degli elettori che si
vogliono calamitare: giovani elettori del sud Italia, con una scolarità medio
bassa. A questi soggetti si propone una propaganda che da una parte martella
sull’odio per la casta e dall’altra propone un eroe nazionale. Considerando che
pagine come queste hanno centinaia di migliaia di follower, è facile immaginare
gli effetti».
Nulla di tutto questo,
però, è illegale.
«Certo
che no, però esiste un problema di profonda manipolazione della realtà contro la
quale non esistono strumenti di difesa adeguati. Le fake news, infatti, non sono
solo le notizie inventate ma per la maggior parte si tratta di manipolazioni di
notizie verosimili, che vengono caricate di retorica per diventare virali e,
nello stesso tempo, nessuno verifica che si tratta di falsi».
Si può parlare di un
modello politico?
«E’
certamente un modello. Politicamente, io credo sia inquietante che i
parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano sottoscritto un contratto ridicolo
nel quale tuttavia si impegnano a versare 300 euro al mese alla Casaleggio
Associati, che non è un partito ma un’azienda privata di comunicazione».
Si può dire che, oggi,
vince le elezioni chi sa usare meglio questi strumenti del web?
«Diciamo
che i social non sono lo strumento esclusivo, ma sono diventati quello decisivo.
Difficile dire quanti milioni di voti abbia spostato la campagna di Cambridge
Analytica però, se si pensa alle elezioni americane, anche un milione di voti in
più o in meno può garantire l’elezione alla Casa Bianca. Insomma, la propaganda
sul web è in grado di spostare le decisioni».
Il web, quindi, condiziona
la realtà?
«Il
web ne condiziona la percezione, e questo è decisivo. La realtà e i conflitti
continuano ad esistere, ma il modo in cui vengono percepiti e il luogo in cui si
propongono le soluzioni è deciso dalla propaganda sul web. In questo modo la
sfera di comunicazione virtuale decide l’orientamento dei settori critici
dell’elettorato. Tornando ai 5 Stelle: il loro sistema di comunicazione prevede
di generare un cortocircuito tra l’abile uso delle news sul web e la sistematica
disinformazione».
L'errore di lasciare il web
a Casaleggio,
scrive Renato Mannheimer, Lunedì 26/03/2018, su "Il Giornale". L'articolo di
Davide Casaleggio sul Washington Post (e poi su Il Dubbio) riporta con chiarezza
il pensiero e, forse, la stessa ideologia dello stratega del Movimento Cinque
Stelle. Ma contiene, al tempo stesso, tematiche di grande importanza. Occorre
dire con franchezza che Casaleggio pone una questione sulla quale è cruciale
riflettere con attenzione. È vero, infatti, come lui sostiene, che il Web ha
cambiato radicalmente la nostra vita per moltissimi aspetti. È mutato il modo di
interagire con gli altri, il modo di lavorare, si sono modificate perfino certe
abitudini nei rapporti sentimentali. Tenuto conto di tutto ciò, non si capisce
perché la rete non dovrebbe cambiare anche i connotati della politica e, in
particolare, dei modi con cui ci relazioniamo con essa. Non solo per quanto
riguarda le modalità di comunicazione o di propaganda, ma anche, specialmente,
le logiche con cui il cittadino si raffronta con il potere costituito e con i
suoi esponenti. Le modalità e i processi con cui si formano le credenze, i
dubbi, le stesse opzioni elettorali. In altre parole, con l'avvento del Web muta
non solo il modo di comunicare, ma anche quello di pensare e di rispondere agli
stimoli che ci vengono dagli attori politici. Più in generale, come diversi
analisti hanno osservato, siamo di fronte a un profondo cambiamento delle
logiche della stessa democrazia. Questo vero e proprio sovvertimento portato dal
Web mi era stato prospettato più di trent'anni fa da Casaleggio senior. Io ero a
suo tempo incredulo, ma devo riconoscere che aveva in gran parte ragione nel
preconizzarmi già allora gli effetti della rete sulle relazioni sociali e sugli
atteggiamenti e sui comportamenti dei cittadini. Certo, Davide Casaleggio ha
torto quando afferma che il Movimento Cinque Stelle è il vero alfiere di questo
mutamento. Che attraverso di esso «i cittadini hanno avuto accesso al potere».
In realtà il «pubblico» del M5s è limitato alla porzione di italiani peraltro
fortemente caratterizzata nei suoi connotati demografici e sociali - che accede
alla piattaforma Rousseau. Per di più con modalità non trasparenti e controllate
dalla stessa Casaleggio e Associati. Anche le cosiddette «parlamentarie», che
Casaleggio descrive come l'esercizio genuino della volontà popolare nello
scegliere i candidati alle elezioni, sono state caratterizzate, come si sa, da
scarsi livelli di partecipazione e da notevoli e sistematiche interferenze e
condizionamenti da parte dei vertici della Casaleggio e Associati. Insomma, la
pratica condotta sin qui dal M5s è assai lontana dall'avere realizzato quegli
stessi ideali di partecipazione e di «vera» democrazia che Casaleggio evoca nel
suo articolo. Ma questa considerazione non ci deve portare a sottovalutare il
punto centrale delle sue argomentazioni. Vale a dire che, come si è detto, la
Rete e in particolare i «social media» hanno radicalmente cambiato i modi di
agire, di pensare e gli stessi meccanismi di formazione delle opinioni e delle
scelte da parte dei cittadini. Con tutti i pericoli (il caso della Cambridge
Analyitica lo dimostra) e i problemi che questi fenomeni comportano. Larga parte
delle formazioni politiche operanti nel nostro paese ha affrontato solo in parte
e talvolta solo in modo approssimativo questa tematica. È un limite che va
superato: trascurare questa rivoluzione in atto costituisce un formidabile
errore e dà spazio proprio al Movimento di Grillo.
Che ipocrisia indignarsi se
le nostre vite sono in vendita,
scrive Francesco Maria Del Vigo, Giovedì 22/03/2018, su "Il Giornale". Ma siamo
sicuri che quello di Cambridge Analytica sia uno scandalo con la esse maiuscola?
È davvero una notizia sconvolgente o è una notizia di dieci anni fa?
Ricapitoliamo: molti di noi, dal 2007, quotidianamente passano ore a caricare
foto, scrivere post, fare giochi, installare app e seminare like su Facebook.
Cosa stiamo facendo in quel determinato momento? Stiamo perdendo tempo, dice
qualcuno. Ci stiamo divertendo e stiamo socializzando, dice qualcun altro.
Stiamo cedendo una mole incredibile di dati sulla nostra vita, dice Mark
Zuckerberg. E lo dice chiaramente. Perché vendere, ovviamente in modo anonimo,
le nostre informazioni - che poi sono i nostri gusti, i nostri hobby, i luoghi
che amiamo o la marca del nostro dentifricio preferito - è la ragione sociale di
Facebook. È il suo business, il suo mestiere. Cadere dalle nuvole è surreale, è
come stupirsi che un calzolaio lustri le scarpe. Vi siete mai chiesti come ha
fatto una matricola di Harvard a racimolare un patrimonio da 70 miliardi di
euro? Coi vostri status, le foto dei vostri gatti e i vostri «mi piace». E noi
tutti, iscrivendoci al social network, abbiamo accettato, più o meno
consapevolmente, questo mercimonio. Ti diamo un po' di noi in cambio di quindici
like di notorietà, abbiamo barattato la nostra privacy con una vetrina dalla
quale poterci esporre al mondo virtuale. Dunque qual è il problema? Il problema
è che in questo caso un'azienda terza ha utilizzato le «nostre» informazioni
all'insaputa di Facebook. Grave, certo. Ma nulla di particolarmente
sconvolgente. Un traffico che, abbiamo ragione di immaginare, accade molto
spesso per scopi commerciali. Il problema è che l'opinione pubblica è disposta
ad accettare di vedere comparire sulla propria bacheca la pubblicità della
propria maionese preferita, ma se entra in ballo la politica la questione
cambia. Se poi, come in questo caso, entrano in ballo la Brexit e gli
impresentabili Trump e Bannon allora la faccenda precipita. Possibile che le
anime belle della Silicon valley, quelli che per mesi ci hanno detto che Trump
era un pazzo scatenato, lo abbiano lasciato giocherellare coi nostri dati? Sì,
perché pecunia non olet. Nemmeno per i nerd di San Francisco. E, per loro, la
nostra opinione politica è un dato come un altro, masticato e sputato dagli
algoritmi per poi essere rivenduto. È l'era dei big data e della data economy.
Che prima piacevano tanto agli intelligentoni à la page, ma che ora, sembra
andargli di traverso. Ma è anche l'era della data politics. E, al netto delle
ripercussioni giudiziarie che ci saranno su questo caso, le campagne elettorali
si sposteranno sempre di più sulla profilazione degli utenti del web e sulla
psicometria. Così sui nostri social, accanto alla pubblicità delle nostre
cravatte preferite, compariranno anche informazioni e annunci politici. È
manipolazione? No, è solo un'altra forma di marketing. Elettore avvisato...
Come si manipola
l’informazione: il libro che ti farà capire tutto,
scrive Marcello Foa il 17 marzo 2018 su "Il Giornale". Ci siamo: il mio saggio
“Gli stregoni della notizia. Atto secondo”, pubblicato da Guerini e Associati, è
in libreria da quattro giorni e i riscontri sono davvero incoraggianti, sia sui
media (ne hanno parlato con ampio risalto il Corriere del Ticino, La Verità, il
Giornale, Libero, Dagospia), sia da parte dei lettori. Alcuni mi hanno scritto:
ma cosa c’è di nuovo rispetto alla prima edizione del 2006? C’è molto: le
tecniche usate dai governi per orientare e manipolare i media, che descrissi 12
anni fa, sono valide ancora oggi e vengono applicate ancor più intensamente, per
questo le ripropongo anche in questo secondo atto ma attualizzate, ampliate e,
nella seconda parte del libro, arricchite da capitoli completamente nuovi, che
permetteranno al lettore di entrare in una nuova dimensione: quella,
sofisticatissima ma indispensabile per capire le dinamiche odierne,
dell’informazione quale strumento essenziale delle cosiddette guerre
asimmetriche, che vengono combattute senza il ricorso agli eserciti ma i cui
effetti sono altrettanto poderosi e che raramente vengono spiegate dai media.
Attenzione: non riguardano solo il Vicino Oriente o l’Ucraina, ma anche le
nostre democrazie, molto più esposte di quanto si immagini. Non mi dilungo,
ovviamente. Sappiate che in questo saggio approfondisco l’uso (e l’abuso) del
concetto di frame dimostrando come sia stato impiegato per “vendere” al popolo
l’euro e impedire per anni un dibattito oggettivo sugli effetti della moneta
unica o per costruire il mito del salvataggio della Grecia e quello
dell’autorazzismo nei confronti della Germania. Ne “Gli stregoni della notizia.
Atto secondo” riprendo alcuni documenti governativi, noti solo agli specialisti,
sull’impressionante influenza del Pentagono su film e produzioni di Hollywood,
spiego il ruolo opaco degli spin doctor e delle società di PR negli allarmi
sanitari (dalla Mucca Pazza all’influenza suina, da Ebola a Zika) e quale ruolo
hanno avuto le Ong e le loro sorelle maggiori (le quango ovvero le Ong quasi
autonome, sconosciute ai più) nelle rivoluzioni colorate e nelle operazioni di
destabilizzazione di Paesi, che un tempo erano opera esclusiva dei servizi
segreti. Accendo un faro sugli aspetti poco noti dell’ascesa di Macron,
sull’altro volto di Obama, dedico molte pagine all’Italia, in particolare
spiegando le tecniche di spin che sono state decisive nell’ascesa e nella caduta
di Matteo Renzi e denuncio le ipocrisie sulle fake news, dimostrando come
servano a rendere l’informazione non più trasparente ma più docile e,
possibilmente, sottoposte a censura. E’ un libro che ho scritto a cuore aperto,
documentatissimo, rivolto a lettori che hanno voglia di capire e di scavare
oltre le apparenze, come Giorgio Gandola, che lo ha recensito su La verità, ha
capito perfettamente. Spero, di cuore, che vi piaccia. Ne parlo anche nella
bella intervista che mi ha fatto Claudio Messora per Byoblu e che trovate qui
sotto. Vi lascio ricordandovi la presentazione che si svolgerà lunedì 19 a
Milano, alla libreria Hoepli, ore 17.30 con Nicola Porro e lo stesso Gandola.
Altre seguiranno in diverse città italiane. Grazie a tutti voi e, naturalmente,
buona lettura!
Ecco come lavorano i
persuasori (non) occulti al servizio dei governi.
Gli spin doctor sfruttano le
convinzioni diffuse fra il pubblico. E agitano lo spettro complottista, scrive
Marcello Foa, Giovedì 15/03/2018, su "Il Giornale". Le insidie che avevo
individuato nel 2006, preconizzandone le derive si sono, purtroppo, puntualmente
verificate. Allora scrivevo che il fatto che i giornalisti non conoscessero le
tecniche per orientare e all'occorrenza manipolare i media, avrebbe non solo
reso molto più fragili le nostre democrazie, generando un sentimento di
crescente sfiducia verso la classe politica, ma anche danneggiato la credibilità
dell'informazione. È il mondo in cui viviamo oggi. Quelle tecniche, come allora,
restano ampiamente sconosciute ai media e, naturalmente, al grande pubblico.
Eppure comprenderle è indispensabile se si vuole cercare di decodificare
l'attualità senza limitarsi all'apparenza, come dovrebbe fare ogni giornalista e
come dovrebbe esigere ogni lettore. Certo, il mondo mediatico nel frattempo è
cambiato. Un tempo la cosiddetta grande stampa aveva il monopolio
dell'informazione, oggi non più e subisce la concorrenza, a mio giudizio
salutare, dei siti e dei blog di informazione alternativi. Oggi il mass media è
sostituito dal personal media che ognuno si costruisce attraverso la propria
rete sui social. Oggi si guarda meno la tv e si passa molto più tempo a
«chattare» su Whatsapp, a pubblicare foto e a tessere relazioni su Instagram.
Oggi, naturalmente, la diffusione di notizie false è ancora più facile benché,
come vedremo, non sia affatto una prerogativa della nostra epoca. Ma gli spin
doctor sono ancora tra noi, più influenti, più informati, più pervasivi che mai.
E non hanno modificato il loro obiettivo, che resta quello di condizionare noi
giornalisti e, in fondo, te, caro lettore; con la decisiva complicità del mondo
politico. Lo spin doctor non ha bisogno di contare sul controllo dei media,
perché sa che per orientare i giornalisti è sufficiente conoscere le loro
logiche. E da buon persuasore è convinto che la propaganda sia davvero efficace
solo quando non è facilmente riconoscibile. Infatti opera avvalendosi di:
- una comprensione perfetta
dei meccanismi che regolano il ciclo delle informazioni;
- il ricorso a sofisticate
tecniche psicologiche, che gli consentono di condizionare le masse.
Tra queste ultime il concetto
più importante in assoluto è quello del frame, che è stato elaborato dal
linguista americano George Lakoff, il quale sostiene che ognuno di noi ragiona
per cornici di riferimento costituite da una serie di immagini o di giudizi o di
conoscenze di altro tipo (culturali, identitarie). Ogni giorno noi elaboriamo
continuamente, senza esserne consapevoli, dei frame valoriali, che possono
essere effimeri o profondi se associati, su temi importanti, a una forte
emozione e ai nostri valori più radicati. La nostra visione della realtà e il
nostro modo di pensare ne risultano condizionati, perché una volta impressa una
larga, solida cornice, il nostro cervello tenderà a giudicare la realtà
attraverso questi parametri. Tutte le notizie coerenti con il frame saranno
recepite ed enfatizzate facilmente dalla nostra mente, rinforzando la nostra
convinzione. Al contrario, tutte quelle distoniche tenderanno a essere
relativizzate o scartate come assurde e, nei casi più estremi, irrazionali,
folli o stupide. Alla nostra mente non piacciono le contraddizioni e questo
spiega perché per un militante di destra gli scandali che colpiscono politici di
sinistra sono percepiti come gravissimi e veritieri, mentre quelli che
colpiscono la propria parte derubricati come delegittimati, irrisori o faziosi.
E naturalmente viceversa. Un abile spin doctor riesce, calibrando le parole, a
indirizzare l'opinione pubblica nella direzione voluta. La tecnica del frame
viene usata non solo per forgiare un giudizio su notizie contingenti, ma anche
per stabilire nell'opinione pubblica dei valori di fondo e dunque il confine tra
politicamente corretto e politicamente scorretto; tra ciò che è conveniente o
non conveniente dire su un argomento; tra ciò che l'opinione pubblica «moderata»
deve considerare ragionevole o deve respingere come scandaloso, ponendo di fatto
le premesse per screditare le opinioni che travalicano quel confine invisibile e
che possono pertanto, all'occorrenza, essere etichettate come estremiste,
complottiste o fasciste.
A proposito di
cospirazionismo, sapevate che il termine fu inventato dalla Cia ai tempi
dell'omicidio Kennedy per screditare le tesi di coloro che contestavano la
versione ufficiale stabilita dalla Commissione Warren? Lo spiega il professor
Lance Dehaven-Smith, osservando come gli effetti di quell'operazione,
circostanziati nel dispaccio 1035-960, sorpresero persino i vertici di Langley.
Da allora è diventato un metodo: quando vuoi screditare qualcuno lo accusi di
essere complottista. Facendo così ottieni due scopi: screditi le sue tesi agli
occhi della massa e lo costringi ad assumere un atteggiamento difensivo, ovvero
a dimostrare di non essere cospirazionista e dunque, sovente, a moderare i toni
delle sue denunce, pena l'autoghettizzazione. Che poi le sue accuse siano
plausibili o fondate diventa inevitabilmente secondario; anzi, colpendo
l'autorevolezza di chi critica, delegittimi in toto le sue idee. E se costui
persiste lo fai apparire sacrilego. Impedisci che anche sulle critiche fondate
si apra una vera riflessione pubblica. Una volta stabilito, il frame resiste nel
tempo e può essere scacciato solo da un altro equivalente che abbia pari o
superiore legittimità. Un esempio? La fine politica di Antonio Di Pietro. Come
ricorderete a screditarlo fu un'inchiesta di «Report» sul suo (presunto) impero
immobiliare, accumulato approfittando anche dei fondi del partito. Quelle accuse
non erano nuove, poiché erano già state formulate da alcuni giornali come il
Giornale e Libero, ma non avevano scalfito l'immagine dell'ex pm rispetto al suo
elettorato, perché ritenute faziose e dunque almeno parzialmente false. Quando
però sono state avanzate da Milena Gabanelli, dunque da una fonte autorevole e
super partes, il leader dell'Italia dei Valori è stato travolto. Ovvero il frame
Gabanelli ha scacciato il frame Di Pietro sul terreno su cui entrambi si erano
costruiti la reputazione, quello dell'onestà.
GLI INFLUENCER.
“Influencer”: chi sono e
cosa fanno,
scrive Stefano Gallon il 15 Settembre 2014 su social-media-expert.net. Figure
talmente importanti da poter ormai parlare di “Influencer Marketing”, ma
esattamente chi sono? E cosa fanno? Un influencer è un utente con migliaia (se
non milioni) di seguaci sparsi sui vari social network; può essere uno YouTuber,
un Instagramer, un blogger o avere semplicemente una pagina su Facebook dove
condivide foto, video e contenuti vari. Fin qui è come un qualsiasi utente nella
rete, ma a differenza degli altri, l’Influencer è in grado letteralmente di
influenzare i suoi followers.
Il ritratto di un influencer.
Su “chi è” l’influencer e “cosa fa” c’è al momento molta confusione, sia da
parte delle azienda che li cercano, che da parte di chi vede tutto questo come
un lavoro (è noto infatti che gli influencer guadagnano molto). Riassumendo:
L’influencer può
essere YouTuber, un Instagramer, un blogger (o simili);
Deve avere moltissimi
followers;
Crea contenuti in grado di
generare moltissime interazioni;
Viene considerato “Credibile”
e “Affidabile”;
L’elemento più importante e
quasi consequenziale di tutto questo è che l’Influencer è letteralmente in grado
di influenzare chi solo segue, grazie non solo alla sua notorietà, ma anche alla
sua “Neutralità” e “affidabilità”. In poche parole, se un grande YouTuber che
seguite vi consiglia di vedere un film e voi lo fate, vi ha influenzato, ma se
lo stesso YouTuber lo ha fatto perché pagato dalla casa di produzione, allora
non è più un influencer, diventando di fatto un Ambassador.
Esperti, giornalisti, VIP e
non… Gli Influencer non sono solamente personaggi nati sul web, spesso possono
essere anche giornalisti o esperti di settore che, con i loro post, sono in
grado di offrire enorme visibilità a notizie, video, prodotti o servizi,
determinandone anche il successo o un fallimento. Ma c’è un’altra categoria che
pur non avendo alcuna competenza specifica, può rivelarsi incredibilmente utile
per promuovere qualsiasi business: i VIP. Alcuni personaggi dello spettacolo
infatti, come cantanti, attori, attrici, speaker e presentatori, hanno un enorme
numero di persone che legge qualsiasi cosa scrivano sui social network, come per
esempio accade per lo Zoo di 105 (che seguo da sempre). Se vai a visitare la
loro pagina Facebook, Instagram o Twitter vedrai come ricevano commenti, like e
condivisioni per qualsiasi cosa. Adesso prova a pensare se gli speaker dello Zoo
di 105 parlassero di te sui loro social network, quanta pubblicità avresti?
Naturalmente questo è solamente un esempio ma spero che il senso sia chiaro.
Perché investire
nell’Influencer Marketing. Coinvolgere gli influencers significa avere una
pubblicità enorme ad un costo bassissimo, soprattutto se restiamo in un target
specifico. Gli influencers hanno un rapporto reale con i propri seguaci che
seguono i consigli dei propri beniamini e sono molto interessati a quello che
condividono sui proprio social.
Dal Passa-Parola al “Click to
Click”. Il buon vecchio metodo del passa-parola non è mai finito, si è solo
evoluto nel “Click to Click”. Adesso infatti quando un argomento va di moda, ne
parlano su Facebook, Twitter, Instagram, realizzano parodie su YouTube, scrivono
articoli su blog e creano ovviamente hashtag tematiche.
Un Influencer è come un amico.
Facciamo un esempio. Quando devi fare un viaggio in un altro paese, chiami i
tuoi amici per avere consigli sul posto che visiterai, li chiami perché ti fidi.
L’influencer per l’utente medio diventa proprio questo, una persona di fiducia,
perché col tempo ha saputo guadagnarsi il rispetto dei suoi followers. Adesso
hai capito perché è importante il loro parere? Allora adesso quando progetterai
la tua nuova campagna pubblicitaria, non tralasciare l’influencer marketing.
Come Star Nel Web. Lunedì 9
ottobre 2017 sono stato ospite in diretta della trasmissione FUORI Tg su Rai 3,
per la puntata intitolata “Come star nel web”. Durante la trasmissione ho avuto
modo di trattare il delicato argomento degli influencer, affrontato anche dal
Sociologo dei Media – Università Carlo Bo di Urbino – Professor Boccia Artieri.
Durante la trasmissione (che dura poco più di 20 minuti) troverete importanti
spunti di riflessione sul tema.
Quando gli influencer danno
i numeri: statistiche e guadagni,
scrive Stefano Gallon l'11 Ottobre 2017 su social-media-expert.net. Sapere
quanto guadagnano gli influencer e quanto sia veramente efficace la loro
comunicazione non è semplice. Youtubers, Blogger e Instagramers infatti sono
(giustamente) molto riservati sul proprio lavoro e sui loro guadagni, anche
anche perché il loro mestiere è complesso e molto competitivo.
Il lavoro di influencer:
facciamo chiarezza. Scrivo questo paragrafo perché mi hanno spesso richiesto
consulenze per “Diventare influencer” o per “Guadagnare come influencer”. Quello
che rispondo a tali richieste è che a mio parere, sono sbagliate in partenza.
Gli influencer sono Youtubers, Bloggers e Instagramers con un enorme numero di
followers, con i quali sono realmente in grado di interagire e di influenzarne
le opinioni o gli acquisti. L’influenza di questi personaggi è dovuta a diversi
fattori, tra cui c’è sicuramente la loro affidabilità e credibilità. Per fare un
esempio pratico, se un famoso YouTuber consiglia di vedere un film, saranno in
molti i suoi seguaci che lo andranno sicuramente a vedere. Se si venisse a
sapere che lo YouTuber in questione è stato pagato dalla casa di produzione per
consigliare il film, ecco che la sua “imparzialità” potrebbe venir meno.
Le aziende non devono pagare
gli Influencer. Riassumendo in poche righe il paragrafo precedente si può
semplicemente dire che un vero influencer non deve essere pagato dalle aziende,
altrimenti perderebbe la sua ragion d’essere. Quando uno YouTuber o un blogger,
in grado di “influenzare”, vengono pagati e coinvolti in una campagna web
marketing, devono essere definiti “Ambassador” e non “influencer”.
Quanto guadagnano le “Web
Star”. Abbiamo parlato di influencer, ambassador, youtuber e quant’altro, ma in
generale, queste figure in grado di vantare un enorme numero di Followers (e non
solo), vengono definite anche “Web Star”, e un loro post può valere diverse
migliaia di euro. Non è facile avere dati precisi sui loro guadagni, ma
personalmente ritengo questa ricerca dell’Economist abbastanza attendibile.
Questa è una stima di quanto
prendono per singolo post i base alla loro popolarità:
Youtube: guadagno medio per
video in base al numero dei followers
100k-500k: 12,500
dollari
500k-1m: 25.000
dollari
1m-3m: 125.000 dollari
3m-7m: 187.000 dollari
Oltre 7m: 300.000 dollari
Facebook: guadagno medio per
post in base al numero dei followers
100k-500k: 6.250
dollari
500k-1m: 12.500
dollari
1m-3m: 62.500 dollari
3m-7m: 93.750 dollari
Oltre 7m: 187.500 dollari
Instagram: guadagno medio per
post in base al numero dei followers
100k-500k: 5.000
dollari
500k-1m: 10.000
dollari
1m-3m: 50.000 dollari
3m-7m: 75.000 dollari
Oltre 7m: 150.000 dollari
Twitter: guadagno medio per
singolo post in base al numero dei followers
100k-500k: 2000
dollari
500k-1m: 4000
dollari
1m-3m: 20.000 dollari
3m-7m: 30.000 dollari
Oltre 7m: 60.000 dollari
Gli Influencer più seguiti sui
social media in Italia
fonte audisocial.it
Di seguito riporto le
classifiche riguardanti gli influencer più seguiti in Italia.
Classifica generale: Gianluca
Vacchi, Chiara Ferragni, Mariano di Vaio.
Youtube:Favij,
Ipantellas, Ghali, St3pny.
Facebook: Mariano di Vaio,
Frank Matano, Fatto in casa da Benedetta, ludovia Comello, Veronica Ferraro.
Twitter: Ludovica Comello,
Selvaggia Lucarelli, Sofia Viscardi, Greta Menchi, Leonardo Decarli.
Instagram: Gianluca Vacchi,
Chiara Ferragni, Mariano di Vaio, Giorgia Gabriele, Favij,
Fashion: Chiara Ferragni,
Mariano di Vaio, Veronica Ferraro, Martina Corradetti, Valentina Vignali.
Come indicato sul sito di
Audisocial, le classifiche generate dal loro sistema non tengono conto dei
personaggi che, per così dire, non sono “nati” su internet (ma provengono da
altri settori come il mondo dello spettacolo), o che non utilizzano la lingua
italiana come principale.
Quanto guadagno i Top
influencer italiani. Dopo aver raccolto diverse informazioni a riguardo ho
deciso di non trascriverle, neanche citando le fonti, per i seguenti motivi:
Non esistono mezzi per sapere
con precisione quanto guadagna un influencer;
Diffondere dati a riguardo
potrebbe lasciare il tempo che trova;
Basta fare una ricerca su
Google per trovare centinaia di pagine sull’argomento.
Le cifre che girano
sull’argomento sono diverse, come i 10 milioni di utili dichiarati nel 2015 da
Chiara Ferragni o come i classici “20mila” euro al mese usati come punto di
riferimento per le web star “Più ricche”. Un top influencer può guadagnare
molto, su questo non c’è dubbio e non lo negano neanche loro, ma è anche vero
che tutta la loro fama, e le loro entrate possono svanire molto rapidamente.
Bloggers, Youtubers (etc) più intelligenti e lungimiranti infatti, non appena
raggiunta una certa stabilità, iniziano a diversificare la propria attività,
proponendo contenuti diversi ma anche lavorando in ambienti diversi. Non per
niente oggi si vedono personaggi nati sul web fare tv, radio, cinema o musical.
Come Guadagno i Top
Influencer. Anche su questo punto, per ovvi motivi, non c’è molta trasparenza,
ma sicuramente possiamo dire che i Top Influencer, quando non lavorano come
Ambassador, guadagnano soprattutto da sistemi come Google Adsense. Alcuni di
loro (anche se qui la situazione non è chiara) possono essere pagati anche per
presenziare a determinati eventi a tema.
Diventare Influencer.
Ovviamente leggendo cifre come 20mila euro al mese, sono sempre di più le
aspiranti web star che sognano di diventare ricche e famose. La realtà dei fatti
però è che lavorare su internet e guadagnare creando contenuti (foto, video,
etc) è veramente complesso. Se il vostro obiettivo è questo, per prima cosa
dovete aver ben chiaro che essere (per esempio) uno Youtuber è un vero e proprio
lavoro, e che pertanto non bastano 2 ore al giorno. Una volta compreso l’impegno
che necessita questo lavoro, dovete iniziare a studiare argomenti come la
comunicazione digitale, il web design, SEO, programmazione, fotografia,
montaggio video e qualsiasi altra materia che pensate possa esservi utile per
iniziare questa nuova professione.
Un Consiglio… puntate una
nicchia. Come scritto in precedenza, per diventare influencer bisogna impegnarsi
e studiare molto, come se si volesse avere successo in qualsiasi altro settore.
Un consiglio però che mi sento di dare a tutti (e che riguarda anche le aziende)
è di non iniziare puntando troppo in alto. Portando un esempio pratico, se
volete diventare un travel blogger di successo, di quelli che parlano di tutto
il mondo, dovete faticare moltissimo e sarà molto difficile raggiungere il
vostro obiettivo. Se invece abbassate il tiro, cercando di diventare (per
esempio) un travel blogger specializzato sulla Tanzania, puntando ad una nicchia
specifica, avrete più possibilità di successo.
Perché le aziende amano gli
influencer. Le aziende sono sempre più alla ricerca di influencer in grado di
aumentare la visibilità e le vendite. Gli influencer (o almeno alcuni di loro)
hanno possono raggiungere anche milioni di persone sul web, proprio nel settore
dove oggi si concentrano gli utenti. Inoltre…Secondo i dati Audiweb aggiornati a
luglio 2017:
In Italia in 32 milioni (dai 2
anni in su) hanno navigato su internet (desktop + mobile) quasi 56 ore;
Più del 65% degli italiani ha
navigato da mobile.
Inoltre Audiweb certifica che
i contenuti web, in Italia, vengono sempre più visionati da smartphone o tablet.
Ogni giorno le persone si collegano mediamente circa 2 ore e mezza. In un mese
la digital audience conta circa 32 milioni di utenti. Con questi numeri è
semplice capire perché le aziende sono sempre più alla ricerca di figure
influenti.
Perché le aziende odiano gli
influencer. “Odio” è sicuramente una parola forte, che uso per evidenziare una
sorta di antipatia che spesso viene manifestata nei confronti di bloggers,
youtubers, etc. Non si parla molto di questo argomento ma nel “Sottobosco” della
rete, si sente spesso parlare di come le aziende non abbiano fatto i salti
giogia quando hanno capito che il successo di un capo di abbigliamento o di un
brand poteva essere deciso un un personaggio “Nato all’improvviso sul web”.
Sinceramente credo che il problema sia che in molti si rifiutano di riconoscere
la grande professionalità dell web star, e l’enorme fatica che ci vuole per
essere seguiti da milioni di persone.
L’importanza di YouTube.
YouTube è sicuramente la piattaforma social più efficace e potente per il web
marketing, molto più di Instagram e anche più di Facebook. YouTube al momento
conta 24 milioni di utenti attivi mensilmente contro I 30 milioni di Facebook,
in Italia, mentre nel mondo ne conta un miliardo contro I 2 del social di
Zuckerberg, ma sono altri I numeri di YouTube che fanno venire le vertigini. Nel
2016, la piattaforma di video più frequentata del mondo, ha potuto vantare circa
un miliardo di ore al giorno di visualizzazioni video, ma sono oltre 400 le ore
di video che vengono caricate ogni giorno, e gli YouTuber più seguiti hanno dai
20 ai 60 milioni di iscritti ai propri canali. Non a caso uno degli influencer
più pagati al mondo, PewDiePie, ha fatto la sua fortuna proprio su YouTube.
Conclusioni. Dopo aver letto
questo articolo ne saprete sicuramente di più sui numeri degli influencer, dei
social network e di internet in generali. Un ultimo consiglio che vi voglio però
dare riguarda proprio questo: i numeri, un aspetto al quale non dovete dare
troppa importanza. Ricordate che su internet ci sono persone reali, e se volete
diventare dei veri influencer, dovete instaurare delle vere interazioni con
loro. Quindi non pensate solo ad aumentare il numero dei vostri followers,
pensate anche ai like, ai commenti e alle interazioni in generale che ricevete.
Gli influencer? Studio
rivela: sono «virali» come le epidemie.
Una ricerca spiega come si propagano i messaggi diffusi da figure-chiave della
rete e aiuta a prevedere chi potrebbe essere il prossimo «untore». Ma una volta
avviata la comunicazione «virale», l’influencer non ha più il controllo della
sua propagazione, scrive Antonella De Gregorio il 30 gennaio 2018 su "Il
Corriere della Sera". Blogger, youtuber, instagrammer: sono loro gli idoli della
rete. Incisivi, comprensibili dalle masse, capaci di veicolare messaggi che
diventano universali attraverso una foto, un pensiero (spesso minimo), un brano
musicale. In comune non hanno solo la capacità di entrare in contatto con
milioni di utenti: sono anche una particolare, efficacissima categoria di
«untori». Così (all’incirca) li classificano alcuni ricercatori dell’Università
delle Isole Baleari, che sullo European Physical Journal hanno pubblicato uno
studio che dimostra come i messaggi diffusi da alcuni influencer si propaghino
esattamente come un’epidemia. Come nelle epidemie - sostengono i ricercatori del
gruppo guidato da Byungjoon Min - anche le informazioni iniziano a diffondersi
partendo da singoli individui. Ecco perché, per individuare una Chiara Ferragni,
stella di Instagram, un Fvij, star di Youtube, un Mariano Vaio (modello e
fashion blogger) - influencer di successo sulla rete e i social network - si
possono usare i modelli matematici con cui si analizza la diffusione dei virus
in un’epidemia.
Il modello. Gli studi fatti
per classificare l’impatto di ogni «influencer», non hanno avuto sinora grande
successo perché - spiegano i ricercatori - non hanno preso in considerazione le
dinamiche di diffusione. Ora invece si è scoperto che è possibile trovare gli
influencer o «diffusori» di virus più importanti in modo analogo a quanto si
riscontra in una rete dalla struttura ramificata, in cui è possibile calcolare
la dimensione probabile di un’epidemia partendo da un singolo diffusore. È
bastato - spiegano gli studiosi - esaminare il problema dalla prospettiva della
trasmissione del messaggio e affidarsi al modello «Sir» (che sta per
Suscettibili, infetti e rimossi), usato per spiegare la crescita e decrescita
del numero di persone colpite dal virus durante un’epidemia. Seguendo questa
proceduta, i ricercatori hanno ottenuto una mappa precisa di come viene
trasmesso il singolo messaggio tra i membri della rete, scoprendo che la
probabilità che scoppi un’epidemia è strettamente legata al punto di partenza in
cui si trova il «diffusore», o influencer. Una volta che la comunicazione
«virale» è iniziata, l’influencer non invece ha più alcun impatto nel
controllare le dimensioni che l’epidemia potrà assumere.
Gli influencer più efficaci.
Le applicazioni di questa teoria, che può essere usata anche su reti più
ramificate, vanno dal marketing virale a strategie efficienti di immunizzazione,
oltre all’identificazione degli influencer più efficaci. Quelli più utili, per
esempio, per instaurare un forte legame tra il personaggio e un brand che viene
«raccontato» attraverso le immagini e i pensieri postati.
Signori (& signore) della
critica in Rete.
Ecco chi sono, come lavorano e quanto fanno vendere i nuovi recensori digitali,
scrive Stefania Vitulli, Domenica 18/02/2018, su "Il Giornale". «All'evento in
diretta su Facebook per l'uscita di Bacio feroce di Saviano ci hanno chiamati in
25. Quattro o cinque che si occupano solo di libri, gli altri erano webstar,
gente da uno o due milioni di follower, come Sofia Viscardi o Michele Bravi. Era
pieno di questi sedicenni superattrezzati con le telecamerine: mi sono sentita
vecchia». Giulia Ciarapica, book blogger, ma anche «giornalista analogica», ha
28 anni e di social se ne intende, ma la rete va così rapida che supera persino
quelle come lei. Per fermare alcuni concetti chiave ha deciso allora di scrivere
un saggio, manuale e mappa aggiornata per orientarsi nel mondo della critica
letteraria 2.0: Book blogger. Scrivere di libri in Rete: come, dove, perché
(Franco Cesati, pagg. 144, euro 12). Dentro ci sono prima di tutto i nomi. Dei
pionieri del blog letterario, come Carmilla, Lipperatura, Vibrisse,
Minima&Moralia. Delle nuove leve, come Doppiozero, Libreriamo, Piego di Libri,
Flanerì. Dei grandi spazi social di promozione come Anobii, Bookcrossing o
Goodreads, degli account twitter come Twletteratura, Lucia Libri, Modusvivendi,
delle pagine Instagram come Petunia Ollister o Vicolostretto o dei profili
Facebook come Letteratitudine, Pausa Caffè, Nuvole d'inchiostro. «In rete c'è
concorrenza, anche se ci aiutiamo e ci promuoviamo tra noi. Però prima di tutto
vorrei dire che cosa non siamo: non siamo influencer - spiega la Ciarapica - Non
scriviamo Che bello questo libro per avere un milione di like. I like ci
servono, ma per promuovere la lettura, non per fare tendenza. Scriviamo
recensioni non prezzolate per promuovere titoli in modo indipendente». I
recensori digitali sono cani sciolti che sanno fare tutto da soli: scrivere,
tagliare, titolare, calibrarsi il tono di voce a seconda di tema e target,
valutare editori e autori e saperci tenere rapporti equilibrati, fare video e
foto professionali, condividere all'ora giusta della giornata (a pranzo e dopo
le 18.30) e scegliere chi taggare, «per non sembrare un poveraccio che cerca la
visibilità a tutti i costi». I più bravi sanno fare i numeri e i numeri sono una
delle grandi novità: per la prima volta gli editori sanno chi e perché smuove
copie in libreria o porta gente alle presentazioni. «Il mio blog, Chez Giulia,
non è supportato da pubblicità e ha una media di 40mila lettori - commenta la
Ciarapica - Ma ci sono blog quotati che fanno anche duemila visualizzazioni
all'ora ogni giorno per articolo e scrivono quattro articoli a settimana, con
una piccola redazione interna». Alcuni fanno vendere davvero: Modus Legendi, ad
esempio, nato dall'unione di lettori forti, chiede ai follower di comprare entro
un certo tempo il libro preferito in una cinquina proposta sul sito e due anni
fa portò in classifica Neve, cane, piede (Exorma) di Claudio Morandini. Mentre i
big come Rizzoli e Mondadori fanno ancora fatica a entrare nella logica, gli
editori indipendenti e medi danno ai blogger la stessa credibilità dei media
tradizionali. «Creano un contenuto che noi usiamo nei lanci, nelle
presentazioni, sui nostri siti. Sembra paradossale, ma i contenuti digitali
restano, non svaniscono come la carta stampata, e innescano un circolo virtuoso
- ci conferma Alice di Stefano di Fazi - I lettori si affezionano alle blogger
la maggior parte sono donne e si affidano ai loro giudizi: Anna Giurickovic Dato
è stata adottata dalle blogger e ha fatto il botto. Ora vanno molto i blog tour:
al lancio di un libro, i blog si mettono insieme e si dividono gli argomenti da
trattare, uno parla solo dei personaggi, un altro della trama. Su Twitter si
riportano frasi dai libri e si fanno andare in tendenza: La manutenzione dei
sensi di Franco Faggiani è stato in lettura condivisa per una settimana.
L'autore? Noi suggeriamo che interagisca, ma non possiamo forzarlo. L'età? Non
conta: Faggiani ha 69 anni e in rete è bravissimo». Gli autori più bravi on line
sono social perché a loro piace, non perché sono scrittori: «Uso la rete come
gruppo di lettura condiviso: chi vive nei paesini reconditi d'Italia si collega,
posta le frasi di un libro amato e si sente meno solo, meno fuori moda, meno
marginale» chiarisce Nadia Terranova, autrice Einaudi e Mondadori, blogger,
quasi 9mila follower su Twitter.
Attenti però: la nuova critica
letteraria ci tiene alla propria indipendenza e non va costretta né
condizionata. La relazione che le blogger o le youtuber creano coi propri
seguaci si basa su libertà e spontaneità nella condivisione: «I miei video
funzionano perché uso Youtube come motore conversazionale - ci spiega Ilenia
Zodiaco, 25 anni, quasi 42mila iscritti al suo canale e oltre 5 milioni di
visualizzazioni totalizzate dal 2011 - Le persone hanno l'impressione di parlare
con un conoscente, instaurare un rapporto diretto e cancellare il mezzo grazie a
un'informalità di fondo. La libreria è un luogo deputato che - specie a chi non
legge e ha già un complesso di inferiorità - fa paura. Nei social invece è come
se la lettura venisse normalizzata. Valuto il mio successo anche attraverso
l'affiliazione con Ibs e Amazon, in base ai libri che vendo dal link diretto
alle mie recensioni. Il massimo l'ho raggiunto con 4321 di Paul Auster: trecento
copie. Ai critici tradizionali consiglio umilmente di provare a risultare più
comprensibili e meno autoreferenziali». Ma chi sono i critici tradizionali?
Massimo Onofri, saggista e professore ordinario di Letteratura italiana,
collaboratore dell'Indice, Avvenire, La Stampa, consulente editoriale, sembra
corrispondere al profilo. Eppure anche lui riserva sorprese digitali: «Ho
scritto i miei ultimi due libri per La nave di Teseo Benedetti Toscani e
Isolitudini, di prossima uscita interamente su Facebook. Mi affascina la
conferma del lettore e il suo contributo alla documentazione, come in un
seminario. Ferma restando la compiutezza formale: sul web scrivo al massimo
delle mie possibilità stilistiche. In rete ho scoperto autori, come Carmen
Pellegrino, che ho stanato quando scriveva di paesi abbandonati. La rete è
implicitamente democratica: intavolare discussioni letterarie sul web è un atto
inclusivo che potenzia l'intelligenza. Ciò non toglie che le gerarchie del mondo
reale si ristabiliscono presto: se uno ha autorevolezza lo commentano, se un
coglione fa la sua defecazione non se lo fila nessuno». Ma fare il critico on
line è o non è un vero lavoro? «Eccome. Può portarti via anche otto ore al
giorno, se lo fai seriamente - chiude la Ciarapica - Ai commenti devi rispondere
subito, per cui spesso non puoi seguire altro. Devi essere competente sulle
logiche del confronto, perché lo spessore di una persona si vede anche da un
cinguettìo. E devi avere una formazione critica di base, se no alla lunga
fatichi a distinguerti. Però ne vale la pena: sul Messaggero non posso mettermi
a fare la critica all'Arbasino, invece sul mio blog certe libertà me le posso
concedere».
Il Paese che non ama,
scrive Mauro Munafò il 14 febbraio 2018 su "L'Espresso". Questo post di Di Maio
dimostra il dominio del Movimento 5 Stelle su Facebook (gli altri partiti
prendano nota). La foto che c'è all'inizio di questo post vi è familiare?
Dovrebbe perché, da quanto mi risulta, è il contenuto politico più visto almeno
dell'ultimo anno sul Facebook italiano. Un record i cui numeri ancora sono in
crescita e che, al momento di scrittura di questo post, significa 115mila
condivisioni e più di 137mila azioni tra like e faccine e circa 20mila commenti.
Si tratta del post con cui Luigi Di Maio, capo politico e candidato premier del
Movimento 5 Stelle, spiega a Filippo Roma come il movimento che guida intende
affrontare il caso dei rimborsi che gli eletti pentastellati hanno bonificato e
poi annullato. Un caso scoperchiato dal programma di Italia 1 Le Iene che sta
occupando prime pagine e Tg e rappresenta un importante banco di prova per Di
Maio stesso per dimostrare la sua capacità di direzione. Quante persone hanno
visto questa foto? Non posso dirlo con certezza (solo l'amministratore della
pagina di Luigi Di Maio lo sa). Ma incrociando i dati su post simili condivisi
da altre pagine politiche, possiamo stimare una cifra di persone raggiunte non
inferiore a 4-5 milioni. (Edit: l'ufficio stampa di Di Maio mi comunica che
hanno superato le 10 milioni di persone raggiunte). Sì, circa 10 milioni di
persone sono state raggiunte direttamente e senza intermediazione alcuna dal
messaggio di Luigi Di Maio. Ora, non è questo il luogo per discutere sulla
questione in sè: non importa cosa ne pensiate del caso rimborsi del M5S. Quello
su cui voglio concentrarmi in questo articolo è la potenza mostrata dai 5 Stelle
nell'uso dei social network: una potenza che nessun'altra forza politica
italiana è in grado di schierare. La forza dei 5 Stelle infatti si fonda sulla
presenza di decine di pagine legate ai diversi eletti con decine di migliaia di
fan ciascuna, a cui si aggiunge un nutrito sottobosco di pagine e gruppi più o
meno ufficiali. Dal mio personale monitoraggio che tengo per l'Espresso, risulta
che sulle 20 pagine politiche con più fan, 8 risultano legate a esponenti del
Movimento. Sulle prime 5, ben 4 sono dell'universo pentastellato. Perché questo
è importante? Semplice. La pagina con più fan e maggiore portata politica in
Italia è quella di Matteo Salvini, che ha da poco superato Beppe Grillo oltre la
quota dei due milioni di like. Ma il vantaggio di Di Maio e soci è legato
all'effetto rete: il post con la Iena di cui parliamo, infatti, mi risulta
essere stato condiviso da almeno 40 importanti pagine della galassia 5 Stelle:
da Grillo ad Alessandro Di Battista fino a quelle degli esponenti meno noti ma
con un loro seguito comunque importante. L'algoritmo di Facebook che determina
cosa vedete sulla vostra pagina tende a privilegiare i contenuti che sono stati
condivisi da più pagine e contatti che seguite. Quindi se Di Maio scrive una
cosa e Beppe Grillo la condivide, e se voi avete i like a entrambe le pagine
(cosa piuttosto probabile se siete fan del Movimento), la probabilità che voi
vediate quel contenuto si moltiplica. Quando Di Maio parla di "effetto
boomerang" per i partiti che stanno cercando di cavalcare il caso dei rimborsi
dei 5 Stelle per screditarli si riferisce quindi anche a questo: non conta
quanti tg, siti o giornali tratteranno la notizia. Lui oggi è in grado di
raggiungere direttamente milioni di potenziali elettori a cui fornirà la sua
versione dei fatti senza filtri e senza dubbi. Un potere, legittimo sia chiaro,
che in questa campagna elettorale è diventato quanto mai rilevante. E che forse
anche dalle parti del Pd dovrebbero iniziare a prendere in seria considerazione.
GLI INTELLETTUALI ITALIANI.
NON SOLO CULTURAME.
Vuoi una frase da duro?
Leggi Plutarco.
Nei suoi "Detti memorabili" trionfa l'etica militare degli spartani, scrive
Matteo Sacchi, Lunedì 05/02/2018, su "Il Giornale". Gli antichi greci li
chiamavano apoftegmi, li consideravano il sale della politica e della retorica e
amavano raccoglierli. Cosa sono? La parola viene dal verbo apophtheggomai,
«enunciare una cosa in forma definitiva», e indica una massima, spesso
pronunciata da un personaggio importante e ritenuta così brillante da meritare
di essere tramandata e riutilizzata alla bisogna. Erano davvero così efficaci?
Winston Churchill ha modellato molti dei suoi discorsi più noti pescando dai
repertori della letteratura classica greca e latina. Ora arriva in libreria il
meglio del frasario raccolto dal più grande biografo dell'antichità, Plutarco
(48 - 127 d.C.). L'autore delle Vite parallele nella sua opera principale aveva
sciolto molti di questi memorabilia linguistici nella narrazione delle esistenze
dei grandi, da Licurgo ad Antonio. Ma già allora si era accorto che il suo
pubblico ne era troppo ghiotto e decise di raccoglierle. Ecco allora spiegata la
genesi del volume che ora arriva in libreria, a cura di Carlo Carena: Detti
memorabili. Di re e generali, di spartani, di spartane (Einaudi, pagg. 234, euro
28). Mancava sino ad ora un'edizione italiana che separasse e rendesse
comodamente fruibili e confrontabili queste schegge raccolte o inventate da
Plutarco (del resto solo dall'anno scorso esiste una valida edizione
dell'insieme dei Moralia fatta da Bompiani). La prima delle tre raccolte lo
storico greco la dedicò direttamente all'imperatore Traiano, in modo che potesse
farsi consigliare dai suoi pari, i monarchi precedenti. Ma che si tratti di
questa o delle altre due, ciò che aleggia attraverso tutti i testi è il mito di
Sparta. I lacedemoni, maschi e femmine, titolati e non, la fanno da padroni. Con
accenti e toni non lontanissimi, se ci consentite un paragone molto pop, da
quelli di un fumetto fantastorico come 300 (o dell'omonimo film). Plutarco fa
della durezza spartana (che pur sapeva eccessiva) strumento didattico, la parte
di cultura greca più facilmente cucinabile in salsa romana. Del resto a quale
centurione non starebbe simpatico lo spartano Agide? «Gli spartani non vogliono
sapere quanti sono i nemici, ma dove sono». E Cleomene? A chi voleva vendergli
dei galli pronti a morire combattendo: «No davvero, dammi di quelli che
combattono e uccidono». Ad Agesilao (444 - 360 a.C.) poi vengono attribuite
frasi che farebbero la fortuna di ogni sceneggiatore hollywoodiano del genere
Swords and sandals. Alla domanda fino a dove si estendevano i confini della
Laconia rispode, brandendo la lancia: «Fino a dove giunge questa». Il consiglio
a uno spartano zoppo che vuole un cavallo per la battaglia? «Non capisci che in
guerra non serve chi fugge ma chi resiste». Ma se Plutarco è l'inventore della
Sparta che piace al cinema, leggendolo vi accorgerete che molte delle metafore
care agli umanisti, compreso il celebre binomio «Golpe et lione» di
machiavelliana memoria, sono in realtà farina degli apoftegmi dello storico
greco.
Così Verdi l'"arcitaliano"
svelò l'anima di un Paese. "Stiffelio" racconta la famiglia, "Rigoletto"
l'amore, "Falstaff" gli anziani: le sue opere sono analisi sociali,
scrive Mattia Rossi, Venerdì 16/02/2018, su "Il Giornale". Il Maestro era morto
ormai da un mese. Aveva chiesto funerali «modestissimi, senza canti e suoni. Due
candele e una croce». Eppure, il 27 febbraio del 1901, tutta Milano scese in
piazza per una sorta di secondo funerale: trecentomila persone, Arturo Toscanini
alla testa di 900 coristi e 120 orchestrali. Fu quello il saluto che l'Italia
volle dare a uno dei suoi «padri»: Giuseppe Verdi. Quella folla immensa non si
accontentò di un sobrio e dimesso addio per onorare colui nel quale, per oltre
cinquant'anni, si era riconosciuta. È proprio questo lato di Verdi, la sua
«arcitalianità», il suo essere stato acuto e incisivo osservatore e cantore del
popolo italico, che va a sondare il nuovo libro di Alberto Mattioli, critico
della Stampa nonché melomane da record (al momento ma il dato è del tutto
provvisorio conta 1.600 recite d'opera viste). E siccome dell'ennesimo solito
libro su Verdi non v'era urgenza, Meno grigi più Verdi (Garzanti, pagg. 150,
euro 16), guarda al compositore di Busseto da un'altra angolatura, «quella
dell'italiano», ovvero come «uno dei pochi intellettuali che hanno raccontato
gli italiani per come sono, e non per come si credono di essere o vorrebbero
essere». S'affaccia un nuovo volto di Verdi che, come sintetizza la
spassosissima penna di Mattioli, diventa un «Lévi-Strauss padano» che ha saputo
tratteggiare con sguardo sincero e disilluso i propri compatrioti. Meno grigi
più Verdi è, dunque, un libro più sociologico e di costume che musicologico, una
sorta di manualetto d'antropologia italica filtrata dai melodrammi del padre del
melodramma. Sotto le maschere dei personaggi verdiani, infatti, si scorge «tutta
una serie di tipi e situazioni e ambienti ricorrenti nella nostra storia e nei
nostri costumi». Prima di vedere, però, quanto sono intrise di italianità le sue
opere, occorre vedere quanto è stato italiano lui, Verdi. Illuminanti, in
questo, sono i capitoli iniziali sulla viscerale italianità dell'operista
bussetano. Il Verdi uomo: non veniva da una famiglia di scarriolanti («un
borghese orgoglioso di esserlo»), era severo, severissimo («se per qualsiasi
ragione, vera o presunta, finivi sulla sua lista nera, non ne uscivi più»); e il
Verdi politico: repubblicano, cavouriano, deputato svogliato (lo racconta egli
stesso: «I 450 non sono realmente che 449 perché Verdi, come deputato non
esiste»), liberale di destra e anticomunista («I Sinistri distruggeranno
l'Italia»), senatore del Regno (sempre svogliatissimo: «Da senatore, Verdi
brillerà solo per la sua assenza». Italianissimo). La profonda identità italica
di Verdi si tradusse, così, nelle sue opere. Ecco alcuni apici dell'italianità
verdiana: Stiffelio «svela i meccanismi della famiglia italiana più tradizionale
e omertosa»; Rigoletto «è l'opera che racconta il rapporto del maschio italiano
con le donne», «oggetto sessuale per il Duca; oggetto di amore esclusivo ma
soffocante per Rigoletto»; Violetta della Traviata è «figura classica
dell'immaginario nazionale, legato a un'idea della donna che è sempre o santa o
puttana»; Riccardo del Ballo in maschera è il «vitellone di provincia»; ne La
forza del destino, «il grand opéra dell'Italia contadina», Verdi racconta il
tempo che fu, «un'Italia provinciale, cattolica, tradizionalista, legata ai suoi
riti sociali e religiosi»; in Don Carlos si trova l'eterno dibattito dei
rapporti tra Stato e Chiesa, ovvero il coraggio di «rappresentare in maniera
così plastica la sconfitta del trono davanti all'altare»; dall'Aida parte «una
forma mentis nazionale che alla fecondità delle terre da conquistare associa
quella delle donne indigene»; l'anziano omonimo protagonista del Falstaff è
«presuntuoso, disonesto, gaglioffo, malizioso ma alla fine tenero». Insomma, tra
gli italiani ottocenteschi e quelli d'oggi non c'è molta differenza. È per
questo che Verdi deve tornare a essere a noi contemporaneo: se ciò avverrà,
tornerà ad essere quello che è, colui che «ci racconta con spietatezza e con
pietà, che ci mette a nudo, che non ci accarezza nel senso del pelo, che ci fa
le domande che tentiamo di eludere, che ci svela le ipocrisie e le
insufficienze, ma anche le generosità e le grandezze».
Quando Scelba disse: «Gli
intellettuali? È solo culturame»,
scrive Daniele Zaccaria il 16
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Le parole della rappresentante 5 Stelle contro i
ragazzi del Cinema America sono una variazione farsesca di un odio antico e
viscerale contro scrittori e artisti. In principio fu Goebbels, ministro della
Propaganda del Terzo reich, con quelle mani implacabili che mettevamo «mano alla
pistola» ogni qualvolta sentiva vibrare nella stanza la parola «cultura». Quasi
sicuramente una citazione apocrifa visto che la celebre invettiva appartiene al
commediografo tedesco Hanns Johst che l’infilò nell’opera Schlageter messa in
scena per la prima volta nell’aprile 1933, in onore del compleanno di Adolf
Hitler. La sostanza in ogni caso non cambia: l’odio viscerale per gli
intellettuali “esangui” e “manipolatori” è un tratto distintivo di ogni regime,
ma anche un (ri) sentimento che ha radici profonde, che trascende il populismo e
incombe persino sulle democrazie più moderne e collaudate come dimostrano le
parole della consigliera pentastellata Gemma Guerrini che ripropone, in forma di
farsa, l’ennesima variazione sul tema. Come non pensare al «culturame» del
democristiano Mario Scelba che nel 1949 commentò così la vittoria dell’anno
precedente contro il Fronte popolare: «La Dc non avrebbe trionfato se non avesse
avuto in sé una forza morale, un’idea motrice, che vale molto di più di tutto il
culturame di certuni». Chi sarebbero i «certuni»? I pensatori oziosi e
«vanitosi» naturalmente, creature prive di fibra e senso pratico, pifferai
magici che incantano e «distraggono» le masse con tutti i loro libri, il loro
cinema, la loro musica, la loro inutile e stucchevole attività. L’ “arte
degenerata” del nazionalsocialismo, «l’eclettismo decadente» denunciato da
Stalin, ogni epoca ha avuto i suoi pretoriani che andavano a caccia di scrittori
e artisti colpevoli di traviare il popolo. E, anche se aiuta, non c’è
necessariamente bisogno di mettere in piedi una dittatura per colpire il
bersaglio grosso. Scelba, che provò senza troppa convinzione a correggere il
tiro, difendeva a suo modo gli angusti orizzonti del piccolo borghese
“poujadista” descritto mirabilmente da Roland Barthes nelle Mythologies, una
figura «che possiede il buon senso alla maniera di un’appendice fisica gloriosa,
di un organo particolare di percezione, che stabilisce uguaglianze semplici tra
quello che si vede e quello che è: il buon senso è come il cane da guardia delle
equazioni piccoloborghesi, definisce un mondo omogeneo, al riparo da disordini e
dalle fughe del sogno, un linguaggio che implica il rifiuto dell’alterità, la
negazione del diverso». La prima descrizione dell’anti- intellettualismo nella
cultura occidentale probabilmente risale a Platone nel celebre passaggio
del Teeteto dedicato al filosofo naturalista Talete: «Mentre stava osservando le
stelle Talete guardava in alto e cadde in un fosso. Una servetta tracia si burlò
di lui, domandandogli come potesse pretendere di osservare quel che accade in
cielo se non sapeva nemmeno ciò che aveva davanti ai piedi». Ecco, l’irridente
servetta tracia, con la “testa sulle spalle” e i “piedi per terra” nel corso
della Storia ha avuto innumerevoli incarnazioni, che si tratti della santa
alleanza che voleva giustiziare l’ebreo Dreyfuss, della caccia alle streghe
nell’America maccartista o degli scrittori (Pasternak, Nabokov) fatti a pezzi
dalla censura sovietica, lo spartito da suonare non cambia. E non cambia nemmeno
la carica di violenza con cui i mazzieri si scagliano contro gli odiati
intellettuali. Rispondendo a Scelba, il critico letterario e poi deputato nonché
suo compagno di partito Luigi Russo colse proprio questo elemento di
prevaricazione: «Ha parlato di culturame, il suo linguaggio ricorda quello dei
corsari neri con il loro “scatolame” e “budellame” e dei campieri siciliani al
soldo dei latifondisti che frustavano i contadini e i braccianti chini sul
lavoro».
1972, alle urne con la
paura addosso.
Così vinse di nuovo la Dc. Storia delle grandi campagne
elettorali, il 1972 e le prime elezioni anticipate, scrive Paolo Delgado il 16
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Furono le prime elezioni anticipate nella storia
della Repubblica, anche se l’eccezione sarebbe di lì in poi diventata norma.
Quando gli elettori si recarono alle urne, il 7 maggio 1972, erano passati solo
quattro anni dalle ultime elezioni politiche, ma sembrava che fossero invece 40
e passa. La Repubblica era cambiata più di quanto fosse mai successo in
precedenza e a un ritmo tanto accelerato da seminare panico e paura. La prima
prova elettorale politica dopo il ‘ 69 operaio e un ciclo di lotte e movimenti
sociali dilagato in ogni anfratto della società era segnata dalla reazione di
chi quella trasformazione la aveva subìta in silenzio ma pieno di rancore per
chi seminava disordine. L’anno precedente, in una tornata parziale di elezioni
amministrative, il Msi di Giorgio Almirante (cioè il partito post- fascista)
aveva raggiunto risultati superiori a quelli che avrebbe toccato, oltre
vent’anni dopo, Gianfranco Fini con la sua ripulita Alleanza nazionale. Era
prevedibile e ampiamente previsto che avrebbe bissato il successone il 7 maggio.
Anche per questo, del resto, la Dc aveva brigato, cercando di non farlo vedere
troppo, per il voto anticipato. I cervelloni di piazza del Gesù, non troppo
diversi da quelli di oggi, avevano calcolato che con un anno difficile davanti
l’emorragia a favore dei nostalgici sarebbe stata ancora più probabile e
corposa. Ma le elezioni anticipate, per la verità, le avevano volute in molti e
il Pci forse più di ogni altro. In parte minima per bruciare i dissidenti
del manifesto, che miravano a portare una loro lista e, dopo le sorprese a
ripetizione degli anni precedenti nelle fabbriche nelle università e nelle
piazze, nessuno poteva dire se sarebbero stati temibili o insignificanti. Ma
soprattutto i comunisti volevano cogliere la preziosa occasione per dribblare
quel referendum sul divorzio che temevano e che avrebbero cercato di evitare,
anche a costo di svendere la sostanza della legge, sino all’ultimo. Nelle
precedenti elezioni, 1968, nonostante la rivolta degli studenti e nonostante i
primi segnali di conflittualità operaia, l’Italia era ancora un Paese
tranquillo. Passata la congiuntura di metà decennio, l’economia aveva ripeso a
tirare, le fabbriche del nord assumevano a valanga giovani meridionali, le
occupazioni e gli scontri tra studenti e polizia turbavano, già, ma nemmeno
troppo. L’Italia del ‘72 era quella della bomba di piazza Fontana e della
montatura anarchica contro Pietro Valpreda, il ballerino anarchico che stava in
galera da oltre due anni mentre il castello di accuse contro di lui si
sgretolava travolgendo anche la credibilità dello Stato. Era un paese dove i
morti in piazza erano tornati a essere frequenti. Era il paese del tentato
golpe- Borghese e della più lunga rivolta metropolitana nella storia italiana e
probabilmente europea, quella di Reggio Calabria, gestita dai neofascisti anche
per l’assenza della sinistra storica. In quattro anni la sicurezza aveva scalato
la classifica dei problemi più avvertiti dagli elettori e il Msi ci lucrava
sopra con perizia. I neofascisti facevano il possibile per fomentare gli scontri
di piazza. Il partito d’ordine da cui gli stessi neofascisti provenivano si
offriva come cura. E il gioco sembrava funzionare. I democristiani puntavano
invece sulla parola d’ordine degli “opposti estremismi”, giusto per riproporre
in chiave adeguata ai tempi selvaggi il proprio eterno ruolo di centro e perno
non solo del sistema politico ma dell’intero assetto sociale. Ma ad alimentare
paure che poi si concentravano sul tema facile della legge e dell’ordine non
c’era solo la violenza di piazza. L’economia segnava pesantemente il passo. La
sonnolenta e immobile stabilità politica degli anni ‘ 60 era un lontano ricordo.
Esaurita di fatto la formula del vecchio centro- sinistra, tanto più dopo la
scissione del Partito socialista unificato che aveva per qualche anno tenuto
insieme i socialisti e i socialdemocratici, la Dc non riusciva né a resuscitare
un nuovo centrosinistra né poteva allargare a destra con il Pli. Il Pci era
appena uscito da un lungo interregno, nel quale Enrico Berlinguer, segretario in
pectore, aveva guidato il partito al posto del malato Luigi Longo ma senza la
legittimazione della segreteria ufficiale. Nominato meno di due mesi prima del
voto, non era pronto per lanciare una campagna politica in grande stile. Il suo
“compromesso storico” sarebbe piombato sul Paese solo l’anno seguente.
Quell’anno la vera campagna elettorale non la fecero i leader politici ma le
piazze, esaltando qualcuno, spaventando molti. L’ 11 marzo a Milano un corteo
della sinistra extraparlamentare finì con scontri violenti, un attacco alla
redazione del Corriere della Sera e un passante, il pensionato Giuseppe
Tavecchio ammazzato da un candelotto lacrimogeno sparatogli sul collo. Capolista
del manifesto era il nome che quasi tutta l’Italia aveva associato prima al
mostro per antonomasia e poi sempre più all’emblema del perseguitato: Pietro
Valpreda, accusato a bomba ancora calda della strage di piazza Fontana, era
uscito di galera dopo oltre due anni in gennaio, per problemi di salute e
soprattutto grazie a una legge, quella che portava il suo nome, che per la prima
volta limitava la custodia cautelare anche per i reati gravi. Però rischiava di
rientrare in galera e per questo il manifesto cercò di fargli scudo con
l’immunità parlamentare. Il 14 marzo, a camere già sciolte, uno sconosciuto
venne trovato morto sotto un traliccio che si apprestava a far saltare, ucciso
dalla sua stessa bomba. Era uno degli uomini più famosi d’Italia, l’editore
miliardario e rivoluzionario comunista Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dei
Gap. Lo shock fu enorme e colpì a destra e a manca, anche perché molti,
sbagliando, ci videro dietro lo zampino omicida dei servizi segreti. C’era chi
si spaventava per i bombaroli rossi e chi per gli spioni di Stato neri. Quella
del 1972 è stata la campagna elettorale più cupa, persino più di quella di sette
anni dopo, nel pieno dell’offensiva terrorista. Gli elettori moderati e
conservatori, che magari non sfilavano sotto le bandiere della neocostituita
“maggioranza silenziosa”, un omaggio a Nixon che quello stesso anno stravinse in
America, ma ne facevano parte erano da poco approdati in un continente nuovo e
inospitale, quello della paura e dello smarrimento. La conclusione fu tragica.
Il 5 maggio a Pisa, durante gli scontri tra polizia e sinistra extraparlamentare
che cercava di impedire un comizio del Msi, un giovanissimo anarchico, Franco
Serantini, fu pestato dalla Celere. Morì due giorni dopo mentre il 93% degli
elettori affollava le urne. La Dc tenne alla grande, perdendo meno di mezzo
punto. Il Msi raddoppiò i consensi, ma fu un successo effimero. Il Pci restò
fermo. Il manifesto invece rimase fuori del parlamento, insieme al Psiup e a
un’altra lista cattolica di sinistra guidata dall’ex presidente delle Acli.
Quarant’anni fa, il 16 maggio
1974, Pier Paolo Pasolini scriveva sul Corriere della Sera uno dei suoi
editoriali che ancora oggi restano nell’immaginario continuando a farci
interrogare sul cuore del "caso italiano", scrive Luciano Lanna su "Le cronache
del garantista". Il tema era oggettivamente pasoliniano: "Il fascismo degli
antifascisti". E il ragionamento che il poeta vi svolgeva era la continuazione
di quanto andava spiegando da oltre un mese, a cominciare dall’editoriale "Gli
italiani non sono più quelli", del 10 giugno, a quello su "Il potere senza
volto", del 27 giugno, sino alle note riflessioni sulla rivoluzione
antropologica e l’omologazione in Italia, dell’il luglio. Si tratta di alcuni
degli articoli che verranno poi raccolti in un libro nel novembre 1975
nell’ultima opera pubblicata in vita da Pasolini: Scritti corsari. In tutti
quegli articoli l’autore denunciava il fatto che nessuno in Italia si mostrava
in grado di comprendere quanto stava realmente accadendo: «Una mutazione della
cultura italiana, che si allontana tanto dal fascismo che dal progressismo
socialista». In realtà, precisava Pasolini, era in atto un fenomeno devastante e
inarrestabile di mutazione antropologica conseguente alla trasformazione del
sistema di Potere: «L’omologazione culturale che ne è derivata riguarda tutti:
popolo e borghesia, operai e sottoproletari. Il contesto sociale è mutato nel
senso che si è estremamente unificato. La matrice che genera tutti gli italiani
è or- mai la stessa…». Sino al passaggio più importante: «Non c’è più dunque
differenza apprezzabile, al di fuori di una scelta politica come schema morto da
riempire gesticolando, tra un qualsiasi cittadino italiano fascista -e un
qualsiasi cittadino italiano antifascista. Essi sono culturalmente,
psicologicamente e, quel che è più impressionante, fisicamente,
interscambiabili…». E anche guardando ai giovani che in quel 1974 si chiamavano
e venivano definiti "fascisti", Pasolini spiegava che si trattava di una
definizione puramente nominalistica e che portava fuori strada: «È inutile e
retorico – concludeva fingere di attribuire responsabilità a questi giovani e al
loro fascismo, - nominale e artificiale. La cultura a cui essi appartengono è la
stessa dell’enorme maggioranza dei loro coetanei». Il problema, semmai, era il
nuovo Potere, non ancora rappresentato simbolicamente e dovuto alla omologazione
della classe dominante, il quale stava omologando la società italiana. Si
trattava – annotava preoccupato Pasolini – di un una omologazione repressiva,
pur se ottenuta attraverso l’imposizione dell’edonismo e della joie de vivre». E
la strategia della tensione ne era a suo avviso una spia significativa che ne
svelava l’altra faccia della medaglia…Pasolini insomma, in totale controtendenza
rispetto agli altri intellettuali suoi contemporanei, invitava a cogliere e
contrastare il volto disumano del nuovo potere piuttosto che a rimuovere il
problema rispolverando un antifascismo fuori contesto e fuori tempo massimo. «E
bisogna avere il coraggio – aggiungeva – di dire che anche Berlinguer e il Pci
hanno dimostrato di non aver capito bene cos’è successo nel nostro paese negli
ultimi dieci anni». Perché infatti, si domandava il poeta, rilanciare trent’anni
dopo la fine della guerra e del fascismo un’offensiva antifascista (che
oltretutto portava fuori strada) invece di aggredire dalle fondamenta il nuovo
potere senza volto, magari con le sembianze di una società democratica e di
massa, «il cui fine è riorganizzazione e l’omologazione brutalmente totalitaria
del mondo»? E in questo passaggio Pasolini aggiungeva un’autocritica inedita e
importante: «In realtà – confessava ci siamo comportati coi fascisti (parlo
soprattutto di quelli giovani) razzisticamente. Non nascondiamocelo: tutti
sapevano, nella nostra vera coscienza, che quando uno di quei giovani decideva
di essere fascista, ciò era puramente casuale, non era che un gesto, immotivato
e irrazionale… Ma nessuno ha mai parlato con loro o a loro. Li abbiamo subito
accettati come rappresentanti inevitabili del Male. E magari erano degli
adolescenti e delle adolescenti diciottenni, che non sapevano nulla di nulla…».
Chissà quanto si sarebbe scongiurato di quanto è avvenuto dopo in termini di
messa in moto dell’antifascismo militante, della conflittualità destra/sinistra
e dello stesso spontaneismo armato successivo – se si fosse dato ascolto,
allora, a Pasolini? Ma la storia non si fa con i "se" e quanto lui scriveva oggi
vale soprattutto come controcanto a una vicenda ancora tutta da analizzare
storiograficamente. Importante, inoltre, il fatto che il succo dell’articolo del
16 luglio riguardasse il "silenzio" mediatico e politico sui vincitori del
referendum del 13 maggio, Marco Pan- nella e i radicali. Di fronte
all’affermazione crescente di un potere a vocazione totalitaria – che si reggeva
sul patto Dc-Pci-Confindustria-cultura consumista – i radicali apparivano a
Pasolini come il solo fenomeno irriducibile ed eccedente. «Nessuno dei
rappresentanti del potere – annotava – sia del governo che dell’opposizione,
sembra neanche minimamente disposto a compromettersi con Pannella e i suoi. La
volgarità del realismo politica sembra non poter trovare alcun punto di
connessione col candore di Pannella, e quindi la possibilità di esorcizzare e
inglobale il suo scandalo». Il Partito Radicale e il suo leader Marco Pannella
erano, spiegava il poeta, i reali vincitori del referendum sul divorzio del 12
maggio e proprio questo non gli veniva perdonato da nessuno. Ma, «anziché essere
ricevuti e complimentati dal primo cittadino della Repubblica, in omaggio alla
volontà del popolo italiano, volontà da essi prevista, Pannella e i suoi
compagni – scriveva Pasolini – vengono ricusati come intoccabili. Invece che
apparire come protagonisti sullo schermo della televisione, non gli si concede
nemmeno un miserabile quarto d’ora di tribuna libera». Antifascismo pretestuoso
e fuori tempo massimo, da un lato, e censura della presenza radicale,
dall‘altro. Una domanda è inevitabile: quanto c’è, quarant’anni dopo, di
continuità con quella logica del potere?
Pasolini e quella profezia
sugli antifascisti,
scrive Giuseppe Papalia il 13 settembre 2017. «Nulla di peggio del fascismo
degli antifascisti» scriveva Pier Paolo Pasolini sulle pagine del Corriere della
Sera, nell’ormai lontano 16 luglio 1974, in Scritti Corsari.
Pasolini al «Corriere della
Sera», scrive Valerio Valentini su "Quattrocentoquattro.com" il 26 febbraio
2014. Voler comprendere a pieno l’esperienza giornalistica di Pier Paolo
Pasolini al «Corriere della Sera» implica necessariamente il tener conto anche
di quelle che furono le reazioni agli articoli che lui scrisse in quegli anni.
Gli Scritti corsari e le Lettere luterane sono la testimonianza di un dialogo
che Pasolini intessé con l’intera società a lui contemporanea: ascoltare un solo
protagonista di quel colloquio, costringerlo ad una monologante ripetitività,
rischia di svilire lo spessore di un intellettuale che, solo se studiato tenendo
conto della pluralità delle voci che con lui dibatterono, può essere
adeguatamente compreso. Non solo. Rileggere gli interventi di Pasolini nel
contesto generale del panorama giornalistico di quegli anni, rivela un altro
importante elemento. E cioè come il modo di lavorare, da parte di Pasolini, fu
enormemente condizionato dagli atteggiamenti assunti dai suoi colleghi in
reazione ai suoi articoli, e come il confronto che egli volle instaurare con i
suoi interlocutori gli risultò funzionale a collocare in una particolare
posizione – estrema e controversa – la propria figura di intellettuale
all’interno del dibattito politico contemporaneo.
PASOLINI AVEVA RAGIONE.
16 giugno 1968. La poesia
dell’autore delle “ceneri di Gramsci”: Il Pci ai giovani di Pier Paolo
Pasolini.
Mi dispiace. La polemica
contro il Pci andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in
ritardo, cari.
Non ha nessuna importanza se
allora non eravate ancora nati: peggio per voi.
Adesso i giornalisti di tutto
il mondo (compresi quelli delle televisioni) vi leccano (come ancora si dice nel
linguaggio goliardico) il culo. Io no, cari.
Avete facce di figli di papà.
Vi odio come odio i vostri
papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio
cattivo.
Siete pavidi, incerti,
disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori,
sicuri e sfacciati: prerogative piccolo-borghesi, cari.
Quando ieri a Valle Giulia
avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli
di poveri.
Vengono da subtopaie,
contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai
bene il loro modo di esser stati bambini e ragazzi, le preziose mille lire, il
padre rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un
facchino, o tenera per qualche malattia, come un uccellino; i tanti fratelli; la
casupola tra gli orti con la salvia rossa (in terreni altrui, lottizzati); i
bassi sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, ecc.
ecc.
E poi, guardateli come li
vestono: come pagliacci, con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio furerie e
popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono
ridotti (per una quarantina di mille lire al mese): senza più sorriso, senza più
amicizia col mondo, separati, esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha
uguali); umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti
(l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra
età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo
contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la
Magistratura, e vedrete!
I ragazzi poliziotti che voi
per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete
bastonato, appartengono all’altra classe sociale.
A Valle Giulia, ieri, si è
così avuto un frammento di lotta di classe: e voi, cari (benché dalla
parte della ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla
parte del torto) erano i poveri.
Bella vittoria, dunque, la
vostra! In questi casi, ai poliziotti si danno i fiori, cari.
Stampa e Corriere della Sera,
News- week e Monde vi leccano il culo.
Siete i loro figli, la loro
speranza, il loro futuro: se vi rimproverano non si preparano certo a una lotta
di classe contro di voi! Se mai, si tratta di una lotta intestina.
Per chi, intellettuale o
operaio, è fuori da questa vostra lotta, è molto divertente la idea che un
giovane borghese riempia di botte un vecchio borghese, e che un vecchio borghese
mandi in galera un giovane borghese.
Blandamente i tempi di Hitler
ritornano: la borghesia ama punirsi con le sue proprie mani.
Chiedo perdono a quei mille o
duemila giovani miei fratelli che operano a Trento o a Torino, a Pavia o a Pisa,
/a Firenze e un po’ anche a Roma, ma devo dire: il movimento studentesco (?) non
frequenta i vangeli la cui lettura i suoi adulatori di mezza età gli
attribuiscono per sentirsi giovani e crearsi verginità ricattatrici; una sola
cosa gli studenti realmente conoscono: il moralismo del padre magistrato o
professionista, il teppismo conformista del fratello maggiore (naturalmente
avviato per la strada del padre), l’odio per la cultura che ha la loro madre, di
origini contadine anche se già lontane.
Questo, cari figli, sapete.
E lo applicate attraverso due
inderogabili sentimenti: la coscienza dei vostri diritti (si sa, la
democrazia prende in considerazione solo voi) e l’aspirazione al potere.
Sì, i vostri orribili slogan
vertono sempre sulla presa di potere.
Leggo nelle vostre barbe
ambizioni impotenti, nei vostri pallori snobismi disperati, nei vostri occhi
sfuggenti dissociazioni sessuali, nella troppa salute prepotenza, nella poca
salute disprezzo (solo per quei pochi di voi che vengono dalla borghesia infima,
o da qualche famiglia operaia questi difetti hanno qualche nobiltà: conosci te
stesso e la scuola di Barbiana!)
Riformisti!
Reificatori!
Occupate le università ma dite
che la stessa idea venga a dei giovani operai.
Quando Pasolini si faceva
raccomandare da fascisti e Dc,
scrive di Giuseppe Pollicelli il 2 novembre 2016 su “Libero Quotidiano”.
Occupandomi da anni dell’assassinio di Pier Paolo Pasolini, sono profondamente
convinto che la verità giudiziaria - l’allora diciassettenne Pino Pelosi unico
artefice dell’uccisione del poeta - non coincida con ciò che davvero accadde a
Ostia nella notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975. Sono però profondamente
convinto anche di un’altra cosa: in troppi rendono da tempo a Pasolini un
cattivo servizio adulterando una verità non meno importante, quella sulla sua
persona. Costoro, per una forma perniciosa d’amore, misconoscono uno dei tratti
fondanti della personalità pasoliniana: quella contraddittorietà che Pasolini
stesso tante volte ebbe a rivendicare. L’ultimo esempio di «mistificazione a fin
di bene» lo si è avuto sabato scorso con l’uscita all’interno di “Alias”,
l’inserto culturale del “Manifesto”, di un articolo intitolato “Quando Pasolini
era precario”. Ne è autore Giovanni Giovannetti, fotografo (suoi sono alcuni
tardi ritratti, peraltro bellissimi, proprio di Pasolini), saggista e anche
editore tramite l’agenzia Effigie. Il pezzo si occupa dei primi anni romani di
Pasolini, il 1950 e il 1951, nei quali lo scrittore, vivendo una situazione di
precarietà economica, cerca comprensibilmente di trovare qualcuno che lo
raccomandi per fargli ottenere un impiego di tipo intellettuale. Questi
tentativi del giovane Pier Paolo erano già noti, ma avendo avuto accesso ad
alcune missive inedite conservate presso il Gabinetto Vieusseux di Firenze,
Giovannetti menziona nel suo articolo un individuo di cui finora non era emerso
il ruolo decisivo nel procurare a Pasolini un posto di insegnante presso la
scuola media “Francesco Petrarca” di Ciampino. Questa persona, di cui parleremo
fra poco, si chiama Casimiro Fabbri. Vale intanto la pena far notare come
Giovannetti, nel suo articolo, tenda a ribaltare l’essenza dei fatti soprattutto
quando ricostruisce le richieste di raccomandazione rivolte da Pasolini ad
alcuni esponenti della Democrazia cristiana, e i tentativi di questi ultimi di
esaudirle. Nel 1950, per esempio, Pasolini contatta Giovan Battista Carron, un
deputato democristiano nativo del Veneto ma residente a Udine, il quale prova a
raccomandarlo al friulano Cristiano Ridomi, all’epoca presidente della Rai. Sarà
poi la volta di Tiziano Tessitori, anch’egli friulano, senatore della Dc e
futuro ministro. Questi cerca dapprima di raccomandare nuovamente Pier Paolo in
Rai, poi prova a sistemarlo alla Treccani, sempre informando il poeta dei suoi
tentativi. I quali si riveleranno vani, ma indubbiamente ci sono stati. Il fatto
che non siano andati a buon fine, però, è ciò a cui si appiglia Giovannetti per
lasciar intendere che, se c’è qualcuno da deplorare, non è Pasolini bensì i suoi
interlocutori democristiani, inattendibili e inconcludenti. «Se è vero che
furono i democristiani a muoversi in orbita clientelare per Pasolini», scrive
Giovannetti, «è altrettanto vero che nulla di concreto Pasolini ne ricavò». Come
si è accennato, c’è però qualcuno da cui Pasolini ottenne un aiuto concreto, e
questo qualcuno ha nome Casimiro Fabbri. Cosa ha fatto Fabbri per Pasolini? È
proprio Giovannetti ad averlo meritoriamente scoperto. Scrive ancora il
fotografo: «Lo stipendio fisso verrà lo stesso, grazie, si direbbe, al ferrarese
Casimiro Fabbri, funzionario del ministero della Pubblica Istruzione nonché
poeta, che a Pasolini sembra lanciare l’agognato salvagente». E se Pasolini, in
alcune righe autobiografiche, scriverà che la sua assunzione alla scuola di
Ciampino è merito del poeta e ispettore scolastico abruzzese Vittorio Clemente,
ciò si spiega con il fatto (lo ricostruisce ancora Giovannetti) che Fabbri e
Clemente erano molto amici. Resta da capire chi fosse Casimiro Fabbri. Sul suo
conto le notizie sono scarse: uomo di lettere e poeta, era nato a Ferrara nel
1907 ed è morto a Roma nel 1964. Quel che è certo è che Fabbri era stato un
intellettuale organico al regime fascista. Lo comprovano alcuni suoi interventi
recuperabili nella rivista “Il Libro Italiano”, edita dal Ministero
dell’Educazione Nazionale e dal Ministero della Cultura Popolare. Sul n. 10
dell’ottobre 1940 c’è persino un suo scritto dedicato alla discussa figura di
Cornelio Di Marzio, esponente di spicco del fascismo e tra i firmatari delle
cosiddette leggi razziali. Dal momento che una non piccola parte della classe
dirigente fascista approdò indenne alla Repubblica, i trascorsi di Fabbri non
devono stupire. Né, a nostro avviso, deve suscitare troppo scandalo che Pasolini
si sia giovato, in un frangente di particolare necessità, dei buoni uffici di
costui. Ma essendo passati, nel 1951, solo pochi anni dal crollo del fascismo,
non è francamente credibile che un uomo come Pasolini non fosse al corrente
della parabola professionale ed esistenziale di Casimiro Fabbri. Il quale, per
di più, aderì nel dopoguerra al Movimento Sociale, sostenendo la corrente che
faceva capo a Giorgio Almirante (segretario della Fiamma dal giugno del 1947 al
gennaio del 1950). Eppure Pasolini non ne rifiutò il supporto. Così come, nel
1960, non si tirò indietro di fronte alla possibilità di scrivere sulla rivista
“Il Reporter”, finanziata dal Msi. Tutte condotte che possono benissimo essere
riferite a quella spiazzante mancanza di linearità che Pasolini per primo
reputava un elemento decisivo di sé. Il problema, appunto, è che troppi
«pasoliniani» sembrano voler privare Pasolini dei suoi dati di umanità, come se
non di un uomo si trattasse ma di un dio. Umanità che, nel bene e nel male, era
invece in Pasolini debordante. Ed è infatti riemersa anche in un articolo che,
come quello di Giovannetti, ha provato a negarla.
La «rivoluzione antropologica
in Italia». Il 10 giugno 1974 il «Corriere della Sera» pubblica in prima
pagina Gli italiani non sono più quelli. Si tratta dell’intervento che, più
d’ogni altro, affronta in maniera programmatica quello che è il vero filo
conduttore di tutta la saggistica corsara e luterana: la mutazione antropologica
degli italiani. Ed è anche lo scritto che, più d’ogni altro, riesce a calamitare
attenzioni e polemiche, aprendo un dibattito che si trascinerà per mesi. Questo
grazie ad una scelta consapevole di Pasolini, il quale propone una lettura di
due eventi che hanno entusiasmato e scioccato l’opinione pubblica – la vittoria
del “no” nel referendum del 12 maggio e la strage di Piazza della Loggia del 28
dello stesso mese – che si distacca radicalmente da quella fornita dal resto
degli intellettuali, soprattutto da quelli di sinistra. Per quanto riguarda il
referendum – il cui esito è stato salutato con toni trionfalistici dagli
osservatori marxisti – Pasolini critica innanzitutto il Pci, che pur risultando
formalmente vincitore nella campagna contro l’abrogazione della legge sul
divorzio, ha dimostrato – coi suoi iniziali tatticismi e con i suoi tentativi di
mediazione per non inimicarsi il Vaticano – “di non aver capito bene cos’è
successo nel nostro paese negli ultimi vent’anni”. Pasolini, che aveva tra
l’altro pronosticato in due precedenti occasioni la vittoria del fronte
divorzista, è senza dubbio felice dell’esito del referendum: lui stesso lo
definisce “una vittoria, indubitabilmente”, e nella Lettera luterana a Italo
Calvino, scritta pochi giorni prima di morire, si ricorderà di questo successo e
lo inserirà tra i meriti che rendono la borghesia di allora migliore rispetto a
quella di dieci anni prima. Tuttavia, in Gli italiani non sono più
quelli, Pasolini si chiede polemicamente se questa vittoria, oltre ad essere un
affermazione del progressismo laico, non stia anche a dimostrare la perdita, da
parte del popolo italiano, di tutti quei valori che lo mantenevano puro nella
sua fedeltà ad una cultura millenaria, la quale non concepiva modelli a cui
aderire che non fossero quelli ormai radicati nella coscienza comune. A
soppiantare un certo bigottismo e una certa arretratezza culturale delle masse
italiane – che Pasolini ha ben presenti, ma in questo momento tace – non sarebbe
stato, in verità, un reale progresso delle coscienze, o quantomeno non in misura
preponderante: a sconsacrare quei valori arcaici sarebbe intervenuto piuttosto
un nuovo “Potere” transnazionale, dai connotati non ancora molto chiari, e
rispondente alle logiche del capitale. E se questo è lo stato dei fatti, almeno
per Pasolini, allora non si tratta per nulla di un trionfo: gli Italiani
dimostrano di essersi affrancati da un vecchio potere clericale e
antidemocratico per obbedire ad un altro potere ancor più repressivo. In un
contesto simile le varie categorie sociali canoniche a cui gli Italiani sentono
di appartenere perdono qualsiasi valore. E questo, a livello politico, provoca
pericolose incomprensioni e anomalie profonde, che Pasolini ritiene
indispensabile investigare per comprendere la nuova realtà che si sta generando:
L’omologazione «culturale» […] riguarda tutti […]. Non c’è più dunque differenza
apprezzabile – al di fuori di una scelta politica come schema morto da riempire
gesticolando – tra un qualsiasi cittadino italiano fascista e un qualsiasi
cittadino italiano antifascista. È così che Pasolini passa ad analizzare l’altro
avvenimento preso in considerazione nell’incipit del suo articolo. Per lo
scrittore è troppo sbrigativo derubricare quanto è accaduto a Piazza della
Loggia soltanto ad atto terroristico ascrivibile ad una precisa minoranza
politica di estrema destra. La responsabilità fattuale della strage ricade, è
vero, su un manipolo di terroristi, ma la cultura di questi criminali è in
realtà, al di là di differenze puramente nominali, il prodotto della stessa
mutazione antropologica che ha portato gli Italiani a sbarazzarsi dei valori
clericali e a votare “no” al referendum.
Le reazioni ad analisi così
deliberatamente provocatorie sono altrettanto veementi. Il settimanale
«L’Espresso» organizza subito una tavola rotonda, alla quale prendono parte
Sciascia, Moravia, Fortini, Colletti e Fachinelli, per discutere dell’effettivo
significato della vittoria dei “no” al referendum e delle osservazioni espresse
al riguardo da Pasolini. Il resoconto della discussione, pubblicato il 23
giugno, è introdotto da un fondo redazionale dai toni mordaci, e dal titolo
beffardo: È nato un bimbo: c’è un fascista in più, sotto l’occhiello Gli
italiani secondo Pasolini. Nelle poche righe d’apertura viene rimproverata a
Pasolini una vaga solidarietà morale con gli attentatori di Piazza della Loggia,
e si arriva addirittura a supporre che Almirante e Rauti abbiano trovato, nello
scrittore bolognese, “un nuovo Plebe”, facendo riferimento al responsabile
culturale del Msi di quegli anni.
Alberto Moravia, nel suo
intervento intitolato Lascia che ti spieghi la differenza tra noi due e…, si
affianca ai molti intellettuali che ritengono sterile l’analisi di Pasolini a
livello politico. Essa “ha senz’altro”, secondo Moravia, “un suo valore di
verità”, ma soltanto “sul piano esistenziale cioè premorale e preideologico”.
Moravia isola un passo, in particolare, di Gli italiani non sono più quelli: il
passo in cui Pasolini ha inteso mostrare come l’opposizione ideologica tra
fascisti e antifascisti sia ormai priva di un reale significato, chiedendosi
ironicamente se Giancarlo Esposti, “nel caso che in Italia fosse stato
restaurato, a suon di bombe, il fascismo, sarebbe stato disposto ad accettare
l’Italia della sua falsa e retorica nostalgia”, ovvero a rinunciare a tutte le
“conquiste dello «sviluppo»”, le quali vanificano, soltanto attraverso la loro
presenza, “ogni misticismo e ogni moralismo del fascismo tradizionale”. Moravia
ribatte che, indipendentemente dall’omologazione culturale in atto, Esposti era
a tutti gli effetti un fascista. E se pure, non lasciandosi corrompere da
un’ipotetica mutazione antropologica, avesse obbedito con più rigore
all’ideologia cui si dichiarava fedele, non avrebbe mutato in alcun modo,
“neppure un poco”, il corso della storia. Anzi, in quel caso avrebbe contribuito
a mantenere lo status quo, dal momento che, come il passato dimostra, “fascismo
e conservazione sono sinonimi”. Eppure Pasolini non sta affatto, come in quei
giorni molti ipotizzano, e come Moravia sembra adombrare, ricercando nei
fascisti degli alleati per attuare una sorta di reazione anticapitalista e
anticonsumista. Per Pasolini, piuttosto – ed è lui stesso a chiarirlo, proprio a
Moravia, in un’intervista concessa a «Il Mondo» l’11 luglio – è preoccupante
pensare che il nuovo Potere ha del tutto stravolto la grammatica ideologica
preesistente, così che ormai le scelte politiche, “innestandosi in questo
nuovo humus culturale”, hanno un significato totalmente diverso rispetto a
quello che avevano fino a qualche anno prima. “Sotto le scelte coscienti, c’è
una scelta coatta, «ormai comune a tutti gli italiani»: la quale ultima non può
che deformare le prime”. Ma smettila di dire che la storia non c’è più è il
titolo del contributo alla tavola rotonda di Franco Fortini. Il quale, a più
riprese e in molti suoi saggi, continuerà per tutta la sua carriera a sostenere
che, nel ruolo di osservatore e teorico politico, Pasolini abbia espresso il
peggio di sé e che infatti “una delle operazioni di bonifica intellettuale e
politica in Italia debba cominciare con la demolizione rappresentata da Pasolini
politico”. Tuttavia, nella circostanza attuale, non si mostra affatto in totale
disaccordo con le osservazioni del collega; ritiene anzi del tutto plausibile
che la vittoria del fronte progressista al referendum possa in realtà costituire
un’ingannevole concessione di quello che Pasolini addita come il “nuovo Potere”.
“La tolleranza repressiva e «progressista» è solo una delle armi del capitalismo
moderno”, argomenta Fortini, ribadendo che “ad una condizione socioeconomica di
sviluppo […] può corrispondere benissimo la peggiore repressione sanfedista”. La
critica che però egli muove a Pasolini, anche alla luce dei loro pregressi
attriti, verte sulla convinzione, espressa in Gli italiani non sono più
quelli, secondo la quale nella nuova fase storica che si sta inaugurando sia
necessario vedere una catastrofe. “Sulle ceneri gramsciane”, ironizza Fortini,
già vent’anni fa si diceva che la nostra storia era finita. Credo invece finita
la mia, non la nostra”. Laddove Pasolini constata un collasso, Fortini è
convinto invece di vedere nient’altro che un nuovo modo di declinare la
dialettica politica, che è in perenne e costante mutazione per adeguarsi ai
nuovi rapporti di forza dettati dal capitalismo. Si tratta quindi di due
approcci per certi versi analoghi alla medesima realtà: semplicemente, Fortini
sembra poter con più tranquillità fare i conti col nuovo, Pasolini no. E lo
spiega nella lunga intervista a «Il Mondo» dell’11 luglio. Penso che il breve
intervento di Fortini potrebbe essere da me utilizzato a mio favore […]. Solo
che l’accanimento di Fortini a voler stare sempre sul punto più avanzato di ciò
che si chiama storia – facendo ciò molto pesare sugli altri – mi dà un istintivo
senso di noia e prevaricazione. Io smetterò di «dire che la storia non c’è più»
quando Fortini la smetterà di parlare col dito alzato.
L’unico partecipante alla
tavola rotonda organizzata da «L’Espresso» che si dichiara sostanzialmente
d’accordo con l’analisi di Pasolini è Leonardo Sciascia. Entrerei in
contraddizione con me stesso se dicessi di non essere d’accordo con l’articolo
di Pasolini […]. Forse la mia visione delle cose […] è meno radicale della sua,
nel senso che mi pare di non dover perdere di vista il fascismo come fenomeno di
classe, di una classe; ma la paura più profonda è tanto vicina alla sua. E
riferendosi a organizzazioni terroristiche di segno opposto rispetto a quelle
ritenute responsabili della strage di Brescia, Sciascia offre un’ulteriore
dimostrazione della validità della tesi di Pasolini. L’azione delle “Brigate
rosse” è stata intesa e spiegata in tanti modi, tranne che in quello più ovvio:
e cioè come il modo di preparare o di cominciare a fare una rivoluzione. […]. È
possibile parlare ancora di rivoluzione se il gesto rivoluzionario è temuto
nell’ambito stesso delle forze che dovrebbero generarlo non solo per la risposta
del gesto controrivoluzionario, che potrebbe facilmente e sproporzionatamente
arrivare, ma anche perché in sé, intrinsecamente, rivoluzione? Non c’è dunque da
pensare, e da riflettere? E mi pare sia, appunto, quel che fa Pasolini. Può
anche sbagliare, può anche contraddirsi: ma sa pensare con quella libertà che
pochi oggi riescono ad avere e ad affermare.
1. Le antologie che raccolgono
la quasi totalità degli articoli che Pasolini scrisse, sul «Corriere» e su altri
quotidiani, tra il gennaio del 1973 e l’ottobre del 1975.
2. Pier Paolo
Pasolini, Scritti corsari, Milano, Garzanti 2008, pp. 39-40.
3. Si tratta di un articolo
pubblicato su «Il Mondo» il 28 marzo, e di un intervento – rimasto inedito fino
al suo inserimento negli Scritti corsari – richiesto a Pasolini del settimanale
comunista «Nuova Generazione», che però si rifiuterà di pubblicarlo.
4. Pasolini, Scritti corsari,
cit., p. 41.
5. Ibidem.
6. È nato un bimbo: c’è un
fascista in più, «L’Espresso», 23 giugno 1974
7. Ibidem.
8. Giovane militante di Ordine
Nero rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine
sull’altopiano di Rascino il 30 maggio 1975.
9. Pasolini, Scritti corsari,
p. 42.
10. È nato un bimbo: c’è un
fascista in più.
11. Pasolini, Scritti corsari,
pp. 57-58.
12. Franco Fortini, Attraverso
Pasolini, Torino, Einaudi 1993, p. 205.
13. È nato un bimbo: c’è un
fascista in più.
14. Ibidem.
15. Sul concetto di “fine
della storia” e sulle polemiche al riguardo trascinatesi per quasi due decenni
tra Pasolini e Fortini, cfr. Fortini, Attraverso Pasolini (in
particolare Introduzione, pp. XII-XIII), e Scotti, “Una polemica in versi”:
Fortini, Pasolini e la crisi del ’56«Studi Storici», LXV (2004), n.4, passim
16. Pasolini, Scritti corsari,
p. 58.
17. È nato un bimbo: c’è un
fascista in più.
18. Ibidem.
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DA
TENCO A PASOLINI, DA TOTO’ A BONCOMPAGNI.
Luigi Tenco, Pier Paolo
Pasolini: quando la tragedia sveglia le coscienze.
Il suicidio di Luigi Tenco (1967) e l’omicidio di Pier Paolo Pasolini (1975): la
gravità di questi due eventi scosse tante persone, ma soprattutto colpì anche
parte di quel blocco conservatore indicato come “maggioranza silenziosa”, scrive
Gianni Martini il 3 dicembre 2012. Si è parlato di “torpore coscienziale”,
condizione politico-culturale che caratterizzava, negli anni ’60 e ’70, larghi
strati della popolazione. “Maggioranza silenziosa”, così veniva definito questo
“blocco sociale” trasversale che dalla piccola e media borghesia arrivava a
toccare anche i ceti popolari. Ritengo importante soffermarmi su questo “muro
sociale” conservatore perché la sua presenza impalpabile e, appunto, silenziosa,
giocò un ruolo significativo. Più che di arretratezza politica penso si
trattasse di una ben più grave arretratezza culturale che si esprimeva in una
mentalità chiusa e refrattaria alle novità. Sarebbe quindi sbrigativo ed erroneo
liquidare come “di destra”, compattamente, quest’area sociale. Infatti, anche
una parte della sinistra popolare, allora legata al P.C.I, condivideva nei fatti
le stesse posizioni conservatrici che non esitarono a condannare l’arte
d’avanguardia, i capelloni dei primi anni ’60, gli omosessuali. Eppure, in
quegli anni ci furono almeno due fatti che, sul piano del costume, scossero la
società civile, arrivando forse a smuovere un po’ anche le “maggioranze
silenziose”: 1967 suicidio di L. Tenco e 1975 omicidio di P. Pasolini. La
sociologia ci insegna che quando nella società civile si verifica un “evento
traumatico” si possono determinare cambiamenti nei comportamenti sociali più o
meno diffusi, in relazione all’entità dell’evento stesso. L. Tenco si suicidò
nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967, mentre era in corso il festival di
Sanremo. Nel drammatico messaggio che lasciò scritto sulla carta intestata
dell’albergo si leggeva un’attestazione d’amore per il pubblico italiano, ma al
tempo stesso una profonda delusione per il passaggio in finale di una canzonetta
insulsa come “Io tu e le rose” e una finta canzone di protesta come “La
rivoluzione”. L’opinione pubblica fu scossa soprattutto perché non ci si
aspettava che il Festival di Sanremo potesse essere sconvolto da una tragedia
simile. La morte di L. Tenco fece irrompere nella spensieratezza del tempio
della canzonetta disimpegnata e leggera, del bel canto popolare, un’altra
realtà: il fatto che si potessero scrivere canzoni frutto di un’ispirazione più
autentica, canzoni che parlassero della vita concreta, non idealizzata e
mistificata. Che le cose stessero iniziando a cambiare – con grida di scandalo
di ben pensanti e reazionari di ogni risma – lo si era in realtà già capito da
qualche anno, visto che il Festival di Sanremo aveva ospitato alcuni complessi
di “capelloni” e canzoni di protesta. Comunque quasi tutta la stampa batté la
strada del “cantante solo, incompreso, forse depresso e inacidito per il mancato
successo”. Certamente il mondo della canzone, dopo quel tragico fatto, non fu
più lo stesso. Nel 1972 nacque a Sanremo il Club Tenco e nel 1974 vi si tenne la
prima “Rassegna della canzone d’autore”. Il Club Tenco (presieduto e fondato da
A. Rambaldi), per statuto, si impegna a promuovere e diffondere un nuovo tipo di
canzone, fuori dalle strategie delle case discografiche e della musica di
consumo. Una canzone rivolta alla parte più sensibile e impegnata della società
civile, già frutto di una vitalità socio- culturale, segno attuale dei tempi. E
veniamo alla drammatica vicenda di P. Pasolini, ucciso barbaramente nella notte
tra l’1 e il 2 novembre 1975. Gli occulti mandanti e le circostanze
dell’omicidio non furono mai del tutto chiarite. Anche in questo caso l’impatto
fu notevole soprattutto sulle componenti della società civile più sensibili e
culturalmente attive. Buona parte della stampa, dopo aver riconosciuto o
semplicemente riportato con distacco il valore dell’impegno artistico e
intellettuale di Pasolini, si soffermò soprattutto sugli aspetti da “cronaca
nera”. La stampa più retriva e moralista trattò il caso come “maturato negli
ambienti omosessuali”. Per il resto ci si limitò con poche eccezioni a
descrivere le scelte di vita di Pasolini. Si perse così (volutamente, sia
chiaro), l’occasione per una discussione non solo sulla statura artistica di
Pasolini ma su ciò che, come giornalista, scriveva su quotidiani e
riviste importanti come “Il corriere della sera”, “Il tempo”, “Panorama”,
“Rinascita”, “Il mondo” ecc, oltre a dichiarazioni rilasciate in interviste,
anche televisive.
Quella rivoluzione chiamata
Luigi Tenco.
Fascinoso, anticonformista, ombroso. Ma anche ironico e
traboccante di creatività, capace di sfidare la morale con canzoni che facevano
pensare. Cinquant'anni fa, il 27 gennaio 1967, il cantautore pose fine alla sua
vita con un colpo di pistola. Lasciando però una grande eredità alla nostra
canzone, scrive Alberto Dentice il 26 gennaio 2017 su "L'Espresso". Se non fosse
mai andato al festival di Sanremo, oggi Luigi Tenco avrebbe 78 anni, la stessa
età di Celentano e chissà, forse sarebbe anche lui un insopportabile gigione.
Invece, il 27 gennaio del 1967, 50 anni fa, con un colpo di pistola Tenco pose
fine alla sua vita tormentata assicurandosi un posto nel paradiso dei “forever
young”, accanto a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e altre
leggende del rock morte giovani e preservate perciò dagli acciacchi del tempo e
dell’età. Che si sia trattato di suicido, di un fatale incidente come capitò a
Johnny Ace (leggenda del R&B fulminato nel 1954 da un colpo partito per sbaglio
mentre giocava con la sua pistola) o di omicidio eseguito su commissione di
oscuri mandanti come quello di Pier Paolo Pasolini, il dibattito è ancora
aperto. Una mole impressionante di libri e di inchieste giornalistiche ne hanno
evidenziato a più riprese l’inconsistenza: si legga in proposito la nuova
aggiornata biografia di Aldo Colonna, “Vita di Tenco” (Bompiani), che arriva ad
adombrare una responsabilità del vicino di stanza, Lucio Dalla. La versione del
suicidio sembrerebbe a tutt’oggi accettata con rassegnata perplessità dalla
stessa famiglia del cantautore, rappresentata dai due figli del fratello,
Valentino Tenco, e dalla loro madre. Suicidio o omicidio? Non è un dubbio da
poco. Cambiando il finale, sarebbe tutto un altro film. E il mito dell’artista
“maudit” che si toglie la vita per protestare contro l’ottusità e la corruzione
che infestano il tempio della musica leggera ne uscirebbe ridimensionato.
Dell’eredità spirituale e artistica di Tenco, nel frattempo ha continuato a
occuparsi, nel segno dell’indipendenza e di una mission creativa scevra da
compromessi con il famigerato “mercato”, la Rassegna a lui dedicata, fondata
proprio a Sanremo da Amilcare Rambaldi, gran signore e appassionato conoscitore
di musica popolare. Il Premio Tenco aprì le porte nel 1974, nel pieno della
stagione d’oro della canzone d’autore. Poi nel ’95 Rambaldi ci ha lasciato e la
manifestazione ha cominciato a perdere un po’ dell’allegria e dello spirito
dilettantesco, nel senso migliore del termine, che ne avevano caratterizzato gli
esordi. Le mitiche serate post festival trascorse all’osteria assistendo alle
sfide in ottava rima tra Guccini e Benigni sono un ricordo. Anche il Tenco ha
aperto le porte al nuovo e ha esteso il concetto di canzone d’autore fino ad
abbracciare l’hip hop, la canzone dialettale, la world music e il pop
all’insegna di quella contaminazione tra i generi che siamo portati a
considerare il suggello della contemporaneità. L’orgoglio della diversità
artistica è rimasto un punto fermo anche per Enrico De Angelis, il direttore
artistico che ne ha guidato le sorti fino a poche settimane fa, coadiuvato da un
ristretto comitato di esperti e appassionati. Per celebrare i 50 anni dalla
scomparsa, l’edizione 2016, la quarantesima, ha previsto un gran finale tutto
dedicato a Luigi Tenco. Titolo: “Come mi vedono gli altri… quelli nati dopo”.
Sul palco fra gli altri anche l’istrionico Morgan che per Tenco ha una vera
adorazione. Gli ha dedicato il prossimo album e una canzone: «Luigi Tenco /
scappato eternamente / oltre lo spazio, le luci e il tempo / perché lui si sente
/vivo / fatalmente/ solo nel momento in cui non è». Ma quanti lo ascoltano,
quanti fra i giovani musicisti e i cantanti oggi conoscono Tenco? La risposta
forse arriverà il 28 gennaio ad Aosta, quando sul palco del Teatro Splendor in
ricordo del cantautore saliranno altri giovani protagonisti della canzone
d’autore. Fra gli altri proprio il toscano Motta, cui è stato assegnato il
recente premio Tenco. E che mentre si appresta a cantare il suo “Una brava
ragazza”, ammette di conoscerlo poco. Ma appunto, chi era Luigi Tenco? Certo è
che quel gesto estremo, notava anni fa Lietta Tornabuoni su La Stampa, «lo aveva
confermato per quel che Tenco era sempre apparso all’euforico, quattrinaio e
prepolitico mondo della musica leggera dei primi anni Sessanta: un guastafeste».
E chissà se Carlo Conti e Maria De Filippi decideranno di commemorare
l’anniversario al prossimo Sanremone. Perché la sua ombra continua a dividere
come quella di un angelo sterminatore. Le cronache del tempo tramandano il
ritratto di un anticonformista dal carattere ombroso e introverso ma assai
consapevole del proprio fascino, jeans e maglione nero d’ordinanza, lo sguardo
sprezzante del giovane arrabbiato a mascherare una profonda fragilità. Insomma,
è uno che se la tira. Oltretutto il Nostro è un lettore accanito, adora Pavese e
in una canzone, “Quasi sera”, cita addirittura versi di Bertolt Brecht. Quanto
basta perché alla fama di intellettuale si sommi quella più sospetta di
comunista. Oggi non ci farebbe caso nessuno, ma nell’Italia pre-sessantotto che
vuole essere ricca, spregiudicata e ottimista basta questo per essere guardato
con diffidenza, specie nell’ambiente ridanciano e superficialotto della
discografia. All’immagine del pessimista introverso da sempre fa da contraltare
quella del Tenco amante della vita, traboccante creatività e perfino spiritoso,
bravissimo a raccontare barzellette, con un debole per le zingarate. Dalle
testimonianze di chi l’ha conosciuto, insomma, Tenco risulta essere stato tutto
e il contrario di tutto. Ma sulla sua missione ha idee chiarissime: «Anche la
canzone può servire a far pensare». Convinto che si debba cantare l’amore con un
linguaggio nuovo, fare a pezzi i luoghi comuni, la rima baciata, il verso
tronco, la retorica imperante. Sì: «Mi sono innamorato di te», ma solo «perché
non avevo niente da fare». Nei primi anni Sessanta, ovviamente, non è il solo
artista impegnato a rinnovare il linguaggio della canzone. Tenco è meno
musicista di Bindi, meno romantico di Paoli, non ha l’aplomb aristo-maledetto di
De André, ma proprio lui, genovese d’adozione (è nato a Cassine in provincia di
Alessandria) è il più politico del gruppo. Nel 1962, “Cara maestra”, il
“j’accuse” contro l’ipocrisia di certi precetti morali impartiti a scuola e in
chiesa, gli era valso due anni di esilio dalla tv. Intanto, nella musica e non
solo in quella, sta cambiando tutto. L’avvento di Bob Dylan, dei Beatles, dei
Rolling Stones ha impresso al mondo un’accelerazione bestiale. Tenco, appena
sbarcato alla Rca, la sua nuova casa discografica, scopre il Piper Club, il
tempio romano del beat e dei capelloni, dove oltre ai Rokes, all’Equipe 84, a
Patty Pravo si possono ascoltare i Primitives, i Bad Boys e molti altri gruppi
rock blues inglesi sconosciuti ma bravissimi.
E perfino
divinità del Rhythm’ n’Blues come Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave.
Tenco a
differenza di Bindi, di Paoli, di Endrigo, di Lauzi, che hanno la bussola
puntata verso la Francia di Brassens, guarda più all’America. Nasce come
sassofonista, viene dal jazz e ha trovato in Paul Desmond il suo modello. Come
se non bastasse, sussurra «Quando il mio amore tornerà da me…» con lo stesso
timbro vellutato di Nat King Cole e in questo come in altri suoi lenti da
mattonella farciti con overdose di violini - pensiamo a “Lontano, lontano” o a
“Ti ricorderai” - riesce a toccare come pochi le corde della malinconia. Proprio
al Piper, però, il Nostro deve rendersi conto che il conflitto, ormai, non è più
fra destra e sinistra, quanto piuttosto una questione generazionale. Da una
parte i giovani, dalla parte opposta tutti gli altri. Lui a 25 anni si sente già
vecchio, e quando nel 1966 scoppia la polemica contro i capelloni, è tra i primi
a schierarsi: «Gli argomenti preferiti di certa gente sono che i capelloni non
lavorano, che non si lavano, che sono ignoranti; bene, a questo punto io mi
proclamo un capellone, mi sento uno di loro». L’ondata dei beat, delle canzoni
di protesta lo vedrà in prima linea, anche se, a onor del vero, il contributo di
Tenco alla causa, “Ognuno è libero”, non si distingue per originalità. Chissà
cosa pensano davvero di lui i giovani che oggi nei dischi infilano cover delle
sue canzoni per accattivarsi la giuria del premio Tenco. I cinquant’anni dalla
morte cadono mentre De Angelis si dimette dal Club denunciando che l’iniziale
«professionalità» si sta trasformando in «professionismo», e gli eredi litigano
con i gestori del museo-omaggio di Ricaldone, rei di aver esposto una
gigantografia del cantante. E intorno a Tenco tira aria di maretta.
«Ecco perché Tenco fu ucciso»
Il libro-inchiesta riapre il caso, scrive Monica Bottino, Sabato 23/02/2013, su
"Il Giornale". «Quando molti giornalisti mi chiedono se esiste il delitto
perfetto, io gli rispondo di sì: è l'omicidio Tenco». Il criminologo Francesco
Bruno ne è convinto. Nella notte del 27 gennaio 1967, durante il Festival di
Sanremo, avvenne quello che a 46 anni di distanza resta ancora uno dei grandi
misteri italiani. Mistero, sì. Nonostante due sentenze della magistratura dicano
che Luigi Tenco si è suicidato, sono tanti e insoluti i dubbi su quella notte. E
non solo. A tentare di far luce su quello che è per molti un «cold case» sono
due giornalisti d'inchiesta: Nicola Guarnieri e Pasquale Ragone che hanno
pubblicato il libro «Le ombre del silenzio. Suicidio o delitto? Controinchiesta
sulla morte di Luigi Tenco» (edizioni Castelvecchi), proprio con la prefazione
del professor Bruno. Un lavoro ponderoso che è il risultato di quattro anni di
ricerche nei faldoni giudiziari, alla riscoperta di interviste dell'epoca con le
persone che a vario titolo furono coinvolte nella vicenda. E nuove
testimonianze. A rendere straordinario il libro non c'è solo la capacità degli
autori di raccontare una storia vera come fosse un noir, ritmandola di colpi di
scena e rivelazioni clamorose, ma anche e soprattutto la pubblicazione di
testimonianze e materiali inediti rinvenuti nell'aula bunker della corte di
Assise di Sanremo. Un lungo lavoro di ricerca che gli autori hanno portato
avanti scavando tra archivi e faldoni, fino a scovare per la prima volta il
foglio matricolare e alcune lettere di Luigi Tenco, documenti finora mai
pubblicati. Il lettore viene assalito da molti dubbi di fronte a un quadro
inquietante e alle troppe incongruenze che emergono dalle carte stesse. Alla
fine emergono anche altre domande: perché Tenco doveva morire? Quali segreti
custodiva? E la richiesta degli autori alla magistratura, sulla base delle nuove
prove emerse, è quella di aprire nuovamente il caso. Intanto è bene sapere che
Luigi Tenco in quei giorni aveva paura. Di più. Temeva per la sua vita, dopo che
poco tempo prima del festival, nei pressi di Santa Margherita due auto lo
avevano stretto e avevano tentato di mandare la sua fuoristrada. Era stata la
terza volta che attentavano alla sua vita, confidò a un amico. Fu a quel punto
che decise di acquistare una pistola Walther Ppk7.65, abbastanza piccola da
tenerla nel cruscotto della macchina. Secondo gli autori non fu questa la
pistola che uccise Tenco perché non uscì mai dalla macchina. Nella stanza 219
del Savoy la polizia dirà di aver rinvenuto una Bernardelli, molto simile alla
precedente, ma naturalmente non quella. Inoltre nel primo verbale stilato dalla
polizia «alle ore tre» (e pubblicato nel libro) si parla di proiettili, di
medicinali, ma non di arma. La pistola non fu repertata. Perché? Forse perché
non c'era? Ma andiamo avanti. È assodato che il cadavere fu condotto
all'obitorio subito dopo il ritrovamento dai necrofori, che poi furono
richiamati e costretti a riportarlo nella stanza dove fu rimesso nella posizione
che aveva al momento del ritrovamento, per consentire alla polizia di scattare
le fotografie e di eseguire i rilievi non fatti prima. Non fu eseguita
l'autopsia. Il cadavere di Tenco non fu svestito né lavato, ad eccezione del
viso. Non fu nemmeno fatto lo «stub», ovvero il test che prova se una mano ha
tenuto la pistola che ha sparato. Nulla. Perché? A distanza di molti anni, a
fronte di molti dubbi, nel 2006 la salma di Tenco fu riesumata. Gli esami furono
- secondo gli autori - incompleti anche in questo caso. Ma ci furono esperti che
si dissero convinti che la pistola che aveva ucciso Tenco avesse un
silenziatore, poiché la ferita sul cranio non era a stella, ma rotonda. Ma il
silenziatore non fu mai trovato. Inoltre nel 2006 non furono fatti accertamenti
sui vestiti, gli stessi che l'uomo indossava al momento della morte e che
avrebbero almeno dovuto avere le tracce dello sparo. Il lettore verrà condotto
attraverso uno dei misteri irrisolti con dovizia di particolari e una
documentazione ricca, sebbene un piccolo appunto (magari in vista di una
ristampa) va fatto per la poca chiarezza delle immagini fotografiche stampate
sulla carta ruvida, e in bianco e nero anche nella ricostruzione. Resta il fatto
che il libro-inchiesta non solo pone questioni, ma fornisce al lettore anche una
possibile chiave di lettura degli avvenimenti che culminarono in quella notte
maledetta. C'è la pista argentina, per dirne una, ma si parla anche di mafia
marsigliese, e di eversione di estrema destra. E anche del potere delle case
discografiche a Sanremo. Non possiamo svelare di più, per non togliere il
piacere di una lettura coinvolgente che attraversa fatti e personaggi della
nostra storia. «Gli esami svolti nel 2006 dall'Ert non chiariscono tutti i punti
oscuri e la tesi del suicidio non combacia con diversi elementi», scrive ancora
Bruno nella prefazione. La soluzione al mistero è ancora lontana. Ma questo
libro è un passo avanti.
Con la morte di Pino
Pelosi, addio alla verità sul delitto Pasolini.
Condannato come unico autore dell'assassinio, malato di cancro, con lui se ne va
la speranza di conoscere come andarono davvero i fatti nel 1975, scrive il 21
luglio 2017 Chiara Degl'Innocenti su "Panorama". Con la morte Pino Pelosi se ne
va l'unica possibilità di scoprire tutta la verità sul delitto di Pier Paolo
Pasolini. Chiamato dalla malavita romana Pino la rana, Giuseppe Pelosi aveva
appena 17 anni quando la notte del 2 novembre 1975, venne fermato alla guida
dell'auto di Pasolini che era stato brutalmente ucciso all’Idroscalo di Ostia.
In quell'auto furono trovate tracce del sangue del poeta ed altri indizi che
portarono direttamente a Pelosi che, fermato, si assunse la responsabilità del
omicidio. Il racconto fu conciso, ma non privo di buchi neri, lacune e aspetti
oscuri. Il giovane infatti disse di aver opposto resistenza alle avances di
Pasolini reagendo con violenza picchiando fino a uccidere. Ma la bestiale
aggressione apparve inverosimile consumata da parte di un ragazzino mingherlino
come Pino. Fermato dalla polizia il giovane, inoltre, era stato trovato privo di
tracce di sangue e fango, mentre il corpo di Pasolini appariva massacrato da una
furia disumana. Nonostante tutto questo Pino Pelosi venne condannato, in un
primo momento per omicidio "in concorso con ignoti" e nel 1979, in via
definitiva, a 9 anni e 7 mesi di carcere come "unico autore" del delitto
Pasolini. Nel 2005 Pino Pelosi ritrattò la sua versione. Dal nulla spuntarono
fuori che sarebbero state tre persone ad uccidere il poeta. Ma poiché una vera e
propria ricostruzione definitiva dei fatti di quella notte non vi fu mai, ora
con la morte di Pelosi questo vuoto resterà incolmabile.
«Se volete la verità su
Pasolini, chiedete a Johnny lo zingaro»,
scrive Simona Musco il 22 luglio 2017 su "Il Dubbio". Intervista all’avvocato
Nino Marazzita, legale della famiglia Pasolini nei processi che hanno portato
alla condanna di Pino Pelosi, morto giovedì a 58 anni. «Se volete la verità
sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini dovete trovare Johnny lo zingaro e
chiederla a lui». Non ci sono vie alternative: chiunque ipotizzi l’esistenza di
una storia segreta, custodita chissà dove, è solo alla ricerca «di pubblicità».
A dirlo è Nino Marazzita, legale della famiglia Pasolini nei processi che hanno
portato alla condanna definitiva di Pino Pelosi, morto giovedì a 58 anni, dopo
una lunga malattia, unico a pagare per la morte dello scrittore, ammazzato nella
notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975 all’Idroscalo di Ostia. Non che si sappia
tutto su quel delitto: mancano gli altri esecutori e senza quelli, dice
Marazzita, non si conosceranno neanche i mandanti. Ma l’altro possibile custode
di quel segreto è scappato a giugno scorso. Giuseppe “Johnny” Mastini,
condannato all’ergastolo per omicidi e rapine, «aveva un legame con Pelosi che
nessuno ha mai voluto approfondire». Perché, dice l’avvocato, «la procura non
voleva la verità». Marazzita parte da qui, dalla cassetta di sicurezza di cui
parla Alessandro Olivieri, difensore di Pelosi. «Sono totalmente convinto
dell’innocenza di Pelosi – aveva dichiarato -. Una parte delle informazioni non
sono state date e sono gelosamente custodite in una cassetta di sicurezza,
perché sono troppo forti. Lui non se l’è mai sentita di diffonderle per paura
che qualcuno potesse toccare lui o i suoi familiari. La verità non è morta con
Pelosi. Ma è talmente pesante e difficile da poter raccontare con semplicità».
Parole che Marazzita etichetta come «balle»: Pelosi è morto e solo Mastini può
raccontare qualcosa. Ma gli indizi che portavano a lui non sono mai stati
considerati. E lo stesso Pelosi manifestava l’ansia febbrile di nascondere ogni
collegamento. «Due elementi portano a Johnny. Quando Pelosi viene arrestato non
si dà pace per aver perso l’anello con la croce militare regalatogli da Mastini,
perché capisce che può collegarlo a lui. È vero che aveva 17 anni – spiega – ma
aveva un’astuzia incredibile. Era capace di vanificare immediatamente una
domanda capziosa e il collegamento ossessivo che aveva fatto con quell’anello
poi ritrovato sul luogo dell’omicidio la diceva lunga. Mastini era claudicante,
per una ferita ad una gamba dopo aver ucciso un poliziotto. Nella macchina di
Pier Paolo fu trovato un plantare, che poteva appartenere ad una sola persona,
ma la mia richiesta di fare un esperimento giudiziale per vedere se fosse suo
non fu mai accolta». Non c’è però «alcun dubbio» che sia stato Pelosi ad
uccidere Pasolini. L’allora 17enne fu fermato la notte stessa a Ostia, alla
guida dell’auto del poeta, un’Alfa Gt 2000 grigia metallizzata. Accusato di
furto, confessò di avere rubato l’auto, raccontando, durante l’interrogatorio,
di essere stato abbordato da Pasolini e di averlo investito involontariamente
dopo una colluttazione a colpi di bastone per aver prima accettato e poi
rifiutato una prestazione sessuale. E, inizialmente, disse di aver fatto tutto
da solo. Il primo processo davanti al tribunale dei minori, presieduto dal
fratello di Aldo Moro, Carlo Alfredo Moro, lo vide condannato per omicidio in
concorso con ignoti. «Quella sentenza fu un capolavoro giudiziario – spiega
Marazzita – Dice che non fece tutto da solo e non è vero che la sentenza
d’Appello negasse la presenza di complici. I giudici di secondo grado non se la
sentirono di dire con certezza che ci fosse qualcun altro, ma non lo esclusero.
E anche Pelosi ammise che c’erano dei complici durante l’intervista con la
Leosini, seppur ampiamente pagato». Secondo il legale, la procura generale, nel
condurre le indagini, «dimostrò chiaramente l’intento di non approfondire ma di
voler bloccare l’inchiesta. Quando il giudice Moro, che aveva capito che non
funzionava niente in quelle piccole indagini fatte in 45 giorni, disse che era
certa la presenza di altri, la procura generale impugnò subito la sentenza,
senza nemmeno attendere le motivazioni – ha aggiunto -. Questo è stato il
segnale che non volevano indagare, perché se si fosse risalito agli esecutori
materiali allora si sarebbe potuto arrivare ai mandanti, che potrebbero essere
anche uomini delle istituzioni. Negli anni ho chiesto la riapertura del caso
cinque volte, perché le indagini vere non sono mai state fatte». Tra i nomi poi
attribuiti ai complici di Pelosi furono fatti anche quelli dei fratelli Franco e
Giuseppe Borsellino, alias Braciola e Bracioletta, trafficanti di droga e
militanti nell’Msi. Un poliziotto infiltrato li aveva anche sentiti vantarsi di
quel delitto ma uscirono dalle indagini dopo aver dichiarato ai magistrati di
essersi inventati tutto per fare i duri. «Di loro parla solo dopo la loro morte
(negli anni 90, ndr) – dice il legale – Erano ormai innocui, mentre Johnny era
ed è ancora pericoloso e rimane l’unico a poter entrare nelle indagini sulla
morte di Pier Paolo». Marazzita non la esclude. «Potrebbe capitare l’occasione,
con magistrati seri, capaci di approfondire. In quel caso, con l’autorizzazione
di Graziella Chiarcossi (la nipote, ndr), la chiederei. E vorrei approfondire i
rapporti tra Pelosi e Mastini, perché e quanto si vedevano, se avevano commesso
reati insieme», ha aggiunto. E la cassetta di sicurezza? «Non esiste. Perché non
è uscita fuori prima?». L’ultimo cenno è al suo rapporto con Pelosi. «Mi vedeva
come un nemico. Aveva paura delle mie domande. Poi, con gli anni, incontrandomi
spesso ha finito per considerarmi uno di famiglia». Ma non abbastanza da
spiegare perché Pasolini è morto. «Quello non lo sapremo mai».
Pier Paolo Pasolini e il
mistero di Petrolio nel film La macchinazione di David Grieco.
Arriva in sala il 24 marzo la pellicola che racconta la stesura del libro e la
morte misteriosa dello scrittore. Nel ruolo del protagonista, Massimo Ranieri.
Mentre il regista fu assistente alla regia di PPP, scrive il 14 marzo 2016
"L'Espresso". «A un certo punto avrò bisogno del tuo aiuto, Alberto», parla così
al telefono con Moravia il Pasolini di David Grieco, nella clip in anteprima del
film La macchinazione, dal 24 marzo nelle sale: «Non so neanche io cosa sto
scrivendo, vado avanti come posseduto da un demonio, ho già superato le 400
pagine e forse arriverò a 2000». «Per ora posso dirti il titolo: Petrolio»,
continua la conversazione tra Moravia e Pasolini, cioè Massimo Ranieri, a cui è
toccato il delicato compito di raccontare gli ultimi giorni di vita
dell’intellettuale, impegnato nel montaggio di Salò e le 120 giornate di
Sodoma e nella stesura del romanzo uscito postumo, atto di accusa che riprende
il libro Questo è Cefis, uscito nel 1972 ma subito scomparso dagli scaffali, in
cui un informato autore sotto pseudonimo ricostruisce «l’altra faccia
dell’onorato presidente», l'altra faccia di Eugenio Cefis, presidente dell’Eni
dopo la morte di Mattei e poi della Montedison, indicato come «il vero capo
della P2». Salò, Petrolio, la relazione con Pino Pelosi, giovane sottoproletario
romano che ha legami con il mondo criminale della capitale. Il 2 novembre 1975,
Pasolini morirà a Ostia. E Grieco, già assistente del cineasta e poeta, con il
suo film si pone la domanda: «Chi ha ucciso Pier Paolo Pasolini?»
Il vero mistero su Pasolini
è capire come il film di David Grieco abbia trovato posto in un cinema.
Quanto volete per smettere? Per lasciare in pace Pier Paolo Pasolini? Tutto
questo tempo sprecato per farlo diventare uno dei misteri d’Italia non sarebbe
meglio adoperato per leggersi qualche poesia, magari sul vincitore dello Strega
che nessuno ricorda l’anno dopo, peggio del vincitore al Festival di Cannes?
Scrive Mariarosa Mancuso il 25 Marzo 2016 su "Il Foglio". Tanto tempo sprecato
per farlo diventare un mistero d’Italia, ripetiamo volentieri, perché le cose
sono andate al contrario: a furia di fare inchieste per stanare scomode verità,
il caso si è ingigantito e l’intrigo si è complicato invece di sbrogliarsi. Fino
al paradosso: il cugino Nico Naldini, di anni 87, uno che non ha mai voluto
sentire parlare di congiure o di complotti (“incidente di percorso in una vita
sregolata”, ha detto più volte) non viene invitato né agli anniversari né alle
celebrazioni. Tutti hanno detto la loro, incluso Walter Veltroni. Massimo
Ranieri ha la parte del poeta nel film di David Grieco “La macchinazione”, ora
nelle sale: è bastato per aggiungersi alla lista dei deliranti. Dopo aver
indossato un giubbotto scamosciato e girato la scena di una partita a calcio in
borgata ha preso anche lui il numeretto e a gran voce ha chiesto la verità su
Pasolini. Uno che si faceva tingere i capelli di nero dalla mamma, racconta il
film, e non si capisce se lo scandalo sta nel nerofumo, o nella tintura
casalinga con la boccetta comprata sugli scaffali del supermercato. Il
complotto, o la congiura, o il grande mistero pasoliniano si estende nel film di
David Grieco fino a comprendere la banda della Magliana (da “Romanzo Criminale”
in poi si porta con tutto). Il mistero più grosso – su cui mancano le indagini –
è sapere come mai un film come questo sia stato scritto, girato, distribuito in
sala, senza che nessuno facesse la minima obiezione. Cinematografica, almeno, se
non di sostanza fanta-criminale. Interessanti anche i retroscena: David Grieco
avrebbe dovuto collaborare con Abel Ferrara, per il suo “Pasolini” presentato
alla Mostra di Venezia nel 2014 (lo stesso anno del ripassino su Giacomo
Leopardi inflitto da Mario Martone). Qualcosa andò storto, e per il gusto della
scissione che caratterizza i cultori di Pier Paolo Pasolini - oltre che la
sinistra italiana – ora si è fatto un film tutto suo (fa coppia con il volume –
sempre firmato David Grieco – uscito da Rizzoli con il titolo “La macchinazione.
Pasolini. La verità sulla morte”). La macchinazione è tanto arzigogolata che
abbiamo vergogna perfino a raccontarla, tra Eugenio Cefis (“lo considero il
demonio dell’Italia d’oggi”, testuale nel film), una sala da biliardo in
periferia, il furto con richiesta di riscatto delle bobine di “Salò - Le 120
giornate di Sodoma”, pagine di “Petrolio” che correggono “bomba alla stazione
Termini” in “bomba alla stazione di Bologna”. Però garantiamo che a vederlo è
peggio.
Pier Paolo Pasolini, la
storia e il mistero irrisolto della morte,
scrive il 29 Ottobre 2015 Emilia Abbo. Pier Paolo Pasolini avvolto in un
mistero. Andiamo a ripercorrere la storia del poeta e nello specifico il caso
irrisolto della morte. Pasolini venne brutalmente ucciso all’idroscalo di Ostia
la notte fra il primo ed il 2 novembre 1975, e pertanto in questi giorni si
celebra il quarantesimo anniversario da quel tragico evento. La mattina del 31
ottobre, ad esempio, il ministro della cultura Dario Franceschini sarà
a Pietralata, un quartiere che era molto caro allo scrittore. Significative
personalità, anche vicine affettivamente allo scrittore (come ad esempio il suo
biografo e cugino Nico Naldini, il suo vecchio amico Giancarlo Vigorelli, nonché
l’italianista Guido Santato, che ne fu il più attento studioso) partono dalla
convinzione che Pasolini divenne, in un certo senso, regista della sua stessa
morte, a causa della vita sregolata e rischiosa che conduceva, e che includeva
la frequentazione dei cosiddetti ‘ragazzi di vita’ delle periferie romane.
Il movente biografico: i
“ragazzi di vita”.
Attraverso la pubblicazione di un diario giovanile, uscito col
titolo Il romanzo di Narciso (1946-7), Pasolini rivela ai lettori la propria
omosessualità. Quando scriveva queste pagine lo scrittore bolognese viveva in
Friuli, nei pressi di Casarsa (la località di cui sua madre era originaria) dove
si era rifugiato all’indomani dell’otto settembre 1943, quando aveva rifiutato
di consegnare le armi ai tedeschi. Il 1945 era stato un anno molto difficile per
Pasolini, per via della perdita del fratello Guido (che era entrato nelle file
del partigianato). Dopo la laurea, conseguita quello stesso anno con una tesi
sul Pascoli, Pasolini trova un posto come insegnante nella scuola media
di Valvassone, ma il 15 ottobre del 1949 verrà denunciato per corruzione di
minorenni, perdendo la cattedra. Anche i dirigenti regionali del PCI, per i
quali Pasolini collaborava dal 1947 sulle pagine del settimanale Lotta e lavoro,
lo espelleranno dal partito. Per sfuggire allo scandalo, Pasolini si rifugia con
la madre a Roma, dove giunge nel gennaio 1950. Il distacco dal mondo contadino
friulano, che verrà da lui sempre mitizzato (non a caso, Pasolini compose poesie
in dialetto casarsese), si accompagnerà ad una nuova presa di consapevolezza.
Alla sua amica Silvana Mauri Ottieri confiderà infatti di sentire ormai sulla
pelle il segno di Rimbaud o di Campana o di Wilde, e quindi di essere destinato
ad un senso di emarginazione e condanna da parte della società. Giunto nella
capitale, la madre prende servizio presso una famiglia come domestica, e
Pasolini si adatta a fare il correttore di bozze ed a vendere i suoi libri
nelle bancarelle rionali. Grazie al poeta Vittorio Clemente, nel dicembre 1951
trova un altro impiego come insegnante a Ciampino. Tuttavia, lo scrittore non
riesce a fare a meno di frequentare l’ambiente periferico ed adolescenziale
delle borgate, che divenne fonte di ispirazione per il suo romanzo Ragazzi di
Vita (1955). Per questo libro Pasolini (accanto alla casa editrice Garzanti)
venne processato, e solo grazie all’intervento di eminenti letterati
come Giuseppe Ungaretti e Carlo Bo (che evidenziarono un senso di umana pietà
misto a crudo realismo) lo scrittore venne assolto. Analoga sorte ebbe il
romanzo Una vita violenta (1955) che intendeva essere una continuazione del suo
progetto ‘sottoproletario’, portato avanti anche nei film Accattone (presentato
al festival di Venezia del 1961) e Mamma Roma (interpretato nel 1962 da Anna
Magnani). Anche in questi capolavori cinematografici i ragazzi delle borgate
romane non hanno alcuna speranza di affrancamento o redenzione, e la morte
diviene l’unica via d’uscita ad un destino di corruttiva miseria e disperazione.
La frequentazione di piccoli malavitosi causerà a Pasolini altri problemi
giudiziari. Nel giugno 1960, ad esempio, Lo scrittore verrà accusato di aver
favoreggiato due ragazzi coinvolti in una rissa, e nel novembre dell’anno
seguente vedrà il suo appartamento perquisito, poiché sospettato di una rapina a
mano armata in un bar di San Felice Circeo. Il responsabile dell’omicidio
Pasolini fu subito ritenuto il diciassettenne reo confesso Giuseppe
Pelosi (soprannominato ‘Pino la rana’), già noto alle forze dell’ordine per vari
furtarelli, e che venne dichiarato colpevole di omicidio doloso nella sentenza
di primo grado. Alla sua versione dei fatti venne aggiunto il ‘concorso con
ignoti’, poi inspiegabilmente smentito dalla corte d’appello il 4 dicembre 1976.
Tuttavia, questa sentenza non é mai stata ritenuta davvero definitiva, anche
perché nel corso del tempo si sono innalzate molte voci (fra cui quella della
scrittrice Oriana Fallaci e del regista Marco Tullio Giordana) a sostegno
dell’omicidio di gruppo, che lasciava spazio ad altri moventi oltre a quello di
un diverbio fra un ‘ragazzo di vita’ ed il suo esigente cliente. Il fatto che il
poeta, quella notte, fosse stato vittima anche (o soltanto) di terzi venne
validato da vari indizi, come ad esempio l’esile corporatura di Pelosi, che al
momento dell’arresto (avvenuto subito dopo il delitto) non aveva significative
ferite o segni di colluttazione sugli abiti. La leggerezza e friabilità
dell’arma del delitto (che fu identificata con una tavola di legno che serviva
ad indicare il numero civico di un’abitazione) sarebbe stata incompatibile con
le ferite che vennero selvaggiamente inferte, e che si addicevano ad un oggetto
assai più pesante e contundente. Nel caso Pasolini, del resto, vi sono state, e
fin dall’inizio, delle gravi negligenze, ed un articolo sull’Europeo del 21
novembre 1975 illustra chiaramente come la scena criminis venne inquinata. La
polizia, accorsa sul posto verso le sette di mattina, non disperse la folla di
curiosi, e non vennero nemmeno indicati i punti esatti dei vari ritrovamenti. La
macchina di Pasolini rimase esposta ad una pioggia insistente, e dopo aver
svolto le prime indagini venne rottamata. Sul luogo del delitto non giunse
nemmeno un medico legale, e sull’adiacente campetto di calcio, che poteva
offrire segni di plantari e pneumatici, venne giocata una partita. Alcuni
oggetti (come ad esempio la camicia e gli occhiali che quella sera Pasolini
indossava) vennero esposti al museo di criminologia di Valle Giulia, ed anche se
in seguito sono stati analizzati con tecniche più moderne e sofisticate (lo
stesso comandante del Ris di Parma, Nicola Garofalo, ha coordinato le perizie) i
risultati rimangono comunque secretati, e non pienamente attendibili a causa
delle negligenze che si verificarono nelle quarantotto ore che seguirono il
delitto. Anche le più fresche testimonianze non ebbero il credito che
meritavano. Assai emblematica rimane quella di un pescatore (immortalata in un
prezioso film-documentario di Mario Martone) che sostenne di avere visto, quella
tragica notte, una seconda auto accanto all’Alfa Romeo di Pasolini, ed udito
voci di diverse persone, oltre al grido disperato dello scrittore che invocava
sua madre. Presente agli atti è la versione della cugina del regista, Graziella
Chiarcossi, secondo la quale il maglione che venne ritrovato sul sedile
posteriore dell’auto non apparteneva a Pasolini. Ma non solo. Il proprietario
della trattoria ‘Biondo Tevere’ ritenne che, quella sera, il poeta era in
compagnia di un giovane che non aveva le stesse caratteristiche fisiche del
diciassettenne di Guidonia. Inoltre, un ex-appuntato dei carabinieri, che
indagava in borghese, mise in evidenza il coinvolgimento di due ragazzini
siciliani (soprannominati ‘fratelli braciola’), che frequentavano lo stesso
circolo ricreativo di Pelosi, e che morirono di malattia negli anni Novanta.
Come se non bastasse, nel maggio 2008 lo stesso Pelosi decise di ritrattare, e
sostenne, durante una trasmissione televisiva, che la sua unica responsabilità
fu quella di avere investito accidentalmente il corpo già inerte di Pasolini,
laddove il delitto vero e proprio venne materialmente eseguito da tre individui
adulti. Aggiunse di aver taciuto fino a quel momento per non esporre i suoi
ormai defunti genitori a ritorsioni. Nonostante questo, la vicenda non prese una
vera e propria svolta, tanto che l’avvocato Nino Marazzita parla ancora oggi di
‘inerzia colpevole’ da parte degli inquirenti (Tusciaweb.it, 26 aprile 2014) e
l’avvocato Guido Calvi (anch’egli incaricato dalla famiglia Pasolini all’epoca
del delitto) ritiene che si sia voluta spegnere la voce del poeta con l’arma
della diffidenza e con ‘risposte sconcertanti’ (Corriere.it, 4 maggio 2010).
Il movente cinematografico:
le bobine di Salò.
Fra le varie teorie sulla morte di Pasolini merita attenzione anche quella che
si profilò grazie alla testimonianza del regista Sergio Citti, il quale asserì
che, poche settimane prima dell’omicidio, Pasolini subì la sparizione di due
bobine cinematografiche (quelle che in gergo sono chiamate ‘pizze’), ovvero di
due copie del suo ultimo film, intitolato Salò. Citti sostenne che quella
fatidica sera del primo novembre Pasolini doveva vedere dei loschi individui,
ovvero i probabili autori del furto, e seppur questo incontro richiedesse un
notevole coraggio, Pasolini era disposto ad affrontarlo lo stesso poiché ci
teneva a recuperare l’insostituibile lavoro di montaggio, che era stato
effettuato con la tecnica del ‘doppio’, ovvero girando le stesse scene anche da
un’inquadratura diversa. Le bobine di questo film, furono probabilmente
sottratte per il loro contenuto scabroso. Pasolini stesso sapeva che questa
pellicola avrebbe suscitato reazioni anche per il suo significato sottilmente
ideologico, poiché si creava una correlazione fra le tematiche dei romanzi
di Sade e la dominazione di massa capitalistica (identificata al kantiano ‘male
radicale’). Mentre girava questo suo ultimo film, forse Pasolini avvertiva
l’avvicinarsi della sua morte. Non a caso, volle accanto a sé figure amiche,
come l’attrice Laura Betti (nel ruolo di doppiatrice) e poi anche
l’affezionato Ninetto Davoli e lo stesso Sergio Citti, per il quale fu questo
film a rendere reali quelle paure che il regista aveva già allontanato
con stoico distacco: La morte compie un fulmineo montaggio nella nostra vita:
ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi <…> e li mette in
successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile ed incerto, un
passato chiaro, stabile, certo e dunque linguisticamente ben descrivibile (Pier
Paolo Pasolini, Empirismo Eretico).
Il movente
letterario: “Lampi su Eni”.
Un’interessante teoria è quella legata alla cosiddetta ‘questione Eni‘, poiché
direttamente riconducibile al lavoro letterario che l’autore, al momento della
sua morte, stava svolgendo con la casa editrice Einaudi. Nel romanzo-inchiesta
(rimasto incompiuto) Petrolio, che venne pubblicato postumo nel 1992 (e del
quale restano 522 pagine) si delinea una lotta di potere che avviene nel settore
petrol-chimico. La finzione del romanzo è riconducibile ad un reale fatto di
cronaca, ovvero alla morte del presidente dell’Eni Enrico Mattei, che avvenne
nel 1967, quando l’aereo su cui si trovava a bordo perse quota sulla campagna
pavese. Pasolini giunse, con trent’anni di anticipo, alle stesse conclusioni del
magistrato Vincenzo Calia, che chiese l’archiviazione del caso nel 2003. Per
Pasolini la morte di Mattei non fu causata da un fatale incidente, ma semmai da
un sabotaggio, da ricondursi agli intrighi dell’ambizioso personaggio che nel
suo romanzo rappresenta Eugenio Cefis, il quale divenne presidente della
Montedison nel 1971, dopo aver co-fondato l’Eni assieme allo stesso Mattei.
Anche la scomparsa del giornalista Mauro de Mauro, che stava preparando un
dossier per il regista Francesco Rosi (il quale decise di girare un film sul
caso Mattei) potrebbe essere legata a qualche scottante notizia non dissimile
dalla teoria portata avanti in Petrolio. Pasolini ebbe come sua fonte il
libro Questo é Cefis, l’altra faccia dell’onorato Presidente, pubblicato nel
1972 sotto lo pseudonimo Giorgio Steimez, e che venne subito ritirato dalla
circolazione, ma del quale Pasolini aveva una versione in fotocopia grazie al
suo amico Elvio Facchinelli. Per Pasolini Mattei non era un un anacronistico
utopista-statalista, ma piuttosto un lungimirante imprenditore, pieno di
entusiasmo e di positive risorse, che aveva già evitato la vendita
dell’Agip negli anni Quaranta. Mattei proponeva ai paesi arabi ed africani
(principali produttori di greggio) condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
proposte dai trust anglo-americani del petrolio, mettendosi quindi in aperta
competizione con le cosiddette ‘sette sorelle’, ovvero con le potenti
multinazionali nella cui orbita atlantica Cefis voleva invece ricondurre
l’economia della nostra nazione. Tuttavia, fu un capitolo in particolare,
intitolato ‘Lampi su Eni’, che venne indicato come probabile movente della morte
dello scrittore. Il 2 marzo 2010 il senatore Marcello Dell’Utri (all’epoca
ancora in attesa di sentenza definitiva) sostenne, durante una conferenza
stampa, di aver visto coi suoi occhi le pagine in questione, che si riteneva non
fossero mai state scritte, e nelle quali sarebbero state fornite informazioni
più specifiche sull’omicidio Mattei. Aggiunse che questo capitolo, altrimenti
detto ‘appunto 21’, sarebbe stato sottratto dallo studio di Pasolini, ed avrebbe
fatto la sua comparsa, nei giorni a venire, alla XXI fiera milanese del libro
antico. Anche se questo in realtà non avvenne, su iniziativa
dell’onorevole Walter Veltroni (il quale scrisse una lettera aperta all’allora
ministro della giustizia Angelino Alfano) un nuovo fascicolo venne aperto sul
caso Pasolini. Tuttavia, nulla di nuovo emerse a riguardo, anche se i legami di
Cefis con la loggia massonica della P2 (che era implicata in quella ‘strategia
della tensione’ della quale Pasolini parlava senza remore) davano adito ad altri
nuovi ed inquietanti scenari.
Il movente giornalistico:
il coraggio “corsaro”.
Comprendere il delitto Pasolini é quindi impossibile se si prescinde
dall’ideologia dello scrittore, che viene apertamente espressa nei suoi Scritti
corsari (1972) dove, senza troppa arte diplomatica, vengono compiute
dissacratorie incursioni nel mondo politico-istituzionale, ed anche nella
società nel suo complesso. In questi scritti (che raccolgono soprattutto gli
articoli giornalistici che Pasolini scrisse per il Corriere della
Sera ed Il Tempo) la marxista critica al capitalismo (ed il conseguente
rimpianto per la civiltà pre-industriale) vengono espressi in modo unico ed
originale, sia per lo stile (assolutamente chiaro, lineare, coerente,
inequivocabile) e sia per i costanti riferimenti alla propria esperienza.
Pasolini traspone in schietti pensieri teorici (ed anche in polemici commenti)
le sue personali e soggettive impressioni, i dettagli e le situazioni che vede e
vive intorno a sé. Questi scritti sono quindi corsari sia per la coraggiosa
genuinità dell’autore e sia perché evocano, seppur indirettamente, un mondo
romanzesco ed avventuroso, creato per appassionare le giovani generazioni.
Pasolini evidenzia come, negli anni Settanta, i giovani abbiano invece perso
ogni vitale entusiasmo, ogni segno particolare, e si siano borghesemente
omologati. Nella sua tendenza a contrapporre i tempi, Pasolini rievoca
i capelloni degli anni Sessanta, che nulla avevano a che fare con quelli del
decennio seguente, che hanno ormai perso la potenzialità semantica dei loro
gesti ed atteggiamenti, ed anche ogni espressività e coloritura gergale. Secondo
l’autore, si é dunque verificata una ‘mutazione antropologica’, poiché i
giovani, nella loro ‘ansiosa volontà di uniformarsi’, non solo sono diventati
simili nella loro ‘sottocultura’ esteriore, ma anche nel modo di parlare e di
pensare (dal centro alla periferia, dal nord al sud, dallo studente
all’operaio), cosicché anche le ideologie si confondono, ‘secondo un codice
interclassista’. Pasolini ritiene che il maggior errore delle nuove generazioni
sia stato quello di non aver mantenuto un dialogo coi loro padri, e quindi di
non aver potuto (dialetticamente e non solo) superare i loro limiti, le loro
colpe. Lo spirito di ribellione ha spinto i giovani a mettersi nelle mani di un
‘nuovo fascismo’ (definito consumistico-edonistico) assai peggiore del
precedente, poiché deforma sottilmente le coscienze e mercifica i corpi. Per
Pasolini, il fascismo mussoliniano dei padri era un fenomeno soprattutto
‘pagliaccesco’, poiché una volta tolte le uniformi e le divise tutti tornavano
identici a prima, coi loro stessi valori e le loro stesse idee. Questo tipo di
fascismo diventa per lui anche archeologico, poiché gli obsoleti comizi in
piazza nulla avevano a che fare coi messaggi pubblicitari del nuovo
bombardamento ideologico televisivo, che si instilla nell’anima in modo subdolo,
imponendosi nel profondo: E’ in Carosello onnipotente che esplode in tutto il
suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà il nuovo tipo di vita che
gli italiani ‘devono’ vivere (Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, ed.
Garzanti, 2015, p. 59). Pasolini riteneva che la manipolazione
pubblicitaria rappresentasse la fine del linguaggio umanistico, e quindi che un
nuovo modo di esprimersi (tecnico, pragmatico, standard) stesse prendendo piede.
Lo slogan Jeans Jesus. Non avrai altri jeans all’infuori di me esemplifica il
modo in cui la nuova civiltà ‘consumistica-edonistica’ ha strumentalizzato
quella dimensione spirituale che prima apparteneva alla Chiesa. Seppur per
Pasolini quest’ultima non sia incolpevole nella sua opulenza e nella sua lunga
storia di potere, non merita comunque di venire spodestata da una tirannia che
non ha alcun rispetto per quel messaggio che egli stesso volle rappresentare, in
tutta la sua sublime semplicità, nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964). Per
Pasolini i giovani stanno dunque vivendo il più repressivo totalitarismo che si
sia mai visto, poiché l’apparente libertà democratica che si respira non è stata
ottenuta attraverso una rivoluzione popolare (come è avvenuto, ad esempio,
nella Russia del 1917) ma è stata imposta dall’alto coi suoi modelli da seguire:
Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di
tolleranza. L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è una falsa
uguaglianza ricevuta in regalo (idem, p.60). Se il mondo contadino
pre-industriale si basava su necessità primarie (come il pane che era già una
benedizione ad averlo) la nuova società dei consumi, nel suo bisogno di
perseguire il superfluo, non solo ha immiserito il paesaggio circostante (nel
quale sono ormai scomparse le lucciole) ma anche la capacità di recepire, di
sentire. Se quest’ultima fosse rimasta intatta, anche ‘una Seicento o un
frigorifero, oppure un week-end ad Ostia’ potrebbero essere interpretati con
poesia e passione, nello stesso modo in cui Leopardi interiorizzava ‘la natura e
l’umanità nella loro purezza ideale’. Pasolini amava profondamente quel senso
di ingenua spensieratezza che caratterizzava i non acculturati, e che ora vede
soltanto umiliati. Simbolo di questa antica felicità dei ragazzi del popolo
diviene il garzoncello del fornaio: Una volta il fornarino, o cascherino-come lo
chiamiamo qui a Roma-era sempre, eternamente allegro: un’allegria vera, che gli
sprizzava dagli occhi. Se ne andava in giro per le strade fischiettando e
lanciando motti. La sua vitalità era irresistibile. Era vestito molto più
poveramente di adesso: i calzoni erano rattoppati, addirittura spesse volte la
camicia uno straccio. Però tutto ciò faceva parte di un modello che nella sua
borgata aveva un valore, un senso. Ed egli ne era fiero. Al mondo della
ricchezza egli aveva da opporre un proprio mondo altrettanto valido. Giungeva
nella casa del ricco con un riso naturaliter anarchico, che screditava tutto:
benché egli fosse magari rispettoso. Ma era appunto il rispetto di una persona
profondamente estranea. E insomma, ciò che conta questa persona, questo ragazzo,
era allegro. (idem, p.61). Secondo Pasolini, anche lo stragismo di quegli anni
(fra cui l’attentato di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969) è
espressione della nevrosi che deriva dal conformismo. Per Pasolini i veri
responsabili degli atti terroristici non erano dei giovani sbandati e senza
validi punti di riferimento, ma semmai il sistema governativo nel suo complesso,
poiché il fatto stesso di far parte del tessuto politico implica il corrompersi,
il divenire conniventi. Pasolini, nel famoso articolo del 1974 Che cos’è questo
golpe? afferma di conoscere i nomi dei veri responsabili delle stragi, ma di non
poterli rivelare poiché (in quanto personalità estranea ai giochi di potere) non
ha ‘né prove né indizi’, ma solo la certezza del suo intuito di uomo
intellettuale, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentati di un
intero quadro politico (idem, p.89). Pasolini riconduceva il termine stragismo
anche alla pratica dell’aborto, che ritiene una tragedia demografica ecologica,
ovvero uno minaccia alla sopravvivenza dell’umanità. Pasolini evidenzia che
nell’ambito del ‘nuovo fascismo’ un figlio che nasce non è più considerato un
dono di Dio, ma soltanto un fastidio, poiché prevale il timore dell’essere in
troppi nella spartizione dei beni di consumo. Piuttosto che rinunciare ai propri
capricci, si preferisce eliminare chi è più debole ed indifeso. Per Pasolini
l’aborto è una colpa morale, un qualcosa che riguarda non la politica ma
la coscienza individuale. La logica dell’eugenetica non ha nulla a che fare con
la democraticità dello stato prenatale, con la sua piena ed incondizionata
aderenza alla vita: Non c’è nessuna buona ragione pratica che giustifichi la
soppressione di un essere umano, sia pure nei primi stadi della sua evoluzione.
Io so che in nessun altro fenomeno dell’esistenza c’è un altrettanto furibonda,
totale essenziale volontà di vita che nel feto. La sua ansia di attuare la
propria potenzialità, ripercorrendo fulmineamente la storia del genere umano, ha
un qualcosa di irresistibile e perciò di assoluto e gioioso. (idem, p.111).
Sono parecchi gli articoli in cui Pasolini permalosamente se la prende coi suoi
critici o detrattori, e che sono, a loro volta, intellettuali (spesso di
sinistra come lui) e anche di tutto rispetto, come ad esempio Umberto
Eco, Giorgio Bocca, Italo Calvino, Giuseppe Prezzolini, Franco Rodano, Maurizio
Ferrara. Secondo Pasolini, anche il mondo intellettuale era chiuso nel suo
ristretto snobismo: Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un
intellettuale. Lo so perché in parte è anche la mia vita. Letture, solitudini
al laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti
intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io,
come il dottor Hyde, ho un’altra vita. Nel vivere questa vita, devo rompere le
barriere naturali (e innocenti) di classe. Sfondare le pareti dell’Italietta, e
sospingermi quindi in un altro mondo: il mondo contadino, il mondo
sottoproletario e il mondo operaio (idem, p.52). Per Pasolini l’unico suo vero
impegno diviene quello preso col lettore, che ritiene all’altezza di accettarlo
nel bene e nel male, di accompagnarlo nelle sue più smodate ed indomite
incursioni: Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza: se non quella che
mi proviene paradossalmente dal non averla e dal non averla mai voluta;
dall’essermi messo in condizione di non aver niente da perdere, e quindi di non
essere fedele a nessun patto che non sia quello di un lettore che io considero
del resto degno di ogni più scandalosa ricerca (idem, p.83).
Alberto Moravia, durante la
celebre orazione funebre in onore di Pasolini, mise in evidenza che era stato
innanzi tutto perso un poeta, ovvero un qualcuno che nasce di rado nel corso dei
secoli.
"<…> Piange ciò che ha
fine e ricomincia. Ciò che era
area erbosa, aperto spiazzo, e
si fa
cortile, bianco come cera,
chiuso in un decoro ch’é
rancore;
ciò che era quasi una vecchia
fiera
di freschi intonachi sghembi
al sole,
e si fa nuovo isolato,
brulicante
in un ordine ch’é spento
dolore.
Piange ciò che muta, anche
per farsi migliore. La luce
del futuro non cessa un solo
istante
di ferirci: é qui, che brucia
in ogni nostro atto
quotidiano,
angoscia anche nella fiducia
che ci dà vita, nell’impeto
gobettiano
verso questi operai, che muti
innalzano,
nel rione dell’altro fronte
umano,
il loro rosso straccio di
speranza."
(Pier Paolo Pasolini Il pianto
della scavatrice, 1956)
Ninetto Davoli: "Il mio
Totò segreto".
I ricordi dell'attore che recitò negli ultimi film del Principe girati da
Pasolini: "Pier Paolo mi disse che avrebbe potuto superare Chaplin", scrive
Ilaria Urbani il 14 aprile 2017 su “La Repubblica”. "Totò senta...". "Dite
Pasolini...". "Antonio si sciolga, faccia una "totolata"". Gli sembra ancora di
averli davanti agli occhi sul set di "Uccellacci e uccellini". Ninetto Davoli,
dopo mezzo secolo, ha ancora vivido il ricordo del confronto tra la più grande
maschera del '900 e il regista corsaro. E nel racconto dell'ex ragazzo di
borgata della baraccopoli Borghetto Prenestino, scoperto da Ppp, sembra di
rivedere anche padre e figlio Innocenti in quell'infinito cammino in bianco e
nero sul set di una pellicola considerata dallo stesso Pasolini "disarmata,
fragile". E di ritrovare pure frate Ciccillo e frate Ninetto. Davoli, dalle
borgate al set del capolavoro poetico e picaresco, svolta colta nella carriera
del Principe. Un incontro epifanico con quell'attore che Ninetto fino ad allora
vedeva al cinema con gli amici. Un sodalizio che proseguì ne "La terra vista
dalla luna" da "Le streghe" e in "Che cosa sono le nuvole?", dal film
""Capriccio all'italiana", l'ultimo girato da Totò prima di morire il 15 aprile
1967.
Davoli, cosa ha significato
per lei Totò?
"Avevo 16 anni, Totò è stato
fondamentale per iniziare quest'avventura, mi ha incoraggiato davanti alla
cinepresa, ha alleggerito questa esperienza. Successe tutto all'improvviso, era
così surreale trovarmi a recitare con il grande Totò, uno che andavo a vedere al
cinema come Stanlio e Ollio. Ma questa volta non dovevo pagare per vederlo, era
lì con me, ed ero pagato per recitare con lui. Mi davano 100mila lire, a uno
povero come me. Facevo il falegname, a casa eravamo in sei in una sola stanza,
vivevamo con 5mila lire alla settimana".
Totò come si rapportava sul
set con questo giovane esordiente?
"Come me veniva dalla povertà,
lui dai quartieri scalcinati di Napoli, io dalle borgate romane, ideologicamente
la pensavamo uguale. Il nostro fu uno scambio di semplicità, una vera
complicità. Secondo Pier Paolo ci somigliavamo. Considerava Totò uno di strada
come me, un non -intellettuale, anche se lo rispettava molto, gli dava del lei:
"Totò senta", "Antonio ascolti"... ".
E Totò nei confronti di
Pasolini?
"Anche Totò gli dava del voi:
era intimorito da Pier Paolo, non improvvisava come faceva in genere, ma
rispettava la sceneggiatura. Pier Paolo gli diceva: Antonio si sciolga, faccia
una "totolata". C'era grande stima".
Pasolini racconta di aver
scelto Totò per quella perfetta armonia tra l'assurdità clownesca tipica delle
favole e l'immensamente umano...
"A Pier Paolo piacevano i film
di Totò e diceva che avrebbe potuto superare Charlie Chaplin se l'avessero
saputo "usare meglio", nel senso se avesse fatto più film d'autore".
Nel '66 Pasolini scrisse un
film sull'utopia, "Le avventure del Re magio randagio", che lei doveva
interpretare con Totò, ma poi non si fece in tempo e che poi ha ispirato un film
di Sergio Citti...
"Sì, ma quella di Pier Paolo
era una storia diversa, non c'entra con quella di Citti. Totò doveva essere il
Re magio e io il suo aiutante. Con un dono partivamo da Napoli alla ricerca di
Cristo che stava per nascere. Attraversavamo Roma, Milano, Parigi, New York e
poi arrivavamo a Betlemme, ma trovavamo Cristo già morto. Dopo la scomparsa di
Totò, Pasolini voleva Eduardo (il titolo diventò "Porno-Teo-Kolossal", ndr), ma
poi è successo quello che è successo...".
Oggi chi è in grado di
raccogliere l'eredità di Totò e Pasolini?
"Non esiste nessuno con quella
potenza e quel coraggio. Totò e Pier Paolo vengono celebrati soprattutto da
morti, ricordiamo che Totò veniva massacrato dai critici. Sono accomunati da un
destino simile. Trovo giusto celebrare Totò a 50 anni dalla morte, ma mi chiedo
perché non prima? Totò andrebbe studiato di più nelle scuole, così come Pier
Paolo ed Eduardo".
Totò.
Da Wikipedia, l'enciclopedia
libera. «Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni,
elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in
cui però per venire riconosciuti in qualcosa, bisogna morire.» (Franca Faldini,
citando le parole del compagno Totò). «Ma mi faccia il piacere!», « ...
bazzecole, quisquilie, pinzellacchere!» (Modi di dire di Totò).
Antonio De Curtis, in
arte Totò. Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno
Porfiro-genito Gagliardi de Curtis di Bisanzio (brevemente Antonio de Curtis)
(Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un artista italiano.
Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe
della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei
maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. Si distinse
anche al di fuori della recitazione, lasciando contributi
come drammaturgo, poeta, paroliere, cantante. Nato Antonio Vincenzo Stefano
Clemente da Anna Clemente (Palermo, 2 gennaio 1881 - Napoli, 23 ottobre 1947) e
dal marchese Giuseppe De Curtis (Napoli, 12 agosto 1873 - Roma, 29 settembre
1944), fu adottato nel 1933 dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di
Tertiveri. Maschera nel solco della tradizione della commedia dell'arte,
accostato a comici come Buster Keaton e Charlie Chaplin, ma anche ai fratelli
Marx e a Ettore Petrolini. In quasi cinquant'anni di carriera spaziò dal teatro
(con oltre 50 titoli) al cinema (con 97 pellicole) e alla televisione (con 9
telefilm e vari sketch pubblicitari), lavorando con molti tra i più noti
protagonisti dello spettacolo italiano e arrivando a sovrastare con numerosi
suoi film i record d'incassi. Adoperò una propria unicità interpretativa, che
risaltava sia in copioni puramente brillanti sia in parti più impegnate, sulle
quali si orientò soprattutto verso l'ultima fase della sua vita, che concluse in
condizioni di quasi cecità a causa di una grave forma di corioretinite,
probabilmente aggravata dalla lunga esposizione ai fari di scena. Spesso
stroncato dalla maggior parte dei critici cinematografici, fu ampiamente
rivalutato dopo la morte, tanto da risultare ancor oggi il comico italiano più
popolare di sempre. Franca Faldini, sua compagna, diventata giornalista e
scrittrice dopo la morte dell'attore, scrisse nel 1977 il libro Totò: l'uomo e
la maschera, realizzato insieme a Goffredo Fofi, in cui raccontò sia il profilo
artistico sia la vita dell'attore fuori dal set, con l'intento principale di
smentire alcune false affermazioni riportate da scrittori e giornalisti riguardo
alla sua personalità.
Totò nacque il 15
febbraio 1898 nel rione Sanità (un quartiere considerato il centro della
“guapperia” napoletana), in via Santa Maria Antesaecula al secondo piano del
civico 109, da una relazione clandestina di Anna Clemente con Giuseppe De Curtis
che, in principio, per tenere segreto il legame, non lo riconobbe, risultando
dunque per l'anagrafe "Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di N.N." Nato
Antonio Clemente, ma conosciuto nel suo quartiere con il nomignolo di "Totò",
che gli fu attribuito dalla madre.
Il marchese Giuseppe De
Curtis, il padre di Totò che, inizialmente, non lo riconobbe come figlio
naturale.
Anna Clemente, la madre, che
tentò di introdurlo come sacerdote. «Meglio ‘nu figlio prevete ca ‘nu figlio
artista», affermava.
Solitario e di indole
malinconica, crebbe in condizioni estremamente disagiate e fin da bambino
dimostrò una forte vocazione artistica che gli impediva di dedicarsi allo
studio, cosicché dalla quarta elementare fu retrocesso in terza. Ciò non creò in
lui molto imbarazzo, anzi intratteneva spesso i suoi compagni di classe con
piccole recite, esibendosi con smorfie e battute. Il bambino riempiva spesso le
sue giornate osservando di nascosto le persone, in particolare quelle che gli
apparivano più eccentriche, cercando di imitarne i movimenti, e facendosi
attribuire così il nomignolo di «'o spione». Questo suo curioso metodo di
"studio" lo aiutò molto per la caratterizzazione di alcuni personaggi
interpretati durante la sua carriera.
Terminate le elementari, venne
iscritto al collegio Cimino, dove per un banale incidente con uno dei
precettori, che lo colpì involontariamente con un pugno, il suo viso subì una
particolare conformazione del naso e del mento; un episodio che caratterizzò in
parte la sua "maschera". Nel collegio non fece progressi, decise di abbandonare
prematuramente gli studi senza ottenere perciò la licenza ginnasiale. La madre
lo voleva sacerdote, in un primo tempo dovette quindi frequentare la parrocchia
come chierichetto, ma incoraggiato dai primi piccoli successi nelle recite in
famiglia (chiamate a Napoli «periodiche») e attratto dagli spettacoli di
varietà, nel 1913, ancora in età giovanissima, iniziò a frequentare i teatrini
periferici esibendosi – con lo pseudonimo di "Clerment" – in macchiette e
imitazioni del repertorio di Gustavo De Marco, un interprete napoletano dalla
grande mimica e dalle movenze snodate, simili a quelle d'un burattino. Proprio
su quei palcoscenici di periferia incontrò attori come Eduardo De
Filippo, Peppino De Filippo e i musicisti Cesare Andrea Bixio e Armando Fragna.
Durante gli anni della prima
guerra mondiale si arruolò volontario nel Regio Esercito venendo assegnato
al 22º Reggimento fanteria, rimanendo di stanza dapprima a Pisa e poi
a Pescia. Venne quindi trasferito al CLXXXII Battaglione di milizia
territoriale, unità di stanza in Piemonte, ma destinate a partire per il fronte
francese. Alla stazione di Alessandria, il comandante del suo battaglione lo
armò di coltello e lo avvertì che avrebbe dovuto condividere i propri
alloggiamenti in treno con un reparto di soldati marocchini dalle strane e
temute abitudini sessuali. Totò a quel punto, terrorizzato, fu colto da
malore (secondo alcune voci improvvisò un attacco epilettico) e venne ricoverato
nel locale ospedale militare, evitando così di partire per la Francia. Rimasto
in osservazione per breve tempo, quando fu dimesso dalle cure ospedaliere venne
inserito nell'88º Reggimento fanteria "Friuli" di stanza a Livorno; proprio in
quel periodo subì continui soprusi e umiliazioni da parte di un graduato; da
quell'esperienza nacque il celebre motto dell'attore: «Siamo uomini o
caporali?».
Dopo il servizio militare
avrebbe dovuto fare l'ufficiale di marina, ma, non digerendo la
disciplina, scappò di casa per esibirsi ancora come macchiettista; venne
scritturato dall'impresario Eduardo D'Acierno (diventò poi celebre la macchietta
de Il bel Ciccillo, riproposta nel 1949 nel film Yvonne la nuit) e ottenne un
primo successo alla Sala Napoli, locale minore del capoluogo campano, con una
parodia della canzone di E. A. Mario Vipera, intitolata Vicolo, che aveva
sentito recitare al Teatro Orfeo dall'attore Nino Taranto, al quale chiese se
poteva "rubargliela".
All'inizio degli anni Venti il
marchese Giuseppe De Curtis riconobbe Totò come figlio e regolarizzò la
situazione familiare sposandone la madre. Riunita, la famiglia si trasferì
a Roma, ove Totò, con la disapprovazione totale dei genitori, fu scritturato
come "straordinario" - cioè un elemento da utilizzare occasionalmente e senza
nessun compenso - nella compagnia dell'impresario Umberto Capece, un reparto
composto da attori scadenti e negligenti. Si affacciò così alla commedia
dell'arte e guadagnò un particolare apprezzamento del pubblico impersonando sul
palco l'antagonista di Pulcinella. Tuttavia, il giovane si sacrificava non poco
per raggiungere il teatro: dal momento che non aveva i soldi neanche per un
biglietto del tram, doveva partire da Piazza Indipendenza per arrivare a Piazza
Risorgimento, che si trovava dall'altra parte della città; a tal proposito,
nella stagione invernale, chiese qualche moneta all'impresario Capece che, in
modo esageratamente brusco e inaspettato, lo esonerò e lo sostituì all'istante
con un altro "straordinario". L'episodio fu un duro colpo per Totò, che rimase
esterrefatto e dopo aver raccolto i suoi effetti si allontanò a malincuore dal
teatro.
In quel breve periodo di
disoccupazione Totò piombò nello sconforto totale ed il suo morale si alzava
solo quando riusciva a racimolare qualche soldo esibendosi in piccoli locali;
nel corso di quelle esperienze, decise di puntare al genere teatrale a lui più
congeniale: il varietà (variété, nella declinazione francese). Progettò di
presentarsi al capocomico napoletano Francesco De Marco (famoso per delle
stravaganti esibizioni teatrali), ma all'ultimo minuto ebbe un ripensamento,
probabilmente a causa dell'insicurezza. L'attore iniziò a ponderare l'idea di
esibirsi da solo e dunque decise di mantenere come modello d'ispirazione Gustavo
De Marco (omonimo, ma non parente del capocomico Francesco), che Totò,
esercitandosi davanti allo specchio, riusciva ad imitare senza particolari
sforzi. Appena sentitosi pronto, decise di tentare al Teatro Ambra Jovinelli,
che al tempo era la massima rappresentazione dello spettacolo di varietà, dove
erano passati artisti come Ettore Petrolini, Raffaele Viviani, Armando
Gill, Gennaro Pasquariello, Alfredo Bambi e lo stesso De Marco. Emotivamente
teso, si presentò al titolare del teatro, Giuseppe Jovinelli, un uomo rude
conosciuto e rispettato per un suo passato scontro con un piccolo boss della
malavita locale. Il breve colloquio andò inaspettatamente bene e Totò, per sua
gioia e incredulità, venne preso. Debuttò con tre macchiette di De Marco: Il bel
Ciccillo, Vipera e Il Paraguay, che ebbero un buon successo di pubblico e un
impensabile entusiasmo da parte di Jovinelli. Il comico firmò un contratto
prolungato col titolare, che lo usò spesso in varie parti dello spettacolo e che
organizzò addirittura un finto match tra lui e il pugile Oddo Ferretti. Il
consenso del pubblico ottenuto al teatro non compensava però lo stile di vita
dell'artista: la paga era molto bassa e non poteva neanche permettersi abiti
eleganti e accessori raffinati (ai quali lui teneva molto) o un taglio di
capelli caratteristico, con le basette come quelle di Rodolfo Valentino. In
quell'arco di tempo fece appunto amicizia con un barbiere, Pasqualino, il quale,
avendo conoscenze in campo teatrale e impietosito dalle ristrettezze economiche
del giovane, riuscì a farlo scritturare da Salvatore Cataldi e Wolfango
Cavaniglia, i proprietari del Teatro Sala Umberto I. Totò rinnovò il suo corredo
teatrale (che fino a quel momento era composto da un singolo abito di scena
sempre più consumato): una logora bombetta, un tight troppo largo, una camicia
lisa con il colletto basso, una stringa di scarpe per cravatta, un paio di
pantaloni corti e larghi a zompafosso, calze colorate e comuni scarpe basse e
nere. La sera dell'esordio l'attore diede il meglio di sé, lasciandosi andare in
mimiche facciali, piroette, doppi sensi e le immancabili macchiette di Gustavo
De Marco. Tra grida di bis ed applausi, l'esperienza al salone Umberto I segnò
per Totò l'affermazione definitiva nello spettacolo di varietà.
Tra il 1923 e il 1927 si esibì
nei principali caffè-concerto italiani, facendosi conoscere anche a livello
nazionale. Grazie ai maggiori guadagni, poté finalmente permettersi di vestire
abiti eleganti e di curare maggiormente il suo aspetto fisico, con i capelli
impomatati e le desiderate basette alla Rodolfo Valentino; fu un periodo roseo
soprattutto per quanto riguarda le donne, con le quali ebbe una serie di
avventure (per lo più con sciantose e ballerine), tanto che acquisì presto la
fama di vero «sciupafemmene». Prima di iniziare un suo spettacolo, sbirciava
sempre tra il pubblico alla ricerca della "bella di turno" alla quale dedicare
la sua esibizione, che il più delle volte, dopo varie serate, lo raggiungeva nel
suo camerino durante l'intervallo o al termine dello spettacolo.
Nel 1927 fu scritturato da
Achille Maresca, titolare di due diverse compagnie; Totò entrò a far parte prima
della compagnia di cui era primadonna Isa Bluette, una delle soubrette più in
voga del periodo, e poi, dal 1928 di quella di Angela Ippaviz; gli autori erano
"Ripp" (Luigi Miaglia) e "Bel Ami" (Anacleto Francini). Nella prima compagnia
conobbe Mario Castellani, destinato a diventare in seguito una delle sue
"spalle" più fedeli ed apprezzate. Nel 1929, mentre si trovava a La Spezia con
la compagnia di Achille Maresca, venne contattato dal barone Vincenzo Scala, il
titolare del botteghino del teatro Nuovo di Napoli, che fu mandato
dall'impresario Eugenio Aulicio per scritturarlo come "vedette" in alcun
spettacoli di Mario Mangini e di Eduardo Scarpetta, tra cui Miseria e
nobiltà, Messalina e I tre moschettieri (dove impersonò d'Artagnan), accanto
a Titina De Filippo. Messalina rimase particolarmente impresso negli occhi del
pubblico, in quanto Totò improvvisò una scenetta in cui si arrampicò su per il
sipario e fece smorfie e sberleffi agli spettatori, i quali andarono totalmente
in visibilio.
Le soddisfazioni professionali
dell'attore non andavano però di pari passo con quelle sentimentali. Nonostante
il suo successo con le donne e le numerose avventure, si sentiva inappagato.
Fino a quando non irruppe nella sua vita Liliana Castagnola, che Totò vide su
alcune fotografie in un provocante abito di scena, rimanendone subito
colpito. La sciantosa, fino a quel momento, era stata costante oggetto delle
cronache mondane: fu espulsa dalla Francia con l'accusa di aver indotto due
marinai al duello, e un suo amante geloso si tolse la vita dopo averle sparato
due colpi di pistola, uno dei quali l'aveva ferita al viso lasciandole un
frammento di proiettile che le causava forti dolori e per i quali assumeva
tranquillanti. A causa della cicatrice, sebbene lieve, ella adottò la
pettinatura "a caschetto" che le copriva guance e fronte. La donna giunse a
Napoli nel dicembre 1929, scritturata dal Teatro Nuovo, e incuriosita dal veder
recitare l'artista napoletano si presentò una sera ad un suo spettacolo. Totò
non si lasciò sfuggire l'occasione e iniziò a corteggiarla mandandole, alla
pensione degli artisti dove lei abitava, mazzi di rose con un biglietto
d'ammirazione, al quale lei rispose con una lettera d'invito. Furono questi gli
inizi di un'intensa (seppur breve e tormentata) storia d'amore. Sebbene fosse
una donna fatale sia sul palcoscenico sia nella vita reale, la Castagnola aveva
per l'artista napoletano un sentimento sincero e passionale, cercando una
relazione stabile e sicura. Dopo il primo periodo iniziarono i problemi legati
alla gelosia: Totò non sopportava l'idea che Liliana, durante le sue tournée,
fosse corteggiata dagli ammiratori e questo lo portò a temere eventuali
tradimenti, situazione che diede origine a continui litigi. Entrambi furono poi
vittime di malelingue e pettegolezzi, la donna entrò in un profondo stato di
depressione e la loro relazione si deteriorò. Liliana, accrescendo un senso di
attaccamento morboso al suo uomo, pur di restargli accanto propose di farsi
scritturare nella sua stessa compagnia; ma Totò, sentendosi oppresso dal
comportamento della donna, fu più volte sull'orlo di lasciarla, fino a quando
decise di accettare un contratto con la compagnia della soubrette "Cabiria", che
lo avrebbe portato a Padova.
L'epilogo fu che Liliana,
sentitasi abbandonata dall'amato, si suicidò ingerendo un intero tubetto di
sonniferi. Fu trovata morta nella sua stanza d'albergo, con al suo fianco una
lettera d'addio a Totò: «Antonio, potrai dare a mia sorella Gina tutta la roba
che lascio in questa pensione. Meglio che se la goda lei, anziché chi mai mi ha
voluto bene. Perché non sei voluto venire a salutarmi per l'ultima volta?
Scortese, omaccio! Mi hai fatto felice o infelice? Non so. In questo momento mi
trema la mano... Ah, se mi fossi vicino! Mi salveresti, è vero? Antonio, sono
calma come non mai. Grazie del sorriso che hai saputo dare alla mia vita grigia
e disgraziata. Non guarderò più nessuno. Te l'ho giurato e mantengo. Stasera,
rientrando, un gattaccio nero mi è passato dinnanzi. E, ora, mentre scrivo, un
altro gatto nero, giù per la strada, miagola in continuazione. Che stupida
coincidenza, è vero?... Addio. Lilia tua»
Totò, che ritrovò il corpo
esanime della donna il mattino seguente, ne rimase sconvolto: il peso della
responsabilità, il non aver capito l'intensità dei sentimenti di lei e i rimorsi
per aver pensato «ha avuto molti uomini, posso averla senza assumermi alcuna
responsabilità», lo accompagnarono per tutta la vita, tanto che decise di
seppellirla nella cappella dei De Curtis a Napoli, nella tomba sopra la sua, e
decretò che, qualora avesse avuto una figlia, invece di battezzarla col nome
della nonna paterna Anna (secondo l'uso napoletano), le avrebbe dato il nome di
Liliana, cosa che poi effettivamente fece con la figlia Liliana De Curtis. Totò
volle inoltre conservare un fazzoletto intriso di rimmel che raccolse la mattina
del ritrovamento del corpo di Liliana, con il quale probabilmente ella si
asciugò le lacrime in attesa della morte. In merito all'impegno già preso, la
sera stessa partì per la tournée con la compagnia a Padova. Era il marzo
del 1930. Tornato a Roma il mese successivo, si esibì nuovamente in numerosi
spettacoli alla Sala Umberto I, dove ripropose il suo repertorio di macchiette e
nuove creazioni, impersonando anche Charlot, come umile omaggio a Chaplin. Tornò
poi a lavorare con l'impresario Maresca, dove iniziò una nuova tournée
riproponendo i successi degli anni precedenti. Sempre nel 1930, anno
dell'avvento del sonoro, Stefano Pittaluga, che produsse con la Cines La canzone
dell'amore (il primo film italiano sonoro), era alla ricerca di nuovi volti da
portare sul grande schermo. Le doti comiche di Totò non gli sfuggirono e dato
che era in procinto di produrre un film, chiamato Il ladro disgraziato, gli fece
fare un provino. La pellicola non vide mai la luce, anche per il fatto che il
regista avrebbe voluto che Totò imitasse Buster Keaton, idea che all'attore non
garbava. Momentaneamente accantonata l'eventualità di entrare nel cinema,
nel 1932 diventò capocomico di una propria formazione, proponendosi
nell'avanspettacolo, un genere teatrale che continuò a diffondersi in Italia
fino al 1940. In tournée a Firenze conobbe l'allora sedicenne Diana Rogliani (la
giovane età della ragazza suscitò inizialmente qualche riluttanza da parte di
Totò, dalla quale ebbe una figlia che, in onore della compianta Castagnola,
battezzò Liliana. Gli anni Trenta furono un periodo di grandi successi per il
comico che, malgrado il guadagno non molto alto, si sentiva affermato: portò in
scena, insieme alla sua prima spalla Guglielmo Inglese (più avanti fu Eduardo
Passarelli), numerosi spettacoli in tutta Italia. Sulla traccia di copioni
spesso approssimativi, Totò ebbe modo di dare sfogo alle risorse creative della
sua comicità surreale, con mimiche grottesche e deformazioni/invenzioni
linguistiche, interpretando anche Don Chisciotte e travestendosi addirittura
da soubrette; imparò così l'arte dei guitti, ossia quegli attori che recitavano
senza un copione ben impostato (molte macchiette le ripropose poi nel suo
repertorio cinematografico: "Il pazzo", "Il chirurgo", "Il manichino”), arte
alla quale Totò aggiunse caratteristiche tutte sue, pronto a sbeffeggiare i
potenti quanto a esaltare i bisogni e gli istinti umani primari: la fame, la
sessualità, la salute mentale. Naturalmente, come si confà allo stile di Totò,
tutto espresso con distinti doppi sensi senza mai trascendere nella volgarità. A
plasmare questa sua forma d'espressione, fu il fatto di aver vissuto per anni in
povertà, difatti lui stesso era del pensiero che "la miseria è il copione della
vera comicità..." che "non si può essere un vero attore comico senza aver fatto
la guerra con la vita". Acquisì quindi una sua originale personalità recitativa,
diventando uno dei maggiori protagonisti della stagione dell'avanspettacolo.
Nel 1933 si fece adottare dal
marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, per ereditarne così la lunga serie di
titoli nobiliari. L'anno successivo mise su casa a Roma insieme alla figlia
Liliana e alla compagna Diana Rogliani (per la quale nutriva un'ossessiva
gelosia), che sposò nell'aprile del 1935. Fu in quel periodo che alcune
personalità importanti tentarono di imporlo nel cinema: tra di loro Umberto
Barbaro e Cesare Zavattini, che cercò infatti di inserirlo nella parte di “Blim"
nel film Darò un milione di Mario Camerini - ruolo andato poi a Luigi
Almirante. Non realizzandosi questi progetti, il vero debutto avvenne
nel 1937 con Fermo con le mani!: il produttore Gustavo Lombardo, fondatore
della Titanus, scritturò Totò dopo averlo notato mentre era a pranzo in un
ristorante di Roma. La direzione fu affidata al regista Gero Zambuto. Il film
però non ebbe gran successo; concepito con mezzi molto scarsi, l'intenzione
primaria era proporre al pubblico italiano un'alternativa del personaggio di
Charlot, di Chaplin. Nel 1938 Totò fu vittima di un infortunio: ebbe un distacco
di retina traumatico e perse la vista dell'occhio sinistro, cosa di cui erano al
corrente soltanto i familiari stretti e l'amico Mario Castellani. Nonostante
l'incidente, trovò la forza di riaffacciarsi per un breve periodo al teatro
d'avanspettacolo, la cui epoca, per lui gloriosa, giunse purtroppo al
termine. In quel frattempo, causa il fatto che si sentiva come soffocato dal
matrimonio e causa anche la sua opprimente gelosia nei confronti della giovane
consorte (si dice che la tenesse perfino chiusa nel camerino mentre lui si
esibiva, la sua vita coniugale entrò in crisi. Decise dunque di ritornare
scapolo e si accordò con Diana per la separazione. In Italia non c'era la
possibilità di divorzio, così dovettero chiedere lo scioglimento all'estero,
in Ungheria, per far sì che fosse poi annullato in Italia. Dopo l'annullamento,
i due continuarono comunque a vivere insieme, trasferendosi in Viale dei
Parioli, insieme alla figlia e ai genitori di lui.
Dopo Fermo con le mani!, del
quale Totò non si ritenne molto soddisfatto, ci fu, nel 1939, un secondo
tentativo, che ebbe inizialmente problemi per i costi di produzione: Animali
pazzi di Carlo Ludovico Bragaglia, dove Totò interpretò un doppio ruolo. Pure
questo suo secondo film non fu del tutto riuscito, sebbene l'attore sfruttò al
massimo le sue potenzialità "marionettistiche". Alla fine del 1939, andò in
tournée a Massaua e Addis Abeba, in Etiopia, accompagnato da Diana
Rogliani, Eduardo Passarelli e la soubrette Clely Fiamma, presentando lo
spettacolo 50 milioni... c'è da impazzire!, scritto insieme a Guglielmo Inglese
e già mostrato al pubblico italiano anni prima. Una volta rientrato in patria
interpretò la sua terza pellicola, San Giovanni decollato, che fu sceneggiata,
tra gli altri, da Cesare Zavattini, al quale venne affidata la regia dal
produttore Liborio Capitani. Zavattini però non se la sentì e il compito passò
ad Amleto Palermi. Il film fu un successo di critica: alcuni commenti sulla
rivista Cinema e su L'Espresso elogiarono proprio la recitazione di Totò, la sua
capacità espressiva, i suoi giochi di parole e i suoi movimenti
snodati. Zavattini, che nutriva ammirazione artistica verso l'attore, scrisse
per lui il soggetto Totò il buono, che non diventò mai un film ma servì allo
sceneggiatore per la realizzazione del film Miracolo a Milano (1951),
di Vittorio De Sica, con il quale instaurò uno dei sodalizi più celebri del
neorealismo cinematografico italiano. Il quarto film fu L'allegro
fantasma sempre di Amleto Palermi, dove a Totò vennero affidati tre ruoli
differenti. Girato nell'autunno del 1940 (uscito poi a ottobre del '41), fu
l'ultimo film che interpretò prima del suo ritorno a teatro.
Questi primi esperimenti
cinematografici surreali non ottennero il successo di pubblico che Totò aveva
invece sul palcoscenico. Quando tornò a teatro, alla fine del 1940,
l'avanspettacolo era già tramontato, sostituito dalla "rivista", un genere
teatrale sorto a Parigi e dal carattere (almeno nel primo periodo)
esclusivamente satirico - per quanto concesso dal regime fascista - presentato
sotto forma di azioni sceniche ricche di allusioni e di accenni piccanti. In
quel periodo l'Italia era da poco entrata in guerra e la ferrea censura del
fascismo era attentissima a qualsiasi battuta ambigua o accenno negativo
sul Governo di Mussolini. Totò debuttò al teatro Quattro Fontane di Roma insieme
a Mario Castellani (da quel momento la sua "spalla" ideale) ed Anna
Magnani (primadonna), con i quali instaurò un solido rapporto artistico e
umano. La rivista era Quando meno te l'aspetti di Michele Galdieri, uno tra i
grandi scrittori di riviste teatrali degli anni Quaranta. Totò strinse con
Galdieri un sodalizio durato nove anni, con spettacoli scritti anche dall'attore
stesso e messi in scena dagli impresari Elio Gigante e Remigio Paone; tra le
riviste più note: Quando meno te l'aspetti, Volumineide, Orlando Curioso, Che ti
sei messo in testa? e Con un palmo di naso. Causa la guerra, furono tempi
difficoltosi anche per il teatro, per la mancanza di mezzi di trasporto, il
divieto di circolazione delle auto private e soprattutto per i bombardamenti, in
particolare a Milano, dove gli spettacoli venivano spesso interrotti e gli
attori erano costretti ad allontanarsi verso il rifugio più vicino, senza avere
il tempo di togliersi gli abiti di scena. Fu il periodo in cui Totò venne
scritturato dalla Bossoli Film per riaprire una fessura nel cinema e prendere
parte ad una nuova pellicola che comprendeva nel cast anche il pugile Primo
Carnera, Due cuori fra le belve (ridistribuito dopo la guerra col titolo Totò
nella fossa dei leoni), del regista Giorgio Simonelli, che venne girato con
animali autentici. Nel maggio del '44, la rivista Che ti sei messo in testa (che
avrebbe dovuto chiamarsi Che si son messi in testa?, un chiaro accenno ai
tedeschi occupanti) creò problemi al comico napoletano, che dopo le prime
rappresentazioni al teatro Valle di Roma, venne dapprima intimorito con una
bomba all'entrata dal teatro, poi denunciato dalla polizia, insieme ai fratelli
De Filippo, con un telegramma dal Comando Tedesco indirizzato al teatro
Principe, che Totò non lesse mai; venne avvertito però da una telefonata
anonima. Per evitare l'arresto, Totò, dopo aver allertato i fratelli De Filippo,
si rifugiò con la ex moglie Diana e la figlia a casa di un amico in via del
Gelsomino nei pressi della via Aurelia, all'estrema periferia ovest di Roma,
mentre i De Filippo si nascosero in via Giosuè Borsi. Passati alcuni giorni Totò
dovette comunque lasciare l'abitazione, per il fatto che molti suoi ammiratori
lo avevano riconosciuto e quindi il nascondiglio non era più sicuro. Tornò a
Roma, dove erano rimasti i genitori, e si segregò in casa fino al 4 giugno, il
giorno della liberazione della capitale (secondo varie testimonianze avrebbe
anche notevolmente contribuito ai finanziamenti della Resistenza romana).
Il 26 giugno riprese a
recitare: tornò al teatro Valle con la Magnani nella nuova rivista Con un palmo
di naso, in cui diede libero sfogo alla sua satira impersonando il Duce (sotto i
panni di Pinocchio), e Hitler, che dissacrò ulteriormente dopo l'attentato del
20 luglio 1944, rappresentandolo in un atteggiamento ridicolo, con un braccio
ingessato e i baffetti che gli facevano il solletico, e mandando l'intera platea
in estasi. «Io odio i capi, odio le dittature... Durante la guerra rischiai guai
seri perché in teatro feci una feroce parodia di Hitler. Non me ne sono mai
pentito perché il ridicolo era l'unico mezzo a mia disposizione per contestare
quel mostro. Grazie a me, per una sera almeno, la gente rise di lui. Gli feci un
gran dispetto, perché il potere odia le risate, se ne sente sminuito.»
Nel 1945, dopo alcune
esibizioni nella capitale, a Siena e a Firenze, portando in scena la
rivista Imputati, alziamoci! (in cui faceva la caricatura di Napoleone), Totò fu
avvicinato al termine dello spettacolo da un partigiano che, indispettito da una
sua battuta di risposta che accomunava ironicamente fascisti e partigiani, lo
colpì al viso con un pugno. Totò, corso immediatamente al commissariato per
denunciare il fatto, decise poi di lasciar correre senza sporgere querela. In
quel periodo il sodalizio artistico con Anna Magnani si interruppe, quando
l'attrice si rivelò al grande pubblico internazionale interpretando il ruolo
della popolana Pina nel film Roma città aperta, diretto dal suo compagno Roberto
Rossellini. Totò invece proseguì per la sua strada continuando col cinema e con
il teatro e incidendo anche il suo unico disco 78 giri come cantante,
interpretando canzoni non sue: Marcello il bello nel lato A e Nel paese dei
balocchi - dove venne coadiuvato da Mario Castellani - nel lato B.
Totò fu membro della Loggia
massonica "Fulgor" di Napoli dal luglio 1945 e, in seguito, della Loggia "Fulgor
Artis" di Roma, da lui stesso fondata. Entrambe le Logge appartenevano alla
"Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana" di Piazza del Gesù. Dopo la morte
del padre (avvenuta nel settembre del '44), Giuseppe De Curtis, tra il 1945 e
gli anni successivi Totò alternò teatro e cinematografia, dedicandosi anche alla
creazione di canzoni e poesie, ma anche ad una buona lettura, diligendo in
particolar modo Luigi Pirandello. Interpretò la sua sesta pellicola, Il ratto
delle Sabine, con il regista Mario Bonnard, film che venne accolto da alcune
critiche avverse, come quella di Vincenzo Talarico, che stroncò l'attore
"augurandosi che rientrasse al più presto nei ranghi del teatro di rivista." Poi
ci fu I due orfanelli, scritto da Steno e Agenore Incrocci e diretto da Mario
Mattoli, con il quale Totò interpretò altri tre film tra il '47 al '49: Fifa e
arena, Totò al giro d'Italia (il primo film in cui compariva il suo nome nel
titolo) e I pompieri di Viggiù (tutti di buon successo e incasso); inoltre, era
il tempo della rivista C'era una volta il mondo di Galdieri, composta da sketch
rimasti famosi, come quello del Vagone letto, con Totò al fianco di Isa
Barzizza, la soubrette che debuttò nel film I due orfanelli e che proprio lui
volle nella rivista, e Mario Castellani, la fedele "spalla" teatrale che lo
accompagnò anche nel cinema, prendendo parte a quasi tutte le sue pellicole
proprio per volere di Totò che, quando non c'erano ruoli disponibili, lo
imponeva come aiuto-regista. La rivista C'era una volta il mondo ebbe tanto
successo che venne presentata anche a Zurigo, recitata in italiano ma acclamata
ugualmente dal pubblico svizzero per la genialità comica degli sketch. Spesso
gli spettacoli di rivista di Totò si concludevano con la classica "passerella",
col comico che correva tra il pubblico con una piuma sulla bombetta, al ritmo
della fanfara dei Bersaglieri (scenetta riproposta nel film I pompieri di
Viggiù). Nell'ottobre 1947, durante le repliche della rivista, la madre di Totò
morì. Malgrado il grande dolore per la perdita di entrambi i genitori, l'attore
non mischiò il lavoro con la vita privata, continuando ad essere il comico Totò
nello spettacolo e il malinconico Antonio De Curtis al di fuori. Aprì anche una
piccola parentesi come doppiatore, prestando la voce al cammello Gobbone nel
film La vergine di Tripoli. Prima di riaffacciarsi al cinema, partì per alcune
tournée a Barcellona, Madrid e altre città spagnole, dove recitò in spagnolo
(senza avere padronanza della lingua) con Mario Castellani nella rivista Entre
dos luces (Tra due luci), improvvisando una canzone non-sense a metà tra
spagnolo e napoletano. Tornato in Italia, ebbe anche una piccola esperienza nel
campo pubblicitario, facendosi fotografare a pagamento sulla rivista Sette che
promuoveva i profumi Arbell.
Da quando entrò nel mondo del
cinema, gli furono proposti moltissimi film, molti dei quali non venivano
nemmeno realizzati, spesso per problemi di produzione o per sua rinuncia. Alcuni
venivano girati contemporaneamente, in tempi ristrettissimi (la maggior parte in
due o tre settimane) e su set spesso improvvisati, tanto che a volte era proprio
la troupe che raggiungeva Totò nelle città in cui recitava a teatro. L'attore,
complice la pigrizia, era sempre molto precipitoso quando gli venivano proposti
dei progetti, ed essendo profondamente istintivo spesso non voleva conoscere
nulla della pellicola che andava ad interpretare, affidandosi quindi alle sue
qualità creative. Così, come sul palcoscenico, dava libero sfogo
all'improvvisazione: il copione rappresentava solo un timido canovaccio per
l'attore, che concepiva sul momento le gag e le battute; così tuttavia nacquero
anche alcune delle sue scene cinematografiche più famose. «Era imprevedibile
[...] recitava a braccio», testimoniò Nino Taranto; «Certe sue folli
improvvisazioni durante la recitazione erano geniali e insostituibili» espresse
invece Vittorio De Sica. Secondo alcuni commenti, invece - come quelli di Carlo
Croccolo, Giacomo Furia e Steno - Totò si rinchiudeva nel suo camerino a provare
e riprovare le sue battute prima dello spettacolo o delle riprese, rileggeva il
copione e modificava i passaggi che non lo convincevano, insieme all'amico Mario
Castellani e agli attori coinvolti.
Le differenze tra teatro e
cinema crearono inizialmente non pochi disordini per l'attore, che, essendosi
formato con lo stile teatrale e quindi con un'unica esecuzione dal vivo, dopo i
primi ciak tendeva a perdere la concentrazione. Doveva perciò essere colto "al
volo" per poter recitare al massimo; quindi la troupe doveva prima preoccuparsi
di sistemare le luci e di preparare la scena con una controfigura, facendo anche
qualche prova. Quando tutto era pronto, si poteva far intervenire Totò. Un'altra
delle differenze tra le due forme d'arte, di cui il comico risentì molto
inizialmente, fu il fatto di non riuscire a comunicare direttamente con il
pubblico, uno dei particolari che più amava del teatro. Proprio per questo, di
solito, i registi (in particolare Bragaglia, con il quale instaurò un solido
rapporto artistico) e i membri della troupe lo spronavano dopo lo stop con un
applauso, in modo da dargli maggiore carica ed entusiasmo. Un altro
inconveniente furono gli orari: Totò, abituato agli orari teatrali, non si
alzava mai prima di mezzogiorno, essendo poi un assertore della teoria che
l'attore "al mattino non può far ridere”, girava nel cosiddetto orario francese,
dalle 13 alle 21. Si stancava poi per le lunghe pause e attese che il cinema
comporta, e inoltre, essendo molto superstizioso, si rinchiudeva in casa e non
lavorava mai di martedì e di venerdì, 13 o 17. Fattori che creavano non pochi
problemi per le riprese. Complicazioni particolari ci furono per Totò al giro
d'Italia, dove erano coinvolti molti ciclisti famosi dell'epoca
come Bartali, Coppi, Bobet, Magni; l'attore, non arrivando in orario, creava
difficoltà. Nella stagione 1949/1950 ottenne l'ultimo successo a teatro con la
rivista Bada che ti mangio!, costata ben cinquanta milioni, che debuttò al
teatro Nuovo di Milano nel marzo del '49, dopodiché Totò si allontanò dal
palcoscenico per dedicarsi esclusivamente al cinema. Dopo I pompieri di Viggiù,
lavorò anche con Eduardo De Filippo nel suo film Napoli milionaria, che accettò
di interpretare senza compenso, in segno dell'affettuosa amicizia che lo legava
ad Eduardo. I due attori, sebbene avessero progettato di realizzare insieme
altri film, non ebbero più modo di incontrarsi sul set, apparendo solo in
episodi diversi de L'oro di Napoli di Vittorio De Sica ed in un breve cameo
ne Il giorno più corto.
Nel 1950 Totò rinunciò alla
proposta di avere un ruolo, insieme al francese Fernandel, nel film di
produzione italo-francese Atollo K, dove avrebbe avuto l'opportunità di recitare
insieme a Stan Laurel e Oliver Hardy, la famosa coppia comica conosciuta in
Italia come Stanlio e Ollio.
Tra il 1949 e il 1950, oltre
a Napoli milionaria, interpretò ben altri nove film, tra i quali alcune
parodie: Totò le Mokò, Totò cerca moglie, Figaro qua, Figaro là, Le sei mogli di
Barbablù, 47 morto che parla, tutti diretti da Carlo Ludovico Bragaglia,
poi L'imperatore di Capri di Luigi Comencini, Tototarzan e Totò sceicco (dove
s'invaghì dell'attrice Tamara Lees) di Mario Mattoli, Yvonne la nuit di Giuseppe
Amato, Totò cerca casa di Steno e Mario Monicelli, un'efficace parodia del
neorealismo sulla crisi degli alloggi, che suscitò un po' d'indignazione da
parte della censura. Questi film, in misura diversa, ebbero un buon successo di
pubblico, ma non di critica, che già dalle pellicole precedenti cominciò a non
gradire lo stile surreale di Totò. Commentando in modo ironico queste avversità
da parte dei critici, il principe osservò che probabilmente si era "guastato col
crescere".
La morte dei genitori fu
l'avvio di uno squilibrio familiare: nel 1951 Diana Rogliani, in seguito a un
violento litigio, se ne andò di casa e si sposò; altrettanto fece, appena
maggiorenne, e contro la volontà di Totò, la figlia Liliana, unendosi in
matrimonio con Gianni Buffardi, figliastro del regista Carlo Ludovico
Bragaglia. Totò restò solo, e in quel breve lasso di tempo scrisse la nota
canzone Malafemmena, che concepì durante una pausa di lavorazione del suo nuovo
film Totò terzo uomo, a cui seguirà Sette ore di guai. La canzone fu
apparentemente scritta per la ex moglie Diana, alla quale era ancora molto
legato, ma i giornali dell'epoca affermarono che Totò l'avesse dedicata
a Silvana Pampanini, l'attrice con la quale recitò in 47 morto che parla e che,
in quel periodo, corteggiava mandandole mazzi di rose e scatole di cioccolatini.
Arrivò perfino a chiederle di sposarlo, uno dei motivi per la brusca separazione
con la Rogliani), ma l'attrice lo respinse.
Nonostante le oscurità e le
delusioni, il 1951 fu un anno importante per la carriera cinematografica
dell'attore. Dopo il successo di Totò cerca casa, venne richiamato
da Steno e Mario Monicelli per interpretare il ruolo del ladro Ferdinando
Esposito in Guardie e ladri, al fianco di quell'attore che fu uno dei suoi amici
più affezionati e una delle sue migliori "spalle", capace di rispondere colpo su
colpo alle improvvise e "aggressive" battute di Totò, Aldo Fabrizi. Per Guardie
e ladri Totò era all'inizio riluttante, il ruolo offertogli era finalmente
reale, diverso dai suoi precedenti personaggi e inserito in un contesto
decisamente più drammatico. Il film ebbe inizialmente problemi con la censura,
ma appena uscito nelle sale fu un successo unanime: alti incassi, grande
apprezzamento di pubblico e plauso inatteso da parte della critica. Nello stesso
anno interpretò, sempre per la regia di Monicelli e Steno, Totò e i re di Roma,
l'unico film che lo vide recitare con Alberto Sordi. L'anno seguente fu premiato
con un nastro d’argento per la sua interpretazione in Guardie e ladri, e l'opera
venne presentata al Festival di Cannes 1952, dove si aggiudicò il premio per la
migliore sceneggiatura, l'anno in cui l'attore collaborò a Siamo uomini o
caporali?, la sua biografia (che si ferma nel 1930 - dopo il suicidio di Liliana
Castagnola) curata da Alessandro Ferraù ed Eduardo Passarelli.
Proprio nel 1952 Totò rimase
colpito da una giovane sulla copertina del settimanale "Oggi", Franca Faldini.
Le mandò subito un mazzo di rose con un biglietto: «Guardandola sulla copertina
di “Oggi” mi sono sentito sbottare in cuore la primavera», poi le telefonò per
invitarla a cena, la ragazza accettò solo quando Totò ebbe modo di farsi
presentare. La Faldini, appena ventunenne, era da poco tornata dagli Stati
Uniti, dove aveva preso parte al film Attente ai marinai! con Dean
Martin e Jerry Lewis. Dopo essersi frequentati per circa un mese annunciarono il
loro fidanzamento. Sebbene restassero insieme fino alla morte dell'artista, la
loro relazione, che non arrivò mai al matrimonio, fu più volte sull'orlo di
essere troncata, per il fatto di essere due persone caratterialmente molto
diverse; un motivo, tra l'altro, fu la differenza di età di trentatré anni. La
situazione di convivenza senza un legame matrimoniale creò scandalo all'epoca,
tanto che, pochi anni più avanti, i due, stanchi di essere tormentati dai
paparazzi e dai giornalisti (che li definivano "pubblici concubini"), furono
costretti a fingere di essersi uniti in matrimonio all'estero, un espediente che
comunque non funzionò sino in fondo.
Franca Faldini comparve anche
nel cast di alcuni film del compagno. Il primo a cui partecipò fu Dov'è la
libertà?, di Roberto Rossellini, che avendo apprezzato Totò in Guardie e ladri,
lo scritturò per il suo film. La lavorazione non ebbe il percorso previsto.
Venne girato nel 1952 e uscì nelle sale due anni dopo, per il fatto che nel
corso delle riprese Rossellini si disinteressò della pellicola e si allontanò
spesso dal set. Molte sequenze furono quindi girate dal regista Lucio Fulci e
sembra che ci fossero state anche delle collaborazioni con Mario Monicelli
e Federico Fellini. Insieme alla Faldini, girò poi Totò e le donne, nuovamente
diretto da Steno e Monicelli, dove Totò recitò per la prima volta con Peppino De
Filippo, con il quale formò in seguito una delle coppie più popolari del cinema
italiano. Dopo che Steno e Monicelli si divisero, entrambi realizzarono,
ciascuno per proprio conto, altri film con Totò. Il primo sfruttò la sua
comicità surreale, il secondo proseguì sull'umanizzazione del personaggio
(cominciata proprio con Guardie e ladri). Il primo grande risultato raggiunto da
Steno fu Totò a colori - gran successo e incassi altissimi - uno dei primi film
italiani a colori, girato col sistema "Ferraniacolor", in cui vennero riproposti
alcuni dei suoi sketch teatrali, come quello di Pinocchio o del Vagone letto con
Castellani e Isa Barzizza. Durante le riprese del film Totò iniziò ad avere
diversi problemi, a causa delle potenti luci usate sul set, che gli causarono
problemi alla sua vista già precaria e addirittura una lieve infiammazione ai
capelli, finendo per svenire a causa dei forti dolori accusati all'occhio
destro, il solo da cui vedeva dopo il distacco di retina del 1938 all'altro
occhio. Continuò comunque a lavorare. Nel 1953, in seguito ad alcune
illustrazioni di Totò il buono disegnate dallo sceneggiatore Ruggero
Maccari su Tempo illustrato, furono (con l'ovvio consenso dell'attore) stampati
e distribuiti degli albi a fumetti di Totò, rappresentato naturalmente in
forma caricaturale, raccolti in una collana chiamata semplicemente Totò a
fumetti, che illustrava storie liberamente ispirate ad alcune sue esibizioni
teatrali. La collana venne pubblicata dalle Edizioni Diana di Roma.
Nel 1954, un suo brano
musicale, Con te, dedicato a Franca Faldini, fu presentato al Festival di
Sanremo, classificandosi al 9º posto nella graduatoria finale. La canzone venne
interpretata da Achille Togliani, Natalino Otto e Flo Sandon's. Nello stesso
anno, i giornali annunciarono che Totò avrebbe interpretato un film muto scritto
da Age e Scarpelli, purtroppo il progetto fu presto annullato per il rifiuto dei
produttori. Girare un film del genere sarebbe stata una grande soddisfazione per
il comico, che affermò: «Il mio sogno è girare un film muto, perché il vero
attore, come il vero innamorato, per esprimersi non ha bisogno di parole»; e fu
proprio durante una vacanza sulla Costa Azzurra, in un periodo imprecisato degli
anni cinquanta, che ebbe un'occasione unica di conoscere nientedimeno che il
maestro del muto Charlie Chaplin, quando il suo yacht si ritrovò per caso
accanto all'imbarcazione dell'artista inglese. Ma Totò, da sempre bloccato
dall'insicurezza e dai complessi d'inferiorità, e pensando poi che l'altro non
lo avrebbe riconosciuto per la sua poca popolarità all'estero, rinunciò a
salutarlo.
Tra il 1953 e
il 1955 interpretò diciassette film, lavorò nuovamente con Steno in L’uomo, la
bestia e la virtù (dall'omonima commedia di Luigi Pirandello), dove nel cast era
presente anche Orson Welles, poi con Mattòli ne Il più comico spettacolo del
mondo (uno dei primi film italiani tridimensionali), e nella trilogia
scarpettiana: Un turco napoletano, Miseria e nobiltà e Il medico dei pazzi. Fu
anche chiamato dall'amico Aldo Fabrizi che lo volle per il film Una di quelle,
al fianco di Peppino De Filippo, Lea Padovani e lo stesso Fabrizi; la pellicola
(ridistribuita successivamente col titolo di Totò, Peppino e… una di quelle),
dal tono drammatico e sentimentale, non ottenne il successo sperato. Si incontrò
nuovamente anche con Monicelli, con il quale girò Totò e Carolina, film uscito
nelle sale dopo un anno e mezzo dal termine della lavorazione perché massacrato
dai tagli della censura, che era infastidita principalmente dai palesi
riferimenti comunisti e dal fatto che Totò interpretasse un poliziotto, e per di
più in un atteggiamento che tendeva a ridicolizzarsi.
Totò, di spirito
caritatevole, per tutta la sua vita compì molteplici gesti d'altruismo, che
includevano sostegno e offerte di viveri ai più bisognosi. Con l’avanzare
dell’età si dedicò sempre più spesso a numerose opere di beneficenza: la vita
privata dell’attore, negli ultimi anni, si limitava a sporadiche apparizioni in
pubblico ma anche (seppur non avendo guadagni eccelsi per il fatto che
pretendeva sempre poco dai produttori a un’intensa attività di
benefattore, aiutando ospizi e brefotrofi, donando grandi somme alle
associazioni che si occupavano degli ex carcerati e delle famiglie degli stessi.
Avendo poi una particolare predilezione per i bambini, dopo la morte del figlio
Massenzio Totò andava spesso a trovare, insieme a Franca Faldini, gli orfanelli
dell'asilo Nido Federico Traverso, di Volta Mantovana, portando con sé regali e
giocattoli. Inoltre, in merito al suo amore per gli animali, per raccogliere
cani randagi acquistò e modernizzò un vecchio canile, L'ospizio dei trovatelli,
che lui stesso visitava regolarmente per accertarsi che i numerosi ospiti a
quattro zampe (si parla di più di 200 cani) avessero le cure necessarie. Le
spese totali per l'assistenza e il mantenimento del canile arrivarono a
costargli circa cinquanta milioni.
Fondò poi la società di
produzione D.D.L., con sede legale al suo domicilio, collegata a Dino De
Laurentiis e all'amministratore di Totò, Renato Libassi. Ebbe l'opportunità di
lavorare con Alessandro Blasetti e anche Camillo Mastrocinque, con il quale girò
molte pellicole di successo. La sua vita privata però, non scorreva tranquilla
come quella di spettacolo: Franca Faldini, in seguito ad un parto
drammatico, diede alla luce il figlio di Totò, Massenzio; il bambino, nato di
otto mesi, morì dopo alcune ore.
Superato il dolore della
perdita del figlio, al quale Totò reagì malissimo rinchiudendosi in casa per
settimane, nel 1956 ritornò sul set interpretando a catena quattro film di
Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con
l'attore dirigendolo in Totò, Peppino e la... malafemmina (in cui si colloca la
nota scena della “lettera”) e ne La banda degli onesti, scritto da Age e
Scarpelli e interpretato insieme a Peppino e Giacomo Furia. Ma la tentazione di
ritornare a teatro lo vinse, e, spronato anche dall'impresario Remigio
Paone, recitò nella rivista A prescindere (che prendeva il nome da un suo modo
di dire), che debuttò al teatro Sistina di Roma alla fine del '56, e che venne
portata in tournée in tutta Italia. Nel mese di febbraio del 1957, a Milano,
Totò venne colpito da una broncopolmonite virale, e nonostante i pareri dei
medici che gli dissero di riposare, tornò sul palco dopo alcuni giorni, ciò gli
causò uno svenimento appena prima di entrare in scena. I medici gli prescrissero
almeno due settimane di assoluto riposo, ma Totò ritornò ugualmente a recitare
esibendosi a Biella, Bergamo e Sanremo, dove cominciò ad avvertire i primi
sintomi dell'imminente malattia alla vista. Il 3 maggio la situazione precipitò:
mentre recitava al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo si avvicinò alla
Faldini (che aveva sostituito l'attrice Franca May e recitava sul palco insieme
a lui) sussurrandole che non vedeva più; contando perciò solo sulle sue abilità
e sull'appoggio degli altri attori, fece in modo di accelerare la conclusione
dello spettacolo. Nonostante lo sconforto e la totale cecità, cercò di resistere
e, per non deludere il pubblico ritornò sul palcoscenico - con un paio di spessi
occhiali da sole - la sera del 4 maggio e, in due spettacoli, del
5. L'interruzione della rivista fu comunque inevitabile. Inizialmente i medici
attribuirono la cecità a un problema derivato dai denti, ma alla fine gli fu
diagnosticata una corioretinite emorragica all'occhio destro. L'impresario della
compagnia, Remigio Paone, non credendogli, richiese una visita fiscale e avrebbe
preteso anche che Totò tornasse a recitare. Totò in un primo tempo fu
completamente cieco, e anche dopo dei lievi miglioramenti e una volta
riassorbita l'emorragia non riuscì più a riacquisire integralmente la
vista. Dovette abbandonare definitivamente il teatro, continuando però con il
cinema: in quell'anno restò quasi inattivo e interpretò solo un film, Totò,
Vittorio e la dottoressa di Mastrocinque, ma le sue capacità recitative,
malgrado la malattia, non si affievolirono mai. L'unico problema era il
doppiaggio, quando alcune scene dei film non venivano girate in presa diretta,
non poteva doppiarsi poiché non era in grado di vedersi sullo schermo e non
poteva sincronizzare le battute con il movimento labiale; in tali occasioni,
veniva doppiato da Carlo Croccolo. Per problemi economici fu costretto a vendere
alcune proprietà, e successivamente decise di soggiornare per qualche giorno
a Lugano, pensando di trasferirvisi definitivamente per motivi fiscali, ma
ritornò a Roma e si spostò in un appartamento in affitto in Viale dei Parioli
con Franca Faldini, che gli rimase sempre vicino, insieme a suo cugino Eduardo
Clemente, che gli faceva da segretario e factotum, e al suo autista Carlo
Cafiero, che di solito lo accompagnava sul set.
Sebbene non si conosca con
certezza il pensiero politico di Totò, si sa da fonti accertate che era
fermamente contrario a qualsiasi forma di dittatura e supremazia (anche per le
sue esperienze personali e per i suoi sbeffeggiamenti del potere), e sembra che,
a detta di Franca Faldini, fosse di idee fondamentalmente anarchiche. A smentire
ciò, è una fotografia del tedesco Eugenio Haas risalente al 1943, scattata sul
set di Due cuori fra le belve e pubblicata sulla rivista "Film", e che
raffigurava l'attore con la "cimice", ossia il distintivo del Partito nazionale
fascista. Si suppone che Totò sia stato in qualche modo costretto a posare per
quella foto, la cui intenzione sarebbe stata quella di "punire l'audacia del
comico", poiché scherniva e derideva il regime fascista nei suoi spettacoli
teatrali, che difatti gli causarono molte complicazioni durante la guerra. Pur
tenendo molto al suo titolo nobiliare, pur conducendo uno stile di vita
sfarzoso, e pur essendo stato definito più volte un monarchico, Totò, secondo la
Faldini, non pretendeva da nessuno di essere chiamato "principe", la sua mania
per la nobiltà rappresentava per lui una sorta di riscatto dalla sua difficile
vita giovanile. Ma il suo «Viva Lauro!», esclamato durante Il Musichiere, venne
naturalmente mal interpretato. Essendo un periodo delicato, in prossimità delle
elezioni politiche, non era tollerabile che un personaggio conosciuto come Totò
osannasse il capo di un partito politico, ma l’unico motivo della sua
esclamazione era dovuto al fatto che Lauro avesse provvisto di case e alimenti
gli abitanti dei "bassi" (le dimore più povere) di Napoli. Totò apprezzò
solamente il gesto, essendo fortemente attaccato alla sua città natale. Pur non
coltivando molto interesse per l'ambito televisivo, nel '58 accettò l'invito
come ospite d'onore nel programma Il Musichiere condotto da Mario Riva, con il
quale aveva lavorato anni prima in alcuni film e riviste teatrali. Durante la
trasmissione Totò si lasciò scappare un «Viva Lauro!», riferendosi ad Achille
Lauro, l'allora capo del Partito Monarchico Popolare; questa sua sgradita,
seppur scherzosa, considerazione politica, gli costò un allontanamento dal
piccolo schermo (salvando alcune interviste in privato) sino al 1965, quando
duettò con Mina a Studio Uno.
Dopo il forzato distacco dalla
televisione, riprese a lavorare nel cinema. Sempre nel '58 recitò con l'attore
francese Fernandel in La legge è legge e, tra le altre pellicole, prese parte al
celebre film I soliti ignoti di Mario Monicelli, interpretando lo scassinatore
in pensione Dante Cruciani e recitando, tra gli altri, con Vittorio
Gassman e Marcello Mastroianni. In quel periodo gli venne assegnato il Microfono
d'argento e in seguito una Targa d'Oro dall'ANICA, per il suo contributo al
cinema italiano e per la sua lunga carriera artistica.
Nel '59 la sua salute
peggiorò, durante la lavorazione del film La cambiale ebbe una ricaduta e non
lavorò per due settimane, prima di concludere le riprese. Seguendo i consigli
medici si concesse alcuni mesi di riposo, e dopo essersi ripreso inviò una sua
canzone, Piccerella Napulitana, al Festival di Sanremo 1959, che però fu
scartata, insieme ad un'altra di Peppino De Filippo. Totò accettò comunque di
occupare il posto come presidente della giuria al Festival, in seguito alle
insistenze di Ezio Radaelli, rifiutando tra l'altro un cospicuo pagamento
giornaliero; però, in seguito a un disaccordo col resto della commissione,
abbandonò prestissimo l'incarico.
Proprio all'apice del
successo, l'agenzia artistica statunitense Ronald A. Wilford Associates di New
York (agenzia di quel Ronald Wilford che avrebbe poi fondato e diretto la
Columbia Artists Management International, considerata una delle agenzie più
potenti del mondo) desiderava scritturarlo per uno spettacolo da rappresentare
in America, insieme a Maurice Chevalier, Marcel Marceau e anche Fernandel.
Naturalmente Totò non se la sentì e preferì rimanere in Italia a continuare in
modo più "rilassante" con la cinematografia, rifiutando così, anche se
malvolentieri, un'offerta importante e un altissimo compenso.
Nel 1961 gli venne comunicato
che era vincitore della Grolla d'oro alla carriera, con la motivazione: «Al
merito del cinema, per aver da lunghi anni onorato l'estro e il genio del Teatro
dell'Arte». Ma la sua salute e i suoi impegni non gli permisero di partecipare
alla premiazione a Saint-Vincent e la Grolla fu assegnata ad un altro attore.
Nonostante la malattia, Totò
(da sempre fumatore) continuava a fumare fino a novanta sigarette al giorno.
Cercò comunque di non rallentare troppo la sua già allora consistente produzione
di film; e per il timore di perdere il lavoro e l'affetto del suo
pubblico, cominciò ad accettare qualsiasi copione: aprì una parentesi con il
regista Lucio Fulci ne I ladri e tornò con Steno nel film I tartassati,
nuovamente al fianco di Aldo Fabrizi, a cui si aggiunse in un ruolo secondario
l'attore francese Louis de Funès. Sebbene fosse quasi completamente cieco
(vedeva solo dai lati degli occhi), tanto da dover indossare un pesante paio di
occhiali scuri che toglieva soltanto per le riprese, si muoveva sul set con
assoluta disinvoltura ed era come se tornasse, solo per un attimo, a
vedere; cosa che proprio lui affermò: «Appena sento il ciak, vedo tutto. È un
effetto nervoso».
Tra i tanti film interpretati
negli anni Sessanta, oltre ai numerosi con Peppino e alcuni con Fabrizi, di buon
successo furono Totòtruffa 62 di Camillo Mastrocinque, Gli onorevoli e la
commedia amara I due marescialli di Sergio Corbucci, poi I due colonnelli di
Steno (ricordato per la scena della “carta bianca”) e Risate di gioia di
Monicelli, che segnò una tappa importante per Totò, dato che fu l'unica volta
che recitò sul set insieme all'amica e compagna storica di teatro Anna Magnani.
Non mancarono poi le parodie, come Totò contro Maciste, Totò e Cleopatra e Totò
contro il pirata nero di Fernando Cerchio, che altro non furono che delle
comiche rivisitazioni mitologiche dei film Peplum, a cui si aggiunsero Che fine
ha fatto Totò Baby? (esplicita parodia di Che fine ha fatto Baby Jane?)
di Ottavio Alessi e Totò diabolicus di Steno, quest'ultimo una parodia del
genere giallo-poliziesco dove Totò concepì una delle sue prove recitative più
complesse e riuscite, dando volto e fattezze a ben sei personaggi differenti.
In aggiunta, la fama che Totò
vantava tra il pubblico, da sempre sfruttata dai produttori, venne usata come
una sorta di veicolo pubblicitario o di lancio per cantanti quali Johnny
Dorelli, Fred Buscaglione, Rita Pavone, Adriano Celentano, e per piccoli attori
come Pablito Calvo che, già interprete di Marcellino pane e vino, recitò poi
in Totò e Marcellino. Esplorò anche il filone notturno-sexy insieme a Erminio
Macario in Totò di notte n. 1 e Totò sexy, due tra i film più fiacchi della sua
carriera.
Nel gennaio del 1964 venne
pubblicizzata la notizia dell'uscita del suo centesimo film, annunciato come il
suo primo interamente drammatico, Il comandante. Diretto da Paolo Heusch e
scritto da Rodolfo Sonego (sceneggiatore di fiducia di Alberto Sordi), richiese
complessivamente otto settimane di lavoro, più del doppio rispetto alla media
dei film di Totò. La notizia diede luogo a festeggiamenti e riconoscimenti, Totò
ricevette perfino la "Sirena d'oro" e agli incontri internazionali del cinema
venne accolto da un applauso interminabile, poche settimane dopo fu intervistato
da Lello Bersani, per Tv7, e da Oriana Fallaci, per L'Europeo. Ma nonostante
tutto, il film, che in realtà era l'ottantaseiesimo, si rivelò un
insuccesso. Poi, presso l'editore Fausto Fiorentino di Napoli, pubblicò il
famoso libro di poesie 'A livella, che in origine si chiamava Il due novembre,
per la quale vinse anche un premio.
Nel 1965 conobbe un
giovane Pasquale Zagaria che, interprete d'avanspettacolo, era stato consigliato
dal titolare del teatro Jovinelli di rivolgersi a Totò al fine di trovare lavoro
nel cinema. In quell'occasione Totò gli suggerì di cambiare il suo nome d'arte,
che era Lino Zaga, spiegando che i diminutivi dei nomi portassero bene e quelli
dei cognomi portassero male. Da allora il giovane attore si conferì lo
pseudonimo di Lino Banfi.
«Ho girato diversi film
mediocri, altri che erano veramente brutti, ma, dopo tutta la miseria patita in
gioventù, non potevo permettermi il lusso di rifiutare le proposte scadenti e
restarmene inattivo... » Al culmine della sua carriera, anche se poco prima
della morte, arrivarono proposte importanti da cineasti come Alberto
Lattuada, Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini. Col primo girò, nel 1965, il
film La mandragola, nel ruolo di Fra' Timoteo, che interpretò in modo
brillante. Il secondo lo avrebbe voluto per il film Il viaggio di G. Mastorna,
dove erano previsti nel cast anche Mina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
Lavorare con Fellini era sempre stata una delle maggiori ambizioni di Totò, ma
la pellicola purtroppo non fu mai realizzata. L'incontro con Pasolini, invece,
fu uno dei più importanti e inaspettati dell'intera carriera cinematografica di
Totò. La prima opera realizzata insieme fu Uccellacci e uccellini, che Totò
accettò senza condividere appieno il suo personaggio e la poetica del regista;
ormai il suo intento principale era produrre opere di qualità, per la ricorrente
paura d'essere dimenticato dal pubblico. Pasolini lo scelse perché rimase
affascinato dalla sua "maschera", che riuniva perfettamente "l'assurdità e il
clownesco con l'immensamente umano". Per la prima volta Totò, durante la
lavorazione di un film, si sentì in qualche modo smorzato, per volere di
Pasolini che lasciava poco spazio ai suoi lazzi e alle sue improvvisazioni,
rispetto a come era solitamente abituato con gli altri registi. Uccellacci e
uccellini, opera di grande forza poetica, fin dall'inizio fu oggetto di
discussioni e controversie, anche se fu quasi unanime il riconoscimento della
grande interpretazione di Totò, che, lodato dalla critica, conseguì una menzione
speciale al Festival di Cannes e il suo secondo nastro d’argento, e, per
esprimere la sua soddisfazione, ringraziò la giuria dei critici cinematografici
italiani attraverso una breve dichiarazione scritta. Prima di ritornare con
Pasolini, ottenne un ruolo in Operazione San Gennaro di Dino Risi, accanto
a Nino Manfredi. Nel 1967 girò con Pasolini il cortometraggio La terra vista
dalla luna, episodio del film collettivo Le streghe, tratto dal racconto di
Pasolini mai pubblicato Il buro e la bura; poi Che cosa sono le nuvole?, un
episodio del film Capriccio all'italiana, dove l'attore prese parte anche a un
altro corto di Steno: Il mostro della domenica.
Furono le sue ultime
pellicole. Venne chiamato anche da Nanni Loy per Il padre di famiglia, di nuovo
con Manfredi, in un ruolo di un anziano anarchico che vive vendendo calzini e
mutande ai compagni della sinistra; film destinato a collocarsi fra i tanti
progetti non realizzati da Totò, poiché girò la prima scena (per ironica
casualità, quella d'un funerale) e morì due giorni dopo.
Totò incontrò la televisione
già nel 1958, insieme a Mario Riva nel programma Il Musichiere. Fece ritorno
solo nel 1965, invitato da Mina nella trasmissione Studio Uno, partecipando a
due puntate: nella prima, subito accolto da un lunghissimo applauso, presentò la
sua canzone Baciami, lasciando cantare Mina mentre lui interveniva facendo da
contrappunto alle parole della canzone con qualche sua classica battuta. Nella
seconda puntata, nel 1966, ripropose invece un vecchio sketch (Pasquale)
con Mario Castellani. La scenetta venne poi incisa, insieme alla poesia 'A
livella, in un disco 33 giri dell'attore. Nel suo ultimo periodo di vita, mise
in lavorazione alcuni caroselli e una serie per la tv chiamata TuttoTotò,
comprendente nove telefilm a cura di Bruno Corbucci e diretti da Daniele D'Anza.
La serie, nata da un'idea di Mario Castellani, doveva essere inizialmente
diretta da Michele Galdieri (l'autore di molte riviste di Totò), ma morì prima
che iniziasse la lavorazione. La maggior parte dei copioni di questi telefilm
apparivano troppo deboli, e soltanto alcuni di questi, con testi
discreti, diedero modo a Totò di esibirsi in alcuni suoi numeri, riproponendo
alcuni dei suoi famosi sketch teatrali. L'attore appariva però provato e
lavorava non più di quattro ore nel pomeriggio, ma nonostante tutto era ancora
in grado di padroneggiare la scena. Il ciclo andò in onda dopo la sua morte, dal
maggio al luglio del '67, per poi essere replicato dieci anni più
tardi. Positiva fu l'accoglienza del pubblico, più fredda quella della critica,
che sottolineava come la comicità di Totò non apparisse al meglio a causa della
realizzazione frettolosa e approssimativa.
Alcuni giorni prima della sua
morte, Totò disse di chiudere in fallimento e che nessuno lo avrebbe ricordato,
dichiarò di non essere stato all'altezza delle infinite possibilità che il
palcoscenico offre (riferendosi chiaramente alla sua vera e unica passione, il
teatro) e si rimproverò del fatto che avrebbe potuto fare molto di più. Morì
nella sua casa di Via dei Monti Parioli, 4; alle 3:25 del mattino (l'ora in cui
era solito coricarsi era le 3:30 circa) del 15 aprile 1967, all'età di 69 anni:
venne stroncato da un infarto dopo una lunga agonia, tanto sofferta che lui
stesso pregò i familiari e il medico curante di lasciarlo morire. Proprio la
sera del 13 aprile confessò al suo autista Carlo Cafiero: «Cafiè, non ti
nascondo che stasera mi sento una vera schifezza». Secondo la figlia Liliana, le
sue ultime parole furono: «Ricordatevi che sono cattolico, apostolico,
romano», mentre a Franca Faldini disse: «T'aggio voluto bene Franca, proprio
assai.»
Nonostante l'attore avesse
sempre espresso il desiderio di avere un funerale semplice, ne ebbe addirittura
tre. Il primo nella capitale, dove morì. La sua salma fu vegliata per due giorni
dalle principali personalità dello spettacolo e non, giunte da tutta Italia per
commemorarlo e rimpiangerlo. Fu accompagnata da più di duemila persone nella
chiesa Sant'Eugenio, sul Tevere, dove si svolse la cerimonia funebre. Tra le
personalità dello spettacolo presenti, all'interno della chiesa si
notarono Alberto Sordi, Elsa Martinelli, Olga Villi, Luigi Zampa e Luciano
Salce; parteciparono anche i registi che lo avevano sempre ignorato, e i critici
che lo avevano avversato e considerato un artista inconsistente e volgare. Sulla
sua bara furono poggiati la famosa bombetta con cui aveva esordito e un garofano
rosso, la cerimonia si limitò a una semplice benedizione a causa delle
difficoltà create dalle autorità religiose, perché con Franca Faldini l'attore
non era sposato, addirittura fu fatta uscire di casa mentre il prete benediceva
la salma di Totò.
Il secondo si svolse a Napoli,
la sua città natale alla quale era particolarmente legato e la sua gioia più
grande sarebbe stata proprio ritornare lì, così fu: Il 17 aprile di pomeriggio
il feretro partì verso la città, scortato da circa trenta vetture. La città
sospese dalle 16 alle 18,30 ogni attività, fu interrotto il traffico, i muri
delle strade furono riempiti di manifesti di cordoglio, le serrande dei negozi
vennero abbassate e socchiusi i portoni degli edifici in segno di lutto. Tra gli
altri personaggi dello spettacolo ed amici stretti, ad attendere il feretro,
c'erano i fratelli Nino e Carlo Taranto, Ugo D'Alessio, Luisa Conte, Dolores
Palumbo. A causa della grande affluenza, il furgone che trasportava la salma
impiegò due ore per raggiungere la chiesa di Sant'Eligio, dove si svolsero i
funerali di fronte alla folla traboccante, valutata in circa 250 000
persone, tra bandiere, stendardi e corone.
L'orazione funebre venne
tenuta da Nino Taranto: «Amico mio, questo non è un monologo, ma un dialogo
perché sono certo che mi senti e mi rispondi, la tua voce è nel mio cuore, nel
cuore di questa Napoli, che è venuta a salutarti, a dirti grazie perché l'hai
onorata. Perché non l'hai dimenticata mai, perché sei riuscito dal palcoscenico
della tua vita a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l'avvolge.
Tu amico hai fatto sorridere la tua città, sei stato grande, le hai dato la
gioia, la felicità, l'allegria di un'ora, di un giorno, tutte cose di cui Napoli
ha tanto bisogno. I tuoi napoletani, il tuo pubblico è qui, ha voluto che il suo
Totò facesse a Napoli l'ultimo "esaurito" della sua carriera, e tu, tu maestro
del buonumore questa volta ci stai facendo piangere tutti. Addio Totò, addio
amico mio, Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che
sei stato uno dei suoi figli migliori, e che non ti scorderà mai, addio amico
mio, addio Totò.»
Dopo il rito funebre, le
autorità furono costrette a far uscire la salma da una porta secondaria,
all'interno della basilica si susseguirono scene di panico e anche
svenimenti; ci furono quattro feriti, due donne e due agenti, in seguito
all'enorme scompiglio causato. Il corpo di Totò venne così scortato da
motociclisti della polizia al Cimitero del Pianto, ove ad attendere c'erano
Franca Faldini, la figlia Liliana con il marito, Eduardo Clemente e Mario
Castellani, che per via della straripante folla decisero di non assistere alla
funzione religiosa e raggiunsero direttamente in auto il cimitero. Totò fu
sepolto nella tomba di famiglia accanto ai genitori, al piccolo Massenzio e
all'amata Liliana Castagnola.
Il terzo funerale lo volle
organizzare un capoguappo del Rione Sanità, nel suo quartiere, che si tenne il
22 maggio, cioè pochi giorni dopo il trigesimo; ad esso aderì un numero
altrettanto vasto di persone, nonostante la bara dell'attore fosse ovviamente
vuota. Eduardo De Filippo, con un partecipato articolo, lo ricordò dalle pagine
del quotidiano Paese Sera nel giorno della sua scomparsa.
«Non è una cosa facile fare il
comico, è la cosa più difficile che esiste, il drammatico è più facile, il
comico no; difatti nel mondo gli attori comici si contano sulle dita, mentre di
attori drammatici ce ne sono un'infinità. Molta gente sottovaluta il film
comico, ma è più difficile far ridere che far piangere.»
Secondo un sondaggio del 2009,
condotto dal giornale online quinews.it con mille intervistati equamente
distribuiti per fasce d'età, sesso e collocazione geografica (Nord, Centro, Sud
e Isole), Totò risultava essere il comico italiano più conosciuto ed amato,
seguìto rispettivamente da Alberto Sordi e Massimo Troisi. I suoi film, visti
all'epoca da oltre 270 milioni di spettatori (un primato nella storia del cinema
italiano), molti dei quali rimasti attuali per satira e ironia, sono stati
raccolti in collane di VHS e DVD in svariate occasioni e vengono ancora oggi
costantemente trasmessi dalla tv italiana, riscuotendo successo anche tra il
pubblico più giovane. Inoltre talune sue celebri battute, espressioni-mimiche e
gag sono divenute perifrasi entrate nel linguaggio comune.
Umberto Eco ha espresso così
l'importanza di Totò nella cultura italiana: «In questo universo globalizzato in
cui pare che ormai tutti vedano gli stessi film e mangino lo stesso cibo,
esistono ancora fratture abissali e incolmabili tra cultura e cultura. Come
faranno mai a intendersi due popoli [cioè cinesi e italiani] di cui uno ignora
Totò?»
Liliana De Curtis, la figlia
del comico, è tuttora attiva per mantenere vivo il ricordo del padre. Molti
italiani, ancor oggi, si rivolgono a Totò inviando lettere e biglietti alla sua
tomba, per confidarsi, chiedere favori e addirittura grazie, come fosse un
santo. La notorietà di cui Totò gode in Italia è andata anche oltre i confini
nazionali: ad esempio in America, dove il comico Jim Belushi lo ha definito un
«clown meraviglioso». L'attore George Clooney, intervistato in Italia in
occasione del remake de I soliti ignoti, Welcome to Collinwood (2002), in cui
lui interpretava il corrispettivo ruolo di Totò, ha altresì dichiarato: «Era un
vero poeta popolare, un fantasista espertissimo nell'arte di arrangiarsi e di
arrangiare ogni gesto ed espressione» precisando inoltre che, secondo il suo
parere, tutti i comici più celebri come Jerry Lewis, Woody Allen o Jim
Carrey devono qualcosa all'attore italiano. «Non era certo solo un comico,
proprio come Buster Keaton. I suoi film potrebbero essere anche muti: riesce
sempre a trasmettere il senso della storia. Grazie ai vostri sceneggiatori e
alla sua mimica, dai suoi film traspare un personaggio a tutto tondo: astuto,
ingenuo e anche vessato dalle circostanze della vita. Per questo continuerà a
essere imitato, senza speranza di eguagliarlo. C'è sempre suspense nella sua
recitazione: si aspetta una sua nuova battuta, una strizzatina d'occhi, ma resta
imprevedibile il suo modo di sviluppare una storia.»
«Tengo molto al mio titolo
nobiliare perché è una cosa che appartiene soltanto a me... A pensarci bene il
mio vero titolo nobiliare è Totò. Con l'altezza Imperiale non ci ho fatto
nemmeno un uovo al tegamino. Mentre con Totò ci mangio dall'età di vent'anni. Mi
spiego?» Dopo l'adozione nel 1933 da parte del marchese Francesco Maria
Gagliardi Focas, cavaliere del Sacro Romano Impero (D. M. di riconoscimento 6
maggio 1941), Totò intraprese lunghe e costose battaglie legali, portate avanti
con determinazione, per il riconoscimento di nobiltà, anche grazie all'aiuto di
esperti avvocati e araldisti. Totò riteneva di appartenere a un ramo decaduto
dei nobili de Curtis, quello dei conti di Ferrazzano, sebbene tale discendenza
non sia mai stata dimostrata. Il 18 luglio 1945 e il 7 agosto 1946 il Tribunale
di Napoli, IV sez., emanò sentenze che gli riconobbero diversi titoli gentilizi,
che vennero registrati a pag. 42 vol. 28 del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana,
tenuto presso l'archivio della Consulta Araldica (Roma, Archivio Centrale dello
Stato): Principe, Conte Palatino, Nobile, trattamento di Altezza Imperiale. Con
sentenza 1º marzo 1950 del Tribunale civile di Napoli, il cognome di Totò venne
rettificato in "Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio", anche
se sul pronao della cappella della sua tomba, nel Cimitero di Santa Maria del
Pianto a Napoli, l'incisione recita solo Focas Flavio Comneno De Curtis di
Bisanzio - Clemente. Di fatto, dalla sentenza del 1946, Totò acquisì i titoli e
i nomi di: Antonio Griffo Focas Flavio Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De
Curtis di Bisanzio, altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del Sacro
Romano Impero, esarca di Ravenna, duca di Macedonia e di Illiria, principe di
Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania,
del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo.
In seguito al riconoscimento nobiliare, Totò fece coniare delle medaglie d'oro
dal peso di 50 grammi l'una ritraenti il suo profilo, come fosse un imperatore
romano, e che amava regalare ai suoi amici più intimi. Sembra che ben cinque
denunce siano state sporte contro l'attore (anche da privati cittadini) per
"abuso di titoli nobiliari".
Immortale Totò, principe
della risata e imperatore solitario.
Morì 50 anni fa, ebbe 3
funerali, vita furibonda e grandi amori, scrive Giorgio Gosetti il 15 aprile
2017 su l' "Ansa". Cosa si può dire ancora di Totò, per gli amici Antonio De
Curtis ma per l'anagrafe Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno
Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, scomparso il 15 aprile di 50 anni
fa nella sua casa romana di Viale Parioli a soli 69 anni di una vita furibonda e
frenetica? Tanto fu applaudito ed esecrato in vita, specie dalla critica, tanto
suscitò passioni ed amori nel pubblico e nelle donne, tanto fu un'anima
solitaria come solo i grandi comici sanno essere e tanto visse sempre
nell'angoscia di non essere ricordato se non per la sua maschera farsesca. Dopo
una consacrazione postuma che lo ha innalzato ai vertici della popolarità e
dell'arte, dopo le mille e mille righe a lui dedicate da studiosi (Umberto Eco)
e artisti (Pasolini scrisse che la "sua maschera riuniva perfettamente
l'assurdità e il clownesco con l'immensamente umano") cosa resta da dire?
Figlio illegittimo del Barone
Giuseppe De Curtis e di Anna Clemente, Antonio "N.N." Clemente detto Totò nasce
il 15 febbraio 1898 nel cuore della "guapperia" napoletana al Rione Sanità in
quella casa modesta che oggi sarebbe il suo museo ed è invece lasciata
nell'incuria a rischio di crollo. Malinconico e solitario, poco versato per gli
studi e complessato per il suo stato di "figlio di nessuno" (il padre lo
riconobbe dopo i 20 anni), Totò si rifugia fin da bambino dietro la maschera del
comico e dell'istrione, le sole armi con cui si fa amare da compagni e grandi.
Esordisce sui palcoscenici periferici di Napoli già nel 1913, ma è solo dopo la
Grande Guerra (sotto le armi ma lontano dal fronte) che abbraccia il suo destino
sul palcoscenico della Sala Napoli scritturato da Eduardo D'Acierno.
Il padre riunisce la famiglia
a Roma e qui Totò, nella totale disapprovazione dei genitori, comincia la sua
vera gavetta da "straordinario" di compagnia, aggregato a diverse formazioni,
spesso lasciato senza lavoro e senza soldi, solo a fatica in grado di farsi
largo nel mondo della commedia dell'arte e dell'avanspettacolo. Il fortuito
incontro con Giuseppe Iovinelli, l'impresario dell'Ambra Iovinelli di Roma e
l'inaspettato successo delle sue macchiette ne fanno rapidamente un divo della
scena comica. Non scorderà mai però la fatica degli esordi: "La miseria - diceva
- è il copione della vera comicità... Non si può essere un vero attore comico
senza aver fatto la guerra con la vita". Simile in questo a Charlot, che spesso
additò a modello, desolato come Buster Keaton a cui fin troppo spesso veniva
accostato per la gestualità straniata, Totò fu però soprattutto un formidabile
autodidatta, capace di cogliere nei tic della gente comune i tratti che poi
elevava a gesti comici (da bambino lo chiamavano 'o spione per la sua attenzione
al lato buffo degli altri), anarchico nel lavoro quanto meticoloso nella
costruzione di sé e delle sue maschere. Nel pantheon dei grandi interpreti "del
corpo" assomma i tratti di Eduardo e Tati, Chaplin e Keaton, ma non viene mai
meno a una originalità senza limiti che, lo faceva applaudire anche dagli
stranieri (dalla Svizzera alla Spagna), mentre solo la pigrizia e la timidezza
provinciale gli preclusero i palcoscenici più grandi, compreso quello americano
dove venne invano invitato. La sua eredità non viene ben descritta dai numeri,
comunque impressionanti: 97 lungometraggi interpretati a passo di carica dopo
l'esordio nel 1937 con "Fermo con le mani", voluto da Goffredo Lombardo che
cercava volti nuovi per il cinema; oltre 50 spettacoli tra commedia, rivista,
avaspettacolo nell'arco di tempo che va dal 1928 al 1957 quando l'aggravarsi di
una acuta malattia agli occhi lo rese praticamente cieco. In parallelo ci sono
poi le prove da cantante (con un successo speciale per "Malafemmena"), le
apparizioni televisive (memorabile "Studio Uno" con Mina), le poesie (la
raccolta di "A' livella"), i fumetti, le pubblicità, le apparizioni a sorpresa.
Ma il cuore di un successo che ancora oggi lo fa primeggiare su ogni altro
protagonista della scena italiana (a grande distanza da Alberto Sordi e Massimo
Troisi) viene da una genialità interpretativa che sempre lo fece autore di se
stesso, in una dimensione sospesa tra osservazione del reale e astrazione
surrealista, satira e farsa, intuizione verbale (celeberrimi i modi dire che
sono entrati nel lessico comune) e costruzione fisica (la maschera-automa, il
guitto e il poeta, il pulcinella e il nobile).
Benché abbia avuto al cinema
pigmalioni come Cesare Zavattini e De Sica, poi grandi sodali come Carlo
Ludovico Bragaglia, Steno e Monicelli o perfetti complici del suo genio (da
Corbucci a Mattoli a Mastrocinque), solo a fine carriera ebbe l'onore dei
maggiori autori italiani: lo voleva Fellini per mai realizzato "Viaggio di G.
Mastorna", lo scelse Pasolini (da "Uccellacci e uccellini" a "Che cosa sono le
nuvole"), lo chiamarono Risi, Bolognini, Lattuada. Eppure nell'immaginario
popolare vive soprattutto per i film interamente modellati su di lui, da
"Miseria e nobiltà" a " Totò le mokò", da "I pompieri di Viggiù" a "47 morto che
parla" fino ai vari episodi di " Totò e Peppino" in coppia con l'amico De
Filippo. Fece scalpore anche nella vita privata, segnata da grandi passioni e
dolori: dal suicidio della prima moglie, la sciantosa Liliana Castagnola, fino
alla tormentata e appassionata storia con Franca Faldini. Si fece adottare, nel
1933, dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, in rincorsa a quel prestigio
aristocratico che gli sembrava riscattare le sue origini; si sentiva davvero
erede del sacro romano impero e della corona di Costantinopoli, anche se le
battaglie legali gli fruttarono spesso denunce e delusioni. Come in una pièce di
Pirandello ebbe l'onore di 3 funerali: il primo a Roma, vegliato per due giorni
dai più grandi di cinema e teatro; il secondo a Napoli in un bagno di folla con
250.000 anime straziate dietro al feretro; il terzo nel cuore di Spaccanapoli
dove un guappo locale organizzò la cerimonia intorno a una bara vuota. Ma a quel
punto la sua arte volava ormai da giorni nel firmamento dei geni.
Totò, 50 anni senza il
Principe della risata: 5 film da vedere su YouTube.
Antonio De Curtis moriva il 15
aprile del 1967, scrive il 14 aprile 2017 su Panorama. "Sono un osso duro, io!
Sono tutt'ossa!", diceva Totò alias Felice Sciosciammocca nel film Un turco
napoletano. Antonio De Curtis, in arte Totò, era infatti tutto nervi e ossa,
viso scavato e un'espressività prepotente e trascinante. Un osso duro della
risata. Morto il 15 aprile 1967 a 69 anni, attore, cantante, poeta e tanto
altro, Totò è stato il "Principe della Risata" ma anche drammaturgo dal fulgente
animo tragico. Coi suoi lazzi, i doppi sensi e la mimica incalzante conquistava.
Ma sapeva anche far increspare il cuore. Nel cinquantesimo anniversario della
sua morte, Napoli festeggia la sua icona con la mostra Totò Genio, un grande
mosaico che rappresenta l'arte di De Curtis in tre luoghi diversi (fino al 9
luglio): il Museo Civico di Castel Nuovo (Maschio Angioino), Palazzo Reale e il
Convento di San Domenico Maggiore.
Per rivederlo nella sua verve
irresistibile, ecco cinque film da vedere completi su YouTube.
1) Totò, Peppino e la...
malafemmina (1956) di Camillo Mastrocinque. Totò in grande forma in questa
commedia, accanto a Peppino De Filippo. Indimenticabile la scena cult della
lettera dettata da Totò e scritta da Peppino, ripresa da Roberto Benigni e
Massimo Troisi in Non ci resta che piangere.
2) Uccellacci e
uccellini (1966) di Pier Paolo Pasolini. Anche film d'autore per Totò, che
accettò il ruolo pur con qualche riserva sul suo personaggio proprio per
ascrivere il suo nome ai film di qualità. Un grande intellettuale come Pasolini
"sdogana" il Principe della Risata facendogli conseguire una menzione speciale
al Festival di Cannes. Per l'attore è il suo ultimo film da protagonista.
3) I due marescialli (1961)
di Sergio Corbucci. Commedia all'italiana che unisce Totò e Vittoria De Sica
nell'Italia in guerra del 1943. Il primo è un ladruncolo, vestito da prete,
l'altro un maresciallo, che si scambiano vestiti e ruoli.
4) Miseria e
nobiltà (1954) Mario Mattoli. La celebre scena di Totò che mangia gli spaghetti
con le mani appartiene a questa commedia. Il comico napoletano ancora una
volta Felice Sciosciammocca, il personaggio immaginario del teatro
partenopeo creato da Eduardo Scarpetta. Nel cast anche Sophia Loren e Valeria
Moriconi.
5) Totò contro Maciste (1962)
di Fernando Cerchio. Parodia dei film peplum, fa parte di una serie di
rivisitazioni mitologiche in chiave comica di cui Totò fu protagonista.
Qualunquista, anarchico,
gotico: a ognuno il suo Totò.
All'epoca i critici non amavano i suoi film. Apprezzati invece da certi
scrittori, da Zavattini a Soldati. La rivalutazione ripartì in pieno post-68,
con un volume di Goffredo Fofi. Che rende merito al più grande comico italiano
di cui il cinema abbia lasciato testimonianza, scrive Emiliano Morreale il 14
aprile 2017 su "L'Espresso". Totò fa ormai parte dell’arredamento domestico
degli italiani: le sue foto nei ristoranti del centro Sud, la sua immagine nei
canali televisivi a riempire le fasce orarie più bisognose. Eppure a rivedere e
ristudiare i suoi film possono arrivare sorprese: basti pensare ai volumi che
gli ha dedicato, alcuni anni fa, Alberto Anile, ritrovando un Totò inedito, alle
prese con la cultura del suo tempo, con la politica, con la censura. I critici,
si è detto, all’epoca non amavano i suoi film. Che erano spesso modesti, ma non
sempre: non solo quelli di Steno e Monicelli, che lo declinavano in versione più
“neorealista” (“Guardie e ladri”, “Totò cerca casa”), ma anche certi che più
direttamente assecondavano il suo genuino versante farsesco: Mattoli, Corbucci,
Mastrocinque. In compenso, Totò era amato da certi scrittori: quelli di
derivazione futurista o surreale, che in lui vedevano la marionetta umana (il
giovane Zavattini, Campanile, Palazzeschi), ma anche acuti osservatori
come Soldati o Flaiano. I fortunati, all’epoca, dicevano che il vero Totò era
quello teatrale, che dal vivo potevano apprezzarsi al meglio le sue qualità.
Probabilmente è vero; forse per questo uno dei suoi film più memorabili è “Totò
a colori” (1952), centone di suoi numeri di varietà, lievitati e portati a
perfezione da anni di improvvisazioni. E non a caso hanno avuto fortuna negli
anni varie antologie dei “numeri” più famosi, che sono in fondo una forma
legittima di mostrare i suoi film. Cerimonia al cimitero di Poggioreale dove il
sindaco ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Totò. Presente anche Elena
de Curtis, nipote dell'artista, che ha detto: "E' qui con noi, si starà facendo
una marea di risate". "Sono davvero entusiasta per la qualità delle iniziative,
la partecipazione, la grande emotività" ha aggiunto de Magistris accompagnato
dall'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, dal presidente
della II Municipalità, Ivo Poggiani, dal Comandante della Polizia Municipale,
Ciro Esposito, dal Questore di Napoli, Antonio De Iesu."Sono passati 50 anni ma
Totò è qui, nella città, tra i napoletani", conclude de Magistris.
La sua rivalutazione ripartì
in pieno post-’68, con un volume di Goffredo Fofi. Ma alla fine della carriera
c’era stato, come è noto, l’incontro con Pasolini. Il quale, forse più ancora
che in “Uccellacci e uccellini”, fece risplendere il suo genio negli episodi a
colori, “La terra vista dalla luna” e “Che cosa sono le nuvole” (in cui, Iago
tinto di verde, recita una delle morti più strazianti viste al cinema,
depositato in una discarica da Domenico Modugno). Rimane infine il rimpianto di
non averlo potuto vedere nei panni di San Giuseppe da Copertino, il “santo
cretino” che volava, in “C’era una volta” di Francesco Rosi (il produttore Ponti
bocciò l’idea). Ognuno, ovviamente, ha il suo Totò preferito. Personalmente, mi
piace ricordare il versante nero, gotico, di “Totò Diabolicus” o “Che fine ha
fatto Totò Baby?”. Del resto, Mario Monicelli sosteneva che Totò gli faceva un
po’ paura: la sua faccia era un teschio, come la maschera di Pulcinella; anche
la critica americana Pauline Kael scriveva dei «suoi occhi stanchi, che hanno
visto tutto». Un aspetto colto magnificamente da Alberto Lattuada, che nella
“Mandragola” (1965) lo fa monologare nelle catacombe. "Ma mi faccia il piacere",
"Cà nisciuno è fesso". I napoletani parlano con le battute di Totò, usate quasi
senza accorgersene nel quotidiano per descrivere una situazione o una persona.
Qualunquista e anarcoide,
aristocratico e plebeo distruttore delle convenzioni, Totò è senza dubbio il più
grande comico italiano di cui il cinema abbia lasciato testimonianza, ed è
l’ultimo “comico primario” di un’Italia povera, mosso dal bisogno di cibo e di
sesso. È forse difficile, per chi è nato dopo la sua morte, cinquant’anni fa,
inserirlo nel mondo da cui proveniva, forse perfino capirlo. Mi viene quasi il
timore, per un attimo, che un giovane oggi possa apprezzare Totò, ma non ridere
davvero con lui.
Totò, 50 anni dopo i
critici continuano a stroncarlo: “Il suo è stato brutto cinema con brutti film”.
"All’interno
di questi film che sono oggettivamente brutti, esclusi pochi costruiti con più
abilità, ci sono pero dei momenti, parlo di cinque minuti, dove Totò dimostra la
sua genialità”, spiega al FQMagazine Paolo Mereghetti. "Lui ha sofferto
tantissimo il fatto che non gli offrissero film di alta qualità, ma quando li ha
fatti è stato molto bravo perché ad esempio con Pasolini, che lo ha persino
fatto diventare buono", afferma Roberto Escobar, critico del Sole 24Ore, scrive
Davide Turrini il 13 aprile 2017 su “Il Fatto Quotidiano. “Totò genio artistico
senza pari, ma i film che interpretava erano (e rimangono) brutti”. Il rapporto
non riconciliato tra la critica cinematografica e i quasi cento film del
“principe della risata” – di cui il 15 aprile 2017 ricorrono i 50 anni dalla
morte – continua. E senza troppe novità. Nell’infinita giaculatoria di mea
culpa, dove tutti hanno rivalutato il comico, la maschera, l’uomo De Curtis,
ecco che per titoli come Totò sexy, Totò e i re di Roma, 47 morto che
parla, Totò Vittorio e la dottoressa, alcune opere a caso su almeno tre quarti
dei titoli da lui interpretati, stellette, pallini, voti in pagella, schede di
rivalutazione non sono mai riapparse, anzi. “Alcuni film di Totò sono
francamente brutti, fatti in fretta, talvolta ne girava sei all’anno come un
matto. E all’interno di questi film che sono oggettivamente brutti, esclusi
pochi costruiti con più abilità, ci sono pero dei momenti, parlo di cinque
minuti, dove Totò dimostra la sua genialità”, spiega al FQMagazine Paolo
Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della sera ma soprattutto
autore del Dizionario dei film (Baldini&Castoldi) dove appena una ventina di
titoli su novantasette interpretati dal comico napoletano raggiungono la
sufficienza (Totò, Peppino e la malafemmina e Totò a colori sono gli unici con 4
stellette ndr). “E’ lo stesso discorso che si può fare per Gary Cooper e
Humphrey Bogart: non tutti i film con Bogie sono capolavori, ma lui era un
grande attore anche nei film brutti. Non c’è nulla di che stupirsi, sul
dizionario si cerca di giudicare un film nella sua complessità e i risultati
sono questi. Ultimamente c’è stata una specie di vulgata critica che per una
battuta comica di livello si è messa a salvare l’intero film. Parlo in generale
di commedie italiane squinternate. Chiaro, si può ridere a una battuta di
Franchi e Ingrassia anche se i loro film venivano fatti oggettivamente coi
piedi. Identico discorso che si può applicare ai lavori interpretati da Totò”.
“Insisto: come cinema in senso stretto quello fatto da Totò è stato un brutto
cinema”, spiega Roberto Escobar, critico del Sole 24Ore e autore di una ricca
monografia su Antonio De Curtis (Totò – Il Mulino). “E dirò di più. È un
paradosso, ma i più bei film interpretati da Totò in realtà tradiscono Totò. Lui
ha sofferto tantissimo il fatto che non gli offrissero film di alta qualità, ma
quando li ha fatti è stato molto bravo perché ad esempio con Pasolini, che lo ha
persino fatto diventare buono, non era più e solo una maschera, ma un grande
attore”. “E comunque lo scrivo da sempre: per fortuna i film che ha interpretato
sono brutti, perché Totò è più dei suoi film” – continua Escobar, “Come diceva
Goffredo Fofi: il film ideale di Totò è un’antologia, non un superfilm con
montate le parti migliori delle sue decine di film, ma la persistenza nella
memoria di un continuum di immagini e emozioni. Quando i miei colleghi critici
di un tempo, come Guido Aristarco, lo stroncavano, potevano sì stroncare i film
ma non si rendevano conto di avere di fronte agli occhi un diamante”. “Pensare
che le intenzioni fossero quelle di girare dei grandi film, equivarrebbe a dare
ai produttori dell’epoca intenzioni che non hanno avuto. Totò, il più grande
comico italiano veniva utilizzato soltanto per fare soldi al botteghino e veniva
usato bene solo in rari casi, cito L’oro di Napoli o Uccellacci e uccellini”,
afferma Alberto Anile, autore del libro fresco di stampa Totalmente Totò. Vita e
opere di un comico assoluto (edizioni Cineteca di Bologna). “Totò non ha potuto
essere come Chaplin, autore totale dei suoi film dalla recitazione alla musica,
è stato autore e regista dei suoi spettacoli. Copioni, personaggi sketch interi,
non solo battute, che poi portò nei film interpretati. Infine, come racconto nel
libro grazie alle dichiarazioni di Vincenzo Talarico e Franca Faldini, negli
anni sessanta, quando Totò era già stanco e disilluso del mondo del cinema,
sbucò un testo per un film muto da lui scritto che Ponti e De Laurentiis
bocciarono. Avrebbe potuto portare al cinema storie scritte e ideate da lui, ma
non avvenne per via dell’insipienza dei produttori”.
Totò, un mito con Napoli
sempre nel cuore,
scrive Franco Insardà i 16 Aprile 2017 su "Il Dubbio". L’antropologo Marino
Niola ci spiega il legame speciale tra Totò e Napoli: «Il mito è un alimento
dell’immaginario in cui ci si riconosce subito». Napoli e Totò, un rapporto
ancestrale, passionale, sincero che ha legato il Principe De Curtis alla città
in modo indissolubile quando era in vita, fino a fargli dire «sto morendo,
portatemi a Napoli» e oggi, a cinquant’anni dalla morte ne ha fatto un mito
partenopeo come San Gennaro e Pulcinella. Il suo essere fisico e metafisico, in
perenne bilico tra l’allegria e la tristezza ne hanno fatto un’icona nella quale
si riconoscono tutti: il sottoproletario, l’aristocratico, il borghese. Marino
Niola, professore di Antropologia dei simboli all’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, collaboratore di Repubblica (ha una rubrica settimanale
sul Venerdì), del Nouvel Observateur e di altre testate straniere, da studioso e
da napoletano ha analizzato a fondo il rapporto tra Totò e i napoletani.
Professor Niola, ci spiega
questo legame così profondo?
«Totò
è stata una grande maschera di Napoli. Una maschera interclassista nella quale
ognuno poteva e può riconoscersi. Ciascuno ci trova una parte di se, e spesso è
quella parte che non quadra troppo. Il suo personaggio era sghembo come il suo
corpo. La sua faccia era un “qui pro quo”, esattamente come il suo “qui pro quo”
linguistico. Questo spiega la facile riconoscibilità per cui ciascuno trova
qualcosa che lo riconduce al proprio intimo e in cui si identifica. Anche questo
è tipico di Napoli, perché è una città di “qui pro quo”, di segni a forte
definizione in cui ci si riconosce subito, ma che è difficile conoscere».
Quanto ha dato Napoli a
Totò e quanto Totò a Napoli?
«La
città gli ha dato sicuramente l’humus culturale, umano, affettivo, sentimentale
da cui poi nasce la sua comicità. E lui ha restituito alla città sempre, in un
modo o nell’altro, nei suoi film, nelle sue poesie, nelle canzoni questo affetto
per Napoli. C’era un feedback continuo. Nel suo rapporto con Napoli non c’era
quella rabbia di Eduardo che lo rendeva antipatico a molti napoletani. Parliamo
di due icone, ma tra loro c’è questa enorme differenza: Eduardo era più una
icona borghese, mentre Totò era interclassista. Totò non voleva insegnare niente
a nessuno, Eduardo dava continue lezioni».
La folla immensa di piazza
del Carmine per l’ultimo saluto a Totò in questi cinquant’anni è aumentata ed è
un amore che si alimenta quotidianamente.
«Perché
di Totò, come per tutte le grandi icone dello spettacolo moderno, è rimasto il
suo corpo immateriale. I suoi film passano continuamente in tantissime tv in
tutt’Italia. Questo fa sì che anche le persone giovani, le quali quando Totò è
morto non erano neanche in mente dei, ricordino le sue battute. Senza contare il
merito incredibile di essere riuscito a rendere famoso nel mondo un posto, che
altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più, come Cuneo».
L’arte di arrangiarsi,
spesso geniale, è una delle caratteristiche dei personaggi di Totò che
ritroviamo da sempre a Napoli.
«Anche
in questo c’è un rispecchiamento: Totò nasce povero e si arrangia continuamente
nella vita e nei suoi film torna questo personaggio che non ha mai dimenticato
la fame. Tante è vero che l’elemento dell’indigenza è presente in molte scene,
nelle quali sogna in modo semplice, da persona del popolo, un alimento per nulla
sofisticato: lo sfilatino. L’aspetto, quindi, dell’arrangiarsi, del sotterfugio,
del piccolo imbroglio è presente, ma i suoi personaggi non sono mai delle
carogne. Utilizza degli espedienti perché gli servono per sopravvivere, per
pagare la scuola alla figlia ad esempio. Si tratta di motivi nobili che ne fanno
un povero cristo, mai il delinquente. Ha rappresentato in pieno il tipo umano
che usciva dalla guerra: povero, pieno di voglia di vita, irriverente e
disincantato quanto basta, che dava alle cose il giusto valore. E infatti da
questo atteggiamento ne deriva una continua lezione di saggezza».
Totò e il cibo è un altro
dei connubi della sua maschera. La scena degli spaghetti di Miseria e nobiltà è
diventata un’icona di moltissime trattorie in ogni parte del mondo. Come lo
spiega?
«È
la fame atavica del popolo. Totò diventa il paradigma, il simbolo del rapporto
tra il popolo e la fame. E il cibo è proprio questo e lui è una grande maschera,
proprio come Pulcinella che tradizionalmente non fa altro che sognare montagne
di maccheroni. Consideriamo anche che molti dei film sono stati girati tra la
fine della guerra e il ’ 57-’ 58, anni decisivi in cui l’Italia comincia a
voltare pagina, si lascia alle spalle la fame ed entra nel miracolo economico,
ma il ricordo della fame è ben presente».
Pulcinella, Totò, Troisi,
Maradona, Pino Daniele: perché Napoli ha bisogno di avere delle figure di
riferimento, direi quasi dei miti?
«Intanto
direi che tutti avrebbero bisogno di queste figure, ma non lo sanno, Napoli è
una città che non ha dimenticato come il mito sia un alimento dell’immaginario
che aiuta a ricostruire continuamente l’identità. Basti pensare che i napoletani
si chiamano ancora con il nome della fondatrice mitica: la sirena Partenope. Il
che vuol dire che il mito è nel cuore e negli occhi e queste figure
rappresentano la collettività. Dopo la sirena Partenope è arrivato San Gennaro,
poi Masaniello, fino a Maradona che incarnava l’uno e l’altro: un po’ Masaniello
e un po’ San Gennaro, un difensore della città e un simbolo della Napoli che
vince e che può fare miracoli. Non a caso nel film “Così parlò Bellavista” di
Luciano De Crescenzo il poeta paragona una finta di Maradona allo scioglimento
del sangue di San Gennaro».
L’arte di Totò è
paragonabile a quella di Chaplin, Groucho Marx o è assoluta e inimitabile?
«Ciascuno
di loro ha una cifra inimitabile, però ce li ricordiamo tutti. Sul piano
dell’arte Totò è grande quanto gli altri e se avesse avuto alle spalle lo star
system americano si parlerebbe di lui allo stesso livello di Chaplin, di Buster
Keaton e degli altri grandi comici Usa. Il fatto che sia partito da una
cinematografia come quella italiana, soprattutto da una cinematografia minore, e
sia arrivato a essere il simbolo vuol dire che parliamo di un campione assoluto».
Come mai il suo linguaggio,
i suoi modi di dire sono entrati nel parlare comune e spesso risolvono con una
battuta imbarazzi, sentimenti e stati d’animo?
«Totò
non chiedeva troppo per essere capito, la sua battuta faceva capire che lui ti
aveva capito, c’era una perfetta sintonia. Ci si può calare in quella battuta
come in un vestito che veste alla perfezione e diventa della persona,
interpretandone il sentimento. Non a caso alcune battute come “siamo uomini o
caporali”, “ma mi faccia il piacere”, “ogni limite ha una pazienza” sono
diventati modi di dire comuni della lingua italiana».
Il titolo del suo ultimo
libro Il presente in poche parole rimanda a un modo di dire alla Totò… “Ho detto
tutto”, ripetuto ossessivamente con Peppino De Filippo in Totò, Peppino e la
malafemmina…Lei, nei suoi libri, analizza la credulità popolari, le manie, le
perversioni legate al cibo e alla cucina: sarebbe stata un’occasione
ghiottissima per la comicità di Totò?
«Assolutamente
sì. Sulle diete, ad esempio, cominciava già a giocarci. Faceva spesso battute
sulla linea, sul dimagrimento. Anche se lui esalta sempre la donna in carne, la
maggiorata, la donna che a Napoli si chiama “ciaciona”, come nel film “Signori
si nasce” quando bacia il seno di una procace e giovane Angela Luce, o quando
chiede a Sophia Loren in “Miseria e nobiltà” di essere accolto nel suo seno. In
lui persino le donne sono quasi da mangiare. Anche in questo è come Pulcinella:
il cibo e il sesso sono due facce dello stesso desiderio».
Totò e le donne: un altro
rapporto molto stretto.
«Strettissimo.
La sua vita è punteggiata da donne decisive. E Napoli è assolutamente donna».
I personaggi di Totò sono
spesso irriverenti, non politically correct, forse è per questo che arrivano
alla gente. Affronta anche temi scomodi: le case chiuse, il regime nazifascista,
la morte e interpreta ancora una volta il sentimento popolare e risolve con uno
sberleffo o una battuta che rimarrà per sempre nella mente. È questa la sua
forza?
«Arrivano
alla gente perché Totò in alcune cose non è stato costretto a censurarsi, mentre
gli argomenti scomodi li ha affrontati con garbo. Quando non poteva affrontarli
esplicitamente li risolveva, come in “Totò e i re di Roma”, con un “poi dice che
uno si butta a sinistra…”. Si è salvato dall’onda del politicamente corretto e
da questa forma di stupidità profonda che si annida nel politicamente corretto,
risolvendo con uno sberleffo situazione pesanti e complicate. Dimostrando che
non c’è bisogno di esasperare certe situazioni, ma che in certi momenti una
battuta dà a tutti una via di uscita».
In occasione dei
cinquant’anni della sua morte il mondo del cinema lo sta ricordando
adeguatamente?
«Gli
sta in parte restituendo, in ritardo, quello che gli ha tolto quando era vivo.
Non dimentichiamo che molti dei lodatori attuali di Totò, come campione della
comicità popolare, sono gli stessi che in quegli anni dicevano delle baggianate
spaventose suoi sui film, figlie di una critica occhiuta e ideologica».
C’è qualche erede di Totò?
«No.
No. No. Una sarebbe potuto essere Massimo Troisi che fondeva in se qualche
aspetto di Totò e qualche altro di Eduardo. Più di Totò che di Eduardo, ma era
un Totò generazionale che ne aveva quindi una parte. Oggi non vedo eredi».
“A proposito di politica,
ci sarebbe qualche coserellina da mangiare?”
Napoli celebra Totò al Rione Sanità, scrive Imma Pepino il 29/04/2017 su “I
Siciliani”. “Mi scusi, mi sa dire dov’è che hanno messo la statua di Totò?”.
“Signurì è facile, deve andare diritto. Non il primo cortile, il secondo”. Il
secondo cortile è l’interno di un palazzo antico: il palazzo dello Spagnuolo,
come recita la targa in legno sul corrimano della scala. La statua di Totò –
realizzata da Giuseppe Desiato, in collaborazione con la Fondazione San Gennaro
– non si trova qui però. L’indicazione che però mi è stata fornita dal
pescivendolo all’ingresso del Borgo Vergini non è del tutto sbagliata, o meglio
ha una sua logica: proprio a palazzo dello Spagnuolo dovrebbe essere realizzato
il museo dedicato alla memoria di Antonio De Curtis – come deliberato nel 1996
dalla Giunta regionale. Il progetto, voluto anche dai cittadini del quartiere
che diede i natali all’artista, è però fermo da vent’anni – come denunciato il
15 Aprile scorso, all’inaugurazione delle celebrazioni, dai rappresentanti della
Terza municipalità (di cui il Rione Sanità fa parte) e in particolare da
Francesco Ruotolo, consulente alla memoria della Municipalità stessa, che ha
affisso in alcuni luoghi simbolo del rione dei manifesti di denuncia rivolti a
sindaco e presidente della regione affinché “Totò non muoia una seconda volta”.
Un signore di mezz’età, anche lui deluso visitatore del museo fantasma, si
sofferma a descrivermi il degrado in cui versa anche la casa in cui nacque
l’artista. Mi dirigo verso Piazza San Vincenzo, il cuore del quartiere. Dopo
aver percorso qualche metro giungo in Largo Vita: qui campeggia il monolite
raffigurante la sagoma di De Curtis. La statua è molto bella, moderna nelle
forme. Si trova poco distante dal viale di ingresso dell’ospedale San Gennaro,
chiuso dalla giunta regionale De Luca. Il presidente, contestato proprio in
occasione dell’inaugurazione della statua, aveva avvalorato la sua decisione
pronunciando un solenne e istituzionale: “Signo’ ma l’avete fatta la pastiera?”.
Potrei percorrere Calata delle fontanelle e ritornare a Materdei, ma decido di
dare un’occhiata anche alla casa di Totò. La strada per arrivare è lastricata di
opere dedicate all’artista, come il busto posto all’angolo di Salita
Capodimonte. Il vecchio appartamento, in Via Santa Maria Antesaecula, è stato
acquistato da un privato e si trova in condizioni di totale abbandono. “La
proprietaria ha levato pure gli infissi alle finestre, però se entrate ci sta
ancora la finestra del suo bagno che si vede dal cortile” mi dice, invitandomi a
entrare, un vicino dell’appartamento accanto a quello di Totò. Un pezzo di
memoria storica privatizzato e sottratto alla collettività. Tra il museo
fantasma di palazzo dello Spagnuolo e la casa saccheggiata. Un patrimonio che
potrebbe portare al riscatto di questo quartiere, e che invece rimane incastrato
da anni tra il disinteresse delle istituzioni e il marchio impresso dalla
camorra. Il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Totò sarebbe una buona
occasione per spostare l’attenzione dal centro città “vetrina” a un quartiere
popolare in cui l’impegno delle istituzioni arriva solo quando c’è da fare una
passerella o raccattare un applauso, un voto. Il Rione Sanità non può ripartire
solo dall’illustre concittadino ma da tutti i cittadini, da tutte le pance, da
tutte le coscienze. Perché è “la somma che fa il totale!”.
È morto Gianni Boncompagni,
il rivoluzionario della tv italiana,
scrive "la Repubblica il 16 aprile 2017. Il conduttore radiofonico, paroliere,
autore televisivo e regista aveva 84 anni. In una carriera di oltre mezzo
secolo, con i suoi programmi ha cambiato la faccia del piccolo schermo.È morto a
Roma Gianni Boncompagni. Aveva 84 anni. Conduttore e autore radiofonico e
televisivo, regista, nel corso di una carriera lunga circa mezzo secolo è stato
l'ideatore di numerosi programmi che hanno segnato la storia della televisione
italiana. Tra i grandi innovatori dello spettacolo insieme a Renzo Arbore, ha
dato vita a show rivoluzionari come Alto gradimento, Bandiera gialla, Pronto,
Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba. Boncompagni era nato ad Arezzo
il 13 maggio del 1932. A dare la notizia della morte sono state le figlie
Claudia, Paola e Barbara: "Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla
famiglia e dagli amici se n'è andato papà, uomo dai molti talenti e padre
indimenticabile". La camera ardente sarà allestita martedì 18 aprile a Roma,
alle 12, nella sede Rai di via Asiago 10. "A tutti i maggiori degli anni 18, a
tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai
giovanissimi". Poi la sigla con la voce di Rocky Roberts. Boncompagni e Renzo
Arbore aprono così Bandiera Gialla, è il 1965, la Rai è quella di Ettore
Bernabei che solo quattro anni prima aveva fatto indossare i collant neri
coprenti alle gemelle Kessler. Bandiera Gialla per primo, nella storia della
radio italiana, porta una ventata beat, apre le porte a Patty Pravo, Lucio
Battisti e alla swingin' London, all'umorismo e alla goliardia. La liturgia
radiofonica va a gambe all'aria, i giovani scoprono di essere giovani e
soprattutto scoprono che c'è spazio anche per loro, per divertirsi. Un trend che
la coppia svilupperà e amplificherà con Alto gradimento (1970), fucina
dell'improvvisazione e del sommo cazzeggio nonsense. "La nostra amicizia è nata
quando avevamo all'incirca 25 anni - ricorda Arbore - un'amicizia non conclusa
ora che eravamo più vicini agli Ottanta che ai Settanta, come diceva sempre lui
con il suo straordinario spirito toscano. Per me è stata un'amicizia
provvidenziale, spero lo sia stato anche per lui. Ci conoscemmo ai tempi di
quando frequentavamo il corso di maestro programmatore, eravamo compagni di
banco. Aveva una visione moderna della vita, un senso d'umorismo
all'avanguardia. Una visione che lo ha portato a rivoluzionare la radio e la tv.
Spero di essergli stato utile con il mio atteggiamento più riflessivo e
romantico, ma altrettanto teso a rivoluzionare la radio e la tv". Nel 1977
Boncompagni debutta in tv con Discoring. Poi arriva Pronto, Raffaella? (1984),
condotto da Raffaella Carrà, di cui è stato pigmalione e con la quale ha avuto
una lunga relazione sentimentale. Tocca poi a Pronto, chi gioca? (1985) condotto
da Enrica Bonaccorti e a tre edizioni di Domenica in. Nel 1991 il passaggio a
Mediaset, con Primadonna condotto da Eva Robin's e soprattutto Non è la Rai, il
programma che ha per protagoniste decine di ragazze adolescenti, alcune
destinate ad continuare la carriera nella tv e nel cinema, come Claudia Gerini,
Alessia Merz, Antonella Elia, Laura Freddi, Lucia Ocone, Romina Mondello,
Sabrina Impacciatore e soprattutto la "primadonna" Ambra Angiolini che diventa
l'idolo dei teenager. E che oggi lo ricorda con questo messaggio: "Se n'è andato
il giorno di Pasqua ....è stato un genio anche nel salutarci. Grazie da una
ragazzina normale che tu hai fatto in modo che crescesse con il coraggio di
essere diversa da tutto, nel bene e nel male. Sei ovunque". Torna alla Rai, nel
1996-97 firma due edizioni di Macao (la prima con Alba Parietti, poi esclusa),
la cui seconda edizione chiude per bassi ascolti. Ugualmente sfortunata
l'esperienza di Crociera. Nel 2002 il rilancio con il Chiambretti c'è di Piero
Chiambretti, tra informazione e varietà, poi tra il 2007 e il 2008 dirige e
conduce Bombay su La7. Padre della tv leggera e imprevedibile, Boncompagni firma
anche delle hit musicali: Ragazzo triste, portata in classifica da Patty Pravo
e Il mondo, successo mondiale lanciato nel 1965 da Jimmy Fontana, nonché tutte
le hit di Raffaella Carrà, da Tuca tuca a Tanti auguri e ancora A far l'amore
comincia tu. "Bandiera gialla", ricordava, " segnò un cambiamento culturale.
Abbiamo lanciato i Beatles contro i Rolling Stones, i complessi li abbiamo
battezzati tutti. Approfittando della scarsa conoscenza dell'inglese mettevamo
anche canzoni con doppi sensi, allora inconcepibili per la radio, tipo Got My
Mojo Working di Jimmy Smith, che voleva dire 'porto il mio cosino a lavorare'".
Ma poi, con un po' di malinconia, aggiungeva: "Oggi non s'inventa più niente.
Gli stadi si riempiono con nomi orrendi, non ci sono mica i Beatles e loro, i
giovani del cavolo, cantano canzoni senza senso. Quelli degli anni Sessanta
erano spaventosi ma l'Italia era molto indietro. Quando dico che per certi
cantanti ci vogliono gli arresti domiciliari così non fanno danni non deve
ridere. Deve darmi retta". Interrogato, pochi anni fa, su quale fosse lo stato
della tv, aveva detto: "Oggi guardo molto Sky, Maurizio Crozza su La7, History
Channel o i film. Sulla Rai solo L'eredità, forse perché mi sento molto bravo
nel dare le risposte. Ma la tv in generale verrà vista sempre meno, anzi nei
prossimi dieci anni scadrà. A guardarla ormai sono solo donne anziane
semianalfabete, quelle che votano Berlusconi. I ragazzi non sanno neanche cosa
sia. La tv di oggi è Internet, con tutto quello che comporta. Sopravviverà per
lo sport, che ci sarà sempre".
Non è la Rai, Gianni
Boncompagni: "Detestavo Bonolis, lo sostituii con Ambra",
scrive Lara Gusatto il 26 marzo 2015 su "Tvzap". Intervistato in occasione della
prima puntata della serie tv 1992 l’autore e regista racconta i retroscena dello
storico programma Mediaset. “Ricordo solo che da Mediaset all’inizio mi
ammollarono Bonolis che aveva già il contratto, ma io lo detestavo allora come
lo detesto oggi. Non gli feci fare niente e dopo un anno misi Ambra al posto
suo”. A parlare e raccontare i retroscena dello storico programma Non è la Rai è
il suo creatore Gianni Boncompagni dalle pagine de “Il fatto quotidiano”.
Complice la serie tv Sky 1992 dove compaiono diverse scene dello show cult di
Mediaset che all’epoca rappresentò un vero caso nella storia della televisione,
il quotidiano ha intervistato il Deus ex machina di Non è la Rai, il suo primo
programma realizzato per il Biscione. E Boncompagni oltre a esprimere il suo
parere nei confronti di Paolo Bonolis, che condusse la seconda edizione dello
show dopo Enrica Bonaccorti, racconta di come nacque il programma: “Berlusconi
voleva farmi fare a tutti i costi Pronto Raffaella? e io gli dicevo che era
impossibile perché era un programma basato sulle telefonate e Mediaset non aveva
ancora la diretta”. E su Ambra e il famoso auricolare rivela “Tutti credevano
che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende,
irriferibili, e lei doveva fare finta di nulla”.
Boncompagni, il grado zero
della tv.
Era interamente e intimamente votato allo spettacolo e alla leggerezza, scrive
su l'"Ansa" Massimo Sebastiani il 16 aprile 201719. Nel giorno in cui il mondo
cristiano celebra la resurrezione di Cristo, Gianni Boncompagni è morto. Se si
fosse trattato di un gesto volontario, potremmo pensare all’ennesimo sberleffo
dissacrante di un uomo che detestava la vecchiaia, il dolore, la sofferenza ed
era interamente e intimamente votato allo spettacolo e alla leggerezza. Aretino
come il più celebre Pietro, e come lui maestro di satira e pasquinate fin dai
tempi della radio - letteralmente decostruita con programmi come Bandiera
Gialla e soprattutto Alto gradimento - Boncompagni, autore e regista più che
conduttore, è stato un protagonista della tv molto lontano sia dal
professionismo impeccabile dei ‘bravi presentatori’ come Mike, Baudo o Corrado,
sia da una concezione ‘biologica’ della televisione come quella di Costanzo, in
cui il corpo del conduttore è tutt’uno con lo schermo e il programma. Al
contrario, secondo un’intuizione confermata anche dal discorso critico dei suoi
detrattori più feroci, è sempre stato il vuoto il vero centro di gravità
permanente della tv di Boncompagni. Un vuoto rivendicato dal teorico
(involontario) della tv di puro intrattenimento, ripetitiva e insensata,
realizzata, come certi B-movie poi diventati di culto, presto e male. Un vuoto
attraverso il quale, a saper vedere, non sarebbe stato difficile scorgere il
‘pieno’ di una rivelazione sociologica sulla società ‘affluente’ (le file delle
mamme a Cinecittà per promuovere la carriera delle figlie, l’esibizionismo, il
gusto per l’azzardo e la ricchezza facile con i celeberrimi fagioli di Raffaella
Carrà). L’unico, ancora fino ad oggi, a poter passare indifferentemente (per lui
e per il broadcaster) da Mediaset alla Rai mantenendo quasi inalterati successo,
caratteristiche e perfino flop. L’unico a poter fare una tv di successo senza
star e senza format. Per chi crede nella società dello spettacolo, cioè per chi
non trova alcuna accezione negativa nell’espressione coniata da Guy Debord per
mettere in guardia dal trionfo dell’immagine sulla realtà nella società
capitalistica, l’intrattenimento è uno solo e non c’è alcuna differenza tra tv
commerciale e servizio pubblico. Non c’è dunque alcuna ragione per soffrire il
passaggio da una all’altra. A chi lo ha etichettato come inventore del nulla
dovrebbero tremare i polsi al pensiero dell’immane e vertiginosa opera creativa
che in questo modo gli viene attribuita. D’altra parte, il successo definitivo
dell’artigiano del vuoto sugli intellettuali più occhiuti e infastiditi viene
certificato da Umberto Eco che, all’apice del proprio successo popolare, si
scomoda per affrontare il ‘caso Ambra’, reginetta con auricolare delle giovani
fanciulle in fiore di ‘Non è la Rai’, che da quel momento chiamerà il semiologo
di Alessandria ‘collega’. E ad ospitarlo nuovamente in Rai, con un’altra
versione di vuoto televisivo, ‘Macao’, sarà, ironia delle cose, proprio un
intellettuale cresciuto alla scuola situazionista di Debord, l’allora direttore
di Raidue Carlo Freccero, oggi membro del cda di viale Mazzini.
Non è la RAI, un
programma-spazzatura forse irripetibile…,
scrive il 24 aprile 2009 Luigi Ruffolo. Uno dei momenti più alzabandierofili e
significativi partoriti dall’incontro tra la televisione padana e quella romana
è stato sicuramente rappresentato da Non è la RAI. Col suo leggendario studio
popolato da cento adolescenti anseriformi tutt’indaffarate a esporsi al pubblico
ludibrio con i soliti pseudoballetti da osteria, o starnazzando giochi
telefonici palesemente truccati e canzoni ultradeficienti. In sostanza, patetici
pretesti per mostrare alle non ancora internettizzate genti un po’ di sana
selvaggina, di quella barely legal, primo pelo vero o presunto. Ci sono state
indubbiamente tante altre trasmissioni all’insegna del tettaculismo più
indefesso in grado di scarcerare nell’aere kitsch, edonismo, tamarraggine e
insignificanza in dosi altrettanto elefantesche. Ma forse nessuna è stata così
sfacciatamente studiata e costruita attorno a un unico, primigenio elemento.
Ovvero l’ego-pisello del suo triste demiurgo. Un omuncolo di mezza età-mezza
calzetta che per fare lo sbruffone decide di esagerare vistosamente, arrivando
là dove nessuno aveva osato. A infrangere con spigliatezza tabù secolari,
mietendo nel silenzio assenso delle italiche abitazioni fiumi di consensi e di
spermatozoi innocenti. Non è la RAI ha probabilmente rappresentato l’espressione
più sublime e genuina di un certo trash televisivo dell’era postcaroselliana, un
picco difficilmente ripetibile nell’epoca del reality a tutti i costi.
Sfruttando forse l’ultimo spiraglio spazio-temporale a disposizione, prima
dell’avvento della pedoparanoia di massa. Prima che il Moige e i suoi astrusi
proclami attecchissero e aderissero quatti quatti alle pareti mentali della
popolazione in modo apparentemente inscrostabile, costringendo eserciti di
regazzini innocenti a passare le loro esistenze murati vivi nelle scuole con la
scusa del mostro impermeabilizzato e dotato di fallo bionico sempre in agguato.
Come dimenticare le inguardabili magliette, l’orripilante merchandising, le
inascoltabili compilation contenenti veri e propri inni generazionali
paragonabili per certi versi a quelli sfornati dal duo Pezzali-Repetto. Come
scordare il moto ipnotico delle acerbe tette rimbalzanti, i teneri visini
indifesi perennemente macerati dalle finte lagrime, la castità quasi irreale
della Trevisan (che infatti, dopo essere stata protagonista del meno svestito
dei calendari dopo quello delle Orsoline, ripudiata da un Piersilvio in cerca di
più fresche prede, non fece carriera). Quella soffusa, quasi sognante atmosfera
ai confini del softporno che avrebbe trovato piena realizzazione solo anni dopo
nel cult movie “Vacanze da spiare” (protagoniste della complessa trama Francesca
Gollini, Ilaria Galassi e Marzia Di Maio). E poi la processione delle
fan-cazziste affamate di provini e proposte indecenti, accompagnate al macello
da genitori ben più esaltati di loro. E gli inquietanti striscioni “Ambra c’è”
delirati da folle di piccoli aspiranti falegnami scatenati all’uscita degli
studi sul Palatino; i cori inneggianti all’aria fritta mista al vuoto cerebrale
impersonificati dall’arrivista teleguidata per antonomasia; e dalle altre,
sciattissime e scimunitissime lolite di quinta categoria servite di contorno.
Morto Gianni Boncompagni.
Un grande, che si vantava di fare «la tv del vuoto pneumatico».
Di sé, con coraggio e cinismo, diceva di essere il rappresentante, il venditore,
il piazzista della tv commerciale. Una condizione tanto rischiosa quanto onesta,
scrive Aldo Grasso il 16 aprile 2017 su "Il Corriere della Sera". Se in radio
sono stati la coppia più innovativa della storia della Rai, in tv Gianni
Boncompagni e Renzo Arbore erano il diavolo e l’acqua santa. Insieme, in via del
Babuino, avevano partecipato al concorso per «maestro programmatore di musica
leggera». È lì che si erano conosciuti, due giovani provinciali (uno veniva da
Foggia, l’altro da Arezzo) con tanta voglia di sfondare: insieme hanno fatto
«Bandiera gialla», «Per voi giovani» e «Alto gradimento»…In tv erano molto
diversi, lo sapevano e ci scherzavano sopra. Boncompagni era pur sempre l’autore
di programmi come «Pronto, Raffaella?» (1983) e «Pronto, chi gioca?» (1985),
«Non è la Rai» (1991), «Casa Castagna» (1995-96), «Macao» (1996)…A onor del
vero, abbiamo faticato non poco prima di convincerci che anche Gianni era un
grande: grande perché diverso dal nostro modo di intendere la tv, perché era
«l’altra faccia» della tv generalista, perché, nonostante le critiche, faceva
una tv coraggiosa, così spavalda da non meritarsi la ricompensa di un elogio, di
una ricerca o il coronamento di un’inquietudine. Di fronte alla retorica della
tv di qualità, della tv per pochi, della tv educativa (la tv perbene esiste solo
in presenza della tv permale), solo Boncompagni ha avuto il coraggio di
rappresentare la realtà in cui viviamo, nella sua banalità, nella sua vacuità.
Di sé, con coraggio e cinismo non comune, diceva di essere il rappresentante, il
venditore, il piazzista della tv commerciale. Una condizione tanto rischiosa
quanto onesta. Diceva di essere un mercenario che non credeva in niente. Nemmeno
nei soldi, dato che non ne aveva più bisogno. La sua frase che più mi ha colpito
è questa: «La tv, tranne casi specialissimi, è tutta spazzatura». Scherzava,
mica tanto, sostenendo di fare la televisione del vuoto pneumatico, la
televisione del nulla. Una tv vacua, ruffiana e opportunista soprattutto nei
confronti dello sponsor: «La tv difficile da fare è quella vuota, non quella
intelligente. Per fare il vuoto ci vuole fantasia, creatività». Per molto tempo
la sua immagine è stata associata a «Non è la Rai», a tutte quelle ragazzine in
mezzo alle quali troneggiava come un satiro danzante della mitologia greca. «Le
belle fanciulle – ripeteva con un sorriso malizioso - sono la mia vita. Accanto
ai giovani, ai giovanissimi mi sento invaso da un senso di benessere, di fresco
benessere che null’altro e nessun’altra cosa mi dà. E allora vivo con loro,
parlo la loro lingua, ho i loro desideri, ne so interpretare gli umori e le
fantasie…». Una trasmissione come «Non è la Rai» non aveva nessun contenuto se
non un’innocua vena estetica del tipo «All’Ambra delle fanciulle in fiore». Una
tendenza un po’ voyeuristica, certo, ma innocente, molto innocente. «Dei miei
programmi – ha detto in un’intervista – salvo soprattutto “Macao”, molto moderno
per l’epoca. E poi “Pronto Raffaella?”, che aprì le trasmissioni del mezzogiorno
e dopo una settimana raggiunse i 14 milioni di spettatori. Un boom oggi
incredibile. Fu merito anche del gioco del barattolo con i fagioli: lo copiai da
una di queste terribili tv private. Capii subito che avrebbe funzionato e
Raffaella si fidò». In Boncompagni spesso prevaleva un disincanto e una mancanza
di fede nella tv che generava un salutare e divertito avvicinamento al mezzo; a
volte invece era un po’ sopraffatto dalla goliardia e allora si lasciava sedurre
dalla velleità narcisistica di comportarsi come un bambino discolo che dice le
parolacce per stupire gli adulti. Riposi in pace.
Gianni Boncompagni.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Giandomenico Boncompagni, meglio conosciuto
come Gianni (Arezzo, 13 maggio 1932 – Roma, 16 aprile 2017), è stato
un conduttore radiofonico, paroliere, autore
televisivo e regista televisivo italiano. Nato in Toscana da padre militare dei
ruoli amministrativi e madre casalinga, a 18 anni si trasferì in Svezia, dove
visse dieci anni svolgendo vari lavori, diplomandosi all'Accademia svedese di
grafica e fotografia, e iniziando l'attività di conduttore radiofonico per la
radio svedese. Durante questa esperienza, ottenne un'intervista dal
sociologo Danilo Dolci che riscosse molto successo. In Svezia si sposa con
un'aristocratica e ha da lei tre figlie, tra cui l'autrice televisiva Barbara.
La moglie lo lascerà di lì a breve, e lui chiederà e otterrà la patria potestà,
crescendo le figlie da ragazzo padre in Italia. Tornato in Italia, vinse nel
1964 il concorso RAI per programmatore di musica leggera, ed iniziò a lavorare
nella radiofonia RAI dove ebbe un grandissimo successo assieme a Renzo Arbore,
nei programmi culto a cavallo tra gli anni sessanta e settanta come Bandiera
Gialla e Alto gradimento, determinanti per la diffusione della musica beat in
Italia. La coppia creò un nuovo modo di fare intrattenimento, basato
sul non-sense, sulla creazione di tormentoni, sull'improvvisazione e
l'imprevedibilità. Nel 1965 debuttò anche come cantante, con il nome d'arte
di Paolo Paolo, incidendo per la RCA Italiana. Sua è anche la voce nella sigla
della Guapa. Sempre nel 1965 scrive insieme a Gianni Meccia il testo per Il
mondo, successo mondiale di Jimmy Fontana, che gli frutta solo nel primo anno
dieci milioni, con cui si compra la prima casa; tra le altre canzoni scritte da
Boncompagni ricordiamo anche Ragazzo triste per Patty Pravo. Fa parte della
prima serie del programma quotidiano del mattino Chiamate Roma 3131 insieme
a Franco Moccagatta e Federica Taddei, 1969. Nel 1977 Boncompagni approda sugli
schermi tv della RAI, dove conduce il programma musicale Discoring, anche questo
di straordinario successo: fu uno dei primi programmi musicali destinato a un
pubblico esclusivamente giovanile, con un proprio gergo, e con le ultime
tendenze del momento sia musicali sia nell'abbigliamento. Da allora le
esperienze televisive si susseguirono continuamente: Superstar e Drim nel 1980 e
poi, per quasi 10 anni in coppia con Giancarlo Magalli come autore, Sotto le
stelle e Che Patatrac nel 1981, Illusione, musica, balletto e
altro nel 1982 e Galassia 2 nel 1983. Oggi è conosciuto soprattutto come autore
e regista di trasmissioni di grande successo popolare: Pronto, Raffaella? che
consacrò la sua ex compagna Raffaella Carrà (1983/1985) che vinse nel 1984 il
titolo di Personaggio televisivo femminile a livello europeo consegnato
dalla European TV Magazines Association e per la quale scrisse spesso i testi di
alcune delle sue più famose canzoni. Proseguì con Pronto, chi gioca? che lanciò
la carriera televisiva di Enrica Bonaccorti (1985/1987). Dal 1987 al 1990 curò
l'ideazione e la realizzazione di Domenica In, dove sdoganò Edwige Fenech, già
famosa come icona sexy grazie ai film scollacciati degli anni '70, e Marisa
Laurito che grazie a lui consolidò la sua fama televisiva. Fu proprio a Domenica
In che nacque l'idea a basso costo del cruciverbone e del pubblico di ragazzine
figuranti, dotate di talento o semplicemente carine e petulanti, che preludevano
quelle che saranno poi protagoniste di Non è la RAI. Risale infatti al 1991 il
passaggio alle reti Fininvest (oggi Mediaset) con Non è la RAI: l'ennesimo
programma di culto con Enrica Bonaccorti, in onda da quell'anno fino al 1995. In
quelle quattro edizioni Boncompagni è stato sempre al centro delle attenzioni
dei media a causa degli scandali legati al programma condotto dalla ancora
minorenne Ambra Angiolini. Lo stesso anno realizzò anche Primadonna con Eva
Robin's, Bulli & pupe (estate 1992) e poi Rock 'n' Roll (1993), praticamente
degli spin-off nati dal successo della trasmissione pomeridiana. Il suo alter
ego in quel periodo era Irene Ghergo, coautrice dei suoi programmi. A Non è la
RAI lanciò appunto il personaggio di Ambra, che all'epoca fu un vero e proprio
fenomeno di costume, ma dalla fucina del programma pomeridiano furono moltissime
le personalità del mondo dello spettacolo che ebbero il loro debutto e che in
seguito si distinsero in vari campi dello spettacolo: da Claudia Gerini a Laura
Freddi, da Sabrina Impacciatore a Nicole Grimaudo, da Antonella Elia a Miriana
Trevisan e Francesca Gollini. Nella stagione 1995/1996 collaborò ad un ultimo
programma in Mediaset con il programma pomeridiano Casa Castagna, presentato
da Alberto Castagna. Tornato in RAI, nel 1996 e 1997 diresse Macao, con Alba
Parietti nella prima edizione e nella seconda con "PI" (personaggio creato
graficamente per sopperire all'abbandono della Parietti), tutto sommato una
variante del modulo di Non è la Rai, con comici, canzoni, ritornelli e un
pubblico di figuranti-protagonisti, dove per la prima volta usò anche personaggi
maschili. Nel 1998 realizza per Rai 2 il programma di prima
serata Crociera condotto da Nancy Brilli; gli ascolti sono molto bassi e la
trasmissione viene soppressa dopo una sola puntata. Ha inoltre fatto parte della
Commissione Artistica del Festival di Sanremo 1998 ed ha collaborato con Piero
Chiambretti per Chiambretti c'è. Nell'estate 2003 ha curato la trasmissione
dell'access prime time di Rai 1 Telefonate al buio, condotta da Mara Venier. Il
9 giugno 2004 firma la regia televisiva per Rai 2 e Rai International del
concerto di Elton John allo Stadio di Reggio Calabria, in Omaggio a Gianni
Versace. Nella stagione 2005/2006 avrebbe dovuto curare Domenica In,
abbandonando tuttavia la trasmissione dopo la prima puntata. Nell'autunno 2008 è
tornato a lavorare come autore per Raffaella Carrà nella nuova edizione
di Carràmba che fortuna. Il 23 ottobre 2006 Gianni Boncompagni è tornato in TV
con un nuovo programma, dal titolo Bombay, trasmesso dall'emittente La7.
Esattamente come nei suoi precedenti programmi, Bombay presentava scenografia
minimale e pubblico composto da ragazze cantanti e vocianti; lo studio era
diviso in due parti: una, molto grande, ospitava la sala regia, affollata di
ragazze, ed un'altra, molto piccola, completamente tappezzata di rose gialle,
rappresentava il vero set televisivo, al cui interno venivano ospitati
personaggi bizzarri che discutevano su temi d'attualità sprofondando in dialoghi
dell'assurdo. Ha partecipato dal 25 maggio 2011 come giurato di Lasciami
cantare!, talent show canoro di Rai 1. Dal 2012 ha curato una rubrica fissa
su Il Fatto Quotidiano dal titolo "Complimenti". Gianni Boncompagni era ateo:
nell'intervista a Claudio Sabelli Fioretti, pubblicata su Io Donna, supplemento
al Corriere della Sera del 4 maggio 2012, ha dichiarato: "Io sono sempre stato
ateo e morirò ateo". Muore il 16 aprile 2017 a Roma all'età di 84 anni e 11
mesi.
Boncompagni fu tra quelli che
misero in circolazione la voce che Mia Martini portasse sfortuna, determinandone
un lungo periodo di lontananza dalla musica. In un'intervista a Epoca del 5
marzo 1989 la stessa Mia Martini ricordava: «La delusione più cocente me la
diede Gianni Boncompagni, un amico per l’appunto. Una volta fui ospite
a Discoring, lui era il presentatore. Appena entrai in studio sentii Boncompagni
che diceva alla troupe: ragazzi, attenti, da adesso può succedere di tutto,
salteranno i microfoni, ci sarà un black out». In un'altra intervista con Enzo
Tortora la Martini definì Boncompagni "detestabile".
VI SCONGIURO. Lo strano
caso di Mia Martini cantante «portasfortuna».
Epoca 05/03/1989. Mia Martini. La cantante che è la sorella di Loredana Berté, è
stata a lungo perseguitata dalla fama di jettatrice una diceria che l’ha
costretta a interrompere la carriera per sei anni. E’ tornata alla ribalta a
Sanremo con la canzone “Almeno tu nell’Universo”. "Jettatrice", Menagramo”,
“portajella”. Il pregiudizio, l'ignoranza e la malafede hanno schiacciato per
anni la vita Domenica Berté, in arte Mia Martini. Nel mondo scaramantico e
superficiale della canzone, quella fama significa isolamento, difficoltà di ogni
genere. Ma adesso, prendendo tutti in contropiede, la cantante è tornata alla
ribalta, partecipando al Festival di Sanremo con un brano, “ALMENO TU
NELL’UNIVERSO”, composto per lei da Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Tutto come
se niente fosse? Non proprio. Anche se Mia Martini, quarantadue anni di Bagnara
Calabra, non lo ammette apertamente, il suo calvario è stato lungo e sofferto.
«Tutto è cominciato nel 1970», racconta. «Allora cominciavo ad avere i miei
primi successi. Fausto Taddeu, un impresario soprannominato “Ciccio Piper”
perché frequentava il famoso locale romano, mi propose una esclusiva a vita. Era
un tipo assolutamente inaffidabile e rifiutai. E dopo qualche giorno, di ritorno
da un concerto in Sicilia, il pulmino su cui viaggiavo con il mio gruppo fu
coinvolto in un incidente. Due ragazzi persero la vita. “Ciccio Piper” ne
approfittò subito per appiccicarmi l’etichetta di “porta jella”» Da allora
l’aneddotica si fece sterminata. Mostra della Canzone, 1973. All’Hotel De Bains
di Venezia, dove alloggia Mia Martini, scoppia un incendio. I colleghi e gli
addetti ai lavori non lo dicono, ma tutti pensano che la colpa sia dell’effetto
Martini. A dieci anni di distanza, un altro incidente stradale. Sull’autostrada
MilanoBrescia, la vettura su cui viaggia la cantante è coinvolta in un
tamponamento a catena. Muore l’impresario Pierluigi Premoli, Mia Martini rimane
ferita. «All’inizio ridevo di questa fama», afferma la cantante. “Poi mi accorsi
che non soltanto i nemici e gli invidiosi, ma anche le persone che amavo si
lasciavano condizionare da questa mia “fama”. La delusione più cocente me la
diede Gianni Boncompagni, un amico per l’appunto. Una volta fui ospite a
DISCORING, lui era il regista. Appena entrai in studio sentii Boncompagni che
diceva alla troupe: ragazzi attenti, da adesso può succedere di tutto,
salteranno i microfoni, ci sarà un black out. Chiesi ai responsabili della mia
casa discografica di allora, di intervenire. Se ne guardarono bene,
giustificandosi col fatto di dovere mantenere buoni rapporti con la Rai». Il
fardello si fece via via sempre più pesante. «Finché ero una cantante di
successo», racconta Mia Martini, «mi sembrava soltanto un gioco fastidioso. Ci
scherzavo su. Se capitavo in un casinò e c’era qualcuno che mi stava antipatico,
mi mettevo dietro a lui per farlo innervosire. Così vince il tuo avversario, gli
dicevo. Poi la cosa divenne sempre più seria». Fatalità? Complotto? «Forse tutte
e due», risponde Mia Martini. «Ho riflettuto a lungo su queste vicende e sono
arrivata alla conclusione che fatalmente ci fu un complotto». Ma non basta.
Anche la vita si accanì con Mia Martini. Il rapporto quasi decennale con il
cantautore Ivano Fossati andò in pezzi. La rescissione del contratto con la
Ricordi le costò 200 milioni. E ancora pettegolezzi, ancora polemiche. Mia
Martini non resse. Sei anni fa il ritiro dalle scena. Pur essendo considerata
una delle migliori interpreti della musica leggera italiana, con alle spalle
successi come “Piccolo uomo” e riconoscimenti internazionali, la sorella di
Loredana Berté si trasferì in campagna, a Calvi dell’Umbria dove vive tutt’oggi.
Cosa l’ha spinta, adesso a rituffarsi nella mischia? «E’ cambiato il mondo della
canzone e sono cambiata anch’io», spiega. «Oggi tutto è più veloce ha il ritmo
di uno spot pubblicitario. Spero che non ci sia più tempo per certe bassezze.
Poi mi ero stancata di cantare per pochi amici. E Sanremo era il palcoscenico
ideale per dire sono tornata». Un nuovo album quasi pronto titolo “Martini Mia”,
canzoni scritte per lei da Dario Baldan Bembo, Enzo Gragnaniello, Maurizio
Fabrizio. Una composta da lei stessa con un titolo più che allusivo “Spegni la
testa”, Una nuova casa discografica, la Fonit Cetra. E ancora la sigla della
serie “Amori”, fra poco in onda su Canale 5. Mia Martini ricomincia sul serio.
Qualche timore? «Ho adoperato questi anni per crescere», commenta serena la
cantante «spero che gli altri abbiano fatto altrettanto». Sopra Mia Martini
oggi. In alto come era nel 1975 a 27 anni. La cantante che è la sorella di
Loredana Berté, è stata a lungo perseguitata dalla fama di jettatrice una
diceria che l’ha costretta a interrompere la carriera per sei anni. E’ tornata
alla ribalta a Sanremo con la canzone “Almeno tu nell’Universo”.
Chiambretti intercetta
l’auricolare di Ambra e sente la voce di Boncompagni,
scrive il 16/04/2017 "La Stampa”. Una delle leggende più celebri della
televisione italiana è senza dubbio quella dell’auricolare che Ambra Angiolini
indossava durante la conduzione del programma di Canale 5 Non è la Rai. Il mito
vuole che l’autore Gianni Boncompagni utilizzasse un collegamento radio per
suggerire ogni parola ad Ambra, così un giovane Piero Chiambretti ha provato a
svelare l’arcano.
“Le dicevo cose tremende”:
Boncompagni e Ambra, gli auricolari che fecero la storia.
Era l’inizio degli anni 90
quando Gianni Boncompagni decise di mettere al timone di Non è la Rai una
giovanissima Ambra Angiolini, preferendola a Paolo Bonolis. Il legame tra i due
scorreva sul filo invisibile di un paio di auricolari, che hanno poi fatto la
storia della tv, scrive il 17 aprile 2017 Eleonora D'Amore su "Fanpage". Nel
2015, in occasione della messa in onda della prima puntata della fiction "1992"
di Stefano Accorsi (nella quale viene più volte citato), il Fatto Quotidiano ha
intervistato Gianni Boncompagni, storico autore e regista di "Non è la Rai". A
poche ore dalla sua morte, è impossibile non fare un tuffo nel passando,
ripercorrendo gli albori di quella tv teen, che in poco tempo divenne il punto
di riferimento di milioni di adolescenti. È vero che c'era un'emulazione
pazzesca. Le ragazze erano tutte vestite uguali, e naturalmente gli sponsor
facevano a gara per darci i vestiti. Però nessuna ragazzina poteva dire una cosa
del genere, manco sapevano cosa volesse dire lo spirito critico. E non avevano
nemmeno sensi di colpa: si divertivano e basta. E fu proprio negli studi del
Palatino in Roma che nacque il mito dell'auricolare. Di fatto, Boncompagni
decise di affidare l'intero programma ad una giovanissima Ambra Angiolini, alla
quale si legò indissolubilmente tramite un paio di auricolari. La leggenda della
prima conduzione a distanza prese vita a poco a poco, sebbene entrambi
smentissero ciclicamente. Poi l'ammissione. Ed è così che il noto regista ne
spiegò la genesi, appena due anni fa: "Non ricordo bene come andò. Ricordo solo
che da Mediaset all'inizio mi ammollarono Bonolis che aveva già il contratto, ma
io lo detestavo allora come lo detesto oggi. Non gli feci fare niente e dopo un
anno misi Ambra al posto suo, con gli auricolari. Tutti credevano che io
suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili, e lei
doveva fare finta di nulla". Già allora, però, fu verificabile quanto le parole
di Boncompagni non fossero solo un elemento di disturbo per la ‘radiocomandata'
Ambra. Piero Chiambretti si prese la briga di intercettarli, dimostrando
quanto il collegamento continuo contaminasse al conduzione stessa.
Barbara Carfagna shock:
"Isabella Ferrari in Rai a 16 anni perchè amante di Boncompagni.
Giovedì 20 Aprile 2017.
Barbara Carfagna, volto del Tg1, al veleno su Facebook contro Isabella
Ferrari e Marco Travaglio, con un lungo e polemico post su Gianni Boncompagni,
che fa il paragone con la vicenda delle famose "cene eleganti" di Berlusconi e
al caso Ruby. Coinvolta anche Claudia Gerini. Così inizia la Carfagna: "Quanto
cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti
amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da
D'Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti
minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella TV di Stato". "Una di
queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari. Qui Insieme
a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi. Però
Boncompagni lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo Pigmalione. Lei
e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave belle e
intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in Teatro con
Travaglio". Per la Carfagna quello di Boncompagni è stato, in chiusura: "un
comportamento oggi condannato, ma negli anni '80 accolto e finanziato pure con i
soldi pubblici".
Barbara Carfagna: Isabella
Ferrari in Rai a 16 anni? Era amante di Boncompagni.
Barbara Carfagna: da Isabella Ferrari al botta-risposta con Marco Travaglio,
scrive "Affari italiani" il 21 aprile 2017. "Quanto cambia chi è la persona che
lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti amavamo e piangiamo la morte
di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da D'Agostino in cui si parlava
di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con
successo, anche nella TV di Stato. C'era anche Freccero che chiosava: "la vita è
come il film 'La Società degli uomini'". E, come spesso accade, aveva ragione.
Una di queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari. Qui
Insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e
Noemi. Però Boncompagni lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo
Pigmalione. Lei e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave
belle e intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in Teatro con
Travaglio. Una parte la fecero fare pure a lui, Bonco sul palco con Ingroia
Ruotolo e Di Pietro. Perché alla fine questo è stato l'esito di un comportamento
oggi condannato, ma negli anni '80 accolto e finanziato pure con i soldi
pubblici. Lui vedeva chiaramente questi paradossi, anzi li sottolineava in
interviste ficcanti e ne rideva".
"Vedo che una valorosa
"collega" della Rai ha approfittato della morte di Bonco per farsi un po' di
pubblicità gratuita, nel solco della lunga tradizione esibizionistica della
mosca cocchiera che salta sul carro funebre credendo di guidarlo, quella per cui
ai matrimoni c'è sempre qualcuno che vuol essere la sposa e ai funerali qualcuno
che vuol essere il morto", scrive Marco Travaglio a Dagospia. "Ricordo alla
"collega" smemorata e male informata che le polemiche (almeno le mie) e il
processo a Berlusconi per le sue frequentazioni con minorenni non hanno mai
riguardato il suo sacrosanto diritto di fare quel che gli pareva nella sua vita
privata: ma (per le polemiche) la sua possibile ricattabilità di uomo di governo
e di Stato e (per i processi) l'accusa - poi caduta - di avere indotto una
minorenne a prostituirsi, cioè a fare sesso a pagamento (reato che il suo stesso
governo aveva deciso di punire con pene più severe di prima)".
"Ho già detto di essere
d'accordo con Travaglio sui differenti ruoli tra Berlusconi e Boncompagni,
infatti la considerazione nel mio post (che, ricordo, non è mia ma dello stesso
Boncompagni a una festa) era sul paradosso, per lui, di trovarsi sul palco con
gli accusatori di Berlusconi per la frequentazione di 16/17enni e per aver dato
inizio alla tv delle veline (il libro Papi di Travaglio -come sottolineato da
Facci- precede il caso Ruby); innovazione sociale a cui non negava di aver
partecipato attivamente e nelle cui varie evoluzioni, anni dopo Non è la Rai,
era finito per un breve periodo indagato insieme a Sabani (poi prosciolto prima
del processo ma mai riabilitato: morì isolato tra mille sofferenze morali,
aiutato solo da Maurizio Costanzo e dal suo avvocato Antonio De Vita). Vicenda
giudiziaria che seguii raccogliendo anche gli sfoghi di Sabani, abbandonato da
tutta la comunità dello spettacolo e privato del consenso del pubblico, che lo
additava anche dopo il proscioglimento. Da parte mia, figuriamoci, nessun
giudizio. Ho avuto una vita piena, libera e amo chi fa altrettanto. Non so
neanche se a 16/17 anni i giovani debbano essere considerati come bambini di 8.
Per quanto riguarda la Volpe e l'Uva, se l'Uva è "Non è la Rai" nel post
precedente quello che cita Travaglio raccontavo di aver passato direttamente le
selezioni senza averle fatte (cantavo nel coro di Nora Orlandi e serviva una
ragazza dai capelli rossi). Non mi presentai e scelsi un esame universitario.
Così come non colsi altre opportunità di ventenne forse più allettanti nel
settore dello spettacolo e della moda. Come dico nel post, precedente la
polemica, non credo per questo di essere migliore né di aver fatto le scelte
giuste. Anzi, rifletto che oggi si potrebbe fare tutto senza il rigore forse
eccessivo di un tempo. Le consiglierei, per correttezza, di aprire ai commenti
la sua bacheca quando accusa qualcuno senza conoscerne la storia. Preciso per il
Corriere che non sono entrata al tg1 nel 2004 (il 2008 fu l'anno dell'assunzione
definitiva voluta da Mimun ma giunta con Riotta dopo 12 anni di precariato) ma
nel 1998 sotto la direzione di Giulio Borrelli e dal 1995 in Rai dopo varie
collaborazioni come cantante nei cori di Nora Orlandi e violinista. Il mio non
era un attacco, tantomeno alla Ferrari che, da donna intelligente, mai ha negato
l'apporto di un uomo così creativo e anticonformista incontrato nella prima
parte della sua vita.
Le (giovani) amanti di
Boncompagni favorite in tv, Claudia Gerini replica: «Nessuno mi ha mai
piazzata».
L’attrice risponde all’attacco della giornalista del Tg1 Barbara Carfagna che
aveva definito lei e Isabella Ferrari «miracolate» per averlo avuto accanto:
«Parole superficiali e parallelismo illogico con Berlusconi, io non ho mai
ricevuto bonifici», scrive Chiara Maffioletti il 21 aprile 2017 su "Il Corriere
della Sera". Claudia Gerini nemmeno sapeva di essere stata chiamata in causa dal
volto del Tg1 Barbara Carfagna. Ma, dopo aver letto quanto scritto dalla
giornalista (che ha definito «miracolate» lei e Isabella Ferrari per aver avuto
accanto il regista e autore tv), assicura: «Non mi sento toccata per niente da
queste parole. In primo luogo perché non sono vere. Mi pare una riflessione
molto superficiale oltre che un parallelismo che non ha senso». Il riferimento è
a Berlusconi, dal momento che la giornalista nel suo post ha scritto: «Quanto
cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti
amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da
D’Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti
minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella Tv di Stato».
Ma l’attrice, con grande
serenità, commenta: «Sono due vicende che non hanno niente a che vedere. E’ vero
che Gianni ha avuto compagne anche molto più giovani, ma non si è mai trattato
di prostituzione o altro. Io non sono stata piazzata da nessuna parte e quello
che ho ottenuto l’ho ottenuto con le mie forze. Non ho mai dovuto fare nessuna
parcella perché stessi zitta, non ho mai ricevuto bonifici. Mi pare davvero un
paragone senza nessun senso».
Botta e risposta al veleno
tra la Lucarelli e la Mosetti: "Hai fatto carriera grazie ai festini".
Una battuta di
Selvaggia Lucarelli ha scatenato una vera e propria "guerra" a colpi di social
con Antonella Mosetti. Le due, dopo essersi accusate a vicenda, hanno chiesto
l'intervento dei loro legali, scrive Anna Rossi, Venerdì 21/04/2017 su "Il
Giornale". Si sa che tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti non è mai stato
tutto rose e fiori, ora un post della giornalista ha riaperto la faida tra le
due. Tutto è iniziato ieri, quando a quattro giorni dalla morte di Gianni
Boncompagni, Selvaggia Lucarelli ha scritto sul suo profilo Facebook una battuta
provocatoria: "Tutti a dire 'Che bravo Boncompagni' (ed era bravo), ma
ricordatevi che la Mosetti è colpa sua". Nel messaggio la blogger alludeva
chiaramente alla partecipazione di Antonella a Non è la Rai. Il messaggio e
l'ironica allusione non è passata inosservata e immediatamente ha scatenato la
reazione della Mosetti. "Na sfigata senza uguali... falla sparlare, solo quello
sa fare", ha risposto indispettita Antonella. Ma le offese non si sono fermate e
tra i commenti, la Mosetti si lascia scappare "invece la nullità (riferita alla
giornalista, ndr) è il prodotto delle raccomandazioni politiche e non solo". Ma
a questa sottile insinuazione Selvaggia Lucarelli non ci sta e parte il botta e
risposta al veleno. "Mortacci oh, tutte 'ste raccomandazioni e solo il giudice a
Ballando? Manco la giuria di qualità a Sanremo al posto di Greta Menchi? E che
cazzo". E ancora la Mosetti risponde: "Mi ha vista a Matrix e ha rosicato.
Aspetto di trovarmela davanti, sto leone da tastiera. I festini la Lucarelli li
ha sempre fatti in privato e lo sanno in molti nel settore spettacolo. Io brutto
cesso, i festini non li ho mai fatti altrimenti a quest'ora sarei stata da altre
parti, tipo le tue. Ci vediamo presto e ai tuoi sostenitori di immondizia, ci
penseranno i miei legali". E poi, riferendosi al suo amico-imprenditore Daniele
Pulcini (coinvolto nello scandalo Mafia Capitale, ndr) e ai presunti festini, la
Mosetti rincara la dose: "Aggiungo cara cessone Lucarelli che te e la tua amica
avete fatto di tutto per mettermi in cattiva luce ma non ci siete riuscite
proprio perché non sono una che fa schifezze a differenza vostra e l'essere
amica da 20 anni di una persona che passa un momento molto difficile, mi fa solo
che onore e non solo a me ma a tutti i suoi storici amici. Sono una delle poche
che non ha nulla da nascondere anzi... Mi dispiace per voi ma è solo amicizia.
Baci cari e di cuore vero. A presto". La discussione tra le due è ancora molto
lunga, tra offese, rimpalli di colpa, insinuazioni e interventi di avvocati le
due donne se ne sono dette di cotte di crude sui social. Il tutto davanti a
centinaia di utenti che tenevano le parti un po' di una e un po' dell'altra.
E POI C’E’ ALDO BISCARDI.
È morto Aldo Biscardi,
l’inventore del “Processo del lunedì”,
scrive l'8 ottobre 2017 "Il Dubbio". Aldo Biscardi avrebbe compiuto 87 anni il
prossimo novembre. Fu caporedattore di Paese Sera prima della Rai, dove nel
1980, lanciò la famosa trasmissione. È morto questa mattina a Roma Aldo
Biscardi, giornalista e conduttore televisivo noto per l’ideazione e la
conduzione del programma televisivo «Il processo del Lunedì». Nato a Larino
(Campobasso), Biscardi avrebbe compiuto 87 anni tra poco più di un mese. Era
ricoverato da qualche settimana al Policlinico Gemelli, assistito dai figli,
Antonella e Maurizio. Da tempo aveva lasciato il video, dove aveva debuttato nel
1979, alla Rai. È del 1980 l’ideazione del programma «Il processo del lunedì»,
primo talk show sul mondo del pallone di cui divenne anche conduttore nel 1983,
moltiplicandone il successo. Nella sua trasmissione record, 33 edizioni
consecutive con lo stesso conduttore, iniziò una battaglia per la moviola in
campo e proprio quest’anno nel campionato italiano è stato introdotto il Var.
Aldo Biscardi, dopo la laurea in giurisprudenza all’Università Federico II di
Napoli con Giovanni Leone, fu collaboratore del Mattino e giornalista di Paese
Sera, dove divenne caporedattore succedendo ad Antonio Ghirelli nella direzione
delle pagine sportive. Da caporedattore, entrò in Rai nel 1979 raggiungendo la
carica di vicedirettore del TG3. Nel 1980 lanciò, su Rai 3, Il Processo del
Lunedì. Famoso una polemica in diretta con Silvio Berlusconi, che intervenne in
collegamento telefonico per protestare contro il modo di presentare notizie che
lo riguardavano, nel 1993 Biscardi lasciò la Rai per Tele+, di cui fu direttore
responsabile fino al 1996. Biscardi propose la stessa formula della sua nota
trasmissione, ma cambiandone il nome, che divenne “Il processo di Biscardi”.
Nel 1996 Biscardi trasferì Il processo su Telemontecarlo, che nel 2001 si
trasformò in LA7. Nel 2005 Biscardi fu direttore della testata giornalistica
sportiva di LA7 e direttore del canale sportivo La7 Sport. Fu coinvolto nello
scandalo di calciopoli in seguito ad alcune intercettazioni di telefonate tra
lui e Luciano Moggi, all’epoca dg della Juventus e principale inquisito nel
processo, nel maggio 2006 lasciò LA7 passando su 7 Gold prima, su T9 e su Sport
1 poi. Biscardi fu sospeso per sei mesi da parte dell’Ordine dei Giornalisti e
lui, in polemica con l’Ordine, decise di non confermare più la sua iscrizione
all’Albo.
Calciopoli. Damascelli
sospeso dall'Odg della Lombardia,
scrive Martedì 10 ottobre 2006 "Affari Italiani". E quattro. Tony Damascelli si
aggiunge a Lamberto Sposini, Franco Melli e Aldo Biscardi nella poco
gratificante lista degli amici di Luciano Moggi. Una cerchia che fin qui ha
riservato più dolori che gioie alle prestigiose firme del giornalismo italiano.
Il dolore in questione significa la sospensione dall'ordine di appartenenza,
Roma per Sposini, Melli e Biscardi, Milano per Damascelli. Proprio nella seduta
di ieri il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha deciso di
sospendere per 4 mesi il professionista Damascelli per il capitolo "Il rapporto
di Moggi con Tony Damascelli" nel "Libro nero del calcio" (989 pagine di
intercettazioni relative allo scandalo calcio) pubblicato da L'Espresso dopo il
rapporto del 19 aprile 2005 della II sezione del Nucleo operativo del Comando
provinciale Carabinieri di Roma. "Le risultanze acquisite - come recita la nota
dell'Ordine - hanno messo in luce un particolare rapporto di amicizia esistente
tra Damascelli e Moggi come affiora dalle conversazioni tra i due intercettate
dai militari dell'Arma Benemerita". La vicenda Damascelli ci permette così di
fare il punto della situazione sugli altri opinionisti di Rai, Mediaset e
emittenze private. Un focus sugli sviluppi del dopo Calciopoli. In Rai - dopo
l'esperienza mondiale di Giuseppe Signori commentatore per "Notti Mondiali" - la
Nazionale (così come in Germania d'altra parte) è seguita da Marco Civoli e
Sandro Mazzola. Niente più Mazzocchi (conduttore della Domenica Sportiva, al suo
posto c’è Jacopo Volpi) passato - sempre su Rai 2 - a un ruolo di inviato nel
reality di Alba Parietti.
È morto Aldo Biscardi,
l’inventore de «Il processo del Lunedì».
Il conduttore televisivo noto per il programma di commento alle partite del
weekend si è spento questa mattina. Avrebbe compiuto 87 anni tra un mese. Domani
i funerali, scrive l'8 ottobre 2017 "Il Corriere della Sera". Un appuntamento
fisso del lunedì per oltre trent’anni. Una trasmissione dove si analizzavano e
commentavano i risultati sportivi del weekend: i momenti più belli, i gol,
falli, i rigori. Lui ne è stato l’ideatore e il conduttore per un decennio. Aldo
Biscardi è morto questa mattina a Roma. Era ricoverato da qualche settimana al
Policlinico Gemelli. Il giornalista, nato a Larino (in provincia di Campobasso)
avrebbe compiuto 87 anni tra poco più di un mese. A darne la notizia è stata la
famiglia. I funerali domani a Roma, nella chiesa di San Pio X. Biscardi si
spegne nell’anno dell’introduzione della Var. Lui, che della moviola in campo è
sempre stato un grande sostenitore. La invocava da oltre trent’anni e ne è
diventato in qualche modo il paladino. Sosteneva fosse uno strumento necessario
per aiutare gli arbitri e all’interno del suo programma c’era sempre uno spazio
riservato alla «moviola», per rivedere gli episodi dubbi e contestati. Aveva
anche fatto una petizione online su change.org, raccogliendo quasi 10mila firme.
La carriera. Nato il 26
novembre 1930, è appassionato di sport — a 360 gradi — sin da giovanissimo.
Sogna di poterne fare la sua professione e si trasferisce a Napoli. La sua lunga
carriera inizia al quotidiano napoletano «Il Mattino». Poi, nel 1965, arriva
nella redazione di «Paese Sera», dove diventa caporedattore. Ma il suo grande
progetto lo realizza più tardi, alla Rai. Vuole creare un programma che sia
contenitore di discussione e commento sulle partite di campionato di Serie A.
Una continuazione degli appuntamenti sportivi del weekend. Ed ecco che, nel 1980
nasce su Rai3 «Il processo del Lunedì», che conduce lo stesso Biscardi dal 1983
al 1993. Le edizioni continuano fino al 2016, anche se con diversi momenti di
pausa. Ma lui intanto passa a Tele+, dove ripropone la trasmissione con un nuovo
nome, «Il processo di Biscardi». Stessa formula, stesso frontman: il giornalista
lo conduce dal 1993 al 2016 (dal 1996 su TMC e poi dal 2003 su La7). «Con la
puntata di ieri sera del Processo ed il clamoroso risultato di ascolto che è
stato raggiunto del 6,50 % di share, tra i più alti mai totalizzati
dall’emittente, si è conclusa trionfalmente la mia stagione televisiva e, con
essa il mio rapporto di collaborazione con La 7». Così Biscardi dice addio al
canale nel 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli in cui il giornalista viene
coinvolto. È accusato di aver ricevuto pressioni dal direttore generale della
Juventus, Luciano Moggi. I commenti alle partite continuano su emittenti più
piccole e locali. L’ultima edizione, quella del 2017, è condotta da Giorgia
Palmas su 7Gold.
I ricordi. «Un giornalista che
ha segnato un’epoca. Ero molto affezionato a lui». Così ricorda Aldo Biscardi il
nipote, l’avvocato Giuseppe Biscardi. «Ero andato a trovarlo recentemente, non
stava molto bene, sono contento di averlo rivisto». Poi, alcuni ricordi del
passato. «Quando poteva, andava a Larino, dove le gente lo fermava per strada
per parlare di calcio. Qualche volta ha seguito le partite del Campobasso, ai
tempi della serie B e spesso lo accompagnavo allo stadio. Sono molto addolorato,
al di là del rapporto di parentela che ci legava». Anche le squadre stanno
ricordando il conduttore che ha inventato il calcio «parlato». Dal Milan, che su
Twitter scrive «Condoglianze sincere alla famiglia. Grande rispetto per un
grande giornalista», alla Fiorentina fino al Palermo, che gli dedica una nota
sul sito ufficiale. La Rai pubblica una nota — «Con Aldo Biscardi scompare oggi
un grande giornalista, ideatore e conduttore di trasmissioni sportive che hanno
cambiato il modo di raccontare il calcio in tv» — e anche il sindaco di Larino,
il Paese dove è nato, esprime le sue condoglianze: «Sono sinceramente colpito e
profondamente toccato per la scomparsa del nostro concittadino — ha detto
Vincenzo Notarangelo — maestro di giornalismo e di vita. Caro Aldo, ricorderemo
sempre la tua competenza, la tua professionalità, ma soprattutto l'amore
incondizionato per Larino. Da oggi questa comunità è un po' più sola».
Morto Aldo Biscardi,
inventore del "Processo del Lunedì". Rivoluzionò i programmi tv sul calcio.
Il popolare giornalista, originario di Larino, avrebbe compiuto 87 anni a
novembre. Aveva cominciato la carriera al Mattino, poi sbarcò alla Rai dove
inventò la sua trasmissione cult, scrive l'8 ottobre 2017 "La Repubblica". E'
morto stamane a Roma Aldo Biscardi, giornalista e conduttore televisivo noto per
l'ideazione e la conduzione del programma televisivo "Il processo del Lunedì".
Ne dà notizia la famiglia all'Ansa. Nato a Larino, in provincia di Campobasso,
Biscardi avrebbe compiuto 87 anni tra poco più di un mese. Il 'Processo del
Lunedì', lanciato nel 1980, è stata una delle trasmissioni calcistiche più
popolari della televisione italiana, una formula inedita che ebbe un successo
straordinario puntando sull'uso processuale della moviola. Biscardi ne assunse
anche la conduzione dal 1983, sostituendo al timone Marino Bartoletti. "Con Aldo
Biscardi scompare oggi un grande giornalista - si legge in una nota dell'ufficio
stampa della Rai -, ideatore e conduttore di trasmissioni sportive che hanno
cambiato il modo di raccontare il calcio in tv. La Rai esprime la propria
vicinanza alla famiglia di Biscardi ricordandone la carriera e i successi,
dall'esordio in video nel 1979, al "Processo del lunedì", al ritorno, in tempi
più recenti, come ospite nei programmi sportivi e di informazione". Nel corso
degli anni il programma cambiò fino a trasformarsi alla fine in una sorta di
show (divenne 'Il processo di Biscardi') dove i commentatori diventavano spesso
personaggi e quasi macchiette. La lenta metamorfosi del programma portò negli
anni a un aumento esponenziale dei toni delle polemiche in studio, che contribuì
alla fine del rapporto con la Rai. Nel 1993, con uno strascico legale di liti
sulla titolarità dei diritti sul programma, Biscardi cambiò rete, passando a
Tele+ e poi a Telemontecarlo e La7 Gold. Aldo Biscardi aveva iniziato la
carriera di giornalista al Mattino e lavorò anche per Radio Montecarlo, ma il
suo nome resta legato alla trasmissione lanciata sulla Rai, che in qualche modo
rivoluzionò il modo di parlare di calcio in televisione. Dopo i vari passaggi di
rete, al declino finale della credibilità del programma contribuirono
le rivelazioni uscite dall'inchiesta su Calciopoli sui condizionamenti subìti
dal conduttore da parte di Luciano Moggi. Nel 2015 Biscardi aveva lasciato la
sua creatura - un programma da record di longevità, 33 anni di fila con lo
stesso conduttore - ai figli, che hanno ereditato il marchio. Biscardi viene a
mancare nell'anno dell'esordio nel campionato di serie A del Var, quella moviola
in campo che lui aveva sempre sostenuto come sistema necessario per aiutare gli
arbitri. I funerali del giornalista si terranno a Roma domani, lunedì, alle ore
15, nella Chiesa di San Pio X nel quartiere Balduina. Nella stessa chiesa sarà
aperta dalle 12 la camera ardente.
È morto Aldo Biscardi,
inventò un modo di far tv: il "biscardismo",
scrive Antonio Dipollina l'8 ottobre 2017 su "La Repubblica". Aveva 86 anni.
Nella sua lunga carriera ha creato una format, Il Processo, che gli sopravvive.
Ha visto la vittoria di una delle sue battaglie, la moviola in campo. Non sono
molti quelli che possono raccontare di aver inventato un genere tv
incancellabile. Aldo Biscardi, morto oggi a Roma a 86 anni, poteva. Il calcio
parlato in tv per come lo conosciamo, in centinaia di trasmissioni, lo ha
inventato lui ed era il 1980. Quando tre anni dopo prese direttamente in mano la
conduzione del Processo impose anche la maschera di se stesso, caotico,
disattento&felice nell'esposizione in lingua italiana, la dizione irripetibile,
la voglia mostruosa di giocare al calcio parlato, appunto. Il Processo, in quel
decennio, fu clamoroso, forse il momento più importante di tutta la settimana
calcistica, partite comprese: aveva gli ospiti top, collaboratori fissi da
leggenda (Gianni Brera, per dire), più personaggi pittoreschi e che davano linfa
assoluta al programma – Costantino Rozzi, per esempio – ma poi passava anche
Giulio Andreotti e decideva in trasmissione i destini futuri di Falcao. Biscardi
intanto lanciava alla grandissima il suo personaggio, in pratica assimilava le
decine di imitazioni di cui era vittima e se ne rafforzava, finché un giorno
girò quello spot del corso di lingua inglese (“Denghiù”) parodiando se stesso e
in parecchi iniziarono a dargli del genio. E da lì a un passo, la trasformazione
in categoria, il biscardismo, la biscardata, a forza di sguub e di “eccipuo”
(copyright Michele Serra, ma chi può escludere che il rosso l’abbia detto
davvero per primo?). Dentro un’aneddotica sterminata, una sorta di Blob vivente
di se stesso, Biscardi è stato per decenni l’autobiografia visibile del calcio
italiano e dei suoi tifosi. Con tecniche televisive da urlo (magari gli scappò e
fu un infortunio, ma cosa c’era di più perfetto del suo “Non parlate tutti
insieme, massimo due o tre per volta”?), tutto rigorosamente live e in qualche
modo sorvegliato passo dopo passo. Dovette cedere solo quella volta, era il
2000, in cui il terzo giorno gli arbitri si arrabbiarono davvero e decisero una
denuncia pesante, lui si presentò col suo avvocato e tentando di farlo alla
chetichella piazzò una memoria difensiva il cui succo era “Guardate che qui in
trasmissione non facciamo sul serio, è uno show tutto inventato per divertire e
quindi non c’è niente di penalmente rilevante”. Fino alla fine, oggettiva, di
tutto che coincise con Calciopoli e alcune intercettazioni in cui dava corda,
sempre alla sua maniera, a Luciano Moggi che dispensava consigli stringenti sul
programma e sulla moviola. Da lì un declino fatto di peregrinazioni per piccole
tv private con l’obiettivo di salvare il marchio Processo di Biscardi (va ancora
in onda, si chiama così e lo curano i suoi figli) e con la battaglia a testa
bassa sulla moviola in campo come centro di gravità permanente. Se n'è andato
con la moviola effettivamente in campo, ha fatto in tempo a definire il Var “Un
inno alla democrazia” e non c’è sintesi migliore di tutto quanto.
Morto Aldo Biscardi, il suo
Processo un rito diventato storia.
Il programma che lo ha reso famoso, un'evoluzione populista della Domenica
Sportiva, portò nelle case degli italiani volti che divennero popolarissimi,
scrive Fabrizio Bocca l'8 ottobre 2017 su "La Repubblica". Se esiste qualcosa,
un posto nell'immaginario che possa essere una via di mezzo tra una santa messa
e una corrida, ebbene quello è il posto del "Processo del Lunedì", il più grande
e strabiliante rito che la tv del calcio abbia mai inventato. In una tv seriosa
in cui tutto deve essere equilibrato e controbilanciato, in cui non si può
pestare i piedi a nessuno, in cui i grandi club - dalla Juve al Milan all'Inter
- vanno solo che ossequiati e anche un po' leccati, Aldo Biscardi porta in tv
una ribellione abbastanza sbracata, la pulsazione della pancia, la passione
tifosa. Un meccanismo comunque efficacissimo e strabiliante, se negli anni 80
vuoi sapere qual è il polso e la febbre del pallone sulla seconda serata di Rai
3 ti devi sintonizzare. Di conseguenza finisce in tv, direi in scena, tutto ciò
che è "anti". E quindi la Roma di Falcao e il Napoli di Maradona come
contrapposizione al potere consolidato. Nord contro Sud, Roma contro Juve,
Napoli contro Milan e così via. Il calcio "anti qualcosa" nasce e prospera
proprio sulla Rai 3 dell'inizio degli anni 80, dove Aldo Biscardi, ex firma di
Paese Sera, che viene quindi dalla sinistra - sulla rete creativa e innovativa
di Angelo Guglielmi - mette in scena questa Corrida. Che praticamente altro non
è che un'evoluzione populista della Domenica Sportiva, la Santa Messa del giorno
prima. Il Processo è provocatorio per principio, organizzato inizialmente con
un'accusa e una difesa, fino a perdere poi nel tempo questa caratteristica
procedurale e penale e accentuare sempre di più quella ring da wrestling. La
cosa stupefacente è che tutto il calcio si sottoponeva ben volentieri a queste
due ore di rissa tv. Era l'esatto opposto di oggi, forse perché Falcao o Platini
sapevano benissimo che la tv avrebbe dato la vera e grande svolta alla loro
carriera. Il primo a capirlo fu ovviamente Silvio Berlusconi le cui comparsate
al Processo erano immancabili, proprio perché questo accresceva la popolarità e
soprattutto il consenso.
Al Processo di Biscardi sono
passate la Juve di Platini, la Roma di Falcao, il Milan di Sacchi, il Napoli di
Maradona. Loro, proprio loro fisicamente, impensabile oggi. Biscardi era un gran
cerimoniere capace di catalizzare il calcio e anche il giornalismo italiano.
Gianni Brera, pur non convintissimo, si fece attrarre da quel circo. Anche
perché la polemica era sempre stato il suo pane, e non voleva lasciarne
l'esclusiva ad altri. E poi Brera era consapevole che comunque quella tv e quel
tipo di trasmissione erano ormai delle "forche caudine" da cui dovevi passare.
Biscardi aveva creato un circo mediatico che ben presto portò nelle case degli
italiani volti che divennero popolarissimi: Mosca, De Cesari, Cazzaniga,
Pacileo, Ameri, Bartoletti. Sono loro che animano la scena teatrale, la
contrapposizione animosa spesso sincera, ma qualche volta anche eccitata e
montata dallo stesso Biscardi. Maurizio Mosca, quello dei pronostici col
pendolino e del berretto e della toga da magistrato, addirittura lo tradì per
inventarsi "L'Appello del Martedì" su Canale 5. In certe occasioni, e non solo
in Rai - il "Processo del Lunedì" evoluto in "Processo di Biscardi" è durato 33
anni - ha decisamente esagerato. E la ricerca dello "sgub" ossessionante, se non
imbarazzante. Luciano Moggi fu una presenza decisamente troppo ingombrante e
negativa ai tempi di Calciopoli. Fino a nuocergli notevolmente. Padre del talk
show sportivo, teorizzatore della polemica a tutti i costi, gran divoratore di
arbitri, il "Gol di Turone" con lui divenne la terza guerra mondiale. La
battaglia della moviola in campo, il famoso Telebim (praticamente una moviola al
200%) l'obbiettivo di una vita professionale. Oggi, solo oggi è diventato
realtà. Al Processo del Lunedì passavano tutti da Falcao a Krol, da Boniek, a
Prohaska ma anche Bearzot, Maradona, Zico. Quando la Roma vinse lo scudetto
Biscardi aveva in studio Viola, Falcao e Andreotti seduti uno accanto all'altro.
Lo juventino e adoratore di Platini Mughini con i suoi occhiali colorati e il
suo "aborro!" diventerà personaggio popolarissimo, il romanista e adoratore di
Falcao Carmelo Bene inveirà al Processo contro tutto e tutti. Ci sono passati
talmente tutti, che Biscardi - unico al mondo - può vantare interventi persino
del Presidente Pertini e di Papa Woytila. Molti si rifiutavano snobisticamente
di partecipare al Processo del Lunedi, ma nessuno si poteva permettere di non
vederlo. Il Tifone, popolarissimo settimanale satirico romano, inventò
addirittura una rubrica su di lui. Se volevi essere qualcuno, se ne calcio
volevi scalare rapidamente posizioni senza essere aristocratico, Biscardi ti
forniva uno straordinario trampolino di lancio. Tutti potevano o dovevano
passare dalle "Forche Caudine". Aldo Biscardi, come Fred Buongusto e Antonio Di
Pietro, veniva da Campobasso, e portò sempre l'inflessione molisana nella sua
parlata. Fino a farne un timbro riconosciuto, unico. "Sgub" e "Denghiu" sono
diventati lessico comune. "Mi raccomando, parlate solo due o tre alla volta!"
mette ormai parecchia tenerezza. E anche un sacco di nostalgia.
Aldo Biscardi, quella
battaglia per Roby Baggio che proprio non vinse,
scrive l'8 ottobre 2017 Simone Vacatello per Crampi Sportivi su "Il Fatto
Quotidiano". Se ne va Biscardi e i più attenti notano il tempismo con cui il
cosmo gli ha prima concesso di assistere alla vittoria della sua battaglia più
nota, quella la cui realizzazione sembrava più improbabile: l’introduzione della
Var, la benedetta moviola in gambo che riuscì ad assurgere allo status di
tormentone principale di una carriera televisiva ultratrentennale. Da un punto
di vista squisitamente extra-sportivo, un’altra vittoria che nel bene e nel male
gli si può – e gli si deve – riconoscere è la spettacolarizzazione del dibattito
sportivo in Tv, al quale ha saputo concedere una dimensione da commedia
dell’arte di cui la cronaca era priva. Con canovacci che cambiavano a seconda
della polemica settimanale, su cui interpreti da commedia plautesca
improvvisavano siparietti che, pur rivelandosi raramente edificanti dal punto di
vista del progresso culturale del Paese, si sono saputi confermare, nel tempo,
come fin troppo onesta fotografia di un’Italia cialtronesca e vivace, che si
prendeva sul serio quando non ce ne sarebbe mai stato motivo, ma sapeva anche
sdrammatizzare all’occorrenza quando le questioni si facevano più spinose dal
punto di vista dialettico. Un ribaltamento continuo della prospettiva di
approfondimento e, di conseguenza, un inno all’intrattenimento fine a sé
stesso col pretesto del pallone. Da Biscardi si incontravano Alberto Bevilacqua,
Sandro Curzi, Tiziano Crudeli e Carlo Taormina, era una specie di conciliabolo
universale del disimpegno, in cui politica, giornalismo e cultura si toglievano
la pancera. I risultati erano imprevedibili: memorabile, ad
esempio, il menage-a-trois tra Maurizio Mosca, il regista Pasquale
Squitieri e Vittorio Sgarbi, in cui l’ultimo gioca il ruolo dello smascheratore
di populismi e il secondo si fa beccare in flagrante tuffo retorico carpiato
sulla distanza tra gli stipendi dei calciatori e quelli dei poliziotti.
Tuttavia, tra una fiera in maschera e l’altra, emergevano spesso tematiche che
al giornalista Biscardi stavano seriamente a cuore, come la moviola in campo
appunto, che 15 anni fa sembrava solo la più donchisciottesca delle boutade, e
la cui attuazione avrebbe paradossalmente nuociuto al suo lavoro, riducendo la
possibilità di polemica domenicale. Una battaglia che Biscardi non vinse, però,
fu quella a favore della convocazione in Nazionale di Roberto Baggio ai mondiali
del 2002. Fare il tifo per Baggio ai Mondiali all’epoca significava davvero
valicare il confine tra romanticismo e utopia: il Divin Codino aveva compiuto 35
anni, giocava nel Brescia ed era appena guarito da un infortunio al legamento
crociato del ginocchio sinistro. Era la Nazionale dei Vieri, degli Inzaghi, dei
Del Piero e dei Totti, e alla guida c’era Giovanni Trapattoni, uno dei tanti
tecnici col pallino del gruppo, del collettivo, con cui lo stesso Baggio,
quintessenza della monade istintiva, refrattaria alle rigidità tattiche,
faticava a dialogare. Nella genuina campagna mediatica c’era tutto il Biscardi
Nazional Popolare, quello in cerca dell’uomo simbolo a cui affidare il ruolo di
frontman e idolo sacro, a dispetto dei tempi che cambiano e che usurano le
strutture fisiche, e con buona pace delle aspirazioni degli altri
protagonisti. Baggio al Mondiale non ci andò, Trapattoni scelse il gruppo, e
quell’Italia (forse sulla carta anche più forte di quella che avrebbe vinto nel
2006) fu eliminata in una controversa gara contro la Corea del Sud padrona di
casa. Col senno di poi si può dire che all’idolo sacro fu risparmiata una
mazzata storica, ma ai posteri rimane l’idea di un romanticismo indefesso, un
lusso che ci si può concedere solo quando nella sconfitta si impara qualcosa su
di sé che prima non si riusciva ad accettare. L’Italia di quegli anni, a
guardarla oggi, faticava ad ammettere quali fossero i propri limiti e
soprattutto dove questi limiti l’avrebbero portata. Ma di questo certo non si
può incolpare Biscardi, anzi. In fondo, tutto si può dire sul respiro della sua
televisione, meno che non fosse pluralista.
Morto Aldo Biscardi: il
Processo e la nascita del «calcio parlato», a metà tra genio e trash. Il suo
programma consacrò le chiacchiere da bar in uno spazio istituzionale, scrive
Aldo Grasso l'8 ottobre 2017 su "Il Corriere della Sera". È morto Aldo Biscardi,
onore ad Aldo Biscardi. Anche se negli anni ho scritto su di lui giudizi poco
lusinghieri, anche se una sua bugia, o cialtronata, mi ha fatto passare momenti
poco simpatici. In fondo è anche stato premiato dalla vita: ha fatto in tempo a
vedere la svolta tecnologica nel calcio e i primi passi della VAR, lui che della
moviola in campo aveva fatto negli ultimi anni un vero e proprio tormentone.
Biscardi è Il processo del lunedì,1980. A poco più di un anno dalla sua nascita,
Raitre (allora Terza rete), ancora in cerca di una precisa caratterizzazione e
di una propria audience, scoprì una dimensione dello sport ancora inesplorata:
il “calcio parlato”. Il Processo consacrò in uno spazio istituzionale le
polemiche e le discussioni da bar, trasferendole in una fittizia aula di
tribunale in cui le diverse parti accusavano, arringavano, difendevano e
finivano immancabilmente per litigare, fomentate e manovrate dall’enfasi verbale
dell’inappellabile giudice Biscardi. Era nato il trash quando questa parola non
era ancora di moda. Protagonisti del dibattito (che in breve tempo abbandonò i
toni forensi per quelli più sanguigni della lite da stadio) erano personaggi
sportivi, del giornalismo, dello spettacolo, della cultura. Da Carmelo Bene ad
Alba Parietti, da giornalisti tromboni a magistrati calciofili. L’importante è
durare. Non come, ma quanto. Il Processo del lunedì di Biscardi è durato più
trent’anni (Raitre, poi Tele+, poi TMC, poi 7 Gold, più varie tv locali) ed è
stato persino celebrato con articoli che, fingendo di prenderne le distanze,
hanno finito per sancirne l’ominosa grandezza. In questo senso, Biscardi è stato
un eroe del nostro tempo. Anni fa, quando eravamo più giovani e ingenui, eravamo
portati a credere che il Processo fosse un modo plebeo e sgangherato di
raccontare il calcio. Forse era così, forse. Ma perché ci sia un sopra e un
sotto, bisogna davvero che ci sia separatezza, che qualcuno si mostri migliore
di un altro. E invece, per molti anni, il Processo è apparso ai più come una
trasmissione guida, il solo modo per raccontare il calcio. Nel 2004 è
intervenuto anche il tribunale di Roma per sancire la natura vera della
trasmissione. Archiviando una querela presentata dall’Associazione Arbitri nei
confronti del Processo, il Pubblico Ministero sostenne che nel programma «la
credibilità obbiettiva delle notizie riportate e fatte oggetto di dibattito è
riconosciuta assai bassa… Ne deriva che la credibilità dell’informazione offerta
e la conseguente attitudine di questa ad essere, in ipotesi, idonea a ledere
l’altrui reputazione sono oltremodo inconsistenti». Traduzione: siccome si
sparano delle fanfaluche è inutile prendersela tanto. Da allora molti programmi
sportivi si sono sentiti autorizzati a seguire questo modello. Biscardi è stato
molto bravo a inscenare psicodrammi nazionali, un formidabile attore. È stato
comunista ma anche grande amico di Berlusconi; è stato moggiano ma anche sodale
degli accusatori di Moggi; è stato uno che stenta a capire le cose ma anche uno
che ha capito tutto. La sua forza? È stato l’ultimo erede dell’istrione
itinerante, il comico dell’arte che recita “a soggetto” lasciando a sé a e a
suoi comprimari ampi spazi d’improvvisazione, pur nella fissità di fondo.
L’importante è durare, come suggeriva Ennio Flaiano: seguendo le mode, tenendosi
al corrente, sempre spaventati di sbagliare, pronti alle fatiche
dell'adulazione, impassibili davanti a ogni rifiuto, feroci nella vittoria,
supplichevoli nella sconfitta. Un vero italiano. E la bugia che mi riguarda? Nel
2003, Biscardi inaugurò una rubrica di critica televisiva: “Il comandante
Stopardi” (alla romana: sto par di…). Per darle forza, mise in giro la voce che
“un grande critico” redigeva per lui opinioni sui programmi sportivi e perché
l’allusione fosse chiara arrivò persino a mostrare un mio libro per un'intera
trasmissione o a citare un pezzo scritto per il “Corriere” spacciandolo come una
cosa scritta apposta per il Processo. Smentii pubblicamente la notizia e la cosa
parve finire lì, in una bolla di sapone. Così non fu. Ai tempi di Calciopoli, in
un’intercettazione, Moggi si rivolse in toni perentori a Biscardi perché mi
togliesse la rubrica e quello rispose subito di sì. Altra smentita, altra
minaccia di querele, ma finire come “intercettato” sui giornali per una notizia
inventata (una fake news) non è cosa piacevole. È sempre stato difficile muovere
delle critiche a Biscardi, con le buone o con le cattive: il suo genio da finto
tonto sapeva sempre volgere a suo favore ogni rimprovero. Ci abbiamo provato con
le citazioni colte, con l’ironia, con il fioretto: niente da fare, ha sempre
vinto lui. Scrivo da soccombente, scrivo come può scrivere uno che ha detto
tutto il male possibile del Processo. Il fatto è che al Processo abbiamo tutti
sacrificato qualcosa, sovente la parte di noi che stimiamo temerariamente la più
nobile, l'intelligenza. Ho perso, il Processo è più vivo che mai (nel frattempo
è trasmigrato in altri programmi) e a me non resta che il privilegio del punto
di vista dello sconfitto. Riconosco però che Biscardi è stato l’inventore del
calcio parlato. Non importa se a spese della grammatica.
Biscardi e il Processo:
cambiò il racconto del calcio fra "sgub" e teatro popolare.
Gli studi che "si sovrapponevano", ma anche gli interventi di Andreotti o
Agnelli, il moviolone e le polemiche. Varriale: "Ha creato un genere, coi
commenti caldi di tifosi alti e bassi", scrivono Clari-Nardi su La Gazzetta
dello sport l'8 ottobre 2017. Ha fatto in tempo a vedere la Var, realizzazione
moderna di quel "Vogliamo la moviola in campo" che è stato vero motto e sorta di
sottotitolo del suo "Processo del lunedì". Aldo Biscardi, ideatore nel 1979 di
una trasmissione che avrebbe condotto in prima persona del 1983, col "Processo"
non creò solo un format fra i più longevi della storia della televisione, ma
cambiò il modo di raccontare lo sport. O meglio il calcio, protagonista quasi
egemone.
IL TEATRO E I "GRANDI" — Al
racconto distaccato, rigoroso, imparziale che lo aveva preceduto sostituì una
sorta di teatro popolare, un circo di leoni di cui lui era il domatore, all'urlo
di "Non sovrapponetevi". Il Processo era programmaticamente "dalla parte della
gente", ma la sua agorà ospitava tutti, miscelando alto e basso in modo
sorprendente: ai congiuntivi martoriati, alle gaffe e alle sparate ("Sono
arrivate 100mila telefonate"), facevano da contraltare gli interventi di
personaggi come Franco Zeffirelli e Gianni Brera. Al Processo andavano tutti,
dai campioni, come Maradona, ai presidenti (alcuni erano presenza fissa, come
Zamparini). Gianni Agnelli fu in studio, nonostante il "boicottaggio" juventino
deciso da Boniperti. E poi c'erano i politici: Andreotti partecipò per la "sua"
Roma e annunciò la conferma di Falcao, D'Alema superò lì il suo tipico distacco,
parecchi anni dopo Berlusconi intervenne per dare la lieta novella: "Kakà
resta". Ma il leader del centrodestra era quasi un habitué, specie quando la
politica si mescolava alla narrazione sportiva.
SGUB E SCANDALI — Negli anni
d'oro una buona fetta d'Italia si fermava per il suo "moviolone" e per gli
scontri fra gli studi contrapposti, quelli di Torino contro quelli di Roma
contro quelli di Milano. Una trasposizione televisiva di scontri da bar, elevati
da interventi di avvocati e politici, che alternavano funzioni istituzionali a
slanci da tifosi, facendo "fioccare polemiche come nespole". A corredo di una
discussione che faceva ascolti, anche per veri o presunti "sgub", c'era la
imitatissima parlata del suo rosso conduttore, quel marchio di fabbrica che
faceva camminare sempre Biscardi sulla sottile linea che divide il personaggio
dalla maschera teatrale, quasi felliniana. In questo, Biscardi era la versione
"sportiva" di un altro grande personaggio della nostra televisione, Mike
Bongiorno. Nel 2006 il suo coinvolgimento (non penale) nel processo Calciopoli,
con telefonate e pressioni di Luciano Moggi alla trasmissione, da un parte
portarono a una sospensione dall'Ordine, dall'altra furono testimonianza del
peso che quel "bar sport" aveva assunto per l'opinione pubblica sportiva.
L'INTUIZIONE — Un'idea geniale
a suo modo, confermata anche dal noto critico televisivo Aldo Grasso a
Gazzetta.it: "Biscardi ha inventato il calcio parlato. Ha avuto l'intuizione,
agli inizi di Rai 3, di spostare dai bar in televisione la disputa sportiva del
lunedì. All'inizio era proprio un processo di nome e di fatto, con difesa,
accusa e lui giudice assoluto ma i toni forensi sono stati sostituiti
rapidamente da quelli da lite da stadio. Quando poi se ne è andato dalla Rai il
programma ha perso forza innovativa, ma lui è stato molto bravo a durare ancora
a lungo, inventando il 'trash' televisivo prima che questa parola prendesse la
ribalta".
IL RICORDO DI VARRIALE — Il
Processo è stato anche palestra per talenti del giornalismo sportivo. Fra questi
anche Enrico Varriale, che ha condotto recentemente i il Processo del lunedì
sulla Rai. Biscardi aveva traslocato da tempo prima a Tele+, poi a
Telemontecarlo: “Sono molto addolorato, - dice Varriale a Gazzetta.it - è stato
lui a permettermi di affacciarmi alla ribalta nazionale. Credeva nei giovani e
li lanciava, mi affidò la Nazionale nel '90. Come giornalista ha creato un
genere, che vanta più tentativi di imitazione della settimana enigmistica.
Quando arrivai a Roma in Rai le trasmissioni sportive erano molto impostate. Lui
ebbe la grande intuizione di portare i commenti caldi di tifosi alti e bassi
abbinandoli a un fiuto per la notizia che ne faceva un giornalista di razza.
Finché è stato in Rai è stato straordinario, i suoi Processi ai Mondiali nel
1990 facevano più share della partita stessa. Poi è diventato più personaggio e
ha dovuto mantenere livello di ascolti: per questo ha dovuto esagerare con scoop
e quant’altro. Ma resta uno che ha creato un genere vero e proprio. Aveva un
grande senso dell’ironia, soprattutto su di sé. Sapeva scherzare sui suoi
difetti".
Biscardi? Grande cronista
Questo sì che è uno «sgub».
In un libro della figlia la storia del conduttore del «Processo» intervistatore
di Pasolini e primo biografo di Papa Wojtyla, scrive Giancristiano Desiderio,
Giovedì 26/07/2012, su "Il Giornale". Il primo «sgub» di Aldo Biscardi risale al
1956 quando, avendo preso da poco il posto di Antonio Ghirelli a Paese Sera, era
a Mosca per seguire il Festival Mondiale della Gioventù insieme con Enrico
Viarisio, Federico Zardi e Vittorio Gassman. Durante il ricevimento al Cremlino,
quando fu il turno della delegazione italiana, il giornalista dai capelli rossi
prese coraggio e, non si sa come, avvicinò Kruscev che gli mise in mano un
panino dicendogli: «Mangia, mangia». La conversazione sfiorò temi politici ed
economici fra champagne e caviale e uscì in prima pagina con un titolo in prima
persona: «Ho brindato con Nikita Kruscev nei giardini del Cremlino». Il futuro
ideatore, regista e conduttore - insomma, mattatore assoluto - del Processo del
Lunedì poi diventato Processo di Biscardi aveva già capito che doveva diventare
egli stesso un personaggio da raccontare. E che personaggio. Lo fa, non senza
qualche comprensibile indulgenza, la figlia Antonella nel libro Tutto (o quasi)
su mio padre ora uscito da Limina (pagg. 133, euro 16) e arricchito dai
contributi in prima persona dall’Aldo del Guinness dal momento che la «creatura»
di Aldo Biscardi ha avuto il riconoscimento dal Guinness World Record come «il
programma tv sportivo più longevo con lo stesso presentatore»: meglio del
David Letterman Show , che nacque proprio nel 1980 ma subì interruzioni, e del
nostrano Maurizio Costanzo show. Tutto ebbe inizio l’1 settembre 1980 alle ore
22,45. Erano presenti nei vari studi di Roma, Milano, Torino e Napoli i
calciatori stranieri più famosi: da Falcao a Krol, da Boniek a Prohaska.
Naturalmente, alla prima «partita» fu subito polemica. Un telespettatore chiese
a Falcao di rispondere a Nantas Salvalaggio che aveva scritto che il brasiliano
era l’unico giocatore straniero che amava marcare a uomo e leggere Oscar Wilde.
L’ottavo re di Roma non si tirò indietro: «Mi sono informato, so che Salvalaggio
ha una bella figlia. Mandi lei a intervistarmi, la preferisco a lui e potrà
riferirgli notizie più sicure sui miei gusti e sulla mia personalità». Era nato
ufficialmente Il Processo del Lunedì. Il giorno dopo Biagio Agnes scrisse a
Biscardi una lettera di congratulazioni, Gianni Arpino vi riconobbe il «bar
dello sport» in tv, Alberto Bevilacqua sul Corriere della Sera ne scrisse come
il primo e coraggioso tentativo di analisi del fenomeno calcistico. Aldo
Biscardi aveva inventato il processo alle partite come anni addietro Sergio
Zavoli inventò il Processo alla tappa del Giro d’Italia. Proprio Zavoli
consigliò Biscardi di sviluppare il gioco soprattutto sul piano della
conversazione salottiera. Cosa che, in verità, tra «movioloni», «sgub», «bombe»
e furiose litigate non sempre è riuscita ma è indubbio che Aldo Biscardi, che
ama raccontare di discendere da Roberto il Guiscardo - «guerriero vichingo che
aveva i capelli rossi come me» ma che non sapeva che avrebbe avuto discendenti
in quel di Larino in Molise - abbia inventato un genere giornalistico popolare
tanto criticato quanto invidiato e copiato. Eppure, quel mattatore di Aldo
Biscardi - amico di Gassman, intervistatore di Pier Paolo Pasolini e di Anita
Ekberg, primo biografo di Papa Wojtyla, autore di testi sulla storia del
giornalismo sportivo e inchieste sulla Rai non andò subito in onda: le prime
due edizioni del Processo furono condotte da Enrico Ameri sì, proprio quello
di «scusa Ameri» - e la terza da Marino Bartoletti, mentre Biscardi faceva tutto
il resto, dal tema agli ospiti alla regia. Ma è quando Aldo va in video, anche
grazie alla vittoria del Mondiale in Spagna nel 1982 e allo scudetto della Roma
nel 1983 che il fenomeno del Processo, con tanto di accusa, difesa e verdetto,
si afferma. In particolare, Biscardi si rivelerà bravo in due cose: dando
notizie e facendo di se stesso, anche con le sue gaffes che lo avvicinano a Mike
Bongiorno, un personaggio e come si usa dire oggi - un brand di successo. Al
fascino popolare della sarabanda di Aldo Biscardi e alla sua naturale simpatia
hanno ceduto in molti: Silvio Berlusconi nel 1990, quindi ben al di qua di Forza
Italia, entrò in studio per un saluto e vi restò per un’ora e mezza, ma ben
prima di lui c’erano stati un capo del governo come Andreotti e un capo dello
Stato come Pertini in uno storico collegamento dalla Val Gardena a 10 gradi
sotto zero, mentre un altro presidente della Repubblica come Carlo Azeglio
Ciampi non esitò a utilizzare la trasmissione di Aldo Biscardi per rilanciare
l’inno di Mameli e invitare gli «azzurri» a non fare scena muta sulle note
dell’inno nazionale.
UN BELL’ABBLAUSO,
scrive l'8/10/2017 Mario Schiani su "Altro Pensiero". Non c’è da stupirsi se,
alla morte di un personaggio famoso – come di chiunque, peraltro – i ricordi
pubblici sono sempre positivi, in qualche caso generosi. Non è una prova di
ipocrisia, quanto di civiltà: poiché sappiamo di essere tutti imperfetti, al
congedo vogliamo che chi lascia porti con sé solo ciò che di buono è riuscito a
trasmettere. Il resto, francamente, è superfluo: ce n’è già troppo nell’aldiquà
per voler contaminare l’aldilà. Detto ciò, non mi sento di contraddire il
principio di cui sopra, se al dolente ricordo di Aldo Biscardi proposto da tanti
(e da me condiviso: se ne va un personaggio del mio passato che ricordo con
divertimento e perfino affetto) oso aggiungere che, magari, non è il caso di
estenderlo fino a nascondere che il famoso “Processo” non era in tutti i suoi
aspetti un esempio di comunicazione di altissimo profilo. Non sempre, almeno.
Non suonerà del tutto irrispettoso, spero, sostenere che mettere due o più
faziosi uno contro l’altro – la struttura essenziale dello show di Biscardi –
non garantiva precisamente obiettività, e magari non sarà superfluo ricordare
che le telefonate in diretta di presidenti e altri potenti del calcio, quelli
che davano ad Aldo “notizie in esclusiva” e favolosi “sgoob”, erano sempre
accompagnate, in studio, da un silenzio ossequioso, quasi servile. Là dove poco
prima scoppiettava il sarcasmo e la critica più inaudita improvvisamente si
sentiva il tonfo delle ginocchia sul pavimento. Insomma, il “Processo del
lunedì” era soprattutto tanto divertimento. Fatti gli appunti di cui sopra,
forse non è il caso di processarlo proprio ora. Ma neanche di assolverlo un
tanto alla lacrima. Come spesso accade, la cosa migliore è mettere i fatti nel
giusto contesto. I meriti – indiscutibili – del “Processo” risaltano evidenti
soprattutto se si pensa a come era trattato, prima della sua istituzione, il
calcio sulla Rai tv. C’era la Domenica Sportiva, ovviamente, e anche Dribbling e
Novantesimo Minuto. E poi “la sintesi del secondo tempo” all’ora di cena (per me
bambino l’accostamento tra minestra e Picchio De Sisti piuttosto che tra robiola
e Pierluigi Cera rimarrà eterno): poco altro. La polemica ben di rado si
inoltrava tra resoconti e commenti che, evidentemente, si volevano pacati al
punto d’essere reticenti. Ma gli italiani non erano un popolo di lettori del
Times e la Rai, come già avevano scoperto Arbore e Boncompagni, non assomigliava
affatto alla Bbc. Biscardi ce lo ricordò nel modo più clamoroso: portando il Bar
Sport in tv, con la sua felliniana varietà di caratteristi. Il calciatore in
pensione non andava più all’osteria del paese a commentare Milan e Juventus:
eccolo, “microfonato” e incravattato, tentare una sapiente analisi tecnica
combattendo nel contempo contro logica e congiuntivi. E il giornalista sportivo,
quello della carta stampata? C’era gloria anche per lui, naturalmente: poteva
far vedere la sua faccia e concedere sfogo al poco o tanto di vanità che
accompagna la carriera di ogni giornalista. Addirittura, gli era concesso di
arrivare alla voluttà del denudamento più audace e di rivelare al mondo i colori
calcistici cari al suo cuore. Perfino l’arbitro, un tempo inavvicinabile come
membro di una casta superiore, finì per partecipare alla mischia, offrendo in
superficie competenza intorno a rigori e fuorigioco, in realtà alimentando a sua
volta recriminazioni, proteste e, naturalmente, sospetti di succosissimi
“gomblotti”. Tutto questo divertiva in passato e diverte ancora oggi (le tv
regionali sono piene di “Processini” che prosperano applicando la formula
biscardiana), ma non ha fatto dell’Italia una nazione di sportivi: ci vorrebbe
un’impossibile rivoluzione per questo. Ha però messo a fuoco una fotografia più
realistica del Paese: quel posto curioso in cui i campanili svettano anche nel
bel mezzo dei campi di calcio.
Giancarlo Dotto (Rabdoman) per
Dagospia - articolo pubblicato il 3 ottobre 2015. Ho voglia di abbracciarlo e
baciarlo ma temo di sgretolarlo. A 84 anni gli umani sono di carta velina. Non
resisto. Lo abbraccio e lo bacio. Non si sgretola. Aldo Biscardi è una roccia,
sotto la zazzera al carotene prodigiosamente uguale a se stessa. Il che conferma
quanto già sapevo. Come tutti gli ergastolani del video, Biscardi ha poco di
umano, e questo me lo rende fisicamente attraente, oltre che intimo. Esposto da
quasi quattro decenni ai raggi catodici, il suo è diventato un corpo spettrale,
un cartonato di lusso, dentro cui resistono frammenti di un inconscio quasi
azzerato dall’abuso di telecamera. Se ancora oggi dici “processo”, da noi
pensano più a Biscardi che a Kafka. Insomma, tecnicamente, una leggenda vivente.
Accudita da Puccia, la governante filippina. Lui non la chiama, la invoca come
un Zeus tonante. “Puccia!”. Sì, qualche smemoratezza, il minimo storico, da
metterci la firma, l’occhio lustro tra la commozione e il tempo, la voce che
manca e qualche volta raschia e rantola, ma sembrano i soffiati dell’attore
ottocentesco quando esagera nel vezzo di simulare il privato essendo pubblico.
Ricordi o allucinazioni? Qualcosa resiste e altro svanisce. “Quella volta che
andai come inviato di “Paese Sera” a Mosca con Pasolini per la festa della
gioventù e lui abbracciò un ragazzo uscito mezzo nudo da casa”. Ogni tanto, gli
parte, credo a sua insaputa, un sorriso di una dolcezza enorme dove ci vedo la
conferma quantica che il tempo è un infinito presente. Il vegliardo che perde
colpi convive con il bambino che bussa la sua innocenza sotto la ruvida,
presunta cazzata della clessidra che si svuota. Il mondo dei sociale
dei global non lo sa e forse non lo conosce neppure, ma Mister Sgub non molla.
La notizia vera è che il suo Processo, l’originale, esiste ancora, vive e sbotta
con noi, più che mai nazionale e inimitabile. Canale 61 del telecomando. “Vieni,
ti faccio vedere una cosa”. Mi mostra alla parete, con un orgoglio che non
potete nemmeno immaginare, la targa del Guinness. Da allora sono passati altri
quattro anni. “36 edizioni consecutive”. Record assoluto di durata televisiva.
Non ti prende più nessuno. Sei
come Fidel Castro. Eterno.
“L’unico che temevo era
l’americano, David Letterman, ma lui ha smesso e, comunque, anche fosse, non
poteva battere il mio record perché è stato un anno fermo”.
Sei come Eduardo. Lui non ha
mai dato l’addio al teatro perché il teatro era la sua pelle.
“No, lui è un’altra cosa e
merita tanto rispetto. Come lo meritava Carmelo Bene. L’ho avuto almeno dodici
volte al Processo”.
Nemmeno tu dai l’addio al
Processo.
“Anche i Pooh hanno dato
l’addio, hai visto?”.
E tu?
“Andare avanti per me è
naturale. Ieri ho finito la trasmissione a mezzanotte e oggi sono qui con te”.
Non senti il peso?
“Onestamente no. Lo sentirei
se non lo facessi. Finché ce la faccio, vado avanti. E una bella abitudine”.
Sei come Moliere e Franco
Scoglio, aspiri alla morte in scena.
“Io mi ritengo un giornalista
che ha lavorato con onestà. Non ho fatto niente di speciale per fare questo
record. Quando lasciai la Rai dopo tredici anni, mi chiamarono subito quelli di
Tele+, e così via”.
Adesso stai in un circuito
nazionale di televisioni private.
“Ieri ho fatto 2 milioni e 800
mila, quasi 3. Non ci credevo. Mi ha fatto piacere sapere che adesso si vede
anche a Larino, il mio paese. Me l’ha detto mio cognato”.
Il tuo è l’unico processo
amato da Berlusconi.
“Ci ho parlato anche ieri. Lo
sento spesso Silvio”.
Che vi siete detti?
“Lui dice che il Milan si
riprende”.
Ci crede in Mihajlovic?
“L’hanno preso, ma non è
l’allenatore suo”.
Come sta l’amico Silvio?
“E’ in gran forma. Ha fatto
pure la dieta…Sta aspettando questa sentenza. Lui è fiducioso e comunque si
ripresenta in politica. Non si vuole arrendere”.
Sta perdendo i pezzi.
“C’è un tale casino in
politica, pure questo Papa…”.
Che c’entra il Papa?
“Secondo me è un Papa
comunista. La mamma della mia valletta, Giorgia, fu sua segretaria in Argentina.
So tutto di lui. Però, pure questo Marino che va a dire: “Mi ha invitato il
Papa”…”.
Hai scritto un libro su
Wojtyla.
“Col quale me so’ fatto la
casa in campagna. Diciotto edizioni. Tutte le prime pagine dei giornali del
mondo. Ho fatto con Gianni Dego anche un disco su Bergoglio distribuito in tutto
il mondo, “Francesco d’Argentina”, testo di Aldo Biscardi”.
Tu e Maurizio Costanzo, gli
irriducibili.
“Lui, però, sta sempre un po’
così così, io invece sto benissimo. Non mi sentirei bene se non lo facessi il
Processo”.
I due figli fedelissimi al
fianco.
“Maurizio è un combattente
come me, anche se a volte mi fa arrabbiare. Ieri sera ha fatto una difesa eroica
di Mancini”.
L’hai trascinato nella tua
storia.
“E’ venuto naturale. Da
bambino tifava Inter. Pensa che una volta intervistai Boninsegna a San Siro, lo
presi in braccio e lui guardava Boninsegna invece che la telecamera”.
Tua figlia?
“Antonella è la vera donna
della mia vita. E’ laureata in architettura, ma sta con me da sempre. Per sua
scelta”.
Un fratello senatore.
“Faceva il preside a
Campobasso. Ha bocciato Fred Bongusto e anche Antonio Di Pietro. Bongusto l’ha
sempre ringraziato. Senza quella bocciatura, non faceva la carriera che ha
fatto”.
L’ha ringraziato anche Di
Pietro?
“Lui vorrebbe sempre stare in
trasmissione da me, anche adesso, ma l’ho fatto venire solo due volte”.
Non è abbastanza telegenico?
“Non mi va. Non è uno sportivo
vero. E poi partirebbe subito la storiella: ecco i due paesani che fanno
comunella… Adesso, poi, ho l’assalto”.
Chi ti assale?
“Tutti gli attori che vogliono
venire da me. Li vedo all’Hilton dove vado spesso. Ce l’ho di fronte casa. Uno
alla volta li farò venire”.
Fedelissimo in studio anche
l’avvocato Taormina.
“Adesso ha comprato anche una
squadra di calcio, l’Arcinazzo, così per divertirsi. Ho anche Vingolo, il più
grande oculista del mondo, ospite fisso. Ha operato tre Nobel, tra cui la
Montalcini”.
Lo paghi Taormina?
“Macché, viene per puro
piacere. Pure Vìngolo. Mi raccomando, l’accento sulla i, sennò s’incazza”.
Capezzone?
“Viene ancora”.
Sta sempre con Berlusconi?
“No, ma cerca di rientrare. Ha
capito che fuori non ha combinato nulla”.
Il tuo telecronista preferito.
“Sarà antiquato, ma dico
Carosio. Gran voce, improvvisava e ti dava il senso della partita. Oggi non te
la fanno vivere la partita. Commentano troppo e non raccontano…te ne dico una
bella su Carosio”.
Dimmela.
“Finale mondiale
Brasile-Svezia del 58. A cinque minuti dalla fine Carosio se l’è fatta sotto”.
Si è urinato addosso?
“No, quale pipì, si cagò
sotto…Chiuse bruscamente la diretta a cinque minuti dalla fine. Un attacco di
diarrea. Se la fece sotto in diretta. Questa non l’ho mai raccontata a nessuno”.
Telecronisti di oggi?
“Sandro Piccinini è il più
bravo”.
Alla Rai c’è il Processo di
Enrico Varriale.
“Varriale è un mio prescelto.
L’ho fatto assumere io in Rai quando lavorava al Canale 21 di Napoli. C’era
Manca presidente socialista. Gli ho detto che il padre di Varriale era
socialista. “Prendiamolo!”, mi fa”.
Il tuo prescelto ti ha
“scippato” il Processo del lunedì.
“M’ha chiesto il permesso, la
testata del programma è mia”.
E tu?
“Gliel’ho dato. “Fallo, tanto
non ti temo”. E infatti non lo vede nessuno il suo Processo”.
Nemmeno tu?
“Sono in onda a quell’ora, ma
non lo vedrei comunque. Mi fa senso. E’ una mia creatura cui hanno dato un nome
posticcio”.
Che cosa vedi della tua Rai?
“Vedo sempre “Novantesimo
minuto” con la Ferrari e Mazzocchi”.
Bravi?
“Si vede che lo fanno come una
professione forzata. Non sono nati con l’istinto per quella cosa. Mazzocchi l’ho
portato io in Rai. Poverina la Ferrari…”.
Perché?
“La incontravo all’Hilton che
non si dava pace. “Non capisco perché mi hanno tolto lo sport. Tutte invidie,
gelosie, cattiverie”. Ora la Monica Maggioni l’ha ripresa. Non ci ho mai parlato
con la Maggioni, ma a orecchio mi piace molto”.
Ne hai avute di vallette.
“Mariella Scirea non solo una
valletta. La sentivo più mia. Vedova di un calciatore famoso e tifosa. Si poteva
permettere di entrare in collisione con il giornalista. La morte del marito ne
ha ingrandita la personalità del triplo”.
Tante belle ragazze. Mai avuto
uno sbandamento?
“Diciamo di no. Tu sei un
giornalista di razza, anche fosse stato credi che te lo direi? Mia moglie sta in
clinica e torna domani. Se mi muore, poi la responsabilità è tua”.
Vabbè, mi liquidi così?
“Ti do uno scoop su Michela
Rocco di Torrepadula, l’ex moglie di Mentana. Bedi Moratti mi telefonò perché le
serviva come attrice in suo film. “Mi basta per una puntata”, mi disse. Non l’ho
mai più rivista”.
Il segreto del Processo?
“Sono passati tutti da me.
Dalla vita politica a quella artistica. Ho avuto Pertini collegato in diretta.
Andreotti e D’Alema. Berlusconi l’ho avuto in diretta sei, sette volte. Ho avuto
in studio anche Gianni Agnelli, contro la volontà di Boniperti”.
Perché non voleva Boniperti?
“Era convinto che fossi contro
la Juve”.
Non ne conosco tanti che hanno
avuto empatia con Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi allo stesso tempo.
“Berlusconi non ha coperto
molto la vita privata, Agnelli sì. Ha avuto una cura certosina in questo”.
Si sono mai invaghiti delle
tue vallette?
“Meglio non dirlo. A
Berlusconi piacevano tante, almeno sei o sette in particolare. Ad Agnelli un
paio. Paola Perissi, in particolare”.
Si sono incontrati?
“La prima volta alla
presentazione della Panda. “È la cosa più bella della tua trasmissione”, mi
disse Agnelli della Perissi. “Te la cedo”, feci io. “Magari” ha detto lui e si
sono abbracciati”.
Altri passaggi scabrosi?
“Quella volta ai mondiali ’90
che m’hanno lanciato Schillaci. Doveva essere il colpo a sorpresa. Lui era
ancora nudo nella stanzetta degli ospiti. Mi buttai su di lui, lo abbracciai e
lo ricacciai dentro”.
Quella volta della pornostar
allo stadio.
“Dissi che gli operatori
ancora la stavano montando. Questo succede perché io vado a braccio...”.
Hai avuto Maradona
opinionista.
“Ospite fisso. Avevo questa
attricetta in trasmissione con me. Una volta ero già in studio che partiva la
diretta e Diego non arrivava. “Dove cazzo sta?”, urlavo. Se ne stava chiuso in
camerino con l’attricetta”.
Si risposa con l’ultima
fidanzata.
“Ti do una bella notizia. L’ho
incontrato la settimana scorsa all’Hilton. “Diego, perché non ti prendi il
figlio?”, gli ho detto. “Ci sto pensando”, mi ha risposto. Quasi sicuramente lo
riconoscerà. Il nipotino è tale e uguale a lui”.
Questa sì è una notiziona.
“Maradona e il figlio
s’incontrano spesso all’Hilton. Diego sta sempre là. Ogni tanto chiede una
massaggiatrice in camera. Lui è il più grande personaggio della storia del
calcio. Non c’è paragone con Messi o Pelè”.
Migliaia di ospiti. Con quali
hai avuto più feeling?
“Con i calciatori non ho mai
legato. Nessun calciatore è venuto in casa mia, al contrario dei dirigenti e
delle vallette”.
La tua idea dei calciatori di
oggi?
“Sono televisivi. Si
controllano. Fai fatica a scoprire cosa pensano. Quelli dei miei tempi non
gliene fregava niente. Vale anche per gli allenatori”.
Il più telegenico?
“Herrera era un talento
naturale. Il suo erede è Mourinho. I calciatori opinionisti sono tutti uguali
nel vestire e nelle pose. Non mi piacciono. Lo puoi scrivere, non me ne frega
niente”.
Ti piace Ilaria D’Amico?
“È la migliore. Buffon mi era
più simpatico prima. Capendo che la carriera va a finire, parla da manager, da
giornalista, assegna i voti”.
Si sta apparecchiando il
futuro.
“Non era così prima. Lasciando
la moglie e mettendosi con questa, una giornalista famosa, è cambiato”.
Il Biscardi romanista.
“Mi piace Rudi Garcia. Lo
conosco. Ma quando la Roma passa all’Hilton, mi allontano, non voglio dare
fastidio. Dino Viola è stato il più grande come presidente. Di Sensi non parlo,
è morto”.
James Pallotta ti piace?
“L’ho conosciuto. Pensavo non
fosse la persona giusta, ma ho cambiato idea. Lui è originario di Rieti, dove io
ho la casa di campagna. Mi piace che è venuto a trovare i suoi parenti sepolti”.
Parliamo di dirigenti.
“Sono cambiati anche loro. Non
che prima fossero più puri. Avevano i loro contatti. Oggi conta solo il
business. È centrale. Il discorso calcistico scema”.
Il tuo amico Luciano Moggi.
“Mi hanno detto che a Torino
abita nel piano sotto quello di Agnelli, il presidente. Se è vero, è una bomba”.
Raccontami il tuo Moggi.
“Era la copia leggermente
sbiadita di Italo Allodi. Italo è stato il primo general manager alla Moggi.
Aveva carta bianca. Poteva fare tutto. Comprare i giocatori, parlare con gli
arbitri, con gli allenatori e i giornalisti. Moggi è una creatura di Allodi”.
Con Luciano vi sentite?
“Ogni tanto. Lui vuole venire
in trasmissione”.
E tu?
“Vediamo. Qualche volta lo
inviterò”.
A proposito di Moggi. La
recente sentenza della Cassazione parla di “associazione per delinquere” e
“frode sportiva”. Dice anche che la sua influenza si estendeva sui media e anche
sul tuo Processo.
“Sentenza equa. Moggi era uno
che non nascondeva di fare tutto per la sua società. Quale giornalista non baro
può negare questo? Quelli come Moggi dettavano le regole del calcio. Come faceva
Allodi ai suoi tempi. Luciano aveva il potere che hanno tutti i manager, solo
che lo ostentava”.
Ti chiamava per condizionare
il tuo Processo?
“Come no, lo faceva con
tutti”.
Hai cominciato nel 1980.
“Ti do un’esclusiva. Il
Processo nacque nell’appartamento di Biagio Agnes, allora direttore generale
della Rai e tifoso Napoli. Lo considero il padre putativo del processo. Ti dico
una bella cosa di Biagio”.
Dimmela.
“Berlusconi voleva rompere il
contratto con Raffaella Carrà. Non funzionava. Io misi insieme Agnes, la Carrà e
Berlusconi per risolvere la cosa. Raffaella tornò in Rai. Mi fece vedere un
anello favoloso. Glielo regalò Berlusconi”.
Gli arbitri.
“Sanno di avere una grande
responsabilità e se la giocano in base al carattere. C’è chi impone i suoi
diktat. Chi lo fa perché è tifoso di una squadra. In Italia non si può dire, ma
è così. Gli arbitri hanno le loro simpatie e a volte possono anche non
resistere”.
Molti sono tifosi della
Juventus?
“Non posso fare il nome, se no
mi querela, anche perché la figlia fa la giornalista. Uno di loro mi disse: “Due
anni che arbitro in serie A e ho dovuto acquistare due cantine per tutti i
regali che mi facevano”. Mica roba da poco. Molte automobili”.
Il più grande arbitro italiano
secondo Biscardi.
“Lo Bello padre. In
trasmissione ho il figlio Rosario collegato da casa sua in Sicilia. Fa la
moviola”.
Il miglior allenatore.
“Helenio Herrera. Carisma
unico”.
Quello italiano?
“Ho una preferenza da sempre
per Fabio Capello. Lo stimavo già da giocatore e poi da allenatore. Come uomo è
eccezionale”.
A 40 anni di Processo ci
arriviamo?
“Ho una salute di ferro grazie
a Dio. Non ho bisogno di medici. Speriamo bene”.
La tv allunga la vita.
“Si dice, ma non è vero. Più
di qualcuno è morto”.
Addio al grande Aldo
Biscardi: ecco le sue 10 citazioni più famose!
Scrive la redazione di Cittaceleste l'8/10/2017. Il suo addio ha lasciato senza
parole il mondo del calcio, di cui è stato protagonista assoluto, senza se e
senza ma. Con il suo “Processo del Lunedì”, Aldo Biscardi, ha colorato di
simpatia e professionalità l’inizio di ogni settimana della nostra vita
calcistica. Per questo, oggi, noi abbiamo deciso di omaggiarlo, regalandovi e
regalandoci le 10 citazioni più famose dell’Aldone Nazionale, destinate – come
lui – a rimanere nella storia:
“Abbiamo uno sgoop
clamoroso!”
“Io sono come Joyce, Pascoli,
Leopardi e Pasolini. È il destino dei grandi poeti essere dileggiati”.
“Le polemiche fioccano come
nespole”.
“La sequenza filmata della
pornostar che si è esibita nuda allo stadio di Piacenza non è pronta. Gli
operatori la stanno ancora montando”.
Non parlate in più di tre o
quattro per volta che sennò non si capisce niente”.
“E’ una notizia importante,
per radio la possono vedere tutti”.
“Non ci accavalliamo!”.
“Dobbiamo andare con il piede
per terra”.
“Denghiù”. (dalla pubblicità
di un corso d’inglese).
“Dove giocherà Baggio l’anno
scorso?”
Morto
Aldo Biscardi: «Parlate non più di due per volta»: antologia delle sue frasi
mitiche.
Frasi iperboliche, strafalcioni, inciampi lessicali: antologia delle frasi che
hanno reso celebri il «Processo del lunedì» e il suo ideatore, scrive Luca
Bottura (ha collaborato Francesco Carabelli) su "Il Corriere della Sera” l'8
ottobre 2017.
Ciao Aldo, che lo Zingarelli
ti sia lieve. Anche se per salutarti aspettiamo la conferma della Var.
Viva il «Che»?
“Per lei il pluralismo è un
opzional” (a Silvio Berlusconi, maggio 1993)
Oriano Fallaci. “Stiamo
dimostrando la fallacità degli arbitri” (aprile 2013)
Ce l’ho muro. “Spalletti non
lo vediamo più, è andato ad allenare in Unione Sovietica” (marzo 2013)
Brigate rozze. “Del Piero è
rinato, cosa incredibile se si pensa che è uno che c’ha mi pare quasi 33 anni!
Corno, che era uno dei suoi EVERSORI, si è dovuto ricredere” (febbraio 2008)
Il secolo breve. “Allora,
questa è l’ultima puntata del 1907 noi ci rivediamo il 14 gennaio del prossimo
anno... ” (dicembre 2007)
Nesti a carico. “L’inevitabile
scheda di Carlo Nesti” (marzo 1988)
Magic bis. “Parlate non più di
due per volta se no non si capisce” (aprile 2011)
Condoni. “La ringrazio a nome
del Presidente della Repubblica e del Consiglio, abusivamente, ovviamente”
(dicembre 2001)
Zazza grande. “Do la parola a
Zaccheroni”. “A Zazzaroni”. “A Zazzaroni, è uguale” (maggio 2001)
Dirittura d’Arrigo. “Dovete
finirla! Qui si va sempre nel cul de sac (pausa) Ahahahaha” (dicembre 2000)
Bum!. “Leggiamo qualche mail
che riassuma il bombardamento che c’è su questo tema” (marzo 2000)
La valletta dell’Eden. “Una
valletta straordinaria… io ne ho avute trentotto, ma una con gli occhi così
profondi, che non si vedono tanto e con le labbra così carnali mai…” (marzo
2009)
Sonno felice. “Ciao a tutti i
miei amici, Rampulla primo piano, che non vedo e sento da parecchio tempo, ora è
al telefono con noi, ciao Felice!” (dicembre 2010, Rampulla si chiama
Michelangelo)
Dite, dite. “Incrocio le dite”
(dicembre 1994)
Sedere è potere. “Il nostro
regista inquadrava sempre i glutei della Cacciatori, che tra l’altro è una gran
bella ragazza” (dicembre 1999)
Santi in paradiso. “Il
moviolone me l’ha chiesto pure il Vaticano per l’attentato al Papa” (giugno
2007)
Iu Uelcom. “Denghiu”
(pubblicità per corso d’inglese De Agostini, gennaio 2001)
CLAUDIO BAGLIONI E LE
SOLITE CANZONETTE.
Quando la sinistra odiava
Baglioni,
scrive Daniele Zaccaria il 6 Febbraio 2018, su "Il Dubbio". Dalla “maglietta
fina” alla direzione artistica del festival di Sanremo. La luminosa carriera di
un autore snobbato dalla critica, adorato dal grande pubblico e oggi celebrato
da (quasi) tutti. Gli altri parlavano di rivoluzioni, di liberazioni, di pace e
di locomotive, di giustizia e di libertà, e lui cantava soave «passerotto non
andare via». Non ci mise molto a finire nella lista nera: vacuo, commerciale,
inconsistente come una “maglietta fina”, quasi certamente di destra, magari
anche fascista, di sicuro sospetto. Comunque impresentabile nelle consorterie
della canzone d’autore: erano gli anni 70 e bastava poco per diventare un nemico
del popolo. Non aveva la gravità di De André, l’istrionismo surreale di Dalla,
l’impegno sociale di Guccini, ma neanche l’ermetismo poetizzante di De Gregori o
la vena erudita di Battiato. Persino Battisti, con quall’aura nera da “cantante
missino” e il suo individualismo anarchico suscitava più rispetto. Lui, Baglioni
Claudio, classe ‘51 romano di Montesacro non aveva nulla di tutto questo, ma più
di tutti gli altri ha incarnato il destino della canzone italiana, unendo almeno
tre generazioni di fan. In oltre quarant’anni di carriera ha venduto milioni di
dischi e non si è mai curato del malanimo degli altri, della critica snob;
l’unica scornata con i suoi avversari è avvenuta fuori tempo massimo, nel 1988
quando viene fischiato al concerto di Torino per Amnesty International, ma fu
una contestazione patetica, animata da reduci spaesati e residuali ( più triste
e fuori tempo di loro solo Antonio Ricci, il creatore di Striscia la notizia che
appena pochi giorni fa ha definito Baglioni «un cantante insopportabile, amato
dai fascisti con il cervello intoppato dal botulino» ). Nel frattempo le sue
melodie si erano già insinuate negli anfratti della memoria collettiva, cantate
a squarciagola da orde di ragazzine sui pulman delle gite scolastiche, sputate
dai juke box sulle spiagge, sussurrate dagli innamorati: E tu come stai, Sabato
pomeriggio, Amore Bello, Lampada Osram e soprattutto Questo piccolo grande
amore, il singolo più venduto nella storia della musica italiana e proclamato
nel 1985 “canzone del secolo” proprio sul palco del festival di Sanremo, lo
stesso che da stasera lo vedrà come gran cerimoniere. Con quella poetica da
storie di vita quotidiana, fatta di avventure estive, di amori non corrisposti
di muretti e motorini, Baglioni continuava a irritare i puristi, talmente
accecati dal pregiudizio da non accorgersi che i testi del cantautore romano
erano molto meno sciatti e banali di quanto loro andavano scrivendo con il
pilota automatico. Il passaggio tra gli anni 70 e 80 intanto è trionfale, con la
tournée Ale-oo porta centinaia di migliaia di giovani ai suoi concerti e con
l’album La vita è adesso straccia tutti i record di vendite. Dopo quel successo,
come spesso accade, arriva la crisi, creativa e personale, che lo porta a un
silenzio di cinque anni. Baglioni è finito, Baglioni è depresso Baglioni non ha
più niente da dire, giubilano i detrattori. E invece Baglioni ripresenta nel
1990 con Oltre, un album bellissimo, il migliore della sua carriera, con un
suono internazionale e la partecipazione di artisti come Paco De Lucia, Didier
Lockwood, Youssou N’Dour, Pino Daniele. Un disco che “suona benissimo” e spiazza
la critica costretta rimangiarsi la bile con cui aveva celebrato il suo
prematuro funerale artistico. Anche l’album successivo Io sono qui è un successo
di pubblico e di critica. I tempi sono maturi perché Baglioni rompa il suo
soffitto di cristallo. Ci pensa Fabio Fazio, che nel 1997 lo porta in Tv a
condurre con lui Anima mia, la trasmissione cult di Rai3 che rivisita in chiave
ironica la musica pop degli anni 70. Quel pubblico “di sinistra” che fino a
qualche anno prima ne parlava facendo la fine bouche lo rivaluta
improvvisamente, quei cenacoli che storcevano il naso ogni volta che le radio
sbrodolavano le sue melodie ora scoprono uno splendido 45enne, colto, spiritoso,
e, incredibile ma vero, anche progressista e sensibile ai diritti sociali e
civili. Per loro dev’essere stato un vero cortocircuito sentirlo gorgheggiare El
pueblo unido jamas sera vencido assieme agli Intillimani. Ma come, Baglioni non
era di destra? No, non lo è mai stato. E chi lo conosce non si è certo stupito
del concerto che nel 2006 ha tenuto a Lampedusa per sostenere l’accoglienza ai
migranti per i quali ha scritto il brano Noi qui, evento che ha replicato più
volte nel corso degli anni. Nell’ultima parte della sua produzione c’è stato un
sobrio ritorno al classico con canzoni meno sperimentali e ritornelli più
orecchiabili, lavori più che dignitosi con alcuni pezzi capaci ancora di
lasciare il segno e arrangiamenti sempre di livello. La consacrazione del
festival è in fondo l’approdo naturale di una carriera fantastica, trascorsa a
pensare, scrivere e suonare canzoni, con lui Sanremo torna nel suo elemento
naturale, la musica. Con buona pace di quello squadrista di Antonio Ricci.
MAI NULLA CAMBIA. 1968:
TRAGICA ILLUSIONE.
16 giugno 1968. La poesia
dell'autore da "Le ceneri di Gramsci.
Il Pci ai giovani. Di Pier
Paolo Pasolini.
I versi sugli scontri di Valle
Giulia che hanno scatenato dure repliche fra gli studenti.
Mi dispiace. La polemica
contro il Pci andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in
ritardo, cari.
Non ha nessuna importanza se
allora non eravate ancora nati: peggio per voi.
Adesso i giornalisti di tutto
il mondo (compresi quelli delle televisioni) vi leccano (come ancora si dice nel
linguaggio goliardico) il culo. Io no, cari.
Avete facce di figli di papà.
Vi odio come odio i vostri
papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio
cattivo.
Siete pavidi, incerti,
disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori,
sicuri e sfacciati: prerogative piccolo-borghesi, cari.
Quando ieri a Valle Giulia
avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli
di poveri.
Vengono da subtopie, contadine
o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai
bene il loro modo di esser stati bambini e ragazzi, le preziose mille lire, il
padre rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un
facchino, o tenera per qualche malattia, come un uccellino;
i tanti fratelli;
la casupola tra gli orti con
la salvia rossa (in terreni altrui, lottizzati);
i bassi sulle cloache;
o gli appartamenti nei
grandi caseggiati popolari, ecc. ecc.
E poi, guardateli come li
vestono: come pagliacci, con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio furerie e
popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono
ridotti (per una quarantina di mille lire al mese): senza più sorriso, senza più
amicizia col mondo, separati, esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha
uguali);
umiliati dalla perdita della
qualità di uomini per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra
età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo
contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la
Magistratura, e vedrete!
I ragazzi poliziotti che voi
per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete
bastonato, appartengono all’altra classe sociale.
A Valle Giulia, ieri, si è
così avuto un frammento di lotta di classe: e voi, cari (benché dalla
parte della ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla
parte del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra! In questi
casi, ai poliziotti si danno i fiori, cari. Stampa e Corriere della Sera, News-
week e Monde vi leccano il culo.
Siete i loro figli, la loro
speranza, il loro futuro: se vi rimproverano non si preparano certo a una lotta
di classe contro di voi!
Se mai, si tratta di una lotta
intestina.
Per chi, intellettuale o
operaio, è fuori da questa vostra lotta, è molto divertente la idea che un
giovane borghese riempia di botte un vecchio borghese, e che un vecchio borghese
mandi in galera un giovane borghese.
Blandamente i tempi di Hitler
ritornano: la borghesia ama punirsi con le sue proprie mani.
Chiedo perdono a quei mille o
duemila giovani miei fratelli che operano a Trento o a Torino, a Pavia o a Pisa,
/a Firenze e un po’ anche a Roma, ma devo dire: il movimento studentesco (?) non
frequenta i vangeli la cui lettura i suoi adulatori di mezza età gli
attribuiscono per sentirsi giovani e crearsi verginità ricattatrici;
una sola cosa gli studenti
realmente conoscono: il moralismo del padre magistrato o professionista, il
teppismo conformista del fratello maggiore (naturalmente avviato per la strada
del padre), l’odio per la cultura che ha la loro madre, di origini contadine
anche se già lontane.
Questo, cari figli, sapete.
E lo applicate attraverso due
inderogabili sentimenti: la coscienza dei vostri diritti (si sa, la
democrazia prende in considerazione solo voi) e l’aspirazione al potere.
Sì, i vostri orribili slogan
vertono sempre sulla presa di potere.
Leggo nelle vostre barbe
ambizioni impotenti, nei vostri pallori snobismi disperati, nei vostri occhi
sfuggenti dissociazioni sessuali, nella troppa salute prepotenza, nella poca
salute disprezzo (solo per quei pochi di voi che vengono dalla borghesia infima,
o da qualche famiglia operaia questi difetti hanno qualche nobiltà: conosci te
stesso e la scuola di Barbiana!)
Riformisti! Reificatori!
Occupate le università ma dite
che la stessa idea venga a dei giovani operai.
E allora: Corriere della Sera
e Stampa, Newsweek e Monde avranno tanta sollecitudine nel cercar di comprendere
i loro problemi?
La polizia si limiterà a
prendere un po’ di botte dentro una fabbrica occupata?
Ma, soprattutto, come potrebbe
concedersi un giovane operaio di occupare una fabbrica senza morire di fame dopo
tre giorni?
e andate a occupare le
università, cari figli, ma date metà dei vostri emolumenti paterni sia pur
scarsi a dei giovani operai perché possano occupare, insieme a voi, le loro
fabbriche. Mi dispiace.
È un suggerimento banale;
e ricattatorio. Ma soprattutto
inutile: perché voi siete borghesi e quindi anticomunisti.
Gli operai, loro, sono rimasti
al 1950 e più indietro.
Un’idea archeologica come
quella della Resistenza (che andava contestata venti anni fa, e peggio per voi
se non eravate ancora nati) alligna ancora nei petti popolari, in periferia.
Sarà che gli operai non
parlano né il francese né l’inglese, e solo qualcuno, poveretto, la sera, in
cellula, si è dato da fare per imparare un po’ di russo.
Smettetela di pensare ai
vostri diritti, smettetela di chiedere il potere.
Un borghese redento deve
rinunciare a tutti i suoi diritti, a bandire dalla sua anima, una volta per
sempre, l’idea del potere.
Se il Gran Lama sa di essere
il Gran Lama vuol dire che non è il Gran Lama (Artaud): quindi, i Maestri - che
sapranno sempre di essere Maestri - non saranno mai Maestri: né Gui né
voi riuscirete mai a fare dei Maestri.
I Maestri si fanno occupando
le Fabbriche non le università: i vostri adulatori (anche Comunisti) non vi
dicono la banale verità: che siete una nuova specie idealista di qualunquisti:
come i vostri padri, come i vostri padri, ancora, cari! Ecco, gli Americani,
vostri odorabili coetanei, coi loro sciocchi fiori, si stanno inventando, loro,
un nuovo linguaggio rivoluzionario!
Se lo inventano giorno per
giorno!
Ma voi non potete farlo perché
in Europa ce n’è già uno: potreste ignorarlo?
Sì, voi volete ignorarlo (con
grande soddisfazione del Times e del Tempo).
Lo ignorate andando, con
moralismo provinciale, “più a sinistra”.
Strano, abbandonando il
linguaggio rivoluzionario del povero, vecchio, togliattiano, ufficiale Partito
Comunista, ne avete adottato una variante ereticale ma sulla base del più basso
idioma referenziale dei sociologi senza ideologia.
Così parlando, chiedete tutto
a parole, mentre, coi fatti, chiedete solo ciò a cui avete diritto (da bravi
figli borghesi): una serie di improrogabili riforme l’applicazione di nuovi
metodi pedagogici e il rinnovamento di un organismo statale.
I Bravi! Santi sentimenti!
Che la buona stella della
borghesia vi assista!
Inebriati dalla vittoria
contro i giovanotti della polizia costretti dalla povertà a essere servi, e
ubriacati dell’interesse dell’opinione pubblica borghese (con cui voi vi
comportate come donne non innamorate, che ignorano e maltrattano lo spasimante
ricco) mettete da parte l’unico strumento davvero pericoloso per combattere
contro i vostri padri: ossia il comunismo.
Spero che l’abbiate capito che
fare del puritanesimo è un modo per impedirsi la noia di un’azione
rivoluzionaria vera.
Ma andate, piuttosto, pazzi,
ad assalire Federazioni!
Andate a invadere Cellule!
andate ad occupare gli
usci del Comitato Centrale: Andate, andate ad accamparvi in Via delle Botteghe
Oscure!
Se volete il potere,
impadronitevi, almeno, del potere di un Partito che è tuttavia
all’opposizione (anche se malconcio, per la presenza di signori in modesto
doppiopetto, bocciofili, amanti della litote, borghesi coetanei dei vostri
schifosi papà) ed ha come obiettivo teorico la distruzione del Potere.
Che esso si decide a
distruggere, intanto, ciò che un borghese ha in sé, dubito molto, anche col
vostro apporto, se, come dicevo, buona razza non mente...
Ad ogni modo: il Pci ai
giovani, ostia!
Ma, ahi, cosa vi sto
suggerendo? Cosa vi sto consigliando? A cosa vi sto sospingendo?
Mi pento, mi pento!
Ho perso la strada che porta
al minor male, che Dio mi maledica. Non ascoltatemi.
Ahi, ahi, ahi, ricattato
ricattatore, davo fiato alle trombe del buon senso.
Ma, mi son fermato in
tempo, salvando insieme, il dualismo fanatico e l’ambiguità...
Ma son giunto sull’orlo della
vergogna.
Oh Dio! che debba prendere in
considerazione l’eventualità di fare al vostro fianco la Guerra
Civile accantonando la mia vecchia idea di Rivoluzione?
Paolo Pietrangeli ricorda
la battaglia di 50 anni fa: «Valle Giulia, i sogni, le mattonate».
Cantautore-regista,
il 1° marzo del ‘68 era lì a fare a botte. I suoi ricordi, il suo bilancio
amaro. Giuliano Ferrara era nel Pci e nel Movimento. Scalzone in Svezia per
rimorchiare, scrive Fabrizio Paladini l'1 marzo 2018 su "Il Corriere della
Sera".
«Il primo marzo/ sì me lo
rammento/ saremo stati/ mille e cinquecento».
Chi se lo rammenta è Paolo
Pietrangeli, 73 anni, storico regista televisivo del Maurizio Costanzo Show, di
Amici, di C’è posta per te. Oggi è anche candidato alle elezioni con Potere al
popolo. Suo papà Antonio fu acclamato sceneggiatore e regista di film come Lo
scapolo, Io la conoscevo bene. Ma soprattutto Paolo Pietrangeli è conosciuto per
le sue canzoni di lotta e di protesta. Contessa, Il vestito di Rossini, Valle
Giulia sono pezzi che tra il 1968 e il 1977 hanno cantato tutti quelli che
volevano cambiare il mondo. Valle Giulia prende spunto proprio dalla battaglia
tra studenti e polizia che esattamente 50 anni fa si scatenò a Villa Borghese,
sotto la facoltà di Architettura. «Noi studenti dei licei ci radunammo a piazza
di Spagna. L’idea era quella di raggiungere gli universitari per poi occupare
Architettura. Feci tutto quel pezzo del corteo con Luciana, che allora era la
moglie di Bruno Trentin. Arrivati a Valle Giulia lei sentenziò: Ma cosa vuoi che
succeda, sarà tutto tranquillo, ci sono i socialisti al governo. Appena
pronunciata quella frase, iniziarono i disordini. C’erano poliziotti e
carabinieri dappertutto. Ma all’inizio le cariche erano abbastanza blande».
E poi?
«È accaduto che per la prima
volta gli studenti, i figli di papà, non hanno avuto paura e non sono fuggiti.
Anzi, hanno reagito».
Eravate armati?
«Sassi presi nelle aiuole e
rami spezzati per fare bastoni. Questa fu una cosa nuova che alla Polizia non
piacque per nulla. Ci diedero insomma un sacco di botte e moltissimi dei fermati
vennero portati nella caserma di via Guido Reni e in Questura dove arrivò la
seconda razione».
Lei venne picchiato?
«Io no ma, adesso lo posso
confessare tanto dopo 50 anni sarà prescritto: tirai un mattone dall’alto e
colpii in testa un agente, uno dei pochi che non aveva l’elmetto. Si sparse la
voce che alcuni poliziotti erano gravemente feriti e io mi sentivo un po’ in
colpa, mi chiedevo: vuoi vedere che ho fatto male a qualcuno? Pensa un po’ che
rivoluzionario irriducibile ero».
E dopo la mattonata che ha
fatto?
«Ero lì con la mia fidanzata
Grazia, che poi sarebbe diventata la mia prima moglie e madre di mio figlio, che
si slogò la caviglia alla prima carica. Non poteva camminare e quindi la misi
sulle spalle come un sacco di patate e giù a scappare verso Villa Borghese.
Arrivai a casa mezzo morto. Aprii l’acqua bollente e mi feci un bagno caldo».
Al calduccio come i figli di
papà che Pier Paolo Pasolini attaccò difendendo i poliziotti figli del popolo?
«Quella poesia mi fece
incazzare. Conoscevo Pasolini perché veniva spesso a casa nostra, al quartiere
Trieste, per parlare con mio padre di progetti comuni. Ma a differenza di tanti
attori e registi che mi salutavano per educazione, affetto o convenienza, lui
niente, non diceva nemmeno Ciao. Io aprivo la porta e lui: Dov’è tuo padre?
Allora andai da mia madre e le dissi: Mamma, ma chi è quel frocio? Lei mi
assestò un salutare sganassone e io imparai la lezione».
Lei già cantava?
«La prima chitarra me la
regalò mio padre, alla fine degli anni Cinquanta. Fu Dario Fo che veniva sempre
ospite da noi a dire a papà: Paolo ha una bella voce, compragli una chitarra.
Iniziai con le filastrocche. In verità non ho mai scritto canzoni, ma solo
raccontato fatti con un po’ di musica».
I leader del movimento
studentesco li conosceva?
«Con Giuliano Ferrara stavamo
tutti e due nel Pci e, un po’ di nascosto, nel Movimento che il partito non
vedeva di buon occhio. Oreste Scalzone era da poco tornato dalla Svezia dove -
secondo me - era andato per rimorchiare. Franco Piperno era più grande e faceva
il capetto. Poi c’erano gli Uccelli e io li detestavo. Una volta andarono a casa
dello sceneggiatore Franco Solinas e gli riempirono la casa di escrementi perché
lui era ricco e comunista».
Fantasia al potere?
«Durante le occupazioni si
organizzavano corsi alternativi. Io proponevo cose tipo Studiare meglio il
latino o I nuovi percorsi di filologia romanza e non partecipava nessuno, mentre
c’erano quelli sul sesso libero che erano sempre pieni. Del resto, questo è il
mio destino: ogni volta che mi piace qualcosa state sicuri che sarà un clamoroso
insuccesso».
Di questo ‘68 che è rimasto?
«Eravamo sicuri, che fosse
l’alba, che poi sarebbe tutto cambiato. Invece non era l’alba ma il tramonto. Lo
spiraglio che avevamo visto non si stava aprendo ma chiudendo. L’industria
culturale, per prima, sigillò tutto. Il peso fu opprimente, poi arrivò la
violenza degli anni 70».
Il sogno ha lasciato qualche
segno?
«Qualche segno e molte
sconfitte. Non si è realizzato nessun sogno né personalmente né collettivamente.
Ma ha lasciato molte amicizie e un modo di sentire comune. Ma se ancora oggi, 50
anni dopo, stiamo a discutere di colore della pelle, mi viene da piangere».
1968, Valle Giulia non è
che il debutto, scrive Paolo Delgado l'1 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Ogni
movimento ha bisogno di una sua mitologia. Nel movimento che spazzò l’Italia per
dieci anni il capitolo eroico di quella ricostruzione non priva di verità ma
neppure di agiografia fu il primo marzo 1968: “la battaglia di valle Giulia”.
Ogni movimento ha bisogno di una sua mitologia, deve attrezzare il suo proprio
calendario, celebrare ricorrenze, allestire liturgie. Nel movimento che spazzò
l’Italia per dieci anni e passa mezzo secolo fa il capitolo eroico di quella
ricostruzione non priva di verità ma neppure di agiografia fu il primo marzo
1968, il battesimo del fuoco fu “la battaglia di valle Giulia”. La chiamarono
così i giornali del Pci, L’Unità, uscito in edizione straordinaria quando per le
strade di Roma ancora risuonavano le sirene della polizia e le celle di San
Vitale erano ancora piene di studenti fermato negli scontro della mattinata, di
fronte alla facoltà di Architettura, e Paese Sera, che usciva di norma tre volte
al giorno e non ebbe quindi bisogno di forzare le rotative con un’edizione
speciale. Anni dopo, ripercorrendo i fatti, Oreste Scalzone, all’epoca uno dei
principali leader del movimento studentesco nella capitale, avrebbe adoperati
toni dissacranti, segnalando che in fondo la battaglia era stata poca cosa,
soprattutto se paragonata a quel che sarebbe poi esploso nelle strade di tutta
Italia: «Un’ora scarsa di lanci di sassi e qualche carica contro la polizia.
Cosa anche questa modesta ma che ebbe grande impatto». La narrazione epica in
voga negli anni ‘ 70, costruita sulle note della celebre canzone dedicata alla
“battaglia” da Paolo Pietrangeli era probabilmente esagerata. La minimizzazione
di Scalzone lo è altrettanto. In quella assolata mattina di tardo inverno romano
si produsse davvero una lacerazione, quegli scontri durati un paio d’ore nei
prati intorno a Valle Giulia segnarono davvero uno scarto, un passaggio d fase,
un salto di qualità. In un certo senso non è esagerato dire che il ‘ 68 cominciò
quel giorno. Nell’università di Roma, la più grande d’Italia, la mobilitazione
studentesca iniziata nel novembre 1967 a Torino, nella sede delle facoltà
umanistiche di Palazzo Campana, e poi dilagata quasi ovunque era arrivata tardi.
Mentre le cronache degli sgombri delle facoltà occupate da parte della polizia e
delle nuove occupazioni diventavano quotidiane alla Sapienza e nelle facoltà
aldi fuori della città universitaria, tra le quali Architettura, non si muoveva
una foglia. L’onda d’urto arrivò solo il 2 febbraio ‘ 68, con l’occupazione di
Lettere e poi, una via l’altra di tutte le altre facoltà. L’occupazione si
prolungò per un mese esatto, poi il rettore D’Avack si decise a chiedere
l’intervento della polizia, o meglio a consentirlo perché una circolare
ministeriale diramata dopo le prime occupazioni aveva chiarito che a decidere
sarebbe stata la forza pubblica salvo esplicito parere contrario dei rettori.
Anno bisestile: l’università fu sgombrata il 29 febbraio. Una manifestazione di
protesta organizzata dagli ormai ex occupanti fu caricata nel pomeriggio. Gli
studenti si riunirono in serata nella sede della Federazione del Pci, in via dei
Frentani, e convocarono una nuova manifestazione per la mattina seguente, con
partenza da piazza di Spagna. Non era la prima volta che i manganelli della
celere si abbattevano sulla testa degli studenti. Ai tempi erano corti e tozzi e
gli agenti non disponevano dell’armamentario che gli sarebbe stato assegnato in
dotazione l’anno seguente, insieme ai nuovi manganelli lunghi: gli scudi in
plexiglas, le visiere, l’incentivo ad adoperare senza parsimonia i candelotti
lacrimogeni. Pur peggio armati, si erano dati da fare più volte. A Palazzo
Campana lo sgombro seguito da immediata rioccupazione e nuova irruzione degli
agenti, in una catena infinita, era diventato quasi un rituale. La carica sui
cortei di protesta degli sloggiati era altrettanto puntuale, prevedibile,
prevista. A Valle Giulia successe però l’imprevedibile. Gli studenti reagirono,
contrattaccarono, scoprirono che strade e parati erano pieni di “armi improprie”
e le usarono. Aveva cominciato Massimiliano Fuksas, un passato da giovane
neofascista spostatosi a sinistra alle spalle, un futuro da archistar di fronte,
ancora avvolto nelle Nuvole. Ben piazzato, provò a forzare il blocco della
polizia sulla porta della facoltà da solo poco prima che il corteo in arrivo da
piazza di Spagna, qualche migliaio di studenti tra cui molti medi, raggiungesse
la scalinata della facoltà. A riguardare oggi le istantanee di quella non
oceanica manifestazione sembra di assistere a un inedito reality: il corteo dei
famosi. Immortalato Giuliano Ferrara, che si prese la sua dose di botte, poi
sparsi qua e là per il grande piazzale di Valle Giulia, Enrica Bonaccorti, Paolo
Liguori, o come si chiamava ai tempi “Straccio”, con i capelli lunghissimi, un
paolo Mieli appena meno compassato, Ernesto Galli della Loggia, sì sì proprio il
futuro editorialista del Corrierone, un Antonello Venditti in anticipo sui primi
accordi, Renato Nicolini, già leader di un’associazione goliardica vicina al
Pci, Paolo Flores d’Arcais. Già innervositi gli agenti ordinarono la carica
quasi subito, al primo lancio di sassi e uova. Per quanto negato in seguito per
anni, a reggere il primo l’urto furono i fascisti. Caravella, l’associazione
studentesca di estrema destra a stretta egemonia Avanguardia nazionale c’era
tutta: Stefano Delle Chiaie, Guido Paglia, Adriano Tilgher, Mario Merlino.
Quanto a scontri frontali erano più addestrati dei rossi: tennero la linea. La
loro presenza fu cancellata peggio che nelle fotografie sovietiche dei funerali
di Lenin per decenni. Riconoscere che a valle Giulia i fascisti non solo
c’erano, ma erano pure in prima fila nella battaglia sarebbe stato poco
conciliabile con la liturgia del caso. Ma anche il Movimento, la sera prima,
aveva deciso di non limitarsi alla fuga e alla resistenza passiva. Arretrati in
un primo momento rispetto ai fascisti, si lanciarono poi in una carica contro i
caricanti che lasciò davvero tutti sbigottiti. Quando mai si erano visti gli
studenti, mica portuali come quelli del ‘ 60 a Genova, oppure operaiacci come
quelli di piazza Statuto a Torino nel ‘ 62, caricare gli agenti, usare rami e
bastoni contro i gipponi, tenere botta di fronte alle cariche? Ancora quella
mattina gli striscioni del corteo in marcia verso valle Giulia esaltavano il
“Potere studentesco”. Il Movimento bersagliava l’università, le baronie,
l’autoritarismo accademico e poi, di conseguenza, la struttura complessiva del
sistema. Da Valle Giulia in poi dall’altra parte della barricata ci fu
direttamente lo Stato.
Il 68 ci ha rubato il
futuro,
scrive il 27 febbraio 2018 Francesco Giubilei su "Il Giornale". Il 1 marzo
ricorrono i cinquant’anni dagli scontri di Valle Giulia a Roma, un evento che ha
segnato simbolicamente l’avvento del Sessantotto nel nostro paese. Le proteste
sessantottine demoliscono i valori su cui si è fondata l’Italia fino a quel
momento compiendo un attacco ai due elementi cardine della società: la famiglia
e la scuola. Come scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale” di domenica: “la
rivolta del ’68 ebbe un Nemico Assoluto, il Padre […] ogni autorità perse
autorevolezza e credibilità”. La delegittimazione del ruolo del padre si
accompagna a un attacco tout court alla famiglia attraverso temi considerati un
tabù (l’aborto, il divorzio, la liberazione sessuale). Le conseguenze più
funeste del Sessantotto avvengono nel mondo della scuola e dell’università dove
il concetto del sei politico diventa una prassi che si è tramandata fino ai
nostri giorni con l’abbassamento complessivo sia della preparazione del corpo
docenti che degli studenti. Il Sessantotto si fonda infatti sul grande equivoco
dell’egualitarismo: tutti dobbiamo avere le stesse opportunità di partenza ma se
una persona è più meritevole di un’altra va premiata. Più in generale è stata
tutta la società ad essere sovvertita: il Sessantotto ci ha fatto scoprire i
diritti ma dimenticare i doveri. Le regole vengono concepite come un qualcosa di
cui si può fare a meno, una mentalità sintetizzata dallo slogan “vietato
vietare”. Anche sul piano culturale le conseguenze del Sessantotto sono nefaste
perché si crea un clima di conformismo dilagante: chi non la pensa come la
maggioranza e non si omologa al pensiero dominante viene emarginato, escluso e
ghettizzato suscitando un odio che sfocerà nei terribili anni di piombo. Un
pensiero caratterizzato dal predominio del politicamente corretto di cui, non a
caso, la nostra società è figlia ed è proprio negli anni successivi al
Sessantotto che il concetto gramsciano di egemonia culturale si realizza a pieno
titolo nel mondo della scuola, dell’università e della cultura portando
l’ideologia nei libri di testo e orientando i programmi scolastici in
senso progressista, in particolare nella filosofia, nella storia e letteratura.
Ma soprattutto, e mi rivolgo in particolare ai miei coetanei, ai giovani nati e
cresciuti nell’Italia postsessantottina, il Sessantotto ci ha rubato il futuro.
La società in cui viviamo è figlia delle proteste studentesche, la classe
dirigente che ci ha governato negli ultimi anni con risultati fallimentari si è
formata nella scuola sessantottina. Nell’illusione di volere sempre più diritti
ci siamo ritrovati a non averne più. Così, nell’Italia del 2018, il vero
rivoluzionario è chi si oppone ai principi sessantottini e lotta per una società
fondata sul merito, il rispetto delle regole e dell’autorità.
La battaglia di Valle
Giulia 50 anni dopo,
scrive Edoardo Frittoli il 28 febbraio 2018 su "Panorama". Tutto cominciò a
causa dell'altissima tensione seguita allo sgombero della Facoltà di
Architettura dell'Università di Roma, a Valle Giulia. Il palazzo era rimasto
occupato per quasi un mese dagli studenti in lotta e il 29 febbraio 1968 il
Rettore Pietro Agostino D'Avack aveva deciso di richiedere l'intervento della
forza pubblica per procedere allo sgombero. La decisione era giunta mentre le
occupazioni degli Atenei italiani si erano moltiplicate, così come era cresciuta
l'ostilità tra gli studenti in agitazione e quelli contrari all'occupazione.
Durante quei giorni di massima tensione, il quadro della protesta universitaria
aveva raggiunto l'apice di ben 25 Università occupate, da Trento a Palermo.
Iniziamo dalle ore immediatamente precedenti la battaglia più famosa della
storia della contestazione studentesca.
Università degli Studi di
Milano, mattina del 29 febbraio 1968. Botte, sassi, vetri infranti, idranti
antincendio in azione in Via Festa del Perdono di fronte ai portoni d'ingresso
delle Facoltà di Lettere e Giurisprudenza. Niente polizia questa volta: lo
scontro si consuma tra occupanti di Lettere e Filosofia e rappresentanti
di destra giunti dalla Facoltà di Giurisprudenza contrari all'occupazione decisa
il giorno prima nell'Aula Magna della Statale. Gli studenti di legge si
presentano di fronte ai picchetti d'ingresso e comincia lo scontro fisico,
dilagato anche nelle vie adiacenti l'Università tanto da indurre i negozianti ad
abbassare le saracinesche. La guerriglia prosegue con gli occupanti che usano
gli idranti antincendio per respingere i "fascisti", che inizialmente arretrano
ma alla fine riescono a sfondare con blocchi di cemento un ingresso secondario.
Si teme il peggio, ma in realtà il contatto non avviene e gli studenti di destra
si rinchiudono in un'aula separati dai loro avversari.
Città Universitaria di Roma,
29 febbraio 1968. Molto diversa e sicuramente più drammatica la situazione
a Roma: lo sgombero si era consumato come richiesto dal Rettore, ed aveva
coinvolto un ingentissimo numero di agenti tra Polizia e Carabinieri in assetto
da guerriglia. Guidati da ben 30 funzionari si presentarono 1.500 uomini alle
porte delle Facoltà occupate, procedendo allo sgombero forzato delle Facoltà di
Scienze Politiche, Lettere e Giurisprudenza, con il Vicequestore Prudenza che, a
bordo di una camionetta, intimava con il megafono la resa agli occupanti.
Assieme alle forze dell'ordine, quella mattina di 50 anni fa, erano
presenti anche gli studenti di destra di "Primula Goliardica" e "La Caravella",
armati di bastoni e catene. Verso la fine della giornata sono sgomberate anche
le Facoltà di Lettere e Architettura, dove vengono posti in stato di fermo
oltre 80 studenti. Con i portoni chiusi dai catenacci messi dalle forze
dell'ordine, un corteo di studenti si dirige verso il centro della Capitale.
Imboccata via Nazionale vengono a contatto con gli agenti che caricano e
lanciano le jeep della Celere nei consueti caroselli. Uno studente rimane ferito
dopo essere stato investito e alla fine della giornata si conteranno 10 persone
in ospedale tra studenti, passanti e forze dell'ordine.
La battaglia di Valle Giulia:
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma: 1 marzo 1968. Il
giorno dopo gli sgomberi voluti dal Rettore D'Avack,
sulle scalinate di Architettura a Valle Giulia stazionano 150 agenti a
protezione del portone d'ingresso. Come ricordato sopra, gli studenti (circa
3.000) arrivarono in corteo provenienti da Piazza di Spagna, dividendosi in due.
Una parte dei manifestanti piegò verso la Città universitaria mentre il grosso
del corteo si diresse dritto verso Architettura a Valle Giulia, la Facoltà
più isolata. Con gli studenti di sinistra sfilarono quel giorno anche i
rappresentanti dei movimenti di estrema destra Avanguardia Nazionale e La
Caravella, in virtù di un accordo di non-provocazione tra le due fazioni
studentesche. Tra i neofascisti decisi a combattere per cambiare l'Università
"dei borghesi" nomi di primissimo piano della galassia nera come Stefano Delle
Chiaie, Adriano Tilgher, Mario Merlino, Giulio Caradonna. Tra i rappresentanti
del movimento studentesco che diventeranno personaggi preminenti nella storia
futura d'Italia Giuliano Ferrara, Ernesto Galli della Loggia, Paolo Liguori,
Aldo Brandirali, Oreste Scalzone. Davanti alle gradinate di Architettura la
scintilla dello scontro alimentata dal lancio di uova, dagli slogan e dalle
provocazione tra le due parti, scocca quasi subito. Partono le prime cariche
della Polizia, ma gli studenti questa volta fanno sul serio. Inizia la
fitta sassaiola sul piazzale antistante la Facoltà; due auto e un pullman della
Celere vengono dati alle fiamme per impedire lo sfondamento da parte delle forze
dell'ordine. Cadono i primi feriti e la superiorità numerica dagli studenti
provoca l'arretramento dei cordoni di Polizia. Alcuni manifestanti riescono ad
impadronirsi di 5 pistole sottratte ai funzionari, la situazione degenera. La
Polizia carica anche con i cavalli cercando di rispondere alla forza degli
studenti che dopo oltre 2 ore di violenti scontri riescono a penetrare
all'interno di Architettura, proprio mentre arrivano i rinforzi di Polizia con
gli idranti a schiuma e i lacrimogeni. Gli studenti di estrema destra
riusciranno ad entrare nelle aule di Giurisprudenza. Sono rimasti sul campo 197
feriti, un bilancio da guerriglia urbana. Di questi ben 150 fanno parte delle
forze dell'ordine, tra i quali figura anche il Vicequestore Provenza, colpito da
una pietra scagliata dagli studenti.
Dalle fratture traumatiche
alla frattura politica. Pasolini, Il PCI e il MSI dopo la battaglia. La Polizia
riuscirà a riprendere il controllo della piazza solo con l'intervento degli
idranti e con un fitto lancio di lacrimogeni, procedendo al fermo ed all'arresto
dei manifestanti fino a tarda notte. La scarpata erbosa di fronte al palazzo
rossiccio della Facoltà di Giurisprudenza mostrava i segni della lunga battaglia
tra gli universitari e i poliziotti, che Pasolini difenderà all'indomani degli
scontri identificando i figli di quei "contadini del mezzogiorno" come veri
rappresentanti del proletariato, assaliti con violenza dai figli privilegiati
dei borghesi. Valle Giulia rappresenterà una cesura definitiva tra
gli studenti e i partiti politici di riferimento, sia a destra che a sinistra.
Il Partito Comunista non intendeva assecondare lo spontaneismo e i miti
stranieri (Mao e Che Guevara) fuori dai canoni interni e ai diktat della
dirigenza, procedendo nei mesi seguenti a numerose espulsioni dalle proprie
organizzazioni giovanili. Dall'altra parte la frattura è netta anche tra
il Movimento Sociale Italiano e l'azione rivoluzionaria di giovani neofascisti
dei primi movimenti extraparlamentari che caratterizzeranno il decennio
successivo. Arturo Michelini, allora segretario missino, prese immediatamente le
distanze di chi aveva combattuto a fianco dei "rossi", anche per il pericolo che
queste azioni "di squadra" potessero influenzare negativamente il tentativo da
parte della dirigenza del partito di rientrare gradualmente nell'arco
costituzionale. Questa frattura sarà così profonda da spingere Michelini
all'organizzazione di una "forza a difesa dell'ordine" che due settimane dopo
gli scontri di Valle Giulia intervenne con la forza contro gli studenti che
avevano di nuovo occupato, guidata da Giorgio Almirante.
L'impatto di Valle Giulia in
Parlamento. Poco dopo la fine degli scontri parlò il Ministro dell'Interno, il
democristiano Paolo Emilio Taviani. Rivolgendosi alla Camera dei Deputati il
ministro difende a spada tratta l'operato della Polizia in difesa delle
istituzioni dell'Italia democratica in senso ampio. Nel suo discorso rievoca la
debolezza della forza pubblica ricordando la debolezza mostrata in occasione
della Marcia su Roma e dall'opportunità lasciata al fascismo in quell'occasione.
Fu interrotto dal deputato comunista Bronzuto, che apostrofò i membri del
Governo come una "manica di fascisti" per la brutalità dell'intervento della
forza pubblica. I missini si univano alle proteste in aula ed a riportare la
calma toccherà ad uno dei protagonisti storici dell'antifascismo italiano,
l'allora Vicepresidente della Camera Sandro Pertini. Chiamato in causa, il
Ministro dell'Istruzione Luigi Gui metteva le mani avanti affermando che la
riforma dell'Università (ancora da discutere e approvare) avrebbe certamente
incluso una rappresentanza dei collettivi degli studenti. Mentre le urla e le
accuse dei rappresentanti in Parlamento si spegnevano a fatica, i comitati
studenteschi si davano appuntamento per una nuova manifestazione a Piazza del
Popolo, che si svolgerà il giorno seguente gli scontri di Valle Giulia senza
registrare particolari incidenti. Anche a Milano, al di là di qualche
tafferuglio alla Statale tra studenti di destra e sinistra, sembrò tornare la
calma alimentata dalla pausa del Carnevale ambrosiano. Tregua che naturalmente
non durerà a lungo.
I dieci danni che ci lasciò
il '68.
Mezzo secolo fa l'arroganza del (presunto) contropotere generò la dittatura
chiamata "politicamente corretto", scrive Marcello Veneziani, Domenica
25/02/2018, su "Il Giornale". Sono passati cinquant'anni dal '68 ma gli effetti
di quella nube tossica così mitizzata si vedono ancora. Li riassumo in dieci
eredità che sono poi il referto del nostro oggi.
SFASCISTA. Per cominciare, il
'68 lasciò una formidabile carica distruttiva: l'ebbrezza di demolire o cupio
dissolvi, il pensiero negativo, il desiderio di decostruire, il Gran Rifiuto.
Basta, No, fuori, via, anti, rabbia, contro, furono le parole chiave,
esclamative dell'epoca. Il potere destituente. Non a caso si chiamò
Contestazione globale perché fu la globalizzazione destruens, l'affermazione di
sé tramite la negazione del contesto, del sistema, delle istituzioni, dell'arte
e della storia. Lo sfascismo diventò poi il nuovo collante sociale in forma di
protesta, imprecazione, invettiva, e infine di antipolitica. Viviamo tra le
macerie dello sfascismo.
PARRICIDA. La rivolta del '68
ebbe un Nemico Assoluto, il Padre. Inteso come pater familias, come patriarcato,
come patria, come Santo Padre, come Padrone, come docente, come autorità. Il '68
fu il movimento del parricidio gioioso, la festa per l'uccisione simbolica del
padre e di chi ne fa le veci. Ogni autorità perse autorevolezza e credibilità,
l'educazione fu rigettata come costrizione, la tradizione fu respinta come
mistificazione, la vecchiaia fu ridicolizzata come rancida e retrò, il vecchio
perse aura e rispetto e si fece ingombro, intralcio, ramo secco. Grottesca
eredità se si considera che oggi viviamo in una società di vecchi. Il
giovanilismo di allora era comprensibile, il giovanilismo in una società anziana
è ridicolo e penoso nel suo autolesionismo e nei suoi camuffamenti.
INFANTILE. Di contro, il '68
scatenò la sindrome del Bambino Perenne, giocoso e irresponsabile. Che nel nome
della sua creatività e del suo genio, decretato per autoacclamazione, rifiuta le
responsabilità del futuro, oltre che quelle del passato. La società senza padre
diventò società senza figli; ecco la generazione dei figli permanenti,
autocreati e autogestiti che non abdicano alla loro adolescenza per far spazio
ai bambini veri. Peter Pan si fa egocentrico e narcisista. Il collettivismo
originario del '68 diventò soggettivismo puerile, emozionale con relativo culto
dell'Io. La denatalità, l'aborto e l'oltraggio alla vecchiaia trovano qui il
loro alibi.
ARROGANTE. Che fa rima con
ignorante. Ognuno in virtù della sua età e del suo ruolo di Contestatore si
sentiva in diritto di giudicare il mondo e il sapere, nel nome di un'ignoranza
costituente, rivoluzionaria. Il '68 sciolse il nesso tra diritti e doveri, tra
desideri e sacrifici, tra libertà e limiti, tra meriti e risultati, tra
responsabilità e potere, oltre che tra giovani e vecchi, tra sesso e
procreazione, tra storia e natura, tra l'ebbrezza effimera della rottura e la
gioia delle cose durevoli.
ESTREMISTA. Dopo il '68
vennero gli anni di piombo, le violenze, il terrorismo. Non fu uno sbocco
automatico e globale del '68 ma uno dei suoi esiti più significativi.
L'arroganza di quel clima si cristallizzò in prevaricazione e aggressione verso
chi non si conformava al nuovo conformismo radicale. Dal '68 derivò l'onda
estremista che si abbeverò di modelli esotici: la Cina di Mao, il Vietnam di
Ho-Chi-Minh, la Cuba di Castro e Che Guevara, l'Africa e il Black power. Il '68
fu la scuola dell'obbligo della rivolta; poi i più decisi scelsero i licei della
violenza, fino al master in terrorismo. Il '68 non lasciò eventi memorabili ma
avvelenò il clima, non produsse rivoluzioni politiche o economiche ma mutazioni
di costume e di mentalità.
TOSSICO. Un altro versante del
'68 preferì alle canne fumanti delle P38 le canne fumate e anche peggio. Ai
carnivori della violenza politica si affiancarono così gli erbivori della droga.
Il filone hippy e la cultura radical, preesistenti al '68, si incontrarono con
l'onda permissiva e trasgressiva del Movimento e prese fuoco con l'hashish,
l'lsd e altri allucinogeni. Lasciò una lunga scia di disadattati, dipendenti,
disperati. L'ideologia notturna del '68 fu dionisiaca, fondata sulla libertà
sfrenata, sulla trasgressione illimitata, sul bere, fumare, bucarsi, far notte e
sesso libero. Anche questo non fu l'esito principale del '68 ma una diramazione
minore o uscita laterale.
CONFORMISTA. L'esito
principale del '68, la sua eredità maggiore, fu l'affermazione dello spirito
radical, cinico e neoborghese. Il '68 si era presentato come rivoluzione
antiborghese e anticapitalista ma alla fine lavorò al servizio della nuova
borghesia, non più familista, cristiana e patriottica, e del nuovo capitale
globale, finanziario. Attaccarono la tradizione che non era alleata del potere
capitalistico ma era l'ultimo argine al suo dilagare. Così i credenti, i
connazionali, i cittadini furono ridotti a consumatori, gaudenti e single. Il
'68 spostò la rivoluzione sul privato, nella sfera sessuale e famigliare, nei
rapporti tra le generazioni, nel lessico e nei costumi.
RIDUTTIVO. Il '68 trascinò
ogni storia, religione, scienza e pensiero nel tribunale del presente. Tutto
venne ridotto all'attualità, perfino i classici venivano rigettati o accettati
se attualizzabili, se parlavano al presente in modo adeguato. Era l'unico
criterio di valore. Questa gigantesca riduzione all'attualità, alterata dalle
lenti ideologiche, ha generato il presentismo, la rimozione della storia, la
dimenticanza del passato; e poi la perdita del futuro, nel culto immediato
dell'odierno, tribunale supremo per giudicare ogni tempo, ogni evento e ogni
storia.
NEOBIGOTTO. Conseguenza
diretta fu la nascita e lo sviluppo del Politically correct, il bigottismo
radical e progressista a tutela dei nuovi totem e dei nuovi tabù. Antifascismo,
antirazzismo, antisessismo, tutela di gay, neri, svantaggiati. Il '68 era nato
come rivolta contro l'ipocrisia parruccona dei benpensanti per un linguaggio
franco e sboccato; ma col lessico politicamente corretto trionfò la nuova
ipocrisia. Fallita la rivoluzione sociale, il '68 ripiegò sulla rivoluzione
lessicale: non potendo cambiare la realtà e la natura ne cambiò i nomi, occultò
la realtà o la vide sotto un altro punto di vista. Fallita l'etica si rivalsero
sull'etichetta. Il p.c. è il rococò del '68.
SMISURATO. Cosa lascia infine
il '68? L'apologia dello sconfinamento in ogni campo. Sconfinano i popoli, i
sessi, i luoghi. Si rompono gli argini, si perdono i limiti e le frontiere, il
senso della misura e della norma, unica garanzia che la libertà non sconfini nel
caos, la mia sfera invade la tua. Lo sconfinamento, che i greci temevano come
hybris, la passione per l'illimitato, per la mutazione incessante; la natura
soggiace ai desideri, la realtà stuprata dall'utopia, il sogno e la fantasia che
pretendono di cancellare la vita vera e le sue imperfezioni... Questi sono i
danni (e altri ce ne sarebbero), ma non ci sono pregi, eredità positive del '68?
Certo, le conquiste femminili, i diritti civili e del lavoro, la sensibilità
ambientale, l'effervescenza del clima e altro... Ma i pregi ve li diranno in
tanti. Io vi ho raccontato l'altra faccia in ombra del '68. Noi, per dirla con
un autore che piaceva ai sessantottini, Bertolt Brecht, ci sedemmo dalla parte
del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Alla fine, i trasgressivi
siamo noi.
Marcello
Veneziani Editorialista del Tempo, sul '68 ha scritto Rovesciare il '68
(Mondadori, anche in Oscar, 2008)
«Così noi Uccelli occupammo
la cupola del Borromini e iniziò il sessantotto»,
scrive Simona Musco il 20 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Paolo Ramundo era il
leader degli “Uccelli”, che organizzarono il blitz a Sant’Ivo alla Sapienza.
Diciannove febbraio 1968: tre studenti di architettura occupano il campanile di
Sant’Ivo alla Sapienza a Roma. Sono gli “Uccelli” Paolo Ramundo, Gianfranco
Moltedo e Martino Branca, all’epoca 26enni, coloro che portano gli studenti
fuori dalle aule, liberandoli dalle discussioni fini a se stesse e dando di
fatto via al ‘ 68. «Volevamo prenderci i luoghi guardando al presente. La nostra
fu una rivoluzione culturale», racconta al Dubbio Ramundo.
Come nascono gli “Uccelli”?
«C’eravamo
incontrati a capodanno, a una festa sulla Flaminia. Abbiamo continuato a
frequentarci, vedendoci spesso in facoltà. Allora c’erano già delle presenze
assembleari e la cosa ci coinvolgeva, ma avevamo una notevole autonomia rispetto
a come venivano presentati nelle assemblee il movimento e la lotta degli
studenti. Sentivamo che era un tema importante, però non ci piaceva che gli
studenti stessero lì seduti ad ascoltare sempre le stesse persone, che facevano
le loro riflessioni e rimandavano alla prossima assemblea. Era una cosa legata a
un futuro ideologico e lontano. A noi interessava che questa agitazione
spingesse gli studenti a prendersi i luoghi che in quel momento avevano vissuto
in modo convenzionale e a saperli usare. Per noi si doveva fare già subito.
Così, quando si parlava troppo, noi protestavamo fischiando e salendo sugli
alberi. Così ci hanno dato questo soprannome. Ci chiamavano hippie: avevamo i
capelli lunghissimi, mentre gli altri erano tutti più convenzionali, legati al
ceto medio-alto».
Come nasce l’occupazione
del campanile?
«Avevo
seguito molto Paolo Portoghesi, grande studioso del Barocco, di Borromini e
dell’architettura innovativa del 600. Conoscevamo quindi bene Sant’Ivo, prima
sede universitaria della città. Quando ci fu un dissenso con alcuni leader del
movimento, che ci fecero cacciare dalla facoltà, pensammo: siamo cacciati fuori,
facciamo uscire anche gli altri studenti. Così andammo da Portoghesi, che in
quel periodo faceva dei sopralluoghi con gli studenti a Sant’Ivo e accettò di
portarci a visitare il luogo».
Senza sapere quale fosse la
vostra intenzione.
«Esatto.
Volevamo essere rilevanti, non semplicemente vederlo. Volevamo suscitasse
attenzione da parte degli studenti e dei cittadini. Portoghesi ci fece salire
fino alla guglia: il posto era straordinario. Appena arrivati disse: “allora,
scendiamo?”. Ma noi dicemmo no, vogliamo che questo luogo, che era stato
archiviato, venga completamente valorizzato, conosciuto e vissuto. Lui rimase
sbalordito».
Come passaste quella notte?
«Faceva
freddissimo. Rimanemmo fino al pomeriggio del 20. Gli studenti di tutte le
facoltà vennero lì, in piazza Sant’Eustachio e corso Rinascimento, e si misero a
cantare e ballare con le fiaccole. Era un momento di grande soddisfazione: per
la prima volta giovani studenti fecero un’iniziativa nella città».
Quindi si può dire che
avete dato inizio al ‘ 68?
«Sì.
Iniziò così, con questa tensione verso l’importanza di essere presenti
all’interno della società e conoscere le nostre aspettative, le condizioni che
criticavamo e volevamo cambiare. Che poi sono tutte cambiate, perché il ‘ 68 ha
generato un grande movimento di cambiamento. Noi dicevamo: non dobbiamo parlare
di un futuro lontano, dobbiamo parlare subito di tutte le situazioni di cui ci
vogliamo occupare, per far sì che ci sia subito un processo di cambiamento
democratico dal basso».
Quali erano le questioni
che vi stavano più a cuore?
«I
processi relativi all’urbanistica, l’architettura, l’arte: dovevano essere super
partecipati e democraticamente collegati alla società in cui ci trovavamo.
Bisogna- va smettere di pensare alla divisione del lavoro e alle tendenze
autoritarie. Tutto doveva diventare fortemente democratico. C’erano tanti temi
sulle procedure con cui fare delle scelte, l’importanza della relazione tra le
persone. L’architetto, ad esempio, non poteva stare da solo in dipendenza di un
costruttore, ma doveva essere prima di tutto in relazione con le finalità di
quello che veniva programmato. Se si doveva fare una scuola si doveva
coinvolgere direttamente i cittadini su come farla, dove collocarla. Prima tutto
veniva imposto dall’alto, quindi i processi democratici erano assolutamente da
sviluppare. Le donne, ad esempio, che in università avevano un ruolo subalterno
ai maschi, dovevano rivendicare la loro autonomia, tant’è vero che da quelle
tensioni nacque il movimento femminista per affrontare i diritti che erano
scritti sulle nostre normative costituzionali, ma non erano messi in pratica».
Qualche giorno dopo ci fu
Valle Giulia. Quale fu il vostro contributo?
«Sicuramente
abbiamo generato quella iniziativa. Siccome la facoltà di architettura era stata
chiusa dal governo autoritario accademico, con la polizia a controllare
l’accesso, gli studenti ti avevano organizzato un corteo da piazza di Spagna
fino a via Gramsci, dove c’era la sede della facoltà. Non avevano programmato di
fare guerriglia, si erano semplicemente dati appuntamento per marciare e
reclamarne l’apertura. Ma all’interno del movimento c’erano dei provocatori.
Qualcuno andò a bruciare una macchina della polizia e si creò uno stato di
tensione che portò a corse lungo le discese di villa Valle Giulia, inseguimenti,
spinte, botte, calci. Ma fu una cosa generata dall’autoritarismo del rettore».
E gli “Uccelli” cosa
fecero?
«Stavamo
in facoltà, avevamo delle pecore con noi, comprate con il contributo di alcuni
intellettuali con lo scopo di sottolineare l’importanza del verde, degli spazi
non costruiti, la cosiddetta agropoli. Quando cominciarono queste corse ci
allontanammo e i carabinieri ci fecero passare. Il giorno dopo sacrificammo una
pecora sull’altare della pace, un gesto simbolico per purificare da quella
violenza, che era nata dall’autoritarismo. La strada, però, non era quella della
violenza, ma era legata alla partecipazione, al coinvolgimento, alla relazione
con le forze politiche, per fare sì che ci fossero dei cambiamenti, non per
limitarci a fare qualche scazzottata».
Cosa accadde dopo?
«Abbiamo
continuato ad essere presenti: facemmo un disegno sulla facoltà con Guttuso
perché volevamo appropriarci dei luoghi in cui studiavamo. Non potevamo essere
marginali e passivi, dovevamo metterci in relazione col mondo culturale e
interessarlo al movimento dei giovani. Era la prima volta che a fare qualcosa
non erano le categorie sociali ma i giovani. E questa è stata la nostra grande
conquista».
Quando il Sessantotto finì
nelle ideologie, risponde Aldo
Cazzullo il 7 febbraio 2018 su "Il Corriere della Sera". Caro Aldo, già
cominciano le rievocazioni. Ma ha ancora senso processare il ‘68? Filiberto
Piccini, Pisa.
Caro Filiberto, La discussione
sul ‘68 l’hanno sempre fatta i sessantottini: spesso celebrandosi, talora
abiurando. Avrebbero diritto di parola anche le generazioni precedenti e
successive. In Italia com’è noto il ‘68 è durato dieci anni, sino al caso Moro.
I miei ricordi di bambino sono scanditi dagli scontri di piazza e dagli omicidi
di terroristi rossi e neri. Certo la rivolta non è stata solo questo; ma negare
che ci sia un nesso tra il ‘68 e gli anni di piombo mi pare arduo. Più tardi ho
cercato, intervistando centinaia di protagonisti, in fabbrica e in questura, ai
vertici Fininvest e in galera, di trovare un senso a quel che era accaduto. Mi
sono fatto questa idea. A un’esplosione libertaria, che ha portato a un sano
cambiamento dei costumi, dei rapporti tra le persone, del ruolo della donna, è
seguito un irrigidimento dogmatico in una parte non trascurabile del
movimento. Lo slancio dei giovani finì ingabbiato nelle due ideologie del
Novecento, il comunismo e il fascismo, destinate a estinguersi da lì a pochi
anni. I giovani di sinistra consideravano il Pci compromesso con la democrazia
borghese, e si proponevano di proseguire il compito cui Togliatti e Berlinguer
avevano rinunciato: la rivoluzione, come in Cina più che come in Russia. Qualche
ex di Lotta continua ha il vezzo di dire di non essere mai stato comunista.
Farebbe meglio a dire di essere sempre stato contro il Pci; ma i militanti di
Lotta continua erano convinti di essere loro i veri comunisti. Qualcosa del
genere, su scala più ridotta, accadde a destra nei confronti del Msi di
Almirante, considerato filoatlantico, filoisraeliano, mercatista. Il risultato
fu una mimesi della guerra civile, che lasciò sul terreno troppo odio e troppi
morti. Di quella generazione salvo una cosa: l’idea, coltivata da molti, che si
potesse essere felici soltanto tutti assieme, affidando la vita alla politica.
La sconfitta è stata dura: qualcuno è finito nel terrorismo, qualcuno nella
droga, qualcuno è rimasto in fabbrica negli anni della restaurazione. La
generazione successiva, quella del riflusso (che è poi la mia), ha creduto che
si potesse essere felici soltanto ognuno per proprio conto; e anche noi siamo
andati incontro alla disillusione, con questo senso di solitudine esistenziale
che ci portiamo dentro.
Il Sessantotto non è ancora
finito. È
stato un processo, non una serie circoscritta di eventi. Solo con la riflessione
storica si esce dalla morsa tra nostalgia e rimozione, scrive Umberto Gentiloni
il 7 febbraio 2018 su "L'Espresso". Il Sessantotto tra i tanti anniversari a
cifra tonda del 2018 sembra mantenere il suo carattere divisivo a partire dalle
declinazioni semantiche che lo qualificano: fedeltà o rimozione, modernità o
conservazione, soggettività o distanza. Difficile uscire da una morsa che ha
accompagnato il corso del mezzo secolo che abbiamo alle spalle, riconducibile al
paradigma opprimente del «passato che non passa» ripresentandosi sotto mentite
spoglie di memorie contrapposte o in forme apertamente conflittuali. Da un lato
la nostalgia del come eravamo, la cifra di una generazione che segnata dagli
appuntamenti con la storia in un anno così ricco di novità cerca di mantenere
saldi legami con un tempo che le appartiene. Un’ancora di certezze e rimpianti
che mostra lo straordinario fascino di poter riavvolgere il nastro di un
itinerario fatto di storie, biografie, luoghi e situazioni. Dall’altro la
critica che punta a ridimensionare, rimuovere, demolire un patrimonio di memorie
e riferimenti comuni che ha attraversato un tratto di storia dell’Occidente. In
mezzo lo spazio stretto e difficile della storicizzazione: giudizi,
interpretazioni, confronti a partire dalla complessità di un passaggio del
dopoguerra che più che un evento isolabile o circoscrivibile prende le sembianze
di un processo dal passo lungo che si manifesta con modalità e tempi diversi in
tanti angoli del pianeta. Uno spazio di analisi e riflessioni ricco di fonti
plurali qualificato da interrogativi che vanno ben al di là del perimetro degli
eventi del 1968. Decisivo non smarrire i punti di partenza nella società di
allora. Ne ha scritto Guido Crainz nell’ultima puntata di questo confronto a
più voci: cosa erano la scuola e l’università italiana? Da dove prende corpo
l’anno delle rivolte? Quali contraddizioni si scaricano sul sistema formativo
incapace di reggere l’urto della scolarizzazione di massa? Il ’68 degli studenti
si lega all’autunno caldo dell’anno successivo, all’emergere di una
conflittualità operaia che ha un’identità politica (salari e contratti) e
generazionale (una nuova classe operaia entrata in fabbrica). Una specificità
italiana il nesso e l’incontro tra studenti e operai, tra l’università e la
fabbrica, tra il 1968 e il 1969.
La discontinuità più incisiva
e duratura chiama in causa l’aspetto qualitativo dell’innovazione: consumi
diffusi, benessere individuale, ricerca di nuove aperture verso mondi emergenti,
scoperta di un tempo libero dal lavoro, cura di sé e del proprio corpo. Il
conflitto da latente diventa manifesto, esplicito. Un crinale tra due mondi, al
tramonto del vecchio non corrisponde una coerente e sinergica opera di
rinnovamento. Molto rimane in vita, resiste e si conserva, altro muta
parzialmente per poi trovare nuovi spazi, altro ancora viene travolto dal
protagonismo di soggettività inedite. La frattura è trasversale, tra opportunità
e chiusure, tra generazioni diverse, tra chi riesce a beneficiare delle
trasformazioni e chi invece rimane emarginato, escluso e mortificato. Speranze e
illusioni muovono uomini e donne verso la ricerca di nuove possibilità in grado
di rompere gabbie e condizionamenti della stratificazione sociale di partenza.
La disperata ricerca di una mobilità possibile. Una tensione costante che non si
riassorbe trovando con il tempo nuovi interpreti non riconducibili alla
indiscussa (fino ad allora) centralità del binomio amico - nemico imposta dal
riflesso condizionato dell’ordine della guerra fredda. Il rapporto tra individuo
e collettività entra in fibrillazione, le strutture tradizionali non soddisfano
le aspirazioni di tanti: ha inizio una parabola discendente per partiti,
organizzazioni collettive, sindacati o associazioni. Difficile trovare un punto
di equilibrio tra la sfera della soggettività individuale che chiede sempre di
più e meglio e le forme di espressione e organizzazione della collettività. Più
si afferma la prima e più sembra irragionevole e irrealistico proporre
l’articolazione di una società per gruppi o identità omogenee, figlie di un
tempo che volge alla conclusione.
Per almeno due decenni sono
mancate ricostruzioni storiche basate su documentazione non episodica o
limitata. Uno studioso attento come Peppino Ortoleva si domandava - nel 1988 in
occasione del ventennale - quali fossero i motivi dell’assenza di un quadro di
riferimento in grado di rompere la morsa tra condanna senza appelli e revival
nostalgici di chi voleva tornare alla meglio gioventù di allora (“I movimenti
del ’68 in Europa e in America”, Editori Riuniti). Il Sessantotto nella sua
lunga durata non può che coinvolgere direttamente una riflessione più generale
sul dopoguerra italiano, sul ruolo dei movimenti, sul peso di una stagione
segnata dal protagonismo di soggettività e culture inedite. Una riflessione
pienamente inserita nelle dinamiche del sistema internazionale. Se sfumano i
ricordi, se si affievolisce il rimpianto per un tempo lontano allora prendono
corpo gli interrogativi e le ipotesi interpretative sulle grandi questioni che
il Sessantotto solleva e proietta sull’Italia e, in un’ottica più ampia, sulle
trasformazioni di un mondo inquieto. Il terremoto nel mondo comunista, la
repressione violenta del riformismo cecoslovacco segna la fine di Mosca come
guida indiscussa del movimento comunista internazionale. E sull’altro versante
la sporca guerra in Vietnam indebolisce i presupposti del mito americano
rendendolo vulnerabile e incerto. I modelli di riferimento perdono terreno,
mostrano il volto contraddittorio del confronto bipolare. L’inizio della fine
dei partiti si sovrappone e si accompagna ai primi i sintomi diffusi sulla
inadeguatezza del confronto Est-Ovest.
La controversa questione dei
lasciti di una stagione non è riconducibile alle dinamiche di un singolo
contesto nazionale. Prevalgono i caratteri distintivi di un fenomeno globale
quali «l’ampiezza geografica e la simultaneità temporale» (Marcello Flores,
Alberto De Bernardi, “Il Sessantotto”, Mulino 1998.) In Italia il Sessantotto si
lega a una crisi più generale del sistema politico, all’indebolimento
inesorabile della capacità dei partiti di essere tramite e filtro tra cittadini
e istituzioni. La fine della centralità di formazioni politiche che avevano
percorso i decenni del dopoguerra con la consapevolezza di essere i soggetti
principali di una dialettica capace di includere e coinvolgere settori diversi
della società italiana. Gli stessi partiti di massa non sono in grado di
comprendere la portata del fenomeno: alcuni ne raccoglieranno l’eredità altri,
soprattutto nella sinistra storica, avranno i benefici dell’ingresso di nuovi
quadri dirigenti, ma il movimento rimane ostile alla cultura e
all’organizzazione dei partiti.
Aldo Moro aveva colto il segno
di un tempo nuovo, scrive del Sessantotto più volte fino ai suoi ultimi giorni.
Verso la fine dell’anno in un Consiglio nazionale della Dc (21 Novembre 1968)
aveva pronunciato parole impegnative e per molti versi inascoltate: «Siamo
davvero ad una svolta della storia e sappiamo che le cose sono irreversibilmente
cambiate, non saranno ormai più le stesse».
Non date la colpa al ’68.
Nella contestazione si confusero differenti umori e pulsioni.
Ma non c’è alcun rapporto con gli anni Ottanta e con i disastri dell’oggi,
scrive Guido Crainz l'1 febbraio 2018 su "L'Espresso". Dimensione nazionale e
internazionale si intrecciano ma forse è bene prendere avvio da realtà concrete,
evitando il rischio (sessantottino?) dell’ideologia. E per discutere realmente
del nostro ’68, per comprenderne coralità e impatto, non dovremmo dimenticare
mai come era la scuola italiana alla sua vigilia, nel vivo di una
scolarizzazione di massa tumultuosa: gli studenti delle superiori erano il 10
per cento di quella fascia di età nel 1951, quasi il 40 per cento nel 1967; gli
universitari erano 230 mila nel 1958, 550 mila dieci anni dopo. Una
scolarizzazione di massa che avveniva in una fase di intensa circolazione
internazionale di idee e suggestioni, in contrasto stridente con una arretrata
“cultura docente” molto diffusa: si vedano le testimonianze di insegnanti
raccolte allora da Marzio Barbagli e Marcello Dei (“Le vestali della classe
media”, da leggere assieme alla “Lettera” di don Milani). «Lo studente è un
sacco vuoto da riempire, dall’alto di una cattedra, di nozioni già
confezionate»: lo scriveva nel 1966 il giornale dei giovani di Azione cattolica,
mentre provocava bufere e processi il giornalino del liceo Parini di Milano per
un’inchiesta su «quel che pensano le ragazze d’oggi». E il giudice inquirente
chiedeva di sottoporre i suoi autori a una umiliante visita medica in base ad
una disposizione fascista sui reati dei minori. In quello stesso periodo
iniziavano ad estendersi le occupazioni delle Facoltà, a partire da
Architettura, e Camilla Cederna ne dava conto proprio su “L’Espresso”. «Sono
stanchi di copiare il Partenone», titolava nel febbraio del 1965, e non era solo
una coloritura giornalistica: gli studenti chiedevano l’introduzione di materie
ancora ignorate dai piani di studio come Storia dell’architettura moderna e
Urbanistica (in un’Italia ormai invasa dalla speculazione edilizia). In un
manifesto-simbolo del ’68, quello degli studenti torinesi, vi è l’elenco dei
“controcorsi” avviati nell’Università occupata, dedicati a temi ancora esclusi
dall’insegnamento: Filosofia delle scienze, Scuola e società, Pedagogia del
dissenso, Psicoanalisi e repressione sociale, Imperialismo e sviluppo sociale in
America latina...La critica del ’68 all’Università fu certo impietosa ma non era
molto diversa l’analisi di un commentatore come Alberto Ronchey, che pur
chiedeva di «Offrire un’alternativa agli errori degli studenti». Ed enumerava le
ragioni di una crisi partendo da Roma: «60.000 studenti, 300 professori» (si
riferisce ai professori ordinari, detentori esclusivi di ogni potere: non era
improprio definirli “baroni”). E poi: «La seconda crisi riguarda gli uomini.
Prima il professore era il re, adesso il re è nudo. La terza crisi discende
dall’insegnamento dispotico, elusivo o muto sui temi che interessano gli
studenti»; e poi ancora «le comunicazioni di massa, che rendono vicino ogni
evento del mondo», «la rottura di linguaggio tra le generazioni», la crisi dei
«partiti, i rapporti fra Stato e società e civile (...). L’ultima generazione
non vede un disegno del tipo di società verso cui vogliamo andare» (“La Stampa”,
18 febbraio 1968). Poco dopo Giorgio Bocca annotava: in pochi mesi «si è
scoperto in modo clamoroso che la didattica di quasi tutte le facoltà
umanistiche e di molte facoltà scientifiche è inadeguata», e che dall’Università
«escono dei giovani incapaci di esercitare una professione». Nel rapido dilagare
del movimento studentesco differenti umori e pulsioni convissero e parvero quasi
fondersi (ha ragione Roberto Esposito): anticonformismo e impegno politico,
laicizzazione e solidarismo sociale, insofferenza per arretratezze
anacronistiche e aspirazioni a profondi rivolgimenti, mentre la realtà del Paese
dava molti argomenti a chi vedeva in ogni ingiustizia una “ingiustizia di
classe”. E bisognerebbe ricordare la realtà delle fabbriche di allora,
nell’intrecciarsi di forme di sfruttamento talora brutali, discriminazioni
inique, illibertà (solo nel 1970 lo Statuto dei lavoratori vi introdurrà la
Costituzione, come si disse): vedere “imborghesimento” in quegli operai è una
licenza filosofica che non condivido. Certo, la coralità dei primi mesi iniziò
progressivamente ad incrinarsi e la radicalizzazione ideologica rapidamente
prevalse. Ad essa contribuirono anche la balbettante ottusità del potere
accademico, il succedersi di interventi repressivi sproporzionati e l’assenza di
un’azione riformatrice (fu la politica a mancare in Italia, non il ’68 a
distruggerla: in Francia fu varata in pochi mesi la riforma Faure, che avviò la
modernizzazione degli atenei e pose rapidamente fine alle proteste
studentesche). E vi contribuì poi una radicalizzazione più generale: il 1969
sarà segnato dall’ “autunno caldo” sindacale e dalla strage di Piazza Fontana,
con l’avvio di una drammatica “strategia della tensione”. In quel clima declinò
- colpevolmente - l’impegno del movimento a rinnovare l’Università, considerata
sempre più area di reclutamento per i gruppi extraparlamentari in formazione.
Con l’infittirsi degli interventi in fabbriche e quartieri, e con il dilagare di
una vecchissima (e disastrosa) ideologia: abbandonata la fase innovativa degli
inizi, ha scritto Vittorio Foa, «straordinarie energie giovanili furono disperse
nel riscoprire e ripetere la Dottrina; nel ricostruire, spesso come caricatura,
quello che si era pensato di mandare al macero». Fu lasciata così cadere la
suggestiva idea, pur avanzata, di dar corpo a una “Università critica”: base
d’avvio di una «lunga marcia attraverso le istituzioni» volta a innovare saperi
e professioni; e a «ridefinire la politica», per usare l’espressione di Carlo
Donolo. Non mancarono neppure disincanti e ripiegamenti ma non è riducibile a
questi estremi la spallata data allora ad un’Italia arcaica: da quei fermenti
venne un più generale impulso alla modernizzazione civile, ad una più ampia
concezione dei diritti, ad una maggiore sensibilità sociale. Si incrinò anche
così il tradizionale profilo del ceto medio italiano, profondamente segnato sin
lì da apatie e conservatorismi. Naturalmente il passaggio dalla prima fase a
quella successiva non può essere rimosso (e costringe a interrogare criticamente
anche i mesi “aurorali”) ma non mi sembra fondato schiacciare gli anni Sessanta
sugli anni Ottanta, e neppure sugli anni Settanta (la contrapposizione del
“movimento del ’77” agli operai, sprezzati come “garantiti”, è l’esatto opposto
del sessantottesco “operai e studenti uniti nella lotta”). Né mi sembra fondato
il «rapporto stretto» che Orsina intravede fra il ’68 e tutti i disastri
dell’oggi, in uno scenario nazionale e internazionale squassato da allora in
ogni sua parte. E nella nostra lettura complessiva è possibile continuare a
ignorare gli studenti della Cecoslovacchia e della Polonia (o della Jugoslavia,
con le divaricanti tensioni che vi comparvero), giustamente ed efficacemente
evocati su queste pagine da Wlodek Goldkorn e da Gigi Riva? Nel ’68 di Praga e
di Varsavia si ebbe la conferma definitiva che il “socialismo realizzato” non
era riformabile e presero avvio anche da lì alcuni degli esili ma straordinari
fili che porteranno all’89. Continueremo a considerarla “un’altra storia”?
1968: tragica illusione o
vera rivoluzione?
E' stato l'anno della catastrofe o quello che ha fatto saltare per sempre tutti
gli equilibri? Mezzo secolo dopo, le posizioni restano inconciliabili. Da
Hoellebeq al Papa, tra critica e nostalgia, scrive Federico Marconi il 18
gennaio 2018 su "L'Espresso". Che cos’è stato il Sessantotto? Mezzo secolo dopo
non si contano i giudizi su uno degli anni che più hanno influito sulla nostra
storia. Libertà e creatività, immaginazione e fantasia, contestazione e
ribellione sono gli elementi di una “rivoluzione” che ha trasformato la
politica, la società e il costume. Ma quali risultati hanno raggiunto quei
ragazzi coi capelli lunghi che occupavano le università e volevano farla finita
con l’autorità, i valori tradizionali, il sapere borghese?
In molti si sono chiesti se il
’68 abbia avuto successo. E c’è chi è convinto di sì. Mario Perniola, il
filosofo appena scomparso, ha visto gli ideali del ’68 realizzati da uno che
sessantottino non è mai stato: Silvio Berlusconi. L’idea l’ha espressa nel 2011
in un pamphlet paradossale e provocatorio: “Berlusconi o il ’68 realizzato”: il
berlusconismo avrebbe fatto propri gli ideali della cultura libertaria esplosa
con il maggio francese, e il suo sfacciato neoliberismo non sarebbe altro che
l’esito della rottura rappresentata da quell’anno. Una realizzazione del ’68
postuma che dà tutto il potere non all’immaginazione, ma all’intrattenimento.
Rivincita di quell’allegria e di quella spinta creativa che, per Edmondo
Berselli in “Adulti con riserva”, sono state sacrificate sull’altare della
seriosità sessantottina. Ma c’è anche chi considera la contestazione studentesca
non una svolta progressista ma reazionaria, con la riproposizione di modelli
autoritari.
Lo storico tedesco Götz Aly in
“Unser Kampf” ha scritto che la generazione del ’68 condivide moltissimi
elementi con quella che nel 1933 ha portò al potere Hitler. La contestazione di
fine anni ’60, secondo Aly, è stata solo un epifenomeno del totalitarismo, che
non avrebbe nemmeno portato alla tanto decantata liberazione della morale e dei
costumi, visto che quel processo era già cominciato negli anni ’50.
Sulla stessa linea Alessandro
Bertante, che in “Contro il ’68” definisce quella ribellione come «una clamorosa
e tragica illusione», spezzata dalla repressione poliziesca e dalle bombe
fasciste. Alcuni ragazzi hanno preso poi la strada dell’eversione armata. Altri
sono tornati nell’ambito sociale di provenienza, la tanto odiata borghesia,
dando ragione a Eugène Ionesco, che gridava agli studenti del maggio francese:
«Tornate a casa! Tanto diventerete tutti notai!».
“Notai” ignoranti,
secondo Indro Montanelli: «Vidi nascere dal Sessantotto una bella torma di
analfabeti che poi invasero la vita italiana portando ovunque i segni della
propria ignoranza». Ma, come tutti i “notai”, ricchi: i sessantottini hanno un
reddito più alto delle altre generazioni, confermano gli studi della Banca
d’Italia sul bilancio delle famiglie. L’economista Riccardo Puglisi lo ha
evidenziato in un articolo nel 2013, che si chiudeva con la proposta di
«rottamarli tutti». E tra coloro che gli hanno dato ragione c’è stato anche uno
che nel 1968 era un maoista che finanziava il movimento smerciando libri rubati,
e che oggi invece è conosciuto come il sondaggista di Porta a Porta. «Sì,
rottamateci tutti» ha risposto Renato Mannheimer, pur difendendo le «innovazioni
che il Sessantotto ha portato in Italia».
Uno che si sente ancora un
sessantottino è Toni Negri, intellettuale, militante e ideologo della sinistra
extra-parlamentare tra gli anni ’60 e ’80. In una recente intervista ha detto
che «il Sessantotto ha fatto saltare tutti gli equilibri», e per questo gli si è
risposto con una cultura reazionaria che ancora oggi lo odia e rifiuta. Ma non
ci sono solo i nostalgici.
Critici e detrattori si
rincorrono non solo in Italia, ma anche Oltralpe. Come Michel Houellebecq che,
nel romanzo “Le particelle elementari”, descrive il ’68 come l’anno della
catastrofe, che ha lasciato solo miseria, individualismo e violenza: un’uscita
che non gli è ancora stata perdonata. E assai critica è stata anche la recente
rilettura dell’anno da parte di Papa Francesco: parlando agli ambasciatori i cui
Paesi hanno rappresentanza presso la Santa Sede, il pontefice ha detto che «in
seguito ai sommovimenti sociali del Sessantotto, l’interpretazione di alcuni
diritti è andata progressivamente modificandosi, così da includere una
molteplicità di nuovi diritti, non di rado in contrapposizione tra loro». Col
rischio di una «colonizzazione ideologica dei più forti e dei più ricchi a danno
dei più poveri e dei più deboli».
La provocazione: il 1968 è
stato l'anno in cui è nato il rancore.
La contestazione chiedeva più
politica. Invece ha prodotto la crisi, più egoismo, la rabbia di oggi. Uno
storico apre il dibattito, scrive Giovanni Orsina il 18 gennaio 2018 su
"L'Espresso". Il Sessantotto compie mezzo secolo in un periodo nel quale la
politica è in grande difficoltà. I segnali sono numerosi, e si presentano in
quasi tutte le democrazie avanzate: dalla presidenza Trump alla Brexit, dalla
scarsa partecipazione alle elezioni francesi al successo elettorale di
Alternative für Deutschland e allo stallo politico in Germania, per arrivare
all’infelice condizione della vita pubblica nostrana. Questi sono – appunto –
segnali: non cause, ma sintomi d’una crisi storica. Il cinquantenario del
Sessantotto ci dà l’occasione per chiederci quale sia il rapporto fra gli eventi
di mezzo secolo fa e il travaglio politico dei nostri tempi. La risposta è che
un rapporto non soltanto c’è, ma è stretto: il Sessantotto è uno snodo cruciale
d’una vicenda pluridecennale che pare esser arrivata oggi alla sua piena
maturazione. Ma come - si obietterà -, un anno stracolmo di politica come il
1968 diviene parte d’una storia che si conclude, sia pure cinque decenni dopo,
con una crisi della politica? In effetti, nelle democrazie occidentali la
contestazione sessantottina nasce anche dal desiderio di ribellarsi contro i
limiti ch’erano stati imposti alla politica dopo il 1945. Il desiderio di
ribellarsi contro il principio secondo cui alcuni àmbiti - a partire dalla vita
famigliare - dovevano esser tenuti il più possibile separati dai conflitti
pubblici. Al contrario: «il privato è politico!». Il desiderio di ribellarsi
contro i limiti che le tecnocrazie e l’“oggettività” scientifica imponevano al
pieno dispiegarsi della volontà umana di cambiamento. Al contrario: «vogliamo
tutto!»; «siate realisti, chiedete l’impossibile!». Il Sessantotto, insomma,
vuole più politica: la produzione d’uno sforzo di trasformazione collettiva
profondo, radicale, impaziente d’ogni limite in estensione o intensità. Questo
desiderio di azione collettiva, tuttavia, monta in un momento nel quale le
grandi ideologie che avrebbero potuto orientare quell’azione sono ormai o del
tutto defunte, o in profonda crisi. A cominciare dalla più rilevante fra di
esse. Il marxismo, in una forma o nell’altra, è l’ideologia portante della
contestazione sessantottina. Ma in quegli anni è già irrimediabilmente colpito
dalla degenerazione del socialismo reale, e forse ancor di più dal successo
delle economie capitalistiche occidentali, che ne falsifica una delle profezie
cruciali: la proletarizzazione universale. Alla crisi dei grandi progetti di
emancipazione collettiva fa da controcanto l’affermazione crescente del
desiderio di emancipazione individuale: se non possiamo essere liberi insieme,
almeno che lo sia io! Non per caso, uno dei pensatori più influenti del
Sessantotto è Herbert Marcuse, intento a superare lo stallo del marxismo
immaginando che il desiderio individuale possa fungere da leva rivoluzionaria.
Se non che, il desiderio di liberazione individuale è destinato a entrare in
conflitto col desiderio di liberazione collettiva - ossia con la politica.
L’azione collettiva richiede organizzazione e disciplina: subordinazione delle
aspirazioni personali agli scopi comuni. E tanto più ne richiede, quanto più
ambiziosi sono i suoi obiettivi. Lo mette in evidenza già all’epoca uno dei
critici più acuti del Sessantotto, Augusto Del Noce, parlando proprio di
Marcuse: «una rivoluzione antipuritana è quel che egli sa proporre: un vero
ferro di legno, per una ragione storica intrinseca … che il motivo puritano è
essenziale a ogni posizione rivoluzionaria seria … Marcuse può perciò essere
definito come il filosofo della decomposizione della rivoluzione». Là dove per
“puritanesimo” bisogna intendere appunto la negazione di se stessi, dei propri
desideri individuali, in vista d’un obiettivo rivoluzionario da raggiungere
tutti insieme. Questa contraddizione è una delle ragioni, e non la minore, per
le quali la contestazione sessantottina non riesce a dar vita a un movimento
politico ampio e robusto, ma si disperde in mille rivoli ideologici l’un contro
l’altro armati; o si riduce a perseguire l’azione per l’azione, magari violenta;
oppure finisce riassorbita nei partiti della sinistra tradizionale. La
contraddizione del resto era ben presente già ai protagonisti dell’epoca – a
Rudi Dutschke, ad esempio, a Daniel Cohn-Bendit. Una delle organizzazioni più
importanti del Sessantotto tedesco, la Lega degli studenti socialisti, si
scioglie nel 1970 perché «se la liberazione della società non è possibile qui e
ora», la Lega «dovrebbe almeno garantire democrazia ed emancipazione nel proprio
ambito». Deve insomma emanciparsi da se stessa. Fra le due anime del movimento
studentesco, quella marcusiana e quella stalinista, nel breve giro di qualche
anno finisce così per prevalere largamente la prima, notava nel 1980 Nello
Ajello in un libro dal titolo assai indicativo: “Il trionfo del privato”. È un
Marcuse depoliticizzato, però: non la soddisfazione del desiderio individuale
come strumento di rivoluzione politica - ma la soddisfazione del desiderio
individuale punto e basta. La vicenda di «Lotta Continua», che Ajello analizza
nelle pagine citate, mostra bene questo passaggio: intorno alla metà degli anni
Settanta il giornale diventa «l’organo più rappresentativo di una mentalità
giovanile di sinistra nella quale il conflitto fra “privato” e “politico” si sta
concludendo con una larga vittoria del primo». Così scrive in quegli anni un
lettore al giornale: «Siate realisti, domandate l’impossibile, dicevano i
compagni del maggio francese. Bene, noi vogliamo essere felici». Nello stesso
torno di tempo, secondo la studiosa americana Kristin Ross, si modifica la
memoria del Sessantotto francese: del suo contenuto politico si perde il
ricordo, mentre le sue componenti esistenziali e culturali si dilatano fino a
occupare tutta la scena. La politicità del Sessantotto si scioglie quindi nel
giro di pochi anni nell’affermarsi dell’individualismo? Piano: magari fosse così
semplice. La spinta alla liberazione personale che cresce a partire dai tardi
anni Sessanta - in forma come s’è detto prima politica e poi impolitica - ha
comunque degli effetti politici di rilievo. Vediamo quali.
La politica “ufficiale”
affronta quella spinta con «moderazione ragionevole» (l’espressione è dello
storico britannico Arthur Marwick): ossia, dove possibile, cede alla pressione.
Sia sul piano retorico: il socialdemocratico Willy Brandt, Cancelliere tedesco
dal 1969, promette un «nuovo inizio», e di «osare più democrazia»; il liberale
Valéry Giscard d’Estaing, Presidente francese dal 1974, dichiara di volere una
«democrazia liberale avanzata». Sia - e soprattutto - sul piano pratico: gli
anni Settanta, com’è ben noto, sono caratterizzati da un processo imponente di
ampliamento dei diritti individuali, sia civili sia sociali, in tutte le
democrazie avanzate.
Il desiderio diffuso di
liberazione individuale e la scelta della politica “ufficiale” di soddisfarlo
generano però dei contraccolpi. Tanto più che i diritti sociali costano, e che
negli anni Settanta giunge al termine la straordinaria crescita economica
postbellica. Politologi come Michel Crozier, Daniel Bell, Samuel Huntington
cominciano a chiedersi quanto a lungo possa sostenersi una democrazia se
l’elettorato chiede troppo. Al di là e al di qua dell’Atlantico studiosi e
intellettuali come Christopher Lasch, Richard Sennett, Gilles Lipovetsky
denunciano l’involuzione dell’“individuo desiderante” in un “narcisista”
incapace di distinguere fra se stesso e la realtà; disconnesso da un passato e
incapace d’immaginare un futuro; sovreccitato, autoreferenziale, e in definitiva
profondamente infelice. Da grande scrittore e giornalista, nel 1976 Tom Wolfe
fornisce un ritratto straordinario di questo narcisista in “The “Me” Decade”, Il
decennio dell’Io. In Italia Augusto Del Noce, Nicola Matteucci, Gianni Baget
Bozzo, fra gli altri, evidenziano i limiti e le contraddizioni della società
«permissiva» o «radicale».
Di fronte al montare della
“democrazia del narcisismo”, quella stessa politica “ufficiale” che ha ceduto
alla pressione individualistica deve cominciare a tirare il freno. Non può però,
o non vuole, affrontare direttamente gli elettori, prendendosi la responsabilità
di dir loro con chiarezza che la festa è finita, e correndo magari il rischio di
dover pagare il prezzo della propria sincerità. Fa allora in modo che i
cittadini si trovino di fronte dei muri di altra natura, tecnica e non politica:
le banche centrali, le autorità indipendenti, le istituzioni economiche
internazionali, il sistema monetario europeo. E naturalmente - soprattutto a
partire dal 1979-80, con l’ascesa al potere di Margaret Thatcher e Ronald Reagan
- il mercato. Che è un Giano bifronte straordinario: da un lato, col
moltiplicarsi dei consumi, soddisfa il narcisismo; dall’altro gli impone la dura
disciplina della concorrenza. Reagan guarderà soprattutto alla faccia della
gratificazione; Thatcher a quella del rigore: «l’economia è il metodo», dirà,
«l’obiettivo è cambiare l’anima della nazione».
Sia quando cede alla richiesta
di maggiore emancipazione individuale, sia quando demanda alle tecnocrazie o al
mercato il compito di arginarla, tuttavia, la politica sega il ramo sul quale
sta seduta. La politica infatti è azione collettiva: ma come potrà mai
ricomporre la società individualistica che essa stessa contribuisce
continuamente a frammentare? E la politica è esercizio del potere: ma quale
potere potrà mai esercitare, se ha contribuito a trasferirne una buona parte a
organismi non politici, nazionali e internazionali? A partire dai tardi anni
Ottanta, poi, nelle democrazie avanzate la destra e la sinistra convergono in
una sorta di “grande centro” ideologico fatto di diritti (il contributo della
sinistra) e di mercato (il contributo della destra) - ma incardinato in tutti i
casi sull’individuo. Anche il conflitto politico, così, deperisce. E gli
elettori cominciano a chiedersi quali siano le loro reali possibilità di scelta.
Alcuni studiosi - Ronald
Inglehart, Ulrich Beck, Anthony Giddens - già dalla metà degli anni Settanta
hanno cominciato a immaginare la ricomposizione politica del caleidoscopio
individualistico: individui “riflessivi”, ossia capaci di generare da se stessi
la propria identità, avrebbero costruito liberamente e creativamente delle nuove
aggregazioni collettive. Ora, è vero che da ultimo, nella nostra epoca, la
politica si sta ricomponendo. Solo, lo sta facendo in una maniera ben diversa da
come immaginavano quegli autori. Altro che individui riflessivi: cittadini
convinti che la politica della liberazione individuale non li protegga più da un
mondo sempre più complesso e incontrollabile si rifugiano nell’ultima ridotta
identitaria possibile - l’identità del luogo di nascita -, aderendo a partiti
sovranisti o localisti. Oppure costruiscono un’identità collettiva nuova, ma
negativa, mescolando finalità e provenienze assai diverse in un calderone
comune: il rancore contro quelli che a loro avviso dovrebbero proteggerli, e non
lo fanno.
Il conflitto politico rinasce
così fra Clinton - figlia del Sessantotto, per tanti versi - e Trump. Fra
l’establishment politico che ha gradualmente preso forma negli ultimi
cinquant’anni, il “grande centro” individualistico dei diritti e del mercato, e
che non riesce a mantenere la promessa universale di emancipazione individuale
dalla quale trae la propria legittimità. E quelli che, per ragioni economiche o
culturali, denunciano il fallimento di quel grande centro e lo combattono.
Per parte loro, questi ultimi
non sanno davvero quali alternative proporre - e quando ne propongono, sono o
assai poco desiderabili o del tutto irrealistiche. Siamo sicuri però che questa
mancanza di realismo sia un ostacolo sulla via del successo politico? Uno che
delle contraddizioni della modernità qualcosa aveva pur capito, Fëdor
Dostoevskij, già un secolo e mezzo fa scriveva: «“Abbiate pazienza, - vi
grideranno, - rivoltarsi è impossibile; è come due per due fa quattro! La natura
non vi consulta; non gliene importa nulla dei vostri desideri e se vi piacciano
o non vi piacciano le sue leggi …”. Signore Iddio, ma che me ne importa delle
leggi naturali e dell’aritmetica, quando per qualche ragione queste leggi e il
due per due non mi piacciono? S’intende che questa muraglia non la sfonderò col
capo, se davvero non avrò la forza di sfondarla, ma nemmeno l’accetterò,
solamente perché ho una muraglia davanti e le forze non mi sono bastate». In
fondo, è un altro modo per chiedere l’impossibile.
Sorpresa: il ’68 è stato
liberale. Al
di là degli slogan marxisti, le proteste giovanili hanno cambiato la società
soprattutto nella cultura e nei costumi, scrive il 19 novembre 2017 Bernardo
Valli su "L'Espresso”. Il 1968 è stato ricco di avvenimenti e nel 2018, ormai
alle porte, le rievocazioni per il cinquantenario non mancheranno. Comincio in
anticipo. L’occasione mi è offerta dalla discussione aperta a Parigi
sull’opportunità di celebrare, come movimento liberale (non libertario)
l’esecrato o mitico Maggio ’68 e dal trovarmi in questi giorni a Praga, dove
mezzo secolo fa fui testimone dell’effimera “Primavera”. L’anno debuttò con la
grande speranza emersa sulle rive della Moldava. Era il 5 gennaio, giorno della
nomina a segretario del partito di Alexander Dubcek. In agosto arrivarono i
carri armati sovietici. Il tentativo di introdurre la democrazia nel comunismo
reale fallì, finì in tragedia, ma annunciò il funerale del repressore -
vincitore del momento. Il funerale ufficiale avvenne soltanto una ventina d’anni
dopo, con l’implosione dell’Urss, ma l’agonia senza ritorno iniziò nella
meravigliosa cornice di questa città che riscopro invasa dai turisti e dalle
pizzerie. Come nel ’38 la Cecoslovacchia era stata lasciata ai tedeschi di
Hitler, trent’anni dopo fu lasciata ai sovietici. Un piccolo prezioso paese è
una facile preda. L’America era impegnata altrove, in Estremo Oriente, dove
subiva l’offensiva del Têt. I suoi soldati, mezzo milione di uomini del più
potente esercito della Storia, scoprirono di avere i viet cong sotto il letto.
Fu la sorpresa di fine gennaio ’68, in occasione del capodanno vietnamita. Gli
americani riuscirono a neutralizzare l’attacco dei guerriglieri infiltratisi
negli alti comandi e nelle caserme, ma capirono che dovevano andarsene. È quello
che fecero quattro anni dopo. Il tempo per fare i bagagli. La grande armata,
vittoriosa nella Seconda guerra mondiale, non sarebbe stata sconfitta
militarmente, ma avrebbe dovuto presidiare per un tempo indeterminato il Sud
Viet Nam con cinquecentomila uomini. Oltre ai guerriglieri sotto il letto a
Saigon e a Hué, c’erano migliaia di manifestanti contro la guerra ogni giorno a
Washington e a New York. Tutto questo equivaleva a una sconfitta. Nel marzo
dello stesso anno, all’altra estremità del pianeta, nella Cuba di Fidel Castro,
veniva promossa un’“offensiva rivoluzionaria”, vale a dire una più ampia
collettivizzazione, tesa a colpire le attività della piccola borghesia urbana.
Il comunismo caraibico accentuava l’impronta sovietica. Sempre nel ’68 erano
ancora in piena attività le “guardie rosse” di Mao. La rivoluzione culturale,
cominciata due anni prima, fu una lotta interna per il potere, ma allora
appariva a molti giovani europei un fermento sociale che avrebbe condotto alla
nascita di un “uomo nuovo”. Tutti questi avvenimenti suscitavano entusiasmi,
illusioni, distorte visioni della realtà, e comunque alimentavano gli slogan
scanditi sui boulevard parigini. Le sponde della Senna erano il teatro di una
rivolta giovanile, poi seguita da scioperi operai, contro il potere, e in favore
di tutti i movimenti, dai maoisti ai viet cong, ai cubani, visti come esempi di
contropotere. Erano immagini lontane, quindi potevano essere idealizzate, in
contraddizione con il carattere libertario del maggio ’68. Libertario e al tempo
stesso liberale. Facevo allora la spola tra il Ponte Carlo sulla Moldava e il
Quartiere Latino in riva alla Senna. Erano le due facce dell’Europa. I giovani
cecoslovacchi non capivano l’opposizione a un regime democratico che era il loro
obiettivo; i giovani francesi non capivano l’opposizione a un regime che si era
liberato del capitalismo. Eppure gli uni e gli altri avevano in sostanza
obiettivi liberali. Ed è proprio questo aspetto che potrebbe essere ricordato
cinquant’ anni dopo. Lo slogan dominante sui boulevard era “proibito proibire”.
Lo stesso poteva essere scandito sulla piazza Venceslav. Ma là arrivarono i
carri armati. In vista del cinquantenario, a Parigi si discute appunto
sull’opportunità di celebrare il Maggio ’68, visto, al di là della rivolta con
tinte marxiste, come un movimento che ha favorito una nuova società più
liberale, una trasformazione culturale e politica. Insomma allora il vecchio
mondo fu ripulito da molte tradizioni e restrizioni. Rinnovò i costumi. Il
carattere libertario è svanito mentre quello liberale, nel senso autentico della
parola, ha lasciato le sue tracce.
SESSANTOTTO: quando invece
del populismo dilagò la rivolta,
scrive Piero Sansonetti il 7 gennaio 2018 su "Il Dubbio". È l’anno cruciale del
secondo 900. Una forma di populismo ma che niente ha a che vedere con quello di
oggi. Il 1968 è stato l’anno di svolta nella storia del dopoguerra, in tutto
l’Occidente, ma anche ad Est. In questi giorni sono usciti diversi articoli su
vari giornali (soprattutto sui giornali di destra) nei quali si chiede di
rinunciare alle commemorazioni. Benissimo, rinunciamo alle commemorazioni, ma
non vedo proprio perché non dovremmo cogliere l’occasione del cinquantesimo
anniversario per tornare a ragionare su quell’anno cruciale, che con la sua
intensità sociale e politica ha modificato il percorso della storia. È un anno
che non ha eguali nella seconda metà del novecento. Non ho mai capito perché,
almeno da un po’ di tempo, l’idea di parlare di storia, e soprattutto del nostro
recente passato, viene vista come una noiosa strampalatezza di un pugno di
nostalgici. Penso che sia esattamente il contrario: la voglia di dimenticare i
fatti che hanno influito sulle nostre vite – che hanno cambiato cultura,
abitudini, modo di pensare e di agire – è un desiderio un po’ da cretini. Ed è
forse una delle ragioni di un certo decadimento della nostra intellettualità,
che chiunque avverte. Il 1968 è stato un anno specialissimo per tre ragioni.
La prima è l’ampiezza della
rivolta che si è sviluppata in quell’anno contro le classi dirigenti e il
sistema. Il ‘ 68 travolse gli Stati Uniti d’America, squassò l’Europa
occidentale democratica, ma ebbe delle ripercussioni eccezionali anche nel mondo
comunista e persino nei paesi autoritari di destra, come la Spagna, il
Portogallo e alcuni paesi dell’America Latina.
La seconda ragione è il
carattere generazionale della rivolta, che non solo non fu un limite ma, al
contrario, moltiplicò la potenza del fenomeno, proiettandolo nel futuro.
La terza ragione è lo
“spirito” originario del ’68, che poi negli anni seguenti si frantumò, in parte
si ribaltò, comunque si spezzettò in mille rivoli, che portarono su sponde anche
molto lontane. Lo “spirito” originario del ’68 è stato la contestazione delle
gerarchie, e dunque del meccanismo essenziale che aveva governato il mondo fino
a quel momento, e che regolava il potere, la distribuzione della ricchezza, i
rapporti tra uomini e donne, la religione, la famiglia, la scuola, il sapere. La
forza del ‘68 non risiedeva tanto nella improvvisa violenza della sua azione, e
della sua contestazione, ma nella potenza rivoluzionaria di quel messaggio, che
era qualcosa di molto più complesso delle vecchie rivendicazioni anarchiche. Ci
sono migliaia di slogan del ’68. Molto diversi tra loro. Alcuni truculenti. (Ne
ricordo uno che gridavamo spesso ai cortei: “È ora di giocare col sangue dei
borghesi…”). Ma il vero slogan che riassume l’anima di quella rivolta è lo
slogan più famoso del maggio francese: «E vietato vietare». Il ‘68 inizia come
grandioso fenomeno libertario. Poi si piega su se stesso, si aggroviglia, e in
moltissime sue espressioni ha un rinculo stalinista e autoritario. Se però
immaginiamo il ‘68 solo come fenomeno di violenza politica e come anticamera
della lotta armata, capiamo pochissimo di quello che è successo e di perché il
‘68 ha dilagato in territori molto lontani dal gruppetto di studenti e di
intellettuali che lo innescò. Fino a coinvolgere, ad appassionare, e talvolta a
travolgere pezzi molto vasti di classe operaia ma anche di borghesia moderata.
Gli effetti più clamorosi del ’68 furono lo spostamento molto sensibile del
senso comune conservatore, che ruppe gli argini, perse i punti di riferimento e
le paure.
Fu un fenomeno populista?
Certamente lo fu, ma quello sessantottino è un tipo di populismo di segno
opposto a quello che conosciamo oggi. Oggi il populismo è una declinazione
del qualunquismo, dell’antipolitica, della paura, anche dell’ignoranza. Non
possiede nessuno spessore ideale, è chiuso in se stesso è rancoroso. Allora fu
un fenomeno opposto: impegnato, molto politico, colto, con una componente
fortissima – qui in Italia – di tipo cattolico, influenzata dalle grandi novità
del Concilio. In comune con il populismo di oggi ha solo la domanda di rottura.
Le risposte a questa domanda, però, sono opposte. Così come, in politica, sono
opposte le spinte rivoluzionarie e quelle reazionarie. Il 1968 nasce sicuramente
in America. Dove la rivolta dei neri e degli hippy era iniziata diversi anni
prima. Aveva incendiato le città, i ghetti, i campus universi- tari. Aveva
spinto possentemente a sinistra il kennedismo, che era nato come proposta di
leggero e moderatissimo cambiamento e invece, con Bob Kennedy, aveva finito per
avvicinarsi moltissimo al punto della rivolta. E però, curiosamente, se andiamo
a controllare le cronologie, ci accorgiamo che il primo atto storico del
sessantotto avviene all’Est. Precisamente il 5 gennaio (giusto ieri era il
cinquantenario) con l’elezione di Alexander Dubcek alla segreteria del partito
comunista cecoslovacco. Dubcek, 46 anni, intellettuale raffinato ma con un lungo
passato di funzionario di partito, aveva riunito intorno a sé un gruppo di
giovani intellettuali quarantenni ed era riuscito a scalzare dal potere il
vecchio Antonio Novotny, uomo legatissimo a Mosca. Iniziò così, in pieno
inverno, la Primavera di Praga, e cioè un periodo di riforme e di grande
mobilitazione politica, con un vastissimo sostegno popolare, che fu il più
robusto e organico tentativo di ristrutturazione del socialismo. Dubcek, spinto
dal vento libertario del sessantotto, introdusse il concetto di libertà come
valore fondante del progetto socialista. E questa non era una modifica, o un
aggiustamento: era il ribaltamento del castello ideologico costruito da Lenin in
poi. Dubcek si convinse che i valori di libertà ed eguaglianza non sono valori
in competizione ma possono integrarsi perfettamente. E’ impossibile immaginare
oggi cosa sarebbe successo se il tentativo di Dubcek non fosse stato represso in
modo brutale, e in parte inaspettato, dalle forze armate sovietiche. Cosa
avrebbe portato, all’umanità, una competizione equilibrata tra capitalismo
rooseveltiano e socialismo democratico. Non lo sapremo mai.
Il tentativo durò meno di otto
mesi. La notte tra il 20 e il 21 agosto le truppe del patto di Varsavia
entrarono a Praga. Dubcek, insieme a Ludvick Svoboda, che era il presidente
della Repubblica, fu portato a Mosca per chiarimenti, e poi deposto. Lo
mandarono a fare l’impiegato in un ufficio, e riemerse solo dopo la caduta del
Muro di Berlino. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, nel 1990. Era in visita in
Italia e volle venire a cena con noi giornalisti dell’Unità, che lo avevamo
intervistato un paio d’anni prima, quando era ancora in semi- clandestinità.
Serio, timido, ma anche molto spiritoso e persino autoironico. Mi ricordo che ci
raccontò una barzelletta forse non spiritosissima in assoluto, ma devastante
perché raccontata da lui. La sintetizzo molto, perché era lunghissima: C’è una
coppia che dorme a Praga la notte del 20 agosto. A un certo punto lei si sveglia
e chiama il marito. Gli dice: “Ehi, cos’è questo sferragliare di camionette qui
sotto casa?”. “Niente”, risponde lui, “sarà il mercato, ora dormi!”. Dopo
mezz’ora lei lo sveglia ancora: “Ehi, sento dei colpi di cannone…”. Lui di nuovo
la tranquillizza: “Sono tuoni, amore, dormi…”. Alle quattro del mattino la
signora si affaccia alla finestra e grida: “Ci sono i carrarmati qui sotto, ci
hanno invaso! ”. Lui resta tranquillo: “non aver paura, poi verranno i sovietici
e ci libererano…”. E già, l’invasione fu una sorpresa. Non solo Dubceck era
convinto che nel nuovo clima del ’68 i sovietici non avrebbero osato. Anche
perché, nonostante tutto, Dubceck considerava i sovietici degli amici. Invece
l’invasione ci fu e gelò il mondo. E’ vero che il ’68 fu un fenomeno
essenzialmente occidentale. Ma se dovessimo mettere due date al suo inizio e
alla sua fine, e cioè alla parabola del sogno sessantottino, prima che il ’68 si
trasformasse, si incattivisse e in parte degenerasse, le date sono quelle lì di
Dubcek: 5 gennaio e 20 agosto. E’ lì, quella notte, che finisce il sogno. Non
solo dei cecoslovacchi, ma di tutti. Cioè di tutti quelli – americani, russi,
polacchi, europei…- che avevano sperato nella riformabilità del potere.
L’impermeabilità del socialismo alle riforme era lì a dimostrare questo: il
potere non accetta di essere messo in discussione, tantomeno di mettersi in
discussione da solo.
In Italia il ’68 inizia invece
con un fatto tragico e che non ha molto a vedere, almeno all’inizio, con la
politica: il terremoto del Belice. Avvenne nella notte tra il 14 e il 15
gennaio, provocò circa 300 morti e rase al suolo decine di paesi della provincia
di Trapani e di Agrigento. Gibellina scomparve. Ma adesso procediamo con la
cadenza della cronologia. In ordine sparso 31 gennaio. In Vietnam inizia
l’offensiva del Tet. Il Tet è il capodanno vietnamita. I vietcong e l’esercito
del Nord, guidato dal mitico generale Nguyen Giap (che 15 anni prima aveva
sbaragliato i francesi a Dien Bien Phu) attaccano tutte le principali città del
Sud Vietnam. Muovono 800 mila uomini armati. E’ un successo militare clamoroso.
Americani e Sudvietnamiti, sgomenti, reagiscono con ferocia. Il primo marzo, a
Saigon, un generale sudvietnamita giustizia per strada, davanti al fotografo, un
guerrigliero vietcong. La foto diventa famosissima.
1 marzo. E’ la vera e propria
data d’inizio del 68 italiano. La battaglia di valle Giulia. Gli studenti
attaccano la polizia che presidia la facoltà di Architettura, a Roma. Inizia un
pomeriggio di fuoco. La polizia non si aspetta l’iniziativa spregiudicata e per
molte ore non riesce a contenere la furia degli studenti. Guidati da Oreste
Scalzone, da Sergio Petruccioli, da Massimiliano Fuksas, da Franco Russo. E con
tanti ragazzini che non hanno nemmeno 18 anni, tra i quali i fotografi
immortalano Giuliano Ferrara, figlio di Maurizio, direttore dell’Unità.
16 marzo. Una pattuglia di
militanti del Msi, guidati da Giorgio Almirante, tentano di attaccare la facoltà
di lettere, occupata dai “rossi”. Vengono messi in fuga, si rifugiano a
Giurisprudenza, si barricano e tirano dal quarto piano un banco sui ragazzi che
assediano la facoltà. Il banco prende in pieno il leader degli studenti, Oreste
Scalzone, che è ridotto in fin di vita (si salverà ma porterà i postumi della
botta per tutta la vita). Lo stesso giorno gli americani compiono in Vietnam
l’azione più orrenda di tutta la guerra. Un gruppetto di marines, guidati da un
certo tenente Calley, rade al suolo un piccolo paese (My Lai) e inizia a
torturare e ad uccidere, uno ad uno, tutti gli abitanti. Ne manda al creatore
450, poi, all’improvviso, irrompe sulla scena un elicottero guidato da un
giovane sottufficiale americano molto coraggioso. Si chiama Hugh Thompson.
Atterra, imbraccia un bazooka e si frappone tra i marines e i vietnamiti. Punta
il tenente Calley e gli dice: o vi ritirate o ti ammazzo. La spunta. Salva un
centinaio di superstiti. La strage però viene nascosta per due anni, poi la
scopre un giornalista dell’Associated Press. C’è un processo. Calley si prende
l’ergastolo ma Nixon lo grazia.
4 aprile. A Memphis, in
Tennessee, dove era andato per tenere un comizio, viene abbattuto con una
fucilata Martin Luther King, il capo della rivolta pacifica nera. Tre anni prima
era stato ucciso, a New York, Malcolm X, il capo della rivolta nera violenta. La
morte di King scatena un’ondata di violenza nei ghetti. Molte decine di morti.
11 aprile. Dopo King è un
altro leader del ‘ 68 a prendersi una revolverata: Rudy Ducke. E’ il capo degli
studenti tedeschi. E’ un agitatore, un combattente, ma anche un intellettuale
molto sofisticato. Gli sparano alla testa. Si salva, ma resta molte settimane
tra la vita e la morte. Non si riprenderà mai del tutto, e morirà dopo dieci
anni, per i postumi delle ferite.
Il 10 maggio parte la Francia.
E il sessantotto raggiunge l’apice. Occupata la Sorbona. Scontri fino a notte
nel quartiere latino.
13 maggio: un corteo immenso
di studenti invade Parigi. Ci sono pure gli operai. Il movimento è guidato da un
ragazzetto franco- tedesco, di appena 20 anni, che si chiama Daniel Cohn Bendit.
Il ragazzo, Dany il rosso, fa tremare De Gaulle, il gigantesco De Gaulle, e fa
temere che la rivoluzione sia davvero alle porte.
Il 5 giugno a Los Angeles
viene ucciso Bob Kennedy. Stava per festeggiare il successo alle primarie della
California. Era difficile che ottenesse la nomination, perché era partito troppo
tardi, ma qualche speranza c’era. Kennedy ormai era diventato uno dei leader
mondiali del 68, se avesse vinto, e avesse poi battuto Nixon, chissà come
sarebbe andata la storia del mondo. Invece fu ucciso da un ragazzetto arabo di
24 anni. Che sta ancora in galera. Si chiama Shiran Shiran.
Del 20 agosto abbiamo già
parlato, con la mazzata di Breznev e la fine della primavera di Praga.
Il 2 ottobre a città del
Messico ancora gli studenti in piazza. La polizia spara in piazza delle Tre
Culture, ne uccide cento. Un massacro che scuote il mondo, che ha gli occhi
puntati sul Messico perché lì stanno per iniziare le Olimpiadi. Negli scontri
resta ferita gravemente la giornalista italiana Oriana Fallaci.
13 ottobre. A Città del
Messico iniziano le Olimpiadi. In un clima cupo e di conflitto.
17 ottobre. Tommie Smith,
atleta nero americano, vince la medaglia d’oro sui 200 metri piani. Terzo arriva
John Carlos, anche lui afroamericano. I due salgono sul podio della premiazione
e alzano al cielo il pugno con un guanto nero. E’ il saluto dei Black Panther.
Tutte le televisioni del mondo trasmettono questa scena. Nei quartieri neri
americani è il delirio di entusiasmo.
Il 5 Novembre Richard Nixon
viene eletto presidente degli Stati Uniti. Ha sconfitto Hubert Humphrey,
vicepresidente uscente e rappresentate molto moderato del partito democratico.
La Casa Bianca, dopo 8 anni, torna ai repubblicani. Simbolicamente è una
vittoria della restaurazione. In realtà negli Usa non cambia molto. Nixon è un
falco in politica estera e una colomba in politica interna. Come Lyndon Johnson,
il suo predecessore che ha lasciato le penne in Vietnam. La vera svolta
conservatrice, in America, avverrà solo 12 anni dopo, con Ronald Reagan.
2 dicembre. Ancora sangue in
Italia, Stavolta ad Avola, Sicilia. La polizia spara sui contadini che occupano
le campagne. Due morti, molti feriti, molta rabbia, molti arresti.
Manifestazioni di protesta in tutt’Italia.
31 dicembre. Il ‘68 se ne va
con un’altra sparatoria. Alla Bussola, night club di Viareggio, gli studenti
attaccano lanciando uova e pomodori sulle pellicce di quelli che festeggiano
(come era successo tre settimane prima alla Scala di Milano). La polizia
interviene. Si scatena la guerriglia. Tra gli studenti c’è il leader di Lotta
Continua, Adriano Sofri, e c’è anche uno studentello diciottenne della Normale
di Pisa, che si chiama Massimo D’Alema. La polizia spara di nuovo. Un ragazzo di
17 anni, Soriano Ceccanti, è colpito alla schiena. Ancora oggi, Soriano sta in
carrozzella, è rimasto paralizzato.
Che c’entra il ‘68 con i
prof che chattano con gli studenti?
Scrive Luciano Lanna il 20 gennaio 2018 su "Il Dubbio". Delle due l’una: o ci si
rapporta criticamente con gli insegnanti e i genitori oppure si fanno saltare i
confini generazionali. Nel 1968 s’era diffusa una massima che venne
spontaneamente assunta a slogan dello spirito di quell’anno di trasformazioni:
«Non fidarti di nessuno che abbia più di trent’anni». Era un monito ironicamente
offerto come consiglio da Charlton Heston ai giovani e ribelli scimpanzé nel
grande successo hollywoodiano di quell’anno, Il pianeta delle scimmie. Uno
slogan che si trasformò via via in una modalità esistenziale e in un rapporto
nuovo rapporto, dialettico e critico, nelle relazioni tra generazioni. Anche per
questo non capiamo come si possa sostenere – l’abbiamo letto sul Messaggero a
firma Marina Valensise, una giornalista e studiosa peraltro documentata e
sofisticata – l’esistenza di un nesso tra alcune recenti denunce di molestie e
abusi a scuola, in particolare relativi a casi riguardanti sconfinamenti in
questa direzione tra professori e allievi, e la cultura del ’ 68. La quale,
filologicamente, si muoveva semmai verso un altro orizzonte: quello della
diffidenza o della messa in discussione critica rispetto alla presunta
autorevolezza delle generazioni precedenti. Cosa c’entra, insomma, il non
fidarsi più a scatola chiusa e il cominciare a verificare criticamente i
rapporti con gli adulti, fossero essi genitori, professori, politici, che è uno
dei portati storicamente più importanti del ’ 68, con quella «deriva erotico-
sentimentale che abolisce ogni barriera tra docenti e discenti, confonde i
confini tra un professore e l’allievo, travolge ogni limite di sicurezza,
scardinando gli argini del rispetto umano e professionale»? Delle due l’una: o
ci si rapporta criticamente con gli insegnanti e i genitori oppure, è il caso
opposto, si fanno saltare i confini generazionali e si ipotizza come normale che
con un docente si possa chattare come se si trattasse di un coetaneo.
Come tanti altri, sia ben
chiaro, Marina Valensise mostra di non avere dubbi: «Abolire – scrive – la
cortina del rispetto, squarciare il velo un tempo invalicabile che dovrebbe
separare maestri e allievi è l’ennesimo frutto marcio prodotto dal ’ 68 e dalla
cultura del ’ 68». Mostrando così di seguire la vulgata ormai egemone, e diffusa
da anni a destra, a sinistra e al centro, secondo cui il Sessantotto – anno che
viene trasformato in un feticcio, in una entità ideologica – da anno cronologico
si trasforma nell’origine di tutti i mali, sociali, antropologiche, culturali.
Nient’altro che in un’utopia, «inservibile e obsoleta – leggiamo ancora
sul Messaggero – che in nome dell’uguaglianza, del ripudio delle forme, della
guerra alla gerarchia e alle differenze ha finito per logorare la vita pubblica,
privando il corpo sociale dei suoi anticorpi e delle valvole di sicurezza
necessarie al suo funzionamento».
Niente di nuovo, in realtà. È
la solita e trita litania sulla rovina della scuola, sul tramonto del principio
di autorità, sulla fine della famiglia borghese, sull’eclisse della
meritocrazia. Quando invece, e la storia stessa lo attesa, il ’ 68 fu più che
altro la messa in discussione e lo scoperchiamento di tutta l’ipocrisia che
aleggiava nella percezione vissuta di queste dimensioni sociali.
Non ci stupiamo comunque del
fatto che la pubblicistica sia ricaduta nella ripetizione di questa lettura. Sin
dal primo decennale, nel 1978, e a proseguire nei tre seguenti anniversari
tondi, non è mancato il profluvio di lamentazioni postume all’insegna della
massima “da allora tutto non fu più come prima”. Con il sospetto che davanti
alle solite esortazioni del tipo “finiamola col sessantottismo”, “è tempo di
archiviare la cultura del ’ 68”, sia più che legittimo il dubbio che in realtà
si voglia parlar d’altro senza averne il coraggio e senza lo sforza
dell’elaborazione di nuove categorie adeguate a interpretare la complessità dei
fenomeni a noi contemporanei. È la scorciatoia del pensiero pigro: è facile
trovare una causa generale per tutto ciò che non comprendiamo e di fronte a cui
ci troviamo spiazzati. È come il personaggio di Alberto Sordi che di fronte ai
suoi fallimenti diceva “io c’ho avuto la malattia” o “io ho passato la guerra”.
Sarebbe invece il caso, ora che siamo al cinquantenario, di “storicizzare”
finalmente il ’ 68, di raccontare cioè quell’anno, con tutte le sue “rotture”,
per quel che è stato veramente. E di smetterla di presentarlo come un feticcio
ideologico da utilizzare come causa di tutti i nostri mali.
Oltretutto, da allora è
passato mezzo secolo, un periodo così lungo e complesso, attraversato da altre
faglie e altri sommovimenti globali, che è davvero impossibile quando non
fuorviante individuare – come nel caso da cui siamo partiti – nei fatti del ’ 68
l’origine di fenomeni del tutto inediti e spiegabili solo con processi davvero
molto lontani da quell’anno. Cosa avrebbe a che fare, insomma, il chattare in
rete in una dimensione orizzonte e privata tra docenti e studenti e le eventuali
conseguenze con le intuizioni dell’anno vissuto all’insegna dell’immaginazione
al potere? Un anno denso di eventi rivoluzionari come il Vietnam e le proteste
contro la guerra, gli studenti contro la polizia a Valle Giulia, il Maggio
francese, la Primavera di Praga, gli assassini di Martin Luther King e Robert
Kennedy, le convenzioni per le elezioni americane che videro la vittoria di
Nixon, la nascita del femminismo… «Con stupore ed entusiasmo – annota Mark
Kurlansky nel fondamentale ’ 68. L’anno che ha fatto saltare il
mondo (Mondadori) – si scoprì che a Praga, a Parigi, a Roma, in Messico, a New
York, si stavano facendo le stesse cose. Grazie a nuovi strumenti quali i
satelliti per le telecomunicazioni e i videotape, la televisione stava rendendo
ognuno consapevole di quanto stavano gli altri. E questo era elettrizzante
perché, per la prima volta nell’esperienza umana, eventi importanti e remoti
erano vissuti in diretta». Questo, non altro, fu il ’ 68. Il professore che non
solo dà ai suoi allievi del tu, ma pretende che glielo diano anche a lui,
insieme con l’e-mail, al numero di cellulare e all’amicizia su Facebook per
poterli chiamare a tutte le ore del giorno e della notte non capiamo cosa
avrebbe dello “spirito del ’ 68”. Uno spirito che, semmai, muovendoci sul piano
dell’immaginario andrebbe storicamente visto nella presenza e nel ruolo di un
premio Nobel come Bob Dylan e di un intellettuale come Francesco Guccini nello
scenario odierno. Queste sì, due vere “lezioni” viventi del Sessantotto.
1977: LA RIVOLUZIONE
ANTICOMUNISTA.
Le date.
A Roma Luciano Lama,
segretario della Cgil, va all’università La Sapienza per un comizio. Viene
contestato dagli studenti e i giovani di Autonomia Operaia assaltano il palco e
costringono Pci e Cgil alla fuga. 17 febbraio 1977
Scontri all’università di
Bologna. Francesco Lorusso, venticinque anni, militante di Lotta Continua, viene
ucciso da un carabiniere. Seguono giorni di guerriglia urbana, Francesco
Cossiga, ministro degli Interni, invia i blindati per presidiare il centro della
città. Viene chiusa Radio Alice. 11 marzo.
A Roma la polizia sgombera
l’università occupata dall’Autonomia. Nella giornata scoppiano scontri nel
quartiere San Lorenzo, con lancio di molotov e colpi di pistola da parte dei
manifestanti contro la polizia. Viene ucciso l’agente Settimio Passamonti,
ventitré anni. 21 aprile.
A Roma durante una
manifestazione scoppiano scontri con la polizia nei quali resta uccisa Giorgiana
Masi, diciotto anni, studentessa. 12 maggio.
A Milano durante una
manifestazione di protesta per la morte di Giorgiana Masi scoppiano nuovi
scontri tra polizia e movimento. L’agente Antonio Custra, venticinque anni,
viene ammazzato da un colpo di pistola. 14 maggio
A Milano un gruppo di
brigatisti tende un agguato a Indro Montanelli. Viene colpito alle gambe con
otto colpi di pistola. 2 giugno.
A Bologna convegno contro la
repressione. Le diverse anime della contestazione si scontrano. C’è chi inneggia
alla lotta armata. Di fatto è la fine del movimento. 23-25 settembre.
A Torino agguato a Carlo
Casalegno, giornalista e vicedirettore de La Stampa. La colonna torinese delle
Brigate Rosse gli spara al volto: morirà il 29 novembre dopo tredici giorni di
agonia. 16 novembre
Tano D’Amico: «Gli anni
Settanta, la lotta, le pistole, l’invisibile».
Intervista di Cecilia Ferrara del 29 giugno 2017 su "Il Dubbio". Non è
facilissimo intervistare Tano D’Amico, il fotografo dei movimenti degli anni 70.
Non che non sia generoso e non si conceda, al contrario, ma non è un
intervistato docile, non risponde alle domande che vuoi tu e come vuoi tu,
divaga, non ti fissa un appuntamento perché dice di non sapere mai dove sarà:
«La gente pensa che io stia tutto il giorno a casa. Non è così». In questo caldo
mese di giugno però è stato possibile intercettarlo per quattro lunedì (il 3
luglio sarà l’ultimo appuntamento) da Zazie nel Metro, un bar del Pigneto a Roma
Est che ha organizzato “I lunedì dell’immagine”, quattro incontri con Tano
D’Amico per parlare di periferie, del ‘77 e del movimento delle donne. L’abbiamo
incontrato prima dell’appuntamento intitolato “E’ stato sconfitto il 77?” e da
prassi gli abbiamo chiesto cosa c’è stato prima degli anni Settanta, come ha
iniziato a fare il fotografo. Si è subito ribellato: «Via, smettiamola con
queste cose… – risponde irritato – Ti spiego: io ho sempre amato le immagini, ma
di qui a pensare di fare il fotografo come mestiere ce ne passa. Non l’ho mai
pensato, neanche negli anni Settanta. Semplicemente era il modo più adatto per
me per vivere e per vedere quello che stava davanti ai miei occhi perché si
formavano davanti a me immagini che non si erano mai viste. Io conoscevo un po’
la storia delle immagini e in quegli anni vedevo cose che non c’erano mai state.
Non solo, si iniziava a vedere un “ceto” che prima non c’era mai stato, per la
prima volta si affacciavano alla soglia della storia quelle persone che la
storia l’avevano sempre subita: le donne che erano sempre passate per minoranza,
i disoccupati, i senza casa, i carcerati, i pazzi, i senza potere».
Ha detto che ha iniziato a
vedere immagini che non aveva mai visto, che differenza c’è in questo tra il
Sessantotto e il Settantasette?
«Io
sorvolerei sul Sessantotto che è troppo celebrato. Quello che c’era prima e che
c’è stato dopo secondo me è più importante. Parlando di immagini che non avevo
mai visto: per prima cosa era come le persone scendevano in piazza. Sembrava che
comparissero tutte insieme, come se fosse passato prima qualcuno con un pennello
e una vernice magari bianca, avesse tracciato una linea e tutti si affacciavano
su quella linea senza bisogno di capi, di condottieri, si compariva tutti quanti
insieme. Quando scendevano tantissime persone in piazza, notavo che scendevano
per conoscersi, per parlarsi, molto più che per ascoltare uno che parla. Ecco,
persone che parlano insieme. Queste sono le mie prime immagini. C’è un momento
in cui sembra che tutti compaiano sul palcoscenico, per questo le mie foto sono
fortemente orizzontali, perché se è vero che ogni uomo e ogni donna è un
segmento verticale è anche vero che molti segmenti verticali insieme compongono
una linea orizzontale».
Un po’ come il Quarto Stato
di Pellizza da Volpedo insomma.
«Sì,
un po’ come il Quarto Stato, ma se mi posso permettere più bello».
Lei è stato testimone di
alcuni eventi fondamentali del ‘ 77…
«Come
tutti… diciamo che io ho fatto caso ad avvenimenti persone e cose che erano
sotto gli occhi di tutti, ma ognuno vede quello che vuole vedere nel modo in cui
lo vuole vedere. Comunque non è che ho lavorato in strada da solo. Le mie
immagini forse comparivano di più anche se pubblicate su giornali marginali, su
poster, stampate male. Ma la domanda vera è dove sono le foto della grande
stampa di 40 o 50 anni fa? Un grande giornale ha usato le mie immagini per
parlare del ‘ 77 ma le ha usate oggi, non le ha usate 40 anni fa».
Che immagini usavano 40
anni fa?
«Le
immagini che servivano a loro, immagini in cui chi scendeva in piazza compariva
come un mostro che minacciava la quiete pubblica, qualcosa di minaccioso. Le mie
immagini non trovavano spazio in nessun giornale, nemmeno il mio che era Lotta
Continua. Questo perché mostrare l’umanità, la bellezza delle persone che
scendevano in piazza era inviso a tutti. Tanto che venivo preso in giro dai miei
compagni in strada, ero diventato una macchietta perché lavoravo tutti i giorni
ma non si vedeva mai una mia immagine sul giornale. Allora c’era chi
affettuosamente mi diceva: “Tano ma ti ricordi di mettere il rullo la mattina
dentro la macchina? Ti sei accertato che i dentini abbiano agganciato il
rullino?». Fu un momento anche di riflessione sul ruolo delle immagini per
esorcizzare e quindi coprire la novità. Fotografare i movimenti è difficile, gli
aspetti di novità arrivano come dei lampi, bisogna coglierlo nelle linee dei
volti che cambiano, nei gesti, negli angoli delle membra. Chi fotografa i lampi
fotografa la novità, ma lo può fare solo se li aspetta. Se non li aspetta si
limita a fare foto di tenebra. La mia diversità si vide nei primi lavori sui
nuovi giornali. Potere operaio del lunedì, sembrò che non aspettasse altro che
il mio modo di vedere. Una mia immagine fu per un periodo la testata di Potere
operaio del lunedì ed era l’immagine di operai sardi che parlavano insieme. Era
su fondo bianco, sembrava quasi mi fossi portato dietro il fondale, perché gli
operai erano sulla riva del mare, aspettavano gli autobus su una strada in riva
al mare. Ecco anche in questo caso era come se fossero comparsi, tutti insieme,
su un palcoscenico».
Cosa successe quando
comparvero le pistole alle manifestazioni?
«Il
mio modo di fotografare era diverso anche nelle foto di documentazione: cercavo
che ci fosse di più. La cosa in più era il contesto, perché se uno mostra un
giovane che tira un sasso quel giovane si prende 5 anni, 7 anni. Non dico di
nascondere certe cose ma di imparare dai classici che hanno sempre mostrato
quello che accadeva – nella pittura, nella fotografia, nel cinema e nel teatro –
senza mandare nessuno in carcere. Serve studio e impegno. È necessario mostrare
il contesto, la bellezza delle istanze. C’è una mia fotografia molto gettonata,
quella della ragazza con il fazzoletto, che in quel fotogramma commette forse
tre reati insieme: ha un fazzoletto che copre il volto, resiste alla forza
pubblica ed è lei che mette la mano per “bloccare” la polizia. Ma nessuno si è
mai sognato di cercarla e di portarla in tribunale perché avrebbero ampliato la
bellezza delle sue istanze che erano quelle delle donne, in confronto a cui i
reati che stava commettendo erano ben poca cosa. Nelle mie immagini si è visto
di tutto, ma anche – m’illudo – tutto quell’invisibile che sono le motivazioni,
i perché, l’affetto che le tiene insieme. Per decenni ho occultato una mia
immagine, quella di Daddo e Paolo, perché pensavo di nuocere. Vent’anni dopo fu
lo stesso Daddo a rimproverami: «Dovevi farla uscire subito», mi disse. È vero
che da giovane dicevo sempre che una bella immagine non fa mai male, una cattiva
immagine fa sempre uno o più danni. Ma non mi sentivo di farlo con la vita degli
altri».
La foto in questione è
quella della manifestazione in piazza Indipendenza del 2 febbraio 1977 in cui
rimasero feriti due militanti di sinistra Leonardo “Daddo” Fortuna e Paolo
Tomassini e un poliziotto, Domenico Arboletti. Nella foto si vede Daddo che
solleva con un braccio il compagno già ferito come per portarlo via, con in mano
una pistola. Che momento fu quello?
«È
stata la nascita del ‘ 77. Per l’attacco che subirono. Quella di Paolo e Daddo
fu una risposta all’attacco di due agenti che non si sapeva fossero della
polizia: non avevano nessun contrassegno e di fatto volevano con la loro
macchina spezzare il corteo in due. Quando il corteo si è compattato e non ha
fatto passare l’automobile è sceso un signore con il mitra e un altro con una
pistola. Era il giorno dopo in cui i fascisti erano entrati nell’università e
avevano ferito uno studente, avere delle armi non era così strano.
Quell’immagine mostra due giovani che non volevano perdere, a nome di tutti
quanti, le conquiste passate che erano anche affettive, di solidarietà. Quando
vent’anni dopo comparve quell’immagine in un blog di Repubblica che si chiama
Fotocrazia fui attaccato duramente, però con citazioni di Omero (che aveva
raccontato un fatto simile), Virgilio, Tasso e Ariosto, insomma non era male».
Un’altra manifestazione
raccontata tantissimo per immagini è stato il G8 di Genova. Che paragone con il
‘ 77?
«Ecco
Genova 2001 dimostra come le immagini possono seppellire un avvenimento. Il modo
in cui si è visto l’omicidio, la morte in diretta di Carlo Giuliani. Quel modo
da “macchina” – come le telecamere piazzate al porto di Napoli che di tanto in
tanto riprendono un omicidio di camorra – ecco io penso che non faccia un buon
servizio all’umanità. Rappresenta l’abdicazione dell’essere umano a vantaggio
della tecnologia. Le immagini di Genova che cosa raccontano? Molte perpetuano il
terrore che la polizia e i carabinieri volevano imporre. E venendo all’omicidio
di Carlo Giuliani, dopo due anni che il video girava ovunque su internet, la
magistratura ha detto che i carabinieri hanno fatto un uso corretto delle armi
da fuoco. L’immagine che non è partecipata, l’immagine abdicata, l’immagine da
macchina non da essere umano non è capace di raccontare il contesto. La verità
non è mai nei verbali della polizia, nelle sentenze dei tribunali. La verità,
quella vera, che rimane nella memoria, è nei romanzi. La verità bisogna farla.
Non è qualcosa che esiste e che le macchine fedelmente riportano, troppo comodo,
non è così. La verità è una creazione dell’uomo, la più bella forse, ma in
natura non esiste, è l’uomo che la farà vedere mettendo insieme le cose,
mostrando il contesto. Una macchina questo non lo potrà mai fare, la verità è un
insieme di ricerche, una ricerca che non finisce mai che l’umanità può fare».
Sulle Onde di Radio Alice
correva il ’77 ribelle,
scrive Luciano Lanna l'8 Marzo 2017, su "Il Dubbio". Quarant’anni fa l’emittente
bolognese venne chiusa dalla polizia, arrestate le sue “voci”. La radio del
movimento studentesco interpretò il cambiamento della società dell’informazione
facendo saltare i vecchi schemi della militanza. Quarant’anni fa, il 12 marzo
1977, il giorno dopo l’uccisione a Bologna dello studente Francesco Lorusso, la
polizia fa irruzione nei locali di Radio Alice, li sigilla e arresta tutti gli
animatori. I media ufficiali avevano scatenato una vera e propria crociata
contro l’emittente, con l’accusa di essere stata la diretta responsabile degli
scontri violenti seguiti alla morte del giovane studente. Per dirla tutta, lo
studente, un 25enne militante di Lotta Continua, era stato freddato da un colpo
d’arma proveniente dalle forze dell’ordine dopo che una bottiglia molotov aveva
raggiunto un autocarro. Ma la morte dello studente dette origine a ulteriori e
pesanti scontri di piazza. Radio Alice aveva solo mandato in onda, come faceva
per tutto quello che accadeva in città, la cronaca degli eventi. Del resto, è
Umberto Eco, curiosamente attento ma spesso critico nei confronti dell’ala
creativa del ’ 77, a difendere la redazione della radio dalla campagna
denigratoria nei suoi confronti. Fatto sta che la chiusura determina la fine di
un anno vissuto in prima persona da quella radio e che è stato decisivo per
l’immaginario di una generazione. Tutti gli arrestati vengono portati in
questura e successivamente trasferiti nelle carceri di San Giovanni in Monte.
Ovviamente, in seguito vengono tutti prosciolti dalle accuse mosse nei loro
confronti. Radio Alice riaprirà circa un mese dopo e continuerà le trasmissioni
per ancora un paio d’anni, ma senza l’apporto degli originali fondatori e senza
più la stessa vocazione, tanto che la frequenza della radio verrà ceduta a Radio
Radicale. Quell’avventura era iniziata ai primi di gennaio del ’ 76, con le
prime trasmissioni di prova dalla mansarda al civico 41 di via del Pratello,
dall’idea di un gruppo di amici e studenti del Dams, il primo dipartimento
universitario in Italia di “arte, musica e spettacolo”. «Quando Maurizio
Torrealta venne a casa mia a propormi di fondare una radio – ha ricordato Franco
Berardi Bifo, uno degli animatori – la trovai una idea bellissima. Pensai:
sappiamo cantare, fare gli speaker, ballare, praticamente possiamo fare tutto:
ma la macchina?». E così si aggregano quelli che avevano le competenze tecniche,
come Torrealta o Andrea Zanobetti, ingegnere elettronico. Si decide di mandare
in onda tutt’altro da quello che si ascoltava dalla Rai: brani di libri,
comunicazioni sindacali, poesie e letteratura, lezioni di zen e di yoga, analisi
politiche, dichiarazioni d’amore, commenti ai fatti del giorno, ricette non solo
macrobiotiche, favole della buonanotte, liste della spesa, la musica dei
Jefferson Airplane, degli Area o di Beethoven. E tutte le trasmissioni, sulla
frequenza di 100.6 megahertz, si aprono e si chiudevano sempre col
brano Lavorare con lentezza, del cantautore pugliese Enzo Del Re. È la versione
bolognese, forse più creativa ed effervescente di altre per la presenza in città
del Dams, di ciò che stava andando in onda in tutta Italia dopo la sentenza
della Corte che aveva dichiarato anticostituzionale il monopolio statale
sull’etere. S’era d’un tratto aperto un vero e proprio vuoto giuridico, nel
quale in brevissimo tempo si inserì un circuito di piccole emittenti locali
improvvisate, le cosiddette “radio libere”. Da questo punto di vista, osserva –
in I sogni e gli spari. Il ’ 77 di chi non c’era (Azimut) – Emiliano Sbaraglia,
«il 1977 produsse un esempio unico e irripetibile di comunicazione radiofonica:
cambiano radicalmente le tecniche di informazione: si modificano, ampliandosi e
migliorandosi, le possibilità di recupero di materiale informativo, i metodi di
trattamento dello stesso, la pubblicazione e la diffusione di una notizia». D’un
colpo irrompe in Italia l’epopea di Radio Popolare a Milano, di Radio Sherwood a
Padova, di Radio Città Futura e Radio Onda Rossa a Roma ma non solo… Nascono
infatti anche Radio University a Milano e Radio Alternativa nella Capitale e
tante altre emittenti “di destra”. Interessante la recensione che L’uno, il
supplemento “politico” di Linus, pubblica nel numero di marzo ’ 77: «C’è il
solito coretto di scena post- brechtiano, tipo Dario Fo… Poi parlano alcuni
giovanotti… Dicono che i servizi segreti sono infiltrati… Poi si mette su un
altro disco, questa volta è una melopea dylaniana contro i grassi borghesi, le
signore puttane che giocano a canasta… Poi si riprende il dibattito e si parla
della strategia della tensione, della manovra della stampa borghese che mette in
risalto gli elementi da fotoromanzo presenti negli atti di terrorismo e di
equivoca criminalità comune. Altra musica, mitteleuropea ( Berlin, mein
Berlin). Poi interviene un parlamentare che rincara la dose: le istituzioni sono
in sfacelo, ma non da oggi; fin dai tempi di Salvatore Giuliano e della strage
di Portella della Ginestra; ancora prima, dallo sbarco degli americani con i
mafiosi». Quindi la sorprendente constatazione: «Tutto questo – si leggeva
insomma agli inizi del ’ 77 sul supplemento di Linus – non viene trasmesso da
una radio libera “democratica”, come si potrebbe pensare. Ma da Radio
University, emittente milanese “fascista”…» ( che trasmetteva addirittura dalla
sede della federazione provinciale del Msi). Non si notavano differenze,
concludeva l’anonimo recensore, con le programmazioni, le parole e i suoni con
le radio legate all’estrema sinistra. E tutto questo era vero, nella
condivisione generazione di un immaginario e di una sensibilità esistenziale che
accomunava il profondo dei giovani di allora, che alla notizia dei sigilli a
Radio Alice, mentre Radio University trasmette in diretta le fasi drammatiche
della chiusura dell’emittente bolognese, il conduttore Walter Jeder invitava i
suoi ascoltatori a solidarizzare con i redattori bolognesi perché spiegava
«potrebbe succedere anche a noi». Insomma, Radio Alice è il simbolo di tutto un
più vasto fenomeno che stava trasformando la comunicazione e l’informazione nel
nostro paese. Ma perché quel nome? La suggestione veniva dal nome del
personaggio di Lewis Carroll, l’autore di Alice nel paese delle
meraviglie e Attraverso lo specchio. Era accaduto che nel ’ 75 era uscito un
saggio di Gilles Deleuze, autore caro ai giovani di quella fase, dal titolo La
logica del senso e che analizzava proprio i luoghi e la mente della protagonista
degli scritti di Carroll. Come se non bastasse, dal ’ 76 e fino al novembre ’ 77
Gianni Celati, docente di letteratura anglo-americana al Dams, tiene un
seminario in forma di lavoro collettivo sulla figura di Alice nel paese delle
meraviglie. Tra i suoi studenti, il futuro narratore Enrico Palandri, Andrea
Pazienza in arte Paz e Roberto Freak Antoni, giovani creativi che
rappresenteranno al meglio lo spirito del ’ 77. «Il nome di Alice era già stato
messo in giro alla controcultura americana ed era diventato una parola d’ordine
per riferirsi a quel tipo di aggregazione sparsa e senza gerarchie che è stato
chiamato movimento», si legge in Alice disambientata, il libro che raccoglie i
materiali del seminario e che verrà pubblicato l’anno successivo dalle edizioni
“L’erba voglio” di Elvio Fachinelli. Fatto sta, che quel seminario tenuto nel ’
77 finisce per definire la figura fiabesca di «Alice come emblema e, in qualche
modo, nome del nuovo movimentismo giovanile, almeno a Bologna. La stessa Alice
che, come ha ricordato Marco Belpoliti, suscitava contemporaneamente le reazioni
polemiche dei «giovani barbuti con tascapani militari», gli ideologizzati e
militanti che erano convinti che l’argomento fosse «futile e lontano dai
problemi della società». Ecco, un personaggio fantastico, un simbolo
dell’immaginario, si tramuta in elemento di discrimine: da una parte chi è in
sintonia con i tempi nuovi, dall’altra chi resta attardato ai vecchi stilemi
ideologici. D’altronde, i partecipanti al seminario ne erano consapevoli. Così
scrivevano sulla scelta di una dimensione tutta “fantastica”: «Quando l’eroe
parte per il fuori, va fuori dal villaggio dove non esistono più i rapporti di
alleanza e parentela che gli forniscono i modelli culturali di comportamento. La
fiaba insegna un modello di comportamento per zone dove l’individuo non è
protetto dai rapporti sociali di alleanza e parentela, trasmette i modi per
stabilire questi rapporti sociali anche fuori dal villaggio». Insomma, Alice
diventa una figura che quell’anno compare un po’ dappertutto, metafora di un
universo giovanile aperto, che sfugge – si legge nel libro – «all’elaborazione
d’una linea e ad esportare verso l’esterno questa linea come proposta di
discorso egemonico». Ancora: «Non parliamo di utopia. Anche l’utopia è un modo
di ridurre le contraddizioni a uno schema fisso… La controcultura ha posto una
questione minima: tutti i rapporti da stabilire sono affettivi, i rapporti
politici sono quelli già esistenti nella nostra società e non piacciono a
nessuno tranne ai politici». È la riscoperta generazionale del “personale”,
dell’esistenziale, del comunitario, rispetto ai vecchi rapporti astratti,
societari, istituzionali, politici: «L’ipotesi venuta dalla controcultura –
leggiamo ancora in Alice disambientata – non è un’utopia, riguarda un problema
di circolazione: un corrersi dietro tutti, cercando di darsi a vicenda dei
rapporti d’identificazione affettiva». E in conclusione il seminario riconosce
che i “mondi della vita” emergenti nella società in quel ’ 77, soprattutto tra
le giovani generazioni, non sono più rappresentabili dalle istituzioni o dei
partiti, quanto dalle reali comunità giovanili, un mondo fatto di pluralità e
differenze: «Le tribù in movimento sono tante e molto differenziate, e con
teorie di campo tanto dissimili». Ecco, quell’icona e Radio Alice
rappresentavano al meglio la rottura con le vecchie forme della militanza e
aprivano la strada a nuove forme di comunicazione. Tant’è vero che il quando il
9 febbraio ’ 76 iniziano le trasmissioni vere e proprie di Radio Alice, si
aprono proprio con la musica di White Rabbit, un brano degli Jefferson Airplane
che non poteva non ricordare il coniglio bianco compagno d’avventure dell’Alice
ispiratrice. E, da subito il flusso quotidiano di informazione è continuo, senza
alcuna interruzione, come invece accadeva con la Rai o con altre emittenti
libere. Sarà proprio questa l’innovazione rappresentata dal prepotente ingresso
di Radio Alice nel mondo della comunicazione. Un’innovazione che, nel 2004,
verrà celebrata dal film Lavorare con lentezza, diretto da Guido Chiesa e
sceneggiato insieme al collettivo Wu Ming. Qui le vicende di due ragazzi
bolognesi si mescolano a quelle dei movimenti studenteschi del ’ 77 e delle
trasformazioni antropologiche, politiche e nella comunicazione di quell’anno. E
mentre queste cose accadono, sullo sfondo – a cominciare dal brano del titolo –
si ascolta sempre, come una sorta di colonna sonora quotidiana, quanto va in
onda sulle frequenze di Radio Alice.
Film d'epoca e documentari
inediti: ecco la rivolta del '77.
Per la prima volta in tv anche due documentari militanti come Pagherete caro,
pagherete tutto del 1975 e Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro
(1976), scrive Matteo Sacchi, Mercoledì 1/03/2017, su "Il Giornale". Il 1977.
Uno degli anni più complicati della storia italiana. Nasce un movimento
universitario che scavalca a sinistra non solo il Pci ma anche i precedenti
movimenti figli del '68, come Lotta Continua. La tensione politica sale alle
stelle e per la prima volta una rivolta, fatta a colpi di cortei e radio libere.
Il movimento però degenera rapidamente. Tra le idee dadaiste degli Indiani
metropolitani e l'invito alla violenza di chi porta le P-38 nei cortei sono
rapidamente le seconde a vincere. Eppure alcune cose dello spirito del '77 è
arrivato sino a noi. Ecco perché a quarant'anni da quei fatti il canale Iris ha
deciso di dedicare quindici film, in cinque serate consecutive proprio al '77 e
dintorni. Protesta, politica, canzoni, terrorismo, amore libero: insomma tutto
il mix di elementi contraddittori di quegli anni di piombo ma non solo è
trattato nel ciclo Black Out (presentato ieri a Milano) che andrà in onda da
sabato 11 a mercoledì 15 marzo. La data di partenza non è scelta a caso, l'11
marzo '77 a Bologna venne ucciso il militante Francesco Lorusso. Tra i film
alcuni d'epoca che danno l'idea di come si sia creato il clima culturale che
portò al '77: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), San
Babila ore 20: un delitto inutile (1976) e La classe operaia va in paradiso
(1971). Per la prima volta in tv anche due documentari militanti come Pagherete
caro, pagherete tutto del 1975 e Festival del proletariato giovanile al Parco
Lambro (1976). L'unico limite dell'iniziativa che ha un bel supporto documentale
è quello che, a parte un filmato introduttivo e uno speciale a cura di Tatti
Sanguineti (forse ce ne sarà anche uno di Maurizio Costanzo), il pubblico è
lasciato solo, in alcuni casi, con delle pellicole (molto ideologiche) che
richiederebbero un po' di inquadramento per essere capite. Soprattutto dai
giovani.
17 febbraio 1977, gli
studenti demoliscono Lama,
scrive Paolo Delgado il 17 Febbraio 2017, su "Il Dubbio". Quarant’anni fa il
segretario della Cgil veniva contestato alla Sapienza dagli studenti della
sinistra ex parlamentare che lo accolsero con fischi e bastoni. Il palco venne
giù come fosse di cartapesta, per qualcuno fu una frattura drammatica, per altri
fu l’episodio più liberatorio del “decennio rosso”. La sola cosa che avevano in
comune era la reciproca ostilità, una sensazione condivisa di estraneità totale,
una punta di disgusto ricambiata senza alcuna cordialità. A quarant’anni di
distanza ancora non si capisce bene chi prese la decisione sciagurata di spedire
Luciano Lama, segretario della Cgil, in mezzo all’università di Roma occupata da
un Movimento che il Pci considerava a un passo dal fascismo conclamato e che
avrebbe visto il Pci e il sindacato come nemici assoluti anche senza le
carinerie che l’Unità elargiva a getto quotidiano. Fu una decisione stupida
ancor più provocatoria, e tanto inspiegabile che poi, per anni, Cgil,
Federazione romana e Sezione universitaria del Pci si sono rimpallati la
responsabilità della brillante trovata. Non poteva che finire malissimo: fu
chiaro da subito. Il Movimento si preparò all’indesiderato appuntamento con una
di quelle assemblee fluviali ed estenuanti che erano all’epoca merce comune. Ore
e ore passate nell’aula I di Lettere, dal primo pomeriggio del 16 febbraio sino
a notte inoltrata, accumulando proposte per poi confutarle, difendendo a spada
tratta linee di condotte alternative ma che tutti, in fondo, sapevano destinate
a essere comunque travolte dagli eventi. Quando uno dei principali leader
dell’ala dura di Autonomia, esasperato, prese alla fine la parola per chiedere:
«Tutto bene, ok. Ma i bastoni dove li mettiamo?» la sterzata fu accolta con
sollievo generale. Finalmente la verità. Non significa che la scelta del
Movimento fosse lo scontro fisico. Se nessuno riteneva che si dovesse accettare
l’offerta degli organizzatori del comizio, disposti a far parlare dopo il super
sindacalista anche un «esponente del movimento studentesco», la linea
maggioritaria era favorevole a una contestazione morbida e ironica, a base di
sberleffi, non di mazzate. Ma tutti, anche i più creativi tra gli indiani
metropolitani, sapevano benissimo che il rischio che le cose prendessero
un’altra piega c’era tutto. Chiedersi dove mettere i bastoni non era segno di
estremismo e di propensione alla violenza. Era semplice realismo. Non poteva che
andare male, ma andò anche peggio del previsto. Anche questo fu chiaro sin dal
primissimo mattino, quando i militanti del servizio d’ordine del Pci e i
funzionari del sindacato cominciarono ad affluire alla Sapienza, anticipando di
un’oretta il segretario. Arrivavano con le facce tirate di chi marcia in
territorio nemico e si aspetta l’agguato dietro ogni angolo. Sembrava l’avessero
fatto apposta, e probabilmente era proprio così, a rimarcare nei particolari la
distanza, anzi la contrapposizione antropologica, l’antagonismo anche estetico,
rispetto ai “diciannovisti “che da 15 giorni occupavano l’università di Roma.
Gli stessi che una decina di giorni prima avevano sottoposto il cronista del
“quotidiano fondato da Antonio Gramsci” a un beffardo processo popolare. Capo
d’accusa: “Affermazioni deliranti”. Sentenza, passibile di immediata esecuzione:
“Espulsione a vita dall’università”. In quelle prime decine di minute, mentre il
servizio d’ordine del Pci montava un palco improvvisato e la tensione
s’impennava assai più del palchetto, il popolo del Pci e quello del Movimento si
guardavano in silenzio, scoprendo quasi con sorpresa una differenza ormai
totale, verificando la profondità di un abisso che non era più colmabile. Le
scritte degli indiani, fatte nella notte, accoglievano i funzionari del partito
che sosteneva con la sua astensione il governo Andreotti e quelli del sindacato
che chiedeva agli operai di sacrificarsi in nome dell’ “interesse generale”.
“Nessuno L’ama”, “I Lama stanno in Tibet”. I comunisti le degnavano appena di
uno sguardo ma bruciavano d’indignazione: come ci si poteva permettere una
simile mancanza di rispetto? Gli insolenti guardavano i sindacalisti con
disprezzo anche maggiore, o forse con un’alterità che non permetteva più neppure
il disprezzo. Quella gente, con le loro facce torve, la mascelle serrate, le
divise d’ordinanza da burocrati così volutamente opposte a quelle altrettanto
d’ordinanza ma variopinte e fantasiose del Movimento, non la si poteva più
bollare, come si era fatto dal ‘ 68 in poi, come semplicemente “revisionista”,
come compagni che miravano allo stesso obiettivo, una mondo diverso e più
giusto, ma per una strada sbagliata, arrendevole, genuflessa, sconfitta in
partenza. Quello ormai era direttamente il nemico in prima persona. Era, nel
momento storico dato, il sostegno e il principale puntello dell’assetto di cui
persino “i revisionisti” erano comunque stati considerati critici pur se non
abbastanza severi. Gli slogan iniziarono ancora prima che Luciano Lama
cominciasse a parlare. La derisione surreale e un po’ demenziale, “Fatti una
pera, Luciano fatti una pera” sul tono di Guantanamera, bruciava forse anche più
della critica politica, dell’accusa di tradimento: “Lama ti prego non andare
via: vogliamo ancora tanta polizia”. Tra il palco, circondato dal servizio
d’ordine del Partito, e la massa di minuto in minuto più folta dei ragazzi di
Movimento, sotto la scalinata di Lettere, non c’erano che pochi metri. “Luciano”
era terreo al momento dell’arrivo nella zona nemica, attorniato dall’immancabile
codazzo di funzionari e dal servizio d’ordine, quasi una replica caricaturale
delle immagini che dall’Urss raccontavano in ogni Tg la mesta fine dell’Ottobre
rosso. Lo era ancora di più quando infine prese la parola, probabilmente già
consapevole dello sbaglio commesso, per pronunciare un discorso che non sarebbe
mai arrivato alla fine e del quale comunque si persero anche le prime parole,
subissate dal fragore dei fischi, dagli slogan strillati a voce sempre più alta.
A determinare una deflagrazione comunque inevitabile furono i palloncini. Tanti,
colorati e innocui. L’arma scelta dagli indiani per marcare la distanza tra il
grigiore plumbeo di chi chiedeva ai sacrificati di sacrificarsi sempre più e la
festosità disperata del Movimento. Il quadrato intorno al palco rispose con i
sassi, forse per esasperazione, forse perché costretti dalla loro stessa favola,
che li voleva impegnati a fronteggiare una forma moderna e camuffata di
fascismo. Nulla come quel discorso di Luciano Lama, segretario della Cgil,
coperto dagli slogan ostili, pronunciato solo a uso delle persone che occupavano
il palco mentre di fronte la sassaiola diventava sempre più fitta, racconta il ‘
77. Più delle autoblindo spedite da Cossiga a Bologna meno di un mese dopo. Più
delle istantanee che concentrano l’attenzione sulle armi in piazza, e così
facendo falsano la storia. Più dei girotondi che trasmettono l’immagine di una
gioiosità che era mimata e copriva invece un malessere profondissimo. Lama
chiuse di corsa il suo discorso, troncandolo di netto, quando si rese conto che
la situazione era definitivamente sfuggita di controllo. Fece in tempo ad
abbandonare il palco e il campo un attimo prima che quei bastoni ai quali si era
alluso la sera precedente entrassero in azione. Una sola carica, decisa e
travolgente, non preordinata, forse neppure decisa da nessuno. Spontanea. Il
palco venne giù come fosse di cartapesta, e in un certo senso lo era davvero.
Poche ore dopo la polizia arrivò in forze a sgombrare l’università. Giusto per
confermare che nulla di quanto era stato rinfacciato a Lama e tramite lui
all’intero Movimento operaio istituzionale poche ore prima era infondato. Non fu
tanto il giudizio politico a tracciare allora nel Movimento una linea di
demarcazione che resiste e ancora separa gli ormai incanutiti. Fu una questione
di sentimenti prima che di analisi politica. Di emozioni, non di mozioni. Per
qualcuno, soprattutto per chi militava o dirigeva gli ex gruppi impegnati nel
tentativo votato a certo fallimento di trasformarsi in partitini, si trattò di
una tragedia, di una lacerazione drammatica che avrebbe dovuto essere a ogni
costo evitata e che andava adesso ricucita quanto prima. Ancora oggi ricordano
il 17 febbraio 1977 come un giorno di lutto. Per molti altri fu il momento di
massima gioia, il singolo episodio più liberatorio dell’intero decennio rosso, e
tale è rimasto nei decenni. Nell’assalto al palco del sindacalista dei sacrifici
non c’era solo il rifiuto della linea decisa da un Pci che abboccava all’amo
teso dal potere democristiano, quello illustrato in anticipo da Moro e Andreotti
al dubbioso ambasciatore americano Gardner. In sintesi: «Dobbiamo prendere
misure che gli operai non accetterebbero ma che grazie al sostegno del Pci
invece passeranno. Poi però proprio l’aver sostenuto quelle misure provocherà un
crollo di consensi a favore del Pci». Strategia mirabile che avrebbe colto tutti
i risultati previsti nel giro di due anni. Non c’era neppure soltanto il
compimento di una divaricazione che dal 1968 in poi si era fatta sempre più
profonda e che aveva in realtà già toccato il punto di non ritorno quando, nel
1970, una serie di articoli dell’Unità denunciò Adriano Sofri per essere entrato
illegalmente alla Fiat comiziando, chiedendone di fatto un arresto che arrivò
puntuale e chiuse il leader di Lotta continua in carcere per mesi. Tutto questo
certamente pesava, ma ancor più a fondo s’agitava un rifiuto globale di quel che
il movimento comunista era stato sino a quel momento. Della sua passione per
l’ordine. Del suo culto della disciplina, sia pur ribattezzata “disciplina di
partito”. Della sua ipocrisia tattica camuffata da ardimentose piroette
strategiche. Del suo culto del partito e di chi nel partito comandava. Della sua
religione dell’obbedienza. Della sua abitudine a colpire il popolo in nome del
popolo. Della sua struttura plumbea. Del suo grigiore costitutivo. Nelle sue
componenti più innovative e nei suoi momenti migliori, quello del ‘ 77 è stato
soprattutto un Movimento contro il “comunismo reale”. Il primo e sinora l’unico
che abbia provato ad aggredire non gli orpelli ma il cuore stesso degli errori
commessi dal movimento comunista non in nome della sua revisione e neppure in
quello di un ritorno alla sua purezza, ma in nome della capacità di evolversi e
cambiare imparando dagli errori senza rinnegare le radici. Per questo la
cacciata di Lama, che della mesta e gelida realtà del movimento comunista era
emblema, è ancora oggi la data chiave di quell’anno distante. E forse per questo
è così difficile consegnare il ‘77 alla nostalgia e alla storia.
Settantasette, parole ed
immagini.
Tano D'Amico è l'autore dietro le foto che hanno raccontato il Movimento del
'77: le proteste, gli scontri, le speranze di una generazione entrata nella
storia muovendo i primi passi dal cortile delle Sapienza. Intervista a Tano
D'Amico di Michele Smargiassi su “Robinson” (La Repubblica) il 19 febbraio 2017.
Vide gli zingari felici. Ne
salvò i volti per noi, con le sue fotografie. Tano D’Amico, 74 anni e un sorriso
da Gavroche, “compagno fotografo”, fotografo dei nomadi, degli occupanti di
case, una lunga storia che comincia prima e finisce dopo il ’77: ma quell’anno,
anche per lui, fu unico. L’anno in cui l’universo si mosse.
Vorrei partire da una foto
non tua. Il militante incappucciato che spara in via De Amicis. Temo che l’icona
del ’77 sia quella.
“Vollero farla diventare così.
Non è un’immagine, è uno scalpo. Era l’immagine che tutta una cultura politica
aspettava. Non solo quella di destra. In quel periodo lavoravo a Lotta Continua,
e il ’77 lo odiavano pure lì. Certo, ricordo cosa scrisse Umberto Eco, che
quella fotografia seppellì il movimento, ma ricordo cosa pensai io quando la
vidi sulle prime pagine dei giornali: che era una brutta immagine, e che le
brutte immagine prima o poi scompaiono”.
Brutta ideologicamente?
“No no, anche in senso
estetico. Se vedessi un’immagine così in un film direi che è brutta, non perché
c’è uno che spara. Le immagini sparatorie nei film di Peckinpah sono bellissime.
Quella che dici tu invece è un’immagine repellente. Al di là di quello che
rappresenta (lo sai vero che quello che si vede non è quello che ammazzò
l’agente di Polizia?), diede origine a cose disastrose, un gruppo di
giovanissimi che si vendettero gli uni gli altri… penso che le immagini si
giudichino anche dal loro futuro”.
Del ’77, tu cercasti solo
belle immagini?
“Penso che le belle immagini
abbiano un posto nell’universo. Quando l’universo vede una brutta immagine,
s’arrabbia. Certe foto invece vengono accolte dall’universo: penso alle due
Polaroid di Moro nel carcere delle Br. Appena le vidi pensai a due icone
bizantine. Nell’ultima foto Moro non fa caso ai suoi assassini che ha davanti,
si appella all’universo, a noi, è già al di là, tutti lo volevano morto. Quella
foto mi ha commosso più delle sue lettere”.
Prima di quella foto tutto
era ancora aperto. E tu eri il fotografo “del movimento”.
“Ma io non volevo fare il
fotografo del movimento. Io volevo fare il movimento, stare nel movimento.
Sapevo che invece il fotografo deve mettersi da parte per osservare. Però
trovavo brutte le immagini del movimento. Cosa ci potevo fare: ero figlio di
emigranti siciliani a Milano, da bambino m’infilavo nei musei, erano gratis e
caldi d’inverno e c’erano guardiani gentilissimi. C’era un’immagine che mi
ricordava il mio Sud, un gruppo di donne normanne. Il pittore, lo seppi dopo, si
chiamava Van Gogh. Forse per questo vedevo subito quando un’immagine smuoveva o
bloccava qualcosa e lo dicevo. E i compagni: allora domani al corteo le foto le
fa Tano”.
Fotografo precettato dal
proletariato.
“Nelle assemblee dicevano
Tano, tutti fotografano i fatti, tu fotografi i nostri desideri. Ebbi grande
affettuosa libertà”.
Il fotografo dei
desideri...
“Be’, non potevo fare
diversamente. Mi mandavano nei posti dove era successo qualcosa ma coi treni di
allora e pochi soldi per il biglietto arrivavo tre giorni dopo, non mi restava
che cercare gli avvenimenti nei volti delle persone. Imparai a leggere la storia
negli occhi della gente”.
Cosa ci leggevi?
“Bellezza. Passavo ore nel
cortile della Sapienza, tra i ragazzi che sonnecchiavano, leggevano libri, si
baciavano. In un libro Chomsky ha scritto che in quel cortile maturava la
storia. Poi seguivo quei ragazzi in strada, nei cortei, fotografavo la loro
grazia. Ma quelle immagini non uscivano mai sui giornali. I compagni mi
prendevano in giro: Tano, ma lo metti il rullino nella macchina? I giornali
volevano immagini di scimmie assetate di sangue, di assassini reali o
potenziali. Le mie immagini erano intrattabili. Ero diventato una macchietta, il
fotografo che fa foto che nessuno vede. Allora venne a casa mia una vera e
propria commissione politica, autonomi, femministe, gay, indiani metropolitani…
Mostrai le foto. Alcuni si misero a piangere. Bisogna fare un libro, dissero.
Fecero una colletta, i soldi dentro un sacco del pattume. Il libro uscì, la
bellezza fu vista”.
Eppure hai scattato anche
tu fotografie “di fatti”. Il giorno in cui ammazzarono Giorgiana Masi...
“Ho condiviso la buona e
cattiva sorte dei movimenti, è una favola che evitassi il conflitto. Quel giorno
feci una foto a un agente in borghese armato. Mi pareva un’immagine banale,
tutti sanno che ci sono gli agenti in borghese. Non era neppure la foto
dell’uomo che sparò a Giorgiana, era un altro posto. Però la sera al
telegiornale sento il ministro degli Interni garantire che non c’erano agenti in
borghese, allora mi vesto e faccio il giro dei giornali con quella foto. Il
primo giorno tutti scrissero che il ministro avrebbe dovuto dimettersi, poi
tornò la solidarietà fra potere e stampa”.
C’è una foto di “fatti” che
invece tenesti per te. Perché? Era una brutta foto?
“Tu dici la foto di Paolo e
Daddo, uno ferito l’altro che lo sorregge e tiene in mano due pistole, dopo gli
scontri del 2 febbraio all’università di Roma. Vero, non la feci vedere a
nessuno. Vent’anni dopo, quando incontrai Daddo nella redazione del Manifesto,
proprio lui mi rimproverò: ma perché non l’hai pubblicata? E io: ma era la tua
vita, c’era il tuo sangue… E lui: no, è tua, è il tuo lavoro”.
Il ’68 era stato
spensierato nel concedersi agli obiettivi. Il ’77 vide in ogni fotografo un
delatore.
“Non volevo essere carnefice.
Sapevo per esperienza che tutta la cultura del mondo s’apparecchia per difendere
quello che già c’è, e che avrebbe usato certe foto per criminalizzare quel che
si oppone. La verità è che nessuno voleva guardare il faccia il movimento del
’77. A destra e a sinistra. Mi ricordava l’Orwell di Omaggio alla Catalogna: gli
anarchici odiati da tutti. Un movimento di cui tutti avevano paura perché
metteva in discussione i ruoli, anche quelli dei giornalisti e dei fotografi.
Quella che dà fastidio al potere, quella che non doveva essere vista era
l’umanità delle persone. Invece sono queste le immagini che rimangono vive, che
oggi si fanno ancora interrogare. Una bella immagine quando è fatta è fatta.
L’universo lo sa”.
Il Movimento del
Settantasette, 40 anni fa. Malesseri e speranze in una stagione di crisi.
Nelle rivendicazioni dei giovani di allora si leggono i segni premonitori di
cambiamenti futuri: i ragazzi erano cresciuti con la scolarizzazione di massa ma
le aspettative risultavano frustrate, scrive Maurizio Caprara il 4 febbraio 2017
su "Il Corriere della Sera".
1. Con la scuola di massa,
più istruzione. Non sempre i lavori ambiti.
Sono trascorsi quarant’anni.
Il 1977 fu per una parte dei giovani italiani un gran frullatore: di
malesseri, speranze, violenza, intuizioni, abbagli, rivendicazioni.
Affioravano i segni premonitori di una crisi dei partiti tradizionali che si
sarebbe aggravata più avanti. Cresciuti con la scolarizzazione di massa, i
ragazzi di quarant’anni fa vivevano meglio di come avevano vissuto i rispettivi
genitori durante o dopo la guerra. Le conquiste del 1968 erano date per
scontate. Le aspettative di molti tuttavia risultavano frustrate: per tanti era
difficile trovare posti di lavoro adeguati al grado di istruzione raggiunto.
Nell’irradiarsi dall’università alle scuole, questa frustrazione si mescolò ad
altro. Ne derivarono richieste di programmi di studio aggiornati, proteste
inventive. L’ondata di assemblee e manifestazioni cominciò perché fascisti, a
Roma, il 1° febbraio avevano sparato su uno studente di sinistra ferendolo
gravemente. La fanatica brutalità dell’Autonomia operaia rese ancora più
pericolosa una spirale di scontri di piazza. In cortei nei quali non erano rari
barricate e lanci di bottiglie Molotov, si aggiunse il ricorso a pistole contro
carabinieri e polizia. Presto, gli spazi di azione per le anime maggioritarie
del Movimento si estinsero. Tra autonomi e altri studenti di sinistra si ebbero
confronti duri, anche fisici. Il quarantesimo anniversario del Settantasette può
essere un’occasione per riflettere su come i sistemi democratici debbano
recepire, indirizzare e selezionare, depurandoli dall’intolleranza, istanze e
disagi di settori della società che si sentono ai margini delle decisioni. Prima
che sia tardi.
2. La ritirata di Lama tra
ironia e violenza.
«I Lama stanno nel Tibet» venne scritto su un muro de «La
Sapienza» di Roma prima che, il 17 febbraio, arrivasse il segretario della Cgil
Luciano Lama. Un suo comizio doveva servire al Pci per dimostrare che
l’università occupata da studenti non poteva fare a meno del sindacato italiano
con più tesserati, guidato da un comunista autorevole. Le anime del Movimento
reagirono in maniere diverse. Soltanto con alcune critiche i gruppi della «nuova
sinistra», tranne Lotta continua su posizioni aspre. Gli Indiani metropolitani,
l’«ala creativa», contestando il comizio al grido di «Ti prego/ Lama/ non andare
via/ vogliamo/ ancora/ tanta polizia». Quando gli «Indiani» lanciarono
palloncini con liquido colorato contro i servizi d’ordine di Cgil e Pci, questi,
non capendo di che si trattasse, risposero con una carica. Finì male. Gli
autonomi assaltarono il palco con spranghe, bastoni e pezzi di asfalto (nella
foto). La ritirata di Lama fu una sconfitta per il più grande Partito comunista
dell’Occidente che dall’anno precedente, per la prima volta dal 1947, in
Parlamento si era avvicinato alla maggioranza astenendosi sulla fiducia al
governo del democristiano Giulio Andreotti. Fu giorno nero anche per la parte
ampia del Movimento che preferiva verso il Pci le armi della critica alla
«critica delle armi».
3. Sperimentazione,
autogestioni: una scuola da cambiare.
L’insegnamento nelle scuole italiane meritava aggiornamenti che tardavano. Nei
programmi didattici lo studio era considerato in troppi casi slegato dal lavoro.
A fare rumore furono le contestazioni intimidatorie dei settori più estremi del
Movimento che pretendevano dai professori presi di mira il «6 politico» nelle
secondarie o il «18 politico» nelle università. Ma quegli obiettivi non
appartenevano né a tutti gli studenti né all’intero Movimento, una parte
consistente del quale richiedeva «sperimentazione didattica»: corsi sugli
argomenti più vari, dall’economia al cinema, dal teatro alla sessualità. Se ne
organizzarono alcuni durante autogestioni e occupazioni di scuole.
4. L’autocoscienza,
fermenti e idee del femminismo.
«La vostra violenza/ è solo/
impotenza», gridavano i cortei femministi denunciando stupri e soprusi subiti da
donne. Si deve anche a quei momenti se oggi è più alto nella nostra società il
disprezzo per i troppi delitti che hanno vittime di sesso femminile. Nel 1977 in
Italia soltanto 35 donne su cento lavoravano o erano in cerca di lavoro. Il
femminismo ha contribuito a farne salire in seguito il numero, riducendo su
questo aspetto la distanza del nostro Paese da altri Stati europei. Nel
Movimento l’«emancipazione» era giudicata da molte ingannevole rispetto alla
«liberazione» della donna. Sommarietà e fondamentalismi non furono assenti. Una
delle attività dei collettivi femministi consisteva nell’«autocoscienza»:
riunioni nelle quali ogni componente comunicava alle altre propri problemi e
pensieri intimi. Occasione di crescita, in vari casi. Non per tutte fu,
psicologicamente, una passeggiata. Per fidanzati e mariti — il comportamento
privato dei quali, in contumacia, veniva esaminato con la lente di ingrandimento
nei collettivi — la tutela della privacy fu un’utopia. Inconfessabile.
5. Volti coperti. E
scoperti, con trucco.
Le foto dei giornali spesso ricordano le manifestazioni del 1977 con volti di
manifestanti coperti da fazzoletti o passamontagna. Immagini scattate durante
cariche di polizia, quando candelotti lacrimogeni rendevano l’aria
irrespirabile, o nel corso di assalti a sedi di partito e blocchi stradali.
Eppure i visi, non soltanto scoperti, anche truccati, furono un elemento non
marginale delle proteste del 1977. Mai prima di allora nell’Italia repubblicana
il ricorso a ceroni, kajal e matite varie aveva avuto una diffusione così
ostentata e vasta per dimostrazioni politiche. A usare il trucco con vistosità
teatrali non erano esclusivamente ragazze. Tra gli Indiani metropolitani, per i
maschi poteva essere di ordinanza. Lo scopo: mettere in evidenza una
irregolarità, un’anomalia, una diversità ritenute ragioni di orgoglio.
6. Il sangue. Le morti.
Fuoco sulle speranze.
L’11 marzo a Bologna in scontri con i carabinieri venne ucciso
Francesco Lorusso, 24 anni, di Lotta continua. Il giorno seguente a Roma una
manifestazione nazionale del Movimento con decine di migliaia di persone venne
sfibrata da autonomi con le P38 o con armi improprie che assaltarono negozi,
gettarono bottiglie incendiarie contro una sede della Dc e bar, scatenarono
guerriglia in più punti del centro della capitale d’Italia. Le violenze furono
per il ministro dell’Interno Francesco Cossiga, democristiano, motivo di porre
divieto anche a una manifestazione indetta dai radicali per il 12 maggio, terzo
anniversario del referendum sul divorzio, in piazza Navona. Ragazzi non
organizzati si trovarono sbandati tra drappelli dei settori più estremi pronti
allo scontro, agenti in borghese con armi in pugno. Cadde colpita da un
proiettile Giorgiana Masi, studentessa di 19 anni. La speranza di cortei senza
sangue si indebolì ancora di più.
7. Un altro lato della
gioventù. Morire in servizio a 25 anni.
A Milano il 14 maggio l’agente
Antonio Custra fu ucciso in via De Amicis. Aveva 25 anni, il salario di un
lavoratore. Le immagini di autonomi che sparavano segnarono un’epoca.
8. Il ministro Cossiga, gli
infiltrati e la repressione.
L’Autonomia operaia
raccoglieva nel 1977 migliaia di persone e suoi spezzoni erano terreno di
reclutamento per formazioni terroristiche. Per quanto non maggioritari, gli
autonomi avevano beneficiato di ambiguità e indulgenze di una parte del
Movimento e riuscirono a deviare il corso degli eventi in diversi cortei e
assemblee. Ma una storia del 1977 non può essere scritta senza tener conto di
quanto detto dal ministro dell’Interno di allora, Francesco Cossiga, in un libro
del 2010, Fotti il potere: «La contestazione, la violenza politica e il
terrorismo minacciavano l’autorità dello Stato e tutti i partiti a cominciare
dal Pci mi chiedevano d riportare l’ordine con ogni mezzo. C’era solo un modo
per farlo: usare la forza. Fu per questo che, dopo aver infiltrato nelle
organizzazioni più estremiste alcuni agenti provocatori, diedi ordine di
lasciare liberi i manifestanti di mettere a ferro e fuoco le città. Dopo due o
tre settimane la gente non ne poteva più e così, forte del consenso popolare,
potei scatenare la repressione».
1977, la rivoluzione che
cancellò la rivoluzione,
scrive Paolo Delgado il 3 gennaio 2017 su "Il Dubbio". I giovani manifestanti
chiudono con la cultura della presa del potere, che dal 1917 russo arriva fino
al ’68. Può sembrare del tutto sproporzionato e quasi irriverente azzardare
confronti tra il ‘77 italiano e la grande rivoluzione che 60 anni prima aveva
rovesciato il secolo e il mondo. Il paragone è certamente impossibile se si
guarda alla portata degli eventi. Non così se ci si concentra invece sulla
cartografia sociale e politica che il ‘77 ridisegna. Il ‘77 italiano certifica
la fine della lunga fase inaugurata dal ‘17 russo, annuncia la fine di quel
mondo, l’impraticabilità di quel modello di rivoluzione. Quello del ‘77 è stato
un Movimento contro il ‘68, segnato dal radicale rifiuto della ossessione
partitistica che aveva dato vita ai gruppi della sinistra extraparlamentare,
della separazione tra le sfere del politico e del privato. Il ‘68, come il 1917,
è il passato. Il 1977 è il presente. I botti che nella notte del 31 dicembre
congedarono il 1976, anno di elezioni politiche finite con una sostanziale
parità tra Dc e Pci, anno che di conseguenza aveva per la prima volta visto il
Pci non opporsi a un governo monocolore democristiano e anzi sostenerlo con
l’astensione, salutarono il 1977 ma solo sul calendario. Politicamente e
culturalmente quello che oggi definiamo “il 77” era cominciato già da un pezzo e
sarebbe proseguito ancora a lungo. A differenza del ‘68, quanto l’esplosione era
stata pressoché contemporanea in tutta la penisola come del resto in tutta
Europa e in mezzo mondo, il cosiddetto ‘77 si presentò in momenti diversi di
città in città. A Milano era iniziato nell’aprile del 1975, con la settimana di
rivolta e scontri seguita alla morte di Claudio Varalli, ucciso da un fascista
il 16 aprile, e di Giannino Zibecchi, investito da un gippone della polizia il
giorno successivo. Era proseguito con la nascita dei Circoli del proletariato
giovanile, la pratica degli espropri nei negozi e nei ristoranti più cari, la
teorizzazione del diritto al lusso, sino agli scontri dell’8 dicembre ‘76 per
l’inaugurazione della stagione alla Scala. L’anno seguente, nel ‘77 propriamente
detto, gli epicentri del Movimento furono Roma e Bologna. L’onda raggiunse gli
operai di Torino, i protagonisti principali del decennio rosso, solo nel ‘79,
con l’ultima grande ciclo di conflittualità operaia alla Fiat. Può sembrare del
tutto sproporzionato e quasi irriverente azzardare confronti tra il ‘ 77
italiano e la grande rivoluzione che sessant’anni prima aveva rovesciato il
secolo e il mondo. Il paragone è certamente impossibile se si guarda alla
portata degli eventi. Non così se ci si concentra invece sulla cartografia
sociale e politica che il ‘ 77 ridisegna, costringendo a depositare nei
ripostigli della memoria quella precedente. Il ‘77 italiano certifica la fine
della lunga fase inaugurata dal ‘17 russo, annuncia la fine di quel mondo,
l’impraticabilità di quel modello di rivoluzione. Quello del ‘ 77 è stato un
Movimento contro il ‘ 68, segnato dal radicale rifiuto della ossessione
partitistica che aveva dato vita ai gruppi della sinistra extraparlamentare,
della separazione tra le sfere del politico e del privato, della concezione
sacrificale che rinviava la festa rivoluzionaria a dopo la conquista del palazzo
d’Inverno di turno, di un’idea della rivoluzione intesa come presa del potere,
dell’universalismo egualitario che il 1917 aveva ereditato dal 1789 e di lì era
arrivato senza scosse al ‘68. La musica del ‘ 77 era diversa, tanto distante dai
movimenti del passato recente quanto la rabbia punk di Anarchy in Uk lo era
dalle utopie del rock impegnato della West Coast hippie. In quella lunghissima
assemblea permanente che si svolse a Lettere dal 2 febbraio, giorno
dell’occupazione della città universitaria, al 17 febbraio, data della cacciata
di Lama dall’università e dello sgombro militare della stessa, si parlava
davvero di tutto, senza ordine del giorno, senza presidenza, senza tentativi di
strutturare il dibattito. Però il tema che appena pochi anni prima sarebbe stato
dominante, l’interrogativo su come dare uno sbocco organizzativo a quel
conflitto spontaneo, quasi non figurava nell’agenda. Il Movimento del ‘ 77
guardava al presente, sostituendo all’orizzonte lontano della rivoluzione a
venire quello immediato del “qui e ora”. Puntava sulla spontaneità, sulla
creatività e sull’autonomia senza inseguire la chimera bolscevica del “soggetto
rivoluzionario”. Rompeva ogni barriera tra privato e pubblico, convinto che il
“personale” fosse del tutto “politico”. Rifiutava l’universalismo per esaltare
le differenze, instaurando il primato di una mitologia “differenzialista”
opposta e forse non meno malintesa e pericolosa di quella egualitaria che aveva
sin lì tenuto banco. Ma tutto il bagaglio che dal Movimento del ‘77 veniva
negato e rinnegato, il ‘68 lo aveva ereditato dalla cultura dei movimenti
rivoluzionari, per come si era definita a partire dall’Ottobre di Pietrogrado.
La rottura del resto era anche più profonda. Gli studenti e i militanti del ‘68,
anche in questo ereditando una cultura politica antecedente alla stessa
rivoluzione russa, identificavano un soggetto sociale rivoluzionario, per alcuni
l’operaio- massa, gli operai di linea e dequalificati delle grandi fabbriche,
per altri i popoli del Terzo mondo destinati ad accerchiare le roccaforti
imperialiste, al quale si rivolgevano pretendendo di mettersene al servizio e
spesso mirando a guidarlo e indirizzarlo. Ma era sempre e comunque altro da sé.
I ribelli del ‘ 77 sentivano e sapevano di essere loro stessi il soggetto
sociale sfruttato e condannato a una vita grama. Erano la prima generazione che
sperimentava sulla propria pelle la fine della società affluente e l’inizio
dell’era del precariato e del neo- schiavismo, erano quindi loro stessi il
soggetto rivoluzionario. Si spiegano così l’urgenza, la violenza e anche la
sostanziale disperazione di un movimento che reagiva mimando la gioia,
mascherando l’angoscia sotto le parvenze beffarde e dissacranti degli indiani
metropolitani e del situazionismo riscoperto, ma alla fine inevitabilmente
arrivando a uno scontro che era violentissimo perché la posta in gioco non
lasciava spazio a possibili mediazioni. I ragazzi del ‘ 68 sapevano che, se
sconfitti, sarebbero comunque tornati alle loro origini e avrebbero ripreso il
loro posto nei ceti medi o medio- alti, come moltissimi hanno effettivamente
fatto. Quelli del ‘ 77 erano senza rete e lo avvertivano a pelle. Come in ogni
cesura storica, la nettezza del taglio si coglie meglio guardando a ritroso di
quanto non si percepisse nel fuoco degli eventi. Gli elementi nuovi e inediti
marciavano fianco a fianco con i bagliori estremi dell’epoca al tramonto, tra i
quali nessuno era più abbacinante delle Brigate rosse, organizzazione comunista
ancora del tutto interna alla logica rivoluzionaria inaugurata dal 1917 e dunque
sospettosa e diffidente quasi quanto il Pci di fronte a quello “strano movimento
di strani studenti”, come lo definì un fortunato pamphlet dell’epoca. Sul piano
del fronteggiamento politico immediato, il nemico principale del Movimento del
‘77 fu il Pci, e lo fu da subito. Il primo febbraio, in piena città
universitaria, viene ferito da una rivoltellata fascista lo studente Guido
Bellachioma. Il giorno dopo, mentre in piazza della Minerva Walter Veltroni
arringa a nome della Fgci alcune centinaia di studenti, migliaia di manifestanti
assaltano e incendiano la sede del Fronte della Gioventù in via Sommacampagna,
dietro piazza Indipendenza, con l’immancabile scia di scontri con la polizia e
con i gruppi fascisti usciti dalla sede in fiamme. Una macchina della polizia in
borghese taglia all’improvviso il corteo e viene bersagliata di sassi. Uno dei
poliziotti, Domenico Arboletti, esce e senza qualificarsi spara alcuni colpi.
Dal corteo rispondono al fuoco, l’agente cade ferito gravemente. Il suo collega
esce a sua volta col mitra spianato, ferisce prima Paolo Tommassini, poi Daddo
Fortuna che tentava di portare via il compagno ferito trascinandolo con una mano
e tenendo con l’altra sia la sua pistola che quella di Tommassini. Dopo la
sparatoria il corteo rientra nella città universitaria e la occupa. Il giorno
dopo Ugo Pecchioli, “ministro degli Interni” del Pci dichiara: «Collettivi
autonomi e fascisti svolgono da tempo un’azione parallela e concomitante, ma non
sono due realtà opposte. E’ la medesima logica che li muove, l’odio per le
istituzioni democratiche». Per la prima volta l’estremismo rosso non è solo
messo sullo stesso piano di quello nero secondo la logica degli “opposti
estremismi” ma è direttamente identificato con una forma di fascismo. Nei giorni
seguenti il cronista dell’Unità Duccio Trombadori viene “processato”
dall’assemblea riunita a Lettere ed «espulso a vita per affermazioni deliranti»
dalla città universitaria. Il bando si allarga in realtà anche ai partitini
della sinistra radicale che si vogliono eredi del ‘68. E’ in questo clima che si
arriva alla folle scelta di organizzare il comizio di Lama nell’università
occupata, il 17 febbraio. L’esito di quella provocazione e il seguito renderanno
la lacerazione più profonda e incolmabile: gli scontri, il palco abbattuto, il
segretario della Cgil messo in fuga con il servizio d’ordine del sindacato mai
così plumbeo e torvo, il successivo arrivo delle ruspe a sgombrare l’università
e poi, meno di un mese dopo, l’esplosione della capitale rossa, Bologna, in
seguito all’uccisione di Francesco Lorusso, i blindati di Cossiga spediti a
ripristinare l’ordine dopo 4 giorni di rivolta, la manifestazione nazionale del
12 marzo a Roma, aperta dai bolognesi che scandiscono “Bologna è rossa del
sangue di Francesco”, che assalta la sede nazionale della Dc in piazza del Gesù,
saccheggia un’armeria sul lungotevere, apre a ripetizione il fuoco sulla
polizia, incendia il commissariato di piazza del Popolo. Non che in precedenza
tra Movimento e Pci corresse buon sangue. Ma la critica si era sempre limitata a
bersagliare “il revisionismo” del partitone, la sua rinuncia alla via maestra
rivoluzionaria. Nel ‘ 77 le cose cambiano: il Pci è individuato come parte
integrante dello Stato, sponda politica eminente di quella trasformazione
sociale complessiva di cui i ragazzi del ‘ 77 si sentivano, a ragione, vittime e
nemici mortali. La deriva che porterà i partiti socialdemocratici a gestire in
prima persona la gigantesca riorganizzazione degli assetti sociali che, a
partire proprio dalla fine dei ‘ 70, cancellerà le conquiste di un secolo
instaurando una sorta di neoschiavismo inizia in quell’anno, così come entra in
scena allora, per la prima volta, il soggetto sociale prodotto da quel
riassetto. Se a distanza di 40 anni non riusciamo a guardare al ‘ 77 con la
stessa distaccata nostalgia che avvolge il ‘68 è perché in quell’anno si è
presentato, da ogni punto di vista, il mondo in cui viviamo oggi. Il ‘ 68, come
il 1917, è il passato. Il 1977 è il presente.
Sogni, errori, libertà. Il
nostro ‘77 fu diverso,
scrive Carlo Rovelli il 14 febbraio 2017, su "Il Corriere della Sera". L’idea
che il mondo andava cambiato è stata sconfitta ma non fu inutile. Quei valori
sono rimasti radicati in noi. Leggo in questi giorni diversi articoli sul
movimento giovanile che è passato sull’Italia nel 1977, quarant’anni fa, breve e
intenso come una folata di vento. Non mi riconosco in questi articoli. Mi sembra
non parlino di quanto ci dicevamo, pensavamo e sentivamo io e i miei amici in
quegli anni lontani. Io non so fare analisi storiche e sociologiche e non voglio
confondere la mia esperienza personale, mia e di qualche amico, con un fatto
storico. Ma allora erano molti gli amici intorno a me che sentivano come me, e
da qualche parte ci sono ancora. Scrivo qualche riga per loro, i miei tanti
amici di allora, e anche per chi magari è curioso di sentire un ricordo diverso.
Alcuni di quegli amici hanno un ricordo magico e mitico di quegli anni. Un
momento intensissimo di scambio, sogni, entusiasmo, voglia di cambiare, voglia
di costruire insieme un mondo diverso e migliore; lo ricordano con nostalgia
intensa, fino a rendere grigia l’immagine di quella che è stata la vita poi. Per
me non è così. Avevamo vent’anni, e a vent’anni la vita è spesso splendida e
rovente, almeno nel ricordo. Non è il profumo della storia, è il profumo della
giovinezza. Per me quegli avvenimenti sono stati sì magici e bellissimi, ma
perché sono stati l’inizio, perché ne ho tratto delle cose. Hanno aperto un
percorso. Non hanno reso la vita successiva meno colorata: sono stati la
scoperta collettiva di colori che sono rimasti con me. Certo, l’anno successivo
al 1977 è stato vissuto da molti di noi come una disfatta. La voglia luminosa di
cambiare il mondo, che ci era sembrata per un attimo aprire possibilità vere, si
scontrava contro la realtà. Naufragava, prima colpita dalla reazione delle
istituzioni, quella che allora chiamavamo la repressione; poi sconcertata per la
violenza di quello che adesso chiamiamo terrorismo. Eravamo in tanti a dirci e
sapere bene che la lotta armata in Italia non avrebbe portato a nulla di buono,
che era solo una reazione estrema e sciocca, in realtà disperata, a sogni che si
chiudevano. I «compagni che sbagliano», lo sapevamo in tanti, erano ragazze e
ragazzi con un senso morale più assoluto degli altri, e, come purtroppo spesso
accade, accecati da questo. Noi volevamo altro, e per un momento, insieme, in
tanti, avevamo pensato fosse possibile. Che fosse possibile andare in quella
direzione. Quale direzione? I grandi sogni hanno la caratteristica che quando
svaniscono sembrano inconcepibili. Talvolta nella storia i sogni più
inconcepibili si realizzano: contro ogni aspettativa dei realisti, la
rivoluzione francese abbatte il predominio dell’aristocrazia, il cristianesimo
conquista l’impero romano, un allievo di Aristotele conquista il mondo e i suoi
amici fondano biblioteche e centri di ricerca, i seguaci di un predicatore arabo
cambiano l’ordine del pensiero di centinaia di milioni di persone, eccetera
eccetera. Più spesso, grandi sogni si scontrano contro la forza del quotidiano,
durano pochissimo o poco, crollano, vengono dimenticati. Sono i tanti rivoli
della storia che, bene o male, non portano da nessuna parte. I movimenti del
Trecento per una chiesa povera, le comunità utopiche del XVIII secolo, o il
sogno egualitario del comunismo sovietico; oppure le fantasie naziste che
appassionavano tanto la gioventù, forse oggi il Califfato… Ma più spesso ancora
quello che succede è più complesso, e la storia segue percorsi tortuosi. Il
Direttorio elimina Robespierre, Wellington batte Napoleone, e il re di Francia
torna sul trono: la rivoluzione ha perso… Ma ha perso davvero? Il movimento
delle suffragette per il diritto di voto alle donne è sconfitto al tempo della
prima guerra mondiale. Ma ha perso davvero? I movimenti storici sono fatti di
idee, giudizi etici, passioni, modi di vedere il mondo. Spesso non vanno da
nessuna parte. Talvolta però lasciano tracce che continuano ad agire in
profondità sul tessuto mentale della civiltà, la cambiano. La nostra civiltà,
l’insieme dei valori in cui crediamo, è il risultato di molti sogni, di molti
che hanno saputo sognare intensamente al di là del presente. Il movimento del
‘77 italiano non è comprensibile da solo. È stato un’espressione tarda, non
certo l’ultima, ma una delle ultime, consapevole di questo, e per questo
intensa, di uno di questi grandi sogni che ha spazzato non l’Italia ma il mondo
intero per un breve ventennio che va dagli anni Sessanta alla fine degli anni
Settanta. Sono stati anni in cui una parte considerevole della gioventù del
mondo intero ha sognato e sperato intensamente di poter cambiare la realtà
sociale in modo molto radicale. Non è stato certo un movimento di pensiero
strutturato e coerente, anzi, era disperso in mille rivoli. Ma nonostante le
grandi diversità, tutti questi rivoli sentivano con assoluta chiarezza di
appartenere allo stesso fiume, dalle piazze di Praga alle università di Città
del Messico, dal campus di Berkeley a Piazza Verdi a Bologna, dalle comuni
hippie rurali e urbane della California ai guerriglieri sudamericani, dalle
marce cattoliche per il Terzo mondo agli esperimenti dell’anti-psichiatria
inglese, da Taizé a Johannesburg, nella strepitosa differenza di atteggiamenti
specifici, c’era un reciproco intenso riconoscimento di appartenere allo stesso
grande fiume, di condividere uno stesso grande sogno. Di «lottare», come si
diceva allora, per un mondo molto diverso. Era il sogno di costruire un mondo
dove non ci fossero forti disparità sociali, non ci fosse dominio dell’uomo
sulla donna, non ci fossero confini, non ci fossero eserciti, non ci fosse
miseria. Era il sogno di sostituire la collaborazione alla lotta per il potere,
di lasciarsi alle spalle i bigottismi, i fascismi, i nazionalismi, gli
identitarismi, che avevano portato le generazioni precedenti a sterminare cento
milioni di esseri umani durante le due guerre mondiali. I sogni si spingevano
lontano: un mondo senza proprietà privata, senza gelosia, senza gerarchie, senza
chiese, senza stati potenti, senza famiglie chiuse, senza dogmi, libero. Dove
non avevamo bisogno degli eccessi del consumismo, e si lavorava per il piacere
di fare, non per lo stipendio. Solo a nominare oggi queste idee sembra di
parlare di delirî. Eppure eravamo in tanti a crederci, in tutto il mondo. In
quegli anni ho viaggiato molto, in diversi continenti, e ovunque incontravo
giovani con questi stessi sogni. Di questo parlavamo i miei amici ed io in
quell’anno, il 1977. Non certo della paura del precariato. Se vogliamo ricordare
qualcosa di quelli anni, è questo che io ricordo. Vivevamo in case aperte. Si
dormiva un po’ qui e un po’ là. Sapevamo bene che l’eroina è pericolosissima e
chiunque avesse un po’ di cervello se ne teneva lontano. Ma sapevano anche che
marijuana e Lsd non lo sono, e si offriva uno spinello con la semplicità con cui
si offre un bicchiere di vino. L’Lsd era tutt’altro: un’esperienza potente e
importante, da trattare con attenzione e rispetto, ma che poteva insegnare
molto. L’occupazione principale, come è d’uso per ogni gioventù, era innamorarsi
e disperarsi per amore; ma il sesso era moneta quotidiana, un modo per
incontrarsi e conoscerci con tutti, dell’altro sesso come del proprio. Era preso
sul serio, come il centro della vita, quasi con religione. E come per ogni
religione, di sesso e amore si voleva riempire la vita. E di amicizia, di
musica, di inventarsi modi di essere insieme, diversi da quelli grigi e
competitivi delle generazioni precedenti. Si provava a vivere in comune, si
provava a non essere gelosi, si provava a condividere. Ci si azzuffava e ci si
disperava come in ogni famiglia, ma il senso di essere una grandissima famiglia
sparsa per il pianeta, era forte: un grandissima famiglia che si adoperava
insieme, come esploratori delle stelle, a costruire un mondo nuovo, molto
diverso… Io mi sono sempre immaginato che le comunità quacchere dei primi coloni
europei in America, i compagni di Gesù in Palestina, i primi cristiani, i
giovani italiani del Risorgimento, i compagni di Che Guevara in Bolivia o gli
allievi di Platone nell’Academia… si sentissero un po’ così…Quel mondo non
l’abbiamo costruito, non c’è ombra di dubbio. La disillusione è arrivata presto.
Alcuni dei progetti li abbiamo abbandonati perché ci sono sembrati sbagliati.
Molti altri semplicemente perché sono gli altri che hanno vinto. La plausibilità
di quei sogni si è sciolta per la mia generazione come neve al sole. Ci siamo
separati, ciascuno è andato nella vita seguendo una sua strada. È stato inutile
sognare? Non credo. Per due motivi. Il primo è che per molti di noi quei sogni
hanno rappresentato il nutrimento fertile su cui costruire la vita. Alcuni di
quei valori sono rimasti radicati dentro di noi e ci hanno guidato. La libertà
di pensiero estrema di quegli anni, in cui tutto sembrava possibile ed
esplorabile e qualunque idea sembrava modificabile, è stata la sorgente per cui
molti di noi hanno fatto quello che poi hanno fatto nella vita. Il secondo
motivo non so se sia credibile o no. Ma esiste lo stesso. Spesso nella storia i
sogni di costruire un mondo migliore sono stati sconfitti. Ma hanno continuato a
lavorare sotterraneamente. E alla fine hanno contribuito a cambiare davvero. Io
continuo a credere che questo mondo sempre più pieno di guerra, di violenza, di
estreme disparità sociali, di bigottismo, di gruppi nazionali, razziali, locali,
che si chiudono nella propria identità gli uni contro gli altri, continuo a
credere che questo mondo non sia l’unico mondo possibile. E forse non sono il
solo.
A COSA SERVONO...
A cosa servono davvero 29
dettagli di oggetti che usiamo tutti i giorni.
Dalla fessura nel tappo delle penne Bic al secondo foro nelle linguette delle
lattine, sono molte le cose apparentemente senza senso che invece sono state
inventate con uno scopo preciso, scrive Andrea de Cesco il 15 marzo 2017 su "Il
Corriere della Sera".
1. Il mini taschino dei
jeans. Molti
oggetti di uso quotidiano sono contraddistinti da dettagli apparentemente
inutili. In realtà spesso questi particolari non sono frutto del caso, ma
rispondono a scopi precisi. Un esempio è il taschino rettangolare cucito
all'interno della tasca destra dei jeans, troppo piccolo persino per metterci le
chiavi di casa. A svelarne la funzione è stata la regina stessa dei jeans. Come
ha spiegato in un post sul suo blog l'azienda californiana Levi’s, il taschino
fu introdotto a fine Ottocento come «watch pocket»: i cowboy lo usavano per
riporre gli orologi da tasca e le pepite d’oro. Negli anni il taschino ha perso
la sua funzione originale per ospitare altri oggetti, dai preservativi (come
suggeriva uno spot del 1995 per i jeans 501) ai bigliettini da cui copiare
durante i compiti in classe.
2. I bottoni sul mini
taschino dei jeans.
A indossare i jeans 150 fa erano soprattutto operai e minatori, che lavorando
sottoponevano la stoffa a uno sforzo tale da ritrovarsi puntualmente con i
pantaloni scuciti o bucati. Nel 1971 la moglie di un lavoratore, decisa a porre
rimedio alla situazione, andò da un sarto, Jacob Davis, e gli chiese di creare
un paio di denim che non si disintegrassero così facilmente. Lui ebbe un'idea:
fissare alcuni «chiodi» a forma di bottone (il loro nome tecnico è «rivetti»)
nelle aree più delicate, quelle che entravano maggiormente in contatto con le
superfici o si danneggiavano a causa dei movimenti. Davis poi contattò
l'imprenditore tedesco Levi Strauss e, insieme, iniziarono a disegnare i nuovi
modelli di pantaloni dotati di rivetto.
3. Il tessuto «extra» che
vendono con i vestiti.
Il pezzetto di stoffa che spesso viene venduto insieme ai vestiti tecnicamente è
un campione di tessuto pensato per testare la reazione dei detersivi per bucato
su quel tessuto particolare. Così, ad ogni lavaggio, possiamo controllare che il
colore non si sbiadisca rispetto a quello originale.
4. La fessura sul manico
delle pentole.
La fessura sul manico delle pentole, in apparenza un banale vezzo
di design, in realtà serve per riporre il mestolo o qualunque altro utensile con
cui mescoliamo il cibo.
5. Il foro nel mestolo per
gli spaghetti.
Oltre che essere utile per fare passare l'acqua nel momento in cui assaggiamo la
pasta per verificarne la cottura, il foro nel mestolo per gli spaghetti ha la
funzione di dosatore. La quantità di spaghetti che ci entra corrisponde alla
porzione standard per una persona.
6. Il collo lungo delle
bottiglie di birra.
Il collo lungo e stretto, utile per impugnare più saldamente la
bottiglia e per evitare di scaldare il liquido con il calore delle mani, è
tipico delle birre chiare, carenti di schiuma e con una bassa data di scadenza.
Le birre scure e maggiormente alcoliche si trovano invece in bottiglie scure
dalla forma più larga e dal collo basso. Queste differenze favoriscono una
diversa ossigenazione e una diversa fermentazione in base al tipo di birra.
7. La rientranza sul fondo
delle bottiglie di vino e di champagne.
Questo tipo di bottiglia garantisce una maggiore resistenza meccanica alla
pressione dei gas contenuti nello spumante e nel vino. Inventato nel IV secolo
per lo champagne, grazie alla sua particolare conformazione il fondo «a campana»
può essere realizzato anche con un vetro sottile. Ormai è comune a tutte le
bottiglie di vino e spumante, con l'eccezione dello champagne francese Louis
Roederer di tipo «Cristal», creato nel 1876 per lo zar Alessandro II. Lo zar
chiese che la bottiglia avesse il fondo piatto e fosse trasparente (motivo per
cui venne realizzata in cristallo) poiché temeva che qualcuno potesse usare il
fondo a campana per nascondervi una bomba.
8. Il piccolo disco
all'interno del tappo delle bottiglie di plastica.
Il suo scopo è sigillare per
bene la bottiglia ed è usato soprattutto per le bevande frizzanti, in modo da
impedire la fuoriuscita del gas.
9. L'anellino sul retro
delle camicie.
Inventato negli Stati Uniti nel 1960, serviva per appendere le
camicie - specialmente negli spogliatoi delle palestre, dove solitamente non
c'erano armadietti e appendiabiti. Oggi ha più che altro una funzione
decorativa.
10. Il piccolo buco nei
finestrini degli aeroplani.
Viene chiamato «foro di respirazione» e svolge un’importante funzione di
sicurezza. Il tipico finestrino del passeggero è composto da tre pannelli.
Quello più vicino al passeggero serve solo a proteggere il pannello di mezzo. I
due pannelli più importanti sono quello esterno e quello di mezzo, che contiene
il forellino. Quando un aereo prende quota, grazie ai sistemi di
pressurizzazione la pressione all'esterno scende molto di più che dentro la
cabina. Lo scopo del forellino del pannello di mezzo è riequilibrare la
pressione fra la cabina e i due pannelli più interni, cosicché la differenza di
pressione sia quasi tutta a carico del pannello più esterno, che è il più
resistente. Nel caso il pannello esterno si rompa, quello in mezzo ne assume le
funzioni. Il forellino serve anche a rilasciare l’umidità dell’aria compresa fra
i pannelli e a impedire che si formino nuvolette o ghiaccio fuori dal
finestrino, permettendo la vista.
11. La parte blu della
gomma per cancellare.
A chiarire la funzione della parte blu delle gomme Pelikan è
stata l'azienda stessa, che presentando il prodotto ha scritto che la porzione
di gomma blu serve per cancellare «inchiostro/inchiostro colorato/penne a sfera
e pastelli». Ma la spiegazione non ha convinto molti. L'idea più diffusa è che
la famigerata parte blu funzioni solo sulle superfici particolarmente spesse.
12. Il buco sul tappo delle
penne Bic. Oltre a prevenire la perdita di inchiostro, il foro evita che i
bambini (o gli adulti) che abbiano inavvertitamente ingoiato il tappo della
penna soffochino. È dal 1991 che le norme di sicurezza prevedono che le penne
abbiano quel buchino sul cappuccio.
13. I buchini sui lati
delle All Stars.
Secondo i progettisti, la principale funzione dei due buchini è
fare ventilare il piede, evitando che sudi troppo. Ma un tempo i fori venivano
usati anche per infilarci un secondo paio di stringhe, in modo da permettere
un'allacciatura della scarpa più aderente. La Converse iniziò a produrre le All
Stars nel 1917 con l'obiettivo di entrare nel mercato delle scarpe per il
basket.
14. La freccia vicino alla
spia della benzina.
Niente di più semplice, e di più utile (soprattutto quando si usa
una macchina a noleggio in un Paese straniero): serve a indicare su quale lato
dell'auto si trova il tappo della benzina.
15. Le lineette in rilievo
sotto la F e la J della tastiera dei computer.
Queste righe, oltre che ai non
vedenti, servono anche a chi sa scrivere senza guardare la tastiera e fungono da
punto di riferimento per disporre le dita correttamente. Il tatto percepisce il
rilievo su questi tasti, riservati agli indici, e il cervello è guidato nel
disporre le restanti otto dita sul tasto convenzionalmente loro assegnato.
16. Il buchino nel
righello.
Più semplice di qualsiasi spiegazione che ci si possa immaginare. Serve —
banalmente — per appenderlo al muro.
17. Il buchino accanto alla
fotocamera dell'iPhone. Il foro in questione è un microfono con la funzione di
registrare l'audio durante i filmati e consentire la cancellazione attiva del
rumore. Grazie a questo microfono l'iPhone è inoltre in grado di riconoscere la
nostra voce in maniera più chiara, interpretando meglio i comandi vocali
utilizzati con Siri.
18. La cavità nel coperchio
della confezione di Tic Tac.
Ha la funzione di
raccogliere una singola caramellina alla volta, così da non doversene versare
una quantità imprecisata nella mano.
19. Il foro sul fondo dei
lucchetti.
In genere i lucchetti vengono utilizzati per fissare o mettere in sicurezza
oggetti che si trovano all’aperto. Il foro che si trova in prossimità della
fessura per le chiavi serve a far drenare l’acqua piovana e i vari residui di
sporcizia rimasti incastrati. Viene usato anche per lubrificare il lucchetto
attraverso olio di vaselina introdotto con una siringa.
20. Il secondo foro sulla
linguetta delle lattine.
Per utilizzarlo bisogna girare la linguetta verso l'apertura. Serve per
infilarci la cannuccia con cui bere.
21. La rigatura intorno al
perimetro delle monete.
Quando le monete erano fatte d’oro e d’argento alcuni raschiavano
via dai bordi un po’ di materiale per rubarlo. Per evitare questo inconveniente
(a causa del quale le monete, perdendo il loro peso corretto, diventavano
inutilizzabili) si è iniziato a creare monete con un particolare zigrinatura sui
bordi, così da poter vedere subito quali erano state contraffatte e quali no.
Oggi il motivo della rigatura è aiutare le persone non vedenti a distinguere fra
le varie monete.
22. La forma esagonale
delle matite.
Lo scopo di questa particolare forma — tipica soprattutto delle
matite utilizzate a scopi professionali — è garantire un’impugnatura perfetta.
Così che la mano non scivoli durante la produzione del disegno.
23. I sacchettini di
silicagel.
Questa bustina piena di palline di silicio che troviamo spesso nelle scatole di
scarpe, nelle borse e in molti altri oggetti serve per assorbire l’umidità che
si potrebbe creare nella scatola stessa.
24. I disegni sulla carta
igienica.
Servono semplicemente per aderire meglio alla pelle e ottenere una maggiore
pulizia.
25. La fessura e la staffa
in metallo seghettata all'estremità del metro a nastro.
La fessura serve per infilarci
le unghie o una vite in modo che il metro non scivoli via, mentre la
seghettatura è stata pensata per imprimere un segno sulla parete nel momento in
cui dobbiamo prendere delle misure ma abbiamo entrambi le mani occupate.
26. Le «alette» che si
aprono sul caricabatterie del MacBook.
Si tratta di un comodo ed
elegante avvolgicavo.
27. La parte zigzagata
della forcina.
La parte zigzagata è la parte inferiore della forcina, quella che va rivolta
verso il cuoio capelluto, in modo che la forcina stessa trattenga meglio i
capelli.
28. I «cilindretti»
presenti in molti cavi.
Si tratta di cilindri di ferrite, utilizzati nei cavi molto lunghi o dove serve
un'altissima precisione nel segnale elettrico al fine di eliminare i disturbi
elettromagnetici dal segnale. In sostanza servono a isolare le frequenze che
spesso si generano all’interno di apparecchiature elettroniche e che potrebbero
disturbare altri dispositivi durante l’alimentazione. Per esempio, nel caso di
cavi che collegano il monitor al PC evitano che le immagini su schermo appaiano
disturbate. Nei cavi di ultima generazione non vengono più usati, in quanto le
più recenti tecnologie li hanno resi presto inutili.
29. La fessura sul
cappuccio del taglierino.
L'utilizzo di questa fessura appare chiaro solo una volta che si
è sfilato il cappuccio, che a questo punto possiamo usare per eliminare le lame
usate. Basta inserire la punta nella fessura e muovere il cappuccio di lato,
fino a quando la lama non si spezza. Assicuratevi di non aver tirato fuori gran
parte della lama quando eseguite l'operazione, altrimenti spezzerete anche le
punte nuove insieme a quella vecchia.
LE FAKE NEWS CHE GIRANO IN
RETE.
Le (false) credenze che
crescono in Rete: 47 fattoidi da sfatare.
Napoleone era basso, la
vitamina C fa passare il raffreddore e la muraglia cinese si vede dallo spazio.
Tutte affermazioni non vere, ma a cui tutti un po’ crediamo. Ecco come stanno le
cose, scrive Vincenzo Scagliarini il 16 febbraio 2018 su "Il Corriere della
Sera".
Le gobbe dei cammelli
contengono riserve d’acqua. Napoleone era basso. L’emisfero sinistro del
cervello è quello razionale, il destro quello artistico. Lo zucchero, per i
bambini, è come una droga. L’acqua bolle più in fretta, se salata. E i vaccini
provocano l’autismo. Tutte bufale. Sono leggende popolari. E non tutte innocue.
Ma, nonostante siano state smentite più volte, continuano a sopravvivere. Sono
anche note come «fattoidi»: racconti spiegati con argomenti verosimili, ma non
verificati. Persuadono perché sono curiosi e facili da ricordare, più di
qualcosa fondato su prove scientifiche. Ecco quali sono i più comuni. E i più
sbagliati.
Il primo falso popolare
riguarda i cammelli e i dromedari. Al contrario di quello di comunemente si
pensa, le gobbe non contengono le riserve d’acqua necessarie alle lunghe
traversate nel deserto. Ma masse di grasso. Che però hanno lo stesso scopo.
Assicurare l’alimentazione per lunghi periodi. Le protuberanze possono contenere
sostanze che provvedono al nutrimento degli animali fino a tre settimane. E
quindi come si idratano? Reni e intestino sono così efficienti che riescono a
trattenere i fluidi molto di più rispetto agli organi di altre specie e il colon
ha un’elevata capacità di riassorbimento dei liquidi. In generale, questi
mammiferi possono sopportare la mancanza di cibo e acqua per circa 20 giorni.
I pipistrelli sono ciechi.
Considerati ciechi, la maggior parte delle persone pensa che i pipistrelli
abbiano a disposizione un sonar per orientarsi al buio. Vero, ma gli occhi li
hanno anche loro. Funzionano perfettamente, anche se soffrono di una forte
miopia. L’apparato visivo, infatti, si è evoluto nel tempo per migliorare le
prestazioni da vicino — per cacciare gli insetti di cui si nutrono — a scapito
di quelle da lontano. Anche se esistono specie, come i megachirotteri, che non
hanno nessun difetto nella vista e, di notte o di giorno, pianificando il volo
anche senza l’aiuto del sonar.
La cintura di castità nel
Medioevo. Altro falso popolare riguarda la cintura di castità, che secondo la
tradizione le donne nel Medioevo erano obbligate a indossare in attesa che il
marito tornasse dalla guerra — le crociate perlopiù — così che il prode
avventuriero potesse essere certo di essere accolto al suo ritorno da una moglie
fedele. Innanzitutto le fasce metalliche avrebbero causato la morte in caso di
una infezione o di una ferita. E ai tempi la cosa succedeva piuttosto spesso.
Poi avrebbero reso vane le speranze di ritrovare — oltre che alla propria donna
— anche un «piccolo erede» al rimpatrio. Come fa un bambino a crescere nella
pancia della mamma se questa è racchiusa da una cinta bloccata con un lucchetto?
Sembra invece che gli strumenti si siano diffusi più avanti, nell’800. A questo
periodo risalgono reperti attualmente conservati in alcuni musei. Non sono di
metallo, ma più morbide e sicuramente non venivano utilizzate per lunghi
periodi. Soprattutto, il loro scopo era ben diverso. Ce n’erano sì per le donne,
ma queste le indossavano di loro volontà (occasionalmente) per proteggersi dagli
stupri. Ce n’erano anche per gli uomini, imposte ai giovani per evitare che si
masturbassero. Ai tempi — puritani — questo tipo di atti veniva considerato
dannoso per la salute e peccaminoso.
La muraglia cinese si vede
dallo spazio. La Grande Muraglia cinese non si vede dallo spazio. Come
confermato dagli astronauti delle missioni Apollo, è solo una diceria: tutto
quello che si vede dalla Luna (e quindi dallo spazio) è una grande quantità di
piccoli punti gialli: le città e le strade illuminate durante la notte.
Napoleone era basso. Napoleone
non era basso. Era 1,69 m che, per l’epoca, significava essere alti sopra la
media. È una che credenza viene dal suo nomignolo “Le Petit Caporal” (il piccolo
caporale), con cui veniva chiamato dagli amici. Inoltre, le sue guardie
personali erano selezionate in base all’altezza e, per questo motivo, nei quadri
sembra sempre il più basso.
«Con Mussolini i treni
arrivavano in orario». «Quando c'era Mussolini i treni arrivavano in orario». È
un'altra bufala ormai ampiamente smentita. I lavori di ristrutturazione della
rete ferroviaria italiana erano stati compiuti prima del fascismo. E, inoltre, i
ritardi c'erano. Ma venivano nascosti, perché la puntualità diventò parte della
propaganda fascista. Che, in questo caso, è sopravvissuta alla fine del regime.
I gladiatori dicevano «Ave
Caesar». I gladiatori non pronunciavano «Ave Caesar, morituri te salutant» prima
di combattere. Tanto meno era qualcosa che si sentiva al Colosseo. Gli storici
hanno trovato una sola volta questa frase nella Roma antica. Nel 52 dopo Cristo,
un gruppo di criminali si presentò così davanti all’imperatore Claudio prima dei
giochi nei quali avrebbero combattuto a morte. Sembra che questo gesto colpì il
princeps romano, che decise di risparmiarli.
I cani sudano dalla lingua. I
cani sudano solo dalla lingua. È falso. Tutti i canidi regolano la temperatura
corporea respirando, ma hanno comunque altre ghiandole sudoripare: si trovano
per lo più sotto le zampe.
Il calabrone per la fisica non
può volare. «Per la scienza il calabrone non può volare, ma non lo sa. Per
questo continua a farlo». È una frase motivazionale che si sente spesso e
significa: «Quando si crede in qualcosa, anche l’impossibile diventa possibile».
In realtà non ci sono mai stati dubbi sul meccanismo aerodinamico che fa volare
i calabroni. L’equivoco nacque negli anni Trenta, quando l’entomologo Antoine
Magnan scrisse nel suo saggio «Le vol des insectes» che, in teoria, i calabroni
non potrebbero volare. Ma si accorse subito dell’errore e si corresse. Nel
frattempo, però, la frase riscosse tanto successo da entrare nel linguaggio
popolare. Per rimanerci.
Scrocchiare le dita fa male.
Scrocchiarsi le dita provoca l’artrite. Falso: non c’è alcuna prova scientifica.
Gli unici test dimostrano che questa pratica non infiamma le articolazioni. È
però stato rilevato che, se fatta con troppa energia, può danneggiare tendini e
legamenti delle mani.
Le diete «purificanti». Non
esiste nessuna «dieta purificante» né che «elimina le tossine». Quando
incontriamo queste espressioni, ci stanno dando un consiglio sbagliato. Le
tossine dell’organismo possono essere smaltite solo dal fegato e dai reni. Il
cibo non ha alcuna capacità di rimuoverle.
Troppe uova fanno male. Il
colesterolo delle uova fa male al cuore. Falso: è una credenza ritenuta vera
fino agli anni Sessanta. Poi è stato dimostrato che, i veri nemici sono i grassi
saturi (che non abbondano nelle uova).
Sushi vuole dire «pesce
crudo». La parola “sushi” significa “pesce crudo”. La traduzione corretta è
piuttosto “assaggio acido” e in Giappone il termine si riferisce ad una vasta
gamma di cibi preparati con il riso.
Lo sciacquone va al contrario
nell’emisfero sud. Il flusso dello sciacquone del water cambia direzione in base
all’emisfero in cui ci troviamo. La vera causa del reflusso al rovescio sono in
realtà i getti d’acqua che puntano nella direzione opposta.
Le unghie crescono anche da
morti. Le unghie continuano a crescere anche dopo morti. E come può essere,
visto che il meccanismo che favorisce la crescita dei tessuti si è spento con il
decesso? Infatti, non è. Piuttosto, è la disidratazione del corpo che avviene in
seguito alla morte che causa la ritrazione della pelle attorno ai capelli e alle
unghie, dando quindi l’impressione che siano cresciuti.
I tori si arrabbiano con il
rosso. I tori sono attirati dal colore rosso. È scientificamente dimostrato che
i tori distinguono solo il giallo e il blu. La loro reazione al drappo rosso è
scatenata esclusivamente dal movimento rotatorio.
Bisogna stare lontano dal
microonde. Le radiazioni del microonde causano il cancro. Preconcetto
assolutamente ingiustificato: stando infatti a numerose ricerche sull’argomento,
i forni a microonde non producono energia sufficiente a danneggiare il Dna
cellulare e quindi non possono causare un tumore.
Svegliare un sonnambulo è
pericoloso. Svegliare un sonnambulo può essere pericoloso per la sua salute. In
realtà, rischia solo di lasciarlo un po’ sorpreso e disorientato, senza però
procurargli alcun danno fisico.
Gli antichi romani erano
bulimici. Durante i banchetti, gli antichi romani vomitavano pur di continuare a
mangiare. Falso, ma c'è chi si è spinto oltre: le case dei nobili avevano un
«vomitorium» una stanza creata per questo scopo. Anche questa una bufala.
Nessuna fonte documenta questa pratica. Certo, la parola può ingannare, ma i
«vomitoria», erano gli ingressi laterali dei teatri. (da «vomere», espellere).
Buddha è grasso. Buddha in
realtà non è grasso. L’asceta indiano Siddhārtha Gautama, che ha fondato questa
filosofia è magro, come mostrato in questa statua del IV secolo dopo Cristo. Il
personaggio calvo, sorridente e con il pancione rotondo viene dalla tradizione
cinese. Il suo vero nome è Budai, un eroe popolare del X secolo venerato per
essere l’incarnazione di Maitreya (il futuro Buddah).
Il 25 dicembre è il compleanno
di Gesù. Gesù non è nato il 25 dicembre. Nei Vangeli non c’è mai questa data. È
stata fissata da papa Giulio I nel 350 dopo Cristo. È stata scelta per due
ragioni: la prima, perché si credeva che l’immacolata concezione fosse avvenuta
il 25 marzo, la seconda per rimpiazzare la festa pagana del «Sol Invictus», che
cadeva lo stesso giorno e concludeva il ciclo dei Saturnali, la celebrazione
radicata a Roma.
I Magi sono dei Re. Nei
Vangeli non ci sono i «tre magi». Né si fa riferimento a loro come re, tanto
meno si parla di cammelli con i quali avrebbero viaggiato. Troviamo un generico
«alcuni magi». Il numero è stato ricavato perché si parla di tre doni portati a
Gesù che gli artisti, a partire dal III secolo, hanno messo in mano a tre
personaggi diversi nelle scene della natività.
I vaccini provocano autismo. I
vaccini possono provocare autismo. Questa è una delle bufale più pericolose. Non
c'è alcun tipo di prova scientifica. Eppure tra le più difficili da sradicare.
Perché viene agganciata a teorie complottiste e ad argomentazioni
pseudo-scientifiche. Crederci, e rinunciare al vaccino esavalente, può mettere a
rischio la vita di un bambino. È uno dei falsi miti da combattere.
I geni hanno l’emisfero destro
più sviluppato. Non esiste alcuna divisione dei talenti tra emisfero destro e
sinistro del cervello. Alcune funzioni, come quella del linguaggio, tendono
attivare un'area specifica del cervello, ma niente di più. Inoltre, se questa
zona è stata danneggiata durante l'infanzia, queste capacità si collocano
altrove, senza che ci siano menomazioni. Tutto ciò è noto da sempre, eppure
continuano a circolare test e mappe (come quella qui sopra) nelle quali vengono
associate qualità personali alle zone del cervello. Che portano a conclusioni
strambe come: «Sei creativo: vuol dire che nel tuo cervello prevale l'emisfero
destro».
Il terzo mondo sono i Paesi
più poveri. Terzo mondo non significa «Paesi sottosviluppati». È un termine che
continua a essere usato, ma non ha più senso. È stato coniato negli anni
Cinquanta dall'economista francese Alfred Sauvy per definire l'assetto
geopolitico dopo la Seconda guerra mondiale. E cioè: primo mondo, dove c'era
l'economia di mercato; secondo mondo, il blocco socialista; terzo mondo, i Paesi
non allineati, e quindi quelli africani.
I fulmini non colpiscono mai
lo stesso punto. I fulmini colpiscono lo stesso punto una sola volta. Anche
questo è falso (e pericoloso). I fulmini si scaricano prima di tutto sugli
oggetti alti o metallici. Se quindi un albero è già stato colpito, non diventa
affatto un punto sicuro.
Prima di Copernico, nessuno
sapeva che la terra era rotonda. Nel Medioevo non si pensava che la Terra fosse
piatta, è sempre stata una leggenda popolare. Che fosse rotonda era già noto ai
greci (Eratostene ne aveva già calcolato la circonferenza, anche se
sovradimensionandola) e queste conoscenze non furono mai dimenticate. La verità
è questa: Cristoforo Colombo incontrò difficoltà nel trovare finanziamenti al
suo viaggio perché si pensava che non avrebbe mai avuto provviste sufficienti
per la traversata oceanica fino alle Indie. E i consiglieri dei regnanti non
avevano tutti i torti. Il navigatore genovese aveva a sua volta sbagliato a
calcolare la circonferenza terrestre, ritenendo il pianeta molto più piccolo e,
se non avesse incontrato il continente americano a metà tragitto, avrebbe finito
i viveri prima di raggiungere l’Asia.
Jihad vuol dire «guerra
santa». Jihad non significa «guerra santa». Può esser tradotto alla lettera come
«sforzo» (per questo è più corretto usare il sostantivo al maschile) e indica la
battaglia interiore che un musulmano deve compiere contro le tentazioni. Però è
una parola malinterpretata tanto dai media quanto dai fondamentalisti islamici.
E dalla propaganda di Daesh.
Il sole è giallo. Il vero
colore del Sole è il bianco. Lo vediamo giallo solo quando è vicino
all’orizzonte, per effetto della «diffusione ottica». Nonostante ciò
nell’immaginario collettivo è sempre giallo. Il perché abbiamo tutti
quest'immagine fissa, non è ancora stato chiarito dalla scienza.
L’Everest è la montagna più
alta del mondo. L’Everest è la montagna più alta del mondo. Anche se lo
riportano tutti i libri di geografia, tecnicamente potrebbe non essere così: la
cima dell’Everest è ufficialmente la più alta al mondo sul livello del mare
(8.848 metri), ma il vulcano hawaiano Mauna Kea (letteralmente, “montagna
bianca”) è il monte più alto della Terra se misurato rispetto alla base, che si
trova a quasi 5.761 metri sotto il livello del mare e che, uniti ai 4.205 metri
di altezza, gli permettono di raggiungere i 9.966 metri complessivi.
Ogni anno di un uomo equivale
a 7 anni di un cane. Un anno dell’uomo equivale a sette del cane. Se è vero in
alcuni casi, questo però non significa che lo sia sempre, perché in realtà
dipende dalla razza e dalla stazza del cane.
Ogni zona della lingua
controlla un gusto. Le diverse zone della lingua rivelano gusti differenti.
Credenza ufficialmente confutata da una ricerca che ha dimostrato che tutta la
lingua è coinvolta nel processo gustativo, sebbene alcune parti di essa siano
più recettive di altre a determinati gusti.
Gli esseri umani hanno 5
sensi. Gli esseri umani hanno cinque sensi. Vero, anche se in realtà i sensi
sono almeno nove e per qualche ricercatore addirittura più di ventuno, ma udito,
vista, tatto, olfatto e gusto sono quelli comunemente riconosciuti.
I biscotti della fortuna sono
cinesi. I biscotti della fortuna sono una tradizione cinese. In realtà hanno
un’origine nippo-americana e solo successivamente sono entrati nella cultura
cinese.
I vichinghi avevano elmi con
le corna. I Vichinghi indossavano elmi con le corna. Anche se in genere siamo
abituati a vederli rappresentati in questo modo, non c’è in realtà alcuna prova
che confermi la predilezione di copricapi con le corna da parte di questo antico
popolo.
Il «frutto proibito» è una
mela. Il frutto proibito di cui si parla nel Libro della Genesi è una mela.
Spulciando le pagine della Bibbia, non si trova alcuna menzione della mela come
frutto proibito.
La vitamina C cura il
raffreddore. La vitamina C è efficace contro il raffreddore. Consiglio
tramandato da generazioni ma non per questo vero: secondo gli studiosi non ci
sarebbero infatti prove concrete che la vitamina C curi il raffreddore; casomai,
può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, così da proteggere l’organismo
dagli attacchi del virus.
Marte è rosso. Marte è rosso.
Il colore rosso del quarto pianeta del sistema solare è solo un effetto dovuto
alla grande quantità di ossido di ferro presente nelle rocce superficiali.
I girasoli seguono il sole. Un
preconcetto assai diffuso sostiene che le corolle dei girasoli seguano il sole
nel cielo quando sono in piena fioritura. La verità è invece che l’allineamento
uniforme dei fiori è il risultato di un fenomeno noto come “eliotropismo”, che
tende ad orientare foglie e fiori nella direzione del sole grazie ad alcune
cellule motrici poste al di sotto del bocciolo.
Non usiamo tutto il cervello.
Le persone usano solo il 10% del cervello. Si tratta di un falso mito, spiegano
i neurologi, perché l’essere umano usa virtualmente tutto il cervello e molte
parti di esso sono attive quasi senza sosta.
Il sangue senza ossigeno è
blu. Prima di essere ossigenato, il sangue è blu. Falso, il sangue è sempre
rosso, sebbene la gradazione possa differire a seconda dei livelli di ossigeno.
Il pesce rosso ricorda solo
gli ultimi 3 secondi. Il pesce rosso ha una memoria di tre secondi. Povero
pesciolino! In realtà, ha un’ottima memoria per essere un pesce e può essere
persino addestrato a reagire alla luce e a certi tipi di musica.
Fare il bagno dopo mangiato fa
male. Bisogna aspettare almeno un’ora dopo che si è mangiato prima di poter fare
un bagno in tutta sicurezza - Dopo mangiato il sangue viene attratto verso
stomaco e intestino, che devono «lavorare» per digerire. Quindi ne rimane a
disposizione meno per i muscoli e per il resto dell’organismo. Se si svolge
un’attività fisica intensa dopo mangiato si verifica quindi una «competizione»
fra apparato digerente e muscoli che «si contendono» il sangue. Questo può
comportare una difficoltà a digerire o una particolare stanchezza, che può
portare in qualche caso allo svenimento per «furto di sangue» al cervello. Se
ciò accade in acqua è chiaro che ci sono dei rischi, perché si rischia
l’annegamento. Ma un conto è fare una lunga nuotata in mare, soprattutto se
l’acqua è fredda. Un altro conto è pucciarsi è «pucciarsi» in acqua calda o
tiepida, magari in una piscina (o persino nel bagno di casa). È evidente che il
rischio è diverso.
Quando siamo più vicini al
Sole, è estate. Le stagioni sono legate alla vicinanza della Terra al sole. In
verità il fenomeno delle stagioni è causato dall’inclinazione della Terra sul
proprio asse di rotazione (lo ricorda anche Wikipedia): nel corso dei mesi muta
l’angolo di incidenza dei raggi solari che raggiungono la superficie del nostro
pianeta. Quindi, quando un emisfero si trova in inverno, i raggi solari
colpiscono la superficie con una maggiore inclinazione rispetto all’orizzonte.
Dunque si ha un minore grado di irraggiamento: l’atmosfera e la superficie
assorbono meno calore e tutto l’emisfero risulta più freddo. Viceversa, quando
in un emisfero è estate, i raggi tendono al perpendicolo rispetto all’orizzonte
e sia l’atmosfera che la superficie assorbono maggior calore, con un conseguente
aumento di temperatura.
Il cioccolato fa venire i
brufoli. Mangiare tanto cioccolato fa venire i brufoli. Un luogo comune caro
alle nostre nonne che però non sarebbe avallato da alcuna prova scientifica.
Gli struzzi impauriti mettono
la testa sotto la sabbia. Gli struzzi nascondono la testa sotto la sabbia quando
hanno paura. La verità è un tantino diversa. Gli struzzi ingoiano ciottoli per
aiutarsi a digerire il cibo, ma per riuscire a trovarli sono costretti a mettere
la testa sotto alla sabbia. Quindi la paura non c’entra proprio nulla.
Il pomodoro è un ortaggio. Il
pomodoro è un ortaggio. Errore: è un frutto e appartiene alla famiglia delle
solanacee, di cui fanno parte anche patata, peperone e melanzana. Non a caso,
gli Aztechi lo chiamavano “tomaltl”, che significa appunto “frutto polposo”.
L’HA DETTO LA TELEVISIONE!
LE FAKE NEWS DI STATO.
Disinformazia. La
comunicazione al tempo dei social,
libro di Francesco Nicodemo. Undici anni fa «Time» incoronò persona dell’anno
«You»: «You control the Information Age. Welcome to your world» si leggeva in
copertina. Ma è davvero così? Siamo noi a controllare l’informazione grazie alla
rete? A ben vedere, il «rumore di fondo» ha preso il sopravvento, disorienta i
cittadini e ne influenza le decisioni. Vaccinare i propri figli, iniziare una
terapia medica, fidarsi della scienza o lasciare che si insinui il dubbio,
mettendo in discussione certezze ormai acquisite? E come agire da elettori
consapevoli? È possibile operare una scelta ponderata sottoposti come siamo al
fuoco di fila di notizie inesatte, falsi allarmismi, parole di odio? Francesco
Nicodemo prova a smascherare in questo libro le distorsioni che agiscono sulla
nostra percezione della realtà. In ballo vi è la vittoria tra due visioni
contrapposte: un mondo ripiegato su se stesso e sulle sue paure, che propone
ricette anacronistiche a problemi sempre nuovi, e uno aperto, ottimista,
orientato al progresso. Sullo sfondo, una profonda convinzione: la risposta più
decisa deve arrivare dalla politica. In che modo? «Coinvolgendo, dialogando,
usando in maniera costruttiva le potenzialità offerte dal digitale, facendo
sentire ciascuno protagonista di un progetto comune».
Disinformazia, élite e
bufale on line: un libro,
scrive Alessandro Gilioli il 3 luglio 2017 su "L'Espresso". Non sono d'accordo
con Francesco Nicodemo, e questa non è una gran notizia: da almeno quattro anni
litighiamo pubblicamente e privatamente di politica, Renzi, Jobs Act, riforma
costituzionale e altro. Del resto Nicodemo ha seguito Renzi dalle prime
Leopolde, fino a diventare tra il 2013 e il 2014 il responsabile nazionale della
comunicazione del Pd - insomma per il segretario Pd ha fatto a lungo "la
propaganda" e credo che non ci sia stato suo post a cui io non abbia
polemicamente risposto. Privatamente, tra uno scazzo e l'altro, gli dicevo
tuttavia che era sprecato per quel lavoro; e la conferma che almeno in questo
avevo ragione è arrivata in libreria con "Disinformazia - La comunicazione al
tempo dei social media", appena edito da Marsilio. Libro su cui (appunto) ho
note di disaccordo ma a cui non si può negare di volare alto nello sforzo di
interpretare alcune delle questioni più dibattute del nostro tempo - almeno per
quanto riguarda la comunicazione: fake news, post verità, "camere dell'eco" e
filter bubble sui social, effetto degli algoritmi proprietari, pregiudizi di
conferma ("bias"), clickbaiting, odio in Rete e trollismo. Il tutto connesso
(secondo l'autore) con alcuni degli esiti politici più recenti, come Brexit e
Trump ma più in generale l'affermarsi nel dibattito di controversie basate su
bufale a proposito di vaccini, migrazioni e complotti vari. L'approccio con cui
Nicodemo cerca di analizzare i temi di cui sopra si basa tanto sulla sua
esperienza quotidiana di comunicatore quanto sulle risposte che provano a dare i
maggiori studiosi della rete e sui dati delle ricerche più recenti e
approfondite in merito. Quello che ne esce, secondo Nicodemo, è una "tempesta
perfetta" a cui tante concause diverse hanno contribuito (marciando divise ma
colpendo unite) fino a creare un caos informativo, un rumore di fondo talmente
potente da coprire i dati di realtà, fino al riunirsi in tifoserie da curva sud
contrapposte e spesso ugualmente malinformate. Tra queste concause, Nicodemo
ipotizza che sia particolarmente significativa quella delle "solitudini globali"
(evidente il riferimento a Bauman) proprie delle società in cui sono sparite le
vecchie strutture aggregative e non si sono ancora create quelle nuove. Ma
accanto a queste, l'autore cita possibili altre cause, a partire da quando è
nato l'Internet 2.0 e da lì la comunicazione è diventata orizzontale e
degerarchizzata, con tutte le potenzialità ma anche i rischi di questo
passaggio, specie all'interno di piattaforme (i social) i cui algoritmi
finiscono per stimolare tanto i "filter bubble" (la camere dell'eco, in cui
ciascuno frequenta solo suoi simili) quanto i "bias" (quel meccanismo per cui
ciascuno cerca solo chi conferma i suoi pregiudizi, evitando le contaminazioni
coi diversi), mentre taluni approfittano di questi meccanismi per banali
interessi economici (il clickbaiting e i profitti che ne derivano) o politici
(cioè di propaganda di parte basata consapevolmente sui falsi). Solo accennata
(e qui viene il mio primo grosso punto di disaccordo) è quella che secondo me è
la principale causa del problema, cioè la crisi reputazionale delle élite, il
crollo di autorevolezza e di credibilità dei vecchi gatekeeper della conoscenza,
della comunicazione, dell'informazione: "esperti", "tecnici", giornalisti,
analisti, economisti e via andare. Insomma di coloro che per missione dovrebbero
fornire i dati e gli strumenti di interpretazione del reale e che invece hanno
sbagliato quasi tutto, piegandosi per insipienza, cecità o malafede alla
narrazione e alla egemonia culturale che poi ha portato al cupo presente
dell'Occidente fatto di impoverimento, disuguaglianze, precarietà,
individualismo, assenza di prospettive, guerre tra poveri, pulsioni di fuga o di
rabbia. Pulsioni che poi - certo - hanno trovato espressione e declinazione
nella rete 2.0 e nei social, e magari sono state distorte dai suoi algoritmi o
strumentalizzate dai suoi pelosi "professionals", ma questa è appunto la
declinazione, non la causa profonda. Altrettanti dubbi nutro sulla ricetta
finale proposta da Nicodemo, cioè sull'affidamento alla politica in un'ottica di
ri-razionalizzaziione della comunicazione, seppur non in termini di imposizione
autocratica bensì di ricreazione di nuove forme di aggregazione sociale, insomma
di "lotta riformista" contro le solitudini globali viste come cause di fondo
degli effetti di cui sopra. Certo che la politica ha i suoi doveri; ma mi pare
che quella dominante vada da tempo nella direzione opposta a quella indicata
(compresa la parte a cui fa riferimento Nicodemo, cioè il Pd) sicché non ho
moltissima fiducia che essa abbia interesse e/o capacità, al momento, di
rovesciare la tendenza all'atomizzazione, all'individualismo, al
tutti-contro-tutti, al ciascun per sé e alla guerriglia molecolare. È, semmai,
il ribaltamento dell'egemonia culturale individualista e vincista che può forse
ridurre le cause di questa disaggregazione, di questa atomizzazione violenta. E
questo ribaltamento di egemonia è compito di ciascuno di noi - "alto" o "basso",
politico o no, professionista o meno della comunicazione - così come è
responsabilità esclusiva invece degli ex gatekeeper ("esperti", economisti,
analisti, giornalisti etc) riconquistare sul campo giorno dopo giorno quella
credibilità e quella autorevolezza che pensano di aver perso per colpa del web
2,0 e che invece hanno perso (soprattutto in Italia!) quasi esclusivamente per
colpa loro, della loro pigrizia intellettuale o del loro accomodarsi accanto al
più potente.
Facebook non è un
tribunale. Ecco perché la legge tedesca è sbagliata.
Ieri la Germania ha approvato una norma che dà 24 ore di tempo ai social network
per rimuovere qualsiasi contenuto "manifestamente illecito", e sette giorni per
quelli che lo sono ma non in maniera manifesta. Altrimenti sanzioni da 50 mila a
50 milioni di euro. Ma questo è un concetto che si evolve, e pure molto
velocemente, scrive Guido Scorza il 2 luglio 2017 su "La Repubblica".
Ventiquattrore per rimuovere qualsiasi contenuto "manifestamente illecito",
sette giorni per per rimuovere i contenuti la cui illiceità non è manifesta. E
in caso di inadempimento sanzioni da 50 mila a 50 milioni di euro. E' questa la
ricetta tedesca, diventata legge ieri, per costringere i social network e, più
in generale, i gestori delle piattaforme che consentono la pubblicazione di
contenuti prodotti dagli utenti a contribuire più attivamente rispetto a quanto
accaduto sin qui nella lotta ai contenuti illeciti online. Ma che significa
"manifestamente illecito" quando si tratta di idee, opinioni, immagini o video
pubblicate dall'utente di un social network? Certo, in talune ipotesi limite,
rispondere può essere facile o, almeno, meno difficile ma nella più parte dei
casi è un esercizio straordinariamente difficile per il più dotto e raffinato
dei giuristi, figurarsi per un moderatore in batteria di quelli schierati dai
gestori delle grandi piattaforme online nel tentativo di limitare la
circolazione di taluni contenuti online. Il confine tra l'esercizio della
libertà di parola nella più grande piazza pubblica della storia dell'umanità e
l'abuso di tale libertà è labile, sottile, sfuggente, magmatico e in continuo
divenire a un ritmo direttamente proporzionale a quello con il quale si
trasformano la cultura, lo stile di vita, il modo di parlare o la il limite di
tolleranza nei rapporti all'interno di qualsivoglia comunità da quella
famigliare a quella globale. Immagini e parole che oggi affollano la nostra
prima serata televisiva, solo una manciata di anni fa sarebbero state ritenute
illecite, offensive, ingiuriose o diffamanti persino se mostrate o pronunciate
in un circolo ristretto e protetto da solide mura. I tempi si evolvono e i
costumi cambiano e, peraltro, tutto questo non avviene contemporaneamente in
ogni angolo del mondo e neppure di un singolo Paese. Il rischio di considerare
lecito ciò che meriterebbe di essere ritenuto illecito e quello ancora più
elevato di ritenere illecito ciò che meriterebbe di essere considerato lecito è
sempre in agguato e quando si stabilisce - come ha appena fatto il Parlamento
tedesco - che a valutare se un contenuto meriti di restare online o, al
contrario di essere rimosso debba essere una società privata anziché un
tribunale il rischio inesorabilmente aumenta sino a diventare democraticamente
insostenibile. Facebook e con Facebook ogni altro gestore di piattaforme online
non sono tribunali, nei loro dipartimenti che si occupano di moderazione non
siedono giudici che rispondono solo alla legge ma dipendenti e dirigenti che, in
ultima analisi, rispondono agli azionisti e al mercato. E le regole del mercato
non sempre - anzi quasi mai - sono democratiche o, comunque, lo sono decisamente
meno delle leggi di uno Stato che, ormai, salvo - per fortuna - poche eccezioni
si ispirano a Carte costituzionali e convenzioni internazionali nelle quali è
scolpito a chiare lettere un principio secondo il quale la libertà di parola di
ogni uomo e di ogni cittadino è un diritto fondamentale. Ma non basta. La legge
tedesca, infatti, non solo confonde una corporation con un tribunale e le regole
del mercato con quelle della Costituzione ma introduce una perversa e pericolosa
variabile nel giudizio affidato ai gestori delle grandi piattaforme online:
multe multimilionarie se considerano lecito un contenuto che avrebbe dovuto
essere ritenuto illecito e omettono di rimuoverlo in una manciata di ore ma
nessuna conseguenza, di nessun tipo se, al contrario, considerano illecito e
rimuovono un contenuto che viene poi accertato essere lecito e, dunque, mettono
un cerotto sulla bocca ad un uomo che aveva semplicemente scelto Internet per
manifestare liberamente la propria opinione. Ve lo immaginate un arbitro di una
partita di pallone che rischiasse di perdere metà dello stipendio se non
fischiasse un rigore che poi la moviola accertasse dover essere fischiato mentre
non rischiasse alcunché laddove fischi un rigore che poi la moviola accertasse
inesistente? Secondo voi quell'arbitro sarebbe sereno nel suo giudizio e
indifferente nella scelta tra fischiare un calcio di rigore in ogni caso dubbio?
Quella tedesca è una legge sbagliata, è una legge muscolare con la quale, con
straordinaria miopia politica e giuridica, si immolano principi e diritti
fondamentali di uomini e cittadini - oggi utenti del web - sull'altare di una
guerra santa che non ha ragione di essere e che, peraltro, con questi strumenti
non si può vincere. Esistono oggi - e naturalmente non sarà sfuggito al
Parlamento tedesco - software che consentono con straordinaria semplicità e in
maniera completamente automatizzata di ripubblicare online un contenuto ogni
ora, minuto o secondo con l'ovvia conseguenza che se anche Facebook e soci
adempissero, a tempo di record, ai nuovi obblighi loro imposti dal Parlamento
tedesco, la quantità di contenuti illeciti presente online potrebbe non
diminuire neppure di un bit. Svuotare Internet dai contenuti illeciti senza
compromettere, in maniera importante, la libertà di manifestazione del pensiero
è velleitario tanto quanto pensare di svuotare il mare con un secchiello. Non
c'è esercito di moderatori e non c'è sanzione multimilionaria rivolta ai gestori
di questa o quella piattaforma capace di ribaltare tale conclusione. Online come
offline i contenuti illeciti si accompagnano a quelli leciti, la buona
informazione a quella cattiva, i reati di opinione alla libertà di parola. Non
esistono scorciatoie o filtri magici per fermare il male lasciando correre il
bene. Si può - e, anzi, si deve - rendere sempre più efficiente e veloce - nel
rispetto del diritto alla difesa - la giustizia dei Giudici e, in taluni
limitati casi, quella delle autorità indipendenti ma guai a derogarvi specie
quando in gioco c'è la libertà di parola.
Dietro le logiche del
controllo di Facebook: ecco perché tutela gli uomini bianchi ma non i bambini
neri.
Un’inchiesta del giornale statunitense ProPublica fa luce sui controversi
criteri in base ai quali il colosso di Menlo Park rimuoverebbe i post contenenti
discorsi d’odio. Le regole sarebbero dovute valere anche per la campagna social
sul Muslim Ban di Donald Trump, scrive Valentina Barresi il 30 giugno 2017 su
"La Repubblica". Mentre Facebook è pronto ad assoldare una nuova schiera di
sorveglianti per dare manforte agli esperti che ogni giorno si scagliano contro
i disseminatori d'odio sulle sue bacheche, l'ultima inchiesta di ProPublica fa
luce sui famigerati "algoritmi della censura" utilizzati dallo staff del social
network per tutelare i destinatari di attacchi virtuali. Nel mirino dei
controllori della piazza digitale più affollata del mondo ogni settimana
finiscono circa 66 mila post bollati come "messaggi d'odio": la scure
dell'azienda di Mark Zuckerberg si abbatte su imprecazioni, offese, incitazioni
alla violenza. Messaggi d'odio caratterizzati, però, da una particolarità. A
essere eliminati sono infatti quei post che attaccano determinate categorie
protette, definite in base a criteri universali quali "sesso, razza, identità di
genere, appartenenza religiosa, orientamento sessuale, nazionalità, etnia,
disabilità o malattie gravi". Un meccanismo semplice, che però produce esiti
paradossali quando gli hate speech sono rivolti a "sottoinsiemi" di tali
categorie, contro i quali gli utenti dietro la tastiera hanno più ampio margine
di manovra. Un esempio della giornalista Julie Angwin rende l'idea. Entrata in
possesso dei documenti interni all'azienda, la firma di ProPublica ha diffuso
uno dei quiz somministrati da Facebook ai propri revisori di contenuti: in una
slide vengono accostati una "donna autista", due "bambini neri" e un gruppo di
"maschi bianchi". Ebbene, la categoria da proteggere dagli attacchi d'odio, a
dispetto di quello che la logica comune suggerirebbe, sarebbe la terza. Quale
principio si cela dietro tale apparente arcano? Il mondo di Facebook è regolato
da una formula, in base alla quale gli "uomini bianchi" sono considerati un
gruppo tutelato dal sistema, poiché entrambe le caratteristiche di sesso e razza
che lo costituiscono sono protette. La "donna autista" e i "bambini neri" sono
invece da considerarsi sottoinsiemi: soltanto una delle due caratteristiche che
li compongono è protetta, pertanto per loro non si configura l'hate speech. Per
lo stesso principio, sono tutelate le "donne irlandesi", ma non i "teenager
irlandesi" combinazione di età (non protetta) e nazionalità (protetta).
Un altro caso che oppone
"universale" a "specifico", è quello riguardante le reazioni a un recente
attacco terroristico a Londra: Clay Higgins, deputato repubblicano della
Louisiana, ha scritto su Facebook che bisognava fare una strage di tutti i
"musulmani radicalizzati" da "cercare, identificare e uccidere". Ma il suo post
non è stato rimosso. Quando invece fu il poeta e attivista di Black Lives Matter
Didi Delgado a scrivere "Tutte le persone bianche sono razziste. Parti da questo
punto di vista, o hai già fallito", il post fu cancellato e il suo account
disabilitato per giorni. Mentre il primo post contiene un invito alla violenza
che in teoria non viola gli standard, in quanto rivolto a una specifica
sottocategoria di musulmani, il secondo è un attacco a un'intera categoria, i
bianchi, e gli algoritmi di Facebook sono istruiti per identificare post di
questo tipo e rimuoverli. Una sfida complessa, scrive ancora ProPublica, è poi
quella della gestione del dibattito politico sui social media. A essere citato è
il caso Donald Trump. Secondo i documenti analizzati dal giornale statunitense,
nei suoi post a favore del Muslim Ban, il tycoon avrebbe ripetutamente violato
le politiche di Facebook, incitando all'esclusione di gruppi protetti. In quel
caso, Mark Zuckerberg in persona è intervenuto per evitare che i messaggi
venissero rimossi, così da proteggere l'azienda da possibili accuse di
parzialità durante la campagna elettorale. "Le nostre policies non portano
sempre a risultati perfetti" ammette Monika Bickert, responsabile della gestione
globale delle politiche di Facebook - Ma questa è la realtà con cui confrontarsi
in quanto abbiamo politiche che si applicano a una comunità globale, dove le
persone in tutto il mondo avranno idee diverse su cosa va bene condividere".
Sebbene Facebook sostenga che i testi potrebbero essere leggermente cambiati
nelle versioni più recenti delle regole per la revisione dei contenuti fornite
al suo staff, gli episodi in cui il suo sistema di controllo si è rivelato
inefficace sono innumerevoli. Il principio del politically correct dietro al
meccanismo si è così ritorto contro lo stesso colosso, che ambisce a connettere
il mondo intero attraverso la sua rete, ma fallisce nel tutelare i più
vulnerabili a una ferocia virtuale dagli effetti spesso tangibili.
Perché crediamo alle
«bufale» e non vogliamo mai cambiare idea.
Che cosa ci spinge a rimanere ancorati a convinzioni smentite da prove concrete?
In gioco entrano ideologie, valori e visioni del mondo oppure paure e fobie. Ma
talvolta può diventare decisiva è la necessità di salvaguardare l’identità
personale o di gruppo, scrive Danilo di Diodoro il 2 luglio 2017 su "Il Corriere
della Sera". Cosa ci induce a credere a un fatto scientificamente provato,
oppure, al contrario, a sospettare della sua credibilità? Perché, in un momento
in cui la scienza sembra raggiungere obiettivi ogni giorno più spettacolari
cresce il malumore nei suoi confronti? Uno dei più eclatanti esempi di questo
fenomeno è la spaccatura che si è creata sul fronte delle vaccinazioni, dove si
parlano, senza capirsi, da una parte gli scienziati che portano prove
schiaccianti sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini, dall’altra gli
antagonisti che non credono a tali prove e sospettano macchinazioni dettate da
interessi e manipolazioni. La ricerca svolta negli ultimi anni in ambito
psicologico ha scoperto alcuni meccanismi che potrebbero sottostare a tale
conflitto, come quella particolare distorsione cognitiva definita “ragionamento
motivato”, una tendenza naturale che porta a selezionare le informazioni che
riceviamo in modo che corrispondano alle nostre convinzioni, mentre vengono
scartate come poco affidabili o credibili le informazioni dissonanti. Quindi il
meccanismo naturale di funzionamento della mente umana sembrerebbe per sua
natura funzionare al contrario: non sono i fatti a convincerci, ma le
convinzioni a selezionare i fatti sui quali ci basiamo. Il fenomeno del
ragionamento motivato è noto da tempo, come fa notare Kirsten Weir in un
articolo appena pubblicato dall’American Psychological Association, nel quale
viene ricordata una classica ricerca effettuata da Peter Ditto, psicologo
sociale dell’University of California: a due gruppi di soggetti furono
presentati risultati favorevoli o sfavorevoli di un test medico fittizio sulla
funzionalità del loro pancreas. Chi aveva ricevuto un responso di malattia era
molto più propenso dei partecipanti dell’altro gruppo a screditare
l’affidabilità del test e a cercare una seconda opinione. Potrebbe anche
sembrare naturale: perché mettere in dubbio una buona notizia e non invece una
cattiva, che, fra l’altro, apre la strada a esami e cure magari inutili? Però
altre ricerche hanno confermato questa tendenza a non accettare facilmente
informazioni che ci mettono in difficoltà, ma anche quelle che contrastano con
le nostre profonde convinzioni personali, con i nostri valori morali o perfino
con quelli del gruppo nel quale ci identifichiamo. «Persone convinte che la
ricerca sulle cellule staminali sia moralmente riprovevole quasi sempre dubitano
che abbia qualche probabilità di indurre futuri passi avanti significativi in
Medicina», dice Brittany Liu, dell’University of California, che insieme a Ditto
ha pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science un
articolo su come le valutazioni morali diano forma alle convinzioni. L’articolo
è basato su una complessa ricerca composta da tre diversi studi sperimentali
sulla psicologia delle scelte individuali e ha dimostrato come più forte è la
convinzione che una persona già ha, più radicata è la sua idea di avere tutte le
informazioni necessarie, e più decisa sarà la sua attività di selezione dei
fatti provenienti dal mondo esterno, in modo che corrispondano a tali
convinzione e idea. Eppure i fatti, soprattutto quelli provenienti dalla
scienza, dovrebbero avere una solidità e un’incrollabilità tali da non dover o
poter essere discussi. Viene attribuita al sociologo e senatore americano Daniel
Patrick Moynihan la frase: «Tu hai diritto ad avere le tue opinioni alle quali
credere, ma non dovresti avere diritto ad avere i tuoi fatti ai quali credere».
In realtà i fatti scientifici sono continuamente messi in discussione, come se
la scienza non riuscisse ad affermarsi al di fuori di certi ambiti, oltre i
quali sembrano vigere tranquillamente altre regole. Dice in proposito Matthew
Hornsey, professore di psicologia alla University of Queensland australiana:
«Malgrado il fatto che il 97 per cento degli scienziati climatologi concordi sul
fatto che il rilascio di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera
influenzi il nostro clima, circa un terzo della popolazione dubita che il
cambiamento del clima sia causato primariamente dall’attività umana. Dopo una
riduzione durata circa un secolo nel tasso di malattie infettive, c’è stato un
recente aumento di morbillo, rosolia, parotite, pertosse, una tendenza in parte
attribuibile all’errata convinzione che le vaccinazioni possano causare malattie
piuttosto che prevenirle». Secondo il professor Hornsey che ha pubblicato,
insieme a Kelly Fielding, un articolo in merito sulla rivista American
Psychologist, posizioni così apertamente antiscientifiche sono, da un punto di
vista psicologico, la punta dell’iceberg, quelle che lui chiama “attitudini di
superficie”. Sotto covano le cosiddette “radici delle attitudini”, che non sono
modificabili dalle prove scientifiche: ideologie, valori e visioni del mondo, ma
anche la necessità di salvaguardare identità personale o di gruppo, oppure
profonde paure personali e vere e proprie fobie. In Internet si possono trovare
informazioni medico-sanitarie completamente fasulle, ma anche informazioni
“certificate”, se si sa dove cercare. «Purtroppo oggi i risultati della ricerca
medica sono in gran parte comprensibili solo da chi ha familiarità con la
metodologia degli studi, con la lingua inglese e ha accesso alle principali
riviste scientifiche internazionali», dice Roberto D’Amico, direttore del Centro
Cochrane Italiano, che opera per far sì che le decisioni sanitarie possano
essere prese seguendo criteri scientifici. «Tuttavia esistono esperienze
finalizzate a rendere più facile l’accesso a informazioni mediche affidabili da
parte dei cittadini. Ad esempio, per capire come funzionano le sperimentazioni
cliniche si può visitare il sito Ecran (European Communication on Research
Awareness Needs) La sperimentazione è la modalità attraverso la quale sono
valutati in maniera scientifica efficacia e sicurezza degli interventi sanitari,
e molti degli interventi oggi utilizzati sono stati prima valutati con il metodo
dello studio randomizzato controllato. «Quando viene ben eseguito, questo tipo
di studio fornisce risposte basate su dati oggettivi che permettono di ridurre
l’incertezza e talvolta di annullarla», continua D’Amico. Su un singolo
intervento possono essere realizzati più studi randomizzati e controllati,
durante i quali efficacia e sicurezza di un nuovo farmaco sperimentale vengono
confrontate con quelle di un altro farmaco già conosciuto o di un placebo.
«Talvolta si hanno risultati discordanti. Per questo sono state sviluppate le
revisioni sistematiche, che consentono di fare una sintesi ragionata dei
risultati dei singoli studi, sulla quale ci si può poi basare per decidere
concretamente quale trattamento scegliere».
Perché crediamo alle bufale
sul web,
scrive Elena Meli, Corriere della Sera - 30 ottobre 2016 - pagina 48. Le false
informazioni sulla salute ci toccano molto da vicino e coinvolgono la nostra
emotività Per questo hanno più successo di altre. La “bufala del cioccolato” ha
fatto scalpore circa un anno fa, tanto da diventare un caso di studio perfino
per la prestigiosa scuola di giornalismo della Columbia University: un biologo e
giornalista scientifico di Harvard, John Bohannon, assieme a due documentaristi
tedeschi, ha condotto un falso studio clinico sostenendo che la cioccolata
facesse dimagrire, lo ha fatto pubblicare su una rivista non troppo attenta ai
dettagli e poi ha fatto circolare un comunicato stampa sul tema. Sbalordito, ha
visto decine e decine di giornali sparare il titolo in prima pagina: nessuno si
era preso il disturbo di leggere a fondo il testo, controllare i dati, capire
che si trattava di una ricerca piena di falle. Le bufale in medicina si
diffondono anche così, come spiega Bohannon: «Molti redattori non l’avranno
neppure letto: sanno che periodicamente escono studi che dimostrano le virtù del
cioccolato e tanto è bastato per pubblicare anche questo». Scarsa attenzione dei
giornalisti a parte, Bohannon tocca uno degli elementi che spiegano perché le
bufale su salute e benessere sono così diffuse: se una notizia “piace”, finiremo
per crederla vera. «Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma esseri
emotivi che pensano: la prima area del cervello che si attiva di fronte a un
messaggio è sempre quella deputata alle emozioni, solo dopo si accende la
corteccia razionale — interviene Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei
consumi e neuromarketing alla Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm
di Milano — . In altri termini scegliamo emozionandoci, poi troviamo una
giustificazione a ciò in cui crediamo: siamo razionalizzatori, più che
razionali». «Un meccanismo ben conosciuto e sfruttato dal marketing — prosegue
Russo — per esempio, per venderci cibi che immaginiamo più buoni o sani solo
perché in etichetta c’è scritto “biologico” o “prodotto locale”, termini che
oggi attirano la nostra attenzione e che associamo al benessere. Sulla salute è
più facile che bufale e false credenze si diffondano proprio perché è un settore
che coinvolge molto più di altri l’emotività». Così eccoci pronti a essere
convinti che la cioccolata faccia dimagrire o anche a credere a cose ben
peggiori, dai vaccini male assoluto alle cure anticancro miracolose che sono in
realtà acqua fresca. Stando agli psicologi, la tendenza a credere alle bufale
così come ai complotti (dalle scie chimiche ai medici che non vogliono curare il
cancro per lucrare con farmaci costosi e inutili) si associa a tratti del
carattere come la mancanza di fiducia sociale, ovvero la tendenza a credere che
gli altri siano in genere poco onesti e sinceri; contano poi il “cinismo
politico”, ovvero un’idea generalmente negativa del sistema e delle istituzioni,
e una bassa autostima che porta a pensare di non poter far mai molto per
cambiare le cose (invece conoscere retroscena che gli altri ignorano o essere al
corrente di qualche verità, qualsiasi essa sia, fa sentire già un po’ più
“potenti”). «Subiamo anche il cosiddetto “pregiudizio della conferma”: dal punto
di vista cognitivo ed emotivo è meno faticoso accettare tutte le informazioni
che avallano le nostre credenze, giuste o sbagliate che siano – osserva
Guendalina Graffigna, docente di Psicologia applicata al marketing sociale
all’Università Cattolica di Milano –. Le bufale ci sono sempre state e si sono
sempre diffuse con il passaparola, adesso l’entità del fenomeno è enorme grazie
al web dove troviamo tutto e il suo contrario e chiunque riesce a reperire
informazioni che comprovano qualsiasi ipotesi, rafforzando le proprie idee. Non
basta: se accediamo a questi contenuti e magari apponiamo un “mi piace” sui
social, gli algoritmi di Internet ci proporranno poi notizie e dati in sintonia
con ciò che abbiamo apprezzato rinforzando ancora di più questa “bolla
informativa” e l’autoselezione delle informazioni». Come difenderci allora?
«Allenando il senso critico e dando credito solo a fonti di informazione
autorevoli — risponde Graffigna —. Purtroppo sono percepite distanti,
autoreferenziali e vengono messe in discussione, in gran parte perché hanno un
modo di comunicare “antico”, poco social: sui siti ministeriali e simili le
informazioni sono date senza tener conto della voglia dei cittadini di essere
protagonisti dei percorsi di cura, di avere un ruolo attivo e dire la propria».
«Il gran proliferare delle bufale — sottolinea l’esperta — è anche sintomo di
questo desiderio di partecipazione che poi prende le strade più disparate». «Il
“tutti ne parlano” trova in breve una sua veridicità a prescindere dai
contenuti, quando viaggia sul web: la gente ritiene veritiere le informazioni
trovate in rete nel 59 per cento dei casi — riprende Russo —. Del resto siamo
“semplificatori”, crediamo a ciò che riusciamo a capire o che conosciamo: se non
siamo motivati o non abbiamo competenze per decidere su un argomento, ci
facciamo guidare da ciò che stimola di più l’emozione.
«È vero per tutto ciò che
riguarda la salute e il benessere — conclude Russo — ed è evidente nella
comunicazione nel settore alimentare, come sanno bene i pubblicitari: non
sarebbe affatto necessario scrivere sulla confezione d’acqua che aiuta la
diuresi, perché tutta l’acqua lo fa, ma la frase si rivolge alla “pancia” del
consumatore e gli fa credere che il contenuto di quella bottiglia sia meglio di
quello di tutte le altre anche se non lo è».
L’ha detto la Televisione,
scrive il dr Daniele Aprile in "Psiche e Soma" il 16 maggio 2013. Le notizie
possono modificare idee e comportamenti? Si, ma solo in pochi casi…Quasi tutti
gli italiani guardano il telegiornale e seguono regolarmente alla tivù programmi
culturali e d’attualità, per la precisione il 68,6 per cento (rispetto all’83
per cento che guarda la tivù ogni giorno). Il 60,2 per cento legge i quotidiani
e il 32,6 ascolta abitualmente i radiogiornali. Lo rivela l’indagine dell’Istat
(l’Istituto di statistica) sui nostri comportamenti quotidiani. Riceviamo dunque
ogni giorno da giornali, radio e televisione un vero bombardamento di
informazioni. Secondo una teoria psicologica ogni notizia è come l’iniezione di
un farmaco: ha un’influenza immediata sul comportamento delle persone, proprio
come una medicina che, appena iniettata, scatena subito una reazione
dell’organismo. Qual è dunque l’effetto delle notizie sulle persone? Davvero
riescono a modificarne opinioni, comportamenti e scelte? E possono anche
influire sul nostro inconscio? La risposta è sì, ma in modo diverso a seconda
delle caratteristiche individuali, dei mezzi di informazione che ce le danno e
di come ce le presentano di volta in volta. In realtà i mezzi di comunicazione,
più che alterare direttamente il modo di pensare e di agire del pubblico,
selezionano gli argomenti sui quali tutti “devono” avere un’opinione. Quando i
giornalisti diffondono determinate notizie, escludendone altre, creano una
specie di “mappa dei fatti” sulla quale si concentra, e discute, la popolazione.
C’è poi una seconda selezione: fra le notizie proposte da stampa, radio e
televisione, ognuno sceglie quelle che lo interessano di più. Sui quotidiani,
per esempio, gli adulti e i ragazzi leggono soprattutto gli articoli di politica
e di attualità (70,3 per cento dei lettori), mentre le donne si concentrano
sulla cronaca locale (76 per cento). Tutti, però, tendono a rivolgersi alle
fonti d’informazione con le quali si sentono più in sintonia. Perfino durante le
campagne elettorali, invece di confrontare il programma dei vari partiti, ci si
informa prevalentemente attraverso i giornali che rispecchiano la propria
ideologia. E si seguono i programmi radio e televisivi che danno più spazio al
partito di appartenenza. Insomma, ognuno cerca di costruirsi un’informazione su
misura, che rispecchi il più possibile il proprio punto di vista.
E se, invece, non si ha ancora
un’opinione su un avvenimento? In questo caso, i servizi giornalistici possono
influenzare i giudizi delle persone. Ma, per riuscirci, ne devono prima
catturare l’attenzione. Il pubblico, in realtà, riesce a memorizzare soltanto
una minima parte delle notizie diffuse dai vari canali d’informazione. Ecco
perché più i messaggi sono brevi, ripetuti e semplici (richiedono, cioè, un
minimo sforzo di comprensione), più vengono recepiti e hanno, quindi,
possibilità di orientare le scelte delle persone. Lo confermano tutte le
ricerche psicologiche più recenti, condotte sia in Europa che negli Stati Uniti,
nelle quali sono state analizzate anche le caratteristiche più efficaci delle
informazioni “persuasorie” per eccellenza: quelle pubblicitarie e quelle diffuse
durante le campagne elettorali. I risultati sono identici: in entrambi i casi,
infatti, le persone condividono, o comunque accettano più facilmente, i messaggi
che hanno uno o più elementi a loro familiari. Ciò favorisce un processo di
identificazione con l’autore, e perfino con il contenuto che le sue parole hanno
espresso. Inoltre, di solito ci si lascia convincere più facilmente se chi
lancia il messaggio è un personaggio di successo, sul quale inconsciamente si
trasferisce la responsabilità della propria, eventuale adesione. Le informazioni
“persuasorie” producono, secondo gli studiosi, “effetti limitati” sulle persone,
proprio perché di solito hanno un unico obiettivo da raggiungere, e in breve
tempo: durante e subito dopo una “campagna” sulla ricerca scientifica, per
esempio, la popolazione reagisce versando ai centri di ricerca una maggior
quantità di finanziamenti. Poi, però, la campagna d’informazione finisce e tutto
torna come prima.
Le notizie, dunque, esercitano
soltanto un’influenza temporanea? Niente affatto. Anzi, possono anche suscitare
reazioni profonde, imprevedibili. E’ accaduto con la guerra del Golfo, nel 1991:
durante la prima settimana, le immagini del conflitto tennero incollati davanti
allo schermo 9 milioni di italiani. Suscitando nelle persone anziane insonnia,
paura, ricordi angosciosi della seconda guerra mondiale.
Oggi, insomma, le notizie
puntano sempre più spesso sul coinvolgimento emotivo del pubblico. Ma, in questo
modo, colpiscono direttamente l’inconscio delle persone. In particolare, le
notizie presentate in modo drammatico e che riguardano un episodio violento,
come un omicidio, stimolano in ognuno sia le tendenze sadiche che quelle
masochistiche. Cioè le due forze aggressive contrapposte che covano in ognuno di
noi, così scatta una doppia paura: quella di essere violenti e quella di subire
un’aggressione. Eppure, le centinaia di informazioni su incidenti, rapine,
violenze d’ogni tipo che tutti ricevono quotidianamente sembrano cadere
nell’indifferenza. Il fatto è che non siamo in grado di sopportare notizie
sconvolgenti. Mancano sicurezze, e modelli di riferimento precisi attraverso i
quali filtrare la realtà. Inoltre non riusciamo a elaborare tutte le
informazioni che riceviamo ogni giorno. Risultato: ci difendiamo con il
distacco. Si tratta, però, di un distacco apparente. Perché, dietro
l’indifferenza, le notizie continuano a esercitare in ognuno una profonda
influenza, in modo diverso a seconda della personalità. I messaggi violenti o
preoccupanti possono far vacillare o, addirittura, far crollare le difese di un
individuo. Provocando in lui forti angosce, o liberando i suoi aspetti più
nascosti. Per esempio, di fronte alla notizia di un suicidio, in chi ha represso
per anni il desiderio di compiere quel gesto può scattare l’impulso ad agire.
Secondo lo studio di un sociologo australiano, Riaz Hassan, la media quotidiana
dei suicidi sale di circa il 10 per cento nei 2 giorni successivi alla comparsa
sui giornali della notizia di un suicidio. Secondo gli psicologi, infatti, c’è
una parte inconscia in noi che, assistendo alle tragedie altrui, riesce a
scaricare tensioni e provare in qualche modo sollievo. Un meccanismo morboso,
cioè quasi patologico e in genere del tutto incontrollabile. Le notizie, dunque,
possono provocare ansia, angoscia, liberare gli aspetti repressi di sé, spingere
alla violenza, alimentare un sottile compiacimento sadico. Tutto questo accade,
in particolare, a chi non possiede una “interiorità strutturata”, cioè alle
persone psicologicamente più deboli, come disturbati psichici o semplici
depressi, o a chi attraversa un momento di particolare fragilità. Ma tutti, in
un modo o nell’altro, subiscono l’influenza delle notizie.
Come difendersi? L’unico modo,
dicono gli esperti, è utilizzare più canali d’informazione, per contrapporre
alle insidie delle tecniche giornalistiche una preparazione più solida e una
maggiore capacità di giudizio.
La televisione è la
detentrice della verità?
Scrive Rolando Tavolieri. Mi chiamo Rolando Tavolieri e sono uno
Psicologo, iscritto all'ordine degli [...] In tanti anni di televisione, di
programmi seguiti, di talk show, di approfondimenti ed altro, possiamo notare
come tutto ciò che viene detto, commentato e scandito dai programmi televisivi
viene accettato per vero, viene recepito come reale, senza però accertarci se
questa o quella notizia sia vera. In pratica da tanti anni ciò che ascoltiamo in
televisione attraverso vari programmi televisivi, nei talk show, nei programmi
di intrattenimento, nei telegiornali, nei programmi di informazione o di
approfondimento, tutte le informazioni che ci vengono date, tutto ciò che viene
detto o riferito, i dibattiti che ne seguono e le interpretazioni di ciò che
accade da parte di presentatori, giornalisti, politici, persone coinvolte ed
altri, viene accettato in modo passivo come reale, come vero.
Ad esempio ti è mai capitato
di sentire diverse persone affermare:
“questa cosa è vera, l’hanno
detta in tv!”;
“dobbiamo comprare quel
farmaco,l’ha detto un medico in tv”;
“dobbiamo mangiare quel cibo,
l’ho sentito dire in quel programma”;
“domani piove, l’ho ascoltato
in tv!”;
“hai seguito il caso di
quell’omicidio? Sicuramente è stata la tal persona, perché l’hanno detto in
televisione”.
Potrei andare avanti facendo
centinaia di altri esempi in cui puoi constatare come la televisione è
diventata ERRONEAMENTE la detentrice della verità, questo fenomeno di percepire
le notizie e le interpretazioni che vengono fatte come reali, spesso è un
fenomeno inconscio, ad esempio quando un personaggio famoso, politico, sportivo
o del mondo del cinema viene “indagato”, la prima impressione che possiamo avere
è che sia “colpevole”, in pratica scambiamo le indagini in corso fatte su una
persona per sapere se è realmente colpevole o se è innocente, per colpevolezza
prima ancora che le indagini vengano fatte o approfondite. Certo lo facciamo
inconsciamente, inconsapevolmente, ma una volta che questo processo viene
innescato, è difficile controllarlo, perché il messaggio che viene assorbito
dalla mente inconscia è quello in cui crederemo dopo, quindi se il messaggio che
la parola “indagato” equivale per noi a “colpevole”, quel messaggio sarà per noi
la realtà, quindi il “Messaggio” che la parola usata in tv o la notizia data ha
per noi diventa la nostra verità e la nostra realtà. La cosa importante che
possiamo fare è quella di “Prenderne Coscienza”, cioè di prenderne atto a
livello cosciente e riflettere bene su cosa stiamo pensando, perché una cosa è
avere un’impressione su una persona e un’altra è essere certi della sua
innocenza o della sua colpevolezza, la differenza la può fare il fatto di
informarsi a 360 gradi, verificare tramite altre persone, tramite il web,
seguire da vicino le indagini, avere più notizie ed informazioni e verificarle
tutte, solo dopo tante verifiche, le informazioni ricevute e la capacità di
“discernere” (separare) le informazioni vere da quelle false, solo allora
possiamo pian piano affermare con attenzione e sempre con un margine di
potenziale errore se quella notizia è vera o falsa o se quella persona è
innocente o colpevole. Il fatto che molte persone credano immediatamente a
questa o a quella notizia, il fatto di dare subito un’interpretazione o di
giudicare quella situazione di cui si parla, o addirittura di criticare o
giudicare immediatamente quella persona di cui si parla senza approfondire o
verificare se quelle notizie su di lui sono reali, dipende da vari fattori,
vediamo assieme quali sono:
Intanto i programmi televisivi
vengono seguiti da milioni di persone, sia nel nostro paese che in altri stati,
grazie alle potenzialità tecnologiche come il decoder, internet, ed altro
ancora, e tutto ciò che viene visto, ascoltato e seguito da tantissime persone,
è come se ci “unisse” un poco, è come se vedendo gli stessi programmi ed
ascoltando gli stessi discorsi o dialoghi di approfondimento in tempo reale,
tutti noi telespettatori avessimo qualcosa in comune, qualcosa che ci unisce ,
come una condivisione mediatica del mondo.
Quando i riflettori della tv
vengono puntati su questa o quella persona, è come se mettesse noi spettatori
nella posizione di diventare i “critici” o i “giudici” dei soggetti in
questione, di ciò che accade e di ciò di cui si parla.
La notizia data in tv viene
spesso amplificata in quanto qualcosa che è vista e sentita da milioni di
persone assume in un certo qual modo un potere forte, in positivo o in negativo,
dipende dalla connotazione che le viene data, mettere l’accento su questa o
su quella notizia le conferisce potere ed anche per questo viene amplificata.
Ecco perché il fatto di parlare tanto e per tanto tempo di qualcuno, gli porta
potere se se ne parla bene o può infangarlo se se ne parla male.
La tv ha il potere di
“dirigere” l’attenzione del telespettatore passivo, verso questo o quel fatto,
verso questo o quel personaggio, ed ovviamente dirigendo l’attenzione verso una
situazione, la distoglie da un’altra notizia che magari è più importante o che
non si vuole approfondire in quel momento per vari motivi. In questo modo la tv
può monopolizzare l’attenzione delle persone a piacimento, e questo è un grande
potere, che però noi possiamo imparare a gestire e controllare attraverso un po’
di riflessione e di analisi.
Anche la “Ripetitività” di una
notizia le conferisce potere, perché più una notizia viene ripetuta e
approfondita e più se ne parla, più questo circolo vizioso tende ad aumentare e
ad amplificarsi. Ecco perché una notizia di cronaca nera sembra non finire mai,
viene data e ripetuta anche per anni, addirittura si sono inventate trasmissioni
apposite per approfondirne ancora di più i contenuti come se i tg non
bastassero, questo perché l’audience aumenta gli introiti, è le notizie sono
dunque legate anche ai soldi che si possono ricavare da esse.
Il fatto di ascoltare una
notizia ci mette nella posizione di assumere il ruolo di “critico” o di
“giudice”, e quindi di sentenziare, di accusare o di dare clemenza al
personaggio di turno, in questo modo possiamo “liberarci” inconsciamente delle
nostre azioni sbagliate, delle nostre “colpevolezze”, del fango che c’è dentro
di noi proiettandolo sugli altri, in questo caso sui soggetti protagonisti di
questa o quella situazione del momento. Infatti scagliare accuse su una persona
è come se ci liberasse o ci distogliesse dalle accuse che dovremo a volte
dirigere su noi stessi, anche questo fenomeno è inconscio (ma forse non sempre).
Come puoi notare le
implicazioni su ciò che accade a livello psicologico e sociale quando diventiamo
spettatori spesso “passivi” di una notizia raccontata in tv, sono implicazioni
“sottili” ma potentissime ed a volte “inconsce”, di cui cioè non ci rendiamo
conto a livello cosciente, ma che seguono una direzione ben precisa e
raggiungono l’obiettivo.
Come possiamo dunque
“Controllare” tutto questo? Come possiamo “Gestire” noi telespettatori questi
fenomeni complessi al fine di non venirne trasportati come da un fiume in piena?
Ecco alcuni consigli Pratici
ed Utili che puoi seguire prima di accingerti ad assumere il ruolo di
spettatore:
Intanto diventa giorno dopo
giorno uno spettatore “Attivo”, come? Avendo la mente aperta, evitando cioè di
credere ciecamente ad una notizia senza averla prima approfondita, verificata ed
assorbita a 360 gradi, osserva la notizia da più punti di vista, soprattutto mi
riferisco ai fatti importanti, tralasciando il gossip, o le notizie inutili che
parlano di pettegolezzi su questo o quel personaggio.
Ascolta le “parole” che
vengono usate per dare una notizia, infatti anche “Come” viene data una notizia
è importante, a volte più del contenuto, perché “Come” viene data una
notizia può amplificarla o ridurla, mettere l’accento sulla notizia o lasciarla
sfuggire nel dimenticatoio, “Trasmettere Emozioni” o renderla insignificante.
Chiediti perché viene dato
risalto ad una notizia e viene tralasciata un’altra notizia più importante. Ogni
tanto le notizie vengono pilotate in una direzione particolare, alcune possono
aumentare gli ascolti, altre meno, così il metro di misura diventa l’audience,
il denaro che si può ricavare attraverso le pubblicità associate a notizie forse
poco importanti ma che, se producono altissimi ascolti arricchiscono chi sta
dietro le quinte, anziché privilegiare l’importanza di alcuni fatti, o l’impatto
sociale che possono avere sulla popolazione, anziché stimolare l’interesse degli
ascoltatori verso notizie di pubblica utilità o innovative in campo scientifico,
nella fisica, nella medicina, nella psicologia, ed altro ancora.
Ascolta le notizie che ti
vengono date in modo “neutrale”, senza far pendere la bilancia delle tue
credenze da una parte o dall’altra, cerca di essere il più obiettivo possibile,
anche quando ti sembra che quella notizia particolare sia vera, reale, o
difficile da confutare, lasciati sempre un margine di “possibilità contraria”,
cioè la tua mente deve essere sempre aperta ai colpi di scena, alle sorprese, al
fatto che puoi sbagliarti, ok?
Cambia l’Atteggiamento con cui
segui le trasmissioni ed ascolti le notizie. Con questo intendo dire che se il
tuo atteggiamento con cui sei abituato ad ascoltare le notizie, le informazioni,
gli approfondimenti è quello di credere subito in ciò che ti viene detto solo
perché lo sta facendo la televisione, se la tua prima impressione sui fatti
raccontati è quella di darne subito un giudizio a priori, fermati un attimo,
rifletti e poniti delle “domande Costruttive” come ad esempio:
“cosa mi fa pensare che quella
notizia sia vera?”;
“cosa mi porta a dare subito
un giudizio su ciò che ho ascoltato?”;
“cosa mi porta a giudicare
questa o quella persona?”;
“cosa mi fa dire che quel
personaggio sia colpevole o innocente?”;
“ho approfondito la notizia?”;
“ho verificato ciò che ho
appreso dalla tv?”;
Ecco, rispondi a domande come
queste e poi Sicuramente il tuo Atteggiamento nei confronti di ciò che ascolti e
di ciò vedi in tv Cambierà. Spero di averti dato alcuni argomenti di Riflessione
per analizzare cosa accade quando ascoltiamo la tv e quando ci facciamo un’idea
riguardo a ciò che ascoltiamo ed alle persone coinvolte in una situazione
particolare. Ricorda quindi i seguenti punti Importanti:
Sii una persona con la mente
Aperta;
Cambia Atteggiamento nel modo
di ascoltare o credere alle notizie;
Cerca di avere un “Ascolto
Neutrale”, il più obiettivo possibile;
Verifica ed Approfondisci le
notizie in 1000 modi diversi;
Percepisci una situazione da
più punti di vista per averne una visione a 360 gradi;
Chiediti se il tuo giudizio o
le tue credenze hanno dei riferimenti validi;
Ascolta “Come” vengono date le
notizie;
Sii una persona Attiva
nell’ascolto;
Dirigi tu la tua attenzione
sui vari fatti, e non lasciare che sia la tv a farlo.
''L'ha detto la tv''
Tecniche e modelli di persuasione mediatica.
Tesi di Laurea Magistrale. Facoltà: Lettere e Filosofia. Autore: Federica
Pollastrelli. La televisione è diventata uno dei mezzi più efficaci per il
fenomeno denominato costruzione sociale della realtà. Costruzione della realtà
perché le informazioni che recepiamo dalla tv si trasformano in idee, credenze e
valori che a loro volta influenzano il modo di percepire il mondo circostante e
il modo di relazionarci con gli altri. Il processo che ha portato la televisione
a diventare uno strumento tanto influente è stato graduale, a volte intenzionale
altre meno, ma sicuramente le tecniche nel tempo si sono affinate grazie ai
progressi in campo psicologico e sociologico, che hanno contribuito a chiarire
le dinamiche comunicative degli individui e gli effetti della comunicazione
mediatica. Se le prime teorie degli anni Venti vedevano l'individuo come una
tabula rasa, quelle più recenti, ridimensionano il concetto di media onnipotenti
e propongono la tematica della costruzione sociale della realtà. Nell'attuale
società dell'immagine è la televisione, attraverso le immagini a veicolare
determinate visioni di ciò che ci circonda, condizionando, quindi, quello che
noi spettatori percepiamo. Tra le tecniche più note per “realizzare” la
costruzione sociale della realtà vi è l'utilizzo del frame. Dato che le persone
solitamente ragionano secondo quadri di riferimento costituiti da immagini o
conoscenze culturali, l'utilizzo del frame, che significa letteralmente cornice
di riferimento, serve per arrivare al nòcciolo di un argomento esprimendo
simultaneamente il proprio modo di concepirlo. Questa, che può sembrare una
banale semplificazione, è in realtà una tecnica molto efficace e sottile, in
quanto non solo permette un controllo sui contenuti detti ma anche e soprattutto
su ciò che non viene detto, stabilendo così un'implicita censura. Un'ulteriore
conferma del fatto che la televisione ha il potere di condizionare la realtà,
possiamo trovarla anche nella comunicazione politica nel momento in cui è venuta
a contatto con il mezzo televisivo. Attualmente, l'efficacia del discorso
politico è strettamente connessa agli schemi narrativi della tv. L'immagine del
leader ha acquisito sempre più peso, diventando perfino più importante dei suoi
discorsi e il fattore intrattenimento sembra essere fondamentale per ottenere
consenso e visibilità, da qui anche il termine politainment. Anche
l'informazione, oltre all'utilizzo del frame, fa molto leva sulle immagini e di
conseguenza sull'emotività dell'ascoltatore. Se pensiamo ai servizi
giornalistici degli ultimi tempi, possiamo vedere come la cronaca nera abbia in
un certo senso il monopolio sugli altri generi informativi. Questo perché da un
lato abbiamo accettato e cerchiamo la cosiddetta “tv del dolore” e dall'altro
lato perché il valore di notiziabilità è più alto e i giornalisti riescono ad
andare avanti per diversi giorni fornendo piccole note di colore o sviluppi
sullo stesso argomento. Inoltre, le tinte forti dei servizi servono alle reti
per garantirsi il numero maggiore di ascolti. Anche per quanto riguarda la
pubblicità ritroviamo lo stesso discorso di costruzione della realtà perché se
questa agli inizi era più legata a far conoscere dei beni di uso comune, oggi il
suo utilizzo è asservito alla creazione di bisogni indotti per cui i beni
vengono caricati di significati simbolici per invogliare all'acquisto facendo
leva sulle pulsioni e i desideri, a partire dai bisogni reali fino a quelli
riguardanti l'immagine di sé, l'autostima, ecc. Lo sfruttamento della narrazione
televisiva crea delle realtà parallele che inevitabilmente condizionano le
nostre scelte e quindi le nostre vite. Anche l'utilizzo degli stereotipi veicola
determinati significati che dalla televisione influenzano poi le nostre
cognizioni. Questo succede perché la tv ricorre spesso al loro utilizzo, anche
solo per ragioni di massima efficienza, dato che si tratta di messaggi semplici
e facilmente riconoscibili dal destinatario, perché hanno origine nel senso
comune. Ma purtroppo gli stereotipi non sono mai neutri, anzi sono molto spesso
discriminatori e portano come conseguenza un'appiattimento della la realtà,
condizionandone addirittura il significato, e a lungo termine ci fanno accettare
con fiducia e senza senso critico ciò che la televisione ci propone, senza
averne fatto esperienza. L'ultima parte dell'elaborato pone in evidenza la
figura femminile, in relazione all'impoverimento dei significati prodotto dal
mezzo televisivo. Già dagli esordi della tv la donna è stata presentata come una
figura accessoria, cercando solo la valorizzazione del suo corpo piuttosto che
altre sue abilità, a dispetto dell'uomo che di solito invece viene
caratterizzato più per il suo talento o le sue attitudini. La conseguenza è
stata quella di modificare la percezione della figura femminile stessa: anche
noi donne oggi ci guardiamo con occhi maschili, perché abbiamo interiorizzato i
canoni insiti nello stereotipo che ci vuole seriali, perfette e sempre giovani.
L'ha detto la televisione,
scrive il 20 ottobre 2009 "Informare per resistere". Sono interessanti i dati di
un sondaggio pubblicato oggi su Repubblica e realizzato da Demos & Pi su "Gli
italiani e l'informazione" che riassumerò in breve. Premesso che la ricerca è
stata effettuata su un campione di 1337 persone maggiori di 15 anni, emerge
ancora una volta il ruolo fondamentale, ai fini informativi, della maledetta
televisione. Vediamo prima di tutto quanta gente guarda la tv. Spulciando le
tabelle pubblicate emerge che il 46% del campione rappresentativo della
popolazione italiana sta davanti alla tv dalle due alle quattro ore al giorno.
Il 17,8% trascorre più di quattro ore attaccato allo schermo in modalità geco,
ed il 27,3% di costoro vota Berlusconi. Forse per riconoscenza per tante ore di
divertimento spappolaneuroni che gli offre gratis. Gli elettori della Lega sono
meno teledipendenti (15,2% con più di quattro ore al giorno) dei pidiellini.
Troppo moderna, la diavoleria. I druidi non avevano la tv. Chi la guarda di
meno, tra gli stakhanovisti del tubo catodico o dell'LCD, sono gli elettori
dell'Italia dei Valori. Un fortunato 1,7% di italiani intervistati dichiara di
non guardare la tv. Rispetto alla rilevazione precedente del 2007, per quanto
riguarda le fonti di informazione quotidiana del campione, in generale aumenta
la fiducia nella tv satellitare, digitale terrestre e per Internet. In crescita
anche i giornali quotidiani mentre calano radio e televisione analogica (RAISET,
La7). Ho sempre l'impressione che queste ricerche di mercato diano risultati un
po' schizofrenici. Infatti, se tra i TG ai quali gli ipnotizzati dalla tv danno
maggiore fiducia calano il TG1 e il TG5 ma aumentano Studio Aperto (ahimé), il
TG de La7, SkyTG24 e soprattutto RAINews24, con un clamoroso +13,4%, il
programma di informazione del quale gli italiani pare si fidino di più è
"Report" della Gabanelli. Una bella domanda del sondaggio riguardava il grado di
indipendenza politica dei mezzi di informazione. In generale gli italiani
indicano come fonte maggiormente obiettiva Internet. Scorporando i dati per
appartenenza politica, la fiducia ad Internet viene data a maggioranza dagli
elettori dei partiti d'opposizione e dei partiti minori, mentre gli elettori di
centrodestra (PDL e Lega) credono alla televisione. Addirittura più i leghisti
dei papiboys, con un bel 37,5%. Sul conflitto di interessi di Berlusconi e se
esso condizioni la libertà di informazione e l'andamento della politica, il
numero di coloro che percepiscono il problema è, in generale, in aumento. Più
che lo stato della libertà di espressione, comunque, preoccupa il
condizionamento della politica. Gli elettori dell'opposizione e coloro che meno
guardano la tv sono coloro che maggiormente si preoccupano del conflitto di
interessi. Gli elettori del PDL e i teledipendenti hard sono coloro che meno
sentono il problema. Forse, ammettendone l'esistenza, temono che gli possa
venire meno la dose. In definitiva, si dimostra per l'ennesima volta che non è
vero che "le televisioni non contano". Contano, eccome se contano. Conta
soprattutto uniformare la poltiglia da far trangugiare ai telespettatori che
stanno lì davanti come uccellini di nido aspettando qualsiasi cosa purchè si
possa ingoiare. E se è merda non se ne accorgono nemmeno. Anzi dicono, come Mina
in quella famosa canzoncina: "Ma che bontà!". Ecco perchè ci si sbatte tanto per
piazzare le persone nostre in RAI, per mettere i papiboys e le papigirls a
leggere il telegiornale delle 20, perchè i tg stanno assomigliando sempre di più
a contenitori di vuoto spinto farciti di nulla. E perchè infine la tv non serve
più per informare ma per disinformare, per tenere assieme il proprio elettorato,
pour épater le papiminkia', manipolarlo e mantenerlo dipendente dalla dose
quotidiana di propaganda. E serve anche, ultimamente, per mazzolare gli
avversari.
Alcune considerazioni finali.
In generale, secondo i dati del sondaggio, gli italiani sembrano guardare meno
la tv per affidarsi invece ad Internet ed ai mezzi di informazione più
innovativi. Si accorgono del cambiamento in senso peggiorativo dell'obiettività
dei telegiornali, leggono i giornali quotidiani ed apprezzano il giornalismo di
inchiesta à la Gabanelli. Sembra quasi un'altra Italia, un paese più maturo di
quanto appaia a sentire il suo peronetto di riferimento. Solo il 17,8% del
campione intervistato risulta teledipendente a livelli da comunità di recupero,
appartenente alla specie "l'ha detto la televisione" ed è infine a maggioranza
berlusconiano. Non sarà, come sospettavo giorni fa, che il papipeople
rappresenti proprio una minoranza gonfiata dagli steroidi televisivi nel
tentativo di emergere da una maggioranza kommunista? Ci mancava solo di essere
un paese dopato.
La sana diffidenza verso
ogni informazione è il naturale antidoto alle bufale,
scrive Alessandro Gilioli il 3
gennaio 2017. Nel suo articolo sul Corriere della Sera di oggi il presidente
dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella torna sulla questione della Rete che
«aumenta notevolmente le possibilità che siano diffuse notizie false e bufale»,
essendo Internet «un sistema decentralizzato in cui chiunque può diventare
produttore di informazione». Questo, sostiene Pitruzzella, danneggia i cittadini
nel loro «diritto a ricevere un’informazione corretta». Di qui la sua idea di
una «istituzione specializzata terza e indipendente che rimuova in tempi rapidi
i contenuti che sono palesemente falsi e illegali». A mio avviso, questa
impostazione della questione parte da un grave errore, da cui discendono quelli
successivi e la drammatica conclusione, cioè la proposta di una sorta di
Tribunale della Verità con poteri censori. L’errore di partenza è pensare che, a
causa di Internet, i cittadini oggi siano vittime passive di notizie false più
di prima: più cioé di quando l’informazione non era decentralizzata e pochi
soggetti (governi ed editori privati) avevano il controllo dell’informazione.
Nell’era dell’informazione esclusivista le notizie – comprese quelle false, che
sono sempre state abbondanti e strumentali agli interessi dei governi o dei
proprietari dei media – godevano infatti di una forza di impatto e di una
capacità persuasiva molto maggiore di qualsiasi bufala online attuale. In altri
termini: erano balle come quelle di oggi, ma piú potenti. Perché provenivano da
fonti considerate ufficiali. Io ci sono cresciuto, in quel mondo lì. Anche
Pitruzzella, che è pure un po’ più anziano di me. Stupisce che non se lo
ricordi. Stupisce che non ricordi l’era in cui frasi come “l’ha detto la
televisione” o “sta scritto sul giornale” erano l’esibizione di una fonte di
certezza. Benché tivù e giornali non siano mai stati pure fonti di verità, ma
anche strumenti di interessi politici ed economici. Che non si potevano
contraddire, cioè di cui nessuno poteva leggere il controcanto. C’era quella
versione lì – o, più spesso, quella omissione lì – e basta. Al massimo si poteva
acquistare un giornale diverso per avere una versione diversa, ciò che comunque
era sforzo di pochi, mentre il conformismo era del tutto senza sfumature e senza
diritto di replica sul medium più facile, diffuso e popolare, la tivù. Allora la
questione non è se oggi circolano più bufale di trent’anni fa ma è se il
cittadino-utente ne è più vittima rispetto a trent’anni fa. E no, non lo è. Per
almeno due motivi. Primo, perché molto più rapida, facile ed economica è la
strada per la replica, per trovare il controcanto rispetto alla bufala (o
all’omissione). Lo sforzo è minimo, avviene nello stesso medium che diffonde il
falso (la Rete), talvolta perfino nei commenti con link al medesimo articolo o
comunque a pochi clic di distanza. Prima, invece, pervenire a qualche preziosa
forma di debunking di una bufala (di giornale o detta in tivù) esigeva una
fatica molto maggiore, ed era infatti prerogativa di pochissimi. Secondo, prima
le persone avevano mediamente meno strumenti di difesa psicologica, erano cioè
meno smaliziate e meno diffidenti verso ciò che veniva immesso dai mezzi di
comunicazione. Insomma, di fronte alle bufale ci cascavamo molto più facilmente.
E la diffidenza – la sana diffidenza verso ogni informazione – è il principale
antidoto a ogni bufala, che sia on line o diffusa in altro modo. La crescita
della diffidenza (connessa proprio con la decentralizzazione dell’informazione!)
è la migliore notizia degli ultimi anni. E siamo solo agli inizi: più la Rete,
medium recente, uscirà dalla sua fase adolescenziale, più la diffidenza
crescerà, più sarà prassi quotidiana di ciascuno imparare a dividere il grano
dal loglio. In altri termini: sì, circolano più balle rispetto a trent’anni fa.
È ovvio, dato che è cresciuta in modo esponenziale la massa di informazioni
circolanti e la massa di produttori di informazioni. Eppure le bufale sono (e
soprattutto saranno) meno pervasive rispetto ad allora (e quindi creano meno
conformismo) perché più facilmente contraddicibili e perché la società che le
riceve ha (e avrà sempre di più) gli anticorpi per reagire, che invece erano
quasi assenti tre decenni fa. Istituire un “Tribunale della Verità” non è solo
un’idea a forte rischio di liberticidio: è anche un sistema che porta a
soffocare la nascita e la crescita degli anticorpi, delegando tutto a un ente
superiore, riportando i cittadini-utenti a una condizione di minorità e di
infanzia mentale (in cui cioè hanno bisogno di un papà che gli dice cos’è verità
e che cosa favola). Tutto questo, per parlare seriamente. Se invece volessimo
fare un po’ di (fondata) ironia, verrebbe da chiedersi che cosa rimarrebbe in
giro dei giornali e dei tg italiani se il tribunale della verità dovesse agire a
360 gradi, non solo sulla Rete ma su tutto il sistema della comunicazione. Nelle
edicole rimarrebbero in vendita giusto i biglietti del tram. In tivù vedremmo
solo il monoscopio con l’ora esatta. E nelle stazioni andrebbero censurati anche
i cartelloni con gli orari di Trenitalia.
Nella palude mediatica si
nascondono gli interessi corporativi di una Italia ancora mentalmente e
istituzionalmente feudale...,
scrive Gilberto Migliorini. Nell'informazione italiana si mescolano diversi
livelli espressivi, dalla carta stampata ai blog passando attraverso la
televisione e il cinema. Al di là della specificità dell’elemento tecnico e
della modalità di comunicazione, permane l'imprinting mentale dell’italiano
medio: un'icona distorta da stereotipi nei quali si dovrebbe riconoscere il suo
vero volto. Quello che si vede nel fondo dell’occhio è un'immagine che si
riflette su specchi deformanti, ed è da questi che a forza di insegnamenti
mediatici l’opinione pubblica ha imparato a riconoscersi. Si tratta
dell'idealtipo dell'abitante del Bel Paese descritto anche da tanta filmografia.
Il format mediatico ha contribuito a mantenere e consolidare il cliché
accentuandolo in tutte le sue forme, dando vita con l’effetto
Pigmalione all'emblematico burattino collodiano; non solo metafora
esistenziale dell’uomo in generale, ma anche icona antropologica di quel
simbionte italico, un avatar alla ricerca di una identità psico-sociale. Alla
base della pochezza culturale del paese c’è una scuola che ha fallito
miseramente proprio dove avrebbe dovuto creare le premesse per formare un
cittadino consapevole e in grado di comprendere la realtà in cui vive. Realtà è
un concetto astratto, qualcosa che richiama immediatamente l’esigenza di
problematizzare, andare oltre i luoghi comuni e le verità già bell'e
confezionate. Realtà è quella che sfugge sempre, una entità indefinita, e
per questo occorre svelarne i risvolti e i doppi fondi, avvicinarsi alla sua
essenza invisibile. Realtà è quella che ci fa essere duttili, curiosi ed
aperti, perché sfida le nostre certezze. Realtà è quella che cerchiamo di
comprendere tra mille difficoltà e contraddizioni, ma senza l’arroganza di chi
crede di conoscerla già per intero e senza mai esercitare l’arte del sospetto.
La vera cultura è quella che si misura nella capacità di guardare il mondo con
scetticismo disincantato, con la volontà di andare oltre le apparenze che ci
attraggono nell'orbita delle false certezze, quelle del si dice, delle
verità già confezionate e pronte all'uso. Una cultura dove i classici della
nostra letteratura non siano solo cariatidi ingessate e mortifere, ma elemento
attualizzante di riflessione, riscoperta delle nostre radici come propulsore di rinascita e
di appartenenza consapevole al nostro passato e progettualità del nostro futuro.
La scuola italiana nell'imprinting dei decreti delegati ha invece trasformato
l’elemento educativo in un sistema convenzionale dove i media hanno fatto il
loro ingresso surrettiziamente per interposta persona (le famiglie) con tutto il
peso degli stereotipi. La democrazia è stata intesa come un mero opinare e come
una sorta di arbitraria presa di posizione, un carnevale di maschere e un
caleidoscopio di illusioni speculari. Un illustre semiologo ha argomentato che “i
social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli”. Si tratta
però di stabilire chi lo sono per davvero, a meno di considerare accademici,
benpensanti e personaggi di rango (illuminati o cariatidi?) come i soli in
grado di effettuare la cernita (dei cretini e non) dall'alto di qualche
infallibile e indiscussa autorità. Nel blob degli opinionisti nessuno può dirsi
escluso dalla selezione, nessuno può chiamarsene fuori. O forse qualche deus ex
machina, noblesse oblige, possiede le stimmate della verità per via di
qualche titolo accademico o laurea honoris causa? I media hanno saputo
affinare tutti i loro strumenti di persuasione su un target (il popolo italiano)
sempre più povero di strumenti culturali, sempre più in balia di imbonitori e
suggeritori, sempre più integrato in un sistema di rinforzi (positivi e
negativi) che lo hanno eletto a ignaro destinatario di un esperimento di
controllo e persuasione. Il burattino alla ricerca della sua identità è stato
immerso in un habitat dove la propaganda e la manipolazione hanno assunto i
caratteri suadenti dell’intrattenimento, dell’informazione e della
partecipazione. Il concetto di democrazia - replicato in tutte le salse e
declinato con le figure retoriche dell’enfasi e dell’iperbole - è risuonato come
un mantra nelle aule parlamentari, nelle piazze e nei comizi. La parola magica è
echeggiata soprattutto in quel frame dei teleschermi dove il mondo là
fuori è a portata di un dito con lo zapping e con la magia di un cambio di
canale repentino. Democrazia come scelta libera di canale tra quelli offerti da
qualche proprietà (pubblica e privata), compresa quella del teatrino di
Mangiafuoco, con tutte le lusinghe di un gioco di ruolo (con ricchi premi e cotillon)
dove l’utente partecipa e recita insieme alla compagnia degli
attori, con Arlecchino e Pulcinella e l’immancabile Colombina. Gli slogan
altisonanti, le seduzioni cromatiche, le allusioni erotiche e le retoriche del
moralismo accattivante hanno circuito e assecondato la dabbenaggine e la
superficialità di un italiano medio educato a pensare per slogan, a
utilizzare i luoghi comuni, le ricette preconfezionate di una cultura usa e
getta. Il target è stato trasformato in una cavia da laboratorio, illuso di
essere il soggetto che sceglie e non l’ignaro oggetto di adescamento e
manipolazione. Tanto più il sistema mediatico è riuscito a occultare le sue
procedure di influenza ‘culturale’ con l’enfasi della retorica e della
demagogia, tanto più la forza persuasiva ha intaccato i residui di razionalità
dell'Homunculus italicus, quello degli spot. Il buon senso è stato
annacquato in un chiacchiericcio insulso e banale, nell'incapacità di
interpretare la realtà mediatica, di penetrarne i meccanismi sottostanti e gli
algoritmi che presiedono al controllo e alla persuasione. Il burattino ha fatto
da comparsa e da fumetto in un diagramma di flusso, una riga di istruzioni in un
copione, convinto di essere protagonista sulla scena... non solo cavia e
zimbello. La società italiana è diventata preda di automatismi mentali, talora
in modo inconsapevole, influenzata da tutte quelle forze più o meno occulte
sotto l’egida di un potere invisibile. Il gioco dei grandi numeri e delle medie
statistiche (una profilazione di carte fidaty e fragranti biscottini) si
è trasformato in una ingegneria politico-istituzionale per regalare all'utente
un’immagine sempre più fedele, per conoscerne i gusti, le predilezioni, le
idiosincrasie, i desideri e perfino i pensieri. Un programma per il futuro? Un
disegno utopico? Un non-luogo più simile a una chimera, un progetto senza capo
né coda, ma mosso dal desiderio di controllo e di potere. Il fine che nel Principe del
segretario fiorentino (Machiavelli) aveva comunque la sua giustificazione in un
sistema di governo ordinato, è diventato quello di un potere che ha in se stesso
l’unica giustificazione. È un Bel Paese governato da gruppi che negoziano con le
forze antagoniste per curare i propri interessi di parte. Il cinico mazziere
utilizza in modo scaltro e senza remore morali tutti gli strumenti in suo
possesso per manipolare e controllare un’opinione pubblica sotto tutela, un po’
con la bacchetta e un po’ con i mezzi suadenti dell’imbonitore. Il bastone e la
carota in una commistione di minacce e di seduzioni amalgamate in forma di
kermesse hanno educato l’italiano ad un opportunismo di sopravvivenza, un
suddito sempre alla ricerca di escamotage in grado di far fronte alla protervia
e all'arbitrio di governanti che promuovono gli interessi del loro clan. Il
risultato è una società plasmata da slogan, controllata da un sistema mediatico
in grado di indurre stili di consumo, comportamenti, modi di pensare e reazioni
emotive. Un Paese dove gli opportunisti perseguono i loro interessi correggendo
e modulando di volta in volta obiettivi e finalità in ragione di programmi
occasionali in prospettive miopi e di corto respiro. Pensare che il Bel Paese
abbia delle teste pensanti in grado di elaborare strategie a medio e lungo
termine, sia pure orientate a degli interessi occulti, significa ritenere che la
nave Italia abbia davvero un comandante, sia pure celato nell'ombra, in grado di
sapere sempre esattamente dove l’imbarcazione sta andando. La realtà è invece
quella di tanti piccoli ammiragli che con i loro piccoli cannocchiali scrutano
gli oggetti meschini della brama di potere in una miopia negoziale fatta di
compromessi e di opportunismi che hanno come meta quel galleggiare tra Scilla e
Cariddi, mantenersi in sella nella prospettiva del comando. Un carpe diem coniugato
nella forma dell’occasionalismo e del dirigismo a spizzico, sia pure in un
quadro di alleanze internazionali e all'interno di un mercato globale. Un
programma ben definito nel suo obiettivo, il potere, ed elementare nei
suoi metodi, con le empiriche correzioni di rotta per non scafare…Il paradosso
italiano è che nel paese cattolico per eccellenza l’etica è quella di un
moralismo da galateo, un senso di giustizia che si appella a una precettistica,
alla correttezza (spesso solo illusoria) dei procedimenti formalmente
ineccepibili, vuoti e altisonanti, e alle belle intenzioni che nascondono
interessi di bottega. Le caste hanno tradotto il loro meschino interesse nella
forma di protocolli legislativi e normativi che ne assicurano protezione e
sopravvivenza sotto forma di un labirinto di codici ricorsivi inespugnabili. Il
povero Pinocchio finisce sempre per essere inseguito dai briganti e impiccato.
Il provvidenziale soccorso al burattino indossa le vesti di una figura
salvifica: lo squalo può assumere perfino le innocue e allettanti sembianze di
una bella e accattivante fatina dai capelli turchini. Descrivere una macchina
organizzativa composta di istituzioni e organismi sembra un’impresa da fisica
sociale applicata alla sociometria e all'economia. I sistemi sociali ed
economici sono più o meno stabili nel breve o nel lungo periodo. L’evoluzione è
il tratto di tutti i sistemi reali. In qualche caso esistono perfino quelle
scosse sismiche che vanno sotto il nome di rivoluzioni dove le società
collassano e subiscono trasformazioni violente. L’immagine dell’equilibrista è
evocativa per un sistema che da sempre possiede una capacità ‘creativa’ di
sopravvivere modificandosi in ragione degli opportunismi. Il sistema Italia si
regge su una stabilità assicurata dalla compartimentazione, una piramide
stratificata dal vertice fino alla base. Non si tratta di una impossibilità
delle persone di ascendere o discendere nella piramide sociale quanto di un
sistema di chiusure che non a caso ricordano il nostro medioevo, una
compartimentazione per gruppi sociali e soprattutto professionali, un sistema di
garanzie e di protezioni alla base anche di quei sistemi mafiosi che in qualche
modo traggono ispirazione e imitano, sia pure al di fuori della legalità,
le idiosincrasie culturali delle nostre istituzioni. Per comprendere la logica
del sistema Italia (e della sua mentalità) occorrerebbe, prima di effettuare una
analisi di tali chiusure (con privilegi e immunità), fare un passo indietro e
guardare al medioevo italiano che rappresenta la nostra matrice culturale. I
modelli istituzionali - sia pure con la connessa innovazione tecnologica -
mantengono un assetto immutabile al di là delle trasformazioni di facciata. Il
potere è riuscito a camuffarsi con garanzie legislative e norme di tutela come
meri specchietti per le allodole. L’evoluzione politica e istituzionale non ha
inciso più di tanto sulla mentalità e il costume, ma soprattutto
sull'organizzazione sociale. Il sistema Italia, nonostante le presunte
innovazioni strutturali, rimane palesemente feudale. Il feudo che viene
generalmente pensato come una entità territoriale ha gradualmente assunto una
fisionomia più simile a un software evanescente che a un hardware fisico: le
strutture del potere, in parte anche interiorizzate sotto forma di ideologie,
hanno dissimulato variamente il loro carattere corporativo negli escamotage
normativi che hanno mantenuto strutturalmente il paese in una condizione di
immobilismo: i privilegi e le immunità hanno assunto una forma indeterminata e
ubiqua, occultandosi dietro le formule propagandistiche e con un sistema
mediatico esso stesso parte integrante delle egemonie sociali e delle strutture
di potere. Il feudo da luogo fisico circoscritto, e da pertinenza ideologica
dell’ortodossia di un gruppo politico, è diventato consorteria di interessi
condivisi dei clan che spartiscono prebende e privilegi. I nuovi signori di
banno hanno tradotto in senso metaforico il dominatus loci, mentre
l’allodio (la piena proprietà) ha assunto il carattere sfumato della concessione
in un giuramento di fedeltà con un diffuso sfruttamento del potere per interessi
privati. Nella nuova realtà italica il feudo è costituito da un sistema
di coperture che delimitano dei perimetri di potere, sistemi normativi che
fungano da cinture di sicurezza e scambi di favore. Il diritto reale ha assunto
il carattere di una rendita (di denaro e potere) in cambio non tanto di una
specifica prestazione professionale (elemento accessorio) quanto di una fedeltà
e consonanza che si esprime nell'omertà e nella complicità comunque legalizzate
nei formalismi giuridici, nei codicilli e nelle norme ad personam. Le caste nel
sistema Italia sono rappresentate da quei gruppi (anche istituzionali) che si
mantengono rigorosamente chiusi in privilegi senza nessun rischio di essere
smascherati come portatori di interessi di parte e al di fuori di una legalità
che non sia solo di facciata. La possibilità di sfuggire a qualsiasi forma di
controllo autenticamente democratico è data da un sistema normativo che nella
indeterminatezza è sempre in grado di giustificare i suoi atti formali. La
quadratura del cerchio è rappresentata da quelle formule ubique che possono
essere lette variabilmente e derubricate a conferma che tutto è sempre fatto
secondo scienza e coscienza. Le leggi rappresentano un flatus vocis dove
l’interprete (quello istituzionalmente legittimato) può sempre fornire la
decodifica di un nominalismo linguistico formalmente ineccepibile. I codici
interpretativi hanno infatti la souplesse necessaria a tradurre i fatti
conclamati sic et nona seconda della convenienza, delle circostanze e
soprattutto degli interessi di riferimento. Il risultato è che le
contraddizioni, le manchevolezze, le inadeguatezze e le incapacità dei vari
strati della piramide sociale – di fatto impermeabili a un controllo e a una
razionalizzazione che non sia soltanto di facciata – dal vertice e scendendo via
via nel sistema delle istituzioni e delle connesse professioni - è sempre in
grado di scaricare alla base tutte le sue incapacità e le sue magagne. Chi paga
è sempre la palude degli utenti in un sistema di inefficienze e di abusi. Il
sistema Italia, al di là delle belle formule di democrazia liberale e delle
tirate ideali, rimane un paese feudale nella mentalità e nella qualità delle sue
istituzioni che godono di quell'immunità derivata da un sistema largamente
autoreferenziale e basato sulla discrezionalità mascherata dai formalismi
giuridici e su forme di legalità di facciata. La divisione dei poteri nel
sistema Italia costituisce non solo l’illusione di una società libera ed aperta,
ma una sorta di divide et impera - sui generis - che trova
autogiustificazione in un rapporto di reciproca legittimazione dei poteri nella
loro completa autonomia e nella loro assoluta discrezionalità in quanto
interpreti di norme tanto vaghe e indeterminate da poter sempre essere ascritte
agli interessi di camarille e corporazioni. L’idea di una responsabilità che
risulti indipendente dalla casta di appartenenza e dalle connesse protezioni e
agevolazioni, è quanto di più alieno e inammissibile per un sistema dove
l’individuo è sempre e soltanto in funzione degli interessi del suo clan (e del
sistema di alleanze tra gruppi di potere) e non già della società nel suo
complesso. Ognuno colga a piacere i riferimenti appropriati…
Umberto Eco: “Con i social
parola a legioni di imbecilli”.
Allo scrittore la laurea
honoris causa in «Comunicazione e Cultura dei media» a Torino. Il conferimento
laurea honoris causa in “Comunicazione e Culture dei Media” a Umberto Eco,
scrive il 10/06/2015 "La Stampa". «I social media danno diritto di parola a
legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino,
senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora
hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli
imbecilli». Attacca internet Umberto Eco nel breve incontro con i giornalisti
nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, dopo aver ricevuto dal
rettore Gianmaria Ajani la laurea honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei
media” perché «ha arricchito la cultura italiana e internazionale nei campi
della filosofia, dell’analisi della società contemporanea e della letteratura,
ha rinnovato profondamente lo studio della comunicazione e della semiotica». È
lo stesso ateneo in cui nel 1954 si era laureato in Filosofia: «la seconda volta
nella stessa università, pare sia legittimo, anche se avrei preferito una laurea
in fisica nucleare o in matematica», scherza Eco. La sua lectio magistralis,
dopo la laudatio di Ugo Volli, è dedicata alla sindrome del complotto, uno dei
temi a lui più cari, presente anche nel suo ultimo libro `Numero zero´. In
platea il sindaco di Torino, Piero Fassino e il rettore dell’Università di
Bologna, Ivano Dionigi. Quando finisce di parlare scrosciano gli applausi. Eco
sorride: «non c’è più religione, neanche una standing ovation». La risposta è
immediata: tutti in piedi studenti, professori, autorità. «La tv aveva promosso
lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il
dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di
verità», osserva Eco che invita i giornali «a filtrare con un’equipe di
specialisti le informazioni di internet perché nessuno è in grado di capire oggi
se un sito sia attendibile o meno». «I giornali dovrebbero dedicare almeno due
pagine all’analisi critica dei siti, così come i professori dovrebbero insegnare
ai ragazzi a utilizzare i siti per fare i temi. Saper copiare è una virtù ma
bisogna paragonare le informazioni per capire se sono attendibili o meno». Eco
vede un futuro per la carta stampata. «C’è un ritorno al cartaceo. Aziende degli
Usa che hanno vissuto e trionfato su internet hanno comprato giornali. Questo mi
dice che c’è un avvenire, il giornale non scomparirà almeno per gli anni che mi
è consentito di vivere. A maggior ragione nell’era di internet in cui imperversa
la sindrome del complotto e proliferano bufale».
Imbecilli e non, tutto il
mondo è social.
L’atto d’accusa di Eco contro il moltiplicarsi di bufale nella Rete ha suscitato
vivaci reazioni tra i lettori e gli internauti. Su Facebook e Twitter regna
davvero lo scemo del villaggio? Scrive Juan Carlos Martin il 12/06/2015 su "La
Stampa". Internet? La catena di montaggio delle bufale, «il luogo in cui nascono
le più assurde teorie complottistiche». Facebook e Twitter? Uno sfogatoio per
quelli che «prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, e di solito
venivano messi a tacere», mentre «ora chi scrive ha lo stesso diritto di parola
di un Nobel». L’atto di accusa pronunciato da Umberto Eco (La Stampa ne ha
riferito nel servizio sulla sua visita a Torino per la laurea honoris causa in
Comunicazione e media) ha suscitato un vasto e vivace dibattito in Rete e tra i
lettori. Ma davvero i social allevano «legioni di imbecilli»? Chiarissimo
professor Eco, mi dispiace contraddirla, ma su Internet si sbaglia. E si sbaglia
proprio dal principio, ovvero da quando afferma che «i social media danno
diritto di parola a legioni di imbecilli». Non perché l’affermazione non sia
vera - chiunque frequenti la Rete lo vede tutti i giorni - ma perché anche gli
«imbecilli» hanno il diritto di esprimersi. La nostra Costituzione, infatti, non
concede la libertà di espressione solo ai premi Nobel, ai «colti» o agli
«intelligenti»: la libertà di parola è assicurata a tutti. Ed è assicurata a
tutti perché è nell’interesse di democrazie ben funzionanti avere il più ampio
spettro possibile di voci, incluse quelle che possono apparire (e magari sono)
estreme o «imbecilli». Con un unico rimedio accettabile, ovvero ancora più
parole: parole di chiarimento, di confutazione, di spiegazione, di
informazione. Ma anche tralasciando questo giudizio di valore, professor Eco,
temo si sbagli anche su alcuni punti successivi. Gli «imbecilli» non stanno
affatto «danneggiando la collettività»: stanno solo esercitando la loro libertà
di parola. Solo una collettività «imbecille» si danneggia perché gli «imbecilli»
parlano. Una collettività non imbecille, infatti, ha gli anticorpi per gestire
le parole di tutti, incluse quelle stupide o inutili. E il fatto che gli «scemi
del villaggio» possano esprimersi su Internet non implica che «Internet li abbia
promossi a portatori di verità». A meno che non si voglia accusare anche Hyde
Park a Londra di promuovere a «portatori di verità» tutti quelli che si fermano
a parlare allo «Speaker’s corner». Sulle sue ultime affermazioni siamo invece in
totale accordo. Il modo giusto per reagire all’enorme - e per me straordinaria -
espansione della libertà di espressione resa possibile da Internet è quello di
dare a tutti gli strumenti critici per valutare ciò che leggono, sentono e
vedono. Cinque secoli fa abbiamo dovuto imparare a valutare l’affidabilità di un
libro basandoci su autore e editore (e ciò non ha impedito che le librerie,
ancora oggi, siano piene di libri che diffondono «bufale» colossali). Poi
abbiamo dovuto imparare a leggere i giornali, e in tempi ancora più recenti
abbiamo dovuto (o avremmo dovuto) imparare a interagire criticamente con radio
e, soprattutto, televisione. Ora è il momento della Rete. È del tutto possibile
espandere gli strumenti critici validi per i mass media tradizionali e insegnare
a giudicare l’attendibilità di una voce di Wikipedia o il grado di affidabilità
di un determinato blog o di una notizia su Facebook. Sono competenze che alcune
università hanno cominciato a insegnare ed è auspicabilmente solo questione di
tempo prima che diventino un insegnamento obbligatorio. Non si può, infatti,
essere cittadini a pieno titolo senza la capacità di valutare criticamente le
informazioni che incrociamo ogni giorno, che provengano dalla televisione, dai
giornali o da Twitter. Certo, è urgente che queste competenze si diffondano,
vista la crescente influenza dei social media. E allora ci aiuti, professor Eco:
usi la sua straordinaria autorevolezza per convincere ministri e rettori a
muoversi più rapidamente. Le garantisco che in tal caso scatterebbe un’altra,
meritatissima «standing ovation».
“Eco, i social network e le
legioni di imbecilli. Difendere la verità è un lavoro che costa fatica”.
Il commento di Gianluca Nicoletti: «Non si produce pensiero nella cultura
digitale se non si accetta di stare gomito a gomito con il lato imbecille della
forza», scrive Gianluca Nicoletti l'11/06/2015 su "La Stampa". Dove andremo a
finire signora mia! Adesso che Umberto Eco ci ha aperto gli occhi sul fatto che
l’umanità sia popolata da legioni d’imbecilli. E’ incredibile che costoro
abbiano pure diritto di parola, senza che nessuno possa metterli a tacere!
S’immagini che Il professore ha detto pure che hanno lo stesso diritto di parola
di un premio Nobel…Pensi signora sarebbe come se io e lei, che ci parliamo dal
balcone mentre stendiamo i panni, potessimo parlare con la stessa dignità che so
di un Dario Fo….Non c’è più religione veramente! Attenzione, non è un paradosso
per criticare il pensiero di quello che ritengo essere uno dei più illustri
rappresentanti viventi della nostra letteratura e saggistica, anzi resto
sinceramente e profondamente ammirato da tutto quello che Umberto Eco ha sinora
prodotto come pensiero. Ma non riesco a reprimere la tentazione di rappresentare
un’onirica ricostruzione di come potrebbe stimolare il dibattito tra due
casalinghe di Voghera il pensiero che egli ha espresso in occasione del
conferimento della laurea honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei media”
da parte dell’Università di Torino. Senza nemmeno lontanamente immaginare che
qualcuno possa mettere in discussione opinioni altrui su temi in fondo così
legati a punti di vista personali, mi verrebbe da dire che finalmente possiamo
misurarci con il più realistico tasso d’imbecillità di cui da sempre è intrisa
l’umanità. Era sin troppo facile per ogni intellettuale, o fabbricatore di
pensiero, misurarsi unicamente con il simposio dei suoi affini. Ora, chi vuole
afferrare il senso dei tempi che stiamo vivendo è costretto a navigare in un
mare ben più procelloso e infestato da corsari, rispetto ai bei tempi in cui
questa massa incivilizzabile poteva solo ambire al rango di lettori, spettatori,
ascoltatori. Stare buoni e zitti, leggere giornali scritti da noi, leggere libri
scritti da noi, guardare programmi in tv in cui al centro eravamo noi, ascoltare
lezioni che facevamo noi. E’ finita purtroppo l’epoca delle fortezze
inespugnabili in cui la verità era custodita dai suoi sacerdoti. Oggi la verità
va difesa in ogni anfratto, farlo costa fatica, gratifica molto meno, ma
soprattutto richiede capacità di combattimento all’arma bianca: non si produce
pensiero nella cultura digitale se non si accetta di stare gomito a gomito con
il lato imbecille della forza. E’ vero, Internet è il libero scatenamento di
ogni menzogna, consolidamento di ogni superstizione, sublimazione di ogni
velleità. Proprio per questo la contemporaneità ci affascina, è una tigre da
cavalcare per non essere da lei divorati. Pensare che ancora possano esistere
gabbie capaci di contenerla e quanto di più lontano dalla realtà si possa
immaginare. Non è questione di supporto del sapere di rango inferiore, può anche
essere come dice il professor Eco che si ritornerà al cartaceo, ma equivarrà al
ritorno al vinile, alle foto con la Polaroid, al cosplay steampunk che sogna un
futuro d’ipertecnologia a vapore e abiti vittoriani. Sono nostalgie che hanno la
loro gloriosa rinascita nella memoria digitale, riportano ogni folle idea del
passato a un funzionale stratagemma perché quei milioni d’imbecilli possano, a
loro piacere, ricostruirsi un’epica individuale, senza aver mai compiuto un
gesto veramente epico in tutta la loro vita… E allora? Chi siamo noi per negare
il diritto all’imbecillità di evolvere con strumenti individuali? Non credo ai
comitati di saggi, ai maestri di vita digitale che fanno dai giornali l’analisi
critica della rete. Le loro sentenze avrebbero quel profumino di abiti
conservati in naftalina che oggi emanano le muffe lezioncine sulla buona
televisione, sul servizio pubblico, sulla qualità dei programmi, su questo è
buono e questo fa male. Siamo tutti intossicati, per questo oggi l’intellettuale
deve fare sua la follia del funambolo. Chi vorrebbe curare gli altri e ancora si
proclama sano, è in realtà (digitalmente) già morto.
Eco aveva ragione, il Web crea
stupidi intelligenti. Anticipiamo l’intervento su "la Stampa" del 09/09/2016 del
semiologo Gianfranco Marrone al Festival di Camogli: «Siamo eroi di Borges
oberati di dati». Ireneo Funes, eroe eponimo della memoria in eccesso, non aveva
corpo. O, quanto meno, lo usava il meno possibile. Ricordando tutto di tutto,
sino ai più minimi dettagli della più banale delle situazioni, ogni cosa e ogni
percezione delle cose, ogni parola ascoltata, ogni sentimento provato, Funes
preferiva vivere nell’oscurità, pensando il meno possibile, esistendo il minimo
indispensabile. Troppe cose in mente per poterne immagazzinare di nuove. E poi:
con quale principio ordinatore? Con quale metodo? Finiva così per essere – nota
Jorge Luis Borges, suo visionario inventore – una pura voce: alta, nasale,
burlesca. Effimera. Va tenuta presente, questa parabola iperletteraria, non
foss’altro perché più volte Umberto Eco se n’è servito per spiegare il
funzionamento della rete, i meccanismi di internet, gli effetti cognitivi ed
estetici dei social network. Eco e Borges, i due autori massimi delle
totalizzazioni impossibili – la biblioteca infinita, il labirinto semiosico, la
mappa uno a uno, Menard che riscrive Cervantes… –, si sono incontrati anche
così, condividendo il problema della memoria ambivalente: pochi ricordi
rincretiniscono, troppi ricordi altrettanto. Quella che è senz’altro – quanto
meno dai sapienti greci ai giganteschi serbatoi delle odierne macchine pensanti,
passando per i big data dei cattivissimi dell’ultim’ora – la principale
prerogativa dell’intelligenza e della conoscenza, della scienza e della
filosofia, la memoria appunto, si trova costretta fra due idiozie opposte e
complementari: l’incapacità cognitiva dello smemorato recidivo, la boria inutile
di chi rammenta oltre il necessario. Funes considera gli umani, inguaribili
distratti, esseri a lui inferiori. Ma ne ha istintiva paura, perché,
diversamente da lui, sanno più o meno come vivere. Messa così, la vexata
quaestio degli stupidi in rete – che Eco, provocandoci sino all’ultimo, ha
voluto consegnarci – acquista una nuova forma. Si ricorderà la polemica che lo
scorso anno, pochissimi mesi prima di lasciarci, una sua dichiarazione pubblica
(«internet è pieno di imbecilli!») aveva scatenato. Soprattutto, manco a dirlo,
in internet stessa. Tutti a dire che non è affatto così, che il maestro una
volta tanto ha toppato, che la rete è il migliore dei mondi possibili… e sorvolo
sugli insulti. In una delle sue ultime «bustine» (che adesso chiude Pape Satàn
Aleppe) lui aveva replicato, sornione, facendo una botta di conti: Facebook ha
moltiplicato i bar dello sport, di modo che chiunque, a ogni momento, si sente
in diritto di parlare a vanvera. Ma il dibattito è tuttora aperto, e serve per
riflettere, oltre che sul web e i suoi cascami, sul senso profondo della
stupidità. Tutt’altro che evidente. Musil, per esempio, osservava che non c’è
peggior stupido di chi ostenta la propria intelligenza. Barthes ricordava che
occorre sentirsi stupidi per esserlo di meno. E già Flaubert ripeteva che la
vera idiozia consiste nel voler concludere. C’è di che. Quanto alla rete, se ne
è detto di tutto e il suo contrario. Salutata al suo nascere come la panacea di
tutti i tutti i mal di pancia ideologici, terreno dove la libertà di parola
avrebbe foraggiato il peace-and-love post-californiano, è diventata l’inferno a
cielo aperto dove ignoti oligarchi succhiano il sangue biancastro del popolo
bue. Fosse soltanto cretineria. La dialettica fra apocalitti e integrati è viva
e vegeta, ed è curioso che a starci dentro sembra esserci lo stesso Eco, che 50
anni fa l’aveva criticata. E qui entra in gioco un profeta poco ascoltato,
quell’José Ortega y Gasset che nella Ribellione delle masse, 1930, aveva visto
giusto: tutti siamo cretini e sapienti insieme. Un esperto di fisica subatomica
farfuglierà scemenze sulle politiche internazionali. Un Premio Nobel in
letteratura interverrà con imbarazzante cipiglio sulle scelte finanziarie
planetarie. Un maturo ingegnere palpiterà leggendo alla fidanzata poesiole da
quattro soldi. Come dire che non c’è sapientone che non sia imbarazzatemene
stolto al di fuori del suo terreno di ricerca scientifica, non c’è pensatore
heideggerianamente autentico che sappia far funzionare uno smartphone d’ultima
generazione. Tutti però, ed è questo il punto, oggi si incontrano ardentemente
sui social media. E non è solo un problema di numeri. Si scompaginano faldoni
polverosi. Si riarticolano paradigmi acquisiti. Da una parte Facebook, Twitter e
soci donano a chiunque la responsabilità di parola, assunta con leggerezza e
insipienza, dando la stura alle opinioni più dure e più pure. D’altra parte
questi cosiddetti media 2.0 ridimensionano tutti e subito, livellando ogni
biodiversità culturale entro le griglie precostituite di un format
adolescenziale. E tutto resta registrato, scritto, archiviato alla rinfusa ma
comunque conservato. Parli chi può, gli altri dietro la lavagna: per far
compagnia a quell’idiota di Funes.
L'idiota di successo.
Un grande semiologo e un grande cineasta. Insieme per dialogare di come va il
mondo. In un libro di prossima uscita. Qui ne anticipiamo un capitolo. Dedicato
all'idiozia. E alla sua pericolosità. Che è quella di convincerci di cose prive
di ogni logica, scrive il 5 maggio 2009 "L'Espresso".
Umberto Eco: Ho fatto una
distinzione, in uno dei miei libri, fra l'imbecille, il cretino e lo stupido. Il
cretino non ci interessa. È quello che porta il cucchiaio verso la fronte
anziché puntare alla bocca; è quello che non capisce quello che gli dici. Il suo
caso è semplice. L'imbecillità, invece è una qualità sociale e, per quel che mi
riguarda, puoi anche chiamarla diversamente visto che per alcuni 'stupido' e
'imbecille' sono la stessa cosa. L'imbecille è colui che in un certo momento
dirà esattamente quello che non dovrebbe dire. È autore di gaffe involontarie.
Lo stupido invece è diverso; il suo deficit non è sociale ma logico. A prima
vista sembra che ragioni in modo corretto; è difficile accorgersi immediatamente
che non è così. Per questo è pericoloso. (...) Ti faccio un esempio. Lo stupido
dirà: 'Tutti gli abitanti del Pireo sono ateniesi. Tutti gli ateniesi sono
greci. Quindi tutti i greci sono abitanti del Pireo'. Ti viene il sospetto che
qualcosa non funzioni perché sai che ci sono dei greci di Sparta, per esempio.
Ma non sai spiegare subito dove e perché si è sbagliato. Dovresti conoscere le
regole della logica formale. Ecco, credo che dovremo occuparci specificamente
dello stupido.
Jean-Claude Carrière: Per me
lo stupido non si accontenta di sbagliare. Afferma chiaro e forte il suo errore,
lo proclama, vuole che tutti lo sentano. È sorprendente vedere quanto la
stupidità è roboante. 'Ora sappiamo da fonti certe che...'. E segue una cazzata
enorme.
Eco: Hai assolutamente
ragione. Se dici con insistenza una verità comune, banale, diventa
immediatamente una bêtise...
Carrière: Flaubert dice che la
bêtise consiste nel voler trattare conclusioni. L'imbecille vuole arrivare da
solo a soluzioni perentorie e definitive. Vuole chiudere per sempre delle
questioni. Ma questa bêtise, che spesso viene recepita come una verità da un
certo tipo di persone, è per noi, con il passare della storia, estremamente
istruttiva. La storia della bellezza e dell'intelligenza, cui limitiamo il
nostro insegnamento, è solo un'infima parte dell'attività umana, lo abbiamo già
detto. Forse bisognerebbe pensare, e del resto tu lo stai già facendo, a una
storia generale dell'errore, dell'ignoranza, oltre che della bruttezza. (...)
Eco: Quanto alla bêtise, dopo
quel che ne hai detto, mi pare che sia una cosa diversa dalla stupidità. Si può
essere stupidi senza essere completamente 'bestia'. Stupidi per caso. (...) Un
caso di epifania dell'imbecillità (nel senso in cui la intendo io) è offerto da
Joyce quando riferisce una conversazione con Mister Skeffington: "Ho saputo che
suo fratello è morto", dice Skeffington. "E aveva soltanto dieci anni", gli
viene risposto. "È in ogni caso doloroso", risponde Skeffington.
Carrière: La bêtise è spesso
vicina all'errore. È questa passione per l'imbecillità che mi ha avvicinato alla
tua ricerca sui falsi. Ecco due percorsi rigorosamente ignorati
nell'insegnamento. Ogni epoca ha le sue verità da una parte e i suoi notori
imbecilli dall'altra, enormi, ma si assume il compito di insegnare, di
trasmettere, solo la verità. In qualche modo, la bêtise viene filtrata. Sì, c'è
un politicamente corretto e un 'intelligentemente corretto'. Detto diversamente,
un buon modo di pensare. Che lo vogliamo o no.
Eco: È il test dela cartina
tornasole che ci consente di verificare se siamo in presenza di un acido o di
una base. Se esistesse una cartina tornasole per questi casi, potremmo sapere,
di volta in volta, se siamo in presenza di uno stupido o di un imbecille. Ma per
tornare al tuo accostamento fra bêtise e falso: il falso non è per forza
espressione di stupidità o di imbecillità. È semplicemente un errore. Tolomeo
credeva in buona fede che la Terra fosse immobile. Commetteva un errore in
mancanza di informazioni scientifiche. Ma forse domani scopriremo che la Terra
non gira in torno al Sole e allora renderemo omaggio alla sagacia di Tolomeo.
Agire in cattiva fede significa dire il contrario di ciò che si ritiene vero. Ma
noi commettiamo sempre i nostri errori in buona fede. L'errore attraversa quindi
tutta la storia dell'umanità e per fortuna peraltro, se no saremmo degli dei. La
nozione di 'falso', che ho studiato, in realtà è molto sottile. C'è il falso che
deve apparire indiscernibilmente (nel senso leibniziano) come la stessa cosa del
suo modello. Chi presenta un falso come vero, sapendo che non è la stessa cosa
del suo modello, è in mala fede, e inganna. C'è poi, invece, il ragionamento
falso di Tolomeo, che parlando in buona fede, si sbaglia. Tolomeo non era un
falsario perché credeva davvero che la Terra fosse immobile.
Carrière: Questa precisazione
non ci facilita nel nostro sforzo di definizione: Picasso diceva che poteva fare
lui stesso dei falsi Picasso. Si è anche vantato di aver fatto i migliori falsi
Picasso del mondo.
Eco: De Chirico ha confessato
anche lui di aver fatto dei falsi De Chirico. E devo confessare anch'io di aver
fatto dei falsi Eco. Una rivista satirica italiana, una specie di Charlie Hebdo,
aveva preparato un numero speciale del 'Corriere della Sera' a proposito
dell'arrivo dei marziani sulla Terra. Evidentemente si trattava di un falso. Mi
hanno chiesto un mio falso articolo firmato da me medesimo, come parodia di Eco.
Carrière: È un modo per uscire
da se stessi, dalla propria carne dal proprio mestiere. E anche dalla propria
testa.
Eco: Ma prima di tutto è un
modo per criticarsi, per mettere tra virgolette i propri luoghi comuni, perché
sono proprio i luoghi comuni quelli che io devo ripetere per fare un falso Eco.
L'esercizio che consiste nel produrre un falso di se stessi è dunque molto sano.
Carrière: Stessa cosa per
questa indagine sulla bêtise che ci ha occupati per alcuni anni. Si è trattato
di un periodo lungo in cui io e Bechtel leggevamo solo, con accanimento, libri
bruttissimi. Spulciavamo i cataloghi delle biblioteche e, alla lettura di certi
titoli, ci facevamo già un'idea del tesoro che ci attendeva. Quando scopri,
nella tua lista, un titolo come 'Dell'influenza del velocipede sui buoni
costumi' puoi stare sicuro che troverai il tuo miele!
Eco: Il problema si presenta
quando un folle interferisce con la tua stessa vita. Come ho già detto, ho
dedicato una ricerca ai folli pubblicati dalle vanity press (editori che
pubblicano i libri a spese dell'autore, ndr) ed è evidente, per me, che
riassumevo le loro idee con ironia. Ora, alcuni di loro non hanno percepito
l'ironia e mi hanno scritto per ringraziarmi di aver preso sul serio il loro
pensiero. Stessa cosa col 'Pendolo di Foucault', che se la prendeva coi fanatici
del complotto e dell'occultismo e che ha suscitato in loro alcuni casi delle
manifestazioni di entusiasmo inattese. Ricevo ancora (o meglio: mia moglie o la
mia segretaria, che le filtrano) telefonate da parte di un Gran Maestro dei
Templari. (...) Detto questo, la difficoltà nel decidere se uno sia un cretino,
uno stupido e un imbecille viene dal fatto che queste categorie rappresentano
dei tipi ideali, sono degli Idealtypen, come direbbero i tedeschi. Ma il più
delle volte troveremo nello stesso individuo una mescolanza delle tre attitudini
messe insieme. La realtà è ben più complessa di questa tipologia. (...)
Carrière: Infatti, la prima
cosa che si scopre studiando la coglionerìa è che siamo coglioni anche noi. È
evidente. Non si trattano impunemente da coglioni gli altri se non ci si rende
conto che la loro coglionerìa è uno specchio per noi. Uno specchio permanente,
preciso e fedele.
Eco: Cadiamo nel paradosso di
Epimenide che dice che tutti i cretesi sono dei bugiardi. Poiché lui è di Creta,
è bugiardo. Se un imbecille ti dice che tutti gli altri sono imbecilli, il fatto
che lui sia imbecille non impedisce che forse ti stia dicendo la verità. Se poi
aggiunge che tutti gli altri sono degli imbecilli come lui, allora dà prova di
intelligenza. Quindi non è un imbecille. Perché quelli veri solitamente passano
la vita a far dimenticare che lo sono. Esiste anche il rischio di cadere in un
altro paradosso, che è stato enunciato da Owen. Tutte le persone sono imbecilli,
eccetto te e me. Ma anche tu, a dire la verità, se ci penso bene...
Carrière: La nostra mente è
delirante. Tutti i libri che collezioniamo, io e te, testimoniano della
dimensione propiamente vertiginosa del nostro immaginario. È particolarmente
difficile distinguere la divagazione e la follia da una parte e l'imbecillità
dall'altra.
Eco: Un altro esempio di
stupidità che mi viene in mente è quello di Nehaus, autore di un pamphlet sui
Rosa Croce scritto all'epoca in cui, verso il 1623, ci si interrogava per sapere
se esistevano o no. 'Il solo fatto che ci nascondono il fatto che esistono è la
dimostrazione della loro esistenza', afferma quest'autore. (...) E per
concludere un'altra storia. Nelle nostre società, in cui il problema del lavoro
si pone per tutti, alcune persone stanno riscoprendo l'artigianato. Spesso,
quando mi capita di avvalermi dei loro servizi, e noto che leggendo il mio nome
sulla carta di credito mostrano di sapere cosa faccio, penso che gli stessi
artigiani, cinquant'anni fa, dei miei libri non avrebbero saputo nulla. Molti
artigiani di oggi, dunque, hanno completato la loro formazione superiore, prima
di dedicarsi a un mestiere manuale. Un amico mi raccontava che aveva dovuto, con
un collega filosofo, prendere un taxi, un giorno, dall'università di Princeton a
New York. L'autista, nel racconto del mio amico, era un orso il cui viso era
completamente coperto da lunghi capelli irsuti. Inizia a conversare per capire
un po' con chi ha a che fare. Loro gli dicono che insegnano a Princeton. Ma
l'autista vuole saperne di più. Il collega, un po' scocciato, dice che si occupa
delle ontologie regionali e dell'epoché e l'autista lo interrompe dicendo: 'Ah,
vuole dire Husserl, no?'. Si trattava, naturalmente, di uno studente di
filosofia che faceva il taxi driver per pagarsi gli studi. Ma all'epoca un
autista che conoscesse Husserl era una specie assolutamente rara. Oggi vi può
capitare di incontrare un autista che ascolta musica classica e che a me fa
domande sul mio ultimo lavoro semiotico. Non è del tutto surreale.
Carrière: Nell'insieme sono
notizie positive, no?
Eco: Possiamo insistere sui
progressi della cultura, che sono manifesti e che toccano categorie sociali che
prima ne erano escluse. Ma contemporaneamente, c'è sempre più imbecillità. Non è
che, perché stavano zitti, i contadini di un tempo fossero scemi. Essere colti
non significa necessariamente essere intelligenti. No. Ma oggi tutte queste
persone vogliono farsi sentire e fatalmente, in alcuni casi, ci fanno sentire
solo la loro imbecillità. Quindi possiamo dire che l'imbecillità di un tempo non
si esponeva, non si faceva riconoscere, mentre adesso offende le nostre
giornate.
LA VERITA' E' FALSA.
La «post-verità» da Platone
fino a Trump.
La filosofa Adriana Cavarero analizza le radici della «parola internazionale
dell’anno», ovvero quando i governanti diventano popolari sfruttando il
pregiudizio e l’ignoranza, scrive Adriana Cavarero il 18 giugno 2017 su "Il
Corriere della Sera". Gli Oxford Dictionaries hanno eletto «post verità» parola
internazionale dell’anno 2016, a seguito del controverso referendum sulla
«Brexit» e dell’elezione presidenziale americana ugualmente contestata, che
hanno contribuito a diffondere questo termine tanto nei mass media che nel gergo
politico. Il dizionario definisce «post-verità» come «in rapporto o contestuale
a circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel plasmare
l’opinione pubblica rispetto alla leva esercitata sulle emozioni e sulle
credenze personali». Il prefisso «post», in questo caso, non significa
«successivo», ma anzi denota un’atmosfera in cui la verità è irrilevante e
prevalgono le credenze radicate nelle emozioni. Ci si chiede se una politica che
fonda la sua agenda sul principio della verità, scartando il regno emotivo di
sentimenti e credenze, sia mai esistita nell’intera tradizione politica
dell’Occidente. A dire il vero è esistita, ma solo nel registro astratto della
teoria: nella fervida immaginazione politica di Platone.
Nella Repubblica, Platone
esamina l’antagonismo tra una politica costruita sulla verità, che corrisponde
alla sua concezione della polis ideale, e una politica costruita invece sulle
emozioni, ovvero sul pathos, la patologia di quella entità politica collettiva
che egli chiama «i molti» — hoi polloi — e che descrive in modo allegorico come
«un grosso animale». Il contesto in cui questa celebre e ignobile immagine
emerge è un discorso di Socrate sulla natura del vero filosofo, che si distingue
dalla natura di altri esperti di logos nell’Atene contemporanea, i sofisti.
Nello sviluppare una speciale tecnica di linguaggio che riesce ad emozionare «i
molti» i sofisti si prestano a pagamento a istruire i futuri leader politici su
un discorso che miri a manipolare il pubblico e, tecnicamente, a conquistarsi i
voti degli elettori. Platone paragona il sofista a qualcuno che «avesse compreso
gli impulsi e i desideri di un animale da lui allevato grande e forte e sapesse
come bisogna avvicinarsi a lui e quando e per quali motivi diventa più
irascibile o più mite, quali suoni è solito emettere a seconda delle
circostanze, e quali, se proferiti da altri, lo ammansiscono e lo irritano; e
tutte queste conoscenze, apprese grazie a una lunga dimestichezza, le chiamasse
sapienza e si volgesse a insegnarle quasi avesse istituito un’arte;… tutto in
base alle opinioni di quel grosso animale».
È risaputo che le teorie
antidemocratiche di Platone sono state storicamente cooptate dalla tradizione
reazionaria e dall’estrema destra, persino dalle ideologie naziste. Eppure vale
la pena riflettere sulla sua critica della democrazia. Platone sostiene che la
democrazia si trasforma inevitabilmente in demagogia, un regime politico che
provoca la corruzione del popolo tramite la manipolazione dell’opinione pubblica
e crea governanti che accrescono la loro popolarità sfruttando il pregiudizio e
l’ignoranza di molti, rinfocolando le loro emozioni e contrastando le decisioni
ragionate. Questi leader si specializzano nel coltivare, incrementare,
riprodurre e riformulare gli impulsi del grosso animale, allo scopo di stabilire
e affermare un sistema di potere fondato sul pathos, una forma di «politica
patologica». In questo senso, la polis ideale di Platone è all’opposto: come
governanti, i filosofi sono in realtà guidati dalla verità del logos, ovvero
dalla capacità della ragione di controllare e reprimere gli impulsi delle parti
più basse e viscerali. I filosofi, sostiene Platone, devono essere educati ad
amare la verità e provare vergogna nel mentire. Al contrario, dato che i
politici educati dai sofisti guardano al logos non come una struttura che
racchiude l’ordine della verità, ma piuttosto come uno strumento di azione per
manipolare le emozioni della gente, essi mentono. La verità è irrilevante in
questo contesto patologico. Talmente irrilevante che qualunque cosa il grosso
animale creda o sia persuaso a credere, ciò corrisponde al vero. Il concetto
della post-verità applicata alla politica, come suggerisce il dizionario di
Oxford e come Platone sembra presagire, non liquida la verità, bensì la rende
irrilevante.
La posta in gioco non è la
verità, bensì il potere: sia il potere generalmente definito come dominio sugli
altri tramite mezzi di persuasione oppure, più nello specifico, come
caratteristica distintiva di operazioni linguistiche capaci di dimostrare
l’irrilevanza e, in ultima analisi, la superfluità del vero. Platone,
antidemocratico ed elitista, è il primo a detestare i tecnici della
manipolazione del popolo che trasformano l’esercizio della menzogna in un’arte
politica efficace, accettabile e gradevole, l’arte del discorso acrobatico, una
specie di funambolismo verbale assai divertente. Per questo motivo Platone non
esita a definire ciarlatani i sofisti e i loro emuli in politica, aggiungendo
che la loro esibizione corrisponde ai gusti popolari degli spettatori del circo.
Potrei aggregarmi alla schiera
degli scettici, ma non è questo il mio scopo. In questo momento, mi appassiono
alla descrizione della fenomenologia della politica patologica, nel suo
annoverare anacronistico e altamente polemico di una serie di caratteristiche e
preoccupazioni riguardanti un certo pathos politico, i cui profili sembrano
convergere nell’attuale definizione di post-verità. Se Platone insistendo sulle
emozioni dei «molti» dava consistenza e giustificazione alla bugia, Hannah
Arendt ci aiuta a comprendere lo specifico della menzogna politica moderna come
«bugia fabbricata» e fittizia. La presa sulle emozioni è in questo caso
aggravata da una comunicazione che, lungi dall’essere manipolazione acrobatica
del discorso, mira ad accattivarsi il pubblico attraverso frasi tanto efficaci
quanto sconnesse: in pratica sembrano vere in quanto prodotte non dalla ragione
ma da impulsi. Improvvisato e privo di coerenza teorica il discorso politico
dell’attuale potere spegne in noi il senso del reale, sostituendo la nostra
presa sulla realtà con fatti «alternativi», fake theory, bugie rese «reali» dai
social media. Nell’era della post verità il potere si esprime con stile
improvvisato. Quello che twitter trasforma in realtà. Il rapporto tra verità e
politica è definitivamente collassato? (Traduzione Rita Baldassarre)
La polemica: verità,
post-verità e ragione. La verità tra sentimento soggettivo, dubbio e controllo
della ragione,
scrive Rocco Buttiglione il 15 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Adesso è di moda la
post-verità. Uno incolto potrebbe pensare che la post-verità sia quello che una
volta si chiamava menzogna ma in realtà non è proprio così. Tra la idea di
menzogna e quella di post-verità sta la morte della idea di verità. I saggi, i
colti, ci hanno spiegato che la verità non esiste. Prima ancora dell’era del web
e della proliferazione incontrollata dei blog, dalle colonne dei grandi giornali
e dalle cattedre universitarie ci hanno detto che la verità è pericolosa per la
democrazia, che quelli che credono una verità hanno la tendenza naturale ad
imporla e quindi sono tendenzialmente totalitari. C’è stato anche chi ha
denunciato la pretesa totalitaria della ragione ed esaltato il primato della
autenticità soggettiva. Che succede quando muore l’idea di verità? Ognuno di noi
è abitato da un groviglio di impulsi, paure, desideri e tensioni istintive. La
idea di verità ha la funzione di controllare (Foucault direbbe sorvegliare)
questo magma, di costringerlo a fare i conti con la realtà. Se questo non
avviene l’uomo rimane prigioniero di se stesso, perde la capacità di adattarsi
all’ambiente, infine muore. Della realtà fanno parte anche gli altri esseri
umani. Quando muore l’idea di verità muore anche il dialogo che unisce gli
uomini fra di loro. Ogni uomo infatti ha una sua verità, che è la risultante
delle sue interne passioni dell’anima. Per poter confrontare la mia verità con
la verità dell’altro ho bisogno di credere in una verità più grande che possiamo
scoprire insieme. Se questa idea viene meno avremo il pluralismo delle verità.
Ognuno griderà la sua verità con tutta la forza di cui dispone. Il pluralismo
delle verità era l’ideale dei decostruzionisti (quelli che volevano decostruire
l’idea di verità). Essi, per la verità, immaginavano la coesistenza pacifica,
senza violenza, delle diverse verità. Adesso abbiamo visto che si sbagliavano.
Non vedevano il fatto che viviamo in un mondo comune e diamo forma alle nostre
società attraverso un lavoro comune. Per realizzare il mio desiderio, per dare
forma alla mia idea di verità, ho bisogno della collaborazione dell’altro.
Credevano che il desiderio fosse buono o almeno innocuo. Non vedevano che
l’invidia la violenza contro l’altro uomo è una componente fondamentale del
desiderio non sottoposto al vincolo della ragione. Assistiamo dunque ad una
regressione di massa. Nel Mercante di Venezia Shakespeare ci offre un modello
insuperabile di questo movimento di pensiero. Io sono frustrato per le mille
ragioni che si frappongono fra il mio desiderio e la sua realizzazione. Invece
di cercare un percorso reale verso la realizzazione del desiderio mi trovo un
responsabile immaginario della mia infelicità. Nel caso di Shakespeare questo
responsabile è Shylock, l’ebreo. La mia frustrazione è reale e la condensazione
delle sue cause in un personaggio fantastico è una grande opera d’arte. La
identificazione di questo personaggio fantastico con l’ebreo reale è invece
demoniaca (esiste anche il demoniaco nell’arte). Io sento che l’ebreo è la causa
del male del mondo e, data che non esiste nessuna ragione superiore abilitata a
giudicare del mio sentimento, allora l’ebreo è davvero, almeno per me (e per
quanti si lasciano contagiare dal mio sentimento) la causa di tutti i mali del
mondo. Per la verità una crisi analoga della idea di verità l’Europa la ha
vissuta fra la fine del secolo XIX e gli inizi del secolo XX. È da quella crisi
che nacquero i totalitarismi. Non a caso i nuovi filosofi della decostruzione
fanno tutti riferimento a Nietzsche. Adesso si tende ad addossare al web tutti i
mali della post verità. Il ragionamento andrebbe rovesciato. La diffusione del
web ha effetti così distruttivi perché avviene in un tempo storico che già
precedentemente aveva rinunciato alla idea di verità. Non abbiamo assistito a
linciaggi mediatici fatti dalla grande stampa che adesso si straccia le vesti
per le bufale del web già molti anni prima della diffusione di internet? Sia
chiaro: internet va regolato ed è del tutto inaccettabile l’idea che esso possa
essere uno spazio anarchico in cui ci si sottrae alla responsabilità per le
proprie azioni. Talvolta le parole sono pietre e chi le scaglia non si può
sottrarre alla propria responsabilità. Il problema vero, però, non è la
regolamentazione del web, é la riabilitazione della idea di verità. Un problema
strettamente connesso, poi, è quello del ripristino dei confini fra i generi
letterari. In occasione dell’anniversario dell’attentato a Charlie Ebdo si
moltiplicano gli articoli che chiedono un uso responsabile della satira. È
giusto chiedere a chi fa della satira di essere responsabile? La satira è sempre
stata un modo di far emergere il represso. Rido perché scopro in me stesso un
umore che collude con quello che la satira mi dice, per crudele ed osceno che
sia. Ne rido perché so che non è vero. È come andare allo zoo (pardon: al parco
biologico) a vedere gli animali feroci. Mi diverto perché so che sono
inoffensivi. Il vero problema è che è saltata la distinzione fra la satira e
l’informazione. Una satira politicamente militante ha diseducato una generazione
abituandola a pensare che il satiro dice la verità ovvero che non esiste
differenza fra il sentimento soggettivo e la verità. Fra il sentimento
soggettivo e la verità esiste il controllo della ragione. La ragione vaglia i
fatti e valuta se essi confermino o contraddicano il sentimento soggettivo. La
ragione sottopone il sentimento soggettivo al controllo metodico del dubbio e lo
lascia valere solo se supera (nella misura in cui supera) questo vaglio del
dubbio. Nel fare questo la ragione considera diverse ipotesi alternative. Esse
hanno però il dovere di rendere ragione di tutti i fatti accertati, non possono
selezionare solo i fatti che le confermano tacendo quelli che le contraddicono.
È solo attraverso questo difficile esercizio che cresce una opinione pubblica
matura. Senza di essa però la democrazia muore.
Noi in trappola tra bufale
e censura.
La circolazione di false notizie online non si combatte con lo stop alla libertà
di parola. Ma evitando l’impunità di chi le diffonde, scrive Roberto Saviano
l'08 gennaio 2017 su "L'Espresso". Come sempre in Italia (anche quando le
notizie che ci riguardano arrivano dall’estero) si ragiona tirando in ballo la
parola “emergenza” per far leva sull’emotività. Come sempre - e questo impedisce
la ricerca reale di una soluzione - si propongono ricette inattuabili e che
hanno un retrogusto amaro, quando non pericoloso. E come sempre, la risposta non
tarda ad arrivare. Anch’essa è scomposta, deve alzare i toni perché la gara è a
chi la spara più grossa, a chi fa più proselitismo e ovviamente il proposito
finale non è trovare una soluzione, ma lasciare tutto com’è. Ché, detto tra noi,
quando le cose vanno male sono in molti a stare bene. Ed ecco la nuova reale e
pressante urgenza ed emergenza democratica: le bufale online, le false notizie.
Non fraintendete il mio tono, è effettivamente un problema che esiste e non va
sottovalutato, ma la sua risoluzione non si chiama censura. Per fare un esempio
che è sotto gli occhi di tutti, secondo l’analisi della testata americana
BuzzFeed, nella fase conclusiva della campagna presidenziale americana, le 20
notizie false più cliccate su Facebook hanno generato più condivisioni, più like
e più commenti rispetto alle 20 notizie vere più cliccate: “Il Papa appoggia
Donald Trump” (notizia falsa) ha avuto più condivisioni dell’inchiesta del
Washington Post sui reati di truffa e corruzione di Trump (notizia vera). L’ho
presa larga, ma sto parlando della nostra Costituzione, quella stessa che molti
vogliono difendere, che pochi conoscono e che pochissimi si impegnano perché sia
effettivamente applicata. Sto parlando dell’articolo 21 di cui cito le prime
righe: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”. E io
aggiungerei questo: la tutela della libera formazione delle opinioni nelle
persone è un diritto fondamentale da tutelare e se le bufale, se le false
notizie presenti online mettono a rischio questa libertà la risposta non può
essere il controllo dello Stato sulle conseguenze, ma la ricerca delle cause.
Allo stesso tempo la soluzione non può essere far finta che il problema non
esista e rivendicare il diritto a dire ciò che si vuole, ovvero il diritto
all’irresponsabilità. Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, rilascia
al Financial Times (ecco la notizia che ci arriva dall’estero) un’intervista
sullo stato dell’informazione in Italia e dice che la maggiore causa di degrado
della democrazia sono le bufale che circolano sul web e sui social. Pitruzzella
dice di non fidarsi del controllo che i social farebbero sulle notizie false e
auspica la costituzione di una serie di istituti indipendenti coordinati da
Bruxelles e modellati sull’Antitrust. Non sarebbe lavoro da affidare a società
private, dice, perché: «è storicamente compito dei poteri pubblici». Afferma di
non temere alcun rischio censura perché le persone «potranno continuare a
utilizzare un web libero e aperto» (con “free”, l’intervista era in inglese, non
credo di riferisse alla gratuità del servizio che in Italia è costoso anche
quando - e capita spesso - è scadente. Ma questa è un’altra storia).
Pitruzzella, a margine della sua intervista, accenna anche alla soluzione già
esistente, ovvero il ricorso dei privati cittadini che si sentono danneggiati
dalle false notizie all’autorità giudiziaria ma, secondo Pitruzzella, la
macchina giudiziaria è notoriamente “clunky” che io tradurrei con “oberata”,
“ingolfata”. Ecco, quindi una risposta di buon senso a Pitruzella poteva essere
questa: ma invece di pensare a un intervento dello Stato, non sarebbe stato
meglio auspicare una riforma del sistema giudiziario dando atto delle
ripercussioni che il suo malfunzionamento ha anche sulla circolazione di notizie
false e sulla sostanziale impunità per chi le produce e le diffonde? E invece no
e a rispondere immediatamente è Beppe Grillo, che nella sua invettiva omette di
citare le bufale da cui tutto oltreoceano era partito, e si accomoda sul banco
degli imputati dicendo che è lui che vogliono zittire e censurare. Pitruzzella
non l’aveva citato Grillo, che però, sentendosi chiamato in causa, rivendica di
fatto il diritto alla bufala. Conclusione: c’è chi vorrebbe censurare e chi
vuole dire balle, in mezzo ci siamo noi. That’s all folks.
La verità? E' falsa: 2016,
un anno di bufale.
Da Agnese Renzi che vota no a Boldi nei panni di Berlusconi, un’antologia delle
migliori-peggiori notizie fasulle alle quali una quantità immane di persone ha
abboccato. Un racconto lungo dodici mesi di disinformazione, scrive Maurizio Di
Fazio il 23 dicembre 2016 su "L'Espresso". Notizie false, falsissime, a cui però
si è creduto in massa. Frottole, meme, favolette acchiappa-click diventate
virali e verità costituita. Bufale passate senza soluzione di continuità dalla
babele interessata dei siti Internet dedicati all’opinione pubblica ufficiale.
Con i social network a fare spesso da porta girevole, da docile quinta colonna
per la moltiplicazione incontrollata delle fandonie legate soprattutto alla
politica, all’attualità, al costume, alla scienza e alla tecnologia. Per il
guadagno di pochi mercanti di menzogne (capaci di aggirare a volte anche il
sistema immunitario dei media autentici), complice la dabbenaggine di molti e
insospettabili fruitori “attivi”, armati di like e condivisione. Questa è la
storia contraffatta, ma sulle prime contrabbandata per buona, dell’anno che se
ne va tra allarmismi, pietismi e le consuete morti ingannevoli di celebrities
della politica e dello spettacolo; rivelazioni della Nasa sull’esistenza degli
alieni; nuove e spaventose malattie in agguato e ripristini imminenti della leva
obbligatoria; Facebook e Whatsapp che diventeranno a pagamento, e il ritorno
alla lira fissato per il primo gennaio; l’ex ministro Cécile Kyenge che vomita
cattiverie contro il nostro Paese, Laura Boldrini che preferisce gli immigrati
clandestini a tutti noi e i giustizieri del pomeriggio che suppliscono col far
west al lassismo di una classe politica che sempre dal primo gennaio ci toglierà
la pensione per ridistribuirla agli immigrati stupratori. Eccovi quindi
un’antologia delle migliori, peggiori bufale del 2016, alle quali una quantità
immane di persone ha abboccato. Un racconto lungo dodici mesi di disinformazione
fattasi, per assurdo, fantomatica informazione corrente.
Attentato a Bruxelles.
Il 23 marzo,
il giorno dopo la strage all’aeroporto dell’Isis, ci casca la gran parte dei
quotidiani italiani online, che pubblicano un video fake in apparenza
riconducibile alle telecamere a circuito chiuso. E il video rimbalza in tutte le
dirette televisive, commentato dal fior fiore degli opinionisti ed esperti di
terrorismo e geopolitica. In verità, il filmato è relativo a un’altra
carneficina, quella perpetrata cinque anni prima, l’11 gennaio del 2011,
all’aeroporto russo di Mosca-Domodedovo, già presente già su Youtube.
Referendum sulle trivelle
di aprile.
Nel pubblicizzare il referendum, i “no triv” assicurano che sposando la loro
posizione si eliminerebbero le piattaforme petrolifere dal panorama dei mari
italiani. Ma non è così: il quesito referendario si limita al divieto del
rinnovo delle concessioni per le trivellazioni in mare entro le dodici miglia. I
fautori del sì agitano invece lo spettro dell’impennata dei licenziamenti e del
crollo delle entrate dei petrolieri qualora perdessero la propria battaglia:
doppio falso. Desta clamore il tweet di Giampaolo Galli, docente e parlamentare
del Pd, che inneggia all’“astensione per Regeni e i marò”.
Sisma e menzogne.
Nemmeno il tempo di riprendersi dallo spavento per i terremoti che squassano,
tra agosto e ottobre, il centro Italia, che si fa largo la bugia epidemica della
magnitudo abbassata ad arte (sotto i sei gradi) per non pagare i danni ai
cittadini. Su Facebook proliferano tanti novelli sismologi, che asseverano con
forza la bontà della loro teoria.
Referendum costituzionale.
Da Gigi
D’Alessio e Barbara D’Urso che smetteranno rispettivamente di cantare e di fare
televisione se vincesse il no, a Vladimir Putin (un beniamino dei bufalari) che
dichiara: “Se vince il sì, la Russia agirà di conseguenza, e non in senso
positivo”. E che dire del presunto outing della first-lady Agnese Renzi, col suo
“Voterò no”? Ma la bufala-spartiacque si mette in moto sulla scia del post
Facebook del frontman dei Liftiba, Piero Pelù, che denuncia di essere stato
costretto a usare una matita non copiativa in cabina elettorale. Parecchi altri
seguono il suo esempio, nonostante la smentita ufficiale del Viminale. Le matite
copiative funzionano solo su certi tipi di carta, e su quella normale si
comportano come semplici matite. S’è sempre saputo.
Immigrati brutti, sporchi e
cattivi. “Il
Governo dà 35 euro al giorno a ogni immigrato”: tra le bufale a tema, questa è
tra le più classiche. E tra gli “scoop” farseschi e xenofobi più originali
dell’anno, si segnala questo del 28 agosto. “Pescara. Io ho più bisogno di quei
terremotati, che si fottano. Da qui non me ne vado. Queste le parole di Mustafa
Thomas Daverie, immigrato sbarcato a Lampedusa nel 2015 che attualmente
soggiorna presso l’hotel (inesistente) “Nobelli” di Montesilvano. Il senegalese
continua affermando che “i terremotati hanno i soldi quindi si possono risolvere
da soli. Io no”, mentre tiene in mano il nuovissimo Galaxy S7 Edge pagato con le
nostre tasse, 35 euro al giorno per la legge stabilita dal governo Renzi in
collaborazione con la Boldrini. La nostra redazione è indignata dai commenti di
questo ragazzo a cui noi italiani abbiamo salvato la vita. Ti senti indignato
anche tu? Condividi il post, tutti devono sapere”. E in migliaia accorrono e
condividono.
L'esordio di Gentiloni.
"Basta
ipocrisie, sono tutti finti poveri e io sono già scocciato di questo piagnisteo:
rimboccarsi le maniche per il futuro del paese, qualche sacrificio non ha mai
ammazzato nessuno, solo così l’Italia tornerà a primeggiare in Europa”. Queste
le frasi che avrebbe proferito il nuovo presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni. Parola, credibilissima, di “Libero Giornale”. Lo sfogo fittizio di
Gentiloni prosegue così: "Ma per ritornare ad essere veramente competitivi gli
italiani devono fare dei piccoli sacrifici quali smettere di lagnarsi sui social
e poi fare la fila per comprarsi l’ultimo iPhone o insultare i protagonisti di
Riccanza per poi fare tavolo in discoteca in 40 per potersi permettere una
bottiglia di DonPero. Risparmiassero 10 euro in più al mese, così potrebbero
campare dignitosamente".
Renzi che parla al
cellulare in momenti decisamente inopportuni.
Nella foto-meme si vedono Renzi, Boldrini, Grasso e Mattarella ad Ascoli al
funerale delle vittime del terremoto, mentre si fanno il segno della croce.
Qualcuno però mette in giro la voce che la mano del premier dietro la cravatta
stia manipolando, in gran segreto, il suo smartphone… Una suggestione e niente
più. Troppo tardi: l’indignazione dilaga sui social.
Pokémon bufala.
Narra uno delle decine di siti di informazione pataccara: “La situazione sta
davvero degenerando, incidente d’auto causato da Pokèmon Go. Un 22enne romano ha
perso il controllo della sua auto che si è ribaltata a causa della brusca
sterzata che il giovane aveva eseguito quando si è accorto che stava invadendo
la corsia opposta. L’auto ha preso fiamme ma per fortuna il giovane è stato
estratto e portato immediatamente in ospedale, dove, per le condizioni
gravissime, è deceduto. La polizia municipale accorsa sul posto ha rilevato
subito che il giovane usava lo smartphone mentre giocava a Pokémon Go, il nuovo
videogame lanciato da Nintendo alcuni giorni fa e che sta facendo impazzire gli
appassionati di tutto il mondo. La distrazione del videogame sul display del
cellulare gli è stata fatale: l’auto è andata completamente distrutta come si
vede nella foto”. Tutto falso. Hai capito, Galileo? Il rapper B.o.b. si professa
convinto che la terra sia piatta e non sferica. E il bello è che lo seguono in
moltitudini in questo suo sragionamento che ci riporta indietro di secoli, ai
tempi della realtà aumentata.
Bufal-Stracult.
1) Il 5 marzo il solito
“Libero Giornale” pubblica un “pezzo” dal titolo Sicilia: estremista islamico
uccide il cane della fidanzata perché annusa il Corano. Svolgimento:
“Bruttissima storia di crudeltà e ignoranza arriva da tranquillo comune
siciliano di Marina di Vigata. Un pizzaiolo algerino di 22 anni, Aarif al Djebar
ha crocifisso il cane della sua fidanzata italiana, una meticcio di Chihuahua.
La bestiola era colpevole di aver annusato il suo Corano, incautamente lasciato
sopra una sedia. L’uomo, che sembra avere legami con l’Isis, l’ha presa e l’ha
crocifissa, poi, non contento ha anche dato fuoco alla carcassa. Il 22enne ha
detto di averlo fatto perché era un cane degli infedeli. Il giovane, che risulta
essere un clandestino, è balzato agli onori della cronaca francese quando nel
2011 fece saltare in aria un allevamento di maiali a Buffle, nella bassa
Provenza”.
2) “Rocco Siffredi ha
intrattenuto rapporti intimi con due donne nel bagno di un ristorante ed è stato
allontanato dal proprietario su sollecitazione di clienti imbarazzati per i
rumori”. Questa leggenda metropolitana è stata purtroppo ripresa e rilanciata
anche da testate serie e autorevoli.
3) “Massimo Boldi vestirà i
panni di Silvio Berlusconi nel prossimo film di Paolo Sorrentino”. La notizia,
piuttosto incredibile, viene pubblicata da svariati giornali solitamente
credibili. Ma era l’ennesima bufala assurta al rango di vero, sia pure giusto
per qualche ora: un’eternità incontenibile, sul web.
I cretini della post verità
Francesco,
scrive Maria del Vigo l'1 gennaio 2017 su “Il Giornale”. É l’anno dei cretini
della post verità. Termine già certificato dal prestigiosissimo Oxford
Dictionary e infatti tutti i più saccenti giornaloni si sono affrettati a
mandare a memoria questa parola: dal Guardian al Washington Post, dal Times al
Corriere della Sera, dal radicalchicchissimo Internazionale a Repubblica. È la
parola dell’anno finito e senza dubbio ci romperanno le balle con questa
strampalata teoria anche in quello che ha appena iniziato. Ma cos’è dunque
questa post verità? Di cosa si stratta? È il solito giro di parole che le elite
radical chic si inventano per darsi un po’ di arie. Questi sterminatori di
parole e di buon senso hanno decretato che siamo nell’era della posto verità; e,
per intenderci, sono gli stessi che chiamano lo spazzino operatore ecologico e
l’handicappato diversamente abile; quelli che hanno inventato decine di
perifrasi per catalogare (con estremo rispetto, ovviamente!) tutti i gusti
sessuali, quelli che si dice genitore 1 e 2, quelli che se dici negro ti mettono
alla gogna e che prima o poi chiameranno i bianchi diversamente neri per non
essere troppo razzisti, senza accorgersi di essere gli ultimi razzisti rimasti
sul pianeta terra. Hanno ecceduto a tal punto in questa ossessione politicamente
corretta da essere diventati la caricatura di loro stessi. E qualcuno,
esasperato da questo galateo dell’ipocrisia, ha sbroccato e ha pensato bene di
ruttargli in faccia. L’ultimo in ordine temporale è stato Beppe Grillo. Ma
torniamo alla post verità e al suo significato. Post verità è un modo per dire
bufala, balla, bugia. Ma siccome – come dicevamo prima - loro non chiamano mai
le cose col loro nome hanno pensato di apparecchiare questo termine paludato. La
post verità è una bufala di nome e di fatto. La teoria è che nel far west della
rete circolino così tante bugie che la gente (che se avessero il coraggio delle
loro azioni definirebbero “plebi”) finisce per crederci e per farsene
influenzare. Per non cadere nel loro stesso gioco: siamo di fronte a una cagata
pazzesca. Provate un po’ a indovinare quando ha preso campo questa idea? Vi
aiuto io: si è fatta largo silenziosamente dopo il successo della Brexit, è
esplosa a livello mondiale a seguito della vittoria di Donald Trump e in Italia
è diventata verbo dopo il trionfo del No al referendum costituzionale. Un caso?
No. Anche perché coloro che la hanno inventata e la utilizzano come una
scimitarra contro le folle populiste, sono gli stessi che non avevano capito
niente di quello che stava ribollendo nei loro rispettivi paesi. Quelli che fino
al giorno prima dicevano che se la Gran Bretagna fosse uscita dall’Europa il
secolare impero di sua Maestà sarebbe andato gambe all’aria, che
quell’arricchito di Trump avrebbe fatto esplodere il mondo e che lo stop alle
riforme avrebbe portato ogni forma di distruzione sullo Stivale (queste non
erano post verità ma semplicemente delle idiozie). Invece la regina è ancora lì
con la sua imperturbabile permanente, Trump rispetto all’ultimo, isterico, Obama
sembra uno statista e in Italia non è cambiato un tubo. Dunque, lorsignori, non
adattandosi a un mondo che va per i fatti suoi e non si adatta ai fatti che
circolano nella loro testa, hanno deciso di ribaltare il tavolo: hanno vinto i
populisti perché la menzogna ha prevalso sulla verità e gli elettori hanno preso
lucciole per lanterne. Insomma, è stato solo un gigantesco abbaglio. Ed è tutta
colpa di internet e dei social network. Il passo successivo – e qualcuno già lo
ha fatto capire tra le righe – è dire che gli elettori sono solo una massa di
imbecilli e quindi bisogna abolire il suffragio universale. Così improvvisamente
la post verità è stata spalmata come un balsamo su tutti i mezzi di
comunicazione. Quando non sai come giustificare un clamoroso fallimento della
tua combriccola ideologica tiri fuori la post verità e tac è fatta. Un manipolo
di cretini che non capisce un cavolo di quello che vuole realmente la gente ha
risolto la situazione classificando come ebeti qualche centinaio di milioni di
persone: noi stiamo dalla parte giusta, loro da quella sbagliata perché sono
ignoranti che si bevono qualunque fesseria. Perché è rassicurante, per chi ha
perso ogni punto di rifermento, convincersi che è tutta colpa delle balle e di
chi le posta su Facebook. Come se non fossero mai esistite le bufale, come se i
cittadini, gli internauti e dunque gli elettori, non fossero capaci di
distinguere autonomamente il vero dal falso. E così da strampalata teoria
autoassolutoria e popolodenigratoria si è trasformata in un’istanza politica. Ed
è questo il pericolo. Perché i governi hanno iniziato a dire che bisogna porre
rimedio a questa cosa, che i social network sono delle cloache a cielo aperto
dove tutti – ohibò! – possono dire quello che gli pare. Giovanni Pitruzzella, il
presidente dell’Antitrust, ha dichiarato al Financial Times che “i pubblici
poteri devono controllare l’informazione”. Oh, finalmente qualcuno ha calato la
maschera. Beppe Grillo, una volta in vita sua, ha detto una cosa giusta: questa
è una nuova inquisizione. Ha ragione. Ci manca solo che i burocrati di Roma o –
ancora peggio – di Bruxelles si mettano a censurare quello che scriviamo sui
nostri profili Facebook… Anche perché, allora, se si dichiara guerra alle balle
bisogna mettere alla berlina tutti, ma proprio tutti i pinocchi del mondo, e non
solo su Facebook. Sento tintinnare le ginocchia in Parlamento. Vogliamo
imbavagliare Maria Elena Boschi perché in televisione diceva che con la vittoria
del No sarebbe stato più difficile combattere il terrorismo islamico? E quella
non era post verità, ma proprio una stronzata. Difatti i cittadini lo hanno
capito, hanno smontato una per una tutte le trimalcioniche promesse referendarie
e hanno dato il benservito a Renzi e al suo governo. A dimostrazione del fatto
che gli elettori non hanno bisogno di una badante di Stato che verifichi e
selezioni per loro quello che possono o non possono leggere. Ma loro, questa
badante ce la vorrebbero appioppare. Vorrebbero mettere le nostre idee in
libertà vigilata, sigillare una zona traffico limitato del pensiero, mettere
fuori legge gli eretici. Perché ci vuole un attimo a infilare le critiche nel
cestino della spazzatura, dello spam illeggibile. Sognano una discarica
indifferenziata del pensiero politicamente diverso. Non scorretto. Gli scorretti
– quelli che vogliono cambiare le regole del gioco – sono soltanto loro. Non ce
la faranno, perché cercare di fermare la rete – la gente – con qualche carta
bollata è come pensare di poter svuotare il Sahara con un cucchiaino da tè. Ma
il 2017 sarà comunque l’anno in cui i cretini della post verità cercheranno di
mangiarsi pezzi della nostra libertà. Libertà di informazione, libertà di
critica e financo politica. Stiamo all’erta.
"Non credono ai social, ma
tre giovani su dieci rilanciano le bufale".
L'87% diffida della Rete, ma
il 28,5% ha condiviso almeno un fake e l'11% diffonde "sempre e comunque". I
dati dell'istituto Toniolo, scrive Cristina Nadotti il 28 gennaio 2017 su "La
Repubblica". Consapevoli che quanto si legge sui social andrebbe verificato, ma
comunque pronti al clic veloce che diffonde la bufala. Ci sono soprattutto due
dati, nell'indagine dell'Osservatorio giovani dell'Istituto G. Toniolo su
"Diffusione, uso, insidie dei social network", capaci di fotografare la società
della post-verità: tra i giovani che hanno dai 20 ai 34 anni circa uno su tre
(il 28,5 per cento) ammette di aver condiviso un'informazione poi rivelatasi
falsa. Eppure il pericolo bufala è noto: l'86,6 per cento afferma che i social
non vanno presi troppo sul serio perché "i contenuti che vi si pubblicano
possono essere tanto veri quanto inventati". Un'anticipazione dell'indagine,
condotta nel mese in corso su un campione di 2.182 persone, rappresentativo dei
giovani dai 20 ai 34 anni, sarà presentata oggi all'incontro "Vero, verosimile,
post-verità", che l'arcivescovo di Milano terrà con giornalisti e comunicatori.
I dati raccolti sulla diffusione delle bufale in rete lasciano tuttavia qualche
speranza su un mutamento di tendenza, su una maggiore consapevolezza nell'uso
dei social. Se, come detto, il 28,5 per cento ha condiviso informazioni poi
risultate false, il 75,4 riferisce che, dopo un'esperienza personale o la
diffusione di una bufala da parte di un amico, ha aumentato la sensibilità sul
tema e l'attenzione ai contenuti "sospetti". In particolare, il 55,6 per cento
ha smesso di condividere contenuti da contatti a rischio e il 41,7 per cento ha
rimosso dalla propria rete chi diffondeva notizie false. Ma resta un 11,2 per
cento che tende a condividere "sempre e comunque, tanto è impossibile appurare
l'attendibilità di quello che circola in rete". La capacità di fiutare l'inganno
e di aumentare l'attenzione è poi strettamente legata agli strumenti culturali.
Tra chi ha il solo diploma di scuola media, la condivisione di un bufala è al
31,7 per cento, scende al 24 per cento tra i laureati. Con un titolo di studio
universitario si individuano le notizie false condivise da altri (77,8 per
cento, contro il 74,6 per cento di chi ha un titolo intermedio e il 70,4 per
cento di chi ha un titolo basso) e anche la reazione dipende dal livello
culturale: il 79,1 per cento dei laureati è pronto a cancellare un contatto
facile alle fake news, contro rispettivamente il 76,7 e 71,4 di chi ha un titolo
intermedio o basso. Confermati anche il primato di Facebook tra i social network
e l'uso dello smartphone. Il 90,3 per cento degli intervistati è presente sul
social di Zuckerberg, il 56,6 per cento è su Instagram, Google+ cattura il 53,9
per cento degli utenti, mentre Twitter resta al 39,9. Chi usa Facebook è più
assiduo (oltre il 90 per cento presente con cadenza quotidiana) e lo strumento
privilegiato per connettersi è il telefonino (72,7 per cento), sul quale si
leggono post di amici e follower (74,1 per cento), news (63,2 per cento), si
conversa via messenger (57,8 per cento) e si commentano post dei contatti (49,1
per cento). Non vacilla il binomio rete/libertà: il 69,2 per cento degli
intervistati considera i social uno strumento dove è più semplice comunicare
stati d'animo ed emozioni ed esprimere "apertamente il proprio punto di vista
sulle questioni più controverse dell'attualità" (71,3 per cento) con un
linguaggio più schietto e diretto (70,1 per cento).
Contro la post-verità in
rete, legittima difesa degli utenti.
Non serve la censura ma il
lavoro di contrasto delle fake news da parte dei lettori, dei giornalisti
liberi, dei siti di fact-checking, in collaborazione con Facebook, Google e
Twitter, scrive l'1 gennaio 2017 su Panorama Luigi Gavazzi. Il post-truth in
rete e i populisti che la usano, la democrazia minacciata, sono entrati
definitivamente nel dibattito politico quotidiano anche in Italia, dopo che
giovedì scorso il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, parlando con
il Financial Times, ha proposto una rete di agenzie pubbliche dei Paesi Ue
contro le notizie e le storie false diffuse online. Questa opera di
individuazione e smascheramento delle bufale, secondo Pitruzzella sarebbe più
efficace se venisse affidata direttamente a autorità pubbliche simili alle varie
antitrust nazionali, invece che essere semplicemente delegata alle grandi
aziende che dominano Internet - Facebook, Google o Twitter e alla loro volontà e
capacità di contrastare le informazioni false. Gli utenti, dice Pitruzzella,
continuerebbero "a usare un Internet libero", ma beneficerebbero di un'entità
"terza", indipendente dal governo, "pronta a intervenire rapidamente se
l'interesse pubblico viene minacciato". Contro Pitruzzella subito si è levato
l'anatema di Beppe Grillo, che ha urlato al complotto contro la libertà di
espressione, cui hanno fatto da eco immediatamente venerdì i social network, e
sabato anche qualche giornale, Il Fatto Quotidiano in testa. Reazione che
ovviamente allontana ogni possibilità di analisi e dibattito civile. Ma certo la
questione del rischio censura merita tutta l'attenzione. Il punto ovviamente non
è essere favorevole o meno alla censura. È invece necessario trovare modi e
strumenti, e regole, per garantire la libertà di espressione, ma anche per
evitare che essa diventi strumento di odio razziale e politico e, questo è il
caso in questione, di informazione ingannevole. E con il web e i social network
che amplificano a dismisura qualsiasi comunicazione, aumentandone il potenziale
di influenza e convincimento, questi strumenti e regole devono essere
probabilmente studiati specificamente. Intanto si tratta di vedere cosa intenda
concretamente Pitruzzella, e come verrà eventualmente definito il potere di
intervento delle agenzie che invoca. Lunedì 2 gennaio sul Corriere della Sera,
il presidente dell'Antitrust ha chiarito parzialmente il suo pensiero. In
sostanza quel che il presidente dell'Antitrust propone è l'introduzione di
"istituzioni specializzate, terze e indipendenti, che, sulla base di principi
predefiniti, intervengano successivamente, su richiesta di parte e in tempi
rapidi, per rimuovere dalla rete quei contenuti che sono palesemente falsi o
illegali o lesivi della dignità umana (non dimentichiamo il caso recente della
ragazza napoletana che si è uccisa dopo la diffusione virale sulla rete di un
suo video che doveva essere privato)". In linea generale è meglio evitare di
andare oltre il perimetro previsto dalle leggi attuali, con le norme sulla
diffamazione e la calunnia, e contro l'incitamento all'odio razziale. Ci sono
poi le regole deontologiche dei giornalisti che potrebbero ispirare anche alcune
regole generali di autoregolamentazione dei social network, relative ai limiti
che si possono imporre alla diffusione delle informazioni. Un'Autorità che
decida cosa è vero e cosa è falso può essere più pericolosa dei danni che vuole
evitare. Buona parte del lavoro di difesa della verità e del diritto a essere
informati correttamente, lo dovrebbero invece fare gli utenti della rete, i
giornalisti, e le aziende protagoniste della diffusione dell'informazione sul
web. Come ha scritto Nadia Urbinati su la Repubblica del 2 dicembre, è il caso
di fare appello alla "responsabilità da parte di coloro che esercitano la
politica e contribuiscono a creare l'opinione. La democrazia non sopporta né le
politiche dell'odio né quelle della verità, ma neppure le azioni repressive che
dovrebbero scongiurarle. Ha bisogno, in questi casi in modo particolare, di
cittadini, di politici e di giornalisti capaci di virtù pubblica, di far
affidamento al senso del limite e dell'autolimitazione. Non è stata ancora
escogitata una forma migliore per governare le emozioni senza pretendere di
estirparle, una medicina che ucciderebbe il malato nell'illusione di guarirlo".
E in successivo intervento a Radio 3, Urbinati ha invocato anche il concetto
di Sfera Pubblica nella definizione che ne ha data Jürgen Habermas. Timothy
Garton Ash che alla questione della libertà di espressione nell'era di Internet
sta dedicando parecchio lavoro - un sito per esempio, e un lungo ed elaborato
libro, Free Speech: Ten Principles for a Connected World - ricorda il contributo
importante che si apprestano a dare le grandi potenze del web, come Facebook,
per esempio, che riconosce l'enorme responsabilità del social network nel
"costruire uno spazio in cui le persone possano essere informate". Ma allo
stesso tempo Garton Ash riconosce come Facebook e gli altri big del web siano da
considerare più partner di altri attori, che essi stessi "arbitri della verità".
Gli attori protagonisti sono innanzitutto gli utenti, che devono sempre più
prestare attenzione, verificare le fonti cui attingono in rete, soprattutto sui
social; scavare nei report poco credibili. E soprattutto rendere pubblico il
proprio lavoro di verifica, mettendo a nudo le fonti di informazione bullshit, i
siti di propaganda. Gli utenti, tutti noi, dovranno anche diventare un po'
antipatici, almeno sui social. Quando un "amico" afferma o rilancia informazioni
evidentemente false, di propaganda, diffamatorie, dovrebbe dirlo apertamente e
esplicitamente. Sarà un lavoro duro e faticoso, ma se lo si fa in tanti, sarà
efficace. A volte le bufale e le interpretazioni "post-fattuali" nascono anche
da un collegamento inventato fra due fatti che non hanno relazioni alcuna di
causa ed effetto, ma come tali vengono presentati. E il collegamento, magari
solo suggerito, in rete rimbalza di account in account, e diventa certo,
creduto. Diventa un post-fatto. E su questo tipo di false informazione il lavoro
di decostruzione degli altri utenti è fondamentale, perché la loro credibilità
sembra incontestabile, sembra quasi probabile, la loro efficacia retorica è
subdola. I media con reputazione di credibilità e indipendenza che devono
dedicare più tempo e attenzione a smascherare i fornitori di informazioni
inventate, deformate e false. BuzzFeed che sta facendo un o sforzo notevole
contro i fake, ha pubblicato a fine anno una lista delle 50 peggiori notizie
false chehanno girato su Facebook nel 2016. Un'operazione che sicuramente aita a
fare chiarezza e a difendersi. Le varie iniziative di crowdfunding e non-profit
per il giornalismo investigativo e il fact-checking dovranno essere create,
sostenute, aiutate, anche con lavoro volontario. Infine, Facebook, Google,
Twitter. E le varie piattaforme di blogging. La tecnologia permette loro "di
individuare ed eliminare - spiega Garton Ash - le notizie diffuse in massa da
robot sotto la regia della Russia di Vladimir Putin o da siti di spamming (alias
"meme farms") il cui scopo è semplicemente arricchirsi con la pubblicità
online".
LE FAKE NEWS DEL
CONTRO-REGIME.
Fake news, il veleno che
piegò Mia Martini,
scrive Domenica 14 maggio 2017 Aldo Grasso su "Il Corriere della Sera". Ventidue
anni fa, di questi giorni, moriva la cantante Mia Martini. Una morte misteriosa,
al culmine di una vita privata e di un percorso artistico segnati dalla
maldicenza: dicevano portasse iella, non volevano mai pronunciare il suo nome.
Proviamo a leggere questa vergognosa storia con gli occhi di adesso. Mia Martini
è stata prima vittima di due fake news (dicevano portasse male per un tragico
incidente in cui persero la vita due musicisti della sua band e per il crollo di
un telone che copriva il palco su cui doveva esibirsi) e poi di bullismo. Un
bullismo feroce, consapevole e adulto: quello di certi suoi colleghi, di certi
impresari, di certi giornalisti. Mia è vissuta per anni nella post verità, nel
regno delle bufale e delle cattiverie. E non c’erano nemmeno gli algoritmi dei
social media a rilanciarle. Di fake news e bullismo si può morire, è bene
saperlo. Ieri come oggi. Sono veleni iniettati per privare la vittima di ogni
difesa. In ebraico c’è un’espressione forte per indicare la maldicenza, lashon
hara (malalingua). È considerata una colpa gravissima, che Dio non tollera: «Non
andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla morte
del tuo prossimo» (Levitico 19:16). Nelle nostre società laiche e illuminate, il
reato ha sostituito il peccato. Ma il rito tribale e persecutorio della
maldicenza è sempre lo stesso, amplificato oggi dal «popolo del web».
Fake news, bufale e
dintorni,
scrive Paolo Campanelli il 17 maggio 2017. Con la scusa dell’“informazione
libera e super partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in
internet, la bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando
propaganda, il metodo più diretto di attacco costituzionale. L’amore per le
bufale è un curioso concetto. Certo, c’è chi spaccia notizie con titoli dubbi o
incompleti per far andare persone sui propri siti e guadagnare soldi, c’è lo
Schierato Politico Estremo che s’inventa storielle inverosimili per favorire la
propria posizione, ma molte, troppe false notizie vengono semplicemente buttate
nella rete e lasciate a loro stesse. Prima di andare oltre, c’è da fare una
chiara differenza: la bufala è differente dal giornale di satira; dove la prima
è disinformazione, i secondi fanno ironia con situazioni chiaramente grottesche
e impossibili, il Vernacoliere è lo storico giornale cartaceo, mentre Lercio è
uno dei più famosi siti internet al riguardo. Il problema sorge quando le fonti
delle bufale si fingono giornali di satira. Ma una cosa è dire che il politico
“presunto corrotto” di turno ha un indice di gradimento del 215% nelle carceri,
cosa impossibile già matematicamente oltre che improbabile dal punto di vista
della necessità di fare rilevazioni, o prendere qualche istantanea da una
fiction o un cartone animato e aggiungerci sotto una didascalia che la faccia
sembrare presa da un momento critico nei libri di storia e aggiunto il colore,
un’altra è incolpare il gruppo di immigrati di turno di aver fatto danni ad un
palazzo storico aggiungendo la foto di qualche resto archeologico cittadino o
dei veri e propri ruderi tanto comuni nel territorio italiano. Quella delle
bufale recentemente soprannominate Fake News (seguendo la denominazione
americana diventata famosa per via del costante usa da parte del loro
Presidente, è una situazione che si autoalimenta, una persona che crede a varie
bufale diventa più suscettibile ad altre, creando un loop di cecità dalla quale
il credulone non si riesce a liberare, al grido di “metti tutto in discussione”.
Tralasciando però la seconda parte “e analizza i risultati metodicamente per non
farti ingannare nuovamente”. Il caso più eclatante degli ultimi tempi è stata
quello di “Luciana” Boldrini: sorella di Laura, presidente della Camera dei
Deputati, accusata di aver speso, solo nell’ultimo anno, ingenti somme pubbliche
nell’accoglienza di immigrati oltre a ciò già fatto dal governo. In realtà Lucia
Boldrini, pittrice, è morta da più di trent’anni. E il punto di origine della
bufala non lascia alcun dubbio, si trattava di un attacco a base di “fango
politico” in piena regola. Ricostruendo il percorso di alcune delle bufale dalla
diffusione più rapida infatti, si giunge ad una cerchia di persone che le creano
“professionalmente”, fin troppo spesso collegati con medie e piccole industrie e
con gruppi politici; dove l’obbiettivo dei secondi è chiaramente quello di
ottenere il voto di persone facilmente influenzabili anche al di fuori dei
sostenitori del proprio partito, per le aziende si tratta di manovre più
subdole: incrementare la vendita di prodotti “alternativi” mettendo in circolo
l’informazione di come i prodotti più diffusi creino problemi all’organismo o
all’ambiente, talvolta persino con informazioni parzialmente corrette. La storia
degli acidi a base di limone che circolava a inizio 2013 è emblematica, in
quanto prendeva in considerazione che il succo di limone è effettivamente una
sostanza acida utilizzata come sgrassatore e come anticoagulante in ambito
medico (acido citrico), ma nelle percentuali di purezza e quantità in cui si
trova negli alimenti è comunque inferiore all’acidità dei succhi gastrici. Gli
effetti più estremi di una bufala possono essere sottovalutati, vedendo come
molte possano essere risolte con una semplice e rapida ricerca su un qualsiasi
browser internet, ma tre sono i giganteschi esempi di una bufala fuori
controllo: l’omeopatia, i vaccini e l’olio di palma. Omeopatia e vaccini
richiedono conoscenze chimiche di un livello al di sopra di quello del cittadino
medio, e comunque prenderebbero troppo tempo, l’olio di palma, invece, pur se
segue gli stessi schemi, è un “concetto” estremamente più comprensibile. Fino a
un paio di anni fa, nessuno si interessava all’olio di palma, eccetto le
industrie alimentari; l’olio di frutti e semi di palma è sempre stato utilizzato
in Africa e medio oriente per una moltitudine di usi, fra cui la preparazione di
cibo, anche sostituendo oli e altri tipi di grassi, come ad esempio il burro,
sapone, ed infine, nel caso del Napalm e del biodiesel, come componente di armi
e di carburanti rispettivamente; una delle peculiarità dell’olio di palma è che
ha una grande percentuale di grassi saturi, e quindi può essere confezionato in
un panetto simile al burro a temperatura ambiente, che ne semplifica la
lavorazione quando si ha a che fare con gli enormi quantitativi industriali.
Tuttavia, con l’aumento della richiesta nel XX secolo, la coltivazione della
palma ha portato a un incremento delle colture a discapito di altre produzioni,
e di deforestazione. A questo si aggiunge che il consumo smodato di quest’olio
ha effetti deleteri sull’organismo, identici all’eccesso di burro e di grassi. A
partire dalla metà del 2014, però, cominciò a girare la notizia che “l’olio di
palma fa male”; In breve tempo, espandendosi a macchia…d’olio, la notizia lasciò
tutta l’Europa terrorizzata. I reparti di marketing delle grandi aziende, però,
presero la palla al balzo, e scrissero chiaramente sui loro prodotti che non
contenevano olio di palma, anche su quelli che non lo avevano mai utilizzato.
Eccetto la Ferrero, che forte della sua posizione, e della sua cremosità,
affermò fermamente che la Nutella, e tutti i suoi fratelli dolciari, avrebbero
continuato a usare l’olio di palma nelle loro ricette, poiché parte essenziale
nella creazione del gusto e non come araldo dei mali dovuti all’eccesivo consumo
di dolci (arrivando persino a fare test di laboratorio). Questo ha indubbiamente
posto il potenziale bersaglio della “bufala” di fronte ad un inatteso dilemma
tra l’ansia indotta dalla pressione mediatica ed il consolidato piacere della
adoratissima crema di nocciole. Con la scusa dell’“informazione libera e super
partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in internet, la
bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando propaganda, il metodo
più diretto di attacco costituzionale. La costituzione, infatti, delinea la
libertà di informazione, che è legata a doppio filo con la libertà di opinione
degli utenti, e con l’obbligo per chi fornisce le informazioni di,
attendibilità, cioè di dimostrare che si tratta di fatti avvenuti. Due concetti
che non possono e non devono sovrapporsi l’uno all’altro, ma che non hanno
alcuna limitazione se semplicemente messi in rete e spacciati per “Fatto”. Dei
passi contro la disinformazione e le bufale sono stati fatti sia dai governi di
vari paesi, fra cui dei timidi passi anche in Italia, che dai privati,
prevalentemente dai social network, ma a questo deve corrispondere un minimo di
attività da parte dell’utente, il cosiddetto “Fact Checking” (o in italiano,
controllo delle fonti), particolarmente da parte di chi si è “laureato
all’università della vita” e da chi si è ritirato dagli studi, conscio di una
minore abilità in ambito di studio e comprensione.
Rai, Alfano denuncia autori
e conduttori Gazebo: "Mi diffamano da tre anni".
Lo annuncia una nota di Alternativa Popolare: "Non si è trattato di un singolo
atto ma di una intera campagna durata anni a spese del contribuente", scrive il
20 maggio 2017 "La Repubblica". Angelino Alfano denuncia autori e conduttori del
programma Rai Gazebo (condotto da Diego 'Zoro' Bianchi su Rai3) per
diffamazione, in sede civile e penale: lo annuncia una nota di Alternativa
Popolare, il partito del ministro degli Esteri. "Ieri, con i soldi degli
italiani, due milioni e mezzo di euro per il 2017!!!, si è consumata la consueta
diffamazione. Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del
servizio pubblico". La nota spiega che: "Ieri, con i soldi degli italiani - due
milioni e mezzo di euro per il 2017 - si è consumata la consueta diffamazione.
Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del servizio
pubblico. Il presidente di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, annuncia,
dunque, di avere dato mandato ai propri legali per denunciare autori e
conduttori di Gazebo in sede civile e in sede penale". È quanto si legge in una
nota. "Alla denuncia, Alfano allegherà i riferimenti diffamatori a lui rivolti
durante gli ultimi tre anni di puntate televisive di Gazebo, per dimostrare ciò
che sarà facile dimostrare: non si è trattato di un singolo atto diffamatorio -
che sarebbe stato comunque grave - ma di una intera campagna diffamatoria durata
anni a spese del contribuente e con una pervicacia diffamatoria che rende
plateale il dolo, l’intenzionalità, la tenace volontà di creare un danno alla
persona e all’area politica che rappresenta. Il punto è reso ancor più grave
dall’enorme sproporzione che vi è, all’interno del servizio pubblico, tra lo
spazio dedicato alla diffamazione da questa trasmissione e lo spazio dedicato
alla informazione, in altre trasmissioni Rai, sulla medesima area politica e
sulla stessa persona che la rappresenta. Infine, è stata la stessa Rai 3, pochi
giorni fa, a sottolineare che tale trasmissione è un mix tra informazione e
satira, con questa frase contenuta nella nota che era stata diffusa e che
riportiamo qui fedelmente: ’... programma caratterizzato dal mix di satira e
informazione che ne definiscono l’identità...’. Quindi, se è già stato
ampiamente superato il confine della satira traducendosi in diffamazione, a
maggior ragione tutto ciò nulla ha avuto a che fare con l’informazione. Ultima
considerazione amara: questa diffamazione non può che essersi svolta con la
azione o la dolosa e persistente omissione di una intera catena di comando che,
dalla rete sino ai vertici massimi, ha consentito questi abusi. Anche costoro,
nei limiti del legalmente consentito, saranno, da Alfano, chiamati a rispondere
sia nel giudizio civile che nel giudizio penale. Alfano fa presente, infine, di
essere giunto a questa amara determinazione dopo tre anni di paziente
sopportazione di questo scempio che ha fatto il servizio pubblico, nella
speranza che vi fosse un operoso ravvedimento nella diffamazione". L'annuncio
della denuncia arriva a pochi giorni dall'ultima polemica: Alternativa Popolare
aveva negato l'accredito a Gazebo per partecipare alla conferenza stampa sulla
legge elettorale convocata nella sede del partito di Alfano.
“Casa Renzi”, la soap
opera infinita del Fatto Quotidiano,
scrive Lanfranco Caminiti il 17 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Consip e la
miseria del giornalismo: quando l’informazione diventa pettegolezzo e spettacolo
di bassa lega. Quel che conta è la cornice narrativa e non più i fatti.
‘Ofiglie: Tu ha da riciri ‘ a
verità, ggiura. Ggiura ca nun ricuordi.
‘ O pate: T’o ggiuro, nun
m’arricuord nniente.
‘ O figlie: Ggiurale ‘ ncoppa
a Maronna ‘ e Pumpei.
‘ O pate: ‘ O ggiuro, ncoppa a
Marunnina nuost’. Nun m’arricuordo nniente.
‘ O figlie: E nun mmiettiri ‘
a mmiezzu ‘ a mamma. ‘ Nce fa’ passa’ nu guaie.
‘ O pate: No, t’o ggiuro, ‘ a
mamma, no.
‘ O figlie: Statte bbuono. E
accuorto.
Non è un dialogo spoilerato
dell’ennesima puntata dell’ennesima stagione della saga dei Savastano, insomma
della fiction Gomorra. Piuttosto una verace traslazione, dal toscano del “giglio
magico” al napoletano più proprio della notitia criminis (tutto ruota intorno il
napoletano imprenditore Alfredo Romeo), dell’ennesima puntata dell’ennesima
stagione di intercettazioni intorno “casa Renzi” – secondo la sceneggiatura di
Marco Lillo, casa di produzione Il Fatto Quotidiano. La quale casa di produzione
pubblica (cioè spoilera, fregando il segreto delle procure) un fitto e
drammatico dialogo tra figlio e padre Renzi riguardo l’incontro con uno degli
imputati del caso Consip. Come se fosse, appunto, la conferma di quanto ha
sempre sostenuto – un appalto “mafiosizzato”, in cui imprenditori, facilitatori,
politici e commissari si tengono insieme da un patto scellerato di corruzione –
e non, piuttosto, quanto è lampante, evidente. Che cioè, l’allora presidente del
Consiglio e segretario del Partito democratico non ne sapesse proprio una
beneamata mazza, e che, pure, tutto quest’ambaradam è stato costruito “ad arte”
per colpirlo. Come è possibile questo, cioè che l’una cosa venga spacciata per
l’altra? È possibile per lo stesso meccanismo per il quale se un personaggio
muore in una stagione di una fiction può capitare che risorga due stagioni dopo:
quello che conta cioè è la “cornice narrativa”, per un verso, e la disponibilità
dello spettatore, per l’altro. E anche la cosa più inverosimile, cioè che un
morto resusciti, viene passata per buona. Vedete, è la stessa risposta di Marco
Travaglio quando gli si fa notare che tutto è un po’ illegittimo. E lui che
dice? Non è questo che conta, è la “sostanza” che conta. La “sostanza” è solo il
racconto. La tensione drammatica del dialogo tra figlio e padre Renzi c’è tutta.
Un figlio deve chiedere conto al padre di un certo comportamento. Di un
episodio, di una cosa. È un uomo fatto, ormai, e l’altro è sulla strada del
declino. È un destino, questo, che prima o poi tocca tutti. Ma non a tutti tocca
prendere di petto il proprio padre, incalzarlo di domande, metterlo all’angolo
perché sia limpido, almeno per una volta, per questa volta. Accenna a qualcosa
d’altro – e toccando proprio un tasto che sa l’altro ha proprio a cuore, la fede
– per fargli capire che non è proprio aria, che non sorvolerà come magari altre
volte è accaduto. Sa che il padre indulge alla bugia, magari piccola piccola, di
quelle che si dicono per il bene – è un insegnamento che i cattolici conoscono a
perfezione. O forse solo all’omissione. Lo ha fatto con lui, chissà quante volte
quand’era piccino, e adesso ancora, adesso che è l’uomo più potente d’Italia, lo
ha fatto con un suo braccio destro, Luca Lotti. «E non farmi dire altro», questo
dice Matteo Renzi a suo padre. L’altro sa di cosa stia parlando il figlio,
capisce, tace. Non farmi dire altro: è una frase forte, potente. Terribile.
Matteo Renzi è un maschio alfa, un capo branco. Ha fatto presto, forse anche
troppo presto, a misurare la sua forza, i suoi denti, la sua zampata con i
vecchi capi del suo branco – non erano di già sdentati. Li ha rottamati a
cornate, a unghiate, a morsi. Per quello che era la storia del suo partito era
poco più di un cucciolo – la gerontocrazia vigeva sovrana nei partiti comunisti
d’occidente. Eppure, quel cucciolo – all’inizio guardato con sufficienza nella
sicurezza di domarlo al primo impatto – ha mostrato che era impastato di
smisurata ambizione e forza. S’era addestrato in casa, prima. Forse presto,
troppo presto, aveva già preso a cornate il proprio padre. Il primo,
probabilmente, a essere rottamato. Vedete, in letteratura, c’è il complesso di
Edipo, l’amore del figlio verso la madre e l’ostilità verso il padre, e il
complesso di Elettra, per spiegarlo dalla parte delle bambine, e il complesso di
Giocasta, l’amore morboso di una madre per il figlio. Ma non c’è letteratura, e
nominazione, per un complesso del padre verso il figlio. Quell’uomo è tornato
adesso come un incubo. E anche gli altri – quelli che ha rottamato politicamente
– sono tornati come un incubo. Tutto troppo presto: nei racconti tutto questo
accade quando il personaggio è ormai in agonia, negli ultimi giorni di vita, in
cui rivede a ritroso la propria storia e tutti quelli che ha “fatto fuori” per
il potere, quel dannato potere, tornano come fantasmi malmostosi. Chi sta
accelerando il corso degli eventi narrativi? Qual è la manina che scrive? Che di
soap opera si tratti è ormai evidente. Gli ingredienti ci sono tutti. Il
malloppo, anzitutto, ovvero: l’avidità. E poi, il militare infedele, le carte
false, il giudice che non decide su fatti e reati ma se gli atteggiamenti di
uomini e donne siano o meno integerrimi, le gazzette ciarliere, gli
azzeccagarbugli, la famiglia, quella naturale e quella allargata della
Massoneria, e soprattutto: isso, issa e ‘ o malamente. Dove isso e issa è
abbastanza facile identificarli, in Renzi e in Maria Teresa Boschi. Non c’è
niente che unisca il caso Consip e il caso Banca Etruria, certo, a parte
l’appartenere entrambi i personaggi principali, le dramatis personae, allo
stesso “pacchetto di mischia”. Non c’è niente che unisca il caso Consip e il
caso Banca Etruria, tranne il fatto che siano due giornalisti – de Bortoli e
Lillo – le “gole profonde”. Scrivono e trascrivono, orecchiano e intercettano,
alludono e illudono. A un certo punto, combaciano pure. Nella tempistica,
intendo. Escono allo scoperto.
Sono loro, i due scrivani, ‘ o
malamente? Due persone, in carne, ossa e testata, per un solo personaggio?
Qualcosa si va sfaldando nella storia. Il militare infedele – che avrebbe dovuto
“sacrificarsi” – va in giro a raccontare come sono andate davvero le cose. A chi
rispondeva. Gli era stato ordinato di fare così, non è farina del suo sacco.
Quasi, dice, ho solo obbedito agli ordini. E addita il responsabile. È stato il
magistrato che indagava a voler lasciare intendere che i servizi segreti si
stessero interessando della cosa – non c’è proprio traccia di questa storia, ma
un faldone che racconta di come probabilmente i servizi segreti si sarebbero
potuti interessare di questa storia. E le trascrizioni un po’ abborracciate, in
cui l’uno veniva scambiato con l’altro, e quello che aveva detto l’uno veniva
messo in bocca all’altro, beh, sì, quelle forse sono state un mio errore – dice
l’infedele – però, dovete capirmi, ero sotto stress, quello – il giudice –
voleva dei risultati e io non avevo in mano niente. Lo chiamava di notte, mentre
compulsava ancora le sudate carte, il giudice Woodcock al capitano Scarfato per
chiedergli conto di cosa fosse riuscito a concludere quel giorno? O lo chiamava
all’alba, mentre iniziava a compulsare le sudate carte, per incitarlo a
concludere finalmente qualcosa quel giorno? Che qua, di risultati, se ne
vedevano pochini. Ah, che stress per il povero capitano. A un certo punto deve
aver capito che sarà solo lui a pagare, a finire a dirigere il traffico a
Forlimpopoli, e non ci sta. Tutto l’impianto narrativo rischia di impazzire come
la maionese. E qua ‘ o malamente iesce ‘ a fora.
Banca Etruria, Renzi contro
De Bortoli: "È ossessionato da me".
Renzi in campo per blindare la Boschi: "Che Unicredit studiasse il dossier
Etruria è il segreto di Pulcinella". E attacca De Bortoli: "Ha un'ossessione per
me", scrive Sergio Rame, Sabato 13/05/2017, su "Il Giornale". "Ferruccio de
Bortoli ha fatto il direttore dei principali quotidiani italiani per quasi
vent'anni e ora spiega che i poteri forti in Italia risiedono a Laterina? Chi ci
crede è bravo". In una intervista a tutto campo al Foglio, Matteo Renzi va
all'attacco dopo le indiscrezioni sul salvataggio di Banca Etruria pubblicate
dall'ex direttore del Corriere della Sera sul nuovo libro Poteri forti (o
quasi). "De Bortoli ha una ossessione personale per me che stupisce anche i suoi
amici". "Quando vado a Milano, mi chiedono: ma che gli hai fatto a Ferruccio?
Boh. Non lo so". Nell'intervista al Foglio l'ex premier non fa sconti a De
Bortoli: "Forse perché non mi conosce. Forse perché dà a me la colpa perché non
ha avuto i voti per entrare nel Cda della Rai e lo capisco: essere bocciato da
una commissione parlamentare non è piacevole. Ma può succedere, non mi pare la
fine del mondo". Per Renzi "che Unicredit studiasse il dossier Etruria è il
segreto di Pulcinella". "Praticamente tutte le banche d'Italia hanno visto il
dossier Etruria in quella fase. Come pure il dossier Ferrara, il dossier Chieti,
il dossier Banca Marche. Lo hanno visto tutti e nessuno ha fatto niente",
continua Renzi. Che, poi, aggiunge: "Ferruccio de Bortoli ha detto falsità su
Marco Carrai. Ha detto falsità sulla vicenda dell'albergo in cui ero con la mia
famiglia. Ha detto falsità sui miei rapporti con la massoneria. Non so chi sia
la sua fonte e non mi interessa. So che è ossessionato da me. Ma io non lo sono
da lui. È stato un giornalista di lungo corso, gli faccio i miei auguri per il
futuro e spero che il suo libro venda tanto". Renzi è convinto che, quanto
prima, "si chiariranno le responsabilità a vari livelli". "E - avverte - se c'è
un motivo per cui sono contento che la legislatura vada avanti fino ad aprile
2018 è che avremo molto tempo per studiare i comportamenti di tutte le
istituzioni competenti. Cioè, competenti per modo di dire. Non vedo l'ora che la
commissione d'Inchiesta inizi a lavorare. Come spiega sempre il professor
Fortis, vostro collaboratore, Banca Etruria rappresenta meno del 2 per cento
delle perdite delle banche nel periodo 2011-2016. Boschi senior è stato
vicepresidente non esecutivo per otto mesi e poi noi lo abbiamo commissariato:
mi pare che non sia stato neanche rinviato a giudizio. Se vogliamo parlare delle
banche, parliamone. Ma sul serio".
Sulla propria pagina Facebook,
De Bortoli replica ricordando all'ex premier che "avendo detto due volte no alla
proposta di fare il presidente, non era tra le mie ambizioni essere eletto nel
cda della Rai". E incalza: "Visto quello che sta accadendo, ringrazio di cuore
per non avermi votato. Non avrei potuto comunque accettare avendo firmato un
patto di non concorrenza". Poi continua: "Io non ho mai scritto che è un
massone, mi sono solo limitato a porre l'interrogativo sul ruolo della
massoneria in alcune vicende politiche e bancarie. Ruolo emerso, per esempio,
nel caso di Banca Etruria. Ho commesso degli errori, certo". Nel libro ne
ammette diversi in oltre quarant'anni. Come quello, in un articolo pubblicato
sul Corriere della Sera sul caso JpMorgan-Mps, della data di un sms solidale
inviato da Marco Carrai a Fabrizio Viola, "licenziato" poi dal governo. "Non so
quali falsità siano state scritte sul soggiorno a Forte dei Marmi nell'estate
del 2014 - continua - mi aspetterei invece da Renzi che chieda scusa al collega
del Corriere che, in quella occasione, stava facendo il suo lavoro e alloggiava
nell'hotel. L'inviato venne minacciato dalla scorta che gli intimò di andarsene.
E gli faccio i miei migliori auguri per il suo libro che uscirà a breve".
Giornalismo del
controregime,
scrive Piero Sansonetti il 13 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Le fake news sono
diffuse dai social network o comunque dalla rete? No. Le fake news sono diffuse
principalmente dai giornali e dalle televisioni. I social vengono a rimorchio,
le rilanciano. Ma non sono loro a costruirle. Almeno, non sono loro a costruire
le fake importanti. La responsabilità della creazione delle bugie e del loro uso
come arma politica e di disinformazione ricade soprattutto sui grandi quotidiani
e sui grandi giornalisti. Giornalismo di contro- regime Cioè, giornalismo di
regime. Proviamo un inventario di avvenimenti recenti. Caso Guidi, con annesse
dimissioni della ministra. Caso Consip, con annessa richiesta di dimissioni del
ministro Luca Lotti. Caso Ong, con annessa richiesta di limitazione dell’azione
dei soccorsi ai migranti sul Mediterraneo. Caso De Bortoli, con annessa – ed
ennesima – richiesta di dimissioni della ministra Maria Elena Boschi. Su questi
quattro casi i giornali italiani e i principali talk show televisivi hanno
vissuto per mesi e mesi. Con titoli grandi in prima pagina e – alcuni – con vere
e proprie campagne di stampa, molto moraleggianti e molto benpensanti. Certo,
soprattutto del “Fatto Quotidiano” – che quando offre ai suoi lettori una
notizia vera succede come successe a Nils Liedholm quando per la prima volta in
vita sua sbagliò un passaggio: lo Stadio di San Siro lo salutò con una ovazione…
– ma anche di parecchi altri giornali che godono di alta fama. Ora vediamo un
po’ come sono finiti questi quattro casi.
Guidi: mai incriminata.
L’inchiesta giudiziaria che la sfiorò, Tempa Rossa, conclusa con il
proscioglimento di tutti. Era una Fake. Federica Guidi è scomparsa dai radar
della politica.
Consip, l’inchiesta è stata
trasferita a Roma, le accuse al padre di Renzi erano fondate su una
intercettazione manipolata da un carabiniere, anche le notizie sull’ingerenza
dei servizi segreti (evidentemente mandati da Renzi per ostacolare le indagini)
erano inventate da un carabiniere e l’informativa al Pm che riguardava queste
ingerenze era stata scritta su suggerimento dello stesso Pm che avrebbe dovuto
esserne informato. Fake e doppia fake.
Ong, l’ipotesi del Procuratore
di Catania che fossero finanziate dagli scafisti è stata esclusa dalla Procura
di Trapani da quella di Palermo e da svariati altri magistrati. Fake. Intanto
l’azione di soccorso ha rallentato.
De Bortoli. Sono passati ormai
quattro giorni da quando, per lanciare il suo libro sui poteri forti, l’ex
direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore ha diffuso la notizia della
richiesta di Maria Elena Boschi all’amministratore delegato di Unicredit di
comprare la banca nella quale lavorava il padre. Boschi ha smentito nettamente.
Anche la banca ha dichiarato che non risulta niente. De Bortoli ha fatto mezza
marcia indietro, poi ha accusato Boschi e Renzi, o almeno i loro ambienti, di
essere massoni, ed è andato in Tv, senza portare neppure uno straccio di prova
delle sue accuse ed evitando il confronto diretto con gli avvocati della Boschi.
Tranne improvvisi colpi di scena, appare evidente un po’ a tutti che l’accusa di
De Bortoli è infondata, altrimenti, ormai, avrebbe fornito degli elementi a
sostegno della sua tesi. Anche qui possiamo dire: fake.
La questione invece del
complotto massonico a favore di Renzi, denunciato da de Bortoli, non è
definibile esattamente una fake, è solo qualcosa di già visto tante volte nella
politica italiana. In frangenti non bellissimi. Il più famoso complotto
massonico – per la precisione giudaico-massonico, anzi:
demo-pluto-giudaicomassonico – fu denunciato da Mussolini, nel 1935, per
favorire la persecuzione dei massoni e poi lo sterminio degli ebrei. Non ci fa
una gran figura De Bortoli a tornare sul quel concetto, peraltro senza avere
proprio nessun indizio sulla appartenenza di Boschi o di Renzi alla massoneria.
E in ogni caso andrà segnalato il fatto che la massoneria non è una associazione
a delinquere. Furono massoni, in passato, un gran numero di Presidenti
americani, tra i quali Washington e Lincoln, furono massoni poeti come Quasimodo
e Carducci, furono massoni Cesare Beccaria, Mozart, Brahms, e svariate altre
centinaia di geni, tra i quali moltissimi giornalisti di alto livello, parecchi
dei quali del Corriere della Serra. Possibile che un giornalista colto e
autorevole come De Bortoli scambi la massoneria per Avanguardia Nazionale?
Eppure De Bortoli ha trovato grande sostegno nella stampa italiana. In diversi
giornali e in diverse trasmissioni Tv la sua “ipotesi di accusa” alla Boschi è
stata ed ancora in queste ore è presentata come dato di fatto: «Lei che ha
svelato la richiesta della ministra…». Una volta esisteva la stampa di regime.
Ossequiosa verso i politici, soprattutto, e in genere verso l’autorità
costituita. Ora esiste la stampa di anti- regime. O di contro- regime, che però
funziona esattamente come la stampa di regime. Anche perché ha dietro di se
poteri molto forti. Non solo un pezzo importante di magistratura ma uno
schieramento vasto di editori, cioè di imprenditoria, diciamo pure un pezzo
robustissimo della borghesia italiana. De Bortoli oggi è sostenuto da quasi
tutti i mezzi di informazione, e si può pensare tutto il bene possibile di lui,
tranne una cosa: che sia un nemico dei poteri forti. De Bortoli, per
definizione, è i poteri forti. Lo è sempre stato, non lo ha mai negato, nessuno
mai ne ha dubitato.
La stampa di contro-regime
funziona esattamente così. Non è una stampa di denuncia ma una stampa che
costruisce notizie e le difende contro ogni evidenza e logica anche queste
crollano. Nei regimi totalitari questa si chiamava “disinformazia” ed aveva un
compito decisivo nel mantenimento al potere delle classi dirigenti. Ora si
chiama fake press e ha un ruolo decisivo nella lotta senza quartiere che è
aperta nell’establishment italiano per la conquista del potere, di fronte alla
possibilità di un rovesciamento dei rapporti di forza nel ceto politico.
L’avanzata dei 5 Stelle ha provocato un terremoto. Pezzi molto grandi,
autorevoli e potenti proprio dei poteri forti si predispongono a dialogare coi 5
Stelle, prevedendone, o temendone, l’ascesa al governo. Questo movimento
tellurico squassa la democrazia e devasta i meccanismi dell’informazione.
Esistono le possibilità di resistere, di fermare il terremoto, di reintrodurre
il principio di realtà – se non addirittura di verità – nella macchina dei mass
media che lo ha perso? Non è una impresa facile. Molto dipende dai giornalisti.
Che però, nella loro grande maggioranza, oggi come oggi non sembrano dei cuor di
leone…
Ferruccio, per favore, se
hai le prove mostrale,
scrive Piero Sansonetti il 12 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Boschi-Banca
Etruria si sta sgonfiando. Finirà nel dimenticatoio come il caso-Guidi, il
caso-Lupi, il caso Madia? Il caso-Boschi si ridimensiona. Molti giornali di
destra hanno mollato la presa dopo la parziale marcia indietro di Ferruccio De
Bortoli, che ha spiegato di non aver mai sostenuto che la Boschi fece pressioni
indebite su Unicredit per salvare Banca Etruria. Eppure nel suo libro c’è
scritto che «Boschi chiese a Ghizzoni (amministratore delegato di Unicredit) di
valutare l’acquisto di Banca Etruria». Resta in campo, al momento, solo Il Fatto
Quotidiano che ieri si è lanciato in soccorso di De Bortoli sostenendo di avere
le prove della colpevolezza della Boschi. Lo ha scritto enorme, in prima pagina,
con l’inchiostro rosso: «Boschi mente: ecco le prove». E ha pubblicato un
servizio d Giorgio Meletti nel quale si parla di una riunione a casa del papà
della Boschi, dirigente di Banca Etruria, con gli amministratori della stessa
Banca Etruria e di alcune banche del Nord. A questa riunione – dice Meletti –
che si tenne nel marzo del 2014, partecipò anche la Boschi. Il servizio di
Meletti è fatto molto bene e sembra assai informato, anche se naturalmente
occorreranno dei riscontri. E tuttavia resta una domanda: ma Meletti non accenna
nemmeno all’ipotesi che a questa riunione, o ad altre riunioni, partecipò
Ghizzoni. E allora perché mai questo fatto dovrebbe provare che De Bortoli ha
ragione? Ieri de Bortoli ha partecipato alla trasmissione televisiva “Otto e
Mezzo” di Lilli Gruber. Ha detto che la vicenda di Banca Etruria è tutta una
vicenda di massoneria. Un paio d’anni fa aveva detto la stessa cosa del governo
Renzi. Né allora né adesso, però, ha citato elementi di prova, o almeno di
indizio. Più che altro è sembrata una sua sensazione. Se anche le accuse alla
Boschi di aver tentato di spingere Ghizzoni a comprare la Banca dove lavorava il
papà dovessero basarsi solo su una sua impressione, non sarebbe una buona cosa.
Questa vicenda può concludersi in tre modi. O De Bortoli si decide a portare le
prove della sua affermazione, e allora il governo Gentiloni va a gambe all’aria.
O De Bortoli queste prove non le ha, e davvero ha scritto il libro solo
basandosi su voci raccolte in ambienti vicini a Unicredit, e allora ci
troveremmo di fronte a un capitolo nerissimo per il giornalismo italiano. Oppure
può succedere che i due contendenti capiscono che è meglio non esagerare nel
duello, anche perché l’uno e l’altra hanno dietro le spalle forze abbastanza
potenti e capaci di far male, e in questo caso anche “Il Fatto” abbasserà i toni
e tutta la storia passerà in cavalleria. Come è successo col caso-Guidi, col
caso-Lupi, col caso Madia. E’ sicuramente la terza l’ipotesi più probabile. E
non è una bella cosa, né per il giornalismo né per la politica.
Quelle cene con Ligresti
per tornare in via Solferino.
La vacanza dell'ex direttore nel resort in Sardegna, scrive Domenica 14/05/2017,
"Il Giornale". Le cronache raccontano di aragoste a quintali per gli ospiti
illustri di Salvatore Ligresti al Tanka Village di Villasimius, in Sardegna.
Vecchie storie, un'altra epoca, uno splendore e una leggerezza che ormai non ci
sono più. Alla corte dell'ingegnere, quando i tempi del crack Fonsai erano
ancora molto lontani, accorrevano in tanti, per lo più personalità del mondo
politico e istituzionale, ministri, generali, prefetti, sottosegretari,
direttori. Andare al Tanka era un po' lavorare, perché lì si tessevano le
relazioni pubbliche che contavano e che portavano spesso alle poltrone
importanti. Relazioni rigorosamente trasversali, bipartisan si direbbe oggi. Il
Tanka, insomma, veniva considerato un po' una prosecuzione dell'ufficio. Anche
se molti scroccavano pure la vacanza, visto che pochi alla fine pagavano il
conto. Qualcuno, quando poi se n'è parlato sui giornali, ha persino negato di
esserci stato. Non si sa mai. Tra i tanti che negli anni sono passati per il
bellissimo villaggio sardo un tempo regno della famiglia Ligresti c'era anche
l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli. Correva l'estate
del 2008. All'epoca non guidava più il quotidiano di via Solferino, che aveva
già diretto per sei anni, dal 1997 al 2003, ma era già in trattativa per
tornarci e si muoveva in quella direzione. C'è chi lo ricorda, infatti, ospite
di Ligresti, proprio lì, nel resort di Villasimius, dove l'ingegnere amava
organizzare cene speciali per i suoi ospiti di riguardo. Quell'estate il
giornalista trascorse qualche giorno al Tanka e tutte le sere sedeva al tavolo
di Ligresti, in quel periodo ancora saldamente al vertice di Fonsai, azionista
di peso del patto di sindacato dell'editore del Corriere della Sera. Per poter
tornare al timone di via Solferino, insomma, era quello il posto giusto dove
mangiare aragoste in compagnia e dove valeva la pena trascorrere qualche giorno
di vacanza. Di lì a qualche mese, infatti, de Bortoli tornò al comando del
giornale milanese, dove è poi rimasto fino al 2015. E pensare che in quei giorni
d'estate furono in molti a stupirsi di vederlo al Tanka, tra i clientes di
Ligresti. C'è anche chi lo ricorda bersaglio di amichevoli sfottò sull'argomento
da parte di chi sedeva con lui al tavolo dell'ingegnere e che sapeva bene perché
fosse lì. Pare che lui non gradisse le prese in giro sull'evidente motivo della
sua presenza in quel luogo. Era tanti anni fa. Un'altra epoca, appunto.
Il libro di de Bortoli e la
memoria corta sul "Corriere" indipendente,
scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 12/05/2017, su "Il Giornale". Ho letto
Poteri forti (o quasi), il libro di Ferruccio de Bortoli già direttore del
Corriere della Sera e del Sole24Ore - edito da «La nave di Teseo», di cui si
parla in questi giorni per il clamore suscitato dal capitolo che svela
l'interessamento della ministra Boschi presso Unicredit per agevolare il
salvataggio della banca di papà, la Etruria. «Memorie di oltre quarant'anni di
giornalismo», recita il sottotitolo di copertina. E questo basta per mettere
l'autore al riparo da critiche su eventuali errori ed omissioni nel racconto che
corre fluido come si addice alla penna di un grande giornalista e direttore.
Perché di «memoria» ognuno ha la sua e ha il diritto di centellinarla a suo
piacimento, che sia per amnesia o per calcolo. Non so perché Ferruccio de
Bortoli abbia deciso di raccontarsi a soli 64 anni. Di solito l'autobiografia
salvo casi di conclamato narcisismo o ragioni economiche arriva a chiudere una
carriera, non a rilanciarla. Svelare retroscena, dare giudizi su uomini viventi
e potenti si presta a ritorsioni pericolose. Conoscendo la cautela dell'uomo,
grande e cauto navigatore, mi vien quindi da pensare che de Bortoli consideri
conclusa la sua brillante carriera, almeno nel giornalismo attivo e di vertice.
Fatti suoi, ovviamente. Ma torniamo al libro. De Bortoli vuole farci credere di
essere stato per dodici anni (in due tranche, 1997-2003, 2009-2015) a capo di un
giornale tempio della libertà e sentinella di democrazia, arbitro imparziale
delle partite alcune violente e drammatiche - che si giocavano nel Paese. È la
vecchia tesi, retorica e falsa, della sacralità del Corriere della Sera,
giornale in cui ho lavorato per diversi anni e che quindi ho ben conosciuto
dall'interno. Il Corriere è stato il primo, e per lungo tempo unico, grande e
ricco giornale nazionale e per questo ha allevato e ospitato le migliori firme
del giornalismo e della cultura per oltre un secolo. Fin dalla nascita, il
vestito è stato a libera scelta da qui la sua apparente indipendenza - del
direttore e dei giornalisti, ma il cappello è sempre stato attaccato dove
padrone voleva: monarchico durante la monarchia, fascista sotto il fascismo,
antifascista alla caduta del regime, piduista all'epoca della P2, filo-Fiat
sotto il regime di Agnelli, benevolo, negli anni più recenti governati da
Bazoli, con il sistema finanziario e bancario vincente. Quest'ultimo è un club
di miliardari i cui membri, come tutti i padroni, sono conservatori, ma hanno la
necessità di apparire progressisti per non avere rogne nel loro espandersi
nell'ombra (in Francia la chiamano «sinistra al caviale»). Tutto ciò non
significa che de Bortoli non sia stato un direttore libero. Lui, nato in altro
mondo (la sua era una solida e umile famiglia), sognava e studiava fin da
giovane racconta chi l'ha frequentato in quegli anni di entrare in
quell'ambiente dorato ed esclusivo. Sulla plancia del giornale degli Agnelli
prima e dei banchieri poi è stato quindi perfettamente a suo agio. Più che di
indipendenza parlerei quindi di coerenza.
Non è poca cosa, la coerenza,
cioè la fedeltà alle proprie idee. Ma perché non dirlo? Perché evitare, in una
biografia di oltre duecento pagine, di scrivere due righe sul suo essere stato
un giovane e convinto comunista, sia pur di quelli che, essendo intelligenti,
avevano capito che più che le piazze era meglio frequentare i salotti, che le
parole potevano essere più utili e potenti delle spranghe alle quali, infatti,
l'uomo, a differenza di tanti compagni, non si è mai neppure avvicinato. Nel
libro la fede politica di de Bortoli la si deduce solo dal fatto che le offerte
di lavoro che narra di aver ricevuto (presidente Rai, sindaco di Milano,
direttore del Corriere) gli arrivavano sempre da politici o banchieri di
sinistra (una, in verità, da Letizia Moratti, ma era appunto per dirigere il
Tg3). Essere di sinistra è infatti la non misteriosa precondizione per dirigere
il Corriere della Sera, altrimenti non si spiega come a giornalisti altrettanto
bravi (penso a Montanelli prima di lui e a Vittorio Feltri suo quasi coetaneo)
sia stata negata tale possibilità. Anche l'attuale direttore, Luciano Fontana,
non a caso professionalmente e culturalmente nasce e cresce all'Unità. De
Bortoli (con Paolo Mieli, con il quale si è avvicendato più volte al comando) è
stato la faccia presentabile dell'antiberlusconismo militante, la lunga mano
della sinistra politica e affaristica (che nel libro, giustamente, si vanta di
aver frequentato con reciproca stima e soddisfazione) per manipolare l'opinione
pubblica in punta di regole («la notizia è notizia», ama ripetere il direttore,
quasi a scusarsi). Noi tutti sappiamo che cosa de Bortoli che oggi ci rinfresca
la memoria anche con aneddoti curiosi - è stato libero di scrivere e far
scrivere, non cosa non ha pubblicato (potere questo più importante del primo).
E, forse, non lo sa neppure lui, perché in un giornale l'acqua inevitabilmente
scorre dove il direttore (e il padrone) traccia il solco. Escludo in modo
categorico che de Bortoli sia mai stato servo di qualcuno, ma socio ho il
sospetto di sì. Forse pure dei magistrati che davano la caccia a Silvio
Berlusconi. Nel libro c'è un lungo paragrafo di elogi a Ilda Boccassini («ne
ammiro il coraggio, per fortuna il Paese ha toghe come lei, coraggiosa e
preparata»). Dice di averla incontrata tante volte, la chiama per nome, «Ilda»,
incurante di poter così suscitare anche solo un sospetto sull'origine di tanta
abbondanza di informazione che il Corriere ha sfornato durante il caso Ruby
(«una inchiesta per la quale è stata ingiustamente attaccata», scrive senza
aggiungere che l'imputato, Berlusconi, è stato assolto per non aver commesso il
fatto e che, quindi, non fu una grande inchiesta). Di Berlusconi scrive con
distacco: «Il Cavaliere non si arrese mai all'idea che un giornale liberale non
stesse per definizione dalla sua parte». Per la verità il Corriere della Sera è
stato «per definizione» contro Berlusconi, il cui dubbio è lo stesso che negli
ultimi cinquant'anni hanno avuto in tanti: come ha fatto un giornale che si dice
liberale a farsi soggiogare dal Pci, dal sindacato interno (un vero Soviet con
diritto di censura), fino a strizzare l'occhio alla non pacifica rivoluzione
sessantottina? Cosa c'era, nel 1994, di liberale nello sperare che Occhetto
prendesse il potere a scapito di un partito davvero liberale come Forza Italia
(io c'ero, dietro le quinte, e l'apparente equidistanza era tifo vero)? Cosa c'è
stato di liberale nel fare un endorsement, alla vigilia del voto del 2006, a
firma del direttore (Paolo Mieli, prima volta nella storia di quel giornale) a
favore di un governo Prodi-Bertinotti? Cosa c'è stato di liberale nell'avere un
pregiudizio profondo nei confronti non solo di un liberale come Silvio
Berlusconi, ma di chiunque emergesse in qualsiasi campo (arte, letteratura,
musica, perfino lo sport) e non fosse dichiaratamente di sinistra? La risposta è
semplice: Il Corriere, da un secolo a questa parte, non è un foglio liberale. È
un camaleonte che ha ingannato, e inganna tuttora, i suoi non pochi lettori
liberali (e tutti i politici liberali che bramano di apparire sulle sue
colonne). Il Corriere di de Bortoli è stato, lo ripeto, «per definizione» e con
un abile gioco di doppi pesi e doppie misure, contro tutto ciò che non era
omologato al clan. Tra i suoi editori nel consiglio di amministrazione Rcs - De
Bortoli ne ha avuto uno mal visto dai salotti della sinistra e simpatico alla
destra: Salvatore Ligresti. E, guarda caso, è l'unico che nelle sue memorie
stronca anche con un certo cattivo gusto: «Mi sono trovato a disagio a sedermi a
tavola con la sua famiglia». Ora, è vero che Ligresti era un personaggio
atipico, che è fallito malamente. Ma sono certo che la sua coscienza non è meno
linda di quella di diversi suoi soci apparentemente «per bene» tanto cari al
direttore. Certo, è facile vantarsi, con un eccesso di civetteria, dell'amicizia
di Mario Draghi: «Una sera camminavo per Parigi, mi suona il telefonino: ciao
Ferruccio, sono Mario...». Facile liquidare l'appoggio entusiasta dato dal
Corriere al disastroso governo Monti dando un paio di buffetti al Professore
oggi in disuso. Facile svelare solo oggi l'aggressione subita da un cronista del
Corriere da parte di Matteo Renzi, taciuta quando l'aggressore era potente primo
ministro. Insomma, è facile continuare la narrazione della favola di un Corriere
della Sera vergine e nelle mani di coraggiosi paladini senza macchia con fonti
disinteressate. Facile e pure legittimo. Ma, almeno io, non ci casco.
LE SOLITE FAKE NEWS DEI
MEDIA DI REGIME.
«Ha vinto il M5S, dateci il
reddito di cittadinanza».
L'assalto ai Caf del barese. Succede nel piccolo comune di Giovinazzo. Cittadini
in fila per ottenere i moduli, centralini tempestati dalle telefonate al
servizio di Comune e Regione, scrive l'8 marzo 2018 “L’Espresso. "Ha vinto il
M5S, ora dateci i moduli per Reddito di Cittadinanza": accade in alcuni Comuni
della Puglia, anche a Bari, dove numerose persone fra ieri e oggi si sono
presentate ai Caf locali e, nel capoluogo, anche a Porta Futuro, il centro
servizi per l'occupazione. Gli episodi, già resi noti dal sindaco di Giovinazzo
(Bari), Tommaso Depalma, che ha parlato di file davanti ai Caf della città, si
stanno verificando anche in queste ore. A Porta futuro a Bari, racconta il
responsabile, Franco Lacarra, "sono una cinquantina le persone che tra ieri e
oggi hanno chiesto i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, si tratta
soprattutto di giovani". "A noi sindaci - afferma Depalma - piacerebbe poter
comunicare ai cittadini che il problema della disoccupazione è risolto e che per
tutti quelli che non hanno lavoro c'è un Reddito di Cittadinanza, ma credo che i
cittadini siano stati ammaliati da spot elettorali". «Ovviamente - aggiunge
Franco Lacarra - non si tratta di folle oceaniche, ma comunque è certo che
molta gente è alla ricerca dei moduli per ottenere il reddito di cittadinanza e
ci chiede informazioni». «Sono soprattutto i giovani - aggiunge - che ci
chiedono informazioni, naturalmente anche i Caf potranno dare una descrizione su
quello che sta accadendo».
"Ha vinto M5S, dateci i
moduli per il reddito di cittadinanza". Numerose richieste ai Caf da Bari e
Palermo. A
Giovinazzo e nel capoluogo pugliese decine di richieste. A Palermo un Caf
costretto a mettere un avviso all'esterno. Ma i Cinque Stelle della Puglia
attaccano: "Una mistificazione", scrive l'8 marzo 2018 "La Repubblica". "Ha
vinto il M5S, ora dateci i moduli per il reddito di cittadinanza": accade in
alcuni Comuni della Puglia, anche a Bari, dove numerose persone dopo l'esito del
voto si sono presentate ai Caf locali. A Bari e a Giovinazzo - ma anche a
Palermo dove gira anche un falso formulario - decine di cittadini hanno chiesto
informazioni sulla modulistica per accedere al reddito di cittadinanza promesso
in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Nel job center di Porta Futuro a
Bari, per esempio, in tre giorni sono pervenute da persone di età compresa tra i
30 e i 45 anni una cinquantina di richieste di accesso alla modulistica. "A chi
si è affacciato chiedendo se fossero già disponibili i moduli per richiedere il
reddito di cittadinanza, abbiamo dato una risposta tecnica, dicendo che non c'è
al momento nessun provvedimento che codifica questo strumento", ha
chiarito Giovanni Mezzina, responsabile dei servizi di orientamento di Porta
Futuro Bari. Anche a Palermo le richieste iniziano ad arrivare. Una decina di
persone si sono presentate al Caf Asia di Piazza Marina. E al patronato
dell'Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini (Enasc), per frenare il
via vai di chi chiedeva informazione hanno affisso un foglio con la scritta in
italiano e in arabo: "In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di
cittadinanza". In Puglia, dal Comune di Giovinazzo, l'assessore alle Politiche
Sociali, Michele Sollecito, racconta che le domande su questo specifico
provvedimento si aggiungono, ma in termini di curiosità, a quelle che da tempo i
cittadini pongono per accedere al Reddito di dignità (Red) della Regione Puglia
e al Reddito di Inclusione (Rei) del Governo. "Non c'è nessuna nuova frenesia
per il reddito di cittadinanza proposto dai 5Stelle, ma curiosità sì. Ma nessun
pugno sul tavolo o nessuna rivendicazione animata. Perché Giovinazzo non è una
città di indolenti parassiti". Dal canto suo il sindaco di Giovinazzo, Tommaso
Depalma (lista civica), ritiene "che i cittadini siano stati ammaliati da spot
elettorali. La vittoria del M5S c'è stata, netta e inconfutabile, ma per il
reddito di cittadinanza la vedo dura". Ma in Cinque Stella della Puglia parlano
di mistificazione della realtà. E raccontano che anche il direttore di Porta
Futuro, Franco Lacarra, "che per dovere di cronaca è il fratello del neoeletto
deputato renziano Marco Lacarra del Pd ha confermato in maniera molto schietta
che non vi era stato alcun assalto". Il comunicato di Porta Futuro, però, non
smentisce: "Alcuni cittadini sono passati dal nostro sportello per chiederci
informazioni e approfondimenti su questo tema. Vogliamo chiarire che tutto ciò è
normale nel nostro Paese: succede ogni volta che vengono divulgate notizie
rilevanti per le politiche del lavoro e per la vita dei cittadini, come è
avvenuto per altre proposte legislative promosse negli ultimi mesi".
La Fake news contro il
Movimento Cinque Stelle delle richieste di massa di reddito di cittadinanza,
scrive il 9 marzo 2018 "Positano News". Da questa mattina in Puglia politici e
giornali hanno lanciato una nuova bufala: FIUMI di persone avrebbero preso
d’assalto alcuni CAF e centri per l’impiego per richiedere il reddito di
cittadinanza. A lanciare l’allarme per primo il sindaco di Giovinazzo (BA) (che
ha appoggiato il PD in campagna elettorale) che, commentando un articolo di una
testata locale, ha parlato di “file davanti ai Caf della città”. La notizia è
stata poi ripresa da “La Repubblica” che ha raccontato di “RAFFICHE DI
RICHIESTE” anche per “Porta Futuro” il centro per l’impiego di Bari. UNA FOLLIA
GENERALE CHE CI E’ APPARSA QUANTOMENO “SOSPETTA” ad appena 4 giorni dal voto,
con un Governo nemmeno insediatosi in attesa che si sblocchi la situazione tra
le varie forze politiche e dunque nessuna possibilità di legiferare. ABBIAMO
DUNQUE DECISO DI ANDARE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN PRIMA PERSONA. Dopo aver
girato alcuni CAF senza scorgere neanche lontani tentativi di “assalti”, abbiamo
deciso di recarci direttamente a “Porta futuro”. Ingresso vuoto. Corridoi vuoti.
(Dell’assalto e delle file interminabili mattutine, neanche un superstite).
All’ingresso alcuni addetti ci hanno subito spiegato che “in realtà noi non
abbiamo visto quasi nessuno, questa notizia ha lasciato di stucco anche noi”. Ci
hanno dunque fatto parlare con il direttore Franco Lacarra (per dovere di
cronaca sottolineiamo essere il fratello del neoeletto deputato renziano MARCO
LACARRA (PD)) che in maniera molto schietta e onesta ci ha confermato che
rispetto agli articoli letti non vi era stato alcun “assalto” ma che è solo
capitato, come gli capita sempre per qualsiasi provvedimento compresi quelli
regionali, che alcune persone NEGLI ULTIMI 3 GIORNI si siano recate a chiedere
informazioni generiche sul reddito di cittadinanza. Abbiamo dunque chiesto al
direttore di riportare la realtà dei fatti specificando di come si sia trattato
di un fenomeno assolutamente normale e quotidiano per loro. Il direttore,
d’accordo con noi, ha dunque richiesto al suo ufficio comunicazione di scrivere
una smentita sul canale Facebook di Porta Futuro. Non sappiamo bene come sia
potuto accadere ma solo pochi minuti dopo lo stesso direttore è stato contattato
telefonicamente, davanti a noi, dallo staff del sindaco renziano ANTONIO DECARO
(PD). Abbiamo ascoltato dunque il direttore costretto a “giustificarsi”
spiegando che con questa smentita avrebbe voluto solo raccontare la verità dei
fatti (a suo parere, testualmente, “una cazzata”). Nel frattempo, mentre eravamo
ancora in loco, sono arrivati altri giornalisti del TG RAI, di Repubblica e pare
che il direttore sia stato contattato anche dalla CNN. Tutto quanto vi abbiamo
raccontato sopra è cronaca, ora traete voi le vostre conclusioni. Dal canto
nostro, vorremmo solo dirvi una cosa: è evidente che la lezione di queste
elezioni politiche a qualcuno non sia bastata. A questo punto vi preghiamo: se
davvero avete così poca considerazione per l’intelligenza dei cittadini italiani
continuate pure a diffondere falsi “scandali” e fake news, vorrà dire che alle
prossime consultazioni elettorali il Movimento 5 Stelle volerà, da solo, oltre
il 41%. A riveder le stelle…
Putin è davvero colpevole?
Qualcosa proprio non torna nel caso Skripal, scrive il 27 marzo 2018 Marcello
Foa su "Il Giornale". Siamo proprio sicuri che ad avvelenare l’ex spia Skripal e
sua figlia siano stati i russi? Permettetemi di avanzare più di un dubbio
esaminando con attenzione le notizie uscite finora. I punti che non tornano sono
questi:
Primo. Qual è il movente?
Quale l’interesse per Putin? Mi spiego: tutti riconoscono al presidente russo
grande sagacia nel calibrare le sue mosse. Eccelle sia nella strategia che nella
tattica. Da tempo sappiamo che gli Stati Uniti (i quali trainano l’Europa) sono
impegnati in un’operazione di logoramento del Cremlino volto a ottenerne un
rialliniamento su posizioni filoamericane, che potrà essere ottenuto con
certezza solo attraverso un cambio di regime ovvero con l’uscita di scena di
Putin. Siccome una rivolta colorata è inattuabile, lo scenario è quello di
rendere insostenibile il peso delle sanzioni e dell’isolamento internazionale,
inducendo le élite russe a ribellarsi al presidente appena rieletto. In questo
contesto, ogni pretesto viene sfruttato per innervosire o indebolire Putin.
Conoscendo l’obiettivo finale, bisogna chiedersi: ma che interesse aveva il
presidente russo a tentare di eliminare un’ex spia, peraltro fuori dai giochi,
ricorrendo al più spettacolare dei tentativi di omicidio, l’unico che – dopo la
vicenda del pollonio – tutto il mondo avrebbe attribuito al Cremlino? Ne
converrete: non ha senso. Diplomaticamente sarebbe stato un suicidio, perché
avrebbe offerto all’Occidente lo spunto per un’ulteriore campagna antirussa, che
infatti si è puntualmente verificata, fino all’ultimo atto, l’espulsione
coordinata dei diplomatici, a cui l’Italia dell’uscente Gentiloni si è accodata,
benchè avrebbe potuto – e proceduralmente dovuto – astenersi. No, Putin non è
leader da commettere questi errori.
E veniamo al secondo punto,
che riguarda il rumore mediatico e il furore delle accuse. Non dimentichiamolo,
la comunicazione è uno strumento fondamentale nell’ambito delle guerre
asimmetriche (tra l’altro è il tema che tratto nel mio ultimo saggio “Gli
stregoni della notizia. Atto secondo”). Quando il rumore mediatico è assordante,
univoco, esasperato, le possibilità sono due: le prove sono incontrovertibili
(ad esempio l’invasione irachena del Kuwait) o non lo sono ma chi accusa ha
interesse a sfruttarle politicamente, il che può avvenire solo se le fonti
supreme – ovvero i governi – affermano la stessa cosa e con toni talmente urlati
e assoluti da inibire qualunque riflessione critica, pena il rischio di esporsi
all’accusa di essere “amici del dittatore Putin”.
Se analizziamo attentamente le
dichiarazioni del governo britannico, notiamo come la stessa premier May
continui a dire che “è altamente probabile” che l’attentato sia stato
sponsorizzato dal Cremlino. Altamente probabile non significa sicuro, perché per
esserne certi bisognerebbe provare l’origine del gas, cosa che è impossibile in
tempi brevi. E nel comunicato congiunto diffuso ieri da Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia e Germania si ribadisce che si tratta di «agente nervino di
tipo militare sviluppato dalla Russia», che farebbe parte di un gruppo di gas
noto come Novichok concepito dai sovietici negli anni Settanta. Ma sviluppato
non significa prodotto in Russia. Se non è stato usato questo verbo – o un
sinonimo, come fabbricato – significa che gli stessi esperti britannici non
hanno prove concrete a sostegno della tesi della responsabilità russa, che
pertanto andrebbe considerata come un’ipotesi investigativa. Non come un
verdetto. Anche la semantica, in frammenti ad alta emotività come questi, è
indicatrice e dovrebbe allertare la stampa, che invece non mostra esitazioni.
Eppure di ragioni per mostrarsi più cauti ce ne sono molte. Vogliamo ricordare
le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein? Ma esempi in tempi recenti
non mancano. L’isteria accusatoria di queste ore ricorda quella delle “prove
incontrovertibili” del 2013, secondo cui Assad aveva sterminato col gas 1300
civili, fa cui molti bambini. Scoprimmo in seguito che a usare il gas furono i
ribelli per provocare un intervento nella Nato. O, sempre in Siria, nel 2107
quando Amnesty e il Dipartimento di Stato denunciarono l’esistenza di un formo
crematorio in cui venivano bruciati i ribelli, rivelazione che indignò
giustamente il mondo ma che venne smentita dopo un paio di settimane dallo
stesso governo americano. Sia chiaro: nessuno sa chi abbia attentato alla vita
di Skipal e di sua figlia e nessuna ipotesi può essere esclusa. Ma la propaganda
è davvero assordante e i precedenti, nonché l’esperienza, suggeriscono maggior
cautela. E un sano scetticismo: perché Putin sarà, per la grande stampa,
“cattivo” ma di certo stupido non è.
Israele-Gaza: tutti i falsi
miti da sfatare.
Dall'onnipotenza del Mossad alla lobby ebraica e all'idea di "Due
popoli due Stati". La complessità del conflitto israelo-palestinese negli anni
ha generato una serie di convinzioni che non si basano sui fatti. Il dizionario
del conflitto dalla A alla Z, scrivono Anna Mazzone e Paolo Papi su "Panorama".
Israele ha avvertito i palestinesi della Striscia di Gaza di abbandonare le loro
abitazioni. La pseudo-tregua è durata un batter di ciglia. I razzi di Hamas
continuano a piovere in Israele e lo Stato ebraico ha ripreso i bombardamenti su
Gaza e si prepara (forse) a un'operazione terrestre. Compresso tra i suoi
falchi, Netanyahu sembra non avere chiara la rotta da seguire e intanto il
numero dei morti aumenta di ora in ora. Si parla di più di 200 persone, tutti
palestinesi e 1 israeliano. Il conflitto israelo-palestinese affonda la sua
storia nella notte dei tempi. Difficile districarsi nelle fitte trame degli
eventi, dei passi fatti in avanti e di quelli (tanti) fatti indietro. E,
soprattutto, difficile non ascoltare le sirene dei "falsi miti". Idee
preconcette, spesso frutto di propaganda da una parte e dall'altra, che a forza
di essere ripetute sono diventate realtà. Abbiamo provato a smontarli uno per
uno.
Il mito dei Paesi arabi
"fratelli". Non è vero, contrariamente a quanto sostiene la vulgata corrente,
che i palestinesi siano vittime esclusivamente delle rappresaglie israeliane. I
Paesi arabi che confinano con Israele, Gaza e Cisgiordania sono stati,
nonostante la retorica antisionista dei governi arabi strumentalmente usata in
chiave interna, tra i più feroci nemici degli oltre 5 milioni di profughi
palestinesi della diaspora, considerati - ovunque siano stati ospitati - come
dei paria senza diritti, degli inguaribili attaccabrighe da confinare in campi
sovraffollati, senza servizi né diritti e controllati a vista dalle onnipotenti
polizie locali. Dalla Giordania - dove durante il settembre nero del 1970 la
polizia giordana lanciò una sanguinosa operazione contro i gruppi palestinesi
nei campi - al Libano - dove i 500 mila profughi che vivono nei campi sono
considerati tuttora senza diritti politici e sociali - fino al Kuwait - dove i
lavoratori palestinesi furono espulsi durante la prima guerra del Golfo per il
sostegno che l’Olp ricevette dal regime di Saddam - non c’è Paese arabo che - al
di là delle magniloquenti dichiarazioni di solidarietà ai fratelli palestinesi
- abbia mai offerto un concreto aiuto ai palestinesi fuggiti dalle loro case.
Sempre in Giordania (e anche in Libano) un palestinese non può studiare Legge o
Medicina e non può essere proprietario di un immobile. Se questi sono
"fratelli", allora forse è il caso di parlare di "parenti serpenti".
Il mito dei negoziati. Non è
vero, o meglio: è estremamente improbabile, visto anche il disimpegno americano
- che una soluzione al conflitto israelo-palestinese possa essere frutto di un
negoziato tra i leader dei due campi, come dimostrano i fallimenti di tutti gli
accordi di pace degli anni '90 e 2000. È assai più probabile che le tendenze
demografiche di lungo periodo dei due gruppi etnici possano mutare,
irrimediabilmente, nei prossimi decenni, la natura politica dello Stato di
Israele. E questo per una ragione molto semplice: se guardiamo alle proiezioni
statistiche scopriamo che al momento in Terra Santa vivono 6.1 milioni di ebrei
e 5.8 milioni di arabi. La demografia dice che gli arabi fanno molti più figli
degli ebrei. E' inevitabile pensare che nel giro dei prossimi dieci anni,
qualora non si riuscisse a raggiungere una soluzione "Due popoli due Stati",
Israele potrebbe perdere progressivamente il suo carattere di Stato ebraico.
Insomma, quello che non si riesce a raggiungere da più di mezzo secolo al tavolo
dei negoziati, potrebbe realizzarlo la Natura.
Il mito degli insediamenti
congelati. Nonostante il governo israeliano abbia più volte dichiarato
l'intenzione di congelare i nuovi piani di insediamento nella West Bank, questo
non è accaduto. L'ultimo esempio è molto recente. Ai primi di giugno di
quest'anno l'esecutivo israeliano ha annunciato uno stop nella costruzione di
nuove abitazioni in Cisgiordania. In realtà, però, su un piano che prevedeva
1.800 nuovi insediamenti ne sono state costruite 381. Forte la pressione da
parte di cinque Paesi dell'Unione europea affinché Israele congelasse i suoi
piani sui nuovi insediamenti. Ma il governo Netanyahu ha fatto sapere che lo
stop è arrivato per motivi "tecnici" e non in seguito alle pressioni europee.
Il mito della
lobby ebraica. E' sicuramente il mito più gettonato. Quello dell'esistenza di
una lobby ebraica in grado di influenzare qualsiasi avvenimento
socio-economico-politico nel mondo è il cavallo di battaglia dell'esercito dei
complottisti. Il mito della lobby "giudaica" affonda le sue radici
nell'antisemitismo e, come tutti i miti, si fonda su idee fantasiose ripetute a
oltranza, nei secoli dei secoli, fino a diventare - almeno per alcuni - delle
verità inviolabili. E' il mito che ha gettato le fondamenta dello sterminio
nazista e che ha motivato nei secoli l'odio nei confronti degli ebrei, accusati
- dopo la Seconda guerra mondiale - di fare "marketing dell'Olocausto" per poter
mantenere una situazione di potere nel mondo. In realtà, basterebbe una sola
domanda per smontare il mito della lobby ebraica: perché - se la lobby esiste
sul serio - Israele non riesce a modificare l'immagine che passa sulla maggior
parte dei media nel mondo e che assegna allo Stato ebraico la maglia nera del
carnefice a fronte di una Palestina presentata largamente come vittima
indiscussa? Il vecchio adagio che la verità sta nel mezzo in realtà vale sia
per Israele che per la Palestina, ed è troppo semplice e superficiale credere
che esista una struttura monolitica e unica come la potente lobby ebraica, in
grado di modificare i destini del mondo.
Il mito di "Due popoli, due
Stati". La soluzione "Due popoli due Stati" è l'idea di creare uno Stato
palestinese indipendente, che possa esistere "assieme" a Israele. Negli anni è
diventata una sorta di "mito", perché sarebbe sicuramente la soluzione migliore
per risolvere un conflitto così complesso, ma è pur vero che al momento le parti
in causa sono troppo distanti. La creazione di creare uno Stato binazionale non
ottiene ugualmente supporto e i sondaggi dimostrano che sia gli israeliani che i
palestinesi preferirebbero la "mitica" soluzione "Due popoli due Stati". E
allora perché questa soluzione non viene raggiunta? La risposta affonda le sue
radici in anni e anni di conflitto israelo-palestinese per la terra, la
legittimazione, il potere. Un tema molto sentito dai palestinesi è il controllo
delle frontiere e la libertà di movimento. Movimento che Israele restringe e
controlla ai check-point e all'ingresso della città di Gerusalemme. E' molto
difficile negoziare una soluzione "Due popoli due Stati" se non ci si riesce a
mettere d'accordo sui confini come punto di partenza. Un ulteriore motivo di
conflitto è la disputa sul controllo di Gerusalemme, casa di molti siti sacri
per gli ebrei, ma anche per i palestinesi (e i cristiani). C'è poi la questione
degli insediamenti israeliani nella West Bank, che fa parte dei territori
palestinesi. L'espansione degli insediamenti israeliani nella West Bank è vista
da molti come il principale ostacolo alla costruzione di una pace stabile e
duratura. Infine c'è Hamas, l'organizzazione terroristica che controlla Gaza,
che non vuole l'esistenza di Israele e si batte per cancellare lo Stato ebraico
dalla mappa mediorientale. Di fronte a queste considerazioni, è evidente come la
soluzione "Due popoli due Stati", pur essendo la migliore da praticare, è anche
un falso mito da sfatare. Almeno finché le parti non muoveranno passi in una
direzione diversa da quella presa finora.
Il mito dell'estremismo
"solo" arabo. Per chi crede che nel conflitto israelo-palestinese il
"terrorismo" si esprima solo sul fronte islamico, questo è un altro mito da
sfatare. In Terra Santa gli estremisti sono anche ebrei e rappresentano un serio
problema per il governo israeliano. Ultra ortodossi, gli estremisti ebraici si
sono spesso distinti per attacchi di gruppo a donne. Come nel caso della ragazza
presa a sassate a Beit Shemesh (nei pressi di Gerusalemme) perché stava
attaccando dei poster della lotteria nazionale per le strade del villaggio. In
occasione della recente visita di Papa Francesco in Terra Santa, le autorità
israeliane hanno vietato a cinque noti estremisti di mettere piede nella città
di Gerusalemme. Considerano lo Stato israeliano "un nemico" e attaccano con
bombe e attentati, esattamente come gli omologhi della controparte palestinese.
Un nome su tutti è quello di Yigal Amir, il terrorista ultranazionalista che nel
1995 ha ucciso Yitzhak Rabin, perché non accettava l'iniziativa di pace sposata
dal premier israeliano e la sua firma sugli accordi di Oslo.
Il mito dell'onnipotenza del
Mossad. I servizi segreti israeliani vengono spesso portati a esempio di
infallibilità, ma non è così. Anche perché è umanamente impossibile. Tuttavia,
il mito dell'onnipotenza del Mossad è uno delle fondamenta su cui si articola il
mito della lobby ebraica, e pertanto resiste tenacemente nel tempo. Eppure, i
flop del Mossad (e dello Shin Bet, l'intelligence israeliana per gli affari
interni) sono sotto gli occhi di tutti. Cominciano nell'ottobre del 1973, quando
Aman, i servizi militari israeliani, giudica "Poco probabile" lo scoppio di una
guerra con i Paesi arabi, Qualche giorno dopo l'esercito sirio-egiziano attacca
Israele, cogliendo il Paese del tutto impreparato. Il capo di Aman fu costretto
a dimettersi. Poco prima, a luglio dello stesso anno, gli agenti del Mossad
danno la caccia ai leader di Settembre Nero, l'organizzazione terroristica
islamica responsabile dell'uccisione di 11 atleti israeliani ai Giochi olimpici
di Monaco del '72. Gli 007 israeliani credono di avere individuato Hassan Salamé
(uno dei leader) in Norvegia. Lo colpiscono, ma poi scoprono di avere ucciso per
sbaglio un cameriere di origine marocchina. In tempi più recenti, a gennaio del
2010 in un hotel di Dubai viene ucciso Mahmoud al Mabhouh, uno dei comandanti di
Hamas. Le foto dei killer (agenti del Mossad) fanno il giro del mondo con i loro
passaporti, su operazione della polizia locale. Infine, a giugno 2011 i siti
dell'IDF, di Shin Bet e del Mossad vengono violati da un gruppo di hackers di
Anonymous, che minaccia un attacco cibernetico contro Israele. Per due ore i
siti non sono accessibili.
Violenti scontri a Gaza: 16
palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Oltre mille feriti. L'Autorità
nazionale palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità
internazionale dopo la violentissima battaglia al confine con la Striscia dove
ha preso il via la 'Grande marcia del ritorno' che commemora gli scontri del
marzo 1976. La mobilitazione durerà fino al 15 maggio, giorno della Nakba. Fonti
diplomatiche: all'Onu riunione d'urgenza a porte chiuse del Consiglio di
Sicurezza, scrive il 30 marzo 2018 "La Repubblica". Sedici morti e più di mille
feriti nella Striscia, secondo il ministero della Sanità. Tra le vittime, la più
giovane ha 16 anni. È il bilancio, ancora provvisorio secondo fonti mediche di
Gaza, degli scontri tra palestinesi e forze della sicurezza israeliane scoppiati
al confine tra il sud della Striscia e Israele, dove ha preso il via la “Grande
marcia del ritorno” convocata da Hamas nell'anniversario dell'esproprio delle
terre arabe per creare lo Stato di Israele nel 1948. Da fonti diplomatiche si
apprende che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, su richiesta del Kuwait, terrà
una riunione d'urgenza sui tragici eventi di Gaza. La stessa fonte, coperta da
anonimato, ha precisato che la riunione avverrà a porte chiuse a partire dalle
18.30 ora locale (le 00.30 in Italia). La Grande Marcia si è aperta nella
Giornata della Terra che ricorda l'esproprio da parte del governo israeliano di
terre di proprietà araba in Galilea, il 30 marzo 1976. Le proteste dureranno
fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele, per i palestinesi
"Nakba", la "catastrofe", come la chiamano, perché molti furono costretti ad
abbandonare per sempre case e villaggi.
L'esercito ha aperto il fuoco
in più occasioni con colpi di artiglieria, munizioni vere e proiettili di gomma
vicino alla barriera di sicurezza davanti a cui hanno manifestato 17 mila
palestinesi. Dalla folla sono stati lanciati sassi e bottiglie molotov verso i
militari. Di primo mattino il colpo di artiglieria di un carro armato aveva
ucciso Omar Samour, un agricoltore palestinese di 27 anni che era entrato nella
fascia di sicurezza istituita dalle forze armate israeliane. Testimoni hanno
raccontato che si trovava su terreni vicini alla frontiera e un portavoce
dell'esercito ha spiegato l'episodio parlando di "due sospetti che si sono
avvicinati alla barriera di sicurezza nel sud della Striscia di Gaza e hanno
cominciato a comportarsi in maniera strana", e i carri armati hanno sparato
contro di loro". Successivamente è stato ucciso con un colpo allo stomaco un
25enne a est di Jabaliya, nel nord del territorio costiero e altri due (fra cui
un 38enne) in punti diversi della frontiera. La maggior parte dei feriti sono
stati colpiti da proiettili di gomma e gas lacrimogeni.
L'Autorità nazionale
palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale. Yusef
al Mahmoud, portavoce dell'Anp a Ramallah, ha chiesto "un intervento
internazionale immediato e urgente per fermare lo spargimento del sangue del
nostro popolo palestinese da parte delle forze di occupazione israeliane".
L'esercito israeliano ha precisato di aver preso di mira "i principali
istigatori" delle proteste violente e ha ribadito che non verrà permesso a
nessuno di violare la sovranità di Israele superando la barriera di sicurezza e
per questo ha anche schierato un centinaio di tiratori scelti. Secondo il
generale israeliano Eyal Zamir, l'esercito è intervenuto perché ha "identificato
alcuni terroristi che cercano di condurre attacchi, camuffandosi da
manifestanti". Zamir ha chiesto ai residenti palestinesi di stare lontano dal
confine e ha accusato Hamas di essere responsabile degli scontri in corso. Le
manifestazioni sono partite da sei punti dell'arido confine tra Gaza e Israele,
lungo una cinquantina di chilometri: in particolare Rafah e Khan Younis nel sud,
el-Bureij e Gaza City al centro, Jabalya nel nord. Il leader di Hamas,Ismail
Haniyeh, ha arringato la folla assicurando che "è l'inizio del ritorno di tutti
i palestinesi". Fonti dell'esercito di Tel Aviv hanno descritto gli scontri:
"Fanno rotolare pneumatici incendiati e lanciano pietre verso la barriera di
sicurezza, i soldati israeliani ricorrono a mezzi antisommossa e sparano in
direzione dei principali responsabili e hanno imposto una zona militare chiusa
attorno alla Striscia di Gaza, una zona dove ogni attività necessita di
autorizzazione".
L'esercito israeliano ha detto
che una ragazzina palestinese di 7 anni è stata "mandata verso Israele per
superare la barriera difensiva". "Quando i soldati hanno realizzato che era una
ragazzina - ha continuato l'esercito - l'hanno presa e si sono assicurati che
tornasse in sicurezza dai genitori". Secondo l'esercito - citato dai media - la
ragazzina è stata inviata da Hamas che "cinicamente usa le donne e i bambini, li
manda verso la frontiera e mette in pericolo le loro vite". La protesta, che
secondo gli organizzatori sarebbe dovuta essere pacifica, ha l'obiettivo di
realizzare il "diritto al ritorno", la richiesta palestinese che i discendenti
dei rifugiati privati delle case nel 1948 possano ritornare alle proprietà della
loro famiglia nei territori che attualmente appartengono a Israele. Sono giorni
che Israele fa intendere che avrebbe usato le maniere forti. Il ministro della
Difesa, Avigdor Liberman, aveva avvertito che qualsiasi palestinese si fosse
avvicinato a una barriera di sicurezza avrebbe messo a repentaglio la propria
vita. Secondo i media israeliani, Liberman da stamane si trova presso il
quartier generale dell'esercito per monitorare la situazione. L'esercito ha
dichiarato la zona "area militare interdetta". Scontri sono in corso anche in
Cisgiordania, nelle zone di Ramallah e di Hebron. Secondo il quotidiano
israeliano Haaretz la mobilitazione chiamata da Hamas è anche un modo per sviare
l'attenzione dal pantano politico all'interno della Striscia: dove dopo la
guerra del 2014 le infrastrutture sono in rovina e la gestione delle necessità
quotidiane è sempre più complicato. "Condanniamo in modo forte l'uso
sproporzionato della forza da parte di Israele contro i palestinesi durante le
proteste pacifiche di oggi a Gaza", ha detto il ministro degli Esteri della
Turchia. "È necessario che Israele ponga fine rapidamente all'uso della forza,
che innalzerebbe ulteriormente le tensioni nella regione", afferma Ankara,
lanciando un invito "alla comunità internazionale a rispettare la sua
responsabilità di convincere Israele ad abbandonare il suo atteggiamento
ostile".
Israele spara sulla marcia
palestinese: 15 morti a Gaza.
Striscia di Gaza. Uomini, donne e bambini per il ritorno e il Giorno della
terra: i cecchini israeliani aprono il fuoco su 20mila persone al confine. Oltre
mille i feriti, scrive Michele Giorgio il 30.3.2018 su "Il Manifesto". Manifesto
Il video che gira su twitter mostra un ragazzo mentre corre ad aiutare un amico
con in mano un vecchio pneumatico da dare alle fiamme. Ad certo punto il
ragazzo, avrà forse 14 anni, cade, colpito da un tiro di precisione partito
dalle postazioni israeliane. Poi ci diranno che è stato “solo” ferito. Una
sorte ben peggiore è toccata ad altri 15 palestinesi di Gaza rimasti uccisi
ieri in quello che non si può che definire il tiro al piccione praticato per
ore dai cecchini dell’esercito israeliano. Una strage. I feriti sono stati un
migliaio (1.500 anche 1.800 secondo altre fonti): centinaia intossicati dai gas
lacrimogeni, gli altri sono stati colpiti da proiettili veri o ricoperti di
gomma. È stato il bilancio di vittime a Gaza più alto in una sola giornata
dall’offensiva israeliana “Margine Protettivo” del 2014. Gli ospedali già in
ginocchio da mesi hanno dovuto affrontare questa nuova emergenza con pochi
mezzi a disposizione. Hanno dovuto lanciare un appello a donare il sangue
perché quello disponibile non bastava ad aiutare i tanti colpiti alle gambe,
all’addome, al torace. «I nostri ospedali da mesi non hanno più alcuni farmaci
importanti, lavorano in condizioni molto precarie e oggi (ieri) stanno
lavorando in una doppia emergenza, quella ordinaria e quella causata dal fuoco
israeliano sul confine», ci diceva Aziz Kahlout, un giornalista.
Gli ordini dei comandi
militari israeliani e del ministro della difesa Avigdor Lieberman erano
tassativi: aprire il fuoco con munizioni vere su chiunque si fosse spinto fino
a pochi metri dalle barriere di confine. E così è andata. Per giorni le
autorità di governo e i vertici delle forze armate hanno descritto la Grande
Marcia del Ritorno come un piano del movimento islamico Hamas per invadere le
comunità ebraiche e i kibbutz a ridosso della Striscia di Gaza e per occupare
porzioni del sud di Israele. Per questo erano stati fatti affluire intorno a
Gaza rinforzi di truppe, carri armati, blindati, pezzi di artiglieria e un
centinaio di tiratori scelti.
Pur considerando il ruolo da
protagonista svolto da Hamas, che sicuramente ieri ha dimostrato la sua
capacità di mobilitare la popolazione, la Grande Marcia del Ritorno non è stata
solo una idea del movimento islamista. Tutte le formazioni politiche
palestinesi vi hanno preso parte, laiche, di sinistra e religiose. Anche Fatah,
il partito del presidente dell’Anp Abu Mazen che ieri ha proclamato il lutto
nazionale. E in ogni caso lungo il confine sono andati 20mila di civili
disarmati, famiglie intere, giovani, anziani, bambini e non dei guerriglieri
ben addestrati. Senza dubbio alcune centinaia si sono spinti fin sotto i
reticolati, vicino alle torrette militari, ma erano dei civili, spesso solo dei
ragazzi. Israele ha denunciato lanci di pietre e di molotov, ha parlato di
«manifestazioni di massa volte a coprire attacchi terroristici» ma l’unico
attacco armato vero e proprio è stato quello – ripreso anche in un video
diffuso dall’esercito – di due militanti del Jihad giunti sulle barriere di
confine dove hanno sparato contro le postazioni israeliane prima di essere
uccisi da una cannonata.
La Grande Marcia del Ritorno
sulla fascia orientale di Gaza e in Cisgiordania è coincisa con il “Yom
al-Ard”, il “Giorno della Terra”. Ogni 30 marzo i palestinesi ricordano le sei
vittime del fuoco della polizia contro i manifestanti che in Galilea si
opponevano all’esproprio di altre terre arabe per costruire comunità ebraiche
nel nord di Israele. I suoi promotori, che hanno preparato cinque campi di
tende lungo il confine tra Gaza e Israele – simili a quelle in cui vivono i
profughi di guerra -, intendono portarla avanti nelle prossime settimane, fino
al 15 maggio quando Israele celebrerà i suoi 70 anni e i palestinesi
commemoreranno la Nakba, la catastrofe della perdita della terra e dell’esilio
per centinaia di migliaia di profughi. Naturalmente l’obiettivo è anche quello
di dire con forza che la gente di Gaza non sopporta più il blocco attuato da
Israele ed Egitto e vuole vivere libera. Asmaa al Katari, una studentessa
universitaria, ha spiegato ieri di aver partecipato alla marcia e che si unirà
alle prossime proteste «perché la vita è difficile a Gaza e non abbiamo nulla
da perdere». Ghanem Abdelal, 50 anni, spera che la protesta «porterà a una
svolta, a un miglioramento della nostra vita a Gaza».
Per Israele invece la Marcia è
solo un piano di Hamas per compiere atti di terrorismo. La risposta perciò è
stata durissima. Il primo a morire è stato, ieri all’alba, un contadino che,
andando nel suo campo, si era avvicinato troppo al confine. Poi la mattanza:
due-tre, poi sei-sette, 10-12 morti. A fine giornata 15. E il bilancio
purtroppo potrebbe salire. Alcuni dei feriti sono gravissimi.
Si rischia la Pasqua di
rappresaglia. In Israele si rischia una Pasqua di rappresaglia,
scrive Fiamma Nirenstein, Sabato 31/03/2018 su "Il Giornale". C'è confusione sui
numeri ma non sul significato della «Marcia del ritorno», come l'ha chiamata
Hamas. 15 morti, 1.400 feriti e 20mila dimostranti sul confine di Israele con
Gaza, in una manifestazione organizzata per essere solo la prima in direzione di
una mobilitazione di massa che dovrebbe avere il suo apice il 15 di maggio,
giorno della Nakba palestinese, il «disastro», festa dell'indipendenza di
Israele, che coinciderà anche con il passaggio dell'ambasciata americana a
Gerusalemme. Un'escalation continua di eccitazione mentre cresceva l'incitamento
ha visto per ben quattro volte unità di giovani armati di molotov, bombe a mano
e coltelli, infiltrati dentro il confine. Un esempio limitato di quello che
Hamas vorrebbe riprodurre su scala di massa, ovvero l'invasione di Israele, come
nei loro discorsi ieri hanno ripetuto i leader massimi Ismail Hanyie e Yehyia
Sinwar. Non a caso nei giorni della preparazione si sono svolte esercitazioni
militari con lanci di razzi e incendi di finti carri armati, pretesi rapimenti e
uccisioni che hanno persino fatto scattare i sistemi antimissile spedendo gli
israeliani nei rifugi. Il messaggio di Hamas era chiaro: marciate, noi vi
copriamo con le armi. Ma le intenzioni terroriste sono state incartate dentro lo
scudo delle manifestazioni di massa e l'uso della popolazione civile, inclusi
donne e bambini, è stato esaltato al massimo. Molti commentatori sottolineano
che se Hamas decide di marciare, non ci sia molta scelta. E una marcia di civili
risulta indiscutibile presso l'opinione pubblica occidentale, ma il messaggio
sottinteso è stato spezzare il confine sovrano di Israele con la pressione della
folla civile, utilizzare le strette regole di combattimento dell'esercito
israeliano che mentre lo stato maggiore si arrovellava, si è trovato nel
consueto dilemma delle guerre asimmetriche: tu usi soldati in divisa e il nemico
soldati in abiti civili, donne, bambini, talora palesemente utilizzati come
provocazione. L'esercito ha confermato che una piccola di sette anni per fortuna
è stata individuata in tempo prima di venire travolta negli scontri. E in serata
Israele ha bombardato con cannonate e raid aerei tre siti di Hamas a Gaza in
risposta a un tentativo di attacco armato contro soldati. La protesta di Hamas -
che arriva alla vigilia della festa di Pesach, la Pasqua ebraica - ha vari
scopi: il primo è legato alla situazione interna di Gaza. L'uso militarista dei
fondi internazionali e il blocco conseguente del progresso produttivo ha reso la
vita della gente miserabile e i confini restano chiusi. È colpa della minaccia
che l'ingresso da Gaza di uomini comandati da un'entità terrorista, comporta per
chiunque, israeliani o egiziani. Hamas con la marcia incrementa la sua
concorrenza mortale con l'Anp di Abu Mazen, cui ha cercato di uccidere pochi
giorni fa il primo ministro Rami Hamdallah; minacciata di taglio di fondi urla
più forte che può contro Israele, cosa su cui la folla araba, anche quella dei
Paesi oggi vicini a Israele come l'Arabia Saudita e l'Egitto, la sostiene. Il
titolo «Marcia del ritorno» significa che non può esserci nessun accordo sul
fondamento di qualsiasi accordo di pace, ovvero sulla rinuncia all'ingresso
distruttivo nello Stato ebraico dei milioni di nipoti dei profughi del '48,
quando una parte dei palestinesi fu cacciata e una parte se ne andò
volontariamente certa di tornare sulla punta della baionetta araba. Israele ha
cercato invano di evitare che alle manifestazioni si facessero dei morti. Ma
nessuno Stato sovrano accetterebbe da parte di migliaia di dimostranti guidati
da un'organizzazione che si dedica solo alla sua morte una effrazione di
confini. Hamas userà i nuovi shahid (povera gente) per propagandare la sua sete
di morte in nome di Allah e contro Israele. Certo questo non crea in Israele
maggiore fiducia verso una pace futura.
Il silenzio assordante sul
massacro dei curdi,
scrive Marco Rovelli il 29 marzo 2018 su Left. Fin dove arriva l’estensione
dell’impunità? Fin dove ci si può spingere nel massacro e nel disprezzo del
diritto? Fin dove si può farlo nella più totale indifferenza della comunità
internazionale e dei media? Erdogan ci sta mostrando sul campo che questi
confini sono assai estensibili. Quella porzione di Medio Oriente che dopo la
dissoluzione dell’Impero ottomano prese il nome di Siria, e che adesso si è
dissolta a sua volta, è il luogo ideale per riplasmare i confini di ciò che è
lecito. Ed è lecito tutto ciò che si può fare, come nello stato di natura di
Hobbes e Spinoza. In quello stato di natura non esiste alcuno Stato civile:
l’assoluta libertà di massacro di Erdogan, allora, ci mostra che non è
collassata solo la sovranità statale siriana, ma pure qualsiasi simulacro di
comunità internazionale. Erdogan ha di fatto invaso la Siria, e tutto accade
come nulla fosse: perché, dal punto di vista di una comunità internazionale, che
non esiste in quanto comunità normata da un diritto, nulla è, in effetti.
Erdogan massacra i curdi, tanto combattenti quanto civili, e, ancora, nulla è. I
curdi del resto sono da cent’anni l’assoluto rimosso del Medio Oriente, vittima
silenziosa delle strategie delle sovranità statali. Negli ultimi quindici anni i
curdi hanno provato a mettere in discussione il principio della sovranità dello
Stato-nazione, attraverso la teoria del confederalismo democratico: e così
adesso, quel Leviatano si abbatte su di loro, in forma di vendetta, lacerando
ancora le carni di quel popolo ribelle. Mentre il sacrificio si compie, il mondo
resta ammutolito. Ma non perché sgomento dalla terribile entità di quel
massacro. Piuttosto, perché nulla sa, e, se sa qualcosa, preferisce non farne
parola. Così appaiono del tutto naturali le immagini di Erdogan in visita in
Italia senza che nessuno dei nostri governanti abbia osato far cenno dei suoi
crimini. Un’infamia inemendabile. E allora, sia gratitudine a chi è penetrato
nei cancelli della fabbrica Agusta, il luogo primo della nostra complicità nel
massacro in corso. È con i nostri elicotteri Agusta Westland che il massacro
viene compiuto. Le pale degli elicotteri fanno un rumore tale, e le bombe
sganciate, che il silenzio dei media e dei governanti si fa sempre più
assordante. Fanno bene al cuore le immagini della partecipazione alle
manifestazioni per Afrin, certo: ma è sempre troppo poco quel che possiamo fare,
perché il silenzio del discorso pubblico ci sopravanza. Ciò, ovviamente, non ci
esime dal continuare a fare. Bisogna ricordare, senza posa, a fronte
dell’obsolescenza programmata del discorso pubblico, dove i morti scompaiono
dalla scena più velocemente di una qualsiasi canzone pop, di qualsiasi
tormentone estivo, come si getta un bene di consumo qualsiasi nell’immondizia.
Ricordiamo, invece. Ricordiamoci di Alan Kurdi, quel bambino curdo finito morto
riverso sulla spiaggia, che il mondo ha guardato in faccia per un istante,
commuovendosi come sempre per interposta persona, per poi assistere il giorno
dopo a un nuovo spettacolo che cancella quello del giorno precedente.
Ricordiamolo, che migliaia di piccoli Alan Kurdi sono uccisi, o costretti a un
esodo immane, dalle nostre bombe. E ricordiamo che Erdogan sta provando a
uccidere la speranza più luminosa di un Medio Oriente da troppo tempo disperato,
la speranza costruita giorno dopo giorno da un movimento curdo che tenta di
ridare forma e contenuti e pratiche nuovi a una parola da noi usurata e consunta
e abusata: democrazia. Ricordiamolo, che è perché i curdi del Rojava
sperimentano una democrazia radicale, che sono massacrati.
ALL’1% GLI UTILI IDIOTI
DELL’UCCIDENTE.
La Siria di Ghouta e la Ghouta di Amnesty, Palmira e Babilonia, i nazifascisti
in agguato, il gender e i migranti: quando i “sinistri” condividono distruzioni
e distrazioni di massa, scrive Fulvio Grimaldi sul suo blogspot, riportato da
Davide il 10 marzo 2018 su ComeDonChisciotte.
Quelli “del popolo”. Quelli
che risultano più nauseabondi sono sempre gli ipocriti. A partire dal
“manifesto” e da tutta la combriccola pseudosinistra dell’imperialismo di
complemento, che volteggia nel vuoto dell’interesse e del consenso di un
elettorato italiano che, per quanto disinformato o male informato sulle cose del
mondo, ha dimostrato di badare più alla sostanza che alle formulette di
palingenesi sociale incise sulle lapidi della sinistra che fu. E la sostanza ci
dice che mettere tutti sullo stesso piano, 5Stelle e ologrammi nazifascisti,
Putin e Trump, opposti imperialismi, migranti in fuga da bombe Nato e migranti
attivati dalle Ong di Soros, jihadisti a Ghouta Est e truppe governative, a
dispetto dell’immane e unanimistica potenza di fuoco mediatica, poi produce al
massimo l’1 virgola qualcosina per cento. Brave persone, certo (esclusi i
paraculi fessi dei GuE), ma fuori dal mondo, da chi è il nemico e da come si
muove l’1% finanzcapitalista e tecno-bio-fascista nell’era del mondialismo e
dell’high-tech. E, permettetemi una risatina, neanche bravi, ma di un narcisismo
solipsista che rivela tratti patologici per quanto è dissociato dal reale,
quelli della Lista del Popolo (Chiesa, Ingroia, bislacchi e farlocconi vari),
trionfalmente giunti allo 0,02%. Ma si può!
Di Maio tra omaggi a San
Gennaro e Mattarella e rifiuto degli F35. Sebbene questo unanimismo di fondo in
fatto di geopolitica tra gli ambiguoni o catafratti della sinistra ausiliaria
del sistema e del sistema i militanti in divisa, possa aver confuso le idee a
molti sulla partita che si gioca in Medioriente, o nei trasferimenti via Ong di
popolazioni, o a proposito dello “Zar Putin” e dei suoi maneggi per non far
vincere Hillary, basta a volte una piccola crepa e la luce passa e illumina
quanto si voleva restasse al buio. Possiamo dire tutto e il contrario di tutto
su Di Maio, ma credo che siano davvero pochini gli italiani che condividono
l’idea che spendere 80 milioni al giorno per muovere guerre a chi non si sogna
di disturbarci e che quindi non abbiano apprezzato il voto 5 Stelle contro ogni
missione militare e contro l’acquisto degli F35. Questo al netto delle promesse
di “normalizzazione” profferite ora a tutto spiano dal leader 5Stelle e che lo
fanno apparire come il pifferaio di Hamelin le cui liete marcette si trascinano
dietro tutti i ratti della prima e seconda repubblica. Pensano di salire sul
carro del vincitore, ma nella storia il pifferaio i ratti li porta a precipitare
nell’abisso. Di Maio se lo ricorda? Non vorremmo che si finisse come la fiaba:
che poi quelli trascinati via sono i bambini.
La Siria si riprende anche
Ghouta: pacifisti e diritto umanisti a stracciarsi le vesti. Prendiamo la Siria,
insieme a tutte le altre guerre, una dopo l’altra, che con ripetitività
parossistica ci vendono come difesa dei diritti umani di un popolo massacrato
dal proprio governante. Ci hanno seppellito in un bunker di menzogne: i tondini
li forniscono le Ong tipo Amnesty International, HRW, MSF, la malta che li tiene
insieme sono i media. Date un’occhiata a questo osceno appello di Amnesty perché
si costringa Damasco a levare l’assedio alla Ghouta. Ancora una volta questo
sempre più lurido arnese del bellicismo imperiale si fa riconoscere. Non una
parola sul golem terrorista che da 7 anni sbrana la Siria e tiene ostaggi, ogni
tanto massacrandoli, gli abitanti delle zone occupate. Mille parole perfide e
lacrimose su Aleppo in corso di liberazione, non una parola su Raqqa
polverizzata dai bombardamenti Usa, con tutti i suoi abitanti, mentre elicotteri
prelevavano quelli dell’Isis per reimpiegarli, insieme agli ascari curdi, in
altri crimini contro il popolo siriano.
Bimbi a Damasco. Ma poi nel
calcestruzzo si apre una crepa. Ed è la pigrizia degli stereotipi. C’è sempre un
dittatore che bombarda il proprio popolo, una massa sterminata di bambini
uccisi, come se, per esempio, Ghouta, fosse tutta una scuola materna, ci sono
sempre gli Elmetti Bianchi e i Medici senza Frontiere, grazie ai soldi di Soros,
che stanno inevitabilmente dalla parte dei “ribelli” e che poi vengono esaltati
e premiati dagli strumenti di comunicazione di coloro che le guerre le
promuovono. Non mancano mai le “armi chimiche di Assad”, linea rossa che poi
regolarmente sfuma, cancellata da prove e testimonianze (grazie russi!), come
sono insostituibili i sanguinari jihadisti di Al Qaida e Isis contro cui gli
imperiali dicono di combattere, ma dopo averli addestrati, armati e poi salvati
dalle offensive dell’esercito siriano e suoi alleati. Qualcuno rovistando nel
web si accorge, a dispetto della furia anti-fake news della Boldrini, che
l’attacco siriano alla provincia di Ghouta avviene dopo sei anni che da lì i
terroristi hanno ininterrottamente bombardato con razzi e mortai i 7 milioni di
civili della capitale Damasco; che le centinaia di vittime dell’offensiva
governativa su Ghouta, “soprattutto bambini”, sono il dato inventato
dall’Osservatorio che i servizi britannici e i jihadisti gestiscono a Londra;
che, se il governo spedisce colonne di autobus a evacuare la gente di Ghouta, o
la Croce Rossa siriana prova a creare corridoi umanitari per rifornire di cibo e
medicinali, a bombardare queste colonne e questi corridoi, voluti dal governo,
saranno difficilmente gli stessi governativi. Nel documentario “Armageddon sulla
via di Damasco” ho illustrato alcuni effetti del martellamento su Damasco, fino
a 90 missili in una settimana. Dal mercato Al Hamidiyya, il più antico e bello
del Medioriente, colpito nel momento di maggiore affollamento, alla stazione di
autobus disintegrata nell’ora di punta, con schizzi di sangue e parti di corpo
spiaccicati fin sul cavalcavia alto 20 metri. Immagini mie e di canali siriani
che nessuno in Occidente ha mai ripreso. E’ successo mille volte, come centinaia
sono state le incursioni aeree dei pirati israeliani. Avete sentito qualche
sussurro di disapprovazione da Amnesty e compari?
Il “manifesto”: tutti uguali
ma uno più uguale. Così, un po’ per volta, si aprono crepe, delle quali la più
grossa è il dubbio che il “manifesto” e affini, quelli che si precipitano a
fornire palchi e ghirlande ad Amnesty, non te la raccontino giusta quando
mettono sullo stesso piano chi spara da Ghouta e chi avanza da Damasco e, anzi,
trovano che i più cattivi siano coloro che “assediano” il sobborgo della
capitale per eliminare uno degli ultimi bubboni tumorali incistati nel proprio
territorio dai gangster imperialsionisti e mica quelli, sicari e mandanti, che
vogliono mantenere, ai costi più inenarrabili, un presidio che tenga sotto tiro
Damasco e impedisca la pacificazione e la vittoria dei giusti. Che sono poi
anche le forze popolari siriane precipitatesi in soccorso ai curdi sotto attacco
turco ad Afrin, a dispetto delle pugnalate alle spalle che questo mercenariato
di Usa, Israele e sauditi, ha inflitto a chi ne aveva accolto, con tanto di
cittadinanza, le centinaia di migliaia di fuggitivi dalle persecuzioni di
Ankara.
Quando parla il popolo, non
gli gnomi da giardino, il re buonista resta nudo. Le ambiguità e distorsioni dei
media, a qualsiasi obbedienza politica pretendano di rifarsi, hanno iniziato a
frantumarsi contro il muro della realtà. Elezioni politiche che mozzano gli arti
alla principale forza di dominio e relegano nell’irrilevanza chi gli opponeva
formule di rito anni ‘50, del tutto avulse da quanto una chiara percezione dello
stato di cose reale richiederebbe, dimostrano che il re è nudo e nudi sono anche
principi, duchi, baroni, paggi, nani e ballerine. La menzogna ha esaurito la sua
capacità mistificatrice. Da fuffa e nebbia, demagogia presidenziale e
pontificale, sono scaturiti irresistibili gli abusi inflitti dai dominanti ai
dominati sul piano sociale, economico, ambientale, di lavoro, scuola, salute. Ma
forse anche i crimini dei quali ci hanno voluto partecipi, anche a spese nostre,
compiuti contro altri popoli. Non sarà un caso che gli unici vincitori di questa
contesa elettorale siano coloro che a spese e avventure guerresche, come alle
sanzioni che a queste si accompagnano, si sono sempre opposti. E se questa barra
la manterranno dritta, sarà già molto.
Al potere via decostruzione e
migrazione. Che sono poi anche quelli che, in un modo o nell’altro, quale
corretto ed equo, quale rozzo e falsamente motivato, hanno messo in dubbio la
sacralità dei facilitatori delle migrazioni “per fame, guerra, persecuzioni”. Il
che ci porta a un’altra considerazione. Invasori e terrorismo jihadista ha posto
particolare accanimento nella distruzione delle vestigia storiche delle nazioni
che sono stati mandati ad assaltare. Ong, umanitaristi, sinistre, Don Ciotti e
missionari nelle colonie, Soros, briciole sinistre, sostengono l’accoglienza dei
rifugiati senza se e senza ma. Ci sono punti di contatto, affinità di obiettivi,
tra queste forze e le campagne che condividono? Non penso al semplicistico
discorso che individua causa ed effetto nelle bombe e nelle conseguenti fughe.
Lo stereotipo del “fuggono da guerre, fame e persecuzioni”. Penso a una manovra
a tenaglia che cancella corpi e spirito di comunità formatesi nel sangue, nei
progetti, nelle sconfitte e nelle rinascite, nella lingua e nei costumi, su una
comune terra, in rapporto con lo stesso ambiente ed è così che ha acquisito
conoscenza e coscienza di sé, identità, autostima, volontà di perpetuarsi e
crescere. Un fiore nell’infinita ricchezza della varietà dei fiori. Prima di
manipolazioni e ibridazioni. Se, io élite di infima minoranza, perseguo un
progetto di dominio mondiale assoluto che solo a me e ai miei subalterni
obbedienti convenga, delle forze così formatesi e così composte, altrettante
negazioni al mio disegno, devo liberarmi. E’ conditio sine qua non per
l’affermazione del progetto mondialista. La mia operazione a tenaglia consiste,
primo, nel cancellarne i segni della storia, delle opere compiute, le fondamenta
dell’edificio che una comunità, un popolo, una nazione, devono avere sempre in
corso d’opera se intendono avere un futuro. Del resto, senza queste tessere del
mosaico, l’umanità si estingue. L’élite regnerà sul deserto o su un altro
pianeta. E, secondo, nello sradicarli, spostare quelli che non ho decimato con
guerre militari o economiche, tagliare radici, staccare il fogliame dal tronco,
disperderlo, alienarlo da se stesso, confondendolo in quello che chiamano
“meticciato”. Erano le mie ultime ore nella Baghdad che ho illustrato in “IRAQ:
un deserto chiamato pace”, aprile 2003. I carri Usa, penetrati in città avevano
sparato i primi colpi contro l’Hotel Palestine, dove stavamo noi giornalisti che
non avevamo seguito l’ordine di Bush di far parlare solo gli embedded al seguito
degli invasori. Morirono un mio amico di Al Jazeera e un reporter spagnolo.
Uscendo dalla città in taxi passai accanto al Museo Nazionale: Protetta da
reparti angloamericani, manovalanza importata dal Kuweit stava già saccheggiando
la più ricca testimonianza della storia araba e irachena, dai sumeri agli
Abbassidi, anche a beneficio dei predatori dei caveau occidentali. Subito dopo
avrebbero disperso e bruciato i testi, resi sacri dal tempo e dall’amore dei
loro lettori, della Biblioteca Nazionale, dalle tavolette cuneiformi della prima
scrittura, alla magnificenza letteraria delle Mille e una notte e ai traduttori
arabi di Aristotele. Intanto i carri americani si preparavano a travolgere sotto
i propri cingoli Babilonia, Ur, Niniveh, Samarra, Nimrud, Ctesifonte, Hatra.
Quattromila anni di creatività umana, di civiltà, di culla della civiltà.
Meticolosamente, sistematicamente polverizzati o predati. E poi stessa procedura
in Siria, Aleppo, Palmira, Libia, Gaza, ovunque la pianta umana fosse più
antica, robusta, rigogliosa, degli stenti arbusti, delle misere gramigne di chi
a una cultura annegata nel sangue ha sostituito centri commerciali, tecnologie
decerebranti e arsenali atomici.
Mosul. In parallelo i
migranti, pezzi interi di popoli, 6 milioni di siriani spodestati, un milione a
disposizione dei minijob di Angela Merkel. E, logicamente, afghani, iracheni,
libici, pachistani e, soprattutto africani: basta seccare con una megadiga
Impregilo un fiume come l’Omo in Etiopia e 60mila perdono l’acqua, i coltivi, la
sussistenza, diventano foglie secche al vento che qualche Ong seduce a farsi
schiavi “meticciati” in un bengodi di sfruttati europei. Come si vede in ogni
sequenza che ci induce a impietosirci e a condividere “l’accoglienza”, sono in
stragrande maggioranza giovani con i tempi e le forze capaci di futuro. Un
futuro abbandonato alle multinazionali a casa propria, ma per il quale fornire
braccia e saperi In Occidente. Sono giovani, in grado di affrontare i pericoli
della filiera del traffico di carne umana, ma non procreeranno più per la
continuità di una comunità arrivata fin ad oggi a dispetto di prove di ogni
genere, procreeranno per il “meticciato”. A compensare ciò che da noi,
nell’esaltazione dei generi e transgeneri della sterilità, non nasce più. E se
crediamo che da tutto ciò noi siamo esenti, proviamo a gettare uno sguardo fuori
dalla finestra, tra un asilo nido che non c’è e una famiglia che il precariato
di sistema rinserra in sogni frustrati. Diamo un’occhiata ai territori
terremotati, banco di prova e cartina di tornasole di un altro fronte della
stessa guerra. Credete che, a quasi due anni dal sisma con migliaia ancora nei
campeggi al mare, in alloggi di fortuna lontani, con attività produttive sparite
per sempre, con la ricostruzione neanche di una stalla, si tratti solo di
inefficienza, ritardi, risse per appalti? Ho girato per quelle terre palmo a
palmo (“O la Troika o la vita – Non si uccidono così anche le nazioni”). Paesi
con le radici nell’impero romano e le chiese del Medioevo, dove hanno lasciato
segni Arnolfo da Cambio, Mantegna, Leopardi, Piero della Francesca: tesori
inenarrabili. I terremotati li vogliono scoraggiati, esportati, migranti anche
loro, i territori privati di una economia nativa, sorta dal genius loci,
anacronisticamente non sovranazionale, ma legata ai bisogni locali, ai biotopi
naturali e umani. Spopolare per nuove destinazioni d’uso. Sovranazionali. Come
quando sradicano con gli ulivi l’anima della Puglia, per far posto a gasdotti e
resort di Briatore. Rifugiati nostrani di cui nessuno tiene conto e né Soros, né
alcuna Ong dei diritti umani reclamano un’accoglienza senza se e senza ma. Tutto
questo Pippo non lo sa. Tutto questo quelli dell’1% “rosso”, PaP (Potere al
Popolo), i PC (le scissioni dell’atomo), o LuE (i neoliberisti, NATOisti,
Bruxellisti, insofferenti di Renzi), non lo sanno. Sepolti nell’altroieri, del
progetto capitalista e della relativa strategia non studiano e non vedono
neanche la più abbagliante evidenza. Nanetti da giardino occupati a strappare
erbacce, mentre fuori cresce una giungla di piante carnivore. E non si accorgono
che, ignorando quella strategia, ogni lotta contro il precariato di vite e
lavoro è già persa, mentre sono del tutto compatibili quelle contro le molestie,
per i matrimoni e le adozioni gay, per ogni più fantasiosa invenzione di genere
come fieramente esibite in quelle manifestazioni d buongusto e di cultura
popolare che sono i Gay Pride, contro la minaccia dell’Onda Nera nazifascista.
Minaccia eroicamente combattuta, da Macerata a Milano a Roma a Palermo, con
l’illusione di ricavarne dividendi boldriniani e poi spassosamente risultata
pulviscolo littorio allo 0,9%, Casa Pound, e allo 0,37% Forza Nuova. Tocca
scioglierli per salvarci dall’orrore di nuovi Farinacci e Himmler, era
l’invocazione tonitruante della Boldrini, grande specialista di armi di
distrazione di massa. Intanto, però, il mondo reale scioglieva lei e i suoi
scioglitori. E senza neanche un sorso di olio di ricino. Ma più compatibile,
anzi, più gradita di tutte, è la campagna per l’accoglienza dei migranti. Roba
di sinistra, ca va sans dire.
I non detti di Ghouta,
scrive Sebastiano Caputo il 22 febbraio 2018 su "Il Giornale". Tutto ciò che
accade in queste ore nella periferia di Damasco, di preciso a Ghouta, è filtrato
da una sconcertante quanto irresponsabile narrativa. In Siria c’è la guerra da
oltre sette anni eppure i grandi e autorevoli mezzi d’informazione sembrano
accorgersene solo ora perché gli ingredienti per la mistificazione della
realtà non mancano affatto. La meccanica comunicativa è più o meno sempre la
stessa: una produzione di notizie scollegate fra loro e confezionate dentro
un frame, cioè la cornice giornalistica da cui è impossibile sfuggire, in questo
caso “la mattanza di Ghouta perpetuata dall’aviazione del governo siriano”.
Seguono immagini scioccanti – in larga parte riportate dai “White Helmets”, il
braccio umanitario e mediatico dei gruppi terroristici- che mostrano le tragiche
conseguenze “dell’offensiva”, intere abitazioni rase al suolo, cadaveri sulla
strada, donne in lacrime, ambulanze, soccorritori in cerca di cadaveri tra le
macerie. Le riprese sono di qualità, il logo con l’elmetto bianco appare di
continuo, le fotografie vengono scattate con cura. Nell’album emerge
un’istantanea che diventa il simbolo di un assedio: una bambina col pigiama rosa
– la scelta del pigiama non è casuale e richiama di riflesso i campi di
concentramento nazista – che viene tratta in salva da casa sua. Esattamente come
ad Aleppo, quando il piccolo Omran Daqneesh fu immortalato coperto di sangue e
polvere nell’ambulanza, peccato che poco tempo dopo il padre svelò la tecnica
dei White Helmets i quali presero il bambino ancora sporco e scosso dai
bombardamenti e lo gettarono in mondovisione sul loro profilo Twitter certi che
le agenzie occidentali lo avrebbero alzato come trofeo. Alla sequenza di
immagini trasmesse a ripetizione – peraltro sempre le stesse – seguono i dati. A
contare i morti ci pensa il generatore di notizie diretto da un solo uomo che
vive in Inghilterra: l’Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Ad accodarsi a
questo macabro spettacolo del dolore sono le organizzazioni non governative
occidentali – Unicef, Save The Children, Médecins Sans Frontières – che mentre
mettono in primo piano i cadaveri putrefatti di donne e
bambini raccolgono donazioni – tramite squallidi banner pubblicitari – dai
lettori distratti e travolti da un flusso ininterrotto di lacrime. Nessuno
vuole negare le conseguenze immonde della guerra, il problema, ancora una volta,
sono i non detti dell’offensiva di Ghouta. Chi vive nel sobborgo di Damasco?
Chi sono questi ribelli (che se ci fate caso non vengono più nemmeno definiti
“moderati”)? Come agiscono? E come fa un’enclave, senza sbocchi autostradali, a
fornirsi di armi e munizioni? Questo spazio geografico si è ritagliato nella
contorta mappa militare nel lontano 2012 e si colloca sul lato nord-orientale,
alle porte della capitale. Quasi 400mila civili sono tenuti praticamente in
ostaggio da tre fazioni jihadiste legate a doppio filo con Al Qaeda - Faylaq al
Rahman, Tahrir al Sham e Jaysh al Islam – che da anni attaccano i quartieri
centrali di Damasco – non lontani dal Suk – a colpi di mortai. L’offensiva
dell’esercito siriano è stata rafforzata per rispondere agli attacchi contro i
damasceni che si sono intensificati proprio in questi giorni. Molti di loro
hanno perso la vita ma se ne parla poco perché la narrativa occidentale è
monodirezionale e classifica i civili siriani in due categorie: alcuni sono più
vittime di altri. Ghouta è anche quel luogo in cui vengono fabbricate e
utilizzate armi chimiche come dimostrò l’attacco del 21 giugno del 2013 in cui
inizialmente furono lanciate accuse contro il governo di Bashar al Assad, poi
smentite dal premio Pulitzer Seymour Hersh e rispedite al mittente fornendo le
prove che invece incolparono proprio quei ribelli “angelizzati” dalla stampa
occidentale, i quali le utilizzarono per trascinare l’amministrazione Obama in
guerra. Ecco, fin quando i grandi esperti con i loro look confortevoli o i
commentatori isterici non vi risponderanno a queste domande precise vorrà dire
che sono alimentatori inconsapevoli di questa grande macchina della
disinformazione, o furbetti che coprono per chissà quali interessi veri e propri
gruppi terroristici complici dei peggior crimini che loro stessi denunciano.
Erdogan tuona sui civili di
Ghouta, ma quelli di Afrin sono “terroristi”,
scrive il 27 febbraio 2018
Lorenzo Vita su "Gli Occhi della Guerra" su "Il Giornale". In questa guerra di
Siria tutto assume connotati incredibili, anche Erdogan che si erge a paladino
del diritto internazionale e umanitario. Parlando della tragedia umanitaria
della Ghouta orientale, il portavoce del presidente turco ha scritto che “il
regime sta commettendo massacri” e che “il mondo dovrebbe dire stop a questo
massacro insieme”. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, venerdì
scorso ha invitato la Russia e l’Iran, alleati della Siria di Assad, a
“fermare” le bombe su Ghouta Est, parlando del bombardamento del sobborgo
damasceno come qualcosa che passerà alla storia come la “Srebrenica siriana”. Il
presidente turco ha deciso di sposare, in questi giorni, una linea fortemente
negativa nei confronti dell’avanzata di Damasco nel sobborgo della Ghouta
orientale. Rompendo quasi definitivamente il patto di Astana con Putin e Rohani,
Erdogan ha deciso di intraprendere una campagna assolutamente contraria al
governo facendo tornare indietro le lancette dell’orologio ai tempi delle prime
rivolte contro Assad, quando Ankara sosteneva il rovesciamento del leader
siriano e le milizie che si ergevano in tutta la Siria. E ovviamente sfrutta la
questione della Ghouta orientale per colpire il governo siriano e imporre la
propria linea nello scacchiere settentrionale siriano. Erdogan è così: chi lo
tutela ha la sua collaborazione e chi non lo tutela diventa nemico. E sono
sempre i curdi dell’Ypg l’ago della bilancia. Quando gli Stati Uniti hanno
deciso di sostenere le milizie del Rojava e del nord dell Siria, il presidente
turco ha abbandonato nella sostanza l’alleanza con Washington schierandosi con
Mosca e sostenendo il piano delle de-escalation zones con l’Iran e la Russia.
Adesso che ha intrapreso l’operazione “Ramoscello d’ulivo” e ha scatenato le
forze armate contro i curdi di Siria, ottenendo il confronto diretto con la
Siria, eccolo di nuovo andare contro il governo di Damasco e provare a
riallacciare i rapporti con gli Usa. Nel frattempo, ha intrapreso contro i curdi
una campagna militare cruenta, che sta tenendo sotto scacco intere città e dove
ci sono già le prime accuse di uso di gas contro i villaggi. Soltanto che,
secondo Ankara, c’è una differenza. Mentre per Erdogan la risoluzione Onu sulla
tregua è giusta per fermare il massacro della Ghouta orientale, la stessa cosa
non vale per Afrin, Manbij. La Turchia ha accolto positivamente l’approvazione
della tregua umanitaria in Siria, ma ha subito messo le mani avanti, dicendo che
questo non avrà alcuna conseguenza su Afrin e l’offensiva di terra nel nord
della Siria perché “resterà risoluta nella battaglia contro le organizzazioni
terroristiche che minacciano l’integrità territoriale e l’unità politica della
Siria”. Non c’è discussione sul fatto che questa decisione” del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu “non abbia alcun effetto sulla operazione che la Turchia sta
portando avanti”, ha confermato il vice premier turco, Bekir Bozdag,
mentre Erdogan ha sottolineato che l’offensiva “continuerà fino a che l’ultimo
terrorista sarà distrutto”. “Sembra che sarà una estate dura e calda per i
terroristi e per i loro sostenitori. Prima ripuliremo Manbij, poi tutta l’area a
ovest dell’Eufrate”, così si è espresso Erdogan. Parole non troppo dissimili da
quelle rivolte dal blocco a sostegno di Assad nei riguardi dell’offensiva contro
Ghouta Est e altre sacche. Eppure, se per Erdogan questi sono massacri sui
civili, quella che ha intrapreso la Turchia è solo un’offensiva contro il
terrorismo. Un interessante punto di vista che fa riflettere su quanto sia
importante l’uso del linguaggio in un conflitto che si svolge anche con le
definizioni.
Ghouta Est: quando i
ribelli mettevano i civili in gabbie,
scrive "Piccole note" il 27 febbraio 2018 su "Il Giornale". La Russia ha
stabilito che da oggi, ogni giorno, ci sarà una tregua umanitaria per Ghouta
Est, dalle 9 alle 14 e chiesto l’apertura di vie di fuga per i civili che vi
abitano. La pressione internazionale per fermare l’attacco dell’esercito siriano
diretto all’enclave di Damasco controllata dai cosiddetti ribelli ha sortito un
primo effetto. Vedremo gli sviluppi: anche la campagna per la riconquista di
Aleppo Est fu uno stillicidio di stop and go, a causa da una pressione
internazionale diretta a contrastare le operazioni dell’esercito siriano.
La Caritas siriana denuncia lo
squilibrio dell’informazione. Esattamente quanto accade adesso, grazie una
fortissima campagna mediatica che dipinge l’operazione contro Ghouta Est come
brutale e i ribelli come eroi in lotta contro il sanguinario regime di Assad. La
guerra è brutta, anche quelle giuste (quella di liberazione dal nazifascismo, ad
esempio, conobbe ombre terribili: Dresda, Cassino, Hiroshima e Nagasaki…). Ma
questa sembra più brutta di altre. E i ribelli che la combattono più umanitari
di altri: ecco che foto e video li immortalano mentre, premurosi, soccorrono i
feriti e altro e più stucchevole. Nessuna notizia di quanto da essi perpetrato a
Damasco in questi giorni. Tanto che anche la Charitas siriana, in un raro
comunicato, ha sbottato: «La maggior parte dei reportage giornalistici si
concentra sui bombardamenti effettuati dalla Siria e dalla Russia su Ghouta
Est». Nulla si dice invece di quanto avviene a Damasco, martellata ogni giorno
«dall’inizio del 2018» da «colpi di mortaio» sparati da quel quartiere (vedi
anche Piccolenote). Come anche nessuna notizia sul raid degli Stati Uniti a Deir
Ezzor compiuto in questi stessi giorni: 25 i civili uccisi (Xinhua). D’altronde
tale silenzio è in linea con quanto accaduto a Raqqa, città coventrizzata dagli
Stati Uniti per scacciarne l’Isis (questa la narrazione ufficiale).
Le gabbie umanitarie degli
eroi di Ghouta Est. Resta che se il quartiere di Ghouta Est non viene liberato,
gli altri quartieri di Damasco resteranno preda dei bombardamenti dei ribelli
cari ai circoli che stanno perpetrando il regime-change siriano. A meno che i
loro sponsor internazionali non li fermino, cosa che non hanno alcuna intenzione
di fare. Gli servono perché sono fonte di destabilizzazione permanente della
capitale siriana. Così anche le campagne umanitarie servono a uno scopo
prettamente bellico: a evitare che Ghouta Est cada ed essi perdano un tassello
prezioso nella prospettiva di portare al collasso il governo di Damasco,
logorandone la resistenza.
Ma chi sono gli eroi di Ghouta
Est? Si tratta di alcune milizie jihadiste, subordinate ad al Nusra (al Qaeda),
la più forte e organizzata. Istruttivo un report di Human Rights Watch,
organizzazione non certo filo-Assad, del 2015: «I gruppi armati siriani mettono
in pericolo i civili, incluse le donne» che espongono «in gabbie di metallo in
tutta Ghouta orientale». Un crimine di guerra, spiega HRW, che i miliziani hanno
usato per evitare gli attacchi del governo siriano. Importante quel cenno a
«tutta Ghouta orientale» contenuto nel testo: indica che le gabbie dell’orrore
sono state usate da tutte le milizie presenti a Ghouta, non dalla sola al Nusra.
Nel report di HRW un cenno a un altro video che immortala «camion che
trasportano gabbie, ciascuna contenente da quattro a otto uomini o donne». I
«ribelli di Ghouta hanno distribuito 100 gabbie, ogni gabbia contiene circa
sette persone e il piano è quello di produrre 1.000 gabbie da distribuire nella
Ghouta orientale». Il bello è che lo sanno anche loro: anche la Cnn, infatti,
aveva ripreso quel video (cliccare qui). Allora, quelle terribili immagini
servivano per denunciare la brutalità dell’estremismo islamico. E così
giustificare un intervento americano in loco. Oggi non servono più, anzi. Così
sono semplicemente obliate. La guerra siriana, come anche altre (Yemen ad
esempio), è «disumana», come ha detto papa Francesco all’Angelus di domenica.
Quelle immagini lo documentano nella maniera più agghiacciante. Come disumana è
la cortina fumogena che intossica le informazioni su quanto realmente sta
avvenendo in quel martoriato Paese.
IL POLITICAMENTE CORRETTO.
LA NUOVA RELIGIONE DELLA SINISTRA.
Insultare la Boldrini è
prova di «maschia libertà»,
scrive Piero Sansonetti il 16 Aprile 2017, su "Il Dubbio". Sul web troneggia la
notizia degli affari d’oro che la sorella di Laura Boldrini combina sulla pelle
degli immigrati. Questa sorella della Boldrini – dice il web – si chiama Luciana
ed è la presidente di 340 cooperative di assistenza ai profughi. Chiaro che si
mette in tasca i milioni. E chiaro anche che è stata Laura a indicarle la buona
strada. E giù insulti. «Scandalo, scandalo!!! E i giornali, complici non ne
parlano! Farabutta, farabutta!». Eh già: Boldrini è la casta, signori, vedete
come è arrogante?. Però non è vero niente. Insultare Laura Boldrini è prova di
«maschia libertà»? La sorella di Laura Boldrini è morta alcuni anni fa. La
sorella di Laura Boldrini non si chiamava Luciana. La sorella di Laura Boldrini
non presiedeva alcuna cooperativa ma faceva la restauratrice di opere
artistiche. Non è vero niente ma sono veri, e bruciano, gli insulti che piovono
a valanga sui social, nei post, nelle mail. In questa storia si congiungono due
questioni, diverse, che spesso si mescolano. La questione delle fake news, ossia
delle notizie false (quelle che una volta si chiamavano leggende metropolitane)
e la questione, cosiddetta, del linguaggio dell’odio. Le leggende metropolitane
sono una vecchia storia, non si sapeva come nascessero ma entravano nel cuore
dell’opinione pubblica. Una volta si diceva che la moglie di Rutelli fosse la
proprietaria di tutti i parcheggi con le strisce blu di Roma. Oppure che il tale
leader politico avesse determinate abitudini sessuali, o una certa fidanzata o
un certo fidanzato segreto, e cose simili. Tutto falso. Ma ci sono anche
leggende metropolitane più pericolose, come quella – per citarne una storica –
che gli zingari rubano i bambini, o che gli ebrei sono proprietari di tutti i
posti chiave nell’economia di una città, o di una regione. Fino a qualche anno
fa queste leggende “aleggiavano” e facevano danni, ma non potevano diffondersi,
e soprattutto “inverarsi”, attraverso la potenza incontrollabile della rete. Ora
il problema si è molto aggravato, perché non solo è sempre più difficile
smentire le fake news, ma la proporzione tra notizie vere e notizie false si sta
ribaltando. Le notizie vere diventano minoranza, e in questo modo il rapporto
tra conoscenza e verità salta in aria.
È un problema? Si, è un
problema serissimo, soprattutto perché al diffondersi dell’informazione non vera
(quella che in Unione sovietica era ben organizzata dallo Stato, si chiamava
“disinformazia” ed era un formidabile strumento di governo e di controllo
sociale) si è sommato il dilagare del linguaggio dell’odio. Di che si tratta?
Della convinzione sempre più diffusa che la misura del valore di ciascun odi noi
– della nostra libertà, e del nostro coraggio, e della nostra capacità ideale –
risieda nella forza d’odio che riusciamo ad esprimere. Usando modi di
espressione violenti e mirando a demolire l’interlocutore col quale vogliamo
dissentire, e umiliarlo, e ferirlo profondamente.
Gli avvocati italiani (e cioè
il Cnf, il Consiglio nazionale forense) sono riusciti in queste settimane a
organizzare un evento che avrà una notevole importanza: un G7 degli avvocati,
che si svolgerà in settembre e metterà a confronto i rappresentanti delle
avvocature dei sette paesi più industrializzati del mondo. E questo G7 degli
avvocati avrà come tema dei suoi lavori proprio questo: come opporsi al
linguaggio dell’odio senza mettere in discussione la libertà di parola, di
pensiero, di espressione, di stampa.
Problema non semplice e che
sicuramente riguarda molto da vicino il giornalismo italiano. Perché è chiaro
che il dilagare della “disinformazia” e dell’odio è uno dei risultati della
perdita di funzione del giornalismo. Il quale aveva tra i suoi compiti
principali quello di mediare tra notizie e popolo, e dunque produrre
informazione vera, verificata, di qualità, approfondita. Il giornalismo si è
trovato spiazzato dall’improvviso successo della rete, e ha visto assottigliarsi
il suo ruolo di mediatore e di “intellettuale”. Ma invece di elaborare una
strategia di rilancio dell’informazione di qualità, ha preferito accodarsi al
linguaggio dell’odio e alle fake news. Facilitato dalla retorica anti- casta.
Le fake news e l’odio vengono usati come mazza per colpire la casta, cioè
soprattutto i politici, e in questo modo si costruisce una gigantesca auto-
giustificazione: “vado contro il potere dunque sono coraggioso – dunque ho
ragione”. Il ruolo della verità sparisce. A dare la prova di correttezza e di
giustezza non è il vero o il falso, ma il grado di rabbia e di attacco al
presunto potere. Questa abitudine giornalistica – il caso Consip, con le
clamorose balle che ha prodotto, è un esempio lampante e recente – è sospinta da
un’ “onda” popolare, ma a sua volta è lei stessa il motore che alimenta
quest’onda, e la protegge, e la giustifica, e la sostiene. Qual è la causa e
quale l’effetto è difficile dire. È facile dire, invece, che se il giornalismo
non si pone il problema di affrontare la propria crisi di identità, sarà
difficile fronteggiare la barbarie del falso e dell’odio. E chi vorrà inondare
di fango la Boldrini, o chiunque altro, potrà farlo liberamente e sentirsi
eroico, libero e vero maschio.
Perché diciamo “migrante”
anziché “immigrato”? Ce lo spiega la Boldrini,
scrive Adriano Scianca il 18 maggio 2015 su “Il Primato Nazionale”. “Migrante”,
participio presente del verbo “migrare”. Grammaticalmente, la parola indica
un’azione che è in corso, che si sta svolgendo in questo momento, senza riguardo
al passato o al futuro. Indica quello che stai facendo ora, non ciò che hai
fatto o ciò che farai. Non c’è né origine né destinazione in un participio
presente. Forse è per questo che il termine è stato scelto come definizione
ufficiale delle masse sradicate che muovono il grande business
dell’immigrazione. Finché la lingua italiana ha avuto una sua logica esistevano
gli emigrati (chi lasciava una terra per andare altrove) e gli immigrati (chi si
era mosso da casa sua e raggiungeva un nuovo luogo), che potevano anche essere
le stesse persone ma viste da prospettive differenti. L’emigrato è andato da qui
verso altrove, l’immigrato è arrivato qui da altrove. Resta comunque l’idea di
un punto di partenza e di arrivo, lo spostamento è una parentesi limitata al
fatto di raggiungere un determinato luogo.
Nei primi anni Ottanta,
tuttavia, comincia a comparire nei documenti ufficiali della Cee la parola
“migrante”. Il giornalismo italiano recepisce la novità a partire dalla fine di
quel decennio, ma è in questi ultimi anni che la parola entra nel linguaggio
comune, sospinta anche dall’eugenetica linguistica operata dal politicamente
corretto.
I motivi del cambio sono
spiegati dall’Accademia della Crusca: “Rispetto a migrante, il termine emigrante
pone l’accento sull’abbandono del proprio paese d’origine dal quale appunto si
esce (composto con il prefisso ex via da) per necessità e mantenendo un senso
profondo di sradicamento su cui proprio quel prefisso ex sembra insistere […].
Migrante sembra invece adattarsi meglio alla condizione maggiormente diffusa
oggi di chi transita da un paese all’altro alla ricerca di una stabilizzazione:
nei molti transiti, questo è il rischio maggiore, si può perdere il legame con
il paese d’origine senza acquisirne un altro altrettanto forte dal punto di
vista identitario con il paese d’arrivo, restare cioè migranti”.
L’emigrante, nel nostro
immaginario collettivo, è l’italo-americano o l’italiano che si è stabilito in
Belgio o Germania per trovare lavoro. Persone che, per quanto siano riuscite a
integrarsi, spesso solo dopo diverse generazioni, per noi restano
sempre “italiani all’estero”, con un legame anche solo virtuale che non si
spezza. Ma legami e appartenenze non sono visti di buon occhio oggi, potrebbero
essere portatrici o suscitatrici di razzismo.
Aggiunge il sito della
Treccani: “Emigrante, come dice l’etimo, sottolinea il distacco dal paese
d’origine, calca sull’abbandono da parte di chi ne esce, come segnala anche
l’etimologico e- da ex- latino. Ad emigrante, proprio per via di quel prefisso,
ma anche a causa del precipitato storico che si è sedimentato nell’uso della
parola, si associa l’idea del permanere di un’identità segnata dal disagio del
distacco, e dunque l’allusione a una certa difficoltà di inserimento nella nuova
realtà di vita […]. In ogni caso, migrante sembra adattarsi meglio alla
definizione di una persona che passa da un Paese all’altro (spesso la catena
include più tappe) alla ricerca di una sistemazione stabile, che spesso non
viene raggiunta. In tal senso, il senso di durata espresso dal participio
presente che sta alla base del sostantivo viene sottolineato: il migrante sembra
sottoposto a una perpetua migrazione, un continuo spostamento senza requie e
senza un approdo definitivo”.
Una “perpetua migrazione”: è
questo il concetto chiave. E va interpretato alla luce di un ragionamento
illuminante fatto a suo tempo da Laura Boldrini, secondo la quale il migrante è
“l’avanguardia dello stile di vita che presto sarà lo stile di vita di
moltissimi di noi”. Anzi, secondo la Boldrini gli immigrati “sono molto più
contemporanei di noi. Di me ad esempio che sono nata in Italia, sono cresciuta
in Italia, ho anche lavorato fuori ma poi continuerò come tanti di noi a vivere
in questo Paese”. Ecco quindi perché dire “migrante” anziché “immigrato”: perché
indica una condizione di sradicamento generale, di continuo movimento,
di nomadismo spirituale in cui forgiare il nuovo cittadino del mondo,
rappresentato dall’immigrato ma al cui modello tutti ci dobbiamo ispirare.
L’immigrazione è un esperimento di laboratorio, la creazione di un uomo nuovo a
cui tutti prima o poi ci dovremo conformare, eliminando il peccato originale del
radicamento per essere anche noi “più contemporanei” e cessare di pensarci come
italiani, marocchini, cinesi o romeni. A quel punto, finalmente, nascerà l’homo
boldrinicum, senza più origini né radici. Adriano Scianca
Boldrini regina del
politicamente corretto: amica dei migranti ma lei non migra,
scrivono il 15 Agosto 2016 Francesco Borgonovo e Adriano Scianca su “Libero
Quotidiano”. È come il bambino di quella storiella, quello che indica il sovrano
in veste adamitica e dice: «Il re è nudo». Anzi, no, il paragone non calza.
Questa è un'altra favola. Qui non c' è il re, c' è una regina ed è vestita. È
lei che guarda il popolo e urla: «Siete tutti nudi». È il motivo per cui perfino
la sua corte la odia: parla troppo, parla troppo sinceramente, dice quello che
sarebbe conveniente non dire, smaschera tutti i piani. Se sveli al popolo che lo
stai riducendo in mutande, il gioco si rompe. Lei è Sua Maestà Laura Boldrini,
la regina del politicamente corretto. Sul fatto che, anche nella metafora, lei
sia vestita è meglio insistere, giusto per autotutelarsi: tre anni fa, per
esempio, cominciò a girare in rete una foto di una donna nuda vagamente simile
al presidente della Camera. Era un fake, una bufala. Ma chi la condivise sui
social network si ritrovò nel giro di qualche giorno la polizia alla porta. È
fatta così, lei, sta sempre allo scherzo. È una delle ragioni per cui, pur
essendo l'incarnazione vivente del pensiero dominante, finisce per non
riscuotere troppi consensi nemmeno in tale ambito: non solo parla troppo, ma è
pure permalosa. Del resto, quando qualche anno fa decise di rendersi «più
simpatica», la Boldrini scelse come consulente Gad Lerner. Uno di cui tutto si
può dire tranne che sia «popolare» o, appunto, particolarmente simpatico. Basta
questo particolare a rendere l'idea di quanta presa sulle masse sia capace di
esercitare Laura.
Una così sarebbe capace di
gettare discredito su qualsiasi causa appoggiasse. E se si tratta di una causa
particolarmente impopolare, un certo tatto è necessario. Prendiamo la Grande
Sostituzione. Significa che prendi l'Italia, scrolli via da essa gli italiani
come se fossero formiche attaccate a un tramezzino durante un picnic, e ci metti
dentro popoli venuti da altri continenti. È quello che sta succedendo, qui da
noi e non solo. Ma non lo puoi dire così, altrimenti c' è il rischio che
qualcuno si incazzi sul serio. Devi per lo meno girarci attorno, ammantare le
tue argomentazioni di finto buonsenso, se possibile citare «gli economisti» o
non precisati «studi americani». Laura no, non ce la fa. Lei è priva della
malizia dei politici. Quando prova a ragionare in soldoni risulta goffa, come
quando twittò: «Italia è Paese a crescita zero. Per avere 66 milioni di abitanti
nel 2055 dovremo accogliere un congruo numero di #migranti ogni anno». Sì,
vabbé, ma chi se ne frega di avere 66 milioni di abitanti qualsiasi nel 2055,
possiamo anche essere 55 milioni di italiani senza dover portare l'Africa intera
in casa nostra, no? A quanto pare, per Madama Boldrini non è così. Ma il meglio
di sé, Laura lo dà quando parla a briglia sciolta. Una delle sue uscite più
memorabili riguardò la confusione tra immigrati e turisti: «Non possiamo, senza
una insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti affluenti
e poi trattare in modo, a volte, inaccettabile i migranti che giungono in Italia
dalle parti meno fortunate del mondo, spesso in condizioni disperate», disse. Ma
cosa c' entra? La Boldrini proprio non riusciva a capire che noi non «offriamo»
servizi di lusso a nessuno ma che i turisti li hanno solo perché pagano per
averli. Per gli immigrati, invece, è lo Stato a pagare. Ma la vera origine di
queste gaffes è «filosofica».
Il top del Boldrini-pensiero
risiede infatti nella sua visione del futuro in stile Blade Runner. Parliamo di
quella volta in cui disse che il migrante è «l'avanguardia di questa
globalizzazione» e, soprattutto, è «l'avanguardia dello stile di vita che presto
sarà lo stile di vita di moltissimi di noi». Capito?
Non si tratta di trasformare
l'immigrato in cittadino europeo, come vorrebbe (vanamente) la retorica
dell'integrazione. Siamo noi a dover diventare come lui. Noi dobbiamo integrarci
con i suoi usi e costumi, o meglio con il rifiuto di ogni uso o costume, occorre
solo abbandonarsi a un insensato nomadismo, all' abbandono generalizzato di ogni
radice. Che l'obiettivo fosse quello di ridurre in miseria noi anziché di dare
benessere a loro era già chiaro. Ma, appunto, è una di quelle cose che in genere
si dicono con una certa prudenza. Laura no, lei non ha filtri. Del resto non è
una politica di professione e non ha quindi le astuzie della categoria.
Laureata in Giurisprudenza,
durante l'università ha dedicato metà del tempo allo studio, metà a viaggi nel
Sud-est asiatico, Africa, India, Tibet: all' epoca preferiva ancora andare lei
nel Terzo Mondo anziché portare il Terzo Mondo qua. Giornalista pubblicista, ha
lavorato per un periodo anche in Rai prima di dar seguito alla sua vera
vocazione: mettere radici nell' inutile carrozzone burocratico dell'Onu. Nel
1989, grazie ad un concorso per Junior Professional Officer, comincia la sua
carriera alle Nazioni Unite lavorando per quattro anni alla Fao come addetta
stampa. Dal 1993 al 1998 lavora presso il Programma alimentare mondiale come
portavoce e addetta stampa per l'Italia. Dal 1998 al 2012 è portavoce della
Rappresentanza per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR) a Roma. Qui scopre il suo vero
eroe: il migrante. Quando vede un migrante, Laura perde ogni freno: deve
ospitarlo, mantenerlo, incensarlo. Arrivano orde di stranieri sui barconi? Lei
vuol dare a tutti il permesso di soggiorno. Erdogan perseguita i turchi? Nemmeno
il tempo di capire se ci saranno persone in fuga dal Paese che lei è già pronta
a spalancare le frontiere. Tanto, che male può mai fare il Santo Migrante? Di
sicuro non può essere un possibile jihadista, perché il terrorismo e
l'immigrazione, per la Boldrini, non hanno alcun legame. E, comunque sia, i
conflitti religiosi non esistono. Dunque, dal migrante non ci si può attendere
che buone cose. Dopo tutto, egli è un po' il partigiano del nuovo millennio. Sì,
Laura lo disse davvero, nel corso di un 25 aprile: «70 anni fa erano i
partigiani che combattevano per la libertà in Italia, oggi capita che molti
partigiani che combattono per la libertà nei loro Paesi, dove la libertà non c'
è, siano costretti a scappare, attraversando il Mediterraneo con ogni mezzo».
Combattono o scappano? Perché fare le due cose insieme non è possibile. In
genere si usano i verbi come due contrari, anzi. O combatti, o scappi. Ma la
logica, si sa, è un riflesso indotto dalla società patriarcale. Così come la
grammatica. I suoi siparietti con i deputati che si ostinano a usare la
«sessista» lingua italiana sono noti. Ma per lei è una crociata: «Sono
arciconvinta - ha detto recentemente al Corriere della Sera - che la questione
del linguaggio rappresenti un blocco culturale.
La massima autorità
linguistica italiana, la Crusca, dice chiaramente che tutti i ruoli vanno
declinati nei due generi: al maschile e al femminile. Ma la maggior parte
accetta di farlo solo per i ruoli più semplici, e si blocca per gli altri». La
Crusca le dà ragione. La Crusca: quella di «petaloso». Per la Boldrini, la
politica è fatta solo di simboli, battaglie di principio, questioni formali. Un
altro dei suoi chiodi fissi sono le pubblicità. «Certe pubblicità che noi
consideriamo normali, con le donne che stanno ai fornelli e tutti gli altri sul
divano, danno un'immagine della donna che invece non è normale e che non
corrisponde alla realtà delle famiglie», disse una volta. Donne in cucina, che
orrore, dove andremo a finire di questo passo? Praticamente non parla d' altro.
Nel maggio del 2013 auspicò
orwellianamente nuove «norme sull' utilizzo del corpo della donna nella
comunicazione e nella pubblicità» perché «se la donna viene resa oggetto nella
sua immagine puoi farne quel che vuoi». Si sa, è un attimo passare dallo spot
della crema abbronzante al femminicidio. Passarono pochi mesi e nel luglio 2013,
si guadagnò più di qualche critica definendo una «scelta civile» quella della
Rai di non trasmettere più Miss Italia. Nel settembre successivo tornò sul punto
in un convegno, parlando di pubblicità e stampa. «Penso a certi spot italiani in
cui papà e bambini stanno seduti a tavola mentre la mamma in piedi serve
tutti. Oppure al corpo femminile usato per promuovere viaggi, yogurt, computer».
Pubblicità obbligatorie con papà che cucinano: è praticamente il punto in cima
alla sua agenda. Il femminismo caricaturale della Boldrini arriva al punto di
distinguere gli attacchi politici a seconda del genere di chi attacca: «Per
principio mi rifiuto di entrare in dispute tra donne che vanno a indebolire la
posizione femminile. Se una donna mi attacca, mi aggredisce in quanto donna, non
rispondo. Non mi presto». Ma che vuol dire? Se ti attacca un uomo rispondi, se
lo fa una donna no? Questa non è discriminazione? Curioso strabismo. Non è
l'unico caso.
Attenta alle parole degli
spot, Laura è stata molto più di bocca buona nel soppesare il linguaggio del
«Grande imam di al-Azhar Ahmad Mohammad Ahmad al-Tayyeb», invitato qualche mese
fa a tenere una «Lectio Magistralis» sul tema «Islam, religione di pace» che si
sarebbe dovuta tenere nella Sala della Regina di Montecitorio. E pazienza se lo
stesso aveva esaltato gli attacchi suicidi contro i civili in Israele, se aveva
detto in tv che alle mogli si possono rifilare «percosse leggere», se ai
combattenti dell'Isis voleva infliggere «la morte, la crocifissione o
l'amputazione delle loro mani e piedi» ma non - attenzione - perché siano degli
assassini, ma perché «combattono Dio e il suo profeta», cioè perché non
interpretano l'islam come dice lui. Le donne in cucina negli spot, no. Se
vengono percosse leggermente dall' imam, invece, va tutto bene. Contraddizioni,
ipocrisia? Non nel fantastico mondo di Laura. Dove tutti i migranti sono buoni.
Anche perché tutti sono migranti. Francesco Borgonovo e Adriano Scianca
Chissà se madonna Laura
Boldrini, papessa della Camera, ha letto di recente I promessi sposi e s'è
dunque imbattuta in Donna Prassede, bigottissima moglie di Don Ferrante,
convinta di rappresentare il Bene sulla terra e dunque affaccendatissima a
"raddrizzare i cervelli" del prossimo suo e anche le gambe ai cani, sempre
naturalmente con le migliori intenzioni, di cui però - com'è noto - è lastricata
la via per l'Inferno, scrive Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano l'11 marzo
2014. Noi tenderemmo a escluderlo, altrimenti si sarebbe specchiata in quel
personaggio petulante e pestilenziale descritto con feroce ironia da Alessandro
Manzoni, e avrebbe smesso di interpretarlo ogni giorno dal suo scranno, anzi
piedistallo di terza carica dello Stato. Invece ha proseguito imperterrita fino
all'altroieri, quando ha fatto sapere alla Nazione di non avere per nulla
gradito l'imitazione "sessista" della ministra Boschi fatta a Ballarò da
Virginia Raffaele, scambiando la satira per lesa maestà e l'umorismo su una
donna potente per antifemminismo. E chissenefrega, risponderebbe in coro un
altro paese, abituato alla democrazia, dunque impermeabile alla regola
autoritaria dell'Ipse Dixit. Invece siamo in Italia, dove qualunque spostamento
d'aria provocato dall'aprir bocca di un'Autorità suscita l'inevitabile
dibattito.
Era già capitato quando la
Rottermeier di Montecitorio aveva severamente ammonito le giovani italiane
contro la tentazione di sfilare a Miss Italia, redarguito gli autori di uno spot
che osava financo mostrare una madre di famiglia che serve in tavola la cena al
marito e ai figli, sguinzagliato la Polizia postale alle calcagna degli
zuzzurelloni che avevano postato sul web un suo fotomontaggio in deshabillé e
fare battutacce - sessiste, ça va sans dire - sul suo esimio conto (come se
capitasse solo a lei), proibito le foto e i video dei lavori parlamentari in
nome di un malinteso decoro delle istituzioni, fatto ristampare intere risme di
carta intestata per sostituire la sconveniente dicitura "Il presidente della
Camera" con la più decorosa "La presidente della Camera". Il guaio è che questa
occhiuta vestale della religione del Politicamente Corretto è incriticabile e
intoccabile in quanto "buona". E noi, tralasciando l'ampia letteratura esistente
sulla cattiveria dei buoni, siamo d'accordo: Laura Boldrini, come volontaria nel
Terzo Mondo e poi come alta commissaria Onu per i rifugiati, vanta un curriculum
di bontà da santa subito. Poi però, poco più di un anno fa, entrò nel listino
personale di Nichi Vendola e, non eletta da alcuno, anzi all'insaputa dei più,
fu paracadutata a Montecitorio nelle file di un partito del 3 per cento e issata
sullo scranno più alto da Bersani, in tandem con Grasso al Senato, nella
speranza che i 5Stelle si contentassero di così poco e regalassero i loro voti
al suo governo immaginario. Fu così che la donna che non ride mai e l'uomo che
ride sempre (entrambi per motivi imperscrutabili) divennero presidenti della
Camera e del Senato.
La maestrina dalla penna rossa
si mise subito a vento, atteggiandosi a rappresentante della "società civile"
(ovviamente ignara di tutto) e sventolando un'allergia congenita per scorte,
auto blu e voli di Stato. Salvo poi, si capisce, portare a spasso il suo
monumento con tanto di scorte, auto blu e voli di Stato. Tipo quello che la
aviotrasportò in Sudafrica ai funerali di Mandela, in-salutata e irriconosciuta
ospite, in compagnia del compagno. Le polemiche che ne seguirono furono
immancabilmente bollate di "sessismo" e morte lì. Sessista è anche chi fa
timidamente notare che una presidente della Camera messa lì da un partito
clandestino dovrebbe astenersi dal trattare il maggior movimento di opposizione
come un branco di baluba da rieducare, dallo zittire chi dice "il Pd è peggio
del Pdl" con un bizzarro "non offenda", dal levare la parola a chi osi nominare
Napolitano invano, dal dare di "potenziale stupratore" a "chi partecipa al blog
di Grillo", dal ghigliottinare l'ostruzionismo per agevolare regali miliardari
alle banche. Se ogni tanto si ghigliottinasse la lingua prima di parlare farebbe
del bene soprattutto a se stessa, che ne è la più bisognosa. In fondo non
chiediamo molto, signora Papessa. Vorremmo soltanto essere lasciati in pace, a
vivere e a ridere come ci pare, magari a goderci quel po' di satira che ancora è
consentito in tv, senza vederle alzare ogni due per tre il ditino ammonitorio e
la voce monocorde da navigatore satellitare inceppato non appena l'opposizione
si oppone. Se qualcuno l'avesse mai eletta, siamo certi che non l'avrebbe fatto
perché lei gli insegnasse a vivere: eventualmente perché difendesse la
Costituzione da assalti tipo la controriforma del 138 (che la vide insolitamente
silente) e il potere legislativo dalle infinite interferenze del Quirinale e dai
continui decreti del governo con fiducia incorporata (che la vedono stranamente
afona). Se poi volesse dare una ripassatina ai Promessi Sposi, le suggeriamo
caldamente il capitolo XXVII: "Buon per lei (Lucia) che non era la sola a cui
donna Prassede avesse a far del bene; sicché le baruffe non potevano esser così
frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti cervelli che avevan bisogno, più
o meno, d'esser raddrizzati e guidati; oltre tutte l'altre occasioni di prestar
lo stesso ufizio, per buon cuore, a molti con cui non era obbligata a niente:
occasioni che cercava, se non s'offrivan da sé; aveva anche cinque figlie;
nessuna in casa, ma che le davan più da pensare, che se ci fossero state. Tre
eran monache, due maritate; e donna Prassede si trovava naturalmente aver tre
monasteri e due case a cui soprintendere: impresa vasta e complicata, e tanto
più faticosa, che due mariti, spalleggiati da padri, da madri, da fratelli, e
tre badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano
accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi cinque guerre, coperte,
gentili, fino a un certo segno, ma vive e senza tregua: era in tutti que' luoghi
un'attenzione continua a scansare la sua premura, a chiuder l'adito a' suoi
pareri, a eludere le sue richieste, a far che fosse al buio, più che si poteva,
d'ogni affare. Non parlo de' contrasti, delle difficoltà che incontrava nel
maneggio d'altri affari anche più estranei: si sa che agli uomini il bene
bisogna, le più volte, farlo per forza". Poco dopo, sventuratamente, la peste si
portò via anche lei, ma la cosa fu così liquidata dal Manzoni: "Di donna
Prassede, quando si dice ch'era morta, è detto tutto". Amen.
Sgarbi contro il
vocabolario politicamente corretto della Boldrini,
scrive il 4 gennaio 2017 "New notizie". Vittorio Sgarbi vs Laura Boldrini: il
noto critico d’arte, che non si fa problemi a dire pubblicamente quello che
pensa di ogni situazione che richiami la sua attenzione, ha preso di mira la
Presidente della Camera, Laura Boldrini: non si tratta della prima volta,
ricordiamo che quest’estate Sgarbi aveva demolito la sua decisione di istituire
una fantomatica commissione parlamentare contro l’Odio. “La Commissione contro
l’odio porterà a risultati sorprendenti. Riconosceremo finalmente i sentimenti
di Totò Riina. Saremo indotti a giustificarlo e forse ad amarlo, anche se non lo
abbiamo concesso ai suoi figli. Sì, esorcizziamo l’odio. Cerchiamo le radici del
male. Perché odiare gli assassini del Bangladesh? Perché provare rabbia e
rancore? Rispettiamo lo slancio religioso dei terroristi. Condividiamo il loro
martirio, i valori reali che li ispirano” aveva allora criticato Sgarbi. Ma non
si ferma qui: il noto critico, che ha tantissimi seguaci sui social e non solo,
ha anche preso di mira il nuovo vocabolario della Boldrini, il cui scopo
politico primario sembra essere quello di declinare al femminile ogni nome. Con
buona pace della grammatica italiana. ‘Sindaca’ e ‘Ministra’ o addirittura
‘Presidente’, neologismi che sono già mutuati da alcuni organi di
informazione. Per deridere questa “battaglia”, Sgarbi chiama il presidente della
Camera Boldrina. “Napolitano ha detto una cosa semplice: che i ruoli prescindono
dai sessi, che non si applicano ai sessi, che sono persone ma che essendo di
genere femminile non diventano femminili, un persono sostiene Sgarbi.
La ministra Fedeli e i
discorsi di Totò.
L’uso caricaturale del politicamente corretto rischia di essere ridicolo anche
quanto si propone obiettivi seri, come nel caso dei decreti delegati sulla
scuola, scrive Gian Antonio Stella il 18 aprile 2017 su "Il Corriere della
Sera". «Signore e signori, dottoresse e dottori, idrauliche ed idraulici,
oboiste ed oboisti, sfogline e sfoglini…». Avanti così, Valeria Fedeli rischia
di fare il verso a certi discorsi del mitico Totò. L’uso caricaturale del
politicamente corretto, infatti, riesce ad essere ridicolo anche quando si
propone obiettivi seri. E se la British Medical Association, come ha raccontato
su il foglio Giulio Meotti, ha tracciato il solco in Gran Bretagna invitando «i
medici a non parlare più di expectant mothers (mamme in attesa), ma di un più
generico pregnant people (gente incinta), per rispettare l’eventuale natività
gay» la nostra ministra dell’Istruzione si è incamminata lesta nel solco. Come
spiega Tuttoscuola, infatti, dopo aver esordito alla ripresa delle lezioni dopo
l’Epifania con un tonante «Care ragazze e cari ragazzi, bentornate e
bentornati», la signora ha sfidato le scontate ironie della popolazione
scolastica (che in queste cose sa essere feroce) con i testi definitivi dei
decreti delegati. Dove ha sfondato la barriera del suono del politicamente
corretto: «Ventinove (29) volte bambino è diventato “bambina e bambino”,
quarantanove (49) volte alunno è diventato “alunna e alunno”, quarantasei (46)
volte studente è diventato “studentessa e studente”». Un esempio? Nel decreto
sull’inclusione spicca: «Valutato, da parte del dirigente scolastico,
l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente…».
Il record, prosegue la rivista
di Giovanni Vinciguerra, «è dentro il decreto sulla valutazione con 44
articolazioni di genere (per fortuna non c’erano le bambine e i bambini
dell’infanzia, non compresi nella valutazione). Al secondo posto il decreto
sull’inclusione con 32 articolazioni, seguito dal decreto della riforma 0-6 anni
con 17 exploit tutti riservati ovviamente a bambine e bambini». E meno male che
i sindacati, che sembrano a loro agio con la ministra-sindacalista, non si sono
accorti d’una profonda ingiustizia: nei «già verbosissimi decreti» non ci sono
distinzioni sul sesso dei docenti. Scelta che avrebbe imposto l’uso di
professoresse e professori, maestre e maestri e così via. Domanda: al di là
delle possibili proteste di chi davanti a un eccesso di precisazioni di genere
potrebbe dichiararsi estraneo all’uno e all’altro sesso, è questo il famoso
«rispetto» per gli studenti? Non sarebbe più rispettoso evitare loro di cambiare
professori ogni anno o passare ore ed ore in edifici a rischio sismico e
idrogeologico?
Politicamente corretto, la
nuova religione della “sottomissione” al “non pensiero” del potere,
scrive il 13 dicembre Giuseppe Reguzzoni su Tempi. Per la nuova religione non è
vero ciò che è vero, ma ciò che si riesce a far apparire tale. Il nemico non è
un’altra religione ma il pensiero stesso. Chi pensa è un potenziale nemico.
Anticipiamo in queste pagine alcuni stralci del saggio Il liberalismo
illiberale, dell’Editore XY.IT, in libreria in questi giorni. L’autore, Giuseppe
Reguzzoni, è uno storico e giornalista, traduttore (tedesco, francese, inglese)
anche di opere di papa Benedetto XVI. Collabora con l’Istituto Mario Romani
dell’Università Cattolica di Milano. Il Politically Correct è il nuovo tabù e
l’aura di timore che lo circonda è il nuovo senso del pudore, del tutto imposto
ed eterodiretto. Preso alla lettera, “politically correct” richiama in qualche
modo l’idea di “correct polity”, dunque una certa buona maniera di governare o,
anche, di stare al mondo gli uni accanto agli altri, di costruire insieme la
politéia, la comunità civile. (…) Il Politicamente Corretto è, nella prassi
sociale di ogni giorno, un elenco implicito di divieti o, se si vuole, di dogmi
indimostrabili. Il sacerdote del Politicamente Corretto non mira ad argomentare,
ma a puntare il dito, con orrificato stupore, su chi osa mettere in questione la
secolarissima sacralità del suo Credo. (…)
Già solo accennare alle grandi
aree semantiche di cui si occupa questo moderno e laico tribunale
dell’Inquisizione costituisce in qualche modo un reato: immigrazione, sicurezza,
differenze di civiltà e di origine geografica e razziale, omosessualità, gender
mainstreaming, temi identitari, domande esistenziali e fedi religiose sono oggi
i nuovi “tabù”, ciò di cui è bene non parlare, anche se, inconsciamente, quando
sopravvive un minimo di spirito critico, lo si vorrebbe fare. L’idea di tabù è
stata sviluppata anzitutto dagli antropologi, come una sorta di proibizione
rituale, implicita e inconscia, ma è stato Freud a evidenziare il nesso tra tabù
e nevrosi. La nostra è una civiltà nevrotica, a tratti schizofrenica, che nega
l’esistenza stessa del problema, confinandolo nei propri tabù. Il Politicamente
Corretto è, appunto, il tabù rispetto alla ricerca e alla percezione della
verità, tutta intera. C’è, tuttavia, chi di questi tabù usa consapevolmente per
consolidare i propri disegni di potere. (…)
Il ministero orwelliano del
condizionamento esiste e la sua forza sta nella sua apparente, superficiale,
invisibilità. Come nel mondo immaginato da Orwell in 1984 la lingua, o meglio,
la “neolingua” è strumento di potere. Solo che, a differenza che nel mondo
distopico di Orwell, nel linguaggio politicamente corretto i termini sono in
costante aggiornamento. Si dice e non si dice, attuando con efficacia forme di
censura preventiva che ostacolano o impediscono ogni forma di pensiero critico
personale, qui proprio come in 1984. (…)
Questi tabù, organizzati
ectoplasmaticamente in quella realtà fluida e in continuo mutamento che è il
Politically Correct, costituiscono la nuova religione civile della società
globale. Qui sta il cambiamento in corso almeno da due decenni e coincidente con
la crisi dei grandi sistemi politici di matrice ideologica, incluso il
liberalismo e la sua pretesa di essere una sorta di via media. Qui sta il
nocciolo della forma che il Politically Correct sta assumendo e il fatto che
esso non sia ormai più solo un linguaggio, ma, appunto, un elemento di raccordo
e coesione sociale, con tratti simili a quelli che Rousseau attribuiva alla sua
religione civile.
Che la formulazione del
modello del Politically Correct abbia avuto luogo prima negli Stati Uniti non è
certamente un dato casuale. Rispetto all’Europa gli Stati Uniti, pur essendo un
paese fortemente secolarizzato, restano tuttavia fortemente segnati da un
ipermoralismo parabiblico, in cui Arnold Gehlen ha riconosciuto i tratti di «una
nuova religione umanitaria». Dopo la Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto,
negli anni Sessanta del secolo scorso, il linguaggio puritano ha subìto una
profonda mutazione a contatto con il linguaggio (neo)marxista veicolato dagli
intellettuali della scuola di Francoforte o ispirato da loro, dapprima rifugiati
negli Stati Uniti e poi installati nelle scuole e università occidentali. È
stato soprattutto con le rivolte giovanili degli anni Sessanta che costoro hanno
assunto il ruolo di sacerdoti del pensiero unico, esercitando un controllo
progressivamente egemone sui media e sui sistemi scolastici ed educativi
occidentali. Già le modalità con cui questo pensiero si è imposto presentano
quei tratti di slealtà che sono caratteristici del linguaggio politicamente
corretto, dal momento che la critica dell’autorità andava di pari passo con
modelli di autoritarismo implicito: si contestavano le figure tradizionali
dell’autorità, avvvalendosi dell’autorità che derivava dalle proprie cattedre e
dai propri ruoli. Il politicamente corretto si presentava antidogmatico,
imponendo però dogmi impliciti e indiscutibili, così come, nella sua versione
sessantottina, si presentava come anticonformista, imponendo però nuove forme di
conformismo radicale e disperato. In questo modo, sleale, il nuovo moralismo
andava costruendo i suoi dogmi, e si avviava a trasformarsi in quella che Carl
Schmitt definiva «la tirannia dei valori». (…)
D’altra parte è l’Occidente,
nel suo insieme, dunque anche l’America, a divenire vittima di se stesso e dei
propri complessi di colpa, evidenti nelle nuove forme di autocensura. Il
bombardamento di slogan antirazzisti, multiculturali, antiomofobi ha assunto
toni parossistici, quasi religiosi. Non si offrono ragioni, ma tabù indiscussi,
e il solo sollevare questioni, anche minime, è considerato blasfemo. Il
politicamente corretto, in quanto nuova religione civile, impone un credo
indiscutibile e indiscusso. Nella nuova religione non si crede perché essa è
ragionevole, ma solo per paura o per assuefazione. Lungo sarebbe l’elenco dei
“dogmi” di questa nuova religione civile, più facile identificare nei grandi
media, voce dei poteri forti, la nuova inquisizione, che sentenzia senza
ascoltare e condanna attraverso mantra ossessivamente ripetuti. Per essa non è
vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si riesce a far apparire tale. Il nemico
di tale tribunale non è un’altra religione civile, filosofica o rivelata, ma il
pensiero stesso. Chi pensa, per il fatto stesso che pensa, è un potenziale
nemico. Non affannatevi a pensare, a voler conoscere la realtà, lo facciamo noi
per voi. Voi limitatevi a divertirvi o compiangervi e, soprattutto, adeguatevi.
La dittatura del politicamente
corretto suppone delle società liberali o, se si preferisce, apparentemente
liberali, dove sia almeno a parole garantita la possibilità di scegliere, magari
cambiando canale tra reti, in realtà tutte omogenee al sistema. È il paradosso
del liberalismo, che vive di presupposti che non è esso stesso in grado di
generare, (…) è l’involuzione di un modello culturale e politico che, partito in
nome della libertà, finisce per ritagliare quest’ultima a uso di chi ha il
potere finanziario e politico. (…) Nel Politicamente Corretto tutto ciò che
marca la differenza tra comunità e individui, finanche tra i due sessi, è
percepito e indicato come un ostacolo imbarazzante. (…)
La laicità radicale, o
laicismo negativo, mira finanche ad annullare i segni storici della presenza
delle religioni in Occidente (dunque della religione cristiana) sostituendovi
altri segni in linea con la propria visione del mondo. Alle comunità religiose è
riconosciuto, al massimo, lo status di enti privati, senza alcuna pertinenza
diretta con la realtà statuale. È quanto non ha mancato di constatare, e
denunciare, papa Giovanni Paolo II lungo tutto il proprio pontificato:
«Nell’ambito sociale si sta diffondendo anche una mentalità ispirata dal
laicismo, ideologia che porta gradualmente, in modo più o meno consapevole, alla
restrizione della libertà religiosa fino a promuovere il disprezzo o l’ignoranza
dell’ambito religioso, relegando la fede alla sfera privata e opponendosi alla
sua espressione pubblica. Il laicismo non è un elemento di neutralità che apre
spazi di libertà a tutti: è un’ideologia che s’impone attraverso la politica»
(Ai presuli della Conferenza episcopale della Spagna, in visita Ad limina
Apostolorum, 24 gennaio 2005).
La campagna contro i
crocifissi, sottoscritta anche da un altro Zagrebelsky, a nome del Consiglio
d’Europa, non è che un elemento di questo complesso processo di sostituzione
simbolica che pretende di investire la totalità del vivere civile e le sue
espressioni non puramente individuali, come accade, esemplarmente, nella
gestione del tempo e della sua dimensione pubblica. Per il momento la rimozione
del calendario cristiano risulta ancora troppo complessa, ma val la pena di
ricordare che essa è già stata sperimentata all’epoca della Rivoluzione francese
e riproposta dai sistemi totalitari del XX secolo. La nascita di un calendario
civile, con applicazione rigorosa di nuove forme di “precetto festivo” si
colloca, a sua volta e in pieno, su questa medesima linea, dal momento che il
calendario rappresenta la scansione ufficiale del tempo in una società. In
Italia il 25 aprile, l’1 maggio e il 2 giugno hanno assunto funzioni che vanno
ormai ben al di là della commemorazione civile di eventi storici importanti. Ci
sono centri commerciali che sono aperti il 25 dicembre, Natale, ma non è
possibile o è estremamente difficile che la stessa cosa avvenga il 25 aprile o
il 2 giugno. Eppure, se il presupposto del laicismo radicale è che tutto è
relativo e che, dunque, nessuna posizione debba essere considerata preminente,
non si capisce bene su che cosa debba fondarsi la sacralità di tali ricorrenze
“civili”.
Alle feste “comandate” del
calendario civile, paragonabili alle solennità del calendario liturgico, si
sommano le “feste di precetto” e le “memorie solenni”, come la giornata della
memoria (ormai imposta in tutte le scuole, con cerimonie e iniziative
culturali), l’8 marzo (festa della donna) o la festa della mamma o il 14
febbraio, san Valentino, festa degli innamorati. Queste ultime, laiche feste di
precetto, tra l’altro, che pur non hanno il carattere di solennità nazionali,
sono oggi elementi costitutivi di una sorta di calendario universale del
Politicamente Corretto.
Tale calendario “civile”, non
potendo annullare del tutto le festività religiose, tende a neutralizzarle. Così
è avvenuto con il Natale cristiano, ormai scomodo sul piano dei dogmi della
religione civile del Politicamente Corretto, che è stato trasformato in festa
dei buoni sentimenti (con apertura dei negozi). D’altra parte, se internet è
l’emblema della nuova società globale, quando si parla di calendario, è
interessante osservare come il motore di ricerca Google ormai da anni scandisca
il fluire dei giorni come una sorta di rubrica liturgica di questa nuova
religione civile secolare, assumendo il ruolo di custode e guardiano della rete.
Intorno al logo di Google abbiamo visto scorrere di tutto: dall’anniversario
della nascita di Confucio, con tanto di costume mandarino stilizzato, a quella
di Galileo, con allegato telescopio, e persino quello di Ludwik Zamenhof, ebreo
polacco creatore dell’esperanto. Non sono mancati riferimenti alla nascita di
Buddha, malgrado la scarsità di dati storici certi, e abbiamo potuto seguire
quasi integralmente la scansione annuale delle principali festività ebraiche. Da
qualche anno ci toccano anche gli auguri ai musulmani per l’inizio e la fine del
Ramadan. Per par condicio il 25 dicembre ci si attenderebbe l’immagine di un
piccolo presepe, ma non è mai stato così. Il massimo che ci è stato concesso è
stato il grassone vestito di rosso, con tanto di renne al seguito, caricatura
inventata dalla Coca Cola del vescovo greco anatolico Nicola di Myra.
Su Google sono costantemente e
volutamente assenti i riferimenti al calendario cristiano in quanto cristiano,
benché il motore di ricerca non abbia ancora rinunciato al calcolo degli anni
dalla nascita di Cristo. I richiami alle feste cristiane sono “tabù”. Ma nella
geografia politica dell’imbarazzo, Google non è che un elemento accanto a
moltissimi altri, come il divieto esplicito del tradizionale augurio “Merry
Christmas” sulle insegne di molti comuni inglesi o quello implicito nella
stragrande maggioranza delle aziende europee ed americane, fino ad arrivare
all’esclusione di presepi e alberi di Natale in alcune scuole statali italiane
in nome della multiculturalità. La domanda che sorge spontanea è se davvero si
tratti solo di imbarazzo o se, piuttosto, queste scelte non sottendano un
disegno nascosto, non siano cioè l’espressione di una visione secolarista che si
va imponendo come una nuova e non esplicita religio civilis, mascherandosi da
laicità dello Stato che, addirittura, come in Zagrebelsky, dichiara di
considerare pericoloso ogni contributo che le religioni possono offrire alla
coesione sociale in quanto tale.
Le forze che agiscono dietro
questo progetto sono molteplici e si muovono sulla base di processi anche molto
differenti di autocoscienza. Sarebbe ingenuo, però, pensare a un movimento in
tutto e per tutto spontaneo, di carattere culturale, quasi che la cultura e la
mentalità dominante non abbiano nulla a che fare con le forme, indotte, del
disciplinamento sociale. Un’analisi compiuta di questi processi è arrivata
sinora più dalla letteratura distopica che dalla riflessione speculativa. Certo,
la teologia successiva al Vaticano II non si è ancora confrontata in maniera
seria con il tema del condizionamento socio-culturale come progetto di
riscrittura della mentalità e della società. I sorrisini e le ironie quando si
tocca il tema dell’influenza della massoneria sulla mentalità odierna la dicono
lunga su questa profonda ingenuità (è davvero solo tale?). Eppure i testi e i
documenti che mettono in guardia da un atteggiamento che cerca di mascherare
l’ingenuità con la spocchia intellettuale non sono pochi. Una cosa è il
complottismo, altra, e ben diversa, è la progettualità culturale sulla società,
particolarmente quando essa non è esplicitata in programmi politici trasparenti,
ma in forme di condizionamento legate ai soft power. (…)
Il cristianesimo non è una
religione civile; il laicismo radicale, almeno implicitamente, sì. Si può
discutere se e quanto le religioni possano contribuire alla religione civile di
una nazione, ma, in una prospettiva cristiana, ciò implica che il termine
“religione” sia inteso in senso quasi metaforico. E implica che la religione
civile non si ponga in termini sostitutivi rispetto alle religioni storiche, ma
ne accolga il contributo (…). Benedetto XVI, riassumendo una posizione che non
può essere tacciata di integralismo fondamentalista, non dice che il
cristianesimo è una religione civile, ma che esso ha una funzione civile. Non è
la stessa cosa (…).
Per dirla con Carl Schmitt, si
tratta di un processo di continua “neutralizzazione” dei riferimenti ideali.
Alle religioni tradizionali si sostituisce la pura razionalità, sino ad arrivare
a cercare un punto di coesione il più neutro possibile nell’economia e nella
tecnica. Tra queste suggestioni di massa, quella che fluttua da un centro
conflittuale all’altro, mantenendo la propria funzione mitica, è certamente
l’idea di progresso. (…) In fondo, mentre il cosmopolitismo settecentesco era
una dottrina filosofica, il globalismo contemporaneo ne è l’erede in forma
“neutralizzata”. L’altro elemento, accanto al mito del progresso e della
“neutralità della tecnica”, impostosi soprattutto dal Sessantotto, è quello dei
diritti dell’uomo, interpretati evolutivamente proprio alla luce del mito del
progresso, come ha acutamente dimostrato la professoressa Janne Haaland Matláry
proprio in rapporto all’idea di dittatura del relativismo. Il concetto riprende
un passaggio fondamentale dell’omelia di Benedetto XVI durante la celebrazione
della Messa Pro eligendo pontifice, che ben riassume il carattere (pseudo)
“religioso” di questa prospettiva. Il dialogo, per funzionare, implica
l’esistenza di un vocabolario comune, in cui i termini fondamentali non vengano
usati in maniera e con significati ambigui od equivoci.
Il relativismo etico
dell’Occidente e il Politically Correct come sua implicita religione civile non
sono in grado di realizzare questo dialogo dato che, nella migliore delle
ipotesi, quel che ne deriva è solo una mera giustapposizione del diverso, una
multiculturalità senza incontro e senza scambio. Anche i diritti dell’uomo,
considerati in sé e per sé, non riescono a uscire dal rischio di
un’interpretazione ambigua ed equivoca. A prescindere dal fatto che la maggior
parte dei paesi islamici non riconosce la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, all’interno dello stesso Occidente è al centro di interpretazioni
opposte che ne annullano il valore “universale”. Il punto è l’uso che oggi si
sta facendo dei diritti dell’uomo. Da una parte sono divenuti la nuova Bibbia
politica di una comunità sociale diversamente priva di qualunque riferimento
ideale, dall’altra sono stati di volta in volta usati come la bandiera di un
valore e del suo esatto contrario, per esempio, della difesa della famiglia
tradizionale e della sua demolizione attraverso il riconoscimento dei cosiddetti
matrimoni omosessuali. Nessuno in Occidente può oggi permettersi di andare
contro i diritti dell’uomo, e allora si tenta di tirarli dalla propria parte,
spostando il problema dall’applicazione dei diritti dell’uomo alla loro
interpretazione.
La Dichiarazione ha una sua
precisa collocazione storica e si tratta di un riferimento storico che ha
qualcosa di miracoloso, di irripetibile. Si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale
e dagli orrori del nazifascismo (quelli del comunismo erano ancora ipocritamente
occultati). La Dichiarazione Universale nacque come reazione al relativismo
politico e legale della Germania hitleriana e, più in generale, delle ideologie
totalitarie, con un implicito riferimento all’idea che stava alla base del
processo di Norimberga. Ai criminali nazisti che si appellavano all’obbedienza
agli ordini ricevuti dall’alto, si ricordava che esiste un’altra obbedienza, ben
più decisiva. Sulla base di questa idea, per la prima volta nella storia, un
tribunale aveva emesso delle condanne non perché gli imputati erano nemici, ma
perché avevano violato questa legge di natura, quella a cui si ispirò la
Dichiarazione.
Ora, perché questa legge possa
davvero essere tale, in forza di quel “sentire comune” di tutta l’umanità a cui
essa fa riferimento, bisogna che non possa essere modificata arbitrariamente
dagli attori politici. Ma è proprio questa la crisi che sta investendo i diritti
dell’uomo. Se essi sono solo una convenzione, modificabile col cambiare delle
opinioni, allora i diritti non sono più tali, perché possono a loro volta essere
modificati. Perché i diritti dell’uomo siano tali, devono essere al di sopra
degli stati, (…) essi non possono neppure essere in balìa dei nuovi poteri
transnazionali che cercano di svuotarli dall’interno reinterpretandoli in
direzione di quel mostro ideologico che è il politicamente corretto. Le grandi
lobbies del potere transnazionale non potendo negare i diritti in quanto tali,
tendono a dissolverli considerandoli solo come delle mere convenzioni, delle
questioni di maggioranza all’interno di un’opinione pubblica da loro dominata o
egemonizzata. (…)
La strategia sottesa è quella
del soft power, vale a dire del condizionamento dell’opinione pubblica da parte
di agenzie internazionali di opinione, con meccanismi acutamente descritti da
Haaland Matláry nel suo volume sui «diritti umani traditi»: si comincia a
imporre la trattazione di certi temi, mettendo in conto il rifiuto della
maggioranza ancora poco “illuminata”; si pretende che se ne parli come di
“diritti civili”, magari facendo riferimento a “casi pietosi” e con l’appoggio
di importanti figure del mondo dello spettacolo o dello sport; ci si appella al
sostegno del mondo scientifico, di volta in volta identificato con qualche
personalità di comodo e si ottengono, alla fine, delle “direttive non
vincolanti” emanate da organismi transnazionali (come – aggiungiamo noi –
potrebbe essere anche il Parlamento europeo). A questo punto il gioco è fatto e
si può intervenire all’interno di ciò che resta dello stato nazionale
appellandosi alle moderne conquiste dei paesi civili e al tale pronunciamento
della tale commissione per chiedere il “diritto” al matrimonio omosessuale, alla
sperimentazione sugli embrioni, alla clonazione eccetera. Nel frattempo si
dilata il vocabolario delle maledizioni politicamente corrette per far sì che
gli avversari nemmeno vengano ascoltati: razzista, omofobo, oscurantista, rozzo.
(…)
È chiaro che la Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo è stata svuotata. Essa ha senso solo in quanto espressione
del diritto naturale, cioè di quel diritto che viene prima di ogni forma di
organizzazione statale e che è inviolabile: «Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati» (Art. 30). Mettere in
questione il carattere universale di questi princìpi e il loro ancorarsi nelle
«leggi non scritte e immutabili» del diritto naturale significa spianare la
strada all’arbitrio e a nuove forme di totalitarismo. All’azione distruttiva del
soft power Haaland Matláry oppone la necessità di riscoprire il valore fondativo
e universale della ragione. La sua proposta di rivalutazione del diritto
naturale indica in modo rigoroso un possibile percorso fondativo della categoria
del “prepolitico” in un contesto culturale e sociale secolarizzato.
In una prospettiva cristiana,
restano due questioni: quella di come l’avvenimento cristiano debba porsi di
fronte a questa sorta di religione globale, incentrata sul mito del progresso e
sulla relativizzazione dei diritti dell’uomo; quella del contributo alla
coesione sociale che il cristianesimo è chiamato a portare nella vita delle
nazioni e nelle relazioni internazionali.
Il punto non è solo il ruolo
che le religioni possono svolgere all’interno delle società secolarizzate, ma,
soprattutto, le condizioni perché queste ultime possano sopravvivere e non
sprofondare in una violenza di tutti contro tutti. (…) Una corretta religione
civile – sempre che si voglia ancora insistere su questa espressione di per sé
ambigua – sarebbe, dunque, necessaria allo Stato liberale e democratico
occidentale proprio in funzione della realizzazione di questi presupposti che
esso non può darsi da solo, ma che può ricevere dalle forze più vive che
esistono al proprio interno.
Senza negare l’evidenza di una
società occidentale divenuta plurale (…), ma comunque bisognosa di riferimenti
etici e ideali comuni, si tratta di relativizzare l’idea di religione civile,
riconoscendole – con Benedetto XVI – un valore necessario, ma non sufficiente:
«Il concetto di religio civilis appare così in una luce ambigua: se esso
rappresentasse soltanto un riflesso delle convinzioni della maggioranza,
significherebbe poco o niente. Ma se invece deve essere sorgente di forza
spirituale, allora bisogna chiedersi dove questa sorgente si alimenta». Ecco,
allora, le due tesi ratzingeriane, per una rilettura della laicità dello Stato e
della religione civile a essa sottesa: «La mia prima tesi è che una religio
civilis che realmente abbia la forza morale di sostenere tutti presuppone delle
minoranze convinte che hanno trovato la “perla” e che vivono questo in modo
convincente anche per gli altri. Senza tali forze sorgive non si costruisce
niente. La seconda tesi poi è che ci devono essere forme di appartenenza o di
riferimento, o semplicemente di contatto con tali comunità», espressione con cui
si intende non solo la presenza di nuove comunità religiose, ma il contributo
fattivo e vitale che le comunità possono dare, come «sale della terra» (che più
avanti Ratzinger chiama anche «minoranze creative»), alla coesione sociale e
civile, in rapporto con tutti i fermenti più vivi che operano all’interno della
società. È evidente che per essere se stessa, l’esperienza cristiana chiede e
necessita di non essere privatizzata e ridotta a puro elemento individuale e
soggettivo. È altrettanto evidente che questa esperienza non deve temere di
rapportarsi a un mondo divenuto plurale, rimanendo però se stessa sino in fondo.
Diversamente, il concetto di religione civile resta «prigioniero in quella
gabbia di insincerità e ipocrisia che è il linguaggio politicamente corretto».
Contro il fascismo di
sinistra.
L’occidente politicamente corretto è un élite vuota e secolarizzata che si crede
eterna, dice Camille Paglia. “Il free speech era l’anima della sinistra degli
anni Sessanta, poi è diventata una polizia del pensiero stalinista”, scrive
Mattia Ferraresi il 6 Febbraio 2015 su "Il Foglio". “Quale visione della vita
propone il liberalismo che sia più grande delle prospettive cosmiche delle
grandi religioni?”, dice Camille Paglia.
New York. Camille Paglia
combatteva il politicamente corretto quando ancora non esisteva. C’era la
cultura perbenista e censoria che veniva dagli anni Cinquanta, ma non esisteva
ancora l’invisibile polizia del linguaggio del “fascismo di sinistra”, come lo
chiama lei, che tracciava il confine fra il legittimo e l’illegittimo nel
discorso pubblico non sulla base di un ben perimetrato codice morale, ma intorno
alle linee incerte della libertà individuale. Non è con la coercizione che il
politicamente corretto si è insediato. E’ stato un docile golpe culturale nel
nome dell’uguaglianza, articolato con il linguaggio accondiscendente dei
diritti, non imposto con il manganello della buoncostume. E’ lo strumento di
protezione degli indifesi, dei più deboli, delle minoranze oppresse, dicevano i
suoi difensori, e l’argomento potrebbe essere ripetuto anche da Mark Zuckerberg
per giustificare l’esclusione da Facebook dei testi che contengono la parola
“frocio” (termine che compare in questo articolo al solo scopo di sfruculiare
l’ottuso algoritmo).
Paglia è passata in mezzo a
tutte le fasi della guerra del politically correct. Faceva il primo anno di
università nello stato di New York quando gli studenti di Berkeley guidati da
Mario Savio manifestavano per la libertà di parola, gettando i semi della
controcultura; in tasca aveva sempre una copia di “Howl” (“la mia bibbia”, dice)
il poema di Allen Ginsberg censurato per oscenità. Nel 1957 la polizia aveva
perquisito – e contestualmente devastato – la libreria di San Francisco che con
inaccettabile affronto aveva continuato a vendere il volume; nei primi anni
Novanta, quando il politicamente corretto si è coagulato in un sistema di regole
per lo più non scritte, diventando convenzione dopo essere stato pulsione, la
femminista contromano era sulla copertina del New York magazine con uno spadone
medievale davanti al Museo d’arte di Philadelphia: una “women warrior” a
presidio della libera cittadella della cultura contro gli attacchi del
politicamente corretto.
Non che lo schema del
politicamente corretto oggi sia stato superato, anzi. Nella sua veste più
minacciosa di “hate speech” – un politicamente corretto con il turbo – il
canone che regola l’indicibile nel discorso pubblico è diventato pervasivo e
meccanico, s’è infiltrato nella rete sotto forma di cavillosi termini d’uso che
si accettano senza leggere; nelle università americane è sempre più frequente il
fenomeno del “disinvito” di oratori che possono offendere la sensibilità di
qualche gruppo minoritario; sul giornale di Harvard lo scorso anno una
studentessa suggeriva di abbandonare la finzione della “libertà accademica” e di
selezionare in modo finalmente esplicito quali eventi approvare e quali no sulla
base della compatibilità ideologica con una certa tavola di valori che
l’università di fatto promuove (e a parole nega). Il massacro islamista nella
redazione di Charlie Hebdo a Parigi ha rinfocolato il dibattito sulla libertà di
espressione e sui suoi limiti. Per qualche settimana siamo stati tutti Charlie,
poi l’occidente benpensante è tornato al suo business as usual: il New York
Times non ha pubblicato le vignette di Maometto per non offendere i lettori
musulmani, Facebook le ha censurate per non far arrabbiare il governo turco e
l’editorialista David Brooks ha fatto notare un’indiscutibile verità: un
giornale come Charlie Hebdo “non sarebbe durato trenta secondi” in qualsiasi
università americana. Si sarebbero sollevate proteste indignate, minoranze
offese avrebbero manifestato e finanziatori altrettanto offesi avrebbero
protestato con argomenti molto più convincenti.
Lo stesso magazine che
ritraeva Paglia fra armature medievali quasi quindici anni fa ha pubblicato di
recente un saggio sul politicamente corretto di Jonathan Chait, opinionista di
tendenza liberal, di cui il Foglio ha dato conto la settimana scorsa. Chait si
scaglia contro la dittatura del politicamente corretto e per capire che ha messo
il dito in una piaga insanguinata del dibattito basta leggere alcune delle
violente reazioni all’articolo da parte di esponenti di minoranze e sottoculture
che esigono protezione da parte della polizia del linguaggio. Il ragionamento
dei critici suona così: Chait può permettersi di attaccare il politicamente
corretto perché è un maschio-bianco-etero-ricco, se soltanto uscisse per un
attimo dalla bolla di privilegio sociale in cui vive capirebbe che le regole per
non offendere le minoranze sono un bene sociale imprescindibile. Questo tanto
per dire dove può portare la foga iconoclasta del movimento
anti-anti-politicamente corretto, che legge qualunque episodio come figura
dell’universale dialettica fra oppressori e oppressi.
Il cuore del saggio di Chait,
però, era il tentativo di dimostrare che il politicamente corretto non è figlio
del liberalismo, ma ne è una perversione, un tradimento introdotto dalla
sinistra radicale d’impostazione marxista e inclinazione totalitaria. Nello
schema di Chait c’è una sinistra buona e liberale che disprezza la correttezza
politica e innalza monumenti al “free speech”, e una sinistra cattiva che con un
rasoio ideologico raschia via dal discorso pubblico ciò che è incompatibile con
il suo pensiero, e usa come scusa la difesa delle minoranze.
La guerriera Camille Paglia
prende a spadate questa rappresentazione, e in una conversazione con il Foglio
ripercorre la genesi del politicamente corretto in seno (e non al di fuori) alla
rivoluzione liberale: “La libertà di espressione era la vera essenza, l’anima
della politica di sinistra degli anni Sessanta, che reagiva al conformismo e
alla censura degli anni Cinquanta, alla quale si opponevano già prima gruppi
radicali underground, i poeti Beat e gli artisti di San Francisco e del
Greenwich Village. La libertà di espressione è sempre stato il mio principio e
la mia motivazione centrale, parte dell’eredità dei filosofi dell’illuminismo
che hanno attaccato con forza le autorità religiose e i privilegi di classe.
Proprio per questo è stato incredibilmente scioccante per me il momento in cui i
liberal americani hanno abbandonato il free speech negli anni Settanta e hanno
inaugurato l’èra del politicamente corretto, per la quale soffriamo ancora oggi.
Invece di difendere il vibrante individualismo degli anni Sessanta, la sinistra
è diventata una polizia del pensiero stalinista che ha promosso l’autoritarismo
istituzionale e ha imposto una sorveglianza punitiva delle parole e dei
comportamenti”.
La sottesa analogia con la
dinamica che dalla rivoluzione giacobina e ai suoi ideali di liberté ecc.
conduce al terrore è certamente politicamente scorretta, e Paglia da sempre
mischia maliziosamente il registro dell’analisi a quello della provocazione
(solitamente quando l’interlocutore pensa si tratti di provocazione in realtà è
il frammento di un ragionamento calmo e lucido), rimane da spiegare il perché, e
forse anche il come. Perché la sinistra ha abbandonato le sue aspirazioni di
libertà per rintanarsi nel fascismo di sinistra? “Per capirlo – dice Paglia –
dobbiamo innanzitutto esaminare il fallimento della sinistra nel comunicare e
capire la maggioranza dell’America, il mainstream. Il documentario Berkeley in
the Sixties, uscito nel 1990, mostra una serie di errori strategici fatti dalla
sinistra, che, ad esempio, ha deciso di associarsi a movimenti che promuovevano
il disordine civile. Questo ha portato a una reazione culturale fortissima, la
quale ha contribuito al risultato delle elezioni del 1968: Richard Nixon è
diventato presidente, ed è nato un enorme movimento conservatore a livello
nazionale”.
Così la destra è riemersa
sulla scena politica grazie alle contraddizioni interne della sinistra, mentre i
liberal scottati dal l’arrivo di Nixon “si sono infiltrati nelle università”.
Erano i primi anni Settanta, ricorda Paglia, “proprio quando ho cominciato a
insegnare”. Questa sinistra che si è riversata nell’accademia “ha fatto
pressioni enormi sugli organi di governo dei college per introdurre cambiamenti
di sistema che poi sarebbero diventati la struttura base su cui è stato
costruito tutto l’edificio del politicamente corretto: sono nati dipartimenti
autonomi e autogestiti di studi femminili, studi afroamericani, chicano
eccetera. Questi programmi ispirati dalla ‘politica dell’identità’ erano basati
innanzitutto sull’ideologia, non su standard di qualità in termini di ricerca. I
professori venivano assunti in quanto true believer e il dissenso da un codice
approvato non era tollerato. Ero orripilata dai rigidi dogmi e dalla mediocrità
intellettuale di tutto questo: oggi è la routine dell’accademia americana”.
I dipartimenti umanistici sono
stati occupati dai discendenti della sinistra illuminata e liberale, non
soltanto dai radicali marxisti, i quali invece occupavano inespugnabili e
tuttavia isolate roccaforti universitarie. “Nei decenni – continua Paglia – i
pensatori indipendenti che cercavano di fare carriera nelle humanities sono
stati cacciati dalle università. Ho avuto a che fare con questo fascismo
dottrinario in tutti i modi possibili. Esempio: il mio primo libro, ‘Sexual
Personae’, che criticava l’ideologia femminista convenzionale, è stato rifiutato
da sette editori prima di essere pubblicato nel 1990, nove anni dopo che avevo
finito di scriverlo. Per fortuna quello era un momento in cui si stava
discutendo del politicamente corretto sui media per via di certi codici
linguistici imposti da università tipo la University of Pennsylvania. Non mi è
dispiaciuto quando il magazine New York ha deciso di dedicarmi la storia di
copertina, anzi se devo dire la verità l’idea della spada è stata mia”.
A quel punto, però, i dettami
del politicamente corretto avevano penetrato a tal punto la cultura che i
giornali di sinistra accusavano Paglia di essere una conservatrice (“accusa
isterica che non aveva alcun senso: avevo appena votato per l’attivista
ultraliberal Jesse Jackson alle primarie democratiche, sono ancora registrata
per il Partito democratico e ho sostenuto, anche finanziariamente, il Green
Party”) e la ragione della reazione convulsa, spiega, è semplice: “La sinistra è
diventata una frode borghese, completamente separata dal popolo che dice di
rappresentare. Tutti i maggiori esponenti della sinistra americana oggi sono
ricchi giornalisti o accademici che occupano salotti elitari dove si forgia il
conformismo ideologico. Questi meschini e arroganti dittatori non hanno il
minimo rispetto per le visioni opposte alla loro. Il loro sentimentalismo li ha
portati a credere che devono controllare e limitare la libertà di parola in
democrazia per proteggere paternalisticamente la classe delle vittime permanenti
di razzismo, sessismo, omofobia eccetera. La sinistra americana è un mondo
artificiale prodotto dalla fantasia, un ghetto dove i liberal si parlano solo
con altri liberal. Penso che la divisione politica fra destra e sinistra sia
moribonda e vada abbandonata, abbiamo bisogno di categorie più flessibili”.
Il “free speech” è un concetto
morto nel cuore della sinistra, ma a morire, più tragicamente e meno
concettualmente, sono anche i vignettisti che disegnano Maometto per rivendicare
la libertà d’espressione. In America molti giornali mainstream non hanno voluto
ripubblicare le vignette di Charlie Hebdo, cosa pensa di tale scelta?
“Dato che le vignette di
Charlie Hebdo erano disponibili in rete, non capisco perché i grandi giornali
avrebbero dovuto ripubblicarle, esponendo i loro staff a potenziali pericoli da
parte di fanatici senza scrupoli. I direttori poi possono anche indulgere in
gesti nobili e simbolici, barricati come sono dietro sistemi di sicurezza molto
più sofisticati di quelli della redazione di Charlie, ma di solito a pagare il
prezzo più alto sono gli inservienti, le guardie, i custodi”. Un’esibizione di
prudenza che non ci si aspetterebbe da un’intellettuale venuta fuori dalla
sinistra, ma a ben vedere Paglia ha passato tutta la vita a combattere una élite
che sbandierava la libertà come valore supremo; la femminista che combatte il
dogma dell’uguaglianza dei ruoli e la lesbica che difende la differenza sessuale
come base antropologica dell’occidente: “Guarda, sono una militante della
libertà di espressione e un’atea, ma rispetto profondamente la religione come
sistema simbolico e metafisico. Odio profondamente le becere derisioni alla
religione che sono un luogo comune dell’intellighenzia occidentale
secolarizzata. Ho scritto che Dio è la più grande idea che sia venuta
all’umanità. Niente dimostra l’isolamento della sinistra dalla gente quanto la
derisione della religione, che per la maggior parte degli uomini rimane una
caratteristica vitale della loro identità. La magnifica ricerca di significato,
dunque religiosa e spirituale, degli anni Sessanta si è persa nella politica
delle identità dei Settanta. Le vignette di Charlie Hebdo erano crude, noiose e
infantili, insultavano il credo di altre persone senza nessuna vera ragione
artistica. Il massacro è stata un’atrocità barbara e la libertà di espressione
deve essere garantita in tutte le democrazie moderne. Ma quale visione della
vita propone il liberalismo che sia più grande delle prospettive cosmiche delle
grandi religioni?”.
Michel Houellebecq nel suo
libro “Sottomissione” parla esattamente dell’assenza di un’alternativa secolare
all’altezza dell’immaginario religioso, che finisce per affermarsi nella vuota
libertà dell’occidente perché porta un surplus di significato. Paglia non ha
letto il libro dello scrittore francese né lo farà. Nessuna antipatia
particolare, soltanto “non leggo romanzieri contemporanei”. E qui Paglia
s’infervora: “A meno che non abbiano una diretta esperienza da zone di guerra,
gli scrittori odierni non hanno nulla da dirci sulla crescente instabilità del
mondo di oggi. Cosa sa esattamente Houellebecq del presente a parte quello che
tutti leggiamo sui media? Per capire il presente leggo sempre testi di storia e
religioni comparate. Siamo in un periodo simile a quello del tardo impero
romano, quando una élite sofisticata, secolare e con uno stile di vita
sessualmente libero pensava che il suo mondo fosse eterno. Il suo vuoto
spirituale era la sua condanna. Quella che è arrivata dalla Palestina era una
religione di passione e mistero che valorizzava il martirio. L’occidente ha
perso la strada, che cos’ha da offrire oggi? Può anche essere che il vecchio
conflitto con il mondo islamico sia il fattore primario nel determinare la
storia nel prossimo secolo. Ma non possiamo capire cosa sta succedendo senza
tornare alle nostre radici culturali e ricostruire un senso di rispetto per la
religione”.
Siamo sottomessi? Sì,
all'autocensura.
Un dossier sull'Impero (culturale) del Bene che spinge al conformismo e umilia
il pensiero, scrive Stenio Solinas, Domenica 14/02/2016 su "Il Giornale". «Il
campo del bene», «la sinistra morale», il «politicamente corretto»... Intorno a
quella che viene considerata «la nuova battaglia ideologica», la Revue des deux
mondes ha costruito un dossier di un centinaio di pagine come cuore del suo
ultimo numero (febbraio-marzo 2016). In esso, storici, sociologi, critici d'arte
e letterari, giornalisti e politici si accapigliano sul tema: c'è chi elogia il
«pensare bene» e chi critica i benpensanti, di destra e di sinistra, chi se la
prende con il progressismo e chi ne riscrive la storia, chi ironizza sul
tartufismo ipocrita del «libero pensiero» e chi nega di voler «diabolizzare»
l'avversario, anche se, sottintende, con il Diavolo non si discute, lo si
combatte...Vent'anni fa, in quello che resta un classico in materia, La cultura
del piagnisteo, Robert Hughes si era mostrato fiducioso: «Un'abitudine
tipicamente americana» l'aveva definita.
«L'appello al linguaggio
politicamente corretto, se trova qualche risposta in Inghilterra, nel resto
d'Europa non desta praticamente alcuna eco». Mai profezia si è rivelata più
avventata, nel piccolo come nel grande, nella politica come nella cronaca, nella
tragedia come nella farsa. Giorni fa, nello spiegare l'invio di militari intorno
alla diga di Mosul, in Iraq, il nostro ministro della Difesa ha detto che
sarebbero andati lì «per curare i feriti» e il suo collega degli Esteri ha
specificato che non andavano certo «per combattere»... L'idea del
soldato-infermiere e/o portatore di caramelle è singolare e richiama alla mente
la neo-lingua e il bis-pensiero del George Orwell di 1984: «La libertà è
schiavitù, l'ignoranza è forza», mentire con purità di cuore, «negare
l'esistenza della realtà obbiettiva e nello stesso tempo trarre vantaggio dalla
realtà che viene negata»...D'altra parte, «la guerra è pace» è in fondo poca
cosa rapportata alle dichiarazioni con cui, poco tempo fa, il rettore di un
college inglese ha deciso che «il ragazzo è una ragazza» e viceversa, e quindi a
scuola gonne e pantaloni sono optional: il sesso non si dà, si sceglie. Se,
indeciso, lo studente/la studentessa, si presentasse nudo/nuda alla meta, ovvero
in classe, non è dato sapere se frequenterà le lezioni... E naturalmente, i
guerrieri della pace e/o i pacifisti della guerra, gli uomini-donne e/o le
donne-uomini fanno anche loro parte di quella corrente di pensiero che ha
stabilito che immigrati e emigranti erano un retaggio del passato, di quando
insomma non eravamo esseri umani: «migranti» rende meglio il concetto, qualsiasi
cosa con esso si voglia dire. È l'onda lunga di quella che Hughes aveva definito
la Lourdes linguistica, dove il male e la sventura svanivano grazie a un tratto
di penna, ma è la stessa idea di natura umana che il pensiero progressista,
ovvero «il campo del bene», ovvero «il politicamente corretto» guarda con
sospetto. Niente è più irritante dell'avere una identità, di uomo e di
cittadino. Come spiega lo storico Jacques Julliard alla Revue des deux mondes,
corrisponde «alla caricatura dell'idea sartriana che l'uomo non è ciò che è, ma
ciò che fa. Alla filosofia del progresso che era quella del XIX secolo, si è
sostituita la filosofia del volontarismo individuale: la decostruzione di ogni
identità individuale a beneficio di una libertà pura nella quale la filosofia
greca avrebbe visto una sorta di hybris, di rivolta contro la natura che gli dei
ci hanno dato. Ecco il fondamento filosofico ultimo della sinistra morale». Il
fatto è, dice ancora Julliard, che l'uomo è un essere storico, e ciò che c'è di
più presente in lui è il suo passato. Viene anche da qui quella strana «teologia
negativa» per la quale si nega la propria identità per far emergere quella
dell'altro. Così, nella Francia del laicismo scolastico, puoi avere dei
programmi dove l'islam diviene obbligatorio, mentre il cristianesimo è
facoltativo...La «cultura dell'eufemismo» vuole le eccezioni preferite alle
regole, le minoranze alle maggioranze, le orizzontalità alle verticalità, e
grazie a lei la contro-verità diventa una verità. Nel «campo del bene», spiega
alla Revue des deux mondes il filosofo Jean Pierre Le Goff, l'emozione e i buoni
sentimenti la fanno da padrone. Non si vuole cambiare la società con la
violenza, e la classe operaia ha smesso da tempo di essere oggetto di interesse.
Si tratta invece di rompere con «il vecchio mondo» estirpandone le idee e i
comportamenti ritenuti retrogradi, in specie nel campo dei costumi e della
cultura. Non ha un modello chiavi in mano di società futura, ma una sorta «di
armatura mentale: svalutazione del passato e della nostra tradizione; appello
incessante al cambiamento individuale e collettivo, reiterazione dei valori
generali e generosi che porteranno alla riconciliazione e alla fratellanza
universali. Da un lato i buoni, dall'altro i cattivi»…Relativista,
antiautoritario, edonista, moralista e sentimentale. Anche libertario? Le Goff
dice di no: «Esercita una polizia del pensiero e del linguaggio di un genere
nuovo. Non taglia le teste, fa pressione e ostracizza». A sentire i difensori
del «politicamente corretto», per esempio il direttore di Libération Laurent
Joffrin, si tratterebbe di una balla. Essere progressisti vuol dire fondarsi sui
valori universali di eguaglianza e giustizia per giudicare le situazioni
contemporanee. Le idee progressiste, insomma, sono politicamente corrette
proprio perché progressiste, e del resto, per restare sempre in Francia, non
siamo di fronte a un affollarsi di pensatori reazionari, sulla stampa come alla
televisione, sempre lì a dire che sono proscritti e intanto però a scrivere e a
parlare senza impedimenti e con qualche lucro: libri, programmi, rubriche
eccetera? Sono loro «il vero pensiero unico»...Le cose sono un po' più
complicate, e trasformare una minoranza che dissente in maggioranza che ha
potere rimanda ancora al bis-pensiero e alla neo-lingua orwelliani. Per quel che
si sa, nessun professore universitario viene fischiato dai suoi studenti per
essersi richiamato all'ideologia dei diritti dell'uomo e a quella del progresso,
e quindi l'ideologia dominante è ancora quella lì ed è ancora saldamente al suo
posto. Solo che è un disco rotto, non inventa più niente e quindi più che alla
confutazione del pensiero altrui si dedica alla sua delegittimazione: non dice
che è falso, dice che è cattivo o che, oggettivamente, fa il gioco del cattivo,
del Male, del Diavolo. Non interessa se le opinioni possono essere giuste, conta
che possano essere strumentalizzate contro il «campo del bene», «l'impero del
bene»... Si arriva così all'assurdo di dichiararsi per la libertà di
espressione, purché però la si pensi allo stesso modo. Naturalmente, c'è anche
un benpensantismo a destra, un politicamente corretto che non è solo o tanto la
retorica del definirsi politicamente scorretti, una sorta di esaltazione per il
rutto intellettuale scambiato per schiettezza anticonformista. È una questione
più delicata. In Francia l'hanno ribattezzata «droite no frontier», ovvero il
sogno della libertà economica, il capitalismo libertario e senza confini che
però non dovrebbe confliggere con i valori familiari e morali. Si esalta il
mercato planetario di massa, ma non si ammette che dietro c'è «l'uomo nomade»,
che al mercatismo del mondo corrisponde quello dell'essere umano. In questo i
due benpensantismi, di sinistra e di destra, finiscono per darsi la mano: il
primo sogna la libertà illimitata di agire sul naturale umano e però fa finta di
rifiutare la libertà economica del mondialismo; il secondo prende per buona
quest'ultima, ma finge di credere che non lo riguardi nella sua quotidianità.
Entrambi tartufi, politicamente corretti.
L'ossessione politicamente
corretta ammazza la cultura e l'Università.
Salisburgo, tolta la laurea ad
honorem a Lorenz per il suo passato nazista. La lettera di protesta dei
professori di Oxford: stanno distruggendo il confronto tra le idee, scrive Luigi
Mascheroni, Domenica 20/12/2015, su "Il Giornale". E l'uomo incontrò il
politicamente corretto. Pochi giorni fa l'università di Salisburgo ha revocato
al grande etologo austriaco Konrad Lorenz, premio Nobel per la Medicina nel 1973
(morto nel 1989), la laurea honoris causa per il suo passato nazista. Studioso
di fama mondiale per gli studi sul comportamento animale - e autore di uno dei
testi più straordinari mai scritto sul valore della conoscenza e
dell'informazione, L'altra faccia dello specchio - Lorenz si distinse fin dagli
anni Trenta per la volontà di diffondere l'ideologia hitleriana. È curioso. Il
passato nazista di Lorenz è noto da sempre (nel 1937 fece domanda per una borsa
di studio universitaria facendosi raccomandare da accademici viennesi come
simpatizzante del nazismo, nel '38 aderì al Partito dopo aver scritto sul
curriculum che aveva messo «tutta la sua vita scientifica al servizio del
pensiero nazionalsocialista», e nel '42 fu spedito sul fronte orientale e fatto
prigioniero dai russi). Eppure Lorenz fu ritenuto meritevole del Premio Nobel
nel 1973. E l'ateneo austriaco lo insignì del titolo onorifico nel 1983. Però,
oggi, lo rinnega. Perché l'abiura non è stata fatta prima? Perché ora? Ha senso?
L'onda lunga del politicamente corretto, nella corrente di risacca, finisce per
travolgere la cultura del passato. Ma è quella del futuro che preoccupa di più.
Lo tsunami scatenato da questo pericoloso atteggiamento sociale che piega ogni
opinione verso un'attenzione morbosa al rispetto degli «altri», perdendo quello
per la propria intelligenza, fino a diventare autocensura, rischia di fare
immensi disastri. Ieri un gruppo di professori di «Oxbridge», cioè di Oxford e
Cambridge, ha scritto una lettera aperta al Daily Telegraph per denunciare il
politically correct che sta uccidendo progressivamente la libertà di pensiero ed
espressione nelle università britanniche, indebolendone il ruolo di spazio
privilegiato del confronto delle idee. Il casus belli è la campagna indetta per
rimuovere la storica statua di Cecil Rhodes, ex alunno e benefattore dell'«Oriel
College» (tanti ragazzi si sono fatti strada grazie ai suoi soldi), perché
considerato l'ispiratore dell'apartheid in Sudafrica. Ma le sue colpe - fa
notare qualcuno - non ne cancellano i meriti a favore del progresso. Un
principio che può essere applicato anche a Lorenz in campo medico. O a Heidegger
in campo filosofico. O a Céline in campo letterario. Ironia della sorte, e
dimostrazione della stupidità insita nel politicamente corretto: l'ex studente
che ha lanciato la crociata per la rimozione della statua, il sudafricano
Ntokozo Qwabe, ha potuto studiare a Oxford grazie a una borsa di studio
finanziata dalla Fondazione Rhodes.L'aspetto più inquietante della faccenda è
che a farsi promotori dell'autocensura basata sulla correttezza politica, ad
Oxford, non sono i professori, ma gli stessi studenti. Gli autori della lettera
aperta, guidati dal sociologo Fran Furedi della University of Canterbury, da
parte loro accusano le università inglesi di trattare i giovani come «clienti»
che pagano rette salate (che è meglio non scontentare) e non come menti da
formare e aprire al confronto. A Oxford un dibattito sull'aborto è stato
annullato dopo che una studentessa ha lamentato che si sarebbe sentita offesa
dalla presenza nell'aula di «una persona senza utero». Che, tradotto, significa
«un uomo». Un comportamento da vera papera che avrebbe di certo incuriosito un
etologo come Lorenz.
La triste ferocia
omo-illiberale contro i cattolici.
Non capisco perché i gay che (giustamente) manifestano per i propri diritti
civili siano un fenomeno progressista e il Family day una "manifestazione
inaccettabile", scrive Piero Ostellino, Giovedì 25/06/2015, su "Il Giornale".
In un Paese civile - e l'Italia, controriformista e intollerante,
indipendentemente dallo schieramento al quale ciascuno appartiene, purtroppo,
non lo è - tutti dovrebbero poter manifestare liberamente le proprie convinzioni
a favore delle proprie libertà, comprese quelle sessuali, senza essere
criminalizzati. Non capisco, perciò, perché i gay che (giustamente) manifestano
per i propri diritti civili siano un fenomeno progressista e il Family day - per
dirla con il sottosegretario Scalfarotto troppo ruffiano verso la vulgata gender
- una «manifestazione inaccettabile». I diritti civili dei gay sono i diritti
dell'uomo teorizzati dall'Illuminismo e sanciti dallo Stato moderno e la
famiglia è il primo nucleo della socializzazione nella nostra società.
Difendiamo entrambi senza farne un caso politico o elettorale. Personalmente,
non sono omofobo e mi vergognerei a discriminare gli omosessuali. Ma non sono
neppure orgoglioso della mia eterosessualità, come alcuni di loro - peraltro per
una comprensibile reazione polemica - affermano spesso di essere della loro
omosessualità. Prendo il mondo come è senza indulgere a concessioni
politicamente corrette o a dannazioni moralistiche. Dico quello che penso,
sperando di pensare sempre quello che dico. Per me, ciascuno gestisce la propria
sessualità - che è una scelta di libertà individuale - come meglio crede. Sono
liberale proprio per tale mio atteggiamento nei confronti di chiunque professi
un'opinione - salvo essere intollerante verso gli intolleranti, come predicava
Locke - o verso comportamenti diversi dal mio. È un dato caratteriale, prima che
culturale. Punto. Non avrei partecipato alla manifestazione del Family day
perché non partecipo a manifestazioni di alcun genere, ma neppure,
aristotelicamente, condivido certa propaganda gender che tende a confondere ciò
che la natura ha creato con le propensioni personali o, addirittura, mondane. Un
maschio è un maschio e una femmina una femmina, anche se in tema di diritti
civili sono ovviamente sullo stesso piano e non lo sono secondo ciò che
intendiamo per «naturale». Detto, dunque, che, in un Paese civile, ciascuno ha
diritto di manifestare liberamente la propria opinione, voglio, però,
aggiungere, che una cosa è, per me, la piena libertà dei gay di manifestare per
i propri diritti civili in quanto diritti umani universali, un'altra sono certe
loro pretese di affermare la propria condizione come postulato politico, come
ormai sta avvenendo in nome di una malintesa idea di politicamente corretto. Non
credo di essere, come eterosessuale, meno apprezzabile di un omosessuale, alla
cui condizione conservo tutta la mia comprensione e tolleranza. Ma dico che se e
è condannabile l'omofobia non vedo perché non lo debba essere l'ostilità, almeno
in certi ambienti, verso l'eterosessualità, che è anch'essa una scelta, oltre
che, diciamo, naturale, individuale. Punto. Tira, invece, una certa aria, da noi
- frutto della conformistica esasperazione del principio di correttezza politica
voluta da una sinistra priva di identità culturale che individua volentieri
nell'adesione «a orecchio» alle parole d'ordine del conformismo una
manifestazione di identità culturale. Aria che francamente trovo, in una
democrazia liberale, del tutto superflua e parecchio stupida. Ho detto che non
avrei partecipato al Family day, ma aggiungo subito di trovare non meno stupidi
i Gay pride e la loro richiesta di legittimazione del matrimonio fra persone
dello stesse sesso. Non sono un fanatico del matrimonio fra maschio e femmina,
che considero solo un fatto attinente al costume e alla tradizione. Mi sono
sposato, persino in chiesa! - perché così aveva voluto la mia futura moglie,
cattolica e moderatamente praticante - ma penso che passerò il resto dei miei
giorni con lei non perché l'ho detto a un prete, ma perché mi ci trovo bene...
Punto.
L’UBBIDIENTE DEMOCRATICO
di Luigi
Iannone. L’intento di questo libro è quello di misurare quanto sia marcato nelle
singole vite e nei percorsi collettivi il nostro grado di assuefazione al
conformismo. Viviamo un mondo in cui siamo allo stesso tempo attori e registi di
una enorme sinfonia pervasa dal politicamente corretto tanto che per
rintracciarne gli echi non dobbiamo fare molta fatica. Basta soffermarsi sugli
accadimenti più banali, sui fatti di cronaca o di costume, sul linguaggio della
politica o dei media. È sufficiente indugiare con animo libero su ognuno di essi
per rendersi conto quanto sia difficile farne a meno. “Luigi Iannone, scrittore
non allineato dalle frequentazioni raffinate, con questo libro ci accompagna nei
sentieri poco battuti, lontani dal politicamente corretto. L’autore si propone
di ricostruire un mosaico ‘differente’ tra presente, passato e futuro, per
ribaltare schemi, épater le bourgeois, non facendo concessioni alla morale
comune, ordinaria, canonica, maggioritaria nell’establishment e nell’immaginario
collettivo progressista.” dalla prefazione di Michele De Feudis.
Alcune anticipazioni
de L’ubbidiente democratico <<(…) incantatori di serpenti, teologi del buonismo
e della correttezza politica sono la stragrande maggioranza e condizionano la
formazione delle coscienze. Da parte loro c’è un’ossessione continua perché, in
genere, il politicamente corretto si compone di fantasmi che si agitano al solo
proferire delle ovvietà: provate, provate a dire che Cécile Kyenge è stata fatta
ministro per il colore della sua pelle; che le quote rosa (e, in subordine, le
donne capolista) sono una stupidaggine, oltre che una forma di razzismo al
contrario; che al Ministero delle Pari opportunità ci va sempre una donna per
fare la foglia di fico; che Rosario Crocetta fece una campagna elettorale
costruita anche sul fatto che in una terra ‘arcaica’ come la Sicilia si
presentava a Governatore un omosessuale, mentre delle proposte programmatiche si
sapeva poco o nulla; provate a dire che i milioni gettati via per liberare
ostaggi italiani in Paesi a rischio potrebbero servire per il nostro welfare e
coloro i quali (o le quali) girano in zone di guerra come novelli San Francesco
e pudiche Santa Chiara, potrebbero qualche volta passare anche dalle mie parti,
nella zona bassa dello Stivale. Troverebbero in tante zone del Sud gli stessi
problemi e tanto, ma proprio tanto, da fare per poveri e diseredati. Provate a
dire io non sono Charlie Hebdo, perché per quanto rispetti la satira e mi
risultino ripugnanti le azioni terroristiche e bestiali le loro idee, faccio
fatica ad essere blasfemo contro qualunque Dio. Provate a dire queste e tante
altre banali verità, e vi subisseranno di ingiurie. Verrete subito cacciati dal
consesso civile e additati nella migliore delle ipotesi come degli intolleranti.
Ma provate a dirle voi. A me manca il coraggio e non le dirò>>.
Libri. “L’Ubbidiente
Democratico” di Iannone: per distinguersi dalla ridente polis dei corretti,
scrive il 20 settembre 2016 Isabella Cesarini su "Barbadillo". Si spalanca con
un’affermazione di Carmelo Bene, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show
– 1994, l’ultimo libro dello scrittore Luigi Iannone. Corsivo che diviene
principio guida dell’opera L’Ubbidiente Democratico, nell’esergo del genio
salentino: “Non me ne fotte nulla del Ruanda. E lo dico. Voi no. Non ve ne fotte
ma non lo dite”. Si tratta di una dichiarazione, all’interno della quale non si
trovano i caratteri di quel “corretto” che attualmente siamo tutti obbligati a
indossare. Iannone si inoltra all’interno di un campo minato che pochi hanno
l’ardire di calpestare. Il suo soliloquio si fa dapprima parola e poi pagina
scomoda, poiché lontana da quello spazio così abusato e gremito del
politicamente corretto. Una città immaginaria solo nel nome, zeppa di tante
bravissime persone, altrettanti buoni propositi, tutti così realizzabili, ma
solo nell’evanescenza dell’incompiuto. E guai a non pensarla come gli abitanti
di questa ridente città: marchio d’infamia e foglio di via. In assenza di
cotanto calore, l’apolide si ritrova rapidamente isolato, ma certamente sereno
in compagnia di quelle idee ritenute così scomode. Pensieri come lampi; zampilli
che attraversano anche gli autoctoni della lieta cittadella, ma restano
sconvenienti e dunque la scelta ricade sulla comodità di restare distesi sul
proprio personale divano del tacere. E rimanendo nel tema morbido del salotto,
lo stesso scrittore confessa il suo – e non solo – incubo ricorrente. La vicenda
onirica si svolge nel salotto più famoso e corretto d’Italia: la casa immacolata
di Fabio Fazio. Cortese sino alla nausea, accogliente nelle ospitate degli
abitanti della città ubbidiente: Fiorella Mannoia, Corrado Augias che in un
altro alloggio ancor più confortevole illumina d’immenso Piergiorgio Odifreddi e
Federico Rampini. Ancora un passaggio sull’agiata villa di Lilli Gruber che
invita Roberto Vecchioni, Jovanotti e compagnia lealmente cantando. Un
ripiegamento onirico, nello specifico meglio noto come incubo, dove i buoni e i
giusti si avvicendano nelle notti turbate dello scrittore. Al risveglio, il
tedio risulta meno onirico, ma ugualmente corposo. Quello di Iannone è un
percorso che svela acutamente molte annose questioni e ripetuti meccanismi. Il
cantante Simone Cristicchi è uno di quei casi, che da un certo punto in poi,
entra di diritto nella categoria dei ripudiati dagli ubbidienti. Portando in
scena lo spettacolo dal titolo Magazzino18, legato all’ostico argomento dei
martiri delle foibe e il dramma degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia,
Cristicchi si fa velocemente indegno della residenza sotto la volta dei
corretti. All’esterno di un tale phanteon di purezza, lo scrittore Iannone
colloca una figura leggendaria che trattiene tutti i caratteri del mito: Hiroo
Onoda. Non come l’icona di un eccesso idealistico, quanto la delicata e
meritevole descrizione di una creatura, che da lontano, si rivolge direttamente
alla nostra voce interiore. Accade in questo piccolo uomo, un’espressione
dell’onore nell’aderenza a quella meravigliosa forma di amor patrio, stimato
malamente come espressione desueta e oltremodo scorretta. Diverso il discorso
per i nostri Presidenti della Repubblica, tutti, da un momento storico in poi,
cittadini onorari della cittadella corretta. Non più latori del potere
temporale, ma cavalieri senza macchia, custodi eterni del potere spirituale.
Figure immacolate con vite prive di umani buchi neri: coerenza e sacralità.
Dunque papi e non capi di Stato in odor di santità e non in tanfo di muffa.
Iniziato dallo storico revisionista Ernst Nolte, allo spirito critico che si fa
maniera di voler scomporre e sezionare anche il più ameno dei luoghi comuni,
Iannone procede come un bulldozer verso le considerazioni scolastiche. Con uno
sguardo nostalgico a quella che ritiene l’ultima degna del nome di riforma,
nella persona di Giovanni Gentile, opera una non poco interessante distinzione
tra scuola come istituzione e studio. Non necessariamente le due cose
coincidono. L’autore stesso, si dichiara tanto avverso alla scuola, quanto
devoto all’apprendimento e all’approfondimento. Caratteristica che si dovrebbe
considerare virtù, anche in merito al fatto di essere stata patrimonio di molti
nomi altisonanti. A fronte del fatto che personalità come Croce e Prezzolini non
raggiunsero l’incoronazione in pianta di alloro, attualmente presunti rapper,
assolvono il ruolo di oracolo. Il reietto dell’arcadica cittadella
dell’ubbidiente, raggiunge l’apoteosi della sua posizione in una più che
scontata affermazione: “Chi sbaglia, paga”. Un coro di indignati si leva davanti
a una dichiarazione così poco chic, qualunquista e fuori da ogni apericena. E
anche se il profano proclamatore, circoscrive il suo pensiero nella premessa,
che alcuno deve essere trattato in maniera deprecabile, non risulta comunque
socialmente accettabile. Ed è proprio in tale incrocio tra la tolleranza a
oltranza e la volontà di ridurre al minimo gli effetti di ogni dramma che le due
strade si confondono, sino ad annullarsi all’unisono. Al contrario, accolti con
una certa deferenza sono coloro che Montanelli sintetizzava nel termine
“firmatari”. Una categoria numerosa che pone la sua firma ovunque, contro o in
favore, poco importa. L’atto apprezzabile prescinde la causa e premia l’atto:
l’autografo. Nell’Eden degli ubbidienti, persino il tempo è differente: l’unico
imperativo è nella rapidità. Elemento imprescindibile che qualifica ogni tipo di
legame sentimentale, amicale o lavorativo. Ogni traccia di sequenzialità,
qualsiasi tratto di gradualità, necessari alla civiltà, vengono prontamente
inghiottiti dalla velocità che svilisce il naturale processo di crescita
identitaria e comunitaria. L’autore ci porta, non privo di un tono amaro,
finanche all’interno delle rovine di Pompei. Non vi è modo di uscire da
un’impasse dove si gioca al rimbalzo di responsabilità tra ministri,
soprintendenti, sotto, di lato o ad angolo, se non mediante un paradosso.
Singolarità, che si dispiega nella sopravvalutazione di alcuna arte
contemporanea, a scapito di meraviglie antichissime e intramontabili. Alla
bellezza che naturalmente affascina, l’esempio in un’emozione provata di fronte
alla grandezza di un Caravaggio, si preferisce cercare il significato ancestrale
di un ortaggio steso a terra in qualche galleria d’arte nel mondo. Allora, il
trionfo appartiene a quel lato deteriorabile, che si elegge a tutto, con le
virgolette di occasione intorno alla parola arte. Nell’incontaminato mondo degli
ubbidienti, lo scrittore ci guida altresì, nella spiegazione dell’uso di una
certa tipologia di linguaggio. Il mansueto democratico adopera una lingua che si
esaurisce tutta nel trionfo della premessa. Un’epifania che accoglie qualunque
argomento, puntualmente preceduto da un mantra, una sorta di nenia: “premesso
che non ho nulla contro…”. Un noiosissimo preambolo che scagiona preventivamente
da qualsiasi accusa, eccezion fatta per quella di viltà. Poiché non vi è mai
l’ardire e/o semplicemente l’onestà di dire ciò che intimamente si pensa. Troppo
rischioso, eccessivamente inelegante e dannoso sino alla cacciata dal borghetto
della compostezza. L’opera di Luigi Iannone figura un invito alla riflessione,
all’ascolto di una voce dissenziente come arma di difesa dallo smottamento di
informazioni che quotidianamente ci cade indosso. Un sovraccarico di notizie,
dove difficilmente si trova la bussola per l’orientamento. Se risulta poco
agevole farlo nelle strade, almeno si provi un tipo di ribellione, forse più
adatta alla nostra società; insorgere verso quella diffusa e prepotente forma di
conformismo che si fregia nel vezzo del mascheramento anticonformista. Lo
spirito libero all’interno di una cittadina tutta edificata sulla compostezza
democratica, tende ad apparire alla stessa maniera dello zio pazzo
in Amarcord di Federico Fellini, nella splendida interpretazione di Ciccio
Ingrassia. Iannone ci dona un sapiente parallelo cinematografico per descrivere
la considerazione che abbraccia coloro che provano a non appiattirsi sulla
melassa perbenista: i matti del paese. E se l’autore apre in Carmelo Bene, chi
scrive si permette – solo dopo aver sollecitato la lettura di questo pungente
pamphlet – di usarlo in conclusione da un estratto del Maurizio Costanzo Show –
1995: “Qualcuno ed era davvero anche lui un genio, ha detto che la democrazia è
il popolo che prende a calci in culo il popolo, su mandato del popolo”.
Ecco come distruggere il
politicamente corretto,
scrive l'1/11/2016 “Il Giornale”. Ci voleva qualcuno che lo scrivesse e Luigi
Iannone lo ha fatto: “provate a dire banali verità, e vi subisseranno di
ingiurie. Verrete subito cacciati dal consesso civile e additati nella migliore
delle ipotesi come degli intolleranti”. L’idea del giornalista e scrittore,
frequentatore abituale del pensiero di Jünger e amico personale del defunto
Ernst Nolte, è balenata a molti, ma ci voleva il suo libro per esprimerla
appieno. Il titolo è L’ubbidiente democratico. Come la civiltà occidentale è
diventata preda del politicamente corretto (Idrovolante Edizioni, pp. 138, Euro
13) e spiega come “incantatori di serpenti, teologi del buonismo e
della correttezza politica sono la stragrande maggioranza e condizionano la
formazione delle coscienze”. E via con esempi eclatanti su cose che tutti sanno
ma è meglio tacere, per non rischiare gli insulti di cui sopra. Quindi, vietato
dire che la Kyenge è diventata ministro grazie al colore della sua pelle, che le
quote rose sono una forma di sessismo alla rovescia, un contentino da dare alle
donne, un po’ come piazzare un filo di perle su un severo gessato da ministro.
Guai a dire che certi delinquono, perché Caino non si tocca e se Abele se la
passa male sono fatti suoi: i criminali vanno capiti. Guai a toccare il capo
dello Stato, che pare il Santo Patrono del politicamente corretto. Che di questo
si tratta, e basta. Di una dittatura soft, che ha messo da una parte i buoni e
gli intelligenti – ossia gli ubbidienti al credo unico imposto dalla vulgata
radical chic – e dall’altra i cafoni, gli ignoranti, gli imbecilli, i puzzoni.
Ossia, quelli che provano ancora a ragionare con la propria testa e non si
lasciano influenzare. L’importante, però, è tacere. Per non fare la fine degli
abitanti di Gorino i quali, non avendo voluto gli immigrati, sono i mostri del
momento. Quelli di Capalbio, che pure non li hanno voluti, invece se la sono
cavata. Chissà perché… ma questa, in fondo, è tutta un’altra storia.
Questo libro è un catalogo
delle opinioni vietate dal politicamente corretto.
Pensate di essere liberi di
esprimervi come vi pare? Provate a esporre tesi anticonformiste durante una
cena, scrive Alessandro Gnocchi, Domenica 29/05/2016, su "Il Giornale". La
libertà d'espressione è meravigliosa e noi tutti siamo convinti di poterla
esercitare. Fino a quando scopriamo che le cose non stanno esattamente così.
Infatti, per chi professa certe idee, non incendiarie ma comunque non allineate
al pensiero unico, c'è la riprovazione del mondo culturale, che si esprime in
due modi: il silenzio e l'insulto delegittimante. In libreria domina ormai il
Saggio Unico, figlio del Pensiero Unico. È solare: su alcuni temi si può parlare
in un solo modo, quello prescritto dal politicamente corretto. L'islam? È una
religione di pace. Il libero mercato? Il vero responsabile di tutte le
ingiustizie del mondo. L'accoglienza indiscriminata degli immigrati? Un dovere
morale e una necessità per sostenere l'economia del Vecchio continente. A
proposito, l'Europa? Una magnifica istituzione senza la quale saremmo ancora più
poveri e perpetuamente in guerra come nel XX secolo. L'appartenenza al genere
maschile o femminile? Uno stereotipo culturale da superare. Avere figli? Un
diritto. L'adozione alla coppie omosessuali? Un diritto. L'eutanasia? Un
diritto. Tutti abbiamo diritto a tutto. Abbiamo perfino diritto a dire che le
cose elencate, o almeno alcune di esse, non ci trovano d'accordo. Ma se lo
esercitiamo, ecco il nastro adesivo sulla bocca per impedirci di parlare e le
accuse infamanti: ignorante, xenofobo, razzista, islamofobo, omofobo. Non se ne
potrebbe almeno parlare, confrontarsi, dibattere? In teoria, sì. In pratica, no.
Se non ci credete, guardate lo spazio occupato dalle idee anticonformiste nelle
librerie, nei programmi televisivi, nei festival, nei convegni. È prossimo allo
zero. Per questo, il libro di Camillo Langone "Pensieri del lambrusco. Contro
l'invasione" (Marsilio, pagg. 180, euro 16; in libreria dal 3 giugno) è
un'autentica rarità. L'autore, firma de il Giornale, mette in fila tutte le
ideologie che considera rovinose per se stesso e per l'Italia. Ne esce un
catalogo delle opinioni vietate dal politicamente corretto. Langone, spesso
partendo dalla notizia di cronaca, a volte di cronaca culturale, colpisce senza
paura proprio nei punti più controversi, e ci mostra che quando un'idea, perfino
buona, viene trasformata in ideologia, produce disastri. Nel mirino ci sono i
nuovi -ismi: l'ambientalismo, l'americanismo, l'animalismo, l'estinzionismo,
l'esibizionismo, l'europeismo, l'immigrazionismo, l'islamismo... Pagina dopo
pagina, gli intellettuali che vanno per la maggiore sono ferocemente dissacrati
(vedi il teologo-non teologo Vito Mancuso alla voce ateismo). Al loro posto,
autori che insegnano a pensare: Guido Ceronetti, Sergio Quinzio, Michel
Houellebecq e altri. Cosa c'entra il lambrusco del titolo? Di fronte alla
liquidazione dell'Italia, meglio rifugiarsi «nell'unico vero vino autoctono
italiano» invece di ricorrere a «dozzinali vitigni alloctoni». Già, perché alla
fine, il libro di Langone si e ci interroga su cosa significhi essere italiani
ai nostri giorni. Per i nichilisti, nulla. Ma Langone non è un nichilista.
Dalle bandiere rosse ai
dogmi del politicamente corretto,
scrive Carlo Lottieri, Domenica 23/10/2016, su "Il Giornale". Quando crollò il
muro di Berlino, in molti furono portati a pensare che l'età del socialismo
fosse alle spalle e che il materialismo storico fosse destinato a finire nella
spazzatura della storia. In parte, le cose sono andate così, se si considera che
l'Unione sovietica si è dissolta velocemente, che la Cina è cambiata in
profondità, che ormai gli ultimi fortini di quell'ideologia sono nelle mani di
fratelli o nipoti di quelli che un tempo furono leader carismatici: da Fidel
Castro a Kim Il Sung. Eppure il comunismo resta onnipresente, dato che larga
parte della cultura contemporanea è pervasa da quella visione del mondo che
ancora oggi esercita un potente influsso sulle categorie che utilizziamo per
interpretare la realtà: sia nell'establishment di sinistra, sia nel populismo di
destra. È sufficiente pensare al trionfo dello stupidario ecologista. È
sicuramente vero che si farebbe fatica a trovare, nel pensiero di Karl Marx
(proiettato verso il futuro e volto a esaltare il progresso industriale) una
qualche legittimazione dell'ambientalismo dominante e delle nuove parole
d'ordine: animalismo, coltivazione biologica oppure «chilometro zero». Eppure il
legame tra il vecchio socialismo ottocentesco e questa nuova sensibilità è
chiaro, poiché in entrambi i casi tutto si regge sulla condanna della società di
mercato. Anche autori che oggi - a ragione - vengono considerati «di sinistra»
(da John Maynard Keynes a John Rawls), definirono le proprie tesi alla ricerca
di un'alternativa moderata e in qualche modo ai loro occhi «ragionevole» tra la
pianificazione e il laissez-faire, tra l'egualitarismo assoluto e l'ineguale
distribuzione conseguente alla lotteria naturale e allo svilupparsi degli
scambi. Oggi il marxismo non ha più il peso che aveva quando Bertolt Brecht,
Herbert Marcuse o Louis Althusser dominavano la scena culturale, ma le
tradizioni ora egemoni si sono definite nel confronto con quelle idee e muovendo
dall'esigenza di dare loro una risposta alternativa. Non c'è quindi da stupirsi
se il dibattito pubblico e spesso la stessa legislazione tendono a considerare
«ineguale» (e di conseguenza ingiusto) ogni rapporto contrattuale che abbia
luogo tra soggetti che hanno posizioni economiche differenti. Il nostro sistema
normativo - che prevede distinti diritti per i proprietari e per gli inquilini,
per i datori di lavoro e per i dipendenti, per i produttori e i consumatori,
ecc. - deriva il suo carattere fortemente discriminatorio dalla tesi secondo cui
un dominio dell'uomo sull'uomo non si avrebbe solo quando qualcuno aggredisce o
minaccia qualcun altro, ma anche quando due persone liberamente negoziano. Siamo
tutti in una certa misura comunisti perché siamo tutti imbevuti dell'idea che
una società dovrebbe eliminare le diversità, soddisfare ogni bisogno, innalzare
i nostri gusti e allontanarci dall'egoismo, impedire che taluno guadagni
miliardi e altri siano indigenti e senza lavoro. Non avremmo mai avuto alcuna
legittimazione della coercizione statale, quando è strumentale a modificare
l'ordine sociale emergente dalla storia e dalle interazioni sociali, senza il
successo del pensiero socialista e senza un intero secolo di riflessione
«scolastica» (con eresie, glosse e innesti di ogni tipo) attorno alle opere di
Marx. Se il nazismo è ovunque condannato senza «se» e senza «ma», ben pochi
esprimono la medesima riprovazione nei riguardi del socialismo: che pure ha
causato un numero di morti innocenti perfino superiore. E questo si deve al
fatto che le posizioni culturali mainstream sono in larga misura una revisione e
una rilettura di temi di ascendenza socialista. S'intende certamente seguire
altre strade, ma non è detto che gli obiettivi siano poi tanto diversi. Un dato
da tenere ben presente è che se il marxismo è stato certamente una teoria a
tutto tondo, sul piano storico-sociale esso è stato anche il catalizzatore di
spinte tra loro diverse, ma accomunate dal voler esprimere un rifiuto radicale
della realtà, identificata - a torto o a ragione - con la società capitalistica.
Con argomenti variamente comunitaristi, egualitaristi, ecologisti,
pseudocristiani e altro ancora, per molti anni gli spiriti rivoluzionari si sono
ritrovati sotto le bandiere rosse essenzialmente per esprimere il più radicale
rigetto delle libertà di mercato e di ogni ipotesi di un ordine
economico-sociale senza una direzione prefissata. E se oggi, come sottolinea
spesso Olivier Roy, circa un quarto dei terroristi islamisti francesi non ha
genitori musulmani né ha radici nei Paesi arabi, questo probabilmente si deve al
fatto che oggi il fondamentalismo incanala, in vari casi, un'analoga volontà
nichilistica di distruggere ogni cosa. Le stesse librerie ci dicono, anche
semplicemente osservando le copertine dei volumi in commercio, quanto il
comunismo sia vivo e vegeto. In effetti, il successo di autori come Thomas
Piketty, Naomi Klein, Thomas Pogge o Slavoj iek (solo per citare qualche nome à
la page) può essere compreso unicamente a partire da un dato elementare: e cioè
dal riconoscimento che l'Occidente è diviso al proprio interno da posizioni
diverse, ma quasi ogni famiglia culturale si concepisce quale profondamente
avversa alla proprietà, al libero scambio, all'anarchia dell'ordine spontaneo.
Quando si consideri pure il «politicamente corretto», con il suo corredo di
censure e proibizioni, è chiaro come si tratti in larga misura di una logica
strettamente connessa a quel risentimento che ha alimentato, sin dall'inizio,
l'egualitarismo socialista e la sua rivolta contro la natura. È chiaro che oggi
nessuno si propone di spedire i dissidenti in Siberia e di disegnare piani
quinquennali che governino dall'alto l'intera economia, ma il reticolato delle
regole approvate dalle assemblee parlamentari delinea un quadro complessivo
quanto mai illiberale: in cui si discrimina ogni libera scelta estranea al
luogocomunismo e si pongono le basi per una società sempre più servile,
assoggettata, priva di ogni capacità d'iniziativa. Carlo Lottieri
Bret Easton Ellis choc: il
politicamente corretto uccide la nostra cultura.
Lo scrittore americano e il critico Alex Kazami contro movimenti antirazzisti e
nazi-femministe, scrivono Andrea Mancia e Simone Bressan, Martedì 4/10/2016, "Il
Giornale". "Che diavolo è successo agli MTV Music Awards? Niente di inquietante
o scioccante, nessuna Miley Cyrus strafatta che insulta Nicki Minaj sul palco,
nessun tipo di provocazione e dunque nessun attimo di divertimento. Tutti
invece, vanno d'amore e d'accordo nel celebrare quella falsa inclusività
politicamente corretta che ormai è diventata terribilmente noiosa e che,
probabilmente, è la causa del vertiginoso crollo nel numero di telespettatori
che ha seguito lo show". A Bret Easton Ellis, lo scrittore americano autore (tra
l'altro) di Less Than Zero e American Psycho, l'edizione 2016 dei Video Music
Awards, organizzata lo scorso 29 agosto da MTV al Madison Square Garden di New
York, proprio non è piaciuta. E durante l'ultima puntata del suo podcast ha
letto integralmente un monologo del giovanissimo scrittore (e
critico-provocatore) canadese Alex Kazami che spara a zero contro gli eccessi
politically correct di una cerimonia ormai diventata un gigantesco spot per
«Black Lives Matter», il movimento finanziato anche da George Soros che accusa
le forze di polizia statunitensi di essere intrinsecamente razziste nei
confronti della comunità afro-americana. Kazami, che non incarna esattamente lo
stereotipo del vecchio trombone della destra conservatrice, visto che è un
millennial di 22 anni dichiaratamente gay, è ancora più feroce di Ellis. "Il
Black Lives Matter Sabbath che è stato rappresentato ai Video Music Awards 2016
rappresenta la fine della cultura per come la conosciamo. L'intero show è stato
un'ode alla narrativa liberal secondo la quale, visto che i bianchi sono tutti
cattivi, almeno una persona su due tra quelle inquadrate dalla telecamera deve
essere una donna di colore, perché siamo costantemente angosciati dalla
necessità di non terrorizzare una generazione di spettatori cresciuta con una
dieta di spazi di sicurezza, auto-vittimizzazione e trigger warning
(l'avvertimento che segnala la possibilità che un testo possa essere offensivo
per qualcuno, ndr)". Una scelta, secondo Kazami, totalmente ipocrita e dettata
soltanto da strategie commerciali: "MTV non vuole esporre il suo pubblico a un
immaginario pop pericoloso, per paura di offendere qualcuno, a meno che questo
immaginario non ricada sotto il mantello protettivo del politicamente corretto.
Ma la musica pop deve essere offensiva, non politicamente corretta". "La
maschera imposta allo show continua il giovane scrittore canadese è stata un
melenso tentativo di dipingere ogni artista sul palco come un campione di bontà,
indulgendo continuamente in riferimenti al movimento Black Lives Matter, alla
brutalità della polizia, a Martin Luther King. Questo era il copione, il dogma a
cui tutti hanno obbedito. Ed era palpabile il terrore che qualcuno potesse
esprimere un'opinione contraria al dogma. È proprio questo che sta uccidendo la
nostra cultura: la paura di essere puniti per non aver aderito integralmente a
questa ideologia collettiva del politicamente corretto". Il principale obiettivo
delle critiche di Ellis e Kazami, con ogni probabilità, è stata l'interminabile
performance di Beyoncé (vincitrice addirittura di otto premi), che nella sua
coreografia ha esplicitamente fatto riferimento agli afro-americani uccisi dalla
polizia (con i ballerini che crollavano al suolo dopo essere stati colpiti da
una luce rossa) e che sul red carpet ha sfilato insieme alle madri di Mike
Brown, Trayvon Martin ed Eric Garner, i tre uomini di colore che con la loro
morte sono diventati il simbolo di «Black Lives Matter» (e una scusa per la
guerriglia urbana scatenata dal movimento in molte città americane). Ellis, in
ogni caso, non è nuovo alle polemiche sugli eccessi del politicamente corretto e
dei social justice warriors. Ad agosto, sempre sul suo podcast, se l'era presa
con le "femministe isteriche" e "naziste del linguaggio" che avevano attaccato
il critico musicale del Los Angeles Weekly, Art Tavana, per un presunto articolo
"misogino" sulla cantante (e modella) Sky Ferreira. Per Ellis, queste femministe
di nuova generazione sono diventate "nonnine aggrappate alle proprie collane di
perle, terrorizzate dal fatto che qualcuno possa pensare qualcosa, su un
qualsiasi argomento, che non sia l'esatta replica delle loro opinioni". "Queste
piagnucolose narcisiste afferma Ellis utilizzano l'altissimo tono morale tipico
dei social justice warriors, sempre fuori scala rispetto alle cose per cui si
offendono. E si stanno trasformando in piccole naziste del linguaggio, con le
loro regole di indignazione prefabbricata, invocando la censura ogni volta che
qualcuno scrive, o dice, qualcosa che non aderisce completamente alla loro
visione dell'universo". "Questa sinistra liberal che si auto-proclama femminista
conclude l'autore di American Psycho è diventata così iper-sensibile da essere
ormai entrata in una fase culturale di autoritarismo. È qualcosa di così
regressivo e lugubre da assomigliare terribilmente a un film di fantascienza
distopica, ambientato in un mondo in cui è permesso un solo modo per esprimersi,
in un clima di castrazione collettiva che avvolge tutta la società".
Pro porno e pro
prostituzione: ecco il femminismo
di Annalisa Chirico in "Siamo tutti puttane", scrive “Libero Quotidiano”. "Siamo
tutti puttane". Un titolo spiazzante quello che Annalisa Chirico, giornalista e
compagna di Chicco Testa, politico di sinistra e dirigente industriale italiano,
ha deciso di dare al suo ultimo libro. Ma già se si legge il sotto titolo ci si
potrebbe fare un idea del concetto che sta alla base della lettura: "Contro la
dittatura del politicamente corretto". Un libro che ha come bersaglio i
perbenisti di sinistra e le femministe alla "Se non ora quando". La Chirico
rivendica il sacrosanto diritto di farsi strada nella vita come ognuno può e
vuole, e quindi, anche diventando una puttana. Un femminismo pro sesso, pro
porno e pro prostituzione, sia per le donne sia per i maschi. Un dibattito a suo
avviso che "ha diviso il Paese tra un popolo di sinistra moralmente
irreprensibile e uno di destra, gaglioffo e sciocco". In un'intervista
a Formiche.net del 7 maggio, la stessa giornalista alla domanda "È Berlusconi ad
averla ispirata?", non risponde esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. "Ho
seguito da cronista il processo Ruby - afferma Chirico - dove nel tribunale
di Milano, non di Riad o della Kabul talebana, trentatré ragazze sono state
vivisezionate nella loro vita privata in qualità di semplici testimoni, senza
alcun capo di imputazione a loro carico. Quando una democrazia smette di
distinguere tra peccato e reato, si getta al macero l'abc della civiltà
giuridica". Dunque nulla di male. Le famose "Olgettine", da Via Olgettina, le
ragazze indagate dalla Procura di Milano per il caso Ruby, non hanno, a suo
parere, la colpa di aver "conosciuto Silvio Berlusconi, il tycoon d'Italia, il
capo di un impero mediatico, il presidente del Consiglio italiano". Un'occasione
ghiotta di farsi notare e farsi apprezzare, per entrare nel mondo dell'apparire,
della tv e dell'estetica da vendere. "E' stato un pornoprocesso, un rito a
elevato tasso moraleggiante, oltre che erotico". Poi dal porno si passa
all'erotico e a quelle foto di Paola Bacchiddu, il capo comunicazione della
lista L’Altra Europa con Tsipras, che qualche giorno fa ha pubblicato una foto
in bikini suscitando clamore. "Mi è sembrata la trovata goliardica di una
ragazza intraprendente. In Italia ne sono nate le solite polemiche perché va di
moda l’idea boldriniana che il corpo vada nascosto in un sudario di pietra. Per
cui i concorsi di bellezza che si fanno in tutto il mondo da noi andrebbero
proibiti. La donna invece è un soggetto che decide come usare il proprio corpo,
sono le pseudofemministe a rappresentarla come un oggetto". Poi attacca Barbara
Spinelli, candida la paladina delle donne e della guerra contro la
mercificazione del loro corpo per Tsipras. "E' un esemplare del livello di
oscurantismo che caratterizza il femminismo nel nostro Paese. Sono le donne che
strumentalizzano le altre donne. La campagna talebanfemminista 'Se non ora
quando' aveva l’unico obiettivo politico di colpire l’allora presidente
Berlusconi, ci ha fatto credere che il suo indomito fallo fosse il principale
assillo delle donne italiane". Infine la frecciatina a Renzi incalzata dalla
giornalista di Formiche.net che gli chiede se la convince "il femminismo alla
Renzi": "Non esiste un femminismo alla Renzi - ha risposto la Chirico - ma una
strategia comunicativa renziana. Il premier ha capito che la sinistra del
presunto primato morale era perdente. Perciò si è abilmente smarcato dalla linea
dei suoi predecessori. E li ha rottamati".
Annalisa Chirico fra
femminismo e provocazione, scrive Benedetto Marchese su “Città della Spezia”.
L'autrice racconta a Cds il suo libro "Siamo tutti puttane" presentato anche
nella rassegna "I grandi temi" di Bocca di Magra: "Quote rosa? Solo se c'è
competenza". “Provocare significa sciogliere il proprio pensiero e lasciarlo
libero di muoversi e concepire qualcosa per noi e per gli altri. Nella società
di oggi c'è una cautela estrema che frena tutto questo”. Ospite nel salotto di
Bocca di Magra di Annamaria Bernardini De Pace e della sua rassegna letteraria
dedicata quest'anno proprio alla provocazione, la giornalista e saggista
Annalisa Chirico sintetizza così il filo conduttore della manifestazione nella
quale ha presentato il ultimo libro “Siamo tutti puttane” (sottotitolo “Contro
la dittatura del politicamente corretto”), senza distinzioni di genere e
ispirato dal Processo Ruby. “Seguendo le udienze – racconta a Cds la
collaboratrice di Panorama e Il Foglio – mi sono resa conto che l'imputato non
era più Berlusconi ma quelle ragazze le cui vita privata veniva vivisezionata e
giudica di fronte al grande moralizzatore pubblico. Era diventato un processo al
senso del pudore e il codice morale si stava sostituendo a quello penale, si
parlava solo di gusti sessuali. Il mio libro – prosegue – è invece un grido di
rivolta contro il moralismo e il politicamente corretto: ognuno ha il diritto di
scegliersi la vita che vuole, e di lavorare per realizzare i propri sogni, anche
rischiando di farsi del male”. Edito da Marsilio e pubblicato dopo i precedenti
“Condannati preventivi” e “Segreto di Stato – il caso Nicolò Pollari”, il libro
delinea anche il pensiero dell'autrice sul femminismo e il ruolo della donna
nella nostra società. “Ho concluso il mio dottorato con uno studio sul corpo
della donna – prosegue – e mi ritengo una femminista pro sesso, pro porno e pro
prostituzione: ciascuna di noi può sentirsi Madonna o puttana ma non deve
sottostare a delle regole. Sono critica verso le Taleban-femministe che hanno
fatto di quel processo solo una battaglia politica contro Berlusconi per poi
sparire subito dopo. Negli anni Settanta le femministe scendevano in piazza al
fianco delle prostitute, oggi troviamo una parte di quella sinistra sui palchi a
puntare il dito contro altre donne che ritengono degradate e che discriminano.
Un movimento che è diventato braccio armato della politica e che è stato
respinto, sempre nella stessa area, da coloro che quarant'anni fa avevano
lottato per i diritti delle donne. Si sono occupate delle “Olgettine” ma non
delle arabe o italiane che vivono segregate. Un problema che riguarda tutto
l'Occidente che non si preoccupa di tutelare ad esempio le eroine di Kobane che
vengono lasciate sole a combattere contro l'Isis”. Chirico, origini pugliesi e
romana d'adozione, non si sottrae poi ad un commento sull'episodio avvenuto
pochi giorni fa su una spiaggia di Fiumaretta con vittima una giovane ripresa
con il compagno in un video che ha girato sugli smartphone di mezza Val di Magra
ed è finito anche sui giornali. “Dobbiamo capire che le giovani d'oggi sono
molto più disinibite e se da un lato queste cose possono accadere normalmente,
dall'altro dovrebbe esserci un limite da parte di chi le pubblica o le
condivide”. Attratta fin da piccola dalla politica e con un passato fra i
Radicali di Pannella l'autrice rivela invece una distanza convinta dalla
militanza: “Ne sono stata interessata, ora la seguo solo per mestiere, ho votato
poche volte e mi sono astenuta sempre senza pentimento. Le quote rosa in
politica? Scegliere donne competenti è importante – conclude – farlo solo per
rispettare la parità è del tutto inutile”.
Chi è Annalisa Chirico, la
paladina del femminismo liberale. La giovane scrittrice e opinionista ha
pubblicato un libro dal titolo esplicito, “Siamo tutti puttane”, nel quale
polemizza contro il femminismo radical-chic di certa sinistra e invoca la
libertà per un nuovo femminismo, scrive I.K su "Gossip di Palazzo" venerdì 23
maggio 2014. 28 anni dalla penna tagliente, aspetto piacente che male non fa,
autodefinitasi “liberale, tortoriana, radicale” sulle pagine delle sue biografie
online, sul proprio sito personale e sul blog di Panorama "Politicamente
scorretta" che gestisce personalmente, dottoranda in Political Theory a alla
Luiss Guido Carli di Roma: Annalisa Chirico è una delle giovanissime
opinion-maker della carta stampata e dell’editoria digitale che stanno mettendo
a dura prova le giornaliste di una volta grazie ad una buona dose di
sfacciataggine e femminile tracotanza. Sulla sua pagina Facebook ci sono
moltissime foto con tutti i sostenitori e acquirenti famosi del suo nuovo
libro, …La giovane scrittrice e fidanzata di Chicco Testa si scaglia contro le
femministe post sessantottine. Autrice di due libri, uno contro l’abuso della
carcerazione preventiva “Condannati preventivi” e l’altro sul caso Niccolò
Pollari e i segreti di stato tra Usa e Italia, Annalisa Chirico è in questi
giorni sulla bocca della politica e del costume italiano per la pubblicazione di
un terzo libro dal titolo decisamente esplicito di “Siamo tutti puttane” nel
quale, come ha spiegato in un’intervista a Dagospia, rivendica il diritto di
ciascuno di farsi strada come meglio può senza dover per forza incappare in
trancianti giudizi operati sulla base della morale altrui. Nello specifico
mirino del libro della Chirico, lanciato in pompa magna anche grazie
all’appoggio una campagna mediatica via Twitter (#SiamoTuttiPuttane è l'hashtag
dedicato) con personaggi famosi quali cantanti, giornalisti provocatori
come Giuseppe Cruciani e svariate partecipazioni televisive, sono finite le
cosiddette taleban-femministe dell’intellighenzia di sinistra, guidate da
Lorella Zanardo di Se non ora quando e dalla presidente della Camera Laura
Boldrini: il libro, ha spiegato Annalisa Chirico, è nato proprio
dall’indignazione che le montava dentro durante il processo alle olgettine, le
ragazze prezzolate da Berlusconi per i famosi festini nella villa di Arcore
gestiti da Nicole Minetti. A ogni udienza m'incazzavo di più: quelle ragazze,
chiamate in qualità di testimoni, in realtà erano imputate, e non per reati del
codice penale, ma per i loro costumi privati. Quelle toghe stavano violando i
diritti di ragazze che avevano avuto la colpa estrema di accarezzare il potere
cercando di inseguire i loro sogni. Embé? Chi siamo noi per giudicare i sogni
degli altri? Le taleban-femministe giudicano. Annalisa Chirico ne ha per tutti,
specialmente per quello che lei chiama "il boldrinismo" della politica: Io sono
femminista, ma il loro è un femminismo perbenista che celebra il modello di
donna madre e moglie. Hanno restaurato il tribunale della pubblica morale. Il
berlusconismo non t'impone come vivere. Il pericolo del boldrinismo invece è che
vuole importi come vivere. E in merito alla sua relazione con Chicco Testa,
sessantaduenne ex presidente di Enel e giornalista su molte testate italiane?
Annalisa Chirico si riconferma sprezzante del giudizio altrui: Non è l’uomo più
vecchio con cui sono stata.
GLI ECCESSI DEL
POLITICAMENTE CORRETTO.
Cicciottelle non di può
dire, ma panciuti sì,
scrive Giordano Tedoldi su “Libero Quotidiano" il 9 agosto 2016. Che la faccenda
del politicamente corretto sia del tutto fuori controllo, e abbia prodotto l'
esatto opposto di ciò che voleva prevenire, e cioè livore, aggressività,
pretesto per giudicare sommariamente il «nemico» e inchiodarlo a una parola
diventata oscuramente impronunciabile, lo dice la furibonda polemica sulle tre
azzurre del tiro con l' arco, bravissime, ma che non sono riuscite a guadagnare
il podio alle Olimpiadi di Rio, cedendo alle russe, e le cui gesta il Resto del
Carlino, nelle sue pagine sportive, ha raccontato con il titolo «il trio delle
cicciottelle sfiora il miracolo olimpico». Ora, poiché viviamo al tempo della
pussy generation, come dice Clint Eastwood che ha coniato l' espressione in una
sua recente intervista a Esquire (scandalizzando tutti perché, sai che scoperta,
il vecchio Clint mostrava interesse per Donald Trump, ma dai, e noi che
pensavamo fosse kennediano tendenza Veltroni…) cioè «la generazione delle
femminucce» - e non staremo a spiegare o a difendere l' uso dell' espressione,
attendendo pazientemente i soliti geni, che ci diranno che offende le donne anzi
«il corpo delle donne» - allora ne consegue che «cicciottelle», riferito alle
tiratrici olimpiche, è «una vergogna», e che i giornalisti che hanno così
titolato sono responsabili della «morte di una professione», e che «sono da
pestare» perché «fanno schifo». Questi commenti, così civili, indice di elevato
pensiero e nobili sentimenti, sono alcuni nella nauseante marea di analoghi
insulti, partoriti dagli indignati del politicamente corretto, presi a casaccio
dalla rete, che ieri ne traboccava. E tutto perché l'anonimo giornalista - di
cui ora la rete pretende il nome, ché si deve pubblicamente umiliarlo, e
pretenderne scuse solenni, e casomai ottenerne anche la radiazione dall' ordine
professionale, provvedimento che gli indignati del web sollecitano ogni ora per
gli episodi più vari e contraddittori - ha detto che tre atlete sono
«cicciottelle». Occorre rammentare alla scatenata pussy generation, quella per
la quale, come dice Clint, «questo non si può fare, quello non si può dire,
quell' altro nemmeno» (tutti divieti stabiliti da loro, beninteso) che quattro
anni fa la rete non si scatenò affatto, per i «Robin Hood con la pancetta», come
vennero chiamati dai giornali i tre arcieri italiani, non propriamente smilzi,
che vinsero l'oro alle Olimpiadi di Londra. Allora, il fatto che i nostri
tiratori fossero «cicciottelli», com' è del resto abbastanza normale in una
disciplina dove non è richiesto il peso forma, semmai occhi di lince e grande
capacità di concentrazione, non destò scandalo alcuno. Soprattutto non destò
scandalo per gli arcieri, così come nulla hanno commentato, stavolta, le
tiratrici italiane. Allora, nessun giornalista fece schifo, né venne indicato
per essere pestato, né sotterrò la professione, né venne minacciato di
radiazione, né se ne pretese con voce stentorea il nome come fosse un nazista
imboscato da decenni. Come mai? Ma perché erano tre uomini. La pussy generation
ha questa idea che esistano delle categorie di «diversi», più sensibili, più
vulnerabili, che vanno curati come piantine stentate, anche malgrado i propositi
e le volontà delle stesse presunte «vittime». Sappiamo quali siano tali
categorie: gli omosessuali, i neri, i «migranti», le donne, in parte anche gli
islamici. Di questi non si può che dire e scrivere ogni bene. Qualunque epiteto
dal significato meno che esaltante, sia anche l'infantile «cicciottello» (ma
seriamente: chi può dirsi offeso, essendo adulto, perché viene definito così?)
mette subito colui che lo usa nei pasticci. E nel dire nei «pasticci» siamo
politicamente corretti, perché ciò che in realtà accade è che viene coperto da
una valanga di merda, escreta da loro, i buoni, i giusti, i politicamente
corretti, la parte avanzata della società, insomma, la pussy generation, che si
gonfia di boria grazie all' esibizionistica amplificazione e risonanza dei
social. Fortunatamente, c' è ancora chi non ha perso il senno, e per criticare
un titolo, criticabilissimo, ci mancherebbe, ricorre all' ironia, sottolineando
che ci vuol coraggio a definire «cicciotelle» tre donne che sanno scoccare
frecce con tanta precisione. Ma la media delle reazioni è l'insulto, la messa
alla berlina, la gogna virale, tutte procedure che il politicamente corretto usa
immancabilmente. E dunque ci chiediamo: come mai un esercizio critico così
barbarico, che usa sempre questi metodi di aggressione, il vile tutti contro
uno, viene tollerato? Perché accettiamo che il controllo sul linguaggio, nella
discussione pubblica, venga affidato all' isteria del «popolo della rete» in
quotidiana caccia di un capro espiatorio? Il quale popolo, altro che ricorrere a
un «cicciottello», quando parte all' attacco, pretende la testa del nemico.
Giordano Tedoldi.
Le "cicciottelle" divorano
il direttore. Ecco come l'hanno rovinato,
scrive “Libero Quotidiano” il 9 agosto 2016. Ha vinto il politicamente corretto,
ha perso il buonsenso a favore della boria che tracimava dai profili Facebook
per tutto ieri, dopo che era stato messo in giro il titolo del Quotidiano
sportivo, supplemento sportivo del Resto del Carlino, sulle tre atlete italiane
del tiro con l'arco, le "cicciottelle" che hanno portato a casa una medaglia di
bronzo. Con una nota da parte dell'editore del quotidiano, Andrea Riffeser
Monti, arriva il licenziamento in tronco del direttore del Qs, Giuseppe Tassi:
"L'editore - si legge - si scusa con le atlete olimpiche del tiro con l'arco e
con i lettori del Qs Quotidiano sportivo, per il titolo comparso sulle proprie
testate relativo alla bellissima finale per il bronzo persa con Taipei. Lo
stesso editore a seguito di tale episodio ha deciso di sollevare dall'incarico,
con effetto immediato, il direttore del Qs Giuseppe Tassi". L'atteggiamento più
dignitoso lo hanno avuto le tre atlete che non si sono volute intromettere nel
carnaio di polemiche sterili. Da parte degli indignati di professione un coro di
proteste sulla trita e ritrita questione del rispetto del corpo femminile,
portata a bandiera quando conviene, dimenticata solo in casi di avversari
politici da disintegrare. Chissà dove erano questi paladini del rispetto in
quota rosa quando si faceva carne da macello delle ragazze coinvolte nei
processi contro Silvio Berlusconi, giusto per citare un trascurabile caso
fenomenologico degli ultimi anni. A poco è bastata la nota di scuse con la quale
lo stesso direttore questa mattina aveva giustificato quel titolo, apparso tra
le altre cose nell'edizione di prima battuta, poi corretto in un'altra forma
nella successiva edizione. Ormai la palla di neve era diventata valanga, con un
il carico da novanta aggiunto dal presidente della Federazione italiana Tiro con
l'Arco, Mario Scarzella, che rivolgendosi proprio al direttore aveva
drammatizzato fino all'inverosimile: "Dopo le lacrime che queste ragazze hanno
versato per tutta la notte - aveva scritto Scarzella - questa mattina, invece di
trovare il sostegno della stampa italiana per un'impresa sfiorata, hanno dovuto
subire anche questa umiliazione". E l'umiliazione doveva essere lavata con un
colpevole da lanciare alla folla assetata di sangue. Di sicuro quel
licenziamento "con effetto immediato" avrà ridato dignità a tutto il genere
femminile.
Le «cicciottelle» e noi
ostaggi dell’ossessione dell’estetica,
scrive Beppe Severgnini su “Il
Corriere della Sera” il 9 agosto 2016. «Il trio delle cicciotelle sfiora il
miracolo olimpico» era un titolo sbagliato. Anzi, peggio: era un brutto titolo.
Ma se licenziassero tutti i giornalisti che hanno fatto un brutto titolo, o un
commento inopportuno, le redazioni sarebbero deserte. Di certo, il sottoscritto
non ci sarebbe. Anni fa, dopo averla incontrata, ho definito «cicciottina»
Scarlett Johansson (su Sette): ai miei occhi era un complimento, la ragazza era
uno splendido manifesto contro l’ossessione della magrezza. Oggi non lo
scriverei. Anche per questo a Giuseppe Tassi, l’autore di quel titolo, rimosso
dalla direzione del Quotidiano Sportivo, concederei l’attenuante della buona
fede: l’impressione è che, in modo un po’ datato, volesse vezzeggiare le ragazze
dell’arco dopo la bella prova di Rio. In fondo, molte testate hanno applaudito
Teresa Almeida, portiere della squadra di pallamano dell’Angola, 170 centimetri
per 98 kg («Fortissima, simpatica e portavoce dei “cicciottelli” di tutto il
mondo», Huffington Post, 7 agosto 2016). Domanda: non sono più offensive le
esternazioni di Matteo Salvini su Laura Boldrini, paragonata a una bambola
gonfiabile? Non sono più indelicati i giudizi di Marco Travaglio su Maria Elena
Boschi («Si occupi di cellulite, non di riforme»). Non sono più spiacevoli i
commenti di Vincenzo De Luca su Virginia Raggi («Bambolina imbambolata»)? Eppure
non risulta che sia partito il linciaggio virtuale. Meglio così, sia chiaro. I
titoli giocati sull’aspetto fisico sono figli di questo clima. E di certe
abitudini. Siamo onesti: dall’inizio delle Olimpiadi molte testate pubblicano, e
molti tra noi guardano, le scollature delle atlete e gli addominali degli
atleti. È un’estensione dell’insopportabile ossessione estetica che domina la
pubblicità, i media e la società; e tiene in ostaggio le nostre vite. I social —
gli stessi che oggi invocano la gogna per l’autore del titolo sulle
«cicciottelle» — godono a umiliare ogni personaggio per qualsiasi imperfezione:
dalla pelle di un’anziana cantante a Sanremo alla pancetta di Higuain
all’esordio con la Juve. Riassumendo. È inopportuno giocare sull’aspetto: il
collega Tassi ha sbagliato. Ma fra disapprovazione e linciaggio c’è un confine.
E ogni giorno viene superato, con euforica ipocrisia.
“Frocio” non si dice.
“Figlio di troia” sì,
scrive Francesco Merlo il 26 gennaio 2016 su "La Repubblica". Dunque “frocio”
non si può dire e “figlio di troia” sì? E “siciliano mafioso” non è razzismo,
mentre “zingaro di merda” lo è? E se fosse ridicolo tutto questo affanno del
perbenismo italiano nel compilare classifiche di legittimità dell’insulto? Non
si può infatti applicare il politicamente corretto all’ingiuria, non esiste
l’offesa sterile, non ci sono parolacce detergenti e anzi spesso il più turpe
vaffanculo, quando è lanciato sotto stress e non quando diventa progetto
politico, disinnesca il pugno. Le male parole come sfogo, come valvole
liberatrici durante uno scontro sul campo di gioco, o sulla strada o persino in
Parlamento, fanno muro ai ceffoni, disarmano gli istinti violenti, impediscono
le botte, sono l’unico modo di darsele di santa ragione senza farsi male. E
chissà se per Mandzukic è più offensiva la parola “zingaro” o la parola “merda”?
Ed è più politicamente scorretto Sarri, che ha dato del finocchio a Mancini,
oppure Mancini che aveva assolto se stesso quando aveva dato del “finocchio” ad
un cronista? E’ infatti una giostra il mondo del politicamente corretto. Basta
un piccolo cambio di scena e l’ingiuriante diventa ingiurato come nel film i
Mostri dove Vittorio Gassman, pedone sulle strisce, si indigna e si ribella
perché gli automobilisti, mentre gli sfiorano il sedere, gli gridano. E Gassman
incede su quelle strisce a passo volutamente lento e abusa dell’asilo politico
che gli offre il codice della strada: come Mancini, “ci marcia”. Ma poi quando
sale sulla sua cinquecento il mostro Gassman sfreccia su quelle stesse strisce
mostrando le corna ai pedoni. Più ancora della strada, lo sport è metafora di
guerra, la vita combattuta con altre armi, non la politica astrusa e neppure la
cultura dei privilegiati, ma il mondo dei sentimenti, materia forse non semplice
ma sicuramente selvatica: il mondo del turpe eloquio. E però Konrad Lorenz
tratterebbe De Rossi come uno dei suoi spinarelli e non certo come un razzista.
Anche Freud sorriderebbe dinanzi alle accuse di omofobia a Sarri. Per non dire
di Lévi-Strauss che si sentirebbe beato davanti a tanti selvaggi. Tanto più che,
con un formidabile testa-coda, il politicamente corretto avvelena anche i
selvaggi. Ieri, nelle tante trasmissioni radio, persino gli ultrà romanisti si
sono impasticcati di politicamente corretto e, dando vita alla figura ossimorica
dell’ultra per bene, dell’estremista formalista, per salvare il loro De Rossi
hanno solennemente stabilito che non essendo Mandzukic uno zingaro non può
sentirsi offeso dalla parola zingaro. Con questa logica se dici puttana a una
puttana la offendi, se invece lo dici a una signora, va bene. L’importante
infatti è non ledere i diritti della minoranza sfruttata (le puttane) anche a
costo dell’onore della maggioranza (le signore). Insomma sei un gran maleducato,
ma politicamente corretto; sei un vero facchino ma non sei un razzista.
Applicando questa logica anche all’ingiuriato, solo un frocio si arrabbia se gli
dicono frocio. Dunque se Mancini si arrabbia vuole dire che è frocio? La
giustizia sportiva, per trovare delle attenuanti a Sarri, ha accolto questa
stramba tesi degli ultrà e ne ha fatto una fonte di legge condannando
l’allenatore del Napoli a solo due giorni di squalifica, e per giunta in coppa
Italia, a riprova che la nostra giustizia sportiva coniuga le regole con
l’humus, la legge con gli umori, in nome del popolo italiano politicamente
corretto, vale a dire della curva sud che strologa di diritto, del bar sport
dove il tifoso-fedele si traveste da laico. Come si vede, il politicamente
corretto della plebe, che di natura è scorretta, è alla fine un pasticcio, è
l’innesto del birignao nella suburra. Come se Marione Corsi, l’ex terrorista dei
Nar, divo della più importante radio romanista (dice), conducesse “Che Tempo che
fa” al posto di Fabio Fazio. Infine c’è la televisione che amplifica e rende
caricaturale il politicamente corretto perché costringe a mentire, non conosce
sfumature, insegna a parlare con la mano davanti alla bocca e dunque a occultare
il corpo del reato, come ha ben spiegato ieri Spalletti, il nuovo allenatore
della Roma. Alla Camera dei deputati sono stati vietati per regolamento gli zoom
proprio per evitare la lettura del labiale e dunque le indiscrezioni
rivelatrici, le schermate dei siti porno visitati mentre si discute della
Finanziaria, l’ingrandimento del display del cellulare di Verdini terminale di
traffici e commerci, le parolacce dette e scritte nei pizzini che gli onorevoli
si scambiano tra loro. E certo non ci piace che sia stata oscurata la casa di
vetro della democrazia. Ma una vota Dino Zoff raccontò che dovendo subire un
rigore, il suo allenatore Trapattoni gli impartì un ordine in forma di
consiglio: buttati a destra perché quello lì calcia i rigori sempre sulla
destra. Al momento del tiro, Zoff per istinto avrebbe voluto andare a sinistra,
ma prevalse l’obbedienza al Mister. Fu gol. E Zoff scomodò il cielo con una
bestemmia e con un insulto secco e forte contro Trapattoni. Lo avesse ripreso la
televisione, Zoff sarebbe passato alla storia del calcio come un insolente e un
blasfemo, nemico di Dio e del proprio allenatore. Ecco dunque l’ultimo pasticcio
del politicamente corretto: la televisione condanna alla trasparenza che però
tanto più sembra fedele quanto più è infedele perché travisa mentre mostra,
deforma mentre informa. E’ allora meglio nascondersi al politicamente corretto?
Oppure è meglio comportarsi come profetizzava Italo Calvino? Conosco un
omosessuale che vive in un piccolo paese e che all’insulto “frocio”, che ogni
tanto gli capita di subire, reagisce con orgoglio.
Insultare una fascista
(incinta) non è reato,
scrive Gian Marco Chiocci il 2 febbraio 2016 su “Il Tempo”. Giorgia Meloni non
ha bisogno di avvocati d’ufficio, la conoscete, sa difendersi da sola. Ma quel
che la fogna di internet le sta vomitando addosso dopo l'annuncio del bebè in
arrivo, imporrebbe una risposta dura e bipartisan che a distanza di 48 ore
ancora non s'è vista. Madri, padri, figli di, parenti prossimi o trapassati: di
insulti familistici la politica si alimenta ogni giorno ma non se n'erano
sentiti rivolti a un feto. I cultori della doppia morale, della superiorità
intellettuale, culturale ed esistenziale, ci regalano sovente perle di ironia
che a parità di sarcasmo, se rivolte a un'immigrata, una lesbica, una politica
di sinistra, scatenano reazioni veementi, rimostranze parlamentare, raccolte di
firme e sit-in in girotondo. Prendete la Boldrini. Impegnata com'è a far
rispettare l'articolo determinativo femminile, "la" presidente della Camera ha
espresso solidarietà all'ex ministro solo quando Fabio Rampelli (l'ombra lunga
di Giorgia) ha evidenziato la sua partigianeria nell'esprimere solidarietà solo
a chi non la pensa come la leader di An. Va detto che anche le politicanti di
centrodestra si sono fatte riconoscere. Hanno tergiversato fino a quando non s'è
mossa la Carfagna, dopodiché qualcuna ha preso coraggio e s'è indignata.
Insomma, se la Bindi è più bella che intelligente, giustamente il mondo
s'indigna con Berlusconi. Ma guai a scandalizzarsi se esponenti democratici
condividono su facebook Madonna Meloni che concepisce senza peccare oppure
ritwittano quel gentiluomo di sua sobrietà di Vladimir Luxuria che cinguetta
sperando di tramandare la specie («auguri e figli trans»). Ti sentirai
rispondere che è satira, sarcasmo, ironia. Ma sì, minimizziamo. Ridimensioniamo
l’accaduto. Lo facevano anche i katanga dell’autonomia operaia quando
sprangavano i missini e si difendevano così: «Uccidere un fascista non è reato».
Un orrore sul sito
dell'Annunziata: giusto insultare il figlio della Meloni,
scrive “Libero Quotidiano” il 3 febbraio 2016. Sull'Huffington Post di Lucia
Annunziata un intervento di rara violenza contro Giorgia Meloni. A firmarlo
è Deborah Dirani, che si definisce "donna, prima. Giornalista, poi". Nel mirino
la leader di Fdi-An, bersagliata da insulti e sfottò dopo aver rivelato di
essere incinta. E la signora Dirani, de facto, spiega che la Meloni si merita
questo tipo di linciaggio. Chiarissimo l'attacco del suo articolo: "Giorgia
Meloni è incinta. Giorgia Meloni è una delle responsabili della degenerazione
della politica del mio Paese. Di quella politica fatta di esclusione, di
negazione dei diritti, di slogan populisti e di intolleranze culturali". Dunque,
la Dirani aggiunge che la Meloni "è incinta e io sono ben contenta, dico sul
serio". E subito dopo riprende a manganellare: "Ma la gravidanza non fa di lei
una persona migliore, non la trasforma magicamente in una donna aperta al
diverso da sé. Resta esattamente quella che è e raccoglie esattamente quello che
tanto si è prodigata a seminare: intolleranza". Insomma, l'intolleranza raccolta
dalla Meloni in questi giorni - ricordiamolo: insulti e sfottò al nascituro,
qualcosa di vergognoso che non c'entra nulla con la politica - sarebbe dovuta
alla presunta intolleranza del personaggio Meloni. Quale intolleranza? Si
suppone il sostenere politiche di destra, una roba che la signora Dirani non può
tollerare, tanto che nello stesso, improponibile e violento, commento si spinge
a scrivere: "Buona gravidanza, Giorgia Meloni e... Speriamo che sia femmina
(volevo aggiungere anche comunista!)".
Mancini e il politically
correct che tarpa le ali alla libertà d'espressione.
Froci, zingari, clandestini e handicappati non esistono più. La "neolingua"
impone gay, rom, migranti e diversamente abili e ora invade anche i campi di
calcio, scrive Francesco Curridori, Mercoledì 20/01/2016, su "Il Giornale".
“Sarri è un razzista, uomini come lui non possono stare nel calcio. Mi son
alzato per chiedere al quarto uomo del recupero. Lui ha iniziato ad inveire
contro di me, dicendo ‘frocio e finocchio’ Sono orgoglioso di esserlo se lui è
un uomo. Persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà
mai. Ha 60 anni, si deve vergognare”. Con queste parole Roberto Mancini rischia
di inguaiare Maurizio Sarri. I due allenatori hanno avuto un brutto battibecco
al termine della partita di Coppa Italia e l’insulto scappato al coach del
Napoli rischia di costargli caro. Secondo le norme della Figc chi ha “stop "un
comportamento discriminatorio e ogni condotta che comporti offesa per motivi di
sesso" rischia
quattro mesi di squalifica che andrebbero scontati anche in campionato. Mancini
ha rotto la regola aurea del calcio che può essere riassunta con la frase di un
celebre film: “ciò che avviene dentro il miglio verde rimane dentro il miglio
verde” e così il web si è diviso su Twitter tra chi scriveva #iostoconMancio e
#iostoconsarri. Siamo all’apoteosi del politicamente corretto. Fabrizio
Marrazzo, portavoce di Gay Center ha chiesto un incontro con il presidente del
Napoli, Auelio De Laurentis e Carlo Tavecchio, presidente della Figc perché “uno
sport così popolare non può permettersi messaggi di violenza". Siamo sicuri che
molti di questi benpensanti di sinistra che si indignano per un “frocio”
scappato in un campo di calcio, dove gli insulti e le bestemmie sono di casa,
sono scesi in piazza a difesa della libertà d’espressione quando l’Isis ha fatto
la strage di Charlie Hebdo. Fintanto che si insulta la Chiesa cattolica o
qualcuno dipinge un Gesù Cristo immerso nella pipì tutto va bene ma se si dice
frocio, zingaro, clandestino, cieco o handicappato allora apriti cielo. Nella
neolingua dei benpensanti frocio deve chiamarsi “gay”, il clandestino
“migrante”, cieco diventa "non vedente", zingaro “rom” e l’handicappato si
trasforma in “diversamente abile”. Come se anche i cosiddetti “normodotati” non
siano diversamente abili tra loro. Non tutti gli uomini “comuni” hanno le stesse
abilità e anche chi non è in sedia a rotelle, nella maggior parte dei casi, ha
abilità diverse se messo a confronto con Rocco Siffredi e Stephen Hawking. Chi
vive in sedia a rotelle, chi non vede o chi non sente è, invece, portatore di
uno o più handicap, ossia di svantaggi cui non si è ancora è posto il giusto
rimedio con un adeguata opera di abbattimento delle barriere architettoniche.
Eppure la sinistra cosa si accinge a fare? Una proposta di legge per aumentare
le pensioni d’invalidità, al momento ferme a poco più di 200 euro? No, la
preoccupazione di Sel è quella di cambiare la dicitura “handicappato” in
“diversamente abile” dal testo di legge 104, come conferma al giornale.it da
Erasmo Palazzotto, promotore della proposta di legge che arriverà in Parlamento
presumibilmente a febbraio. Se si va avanti di questo passo si dovrà chiedere a
Iva Zanicchi di cambiare la sua canzone da “dammi questa mano, zingara” a “dammi
questa mano, rom”. Dire “frocio” fa scandalo proprio nel momento in cui il
governo depenalizza il reato di ingiuria tanto che persino Vittorio Sgarbi, per
protesta, ha abbandonato una trasmissione tivù senza insultare nessuno. A breve
sarà impossibile anche dare del “cornuto” all’arbitro. Preparatevi al marito con
una moglie “diversamente fedele”… Siamo alle comiche finali del politicamente
corretto.
Sarri e il solito coro del
"Politicamente corretto" a giorni alterni,
scrive "Il Piccolo D'Italia il 20 gennaio 2016. Fonte: Fabrizio Verde, Francesco
Guadagni e Alessandro Bianchi per L’Antidiplomatico. In occasione della partita
di calcio tra Napoli e Inter, valevole per la qualificazione alla semifinale
della Coppa nazionale, è entrata in azione la solita ipocrisia e doppia morale
di marca italica. Evento scatenante, un litigio tra i tecnici delle due
compagini calcistiche Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Quest’ultimo, allenatore
dell’Inter, nel dopo partita ha lanciato accuse di razzismo nei confronti del
tecnico toscano che allena la squadra partenopea, colpevole di averlo
apostrofato con i termini ‘frocio’ e ‘finocchio’. Per Maurizio Sarri, che
dichiara di non ricordare le parole esatte ma si è scusato a telecamere spente
nello spogliatoio dell’Inter prima dell’accusa mediatica di Mancini, si è
trattato di una caduta di stile, questo è fuor di ogni dubbio. Ma è l’intero
contesto di abnorme colpevolizzazione dell’allenatore del Napoli ad essere
oggettivamente fuori luogo. Innanzitutto bisogna ricordare che l’Italia è il
paese dove in occasione di ogni partita di calcio vengono gridati i più beceri
cori razzisti nei confronti della città di Napoli e dei suoi abitanti, nel
generale disinteresse di giornalisti e addetti ai lavori, che fanno a gara nel
minimizzare questi atti di razzismo, declassandoli a semplici sfottò da stadio,
senza tener contro del retroterra culturale che vi è dietro a questi slogan
beceri e razzisti. Si tratta degli stessi personaggi che da ieri cercano di
ergersi a improbabili moralizzatori del mondo del calcio. Si tratta, si sa, del
solito “politicamente corretto” creato ad arte. Che dire poi dello stesso
Roberto Mancini che si è precipitato ai microfoni della Rai a denunciare
indignato delle offese ricevute, dopo aver provato nello spogliatoio del Napoli
a venire alle mani con il tecnico toscano? Si tratta dello stesso Mancini che
nel 2000 intervenne in difesa del suo amico Sinisa Mihailovic, il quale aveva
definito il centrocampista dell’Arsenal Vieira un «negro di merda», con queste
testuali parole riportate dal quotidiano ‘La Repubblica’: «Nel corso di una
partita l’agonismo esasperato può portare a momenti di tensione e di grande
nervosismo. Credo che anche qualche insulto ci possa stare. L’importante è che
tutto finisca lì». Lo stesso Mancini che da allenatore del Manchester City
rischiò di finire alle mani con ben due suoi giocatori Adebayor e Tevez. Il
primo accusato di fingere un infortunio poi rivelatosi vero, il secondo per
divergenze tecnico-tattiche. Il litigio tra il tecnico di Jesi e l’attaccante
argentino trovò il suo culmine quando Mancini affermò nei confronti di Tevez
‘l’elegante’ frase «go fuck your mother». Insomma, il tecnico che ieri si è
tanto scandalizzato non ha nulla da invidiare alle tante teste calde che
popolano il calcio mondiale. In ultima analisi è curioso notare come quegli
stessi giornalisti che ieri si sono affrettati nel crocifiggere un allenatore
per un insulto proferito in un momento di grande concitazione e nervosismo,
siano gli stessi che da anni ignorano il più becero razzismo, le ruberie, i
macroscopici brogli e quant’altro accade nel mondo del calcio. E, infine, un
ultimo punto, il più importante perché non parliamo più di qualcosa attinente ad
un gioco, è curioso notare come quegli stessi giornalisti che ieri si sono
affrettati nel crocifiggere un allenatore per un insulto proferito in un momento
di grande concitazione e nervosismo, siano gli stessi che ignorano e tollerano
ogni giorno lo stupro di diritti, democrazia e della nostra Costituzione che
avviene ogni giorno. Lo stato in cui versa un’Italia sempre più schiacciata
della dittatura europea neoliberista dipende anche, e soprattutto, dal coro del
“politicamente corretto” dei bombardatori umanitari a giorni alterni.
Quella sinistra
"politicamente corretta" che da settant'anni deride e insulta i gay.
Togliatti offendeva
Gide mentre la rivista diretta da Berlinguer inseriva gli "invertiti" fra i
nemici di classe. Fino alle scivolate di D'Alema e Bersani, scrive Cristina
Bassi, Martedì 18/04/2017, su "Il Giornale". «A froci!», «finocchio»,
«culattoni», «checca squallida»: la destra, certo, si è spesso messa in
(cattiva) luce quando si è trattato di insulti omofobi e battute da trivio.
Post-missini e leghisti in testa. E se la Dc usa per decenni la maldicenza, pure
Beppe Grillo scivola su un «At salut, buson!», rivolto a Nichi Vendola dal palco
di Bologna (2011). Ma arrivano dalla sinistra progressista le invettive più
insidiose contro i gay. A volte vaghe: «È mollezza borghese». Altre dirette:
«Deviati», «pederasti», «invertiti». Altre ancora subdole: le unioni
omosessuali? «È mai possibile che i problemi dell'Italia siano questi?», si
chiede D'Alema nel 2006. «È meglio che un bambino cresca in Africa piuttosto che
con due uomini o due donne», dichiara un anno più tardi Rosy Bindi, madre del
ddl sui Dico. Dopo Stai zitta e va' in cucina, saga del sessismo a Palazzo, il
giornalista di SkyTg24 Filippo Maria Battaglia pubblica Ho molti amici gay - La
crociata omofoba della politica italiana (Bollati Boringhieri).
Partiamo dal dopoguerra. Nel
1950 Palmiro Togliatti sul mensile Rinascita si scaglia, sotto pseudonimo,
contro André Gide che si è ricreduto sul comunismo. A sentirlo parlare, sostiene
il segretario del Pci, «vien voglia di invitarlo a occuparsi di pederastia,
dov'è specialista». E un anno prima: «Se quando ha visitato la Russia nel 1936
gli avessero messo accanto un energico e poco schizzinoso bestione che gli
avesse dato le metafisiche soddisfazioni ch'egli cerca, quanto bene avrebbe
detto, al ritorno, di quel Paese!». Mentre il mensile della Fgci Gioventù Nuova,
diretto da Enrico Berlinguer, se la prende con Jean-Paul Sartre: «Un degenerato
lacchè dell'imperialismo, che si compiace della pederastia e dell'onanismo».
Riflette l'autore: il messaggio dell'apparato è che «tra i comunisti non c'è
posto per gli omosessuali, invertiti e pederasti (usati spesso come sinonimi)
sono solo gli avversari borghesi».
C'è l'espulsione dal Pci di
Pier Paolo Pasolini «per indegnità morale» nel 1949. Francesco Rutelli che nel
2000 da sindaco di Roma ritira il patrocinio al Gay Pride perché si tiene nei
giorni del Giubileo. E la reazione di Giancarlo Pajetta nella seconda metà degli
anni '80. A Botteghe Oscure nota facce nuove: «Incuriosito, si avvicina,
scoprendo che si tratta della prima delegazione gay accolta in via ufficiale
nella sede comunista. E prima le puttane, e adesso i finocchi si sfoga,
scuotendo la testa ma che c... è diventato questo partito?». Arrivando ai giorni
nostri, ecco la sinistra «diversamente omofoba». Nel 2009 Bersani manifesta
«forti perplessità» sulle unioni gay. È bene, spiega, regolare un fenomeno
cresciuto «a dismisura». Però «poi non è che lo chiamo matrimonio omosessuale
perché non sono assimilabili». Ancora: «È mai possibile che i problemi
dell'Italia siano i Pacs e la Tav?, si domanda nel 2006 l'ex premier Massimo
D'Alema (...). Prima di aggiungere, significativamente: Ci siamo fatti
incastrare a discutere di questioni marginali rispetto ai problemi del Paese».
Pochi mesi dopo aggiungerà che il matrimonio tra omosessuali «offenderebbe il
sentimento religioso di tanta gente». Nel 1995 aveva dichiarato: la coppia omo
non può «essere considerata una famiglia».
A sinistra la «tolleranza
repressiva» ha lasciato il posto al silenzio imbarazzato: «C'è una generazione
di gente brillantissima che viene dal Pci che non ha mai fatto coming out
racconterà nel 2012 la deputata dem Paola Concia Donne e uomini, personaggi di
primo piano di quel partito. Se avessero dichiarato pubblicamente la loro
omosessualità avrebbero fornito carburante alla sinistra». Non solo: «Alcuni
colleghi del Pd (...) ogni volta che mi vedono parlare con una donna, si
strizzano l'occhio e dicono che ci sto provando (...). Pregiudizi che trovano
conferma nel 2011 quando la deputata annuncia che si sposerà in Germania con la
compagna. Che si dice in questi casi?, le domanda Rosy Bindi». Infine Vendola
che confessa: «È stato forse più facile dire la mia omosessualità ai preti che
al partito».
Da Che Guevara a Orlando,
tutte le contraddizioni del mondo gay,
scrive Adriano Scianca il 14 giugno 2016 su “Il Primato nazionale”. Il 14 giugno
1928 nasceva a Rosario, in Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, destinato a
passare alla storia, col nomignolo di Che, per l’apporto dato alla rivoluzione
comunista cubana e per essere stato, dopo l’instaurazione del regime castrista,
uno dei suoi principali esponenti. Di lui si è detto e scritto tutto. Non è
neanche una novità sconvolgente quella per cui, nella visione guevarista
dell’uomo nuovo, non ci fosse posto per l’omosessualità: che il Che sia stato
l’artefice della creazione di veri e propri campi di concentramento per
omosessuali, in cui finirono anche molti simpatizzanti per la rivoluzione, è
cosa ben documentata. Eppure il brand guevarista va forte proprio in quei
settori che vorrebbero fare l’esame del dna a chiunque sia anche solo in odore
di “omofobia”. Beninteso, non vogliamo frettolosamente liquidare qui la
rivoluzione cubana con un giudizio piccolo-borghese limitato ai suoi “crimini”,
ma certo la contraddizione stride, e parecchio. Non è la sola, se restiamo in
campo “lgbt”: al recente gay pride di Roma, per esempio, sono stati fotografati
dei cartelli che inneggiavano al boicottaggio dei prodotti israeliani e alla
libertà della Palestina. Ben fatto, la causa palestinese gode di tutta la nostra
simpatia. Ma, anche qui, non si può non ragionare in punta di coerenza: Israele
è uno Stato estremamente gay friendly, cosa che è difficile dire della
controparte palestinese e del mondo musulmano in genere. È questo il motivo per
cui, dopo la strage di Orlando, il pensiero dominante è andato in tilt: un
musulmano, figlio di immigrati, che fa strage di gay. Come uscirne? Sel, in
Italia, ha risolto la questione, dando la colpa al fascismo, ma questa è
patologia psichiatrica e va lasciata quindi agli specialisti. Abbiamo detto del
gay pride: non è forse quella una contraddizione ambulante? Uno sfoggio
identitario per rivendicare diritti e uguaglianza. L’espressione di una
sottocultura trasgressiva per reclamare l’accesso al perbenismo borghese. Un
ostentato “siamo diversi da voi” per far capire alla gente “siamo uguali a voi”.
Ora, questo micro-viaggio che parte da Che Guevara e arriva non a Madre Teresa,
come la Chiesa immaginaria di Jovanotti, ma allo stragista di Orlando passando
per i carri chiassosi del gay pride, cosa vorrebbe dimostrare? Nulla, se non che
l’ortodossia politicamente corretta, che ha nelle rivendicazioni lgbt la sua
punta di lancia più avanzata, è un sistema logico fallace e un sistema etico
claudicante. E che la dittatura del pensiero unico è innanzitutto una dittatura
del non pensiero. Adriano Scianca
Omofobia sinistra.
Era il 1934 quando
Klaus Mann, il figlio dello scrittore Thomas che ebbe una vita signorilmente
intensa e signorilmente angosciata, scrisse un pamphlet contro la persecuzione
dei “pederasti”. Persecuzione degli omosessuali da parte della sinistra. Sì,
perché se oggi negli stereotipi c’è l’omofobia di destra e l’omofilia di
sinistra, un tempo, e non fu molto tempo fa, c’era l’omofobia di sinistra e
l’omofilia di destra. Klaus Mann denuncia “l’avversione nei confronti di tutto
quanto è omoerotismo che nella maggior parte degli ambienti antifascisti e in
quasi tutti gli ambienti socialisti raggiunge un livello intenso. Non siamo
molto lontani dall’arrivare a identificare l’omosessualità con il fascismo. Su
questo non è più possibile tacere”, scrive Giulio Meotti il 22 Luglio 2013 su
“Il Foglio”. E ancora: “Come mai sui giornali antifascisti leggiamo parole come
‘assassini e pederasti’ abbinate quasi con la stessa frequenza con cui vengono
abbinate sui fogli nazisti le parole ‘traditore del popolo ed ebreo’? La parola
‘pederasta’ viene usata come un’ingiuria”. Né in “Arcipelago Gulag” di Alexander
Solzenicyn, né nei “Racconti della Kolyma” di Varlam Salamov, c’è una parola per
raccontare la sorte degli omosessuali nei campi sovietici. Sono chiamati,
semplicemente, “gli infamati”. In un’opera di divulgazione del commissariato
sovietico di Pubblica sicurezza del 1923, intitolato “La vita sessuale della
gioventù contemporanea”, si legge che l’omosessualità è “una forma di
alienazione” che sarebbe scomparsa, naturalmente o meno, con l’avvento del
comunismo. La morale sessuale della sinistra ha sempre oscillato fra la critica
radicale delle istituzioni borghesi, a cominciare dal matrimonio, e quella delle
“degenerazioni” del costume, segno della corruzione che veniva dalle classi
dominanti e capitalistiche. Nel 1862 il proclama della “Giovane Russia”
postulava l’abolizione del matrimonio “fenomeno altamente immorale e
incompatibile con una completa eguaglianza dei sessi”. La critica di Engels
(“Origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato”) indusse la
prima generazione di rivoluzionari russi a considerare la famiglia come una
“istituzione superata”. August Bebel scriveva che “il soddisfacimento
dell’impulso sessuale è un affare privato di ciascuno proprio come il
soddisfacimento di ogni altro impulso naturale”. Ma quando una militante
bolscevica, nel 1915, stese un pamphlet favorevole al “libero amore”, Lenin
rispose che questa era una concezione borghese, non proletaria. Parlando con
Klara Zetkin, nel 1920, definì “completamente antimarxista e per di più
antisociale la famosa teoria secondo cui, nella società comunista, la
soddisfazione dell’istinto sociale e dell’amore è una cosa semplice e
insignificante come bere un bicchier d’acqua”. Queste teorie e i conseguenti
comportamenti si erano diffusi nella prima fase rivoluzionaria, negli ambienti
intellettuali delle grandi metropoli, dominati dallo spirito dissacratore dei
futuristi, che consideravano l’omosessualità solo un modo diverso di bere un
bicchier d’acqua. A mano a mano che il potere sovietico si estese alle campagne,
con la guerra civile e la Nep, la situazione mutò radicalmente. La famiglia
tradizionale tornò a essere il modello e ogni “devianza” fu condannata.
Si cominciò con l’attacco di
Bucharin alla diffusione fra i giovani di “gruppi decadenti e semiborghesi con
nomi come Abbasso l’innocenza, Abbasso il pudore” e si finì con l’inserire nel
codice penale la condanna ai lavori forzati per l’omosessualità. Gli
intellettuali comunisti occidentali si adeguarono. Uno dei testi più noti di
Bertolt Brecht, “Ballade vom 30 Juni”, presenta Hitler e Ernst Röhm come amanti
di letto, usando l’accusa di omosessualità per screditare il nazionalsocialismo.
Si arriverà, con il giornalista Georges Valensin, a dichiarare che nella Cina di
Mao “l’omosessualità non esiste più” (l’Espresso, 20 novembre 1977).
Il Pcf si distinse
nell’attacco a “intellettuali degenerati” come André Gide, l’autore di “Si le
grain ne meurt”, l’autobiografia dove confessa come in una psicoterapia le
“brutte abitudini” di bambino onanista all’Ecole Alsacienne o le crudeltà di
adulto libertino inflitte alla madre. “Ce vieux Voltaire de la pédérastie”,
scrisse di lui Ernst Jünger, che così sintetizzò il suo nichilismo scettico
redento dall’eleganza dello stile. Gide l’alfiere dell’individualismo
antiborghese, il custode del classicismo che disse “Je ne suis pas tapette,
Monsieur, je suis pédéraste”. Ma anche il militante dell’antifascismo infatuato
per breve tempo del comunismo e che, sontuosamente accolto nel 1936 a Mosca,
ritornò in occidente per scrivere “Retour de l’Urss” e “Retouches à mon retour
de l’Urss”, i libri in cui riferì quello che aveva visto realmente nella Russia
staliniana. Divenne così “Gide, il traditore”, “il bieco reazionario”, “il servo
dei padroni”, “il nemico della classe operaia”: questo il campionario di epiteti
pubblicati a caratteri cubitali contro l’omosessuale antesignano. “Quelle sue
calunnie, assurde e ignobili, contro il paese guida del comunismo
internazionale, sono la bava avvelenata di un degno figlio della piccola
borghesia, di un alleato dei nostalgici nazisti e delle camicie nere”,
scrivevano i giornalisti dell’Humanité, il quotidiano del Partito comunista
francese. E i loro colleghi della Pravda, organo del Partito comunista
sovietico, rivolgendosi ai lettori militanti: “Sapete perché il signor Gide ce
l’ha tanto con noi e con i nostri compagni? S’è indignato, poverino, ha provato
un disgusto indicibile, quando si è accorto che i comunisti di Mosca non sono
pederasti”.
Quando a Stoccolma, nel 1947,
diedero al settantottenne Gide il premio Nobel per la Letteratura, Jean Kanapa
arriverà a dire che dieci anni prima lo scrittore aveva provato disgusto per i
bolscevichi “accorgendosi che essi non erano pederasti”. Nel 1949 Dominique
Desanti lo descrisse vecchio di ottantun anni “con già sul viso la maschera
della morte”, circondato da giovani ammiratori che avevano trovato nei suoi
libri la stessa liberazione che altri trovavano a Place Pigalle. Nel coro di
mostrificazione di Gide non mancherà la voce di Palmiro Togliatti, il segretario
del Pci che sotto lo pseudonimo di Roderigo di Castiglia, dal giorno del suo
ritorno in Italia, nell’ottobre 1943, a quello della sua morte a Jalta,
nell’agosto 1964, svolse il suo magistero culturale sulle pagine di Rinascita.
Nel maggio 1950, scriverà a proposito di Gide: “Al sentire Gide, di fronte al
problema dei rapporti fra i partiti e le classi, dare tutto per risolto
identificando l’assenza di partiti di opposizione, in una società senza classi,
con la tirannide e il terrorismo, vien voglia di invitarlo a occuparsi di
pederastia, dov’è specialista, ma lasciar queste cose, dove non ne capisce
proprio niente”.
Il 20 febbraio 1951,
all’indomani della scomparsa di Gide, l’Humanité pubblicherà un necrologio
intitolato “Un cadavere è morto”. E’ lo stesso Kanapa che nel 1947 riassunse la
posizione ufficiale del Partito comunista francese in un saggio intitolato
“L’esistenzialismo non è un umanesimo”, in cui si arriva a sostenere che “il
significato sociale dell’esistenzialismo è la necessità attuale per la classe
sfruttatrice di addormentare i suoi avversari” e che Jean-Paul Sartre era un
“pederasta che corrompe la gioventù”. In Italia si seguì un doppio binario. Gli
omosessuali non venivano ammessi nel partito e quando venivano scoperti, come
nel caso famoso di Pier Paolo Pasolini, venivano espulsi in base alla norma
sulla “condotta esemplare” contenuta nello statuto comunista. C’è ad esempio il
caso di Pietro Secchia, sul quale cominciarono a circolare voci soltanto dopo
che, morto Stalin e fuggito il suo più stretto collaboratore, fu esautorato dal
suo ruolo di capo dell’Ufficio quadri, quello che vigilava sulla vita, anche
privata, di “compagni e dirigenti”. Sul piano pseudoscientifico pesarono a lungo
le teorie biologiche di Andrei Lissenko, che sosteneva una specie di superiorità
razziale del proletariato nel quale “fenomeni di devianza”, come
l’omosessualità, potevano sussistere solo come il risultato della contaminazione
di altre classi. Nel Partito comunista, di omosessualità non si parlerà a lungo.
Nel convegno del 1964 dedicato a “Famiglia e società nell’analisi marxista” si
accenna polemicamente, lo fa Umberto Cerroni, “alle false alternative teoriche
del ribellismo sessuale”, mentre la ricognizione della “esperienza sovietica” di
Luciana Castellina arriva a criticare “gli eterodossi, gli innovatori” come
sostenitori “del ritorno a una tematica crepuscolare, in difesa del privato e
dei suoi tenui sentimenti”. Ancora nel 1979 Antonio Roasio, uno dei fondatori
del Partito comunista a Livorno, non trovava di meglio che criticare l’Unità per
“l’eccessivo rilievo” dato all’omosessualità in un numero del quotidiano e che
“comunque la si giudichi, l’omosessualità non può essere considerata un aspetto
della libertà sociale”.
C’è poi la storia, quella
vera, del “Che”, Ernesto Guevara. Una storia che in pochi raccontano oggi e che
le stesse associazioni omosessuali militanti hanno sempre nascosto. Con il
passaggio di poteri da Batista a Castro, nel 1959, Guevara venne nominato
procuratore militare con il compito di reprimere “gli oppositori della
rivoluzione”. Nei tribunali finiscono per espressa volontà del Che molti
religiosi, tra cui l’arcivescovo dell’Avana, e moltissimi “maricones”, gli
omosessuali. Il Che realizza campi di lavori forzati ed elabora i regolamenti
dentro le galere del regime, che fissano le punizioni corporali per i più
facinorosi, come i lavori agricoli eseguiti nudi. Alcuni reduci racconteranno di
“maricones” uccisi personalmente, con colpi di pistola alla tempia, dal
leggendario guerrigliero. Perché nella Cuba comunista tanto amata in occidente,
il castrismo ha perseguitato gli omosessuali chiamandoli “pinguero” (marchetta)
e “bugarrón” (uno che cerca sesso spasmodicamente). E se nella Cuba di Batista i
gay stavano male e basta, fu tra il 1965 e il 1968, dopo la rivoluzione, che ci
fu il trionfo delle Unidades militares de ayuda a la producción, veri e propri
lager con guardie armate e filo spinato. Ci finivano dal “poeta finocchio”
all’“attore effeminato”, tutti in divisa blu, sottoposti a marce durissime, cibo
scarso, ma anche “cure” con gli elettrodi attaccati ai genitali. Il comandante
Ernesto Guevara fu lì uno degli aguzzini.
Granma, l’organo ufficiale del
Partito comunista cubano, nell’aprile 1971 scriveva per esempio che “il
carattere socialmente patologico delle deviazioni omosessuali va decisamente
respinto e prevenuto fin dall’inizio. E’ stata condotta un’analisi profonda
delle misure di prevenzione e di educazione da rendere efficaci contro i focolai
esistenti, inclusi il controllo e la scoperta di casi isolati e i vari gradi di
infiltrazione. Non si deve più tollerare che gli omosessuali notori abbiano una
qualche influenza nella formazione della nostra gioventù. Siano applicate severe
sanzioni contro coloro che corrompono la moralità dei minori, depravati recidivi
e irrimediabili elementi antisociali, ecc.”. L’omosessualità è trattata alla
stregua di un virus patogeno. Nel 1979 gli atti omosessuali vennero
decriminalizzati a Cuba, ma i gay continuarono a venire accusati di essere
“oppositori del regime”, sbattuti in galera senza processo, mandati a morte in
quell’isola magnifica che descrive Claudio Abbado. Il quotidiano Juventud
rebelde pubblica una foto di un impiccato, un “gusano”, un verme, e sui
pantaloni c’è scritto “homosexual”. Nel 1984 Néstor Almendroz e Orlando Jiménez
Leal producono il documentario “Cattiva condotta”, dove raccontano la
persecuzione del regime castrista contro i gay. Racconta lo scrittore Guillermo
Cabrera Infante: “La persecuzione degli omosessuali dei due sessi fu una
persecuzione di dissidenti. Gli omosessuali deviano dalle norme borghesi. I
comunisti sostengono le coppie convenzionali, il matrimonio… L’omosessualità
minaccia tutto ciò, perciò gli stati totalitari la temono”. Ancora l’articolo
303 del codice penale del 30 aprile 1988 punisce chi “manifesti pubblicamente”
la propria omosessualità con pene che variano tra i tre mesi a un anno di
prigione o una multa che va da cento a trecento cuotas per coloro che
“infastidiscono in modo persistente gli altri con proposte amorose omosessuali”.
In occidente, dove oggi vige l’omofilia militante e avanza la censura
antiomofoba, l’omosessualità è stata sempre una questione di emarginazione.
Nell’emisfero comunista, e nel pensiero della sinistra europea, l’omosessualità
era destinata a scomparire. Assieme ai froci. Una “soluzione finale” contemplata
in un articolo che Maksim Gorkij, la bandiera degli scrittori sovietici, l’amico
di Lenin, il padre del realismo socialista, pubblicò il 23 maggio 1934
contemporaneamente sulla Pravda e sull’Izvestia, sotto il titolo “Umanesimo
proletario”: “Nei paesi fascisti, l’omosessualità, rovina dei giovani, fiorisce
impunemente; nel paese dove il proletariato ha audacemente conquistato il
potere, l’omosessualità è stata dichiarata crimine sociale e severamente punita.
Eliminate gli omosessuali e il fascismo scomparirà”.
SINISTRISMO E RADICAL-CHIC.
Radical chic. Locuzione:
Che riflette il sinistrismo di maniera di certi ambienti culturali d'élite, che
si atteggiano a sostenitori e promotori di riforme o cambiamenti politici e
sociali più appariscenti e velleitari che sostanziali.
Ecco come smascherare i
radical chic 2.0 (in 12 punti),
scrive Francesco Maria Del
Vigo il 26 agosto 2014 su "Il Giornale". Qualche giorno fa, sul Giornale, ho
pubblicato una lista in nove punti sui tic dei radical chic on line. Questa è la
versione integrale:
La foto del profilo non è
(quasi) mai una loro foto. Sarebbe troppo nazionalpopolare. Mettono solo
frammenti di film di qualche regista polacco mai distribuiti fuori dalla
circonvallazione di Varsavia.
Quando scelgono una loro
immagine deve essere schermata da almeno cinque o sei filtri, avere delle
velleità artistiche e magari ritrarre solo una parte del viso. Espressione
sempre preoccupata per i destini del mondo. Il sorriso è bandito come un
retaggio del ventennio berlusconiano.
L’oroscopo è un vizio da
portinaia. Ma se si tratta di quello di Internazionale no. Lo condividono su
tutti i social come se fosse il Vangelo.
Le foto delle vacanze vanno
bene solo se si è nel terzo mondo o in un campo profughi. Pose obbligatorie:
sguardo corrucciato, camuffati da indigeni e nell’atto di solidarizzare con gli
abitanti del luogo. Il colore (degli abitanti del luogo) deve essere intonato
alla nuance dei sandali Birkenstock.
Su Twitter parlano tra di loro
di cose che capiscono solo loro. Sublimazione del sogno radical chic:
l’esposizione mediatica del salotto (ovviamente etnico) di casa propria.
Sì al selfie, ma solo se ha un
significato sociale e politico. Possibilmente con un cartello in mano che
sostiene la battaglia di qualche gruppo di contadini ugandesi. Ancora meglio se
su iniziativa di Repubblica.it.
La Reflex. Più che uno
strumento fotografico è un monile, una collana da appendere al collo.
Condividono e scattano foto solo con voluminosissime – e costosissime – macchine
fotografiche professionali. Preferiscono Flickr a Instagram, troppo plebeo.
Il meteo è il prolungamento
della politica coi mezzi della natura. Se piove non è colpa del governo ladro,
ma dello scioglimento dei ghiacci dovuto al capitalismo diabolico. Condividere
(sui social) per educare.
Il cibo non esiste. Esiste
solo il food. Da fotografare e condividere sui social solo a tre condizioni: che
sia a km 0 (va bene anche se è stato coltivato nella rotatoria di Piazzale
Loreto), etnico o equo e solidale.
La petizione on line è la
nuova e comodissima forma di contestazione. Va bene per risolvere tutti i
problemi: dal cambio degli stuoini nel condominio (meglio sostituirlo con un
piccolo kilim) alla fame nel mondo. Basta un click. Tutto il nécessaire è su
Charge.org.
Film, libri, giornali. Tutto
in lingua straniera. Molto chic condividere video di serie tv in lingua
originale non ancora trasmessi in Italia. Appena oltrepassano le Alpi diventano
rigorosamente pacchiane.
Anche Youporn è troppo pop.
Forse anche sessista, potrebbe addirittura essere di destra con quello sfondo
nero… Meglio ripiegare su siti soft porn o intellettual-erotici. Ammesso anche
spulciare tra le pagine osè di Tumblr.
Le 9 differenze tra tamarri
e radical-chic,
scrive il 4 novembre 2014 Enrico Matzeu. (Gli stilisti mi evitano, le pr non mi
invitano ai party più glamour. Scrivo sull’Oltreuomo per vendicarmi di loro.) La
giungla umana è fatta di tante specie diverse, di tanti tipi umani che vengono
costantemente tenuti sotto osservazione da antropologi e ornitologi. Tra queste
specie, due meritano di essere analizzate con cura certosina: i Tamarri e i
Radical-chic. Due categorie che come i binari della transiberiana non si
incontreranno probabilmente mai. Entrambe le categorie si schifano a vicenda ed
entrambe vanno orgogliose delle loro variopinte peculiarità. Ho provato con cura
e garbo a sottolineare le differenze tra gli zarri e gli snob, nei nove ambiti
dove emerge al meglio la loro personalità. Le 9 differenza tra Tamarri e
Radical-chic:
1. Abbigliamento. I Tamarri
doc vogliono stare comodi e si infilano i pantaloni della tuta anche per il
matrimonio del cugino di ottavo grado (ah no, lì indossano i pantaloni della
festa in finto acrilico traslucido). Le donne non rinunciano ai leggings, mai,
neanche quando i leggings rinuncerebbero volentieri a loro. Entrambi portano con
ossessione i gilet imbottiti, come fossero costantemente a bordo della Costa
Concordia. I radical-chic invece portano la giacchia in velluto a costine anche
in spiaggia, con camicette alla coreana e le immancabili Clarks. Per le donne
l’abito asimmetrico di qualche stilista giappo-svedese è d’obbligo nell’armadio.
2. Vacanze. I Tamarri amano il
sole più di se stessi e se d’inverno passano il tempo libero stesi su un lettino
abbronzante, d’estate preferiscono di gran lunga le sdraio di polipropilene di
Rimini e Riccione. I più internazionali svernano invece a Ibiza o Mykonos,
sfoggiando costumini con sospensorio annesso o bikini tigrati. I radical-chic
temono il sole più dell’ebola e se una volta amavano Capalbio ora preferiscono
di gran lunga il Museo d’Orsey di Parigi o al massimo qualche sperduta isola del
Mediterraneo a mangiare crudité di pesce e piatti bio.
3. Borse. I Tamarri amano
indubbiamente accessori griffati, evidentemente griffati. Le donne non
rinunciano al bauletto Louis Vuitton (meglio se tarocco) e gli uomini al
borsello di Gucci (meglio se rubato). Per i radical-chic le borse sono unisex.
Sia uomini che donne infatti usano quasi esclusivamente borse in tela, meglio se
di qualche festival filosofico-cinefilo-letterario, ai quali probabilmente non
sono neanche mai stati.
4. Ristoranti. Per i Tamarri
sushi is the new pizza. Si abbuffano come bambini del Biafra in un qualsiasi all
you can eat del quartiere e più ordinano più si sentono dei giusti. I
radical-chic hanno smesso di mangiare il sushi da almeno tre anni. Ora si
dedicano alla cucina vietnamita, alle hamburgerie dove si ordina con l’IPad o da
Eataly, dove un ordine costa come un IPad.
5. Tatuaggi. I Tamarri si
tatuano con gusto tutto il corpo come fosse una tela impressionista (nel senso
che fa impressione). Partono con un tribale sui bicipiti e finisce che si
colorano anche la mano con il viso della nonna defunta. Le iniziali del proprio
amato sono indispensabili e diventano un marchio a fuoco come per le vacche. I
radical-chic invece si dividono tra quelli che vogliono il tattoo old school,
con marinai e sirene (che neanche nei Pirati dei Caraibi), oppure puntano sui
tatuaggi minimalisti, fatti di disegni stilizzati o schizzi di Mirò.
6. Occhiali da sole. Un
Tamarro come si deve si distingue anche e soprattutto da un paio di occhiali da
sole. Per la regola che più grosso ce l’hai (l’occhiale) più sei figo, al
Tamarro tipo piace esagerare, con montature che invadono la faccia, peggio di
Putin con l’Ucraina, e lenti specchiate che ti riflettono pure le adenoidi. Il
radical-chic non rinuncia ai suoi Rayban, meglio se tartarugati, pieghevoli,
vintage, in limited edition e con la cordicella al collo. Sia mai li perdano.
7. Musica. Da adolescenti la
musica dance è per i Tamarri come l’insulina per i diabetici: questione di vita
o di morte. Crescendo, si affezionano ai neo melodici italiani, possibilmente
amici della De Filippi o con almeno un paio di date in America Latina. I
radical-chic citano De André, Guccini e Battiato ogni tre per due, spesso
confondendoli tra loro e odiano tutto ciò che è pop (talvolta addirittura i
pop-corn). Frequentano club con musica dal vivo e non si perdono i concerti dei
gruppi più indie del momento, anche di quelli che non conoscono.
8. Libri. Diciamocelo, i
Tamarri leggono più volentieri le riviste scandalistiche (o scandalose) dei
libri, però se proprio devono entrare in una libreria ne escono con la biografia
di qualche calciatore, qualche libro di aspiranti motivatori e naturalmente il
libro dell’Oltreuomo. I radical chic millantano sempre letture impegnate e
impegnative e sui loro comodini ci sono pile e pile infinite di libri, tra i
quali si leggono titoli di Kafka, Hesse e Tolstoj, ma in fondo, messo al
contrario, un po’ nascosto c’è sempre una delle novità letterarie di Fabio Volo.
I radical-chic in salotto hanno sempre l’ultimo libro fotografico di Oliviero
Toscani. Ottimo soprammobile.
9. Sport. La palestra è per i
Tamarri come la Mecca per i musulmani. Quando entrano però loro non si tolgono
le scarpe perché devono sfoggiare le ultime sneakers giallo fluo con i lacci
fucsia e le canotte ascellari. Bicipiti, tricipiti e addominali devono essere
tonici e tirati più della pelle di un tamburo e sfoggiati sotto a camicie e
t-shirt aderenti dal dubbio gusto. I radical-chic boicottano la palestra perché
la ritengono anticostituzionale e preferiscono di gran lunga la corsa,
possibilmente al Central Park di New York o il tennis, perché si possono
indossare quei gonnellini tanto chic.
Radical chic.
Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Radical chic è un'espressione idiomatica mutuata
dall'inglese per definire gli appartenenti alla borghesia che per vari motivi
(seguire la moda, esibizionismo o per inconfessati interessi personali)
ostentano idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale o comunque
opposte al loro vero ceto di appartenenza. Per estensione, la definizione di
radical chic comprende anche uno stile di vita e un modo di vestirsi e
comportarsi. Un atteggiamento frequente è l'ostentato disprezzo del denaro, o il
non volersene occupare in prima persona quasi fosse tabù, quando in realtà si
sfoggia uno stile di vita che indica un'abbondante disponibilità finanziaria o
improntato al procacciamento dello stesso con attività che, qualora osservate in
altri, un radical chic non esiterebbe a definire in modo sprezzante, come
volgarmente lucrative. Inoltre tale atteggiamento sovente si identifica con una
certa convinzione di superiorità culturale, nonché con l'ostinata esibizione di
tale cultura "alta", o la curata trasandatezza nel vestire e, talora, con la
ricercatezza nell'ambito di scelte gastronomiche e turistiche; considerando,
insomma, come segno distintivo l'imitazione superficiale di atteggiamenti che
furono propri di certi artisti controcorrente e che, ridotti a mera apparenza,
perdono qualsiasi sostanza denotando l'etichetta snobistica. La
definizione radical chic fu coniata nel 1970 da Tom
Wolfe, scrittore e giornalista statunitense. Il 14 gennaio di quell'anno,
Felicia Bernstein, moglie del celebre compositore e direttore
d'orchestra Leonard Bernstein, organizzò un ricevimento di vip e artisti per
raccogliere fondi a favore del gruppo rivoluzionario marxista-leninista Pantere
Nere (alcuni membri delle Pantere Nere furono invitati al ricevimento). Il party
si tenne a casa dei Bernstein, un attico di tredici camere su Park Avenue (un
ampio viale di Manhattan). Tom Wolfe scrisse un ampio resoconto sulla serata,
descrivendo in modo molto critico gli invitati, rappresentanti dell'alta società
newyorchese. Ne risultò un articolo di 29 pagine pubblicato sul New York
Magazine dell'8 giugno 1970. In Italia, l'espressione fu ripresa da Indro
Montanelli nel celebre articolo Lettera a Camilla, in forte polemica con la
giornalista Camilla Cederna, quale ideale rappresentante dell'italico
"magma radical-chic", superficiale e incosciente culla degli anni di piombo. In
seguito, egli chiarì che la vera destinataria della lettera aperta era
invece Giulia Maria Crespi, allora padrona del «Corriere della Sera» e amica
della Cederna, con la quale i dissidi sarebbero sfociati, l'anno seguente,
nell'allontanamento di Montanelli dal quotidiano di via Solferino, dove lavorava
sin dal 1937. A parte l'adozione del neologismo, l'argomento era già stato
affrontato da Montanelli in vari scritti, nei quali lamentava la frivola
ideologia sfoggiata da certa borghesia ricca e pseudo-intellettuale lombarda,
facendone anche un ritratto tragicomico nella pièce teatrale Viva la
dinamite! (1960).
Cosa sono i radical chic?
Scrive Luca Sofri il 29 agosto 2014 su "Il Post". In teoria non "sono": abbiamo
trasformato noi un'espressione inventata da Tom Wolfe nel 1970 e che ormai è
usata lontanissimo dal suo senso. Nella rituale e un po’ ammuffita terminologia
del dibattito pubblico italiano prospera da decenni con minore o maggiore
frequenza l’espressione “radical chic”, usata prevalentemente in modo offensivo
e dispregiativo, per indicare la presunta incoerenza di persone che si dicono
politicamente di sinistra ma hanno redditi maggiori di quelli che un luogo
comune anacronistico attribuirebbe ai militanti di sinistra. Proprio perché il
termine è usato quasi sempre per polemica e con intenzioni aggressive, la
coerenza del suo uso non è di solito rilevante: è diventato un insulto come un
altro. Ma la sua storia è interessante, così come quella della nebbia semantica
in cui è poi finito ora che viene usato spesso a caso e per mille cose diverse
tra loro. Il termine “Radical chic” è formato dalla parola inglese “radical” –
che vuol dire “radicale” nel senso dell’intensità dell’attivismo e degli
obiettivi politici – e da quella francese “chic”, “raffinato”. Nella definizione
del dizionario Treccani è sia un aggettivo che un sostantivo, e indica: «che o
chi per moda o convenienza, professa idee anticonformistiche e tendenze
politiche radicali». L’Oxford Dictionary precisa (in inglese “radical chic” è un
concetto, non una persona): si tratta «dell’ostentazione», molto alla moda, di
idee e visioni «radicali e di sinistra». Radicale, per moda. Wikipedia esplicita
un terzo elemento: al concetto di “radical chic” è associata anche la ricchezza.
Il “radical chic” appartiene «alla ricca borghesia» o proviene «dalla classe
media» e «per seguire la moda, per esibizionismo o per inconfessati interessi
personali, ostenta idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale (come
il comunismo) o comunque opposte al suo vero ceto di appartenenza». Spiegazione
che si può sbrigativamente riassumere nella frase “fai il comunista con il
maglione di cachemire” (sinistra in cachemire è una delle diverse varianti usate
per concetti simili, come gauche-caviar o champagne socialist). La versione
inglese di Wikipedia dice che il “radical chic” è un esponente della società,
dell’alta società e della mondanità impegnato a dare di sé un’immagine basata su
due pratiche: da una parte quella di definire sé stesso attraverso la fedeltà e
l’impegno ad una causa, dall’altra a esibire questa fedeltà perché quella stessa
causa è alla moda e qualcosa di cui si preoccupa (anche tra i ricchi). Per il
termine “Champagne socialist” Wikipedia spiega una cosa uguale e simmetrica: non
un ricco che si atteggia artificiosamente a persona di sinistra, ma uno di
sinistra che è ricco e ha abitudini da ricco in contraddizione con i suoi
pensieri. Nell’uso comune, in italiano, “radical chic” è usato per definire
entrambi i casi. L’introduzione della definizione di “radical chic” viene
attribuita storicamente allo scrittore e giornalista americano Tom Wolfe che
sul New York Magazine del giugno 1970 pubblicò un lunghissimo
articolo intitolato “Radical Chic, That Party at Lenny’s”. Wolfe fece un
resoconto del ricevimento che qualche mese prima Felicia Bernstein, moglie del
compositore e direttore d’orchestra Leonard, organizzò per raccogliere fondi a
sostegno del gruppo rivoluzionario delle «Pantere nere». La festa si svolse a
casa dei Bernstein, in un attico su Park Avenue, a Manhattan. Erano presenti
molte personalità che provenivano dal mondo della cultura e dello spettacolo
newyorchese e i camerieri in livrea (camerieri bianchi per non offendere gli
ospiti afroamericani) servivano tartine al Roquefort. Dopo una breve
introduzione, la prima parte del racconto di Tom Wolfe inizia così:
«Mmmmmmmmmmmmmmmm». Sedici lettere, un’onomatopea per esprimere l’aria di
appagamento che circolava in quella serata, ma anche che cosa Wolfe intendesse
per “radical chic”: una specie di corrente, di moda, di milieu, un matrimonio
pubblico molto ridicolo tra la buona coscienza progressista delle classi più
ricche e la politica di strada, un corto circuito in cui alcuni rischiavano
davvero, per le loro idee, e altri invece non rischiavano niente e in cui c’era
l’illusione di una collaborazione e contaminazione tra diversi mondi e diverse
classi sociali. La serata fu molto criticata: un editoriale del New York
Times sostenne che aveva offeso e arrecato danno a quei neri e a quei bianchi
che «lavorano seriamente per la completa uguaglianza e la giustizia sociale»,
Felicia Bernstein rispose pubblicamente difendendo la sua festa. Fatto sta che
il termine usato da Wolfe per descrivere l’atteggiamento dei Bernstein si
diffuse ben presto in tutto il mondo, e in Italia si radicò ancora più che
altrove e prese a indicare, in maniera inesatta, una persona o un atteggiamento,
diventando anche aggettivo. L’espressione fu ripresa sul Corriere della Sera il
21 marzo del 1972 da Indro Montanelli in un famoso articolo intitolato “Lettera
a Camilla” e rivolto a Camilla Cederna, la giornalista italiana che si era
occupata della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla questura
di Milano dove si trovava accusato innocente dell’attentato di Piazza Fontana
nel 1969. Montanelli descrisse Cederna così. «C’è chi dice che, più delle bombe,
ti sei innamorata dei bombaroli, e questo, conoscendo i tuoi rigorosi e severi
costumi, posso accettarlo solo se alla parola “amore” si dia il suo significato
cristiano di fratellanza […]. Fino a ieri testimone furtiva o relatrice discreta
di trame e tresche salottiere, arbitra di mode, maestra di sfumature,
fustigatrice di vizi armata di cipria e piumino, ora si direbbe che tu abbia
sempre parlato il gergo dei comizi e non sappia più respirare che l’aria del
Circo. Ti capisco. Deve essere inebriante, per una che lo fu della mondanità,
ritrovarsi regina della dinamite e sentirsi investita del suo alto patronato.
Che dopo aver tanto frequentato il mondo delle contesse, tu abbia optato per
quello degli anarchici, o meglio abbia cercato di miscelarli, facendo anche del
povero Pinelli un personaggio della café society, non mi stupisce: gli anarchici
perlomeno odorano d’uomo anche se forse un po’ troppo. Sul tuo perbenismo di
signorina di buona famiglia, il loro afrore, il loro linguaggio, le loro
maniere, devono sortire effetti afrodisiaci. Una droga». Montanelli, con la sua
sgradevole descrizione contribuì già allora in realtà a far scivolare il
concetto originario di “radical chic” verso la confusione condivisa che sta oggi
intorno a questa espressione. Che rapidamente fu fatta propria da chi a destra
voleva accusare qualcuno di sinistra di scarsa coerenza e successivamente
adottata nelle polemiche interne alla sinistra quando il mondo cominciò a
cambiare e gli elettori di sinistra smisero di essere prevalentemente
“proletariato” in senso stretto. Negli ultimi anni, con lo sviluppo di maggiori
contraddizioni nella sinistra italiana di fronte a grossi cambiamenti, ma anche
legata a tradizioni radicate, l’accusa è tornata a essere usata molto proprio a
sinistra come contraltare di tutti i richiami alla “vicinanza al territorio”,
“ai problemi della gente”, stimolata dai fallimenti delle dirigenze politiche
della sinistra in questo periodo. E un generale antintellettualismo in grande
crescita è stato un altro fattore che ha alleato nell’uso del termine sia leader
della sinistra radicale che politici e stampa di destra, per attaccare da parti
opposte gli esponenti della sinistra più riformista. Così oggi “radicalscìc” è
diventato un insulto di uso comunissimo e destinato a persone dai redditi più
vari e dalle posizioni più articolate. Con la contraddizione che oggi i
principali destinatari dell’epiteto sono persone che hanno posizioni niente
affatto radicali, anzi sono gli oppositori della sinistra radicale: l’uso più
convincente del termine negli anni passati è stato quello destinato a Fausto
Bertinotti, un uomo in effetti elegante e di modi garbati, coi pullover di
cachemire e posizioni di estrema sinistra; mentre quando lo si dice per esempio
a persone come Matteo Renzi, per niente radical e nemmeno
straordinariamente chic, il senso è definitivamente stravolto.
Il corso per diventare un
vero radical-chic.
Sul web impazza una locandina che promette fantomatiche lezioni.
L'obiettivo: incarnare perfettamente lo stereotipo nel minor tempo possibile,
scrive il 6 Dicembre 2013 "Libero Quotidiano”. Il radical-chic. Una figura che
accompagna gli "anni duemila". Rigorosamente di sinistra (ma critico con la
sinistra stessa), snob ma finto alternativo, con la puzza sotto al naso, un po'
terzomondista ma elitario, molto tollerante soltanto a parole, il radical-chic è
odiato da tutti: da chi non lo è e da chi, invece, ne incarna lo stereotipo.
Già, perché il radical-chic, essenzialmente, disprezza e denigra, ottenebrato da
una sorta di nichilismo illuminante di cui lui, e solo lui, è dotato in
abbondanza. Non è semplice essere un radical-chic. Ci vogliono anni di
studio, le giuste frequentazioni, una certa inclinazione. Ma da oggi imparare è
possibile. Almeno questo è quanto promette una locandina che circola sul web, e
che nel tam-tam di Twitter e Facebook ha già avuto un certo successo. Si tratta
del "Primo corso di Radical Chic". Sottotitolo: "L'unico corso con attestato
riconosciuto a livello nazionali". La promessa: "Impara tutti i segreti per
sc... le donne più insipide del sistema solare in sole 10 lezioni da dieci ore".
L'omaggio: "I primi 10 iscritti riceveranno in omaggio la guida Diventa buddista
in un'ora". I contenuti - Nel mirino, insomma, tutti gli stereotipi molto
radical e altrettanto chic: quello appena citato buddismo, quello sulle donne
(quelle radical-chic, sia chiaro) molto insipide e quello relativo all'ambizione
(malcelata) dei radical-chic, ossia fare l'amore il più possibile (anche se le
parole usata per indicare la "circostanza" è ben più volgare). La locandina
entra poi nel merito del corso, in cui si imparerà "come curare al peggio barba
e capelli", "come metterci ore a capire come vestirsi per sembrare uno che si
butta addosso la prima cosa nell'armadio". S'apprenderà poi "l'importanza del
velluto a costine e del cachemire", e verrò chiarito l'amletico dubbio: "Clarks
o mocassini?". E ancora, verrete illuminati sull'"importanza
dell'abbinamento aperitivo-bio e musica jazz", nonché su "tutti i vini buoni, i
cantautori, teatri, viaggi da citare", e sempre in termini di viaggi due regioni
non avranno più segreti grazie al corso di geografia "dettagliato di Toscana e
Umbria". Altri temi utili per la formazione: "Pere e formaggio, parliamone" e
"le migliori supercazzole da pronunciare per fare colpo al primo approccio".
Quindi una lezione su "tutte le parole più impressionanti, quali: Flaubert,
sushi, Moleskine e tante altre!". Infine un seminario su "come raggiungere in
bicicletta le mostre di fotografia, presentazioni di libri e sale d'essai più
scrause dell'intera Ue" e "come mettere in atto la rivoluzione del salotto di
casa propria". Il tutto, conclude la locandina, con una "quota d'iscrizione
promozionale a 5.000 euro per il primo ciclo di lezioni (Iva esclusa)".
Ebbene sì, siamo
radical-chic,
scrive Eugenio Scalfari il 10 aprile 2012 su “L’Espresso”. L'etichetta che la
destra populista ci affibbia come un insulto, per noi è diventata un motivo
d'onore. Perché si riferisce a una cultura laica, eterodossa e ironica. Che
guarda a Voltaire, Keynes, Einstein e Roosevelt. Fino a qualche tempo fa per
definire un tipo bizzarro e "con la puzza sotto il naso" rispetto alle mode e ai
comportamenti altrui si usava la parola snob. Non c'era altro modo e altro
termine. Sebbene l'origine di quella parole fosse "sine nobilitate" il
significato semantico era cambiato, anzi si era capovolto. Lo snob una sua
nobiltà l'aveva: disprezzava l'uomo medio, la cultura tradizionale, i luoghi
comuni, l'oleografia del passato. Disprezzava anche i buoni sentimenti o
comunque li metteva in gioco. Spesso gli artisti erano definiti snob quando
rompevano le regole del consueto. Quello che fu marcato con questo termine con
maggiore insistenza degli altri fu Oscar Wilde, un po' per il suo modo di
pensare e di scrivere e molto per la sua dichiarata e ostentata omosessualità
che gli costò la prigione e l'esilio. Ma anche Dalí, anche Ravel, i surrealisti
e molte "avanguardie" furono giudicati esempi di snobismo e perfino Proust, "lo
sciocchino del Ritz". Durante il fascismo e la sua cultura muscolare i giornali
satirici descrivevano lo snob come un gentleman passatista con le ghette sulle
scarpe e il monocolo all'occhio. Adesso però quella definizione è stata
sostituita da un'altra: non si dice più snob ma invece radical-chic. Non è un
sinonimo, c'è qualche cosa in più ed è una dimensione politica: il radical-chic
è di sinistra. Di una certa sinistra. Per guadagnarsi quella definizione deve
stupire e spiazzare anzitutto la vera sinistra che, per antica definizione, si
identifica con l'ideologia marxista. Togliatti - tanto per dire - non è mai
stato neppure lontanamente considerato un radical-chic né Berlinguer, né
Amendola o Ingrao. Bertinotti? Lui sì, gli piacciono i salotti, gli piacciono i
pullover di cashmere e va spesso in giro con Mario D'Urso che è uno "chic"
riconosciuto. Ma i veri radical-chic sono gli amici e i consimili di Camilla
Cederna. Dunque stiamo parlando di noi, che fondammo questo giornale 57 anni fa
e ne facemmo quello che è ancora oggi, un giornale di ricerca costante della
verità, di denuncia delle brutture e delle malformazioni del malgoverno, di
difesa dell'etica pubblica e di impegno civile. Accoppiando però, nel
linguaggio, nella grafica, nella scelta delle fotografie, una vena di ironia e
di autoironia, una leggerezza di stile che nulla doveva avere del sermone da
sacrestia. Vedi caso: il partito radicale nacque nelle stanze del "Mondo" e de
"l'Espresso" nel 1956, visse sei anni e si sfasciò nel '62. Marco Pannella e i
suoi amici, che ne facevano parte, decisero di continuare con lo stesso "logo"
del cappello frigio, dandogli però un contenuto più libertario che liberale. I
radical-chic sono una definizione coniata dalla destra populista e qualunquista
che però ha trovato qualche corrispondenza anche nel marxismo ufficiale. Quando
il gruppo de "Il Manifesto" fu espulso dal Pci, c'era contro di loro una vaga ma
percepibile aura di puritanesimo luterano contro un'eterodossia che irrideva gli
schemi ideologici e amava Lichtenstein, la musica di Schönberg e perfino -
perfino - i salotti. Non erano affatto radical-chic quelli del "Manifesto" ma
tali li considerò la segreteria del Pci che li buttò fuori. Quanto a cultura i
radical-chic sono illuministi e voltairiani, tra i loro personaggi di culto
campeggiano Einstein, Keynes e Roosevelt. La definizione di radical-chic
all'inizio gli sembrò insultante ma adesso se ne sentono onorati vista la sponda
da dove proviene.
Radical choc,
scrive Annalena
Benini il 15 Aprile 2011 su “Il Foglio”. Alberto Asor Rosa si è
sbagliato: pensava di essere a una cena après-concert, in cui ci si ritrova nel
proprio ambiente, sicuri di essere compresi nella teorizzazione mondana del
colpo di stato. Purtroppo il professore stava sbadatamente scrivendo su un
quotidiano, e in questi casi diventa “complicato far capire a chi è fuori
dall’ambiente come simili bisogni apparentemente volgari siano assoluti” (lo
scriveva Tom Wolfe nel 1970 in “Radical Chic. Il fascino irresistibile dei
rivoluzionari da salotto”, a proposito della necessità dei rivoluzionari
dell’East Side di avere un posto dove andare il fine settimana, in campagna o al
mare, di preferenza tutto l’anno, ma necessariamente da metà maggio a metà
settembre). L’urgenza di un golpe da salotto è pari, per intensità, almeno
all’impresa della ricerca dei domestici (in “Radical Chic” dovevano essere
bianchi, per non urtare i sentimenti delle Black Panther durante i party). Sono
cose futili e grevi insieme, quindi allarmanti: bisogna pensare intensamente a
Mario Missiroli, storico direttore del Corriere della Sera, quando diceva: “In
Italia non si potrà mai fare la rivoluzione, perché ci conosciamo tutti”, per
non prendere completamente sul serio le incitazioni al golpe contro Silvio
Berlusconi di uno scrittore Einaudi. L’idea di avvalersi dei Carabinieri e della
Polizia di stato (per congelare le Camere, sospendere tutte le immunità
parlamentari e dare alla magistratura le sue possibilità e capacità di azione,
stabilire d’autorità nuove regole elettorali), è geniale, perché consente di
salire sul cellulare della Polizia e andare alla guerra civile con lo chauffeur,
ristabilendo così la più profonda vocazione democratica senza seccature di
parcheggio o di tassametro. Ci sarà però il problema di come vestirsi: non si
può esagerare con le mise da teatro, troppo frivole, che potrebbero per sbaglio
richiamare certe serate berlusconiane, ma non si può nemmeno arrivare vestiti
tipo “boccone del povero”, con una qualche orribile accoppiata dolcevita-jeans
(data anche l’età veneranda dei golpisti), quindi il consueto abbigliamento
accademico è da preferire: un tweed, per esempio, ma se i Carabinieri marciano
sul Parlamento dopo mezzogiorno, il tweed è già inadatto. Bisognerà accordarsi
per un’ora sobria, ma non da levatacce di operai con le borse sotto gli occhi e
cattivi caffè preparati da mogli scarmigliate: le dieci e mezzo del mattino,
ecco l’ora perfetta per un golpe, dà un senso di attivismo e di zelo, ma
rilassato, un po’ come gli orari delle lezioni all’università. Sarà
elettrizzante e romantico (purché a debita distanza dal popolo e dalle
provocazioni sulla sovranità dei cittadini e del Parlamento), sarà finalmente
una cosa fatta come si deve, senza mezze misure, con la gente giusta, gli
sguardi severi, le barbe curate, i baffi bianchi, foto intense nei risvolti di
copertina, certi deliziosi cocktail après-golpe. Resta però quel piccolo tarlo,
che già impensieriva i radical chic di Tom Wolfe nelle donazioni alle Black
Panther: la rivoluzione non è fiscalmente detraibile.
Libri. “Radical Chic.
Conoscere e sconfiggere il pensiero unico globalista” de La Via Culturale,
scrive il 29 aprile 2017 Jaap Stam su "Barbadillo. Il 24 aprile è
uscito “Radical Chic. Conoscere e sconfiggere il pensiero unico globalista” (ed.
La Vela, pp 176, euro 12), l’ultimo libro di Alessandro Catto, blogger su Il
Giornale e fondatore del blog “La Via Culturale”. Di seguito pubblichiamo un
estratto del libro, che elabora una forte critica verso il pensiero unico.
“Populismo, demagogia, fascismo, chiusura mentale, provincialismo: termini che
ultimamente vengono utilizzati in maniera dozzinale contro chi cerca di porre un
argine al processo di globalizzazione. E’ il paradosso di una democrazia
accettata solamente quando corrisponde agli auspici di una classe autodefinita
democratica e tollerante ma capace di occupare spazi informativi, tribune
politiche e istituzioni in maniera impropria e di impedire un reale e aperto
confronto sui rischi del presente. Sono i paradossi di chi, antifascista in
assenza di fascismo, in un’astratta idra di internazionalismo del mercato
giustifica e promuove le peggiori distorsioni ai processi democratici e ai
diritti sociali dei popoli occidentali. In capitoli brevi, ironici e frizzanti
si fa luce su un fenomeno, quello liberal, che sta subendo una profonda
ridiscussione ma che ancora oggi non è pienamente conosciuto, nemmeno dai suoi
contestatori. Il presente volume analizza la nascita, la crescita e lo sviluppo
di una sinistra che spesso ha finito con l’adottarne lo stile e i contenuti,
astraendosi pure dalla sua missione storica, quella della difesa delle fasce
sociali più deboli e del lavoro. Radical Chic è il libro ideale per capire il
vero retroterra politico e culturale del pensiero unico politicamente corretto.
Dall’istruzione all’economia, dalla storia all’attualità, dalla geopolitica alla
cultura, vengono sfatati in modo leggero e divertente tutti i miti pro-global ai
quali siamo quotidianamente esposti e le loro pretestuose retoriche, sempre più
incapaci di nascondere il distacco tra l’alto e il basso della nostra società,
tra chi con il cosmopolitismo imperativo per tutti ci guadagna e chi, ogni
giorno, perde diritti, spazi democratici e possibilità di emancipazione a casa
propria”.
Ecco “Radical Chic”, il
libro contro il pensiero unico politicamente corretto,
scrive Alessandro Catto il 3 maggio 2017 su “Il Giornale". Si chiama Radical
Chic ed è il nuovo libro de La Via Culturale. Edito dalla casa editrice La Vela,
è il libro ideale per capire il vero retroterra politico e culturale del
pensiero unico politicamente corretto. Dall’istruzione all’economia, dalla
storia all’attualità, dalla geopolitica alla cultura vengono sfatati tutti i
miti pro-global ai quali siamo quotidianamente esposti e le loro pretestuose
retoriche, sempre più incapaci di nascondere il distacco tra l’alto e il basso
della nostra società, tra chi con il cosmopolitismo imperativo per tutti ci
guadagna e chi, ogni giorno, perde diritti, spazi democratici e possibilità di
emancipazione a casa propria. Populismo, fascismo, chiusura mentale,
provincialismo: nel volume si parla anche dell’abuso di questi termini,
utilizzati in maniera dozzinale contro chi cerca di porre dei paletti alla
retorica della globalizzazione. Il paradosso di una democrazia accettata
solamente quando corrisponde agli auspici di una classe autodefinita democratica
e tollerante ma capace di occupare spazi informativi, culturali e politici in
maniera impropria, impedendo un reale e aperto confronto sui rischi del
presente. Nel perenne paravento dell’antifascismo in assenza di fascismo, la
storia di una pseudosinistra che spesso ha finito con l’astrarsi pure dalla sua
missione storica, quella della difesa delle fasce sociali più deboli e del
lavoro. Un libro di 170 pagine suddiviso in brevi e frizzanti capitoletti, di
facile lettura e privo di approcci accademici o troppo complessi, fruibile da
tutti e capace di fare veramente luce su di un fenomeno, quello liberal e
politically correct, così importante nel presente dell’Europa ma ancora poco
conosciuto, soprattutto da chi tenta di costruire una alternativa.
Quei radical chic della
sinistra da salotto schierati dalla parte dei tassisti del mare…,
scrive Franco Busalacchi il 2 maggio 2017 su "I Nuovi Vespri". Sarà perché mio
nonno fu assassinato da un fascista, sarà perché mio zio ha fatto la resistenza
in Lombardia con in tasca la tessera del PCI firmata da Palmiro Togliatti, ma io
a questi nipotini di Bertinotti li manderei tutti, prima dell’alba, a
raccogliere pomodoro nelle serre e nei campi in sostituzione di quei migranti il
cui arrivo è per loro una benedizione. Sarà perché mio nonno fu assassinato da
un fascista e mio zio (suo figlio) fece la Resistenza, muovendosi per tutta la
Lombardia con in tasca una tessera del Partito comunista datata 1943, firmata da
Palmiro Togliatti e rinnovata nei due anni successivi, rischiando di essere
fucilato sul posto se l’avessero beccato; sarà per la conseguente aura che si è
respirata sempre in casa mia, ma quando io sento uno di questi nostri comunisti
con la barca e la erre moscia, mi incazzo come un animale. Tutti questi radical
chic, nipotini di Bertinotti, il quale ancora, tra una rivoluzione in salotto e
un’altra, percepisce una cospicua, aggiuntiva indennità come ex Presidente della
Camera dei deputati, io li porterei una bella mattina, prima dell’alba, a
raccogliere pomodoro nelle serre e nei campi in sostituzione di quei migranti il
cui arrivo è per loro una benedizione. Sepolcri imbiancati che fanno del
buonismo a buon mercato una bandiera con la quale coprono la loro ipocrisia.
Tutti dalla parte dei tassisti del mare che speculano sulle disgrazie altrui. A
questo si è ridotto il messaggio del Sol dell’avvenir: “Impossibilitati fare
rivoluzione per mancanza tempo, auspichiamo e ribadiamo… Ci vediamo stasera da
Giangi”. Ve li immaginate questi manichini azzimati capeggiare una sfilata (non
una marcia, ovviamente) contro la Beretta, la Agusta, la Oto Melara, gruppi
economici che vendono armi a quelli che sparano sulle popolazioni che sono
costrette lasciare i loro Paesi? Per carità! Troppo complicato. “Primavera
d’intorno brilla nell’atria e per li vampi esulta. E’ tempo di granite e di
brioscine. Al bar si pontifica meglio davanti ad un Cuba libre ornato di un
parasole in miniatura.
Se li sentisse Lèon Bloy!
Quel razzismo immaginario
dei radical-chic.
L’escalation della cacciata degli italiani è talmente evidente
che i buonisti replicano solo con la solita accusa ad minchiam di razzismo,
scrive Ennio Castiglioni il 28 Aprile 2017 su "Il Populista". Pascale Bruckner
ci ha spiegato come esista un “razzismo immaginario”. Per soffocare la libertà,
il dibattito si grida subito al razzismo e si trascinano le persone in tribunale
come nei regimi totalitari. I Governi e le multinazionali ci vogliono così
nascondere come sia in atto un piano per modificare profondamente l’occidente e
far sparire gli italiani. Se vi sembra poco…Mentre dalla Libia, dove ci
sarebbero tra 700mila e un milione di migranti, continua l’invasione con ben
37mila arrivi nei mesi più freddi dell’anno, il Governo con grande solerzia
prepara l’accoglienza. È scritto a chiare lettere nel DEF (Documento di economia
e finanza) 2016 l’intento di favorire, piuttosto che arrestare questo esodo
mirato. Si cerca di reperire le risorse necessarie a sostenere un flusso
migratorio di circa 310mila unità, con un profilo crescente per i prossimi 15
anni. L’escalation della cacciata degli italiani è talmente evidente che si può
replicare solo con la solita accusa ad minchiam di razzismo. Se nel 1994 gli
immigrati regolari erano 500mila, nel 2016 sono oltre 5 milioni e si vuole
consentire l’ingresso ad altri 310mila all’anno per i prossimi 15 anni, nel 2031
ci saranno quasi 10 milioni di immigrati, il 17% della popolazione, mentre chi
avesse la fortuna (o la sfiga) di campare fino al 2065 vivrà in un’Italia dove
uno su tre sarà immigrato. Ormai le navi delle varie Ong non si limitano più al
salvataggio in mare, ma si spingono nelle acque libiche dove regolarmente
prelevano i migranti per trasportali sulle coste italiane. Il tutto con la
complicità dei canali di informazione ufficiali e con un Governo che si guarda
bene dal mobilitare la Marina Militare o la Guardia Costiera. Molti politici
italiani, mentre si fingono commossi di fronte alle immagini di morte nel Canale
di Sicilia continuano ad essere al servizio delle multinazionali, che versano
enormi somme di denaro alle loro Fondazioni. Queste immense società dove il
profitto e la speculazione finanziaria hanno ormai oscurato la figura dell’uomo
e cancellato ogni questione morale, necessitano di un costante apporto di
manodopera a basso costo, di giovani braccia da sfruttare. Se diamo un’occhiata
oltre Oceano vediamo ben 97 società del settore tech, Apple, Google, Facebook,
Microsoft, Netflix, Snap e così via, che hanno chiesto ai tribunali di bloccare
l’esecuzione dei decreti presidenziali, voluti da Donald Trump, per regolare
l’immigrazione. Avrebbero potuto avanzare al grido “Non toglieteci gli schiavi!”
L’Italia, se non dovesse accadere qualcosa, ad esempio un Governo a guida
Salvini, diventerà ben presto un Paese di braccianti africani, di religione
islamica, da utilizzare per pochi euro all’ora. Chi dice questo viene accusato
di essere uno sporco razzista? Beh, francamente, con la posta in gioco, chi se
ne frega!
Il Politicamente corretto
ha ucciso la cultura occidentale,
scrive Francesco Giubilei su "Il Giornale il 13 novembre 2015. Uno dei
principali mali della nostra società – forse il più profondo e grave perché
subdolo, ramificato e stratificato – è il politicamente corretto. Una vera e
propria dittatura – come recita il sottotitolo del libro di Annalisa Chirico che
tratta di tutt’altro argomento “contro la dittatura del politicamente corretto”
– che è diventata ancor più evidente con il web. Perché in una società di
tuttologi, di esperti in ogni settore dello scibile umano, in un bar sport a
cielo aperto come è diventata la società del XXI secolo, avere posizioni che
contrastano il pensiero comune non è ormai più concesso, in barba alla
democrazia. Criticare la visione della massa porta ad essere tacciati come snob
o, peggio ancora, con un paradosso che stento a comprendere, di essere
antidemocratici. Perché sostenendo posizioni scomode o non omologate, si offende
l’altrui libertà. Così non è più possibile pubblicare sui social la foto di una
cena a base di maialino arrosto perché si offende la sensibilità dei vegani, non
si può più pubblicare un crocifisso perché si è irrispettosi verso le altre
religioni. Il risultato è quello di annichilire la nostra storia, le nostre
tradizioni e la nostra cultura, creando una società senza valori e identità e
quindi senz’anima. Proprio in questi giorni sono avvenuti due episodi in tal
senso sconcertanti, uno negli Stati Uniti e uno nel nostro paese. La celebre
catena di caffetterie Starbucks ha deciso di eliminare la scritta “Merry
Christmas” dalle tazze di Natale per rispettare le altre credenze religiose. Mi
chiedo a questo punto quale sia l’utilità delle tazze natalizie se non si
celebra il Natale, ah già il denaro… L’episodio accaduto a Firenze è invece
ancor più grave e preoccupante: “le crocifissioni di Chagall e Guttuso, la pietà
di Van Gogh, la via crucis di Fontana potrebbero urtare <la sensibilità delle
famiglie non cattoliche>, e per questo le terze classi dell’elementare Matteotti
di Firenze non andranno a visitare la mostra dove queste opere sono esposte,
cioè la ‘Bellezza Divina’ a Palazzo Strozzi”, scrivono Adinolfi e Bocci su la
Repubblica. Siamo giunti al punto che anche le opere d’arte di alcuni dei
principali artisti al mondo possono urtare la sensibilità dei credenti di altre
religioni, non resta che abbattere chiese e monumenti per evitare che possano
creare fastidi e malumori.
Firenze, la mostra con le
tele di Chagall e Van Gogh vietata ai bimbi della scuola: "Urta i non
cattolici".
I genitori
contro la scelta del consiglio interclasse delle terze elementari dell'istituto
Matteotti di fermare la gita all'esposizione "Divina Bellezza" sul rapporto tra
arte e sacro. Il preside: "Nessun motivo religioso, la programmazione è ancora
in corso". Inviato un ispettore del Miur, scrivono Gerardo Adinolfi e Valeria
Strambi il 12 novembre 2015La
Crocifissione bianca di Chagall, il quadro preferito da Papa Francesco che per
l'occasione della sua visita a Firenze era stato spostato da Palazzo Strozzi al
Battistero, non potrà essere visitato dagli alunni della terza elementare della
scuola Matteotti del capoluogo toscano. E così neanche la Pietà di Van Gogh, la
Crocifissione di Guttuso, l'Angelus di Millet e le altre cento opere della
mostra Divina Bellezza. Ai bambini dell'istituto così non sarebbe concesso di
conoscere le sculture di Fontana, ma anche i quadri di Munch, Picasso, Matisse
che, nell'esposizione fiorentina, riflettono sul rapporto tra arte e sacro
avendo come filo conduttore proprio il tema della religione. La gita per gli
alunni del Matteotti è vietata. Il motivo? "La visita è stata annullata per
tutte le terze per venire incontro alla sensibilità delle famiglie non
cattoliche visto il tema religioso della mostra", si legge, secondo quanto
riporta il quotidiano La Nazione, dal verbale della riunione del consiglio
interclasse dello scorso 9 novembre redatto da un rappresentante di classe e
distribuito a tutti i genitori. Con le proteste partite proprio da molte
famiglie arrabbiate dalla decisione: "I nostri figli non potranno più studiare
storia dell'arte, basata proprio sull'arte sacra? - si sono chiesti i genitori
contrari al divieto - siamo a Firenze, vedremo quindi negare le gite a Santa
Croce, in Duomo e agli Uffizi perché ci sono figure sacre?". Domande poste anche
al preside dell'Istituto Alessandro Bussotti che però ribatte alle accuse e
spiega: "La visita non è stata annullata perché nessuna visita era
precedentemente stabilita, la programmazione è ancora in corso e non è detto che
non si faccia. Una classe delle medie dell'Istituto comprensivo la farà. Se gli
insegnanti nella programmazione avevano deciso di non farla sicuramente non è
stata per motivazioni religiose. Tutti indipendentemente dalla fede devono poter
godere delle bellezze dell'arte". Ribattono anche gli insegnanti delle terze del
Matteotti: “L’inclusione, o meno, di visite a mostre o musei non ha motivazioni
di ordine religioso, ma esclusivamente di natura didattica, nell’ambito
dell’attività di progettazione, che è propria della libera espressione
dell’attività docente, in relazione all’efficacia della ricaduta sul processo di
apprendimento degli allievi.” Cosa sia successo nel consiglio di interclasse
spetterà dunque scoprirlo ad un ispettore del Miur che arriverà forse già domani
da Roma alla scuola elementare di viale Morgagni per fare luce sul caso. A
confermare l'ispezione è stato il direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale della Toscana Domenico Petruzzo. "Stamani - ha affermato Petruzzo -
ci siamo sentiti con l'ispettore" che arriverà alla scuola "al più presto, forse
domani". "Dobbiamo vigilare e avere cognizione del caso in modo preciso" ha
continuato il direttore dell'Usr Toscana, spiegando che "occorre riserbo" fino a
che non saranno "accertate con precisione le cose come stanno". Al termine degli
accertamenti, ha detto ancora, "saranno prese le misure per le responsabilità
che ci sono". Di sicuro c'è che quelle tre righe in uno dei quattro verbali sono
state scritte, e diffuse tra i genitori. Se è vero che una scuola fiorentina ha
annullato la visita degli alunni ad una delle più belle mostre fiorentine di
arte sacra degli ultimi anni 'per venire incontro alla sensibilità delle
famiglie non cattoliche' saremmo davanti ad un fatto quantomeno insensato. Non
solo perché siamo da sempre la città del dialogo interreligioso, ma anche perché
sarebbe un errore grossolano escludere dalle scuole la fruizione del nostro
patrimonio di storia e cultura che comprende oggettivamente anche l'arte sacra,
che per forza di cose da noi è arte cristiana", ha detto il sindaco di Firenze
Dario Nardella. "Senza togliere che alla mostra "Bellezza divina", accolta in
Palazzo Strozzi vi sono mirabili pitture del grande Chagall che proprio
cattolico non è! A volte mi chiedo... ma a cosa pensano certi insegnanti? - va
avanti il sindaco - Forse che io, cattolico, non possa fare una gita ad
Istanbul o a Tel Aviv perché queste città ferirebbero il mio credo?". Forza
Italia parla invece di "Follia ideologica" mentre la Lega Nord ha organizzato
una protesta pacifica all'esterno della struttura per la prossima settimana.
L'ARTE SACRA VIETATA A SCUOLA: LA STUPIDITÀ DI UN DIVIETO.
Alla scuola elementare Matteotti di Firenze è stato deciso di non far visitare
la mostra “Bellezza Divina” in corso a Palazzo Strozzi con opere di Van Gogh,
Guttuso, Matisse, Picasso e la celebre Crocifissione Bianca di Chagall per non
urtare la sensibilità dei non cattolici visto il tema religioso. Allora si
dovrebbero eliminare tutte le gite ai musei italiani ed europei e togliere la
storia dell’arte dai programmi, scrive Antonio Sanfrancesco il 12 novembre 2015
su “Famiglia Cristiana”. Quando l’ideologia, unita alla mancanza di buonsenso,
entra nelle scuole accadono cose assurde. È il caso della scuola elementare
Matteotti di Firenze dove
il consiglio interclasse del 9 novembre scorso, come riferisce La
Nazione, ha deciso di annullare per tutte le classi terze della
scuola la visita già programmata alla mostra “Bellezza Divina” allestita a
Palazzo Strozzi. Il motivo? «Per
venire incontro alla sensibilità delle famiglie non cattoliche visto il tema
religioso della mostra», recita il verbale della riunione redatto da un
rappresentante di classe. Nell'esposizione si possono ammirare oltre cento opere
di celebri artisti italiani che vanno da metà Ottocento al Novecento tra cui
capolavori famosissimi come l’Angelus di
Jean-François Millet, eccezionale prestito dal Musée d’Orsay di Parigi, la Pietà di Vincent
van Gogh dei Musei Vaticani, laCrocifissione di Renato
Guttuso delle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma,
laCrocifissione
bianca di Marc Chagall,
proveniente dall’Art Institute di Chicago. Più altre opere di artisti del
calibro di Gaetano Previati, Felice Casorati, Gino Severini, Renato Guttuso,
Lucio Fontana,Pablo Picasso, Max Ernst, Stanley Spencer, Georges Rouault, Henri
Matisse. I non cattolici potrebbero aversene a male, e quindi meglio non far
conoscere nulla ai ragazzi. In base a questo scellerato principio, anche la
storia dell’arte dovrebbe essere bandita dai programmi scolastici visto che la
stragrande maggioranza di essa è sacra e ha per tema la religione cristiana. A
scuola non si dovrebbe studiare la Commedia di
Dante e – per restare a Firenze – dovrebbero essere abolite anche le gite in
Duomo, in Santa Croce o gli Uffizi dove le immagini sacre di certo non mancano.
Se così fosse, i cristiani che vanno a Istanbul non potrebbero visitare la
Moschea Blu o ammirare un tempio induista in India. Il preside dell’Istituto, Alessandro
Bussotti, ha fatto sapere che non era presente alla riunione spiegando
che «l’eventuale esclusione della visita non ha motivazioni religiose e non è
escluso che la mostra possa essere reinserita nei programmi didattici se non di
tutte, almeno di alcune classi». A completare il quadro di una vicenda
inquietante e grottesca insieme c’è il commento, di assoluto buonsenso,
dell’imam di Firenze, Izzedin
Elzir, che ha detto che andrà a vedere la mostra e che il Crocifisso «non
offende nessuno ed è il simbolo di una fede religiosa che rispettiamo». Di
scelta «insensata» parla il sindaco di Firenze Dario
Nardella: «Alla mostra», ha scritto in un post su Facebook, «vi sono
mirabili pitture del grande Chagall che proprio cattolico non è! A volte mi
chiedo...ma a cosa pensano certi insegnanti? Forse che io, cattolico, non possa
fare una gita ad Istanbul o a Tel Aviv perché queste città ferirebbero il mio
credo?».
Il direttore del museo:
"Vietare la mostra? All'estero non sarebbe mai successo".
Arturo Galansino,
direttore generale di Palazzo Strozzi: "Quando l'ho saputo sono rimasto
interdetto. Vieteranno anche i lavori di Michelangelo e Leonardo perché trattano
di arte sacra?", scrive Giovanni Masini Venerdì 13/11/2015 su "Il Giornale”.
Quando lo raggiungo al telefono, Arturo Galansino sembra più divertito che
altro. Il giovane direttore generale di Palazzo Strozzi, fresco di nomina (è a
Firenze da marzo, in precedenza aveva lavorato a Louvre e National Gallery, ndr),
non si capacita della bufera che si è scatenata dopo che a una scolaresca
fiorentina è stato vietato di visitare la mostra sull'arte sacra allestita
proprio nel suo museo per "non offendere i bimbi non cattolici".
D'altronde il politicamente
corretto è eccepito solo alla controparte politica.
Cristo nell'urina: l'opera
scandalo patrocinata dalla regione Toscana.
L'opera di
Andres Serrano verrà esposta al Photolux Festival di Lucca e ritrae un
crocifisso in un bicchiere di urina. L'ira della Lega Nord, scrive Giuseppe De
Lorenzo Venerdì 13/11/2015 su “Il Giornale”. Un crocifisso, simbolo non solo di
una religione ma anche della cultura italiana ed europea, immersa nell'urina.
Chiamatela pure arte. Ma blasfema. Al Photolux Festival di Lucca, dal 21
novembre al 13 dicembre prossimi, verrà esposta "Piss Chirst", una fotografia
realizzata da Andres Serrano, fotografo statunitense, che ha immortalato un
crocifisso immerso in un bicchiere pieno della sua urina. Sono anni che l'opera
crea scandalo. Succede dalla sua prima esposizione nel lontano 1987 negli Usa.
In quel caso due senatori repubblicani portarono il caso anche in Parlamento. Da
noi, invece, il Pd ha deciso addirittura di patrocinare la mostra in cui verrà
esposta. Il simbolo della regione Toscana, infatti, campeggia su volantini e sul
sito della mostra internazionale di di fotografia. A denunciare il fatto sono
stati due esponenti locali leghisti in una nota: "È inammissibile - affermano i
consiglieri regionali Manuel Vescovi ed Elisa Montemagni - che si sostengano
iniziative di questo genere, dove vengono esposte opere che offendono
pesantemente il cristianesimo. Un'opera che umilia Cristo e rende omaggio
all'Islam". Gli esponenti leghisti annunciano che durante il festival
"organizzeranno un presidio davanti alla sede della mostra per esprimere il
nostro totale dissenso. Invitiamo i cittadini toscani ad unirsi a noi in questa
forma di pacifica protesta che vuole difendere le nostre profonde radici
cristiane". Secondo il direttore del festival, Enrico Stefanelli, invece,
l'opera ha pieno diritto ad essere esposta. "Lo spirito del festival - ha detto
- è quello dell'equilibrio in un contesto di libertà". "Quell'opera - continua -
non è nata come un oltraggio o una contestazione del Cristo, quanto piuttosto
della mercificazione delle immagini. Poi dobbiamo collocarla nel periodo storico
in cui è stata realizzata, negli anni '80". Sarà. Ma mentre il crocifisso
nell'urina merita di essere visto e pubblicizzato, solo ieri in una scuola
di Firenze ad alcuni bambini è stata vietata la mostra con dipinti raffiguranti
il Cristo perché i crocifissi "urtano i non cattolici". Allora facciamo una
proposta: si annulli anche questa che urta i cattolici. Anche se già sappiamo
che i buonisti ci diranno di no ed utilizzeranno i soliti due pesi e due misure.
Le ragioni dei cattolici, per loro, non hanno ragione d'esistere.
Al contrario.
“Carabiniere spara”: la
canzone controcorrente indigesta ai buonisti.
Il singolo
di Matteo Greco in difesa del diritto delle forze dell'ordine di sparare per
fare il loro lavoro è stata sommersa dagli insulti della sinistra, scrive
Giuseppe De Lorenzo Venerdì 13/11/2015 su “Il Giornale”. “Mi sento un
cantautore controcorrente. So bene che questo non mi renderà famoso. Ma non
importa”. Matteo Greco non ne è irritato. La sua canzone “Carabiniere spara” ha
provocato reazioni stizzite dalla maggioranza degli ascoltatori. “Perbenisti”,
li chiama lui. Ma se ne farà una ragione: sa bene che il successo è più facile
con un testo buonista, piuttosto che di buonsenso. L’ultimo singolo del
cantautore di Falconara Marittima è diventato famoso, suo malgrado, per la
quantità di insulti ricevuti. Il motivo è tutto - o quasi - nel titolo: “Carabiniere
spara”. Spara ai ladri che rendono impossibile la vita nelle città. Spara
(metaforicamente) al governo che non fa nulla per cambiare le cose. E così è
stato messo all’indice dalle varie sinistre, culturali e non. Gli hanno dato del
razzista, istigatore d’odio e c’è anche chi ha avanzato denuncia alla procura
della Repubblica per apologia di reato. La canzone, la cui musica può piacere o
meno, lancia un messaggio semplice su sicurezza e immigrazione. “La cittadinanza
non si può regalare - afferma Greco - bisogna conquistarsela. Per ridurre la
criminalità è necessario gestire l’immigrazione con maggiore intelligenza”.
Concetto reso chiaro sin dalla prima strofa: “Spiegami cosa ci fa un uomo con
machete in mano, nessuno che lo può fermare, nessuno che gli può sparare”.
Da cosa nasce questa
canzone?
“Da due casi di cronaca.
Quello di Milano, quando Kabobo ha creato il panico con il suo machete. E la
vicenda molto simile di Jesi, dove un ragazzo sfondò la vetrina di un negozio,
prese due machete e si mise a camminare per tutto il centro storico. Venne
fermato da un carabiniere - quello della canzone - che aveva la pistola in mano,
ma non sparò”.
A lui rivolgi un complimento: “Tanto onore a te”. Perché allora
il titolo della canzone sembra biasimare la scelta di non aver aperto il fuoco?
“Bisogna partire dal
principio. Una cosa simile non dovrebbe succedere: il poliziotto non dovrebbe
essere messo nelle condizioni di usare le armi. Questo è (sarebbe) il ruolo
dello Stato, che però non sta assolvendo al suo compito”. Ma quel carabiniere
avrebbe dovuto sparare, sì o no? “Cristianamente dico che una vita risparmiata è
sempre una vittoria. Il gesto che io richiamo nella canzone, “Carabiniere
spara”, più che una richiesta è un avvertimento. Se non verranno trovate delle
soluzioni, se i cittadini continueranno a sentirsi insicuri, saranno costretti a
farsi giustizia da soli. Il mio grido è un allarme: bisogna permettere alle
forze dell’ordine di fare il loro mestiere”.
Le forze dell’ordine si
sentono frustrate dall’impossibilità di garantire la sicurezza dei cittadini.
“Sono anni che sento
poliziotti e carabinieri lamentarsi di essere in trincea con mezzi
insufficienti. Agenti che perdono un’intera giornata a identificare un
malvivente, che rischiano la vita per arrestarlo e poi lo vedono il giorno dopo
fuori di prigione. Inutile lamentarsi poi delle città insicure”.
Te la prendi anche con il
governo “che non dice niente”.
“Il Governo è colpevole di non
aver messo al primo posto la sicurezza e la tutela della vita dei cittadini.
Sembra essere distante dalla vita reale, è percepito assente”.
Perché i “buonisti”, come
li chiami tu, ti hanno criticato così tanto?
“La gente non ragiona.
Preferisce stare con gli occhi bendati e coccolarsi nei bei pensieri buonisti.
Bisogna invece essere razionali. Parlare di difesa significa focalizzarsi sulla
vita di una persona. Pensiamo agli anziani, che hanno pagato anni di tasse per
ritrovarsi obbligati a stare chiusi in casa perché se escono rischiano di essere
rapinati o aggrediti. E’ questa l’Italia per cui hanno lavorato? A me questo
Paese non va più bene. E l’ho cantato”.
Nel testo dici di “rivolere
la mia Italia, una città libera”.
“Il nostro è un Paese non più
libero di essere vissuto. La mia Italia, invece, è quella in cui i ragazzini
sono di nuovo padroni delle loro piazze e i nonni delle loro panchine.
Qualcuno ti avrà spiegato
però che non è il tipo di canzone con cui si diventa famosi.
“Lo so benissimo. Ma io scrivo
quello che penso. So di andare controcorrente, ma sono anche fiero di essere
riuscito a coinvolgere le forze dell’ordine. Ho ricevuto tantissimi messaggi di
apprezzamento di agenti, poliziotti o soldati. Una volta l’ho anche fatta
ascoltare in piazza ad alcuni carabinieri”.
E come hanno reagito?
“Con un semplice ‘grazie’. Che
vale più di mille parole. E pensare che tra i passanti che mi hanno sentito
suonare e che si sono fermate, c’erano soprattutto stranieri. Questo sa cosa
vuol dire?” Mi dica. “Che nel loro Paese sono abituati a far rispettare le
regole. Solo in Italia vale il contrario”.
A proposito della foto del
ministro Marianna Madia pubblicata su "Chi" con il titolo "con il gelato ci sa
fare". c'è chi scrive Madia-Signorini: giù le mani dal pompino! Scrive Fulvio
Abbate su “Il Garantista”. Giù le mani dal pompino! Ecco, di fronte alla
querelle Signorini-Madia, volendo essere epici, ma ancora di più sinceri,
onesti, popolari, bisognerebbe dire subito così, affermando questa semplice
verità, quasi un bisogno di liberazione dalla falsità, perfino dall’ipocrisia
virtuosa da educandato o perfino terrazza di sinistra. E ancora di più,
occorrerebbe aggiungere abbasso ogni forma di allusione, assodato che alludere
in certi casi, quando c’è di mezzo il piacere, il corpo, la realtà genitale,
cioè la fica e il cazzo, significa innanzitutto non consentire a un concetto di
liberamente volare, quasi che dovessimo vergognarci d’aver semplicemente
chiamato una certa cosa, un certo atto, con il suo nome proprio. Dunque, così
come una rosa è una rosa, una fellatio è una fellatio, un pompino è un pompino,
un cazzo, una fica, ecc…Per questa ragione, sebbene ne abbiamo appena
pronunciato la parola, talvolta è davvero da ipocriti dire fellatio, quasi a
voler nascondere dietro la grazia remota e letteraria di un affresco pompeiano
la realtà delle cose, la realtà concreta del pompino, come atto di piacere e
d’amore. Di voglia. Punto. Al di là di chi lo pratica e dei sessi implicati,
cioè in questione. Volendo restare in ambito storico, c’è stato un tempo in cui
molti infelici, forti di una cultura da bordello, erano assolutamente convinti
che quella del pompino fosse una pratica “degradante”, non a caso le prostitute,
attribuendo loro un tratto razzista, erano dette e ritenute anche “pompinare”,
quasi come un titolo-marchio di felice e necessaria infamia, un Collare della
Santissima Annunziata ulteriore, lì a garantire le loro prerogative, la loro
abiezione quasi, e tuttavia doverosa. Menzogne, tutte bugie, tutti e tutte,
uomini e donne, amano i pompini: farli e averli fatti, riceverli e offrirli.
Tutte sciocchezze da antichi tabù da sottoscala o refettorio cattolico
concentrazionario sessuofobico che tutto ciò non sia vero. Per questa ragione le
allusioni alle foto della ministra Marianna Madia che lecca un cono gelato sono
innanzitutto desolanti, così come lo è altrettanto, se non di più, l’idea
d’essere in presenza di una lesa maestà per il fatto stesso di avere associato
quel gelato all’atto sessuale di cui sopra. Anche il manifesto di “Lolita” con
la ragazza Sue Lyon che, armata di occhiali a forma di cuore, tiene tra le
labbra un lecca-lecca alludeva, e tuttavia quelle immagini nella loro allusione
sembravano esser lì a tracciare un ideale arcobaleno di piacere nel cielo della
consapevolezza sessuale. Fa davvero specie che i volti sfigurati dei bambini
morti in guerra non facciano suonare la stessa sirena dello sdegno pieno, così
come invece accade con il pensiero stesso di un coito orale. Ripeto: nulla è più
penoso della cultura rionale dell’allusione, dell’ammicco, del doppio senso di
cui si è nutrito l’avanspettacolo del peggiore casino per decenni, forte di
canzoni come “Ai romani piaceva la biga, più dinamica della lettiga” o del poema
di Ifigonia e delle sue ancelle che “nell’arte di fare pompini battevano le
troie di tutti i casini”, e giù con le risate, e giù a ridere ancora con la mano
sul “pacco” – ma è ancor più ripugnante pensare che si debba rigorosamente
arrossire o magari provare sdegno davanti a un qualcosa che appartiene
all’immaginario desiderante, cioè del piacere, dunque della condivisione, poiché
in nome di un sacro codice ipocrita si è ritenuto che si tratti di cose
indicibili. Anni fa, ragionando nero su bianco sulla sparizione del cosiddetto
69 su un quotidiano, mi ritrovavo a constatare che quel genere di doppio scambio
era pressoché svanito dal palmarès delle predilezioni condivise, al contrario,
volate via le vecchie bugie sessuofobiche della cultura da bordello, la fellatio
– cioè il pompino o bocchino o pompa – e chiamarli qui con il loro nome è
innanzitutto un fatto politico, liberatorio, viveva invece intatto e acclamato
sull’ideale tabellone luminoso delle predilezioni, dei desideri, delle voglie,
per questa ragione non c’è davvero scandalo nelle immagini di Marianna Madia
felice del suo gelato da leccare, così come non c’è scandalo nell’affiancare
quelle stesse foto al già citato manifesto del film di Kubrick. Giù le mani!
Il mondo è una community sui
social network. Nessuno comunica più fisicamente. L’anonimato sui social ci
protegge. Fisicamente non ci rimane che comunicare a gesti, oppure conformarsi
al politicamente corretto di sinistra o al bacchettone bigotto di destra.
Riportiamo l'opinione del Dr
Antonio Giangrande, sociologo storico e noto saggista, autore della collana
editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo".
La virtualizzazione della
società si fa sentire in molti aspetti della nostra vita quotidiana. Uno degli
ambiti in cui è più presente, e spesso ha effetti più limitanti, è quello della
comunicazione fra mezzi d’informazione e pubblico, fra istituzioni e cittadini,
fra cittadini e altri cittadini.
Era della comunicazione dove
non comunichiamo. Questo paradosso la dice lunga e ci avverte che non si ascolta
più, si parla e basta.
Leggiamo sui giornali o
ascoltiamo in televisione, morto per overdose…, si uccide perché va male a
scuola, bambino di tre anni ucciso in circostanze misteriose,…, figli che
uccidono i genitori, madri che uccidono i figli e quel che è incredibile è che
le persone si stanno abituando ai fatti negativi. Divenendo negativi essi
stessi. Abitudine che potrebbe essere la punta di un iceberg, dove sotto c’è un
vuoto di valori causato anche da una generazione che è riuscita a mettere in
discussione tutto e il contrario di tutto.
Sono andati in crisi le
istituzioni, la chiesa, la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro e siamo
senza un collante per regole e certezze e la community virtuale è la nostra
isola felice dove sfogarci.
Ci indaffariamo a cercare
amici sui social e ad aumentarne il numero sui nostri profili per avere
visibilità e proseliti, per poi scoprire che proprio amici non sono. Ostilità od
indifferenza sono le loro caratteristiche. Le nostre caratteristiche, perchè
loro siamo noi.
Recentemente, ci sono stati
diversi casi di chiusura di account legati a minacce ed offese sui principali
social network. Non ultimo, il direttore del TG di La7, Enrico Mentana, che ha
deciso di cancellare il proprio profilo Twitter a causa di continui insulti.
Personaggi noti, del mondo dello spettacolo e non, denunciano quasi
quotidianamente questo fenomeno dilagante. Insulti gratuiti, minacce, gravi
offese e istigazioni alla violenza di ogni genere. C'è un po' di tutto nei
social network più famosi. Chiunque, sui social network, inserisce ciò che
vuole: considerazioni su politica, personaggi dello spettacolo, link divertenti,
video divertenti, fotografie, aggiornamenti di stato….
Questo popolo social ciarlante
ed imperito, spesso, vuol far politica......
Il paradosso è che il potere
si difende punendo questi comportamenti, con l'intento di renderci tutti
conformisti.
Conformista come già cantò
Giorgio Gaber
"Io sono un uomo nuovo,
talmente nuovo che è da tempo che non sono neanche più fascista.
Sono sensibile e altruista,
orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista.
Da un po' di tempo
ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti
socialista.
Io sono un uomo nuovo, per
carità lo dico in senso letterale.
Sono progressista, al tempo
stesso liberista, antirazzista e sono molto buono, sono animalista.
Non sono più assistenzialista,
ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista.
Il conformista è uno che di
solito sta sempre dalla parte giusta.
Il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che
tiene sotto il braccio due o tre quotidiani e quando ha voglia di pensare, pensa
per sentito dire.
Forse da buon opportunista, si
adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso.
Il conformista è un uomo a
tutto tondo che si muove senza consistenza.
Il conformista s'allena a
scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive
di parole da conversazione.
Di notte sogna e vengon fuori
i sogni di altri sognatori, il giorno esplode la sua festa che è stare in pace
con il mondo e farsi largo galleggiando.
Il conformista, il
conformista.
Io sono un uomo nuovo e con le
donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista
Son disponibile e ottimista,
europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista.
Ero marxista-leninista e dopo
un po' non so perché mi son trovato cattocomunista.
Il conformista non ha capito
bene che rimbalza meglio di un pallone.
Il conformista aerostato
evoluto, che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola
sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente
realizzato.
Vive e questo già gli basta e
devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi.
Il conformista, il
conformista.
Io sono un uomo nuovo,
talmente nuovo che si vede a prima vista sono il nuovo conformista."
Non so più dove
girarmi. Giornali on line e non, social network, radio, tv…Non
c’è scampo: il buonismo dilaga ovunque. Un buonismo fintissimo: quello
politicamente corretto.
Perché oggi, in Italia, se
critichi qualsivoglia malvivente sei razzista (se è straniero).
Sei intollerante (se è
italiano).
Sei sessista (se è un uomo e
tu una donna, e viceversa).
Sei cattivo (se è un essere
umano).
Dobbiamo essere tutti bravi,
altruisti e generosi. Comprensivi, giusti e dalla mente aperta. Certo che
dobbiamo! Ma non significa certo che dobbiamo anche giustificare tutto e tutti o
conformaci alla cultura mediatica che va per la maggiore.
Potremmo esprimere il nostro
pensiero con un linguaggio che nel gergo quotidiano è consentito, mentre se
diffuso a mezzo stampa è definito scorretto?
Potremmo esprimere
un'opinione, senza essere tacciati come discriminatori?
La discriminazione consiste in
un trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o un gruppo
di individui in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria.
Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il sessismo, lo
specismo e l'omofobia.
L'espressione politicamente
corretto (traduzione letterale dell'inglese politically correct) designa
una linea di opinione e un atteggiamento sociale di estrema attenzione al
rispetto generale, soprattutto nel rifuggire l'offesa verso determinate
categorie di persone. Qualsiasi idea o condotta in deroga più o meno aperta a
tale indirizzo appare quindi, per contro, politicamente scorretta (politically
incorrect). L'opinione, comunque espressa, che voglia aspirare alla
correttezza politica dovrà perciò apparire chiaramente libera, nella forma e
nella sostanza, da ogni tipo di pregiudizio razziale, etnico, religioso, di
genere, di età, di orientamento sessuale, o relativo a disabilità fisiche o
psichiche della persona.
Insomma, politicamente
corretto significa ipocrisia.
"L'ipocrisia è il linguaggio
proprio della corruzione". Lo afferma Papa Francesco, nell'omelia durante la
messa mattutina celebrata nella cappella della Domus Santa Marta in Vaticano,
presenti fra gli altri i vertici della Rai, con la presidente Anna Maria
Tarantola e il direttore generale Luigi Gubitosi. "L'ipocrisia - sottolinea il
Papa, facendo riferimento alla pagina del Vangelo sulla domanda dei farisei
sulla liceità del tributo da dare a Cesare - non è un linguaggio di verità,
perché la verità mai va da sola, mai, ma va sempre con l'amore. Non c'è verità
senza amore, l'amore è la prima verità e se non c'è amore non c'è verità". I
farisei, gli ipocriti, "vogliono invece una verità schiava dei propri interessi;
l'amore che c'è è quello di se stessi e a se stessi: quell'idolatria narcisista
li porta a tradire gli altri, li porta agli abusi di fiducia". Francesco punta
il dito sui falsi amici che "sembrano tanto amabili nel linguaggio", sui
"corrotti che con questo linguaggio cercano di indebolirci". Infatti, "gli
ipocriti che cominciano con la lusinga, con l'adulazione, finiscono cercando
falsi testimoni per accusare chi avevano lusingato. Il nostro linguaggio -
conclude il Papa - sia il parlare dei semplici, con anima di bambini, il parlare
in verità dall'amore".
Il politicamente scorretto è
tale, però, ad intermittenza.
Sto pensando agli epiteti che
sono stati lanciati ad Andreotti sulla sua scoliosi, a Berlusconi o Brunetta per
la loro altezza, Alfano per il suo viso... etc. La scusa sciocca della satira
non basta: anche al sesso maschile (o femminile purchè del campo avverso)
vengono riservate considerazioni sgradevoli. Vogliamo fare una carrellata che
non ha scandalizzato stranamente nessuno?
"Condoleezza [Rice], con
quelle guancette da impunita, è la leader maxima delle donne-scimmia" (Lidia
Ravera, L'Unità, 25 ottobre 2004).
"Di sicuro [il Ministro
Gelmini] non è un essere umano. Dovremmo chiamare i professori di chimica per
capire che cos’è" (Andrea Camilleri).
"Se dopo De Nicola, Pertini e
Fanfani, ci ritroviamo con Schifani, sono terrorizzato dal dopo: le uniche forme
residue di vita sono il lombrico e la muffa. Anzi, la muffa no perché è molto
utile" (Marco Travaglio).
Appari politicamente
scorretto, anche se non lo sei? Scatta l'invettiva, secondo l'accusa dei
giornalisti, anche per frasi o comportamenti innocenti.
L'invettiva razzista. Il caso
forse più noto tra quelli registrati, però, riguarda la televisione. Si tratta
della vicenda che ebbe per protagonista Paolo Bonolis il quale, nel corso della
trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro” ebbe la infelice idea di travestirsi
da domestico filippino e di esibirsi in una gag che scatenò la reazione
indignata della comunità filippina in Italia, stufa di essere considerata alla
stregua di un'associazione di camerieri e di donne di servizio. Romulo Sabio
Salvador, consigliere aggiunto di Roma Capitale, a nome dei suoi connazionali
scrisse una lettera indignata a Mediaset, all'Agcom e, appunto, all'Unar. E
proprio a proposito di filippini. Il presidente della Sampdoria parlando con
Massimo Moratii, ex presidente dell’Inter, ebbe a dire a proposito di Thohir, il
suo successore all’Inter: “caccia quel filippino”, giustificandosi poi con
Valerio Staffelli su Striscia La Notizia dicendo “l’ho saputo dalla televisione
che era indonesiano….”. Carlo Tavecchio, presidente FIGC, ha dichiarato: «Le
questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro.
L’Inghilterra individua i soggetti che entrano, se hanno professionalità per
farli giocare. Noi, invece, diciamo che Opti Poba - dice inventando un nome - è
venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare nella Lazio. E
va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo
pedigree». Tavecchio è stato punito dai media, dalla UEFA e dalla FIFA.
L'invettiva omofoba. Eziolino
Capuano, allenatore dell’Arezzo (Lega Pro), «Prendere gol in superiorità
numerica al 90’ è vergognoso, non lo accetto», ha detto a Radio Groove dopo la
sconfitta di Alessandria degli amaranto, e prima di esplodere: «Se avessero
perso in maniera diversa non avrei detto nulla, però in campo le checche non
vanno bene. In campo devono andare gli uomini con le palle e non le checche»
Capuano è stato crocifisso dai giornali. Ormai la lobby gay in Parlamento non
solo mira ad avere un matrimonio tutto loro ed avere figli non loro, ma sulla
comunicazione comune vieta ogni parola riferita alla loro condizione sessuale.
Più per gli uomini. Ormai è vietato dire quelli dell'altra sponda, quelli
dell'altra parrocchia e poi frocio, ricchione, finocchio, culo, culattone,
culano, culatino, bucaiolo, buso o busone, bardassa o bardascia, buggerone,
checca, cupio, garrusu, invertito, gay, urningo o uraniano, femminello,
mezzafemmina, pederasta, sodomita, invertito, pigliainculo.
L'invettiva sessista. Il
settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica quattro fotogrammi rubati del
ministro mentre mangia un gelato con il titolo “ci sa fare con il gelato” e
l'Ordine dei giornalisti apre un procedimento. "Uno schifo". "Qualcosa di
disgustoso". "Spazzatura". L'indignazione, a dir poco, esplode in rete insieme a
disgusto e incredulità per quattro fotogrammi rubati al ministro Marianna Madia,
e messi in doppia pagina su "Chi" con un titolo volgare e ammiccante. I tweet e
i post su Facebook sono migliaia. Due facciate che vengono "difese" proprio dal
direttore di Chi, Alfonso Signorini, che twitta: "Calippo si e gelato no?", con
l'ashtag #duepesiduemisure. Il riferimento è alle foto di Francesca Pascale
apparse nel febbraio 2013. Il riferimento non è puramente casuale, anzi è chiaro
e diretto al servizio pubblicato tempo fa da Oggi, gruppo Rcs, in cui venivano
riproposte vecchie immagini di Francesca Pascale che mangiava un Calippo nel
corso di una clip per una televisione locale. Il direttore di Chi
poi, intervistato da Giorgio Mulè alla presentazione del suo libro "L’altra
parte di me" nella tappa catanese del tour Panorama d’Italia, ha spiegato meglio
il suo pensiero: "Chi oggi s’indigna per il titolo che ho fatto alle foto della
Madia che mangia il cono gelato ha marciato per anni sul calippo della
Pascale. Io aderisco a una scuola di pensiero secondo cui la malizia sta negli
occhi di chi guarda e non di chi la fa, accusare me di sessismo o di
persecuzione a sfondo sessuale è assurdo, per non parlare di certe campagne
davvero infamanti, per usare la stessa parola che usano oggi contro di me, sulle
giarrettiere della Brambilla o il calendario della Carfagna".
L'invettiva pedofila. Del
resto oggi tutto ha il sapore di proibito, ma anche solo pensare di essere
amorevole con i figli, ti conduce subito sulla sponda più terribile: quella dei
genitori oggetto di riprovazione. È una categoria semplice, assoluta e
falcidiante. Ha il potere di bloccare l'azione sul nascere, perché influisce
direttamente sul pensiero: è la forza del politicamente corretto, che rovina
perfino i momenti di divertimento o di affetto. È il motivo per cui non si dà
più un bacio innocente o una carezza, agli adulti, così come ai bambini: passi
immediatamente per un maniaco o per un pedofilo. Ecco il motivo per cui i
bambini non giocano più nei cortili, non prendono più un ascensore da soli, non
possono giocare a palla in riva al mare, mentre è così difficile fermare i
piccoli sbandati o i delinquenti, quelli veri. Ed è molto più facile fare
sentire un genitore come un criminale, che fare divertire un bambino.
L'invettiva giudiziaria. Le
lacrime e la rabbia lasciano il posto alla determinazione. «Mi devono uccidere
per fermarmi», dice Ilaria Cucchi all’indomani della sentenza della corte di
appello di Roma che vede tutti assolti gli imputati per la morte del fratello
Stefano, deceduto il 22 ottobre di cinque anni fa dopo una settimana di ricovero
in ospedale. Una vicenda che ha provocato uno strascico di polemiche su cui
interviene anche il presidente della Corte d’Appello di Roma, Luciano Panzani:
«Basta gogna mediatica, non c’erano prove».
L'invettiva specista. Lo
specismo è l'attribuzione di un diverso valore e status morale agli individui a
seconda della loro specie di appartenenza. Il termine fu coniato nel 1970 dallo
psicologo britannico Richard Ryder, per calco da razzismo e sessismo, con
l'intento di descrivere in particolare gli atteggiamenti umani che coinvolgono
una discriminazione degli individui animali non umani, inclusa la concezione
degli animali come oggetti o proprietà. Il termine viene usato comunemente nel
contesto della letteratura sui diritti animali, per esempio nelle opere di Peter
Singer e Tom Regan. Succede spesso di leggere sui giornali o di vedere video su
youtube di incredibili salvataggi, per mano umana di animali (specialmente cani)
in difficoltà. Quello che però lascia perplessi è
leggere di un intervento simile proprio in un luogo come quello di Carloforte,
noto per la tradizionale mattanza dei tonni.
Questo salvataggio, se ci si sofferma un attimo a pensare, ha davvero
dell’incredibile. Uomini che si uniscono e si impegnano con tutte le loro
energie per salvare una vita da annegamento certo mentre stanno per calare le
reti che spezzeranno le vite, attraverso una lenta e dolorosa sofferenza, di
centinaia e centinaia di pesci. Purtroppo questo è lo specismo, che
quotidianamente e ovunque nel mondo continua a dilagare ma che dobbiamo cercare
di abbattere. Come per l'allevamento Green Hill, ovvero: la preoccupazione
riguarda solo i cani di Green Hill, non c'è nessuna condanna delle inenarrabili
crudeltà perpetrate in laboratorio su altri animali quali topi, ratti o maiali.
Era della comunicazione dove
non comunichiamo. Non si ascolta più, si parla e basta....
In conclusione. Come si può
non essere politicamente corretti e conformisti? Basta essere corretti e
veritieri nell’espressione del pensiero. Basterebbe abbeverarsi dal sapere dei
buoni maestri senza tema di smentita, pensare un attimo a quello che si dice o
si scrive e non vedere cose brutte in cose estremamente innocenti!
L'ipocrisia dei "no Cav".
Giornalismo malato da una guerra civile.
L’odio nei confronti di Berlusconi trasuda sulla stampa di sinistra che
rivendica anche la propria egemonia culturale, scrive Paolo Guzzanti su “Il
Giornale”. Su «Carta straccia» Giampaolo Pansa offre di giornali e giornalisti
di oggi uno spettacolo spesso grottesco, ma più spesso desolante. Che il
giornalismo italiano sia diverso da quello degli altri Paesi è un fatto storico:
per lo più scritto con pretese letterarie e molta retorica supponente si sta
trasformando sempre più in una brodaglia di violenza e imprecisione che lascia
spesso sbalorditi i colleghi stranieri: «Davvero potete scrivere usando il
condizionale senza prove? Da noi ci sbatterebbero in galera…». A nessuno, mai,
nel Regno Unito o negli Stati Uniti, in Francia o in Svizzera, ma neanche in
Polonia o in Romania, verrebbe in mente di inserire (come è accaduto in questi
giorni) nell’articolo di un cattedratico un lungo brano ignoto all’autore ma
spacciato come autentico e difendere poi un tale arbitrio come libertà
d’informazione. Non sono di quelli che esaltano il giornalismo «anglosassone»
immaginato come asettico e impersonale, ma ho un grande rispetto per il
giornalismo americano e britannico e per il modo accurato in cui trattano i
fatti anche quando le testate si schierano politicamente: del resto in quei
Paesi la pagina dei commenti è di competenza dell’editore, perché il direttore
si deve preoccupare soltanto delle notizie e curare che siano complete e
corredate dalle fonti. Quel giornalismo, che non è certo esente da difetti, ha
però prodotto antidoti e anticorpi che ancora funzionano bene, attraverso
scandali e processi sulla cattiva informazione. Walter Lippmann, che influenzò
il presidente Wilson alla fine della Grande Guerra e che morì criticando Lyndon
Johnson per la politica bellicosa nel Vietnam, creò la parola «stereotipo» –
oggi si direbbe «politicamente corretto» – per indicare il pericolo delle
opinioni automatiche e moralmente prefabbricate. Fu lui del resto a dire che «la
salute della società dipende dalla qualità delle informazioni che riceve»
affermazione non contestabile ma priva di riscontro in Italia. Lippmann
ricordava anche che la notizia e la verità non sono la stessa cosa e questo
perché l’informazione e la comunicazione non sono la stessa cosa: spacciarle
l’una per l’altra produce una forma di giornalismo che si vieta di pensare,
anticipando così, come ha scritto Marco Bardazzi su «Ttl», il monito di Hannah
Arendt: «quando gli uomini rinunciano a dire quel che pensano, spesso smettono
anche di pensare». Da noi, peccato, niente Hannah Arendt e niente Walter
Lippmann, ma tutt’al più un composto Umberto Eco che nel suo «Costruire il
nemico» riconosce che Julien Assange, la primula rossa di WikiLeaks, ha
finalmente certificato che il re è nudo ponendo la stampa di fronte alla
responsabilità di decidere, senza ricorrere a Internet, che cosa sia reale e
meriti di essere stampato. Di «Carta Straccia» condivido il giudizio positivo su
Antonio Padellaro direttore del Fatto Quotidiano, e su Marco Travaglio come
fenomeno di straordinaria efficacia e qualità, a prescindere dalle differenze di
opinione. Del resto è stato proprio il direttore del Fatto Quotidiano a dire a
Laura Cesaretti, sul Giornale del 1° novembre 2010, che «la sinistra ha una
grande suscettibilità nei confronti della libertà di stampa. Una suscettibilità
che può raggiungere livelli insopportabili, in-sop-por-ta-bi-li!». E lo stesso
Padellaro, ricorda Pansa, considerò la campagna sulla casa di Montecarlo
un’operazione giornalistica efficace e ineccepibile. Anche a me la nascita e il
successo del Fatto hanno entusiasmato al di là della linea politica, perché quel
successo dimostra che esistono segmenti di opinione pubblica in attesa di essere
rappresentati sia sui giornali che in politica. Ma ecco che mi imbatto, fra i
documenti di «Carta straccia» in alcune parole di Marco Travaglio che ignoravo,
pubblicate sul blog di Beppe Grillo e che, sorpresa, esaltano e rivendicano il
diritto all’odio. Così: «Chi l’ha detto che non posso odiare un politico? Chi
l’ha detto che non posso augurarmi che il Creatore se lo porti via al più
presto? Non esiste il reato di odio». Che cosa rispondere? Che è vero, il reato
di odio non esiste sui codici, ma dovrebbe esistere nelle coscienze. Oggi l’odio
trasuda dalle pagine stampate di entrambi i fronti, ma con una sperimentata
prevalenza dell’odio di sinistra, che è più antico, raffinato e velenoso. Sul
Giornale io stesso alcuni anni fa denunciai la categoria degli «odiatori
professionisti», come nuova mutazione giornalistica: gente che non attacca
soltanto con le notizie, ma che incita all’odio e, di conseguenza, alle sue
applicazioni pratiche. Una volta rivendicato il diritto di esprimere l’odio, è
difficile prendere le distanze da atti di violenza come il famoso duomo sulla
faccia di Berlusconi, a causa del quale Sabina Guzzanti è stata violentemente
attaccata avendo lei, antiberlusconiana, espresso disagio alla vista del sangue.
Ma la pratica dell’odio e del disprezzo non è una novità fra giornalisti e
intellettuali: ricordo che quando da giornalista certificavo che Francesco
Cossiga non era affatto matto (come voleva invece il comitato degli
intellettuali che seguivano le indicazioni di Eugenio Scalfari) amici e colleghi
cominciarono a cambiare marciapiede quando mi vedevano. Ricordo Tullio de Mauro,
il celebre linguista, che mi sibilò: «Ma che cazzo scrivi Paolo? Ma non ti
vergogni?». E non mi rivolse più la parola. Il giornalismo è da molto tempo al
limite della guerra civile latente, sicché berlusconismo e antiberlusconismo
sono diventate due categorie del cattivo spirito dei tempi, uno Zeitgeist al
limite della malattia mentale. Ma, ancora una volta, non si tratta di una novità
dovuta alla discesa in campo dell’uomo descritto come il «Grand Villain», o
«Caimano» perché prima di Berlusconi esistevano altri «grand villain» contro i
quali la stessa macchina da guerra funzionava attaccando Bettino Craxi e
Andreotti, e prima ancora Forlani e Fanfani senza escludere Aldo Moro. Anche
allora, con appena una misura di maggior pudore, il clima era quello di una
guerra civile giornalistica agli ordini di quella politica è sempre stata
coltivata con genialità da personalità della sinistra estremamente colte e
raffinate anche se crudeli, come Palmiro Togliatti (sotto lo pseudonimo di
«Roderigo de Castilla») o geniali e letterarie come «Fortebraccio» (Mario
Melloni). La sinistra nata dai lombi del Pci si presenta poi sempre come un
unico campione etico rivendicando di conseguenza una egemonia culturale che
interviene alla fine sulle carriere, i finanziamenti, i premi, i festival, le
legittimazioni e le delegittimazioni. E questo è un mestiere che il giornalismo
di destra, per sua colpa o per un suo limite genetico, non ha mai saputo o
voluto correggere, limitandosi a protestare in maniera inconcludente e anche un
po’ isterica. L’Italia che Pansa descrive in «Carta Straccia» è un caso grave ma
non unico perché l’egemonismo giornalistico di sinistra è universale dagli Stati
Uniti alla Francia dove il politico italiano di sinistra Dario Franceschini può
veder pubblicato il suo ottimo romanzo presso un editore come Gallimard, cosa
che difficilmente potrebbe accadere ad un politico di centrodestra di pari
valore. E così nella letteratura: se Gabriel Garcia Marquez, ritenuto di
sinistra e amico personale di Fidel Castro, ebbe il Nobel per la letteratura nel
1982, il vecchio e cieco Jorge Luis Borges, accusato di essere un reazionario
aspettò invano per tutta la vita. E infatti ha fatto discutere l’anomalia grazie
alla quale il premio Nobel sia andato nello scorso ottobre a Mario Vargas Llosa,
considerato di destra ma nato a sinistra, autore col figlio anche di un
folgorante «Manual del Perfecto idiota Latino-Americano» che ha spellato il
giornalismo sinistrese del suo mondo. In Italia, Paese da cui scaturiscono o
sono scaturiti cattolicesimo, fascismo e il più influente partito comunista
occidentale, la sostituzione del giornalismo con la propaganda è stata una
strada obbligata: soltanto da noi si poteva inventare l’espressione «linea
editoriale» per giustificare nel servizio pubblico televisivo l’uso di un
linguaggio di propaganda, la censura e l’eccesso, sia di sinistra che di destra.
La «verità» stessa, come premessa dell’informazione corretta e completa, in
Italia è relegata al rango di «arroganza». Ed è questo il motivo per cui, senza
dover aspettare Berlusconi, i politici italiani hanno sempre avuto nei confronti
del giornalismo un atteggiamento padronale creando il ridicolo fenomeno del
politico «di riferimento», padrino-padrone che promette carriere e direzioni nei
telegiornali «d’area». Ci fu un tempo in cui Giampaolo Pansa ed io chiudevamo di
notte la seconda edizione di Repubblica in tipografia. Una notte arrivarono in
redazione, piangendo disperati, i parenti di alcune persone morte avvelenate. Li
ascoltammo e Pansa disse: «Avete ragione, è una tragedia immane, guardate qui:
“familia” nel titolo senza la “g”! Santo cielo, che catastrofe…». Mentre i
parenti delle vittime se ne andavano stizziti per la nostra insensibilità ci
precipitammo a correggere il titolo. Un episodio minimo, che però Pansa e io
ricordiamo ogni volta che ci parliamo perché contiene forse la misura
dell’aneddoto buffo, del mestiere minore, la corsa in tipografia, i casi della
vita, quel modo semplice e casuale che costituiva la cifra del nostro mestiere.
Eravamo in fondo dei proletari della notizia e appartenevamo a una generazione
che si poteva permettere un giornalismo tutt’altro che neutrale, anzi schierato
e combattivo, ma usando sempre e soltanto rigorosamente i fatti.
Giampaolo non ha nessuna
intenzione di accedere - come molti suoi coetanei - a una vecchiaia omaggiata e
sacrale, scrive Luca Telese su “Il Fatto Quotidiano. Non aspira a entrare nel
novero dei vecchi saggi che invecchiano bene, centellinano il talento e le
esternazioni, amano farsi benvolere da tutti, si risparmiano molto e si fanno
celebrare di più. Nel suo ultimo libro, per esempio, Pansa spara su Fabio Fazio,
su Ezio Mauro, su Nichi Vendola, su Michele Santoro sul nemico (di sempre!)
Giorgio Bocca e tanti altri (ma, stranamente, parla bene di questo quotidiano).
E risparmia la destra. Il fatto è che Giampaolo Pansa ha scritto un altro libro
sul giornalismo (si intitola Carta Straccia), e ha - diciamo la verità - un
caratteraccio: gli piace che nella sua scrittura si indovini il ghigno dei
cattivi del cinema francese in bianco e nero, un Jean Gabin marsigliese tutto
sangue e inchiostro. In questa parte della sua vita, per dire, Pansa ama farsi
nemici, tirare freccette al curaro su alcuni bersagli privilegiati, fra cui
svetta Repubblica, il quotidiano che lo ha consacrato. Non è elegante, ma lui se
ne frega. Giampaolo è romantico, passionale, viscerale vendicativo, ma anche
cameratesco: ora è a Libero, e "i due mastini" della coppia di direzione si
trovano effigiati in un capitolo celebrativo che li mostra un po' canaglie, ma
simpaticissimi. Pansa, temo, ci seppellirà tutti con uno sberleffo o con una
scudisciata a mezzo stampa. Giampaolo, in fondo - se passi ai raggi X la sua
bibliografia di ben 45 tomi - ha scritto praticamente trenta libri su due soli
argomenti: il giornalismo (e la propria vita); e poi la Resistenza e il fascismo
(prima e dopo "il ciclo dei vinti"), su cui ha cambiato clamorosamente idee. Non
lo nega, anzi. Ma l'amore ne esaltava la Resistenza e l'eroico partigiano
"Infuriato", il ciclo dei vinti è dedicato alla demolizione della Resistenza
(prima "quella comunista", poi tutte "le altre"). Insomma, questi libri Pansa li
ha scritti raccontando sempre la stessa storia (e talvolta persino gli stessi
aneddoti) ma virandoli in maniera diversa, in nome di un revisionismo
esistenziale che è uno dei motivi per cui una sterminata tribù di lettori
almanacca i suoi libri. Meravigliosa contraddizione: un titolo dispregiativo per
officiare il culto della stampa. Anche in questo libro, per esempio, c'è la
storia del suo binocolo Zeiss, c'è la redazione de La Stampa conosciuta da
ragazzo, e raccontata anche ne Il Revisionista (2009), ma pure nel ''Romanzo di
un ingenuo'' (2000) che è stata la sua prima autobiografia. C'è di nuovo
l'intervista a Enrico Berlinguer che è stata già raccontata in ''Ottobre addio''
(1982) e - ancora - ne Il Revisionista (2009). E così c'è da esser certi che
arriveranno anche un altro libro e un altro ritorno, perchè Pansa riscrive se
stesso cambiando continuamente lo scenario che gira intorno,la fissità del
demiurgo che scruta il mondo nel circo immaginario del suo Bestiario. Giampaolo
è meticoloso, a volte maniacale. Un altro, in un capitolo dedicato alla
demolizione sistematica e feroce di Fazio non metterebbe mai una frase come
questa: "Non mi ha mai voluto nel suo salotto per una colpa imperdonabile: il
mio presunto anti-antifascismo, attestato dai libri che andavo scrivendo sulla
guerra civile. Però aveva accolto col tappeto rosso quel collaudato fascista di
Fini". Fazio non lo ha voluto e lui ratatatà - squaderna la sua arma più
micidiale, l'archivio. Una volta me lo fece vedere, senza compiacimento, come un
chirurgo che apre la teca dei bisturi. Un garage della sua casa di San Casciano,
un arsenale pronto per essere usato a ogni occorrenza, contro chiunque: "Ho una
cartellina anche su di te", e rideva. Pansa è un vecchio cronista cresciuto
nella religione del "cartaceo": ritaglia anche le lettere dei lettori. Oppure
estrae dal garage la raccolta de ''Il dito nell'occhio'', la rubrica che 15 anni
fa Nichi Vendola teneva su Liberazione, infilando una antologia antidalemiana:
"Massimo è gravemente atlantico", "cinicamente spoglio di dolore", "goffamente
demagogico", "con una spocchia da statista neofita", "livido come i neon del
metrò". Conclusione dell'autopsia: "12 anni fa il deputato Vendola era un
polemista dal pensiero violento e dal linguaggio stridulo". In fondo ''Carta
straccia'', il potere inutile dei giornalisti italiani (Rizzoli, 427 pagine
19.50) è la fusione di uno strumento perfetto e di un umore sulfureo. E' un
viaggio nel garage di San Casciano con intenzioni contundenti, ed effetti
sorprendenti. Ad esempio nel capitolo su Il Fatto, che dopo tre pagine sugli
strafalcioni dei giornali italiani e un paio di scotennamenti senza rete ti
potresti stupire: "Nella Grande crisi della carta stampata un solo giornale si
rivelò capace di andare contro la corrente: Il Fatto".A Giampaolo questo
giornale non piace, ma dopo aver tratteggiato i medaglioni di "Beriatravaglio"
(copyright di Staino) e di Antonio Padellaro, rende un onore delle armi al
successo ottenuto: "Di chi era il merito? Prima di tutto del direttore,
Padellaro. Poi della star del giornale, Travaglio. Infine della redazione".
Memorabile l'episodio di un collega di La Repubblica - unico non citato per nome
- che propone una brillante intervista al segretario del Psdi Luigi Longo. Il
giorno dopo Pansa, all'epoca vicedirettore riceve questa telefonata di Longo:
"Ho letto l'intervista. Mi sembra molto fedele, rispecchia bene il mio modo di
considerare il momento politico. Ha un solo difetto. Io non ho mai dato nessuna
intervista". Per colpire Bocca (per lui ha la stessa passione che Achab ha per
Moby dick) estrae dal'articolo una "intervista doppia" del 1980 sul terrorismo
raccolta da un giovanissimo Lucio Caracciolo. Bocca sosteneva che i covi delle
Br erano una invenzione, Pansa che le Br erano attive dal 1971. Sul quotidiano
di Mauro un intero capitolo, e una sentenza feroce: "Perché non fare di La
Repubblica una vera formazione politica? I militanti c'erano. I Soldi pure.
Anche il leader non mancava. Era un direttore-segretario caparbio, aggressivo,
più carismatico di moti big della casta partitica".
Giampaolo Pansa è uomo di
furori, non di convenienze, scrive Stefano Di Michele su “Il Foglio”. Pure di
rancori, ma non di ipocriti ritegni. E nemmeno di malafede. Forse si è sentito
ferito, Pansa – anzi, sicuramente è stato ferito. Una ferita non medicata, la
sua, né dagli amici che furono né dai compagni che l’amarono – ché loro,
soprattutto, si fecero assalitori. Piuttosto, ognuno a versare sale, su quella
ferita, a lanciare stupide accuse, ad attruppare becere squadracce
iperdemocratiche (l’iperdemocrazia essendo la china che conduce prima a
un’eccessiva considerazione di sé, quindi al fanatismo) per impedirgli di
presentare i suoi libri su quella che lui – con ostinazione sempre più ostinata
ogni volta che qualcuno gliela rinfaccia – chiama la “guerra civile”. Si è
aperta con “Il sangue dei vinti” la seconda vita (da scrittore di gran successo)
di Pansa. E con “Il sangue dei vinti” ha avuto inizio la seconda esistenza (di
gran disdegno) di Giampaolo agli occhi dei suoi detrattori. Quelli fanatici e
offesi, lui cocciuto. E il suo sarà, c’è da pensare, il secondo paradosso
giornalistico-politico di quest’Italia da Seconda Repubblica e di ancestrali
collere. Se Montanelli, icona del giornalismo di destra, è finito sugli altari
davanti ai quali compie riti gente di ogni sfumatura di sinistra, probabilmente
tra cento anni (nei giorni caldi della Ventinovesima Repubblica), quando Pansa
non ci sarà più, sarà lui, antica icona del giornalismo di sinistra, issato
sull’altare davanti al quale s’aduneranno manipoli di destrorsi incontinenti.
Essendo uomo di carattere, Pansa ne ha uno pessimo – e la mai sopita
intelligenza delle cose (movente, opportunità, aggressori) lo costringe a una
tignosa, divertita e (magari) dolente ricapitolazione.+Perché fa i conti con i
suoi nemici, Pansa, e fa anche i conti con se stesso. Un pugno di anni, e un
intero orizzonte è mutato. E in fondo, come è stato con il suo precedente libro
“Il revisionista”, anche questo “Carta straccia. Il potere inutile dei
giornalisti italiani” (Rizzoli), è un altro pezzo della sua resa dei conti – con
l’antico universo che l’ha amato e poi espulso; con se stesso, che
quell’universo ha prima attraversato e poi rinnegato. E’ un libro divertente,
perfido, feroce – scritto divinamente, quindi scritto da Pansa. Ma le oltre
quattrocento pagine, alla fine, lasciano un senso di amarezza: nell’area della
sinistra decente e civile, che il Pansa che fu rimpiange, ma lo stesso ama il
Pansa che è, innanzi tutto. E forse, nello stesso autore. Perché il libro è
scanzonato, “libraccio carogna” come piace dire a lui, che marcia e macina –
facce, parole, giudizi impertinenti. Ma non è un libro sul giornalismo e sui
giornalisti: non così ampio, non così riduttivo. E’ un libro su Pansa e sul suo
mondo di giornali e giornalismo. Su ciò che fu (con qualche eccesso di
sottovalutazione, e forse qualche giudizio ingeneroso) e su ciò che è (con
qualche eccesso di partecipazione, e forse qualche giudizio eccessivamente
generoso). Una sorta di (nuova) autobiografia professionale, dove Pansa getta
via quel che ancora conservava di ricordi affettivi sul fondo di un polveroso
cassetto, e abbraccia – con la generosità di sempre, quella che ogni giovane
cronista che ha avuto a che fare con lui ha sperimentato – il nuovo mondo:
Belpietro invece di Scalfari, Feltri invece di Bocca “l’uomo di Cuneo” (in
realtà da un pezzo, al posto di Bocca chiunque andava bene), e Lerner e
l’Ingegnere e la ex direttrice dell’Espresso, e la Gruber, ed Ezio Mauro, e la
Concita – per tacer, senza tacere, di quel Fazio lì… Ha invece pagine
bellissime, commoventi, quando ricorda vecchi colleghi come Gaetano Scardocchia
e Gianni Rocca. Fino all’eruzione finale: mai votato il Cav!, Pansa – solo i
cretini pensano che le persone intelligenti possano cambiare idea facendo
mercato di se stessi – ma se continuano a fargli girare i santissimi… Gran libro
di cenere e furie – e pernacchie e (qua e là) persino risate.
GLI ESTREMISTI DELLE NOSTRE
VITE.
Gli estremisti delle nostre
vite.
Pasolini aveva ragione, scrive Francesco Boezi il 2 novembre 2016 su “Il
Giornale”. “Caro Gennariello – scrisse Pasolini ad un allievo immaginario – a
causa della scuola diseducatrice sei qui davanti a me come un povero idiota,
umiliato, anzi degradato, incapace di capire, chiuso in una morsa di meschinità
mentale che, fra l’altro, ti angoscia”. Sono le poche righe da cui è scaturita
l’idea di dar vita a questo blog. Parole portatrici di una struggente quanto
tragica attualità “Gennariello” fu il destinatario ipotetico cui Pasolini inviò
un “trattatello pedagogico” raccolto in Lettere Luterane. Un giovane di quindici
anni, napoletano, borghese, amante del calcio. Il prototipo di studente
potenzialmente imbevuto dal conformismo. Lo scrittore e regista romano cercò di
metterlo in guardia dai professori, dai compromessi degli intellettuali,
dall’immobilizzazione delle aspirazioni dentro un consesso culturale marcio ed
incapace di sviluppare il libero pensiero, la libera immaginazione, la vocazione
dell’intelligenza personale. Gli individui all’interno della scuola italiana,
insomma, andrebbero sviluppandosi come contenitori vuoti, buoni solo ad essere
riempiti con le nozioni utili al pensiero dominante, a quella cultura
totalizzante cui Pier Paolo Pasolini addossava la responsabilità di voler
accentrare tutto dentro la civiltà dei consumi. Chissà cosa avrebbe pensato
Pasolini dell’accordo tra il Miur e Mcdonald’s per l’alternanza scuola-lavoro.
Il ministero dell’istruzione, infatti, ha siglato un’intesa per cui gli studenti
potranno svolgere le ore previste dalla legge 107 (Buona Scuola) all’interno dei
locali del celebre fast food. Un favore niente male ad una multinazionale,
mentre il Pd in piazza canta “Bella Ciao” in sostegno del Sì al referendum.
Chissà cosa avrebbe scritto a Gennariello. Probabilmente le stesse medesime
cose. La forza di Pasolini, d’altro canto, sta nell’essere stato un profeta. Era
il 2 novembre 1975 quando l’autore di “Scritti corsari” fu assassinato
all’Idroscalo di Ostia. Il poeta di Casarsa aveva già compreso che persino la
scuola si sarebbe rivelata corresponsabile del proliferare dei modelli imposti,
della distruzione delle differenze, dell’omologazione, di un edonismo neo-laico
privato di qualunque valore umanistico, del dominio, insomma, dell’ideologia del
consumo e dell’immagine. L’istituzione scolastica, alla fine della fiera, come
stampella del totalitarismo della mercificazione. Gli studenti italiani
lavoreranno a Mcdonald’s nelle ore di lavoro previste dalla 107. Deve essere
stato questo il sogno ribelle dei sessantottini che oggi occupano le cattedre ed
i banchi ministeriali d’Italia. Pasolini aveva ragione.
Viaggio tra i
fondamentalisti della porta accanto: dai nazi-vegani ai dittatori del piatto,
quelli che vogliono imporci le loro ideologie,
scrive Domenico Ferrara, Mercoledì 02/11/2016, su "Il Giornale". Pubblichiamo un
estratto del libro di Domenico Ferrara, "Gli estremisti delle nostre vite". Un
viaggio attraverso i fondamentalisti della porta accanto: dai nazi-vegani ai
dittatori del piatto passando per gli ecologisti estremi e altro ancora.
Insomma, quelli che trasformano scelte di vita personali in ideologie da imporre
a tutti. Vogliono metterci le catene. Non siamo più liberi. E non c’entra la
libertà filosofica né la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
Qui parliamo di arbitrio. E di estremismo. C’è una parte della società di oggi
che cerca non tanto di inculcarci delle dottrine (ché sarebbe un fine legittimo
che garantirebbe almeno la facoltà di non partecipare alle lezioni) quanto di
imporci dei paradigmi, degli stili di vita, dei regimi alimentari. È una parte
della società che mina nel profondo la nostra libertà di scelta. E, il più delle
volte, lo fa con la violenza fisica o verbale, con l’allarmismo sociale o ancora
con il terrorismo psicologico. Sono i talebani delle nostre vite. Gli estremisti
della quotidianità. I portatori malati di un pernicioso nazismo delle idee.
Quello che confina i disertori in un ghetto sociale, i cui componenti vorrebbe
che diventassero una minoranza sempre meno influente. E soprattutto meno libera.
Il verbo che loro diffondono è il solo possibile, quello giusto. Alla faccia del
rispetto delle opinioni altrui. Si dice che la nostra libertà finisca dove
inizia quella degli altri. Ma loro, gli altri, non conoscono confini. E,
soprattutto, non credono nella libertà del prossimo, anzi, fanno di tutto pur di
contrastarla e demolirla. In un’epoca in cui i terroristi dell’Isis condizionano
le nostre esistenze, tagliando, oltre alle teste dei loro nemici, anche la
nostra cartina geografica (prendete un mappamondo e fermatevi a riflettere un
secondo su quali posti in questo periodo evitereste per paure di un attentato
dell’Isis e vedrete che non sono pochi), c’è un altro tipo di fondamentalismo
(ideologico) che si insinua nelle nostre vite. Il più delle volte non ce ne
rendiamo conto, ne siamo inconsapevoli. Altre volte invece ci si presenta
davanti con una virulenza inaudita. Prendete i nazivegani per esempio. Sì,
proprio quelli. Ma badate bene, qui non si prendono in considerazione coloro che
hanno scelto la via dell’ascetismo culinario e che il massimo del fastidio che
possono procurare è la confusione dell’amico che se li trova a cena e che
rimodella il menu a immagine e somiglianza degli invitati. No, quelli sono i
vegani moderati, quelli che pacatamente ti spiegano le ragioni della loro
scelta, che discettano di cibo industriale e che ti saprebbe- ro elencare i
macchinari utilizzati per la cottura del pollo e gli elementi chimici usati per
alimentare gli animali del pianeta. Scelta legittima e financo condivisibile.
Perché scelta privata. Ognuno è libero, in teoria, di impiattarsi quello che più
gli pare e piace. Nei limiti della legge, ovviamente. Non stiamo parlando di chi
vuole farsi bistecche di panda e cucinare i gatti. Per carità. Qui si parla
degli estremisti, quelli che fanno vere e proprie azioni di «guerriglia» contro
i carnivori. Sono i paladini della violenza delle idee, disposti a tutto pur di
convertire un infedele. Ma in realtà la conversione è un obiettivo che non si
prefiggono. Loro puntano alla punizione. Lo ha spiegato perfettamente Valerio
Vassallo, il leader di uno di questi movimenti vegani in un’intervista al
programma Le Iene che ha fatto il giro del web. «Se vedo una persona che mangia
un panino con la mortadella, se riesco ci sputo dentro. Se vedo una signora con
una pelliccia, faccio di tutto per danneggiargliela. Se, per salvarsi la vita,
mia madre fosse costretta a usare dei farmaci testati sugli animali, la
disconoscerei». Sempre lui, insieme ai suoi compagni di ideologia, bloccò una
gara di pesca alla trota sulle rive del fiume Sesia cercando di convertire un
padre con queste dolci parole: «Tu stai insegnando a tuo figlio ad uccidere»,
innescando con lui un acceso alterco e impaurendo il bambino che scoppiò in un
pianto dirotto. Colpirne uno per educarne cento. I nazivegani non guardano in
faccia niente e nessuno. E riscrivono la storia, a modo loro. Nelle loro menti
stanno rivivendo gli anni del nazismo: ciò che avviene negli allevamenti
rappresenta - per loro - un nuovo Olocausto e gli animali sui quali si sono
testate e si testano le medicine del passato, del presente e del futuro
patiscono le stesse pene dell’inferno che patirono gli ebrei. Ma le fondamenta
su cui si poggia questa sorta di religione ultra-ortodossa sono labili come un
grissino (vegano) e non trovano alcun appiglio scientifico se non l’ancor più
fragile precetto in base al quale è inutile testare i farmaci sugli animali se
tanto poi sono gli uomini a doverli assumere. È l’antiscienza per eccellenza. O
peggio, il disconoscimento della scienza stessa. A meno che, per salvare gli
animali, non si voglia passare direttamente ai test sui bambini.
Giù le mani da Magdi
Cristiano Allam,
scrive Andrea Pasini il 30 ottobre 2016 su “Il Giornale”. Chi sono davvero i
razzisti? In questi giorni Magdi Cristiano Allam, intellettuale e giornalista
tra i più liberi in Italia, nonché caro amico di chi scrive, è stato nominato
cittadino onorario dal comune di Cascina, centro abitato di 45mila persone in
provincia di Pisa. A volerlo insignire di tale carica sono stati l’assessore
alla cultura, Luca Nannipieri, ed il sindaco, Susanna Ceccardi. Quello di cui
stiamo parlando è il primo comune toscano ad essere governato dalla Lega Nord.
“Fino a qui tutto bene; il problema non è la caduta, è l’atterraggio”, così
recitava il monologo più famoso della pellicola L’odio (La Haine) film diretto e
scritto, nel 1995, da Mathieu Kassovitz. L’atterraggio è rappresentato dai
sedicenti appartenenti allo schieramento locale del Pd, la Cascina Democratica,
che vuole ergersi ad unico detentore del potere di gestione del pensiero in
città. Dai loro canali social alzano il pugno sinistro al cielo: “Restiamo
convinti che l’assegnazione della cittadinanza ad Allam sia un gesto sbagliato e
ci pare opportuno far conoscere la nostra opinione ai cittadini”, poi continuano
“si prefigura il ritorno alla difesa del feudo, in maniera sempre più
bellicosa”. Vogliono avere la prima e l’ultima parola, vogliono ergersi a
liberatori delle coscienze quando sono i primi a promuovere leggi e discorsi
liberticidi. La loro intenzione è quella di tappare la bocca a chi dice no, a
chi si solleva contro una società corrotta e che frana insieme ai suoi
valori. Anche il Psi, ma sono ancora vivi?, non ha perso tempo e ha cercato
pubblicità attraverso la figura, stoica in questo caso, di Magdi. “Il Psi di
Cascina non può né approvare né sottacere ad un’operazione di arruolamento
forzato di Oriana Fallaci. E’ oggettivamente fuorviante associarla a culture e
ad opinioni politiche, mai condivise e da cui è stata lontana tutta la vita,
come si sta tentando di fare con l’iniziativa promossa presso il teatro
Politeama”. Stiamo parlando di Cassandre, riferendoci a Magdi e alla Fallaci,
capaci di vedere il futuro, analizzarlo, studiarlo e predirlo. Personalità che
non hanno paura a caricare la loro anima, tra cultura e volontà di non cedere,
per colpire il male di questi tempi. La disoccupazione ci sta mettendo in
ginocchio, l’immigrazione ci sta rubando la nostra identità sacra e la politica
sta spegnendo ogni sogno rivolto verso l’avvenire ed il problema è
un’onorificenza? VERGOGNATEVI. I democratici, e chi altrimenti?, hanno definito
il saggista “un personaggio che soffia sul fuoco del fondamentalismo”, ma non è
finita qui perché viene descritto, dagli adepti renziani, come un uomo “che
divide e nasconde dietro l’espressione scontro di civiltà l’idea di nuova guerra
santa”. Ho dovuto rileggere certe dichiarazioni, almeno due volte, per
sincerarmi che fossero vere. Come può un uomo che per 56 anni è stato musulmano,
che ha raggiunto l’Italia partendo dall’Egitto, dove è nato, con un visto per lo
studio in tasca essere un seminatore d’odio. Un intellettuale che ha abbracciato
il Cristianesimo e che combatte ogni giorno il fondamentalismo islamico capace,
solamente, di inorridire l’intero globo. Persona dotta, istruita e volenterosa
la cui unica colpa è quella di dire la verità, nient’altro che la verità. “Dare
del seminatore di intolleranza a me è estremamente grave. Sottintende il fatto
che ho un pregiudizio nei confronti degli immigrati o dei musulmani che
corrisponde ad un reato perché parliamo di razzismo. Ricordo loro che io sono
stato un immigrato vero in Italia. Mi rappresentano come un terrorista ma io
sono una vittima del terrorismo e di quelli che seminano intolleranza: da 14
anni vivo sotto scorta”, questo ha dichiarato, lo scrittore, sulle colonne de Il
Giornale. Eppure i veterocomunisti pisani, tanto ligi a parlare di morale, però
incapaci nella loro dottrina politica di averne una, dovrebbero sapere che il
comune di Cascina, nel 1998, ha consegnato la cittadinanza a Silvia Baraldini.
Quest’ultima ha scontato 23 anni di galera, per associazione eversiva, tra gli
Stati Uniti d’America e l’Italia. Vicina al movimento Black Panther Party è
finita in manette per concorso in evasione, associazione sovversiva (nel
curriculum figurano anche due tentate rapine) ed ingiuria al tribunale. Resto
disgustato da questo tipo di proteste e dichiarazioni puramente ideologiche,
capaci di mostrare solo l’ignoranza di chi critica per partito preso senza
analizzare i contenuti. In questo caso parliamo di una persona che conosce, a
memoria, il Corano e che da quando si è convertito è stato dichiarato un uomo
morto dall’Islam, proprio per via della sua conversione. Ma a quanto pare i
difensori di questa religione, che promuove l’odio, bramano per diventare i
primi complici del fondamentalismo religioso se le nostre città si
trasformeranno nella Parigi della sera del 13 novembre. Del resto ognuno si
sceglie i propri modelli di civiltà, il mio l’ho scelto ed è un esempio di
disciplina e di lotta per ognuno di noi: MAGDI CRISTIANO ALLAM.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
Economia Sommersa: Il Nord
onesto e diligente evade più del Sud, scrive
Emanuela Mastrocinque su “Vesuviolive”. Sono queste le notizie che non
dovrebbero mai sfuggire all’attenzione di un buon cittadino del Sud. Per anni ci
hanno raccontato una storia che, a furia di leggerla e studiarla, è finita con
il diventare la nostra storia, l’unica che abbiamo conosciuto. Storia di miseria
e povertà superata dai meridionali grazie all’illegalità o all’emigrazione, le
due uniche alternative rimaste a “quel popolo di straccioni” (come ci definì
quella “simpatica” giornalista in un articolo pubblicato su “Il Tempo” qualche
anno fa) . Eppure negli ultimi anni il revisionismo del risorgimento ci sta
aiutando a comprendere quanto lo stereotipo e il pregiudizio sia stato utile e
funzionale ai vincitori di quella sanguinosa guerra da cui è nata l‘Italia.
Serviva (e serve tutt‘ora) spaccare l’Italia. Da che mondo e mondo le società
hanno avuto bisogno di creare l’antagonista da assurgere a cattivo esempio, così
noi siamo diventati fratellastri, figli di un sentimento settentrionale razzista
e intollerante. Basta però avere l’occhio un po’ più attento per scoprire che
spesso la verità, non è come ce la raccontano. Se vi chiedessimo adesso, ad
esempio, in quale zona d’Italia si concentra il tasso più alto di evasione
fiscale, voi che rispondereste? Il Sud ovviamente. E invece non è così. Dopo
aver letto un post pubblicato sulla pagina Briganti in cui veniva
riassunta perfettamente l’entità del “sommerso economico in Italia derivante
sia da attività legali che presentano profili di irregolarità, come ad esempio
l’evasione fiscale, che dal riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività
illecite e mafiose” abbiamo scoperto che in Italia la maggior parte degli
evasori non è al Sud. Secondo i numeri pubblicati (visibili nell‘immagine
sotto), al Nord il grado di evasione si attesta al 14, 5%, al centro al 17,4%
mentre al Sud solo al 7,9%. I dati emersi dal Rapporto Finale del Gruppo
sulla Riforma Fiscale, sono stati diffusi anche dalla Banca d’Italia. Nel
lavoro di Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati “L’economia
sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach
con una applicazione al contesto italiano” si legge “dalle stime a
livello territoriale si nota una netta differenza tra il centro-nord e il sud,
sia per quanto attiene al sommerso di natura fiscale che quello di natura
criminale. Per quanto riguarda infine l’evidenza disaggregata per aree
territoriali, è emerso che le province del Centro-Nord, in media, esibiscono
un’incidenza maggiore sia del sommerso da evasione sia di quello associato ad
attività illegali rispetto alle province del Sud, un risultato che pare
contraddire l’opinione diffusa secondo cui il Mezzogiorno sarebbe il principale
responsabile della formazione della nostra shadow economy. Viene meno, di
conseguenza, la rappresentazione del Sud Italia come territorio dove si
concentrerebbe il maggiore tasso di economia sommersa". E ora, come la
mettiamo?
Si evade il fisco più al Nord
che al Sud. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione
redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma
totale delle principali imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91
miliardi. Il 52% di questa cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24
miliardi del centro (26% del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il
dato è influenzato dal maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono
i tecnici del Tesoro, la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese
che trova irregolarità fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al
96,9% sulle Pmi. Il record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in
regola. 100% di `positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad
ogni modo, l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013,
ha rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è
così salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un
numero in calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di
30,4 miliardi del 2011.
Ma quale Sud, è il Nord che
ha la palma dell’evasione,
scrive Vittorio Daniele su “Il Garantista”. Al Sud si evade di più che al Nord.
Questo è quanto comunemente si pensa. Non è così, invece, secondo i dati della
Guardia di Finanza, analizzati da Paolo di Caro e Giuseppe Nicotra,
dell’Università di Catania, in uno studio di cui si è occupata anche la stampa
(Corriere Economia, del 13 ottobre). I risultati degli accertamenti effettuati
dalla Guardia di Finanza mostrano come, nelle regioni meridionali, la quota di
reddito evaso, rispetto a quello dichiarato, sia inferiore che al Nord. E ciò
nonostante il numero di contribuenti meridionali controllati sia stato, in
proporzione, maggiore. Alcuni esempi. In Lombardia, su oltre 7 milioni di
contribuenti sono state effettuate 14.313 verifiche che hanno consentito di
accertare un reddito evaso pari al 10% di quello dichiarato. In Calabria, 4.480
controlli, su circa 1.245.000 contribuenti, hanno consentito di scoprire un
reddito evaso pari al 3,5% di quello dichiarato. Si badi bene, in percentuale,
le verifiche in Calabria sono state quasi il doppio di quelle della Lombardia. E
ancora, in Veneto il reddito evaso è stato del 5,3%, in Campania del 4,4% in
Puglia, del 3,7% in Sicilia del 2,9%. Tassi di evasione più alti di quelle delle
regioni meridionali si riscontrano anche in Emilia e Toscana. Alcune
considerazioni. La prima riguarda il fatto che nelle regioni del Nord, dove più
alta è la quota di evasione, e dove maggiore è il numero di contribuenti e
imprese, si siano fatti, in proporzione, assai meno accertamenti che nel
meridione. Poiché, in Italia, le tasse le paga chi è controllato, mentre chi non
lo è, se può, tende a schivarle, sarebbe necessario intensificare i controlli là
dove la probabilità di evadere è maggiore. E questa probabilità, secondo i dati
della Guardia di Finanza, è maggiore nelle regioni più ricche. La seconda
considerazione è che il luogo comune di un’Italia divisa in due, con un Nord
virtuoso e un Sud di evasori, non corrisponde al vero. L’Italia è un paese unito
dall’evasione fiscale. Il fatto che in alcune regioni del Nord si sia evaso di
più che al Sud non ha nulla a che vedere né con l’etica, né con l’antropologia.
Dipende, più realisticamente, da ragioni economiche. L’evasione difficilmente
può riguardare i salari, più facilmente i profitti e i redditi d’impresa. E dove
è più sviluppata l’attività d’impresa? Come scrivevano gli economisti Franca
Moro e Federico Pica, in un saggio pubblicato qualche anno fa della Svimez: «Al
Sud ci sono tanti evasori per piccoli importi. Al Nord c’è un’evasione più
organizzata e per somme gigantesche». Quando si parla del Sud, pregiudizi e
stereotipi abbondano. Si pensa, così, che la propensione a evadere, a violare le
norme, se non a delinquere, sia, per così dire, un tratto antropologico
caratteristico dei meridionali. Ma quando si guardano i dati, e si osserva la
realtà senza la lente deformante del pregiudizio, luoghi comuni e stereotipi
quasi mai reggono. Di fronte agli stereotipi e alle accuse – e quella di essere
evasori non è certo la più infamante – che da decenni, ogni giorno e da più
parti, si rovesciano contro i meridionali, non sarebbe certo troppo se si
cominciasse a pretendere una rappresentazione veritiera della realtà. Insieme a
pretendere, naturalmente, e in maniera assai più forte di quanto non si sia
fatto finora, che chi, al Sud, ha responsabilità e compiti di governo, faccia
davvero, e fino in fondo, il proprio dovere.
Quante bugie ci hanno
raccontato sul Mezzogiorno!
Scrive Pino Aprile su “Il Garantista”. L’Italia è il paese più ingiusto e
disuguale dell’Occidente, insieme a Stati Uniti e Gran Bretagna: ha una delle
maggiori e più durature differenze del pianeta (per strade, treni, scuole,
investimenti, reddito…) fra due aree dello stesso paese: il Nord e il Sud;
tutela chi ha già un lavoro o una pensione, non i disoccupati e i giovani; offre
un reddito a chi ha già un lavoro e lo perde, non anche a chi non riesce a
trovarlo; è fra i primi al mondo, per la maggiore distanza fra lo stipendio più
alto e il più basso (alla Fiat si arriva a più di 400 volte); ha i manager di
stato più pagati della Terra, i vecchi più garantiti e i giovani più precari; e
se giovani e donne, pagate ancora meno. È in corso un colossale rastrellamento
di risorse da parte di chi ha più, ai danni di chi ha meno: «una redistribuzione
dal basso verso l’alto». È uscito in questi giorni nelle librerie il nuovo libro
di Pino Aprile («Terroni ’ndernescional», edizioni PIEMME, pagine 251, euro
16,50). Pubblichiamo un brano, per gentile concessione dell’autore. Quante volte
avete letto che la prova dell’ estremo ritardo dell’Italia meridionale rispetto
al Nord era l’alta percentuale di analfabeti? L’idea che questo possa dare ad
altri un diritto di conquista e annessione può suonare irritante. Ma una qualche
giustificazione, nella storia, si può trovare, perché i popoli con l’alfabeto
hanno sottomesso quelli senza; e í popoli che oltre all’alfabeto avevano anche
”il libro” (la Bibbia, il Vangelo, il Corano, Il Capitale, il Ko Gi Ki…) hanno
quasi sempre dominato quelli con alfabeto ma senza libro. Se questo va preso
alla… lettera, la regione italiana che chiunque avrebbe potuto legittimamente
invadere era la Sardegna, dove l’analfabetismo era il più alto nell’Italia di
allora: 89,7 per cento (91,2 secondo altre fonti); quasi inalterato dal giorno
della Grande Fusione con gli stati sabaudi: 93,7. Ma la Sardegna era governata
da Torino, non da Napoli. Le cose migliorarono un po’, 40 anni dopo l’Unità, a
prezzi pesanti, perché si voleva alfabetizzare, ma a spese dei Comuni. Come
dire: noi vi diamo l’istruzione obbligatoria, però ve la pagate da soli (più o
meno come adesso…). Ci furono Comuni che dovettero rinunciare a tutto, strade,
assistenza, per investire solo nella nascita della scuola elementare: sino
all’87 per cento del bilancio, come a Ossi (un secolo dopo l’Unità, il Diario di
una maestrina, citato in Sardegna , dell’Einaudi, riferisce di «un evento
inimmaginabile »: la prima doccia delle scolare, grazie al dono di dieci
saponette da parte della Croce Rossa svizzera). Mentre dal Mezzogiorno non
emigrava nessuno, prima dell’Unità; ed era tanto primitivo il Sud, che partoriva
ed esportava in tutto il mondo facoltà universitarie tuttora studiatissime:
dalla moderna storiografia all’economia politica, e vulcanologia, sismologia,
archeologia… Produzione sorprendente per una popolazione quasi totalmente
analfabeta, no? Che strano. Solo alcune osservazioni su quel discutibile
censimento del 1861 che avrebbe certificato al Sud indici così alti di
analfabetismo: «Nessuno ha mai analizzato la parzialità (i dati sono quelli
relativi solo ad alcune regioni) e la reale attendibilità di quel censimento
realizzato in pieno caos amministrativo, nel passaggio da un regno all’altro e
in piena guerra civile appena scoppiata in tutto il Sud: poco credibile, nel
complesso, l’idea che qualche impiegato potesse andare in giro per tutto il Sud
bussando alle porte per chiedere se gli abitanti sapevano leggere e scrivere»
rileva il professor Gennaro De Crescenzo in Il Sud: dalla Borbonia Felix al
carcere di Penestrelle. Come facevano a spuntare oltre 10.000 studenti
universitari contro i poco più di 5.000 del resto d’Italia, da un tale oceano di
ignoranza? Né si può dire che fossero tutti benestanti, dal momento che nel
Regno delle Due Sicílie i meritevoli non abbienti potevano studiare grazie a
sussidi che furono immediatamente aboliti dai piemontesi, al loro arrivo.
Sull’argomento potrebbero gettare più veritiera luce nuove ricerche: «Documenti
al centro di studi ancora in corso presso gli archivi locali del Sud dimostrano
che nelle Due Sicilie c’erano almeno una scuola pubblica maschile e una scuola
pubblica femminile per ogni Comune oltre a una quantità enorme di scuole private»
si legge ancora nel libro di De Crescenzo, che ha studiato storia risorgimentale
con Alfonso Scirocco ed è specializzato in archivistica. «Oltre 5.000, infatti,
le ”scuole” su un totale di 1.845 Comuni e con picchi spesso elevati e
significativi: 51 i Comuni in Terra di Bari, 351 le scuole nel complesso; 174 i
Comuni di Terra di lavoro, 664 le scuole; 113 i Comuni di Principato Ultra, 325
le scuole; 102 i Comuni di Calabria Citra, 250 le scuole…». Si vuol discutere
della qualità di queste scuole? Certo, di queste e di quella di tutte le altre;
ma «come si conciliano questi dati con quei dati così alti dell’analfabetismo?
». E mentiva il conte e ufficiale piemontese Alessandro Bianco di Saint-Jorioz,
che scese a Sud pieno di pregiudizi, e non li nascondeva, e poi scrisse quel che
vi aveva trovato davvero e lo scempio che ne fu fatto (guadagnandosi
l’ostracismo sabaudo): per esempio, che «la pubblica istruzione era sino al
1859 gratuita; cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali
di ogni provincia»? Di sicuro, appena giunti a Napoli, i Savoia chiusero
decine di istituti superiori, riferisce Carlo Alianello in La conquista del Sud.
E le leggi del nuovo stato unitario, dal 1876, per combattere l’analfabetismo e
finanziare scuole, furono concepite in modo da favorire il Nord ed escludere o
quasi il Sud. I soliti trucchetti: per esempio, si privilegiavano i Comuni con
meno di mille abitanti. Un aiuto ai più poveri, no? No. A quest’imbroglio si è
ricorsi anche ai nostri tempi, per le norme sul federalismo fiscale regionale.
Basti un dato: i Comuni con meno di 500 abitanti sono 600 in Piemonte e 6 in
Puglia. Capito mi hai? «Mi ero sempre chiesto come mai il mio trisavolo fosse
laureato,» racconta Raffaele Vescera, fertile scrittore di Foggia «il mio
bisnonno diplomato e mio nonno, nato dopo l’Unità, analfabeta». Nessun Sud,
invece, nel 1860, era più Sud dell’isola governata da Torino; e rimase tale
molto a lungo. Nel Regno delle Due Sicilie la ”liberazione” (così la racconta,
da un secolo e mezzo, una storia ufficiale sempre più in difficoltà) portò
all’impoverimento dello stato preunitario che, secondo studi recenti
dell’Università di Bruxelles (in linea con quelli di Banca d’Italia, Consiglio
nazionale delle ricerche e Banca mondiale), era ”la Germania” del tempo, dal
punto di vista economico. La conquista del Sud salvò il Piemonte dalla
bancarotta: lo scrisse il braccio destro di Cavour. Ma la cosa è stata ed è
presentata (con crescente imbarazzo, ormai) come una modernizzazione necessaria,
fraterna, pur se a mano armata. Insomma, ho dovuto farti un po’ di male, ma per
il tuo bene, non sei contento? Per questo serve un continuo confronto fra i dati
”belli” del Nord e quelli ”brutti” del Sud. Senza farsi scrupolo di ricorrere a
dei mezzucci per abbellire gli uni e imbruttire gli altri. E la Sardegna, a
questo punto, diventa un problema: rovina la media. Così, quando si fa il
paragone fra le percentuali di analfabeti del Regno di Sardegna e quelle del
Regno delle Due Sicilie, si prende solo il dato del Piemonte e lo si oppone a
quello del Sud: 54,2 a 87,1. In tabella, poi, leggi, ma a parte: Sardegna, 89,7
per cento. E perché quell’89,7 non viene sommato al 54,2 del Piemonte, il che
porterebbe la percentuale del Regno sardo al 59,3? (Dati dell’Istituto di
Statistica, Istat, citati in 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud
1861-2011, della SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). E si
badi che mentre il dato sulla Sardegna è sicuramente vero (non avendo interesse
il Piemonte a peggiorarlo), non altrettanto si può dire di quello dell’ex Regno
delle Due Sicilie, non solo per le difficoltà che una guerra in corso poneva, ma
perché tutto quel che ci è stato detto di quell’invasione è falsificato: i
Mille? Sì, con l’aggiunta di decine di migliaia di soldati piemontesi
ufficialmente ”disertori”, rientrati nei propri schieramenti a missione
compiuta. I plebisciti per l’annessione? Una pagliacciata che già gli
osservatori stranieri del tempo denunciarono come tale. La partecipazione armata
dell’entusiasta popolo meridionale? E allora che ci faceva con garibaldini e
piemontesi la legione straniera 11 domenica 4 gennaio 2015 ungherese? E chi la
pagava? Devo a un valente archivista, Lorenzo Terzi, la cortesia di poter
anticipare una sua recentissima scoperta sul censimento del 1861, circa gli
analfabeti: i documenti originali sono spariti. Ne ha avuto conferma ufficiale.
Che fine hanno fatto? E quindi, di cosa parliamo? Di citazioni parziali,
replicate. Se è stato fatto con la stessa onestà dei plebisciti e della storia
risorgimentale così come ce l’hanno spacciata, be’…Nei dibattiti sul tema, chi
usa tali dati come prova dell’arretratezza del Sud, dinanzi alla contestazione
sull’attendibilità di quelle percentuali, cita gli altri, meno discutibili, del
censimento del 1871, quando non c’era più la guerra, eccetera. Già e manco gli
originali del censimento del ’71 ci sono più. Spariti pure quelli! Incredibile
come riesca a essere selettiva la distrazione! E a questo punto è legittimo
chiedersi: perché il meglio e il peggio del Regno dí Sardegna vengono separati e
non si offre una media unica, come per gli altri stati preunitari? Con i numeri,
tutto sembra così obiettivo: sono numeri, non opinioni. Eppure, a guardarli
meglio, svelano non solo opinioni, ma pregiudizi e persino razzismo. Di fatto,
accadono due cose, nel modo di presentarli: 1) i dati ”belli” del Nord restano
del Nord; quelli ”brutti”, se del Nord, diventano del Sud. Il Regno sardo era
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Sardegna. Ma la Sardegna nelle statistiche
viene staccata, messa a parte. Giorgio Bocca, «razzista e antimeridionale »,
parole sue, a riprova dell’arretratezza del Sud, citava il 90 per cento di
analfabeti dell’isola, paragonandolo al 54 del Piemonte. Ma nemmeno essere di
Cuneo e antimerìdionale autorizza a spostare pezzi di storia e di geografia: la
Sardegna era Regno sabaudo, i responsabili del suo disastro culturale stavano a
Torino, non a Napoli;
2) l’esclusione mostra, ce ne
fosse ancora bisogno, che i Savoia non considerarono mai l’isola alla pari con
il resto del loro paese, ma una colonia da cui attingere e a cui non dare; una
terra altra («Gli stati» riassume il professor Pasquale Amato, in Il
Risorgimento oltre i miti e i revisionismi «erano proprietà delle famiglie
regnanti e potevano essere venduti, scambiati, regalati secondo valutazioni
autonome di proprietari». Come fecero i Savoia con la Sicilia, la stessa
Savoia, Nizza… Il principio fu riconfermato con la Restaurazione dell’Ancièn
Regime, nel 1815, in Europa, per volontà del cancelliere austriaco Klemens von
Metternich). E appena fu possibile, con l’Unità, la Sardegna venne allontanata
quale corpo estraneo, come non avesse mai fatto parte del Regno sabaudo. Lo dico
in altro modo: quando un’azienda è da chiudere, ma si vuol cercare di salvare il
salvabile (con Alitalia, per dire, l’han fatto due volte), la si divide in due
società; in una, la ”Bad Company”, si mettono tutti i debiti, il personale in
esubero, le macchine rotte… Nell’altra, tutto il buono, che può ancora fruttare
o rendere appetibile l’impresa a nuovi investitori: la si chiama ”New Company”.
L’Italia è stata fatta così:
al Sud invaso e saccheggiato hanno sottratto fabbriche, oro, banche, poi gli
hanno aggiunto la Sardegna, già ”meridionalizzata”. Nelle statistiche ufficiali,
sin dal 1861, i dati della Sardegna li trovate disgiunti da quelli del Piemonte
e accorpati a quelli della Sicilia, alla voce ”isole”, o sommati a quelli delle
regioni del Sud, alla voce ”Mezzogiorno” (la Bad Company; mentre la New Company
la trovate alla voce ”Centro-Nord”). Poi si chiama qualcuno a spiegare che la
Bad Company è ”rimasta indietro”, per colpa sua (e di chi se no?). Ripeto: la
psicologia spiega che la colpa non può essere distrutta, solo spostata. Quindi,
il percorso segue leggi di potenza: dal più forte al più debole; dall’oppressore
alla vittima. Chi ha generato il male lo allontana da sé e lo identifica con chi
lo ha subito; rimproverandogli di esistere. È quel che si è fatto pure con la
Germania Est e si vuol fare con il Mediterraneo.
Oliviero Toscani, intervenendo
alla trasmissione radiofonica "La Zanzara" su Radio 24, ha definito i veneti «un
popolo di ubriaconi e alcolizzati. Poveretti, non è colpa loro se nascono in
Veneto». «I veneti sono un popolo di ubriaconi - ha proseguito Toscani -
Alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri». «Poveretti i veneti - ha
ribadito - non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Basta
sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino».
Oliviero Toscani e le offese
ai veneti. Un pasticcio geografico da risolvere con le scuse. A «La zanzara» su
Radio24 ha detto: «I veneti sono un popolo di ubriaconi. Alcolizzati atavici, i
nonni, i padri, le madri». Il presidente del Veneto: «Chieda scusa», scrive
Beppe Severgnini su “Il Corriere della Sera”. Si chiama Toscani, è lombardo e ha
fatto incavolare i veneti: bel pasticcio geografico. A «La zanzara» su Radio24 -
il programma dovrebbe chiamarsi «Il ragno», visto quanti ne cattura nella sua
rete - ha detto: «I veneti sono un popolo di ubriaconi. Alcolizzati atavici, i
nonni, i padri, le madri (...) Poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce
in quel posto, è un destino (...) Basta sentire l’accento: è da ubriachi, da
alcolizzati, da ombretta, da vino». Perché lo ha fatto? Pensava di essere
spiritoso. «Era una battuta divertente. Se gli unici a non divertirsi sono
alcuni veneti, mi dispiace». Divertente? Mettiamola così: il fotografo Oliviero
Toscani è più bravo con gli occhi che con la lingua. E l’umorismo sballato è
un’aggravante, non un’attenuante. Infatti, in Veneto, sono partite proteste,
querele, class action, dichiarazioni politiche (quelle non mancano mai).
Significa che è vietato scherzare su nazioni, regioni, città? Certo che no. Vuol
dire, come sostiene la correttezza politica, che «i caratteri dei popoli sono
un’invenzione, ed esistono solo le persone»? Macché. Gli ambienti - la storia,
la geografia, l’economia, la cultura - condizionano i comportamenti. Esiste un
comun denominatore tedesco, come esiste un comun denominatore americano, russo,
italiano. Chi lo nega è in malafede. E tra noi italiani esistono i lombardi, i
toscani, i siciliani. I primi tendono all’entusiasmo, i secondi alla tattica, i
terzi all’attesa. Come Berlusconi, Renzi, Mattarella. Come riassunto
dell’elezione del presidente della Repubblica, vi piace? O è banale? Be’,
comunque nessuno s’è offeso: non a Milano, non a Firenze, non a Palermo. Per un
motivo semplice: lombardi, toscani e siciliani mi piacciono. Mi piace il fatto
che esistano italiani diversi. E s’è capito anche in poche righe. Cosa sto
cercando di dire? Una cosa semplice. Mai parlare, mai scrivere, mai giudicare
pubblicamente un popolo, se non gli vuoi bene. Mai scegliere l’umorismo se non
sei certo di saperlo maneggiare. L’ironia è la sorella laica della misericordia;
il sarcasmo, il fratello odioso dell’intelligenza. Una sintesi affettuosa è
consentita, gradita e utile. Una generalizzazione acida è inopportuna, sgradita
e insidiosa. Oliviero Toscani, che non è né cattivo né sciocco, dovrebbe averlo
capito. Chieda scusa e finiamola qui. Ostrega!
«Veneti ubriaconi»,
denunciato Toscani e sul web impazza la satira,
scrive”Il Gazzettino”. Alcuni
tribunali hanno ricevuto oggi esposti e ricorsi contro il fotografo Oliviero
Toscani per le offese ai veneti definiti "Un popolo di ubriaconi, dei poveretti"
, ma anche politici di vario colore si stanno attivando con iniziative: «Non può
rimanere impunito, la giunta Zaia deve chiedere il rispetto della legge Mancino
che punisce, anche col carcere, chi con azioni o dichiarazioni fa
discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi» attacca il consigliere
regionale Giovanni Furlanetto del Gruppo Misto, che ha presentato
un'interrogazione urgente «È necessario che la giunta difenda il proprio popolo,
l'immagine che Toscani ha voluto dare è distorta e mirata a screditare un
Popolo. Forse aveva bevuto prima di esternare tali pensieri verso una delle
regioni più laboriose ed ingegnose d'Europa». Tornando agli aspetti legali a
Padova mezza dozzina di cittadini si sono sentiti particolarmente offesi dalle
dichiarazioni dell'ex pubblicitario del gruppo Benetton e ha chiesto un
risarcimento danni. L'avvocato Giorgio Destro assiste Renza Pregnolato,
interprete, una 59enne, nativa di Vescovana ma residente a Padova e spiega:
«Abbiamo già presentato una citazione a giudizio per Toscani a comparire di
fronte al Giudice di Pace, chiedendo 5 mila euro di risarcimento per danni
morali per ingiuria e diffamazione - dice l'avvocato Destro - Se alla causa, che
potrebbe essere discussa il 16 aprile prossimo, si aggiungeranno altre persone
si può valutate una class action». Naturalmente ironie, satira e commenti
stanno inondando il web.
Oliviero Toscani insiste:
"Nessuna scusa ai veneti ''ubriaconi'', loro chiamano terroni i meridionali".
Non molla e non chiede scusa Oliviero Toscani che ai
microfoni della Zanzara su Radio 24 rincara la dose dopo aver dato degli
"ubriaconi" ai veneti..., scrive “Radio 24”.
Toscani: "Non chiedo scusa ai Veneti, le ricerche mi danno ragione". Non molla e
non chiede scusa Oliviero Toscani che ai microfoni della Zanzara su Radio 24
rincara la dose dopo aver dato degli "ubriaconi" ai veneti: "Non devo chiedere
scusa, non ho detto niente di male. Ci sono anche ricerche e statistiche. Il
Veneto era una regione poverissima e l'unica ricchezza era la medicina, il vino
e la grappa che si dava anche ai bambini per curarli. Un alcolismo atavico".
"Chiedo scusa per loro dice Toscani ironicamente per quelli che non hanno capito
la satira". Il governatore Zaia pretende le scuse, insistono i conduttori
Giuseppe Cruciani e David Parenzo: "Zaia non ha niente da fare (no ga gnente da
far, benedetto, dice Toscani in dialetto, ndr) se si cura di una stupidata così.
Ci rida sopra. E poi alzi la mano un veneto che non ha mai dato del terrone a un
italiano del sud. Ditemi un veneto che non ha mai insultato un nero o un
immigrato. Vi ricordate di Gentilini?". "Non penso di aver offeso nessuno spiega
ancora il fotografo a Toscani: "Alzi la mano un veneto che non ha mai insultato
il Sud o gli immigrati. Ho detto una cosa banale e scontata, un po' di senso di
humor, dai. Una volta era un popolo che rideva, adesso hanno la coda di paglia.
Forse si sono offesi perché quello che ho detto è un po' vero. Ho letto anche
che dovrei sciacquarmi la bocca, sì ma col prosecco". Ma lei ha lavorato tanto
tempo con aziende venete, sputa nel piatto dove ha mangiato?: "Che storia
questa. Ho lavorato e se non fossi stato bravo non mi avrebbero pagato. Li ho
fatto diventare famosi, anche per prodotti in cui i veneti non sono forti. Ho
lavorato seriamente, cosa devo ringraziare?".
La mia amica terrona e la
paura della Polentonia.
Ho un’amica di origini terrone che vive a Milano, scrive
“Marteago”. Per motivi di lavoro si dovrebbe spostare in Veneto. La sapete la
sua preoccupazione? Ha paura del razzismo dei veneti nei confronti dei terroni.
La cosa mi ha fatto pensare. Ma noi polentoni siamo davvero così cattivi? Peggio
dei milanesi? La risposta é sì e anche no. Cioé dipende. C’é sicuramente del
risentimento del veneto lavoratore che paga le tasse e se le vede sperperare da
Roma che li passa a dei brutti soggetti al Sud. C’é anche una forte differenza
culturale. Diciamoci la verità. Siamo popoli diversi. L’Italia é un’arlecchino
messo assieme a forza. Un napoletano con un veneto centra tanto quanto un veneto
con un austriaco. E’ ovvio: l’Austria é più vicina. Mi permetto di fare questa
analisi in virtù della mia visione mondiale dei popoli. Cioé viaggio molto, vedo
molti popoli, passo le frontiere e mi rendo conto di come spesso queste
frontiere non corrispondano con le vere frontiere dei popoli. In Italia, se
volessimo avere delle frontiere reali, ce ne sarebbe una dalle parti di Roma.
Staremmo meglio noi, e starebbero meglio anche loro, che sono in gran parte
vittime della Cassa del Mezzogiorno. Insomma, motivi per non amarci ce ne sono
molti. Però…dobbiamo fare uno sforzo e capire un concetto fondamentale: il
singolo non può essere ritenuto responsabile delle colpe collettive. Non
possiamo incolpare il mio amico Jack di Shanghai del fatto che in Cina c’é la
pena di morte. Non possiamo incolpare una ragazza rumena del fatto che ci sono i
Rom che rubano. Non possiamo incolpare il Fullio del fatto che la gran parte dei
politici sono dei brutti soggetti. Frasi inutili: é sempre più semplice
generalizzare. Almeno all’inizio. Qui sta in effetti la soluzione. Ho detto alla
mia amica che se viene in Veneto la gente che conoscerà la tratterà bene,
perché é una brava ragazza. Ci saranno sicuramente delle situazioni poco
simpatiche: la cassiera al supermercato che appena sente il suo accento scende
di tre gradi centigradi e le crescono le unghie, il benzinaio ignorante e
leghista che sfoga la sua frustrazione facendo cadere una goccia della benzina
sulle sue scarpe da terrona pagate con le sue tasse e così via. Ma ci sarà
anche gente che le vorrà bene, nuove amicizie e situazioni simpatiche. Non
sarà sempre facile. Mi sono permesso di usare il termine “terrona” proprio per
svuotarlo dell’accezione negativa. Noi siamo polentoni e loro terroni. Domani
vado a Riga con quattro catanesi, quindi non posso essere accusato di niente.
Voi cosa ne pensate? Avete esperienze al riguardo? E se chi legge é del
Sud..come siamo noi veneti? Che difficoltà ci sono per chi viene da fuori?
Perché siamo brava gente in fondo, o no?
Toscani, lettera di scuse a
Zaia, «Ma dentro di me confermo tutto». Il fotografo risponde al
governatore: sono lombardo e atavicamente leghista, come voi ho nell’anima il
sentore di latte vaccino e quella voglia naturale di non pagare le tasse, scrive
“Il Corriere del Veneto”.
«Caro Signor Presidente, Le
scrivo con l’ansia e la fretta del Suo ultimatum di 48 ore che pende sulla mia
testa. Deve riconoscere, Presidente, che persino le ingiunzioni dell’Isis
lasciano 72 ore alla risposta. Premesso ciò, le dico che ho una cosa in comune
con la lega: l’amore per le cose colorite. Sono leghista atavicamente, essendo
lombardo. Ho anch’io, dentro di me, le due anime tipiche dei padani, che sotto
l’illuminismo di Cesare Beccaria e Pietro Verri nascondono questo sentore del
latte vaccino (che è l’alito della lega) e di quel localismo rurale che è fatto
di terra, di cielo, di laghi, di nuvole, di paesaggio, di cibo, di vino; ma
anche di naturale voglia di non pagare le tasse, di tenere tutto per sé, di non
essere solidali, di essere intolleranti, di mettere i cani da guardia ai
cancelli di ferro battuto della propria villetta a schiera, per azzannare
chiunque sia diverso: “Va ben el mat in piaza, ma che non sia dea mia raza”.
Purtroppo, da tanti anni, io non sono più completamente della Vostra “Razza”,
deve capire che io ormai sono toscano di fatto, oltre che di nome, e sono sicuro
che se avessi fatto questa battuta ai miei conterranei, saccenti e saputelli
come siamo, mi avrebbero subito citato Baudelaire e il suo “Per non essere gli
schiavi martirizzati del Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre!”. Perché
proprio così, siamo noi Toscani, sempre ubriachi di virtù, di poesia, di
bellezza. E di vino. Però, il Vostro linguaggio, mi piace ancora, perché è
eccessivo, iperbolico, espressionista, colorato; un linguaggio che morde e non
accarezza, in una parola sola: un linguaggio, secondo me, atavicamente ubriaco.
Quindi chiedo ancora scusa a Lei, che è il Presidente di tutti i Veneti astemi,
degli alcolisti sobri e dei bevitori moderati per il linguaggio un po’ leghista
che ho usato per fotografare i miei simpatici amici del Veneto. Nella sostanza,
però, dentro di me, confermo tutto. Perché c’è un rapporto forte tra territorio,
aria, fuoco, odori, saperi e sapori, sapori veneti come la polenta, il fegato
alla veneziana, il baccalà alla vicentina, risi e bisi, il risotto alla
trevigiana, e le bolle acide del Prosecco, l’alcolicità dell’Amarone, la
tossicità del Clinto, la bella inconsistenza del Valpolicella, il tannino del
Recioto di Soave, l’amarezza del Bardolino, l’asciuttezza del Pinot, il
verdognolo del Verduzzo. Caro Presidente, ogni volta che La vedo, scorgo nella
Sua faccia la gentilezza sotto l’asprezza, e l’asprezza sotto la gentilezza.
Quindi, mi scusi e scusatemi. Sono sicuro che, questa volta, la Sua gentilezza e
quella di tutti i Veneti prevarrà, sicuramente mi perdonerete, invece di perdere
tempo, denaro, energia e simpatia nelle infinite vie legali. La ringrazio e
ringrazio tutti i Veneti, sperando di incontrarvi presto per una fantastica
bevuta alla salute dell’Italia Unita.
"L’Unità d’Italia? Da 150
anni gronda sangue dei terroni".
Da direttore di Gente a paladino del Mezzogiorno col libro sui misfatti dei
Savoia, Pino Aprile racconta come i 150 anni dell’Unità d’Italia grondino sangue
dei terroni. A lui Al Bano al Festival di Sanremo dedica un inno, ma c’è chi lo
minaccia di morte, scrive Stefano Lorenzetto su “Il Giornale”. La
rappresentazione plastica di come sia impossibile mettere d’accordo polentoni e
terroni l’ho avuta davanti alla vetrina di una libreria di Verona. Siccome per
la copertina del suo Terroni, edito da Piemme, Pino Aprile ha scelto una
silhouette capovolta dello Stivale, con la Sicilia a nord e la Campania a sud,
una zelante commessa ha pensato bene di correggergliela esponendo il volume col
titolo a rovescio. In un solo colpo la libraia ha così ristabilito il primato
del planisfero, confermato il sottotitolo dell’opera ( Tutto quello che è stato
fatto perché gli italiani del Sud diventassero «meridionali» ) e ribadito senza
volerlo la battuta di Marco Paolini riportata nelle pagine interne: «Quando non
si vuole capire la storia, la si trasforma in geografia». Uscito dalla
tipografia Mondadori printing di Cles, Trento, Val di Non (a dimostrazione che
l’Italia unita almeno per gli editori è cosa fatta), Terroni è diventato nel
giro di dieci mesi bestseller, oggetto di scontro, manifesto dell’orgoglio
sudista, testo sacro per i revisionisti del Mezzogiorno, strumento di lotta
politica e ora persino brano del Festival di Sanremo: Al Bano, 67 anni, pugliese
di Cellino San Marco, inserirà nel suo Cd l’inno Gloria, gloria scritto da Mimmo
Cavallo e ispirato al saggio di Aprile, 60 anni, pugliese di Gioia del Colle.
Non basta. Terroni è l’edizione multimediale per iPad, con foto, interviste e
spezzoni dal film E li chiamarono briganti di Pasquale Squitieri, in uscita a
febbraio. Terroni è lo spettacolo teatrale che andrà in scena il 21 marzo al
Quirino di Roma, «per rispondere a Umberto Bossi e alla sua arroganza, per dire
basta a questo massacro che dura da 150 anni », proclama dalle pagine di
Facebook l’attore-regista Roberto D’Alessandro, cresciuto alla scuola di Gigi
Proietti. Terroni, insomma, è tifo da stadio: non a caso l’autore, pur avendo
ormai perso il conto delle ristampe («almeno una ventina»), rivela d’averne
venduto 150.000 copie, mentre su Wikipedia un biografo infervorato gliene
attribuisce addirittura mezzo milione, il che, anche a voler considerare le
brossure veicolate da Mondolibri e gli ebook scaricati da Internet, appare
piuttosto esagerato. Pino Aprile è stato vicedirettore di Oggi e poi direttore
di Gente. Prima d’avere come target fisso Carolina di Monaco («ho scoperto che
era calva: scoop mondiale »), s’era sempre occupato di terrorismo e politica. Da
pensionato pensava di dedicarsi alla passione della sua vita: il mare. Ha
diretto il mensile Fare vela e ha scritto tre libri dai titoli sanamente
monomaniacali: Il mare minore, A mari estremi e Mare, uomini, passioni. Poi gli
è scappato Terroni ed è finito nell’oceano in tempesta: «Ho accettato finora
quasi 200 presentazioni. Nel frattempo sono giunti all’editore altri 500 inviti.
In teoria avrei l’agenda piena di appuntamenti sino alla primavera del 2012, se
non ricevessi altre richieste. Invece continuano ad arrivarne. Mi chiamano
anche all’estero. La prima trasferta è stata in Svezia, quindi Londra, Zurigo,
Manchester, New York... Sono distrutto».
Ma la invitano solo i
circoli dei calabresi o anche quelli degli emigrati veneti?
«Università, centri di
cultura, associazioni italiane, come la Dante Alighieri».
È il libro di saggistica
che resiste da più mesi in classifica o sbaglio?
«Vero. Spero che mi venga
perdonato».
Com’è nata l’idea di
Terroni?
«Avevo delle domande, cercavo
delle risposte. Se davvero a fine Ottocento i meridionali erano poveri,
arretrati e oppressi, perché mai reagirono contro i “liberatori” venuti dal Nord
con una guerra civile durata a lungo e successivamente con la fuga, emigrando?
Solo dopo molti anni ho pensato di farne un libro».
Ha ricevuto offese o
minacce?
«Offese tante. Qualcuno mi
chiede se non ho paura. E di che? Su Facebook un tale mi ha scritto: “Farai la
fine di D’Antona”. Ho cercato di rintracciarlo, ma risultava inesistente. Del
resto quella è una lavagna collettiva su cui compare di tutto: un estimatore mi
ha dedicato lo slogan pubblicitario “Terroni, non ci sono paragoni”. È seccante
la supponenza di chi crede di sapere già tutto e non è nemmeno sfiorato dal
dubbio».
Alla presentazione di
Torino s’è quasi sfiorata la rissa.
«Eravamo nella Sala dei
Cinquecento, gli altri sono rimasti in piedi... Una persona ha inveito contro
Roberto Calderoli, che non era presente, per gli insulti rivolti dal ministro
leghista ai napoletani. Gli interventi di Marcello Sorgi, Massimo Nava e
Pietrangelo Buttafuoco sono filati via lisci. Quando ha cominciato a parlare
Giordano Bruno Guerri, che ha scritto un libro sul brigantaggio postunitario, la
stessa persona lo ha offeso. Lo storico è sceso dal palco per regolare i conti e
il contestatore s’è zittito. Meno male: Guerri discende dai pirati etruschi, ha
profilo da pugile e mani da cavatore di ciocco».
Si può dire che Terroni
abbia fatto venire al Sud la voglia di secessione che fino a ieri serpeggiava
solo al Nord?
«No. È stato detto che Terroni
incita i meridionali alla sollevazione. Figuriamoci! Il Mezzogiorno non ha voce:
tutti i giornali nazionali, eccetto La Repubblica, si pubblicano al Nord e le
tre reti televisive private sono di un editore lombardo che, da capo del
governo, ha voce in capitolo pure in quelle pubbliche. Per la legge di
prossimità, la stampa trova più interessante il miagolio del gatto di casa
rispetto al ruggito del leone nella savana. Il Nord scopre che cosa sta
accadendo dalle mie parti solo quando s’interroga sul successo di Terroni o del
film Benvenuti al Sud . Ma Terroni è il dito che indica la luna, non la luna. Ci
sono libri che cambiano il cuore degli uomini. Mi spiace, il mio non è fra
questi: sono nato di febbraio e non ho avuto per padre putativo un mite
falegname. La voglia di secessione del Sud germoglia come reazione agli insulti
dei ministri del Nord. È meno forte e diffusa che in Lombardia o nel Veneto, ma
cresce».
Quali sentimenti suscitano
in lei i 150 anni dell’Unità d’Italia?
«Di delusione, talvolta di
disgusto. In quale Paese può restare in carica un ministro che ha trattato la
bandiera nazionale come carta igienica? O un sindaco che ha marchiato con
simboli di partito la scuola dei bambini? L’Italia unita era da fare, perché
ogni volta che cade una frontiera gli uomini diventano più liberi, più ricchi,
più sicuri, più felici. Ma non era da fare con una parte del Paese schierata
contro l’altra. La ricorrenza dei 150 anni poteva diventare l’occasione per fare
onestamente una volta per tutte i conti con la storia. Così non è».
Che cosa pensa dei Savoia?
«Si sono trovati al posto
giusto nel momento giusto. Mentre un’esigua minoranza, non più dell’1-2 per
cento della popolazione, era animata dal pio desiderio di unificare l’Italia,
loro ne avevano l’impellente necessità: strozzati dai debiti, potevano salvarsi
solo con l’invasione e il saccheggio del Sud. Lo scrisse nel 1859 il deputato
Pier Carlo Boggio, braccio destro di Cavour: “O la guerra o la bancarotta”. Fino
al 1860, per ben 126 anni, i Borbone mai aumentarono le tasse. Nel Regno di
Napoli erano le più basse di tutti gli Stati preunitari».
Bruno Vespa mi ha
confessato la sua sorpresa nello scoprire solo di recente che nel regno
borbonico le imposte erano soltanto cinque, contro le 22 introdotte dai Savoia.
«I soldi del Sud ripianarono
il buco del Nord. Al tesoro circolante dell’Italia unita, il Regno delle Due
Sicilie contribuì per il 60 per cento, la Lombardia per l’1 virgola qualcosa, il
Piemonte per il 4. Negli Stati via via annessi all’Italia nascente, appena
arrivavano i piemontesi spariva la cassa».
E di Giuseppe Garibaldi che
cosa pensa?
«Romantico avventuriero, di
idee forti, semplici, a volte confuse, ma più onesto di altri nel denunciare,
solo a cose fatte però, le stragi e le rapine compiute nel Mezzogiorno. Qualche
problema di salute, per l’artrosi che gli rendeva doloroso cavalcare: a Napoli
arrivò in treno. Qualche disavventura familiare: la giovane sposa incinta di un
altro. Qualche pagina oscura nel suo passato sudamericano: la tratta degli
schiavi dalla Cina al Perù. Ne hanno fatto un santino. Ma va bene così, ogni
nazione ha bisogno dei suoi miti fondanti. Basta sapere chi erano veramente».
E di Camillo Benso conte di
Cavour che cosa pensa?
«Grande giocatore, specie
nell’imprevisto. Non voleva la conquista del Regno delle Due Sicilie: gli
bastavano il Lombardo- Veneto e i Ducati. Già la Toscana gli pareva in più. Ma
quando l’avventura meridionale ebbe inizio, in breve la fece propria, persuase
il re, neutralizzò Garibaldi, ammansì chi si opponeva. Qualche suo vizietto
sarebbe stato da galera. Come molti padri del Risorgimento, non mise mai piede
al Sud: lo conosceva per sentito dire».
La peggiore figura del
Risorgimento?
«Il generale Enrico Cialdini,
poi deputato e senatore del Regno. Un macellaio che menava vanto del numero di
meridionali fucilati, delle centinaia di case incendiate, dei paesi rasi al
suolo. Prima di diventare eroe pluridecorato del Risorgimento, fu mercenario
nella Legione straniera in Portogallo e Spagna. Uccideva i suoi simili a
pagamento».
Quali sono gli episodi
risorgimentali più rivoltanti, che l’hanno fatta ricredere sulla sua italianità?
«Non si può smettere di essere
italiani. Però mi sono dovuto ricredere circa il racconto bello e glorioso sulla
nascita del mio Paese che avevo imparato a scuola. Da adolescente fremi
d’indignazione per gli indiani sterminati sul Sand Creek e da grande scopri che
i fratelli d’Italia nel Meridione fecero di peggio. La mitologia risorgimentale
cominciò a vacillare quando lessi La conquista del Sud di Carlo Alianello. Vi si
narrava la storia di una donna violentata e lasciata morire da 18 bersaglieri,
che già le avevano ammazzato il marito. Il figlioletto che assistette alla
scena, divenuto adolescente, si vantava d’aver ucciso per vendetta 18 soldati di
re Vittorio Emanuele a Custoza. Poi il massacro di Pontelandolfo e Casalduni,
5.000 abitanti il primo, 3.000 il secondo, due delle decine di paesi distrutti,
con libertà di stupro e di saccheggio lasciata dal Cialdini ai suoi soldati,
fucilazioni di massa, torture, le abitazioni date alle fiamme con la gente
all’interno. E le migliaia di meridionali squagliati nella calce viva a
Fenestrelle, una fortezza-lager a una settantina di chilometri da Torino, a
1.200 metri di quota, battuta da venti gelidi, dove la vita media degli
internati non superava i tre mesi. Per garantire ulteriore tormento ai
prigionieri, erano state divelte le finestre dei dormitori. Viva l’Italia!».
Gianfranco Miglio, ideologo
della Lega, mi confidò che era ancora terrorizzato da certe storie atroci udite
da bambino, quando il nonno gli raccontava che, giovane bersagliere in Calabria,
aveva trovato un suo commilitone crocifisso su un termitaio dai briganti.
«Le ha anche raccontato che
cos’aveva fatto quel bersagliere? Era in un Paese invaso senza manco la
dichiarazione di guerra. Maria Izzo, la più bella di Pontelandolfo, fu legata
nuda a un albero, con le gambe divaricate, stuprata a turno dai bersaglieri e
poi finita con una baionettata nella pancia. A Palermo uccisero sotto tortura un
muto dalla nascita perché si rifiutava di parlare. Riferirono in Parlamento
d’aver fucilato, in un anno, 15.600 meridionali: uno ogni 14 minuti, per dieci
ore al giorno, 365 giorni su 365. Ma il conto delle vittime viene prudentemente
stimato in almeno 100.000 da Giordano Bruno Guerri. Altri calcoli arrivano a
diverse centinaia di migliaia. La Civiltà Cattolica, rivista dei gesuiti, nel
1861 scrisse che furono oltre un milione. La cifra vera non si saprà mai».
Da Terroni :«“Ottentotti”,
“irochesi”, “beduini”, “peggio che Affrica”, “degenerati”, “ritardati”,
“selvaggi”, “degradati”: così i meridionali vennero definiti, e descritti con
tratti animaleschi, dai fratelli del Nord scesi a liberarli».
Io sono veneto. Ha idea di quante ce ne hanno dette e ce ne dicono? Razzisti,
analfabeti, beoti, ubriaconi, bestemmiatori, evasori fiscali, sfruttatori di
clandestini. Non crede che se cominciamo a tenere questo genere di contabilità,
non la finiamo più?
«Devono finirla i Bossi, i
Calderoli, i Borghezio, i Salvini, i Brunetta. Quella degradazione dei
meridionali ad animali preparò e giustificò il genocidio. Ricordo le parole di
un intellettuale di Sarajevo: “Non è stato il fracasso dei cannoni a uccidere la
Jugoslavia. È stato il silenzio. Il silenzio sul linguaggio della violenza,
prima che sulla violenza”. Un ministro della Repubblica ha minacciato il ricorso
ai fucili. In Italia, adesso. Non a Sarajevo, allora».
Lei scrive che Luigi
Federico Menabrea, presidente del Consiglio dei ministri del Regno, nel 1868
voleva deportare in Patagonia i meridionali sospettati di brigantaggio. Che cosa
dovrebbero dire i veneti deportati per davvero da Benito Mussolini nelle
malariche paludi pontine per bonificarle?
«Menabrea voleva deportare i
meridionali per sterminarli. I veneti nelle paludi pontine non furono deportati:
ebbero lavoro, casa, terra risanata con i soldi di tutti e a danno di quelli che
vi morivano di malaria da secoli per trarne pane. Ma vediamo il lato positivo:
fra poveri s’incontrarono. E dove il sangue si mischia, nasce la bellezza. La
provincia oggi chiamata Latina ha dato all’Italia la più alta concentrazione di
miss da calendario per chilometro quadrato. E pure Santa Maria Goretti, che si
fece uccidere per difendere la propria femminilità».
Scrive anche: «La Calabria
non appartiene, geologicamente, al Mezzogiorno, ma al sistema alpino: si staccò
con la Corsica dalla regione ligure-provenzale e migrò, sino a incastrarsi fra
Sicilia e Pollino». Recrimina persino sull’orografia?
«O è un modo per dire che a
Sud vogliono venirci tutti?».
Si dilunga sul caso di
Mongiana, che in effetti è impressionante. Però che cosa dimostra? Da Nord a
Sud, ogni distretto industriale piange i suoi dinosauri.
«Mongiana, in Calabria, era la
capitale siderurgica d’Italia e oggi contende alla confinante Nardodipace lo
scomodo primato di Comune più povero d’Italia. I mongianesi, sradicati dal loro
paese, si sono trovati a lavorare nelle fonderie del Bresciano: 150 famiglie,
circa 500 persone, solo a Lumezzane, che è ormai la vera Mongiana. Dove prima
1.500 operai e tecnici siderurgici specializzati rendevano autosufficiente
l’industria pesante del Regno delle Due Sicilie, adesso non è rimasto neppure un
fabbro. Il più ricco distretto minerario della penisola fu soppresso dal governo
unitario per un grave difetto strutturale: si trovava nel posto sbagliato, nel
Meridione. Il Sud non doveva far concorrenza al Nord nella produzione di merci.
E questo fu imposto con le armi e una legislazione squilibrata a danno del
Mezzogiorno. La vicenda di Mongiana è esemplare, nell’impossibilità di
raccontare tutto. Ma accadde la stessa cosa con la cantieristica navale,
l’industria ferroviaria, l’agricoltura».
In occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, la città di Gaeta vuol chiedere un risarcimento per
l’assedio savoiardo del 1861: 500 milioni di euro. Mi ricorda il Veneto, che
pretende i danni di guerra dalla Francia per il saccheggio napoleonico del 1797:
1.033 miliardi di euro.
«C’è una differenza: al
risarcimento di Gaeta s’impegnò il luogotenente, principe di Carignano, in nome
del quale il generale Cialdini, responsabile di quelle macerie, garantì per
iscritto: “Il Governo di Sua Maestà provvederà all’equo e maggiore possibile
risarcimento”. Quando gli amministratori comunali andarono per riscuotere, il
nuovo luogotenente, Luigi Farini, già distintosi con moglie e figlia nel
patriottico furto dell’argenteria dei duchi di Parma, consigliò loro di
rivolgersi “alla carità nazionale”».
Lei è arrivato al punto da
dichiarare che Giulio Tremonti ruba al Sud per dare al Nord. Forse dimentica che
il Veneto ha solo 225 dirigenti regionali mentre la Sicilia ne ha 2.150. L’855
per cento in più. Che si aggiungono ai 100.000 dipendenti ordinari. Allora le
chiedo: chi ruba a chi, se non altro lo stipendio?
«I fondi per le aree
sottoutilizzate sono, per legge, all’85 per cento del Sud, e invece sono stati
abbondantemente spesi al Nord. I 3,5 miliardi di euro con cui è stata abbuonata
l’Ici a tutt’Italia erano quelli destinati alle strade dissestate di Calabria e
Sicilia. I cittadini della Val d’Aosta spendono il 10.195 per cento in più della
Lombardia, pro capite, per i dipendenti regionali. Ma è una ragione a statuto
speciale, si obietta. Giusto. Pure la Sicilia lo è. Il che non assolve né l’una
né l’altra. Ma il paragone si fa sempre con l’altra».
Il sociologo Luca Ricolfi
in "Il sacco del Nord" documenta che ogni anno 50 miliardi di euro lasciano le
regioni settentrionali diretti al Sud. E lei me lo chiama furto?
«Intanto i conti andrebbero
fatti sui 150 anni. E poi lo stesso Ricolfi spiega che quei dati, valutati
diversamente, portano a conclusioni diametralmente opposte. Non tutti sono
d’accordo sul metodo scelto da Ricolfi. Vada a farsi due chiacchiere col
professor Gianfranco Viesti, bocconiano che insegna politica economica
all’Università di Bari».
S’ode a destra uno squillo
di tromba: Terroni. A sinistra risponde uno squillo: Viva l’Italia! di Aldo
Cazzullo. Che l’ha accusata d’aver paragonato i piemontesi ai nazisti solo per
vendere più copie.
«Incapace di tanta eleganza, a
Cazzullo confesso che scrivo nella speranza di essere letto. E non capisco
perché il suo editore spenda tanti soldi per pubblicizzare Viva l’Italia! se lo
scopo è quello di non vendere copie. Il mio libro s’è imposto col passaparola».
Non nominare il nome di
Marzabotto invano, le ha ricordato Cazzullo.
«Che differenza c’è fra
Pontelandolfo e Marzabotto? Mettiamola così: il mio editore ha nascosto
l’esistenza di Terroni, l’editore di Cazzullo ha fatto il contrario. Nessuno dei
due ha ottenuto il risultato sperato».
Anche Ernesto Galli della
Loggia e Francesco Merlo hanno maltrattato il suo pamphlet.
«Libera critica in libero
Stato: non si può piacere a tutti. A me piace non piacere a Galli della Loggia,
per esempio. Prima ha parlato di “fantasiose ricostruzioni”. Poi, al pari di
Merlo e di qualche altro, ha obiettato che le stragi risorgimentali nel Sud
erano note e da considerarsi “normali” in tempo di guerra. A parte che a scuola
tuttora non vengono studiate, allora scusiamoci con i criminali nazisti Herbert
Kappler e Walter Reder per l’ingiusta detenzione; critichiamo gli Stati Uniti
che hanno inflitto l’ergastolo all’ufficiale americano responsabile dell’eccidio
di My Lai in Vietnam; chiediamoci perché si condanni il massacro dei curdi a
opera di Saddam Hussein. Insomma, solo l’uccisione in massa dei meridionali è
“normale”?».
Sergio Romano sul Corriere
della Sera s’è dichiarato infastidito dai «lettori meridionali che deplorano i
soprusi dei piemontesi, l’arroganza del Nord, il sacco del Sud, e rimpiangono
una specie di età dell’oro durante la quale i Borbone di Napoli avrebbero fatto
del loro regno un modello di equità sociale e sviluppo economico». E vi ha
ricordato che, per unanime consenso dell’Europa d’allora, «il Regno delle Due
Sicilie era uno degli Stati peggio governati da una aristocrazia retriva,
paternalista e bigotta».
«Senta, foss’anche tutto vero,
e non lo è, questo giustifica invasione, saccheggio e strage?Mi pare la tipica
autoassoluzione del colonizzatore: ti distruggo e ti derubo, però lo faccio per
il tuo bene, neh? Infatti, l’Italia riconoscente depone ogni anno una corona
d’alloro dinanzi alla lapide che ricorda il colonnello vicentino Pier Eleonoro
Negri, il carnefice di Pontelandolfo e Casalduni, e nega ai paesi ridotti in
cenere rimasero in piedi solo tre case persino il rispetto per la memoria».
Lei ha fatto il servizio
militare?
«Arruolato, C4 rosso, se non
ricordo male: mi dissero che, se fosse scoppiata la guerra, sarei finito in
ufficio. I miei polmoni non davano affidamento: postumi di Tbc e quattro
pacchetti di Gauloises al giorno».
Se scoppiasse una guerra,
difenderebbe l’Italia o no?
«Oh, ma che domande sono? Lo
chieda a Bossi e a Calderoli! Io sono un italiano che pretende la verità critica
su com’è nato il suo Paese e la fine della sperequazione e degli insulti a danno
del Sud. La questione meridionale non esisteva 150 anni fa, il Consiglio
nazionale delle ricerche ha dimostrato che prodotto lordo e pro capite erano
uguali al Nord e al Sud. I meridionali, con un terzo della popolazione, diedero
circa la metà dei caduti nelle trincee della prima guerra mondiale».
Silvius Magnago, lo storico
leader della Svp, mi disse: «La patria è quella cui si sente di appartenere con
il cuore. La mia Heimat è il Tirolo. Heimat, terra natia. Voi italiani non
possedete questo concetto. Non potete capire». Che cosa significa patria per
lei? E qual è la sua Heimat?
«Lo dico nell’esergo del mio
libro, con parole rubate allo scrittore francese Emmanuel Roblès: patria è “là
dove vuoi vivere senza subire né infliggere umiliazione” ».
Sarebbe favorevole a
un’Italia divisa in cantoni, come la Svizzera?
«No. Una frontiera non
migliora gli uomini. Al più, può peggiorarli. Ma se la Lega, dopo vent’anni di
strappi, recidesse l’ultimo filo che tiene ancora unito il Paese, un attimo
prima il Sud dovrebbe andarsene, contrattando l’uscita, per evitare di essere
derubato di nuovo».
Su quali basi
andrebberifatta l’Unità d’Italia?
«Eque. La forma garantisce
poco la sostanza: vada a spiegare ai giovani che la nostra è una Repubblica
fondata sul lavoro. O che la legge è uguale per tutti. O che le Ferrovie dello
Stato assicurano il servizio in tutto il Paese: Matera, amena località europea,
è ignota alle Fs, lì il treno non è mai arrivato».
Fosse lei il presidente del
Consiglio, che farebbe per ripulire Napoli dai rifiuti?
«Nominerei commissario
Vincenzo Cenname, il sindaco che ha fatto di Camigliano, provincia di Caserta,
un esempio virtuoso nello smaltimento, grazie alla raccolta differenziata che
copre il 65 per cento del totale. Cenname s’è rifiutato di affidarne la gestione
a un ente provinciale, la cui inefficienza è testimoniata dalle immondizie che
vengono lasciate nelle strade per scoraggiare la raccolta differenziata a favore
degli inceneritori. Per questo Cenname è stato rimosso dal prefetto, quasi fosse
a capo d’una Giunta camorrista».
Siamo alla domanda delle
cento pistole: i terroni hanno voglia di lavorare sì o no?
«Capisco che la domanda lei
deve porla e immagino che le costi dar voce agli imbecilli. Se fossi maleducato,
risponderei: ma mi faccia il piacere! Non lo sono e quindi rispondo: quei 5
milioni di meridionali che stanno nelle fabbriche del Nord, dall’abruzzese
Sergio Marchionne in giù, come li vede? Sfaticati? Quei 20 milioni di emigrati
nel mondo, che per la prima volta nella loro storia millenaria presero la via
dell’esilio volontario dopo i disastri dell’Unità d’Italia, sono andati altrove
a far nulla? La mia regione fu l’unica in cui per l’aridità della terra fallì il
sistema di produzione dell’impero romano, imperniato sulla villa. Ebbene di quei
deserta Apuliae, deserti di Puglia, la mia gente nel corso dei secoli, col
sudore della fronte, ha fatto un giardino, rubando l’umidità alla notte con i
muretti di pietra e piantando 60 milioni di ulivi. Mica come Bossi, che non ha
lavorato un giorno in vita sua. Anzi, sa che le dico, senza offesa, eh? Ma mi
faccia il piacere!».
Il 52 per cento della
popolazione di Terzigno, provincia di Napoli, campa a carico dell’Inps. Sarà
mica colpa dell’Inps?
«Se mi togli tutto, mi attacco
a quello che c’è. Assistenza? Assistenza! Non mi piace, ma non ho altra scelta.
A Parma, 170.000 abitanti, il ministero ha deciso di erogare lo stesso i soldi
per la metropolitana progettata per 24 milioni di utenti, poi ridotti a 8,
infine abbandonata, per vergogna, spero, nonostante lo studio costato 30 milioni
di euro. È la città della Parmalat, la peggior truffa di tutti i tempi. Però la
truffa del falso invalido scandalizza maggiormente. Be’, a me le truffe danno
fastidio tutte. Quella del povero la capisco di più».
La metà delle cause contro
l’Inps si concentra in sei città del Sud: Foggia, Napoli, Bari, Roma, Lecce e
Taranto. A Foggia è pendente circa il 15 per cento dell’intero contenzioso
nazionale dell’istituto. Tutti i 46.000 braccianti iscritti alle liste di Foggia
hanno fatto causa all’Inps. Dipenderà mica dai Savoia.
«Per quanto possa sborsare
l’Inps da Terzigno a Lecce, non si arriverà mai ai miliardi di euro che ci
costano le multe pagate per colpa degli allevatori padani disonesti, grandi
elettori della Lega. O assolviamo tutti, ed è sbagliato, o condanniamo quelli
che lo meritano. Con una differenza: la truffa delle quote latte è già
accertata. Aspettiamo di vedere come finiscono i procedimenti contro l’Inps».
C’è poco da aspettare: a
Foggia, su 122.000 cause presentate, 25.000 sono state spontaneamente ritirate
dagli avvocati. Erano state avviate per lo più a nome di persone morte o
inesistenti.
«Ma non è detto che tutte le
altre siano immotivate. Ripeto: aspettiamo».
Non sarà che lei mi diventa
il Bossi del Sud?
«Già l’accostamento è
offensivo. Io non giudico il mio prossimo dalla latitudine e ho sempre lavorato;
né ho festeggiato tre volte la laurea, senza mai prenderla. Mi hanno offerto
candidature, ma ho ringraziato e rifiutato, perché inadatto: sono incensurato,
ho pagato la casa con i miei soldi e voglio morire giornalista».
Eppure Giordano Bruno
Guerri ha scritto che Terroni è sostenuto da piccoli ma combattivi gruppi
neoborbonici e dal Partito del Sud di Antonio Ciano, assessore a Gaeta, e
potrebbe diventare il testo sacro di una futura Lega meridionale, contrapposta a
quella di Bossi.
«Il libro, una volta uscito,
va per la sua strada, come i figli. Non puoi dirgli tu dove andare. Terroni non
è sostenuto: è letto. E chi lo legge ne fa l’uso che vuole, a patto di non
attribuirlo a me. Stimo Ciano e seguo con attenzione il Partito del Sud, i
Neoborbonici, l’Mpa del governatore siciliano Raffaele Lombardo, l’associazione
Io resto in Calabria di Pippo Callipo, il movimento Io Sud di Adriana Poli
Bortone. Ma resto un osservatore interessato ed esterno. Ero anche amico di
Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso dalla camorra con nove colpi di
pistola. Ricordo i suoi funerali, con quei fogli tutti uguali attaccati alle
saracinesche dei negozi chiusi e ai portoni delle case: “Angelo, il paese muore
con te”. Oggi per fortuna Pollica va avanti nel suo nome. In una ventina d’anni
da sindaco, Angelo aveva arricchito tutti, senza distruggere niente del
territorio, vero capitale del paese. Ammiravo il suo coraggio, la sua fantasia,
la sua capacità di trasformare le idee in fatti. Ho pianto accompagnandolo al
cimitero. Se avesse potuto vedermi, si sarebbe messo a ridere».
Per chi vota?
«La prima volta votai Dc per
ingenuità, su consiglio d’un amico. Delusione feroce. Poi a sinistra, senza mai
avere un partito, cosa che ritengo incompatibile col giornalismo. Infine quasi
stabilmente per i repubblicani di La Malfa, padre, ovviamente. Alle prossime
elezioni forse non voterò, anche se so di fare un regalo ai peggiori».
Non mi pare che la
sinistra, con l’unico presidente del Consiglio originario di Gallipoli, abbia
migliorato la condizione del Sud.
«Massimo D’Alema ha il
collegio elettorale a Gallipoli e la moglie pugliese. Ma è romano. E poi,
ripeto, l’essere di qui o di là non significa nulla. Il meridionalismo è una
dottrina solo italiana, nel mondo. È stata praticata da uomini eccelsi per
cultura e moralità,ma è un’invenzione di italiani del Nord, specie lombardi.
Solo dopo una generazione sono sorti i meridionalisti meridionali. Che mi frega
di dove sei? Fammi vedere cosa fai!».
Lei lamenta l’invasione
burocratica piemontese del Meridione, però Mario Cervi le ha ricordato che oggi
il Sud amministra col proprio personale la macchina burocratica e giudiziaria
dello Stato nell’Italia intera. E i risultati non sono brillanti.
«Tutti, ma proprio tutti gli
enti, le banche, le aziende pubbliche o parapubbliche d’Italia sono in mano a
settentrionali, in particolare lombardi, a parte un napoletano e tre romani.
Vuol dire che se cotanti capi non riescono a raggiungere buoni risultati la
colpa è dei sottoposti? Se si vince è bravo il generale e se si perde sono
cattivi i soldati? Quando dirigevo un giornale, la mia regola era: chiunque
abbia sbagliato, la colpa è mia».
Vuoi fare successo? Inventati
una Gomorra! Uno scrittore fallito inventa un reportage su Scampia. E, sparando
"ca...te senza pietà" arriverà alla gloria. La geniale parodia di Roberto
Saviano fatta da Francesco Mari, scrive Nicola Mirenzi su “Il Giornale”.
Francesco Mari, La ragazza di Scampia, Fazi, 2014. Altro che il vero. È lo
spruzzo di realtà, specie se criminale, che scala le classifiche, diventa
bestseller e assalto ai botteghini. Ecco la messinscena che Francesco Mari fa a
pezzettini con il suo romanzo d’esordio, La ragazza di Scampia (Fazi
Editore, 256 pp, 16 euro), prendendosi gioco dei prodigi dello storytelling
camorristico nazionale, dove la scena di Napoli è sempre acchitata per
compiacere l’occhio di chi guarda, desideroso di confermarsi nell’idea che “i
napoletani abitano dentro un noir a cielo aperto”. Il protagonista, Franco,
tardo trentenne funzionario del comune, ha una vita noiosa. Il momento di più
alta eccitazione della giornata lo raggiunge quando si ficca le cuffie dell’iPod
nelle orecchie andando in ufficio. “Niente Radiohead e niente Anthony and the
Johnsons da queste parti. Niente nomi giusti e gusti ricercati, di chi di musica
ne capisce. Qui si attinge l’illuminazione a botte di Madonna, Jennifer Lopez e
Céline Dion”. Poi c’è la depressione del lavoro: “Otto ore quotidiane di ufficio
in cui faccio questo: niente”. Per arrivare alla ciliegina sulla torta delle le
donne: ““È quasi un anno che non scopo, Vale!”, Chi cazzo se ne frega della
crisi economica, la disoccupazione, i problemi preadolescenziali di tuo figlio”.
Un monologo interiore che si conclude sempre con la stessa resa: un bacio sulle
guance. Franco però scrive. Rimugina la rivincita. Il piano è convincere un
editore cool di Milano, uno di quelli che ti fanno svoltare da un giorno
all’altro, di pubblicare un libro. S’inventa così di sana pianta un Reportage
dall’inferno di Scampia (e dove, senno?). “Come Michael Douglas in Un giorno di
ordinaria follia, ho imbracciato la mia arma e ho cominciato a sparare cazzate
senza pietà”. Un cantante neo-melodico che svela i segreti dei clan. Il gruppo
rap impegnato nel sociale. Una donna-coraggio che perde il fratello e decide di
parlare senza paura di morire ammazzata: “I killer che mi verranno a fare fuori
li aspetterò qua, a casa mia”. È una storia afrodisiaca. Combacia alla
perfezione con l’ideologia del romanzo criminale. Il mafia-reality-show.
L’editore si convince d’aver scovato il nuovo Saviano. Firma il contratto.
Pianifica di far uscire il libro insieme a un film. “Faranno il botto”,
presagisce. Sale su su sino al settimo cielo. Da dove non scenderà neanche
quando scopre che è tutta una sceneggiata. Era la Napoli che voleva farsi
raccontare. La racconterà. “Vera, falsa, che importanza ha?”. A sfottere
godiamo: siam settentrionali.
ESSERE LIBERALI OD ESSERE
DI SINISTRA?
Dover scegliere di essere
egoisti e meschini o saccenti e cattivi?
Dante contro gli immigrati:
"La mescolanza delle genti è causa dei mali delle città".
Nel XVI canto del Paradiso Dante, tramite il suo avo Cacciaguida, lancia
un'invettiva contro gli stranieri che hanno invaso Firenze e contro la Chiesa,
complice dell'invasione, scrive Matteo Carnieletto su “Il Giornale”. Esiste un
Dante Alighieri che Benigni non vuole o non può vedere. Un Dante reazionario.
Reazionarissimo. Un Dante che sarà poi ripreso dal "cattolico belva" Domenico
Giuliotti e da Ezra Pound. Questo Dante, il vero Dante, ha scritto parole
durissime contro l'immigrazione e contro la Chiesa che si rende complice di
questa tratta di uomini. Basta leggere il sedicesimo canto del Paradiso,
dove Dante, accompagnato da Beatrice, è a colloquio con Cacciaguida, il glorioso
avo che trovò la morte durante la seconda crociata. Dante chiede a Cacciaguida
di parlargli di Firenze, di raccontargli come fosse nei tempi civili. Subito
Cacciaguida si infiamma "come s’avviva a lo spirar d’i venti / carbone in
fiamma, così vid’io quella / luce risplendere a’ miei blandimenti". Ricorda come
gli abitanti di Firenze fossero un quinto rispetto a quelli che ci sarebbero
stati 150 anni dopo dopo la sua morte: "Tutti color ch'a quel tempo eran ivi /
da poter arme tra Marte e ‘l Batista, / eran il quinto di quei ch’or son vivi.
Ma la cittadinanza, ch’è or mista / di Campi, di Certaldo e di Fegghine, / pura
vediesi ne l’ultimo artista". Ovvero: la popolazione di Firenze, che ora è
mescolata con gli abitanti di Campi Bisenzio, Certaldo, Figline Valdarno, era
pura fino al midollo. Fino al più semplice degli artigiani. E di chi è la colpa,
secondo Cacciaguida e, quindi, anche secondo Dante? Della Chiesa che favorisce
l'immigrazione dei toscani a Firenze: "Se la gente ch’al mondo più traligna /
non fosse stata a Cesare noverca, ma come madre a suo figlio benigna, / tal
fatto è fiorentino e cambia e merca, / che si sarebbe vòlto a Simifonti, / là
dove andava l’avolo a la cerca". Ovvero: se la Chiesa non fosse stata matrigna
nei confronti dell'imperatore e fosse stata amorevole nei confronti del figlio,
certi fiorentini che ora passano il tempo a cambiar valute e a mercanteggiare
sarebbero rimasti a Semifonte a chiedere l'elemosina come facevano i loro avi. E
Dante riconosce la causa prima della decadenza delle città nell'immigrazione
indiscriminata: "Sempre la confusion de le persone / principio fu del mal de la
cittade, / come del vostro il cibo che s’appone". Ovvero: la mescolanza delle
genti provoca sempre il male delle città. Insomma, attenti progressisti e
radical chic a leggere Dante. Potreste rimanere parecchio delusi.
Il Giornale: "Dante era contro
gli immigrati". Ma il dantista Mirko Volpi li stronca: "Operazione forzata, non
tirate Dante per la giacca", scrice Laura Eduati su L'Huffington Post. Sette
secoli prima dell'arrivo dei barconi dall'Africa, Dante Alighieri si scagliava
contro gli immigrati. O almeno questa è la lettura del quotidiano "Il Giornale"
che cita il XVI canto del Paradiso, dove viene deplorato l'arrivo degli abitanti
del contado a Firenze, città ora impura perché ha accolto genti di diversa
provenienza. Per questo, avverte l'autore dell'articolo, "radical chic" e
fautori dell'accoglienza dei profughi rimarrebbero delusi dalla lettura della
Divina Commedia. Dante chiede a Cacciaguida di parlargli di Firenze, di
raccontargli come fosse nei tempi civili. Subito Cacciaguida si infiamma "come
s’avviva a lo spirar d’i venti / carbone in fiamma, così vid’io quella / luce
risplendere a’ miei blandimenti". Ricorda come gli abitanti di Firenze fossero
un quinto rispetto a quelli che ci sarebbero stati 150 anni dopo dopo la sua
morte: "Tutti color ch'a quel tempo eran ivi / da poter arme tra Marte e ‘l
Batista, / eran il quinto di quei ch’or son vivi. Ma la cittadinanza, ch’è or
mista / di Campi, di Certaldo e di Fegghine, / pura vediesi ne l’ultimo
artista". Ovvero: la popolazione di Firenze, che ora è mescolata con gli
abitanti di Campi Bisenzio, Certaldo, Figline Valdarno, era pura fino al
midollo. Fino al più semplice degli artigiani. Dopo aver sottolineato che la
colpa della mescolanza era della Chiesa, così come ricorda lo stesso
Cacciaguida, Il Giornale conclude riportando l'opinione di Dante sullo
spostamento delle persone da un luogo all'altro: "Sempre la confusion de le
persone / principio fu del mal de la cittade, / come del vostro il cibo che
s’appone". Ovvero: la mescolanza delle genti provoca sempre il male delle città.
"Si tratta di una indebita attualizzazione di Dante, una operazione forzata che
tira l'autore della Divina Commedia per la giacca cercando di portarlo sugli
argomenti di attualità e piegandolo alle proprie convinzioni", commenta Mirko
Volpi, ricercatore e studioso di Dante all'Università di Pavia. "Dante non è
moderno e non è modernizzabile, perciò quello che scriveva non può essere
utilizzato in una polemica attuale come l'immigrazione, così come non si poteva
usarlo in chiave anti-Islam". Volpi, che affianca il suo lavoro di filologo a
volumi più leggeri come "Il Diario di Mirko V." e che a luglio sarà in libreria
con "Oceano Padano" (Laterza), ricorda il senso reale delle terzine citate da
Il Giornale: "Il dialogo con Cacciaguida si inserisce in una polemica
differente: quella che Dante ha sempre nutrito nei confronti dell'avidità e
della sete di ricchezza. Il trasferimento di commercianti e artigiani dal
contado a Firenze è dunque visto come una conseguenza della fame di denaro, e
perciò giudicato negativo e portatore di corruzione in una città che secondo la
sua visione un tempo era stata pura e incontaminata". "Fare un parallelo tra lo
spostamento di qualche centinaio di persone dalle colline alla città non può
essere nemmeno lontanamente paragonabile con l'esodo dei profughi a bordo dei
barconi nel Mediterraneo: anche questa è una forte sproporzione che indica una
maniera sbagliata di leggere Dante. Non è Dante a dover arrivare nel 2015, siamo
noi a dover tornare indietro e scoprire il Dante del suo tempo, con i valori
eterni che promuove".
Antonio Socci su “Libero
Quotidiano”: ecco il Dante che Benigni non ci ha mai raccontato. In altri
tempi a celebrare solennemente in Senato, alla presenza del Capo dello Stato, il
750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, sarebbero state chiamate
personalità del calibro di Francesco De Sanctis o Benedetto Croce. Ma ogni
epoca ha i vati che merita. Così, pare per volontà del presidente Grasso, il
Senato nei giorni scorsi ha fatto tenere la suddetta prolusione al comico di
Vergaio, Roberto Benigni. È lui il nuovo vate della nazione? Non è facile capire
com’è che - per gli attuali vertici dello Stato - un gigante del pensiero e
della storia nazionale come Dante debba essere illustrato in Senato da un attore
comico. Perché Benigni questo è: un ottimo comico, divertente, ma pur sempre un
comico che va benissimo per la tv e per le piazze. Ma non risulta che abbia
titoli o meriti filosofici, letterari o storici per tenere la prolusione in
Senato. Del «Benigni poeta» del resto ricordo solo l’Inno del corpo sciolto
sulle cui strofe è meglio sorvolare. Evidentemente il presidente Grasso al nome
di Dante riesce ad associare solo quello di Benigni, segno di una «cultura» non
proprio vastissima e perlopiù televisiva. In fondo avrebbe potuto reperire
anche sui giornali (non dico sui libri) nomi di intellettuali contemporanei - da
Ernesto Galli della Loggia a Umberto Eco, al cardinale Giacomo Biffi - a cui
affidare una riflessione che avesse un'autorevolezza adeguata all’aula del
Senato. Ma i vertici dello Stato ritengono che Benigni sia l’oratore più adatto
per gli attuali parlamentari. Qualcuno ha notato che di questo passo potrebbero
chiamare in Senato a celebrare il Petrarca un Alvaro Vitali e Checco Zalone per
il Manzoni. Forse il paragone non è giusto. Benigni ha fatto obiettivamente una
buona opera di divulgazione popolare con le sue letture dantesche. Sono molto
divertenti gli spettacoli che ha dedicato alla Divina Commedia. Ma sono appunto
spettacoli di un ottimo attore comico. Altra cosa dovrebbe essere una solenne
riflessione in Senato sul 750° anniversario della nascita di un poeta così
grande e così importante per il nostro Paese da aver letteralmente coniato la
nostra lingua italiana (perché - se non lo si sa - la Divina Commedia fu scelta
come il canone della nostra lingua). Possibile che delle nostre istituzioni e
della nostra identità culturale millenaria si abbia una considerazione che non
va oltre gli esilaranti spettacoli di un attor comico? Possibile che nessuno
abbia sentito, nell'occasione, la necessità di una riflessione seria sulla
nostra identità nazionale? Sarebbe questo il «senso delle istituzioni» che viene
sempre sbandierato da lorsignori? Ed è questa la consapevolezza culturale che le
nostre classi dirigenti hanno della storia e del destino di questo Paese? Da
Benigni, in Senato, per questa nostra Italia del cazzeggio, è arrivata la solita
raffica di battute. Simpatica quella secondo cui PD significherebbe Partito di
Dante. Lui l’ha detta ridendo, ma si sa che Arlecchino si confessa burlando e -
in fin dei conti - l'operazione fatta in questi anni da Benigni è stata proprio
questa: trasformare Dante in un autore «politically correct». Infatti si è
verificato questo singolare e buffo fenomeno: negli ultimi quindici anni Dante -
o meglio il Dante benignesco - è entrato nel Pantheon del progressista italico.
Curioso no? Con il '68 la Divina Commedia fu di fatto spazzata via dalla scuola,
Dante era considerato un barboso bigotto reazionario. Poi Benigni, per la sua
Italia progressista, l’ha tirato fuori dal lazzeretto in cui era stato relegato.
Ma non che oggi Dante venga letto o davvero riproposto a scuola e studiato e
amato. No. Quanti fra coloro che si dicono appassionati dantisti sulla scorta
di Benigni hanno mai sentito parlare o letto Auerbach o Contini o Singleton?
Ancor più si tengono a distanza dalla dottrina cattolica di Tommaso d’Aquino e
Bernardo di Chiaravalle che struttura tutta la Commedia. Figuriamoci. Il Dante
dell’intellettuale collettivo e della Sinistra benpensante in realtà è Benigni,
non il poeta della Divina Commedia che resta - ai loro occhi - un indigeribile
trombone cattolico-reazionario. Infatti Benigni, per renderlo digeribile al
delicato stomaco della sinistra salottiera, ha «appannato» il vero Dante, quello
«politicamente scorretto», scomodo e urticante. Oggi il vero Dante, redivivo,
sarebbe letteralmente schifato e considerato quasi un appestato, sia nelle curie
ecclesiastiche che in quelle laiche, come del resto gli accadde in vita. Infatti
visse ramingo e braccato. Fu considerato un fallito come politico e pure come
intellettuale se - lui vivente (già circolavano l'Inferno e il Purgatorio) - fu
data l’incoronazione di poeta (che era un po’ il Nobel di allora) a un tal
Albertino Mussato, per aver scritto una tragedia, l’Ecerinis, che nessuno
ricorda più. Dante fu esiliato da Firenze e morì in contumacia (come Craxi!) con
l’accusa di «barattiere», cioè tangentista. Dunque o Dante era un ladro (perciò
sarebbe considerato col disprezzo riservato ai politici corrotti) o - ed è certo
- non lo era e allora fu vittima di una giustizia di parte (politicizzata),
davanti alla quale - fra l'altro - non volle comparire disprezzandola (così
guadagnandosi la condanna al rogo). Del resto ha lasciato nella Commedia parole
di fuoco contro chi lo condannò. Ed insieme il suo alto lamento sull'Italia che
vede come un «bordello» e come una nave senza timoniere, sbattuta qua e là dalle
tempeste e rovinata da classi dirigenti miserabili. Ma il Poema sacro - che non
ha eguali nella letteratura mondiale (in questo Benigni ha ragione: «non è
l’apice della letteratura italiana, è l’apice di tutte le letterature, non c'è
niente di più alto») - contiene pure un'impressionante e «spudorata» serie di
violazioni del politically correct, tale da fare impallidire l’odierna mentalità
dominante. Tempo fa un'associazione internazionale - riferiva il Corriere della
sera - ne chiese la cancellazione dai programmi scolastici o la «correzione» dei
suoi presunti contenuti «islamofobici, razzisti ed omofobici». In realtà non c’è
nessun razzismo, ma è vero che il poema dantesco può sembrare urticante a due
«partiti» oggi agguerritissimi, il mondo musulmano e il movimento gay, in
riferimento a coloro che il poeta pone all’Inferno. Del resto, da «cattolico
integralista» come oggi lo si definirebbe (ma in realtà è solo cattolico), mette
all'inferno pure gli eretici, i bestemmiatori, gli adulatori e (pur essendo lui
alquanto sensibile alle grazie femminili) anche i lussuriosi. Infine, come se
non bastasse, condanna con parole di fuoco diversi Papi del suo tempo,
mettendoli all'inferno e sparando a zero sulla corte pontificia, pur
professandosi cattolicissimo. Anzi, proprio perché cattolico. Cosa che oggi, in
tempo di bigottismo imperante, sarebbe ritenuta inammissibile: ma lui era
cattolico, non clericale, né papolatra, mentre oggi tutti sono clericali e
papolatri, senza però professare la fede cattolica. Il cardinale Giacomo Biffi
ha scritto: «La cristianità ha un esempio ammirevole del connaturale connubio
tra fede e libertà in Dante Alighieri. Proprio la sua indubitabile adesione alla
verità cattolica consente e illumina la sua perfetta autonomia di giudizio,
svincolata da ogni timore o condizionamento umano. Dante non teme di criticare
l’operato dei Papi e le loro scelte operative, fino a collocarne diversi nel
profondo dell'inferno. Ma in lui non viene mai meno e mai minimamente s’attenua
“la reverenza delle somme chiavi” (Inf. XIX, 101). Quando si tratta di esprimere
riserve o biasimi che egli ritiene dovuti, non ci sono sconti né per i laici, né
per gli ecclesiastici, né per i monarchi, né per i semplici cittadini... tenuti
tutti, senza eccezioni, ad attenersi alla legge evangelica». Dante non fu solo
il più grande dei poeti, ma - essendo davvero cristiano - fu un uomo libero. E
per questo scomodo.
Perchè preferiamo Einaudi a
Croce, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”.
Si può tecnicamente affermare che ci siano più “Storie del pensiero liberale”,
che pensatori liberali in circolazione. Ve ne consiglio una, fresca di stampa,
scritta da Giuseppe Bedeschi per i tipi della Rubettino. Se l’autore non si
offende, direi che la parte che vale di più è proprio la sua corposa
introduzione. È una roba che può leggere chiunque: anche un autodidatta, come
chi scrive. È semplice e ben organizzata. Molto chiara l’esposizione sul diverso
fondamento filosofico del liberalismo delle origini. Quello di Locke basato su
un diritto naturale alla libertà individuale, sacrosanto e sovraordinato a
qualsiasi invenzione realizzata dagli uomini stessi. Hume contesta invece i
presupposti del contratto tra individui con cui nascerebbe lo Stato nella teoria
lockiana, sostenendo che dal punto di vista strettamente storico chi ci governa
deve il suo scettro a qualche prepotenza o conquista del passato. E che dunque
il liberalismo (conclusione simile a Locke) deve difendere i cittadini dallo
Stato. Non ve la facciamo lunga, ma potremmo continuare con tante delle porte
intellettuali lasciate aperte nella sua introduzione da Bedeschi. Il liberalismo
come si concilia con la democrazia? Per l’autore la sintesi c’è. Ma non per
l’intero pantheon degli autori che ricorda. E come mettere insieme eguaglianza e
libertà? Insomma i grandi temi del pensiero liberale sono ben amalgamati nella
prima parte del libro e poi rubricati in capitoli dedicati ai grandi pensatori
nel prosieguo. Scrive Bedeschi che proprio queste numerose distinzioni tra
pensatori liberali hanno fatto parlare qualcuno di “liberalismi” al plurale. Una
posizione però inaccettabile. Vi consigliamo tra l’altro di leggere l’ultima
parte dedicata ai liberali tra le due guerre. L’autore nota, giustamente, come
sia il periodo meno fecondo per l’idea liberale. Ma sentite come definisce
Benedetto Croce: “in un quadro generale di decadenza del liberalismo medesimo,
sia in Kelsen sia in Croce si avverte l’indebolimento, o addirittura, il venir
meno di alcuni motivi fondamentali del pensiero liberale”. E ancora: “Croce non
può essere considerato un grande pensatore liberale”. Qualche pagina più avanti
il suo famoso dibattito sulle libertà economiche con Luigi Einaudi, vi darà
qualche elemento in più per giudicare. Se oggi dovesse aggiornare la sua storia
del liberalismo, temo che Bedeschi farebbe ancor più fatica a trovare un grande
pensatore liberale per il nuovo millennio.
Lev Tolstoi su “Il Giornale”:
"La rivoluzione non si fa con la violenza". "La condizione dell’umanità attuale
è tanto più deplorevole in quanto nei nostri cuori noi concepiamo la possibilità
di un'altra vita, completamente differente, ragionevole e fraterna, senza pazzia
del lusso di alcuni e la miseria e l'ignoranza degli altri, senza esecuzioni,
dissolutezza, violenza, armamenti, guerre. Ma il regime presente, mantenuto
dalla forza, si è radicato a tal punto che noi non possiamo immaginare una vita
collettiva senza un’autorità governativa; noi ci siamo a tal punto abituati che
cerchiamo di realizzare addirittura l’ideale di una vita libera e fraterna
attraverso degli atti d’autorità, vale a dire con la violenza. Questo errore è
alla base del disordine morale e materiale della vita passata, presente e futura
della cristianità. Un esempio lampante ci è donato dalla Rivoluzione francese.
Gli uomini della Rivoluzione hanno posto chiaramente gli ideali di uguaglianza,
di libertà e di fraternità, in nome dei quali essi hanno desiderato trasformare
la società. Da questi principi sorsero delle misure concrete: abolizione delle
caste, ripartizione uguale delle ricchezze; soppressione dei titoli e dei gradi,
della proprietà fondiaria, dell'esercito permanente, istituzione dell'imposta
sul reddito, pensioni per i lavoratori; separazione della chiesa e dello stato,
cioè l'istituzione di una dottrina razionale, comune a tutti. Queste misure,
essendo sagge e benefiche, erano la conseguenza diretta dei veri principi di
libertà, uguaglianza e fraternità posti dalla Rivoluzione. Questi principi, così
come le misure che ne sono sorte, sono stati, sono e resteranno veri, e
rimarranno come l'ideale dell'umanità fintanto che non saranno realizzati.
Tuttavia, questo ideale non potrà mai essere realizzato con l'aiuto della
violenza. Malauguratamente, gli uomini della Rivoluzione erano talmente abituati
all'uso della forza come unico mezzo d'azione, che non si accorsero della
contraddizione che conteneva l'idea di realizzare l'uguaglianza, la libertà e la
fratellanza attraverso l'uso della violenza. Essi non si accorsero che
l'uguaglianza è l'opposto della dominazione e della sottomissione, che la
libertà è inconciliabile con la costrizione e che non si può avere della
fratellanza tra coloro che comandano e coloro che obbediscono. Da questo fatto
derivano tutte le atrocità del Terrore. L'errore non è tanto nei principi, come
credono alcuni - essi sono stati e restano veri -, ma nei mezzi in cui si sono
applicati. La contraddizione che spuntò così nettamente e brutalmente durante la
Rivoluzione francese e che, al posto del bene, conduce al male, dimora fino al
giorno d'oggi, rivelandosi in tutti i tentativi di migliorare l'organizzazione
sociale. In effetti, si spera di realizzare questo miglioramento con l'aiuto del
governo, cioè con la forza. Ancora meglio questa contraddizione si manifesta non
soltanto nelle dottrine sociali attuali, ma nelle stesse dei partiti politici
più progressisti: socialisti, rivoluzionari, anarchici, che prevedono la città
futura. Insomma, gli uomini cercano di raggiungere l'ideale di una vita
razionale, libera e fraterna attraverso l'aiuto della forza, quando questa,
qualsiasi forma essa prenda, non è altro che il diritto ottenuto da alcuni per
disporre degli altri e, in caso di insubordinazione, di contrastare questi con
il mezzo estremo: l'assassinio. Vale a dire: realizzare l'ideale della felicità
umana mediante l'omicidio. La grande Rivoluzione francese è stata l’enfant
terrible che, in mezzo all’entusiasmo di tutto un popolo, davanti alla
proclamazione delle grandi verità rivelate e all'inerzia della violenza, ha
espresso, in maniera candida, tutta l'inettitudine della contraddizione nella
quale si dibatté allora e si dibatte ancora l'umanità: «Liberté, égalité,
fraternité ou la mort». \[…\] Ora, la meta - il bene di ognuno e di tutti - è
raggiunta unicamente grazie alla trasformazione interiore dell'individuo, per
l'elaborazione di una coscienza religiosa e indipendente, allo scopo di vivere
in conformità con questa concezione personale. Nello stesso modo che una materia
in combustione può da sola comunicare il fuoco a delle altre materie, solo la
vera fede e la vera vita di un uomo possono essere trasmesse ad altri uomini,
diffondere e consolidare la verità religiosa. Dunque, solo la propagazione e il
consolidamento della verità religiosa migliorano le condizioni degli uomini.
Ecco perché non c'è un mezzo per liberarsi da tutti i mali di cui soffrono gli
uomini, compreso l'atroce male che commette il governo: il lavoro interiore che
ognuno di noi deve fare al fine d'essere l'architetto del proprio miglioramento
morale. \[…\] Ora, questa libertà vera può essere realizzata solamente con il
rifiuto di sottomettersi a qualsiasi autorità, senza ricorrere alle barricate,
assassini e nuove istituzioni ottenute e sostenute con il ricorso alla violenza.
\[…\] Penso che proprio ora stia cominciando quella grande rivoluzione che si è
andata preparando per duemila anni in tutto il mondo cristiano. Una rivoluzione
consistente nella sostituzione del cristianesimo degenerato, di quel potere di
pochi e la schiavitù di tutti gli altri, in un cristianesimo vero, alla base
dell'eguaglianza di tutti gli uomini e di una libertà autentica, quella propria
degli esseri ragionevoli. Lev Tolstoi"
25 APRILE 2015. 70 ANNI
DALLA LIBERAZIONE. L'ALTRA RESISTENZA CONTRO IL RITO DELL'ANTIFASCISMO UN PO’
FASCISTA.
L'Italia liberata dagli
alleati. La storia scritta, invece, da chi si dichiara vincitore: Saccenti e
cattivi sempre contro.
Dubbi e ricordi di
Salandra. Così l'Italia entrò in guerra.
Primo ministro fra il marzo
1914 e il giugno 1916 fu lui, con Sonnino, a "pilotare" il Paese dalla
neutralità all'intervento a fianco dell'Intesa, scrive Francesco Perfetti su "Il
Giornale". Il 2 giugno 1915 Antonio Salandra pronunciò in Campidoglio, nella
bella sala degli Orazi e Curiazi, un celebre e appassionato discorso per
illustrare le motivazioni che avevano spinto l'Italia a imbracciare le armi.
Disse che la guerra, appena iniziata per l'Italia, era «santa» e si combatteva
«a tutela delle più antiche e più alte aspirazioni, dei più vitali interessi
della patria». Aggiunse che sarebbe stata «più grande di qualunque altra la
storia» ricordasse e che avrebbe coinvolto tutti gli italiani. Per dare al
discorso il carattere di un solenne atto di governo era stato scelto un giorno
non festivo. Salandra aveva lavorato al discorso per due mattinate, ma gran
parte di esso fu pronunciato a braccio sulla base di appunti. Cionondimeno ebbe
successo e piacque persino a Benedetto Croce non certo tra i fautori
dell'intervento, che vi trovò parole «veramente da italiano, da italiano antico
e moderno, insieme borghese nel miglior senso della parola» e del quale gli
piacque «quell'assenza completa di fanatismo nazionalistico, quella concezione
patriottica e umana insieme, che è una delle più belle note dell'italianità».
Salandra era succeduto a Giolitti nel marzo 1914. Aveva superato i sessant'anni
e aveva alle spalle una lunga carriera politica: eletto deputato per la prima
volta nel 1886, aveva poi ricoperto più volte incarichi di sottosegretario e
ministro. Era, anche, uno studioso illustre di diritto amministrativo, formatosi
culturalmente alla scuola di Francesco De Sanctis e di Silvio Spaventa.
Liberal-conservatore, si era battuto per «l'unione di tutte le forze liberali»
contro i partiti estremi e, formando il governo, si era ispirato al principio di
creare una «concentrazione liberale» alla quale partecipassero esponenti della
sinistra zanardelliana, del centro e della destra. Interessato soprattutto alla
politica interna, all'amministrazione, al rafforzamento dello Stato e alla
costruzione del grande partito liberale, si trovò subito a dover gestire la
posizione dell'Italia, allora legata dalla Triplice Alleanza
all'Austria-Ungheria e alla Germania, di fronte alla guerra scoppiata
nell'estate del 1914. La sua prima scelta fu la neutralità, il 3 agosto di
quello stesso anno. Poi venne, l'anno successivo, dopo le «radiose giornate» del
maggio 1915, la decisione di prendere parte al conflitto per portare «a
compimento il Risorgimento» ed «elevare l'Italia alla realtà di grande potenza».
Proprio al periodo compreso fra la scelta neutralista e quella di entrare in
guerra Salandra dedicò un importante volume di «ricordi e pensieri» intitolato
L'intervento che la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze ha
ristampato in una curata edizione anastatica e che verrà distribuito
gratuitamente a tutti i partecipanti al grande convegno Niente fu più come
prima. La Grande Guerra e l'Italia cento anni dopo , che si svolgerà a Firenze
il 13 e 14 marzo. L'opera è una testimonianza che ricostruisce, sulla base dei
ricordi di un protagonista e sulla documentazione, le trattative con l'Austria e
quelle con l'Intesa, la stipulazione dell'accordo di Londra, le battaglie in
piazza e in Parlamento fra neutralisti e interventisti, la crisi del maggio
1915, gli estremi tentativi diplomatici per evitare l'ingresso in guerra e le
fasi della mobilitazione militare e civile. Salandra aveva cominciato a pensare
che la neutralità fosse destinata a finire quando «l'ambizioso piano germanico
della guerra di poche settimane» si era infranto sulle rive della Marna.
C'erano, quindi, state, prima, la crisi governo per divergenze sul finanziamento
del piano militare e, poi, la formazione del nuovo gabinetto del quale entrarono
a far parte personalità come Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino.
Quest'ultimo, nominato ministro degli Esteri, era legato a Salandra da una
trentennale amicizia e da una «solidarietà politica» in nome di una concezione
«forte» del liberalismo e della necessità di un «ritorno allo Statuto» per
recuperare o tonificare il prestigio e l'autorità dello Stato. I veri
protagonisti dell'attività diplomatica svolta in maniera sotterranea nei
difficili e drammatici mesi compresi fra il novembre 1914 e la primavera del
1915 furono, proprio, loro due, Sonnino e Salandra. Questi lo riconosce senza
mezzi termini: «del bene e del male a noi due spetta l'onore e il biasimo». Le
trattative con Vienna e Berlino iniziarono nel dicembre 1914 ma si arenarono per
l'insufficienza dei compensi offerti all'Italia dalle potenze della Triplice.
Quelle con l'Intesa, che avrebbero portato al Patto di Londra e all'impegno
italiano a entrare in guerra entro un mese, cominciarono all'inizio di marzo. La
descrizione che Salandra fa della crisi di maggio è precisa e ricca di
chiaroscuri. Il fronte interventista era costituito da intellettuali e studenti,
nazionalisti, irredentisti, sindacalisti rivoluzionari. Era, per così dire, un
vario interventismo raccolto attorno al progetto di completare l'unità nazionale
e assicurare all'Italia un ruolo paritario fra le potenze. A esso si
contrapponeva il fronte neutralista comprendente liberali giolittiani,
socialisti e cattolici. Sottolinea Salandra come la spinta venisse proprio dal
Paese: «mentre i neutralisti tenevano il campo a Montecitorio, gli interventisti
occupavano le piazze». Poi, finalmente, ci fu la dichiarazione di guerra contro
l'Austria. Dal volume emerge la personalità di un uomo che, liberale con una
visione conservatrice della politica in linea con la tradizione della Destra
storica, segnò la fine dell'età giolittiana e del tentativo di Giolitti di
proporre un liberalismo fondato sull'arte del compromesso e sulla prassi della
mediazione. Con la sua «politica nazionale» contrapposta alla «sana democrazia»
di Giolitti, Salandra diventò il naturale punto di riferimento della «borghesia
liberale» costituita dai nuovi ceti medi sorti dal processo di
industrializzazione e modernizzazione dell'Italia postunitaria.
La stanza di Montanelli su “Il
Corriere della Sera”: Ecco perchè Mussolini entrò in guerra. Caro
Montanelli, Sono un giovane appassionato di argomenti storici e ultimamente sto
leggendo il suo libro sulla storia d'Italia del Novecento. Per quanto riguarda
il secondo conflitto mondiale, vorrei farle questa domanda. Secondo lei
Mussolini proprio non avrebbe potuto fare a meno di entrare in guerra a fianco
della Germania di Hitler nel giugno del 1940, e, magari, non avrebbe fatto
meglio a fare come Franco, cioè il neutrale? Arduino Lapo. Caro Lapo, Se lei sta
leggendo il libro mio e di Cervi sull'Italia del Novecento, dovrebbe avervi già
trovato risposta alla sua domanda. Niente e nessuno costringeva Mussolini a
entrare in guerra a fianco della Germania. Il problema si era posto il 3
settembre dell'anno prima (1939), quando la guerra era stata - controvoglia,
molto controvoglia - dichiarata da Francia e Inghilterra alla Germania che aveva
invaso la Polonia. E in quel momento forse Hitler avrebbe voluto che l'Italia si
schierasse al suo fianco, come stabiliva il patto d'alleanza (il famoso e
famigerato "Patto d' Acciaio") fra i due Paesi. Mussolini, addusse due motivi a
giustificazione della sua - come oggi la si chiamerebbe - "desistenza". Il primo
era quello di non essere stato nemmeno informato del colpo di mano sulla Polonia
che non poteva non provocare l'intervento di Francia e Inghilterra, dati
gl'impegni che alla Polonia le legavano. Il secondo era la condizione posta da
Mussolini e, a quanto pare, accettata da Hitler, che la guerra non dovesse
scoppiare prima di altri tre anni, quanti ne occorrevano all'Italia - da poco
reduce dagli sforzi bellici compiuti in Abissinia e in Spagna - per
prepararvisi. Tutto questo era noto solo nei ristretti ambienti della
diplomazia. Ma io, che in quel momento mi trovavo a Berlino per conto di questo
giornale, ricordo con quale disprezzo ci guardavano i tedeschi. "I soliti
traditori" pensavano di noi italiani. Nel giugno del '40 le cose erano del tutto
cambiate. L' esercito francese era stato spazzato via dalla Wehrmacht, solo un
brandello di quello inglese era riuscito a reimbarcarsi e a tornare a casa. E la
Germania, convinta di non aver più bisogno di aiuto per giungere alla vittoria,
non solo non sollecitò l' intervento italiano, ma ne fu infastidita. (Che cosa i
tedeschi pensassero di noi, mi era stato chiaro fin dal 1938, quando, di
passaggio a Londra, venni a conoscenza di un episodio che governo e stampa
inglesi avevano, per motivi di opportunità, tacitato. Un'associazione di reduci
della prima guerra mondiale aveva invitato a una conferenza uno dei più
autorevoli Marescialli tedeschi - Brauchitsch mi dissero, ma poi mi smentirono -
sulle nuove tecnologie militari. Alla fine del banchetto che seguì, qualcuno gli
chiese chi avrebbe vinto la prossima guerra. "Chi la vincerà, non lo so -
avrebbe risposto l'ospite -, ma so con sicurezza chi la perderà: chi avrà per
alleato l'Italia". Non giuro sul nome di Brauchitsch, ma sull'autenticità dell'
episodio sì). Fu quindi di sua testa, e contro l'opinione dei suoi uomini
migliori - Grandi, Balbo, Bottai - e dello Stato Maggiore a guida Badoglio, che
Mussolini volle e decise la guerra. Perchè? Perchè era convinto che i tedeschi
l'avessero già vinta, e che quindi convenisse sedere, al tavolo della pace, al
loro fianco. Lei mi chiederà in quali documenti questo sta scritto. No, i
documenti non ci sono nè potrebbero esserci. Sono i gesti, le parole e le
decisioni di Mussolini a darcene la certezza, del resto condivisa da tutti
coloro che avevano accesso a lui e coi quali ho a lungo e ripetutamente parlato.
Mussolini era intelligente, ma abbastanza ignorante. Non sapeva cosa fossero
l'Inghilterra e l'America. Uomo dell'Ottocento e di cultura ricalcata sulla
pubblicistica francese della fine di quel secolo (i suoi autori erano Zola e
Sorel), coltivava il mito della Grande Armee, e, quando la vide crollare in
pochi giorni, si persuase che più nulla e nessuno potesse arrestare la marcia
trionfale dell'odiato (sì, odiato: so quel che dico) alleato. Franco, molto meno
intelligente, ma più scaltro, freddo e calcolatore di lui, non ci cascò
("Piuttosto che avere un altro colloquio con quel tipo - disse Hitler al termine
del loro incontro nel '40, sulla costa basca -, preferirei farmi strappare tutti
i denti"), e così salvò il suo Paese e se stesso. Nemmeno questo sta scritto nei
documenti. Ma lo si ricava, senza possibilità di dubbio, dai fatti.
Aprile 1945: gli ultimi
giorni di Mussolini.
Il 16 aprile lascia il Garda. A Milano cerca inutilmente la mediazione con il
CLNAI quando la RSI è ormai agonizzante e i tedeschi si ritirano,scrive Edoardo
Frittoli su "Panorama". "Si, Giulio Verne,…ne riparleremo più avanti". Così
Mussolini aveva ironicamente risposto al capo della polizia repubblicana
Tamburini quando questi aveva fantasticato sulla possibilità di fuga del duce e
dei gerarchi a bordo di un sottomarino costruito a Trieste e diretto in
Argentina o Polinesia. Il Mussolini dei primi mesi del 1945 è lo spettro di sé
stesso. L'ultima fiammata l'aveva spesa al Teatro Lirico di Milano nel dicembre
precedente. I tedeschi ormai parlano sempre meno di armi segrete e saccheggiano
sempre di più derrate e macchinari industriali nell'ottica di un'estrema difesa
del Reich. La violenza e l'anarchia dei reparti "speciali" di Polizia
Repubblicana e delle Brigate Nere lo avevano spinto allo scontro con alcuni
membri del governo di Salò, sopra tutti Buffarini Guidi. Poi c'erano i battitori
liberi come Roberto Farinacci, più vicini ai tedeschi che a Mussolini, che
agitavano le acque nella speranza di una successione alla guida del fascismo
repubblicano. E gli alleati germanici, con lo strapotere di
plenipotenziari vicini a Hitler come Karl Wolff, Eugen Dollmann, Walter Rauff
(uno dei padri delle Gaswagen, le camere a gas mobili). Nel marasma degli
ultimi giorni della RSI Mussolini altalena tra il purismo del ritorno
alla rivoluzione sansepolcrista e spinte neo-socialiste,
reminiscenze della sua cultura pre-fascista. Si avvicina e lo
avvicinano intellettuali e personaggi grotteschi, che gli propongono soluzioni
impraticabili nell'imminenza della fine. Edmondo Cione, un allievo di Benedetto
Croce, gli presenta un nuovo assetto politico del fascismo repubblicano, che
avrebbe dovuto includere elementi dell'opposizione liberale e cattolica in senso
critico. Divorato dall'ulcera, il Mussolini degli ultimi giorni di Salò sembra
voler perseguire a tutti i costi la strada della "socializzazione" delle
industrie e dell'agricoltura. Da un lato per cercare di preservare il patrimonio
industriale del Nord dalla devastazione operata dai tedeschi. Dall'altra pensa
ad un passaggio di mano dal fascismo ad uno stato socialista e anti borghese.
Il piano non sarà mai di fatto attuato per la risoluta avversione dei tedeschi e
per la generale ostilità degli operai in continua agitazione, nonostante le
concessioni salariali promesse dalla RSI. Con l'avvicinarsi degli Alleati e con
la ripresa dell'azione da parte del CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia) il governo di Salò comincia a formulare ipotesi di estrema
resistenza o, eventualmente, di fuga in Svizzera per poi giungere nella Spagna
franchista e da qui in Sudamerica. Nasce in questi giorni il piano cosiddetto
R.A.R. (Ridotto Alpino Repubblicano). Si trattava di fortificare la zona
montuosa della Valtellina e resistere almeno fino all'arrivo degli Alleati. Il
più convinto sostenitore del ridotto era Alessandro Pavolini, segretario del
PFR. Il vecchio generale Graziani, rassegnato e depresso, lo aveva deprecato sin
dall'inizio. Infatti mancavano le forze necessarie per realizzarlo e difenderlo.
Risultò chiaro sin da subito che il ridotto sarebbe stato devastato in poco
tempo dall'aviazione alleata. Mussolini asseconda i suoi e cerca di contattare
gli Alleati, i quali rispondono categoricamente: resa incondizionata. Il
CLNAI fa altrettanto, così che Mussolini cerca contemporaneamente due strade
alternative. Dal 16 aprile il duce decide di andarsene dalle sponde del Garda e
lascia Gargnano per Milano, dove si stabilisce in Prefettura. Nella capitale
lombarda Mussolini cerca contatto con l'ambasciatore svizzero Troendle. Questi
temporeggia, ponendo difficili condizioni alla richiesta di asilo per il duce e
i ministri di Salò. L'altra via è la mediazione della Chiesa. Per questo
l'Arcivescovo di Milano Idelfonso Schuster si attiva per organizzare un incontro
con il governo del CLNAI. Incontro che avviene presso la sede dell'Arcivescovado
il 25 aprile, giorno dell'insurrezione. Ad attendere Mussolini c'è il generale
Raffaele Cadorna, comandante militare del CVL e c'è Riccardo Lombardi per il
CLNAI. Per il governo della RSI ci sono il generale Graziani e il
sottosegretario Francesco Maria Barracu, il fondatore dei "Volontari di
Sardegna-Battaglione Angioy" , grande invalido e seguace di Mussolini fino
alla fine. I colloqui di fatto non cominceranno mai perché al duce è annunciata
la voce di una pace separata con gli Alleati voluta da Karl Wolff. Mentre in
città echeggiano gli spari e i tumulti dell'insurrezione generale, Mussolini fa
ritorno in Prefettura. In corso Monforte termina la sua permanenza a
Milano. Verso le 19 raduna i suoi comunicando di fatto la volontà di lasciare la
città alla volta di Como, per un "precampo" prima del tentativo di
espatrio in Svizzera. A nulla valgono gli estremi tentativi di Carlo Borsani, il
cieco di guerra, di far tornare il duce in Arcivescovado. Alle 19,30
circa l'autocolonna con Mussolini e il suo seguito lascia Milano per l'ultimo
viaggio.
E alla fine arrivarono gli
Alleati. Le
divisioni britanniche e americane superarono il Po il 24 aprile. E appresero
lungo la strada per Milano che la città era già stata liberata. E i primi carri
armati alleati arrivarono in Duomo solo il 29 aprile, scrive Massimo de
Leonardis su “Il Corriere della Sera”. Le liberazioni delle grandi città
italiane ebbero caratteristiche diverse. A Roma, per ragioni strategiche e
per la sua peculiarità di sede del Papato, non vi furono né battaglia né
devastazioni: i tedeschi si ritirarono poco prima dell’arrivo degli alleati.
Opposto il caso di Firenze, con la città divisa e aspri scontri, che durarono
settimane. Torino fu aggirata dalle truppe tedesche in ritirata, ma vi si
manifestò il fenomeno dei franchi tiratori fascisti. A Milano le truppe
americane arrivarono con la città già in mano ai partigiani, tranne alcuni
centri di resistenza tedeschi. Nell’aprile 1945, sotto il Comando Supremo
Alleato nel Mediterraneo del britannico Generale Sir Harold Alexander, operava
in Italia, agli ordini dell’americano Tenente Generale Mark W. Clark, il XV
Gruppo di Armate, composto dall’8a Armata britannica del Generale Sir Richard L.
McCreery, e dalla 5a Armata americana del Tenente Generale Lucian K. Truscott,
Jr, che contava circa 270.000 soldati (con altri più di 30.000 di riserva),
oltre 2.000 pezzi di artiglieria e mortai e migliaia di veicoli, ed era
schierata sulla linea di montagna a zig zag dal mare Tirreno, all’altezza del
Cinquale tra Viareggio e Massa, al Monte Grande, vicino alla via Emilia. Da qui,
verso sud-est, partiva il fronte della 8a armata britannica, a cavallo dei fiumi
Sillaro e Santerno, e poi a nord-est lungo la sponda sud del Senio fino alla
riva meridionale della laguna di Comacchio sull’Adriatico. Le operazioni
preliminari iniziarono sul fronte dell’8a armata alle 3 del 2 aprile nella
laguna di Comacchio, mentre l’azione diversiva sulla costa tirrenica iniziò il 5
aprile. Alle 14 del 9 aprile, dopo massicci bombardamenti ed un intenso fuoco di
preparazione dell’artiglieria, iniziò l’attacco generale della 8a armata e alle
9.45 del 14 quello della 5a Armata. La svolta nell’offensiva avvenne il 20; il
21 fu conquistata Bologna e a mezzanotte del 24 l’88a divisione di fanteria
americana passò per prima il Po. Il Generale Truscott ordinò l’avanzata della 5a
Armata verso Verona, conquistata il 26 aprile, per separare la 10a e la 14a
Armata tedesca, bloccare le vie di ritirata verso il Brennero e rompere la linea
dell’Adige. Più a Occidente la 1a Divisione Corazzata americana, gli «Old
Ironsides», doveva bloccare le linee di ritirata verso l’Austria e la Svizzera
tra i laghi di Garda e di Como. Il 27 la Divisione incontrò partigiani
provenienti da Milano, apprendendo che la città era stata liberata dalle forze
della Resistenza. La mattina di domenica 29, gli americani occuparono la
periferia e i primi carri armati arrivarono fino al Duomo; la sera il Col.
americano Charles Poletti, governatore militare alleato in Lombardia, fu
ricevuto in prefettura dai membri del Clnai e del Cvl. Il pomeriggio del 30
entrò in città il Tenente Generale Willis D. Crittenberger, comandante del IV
Corpo d’Armata americano, con il Combat Command “B”. Già dal 27 era comunque a
Milano il Capitano Emil Quincy Daddario dell’Office of Strategic Services
(antesignano della CIA). Il giorno precedente aveva arrestato a Cernobbio il
Maresciallo Rodolfo Graziani e i Generali Bonomi e Sorrentino; li trasferì a
Milano, prima all’Hotel Regina, poi al Grand Hotel et de Milan e infine al
carcere di S. Vittore, da dove infine li condusse verso Bergamo. L’Hotel Regina,
tra le vie Silvio Pellico e Santa Margherita, era sede del comando della
Sicherheitspolizei-SD. Daddario negoziò la resa dei tedeschi, che avevano
rifiutato di arrendersi ai partigiani. Il 30, protetti da mezzi corazzati
americani e sotto le armi puntate dei partigiani, i tedeschi abbandonarono
l’albergo. Una folla minacciosa tentò di assalirli e gli americani spararono
raffiche di mitra in aria per “calmare gli animi”. Nel frattempo, intorno a
Milano le truppe americane e brasiliane eliminarono sacche di resistenza di
truppe tedesche e della RSI. Dal 9 aprile al 2 maggio 1945, data della resa in
Italia, le perdite dei tedeschi e dei fascisti, tra morti, feriti e dispersi,
furono di 70.000 uomini, quelle alleate di 16.700.
Professore ordinario di Storia
delle relazioni e delle istituzioni internazionali e Docente di Storia dei
trattati e politica internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dallo stop alle vendette alla «coabitazione»: Antonio Greppi, il sindaco della
Liberazione. Rimasto nella memoria di tutti i milanesi, Antonio Greppi aveva
visto morire un figlio, Mario, per mano della Legione «Ettore Muti». Ma non
esitò a fermare le rappresaglie contro gli ex repubblichini, scrive Jacopo
Perazzoli su “Il Corriere della Sera”. Per i milanesi è rimasto, fino
all’ultimo, il sindaco della Liberazione, perché il socialista Antonio Greppi
(1894-1982) a capo della nostra città c’era arrivato quando i nazisti erano
ancora asserragliati nell’hotel Regina, a pochi passi da piazza della Scala. Non
appena nominato dal Clnai il 27 aprile 1945, il neo primo cittadino si spese con
determinazione per risolvere le gravi criticità lasciate sul campo dalla guerra.
Fu così quando, per contrastare l’annoso problema del fabbisogno di alloggi per
i milanesi, decise di nominare un commissario ad hoc e, al tempo stesso, di
rivolgersi direttamente ai concittadini, perché coloro che ne avessero la
possibilità mettessero a disposizione dei senzatetto alcuni locali: era l’inizio
della coabitazione, che sarebbe rimasta nella memoria storica della città per
molto tempo. Ma non soltanto. Per esempio, sul piano dell’assistenza sociale, il
sindaco non perse tempo: pur in un regime di ristrettezza economica (nel 1945 le
casse comunali disponevano di poco meno di 5 milioni di lire da spendere), optò
per riorganizzare l’Ente comunale di assistenza, un organo ideato negli anni del
fascismo. Esso fu affidato alla direzione di un altro socialista illustre, Ezio
Vigorelli, che riuscì a fronteggiare con efficacia le conseguenze del caro
viveri (nel secondo semestre del 1945 il costo della vita era infatti aumentato
del 20,8%). Ugualmente riconducibile ai limitati mezzi finanziari fu un’altra
scelta che contraddistinse l’operato di Greppi: nel 1945, quando uno dei
problemi maggiori in città era rappresentato dal diffondersi della tubercolosi,
il primo cittadino creò il cosiddetto «fondo penicillina», per coprire le spese
necessarie all’acquisto del medicinale per i cittadini meno abbienti e chiese ai
milanesi di finanziarlo, trovando un’adesione plebiscitaria. Un altro aspetto,
questo di natura morale, ha contribuito a tramandare un’immagine positiva del
«sindaco della Liberazione». Nei giorni immediatamente successivi alla resa
delle forze nazifasciste, si scatenò in città un’ondata di vendette contro gli
ex sostenitori della Repubblica di Salò. Da apprezzato avvocato penalista,
Greppi non esitò a prendere posizione ufficiale contro quelle violenze, benché
lui stesso fosse da considerare una vittima indiretta del fascismo, dato che suo
figlio Mario, membro dell’VIII brigata Matteotti, era caduto a Milano nel corso
di una rappresaglia attuata dalla legione Ettore Muti. La sua posizione
contraria alla prosecuzione della violenza politica, una volta terminata la
Resistenza, non toglie nulla al fatto che Greppi fosse una personalità integrata
nell’antifascismo milanese. Il Clnai, su precisa volontà del suo presidente
Alfredo Pizzoni, lo scelse quale primo cittadino anzitutto perché godeva di
ottime credenziali da oppositore della dittatura. Nel 1938 e nel 1940 venne
infatti internato a San Vittore poiché sospettato – non a torto – di attività
clandestina antifascista (dal 1937 reggeva le sorti del Centro interno del
Partito socialista), e il 26 luglio 1943 firmò, quale rappresentante del Psi, un
manifesto dei partiti democratici milanesi con cui si chiedeva la liquidazione
di qualsiasi traccia del ventennio mussoliniano. Sottoscrivere quel documento,
soprattutto in seguito alla rinascita del fascismo sotto le vesti della
Repubblica sociale, volle dire per Greppi prendere la via dell’esilio: dopo
l’uccisione di Aldo Resega, il commissario federale di Milano della Rsi, fu
costretto a riparare in Svizzera, visto che sul suo capo pendeva una condanna a
morte. Dietro a quel motivo se ne celava però un altro che spinse i vertici del
Clnai a puntare su Greppi. Partendo dal presupposto che scegliere un socialista
quale sindaco di Milano significava ricollegarsi idealmente alla stagione dei
suoi predecessori Caldara e Filippetti, venne indicato Greppi perché all’interno
di quella famiglia politica era uno dei pochi che potevano contare su una buona
esperienza amministrativa. Infatti, tra il 1920 e il 1922, seguendo un
suggerimento giuntogli direttamente da Filippo Turati, aveva guidato
l’amministrazione di Angera, la città da cui proveniva; nel piccolo centro
lacustre impostò un’azione che avrebbe poi perseguito nel capoluogo lombardo,
rappresentata dalla messa in campo di misure di politica sociale e culturale,
insieme ad un forte sviluppo dell’edilizia convenzionata. Per questa serie di
ragioni Sandro Pertini, allora capo dello Stato, parlò di «un grande vuoto nella
vita democratica» lasciato da Greppi con la sua scomparsa, avvenuta il 22
ottobre 1982. L’autore fa parte del dipartimento di Studi umanistici
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»
Primo Maggio e 25 Aprile:
ma è ancora festa?
Momenti di patriottismo per altri soltanto ponte. E c'è chi pensa di abolirle,
scrive Carmelo Caruso su "Panorama". E poi è subito 2 maggio. E prima ancora era
stato il 26 aprile. Portate via dal giorno successivo, affievolite dalle
proteste che non mancano (A Napoli quest’anno con evento sospeso). 25 Aprile e 1
maggio, celebrazioni con appendice musicale “segnato dal tempo”, ha avuto modo
di dire perfino Susanna Camusso, segretario della Cgil, tanto da far ipotizzare
la fine di quello che è divenuto la foto del primo maggio ovvero il concertone
di piazza San Giovanni. Feste, certo e già lo storico Mario Isnenghi
sottolineava come non ci sia festa il cui fine non sia la creazione di una
memoria condivisa, strumenti per costruire una nazione. Forse. Divenute un lungo
“ponte” per alcuni, a vedere le piazze sempre meno affollate, per altri un
braccio di ferro sempre più vinto dalle catene commerciali che ne hanno fatto
una crociata del lavoro senza attenuanti. Serrare le saracinesche o tenerle
aperte? A Firenze un anno fa fu protesta condivisa perché fosse festa di tutti,
ma peggio provò a fare Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, quando si
disse pronto ad abolirle o meglio “a spostarle” alle domeniche tutte quelle
feste repubblicane che compongono il calendario laico di un paese: 25 aprile, 1
maggio e 2 giugno, provocando la solita polemica tra abolizionisti e
antiabolizionisti. Rientrò subito dopo le proteste di storici e dell’Anpi con la
benedizione del nostro presidente. Del resto l’idea di abolire le feste era
passata in mente anche a Giulio Andreotti che abolì nel 1976 addirittura
l’Epifania poi reintrodotta da Bettino Craxi, ma l’abolizione del primo maggio
la realizzò solo Benito Mussolini che nel 1925 volle sopprimere la festa dei
lavoratori che nel frattempo erano stati trasformati in cocci delle
“corporazioni”, il compromesso storico inventato dal duce tra padroni e operai.
Polemica stantia, salvo registrare, come appunto la Camusso, un qualcosa che sa
di logoro e non per il simbolo quanto per la contingenza. «Il concerto del
Primo Maggio vuole parlare ai giovani con un linguaggio che ci permette di
interloquire con loro. Il prossimo è il 25simo. Tutte le cose sono segnate dal
tempo». E ha precisato: «Bisogna fare una riflessione ma non voglio dire
comunque che questo sia l'ultimo». “Magari andrebbe ripensata con nuove
formule, ciò non toglie che queste siano e rimangono feste di tutti – convinto
risponde il presidente dell’Anpi, Carlo Smuraglia che proprio nel 2006 decise di
aprire le porte dell’associazione - prima eravamo solo partigiani, adesso anche
i giovani vengono ad iscriversi. E’ stato un modo per rigenerare. Proprio per
questo credo che il concerto non bisogna eliminarlo, rimane un modo per fare
uscire dall’isolamento i giovani. E’ il classico momento d’incontro. Poi è
inevitabile che una festa come il Primo Maggio abbia subito dei contraccolpi a
causa della crisi”. Un riflusso che addolora per primi i padri della Repubblica,
quei Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano che di fatto si sono “inventati”
la festa del 2 giugno togliendole quella patina di retorica e parata per
riconsegnarla alla memoria degli italiani come battesimo e genetliaco della
Repubblica. Notizia vuole che il presidente abbia deciso di celebrare per quest’
anno un 2 giugno “sobrio” senza ricevimenti con i diplomatici e c’è chi come Sel
di Nichi Vendola auspica la sospensione della parata, ecco. Del resto ci sono
date che s’iscrivono e che devono farsi stele dice la storica dell’arte
Antonella Sbrilli ricordando l’uso che il pittore Jacques Louis David ne fece
nel suo “La Morte di Marat”, attraverso quella data che si legge nel testamento
del giacobino il quadro si fa monumento annotò lo scrittore Michael Butor. E
credere che ci avrebbero unito anche se così non sembrerebbe, almeno a leggere
quanto accaduto ieri a Napoli, alla Città della Scienza, da poco incendiata.
Tafferugli tra Cobas e sindacati, insomma frazionismo sindacale con i Cobas che
gridavano: “Non c’è niente da festeggiare”. Sicuri? Proprio anni fa su questo
stesso giornale lanciava la sua provocazione Paolo Guzzanti premettendo l’accusa
a cui sarebbe andato incontro: “Lo so mi tacceranno di revisionismo”. Eppure era
proprio quel polemista di Guzzanti stroncandolo a ricordare un primo maggio che
oggi sa di sbiadito: “Grumi di memorie inconfessate, se non Spartaco Polizza da
Volpedo, almeno le cariche della Celere di Mario Scelba o l’eco dei bambini
minatori e di David Copperfield. Quel che non va è proprio la retorica di un
mondo morto e non ci sono ingaggi di musica sotto il palco che possono dare vita
a ciò che è morto”. La pioggia ieri ha fatto il resto e se si aggiunge il contro
concertone (brutto definirlo così) organizzato a Taranto da David Riondino, il
più noto commissario Montalbano giovane, le somme si tirano da sé, piazze divise
e il pericolo di un deja vu che sa di stanchezza e scoramento. Di solito
è questo il destino di qualsiasi data e il poeta Valerio Magrelli ne ha cantato
in una sua poesia la caducità: “Luce di stella morta/ giunta da un trapasso
presente/ il suo oggi è lo ieri/luce salma/ memoria di un oltretomba
quotidiano”. Che sia colpa dell’impossibilità di allungare le date? Probabile,
visto che ogni celebrazione è destinata a finire troppo presto, allungarle è
soltanto un desiderio che l’incedere quotidiano ha impedito. Sarà per questo che
nel testo irridente di Elio e le Storie Tese “Il complesso del primo maggio”,
gioco satirico di controinformazione sui clichè della festa, la voce di Eugenio
Finardi subentra a ricordare una verità: “Il primo maggio è fatto di gioia, ma
anche di noia…”. Nel frattempo è già tre maggio, meno un mese al due giugno…
25 aprile, una festa lunga
70 anni.
Iniziative, immagini e celebrazioni per l'anniversario della Liberazione. 25
aprile, cinque libri per la Festa della Liberazione. Dai classici di Calvino e
Vittorini ai più recenti di Aldo Cazzullo e Giacomo Verri, cinque romanzi per
ricordare, scrive Andrea Bressa su "Panorama". Come ogni anno, il 25 aprile ci
si ferma per un giorno a ricordare e celebrare la liberazione dal giogo fascista
e dalla barbarie della guerra. La nostra Festa della Liberazione la vogliamo
passare anche tra le pagine di chi ha saputo raccontare i drammi di quegli anni,
magari anche impegnato nella lotta in prima persona. Ecco dunque cinque libri
per riflettere sul significato di una ricorrenza tanto importante.
La mia anima è ovunque
tu sia –
Aldo Cazzullo (Mondadori)
Nella primavera del 1945 i
tedeschi sono ormai costretti a ritirarsi abbandonando i frutti delle loro
razzie. Nella città di Alba i tesori dei nazisti vengono spartiti tra il capo
dei partigiani e un rappresentante della Curia. Più di cinquant’anni dopo, un
misterioso omicidio scuote la città e sembra riportare a galla gli eventi di
quei giorni febbrili.
Uomini e no
– Elio Vittorini (Mondadori)
Il primo romanzo in assoluto
sulla Resistenza, scritto quando la lotta per la liberazione dal nazifascismo
era ancora in corso. Il capitano Enne 2 guida il suo gruppo di partigiani alla
scoperta di una Milano spettrale e deserta, ormai abbandonata alle violenze e ai
soprusi della guerra.
Il partigiano Johnny
– Beppe Fenoglio (Einaudi)
Questo classico della
letteratura partigiana ha il sapore di una moderna epopea. Il giovane Johnny,
studente di letteratura inglese, decide di prendere parte alle azioni di
guerriglia per difendere le sue amate Langhe dall’invasore nazista. Il romanzo
s’ispira in larga parte alla biografia dell'autore.
Il sentiero dei nidi di
ragno –
Italo Calvino (Mondadori)
La guerra civile al tempo
della Resistenza è narrata dal punto di vista di Pin, un bambino che osserva con
stupore e con sinistra ammirazione le imprese compiute dai ‘grandi’. L’apparente
sicurezza con cui affronta fascisti e partigiani cela in realtà un profondo
disagio, quello dell’orfano di guerra abbandonato da tutti.
Partigiano Inverno
– Giacomo Verri (Nutrimenti)
Un ragazzino innamorato, un
giovane irrequieto e un pensionato mite e disorientato, sullo sfondo di una
Resistenza raccontata in forma di epica contemporanea. Dal passato non arriva
solo la storia narrata, ma anche il registro e la voce di un mondo lontano.
C’è un antifascismo un pò
fascista.
Scrive Piero Sansonetti su "Il Garantista". Esistono tre modi di concepire
l’antifascismo, e quindi di celebrare il settantesimo anniversario della
Liberazione, che cade sabato prossimo, 25 aprile.
Il primo è un modo freddo e
storico. Che si limita a osservare la grandiosità di quella data che rappresenta
la caduta del nazi-fascismo, e cioè di un fenomeno e di una leadership politica
dell’Europa occidentale che trascinò l’intero continente sull’orlo del baratro,
al limite della fine della civiltà. E’ talmente gigantesco l’obbrobrio politico
creato dal fascismo e dal nazismo – e che ha avuto il suo apice nel razzismo e
nello sterminio della popolazione ebraica e dei rom – che la sua sconfitta
militare (in Italia sancita dall’ingresso a Milano dell’esercito
anglo-americano) segna uno spartiacque nella storia del nostro paese e del
continente.
Il secondo è il modo della
retorica. Il più diffuso. L’antifascismo proclamato non come un valore ma come
una ”appartenenza”. Una bandiera. L’antifascismo come luogo degli eletti, al di
fuori del quale c’è solo feccia e vermitudine, e dunque chiunque non entri con
baldanza e convinzione nel cenacolo antifascista, e non si sottoponga ai riti e
alle giaculatorie, è condannato ad essere scacciato tra i reietti. Questo è
l’antifascismo più diffuso. E’ l’antifascismo delle cerimonie, ed è una specie
di sotto-ideologia, dai confini molto vasti -dalla vecchia Dc ai centri sociali
– che ha permesso per anni alle forze politiche di sinistra di rinunciare ad una
propria struttura politica – di idee e di progetto – perché questa struttura era
sostituita dal pacchetto-già-pronto dell’antifascismo e della militanza
antifascista. Dentro questo antifascismo non ci sono idee o valori: c’è
”identità”. Anzi, questo modo di concepire l’antifascismo è esso stesso
”identità”. E questa “identità”, siccome è molto debole, labile, perché non sia
dispersa, è “militarizzata”.
Poi c’è un terzo modo di
pensare l’antifascismo. Ed è quello di ricercare, di ricostruire e poi di
affermare i suoi valori. Quali sono i suoi valori? Sono il rovesciamento delle
caratteristiche più reazionarie del fascismo, e cioè delle caratteristiche che
lo hanno portato alla condanna della storia. Proviamo ad elencarle.
L’autoritarismo. L’illiberalismo. L’intolleranza e la richiesta di appartenenza.
Il militarismo. Il pensiero unico. La violenza, fisica e culturale. L’arroganza.
Il senso di superiorità. Il razzismo e la xenofobia. Lo statalismo. La
repressione. Il disprezzo per lo stato di diritto. L’antifascismo del ”terzo
tipo” è quello che trasforma in valori la lotta contro queste tendenze. Ed è un
antifascismo attualissimo, perché queste tendenze non solo sono presenti, e
radicate, nello spirito pubblico italiano di oggi, ma sono larghissimamente
maggioritarie e prevalenti. E sono trasversali, uniscono destra e sinistra, così
come fu trasversale il movimento fascista. Quasi tutte queste tendenze si
ritrovano, esasperate, (ma in misura variabile) nel leghismo, nel grillismo, nel
travaglismo. E si ritrovano anche, meno esasperate, ovunque. Il ”renzismo”, se
lo vogliamo chiamare così, non è certo esente dalla retorica fascista, sia nei
suoi aspetti autoritari (riduzione del parlamento a bivacco di manipoli …) sia
nel suo linguaggio politico (spianiamo tutto, chissenefrega del dissenso,
abbasso i vecchi evviva la giovinezza, se avanzo seguitemi…). E anche nella
violenza della polemica politica.
Dei tre tipi di antifascismo
che ho citato, il primo è scarsamente rilevante, il secondo è dilagante, il
terzo è del tutto marginale. E come tutti gli antifascismi che si rispettano è
quasi clandestino…Il problema drammatico è che l’antifascismo di secondo tipo,
quello retorico e militarista, che ha dominato il dibattito politico durante
tutto il tempo della prima e della seconda repubblica, oggi sta assumendo
caratteristiche sempre più militariste, autoritarie e intolleranti, quasi
sovrapponendosi allo stesso fascismo. E’ un antifascismo di tipo fascista. E
tuttavia è l’unico antifascismo con diritto di parola. Se fino a qualche anno fa
il suo limite era l’assenza di pensiero e il trionfo del conformismo, ora le
cose si sono complicate, perché si è mescolato con i grandiosi populismi di
destra e di sinistra di questi anni, ed ha subito un fortissimo degrado. Basta
ascoltare le posizioni di gran parte del mondo politico e giornalistico
sull’immigrazione. Sono posizioni che sempre più spesso “sdoganano” principi di
tipo nazista. E alle quali non si oppone quasi nessuno, al di fuori della Chiesa
cattolica. Oppure basta seguire le polemiche più diverse, su tanti giornali, e
la carica di intolleranza e di rifiuto del dialogo, e di senso di superiorità
che vi si trova. Mi ha colpito un articolo di Antonio Padellaro – persona mite e
seria – pubblicato ieri sul “Fatto”. Giustamente Padellaro in quell’articolo
rivendica il diritto ad essere “buonisti” e rivendica persino il valore della
tolleranza contro quello dell’intransigenza. E una riga esatta dopo aver scritto
questo, si ricorda che sta scrivendo sul ”Fatto” e si rivolge ai suoi avversari
politici, che ha visto in un certo talk show, e li definisce la ”feccia di
qualche zoo del Nord-est”. E’ questo il problema: a nessuno viene in mente che
rivendicare la tolleranza e definire feccia chi dissente (a qualunque titolo e
su qualunque posizione) non funziona. E però ci avviamo a celebrare un 25
aprile in questo clima. Che non credo sia molto diverso da quello del 1922.
A chi il 25 aprile? Ai
soliti noti (ma su Raiuno).
Prima serata a rischio retorica con Saviano, Pif, Albanese, Paolini e Ligabue,
scrive Maurizio Caverzan su "Il Giornale". Ci saranno tutti o quasi. Dite un
nome e lo trovate. Fazio e Saviano, Albanese e Marco Paolini, Pif e Ligabue. E
poi chissà quanti altri. Del resto, il momento è solenne, bisogna ammetterlo:
settant'anni dalla Liberazione del 25 aprile 1945. Quindi, per l'occasione,
Raiuno si traveste da Raitre o, se preferite, Raitre trasloca su Raiuno. Una
grande serata unificante, dal titolo schietto e festoso: Viva il 25 aprile! col
punto esclamativo. Una serata che avrà nella Piazza del Quirinale il cuore
pulsante della celebrazione officiata da Fabio Fazio. «Perché le vere feste si
fanno in piazza - recita il comunicato di Raiuno - e la piazza del Quirinale è
la piazza di tutti». E ancora: «Il 25 aprile è una festa di compleanno e
quest'anno ricorre il 70° compleanno della Libertà». Insomma, diciamola tutta,
una grande serata a rischio retorica. Per la quale il servizio pubblico non ha
lesinato sulle risorse. Ordunque, Fazio all'ombra del Quirinale, Pif in
collegamento dalla Sicilia, Roberto Saviano da Montecassino, Marco Paolini ed
Elisabetta Salvatori da Sant'Anna di Stazzema, Antonio Albanese da Alba, Ligabue
e Francesco De Gregori in concerto da un'altra piazza di Roma. En plein. Dicono
i beninformati che a volere la grande serata unificante sia stato il direttore
generale della Rai, Luigi Gubitosi. E che abbia orchestrato l'operazione in
perfetta sintonia con Andrea Vianello, direttore di Raitre, con il quale
peraltro l'intesa è consolidata dalle trattative sul caso Floris e dalla scelta
di trasmettere Gomorra sulla Terza rete con lancio della coppia Fazio-Saviano, e
non, per esempio, su Raidue. Secondo queste fonti il capo di Raiuno, Giancarlo
Leone, avrebbe fatto buon viso a forza maggiore. E ora aspetterebbe di vedere
come va il mezzo trasloco, il cambio di tasto sul telecomando con conseguente,
probabile, spaesamento del pubblico. Tuttavia, non c'è tanto da stupirsi. Perché
comunque, questa strana serata nasce da un equivoco che viene da lontano. Ovvero
che la Liberazione della Seconda guerra mondiale e la Resistenza siano esclusive
di una certa sinistra, più salottiera che militante, ma pur sempre sinistra
(come se non esistessero partigiani non comunisti o azionisti). E, di
conseguenza, che l'anniversario di uno dei momenti fondanti della Repubblica non
possa essere gestito se non dai soliti noti. Ma siccome quest'anno il
«compleanno della Libertà» è più solenne perché trattasi del settantesimo, cifra
tonda, ci voleva la rete ammiraglia, il primo canale, la massima potenza di
fuoco. Sarà davvero difficile restare alla larga dalla retorica.
Quest'anno torna la
retorica. La Storia invece fa il ponte.
Per la festa il diktat è archiviare il "revisionismo", scrive Matteo Sacchi su
"Il Giornale". Ma la Resistenza quanto dura? La risposta di qualcuno è semplice,
da corteo: «Ora e sempre Resistenza!». Viene da una poesia di Calamandrei, per
carità, ma senza la dedica al generale Kesselring (che voleva un monumento dagli
italiani) perde di senso. E così, a 70 anni dal 25 aprile, se uno sfoglia i
giornali o va in libreria si trova davanti una serie di richiami alla lotta al
nazifascismo che dà l'impressione che Kesselring prema di nuovo contro il
baluardo alpino. Anzi, se in questi anni qualche tentativo di ragionamento più
pacato lo si è fatto, la cifra tonda e l'inserimento della ricorrenza nel
calendario del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse
nazionale sono visti da qualcuno come l'occasione per tornare alla «Resistenza
perfetta». Lo storico Giovanni De Luna lo teorizza nel suo volume intitolato
proprio La resistenza perfetta (Feltrinelli). Dice di provare «un insopportabile
disagio» quando si indaga sulle imperfezioni della Resistenza: «Dagli anni '90
in poi si è messa in moto una valanga di fango e detriti inarrestabile,
alimentata da una storiografia punteggiata da aneddoti poco edificanti». Meglio
mettere tutto sotto lo zerbino e buttarla in retorica, allora? Qualche esempio.
A Modena lo scorso weekend c'è stato il Festival play , un poco resistenziale
festival del gioco. Si è dovuto comunque colorirlo di «memoria». Si è giocato
alla staffetta partigiana. Oppure a Radio Londra. Niente di male, però la caccia
al tesoro che parte da dove si uccise Angelo Fortunato Formiggini e finisce alla
lapide per i fucilati è un po' troppo. Meglio allora lo spiegamento di libri del
Corriere della Sera che sino al 26 settembre proporrà letteratura partigiana.
Promuovendo l'operazione con titoli tipo: «Raccontare la Resistenza, un impegno
di libertà». E c'è anche un po' di confusione, visto che tra i libri
resistenziali finiscono dei racconti di Mario Rigoni Stern che con la Resistenza
hanno poco a che fare ( Aspettando l'alba ). Ma siamo alle solite, tutto è
Resistenza, persino Rigoni Stern, volontario fascista, che scriveva: «Non vi è
stata una guerra più giusta di questa contro la Russia sovietica». Certo, si
dirà: ha cambiato idea mentre era in un lager tedesco, dopo l'8 settembre.
Forse. Di sicuro il 25 aprile stava ancora cercando di tornare a piedi dalla
Polonia, rientrò a casa il 5 maggio. Del resto qualsiasi cosa, in attesa del
70º, può essere «partigianizzata». Mettiamo che si decida di parlare di una
mostra di Mario Dondero, come ha fatto La Stampa il 10 aprile. Dondero è un
grande della fotografia. Fra le altre cose ha fatto il partigiano in Val
d'Ossola, ma questo poco o nulla ha a che fare con i suoi scatti. Però il titolo
diventa: «Dondero, la guerra all'ingiustizia del partigiano con l'obiettivo».
L'intervistatore sentirebbe pure la necessità di denunciare «il revisionismo
diventato senso comune». Meno male che il revisionismo è diventato senso comune:
proprio La Stampa pubblica in prima pagina un «conto alla rovescia» per il 25
aprile a firma Paolo Di Paolo, scrittore «inviato nel 1945». L'inviato raccoglie
a piene mani virgolettati d'epoca di Togliatti. E il quotidiano propina anche
titoli equilibrati come: «Il momento della scelta tra barbarie e civiltà». Per
non dire di come è stata strumentalizzata la lettera del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella a Micromega . Di tutto ciò che ha scritto, nelle
titolazioni di alcuni giornali come il Fatto , si è isolata (quando non
forzosamente interpretata) solo la frase sull'evitare «pericolose equiparazioni
tra i due campi in conflitto». Lo storico Angelo D'Orsi, sempre sul Fatto esulta
per «la fine del “rovescismo” alla Pansa», e nella sua visione persino Luciano
Violante, che osò «salutare i ragazzi di Salò», sembra un apologeta. Beh, certo
ma quel che conta, chioserà qualcuno, è la tv! Iris, canale Mediaset dedicato al
cinema, da oggi al 24 aprile, presenterà il ciclo «Storie di libertà», omaggio
alla Resistenza. A commentare la rassegna, Fausto Bertinotti. Quanto ai titoli:
Il Generale della Rovere , Il delitto Matteotti , I piccoli maestri ... E anche
l'hollywoodiano Il mandolino del Capitano Corelli che, a essere sinceri,
trasforma l'eccidio di Cefalonia in un polpettone romantico a cui forse
bisognerebbe «resistenzialmente» ribellarsi. Raiuno invece imbastirà una serata
affidata a Fazio. Ospiti i soliti noti: Saviano, Paolini, Albanese, Ligabue...
Che sia un po' sbilanciata a sinistra? Sulle librerie sarebbe meglio non far
parola. Oscar Farinetti, il patron di Eataly, in Mangia con il pane (Mondadori)
racconta le avventure del padre Paolo Farinetti. Il comandante Paolo ha un
curriculum bellico di tutto rispetto: liberò dalle carceri di Alba 22 detenuti
politici. Ma la biografia si trasforma in una narrazione edulcorata. E Farinetti
jr., quando può, si ritaglia anche uno spazietto per spiegare quanto è bella
Eataly: «Non è un impero, è piuttosto un gruppo di lavoro di circa 4mila persone
che si sbattono per celebrare la meraviglia dell'agroalimentare italiano».
Insomma, resistere oggi è mangiare bene. Del resto a Milano si va dal «tutto è
Resistenza» alla Resistenza a rischio di antisemitismo. La brigata ebraica non è
gradita in piazza. Perché? Perché si fa resistenza anche a Israele. Abbastanza
per far adirare anche il presidente della Fondazione Anna Kuliscioff, Walter
Galbusera: «I veri partigiani... sono rimasti in pochi e i gruppi dirigenti non
sempre hanno atteggiamenti costruttivi». Polemiche non dissimili si sono
sviluppate anche a Roma. Dove c'è chi ha detto - e la presidente della Camera
gli ha dato ragione - «si dovrebbe togliere la scritta “Dux” dall'obelisco del
Foro Italico a Roma». Cancellare i nomi è un modo un po' strano di rievocare la
storia. Ecco, la Storia? Quella il 25 aprile fa il ponte.
Giorgio Albertazzi: "Io, il
duce, piazzale Loreto", scrive “Libero Quotidiano”. Sta per tornare il 25
aprile. E come accade tutti gli anni, torna la retorica della Liberazione. Prima
sui giornali e poi sulle piazze. Uno dei quotidiani che si è portato avanti è Il
Fatto Quotidiano, che dedica al 25 Aprile due pagine, una delle quali dedicata a
una intervista a Giorgio Albertazzi. Che fu negli ultimi mesi della Seconda
guerra mondiale tra i fascisti di Salò. E su quanto accadde in piazzale Loreto
ha un giudizio sicuramente controcorrente. "Piazzale Loreto fu solo macelleria
messicana. Niente altro. Fu uno schifo, per chi l' ha voluto e chi l' ha portato
a termine quel disegno. Ma non poteva essere evitato, non nel senso politico del
termine, ma perché l' uomo è quella cosa lì. Un animale? Il peggiore degli
animali". Lui non c'era, quel giorno a Milano: "Non ero in Italia. Io ero a
combattere. Paradossalmente contro i tedeschi che erano i nostri alleati. Ma
nella confusione di quei giorni ci trovammo a sparare ai tedeschi, in Austria,
tra le montagne innevate. Senza più niente". La fama di fascista non me la sono
mai scrollata di dosso. Andai a Salò come tanti ragazzi, convinto che lì si
combattesse per l' Italia, ma con altro spirito, e soprattutto consapevole che
in quel momento stavo dalla parte di chi già aveva perso". Finì due anni in
carcere, per essere stato coi Repubblichini: "Come dissi in un' intervista all'
Espresso nella sentenza del Tribunale militare che mi ha assolto in istruttoria
dopo due anni di carcere preventivo, c' è scritto che ho messo in salvo 19
ebrei. Ma non l' ho mai raccontata questa cosa. Non mi andava. le mie
responsabilità, seppur di ventenne, me le prendo tutte".
Il 25 aprile nei diari conservati all'archivio di
Pieve Santo Stefano. Quel giorno di 70 anni fa a Milano raccontato dalle parole
di chi era lì. Nove storie selezionate tra quelle conservate nell'archivio
diaristico nazionale, scrive
Nicola Maranesi su “L’Espresso”.
Sono trascorsi settant’anni da quel mercoledì 25 aprile 1945. Il giorno della
Liberazione, il giorno in cui l’Italia ha debellato il nazifascismo e chiuso
l’oscura esperienza della Repubblica Sociale Italiana. Milano è stata e resta il
luogo simbolo di quel passaggio storico. Una città che in pochi giorni ha
vissuto gioie estreme e dolori estremi, distribuiti tra centinaia di migliaia di
persone che tornavano ad abbracciarsi e altrettante che continuavano a
uccidersi. Con le vittime e i carnefici a passarsi il testimone, in uno di quei
momenti della storia in cui è impossibile tracciare un confine universale tra
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Per comprendere cos’è accaduto in città
in quei giorni di 70 anni fa non esiste racconto più efficace di quello
racchiuso nei diari e nelle memorie di chi c’era. Centinaia di questi sono
conservati presso l’ Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano , in
provincia di Arezzo. Una rapida perlustrazione di questo fondo in gran parte
inedito lascia affiorare le voci dei protagonisti.
Ne abbiamo scelte nove,
che ci sembrano rappresentative di sentimenti e stati d’animo diversi e
complementari. A partire da quella dell’operaio della Compagnia generale
elettricità Antonio De Palo
("Due fucilati")
che il 24 assiste a uno degli
ultimi crimini commessi dai fascisti, che “per impressionare le maestranze”
fucilano due partigiani prelevati dal carcere di San Vittore nel piazzale
antistante la sede della Compagnia. C’è poi quella della giovane studentessa di
ragioneria Maria Rachele Ciccarelli
(“Liberi? Sembra impossibile”),
che riassume l’enorme impatto delle novità che si stanno abbattendo sulla vita
di tutti con una semplice frase, pronunciata dal sanatorio dov’è in cura:
“Liberi. Cosa vuol dire per noi liberi. Mi sembra impossibile”. Una libertà che
sfugge a Rina Alberici
("Trentasette morti"),
che nella sua testimonianza racconta ancora di esecuzioni sommarie, ma che
vedono invertirsi le parti tra vittime e carnefici. Allo stabilimento Breda gli
operai insorti hanno imprigionato il personale dirigente. Compilano una lista di
capi d’accusa e si fanno giustizia da soli. Tra i reclusi c’è anche Aurelio,
marito di Rina, che verrà risparmiato e tornerà a casa salvo, facendosi però
strada tra i cadaveri di trentasette colleghi ammucchiati di fronte al cancello
della fabbrica. Non rischierà la vita ma subirà una violenta aggressione la
giovanissima Maria Luisa Torti
("Picchiata dai partigiani")
che sarà picchiata e rasata dai partigiani per essersi rifiutata di baciare una
lercia bandiera rossa. Sono gli episodi più tragici di una riconquista della
città che annovera molte tappe pacifiche, come quelle che Antal Mazzotti
("Scene dalla
Liberazione") e il membro
del Comitato di liberazione nazionale Vella Folgore
("La riconquista di Milano")
descrivono minuziosamente
nei rispettivi diari. Sono i rovesci inaspettati che il partigiano ed ex
repubblicano Luigi Mingozzi riassume alla perfezione nella sua biografia e nel
racconto delle giornate che seguono il 25 aprile
("Vendette, festeggiamenti,
amori"). Tutte queste
storie di gente comune rappresentano tasselli che aiutano a comprendere la
Storia. E a rispondere agli interrogativi. Come quelli che è lecito porsi al
cospetto della compassione che prova il piccolo Mauro Pistolesi
("Più pietà che odio" )
pur trovandosi di fronte ai
fascisti fiancheggiatori dei nazisti, responsabili dei delitti ai quali ha
assistito. Come quello di cui parla un altro testimone, Claudio Cimarosti
("A otto anni ho visto
il duce a testa in giù"),
nella sua memoria. Claudio ha otto anni quando il 29 aprile il padre lo conduce
a piazzale Loreto per vedere i cadaveri di Mussolini, Clara Petacci e dei
gerarchi. “Come hai potuto pensare di portare un bambino?”, ha chiesto al
genitore anni dopo. “Mi sembrò assolutamente normale portare anche te”, la
risposta. “Tutti gioivano che il fascismo avesse fatto quella fine. Che fosse
finita la guerra, le lotte civili, la dittatura. E mi sembrò giusto far
partecipare anche te a questa gioia”.
"A otto anni ho visto il duce
a testa in giù". A soli otto anni Claudio Cimarosti è già abituato a guardare la
morte in faccia. Non solo quella che gli appare a piazzale Loreto nei volti del
Duce, di Clara Petacci e dei gerarchi, al cospetto dei quali è posto dal padre
senza alcun indugio. Tra partigiani assassinati e violenze verbali, Claudio può
dire di aver bruciato presto le tappe della vita. Quel
giorno in piazzale Loreto io c’ero. Prima ancora che fossero appesi a testa in
giù alla pensilina del distributore di benzina, la notizia che Mussolini e la
Petacci erano stati uccisi ed erano in piazzale Loreto si sparse per la città.
Anche mio papà lo seppe, prese immediatamente la bicicletta, mi mise in canna e
partimmo per piazzale Loreto. In piazzale Loreto c’era una folla enorme. Mio
papà, con me per mano, tentò di avvicinarsi al punto dove c’erano i cadaveri di
Mussolini, della Petacci e degli altri gerarchi, ma fu impossibile anche perché,
ad un certo punto, la strada era stata completamente allagata. […] Poco dopo che
fummo arrivati furono appesi a testa in giù alla pensilina di un distributore di
benzina e noi potemmo vederli. Forse credo […] che quello non debba essere stato
uno spettacolo molto edificante per un bambino di otto anni! E questo ebbi modo
di dirlo a mio papà, una sera, chiacchierando, qualche anno prima che lui
morisse. “Come hai potuto pensare – gli chiesi – di portare un bambino di otto
anni a vedere dei cadaveri esposti in piazza?”. E lui mi diede ragione. “Oggi –
mi disse – Non lo rifarei sicuramente, ma questo ti deve far capire che clima
c’era in quel periodo, che aria si respirava in quei giorni. Tu sai che in vita
mia non sono mai stato un esagitato, però quel giorno mi sembrò assolutamente
normale portare anche te, perché quello era un avvenimento storico eccezionale,
ma soprattutto perché tutti gioivano che il fascismo avesse fatto quella fine.
Che fosse finita la guerra, le lotte civili, la dittatura. E mi sembrò giusto
far partecipare anche te a questa gioia”. […] D’altro canto non era la prima
volta che vedevo dei cadaveri. Era una cosa quasi normale in quel periodo. Una
mattina io ed i miei amici, nel bel mezzo del parco Solari che dovevamo
attraversare per andare alle scuole di via Ariberto, trovammo, steso in un
prato, il cadavere di un partigiano. Evidentemente era stato ucciso nel corso
della notte e giaceva là da ore senza che alcuno se ne curasse. Un’altra volta
andammo a vedere due partigiani che erano stati fucilati a piazza Cantore. E di
morti se ne sentiva parlare ogni giorno. Uccisi da entrambe le parti, partigiani
e fascisti. E si sentiva parlare di gente arrestata, di persone sparite, si
sentiva parlare di torture che avvenivano nelle carceri.
Trentasette morti. Madre del
piccolo Pierpaolo e moglie di Aurelio, un dirigente della Breda, Rina Alberici
ha lasciato una testimonianza autobiografica sul 25 aprile priva di entusiasmi.
Nelle ore che accompagnano la Liberazione, ore che definisce “della caccia
all’uomo, sanguinosa e fratricida”, un pericolo di morte minaccia la sua
famiglia: Aurelio è stato sequestrato dagli operai insorti. Il diario di Rina
Alberici (foto di Luigi Burroni)Io e Pierpaolo (il
figlio di Rina, ndr) sembravamo due senza fissa dimora; la maggior parte del
tempo lo passavamo per strada, scrutando qua e là in attesa di un arrivo. Un
pomeriggio, guardando verso viale Umbria vidi stagliarsi nella luce fra gli
alberi una sagoma e mi parve di riconoscere Aurelio. “Non è lui” mi dissi
“Aurelio non viaggia in bicicletta”. Quell’uomo pedalava piuttosto forte tenendo
il manubrio con una sola mano poiché nell’altra aveva una ciambella con
coperchio per W.C. Scuotendo la manina Pierpaolo gridavo: “Guarda è papà, papà;
Aureliooo” e scoppiai a piangere. Aurelio stava bene, non aveva né fame né sete;
in quei tre giorni, rinchiusi nei sotterranei, mangiarono e bevvero come
nababbi; non gli fecero mancare neppure il fumo. Secondo gli “aguzzini” si
trattava degli ultimi pasti della loro vita. […] All’entrata in Milano degli
americani gli operai misero in atto repentinamente la loro “rivolta”; già armati
(un’organizzazione fatta a regola d’arte) presero possesso di tutto lo
stabilimento (Breda, dove lavorava Aurelio, ndr) convogliando il personale
dirigente o con alte cariche nei sotterranei che avevano funzionato come rifugi
antiaerei. Il Comitato promotore disponeva della lista di coloro su cui
pendevano i capi d’accusa; di mano in mano ne prelevarono quattro o cinque, ma
non facevano più ritorno. Aurelio, fra i rinchiusi, quando sentiva l’appello gli
sembrava che il cuore volesse scoppiargli. Ne furono prelevati una quarantina
circa; non era difficile immaginare la fine che fecero. Il terzo giorno Aurelio
si sentì chiamare, le gambe gli tremavano ed un incaricato gli disse che poteva
andare a casa; su di lui non pendevano capi d’accusa. Non gli sembrò vero. […]
Uscendo dal cancello dovette scavalcare circa 37 morti fucilati, abbandonati in
mucchio per terra. La fretta e la paura non gli diedero la possibilità di
riconoscerli; là si fucilava senza regolare processo. Presa una bicicletta
qualsiasi incominciò a pedalare, ma visto un posto di blocco si fermò
rifugiandosi in un negozio di servizi igienici e per non fare la figura del
fuggiasco trattò l’acquisto della famosa ciambella.
Picchiata dai partigiani.
Quando giunge il 25 aprile e la Liberazione Maria Luisa Torti ha una sola
certezza. Il peggio è passato. Purtroppo sbaglia. Mentre osserva senza favori
l’ingresso degli americani a Milano, è vittima di una ritorsione immotivata da
parte dei partigiani. Il diario di Maria Luisa Torti (foto di Luigi Burroni)Era
il giorno che era logico pensare che chiunque avrebbe come minimo avuto la forza
di alzare la testa, di guardare avanti, perché ognuno di noi sopravvissuti
potevamo dire “io ho già pagato!”. Invece io, proprio io, non avevo ancora
finito di pagare. Il tempo, le ore non avevano misura, so che non era ancora del
tutto buio [… so che la porta venne spalancata improvvisamente ed entrarono due
partigiani, ovvero così si presentavano in quei momenti di caos, tutti coloro
che avevano voglia di alzare la voce. Questi due ragazzi (perché non avevano più
di sedici-diciassette anni) che conoscevo bene perché abitano due palazzi oltre
il mio, prima buttarono all’aria la casa, cassetti e armadi in cerca di che cosa
non so, perché infatti non presero nulla, poi guardandomi dissero “tu vieni con
noi”. Ricordo solo le labbra di papà che erano diventate due fessure dipinte di
bianco. I vicini di casa silenziosi che avevano riempito la stanza e io (ancora
oggi per quanti sforzi faccia, non ricordo come scesi le scale, come mi trovai
in quel piccolo giardino di quella villetta) io mi vedevo lontana, non vivevo in
prima persona. C’era una macchina accanto a me da dove scendevano tanti
partigiani, erano aggrappati alle portiere, e avevano tutti i capelli e la barba
lunghi, e tutti avevano intorno al collo un fazzoletto rosso, e tutti cantavano
continuamente fino a drogarsi col canto “…e bandiera rossa sempre vincerà…e
bandiera rossa sempre vincerà…”. I due stupidini che mi avevano prelevata a casa
dissero al compagno Lupo: “Questa è una repubblichina”. Dieci, cento mani mi
spinsero, mi toccarono, mi spinsero, i bottoncini della camicetta bianca erano
saltati ed il mio seno era semiscoperto. Ero una fanciulla di una figura
meridionale bruna e prorompente, perciò maggiormente tutti erano eccitati. I due
ragazzi che mi avevano portata non c’erano più; forse chi era più grande di loro
e che mi conosceva sapeva che io non c’entravo per niente con tutto ciò, ma la
voce del compagno Lupo mi portò alla realtà perché mi gridò: “Bacia la
bandiera”. Davanti a me c’era una specie di tovaglia rossa, lercia, sporca,
bagnata, strappata, puzzava di sudore e di sangue e il tessuto (non il simbolo)
mi fece schifo e voltai la faccia…non l’avessi mai fatto! Il volto mi fu
riempito di schiaffi, il primo mi colpì subito la bocca, mi si ruppe il labbro
superiore e sentivo il sapore dolciastro del mio sangue, i mei capelli lunghi si
sparpagliavano intorno al mio volto e ogni tanto sentivo: “Bacia la bandiera”. E
io cretina continuavo a voltare la faccia finché i miei capelli, che mi
coprivano il volto, e che mi entravano in bocca quando prendevo fiato per urlare
di nuovo…improvvisamente il mio volto era libero. E i miei bei capelli neri e
riccioluti, erano in terra più in là. E quelli ridevano e quello con la forbice
che faticava a tagliare. E quelli che mi tenevano la testa. E io che urlavo e
poi una voce forte che grida “Basta!”. Basta. […] Fui sollevata da terra e
Glauco, un ragazzo che conoscevo da piccola ed ora già adulto, pulito, con gli
occhiali i capelli normali e diventato qualcuno di importante durante la vita
partigiana, presami per un braccio mi disse: “Stai tranquilla, è stato un
errore…”.
L'altra Resistenza. Quella
che nessuno vuole più ricordare.
Il saggio di Ugo Finetti
ricostruisce le vicende di militari e partigiani dimenticati Erano patrioti e
lontani dal Pci, per questo nei libri di storia non c'è stato posto per loro,
scrive Matteo Sacchi su "Il Giornale". Tra l'8 settembre del 1943 e il 25 aprile
del 1945 (data ufficiale della Liberazione, anche si sparò ancora un bel po')
chi ha combattuto per liberare l'Italia dall'occupazione tedesca supportata
dalle forze (assolutamente gregarie) della Rsi? La risposta all'apparenza è
molto semplice. In primo luogo gli anglo-americani e gli alleati, tra cui
andrebbe citato il numerosissimo contingente polacco che arrivò a contare 75mila
uomini. In secondo luogo le forze cobelligeranti italiane, il Corpo Italiano di
liberazione, ovvero ciò che restava del regio esercito. Che crebbe di
consistenza durante il conflitto per arrivare a contare 22mila uomini
perfettamente armati e disciplinati. Poi le formazioni partigiane di diversa
estrazione ideologica e politica. Nel '43 i loro organici erano ridottissimi.
Nell'aprile del '44 secondo la maggior parte delle fonti contavano circa 22 mila
uomini. Le formazioni comuniste erano le più numerose, ma ben lontane da
rappresentare la maggioranza assoluta delle forze partigiane. Quello fatto sin
qui potrebbe sembrare un bigino inutile ed ovvio. Però a settant'anni dal 25
aprile del '45 l'immagine che ci viene regalata della Liberazione è ancora molto
distorta. Ideologizzata. Il contributo delle truppe regolari italiane
marginalizzato, i partigiani raccontati come se avessero tutti al collo un
fazzoletto rosso (ma rosso comunista, perché anche sui socialisti già si
potrebbe storcere il naso), gli anglo-americani rimossi, anzi quasi colpevoli di
averci negato la possibilità di essere inclusi nel Patto di Varsavia. È del
resto di qualche giorno fa un titolo delle pagine di Repubblica che recitava
così L'Armata Rossa che fece la Resistenza. Racconta le vicende dei soldati
sovietici che fuggiti ai tedeschi cooperarono coi partigiani. Sulla loro
consistenza numerica non occorre fare molti conti, nel testo si spiega che se ne
sa poco, ma il titolo fa ben capire dove si vuole andare a parare. Se si vuole
sfuggire a questo clima, che ha stravolto la storiografia per decenni, è di
aiuto il testo di Ugo Finetti che proponiamo in allegato con il Giornale nella
nostra biblioteca storica, La Resistenza cancellata (pagg. 376, euro 7,60 più il
prezzo del quotidiano). Finetti, ex giornalista della Rai con all'attivo
moltissime inchieste e reportage, ricostruisce in questo saggio l'uso politico
della Resistenza fatto nel Dopoguerra. Spiegando quanto quest'uso politico abbia
fatto male alla stessa Resistenza. Per usare le sue parole: «Quando
l'antifascismo diventa un marchio di cui una minoranza pretende di avere
l'esclusiva, e si accusa quotidianamente di fascismo la maggioranza, si scava un
fossato tra antifascismo e opinione pubblica». Ma soprattutto Finetti dà largo
spazio alla storia dei resistenti dimenticati. In prima istanza i militari. E
rende loro giustizia dopo decenni di oblio: «La resistenza non fu infatti una
guerra civile tra due élites - i rivoluzionari comunisti e gli irriducibili di
Salò - ne ebbe come caratteristica la lotta di classe. Vide alla nascita come
protagonisti militari guidati da ufficiali “legittimisti”... Le prime formazioni
hanno come denominazione richiami risorgimentali e gli Alleati ne favorirono la
nascita. Il Partito comunista, dal 25 luglio 1943 fino all'aprile 1944, svolse
un ruolo del tutto secondario». E l'opera di ricerca di Finetti è pregevole
soprattutto quando aiuta a riscoprire personaggi importanti come il colonnello
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, che fu il vero organizzatore della lotta
antitedesca a Roma. Partecipa all'inutile tentativo di difendere la città sotto
l'attacco tedesco. Si dà alla clandestinità. Il 10 dicembre 1943, quale
comandante riconosciuto dal governo Badoglio, dirama a tutti i raggruppamenti
militari nell'Italia occupata dai nazifascisti la circolare 333/op, nella quale
vengono indicati gli obbiettivi dell'organizzazione clandestina e le direttive
per la condotta della guerriglia. Le sue parole d'ordine erano: «guerra al
tedesco et tenuta ordine pubblico». Cosa che lo metteva in forte concorrenza con
i Gap (Gruppi di azione patriottica) e getta una luce sinistra sul suo arresto e
la sua fucilazione alle fosse ardeatine. Ma non è un caso isolato. Anche Edgardo
Sogno, medaglia d'oro della Resistenza, contatto principale di Radio Londra tra
i resistenti italiani, è stato ostracizzato. Stessa sorte per Alfredo Pizzoni
che subito dopo l'8 settembre 1943, pur non appartenendo ad alcun partito
politico, fu scelto per presiedere il Cln lombardo, che nel febbraio 1944
divenne il ClnaI. Nei libri di storia non compare, troppo borghese. Finetti
rende giustizia a quei patrioti, come i militari che resistettero alla Wehrmacht
mentre per colpa del Re e di Badoglio il Paese finiva allo sbando, che sono
stati rimossi dalla memoria perché non omologabili. È revisionismo? O il
revisionismo di comodo è stato il precedente oblio?
Non erano tutti comunisti.
La Resistenza fuori dal mito.
Una lunga mistificazione, scrive Francesco Perfetti su "Il Giornale". Vent'anni
or sono, nel 1995, Renzo De Felice, dopo aver ricordato che la Resistenza era
stato «un grande evento storico» che nessun revisionismo sarebbe riuscito a
negare, richiamò l'attenzione sul fatto che i numeri di quanti avevano preso
parte attiva alla lotta partigiana erano ancora controversi. Ma, quali che ne
fossero le dimensioni, quel che sembrava certo allo studioso, era il fatto che,
al contrario di quanto si sosteneva generalmente, non era possibile «definire la
Resistenza un movimento popolare di massa» se non nelle settimane che
precedettero la resa dei tedeschi e la vittoria delle truppe alleate. Del resto
anche uno dei suoi principali protagonisti, il generale Raffaele Cadorna aveva
scritto nelle sue memorie che, al momento della liberazione, il numero dei
partigiani era cresciuto «a dismisura» e aveva aggiunto: «Un semplice fazzoletto
rosso al collo bastava a tramutare un pacifico operaio o un contadino in
partigiano persuaso di avere acquistato larghe benemerenze nella liberazione
della patria». L'amara verità è che la grande maggioranza degli italiani, ormai
stanca della guerra, aveva preferito evitare di schierarsi in maniera palese a
favore della Resistenza o della Repubblica sociale italiana. Il sentimento
collettivo era andato coagulandosi, non per opportunismo ma come scelta di «mera
necessità» e come «male minore», in una sorta di «zona grigia» costituita
essenzialmente da «quanti riuscirono a sopravvivere tra due fuochi, impossibile
da classificare socialmente, espressa trasversalmente da tutti i ceti, dalla
borghesia alla classe operaia». La tesi di De Felice sembrò dirompente perché
metteva in discussione non già la Resistenza in quanto tale ma piuttosto il suo
uso politico e ideologico, la sua strumentalizzazione. Quello dello storico era,
in realtà, un invito a rileggere e studiare la Resistenza al di fuori del «mito»
che ne era stato accreditato soprattutto ad opera dei comunisti. Questi ultimi
erano riusciti a far prevalere l'idea non solo di una grande rivolta popolare di
massa ma anche, e soprattutto, di un fenomeno unitario a guida comunista. Cosa
che non era affatto vera perché alla Resistenza, nelle sue varie fasi, presero
parte, oltre ai comunisti e agli azionisti con le brigate «Garibaldi» e
«Giustizia e Libertà», anche esponenti di altre forze politiche, dai cattolici
ai socialisti, dai liberali ai monarchici inquadrati in brigate e formazioni
autonome, talora in dissenso sulle scelte operative. Per non dire, infine, del
contributo alla lotta di liberazione da parte dei militari italiani del Corpo
italiano di Liberazione e di quell'altra e coraggiosa forma di resistenza
rappresentata dal rifiuto di collaborare con i tedeschi da parte dei soldati
internati nei campi di concentramento, gli Imi dei quali fece parte anche
Giovannino Guareschi. Alle origini del processo di mistificazione storica della
Resistenza c'era un preciso disegno portato avanti dal Partito comunista e, in
via subordinata, dal Partito d'azione, quello di accreditare che la Resistenza
fosse il vero e il solo evento rivoluzionario della storia dell'Italia unita. Il
che spiega, per inciso, il motivo per il quale le formazioni autonome, quelle
cioè che facevano riferimento a forze politiche diverse dal Pci o dal Pda,
fossero guardate con diffidenza se non addirittura con ostilità. Rientra, per
esempio, in questo quadro - e vi entra in maniera emblematica delle lotte
intestine all'interno del movimento partigiano - il caso dell'eccidio della
malga di Porzûs, dove un gruppo di partigiani della Brigata Osoppo di
orientamento cattolico e laico-socialista fu barbaramente liquidato da parte di
partigiani comunisti. Spiega, ancora, perché si dovesse glissare sul contributo
militare, importante ed anzi essenziale, degli Alleati alla liberazione del
Paese e perché si inventasse quella dubbia categoria interpretativa della
Resistenza come «secondo Risorgimento» giustamente criticata da un grande ed
equilibrato storico come Rosario Romeo. E spiega, infine, come, per molto tempo,
la storiografia ufficiale della Resistenza, quella che De Felice avrebbe
definito la vulgata, si fosse preoccupata non soltanto di minimizzare, di fatto
sottovalutandola, la partecipazione delle componenti non comuniste all'epopea
resistenziale. Quando, nel 1991, venne pubblicato il volume di Claudio Pavone
dal titolo Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza ,
sembrò che si aprisse una stagione completamente nuova rispetto, per esempio, al
classico libro, la Storia della Resistenza , che uno storico militante come
Roberto Battaglia aveva scritto, quasi a caldo e sotto la guida ispiratrice di
Luigi Longo, presentando, in chiave marxista, la Resistenza come una guerra di
popolo egemonizzata e guidata dai comunisti. La novità stava, in primo luogo,
nel recupero, in ambito storiografico, della nozione di «guerra civile» prima
sdegnosamente rifiutata e utilizzata solo nella polemica politica e in talune
ricostruzioni provenienti dall'ambiente neofascista. Adesso la «guerra civile»
non era più rifiutata, ma diventava un aspetto della Resistenza accanto ad altri
due, quelli di una «guerra patriottica» e di una «guerra di classe». Ma si
trattava di una novità apparente perché, al fondo del discorso, rimaneva in
piedi l'equazione che tendeva a collegare l'idea della Resistenza con l'idea di
una rivoluzione politica e sociale. Non è un caso che la ponderosa, e pur
importante, opera di Pavone liquidasse la vicenda di Porzûs in una nota e
sottovalutasse il contributo delle componenti non comuniste o azioniste della
Resistenza: come dimostra, per esempio, il fatto che le citazioni del nome di un
liberale come Edgardo Sogno si contino sulla punta delle dita. Il proposito
comunista di accreditare l'immagine di una Resistenza unitaria guidata dai
quadri dirigenti del partito comunista e farne il fondamento legittimante dello
Stato democratico post-fascista era funzionale al disegno di Palmiro Togliatti,
e dei suoi accoliti, di conquistare il potere attraverso l'affermazione della
«democrazia progressiva». Era un proposito di natura «pedagogica» e politica al
tempo stesso che si risolveva, però, in un vero e proprio «tradimento» della
Resistenza stessa e dei suoi valori. La storia della Resistenza raccontata dalla
vulgata comunista e azionista è contenuta in un libro ideale pieno di pagine
stracciate e cancellate che solo da poco tempo alcuni volenterosi ricercatori
stanno tentando di restaurare o ricostruire. È la storia di una «Resistenza
rossa» che si sarebbe affermata, come sostenne Luigi Longo durante le
celebrazioni del primo decennale, vincendo le opposizioni di cattolici e
liberali e di tutti quegli antifascisti che, troppo legalitari, ne boicottavano
il carattere di movimento popolare di massa e ne ostacolavano l'evoluzione in
senso classista. Ma è una storia falsa che ha avuto successo soltanto grazie
all'egemonia culturale gramsci-azionista che per molto tempo, per troppo tempo,
ha condizionato le menti degli intellettuali italiani. È ora di riscrivere la
storia vera della Resistenza, con le sue luci e le sue ombre, per assegnarle il
posto che, legittimamente, le spetta. Al di là e al di fuori del mito. E,
soprattutto, delle speculazioni politiche.
La guerra dei sette giorni
dei «repubblichini» traditi.
Dopo il 25 aprile del 1945, i tedeschi sacrificarono gli italiani per proteggere
la propria ritirata verso il Brennero. E per gli uomini della Rsi il conflitto
proseguì fino al 2 maggio, scrive Rino Cammilleri su "Il Giornale". Nel 70º
anniversario del «25 aprile» l'editore D'Ettoris ha pubblicato un libro che
mancava: Il gladio spezzato. 25 aprile-2 maggio 1945: guida all'ultima settimana
dell'esercito di Mussolini (pagg. 144, euro 14,90). L'autore, Andrea Rossi,
dottore di ricerca in Storia Militare, colma una lacuna. Sì, perché, come dice
Francesco Perfetti nella prefazione, permane «la convinzione che il 25 aprile
1945 siano cessate definitivamente le ostilità in Italia». Ma «il conflitto durò
ancora per una settimana provocando perdite fra militari e civili almeno fino al
2 maggio 1945. Questi sette giorni sono stati poco esplorati dalla
storiografia». Con una precisione da consumato studioso, Rossi ci informa nel
dettaglio su ciò che avvenne in quella settimana fatale. Che conobbe il caos, le
diserzioni, il «si-salvi-chi-può», i voltagabbana, ma anche pagine di autentico
valore e di lotta disperata. Già, perché fu subito chiaro, a chi voleva vederlo,
che «i tedeschi intendevano sacrificare gli italiani per proteggere la propria
ritirata verso il Brennero», cosa che fin dal febbraio 1945 era stata decisa in
una riunione a Parma dei vertici militari tedeschi. Del resto, che cosa questi
pensassero degli italiani era stato bene espresso in un giudizio del generale
Eugen Ott, ispettore della Wehrmacht per le divisioni della Rsi: «Conoscendo la
qualità militare e la mentalità dell'italiano \ non ci si può aspettare molto da
questa truppa». Così, i repubblichini furono praticamente lasciati a vedersela
con l'avanzata anglo-americana e i partigiani. E i fedeli del Duce sapevano bene
che questi ultimi non erano inclini a fare prigionieri. «Come bene aveva intuito
Renzo De Felice (e, a onor del vero, assai prima Beppe Fenoglio) nella sua opera
postuma e, purtroppo, incompleta, fu guerra civile “senza se e senza ma”, e il
solo fatto che se ne parli a quasi settanta anni di distanza accalorandosi come
se tali eventi fossero di attualità, dimostra a volumi - se ancora ce ne fosse
bisogno - che come tale essa è percepita ancora oggi da molti italiani».
Fenoglio nel 1949 aveva intitolato una sua prima raccolta di scritti Racconti
della guerra civile , ma l'editore Einaudi l'aveva modificato in Racconti
barbari . Il termine «guerra civile» dilagò solo dopo la pubblicazione, nel
1991, del libro di Claudio Pavone Una guerra civile (Bollati Boringhieri). In
quei giorni parossistici il destino dell'agonizzante repubblica fascista e delle
sue forze armate era l'ultimo dei pensieri non solo dei tedeschi, ma anche degli
Alleati, per i quali l'Italia rappresentava un teatro di guerra secondario nello
scacchiere europeo. Inoltre «i leader occidentali (Winston Churchill su tutti)
temevano una replica dell'amara esperienza greca, dove alla liberazione era
seguita una feroce guerra civile fra nazionalisti e comunisti nella quale le
truppe britanniche erano rimaste pesantemente coinvolte». La guerra era ormai
praticamente conclusa e l'evitare un insensato sacrificio di vite umane fu il
problema che occupò le lunghe trattative in Svizzera tra Karl Wolff,
plenipotenziario delle forze armate tedesche, e Allen Dulles, responsabile
dell'Oss (Office of strategic service), che negoziarono la resa tedesca in
Italia. Ma che fare dei prigionieri repubblichini? «Questi ultimi erano
considerati dagli Alleati alla stregua dei tedeschi, ossia reparti combattenti i
cui componenti ricadevano pienamente sotto la convenzione di Ginevra». Così non
la pensava Giovanni Messe, capo di stato maggiore del regio esercito, per il
quale, essendo l'Italia di Vittorio Emanuele III ufficialmente in guerra con la
Germania dall'ottobre 1943, i soldati di Salò erano colpevoli di tradimento per
aver collaborato in armi «con il tedesco invasore». E dire che il Messe era
stato a suo tempo decorato dai tedeschi con la croce di ferro di prima e seconda
classe e, per giunta, era l'unico Maresciallo d'Italia ad avere ottenuto
l'ambitissima Ritterkreuz che neanche Graziani, capo delle forze armate
repubblichine, aveva. Per quanto riguardava il Cln, questo aveva stabilito
l'instaurazione di tribunali straordinari che avrebbero dovuto giudicare i
«collaborazionisti». Il Cmrp (Comitato militare regione Piemonte), da parte sua,
decise di passare subito per le armi tutti coloro che avessero militato nelle
forze armate di Salò. Né i fascisti, d'altro canto, si comportavano in modo
granché diverso con i partigiani catturati. I marò repubblichini furono
abbandonati dal generale tedesco Eccard von Gablenz, che contrattò il ritiro dei
suoi uomini con i partigiani senza dirlo agli italiani. Questi, decimati
dall'aviazione alleata durante la fuga, il 26 aprile 1945 decisero di
sciogliersi. Tutti a casa (forse). Quelli di Brescia, responsabili di una
rappresaglia, nello stesso giorno «con poca accortezza» si consegnarono al Cln
di Lumezzane. Con il risultato che il loro comandante, tenente colonnello Mario
Zingarelli, e venticinque marò furono fucilati il 10 maggio. E così via.
Italiani contro italiani. Più guerra civile di così...
Ecco le memorie inedite dei
"repubblichini" di Salò.
I ragazzi di Salò erano spesso giovani che avevano perso tutto e mossi da ideali
patriottici. Ecco le loro testimonianze, scrive Roberto Chiarini su "Il
Giornale". Parafrasando Carl Schmitt, si potrebbe affermare che, se nello stato
di eccezione si costituisce una nuova legittimità, della legittimità in quello
stesso passaggio si definiscono anche i principi fondativi. Il nostro stato
d'eccezione è stata la Liberazione. Si fissarono allora i criteri ispiratori del
nuovo Stato. Il 28 aprile è il giorno in cui i partigiani passarono per le armi
l'artefice della dittatura, l'8 maggio quello in cui finì la guerra in Europa,
ma è il 25 aprile, giorno della sollevazione di Milano contro l'occupante
nazista e il collaborazionista fascista, che è stato assunto come data simbolo
della nuova Italia. La Repubblica, nata dalla Resistenza, ha fatto
dell'antifascismo lo statuto valoriale che ha tracciato il confine della
legittimità democratica. Ne è derivato che l'assolutizzazione della «giusta
causa» dei partigiani contro la «causa sbagliata» dei militi della Rsi abbia
portato ad assolutizzare uniformandole anche le ragioni della lotta ingaggiata
dai due campi nemici: delle avanguardie consapevoli al pari delle maggioranze
gregarie. Quel che vale per un giudizio storico-politico complessivo sulla
Liberazione, non è detto però valga anche come criterio nella considerazione
delle singole vicende personali. Non tutti i «ragazzi di Salò» furono volontari.
Non tutti furono fascisti irriducibili. Non tutti furono sanguinari, anche se
tutti si caricarono sulle spalle la responsabilità di sostenere la causa di
un'Italia e di un'Europa destinate a divenire baluardi di regimi totalitari e
razzisti. Del fascismo repubblicano disponiamo di una ricca letteratura fatta di
memoriali o di ricostruzioni redatte per lo più da gerarchi o da personaggi in
vista del regime, tutte ovviamente più o meno auto-assolutorie. Meno conosciuti
sono, invece, i percorsi esistenziali, morali, alla fine anche inesorabilmente
politici dei - chiamiamoli - «giovani qualunque», seppure essi costituissero la
gran massa di quanti vestirono la divisa saloina. Per quel che si è riusciti a
indagare, il mondo dei giovani dell'esercito di Salò risulta più variegato e
complesso di quanto sommari giudizi abbiano sinora lasciato intendere. Ecco due
casi a nostro giudizio istruttivi.
Umberto, un ragazzo di Padova
non ancora diciottenne, in una giornata di sole della primavera del 1944 va con
gli amici a giocare la sua solita partita al pallone. Torna a casa e scopre di
essere diventato orfano di entrambi i genitori e per giunta anche ridotto sul
lastrico. Non c'è più nemmeno la sua casa, colpa di un bombardamento. Non
sapendo a quale santo votarsi, non trova di meglio per campare che arruolarsi in
Marina, nelle file della X Mas. Viene dislocato in Friuli, dove nel corso di uno
scontro finisce prigioniero dei partigiani. Liberato dai suoi commilitoni, è
trasferito sul Senio, nei pressi di Castel Sampietro. Qui è impiegato in
rischiose azioni sulla linea del fronte. Ferito nel corso di un bombardamento,
dopo un trasferimento avventuroso, è ricoverato prima nell'ospedale di Argenta,
poi in quello di Verona. Le sue condizioni peggiorano per le molteplici, gravi
ferite riportate. È salvato in extremis da un ufficiale medico tedesco che gli
asporta decine di schegge. Non ha ancora finito la convalescenza che si vede
costretto a fuggire dall'ospedale per non finire nelle mani dei partigiani ormai
alle porte di Verona. È a Padova, a casa di una zia dove si sta curando le
ferite, quando viene sorpreso dal 25 aprile. Fugge. Tenta inutilmente di
rifugiarsi in Francia. Ripiega allora su Bardonecchia. Qui riesce a sopravvivere
e soprattutto ad occultare il suo passato da repubblichino facendo il garzone da
un fornaio comprensivo. Sospettato di nascondere un passato da milite della Rsi,
alla fine del 1945 lascia Bardonecchia per Padova, dove riesce ad arruolarsi
nella Guardia di Finanza. Conduce poi una vita nell'ombra, ben guardandosi da
compiere atti che facciano riesumare il suo passato compromettente. È la figlia
a metterlo nei guai sposando - parole sue - «un comunista» che non manca di
riaprire la ferita. Ma il colpo più duro lo riceve allorché l'adorata nipotina,
di ritorno dalla scuola, lo apostrofa corrucciata: «Ma tu nonno è vero che sei
un massacratore di partigiani?». L'anziano «ragazzo di Salò» scoppia in un
pianto sconsolato. Prende allora la decisione di registrare a futura memoria la
sua esperienza di combattente della Rsi. Scopo - confessa - lasciare
testimonianza perché un giorno la nipotina, divenuta adulta, possa rendersi
conto che suo nonno non si è macchiato di delitti né di azioni infamanti.
Tre amici ricevono la chiamata
alle armi dall'esercito di Salò. Hanno tutti un'educazione fascista ma nessuno è
un ardente mussoliniano. Pur senza entusiasmi, accettano di arruolarsi. Uno,
Vaifro, finisce sul fronte orientale dove troverà la morte. Gli altri due,
Amilcare e Lucio, sono inviati sul fronte occidentale, in Liguria, in due unità
diverse. In occasione di una licenza, Lucio riceve dalla madre del commilitone
una lettera e un pacco da consegnare all'amico. Al suo rientro, si presenta alla
caserma di Amilcare ma, non appena fa il suo nome, suscita allarme: viene a
sapere che ha disertato unendosi a una formazione partigiana. Temendo che nella
lettera siano presenti indicazioni compromettenti, Lucio decide di consegnare ai
superiori solo il pacco. L'amico finirà comunque catturato, torturato e ucciso.
Lucio invece finisce la guerra sempre sotto le insegne della Rsi. A fine guerra,
tornando al paese teme di finire oggetto di una qualche attenzione non benevola
da parte dei partigiani del posto. Non gli succede invece nulla di tutto questo.
La madre di Amilcare, sorella del sindaco socialista insediatosi dopo la
Liberazione, lo mette sotto la sua protezione. Mostra in tal modo la sua
riconoscenza per il gesto con cui Lucio, tenendo per sé la lettera a suo tempo
consegnatagli, aveva coperto la fuga dell'amico. Da allora fino alla morte,
avvenuta qualche anno fa, Lucio non manca mai di onorare ogni anno nel giorno
dei morti con una corona di fiori la memoria dei suoi due amici, Vaifro e
Amilcare, l'uno repubblichino, l'altro partigiano.
Albero della Vita in piazza
Loreto, ma l'Anpi: "Offusca ricordo dei partigiani".
Secondo il comune, la torre simbolo di Expo potrebbe finire in piazzale Loreto,
"per cancellare un momento storico controverso". I partigiani insorgono:
"Confonderebbe le idee", scrive Ivan Francese su "Il Giornale". Ha sempre diviso
e continua a dividere gli animi dei milanesi e degli italiani, piazzale Loreto.
Prima teatro della barbara esposizione dei cadaveri di quindici partigiani,
fucilati nell'agosto 1944 dalle forze della Repubblica di Salò e quindi lasciati
esposti al pubblico ludibrio; poi, nell'aprile 1945, testimone dell'altrettanto
barbara esposizione dei cadaveri di Mussolini, Claretta Petacci e altri
gerarchi, in quella che lo stesso comandante partigiano Ferruccio Parri definì
un'oscena "macelleria messicana". Da novembre piazzale Loreto potrebbe ospitare
l'ormai celeberrimo "Albero della Vita" progettato per diventare il simbolo di
Expo. La torre di 35 metri di Marco Balich potrebbe venire trasferita nella
piazza alla fine di corso Buenos Aires su proposta dell'assessore al Verde
Chiara Bisconti. "Per cancellare un momento storico controverso con un inno alla
vita", spiega la Bisconti. Una proposta che ha subìto scatenato le ire dei
partigiani: "Sarebbe una nota stonata che creerebbe solo confusione - protesta
il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati - Il simbolo di piazzale Loreto
c'è già ed è il monumento che ricorda i 15 partigiani, che da tempo chiediamo
che venga restaurato. L'installazione di Basich resti sul sito di Expo". Più
favorevole, invece, il centrodestra. Non si oppone, ad esempio, l'ex vicesindaco
Riccardo De Corato, che però avverte: "Prima dovremmo mettere anche una targa
che ricordi che qui è stato appeso Mussolini".
Veneziani: il 25 aprile
nega dignità anche a chi ha dato la vita per la patria,
scrive Antonella Ambrosioni su “Il Secolo D’Italia”. “Non celebriamo il 25
aprile perché
non è una festa
”. È stato chiaro, ultimativo,
Marcello Veneziani,
giornalista e scrittore, autore di saggi storici e filosofici, fresco di nomina
come direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Il 25 aprile non
è una festa perché rimane una celebrazione
divisiva
e mai concepita all’insegna della
veritas e della
pietas,
sostiene il neo direttore.
Veneziani, lei ha
parlato di una festa divisiva e di una festa “contro”. Parole quanto mai
opportune ascoltando le esternazioni colme di rinata retorica resistenziale e
antifascista del presidente della Camera prima, del Capo dello Stato poi, non
trova?
«Sì,
il 25 aprile non è mai stata una festa inclusiva e nazionale, ma è sempre stata
la festa delle bandiere rosse, che rappresentano legittimamente una parte degli
italiani, ma solo una parte, non sono l’Italia. È una festa nata contro “gli
italiani del giorno prima”, ovvero non considerava che gli italiani fino ad
allora non erano stati certo antifascisti. Non è un festa di tutti gli italiani,
perché non rende onore al nemico, anzi nega dignità e memoria a tutti costoro,
anche a chi ha dato la vita per la patria, solo per la patria, pur sapendo che
si trattava di una guerra perduta. Oggi c’è una rinnovata enfasi corale per un
evento che più si allontana nel tempo, più è lontano dalla sensibilità della
gente e più viene imposto mediaticamente. Per cui mi sono convinto che sia
necessario ridiscutere il valore di questa festa così come viene concepita».
Lei sostiene che nella
retorica di parte il 25 aprile “oscura” persino la Grande Guerra: come è
possibile?
«Facendo
parte del Comitato degli anniversari di Palazzo Chigi, ho potuto notare proprio
questo paradosso: mentre alcune ricorrenze, come il centenario della Grande
Guerra, sono ricordate solo negli aspetti tragici, catastrofici, con il carico
di dolore, sacrifici e morte, sul settantesimo del 25 Aprile prevale
esclusivamente l’aspetto celebrativo, senza mai ricordare le pagine nere,
sporche, sanguinose che l’hanno accompagnata. Negli ultimi tempi è poi è
cresciuta l’ enfasi per i 70 anni della Liberazione parallelamente a una minore
attenzione per i 100 anni della Prima Guerra mondiale. Anzi, per la Grande
Guerra si è deciso solo di restaurare monumenti, per il 25 aprile vi sono
celebrazioni ovunque. Prima considerazione: scusate, il centenario è una data
più importante, una data “tonda”, non la celebriamo mai; mentre il 25 aprile
viene celebrato ogni anno, è l’unica festa civile del nostro Paese, oltre alla
Festa del Lavoro, quindi non è certo una festa trascurata; e oltretutto è
irrituale celebrare i Settantesimi. Chiedevo, pertanto, nient’altro che
l’equiparazione dei giudizi storici, esaminare i due eventi dal punto di vista
storico e non celebrativo, mettendo in luce anche i punti critici della
Resistenza».
Le parole del Capo
dello Stato non aiutano certo a ricomporre la memoria storica quando ancora una
volta ristabiliscono una gerarchia tra giovani di Salò e partigiani: pietà per i
morti – ammette – ma i primi stavano dalla parte sbagliata, i secondi da quella
giusta. Parole che segnano un passo indietro rispetto al processo di
riconciliazione avviato da Luciano Violante quando parlò della necessità di
comprendere le ragioni dei ragazzi e delle ragazze che scelsero la Rsi.
Giampaolo Pansa su “Libero
Quotidiano”: tutte le falsità sulla Resistenza. "Gli anniversari
dovrebbero essere aboliti. Soprattutto quando celebrano un evento politico che
si presta a una giostra di opinioni non condivise. Accade così per il
settantesimo del 25 aprile 1945, la festa della Liberazione. Una cerimonia che
suscita ancora contrasti, giudizi incattiviti e tanta retorica. A volte un mare
di retorica, uno tsunami strapieno anche di bugie e di omissioni dettate
dall'opportunismo politico. Per rendersene conto basta sfogliare i quotidiani e
i settimanali di questa fine di aprile. È da decenni che studio e scrivo della
nostra guerra civile. Ma non avevo mai visto il serraglio di oggi. Una fiera
dove tutto si confonde. Dove imperano le menzogne, le reticenze, le
pagliacciate, le caricature. È vero che siamo una nazione in declino e che ha
perso la dignità di se stessa. Però il troppo è troppo. Per non essere soffocato
dalla cianfrusaglia, adesso proverò a rammentare qualche verità impossibile da
scordare. La prima è che la guerra civile conclusa nel 1945, ma con molte code
sanguinose sino al 1948, fu un conflitto fra due minoranze. Erano pochi i
giovani che scelsero di fare i partigiani e i giovani che decisero di combattere
l'ultima battaglia di Mussolini. Il «popolo in lotta» tanto vantato da Luigi
Longo, leader delle Garibaldi, non è mai esistito. A perdere furono i ragazzi di
Salò, i figli dell'Aquila repubblicana. Ma a vincere non furono quelli che
avevano preso la strada opposta. L'Italia non venne liberata da loro. Se il
fascismo fu sconfitto lo dobbiamo ad altri giovani che non sapevano quasi nulla
di un Paese che dal 1922 aveva obbedito al Duce e l'aveva seguito in una guerra
sbagliata, combattuta su troppi fronti. La vittoria e la libertà ci vennero
donate dalle migliaia di ragazzi americani, inglesi, francesi, canadesi,
australiani, brasiliani, neozelandesi, persino indiani, caduti sul fronte
italiano. E dai militari della Brigata Ebraica, che oggi una sinistra ottusa
vorrebbe escludere dalla festa del 25 aprile. Gli stranieri e gli italiani si
trovarono alle prese con una guerra civile segnata da una ferocia senza limiti.
Qualcuno ha scritto che la guerra civile è una malattia mentale che obbliga a
combattere contro se stessi. E svela l'animo bestiale degli esseri umani. Tutti
gli attori di quella tragedia potevano cadere in un abisso infernale. Molti lo
hanno evitato. Molti no. Eccidi, torture, violenze indicibili non sono stati
compiuti soltanto dai nazisti e dai fascisti. Anche i partigiani si sono
rivelati diavoli in terra. In un libro di memorie scritto da un comandante
garibaldino e pubblicato dall' Istituto per la storia della Resistenza di
Vercelli, ho trovato la descrizione di un delitto da film horror. Una banda
comunista, stanziata in Valsesia, aveva catturato due ragazze fasciste, forse
ausiliarie. E le giustiziò infilando nella loro vagina due bombe a mano, poi
fatte esplodere. La ferocia insita nell' animo umano era accentuata dalla
faziosità ideologica. La grande maggioranza delle bande partigiane apparteneva
alle Garibaldi, la struttura creata dal Pci e comandata da Longo e da Pietro
Secchia. È una verità consolidata che tra le opzioni del partito di Palmiro
Togliatti ci fosse anche quella della svolta rivoluzionaria. Dopo la Liberazione
sarebbe iniziata un' altra guerra. Con l' obiettivo di fare dell' Italia l'
Ungheria del Mediterraneo, un Paese satellite dell' Unione Sovietica. I
comunisti potevano essere più carogne dei fascisti e dei nazisti? No, perché chi
imbraccia un' arma per affermare un progetto totalitario, nero o rosso che sia,
è sempre pronto a tutto. Ma esiste un fatto difficile da smentire: le stragi
interne alla Resistenza, partigiani che uccidono altri partigiani, sono tutte
opera di mandanti ed esecutori legati al Pci. La strage più nota è quella di
Porzûs, sul confine orientale, a 18 chilometri da Udine. Nel pomeriggio del 7
febbraio 1945, un centinaio di garibaldini assalgono il comando della Osoppo,
una formazione di militari, cattolici, monarchici, uomini legati al Partito d'
Azione e ragazzi apolitici. Quattro partigiani e una ragazza vengono soppressi
subito. Altri sedici sono catturati e tutti, tranne due che passano con la
Garibaldi, saranno ammazzati dall' 8 al 14 febbraio. Un assassinio al
rallentatore che diventa una forma di tortura. In totale, 19 vittime. La strage
ha un responsabile: Mario Toffanin, detto "Giacca", 32 anni, già operaio nei
cantieri navali di Monfalcone, un guerrigliero brutale e un comunista di marmo.
Ha due idoli: Stalin e il maresciallo Tito. Considera la guerriglia spietata il
primo passo della rivoluzione proletaria. Ma l' assalto e la strage gli erano
stati suggeriti da un dirigente della Federazione del Pci di Udine. Di lui si
conosce il nome e l'estremismo da ultrà che gioca con le vite degli altri. È
quasi inutile rievocare le imprese di Franco Moranino, "Gemisto", il ras
comunista del Biellese. Un sanguinario che arrivò a uccidere i membri di una
missione alleata. E poi fece sopprimere le mogli di due di loro, poiché
sospettavano che i mariti non fossero mai giunti in Svizzera, come sosteneva
"Gemisto". Il Pci di Togliatti difese sempre Moranino e lo portò per due volte a
Montecitorio e una al Senato. Anche lui come "Giacca" morì nel suo letto. Tra le
imprese criminali dei partigiani rossi è famoso il campo di concentramento di
Bogli, una frazione di Ottone, in provincia di Piacenza, a mille metri di
altezza sull' Appennino. Dipendeva dal comando della Sesta Zona ligure ed era
stato affidato a un garibaldino che oggi definiremmo un serial killer. Tra l'
estate e l' autunno del 1944 qui vennero torturati e uccisi molti prigionieri
fascisti. Le donne venivano stuprate e poi ammazzate. Soltanto qualcuno sfuggì
alla morte e dopo la fine della guerra raccontò i sadismi sofferti. A volte
erano dirigenti rossi di prima fila a decidere delitti eccellenti. Le vittime
avevano comandato formazioni garibaldine, ma si rifiutavano di obbedire ai
commissari politici comunisti. Di solito questi crimini venivano mascherati da
eventi banali o da episodi di guerriglia. Uno di questi comandanti, Franco
Anselmi, "Marco", il pioniere della Resistenza sull' Appennino tortonese, dopo
una serie di traversie dovute ai contrasti con esponenti del Pci, fu costretto
ad andarsene nell' Oltrepò pavese. Morì l' ultimo giorno di guerra, il 26 aprile
1945, a Casteggio per una raffica sparata non si seppe mai da chi. Negli anni
Sessanta, andai a lavorare al Giorno, diretto da Italo Pietra che era stato il
comandante partigiano dell' Oltrepò. Sapeva tutto del Pci combattente, della sua
doppiezza, dei suoi misteri. Quando gli chiesi della fine di Anselmi, mi regalò
un' occhiata ironica. E disse: «Vuoi un consiglio? Non domandarti nulla. Anselmi
è morto da vent' anni. Lasciamolo riposare in pace». Un' altra fine carica di
mistero fu quella di Aldo Gastaldi, "Bisagno", il numero uno dei partigiani in
Liguria. Era stato uno dei primi a darsi alla macchia nell' ottobre 1943, a 22
anni. Cattolico, sembrava un ragazzo dell' oratorio con il mitragliatore a
tracolla, coraggioso e altruista. Divenne il comandante della III Divisione
Garibaldi Cichero, la più forte nella regione. Era sempre guardato a vista dalla
rete dei commissari comunisti della sua zona. Nel febbraio 1945, il Pci cercò di
togliergli il comando della Cichero, ma non ci riuscì. Alla fine di marzo
Bisagno chiese al comando generale del Corpo volontari della libertà di abolire
la figura del commissario politico. E quando Genova venne liberata, cercò di
opporsi alle mattanze indiscriminate dei fascisti. Non trascorse neppure un mese
e il 21 maggio 1945 Bisagno morì in un incidente stradale dai tanti lati oscuri.
In settembre avrebbe compiuto 24 anni. Ancora oggi a Genova molti ritengono che
sia stato vittima di un delitto. Sulla sua fine esiste una sola certezza. Con
lui spariva l'unico comandante partigiano in grado di fermare in Liguria
un'insurrezione comunista diretta a conquistare il potere. Scommetto mille euro
che nessuno dei due verrà ricordato nelle cerimonie previste un po' dovunque. Al
loro posto si farà un gran parlare delle cosiddette Repubbliche partigiane.
Erano territori conquistati per un tempo breve dai partigiani e presto perduti
sotto l' offensiva dei tedeschi. Le più note sono quelle di Montefiorino, dell'
Ossola e di Alba.
Nel 1944, Montefiorino, in
provincia di Modena, contava novemila abitanti. Con i quattro comuni confinanti
si arrivava a trentamila persone. L' area venne abbandonata dai tedeschi e i
partigiani delle Garibaldi vi entrarono il 17 giugno. La repubblica durò sino al
31 luglio, appena 45 giorni. Fu un trionfo di bandiere rosse, con decine di
scritte murali che inneggiavano a Stalin e all' Unione Sovietica. Vi dominava
l'indisciplina più totale. Al vertice c' era il Commissariato politico, composto
soltanto da comunisti. Il caos ebbe anche un lato oscuro: le carceri per i
fascisti, le torture, le esecuzioni di militari repubblicani e di civili. Ma
nessuno si preoccupava di difendere la repubblica. Infatti i tedeschi la
riconquistarono con facilità. La repubblica dell'Ossola nacque e morì nel giro
di 33 giorni, fra il settembre e l'ottobre del 1944. Era una zona bianca,
presidiata da partigiani autonomi o cattolici. E incontrò subito l' ostilità
delle formazioni rosse. Cino Moscatelli, il più famoso dei comandanti comunisti,
scrisse beffardo: «A Domodossola c' è un sacco di brava gente appena arrivata
dalla Svizzera che ora vuole creare per forza un governino pur di essere loro
stessi dei ministrini». La repubblica di Alba venne descritta così dal grande
Beppe Fenoglio, partigiano autonomo: «Alba la presero in duemila il 10 ottobre e
la persero in duecento il 2 novembre 1944». Durata dell'esperimento: 23 giorni,
conclusi da una fuga generale. Sentiamo ancora Fenoglio: «Fu la più selvaggia
parata della storia moderna: soltanto di divise ce n'era per cento carnevali.
Fece impressione quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme di
gala di colonnello d'artiglieria, con intorno alla vita il cinturone rossonero
dei pompieri...». In realtà la guerra civile fu di sangue e di fuoco. Con
migliaia di morti da una parte e dall'altra. Dopo il 25 aprile ebbe inizio
un'altra epoca altrettanto feroce. L'ho descritta nel libro che mi rende più
orgoglioso fra i tanti che ho pubblicato: Il sangue dei vinti. Stampato da un
editore senza paura: la Sperling e Kupfer di Tiziano Barbieri. Un buon lavoro
professionale. Dal 2003 a oggi, nessuna smentita, nessuna querela, ventimila
lettere di consenso, una diffusione record. Ma le tante sinistre andarono in
tilt. E diedero fuori di matto. Più lettori conquistavo, più venivo linciato
sulla carta stampata, alla radio, in tivù. Mi piace ricordare l' accusa più
ridicola: l' aver scritto quel libro per compiacere Silvio Berlusconi e ottenere
dal Cavaliere la direzione del Corriere della Sera. Potrei mettere insieme un
altro libro per raccontare quello che mi successe. Qui preferisco ricordare i
più accaniti tra i miei detrattori: Giorgio Bocca, Sandro Curzi, Angelo d'Orsi,
Sergio Luzzatto, Giovanni De Luna, Furio Colombo, qualche firma dell'Unità,
varie eccellenze dell' Anpi, del Pci e di Rifondazione comunista. Tutti erano
mossi dalle ragioni più diverse. Se ci ripenso sorrido. La meno grottesca
riguarda l' ambiente legato al vecchio Pci. Dopo la caduta del Muro di Berlino e
la svolta di Achille Occhetto nel 1989, gli restava poco da mordere. Si sono
aggrappati alla Resistenza. E hanno inventato uno slogan. Dice: la Resistenza è
stata comunista, dunque chi offende il Pci offende la Resistenza. Oppure: chi
offende la Resistenza offende il Pci e gli eredi delle Botteghe oscure. Ecco
un'altra delle menzogne spacciate ogni 25 aprile. Insieme alla bugia delle
bugie, quella che dice: le grandi città dell' Italia del nord insorsero contro i
tedeschi e li sconfissero anche nell' ultima battaglia. Non è vero. La Wehrmacht
se ne andò da sola, tentando di arrivare in Germania. In casa nostra non ci fu
nessuna Varsavia, la capitale polacca che si ribellò a Hitler tra l'agosto e il
settembre 1944. E divenne un cumulo di macerie. In Italia le uniche macerie
furono quelle causate dai bombardamenti degli aerei alleati. Che cosa resta di
tutto questo?
Di certo il rispetto per i
caduti su entrambe le parti. Ma anche qualcos'altro. Quando viaggio in auto per
l' Italia, rimango sempre stupito dalla solitaria immensità del paesaggio. Anche
nel 2015 presenta grandi spazi vuoti, territori intatti, mai violati dal
cemento. È allora che ripenso ai pochi partigiani veri e ai figli dell' Aquila
fascista. E mi domando se avrei avuto il loro stesso coraggio se fossi stato un
giovane di vent'anni e non un bambino. Si gettavano alle spalle tutto, la
famiglia, gli studi, l'amore di una ragazza, per entrare in un mondo alieno,
feroce e sconosciuto. Erano formiche senza paura e pronte a morire. L'Italia di
oggi merita ancora quei figli, rossi, neri, bianchi? Ritengo di no. Giampaolo
Pansa".
Pansa: «La Boldrini dovrebbe andare al
doposcuola. Non conosce la storia», scrive Aldo Di Lello su “Il Secolo
D’Italia”. «La
Boldrini?
Dovrebbe andare a ripetizione di storia». Non fa sconti,
Giampaolo
Pansa, alla
terza carica dello Stato dopo
Bella ciao
cantata nell’Aula della Camera e dopo gli interventi sul 25 aprile che hanno
riproposto i temi della vecchia vulgata resistenziale della Prima repubblica. In
questi giorni di retorica d’annata, l’autore de
Il sangue dei vinti
è intervenuto su
Libero (23
aprile) per ricordare alcune verità scomode sulla Resistenza.
Allora Pansa, non
ritieni che il clima di questo settantesimo anniversario del 25 aprile sia
caratterizzato da un sorta di passo indietro rispetto alle aperture e alle
ammissioni di qualche anno fa? Penso a Mattarella, che non vuol sentir parlare
di “ragioni” dei “ragazzi di Salò”, a differenza di quanto a suo tempo affermò
Luciano Violante e di quanto, più recentemente, ha ammesso Napolitano. Penso
soprattutto alla Boldrini, che giorni fa, in televisione, è arrivata a
negare l’esistenza di una guerra civile. Per la presidente della Camera
bisognerebbe solo parlare di «lotta di liberazione». Un vero e proprio ritorno
al passato. Non ti pare?
«Non
voglio polemizzate con Mattarella: è una persona che stimo. È il Capo dello
Stato e mi rappresenta. Della Boldrini penso invece che dovrebbe essere mandata
al doposcuola, perché dimostra di non conoscere la storia italiana. Non
può parlare in quel modo. L’estrema semplificazione della sua non conoscenza c’è
stata quando ha fatto intonare
Bella ciao
alla Camera: non è mai stata una canzone partigiana. I partigiani cantavano
Fischia il vento. Ha
fatto uno spettacolo da teatrino dell’oratorio rosso».
Che differenza noti
tra il tempo in cui uscì
Il sangue dei vinti
e oggi?
«Il
sangue dei vinti uscì nel 2003
ed ebbe subito un successo pazzesco. Dopo pochi mesi aveva già venduto
duecentomila copie. E l’interesse è continuato negli anni successivi, fino alla
vendita di un milione di volumi. Fui bersagliato in tutti i modi. Me ne dissero
di tutti i colori. E si trattava spesso di accuse ridicole e grottesche. Ci fu
anche chi, ad esempio, disse che volevo fare un regalo a Berlusconi per farmi
nominare direttore del
Corriere della Sera.
Non c’è dubbio che era un’Italia faziosa. Oggi abbiamo una faziosità nascosta,
che non si esprime. Siamo alle prese con una crisi economica che, nonostante
quello che dice Renzi, non è affatto risolta. E poi c’è l’enorme dramma delle
migrazioni e degli sbarchi. L’Italia è come un malato che non si è ancora alzato
dal letto per la paura di muoversi. Rispetto ad allora, l’Italia è più
addormentata. Ed è su questa Italia che si è abbattuto lo tsunami di
retorica per il settantesimo anniversario del 25 aprile».
Non ritieni che, in
questa Italia addormentata, il conformismo attecchisca più facilmente?
«Ti
rispondo con un esempio tratto dai miei ricordi d’infanzia. A quel tempo, avrò
avuto otto o nove anni, i miei genitori mi facevano preparare il “prete”. Sai
che cos’è?»
NON APRITE QUELL’AZIENDA.
PER ESEMPIO UNA CASA EDITRICE. LA BUROCRAZIA VI UCCIDERA’.
Non aprite quella casa
(editrice). Se no la burocrazia vi ucciderà. Tasse, regole complicatissime,
distribuzione bloccata e lungaggini Lanciarsi nel mercato editoriale è
un'impresa titanica. Parola di esperto, scrive Gianluca Barbera su “Il
Giornale”. Volete aprire una casa editrice? Vi hanno detto che oggi fare impresa
è più facile? Avete prestato fede alle promesse di Renzi di ridurre la
burocrazia e le tasse? Alle parole di Monti quando assicurava che i giovani
avrebbero potuto costituire una società con un euro? Se avete creduto a tutto
questo avete vinto il Premio Babbeo dell'Anno. La verità è che chi vuole fondare
una casa editrice deve affrontare non solo un surplus di burocrazia e costi, ma
anche rischiare di finire in un reparto di Neuropsichiatria. Partirò da un
indovinello. Giovanni, Marco e Paola vogliono aprire una casa editrice. Su
suggerimento del commercialista (figura immancabile della contemporaneità, come
il prete nell'Ottocento) optano per una società a responsabilità limitata,
10mila euro di capitale sociale (il minimo consentito). Dopo aver depositato in
banca i tre decimi del capitale previsti dalla legge, si recano dal notaio,
firmano l'atto costitutivo e, dopo aver pagato l'onorario (non meno di 1800
euro), si sentono dire: «C'è però un piccolo problema. Per ottenere la partita
Iva e l'iscrizione alla Camera di Commercio, come la legge impone, bisogna
disporre di una PEC (casella di posta certificata). Ma per ottenere una PEC
occorre avere già la partiva Iva». I tre si scambiano un'occhiata fra
l'incredulo e il divertito. «Ci sta dicendo che per ottenere la partita Iva
dobbiamo avere la PEC e per ottenere la PEC dobbiamo avere la partita Iva?».
«Proprio così» risponde il notaio allargando le braccia. «E allora come si fa?»
domandano allibiti. Inizia un balletto di telefonate: il notaio parla col
commercialista, il commercialista coi tre aspiranti editori, questi con una
società che fornisce PEC, ma non se ne viene a capo. I ragazzi perdono la
pazienza: «Non saremo certo i primi! Come fanno gli altri?». Dopo un attimo di
esitazione: «Purtroppo sono le nuove disposizioni di legge, e una soluzione non
c'è... Ognuno trova il modo di arrangiarsi come può... Basta individuare
l'anello debole della catena e trovare una scappatoia». E ora, che fare? Come
sapete, con un po' di buona volontà in Italia una soluzione si trova sempre.
Lascio al lettore scovare la soluzione. Ma questo, ovviamente, non è che il
principio. Perché un istante dopo il notaio aggiunge che, PEC o non PEC, senza
il supporto di un commercialista non può inoltrare richiesta di partita Iva. E
infine ricorda loro che devono saldare con un assegno perché il pagamento deve
essere tracciabile e dunque serve un conto in banca. Riassumiamo: notaio,
commercialista, banca. Restano solo il geometra e l'avvocato e poi non manca
nessuno. Ma il peggio deve venire. Il giorno dopo, col morale sotto i tacchi, i
tre si recano dal commercialista, che presenta subito il conto: 355 euro per
l'iscrizione nel registro delle imprese, 1.480 per la comunicazione d'inizio
attività alla Camera di commercio, 395,17 per la vidimazione dei libri sociali,
115,80 per la famosa PEC, un importo variabile per l'iscrizione all'Inps. E
naturalmente c'è l'onorario del commercialista di cui tenere conto. I ragazzi
mettono mano al portafogli e a fine giornata si rendono conto che, prima ancora
di aver cominciato a lavorare e a produrre qualcosa, il capitale sociale si è
già quasi dimezzato. E non è finita. C'è da farsi assegnare il codice Isbn
(quello che trovate sul retro di copertina dei libri), indispensabile per
commercializzare le loro pubblicazioni: costo dell'operazione 292,80 euro. C'è
poi da registrare il marchio: altri 245 euro, oltre alla pazienza di cui ci si
deve armare per far fronte all'indolenza e ignavia dei funzionari dell'ufficio
marchi e brevetti, distaccato presso la Camera di commercio. E poi c'è la banca
presso la quale vi recherete per aprire il conto: vi farà cascare dall'alto ogni
cosa, vi chiederà di sottoscrivere un documento chiamato «antiriciclaggio» di
cui nessuno pare capire l'utilità (se riciclate denaro, non sarete così stupidi
da dichiararlo). Dovrete rispondere a un fuoco di fila di domande ed esibire una
quantità di documenti di cui sul momento non disporrete e per ottenere i quali
dovrete rivolgervi nuovamente al notaio e al commercialista. E poi naturalmente
la società andrà censita e se volete operare con l'home banking bisognerà fare
richiesta di un codice operativo. Altro tempo, altri costi. Se per di più avete
fatto domanda per un piccolo fido, vi aspettano decine di firme da apporre. E
guardatevi bene dal cambiare la sede sociale: sarebbero altri 380 euro alla
Camera di commercio. Ma ora finalmente si parte, direte voi. Certo. Ma tenete
presente che il proprietario dell'ufficio che avrete affittato vi chiederà una
lauta caparra più il primo mese o trimestre anticipato. E ve la dovrete vedere
coi tempi della Telecom per l'allaccio delle linee telefoniche e dell'Adsl, con
la società elettrica, con quella del gas, con le loro arzigogolate procedure di
attivazione, con le ore di attesa quando vi rivolgerete ai loro numeri verdi.
Imparerete a convivere con adempimenti burocratici pressoché quotidiani, in un
quadro normativo che cambia ogni anno in peggio, con una sfilza di tasse da far
accapponare la pelle: Iva, Ires, Irap, Tari, Tasi o Tares o Tirsu o Trise (o
come diavolo si chiama), ritenute d'acconto, acconti su imposte future,
contributi previdenziali, tasse camerali, tasse annuali sui libri sociali, costi
per la frequenza obbligatoria a corsi di primo soccorso e sicurezza sul lavoro
(e relativi aggiornamenti periodici). E poi il famigerato Entratel, il modello
770, il redditometro, lo spesometro, la nuova Certificazione Unica (centinaia di
pagine da stampare e spedire in triplice copia, alla faccia
dell'informatizzazione e delle campagne per il risparmio della carta). E ancora
la tenuta del libro dei verbali, il registro delle tirature, il foglio delle
presenze, il libro matricola, il Dps (documento programmatico per la sicurezza),
quello della valutazione dei rischi, la redazione del bilancio annuale coi suoi
rovelli interpretativi, la compilazione degli studi di settore, la fattura
elettronica per chi lavora con enti pubblici (te le fa il commercialista,
ovviamente non gratis), la dichiarazione dei redditi. Per non parlare dei folli
interessi bancari sui fidi... E non abbiamo ancora fatto cenno al fatto che vi
servirà un buon distributore, altrimenti i libri come ci arrivano in libreria? E
questo è l'ostacolo degli ostacoli. Anche perché è in atto una rivoluzione. Si
sta passando da una situazione di relativa concorrenza a una di quasi monopolio.
Il tutto con l'avallo dell'Antitrust, che ha autorizzato la fusione tra il
gruppo Messaggerie Libri e Feltrinelli (socio unico di Pde, l'altro distributore
storico), assai più nefasta per il pluralismo editoriale del paventato
matrimonio tra Mondadori e Rizzoli. Grazie a una sentenza dell'Antitrust del
dicembre 2014, per trovarsi un distributore tutto si è fatto più complicato.
Dovrete presentare una mole di documentazione prima non necessaria. Vi verrà
richiesto di esibire documenti attestanti la solidità finanziaria della vostra
azienda: in soldoni, si tratterà di dimostrare di non avere gli ultimi due
bilanci in perdita (ma se sei nuovo come fai a esibire gli ultimi due bilanci?)
e di non essere gravato da protesti. Dovrete dimostrare inoltre di possedere una
solida rete di promozione. Ma fermiamoci qui, per carità, benché ci sarebbe
altro da aggiungere. Anche perché a questo punto i nostri baldi giovani sono
invecchiati perlomeno di cinquant'anni, se non all'anagrafe perlomeno nello
spirito. Ma in fondo sono stati fortunati. A semplificargli le cose ci ha
pensato Renzi. Altrimenti, sai che dolori!
VUOI CANTARE? IL CONCORSO
E' TRUCCATO.
Brogli a Sanremo, parte la
denuncia.
Michelangelo Giordano,
cantautore 36enne calabrese approdato a Milano in cerca di gloria, si è
ritrovato con una lettera di esclusione in mano, scrive Martino Villosio su “Il
Tempo”. L'appuntamento è per il 13 aprile 2015, tribunale civile di Imperia. È
lì che andrà in scena la prima "puntata" di un dopo Festival al vetriolo. Una
querelle diversa da quelle costruite ogni anno per insapidire le tradizionali
settimane sanremesi, perché stavolta di mezzo c'è una causa per danni, e le
accuse - la cui eventuale fondatezza toccherà ai giudici riscontrare - di un
giovane cantautore calabrese. Si chiama Michelangelo Giordano, ha 36 anni e nel
suo curriculum rivendica alcuni guizzi pregevoli, come la vittoria del premio
"Una canzone per Amnesty 2013", oltre ad un mentore del calibro di Mogol che lo
avrebbe notato durante un seminario di musica organizzato dalla scuola di musica
fondata dallo stesso paroliere (il CET) incoraggiandolo a trasferirsi dalla
Calabria a Milano. Il concorso Giordano, lo scorso settembre 2014,
decide di iscriversi alla manifestazione "Area Sanremo 2014", promossa con bando
pubblico e gestita dalla società "Sanremo Promotion" controllata dal comune
ligure. Il concorso, che ha aperto le porte della partecipazione al Festival
della canzone italiana 2015 ai suoi due vincitori, prevedeva nella sua prima
fase la selezione di 40 finalisti da parte di un'apposita commissione di
valutazione, composta dalla storica voce dei Pooh Roby Facchinetti (presidente),
dalla cantante Giusy Ferreri e dal produttore e rapper Dargen D'Amico. A
novembre, Giordano si è esibito davanti a quella giuria eseguendo il brano "Chi
bussa alla porta", tema impegnato (il panico e la sofferenza di chi è
vulnerabile ai suoi attacchi), parole e musica scritte da lui. Al termine, come
riportano i suoi avvocati Marzia Eoli e Luca Fucini nell'atto di citazione
presentato ad Imperia contro la Sanremo Promotion, i giudizi della commissione
sarebbero stati "entusiasti", sia per "l'originalità del brano prescelto" che
per la musica e il testo. Un giudizio positivo che troverà riscontro,
evidenziano ancora gli avvocati, nella scheda di valutazione di Giordano al
quale Roby Facchinetti attribuirà addirittura quattro dieci su quattro. La
doccia fredda Cinque giorni dopo, però, l'artista riceve da Sanremo Promotion la
comunicazione del mancato superamento della fase eliminatoria. Chiede di poter
visionare la propria scheda di valutazione, e davanti ai giudizi "più che
lusinghieri" (scrivono i suoi due avvocati) che la inchiostrano rimane ancora
più sconcertato. Decide così di fare un accesso agli atti, per confrontare la
sua scheda con quelle dei 40 finalisti, per conoscere i criteri di valutazione
adottati e per visionare i verbali della commissione contenenti questi ultimi.
Punteggi più alti Dalle schede, recita ancora l'atto di citazione, emerge che
"alcuni candidati ammessi alla successiva fase finale riportano giudizi
espressi, sia con punteggi numerici e sia con il giudizio complessivo, di gran
lunga inferiori a quelli riportati da Giordano". Nella scheda di valutazione, in
effetti, il cantautore ha un 9,17 (media finale dei punteggi ottenuti per le
singole componenti dell'audizione e cioè voce, presenza scenica, performance e
brano) e un 9 (giudizio complessivo espresso dai commissari). Altri quattro
concorrenti selezionati al suo posto tra i 40 finalisti, portati come esempio
nella citazione, hanno tutti voti inferiori al 9, oscillanti tra l'8,80 e
l'8,50. "Perché", si chiede l'artista, "sono stato scartato dopo essere stato
valutato così positivamente?". Il verbale Nel verbale stilato dalla
commissione e che data a prima dell'inizio delle selezioni, in realtà, si dice
che "al termine di ogni audizione la commissione compilerà una scheda
dell'esibizione. La commissione stabilisce che le valutazioni contenute nelle
suddette schede non determineranno la classifica finale dei candidati e quindi
non saranno in alcun modo vincolanti in ordine alla scelta dei finalisti".
Quelle valutazioni formulate dai giurati andrebbero considerate alla stregua di
consigli utili ai giovani concorrenti per individuare i propri punti forti e
quelli da perfezionare. Per gli avvocati di Giordano, invece, le cose non
starebbero così. Le schede di cui si parla nel verbale sono definite
"dell'esibizione" e non "di valutazione", dicono. Nel bando di concorso che
disciplina "Area Sanremo 2014", riportano inoltre nella citazione, all'articolo
6 si legge che "la commissione di valutazione adotterà le proprie decisioni in
seduta segreta secondo i criteri che saranno resi noti ai candidati prima
dell'inizio delle selezioni mediante pubblicazione sul sito internet
www.area-sanremo.it". Il bando e i criteri delineati nel sito, sostengono gli
avvocati di Giordano, sarebbero pertanto l'unica "legge di gara" individuabile e
le schede di valutazione "l'unico elemento di giudizio in cui la commissione ha
espresso un punteggio numerico per ogni parametro ispirato ai criteri fissati
sul sito internet". "Siamo di fronte a una selezione con bando pubblico",
afferma Giordano al telefono da Sesto San Giovanni, "un parametro di valutazione
trasparente doveva esistere e i punteggi delle schede di valutazione sono
l'unico che si possa individuare in questo concorso". Gli avvocati del
cantautore chiedono alla Sanremo Promotion 250.000 euro, puntando su un
risarcimento per "perdita di chance" dal momento che il loro assistito, escluso
dalla selezione finale malgrado l'alto punteggio ottenuto, non ha potuto
esibirsi davanti ai rappresentanti delle principali case discografiche
multinazionali e ai manager musicali ammessi all'ascolto dei 40 finalisti.
Chiedono anche il ristoro dei 3.860 euro che l'artista, al pari degli altri 3876
concorrenti, ha dovuto spendere per poter partecipare alla selezione. Inclusi,
riportano ancora gli avvocati, i soldi versati per la partecipazione ad un corso
di formazione per gli iscritti, obbligatoria per poter accedere alle selezioni
vere e proprie, con vitto, alloggio e viaggio a carico dei cantanti. Il comune
di Sanremo, da noi contattato, non ha inteso per il momento commentare la
vicenda. Abbiamo fatto pervenire una richiesta di replica anche a Sanremo
Promotion, posta in liquidazione a febbraio dopo il voto a maggioranza del
consiglio comunale cittadino, senza però venire ricontattati.
Denis Fantina, la star di
Amici rifiutato al talent The Voice di Rai 2,
scrive “Libero Quotidiano”. Il talent The Voice quest'anno è diventato l'ultima
spiaggia di tanti cantanti quasi dimenticati. Dopo Chiara Iezzi di Paola e
Chiara, nell'ultima puntata del talent in onda su Rai 2 si è presentato Denis
Fantina, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi, oggi
conosciuto come Amici, ben 15 anni fa. I giudici però lo hanno bocciato
clamorosamente. Denis ha cantato il brano di Marco Mengoni "Credimi ancora" e,
una volta capito chi fosse, i giudici hanno cercato di giustificarsi. Il primo
ad arrampicarsi sugli specchi è stato il giudice Francesco Facchinetti: “Per
quanto riguarda il team Fach eravamo quasi sul pulsante, hai fatto trenta e non
hai fatto trentuno”. Cerca di metterci una pezza anche Piero Pelù: “Io non mi
sono girato perché tu hai portato questo pezzo di Mengoni e lo hai cantato con
un piglio metallaro ma se tu ti fossi buttato più sul versante heavy metal ti
avrei votato. Complimenti perché hai cantato da Dio”. Un'amara consolazione,
senz'altro.
Le Blind Audition di
The Voice 3 sono terminate,
scrive "Panorama”. Il 25 marzo 2015 i quattro coach hanno infatti completato le
loro squadre, che comprendono 16 talenti per team, e dal prossimo mercoledì si
passa dunque alla seconda fase del talent show, ovvero le Battle:
accoppiati due a due dal proprio giudice, i cantanti dovranno scontarsi per
rimanere in gara cantando la stessa canzone. In queste puntate, l’eliminato avrà
la possibilità di essere ripescato da un altro giudice. È il momento di osare e
di fare il grande salto, è l’ultima chance per molti degli aspiranti cantanti,
visto che i quattro team sono quasi chiusi. Nella lunga carrellata di talenti
che si sono esibiti ieri sera, ce n’è uno già noto: alle audizioni al buio si è
presentato anche Dennis Fantina, vincitore di Saranno Famosi, cioè la
prima edizione di Amici. “Quando vinci credi che il tuo mondo cambi
totalmente, invece non è così – racconta nell’rvm di presentazione – Oggi
collaboro con un bar, si fa fatica, meno male che mia moglie lavora. Dopo il
programma ho fatto album e concerti, poi il fermento è venuto meno. Voglio
masticare nuovamente musica: della mia voce mi fido molto, dell’emozione no. Me
la gioco e vediamo cosa accade”. Così sale sul palco e canta Credimi ancora
di Marco Mengoni – e su Twitter Fiorello sottolinea la scelta sbagliata del
brano - ma nessuno dei giudici si gira. Il primo a riconoscerlo è Francesco
Facchinetti, poi a ruota gli altri. Quando torna nel backstage Fantina è
visibilmente contrariato e intanto i giudici commentano la sua esibizione. “Se
canta Zarrillo, spacca”, azzarda Facchinetti e J-Ax replica ironico: “Ma nessuno
vuole che canti Zarrillo, nemmeno Zarrillo”. Francesco e Roby Facchinetti -
ribattezzato “il sommo maestro, l’eccelso cantore”, per via delle perifrasi
ardite, dal conduttore Federico Russo – sono i primi a chiudere il team
scegliendo Giulia Pugliese. Dunque il cantante dei Pooh non può più schiacciare
il “pirellone”, come aveva erroneamente ribattezzato il pulsante che consente
alla sedia di girarsi. Il #teamFach è al completo. “Abbiamo iniziato col
botto, cioè con la tua caduta, e finiamo alla grande”, commenta Francesco. In
totale, padre e figlio portano alla Battle dieci donne e sei uomini:
“Abbiamo trovato quello che cercavamo”. Noemi e Piero Pelù hanno un solo
cantante da scegliere, J-Ax invece ancora due. Tocca a Noemi tagliare il
traguardo per seconda e chiudere il team dei fiori d’acciaio – così lo chiama
perché, spiega, delicato ma al tempo stesso solido – e scommette su Giuseppe
Izzo. “Quest’anno il team Noemi spacca. Non mi sono focalizzata su un solo tipo
di voce: ho timbri unici e super pop, è molto eterogeneo”. Contenta e
soddisfatta. Restano tre posti a disposizione e Pierluca Tevere ipoteca
l’accesso alle Battle conquistando Piero Pelù, che pigia il pulsante poi
s’infila sotto il tendone che nasconde il cantante a tutto il pubblico. “Stavo
svenendo quando ho visto la testa di Piero”, commenta Pierluca. “Mi aspettavo
una donna, è stato un piacevolissimo shock. Il team Diablo ha una grandissima
varietà di timbri e di personalità”, commenta il coach. Il quindicesimo posto
nel team J-Ax se lo aggiudica invece Edoardo Esposito, in arte Edo Sparks, poi
il rapper la tira per le lunghe, fa esibire quattro diversi aspiranti cantanti
ma non trova quella che definisce “una voce killer”. Alla fine punta su Maurizio
Di Cesare, cagliaritano di 22 anni, che lo conquista e chiude la Blind Audition.
“Questa è la voce che volevo: mi fa perdere la testa. Ora il team loser 2.0 è
chiuso: mi sono lasciato guidare da istinto ed emozione, ho tentato di cercare
cose non precise o intonate, ma stilose”.
The Voice, Dennis Fantina
fuori: “Hai cantato la canzone sbagliata”. E lui su Facebook: “Il brano non l’ho
scelto io”,
scrive Michele Monina su “Il Fatto Quotidiano”. L'eliminazione dell'ex vincitore
di Amici non è certo un caso di Stato ma fa un po' specie che si escluda un
professionista accampando scuse ridicole. Così come fa specie che i giudici,
specie Noemi, la cui carriera è tutta da costruire, e Francesco Facchinetti, si
lascino andare a commenti lapidari non si capisce bene da che altezza. Ci
risiamo. Ieri sera si sono chiuse le Blind audition di The Voice, terza
stagione, e come era già capitato in passato con la cantante dei Jalisse,
eliminata alla cieca, i cinque baldi giudici hanno seccato Dennis Fantina, primo
vincitore di Amici di Maria De Filippi, una vita fa. E esattamente come è
capitato con colei che ha reso Fiumi di parole uno dei peggiori incubi della
nostra giovinezza, via a scuse e supercazzole per giustificare l’aver escluso
incautamente un professionista dalla futura competizione televisiva. Ora,
partiamo da un presupposto fondamentale, The Voice è un programma tv. Niente a
che fare con la musica. Nessun cantante di successo è uscito da li, neanche
altrove. Chi ne esce rafforzato, molto, è il giudice, che in Italia, come
altrove, vede spesso una carriera morta di colpo rinata. Ma di musica, niente.
Dennis è stato sputato sul palco a giochi praticamente fatti. Pochi i posti
disponibili rimasti, e quindi selezioni più ardue. I giudici, mentre cantava, ne
hanno decantato le doti, ma nessuno si è girato. Bye bey Dennis. La canzone non
è adatta, hanno detto, aprendo un piccolo caso. Perché, anche qui, ci si pone
una domanda: chi decide le canzoni da proporre? Spesso gli autori stessi.
Quindi, decidono di giocare un volto conosciuto a giochi fatti, gli scelgono la
canzone e tanti saluti. Chiara di Paola e Chiara, per dire, la cui presenza
sicuramente è più interessante rispetto a quella d Dennis, un po’ usurato dal
tempo, è stata messa in condizione di passare a scatola chiusa, tra le prime a
esibirsi. Non che l’eliminazione di Dennis sia un caso di Stato, chiaro. Ma fa
un po’ specie che si escluda un professionista accampando scuse ridicole. Così
come fa specie che i giudici, specie Noemi, la cui carriera è tutta da
costruire, e Francesco Facchinetti, si lascino andare a commenti lapidari non si
capisce bene da che altezza. Diciamolo, The Voice, che l’anno scorso ha avuto un
po’ di successo non certo per la voce di Suor Cristina, ma per il famoso abito
che fa la monaca, è il talent con meno talento tra quanti si vedono in giro. E
quando un talento c’è, spesso, viene lasciato scappare, per pura opportunità
televisiva. Non è un caso che Laura Pausini si sia guardata bene dal venire a
fare il giudice in Italia, andando prima in Messico e poi, ora, in Spagna. Ora
le squadre sono chiuse, c’è una trans, qualche caso umano, Chiara Iezzi e poco
altro di interessante. C’è j-Ax coi suoi stucchevoli Axforismi, Noemi con la sua
boria, i due Facchinetti che mettono in scena un quadretto familiare tutto da
dimostrare e Piero Pelù, l’unico che sembra affrontare la cosa con un minimo di
cuore. Poi c’è la gara, ma fortunatamente non lascerà traccia dietro di sè.
POVIA ED I MORALIZZATORI.
Saccenti e cattivi. Ecco a voi
i sinistroidi.
I moralizzatori della rete
prendono di mira Povia.
Ovviamente sono quasi tutti utenti fake, scrive Riccardo Ghezzi su “Quelsi”.
Giuseppe Povia come Red Ronnie. Amaro destino per artisti o personaggi pubblici
che non fanno del “politicamente corretto” la loro ragione di vita. Guai a dire
qualsiasi cosa che non strizzi l’occhio al pensiero unico e dominante della
kultura, ossia al pensiero, se così si può chiamare, della sinistra. Anche un
innocente post come “L’Italia va gestito da italiani”, in riferimento alla
nomina del ministro italo-congolese Kyenge la “nera”, può scatenare una reazione
turbolenta da parte degli evangelizzatori giustizieri della rete. Era già
successo a Red Ronnie quando aveva osato andar contro il guru Giuliano Pisapia
in piena campagna elettorale per le amministrative di Milano, ora la medesima
sorte è riservata a Povia, reo di avere espresso un semplice parere su facebook.
La fan page di Povia non è invasa come quella di Red Ronnie ai tempi, ma il
cantante riceve quotidianamente messaggi di insulti o disprezzo, a volta dal
contenuto palesemente diffamatorio, altre con minacce od inviti a “suicidarsi”.
Povia, pazientemente e pacatamente, risponde a tutti. Anche agli utenti con nome
e foto palesemente fittizi. Inutile dire che i leoni da tastiera si sottraggono
regolarmente alla discussione, preferendo la “toccata e fuga” di insulti.
Da qui l'intervento tramite
facebook di Antonio Giangrande in favore di Povia. «Sig. Povia, lei conosce
Antonio Giangrande? Basta mettere il suo nome su Google e vedere le pagine web
che parlano di me e poi, cliccare su libri. Li si vedranno i titoli di tutti i
saggi che ho scritto, ciascuno di 800 pagine circa. Dimostro in fatti, quello
che lei, traduce nei suoi testi. Libri che ho scritto dopo 20 anni di ricerche.
Sono censurato, come lei, perché scomodo. Le devo dire, però, caro compagno di
viaggio, orgogliosi di essere diversi, che a quelli come noi liberi e non
omologati alla cultura sinistroide, non rimane che raccontare con i propri libri
e con le proprie canzoni la realtà contemporanea ai posteri ed agli stranieri,
perché in Italiopolitania, Italiopoli degli italioti, siamo un seme che mai
attecchirà.»
«Antonio, grazie, pubblicalo
sulla mia bacheca quello che hai scritto, che mi fai sentire meno solo e
guardati questi video sennò non capisci bene. Ci vediamo in live Giuse.»
"Chi comanda il mondo": il
web si schiera pro e contro sulla canzone di Povia,
scrive di Don Ferruccio Bortolotto su “Riviera 24”. Ho deciso di condividere con
i nostri lettori questo video perché non ho voglia di sonnecchiare in questo
momento di estrema debolezza culturale per la nostra Europa. Domanda, denuncia
vie di soluzione ed un’aggressiva quanto risanatrice profezia sono nel ritmo
della canzone di Povia «Chi comanda il mondo». Ho guardato e riguardato il
video, che mi è stato inviato da un amico, con la matita in mano per fermare
sulla carta i frammenti della visione del cantautore, che come pugni rompono i
muri di pietra degli occhi e della testa. «La musica può arrivare dove le parole
non possono» - canta Povia – ed è vero: le sue percussioni e la sua voce scavano
un solco che non può lasciare indifferenti. In questo caso la musica riesce a
diventare un imperativo ascoltato dalla nostra volontà intorpidita e
saccheggiata di dolore e di potere. Ho deciso di condividere con i nostri
lettori questo video perché non ho voglia di sonnecchiare in questo momento di
estrema debolezza culturale per la nostra Europa. Cerco un silenzio che non sia
quello che precede ed accompagna il sonno, ma quello di chi con attenzione
veglia custodendo il fuoco di un desiderio profondo che tutti abbiamo nel cuore:
la voglia di sapere. Non difendere questo desiderio è acconsentire alla
tirannia.
Povia e Assotutela: botte
da orbi sul web. L'artista accusato di "istigare l'odio razziale" nel suo ultimo
brano "Chi comanda il mondo?",
scrive Chiara Rai su “Il Tempo”. Il cantautore Giuseppe Povia e il presidente di
Assotutela Michel Emi Maritato danno spettacolo su Facebook. Ad accendere la
miccia non è stato l'artista: l'ultima canzone di Povia ha mandato su tutte le
furie Maritato il quale non digerisce le parole contenute nell'ultimo brano
dell'artista a tal punto da minacciarlo di denuncia per istigazione alla
violenza e all'odio razziale. Queste accuse pesanti come macigni sorgono,
secondo Maritato, da alcuni passaggi che conterrebbero messaggi subliminali che
alimenterebbero l'antisemitismo. Così, sicuro della sua veste di paladino della
causa, il presidente di Assotutela non risparmia commenti al vitriolo: "Ha perso
un’altra occasione per stare zitto il cantautore Giuseppe Povia - esordisce
Maritato - in questi giorni difficili dove il mondo è minacciato dall'Isis e le
comunità ebraiche sono in tensione per il timore di eventuali attacchi, ci
mancava la genialata di Povia a gettare fuoco sulla benzina. Il nuovo brano ‘Chi
comanda il mondo?’ contiene anche nel clip ufficiale immagini riferimenti a
personaggio e messaggi subliminali che a nostro avviso alimentano
l’antisemitismo". E poi minaccia: "Nelle prossime ore, in collaborazione con i
nostri legali - conclude - stiamo valutando un esposto alla procura di Roma per
istigazione alla violenza e all'odio razziale, mi meraviglio della
superficialità con la quale vengano elaborati certi testi e vengono accostate
alcune simbologie apparentemente contro gli Ebrei, spero vivamente non sia stata
una trovata pubblicitaria di un’ormai stella cadente, ma solo un grande
fraintendimento". In pratica la tesi di Assotutela è questa: dato che Povia
sarebbe in decadenza, l'unica forma di promozione è lanciare un pezzo shock per
alimentare le polemiche e dunque vendere più dischi. Ma la risposta del
cantautore non si è fatta attendere. Povia non ci sta e le canta al presidente
Maritato: "Addirittura una denuncia? Invece di valutare un esposto, valuterei il
dialogo, stiamo tutti dalla stessa parte". E poi l'artista spiega meglio: "La
canzone 'Chi comanda il mondo?' è chiaramente riferita alla dittatura
finanziaria mondiale che sta impoverendo il mondo, punto". Povia, rivolgendosi
poi direttamente ad AssoTutela commenta: "Se vi riferite alla frase "messo sulla
croce in Israele" vuol dire semplicemente e simbolicamente che Gesù Cristo che
doveva salvare questo mondo, è stato messo sulla croce un tempo nell'attuale
Gerusalemme. Se fosse stato messo sulla croce a Carmagnola o a Sacrofano o a
Santa Marinella, avrei cantato quei nomi. Se vi riferite ad un'altra frase,
ditemi pure". Il cantautore infine conclude con un invito invito al dialogo:
"Sono contento che invece la maggioranza abbia capito il brano. Invece di
valutare una denuncia, valuterei il dialogo, stiamo tutti dalla stessa parte ma
come dice la canzone: 'siamo divisi dai simboli, noi singoli' ed è quello che
vogliono i grandi potenti. Ci vogliono divisi. Non cascateci". Ma la questione
non sembra chiusa qui, a quanto pare le spiegazioni sembrano non essere
sufficienti. Soltanto la conclusione del continuo tam tam di messaggi sul social
network potranno dirci chi dei due avrà la meglio sull'altro.
Testo - Chi comanda il mondo?
– Povia
Fate la nanna bambini,
verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e
disegnate i colori
Chi comanda il mondo, c’è una
dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi
immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, oltre
che il potere vuole il tuo dolore
e dovrai soffrire, e sarai
costretto ad obbedire
Chi comanda il mondo, voglia
di sapere, voglia di capire
Chi comanda il mondo, sotto
questo cielo che ci può sentire
e chi ha creato il mondo,
Torre di Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, messo
sulla croce in Israele
C’è una dittatura di
illusionisti finti
economisti equilibristi
terroristi padroni del mondo
peggio dei nazisti
che hanno forgiato altrettanti
tristi arrivisti stacanovisti
gli illusionisti, che ci hanno
illuso con le parole libertà e democrazia
fino a portarci all’apatia
creando nella massa, una massa
grassa di armi di divisione di massa
media, oggetti, nomi, colori,
simboli
la pensiamo uguale ma siamo
divisi noi singoli
dormiamo bene sotto le coperte
siamo servi di queste
sorridenti merde
Fate la nanna bambini,
verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e
www.nuovecanzoni.com disegnate i colori
Fate la nanna che la mamma, vi
cullerà sui suoi seni
Fate la nanna bambini volati
nei cieli
Ma un giorno un bambino di
questi si sveglierà
e l’uomo più forte del mondo
diventerà
portando in alto l’amore
Chi comanda il mondo, c’è una
dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi
immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, Torre di
Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, dice
sempre che va tutto bene
La libertà e la lotta contro
l’ingiustizia
non sono né di destra né di
sinistra
la musica può arrivare
nell’essenziale
dove non arrivano le parole da
sole
gli illusionisti ci hanno
incastrati firmando i trattati
da Maastricht a Lisbona
siamo tutti indignati perché
questi trattati
annullano ogni costituzione
quì bisogna dare un bel colpo
di scopa
e spazzare via ogni stato da
quest’Europa
se ogni stato uscisse
dall’Euro davvero
magari ogni debito andrebbe a
zero
perché per tutti c’è un punto
d’arrivo
nessuno lascerà questo mondo
da vivo
vogliamo una terra sana, sana
meglio una moneta sovrana (che
una moneta puttana)
Fate la nanna bambini,
verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e
disegnate i colori
Fate la nanna che la mamma, vi
cullerà sui suoi seni
Fate la nanna bambini volati
nei cieli
Ma un giorno un bambino di
questi si sveglierà
e l’uomo più forte del mondo
diventerà
portando in alto l’amore
Chi comanda il mondo, c’è una
dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi
immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, oltre
che il potere vuole il tuo dolore
e dovrai soffrire, e sarai
costretto ad obbedire
Chi comanda il mondo, voglia
di sapere, voglia di capire
Chi comanda il mondo, sotto
questo cielo che ci può sentire
e chi ha creato il mondo,
Torre di Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, messo
sulla croce in Israele
Fate la nanna bambini volati
nei cieli
Povia e il coraggio di dire
di no: meglio una moneta sovrana che puttana,
scrive Gloria Sabatini su “Il Secolo d’Italia”. Chi comanda il mondo? Chi
comanda il mondo? È la domanda ossessiva che dà il titolo all’ultimo album
di Giuseppe Povia, che, piglio naif e linguaggio scomodo, apre uno
squarcio di luce potente sull’attualità mettendo in musica il suo gigantesco no
al dominio planetario della grande finanza, di «illusionisti e finti
economisti». C’è una dittatura – canta Povia – un dittatura senza volto, fatta
di balle e finte illusioni che vorrebbe un popolo inebetito. «Silenzio / fate la
nanna bambini / verranno tempi migliori / Chi comanda il mondo? / C’è una
dittatura, c’è una dittatura / Non puoi immaginare quanto fa paura / Chi comanda
il mondo? / Oltre che il potere / vuole il tuo dolore / e dovrai soffrire / e
sarai costretto ad obbedire…», è l’incipit del brano che farà discutere e
solleverà lo sdegno delle anime belle del progressismo planetario, quelle sempre
pronte a gridare allo scandalo e al complotto. «C’è una dittatura di
illusionisti finti economisti equilibristi, terroristi padroni del mondo peggio
dei nazisti che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti stacanovisti…Ci
hanno illuso con le parole libertà e democrazia fino a portarci all’apatia». La
dichiarazione di guerra all’eurocrazia non potrebbe essere più esplicita: «Gli
illusionisti ci hanno incastrati firmando i trattati da Maastricht a
Lisbona, siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni
costituzione». Povia conferma la sua verve provocatoria e anti-ideologica quando
canta che «la libertà è la lotta contro l’ingiustizia non sono né di destra né
di sinistra, la musica può arrivare nell’essenziale dove non arrivano le parole
da sole». Un passo avanti a molti politologi e opinionisti. E per finire un
appello contro i grand commis di oggi e di ieri: «Qui bisogna dare un bel colpo
di scopa e spazzare via ogni Stato da quest’Europa. Se ogni Stato uscisse
dall’euro davvero magari ogni debito andrebbe a zero. Vogliamo una terra sana
sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana».
Messo in croce dal web.
L’autore de I bambini fanno oh e di Luca era gay non è nuovo ad
attacchi e isterie online. Qualche giorno fa Michel Emi Maritato, presidente di
Assotutela, ha ingaggiato un derby a distanza dalla sua bacheca Facebook
accusando Povia di contenuti antisemiti e arrivando a minacciare denunce «per
istigazione alla violenza e all’odio razziale». «In questi giorni difficili dove
il mondo è minacciato dall’Isis e le comunità ebraiche sono in tensione per il
timore di eventuali attacchi, ci mancava la genialata di Povia a gettare fuoco
sulla benzina». A dir poco squallida la tesi di Assotutela secondo la quale
l’artista avrebbe lanciato il pezzo shock per vendere più dischi e risalire
dalla “decadenza”. «Addirittura una denuncia – risponde elegantemente Povia –
invece di valutare un esposto, valuterei il dialogo, stiamo tutti dalla stessa
parte. La canzone Chi comanda il mondo? è chiaramente riferita alla
dittatura finanziaria mondiale che sta impoverendo il mondo, punto». Dov’è lo
scandalo? «Se vi riferite alla frase “messo sulla croce in Israele”, vuol dire
semplicemente e simbolicamente che Gesù Cristo, che doveva salvare questo mondo,
è stato messo sulla croce un tempo nell’attuale Gerusalemme. Se fosse stato
messo sulla croce a Carmagnola o a Sacrofano o a Santa Marinella, avrei cantato
quei nomi». Geniale.
Povia e la denuncia per Chi
Comanda il Mondo?: il Dott. Maritato fa chiarezza su “New Notizie”. Da due
giorni circola inarrestabile sul web la notizia secondo la quale Povia
rischierebbe di essere denunciato per il suo ultimo brano Chi comanda il mondo?:
a detta di diverse fonti sul web, la denuncia potrebbe partire dall’Associazione
per la tutela del cittadino AssoTutela, presieduta da Michel Emi Maritato. Ma
facciamo una breve cronistoria di quanto accaduto. Il 5 Marzo Povia pubblica sul
proprio canale YouTube il brano Chi comanda il mondo?, brano di denuncia che
tende a sottolineare le dinamiche di potere – a volte occulte – che
governerebbero il mondo e costringerebbero l’umanità ad una sorta di schiavitù.
Passa circa una settimana (e giungono alcune decine di migliaia di views per il
video, che vi proponiamo in coda) e si diffonde la notizia secondo la quale
AssoTutela sarebbe pronta a sporgere denuncia contro il cantante per le
tematiche proposte (vedremo che, in realtà, non è esattamente così). Pronta,
quindi, giunge la replica di Povia attraverso Facebook. Dal canto nostro,
abbiamo avuto modo di sentire telefonicamente il Dottor Michel Emi Maritato che,
disponibilissimo, ci ha spiegato la propria personale posizione: “Per Povia ho
una grande stima e mi ritengo un suo fan. Condivido le tematiche espresse nel
brano; dal canto mio sono un signoraggista, lavoro quotidianamente per
combattere contro l’usura bancaria e gli abusi di Equitalia. Ciò che non
condivido è un certo tipo di simbologia esoterica, presente all’interno del
video. Una simbologia che sottende una lotta al potere ebraico e che rappresenta
una scelta quantomeno poco felice in un momento come quello attuale, con
l’incombenza della minaccia dell’Isis”. “Il messaggio poteva passare anche senza
determinate immagini, in maniera più delicata”. Circa la denuncia, quindi, il
Dottor Maritato ha detto: “La denuncia è al vaglio dei legali. Saremmo comunque
felici se Povia accettasse un confronto e spiegasse le sue posizioni, magari
attraverso i nostri mezzi di comunicazione”. Per poi concludere: “Povia è una
grande arista. Un artista anticonformista che con le sue scelte rischia di
essere tagliato dai circuiti mainstream. Chi ha confezionato il videoclip,
d’altro canto, ha inserito dei simboli che possono incitare all’odio razziale.
Ciò magari è stato fatto senza che Povia ne fosse consapevole, ma rimane il
fatto che una determinata simbologia si sarebbe potuta evitare”.
AssoTutela contro Povia per il
brano ''Chi comanda il mondo'', scrive “Il Mamilio”. Al centro della vicenda il
brano ''Chi comanda il mondo''. “Ha perso un’altra occasione per stare
zitto il cantautore Giuseppe Povia”. Lo dichiara in una nota il presidente di
AssoTutela Michel Emi Maritato. “In questi giorni difficili dove il mondo è
minacciato dall’Isis e le comunità ebraiche sono in tensione per il timore di
eventuali attacchi ci manca la genialata di Giuseppe Povia benzina sul fuoco. Il
nuovo brano Chi comanda il mondo contiene anche nel clip ufficiale immagini
riferimenti a personaggio e messaggi subliminali che a nostro avviso alimentano
l’antisemitismo. Nelle prossime ore, in collaborazione con i nostri legali,
stiamo valutando un esposto alla procura di Roma per istigazione alla violenza e
all’odio razziale, mi meraviglio – conclude Maritato nel comunicato – della
superficialità con la quale vengano elaborati certi testi e vengono accostate
alcune simbologie apparentemente contro gli Ebrei, spero vivamente non sia stata
una trovata pubblicitaria di un’ormai stella cadente, ma solo un grande
fraintendimento''. La reazione di Povia, direttamente dal suo profilo Facebook,
non si è fatta attendere: ''La canzone "Chi comanda il mondo" - scrive - è
chiaramente riferita alla dittatura finanziaria mondiale che sta impoverendo il
mondo, punto. Se vi riferite alla frase "messo sulla croce in Israele" vuol dire
semplicemente e simbolicamente che Gesù Cristo che doveva salvare questo mondo,
è stato messo sulla croce un tempo nell'attuale Gerusalemme''. ''Se fosse stato
messo sulla croce a Carmagnola o a Sacrofano o a Santa Marinella - continua il
cantante - avrei cantato quei nomi. Se vi riferite ad un'altra frase, ditemi
pure. Sono contento che invece la maggioranza abbia capito il brano. Invece di
valutare una denuncia, valuterei il dialogo, stiamo tutti dalla stessa parte ma
come dice la canzone: "Siamo divisi dai simboli, noi singoli" ed è quello che
vogliono i grandi potenti. Ci vogliono divisi. Non cascateci''.
Per la canzone mi dicono:
“VENDUTO!! GUADAGNI SOLDI!!”
(Leggete dai..non è possibile), scrive Povia sul suo Blog Lunedì, 09 Marzo 2015.
Il video della canzone “Chi comanda il mondo” è stato visto in meno di 4
giorni da oltre 40 mila persone senza pubblicità. SONO SOLO LO VOLETE CAPIRE?
SOLO! SENZA PUBBLICITA’. Solo con il vostro PASSAPAROLA e vi dico G R A Z I
E! Anzi devo ringraziare anche rispettivamente i creatori di Facebook e Youtube
che mi permettono di diffondere un minimo la mia musica e ciò che penso. La
canzone l’ho prodotta di tasca mia e il video mi è stato concesso da Marco
Carlucci, uno dei più grandi registi social-underground che ci sono nel panorama
italiano. Neanche lui è un venduto, sennò non avremmo trovato intesa su certi
argomenti che toccano la finanza. Lui è lo stesso che mi fece i video di “Luca
era gay” e “La Verità” realizzati soprattutto per ammirazione artistica e
intellettuale nei miei confronti. Abbiamo pensato che poteva nascere un video da
quest’altra canzone, punto. Come andava andava. Senza aspettative. (Parlo di
“chi comanda il mondo”). VENDUTO? IO? Dai..vi prego.. Non voglio dire parolacce
o insulti perchè non servono in questo caso ma vorrei chiarire che non solo non
sono un venduto e non lo sono mai stato davvero, ma non guadagno soldi su questo
brano per il seguente ed elementare motivo: Non l’ho caricato sui portali a
pagamento, E’ GRATIS, lo potete ascoltare e vedere quando e come volete. Lo
ripeto QUANDO E COME VOLETE. Scommetto che ce lo avete già sull’I-pod in mp3
vero? E’ GRATIS. E sarei VENDUTO? E DOVE LI GUADAGNEREI I SOLDI SENTIAMO? Bene,
la notizia vera però è questa: SONO IN VENDITA!!! SONO IN VENDITA, CERTO CHE
SI! Ma non ho bisogno di qualcuno che mi produca solo un disco, ho bisogno che
sposi il mio pensiero, la mia spiritualità, il mio carattere la mia arte e il
mio combattere questo ANTISISTEMA che sta degenerando tutte le nuove generazioni
vendendo una “Libertà” fatta di troppa devastazione, troppo eccesso di droga,
sesso e amore venduto come quello che si vede sui siti porno gratuiti. IO SONO
IN VENDITA! MA NON SONO VENDUTO, MAI! AVREI PARTECIPATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI, UN
PROGRAMMA PER IDIOTI. Non ce l’ho con chi ci partecipa ma con chi lo guarda. Non
è l’abbondanza il problema, ma chi se la beve. e si, ho detto che combatto
contro L’ANTISISTEMA, avete capito bene! Il problema è proprio L’ANTISISTEMA!
Quello che ci fa sentire in colpa se esprimiamo il nostro normalissimo pensiero.
Insultate i vostri idoli! Insultate coloro che vi dicono ciò che volete sentirvi
dire. Quelli che girano intorno al problema ma non lo centrano come si deve,
perchè si cagano addosso. Quelli che rinnegano i loro testi, le loro canzoni, le
loro dichiarazioni. Quelli che parlano di un'umiltà che non ha nessuno in questo
mondo e che fanno i finti umili. Insultate quelli che vogliono farvi credere che
non si vendono ma che invece in quest’ambiente di cani e cagnette in calore
tutti messi a pecora, ci sguazzano e ci si ritrovano proprio bene. Quelli
sono i veri VENDUTI e voi i loro COMPLICI PERFETTI. Io sono solo,
artisticamente solo e non piango: MI CI GIOVO, ME NE VANTO, GODO! SONO LIBERO.
Povia ad Affari: "Il
concerto del Primo Maggio? Non ci vado solo perché fa figo". Intervista di
Giovanni Bogani Martedì, 11 aprile 2006. Il piccione di Povia? Abitava su un
tetto, nel centro di Firenze. Quello che ha ispirato la canzone che ha vinto a
Sanremo, quello che si accontentava delle briciole, quello che volava basso,
perché il segreto è volare basso. Stava su un tetto fiorentino. “E neanche lo
sopportavo”, dice lui, fiorentino per amore, da cinque anni: per amore della sua
donna Teresa, che gli ha dato da poco una figlia. “Ogni mattina, a mezzogiorno,
io appena sveglio, e questo piccione a tubare, ad amoreggiare e a rumoreggiare,
con tutti i suoi rumorini da piccione. E io, piano piano, mi sono chiesto se non
avesse ragione lui, con il suo amore così semplice, in qualche modo così
assoluto. E ho cominciato a scrivere una canzone su di lui”. Povia, nelle strade
medievali di Firenze, tra i vicoli intorno a Ponte Vecchio, ha vissuto anni di
bohème. E in questi anni, ha maturato il suo talento. Ha coltivato i suoi sogni,
tra un turno e l’altro del suo lavoro di cameriere. Lo incontriamo in un bar. E
ci facciamo raccontare i suoi anni anonimi. Quando ancora il successo era un
miraggio lontano, da afferrare, semmai, o forse da non raggiungere mai.
Povia, quali erano i luoghi
della tua Firenze?
“Piazza Santo Spirito, dove mi
ritrovavo con il mio amico Simone Cristicchi, che aveva anche lui una fidanzata
a Firenze; il Porto di Mare e l’Eskimo, due locali dove si fa musica dal vivo,
ai quali sono molto legato. E piazza della Passera: lì, al caffè degli
Artigiani, un piccolo caffè frequentato da turisti americani, nel mezzo del
cuore della Firenze antica, ho lavorato per due anni”.
Hai lavorato a lungo come
cameriere?
“In tutto, diciotto anni. Di
qua e di là, a Milano, a Porto azzurro all’isola d’Elba, e poi a Firenze”.
Che cosa si impara?
“La pazienza, prima di tutto.
E poi si impara a riconoscere le brave persone. E anche gli altri, quelli che
brave persone non sono”.
Ci sono stati momenti in
cui hai pensato di smettere, di mollare tutto?
“Praticamente, in
continuazione. Pensavo sempre: basta, adesso smetto. In questo mondo, nessuno ti
apre le porte. Stavo male, mi sentivo a mio agio solo con la mia fidanzata…”.
Quando l’hai conosciuta,
Teresa?
“L’ho conosciuta in modo
classico, in una discoteca all’isola d’Elba. Dodici anni fa. Teresa è di
Firenze; ci siamo visti per sette anni attraversando l’Italia da una parte
all’altra. Poi, cinque anni fa, sono venuto ad abitare qui”.
E ora chi sei?
“Uno che non si considera un
artista, ma uno che vorrebbe scrivere canzoni per tutti. Per comunicare alla
gente. Uno che vorrebbe essere semplice, e chiaro, e dare emozioni. Insomma,
vorrei essere ‘pop’. E non sono né di destra né di sinistra. Ho cantato per il
papa, ma non per vestirmi di una bandiera. Perché ci credo io, e basta”.
Insomma, tu non ti schieri.
Ma la religione è importante per te. Da quando?
“Da quando ero depresso,
praticamente disperato. Non riuscivo a sfondare con la musica, passavo da un
lavoro di cameriere all’altro, non avevo neanche una città di cui potessi dire:
è casa mia….E poi, nella sala di aspetto di una stazione, do un euro a un frate
cappuccino che chiedeva, con molta discrezione, dei soldi. Lui mi dice: siediti.
Come, siediti? Mi sono seduto, perché ho visto che aveva un volto intenso,
serio, che aveva qualcosa da dire. Abbiamo parlato. E questo frate cappuccino mi
ha cambiato la vita”.
Come è la tua vita adesso?
“Semplicissima. Sto con la mia
donna, Teresa, con mia figlia Emma, che ha 15 mesi e comincia a ‘gattonare’. E
vado a fare la spesa al supermercato, come tutti”.
E’ più bello scrivere le
canzoni o cantarle?
“Per me, scriverle. Mi ci
vogliono cinque minuti per avere un’idea, e mesi per finire una canzone. E nel
mezzo, c’è il lavoro più bello del mondo. Dare vita a una melodia, a un’armonia,
a delle parole. Creare qualcosa che prima non esisteva. A volte mi stupisco
ancora, di questo miracolo che accade ogni volta”.
Una curiosità. Ma dove
abitava il piccione della canzone con cui hai vinto Sanremo?
“Di fronte alla mansarda dove
vivevo io, a Firenze. Mi svegliavo, e vedevo tutti i giorni questo piccione che
tubava. Non lo sopportavo: io non amo i piccioni, per niente! Ma poi ho capito
che aveva la sua ragione di vita, che aveva il suo diritto alla felicità,
all’amore. E che, a suo modo, sui tetti di fronte a casa mia, lui viveva
l’amore in un modo assoluto”.
Quale canzone stai
scrivendo?
“Una canzone sull’amicizia.
Che sarà più bella di tutte quelle che ho scritto fino ad ora. Ma una canzone
non si fa in cinque minuti. Ci vogliono mesi. In cinque minuti ti viene un’idea,
un titolo, un ritornello. Il resto è lavoro, è fatica”.
Concerti? Farai quello del
Primo Maggio?
“No. Ma non perché ho suonato
per il Papa, e non faccio il Primo Maggio. Non lo faccio perché molti suonano in
quel concerto per atteggiamento, e non per convinzione. Ci vanno perché fa
figo”.
«Preferisco rinunciare sia a
consensi, sia a compensi - spiega Povia in un video pubblicato sul suo profilo
Facebook il 10 marzo 2015 - Perché tanto so che se dico di sì a uno, poi gli
altri se la prendono e storcono il naso. Tanto sempre è andata così. Nel 2005
stavo partecipando con i”I Bambini fanno oh” al concerto del Primo maggio a
Roma, ma poi mi dissero: se vieni da noi, poi non devi mai andare con gli altri.
Allora risposi: no, grazie. E da lì il mio percorso è quello che conoscete,
senza mai nessun appoggio politico o discografico e sempre pieno, pieno di
critiche e di insulti che non tarderanno ad arrivare».
POVIA: SE CANTASSI "LUCA E’
TORNATO GAY" DIREBBERO CHE HO SCRITTO UNA CANZONE BELLISSIMA.
Intervista di Davide Maggio.
Con le sue canzoni ha fatto parlare spesso di sè negli ultimi anni. Prima “I
bambini fanno oh” poi “Luca era Gay”, passando per “Vorrei avere il
becco”, Giuseppe Povia è un cantautore che sa come colpire l’opinione pubblica.
In occasione del suo impegno a I Migliori Anni, abbiamo fatto una lunga
chiacchierata con lui e ne è uscita fuori l’immagine di un cantautore con le
idee chiare, che crede molto nel suo lavoro, consapevole del fatto che le
critiche siano parte del gioco. L’importante, dice, è essere intellettualmente
onesti.
Stai ricevendo consensi di
pubblico a I Migliori Anni. Essere popolare ti lusinga o ti infastidisce perché
allontana la tua immagine da quella del cantautore di nicchia?
«Quando
hai qualcosa da dire devi essere popolare, perché a più persone arrivi e più
puoi aiutare, altrimenti è inutile che fai arte, inutile che fai musica. Ci sono
invece personaggi di nicchia che vogliono rimanere nella nicchia… ma se la
raccontano. Io guardo fissa la telecamera perché la gente deve riconoscere in me
uno che canta delle canzoni che possono aiutare a vivere meglio. La musica può
cambiare tantissime cose. I bambini fanno oh ha aiutato dei bambini a uscire dal
coma».
In Italia esistono dei
cantautori di serie A e di serie B?
«Sono
gli addetti ai lavori che ti accreditano o screditano. Ogni artista ha un
consenso da una parte e poco consenso dall’altra. Io, per esempio, vengo
attaccato da varie fazioni per le tematiche che tocco, da altre invece vengo
acclamato. E’ chiaro però che mi sento cantautore a 360 gradi e non posso
parlare solo d’amore. De Gregori fu attaccato dalla critica velatamente perché
lo accusarono di aver offeso le persone obese con La Donna Cannone, oppure De
Andrè fu criticato perché istigava alla prostituzione con Bocca di Rosa. Non mi
sto paragonando a loro, dico solo che la strada che seguo nella musica è quella
del cantautore. Se scrivo “Luca era gay” o “La verità”, ispirata alla storia di
Eluana Englaro, ci sono dei motivi che vanno oltre la furbizia per far parlare
di me. Ma poi chi non è furbo in questo ambiente? (ride) E meglio esserlo su
argomenti intellettualmente onesti che per le movenze o per i vestiti».
Conosci Pierdavide Carone?
«Si,
l’ho sentito a Sanremo dove ha portato un pezzo che mi piaceva con Dalla e poi
ha cantato “Di Notte”, una canzone che andava su parecchie radio. So che è un
autore giovane e gli autori giovani servono in Italia. E poi è uno dei pochi che
scrive pure per gli altri e non solo per sé».
Il tuo rapporto con i
talent, dunque?
«Non
ce l’ho con i talent. Da una parte è positivo perché parla di musica e
dall’altra parte è deleterio perchè su 40 persone che partecipano non ce la
possono fare tutti. Se hai una squadra di persone che ti stanno dietro e che
fanno un progetto per te come è stato fatto per la Amoroso, Giusy Ferreri o
Marco Mengoni può funzionare. Se fai il primo singolo che magari non va tanto
bene e ti abbandonano, vai in crisi psicologica».
Sottolinei spesso
l’importanza del cantautorato.
«I
cantautori, dal dopoguerra in poi, hanno fatto la storia della musica italiana
attraverso filosofie di pensiero e emozioni nuove. Attraverso le loro canzoni
hanno parlato di satira, di politica e di tante tematiche sociali. La figura del
cantautore dovrebbe tornare a essere qualificata perché negli ultimi dieci anni
è stata un po’ sorpassata. Oggi si tende più ad omologare la musica a un unico
genere, a un unico suono. Io ho la sensazione di sentire sempre la stessa
canzone cantata da cantanti diversi. Il suono deve essere quello, altrimenti
radiofonicamente sei penalizzato. Voglio togliermi dalla testa la parola
radiofonico».
Hai inaugurato anche una
scuola per cantautori.
«Sì,
la scuola è il CMM di Grosseto che è aperta dal 1994 e si occupa di musica a 360
gradi. Al suo interno ho aperto la sezione cantautori che non ha la presunzione
di insegnare a scrivere le canzoni, perché le emozioni non si insegnano da
nessuna parte. Arrivano molti ragazzi giovani che hanno del talento insegno loro
quello che Giancarlo Bigazzi, che per tre anni è stato il mio maestro, ha
insegnato a me».
Nel tuo inedito, Siamo
Italiani, presentato a I Migliori Anni, avresti potuto essere più cattivo con la
nostra descrizione. C’è una strofa che avresti voluto inserire ma poi hai
preferito tagliare?
«A
essere cattivi ci pensano agli altri, io sono il buonista. Dicono che “siamo
italiani è populista”. Populista è un termine nobile, a parte che finisce per
ista. Dovrebbe essere populesimo che è ancora più bello. E’ un termine
patriottico, popolare e poi in questo caso è un termine che parla al cuore degli
italiani. “Siamo italiani” è una canzone che parla dei nostri pregi e dei
difetti. Siamo uno stivale al centro del mondo e tutti ci vogliono mettere i
piedi dentro, anche se ci criticano».
Una strofa della tua
canzone dice: “siamo italiani, ed è ora di cambiare questa storia. ci meritiamo
di vivere in un mondo che abbiamo inventato noi”.
«Gli
italiani sono positivi, sono quelli che si rialzano. Non è una canzone cattiva,
ma positiva. Sono tutti bravi a fare gli oratori, ma alla fine l’ipocrisia non
paga. Se uno riesce a dire le cose che pensa veramente fa più bella figura anche
se ci si brucia una parte di pubblico. Quindi “siamo italiani… su le mani”».
Su le mani, perché?
«Qualcuno
intende su le mani perché ci stanno puntando una pistola, invece qualcun altro
intende su le mani perché possiamo conquistare pure il cielo. E questo è vero».
Già deciso per chi votare?
«Non
ancora, non c’è una faccia nuova. Mi piaceva molto Renzi, l’ho conosciuto e avrà
tempo per farsi strada. Non è che io sia politicamente disilluso, perché un
pensiero ce l’ho, che è quello che va a favore di famiglia, di ricerca, sanità,
strutture, di cultura, però alla fine dentro un partito ci sono tre leader che
litigano… ti sembra una cosa un po’ una comica e la prendi a ridere.
Probabilmente, credo che non andrò a votare perché non mi sento stimolato».
Luca era gay è del 2009. A
cantarla oggi le polemiche sarebbero state le stesse di allora?
«Si,
certo. Se cantassi: “Luca non sta più con lei ed è tornato gay” tutti direbbero
che ho scritto una canzone bellissima. Io ho cantato “Luca era gay e adesso sta
con lei” e sono stato accusato di aver detto che un gay è malato. Io ho rispetto
per la parola malattia che credo sia una parola con cui nessuno voglia avere a
che fare: nella canzone c’è una strofa che dice “Questa è la mia storia, solo la
mia storia, nessuna malattia, nessuna guarigione”. Parlavo della storia di una
persona che se non si trova in una condizione può cambiare perché – al di là del
fatto che la storia sia vera – è vero che si può. Non ho cantato la parte che
avrebbero voluto sentire quelli che fanno i finti paladini difensori. Ho
raccontato una storia e non pensavo che succedesse tanto casino. La racconterò
tutta la vita. Ad avercene di “Luca era gay”, anche perché è una canzone
intellettualmente onesta».
Cosa ne pensi delle
adozioni gay?
«Secondo
me, un bambino dovrebbe avere una figura paterna e una materna. Questa è
pedagogia. Poi da una parte ci sarà la gente che ritiene che sia meglio affidare
i bambini a una coppia omosessuale che si vuole bene piuttosto che abbandonarli
in un bidone o affidarli ad una casa famiglia. Secondo il mio pensiero
personale, e quindi condivisibile o meno, nelle case famiglia lavorano persone
preparate e che conoscono i bambini e poi ci sono tantissime coppie
eterosessuali in attesa inutilmente che gli venga affidato un bambino».
A differenza che in quello
della musica, nel mondo del calcio, l’omosessualità è ancora un argomento tabù.
«Si
arriverà anche nel calcio a parlarne. perché il mondo sta andando in quella
direzione. Bisogna riuscire ad accettare una persona nella condizione in cui sta
bene. Io sono stato scambiato per quello che ce l’ha con i gay, e se fosse così
lo direi. Mi hanno dato dell’ omofobo e adesso quando faccio i concerti spiego
cosa significa davvero omofobia. Io non ho paura degli omosessuali. Credo che
nessuno ne abbia. Omofobia è un termine politicamente inventato negli ultimi
anni. Forse il nuovo termine è “poviafobia.” A Firenze (dove vive, ndDM) non ho
nessun problema a entrare in un locale gay, ma in quel momento sento di esser
guardato male e allora chi è che discrimina?»
Al posto di Morgan a
XFactor o al posto di Grazia Di Michele ad Amici?
«Morgan
è uno che giudica e ha il suo carattere, è un cantautore e non ha mai scritto
una canzone che ha scalato le classifiche. E’ molto stimato perché ha una grande
cultura. Vorrei avere la cultura di Morgan e il buon senso di Grazia Di Michele».
Parliamo di televisione,
qual è il programma che proprio non riesci a guardare?
«La
pubblicità (ride). Non lo so, non c’è un programma. A parte il calcio, la
televisione non la guardo tanto. Guardo Violetta, a cui mi ha fatto appassionare
mia figlia Emma. E’ la storia di una ragazzina che canta. Quando verrà in
Italia, le ho promesso che la porterò al concerto».
Vasco Rossi o Ligabue?
«Io
son cresciuto con Vasco Rossi, con i suoi testi, con il suo stile di vita. Sono
stato due anni in comunità perché ho fatto delle cavolate ai tempi in cui avevo
venti, ventidue anni. Vasco l’ho ascoltato perché le sue canzoni mi davano la
speranza di vivere in una condizione migliore. Cosa che poi è accaduta. Ligabue
è molto più preciso. Ha dei testi ultimamente molto più forti..Scrive cose tipo
“l’amore conta – conosci un altro modo per fregar la morte” che è una cosa che
avrei volto scrivere io».
Devi scegliere un cantante
con cui fare un tour. Chi sceglieresti?
«Non
sopporto i duetti e queste operazioni discografiche. Forse con Baglioni, ma a
cantare i suoi pezzi. Se dovessi fargli da corista, allora sì».
Il prossimo brano che
interpreterai a I Migliori Anni?
«Tanta
voglia di lei dei Pooh. E’ la prima canzone che ho cantato…e non è detto che la
canti bene».
Sei nella condizione di
poter invitare a cena fuori una tua collega de I Migliori Anni, chi scegli?
«Alexia.
Non che ci sia qualcosa, per carità (ride). E’ una ragazza intelligente,
piacevole, con la quale puoi parlare di tantissime cose. Ha un cervello, è
mamma e a me piacciono le donne mature di testa».
Guarderesti Italia’s Got
Talent se non fossi impegnato con I Migliori Anni?
«A
me di solito piacciono i programmi di cose inedite. Gli darei un’occhiata per
curiosità, ma poi non so».
Hai mai detto in
un’intervista qualcosa di cui poi ti sei pentito?
«Si,
ma alla fine bisogna dire quello che si pensa. Certo, un cantautore o un
personaggio di spettacolo deve stare attento a pesare le parole. Qualunque cosa
io dica vengo sempre catalogato in una casella politica. Non mi piace che ogni
volta alcuni giornalisti facciano il gioco della collocazione politica
dell’editore».
Quando uscirà il tuo disco?
«Esce
il 19 novembre che è il giorno del mio compleanno e si chiamerà Cantautore. E
poi nel 2014 porterò in giro per i teatri uno spettacolo. Parlerà di tutto,
d’amore, di politica, di ironia, di satira, tematiche sociali. Sono 90 minuti di
chitarra e voce per rilanciare il concetto del cantautore, far capire, più a me
stesso che alla gente, che una canzone resta in piedi anche se è solo chitarra e
voce. Una volta fatto questo si può riarrangiarla come vuoi. Oggi invece si fa
un po’ il contrario».
Guarderai Sanremo?
«Si.
Fazio, bisogna rendergliene merito, ha fatto un Sanremo rischioso, secondo i
suoi gusti e con un cast apparentemente di nicchia Con un cast così il rischio è
che anche questo Sanremo sarà costruito più sul contorno che sulla musica. Sono
curioso di sentire la canzone di Marco Mengoni che mi piace un sacco. Secondo me
potrebbe vincere. E’ uno, che non so come faccia, ma canta come Freddy Mercury».
Hai un look ben
distinguibile, all’apparenza sembri uno di quelli che non ci pensa tanto e
invece…
«L’abito
fa il monaco (ride). Non mi vesto mai in maniera distratta. Sabato scorso ai
Miglior Anni ero vestito di bianco, che dà sempre l’idea di pulito… e poi bianco
fuori un po’ sporco dentro. Quando mi vesto di nero, metto una collana che fa
luce, mi piacciono gli accessori, i capelli lunghi e lo scegliere le scarpe
intonate».
EPPURE CHE GUEVARA ERA
CONTRO I GAY.
Eppure Che Guevara organizzò
il primo campo di concentramento per gay, scrive Enrico Oliari su “Quelsi”. Il
medico argentino che condusse la rivoluzione cubana organizzò i lager per i
dissidenti e gli omosessuali. Questi ultimi furono da lui perseguitati in quanto
tali: il “Che” non fu secondo nemmeno ai nazisti. Ecco un ritratto che Massimo
Caprara, ex segretario di Palmiro Togliatti, ha descritto del rivoluzionario.
Con la fuga del dittatore Fulgencio Batista e la vittoria di Fidel Castro, nel
1959, il Comandante militare della rivoluzione, Ernesto “Che” Guevara, ricevette
l’incarico provvisorio di Procuratore militare. Suo compito è far fuori le
resistenze alla rivoluzione. Lasciamo subito la parola a Massimo Caprara (*), ex
segretario particolare di Palmiro Togliatti: “Le accuse nei Tribunali sommari
rivolte ai controrivoluzionari vengono accuratamente selezionate e applicate con
severità: ai religiosi, fra i quali l’Arcivescovo dell’Avana, agli omosessuali,
perfino ad adolescenti e bambini”. Nel 1960 il procuratore militare Guevara
illustra a Fidel e applica un “Piano generale del carcere”, definendone anche la
specializzazione. Tra questi, ci sono quelli dedicati agli omosessuali in quanto
tali, soprattutto attori, ballerini, artisti, anche se hanno partecipato alla
rivoluzione. Pochi mesi dopo, ai primi di gennaio, si apre a Cuba il primo
“Campo di lavoro correzionale”, ossia di lavoro forzato. È il Che che lo dispone
preventivamente e lo organizza nella penisola di Guanaha. Poi, sempre quand’era
ministro di Castro, approntò e riempì fino all’orlo quattro lager: oltre a
Guanaha, dove trovarono la morte migliaia di avversari, quello di Arco Iris, di
Nueva Vida (che spiritoso, il “Che”) e di Capitolo, nella zona di Palos,
destinato ai bambini sotto ai dieci anni, figli degli oppositori a loro volta
incarcerati e uccisi, per essere “rieducati” ai principi del comunismo. È sempre
Guevara a decidere della vita e della morte; può graziare e condannare senza
processo. “Un dettagliato regolamento elaborato puntigliosamente dal medico
argentino – prosegue Caprara, sottolinenado che Guevara sarebbe legato al
giuramento d’Ippocrate – fissa le punizioni corporali per i dissidenti recidivi
e “pericolosi” incarcerati: salire le scale delle varie prigioni con scarpe
zavorrate di piombo; tagliare l’erba con i denti; essere impiegati nudi nelle
“quadrillas” di lavori agricoli; venire immersi nei pozzi neri”. Sono solo
alcune delle sevizie da lui progettate, scrupolosamente applicate ai dissidenti
e agli omosessuali. Il “Che” guiderà la stagione dei “terrorismo rosso” fino al
1962, quando l’incarico sarà assunto da altri, tra cui il fratello di Fidel,
Raoul Castro. Sulla base del piano del carcere guevarista e delle sue
indicazioni riguardo l’atroce trattamento, nacquero le Umap, Unità Militari per
l’Aiuto alla Produzione (vedi il dossier di Massimo Consoli in queste pagine),
destinati in particolare agli omosessuali. Degli anni successivi, Caprara
scrive: “Sono così organizzate le case di detenzione “Kilo 5,5″ a Pinar del Rio.
Esse contengono celle disciplinari definite “tostadoras”, ossia tostapane, per
il calore che emanano. La prigione “Kilo 7″ è frettolosamente fatta sorgere a
Camaguey: una rissa nata dalla condizioni atroci procurerà la morte di 40
prigionieri. La prigione Boniato comprende celle con le grate chiamate
“tapiades”, nelle quali il poeta Jorge Valls trascorrerà migliaia di giorni di
prigione. Il carcere “Tres Racios de Oriente” include celle soffocanti larghe
appena un metro, alte 1.8 e lunghe 10 metri, chiamate “gavetas”. La prigione di
Santiago “Nueva Vida” ospita 500 adolescenti da rieducare. Quella “Palos”,
bambini di dieci anni; quella “Nueva Carceral de la Habana del Est” ospita
omosessuali dichiarati o sospettati (in base a semplici delazioni, ndr). Ne
parla il film su Reinaldo Arenas “Prima che sia notte”, di Julian Schnabel
uscito nel 2000″. Anni dopo alcuni dissidenti scappati negli Usa descriveranno
le condizioni allucinanti riservate ai “corrigendi”, costretti a vivere in celle
di 6 metri per 5 con 22 brandine sovrapposte, in tutto 42 persone in una cella.
Il “Che” lavora con strategia rivolta al futuro Stato dittatoriale. Nel corso
dei due anni passati come responsabile della Seguridad del Estado, della
Sicurezza dello Stato, parecchie migliaia di persone hanno perduto la vita fino
al 1961 nel periodo in cui Guevara era artefice massimo del sistema
segregazionista dell’isola. Il “Che”, soprannominato “il macellaio del
carcere-mattatoio di “La Cabana”, si opporrà sempre con forza alla proposta di
sospendere le fucilazioni dei “criminali di guerra” (in realtà semplici
oppositori politici) che pure veniva richiesta da diversi comunisti cubani.
Fidel lo ringrazia pubblicamente con calore per la sua opera repressiva,
generalizzando ancor più i metodi per cui ai propri nuovi collaboratori. Secondo
Amnesty International, più di 100.000 cubani sono stati nei campi di lavoro;
sono state assassinate da parte del regime circa 17.000 mila persone
(accertate), più dei desaparecidos del regime cileno di Pinochet, più o meno
equivalente a quelli dei militari argentini. La figura del “Che” ricorda da
vicino quella del dottor Mengele, il medico nazista che seviziava i prigionieri
col pretesto degli esperimenti scientifici.
LA PICCOLA EGUAGLIANZA, IL
POPULISMO E LA CADUTA PARZIALE DEGLI DEI (I MAGISTRATI).
Eguaglianza «aritmetica» o
«proporzionale», secondo la distinzione di Aristotele?
Nel punto d'arrivo o di partenza? Verso l'alto o verso il basso, come vorrebbero
le teorie della decrescita? Se due mansioni identiche ricevono retribuzioni
differenti, dovremmo elevare la peggiore o abbassare la piú alta? Ed è giusto
che una contravvenzione per sosta vietata pesi allo stesso modo per il ricco e
per il povero? Sono giuste le gabbie salariali, il reddito di cittadinanza, le
pari opportunità? E davvero può coltivarsi l'eguaglianza fra rappresentante e
rappresentato, l'idea che «uno vale uno», come sostiene il Movimento 5 Stelle?
In che modo usare gli strumenti della democrazia diretta, del sorteggio e della
rotazione delle cariche per rimuovere i privilegi dei politici? Tra snodi
teorici ed esempi concreti Michele Ainis ci consegna una fotografia delle
disparità di fatto, illuminando la galassia di questioni legate al principio di
eguaglianza. Puntando l'indice sull'antica ostilità della destra, sulla nuova
indifferenza della sinistra verso quel principio. E prospettando infine una
«piccola eguaglianza» fra categorie e blocchi sociali, a vantaggio dei gruppi
piú deboli. Una proposta che può avere effetti dirompenti.
Michele Ainis racconta le
ingiustizie italiane nel nuovo "La piccola eguaglianza".
In un libro il costituzionalista denuncia le piccole e grandi storture che
inquinano la vita pubblica e professionale del Paese. E le colpe della sinistra,
scrive Tommaso Cerno su “L’Espresso”. C'è una mappa italiana che la sinistra fa
finta di non vedere. Racconta centinaia di piccole ingiustizie, una miriade di
micro diseguaglianze, di stravaganti contraddizioni, iniquità, storture di un
Paese dove essere uguali a parole è l’obiettivo di tutti, nei fatti resta un
traguardo lontano. Michele Ainis ne traccia una radiografia tanto dettagliata
quanto inquietante nel suo libro-breve “La piccola eguaglianza” (Einaudi, 136
pagine, 11 euro), un viaggio da costituzionalista ma prima ancora da cittadino
dentro la contraddizione che fonda il sistema-Italia: nella teoria, siamo tutti
uguali davanti alla legge, nella pratica la Repubblica nulla fa per rimuovere -
come da mandato dei padri costituenti - gli ostacoli che impediscano di godere a
pieno di tale principio. Con una denuncia chiara e nitida delle responsabilità
della politica e, in particolare, della sinistra. Se Norberto Bobbio, spiega il
costituzionalista, «scolpì la distinzione fra destra e sinistra in base al loro
atteggiamento verso l’idea dell’eguaglianza», tanto da farne la stella polare
dei progressisti, nei fatti tutti questi paladini dei più deboli, dei
diseredati, dei potentati economici non si vedono. Anzi, aggiunge Ainis, «in
Italia resistono i privilegi di stampo feudale», denunciati sempre e soltanto
dai movimenti liberali e radicali. Poco, anzi pochissimo, dai riformisti di
governo. La copertina del libro di Michele Ainis L’elenco del professore è
serrato: bancari che lasciano il posto ai figli (siamo al 20 per cento dei casi
in Italia), famigliari di ferrovieri che ancora nel 2015 viaggiano gratis sui
treni, assicuratori che ci propinano le polizze più care d’Europa, e ancora
tassisti che si proteggono con il numero chiuso. E avanti con farmacisti e
notai, definiti da Ainis “creature anfibie”, nel senso terrestre della funzione
pubblica e in quello acquatico dei guadagni privati. Spesso grazie a
strafalcioni semantici, come nel caso dei medici che per prendersi lo stipendio
dell’Asl e quello del privato a caccia di un luminare che risolva l’enigma di
una malattia si affidano, portafoglio alla mano, all’intramoenia extramuraria.
Uno scioglilingua che sembra scritto apposta per fregare i cittadini. Eppure,
denuncia Ainis, gli unici a reclamare non sono quelli della sinistra
parlamentare. Un saggio, dunque, ma anche un manuale delle fregature italiche
che la politica finge di non vedere. Una guida ragionata del delirio di una
democrazia che si professa a parole e non si applica nei fatti. Ainis spazia dal
lavoro, dove di fronte a tassi di disoccupazione da record, non c’è alcuna
trasparenza dell’offerta, nessuno “bandisce” i posti, consentendo una vera
concorrenza. Per non parlare delle donne, abbandonate a se stesse, senza aiuti
reali per educare i figli, dalla scarsità dei nidi alla casa, e rese dunque non
eguali nella concorrenza con gli uomini. D’altra parte, avverte il professore,
la sinistra «è anche quella che accetta i benefit di cui gode il Vaticano o in
generale lo statuto di favore attribuito alla confessione cattolica» in
un’Italia che, Costituzione alla mano, non ha certo una religione di Stato. Fino
al caso dei famosi prof di religione, che finiscono per mettere in tasca più
quattrini dei colleghi di ginnastica. Tanto per dimostrare anche nel
portafoglio, come lo spirito e il corpo non valgano uguale in Cielo, ma nemmeno
sulla Terra. E tanto per ricordare, come Ainis fa, che la legge sulla libertà
religiosa fu proposta «dal più democristiano fra i politici democristiani
(Andreotti durante il suo sesto governo, nel 1990), e poi mai approvata dagli
esecutivi di sinistra che si sono alternati nel quarto di secolo successivo».
Vale a dire Prodi, per due volte, D’Alema, Amato, Letta e Renzi. Per diventare
un paese dove essere poveri o nullatenenti sembra l’unico modo per non essere
attaccati o sospettati di chissà quale furto allo Stato o ai concittadini. In
un’escalation pauperista indegna di una democrazia. «Dunque fermiamoci, finché
siamo ancora in tempo», avverte Ainis. «Perché da un malinteso ideale di
giustizia deriva la massima ingiustizia». E perché da un’ideologia del genere
sgorga un veleno che può uccidere la democrazia stessa nel nome del quale si è
generato.
Non tutte le eguaglianze
sono eguali (e alcune fanno male),
scrive Sabino Cassese su “Il Corriere della Sera”. Nei primi giorni di gennaio,
l’incontro tra scienziati sociali e economisti americani tenutosi a Boston, nel
quale l’economista francese Thomas Piketty ha esposto le sue idee sulle
crescenti diseguaglianze di reddito e di ricchezza nelle società capitalistiche,
ha suscitato accesi dibattiti, trasformando una compassata riunione di circa 12
mila studiosi in un campo di battaglia, diviso tra coloro che ritengono
accettabile il livello di diseguaglianza delle nostre società e quelli che,
all’opposto, pensano che occorra porvi rimedio, semmai con una tassa mondiale
sulla ricchezza. Questo è solo un indizio dell’importanza del tema
dell’eguaglianza, al quale opportunamente Michele Ainis dedica un breve libro
(“La piccola eguaglianza”, Einaudi) che è, nello stesso tempo, di riflessione e
di divulgazione. Ainis parte da una ricchissima illustrazione di casi di
incongruenze amministrative e normative, di irrazionalità, di piccole iniquità,
di storture, per poi passare in rassegna piccole e grandi diseguaglianze ed
esporre e sviluppare, in forma divulgativa, idee maturate nei suoi lavori
scientifici. Spiega che alla eguaglianza in senso formale (tutti sono eguali di
fronte alla legge) si è venuta ad accostare l’eguaglianza in senso sostanziale
(per cui la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di
fatto l’eguaglianza). Rileva che le due declinazioni dell’eguaglianza sono in
conflitto. Infatti, la prima si esprime attraverso misure negative, la seconda
con azioni positive. La prima tende a conservare lo status quo , la seconda a
ribaltarlo. La prima comporta eguaglianza degli stati di partenza, la seconda
eguaglianza dei punti di arrivo. La prima ha come destinatario il singolo, la
seconda riguarda gruppi o categorie. Infine, la prima spinge verso discipline
uniformi, la seconda verso discipline differenziate. Per far consistere le due
declinazioni dell’eguaglianza, ambedue necessarie — continua Ainis — occorre
convincersi che la prima deve funzionare come regola, la seconda come eccezione
temporanea, destinata a durare finché le discriminazioni a danno di particolare
categorie siano finite. Le azioni positive «possono opporsi alle piccole
ingiustizie, quelle che penalizzano gruppi o classi di soggetti all’interno di
una comunità statale. La piccola eguaglianza, l’eguaglianza “molecolare” è tutta
in questi termini. E i suoi destinatari sono i gruppi deboli, le minoranze
svantaggiate». L’altra lezione che Ainis trae dalla sua ampia rassegna di casi è
quella che l’egualitarismo è pericoloso. L’eguaglianza radicale è l’antitesi
dell’eguaglianza, perché appiattisce i meriti e perciò salva i demeriti. Così
come l’appiattimento dei destini individuali, ispirato all’ideologia del
pauperismo, discende da un malinteso ideale di giustizia, da cui deriva la
massima ingiustizia. In un’Italia affamata di giustizia, temi come questi
dovrebbero divenire motivi di discussione quotidiana. Stanno maturando altre
esigenze di eguaglianza, mentre istituti chiamati ad assicurare l’eguaglianza
producono vistose diseguaglianze. Consideriamo solo quattro ostacoli
all’eguaglianza. Il primo è quello che deriva dall’accesso privilegiato al
lavoro e colpisce specialmente i giovani. Alle difficoltà del mercato del
lavoro, derivanti dalla limitatezza dell’offerta di posti di lavoro, si aggiunge
la scarsa trasparenza dell’offerta. Né i datori di lavoro privati né quelli
pubblici «bandiscono» i posti, consentendo conoscenza e concorrenza in modo
eguale a tutti. Al lavoro si accede, quindi, attraverso procedure privilegiate,
la famiglia, le conoscenze personali, i legami di «clan» politici, i canali
«mafiosi». Un secondo ostacolo è quello che non consente alle donne l’accesso al
lavoro. Carenza di provvidenze per la famiglia, scarsità di asili nido, mancanza
di supporti ai nuclei familiari escludono le donne dal lavoro (con il paradosso
che la loro presenza in ogni grado di scuola è prevalente, mentre diminuisce
sensibilmente negli altri luoghi di lavoro, con poche eccezioni, quali
l’insegnamento e la magistratura). Un terzo grave problema di giustizia sociale
riguarda gli immigrati. Sia i giudici sia il Parlamento stanno estendendo a loro
favore, ma in maniera contraddittoria e parziale, i diritti politici, i diritti
di libertà e i diritti a prestazioni da parte dello Stato (accesso alla scuola,
al sistema previdenziale, al sistema assistenziale, alla sanità) spettanti ai
cittadini. Ma dopo quanto tempo gli immigrati cominciano a godere di questi
diritti, avvantaggiandosi della solidarietà della collettività nella quale sono
entrati? Perché alcuni di questi diritti vengono riconosciuti e altri non lo
sono? Quali costi il riconoscimento comporta e quali condizioni, quindi, bisogna
porre a esso? Infine, lo Stato del benessere opera principalmente a favore dei
pensionati, meno per gli inoccupati e i disoccupati. Lo squilibrio delle risorse
conferite, per vincere le diseguaglianze, ai diversi rami del welfare produce,
paradossalmente, altre diseguaglianze.
Questo breve
saggio sul principio di eguaglianza e su ciò che lo mette in crisi si articola
in sei capitoli,
scrive Fulvio Cortese.
Il primo chiama
subito in causa la disperante concretezza del tema e si risolve in una
carrellata di esempi, tratti dalla cronaca, su quale sia, nel nostro paese, la
varia e diffusa fenomenologia della discriminazione.
Il secondo capitolo
spiega preliminarmente quale sia l’approccio migliore per garantire
l’eguaglianza, suggerendo che il principio possa garantirsi in modo credibile
solo in una prospettiva
relativa
– definita dall’Autore come “molecolare” – e quindi resistendo alla tentazione
di “alzare gli occhi al cielo” e di voler realizzare un’impossibile eguaglianza
assoluta.
Proprio in
questa direzione, il terzo capitolo chiarisce in modo sintetico, ma efficace,
come la dottrina costituzionalistica e la Corte costituzionale abbiano elaborato
e consolidato precise tecniche di analisi per verificare il puntuale rispetto
del principio da parte del legislatore.
Il quarto
capitolo si domanda se esitano anche dei criteri positivi per guardare
all’eguaglianza, da un lato evidenziando che il principio non esige sempre una
parità di trattamento verso l’alto o verso il basso (dipende dalla rilevanza
costituzionale del “diritto” cui di volta in volta si ambisce), dall’altro
ricordando che alla base di una corretta metabolizzazione dell’eguaglianza sta
la consapevolezza che essa non serve per assicurare a tutti un identico punto
d’arrivo, bensì per consentire a ciascuno di esprimere le proprie capacità.
Il quinto capitolo,
allora, è la
mise en place
delle acquisizioni maturate nel corso della trattazione, volgendo così lo
sguardo, in modo talvolta originale, a fattori differenzianti ancora e sempre
particolarmente spinosi (il sesso, l’età, l’etnia, la provenienza territoriale,
la religione; ma anche la pericolosa e strutturale frattura che si insinua
invariabilmente tra governanti e governati).
Il sesto capitolo,
infine, non ha un valore veramente conclusivo. Preso atto che la sinistra ha
ormai abbandonato il suo ruolo di essere paladina dei più deboli, il libro si
chiude con la sconsolata ricognizione del dibattito pubblico dei nostri giorni e
della costante e strisciante tentazione di molti a risolvere la percezione della
propria diseguaglianza nella speranza che i destini individuali si appiattiscano
e nell’affermazione dell’infelicità altrui. Nella parte in cui si limita a
rievocare – in modo peraltro riuscito – il succo della giurisprudenza
costituzionale sul principio di eguaglianza, la tesi “molecolare” illustrata da
Ainis non presenta profili di particolare novità, se non per un pubblico
totalmente digiuno del contributo che il diritto sa dare alla razionalizzazione
delle discriminazioni. Spunti intelligenti, però, ci sono, e si trovano
soprattutto dopo p. 84, nella parte in cui (capitolo quinto) l’Autore affronta
le “categorie dell’eguaglianza” e si pronuncia su come sciogliere i fattori
differenzianti sopra ricordati. Sulla diseguaglianza sessuale, si ribadisce
l’importanza delle
affirmative actions,
ma si ricorda che lo strumento va usato
con cura
e
a tempo,
e si guarda con scetticismo all’introduzione delle quote di genere nelle
competizioni elettorali. Si esprime, poi, cautela anche nei confronti della
tendenza giovanilistica che pretende di rimuovere le diseguaglianze anagrafiche
con una netta espulsione dei più vecchi; si critica la perdurante situazione di
minorità cui sono condannati gli stranieri, rimarcando come l’impossibilità di
esercitare il diritto di voto, specie a livello locale, comporti un’aperta
violazione del principio cardine “no taxation without representation”; si
sottolinea la sopravvenuta insostenibilità delle differenze di regime tra nuove
e vecchie minoranze (tanto che lo Stato appare “forte con i deboli, debole con i
forti”); si argomenta l’opportunità di considerare
apertis verbis
le differenze socio-economiche Nord-Sud, ripescando l’esperienza della gabbie
salariali; si insiste sul carattere indispensabile di una legge sulla libertà
religiosa (per non dover più ammettere, con Orwell, che “tutti gli animali sono
uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”); si guarda, infine, alle lezioni
degli antichi per ristrutturare i vizi della democrazia dei moderni
(ipotizzando, ad esempio, non solo il ricorso a forme di
recall,
ma anche l’introduzione del sorteggio per talune cariche pubbliche, e anche per
affidare ad una rappresentanza qualificata di cittadini alcune funzioni su cui i
parlamentari versano in conflitti di interesse: “la verifica dei poteri, le
cause di ineleggibilità e d’incompatibilità, il giudizio sulle loro immunità, la
legge elettorale, la misura dell’indennità percepita da deputati e senatori, il
finanziamento dei partiti”). Michele Ainis – che oltre ad essere un apprezzato
costituzionalista e un noto opinionista, è anche un
romanziere
– si conferma uno scettico costruttivo, che non cede mai al fascino di visioni
radicali e ottimalistiche, e il cui sforzo appare quello di fornire, come se
fossero pillole, un po’ di istruzioni per l’uso a chi siede nella cabina di
pilotaggio delle riforme.
Eguaglianza molecolare,
scrive l'8 febbraio 2015 Il Sole 24 Ore, ripreso da Stefano Azzara sul suo Blog
"Materialismo Storico". In un episodio della serie Dr. House, il medico
televisivo politicamente scorretto si trova di fronte un paziente di colore, il
quale si aspetta la prescrizione di un farmaco largamente usato dalla
popolazione bianca, che però sarebbe inefficace a causa delle caratteristiche
genetiche dell’uomo (data cioè la sua appartenenza etnica). Quando House gli
prescrive un diverso farmaco, il paziente lo insulta, accusandolo di razzismo.
Il nostro ritiene tempo perso cercare di spiegargli la questione, e se ne libera
accontentandolo, cioè discriminandolo rispetto a un bianco per quanto riguarda
l’appropriatezza del trattamento. Le decisioni che si prendono in ambito medico
continuano a essere utili, come lo erano per Socrate, Platone e Aristotele, per
ragionare sulla logica delle regole da usare per trattare gli altri e governare
una società con giustizia, nonché sugli aspetti della psicologia umana che
interferiscono con l’efficace uso di tali regole. La medicina e i medici non
sono più quelli dell’antichità o di prima dell’avvento della medicina
sperimentale, nel senso che fanno riferimento al metodo scientifico per
controllare l’adeguatezza dei trattamenti. Un metodo che ha stabilito il
principio che i pazienti vadano trattati in modo eguale, salvo che non vi siano
ragioni valide, cioè dimostrabili e controllabili, per fare diversamente. Il
biologo molecolare e premio Nobel Francois Jacob ha ricordato che l’eguaglianza,
come categoria morale e politica, è stata inventata «precisamente perché gli
esseri umani non sono identici». Lo studio dei contorni concreti della diversità
biologica in rapporto all’idea astratta e controintuitiva dell’eguaglianza
politica e morale, usando i risultati che scaturiscono dalla ricerca
naturalistica e che dimostrano le difficoltà psicologiche individuali di
elaborare un’idea razionale di giustizia, può essere un’ottima opportunità di
avanzamento anche per le scienze umane. Che comunque arrivano a conclusioni
coerenti e valide anche confrontando i risultati che derivano dall’uso di idee
diverse di eguaglianza. Infatti, anche per il costituzionalista Michele Ainis,
«la storia del principio di eguaglianza è segnata dalla differenza, non dalla
parità di trattamento. [...]è segnata dalla progressiva consapevolezza della
necessità di differenziare le situazioni, i casi, per rendere effettiva
l’eguaglianza». Il libro di Ainis passa in rassegna le diseguaglianze o i
soprusi causati da leggi ideologiche o etiche, che prevalgono in Italia rispetto
ad altri Paesi. E argomenta che non è prendendo di mira le macro-diseguaglianze
(es. sconfiggere la povertà nel mondo) che si riesce a migliorare il
funzionamento delle società umane, ma concentrandosi sulle dimensioni micro,
dove si può più agire per ripristinare una concreta giustizia sociale e
politica. Se si osservano le diseguaglianze con il microscopio, invece che con
il cannocchiale, e si va alla ricerca di un’«eguaglianza molecolare», cioè non
tra individui, ma tra gruppi o categorie, ci si può aspettare almeno una
gestione «minima, ma non minimale» dei problemi e delle sfide. Ainis ricorda un
fatto, dietro al quale esiste una montagna di prove, cioè che l’eguaglianza ha a
che fare con la giustizia, e che siamo disposti ad accettare un danno piuttosto
che un’ingiustizia. Si tratta di una predisposizione evolutiva che funziona come
un universale umano, e implica che si devono negoziare politicamente i valori,
sapendo che questi tendono a variare nelle società complesse, e che la loro
diversità è una risorsa da valorizzare. Ciò può essere fatto usando tre criteri:
a) evitando di pensare che eguaglianza equivalga a identità; b) le decisioni che
differenziano i diversi casi devono avere una base di ragionevolezza; c) usare
proporzionalità o misura, per stabilire un vincolo oggettivo grazie al quale le
decisioni legali continuino a dimostrarsi migliori nel discriminare e pesare
fatti e contesti, rispetto alla politica. Il libro di Ainis è una salutare
lezione di politica e diritto in chiave liberale, cioè suggerisce una strategia
che coincide con i principi di fondo del liberalismo, per governare
efficacemente società umane complesse e fortemente dissonanti rispetto alle
predisposizioni evolutive che condizionano il comportamento umano. È un fatto
che nell’età moderna i sistemi liberali si sono dimostrati, col tempo, le
strategie migliori, anzi meno peggio di tutte le altre, per evitare che le
diversità naturali diano luogo a diseguaglianze e quindi ingiustizie e
sofferenze. Ma perché le idee liberali sono migliori? A parte la banale
considerazione che non incarnano una credenza cioè non riflettono un’ideologia,
ma un metodo, alla domanda risponde l’ultimo libro di Michael Shermer, editor di
Skeptic e uno dei più lucidi sostenitori dell’esigenza di superare
l’antinaturalismo che ancora caratterizza in larga parte l’epistemologia delle
scienze umane. Shermer riassume lo stato delle conoscenze e dei dati che
dimostrano che nel corso degli ultimi due secoli si è avuto un massiccio
progresso morale, e che tale risultato è dovuto al prevalere della scienza e
della razionalità negli affari umani. Soprattutto per quanto riguarda l’economia
e il governo della società. L’efficacia del metodo scientifico e i presupposti
sociali per farlo funzionare hanno ispirato anche la logica del
costituzionalismo liberale. Rilanciando alcune idee di James Flynn e di Steven
Pinker e passando in rassegna una serie impressionante di prove, intercalate da
storie e aneddoti, Shermer ritiene che la diffusione della scienza, e in modo
particolare del metodo scientifico, abbia determinato uno sviluppo delle
capacità di astrazione e quindi un livello di razionalità che ha consentito alle
persone di capire l’infondatezza e l’ingiustizia delle discriminazioni di
genere, religione, sesso o appartenenza tassonomica. L’immagine dell’arco morale
è presa da un celebre discorso di Martin Luther King, per il quale tale arco «è
lungo, ma flette verso la giustizia». Shermer ritiene che le forze che hanno
piegato l’arco morale sono la scienza e la razionalità.
Siamo tutti bravi a
sciacquarci la bocca sull'uguaglianza. Ecco il fenomeno dei populisti.
Il Populismo.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il populismo (dall’inglese
populism, traduzione del russo народничество narodničestvo) è un
atteggiamento culturale e politico che esalta il popolo, sulla base di principi
e programmi ispirati al socialismo, anche se il suo significato viene spesso
confuso con quello di demagogia. Il populismo può essere sia democratico e
costituzionale, sia autoritario. Nella sua variante conservatrice è spesso detto
populismo di destra. Prende il nome dall'omonimo movimento sviluppatosi in
Russia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che proponeva un
miglioramento delle condizioni di vita delle classi contadine e dei servi della
gleba, attraverso la realizzazione di un socialismo basato sulla comunità rurale
russa, in antitesi alla società industriale occidentale. Un partito populista (Populist
o People’s party) venne fondato nel 1891 anche negli Stati Uniti da
gruppi di operai e agricoltori che si battevano per la libera coniazione
dell’argento, la nazionalizzazione dei mezzi di comunicazione, la limitazione
nell’emissione di azioni, l’introduzione di tasse di successione adeguate e
l’elezione di presidente, vicepresidente e senatori con un voto popolare
diretto; sciolto dopo le elezioni presidenziali del 1908. Il termine è stato
riferito alla prassi politica di Juan Domingo Perón (vedi la voce peronismo e la
sua recente variante di sinistra, il kirchnerismo), al bolivarismo e al
chavismo, in quanto spesso fanno riferimento alle consultazioni popolari e ai
plebisciti, perché il popolo decida direttamente nei limiti della Costituzione.
Il movimento precursore di questa idea di democrazia può essere indicato e
riconosciuto nel bonapartismo (Napoleone I e Napoleone III, in accezione
cesaristica) e nella rivoluzione francese, specialmente nelle fazioni che si
rifacevano alle idee politiche del filosofo Jean-Jacques Rousseau, come i
giacobini. In Italia è stato spesso usato con accezione negativa, nei confronti
del fascismo o del berlusconismo, e di vari movimenti leaderistici, spesso
affini alla destra, ma anche al centro-sinistra (come l'Italia dei Valori di
Antonio Di Pietro); spesso questi gruppi hanno rifiutato questa etichetta.
L'accezione del termine in senso positivo, come "vicinanza al popolo e ai suoi
valori", è stata invece rivendicata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio per
il proprio movimento politico. La parola populismo può avere numerosi campi di
applicazione ed è stata usata anche per indicare movimenti artistici e
letterari, ma il suo ambito principale rimane quello della politica. In ambito
letterario si intende per populismo la tendenza a idealizzare il mondo popolare
come detentore di valori positivi. Il largo uso che i politici e i media fanno
del termine "populismo" ha contribuito a diffonderne un’accezione
fondamentalmente priva di significato: è rilevabile infatti la tendenza a
definire "populisti" attori politici dal linguaggio poco ortodosso e aggressivo
i quali demonizzano le élite ed esaltano "il popolo"; così come è evidente che
la parola viene usata tra avversari per denigrarsi a vicenda – in questo caso si
può dire che "populismo" viene talvolta considerato dai politici quasi come
un sinonimo di "demagogia". La definizione di "populismo" data dal
vocabolario Treccani è "...atteggiamento ideologico che, sulla base di princìpi
e programmi genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e
velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi. Con
significato più recente, e con riferimento al mondo latino-americano, in
particolare all’Argentina del tempo di J. D. Perón (v. peronismo), forma di
prassi politica, tipica di paesi in via di rapido sviluppo dall’economia
agricola a quella industriale, caratterizzata da un rapporto diretto tra un capo
carismatico e le masse popolari, con il consenso dei ceti borghesi e
capitalistici che possono così più agevolmente controllare e far progredire i
processi di industrializzazione.".
La definizione di "populismo"
data dal dizionario Garzanti è:
1. atteggiamento o movimento
politico, sociale o culturale che tende all’elevamento delle classi più povere,
senza riferimento a una specifica forma di socialismo e a una precisa
impostazione dottrinale;
2. (spreg.) atteggiamento
politico demagogico che ha come unico scopo quello di accattivarsi il favore
della gente;
3. (st.) movimento
rivoluzionario russo della seconda metà del XIX secolo, anteriore al diffondersi
del marxismo, che teorizzava il dovere degli intellettuali di mettersi al
servizio del popolo.
Per alcuni tale nozione sembra
essere più volta a spiegare fenomeni politici passati che non a descrivere il
significato attuale del termine. Populista, oggi, è piuttosto chi accetta come
unica legittimazione per l'esercizio del potere politico quella derivante dal
consenso popolare. Tale legittimazione è considerata unica e di per sé
sufficiente a legittimare un superamento dei limiti di diritto posti, dalla
Costituzione e dalle leggi, all'esercizio del potere politico stesso. Il termine
non ha alcun legame con una particolare ideologia politica (destra o sinistra) e
non implica un raggiro del popolo (come al contrario implica la demagogia), ma
anzi presuppone un consenso effettivo del popolo stesso. Per altri la parola in
ambito politico conserva il senso dispregiativo sinonimo di demagogia. Il
termine nasce come traduzione di una parola russa: il movimento populista è
stato infatti un movimento politico e intellettuale della Russia della seconda
metà del XIX secolo, caratterizzato da idee socialisteggianti e comunitarismo
rurale che gli aderenti ritenevano legate alla tradizione delle campagne russe.
Allo stesso modo il termine può essere considerato legato al People's Party, un
partito statunitense fondato nel 1892 al fine di portare avanti le istanze dei
contadini del Midwest e del Sud, le quali si ponevano in conflitto con le
pretese delle grandi concentrazioni politiche industriali e finanziarie, e
anch’esso caratterizzato da una visione romantica del popolo e delle sue
esigenze.
Gli studiosi di scienze
politiche hanno proposto diverse definizioni del termine ‘populismo’. «A
ognuno la sua definizione di populismo, a seconda del suo approccio e interessi
di ricerca», ha scritto Peter Wiles in Populism: Its Meanings and
National Characteristics (1969), il primo testo comparativo sul populismo
internazionale curato da Ernest Gellner e Ghita Ionescu. Tuttora giornalisti e
studiosi di scienze politiche usano spesso il termine in maniera contraddittoria
e confusa, alcuni per fare riferimento a costanti appelli alla gente che
ritengono tipici di un politico o un movimento, altri per riferirsi a una
retorica che essi considerano demagogica, altri infine per definire nuovi
partiti che non sanno come classificare. Negli ultimi anni diversi studiosi
hanno proposto nuove definizioni del termine allo scopo di precisarne il
significato. Ad esempio, nel loro volume Twenty-First Century Populism: The
Spectre of Western European Democracy, Daniele Albertazzi e Duncan McDonnell
hanno definito il populismo come «una ideologia secondo la quale al ‘popolo’
(concepito come virtuoso e omogeneo) si contrappongono delle élite e una serie
di nemici i quali attentano ai diritti, i valori, i beni, l’identità e la
possibilità di esprimersi del popolo sovrano». Regimi come quello fascista
nella persona di Mussolini, quello nazista di Hitler e in generale la maggior
parte delle dittature, sono un perfetto esempio del rapporto diretto fra il
leader e le masse che si definisce populismo. Ma al di là di questo e di
alcune caratteristiche retoriche, la definizione di populismo è rimasta
estremamente vaga, facendone per lungo tempo una comoda categoria residuale,
buona per catalogare una grande varietà di regimi difficili da classificare in
maniera più precisa ma nei quali era possibile ritrovare qualche elemento
comune. Questi elementi erano la retorica nazionalista ed anti-imperialista,
l’appello costante alle masse e un notevole potere personale e carismatico del
leader. Questa concezione nebulosa del populismo è stata utile durante la
seconda metà del Novecento per inserire in una categoria comune vari regimi del
Terzo Mondo, come quello di Juan Domingo Perón in Argentina, Gamal Abd el-Nasser
in Egitto e Jawaharlal Nehru in India, che non potevano essere definiti
democrazie liberali né socialismi reali. Un’altra accezione di populismo (ma
neanche questa tenta di dare al termine una definizione precisa) è quella che lo
rende un “contenitore” per movimenti politici di svariato tipo (di destra come
di sinistra, reazionari e progressisti, e via dicendo) che abbiano però in
comune alcuni elementi per quanto riguarda la retorica utilizzata. Per esempio,
essi attaccano le oligarchie politiche ed economiche ed esaltano le virtù
naturali del popolo (anch’esso mai definito con precisione, e forse
indefinibile), quali la saggezza, l’operosità e la pazienza. Il populismo
guadagna perciò consensi nei momenti di crisi della fiducia nella "classe
politica". Il politologo Marco Tarchi, in "L'Italia populista", ricostruisce le
vicende del populismo in Italia, dove i momenti di minima fiducia nella politica
(e nei politici) si sono avuti con la Seconda guerra mondiale e con la denuncia
della corruzione del sistema politico a seguito delle inchieste di Mani Pulite.
Tarchi si sofferma soprattutto sui due movimenti più schiettamente populisti:
l'Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini (l'"uomo qualunque" contro l'"uomo
politico") e la Lega Nord (il "popolo del nord" contro "Roma ladrona"). Nella
politica italiana contemporanea per Guy Hermet Forza Italia è invece un esempio
di «neo-populismo mediatico», ovvero una forma di demagogia che fa dei mass
media il suo veicolo di diffusione.
Tutti populisti,
scrive Leopoldo Fabiani su “L’Espresso”. Chi è più populista, Beppe Grillo o
Matteo Salvini? E se scoprissimo che a battere in breccia tutti e due fosse
invece Matteo Renzi? Volendo, ognuno potrebbe divertirsi a compilare la propria
classifica, seguendo le indicazioni fornite da Marco Tarchi nel libro
Italia populista
(il Mulino, 380 pagine, 20 euro), seconda edizione sostanziosamente aggiornata
rispetto alla prima del 2003. Partiamo dalla definizione: più che un'ideologia o
uno stile politico, dice Tarchi, il populismo è una
mentalità.«Che
individua il popolo come una totalità organica artificiosamente divisa da forze
ostili, gli attribuisce naturali qualità etiche, ne contrappone il realismo, la
laboriosità e l'integrità all'ipocrisia, all'inefficienza e alla corruzione
delle oligarchie politiche, economiche sociali e culturali e ne rivendica il
primato, come forma di legittimazione del potere, al di sopra di ogni forma di
rappresentanza e di mediazione». Alla luce di questa definizione e seguendo il
percorso del libro tra le varie formazioni italiane ed europee che populiste
possono essere classificate, si potrebbe dire che oggi tutta la politica è
populista. A destra come a sinistra. E in fondo, si può aggiungere, quando
Angela Merkel sostiene che non si capisce perché l'operaio tedesco dovrebbe
pagare per l'incapacità e le ruberie dei governanti greci, ecco che anche
l'austera cancelliere propone un discorso populista, sia pure in un'inedita
forma “transnazionale”. Se la mentalità populista è ormai così pervasiva da aver
egemonizzato tutta la politica, si potrebbe essere tentati di concludere che è
inutile oggi demonizzare il populismo, che i politici sono in qualche modo
obbligati a parlare questo linguaggio. E che poi quello che conta è quello che
fanno. Ma proprio qui c'è un problema: si sono visti molti leader ottenere
consensi, anche ampi, esaltando questa mentalità. Qualcuno, Berlusconi per
esempio, così è anche riuscito ad andare al potere. Ma nessuno poi è stato
capace di governare. Almeno finora.
Siamo tutti populisti.
Se è comunicazione personale diretta, allora va ben oltre la Lega, Grillo e
Berlusconi. Diventa un imperativo per chiunque intenda imporsi, scrive Ilvo
Diamanti su
“La Repubblica”.
C'è un fantasma che si aggira in Europa e in Italia. Inquietante e opprimente.
Il populismo. Una minaccia diffusa, che echeggia in questa confusa campagna
elettorale, in vista delle Europee. Eppure "mi" è difficile spiegare di che si
debba avere "paura". Il populismo, infatti, associa forze politiche diverse e,
talora, opposte fra loro, ma "unite" contro l'Unione Europea e contro l'Euro. Il
termine, ad esempio, viene applicato al Front National, in Francia, e alla Lega,
in Italia. Insieme ad altri partiti, di altri Paesi, fuori dall'Euro. Come
l'Ukip, in Inghilterra. Anche se il Fn e l'Ukip si oppongono alla Ue in nome
della sovranità, rispettivamente, della Francia e dell'Inghilterra. La Lega,
invece, in nome dell'indipendenza dei popoli padani e contro la sovranità
dell'Italia. Fino a poco più di vent'anni fa, al contrario, era a favore
dell'Europa - delle Regioni. Ma la Lega è abituata a cambiare idea, in base alle
convenienze. Come ha fatto nei confronti dei veneti(sti). Nel 1997, al tempo
dell'assalto al campanile di San Marco, i Serenissimi, secondo Bossi, erano
"manovrati dai servizi segreti italiani". Oggi, invece, sono perseguitati
dall'imperialismo romano. Ma la lista dei populisti va ben oltre. Coinvolge gli
antieuropeisti del Nord Europa e quelli dell'Est. Per tutti e fra tutti, il
Fidesz di Viktor Orbán che ha trionfato di recente in Ungheria (dove Jobbik,
movimento di estrema destra, ha superato il 20%). Oltre ad Alba Dorata, in
Grecia. In Italia, però, il populismo è un'etichetta applicata senza molti
problemi. Riguarda, anzitutto, il M5s e Beppe Grillo. Per il loro
euroscetticismo ma, soprattutto, per l'esplicita opposizione alla democrazia
rappresentativa. In nome del "popolo sovrano" che decide da solo. Senza
rappresentanti. Grazie al referendum che ormai si può svolgere in modo
permanente nella piazza telematica. La Rete. Naturalmente, il Popolo, per
potersi riconoscere come tale, ha bisogno di riferimenti comuni. Così si rivolge
a un Capo. Che comunichi con il Popolo direttamente. Senza mediazioni e senza
mediatori. Attraverso i Media. La Rete, ma anche la televisione. Dove il Capo
parla con me. Direttamente. In modo "personale". Non a caso, il Grande Populista
del nostro tempo è stato Silvio Berlusconi. Il Berlusconismo, in fondo, è
proprio questo: partito e Tv riassunti nella persona del Capo. La Rete ha
moltiplicato il dialogo personale. Perché tutti possono parlare con tutti. Con
il proprio nome, cognome, account e alias. Associato a un'immagine, una fotina,
un marchio, un profilo. Naturalmente, c'è bisogno di un blogger, che orienti il
dibattito e che, alla fine, tiri le somme. Ma che, soprattutto, dia un volto
comune a tanti volti (oppure un "voto" comune a tanti "voti"). Che fornisca una
voce comune a un brusio di messaggi fitto e incrociato. Senza Grillo, il M5s non
sarebbe un MoVimento. Ma un'entità puntiforme priva di "identità". Grillo,
d'altronde, sa usare la Tv, oltre che la Rete (guidato da Gianroberto
Casaleggio). La maneggia da padrone. C'è sempre senza andarci mai. È la Tv che
lo insegue, nelle piazze e, ora e ancora, nei teatri. Riprende e rilancia i suoi
video, prodotti e postati nel suo blog. Ma se il populismo è comunicazione
personale diretta senza mediazione, allora va ben oltre la Lega, Berlusconi e
Grillo. Diventa un imperativo per chiunque intenda imporsi, politicamente.
Perché deve saper usare la Tv e i nuovi media. Diventare protagonista di quella
che Georges Balandier ha definito "La messa in scena della politica". Come ha
fatto Matteo Renzi. Capace, meglio di ogni altro, di parlare direttamente al
"popolo". Di lanciare sfide simboliche e pratiche. In Italia, d'altronde, ogni
riforma promessa è rimasta tale. Imbrigliata da mille difficoltà, mille
ostacoli. Renzi, per questo, va veloce. E parla direttamente al popolo. A
ciascuno di noi. Guarda dritto nella macchina da presa. E ci chiama per nome. È
per questo che Grillo lo ha preso di mira, come il suo principale, vero "nemico"
(politico). Perché il popolo ha bisogno di un capo che gli indichi i suoi
nemici. Gli "altri" da cui difendersi. L'Europa, la globalizzazione, le banche,
i mercati. Gli "stranieri". Gli immigrati, i marocchini, i romeni, i veneti, i
romani, gli italiani. E, ancora, le élite, la classe politica, i partiti, i
giornalisti, i giornali, i manager, le banche, i banchieri. Così il catalogo dei
populismi si allarga, insieme all'elenco dei populisti. Berlusconi, Grillo,
Marine Le Pen (per non parlar del padre), Renzi. Ma anche Vendola, con il suo
parlar per immagini e il suo partito personalizzato. Lo stesso Monti, bruciato
dal tentativo di diventare pop, con il cagnolino in braccio (che fine avrà fatto
Empy?). Uscendo dal "campo" politico, Papa Francesco è, sicuramente, il più
bravo a parlare con il suo "popolo". Il più Pop di tutti di tutti. D'altronde,
alle spalle, ha esempi luminosi, come Giovanni Paolo II e, ancor più, Giovanni
XXIII. E poi è argentino, come Perón. Scivola sull'onda di una lunga tradizione.
Non è un caso, peraltro, che la fiducia nei suoi confronti sia molto più alta di
quella nella Chiesa. Perché Francesco, sa toccare il cuore dei fedeli (e degli
infedeli). E supera ogni confine. Ogni mediazione. Va oltre la Chiesa. Parla al
suo popolo, senza distinzioni (visto che la fiducia nei suoi riguardi viene
espressa da 9 persone su 10). Per questo, diventa difficile dire chi sia
populista. O meglio, chi non lo sia. Perché tutti coloro che ambiscano a imporsi
sulla scena pubblica debbono usare uno stile "populista". E lo ammettono senza
problemi, mentre ieri suonava come un insulto. Echeggiando Jean Leca: "Quel che
ci piace è popolare. Se non ci piace è populista". Oggi invece molti
protagonisti politici rivendicano la loro identità populista. Grillo e
Casaleggio, per primi, si dicono: "Orgogliosi di essere insieme a decine di
migliaia di populisti. (...) Perché il potere deve tornare al popolo". Mentre
Marine Le Pen si dichiara "nazional-populista", in nome del "ritorno alle
frontiere e alla sovranità nazionale". Meglio, allora, rinunciare a considerare
il "populismo" una definizione perlopiù negativa e alternativa alla democrazia.
Per citare, fra gli altri, Alfio Mastropaolo, ne fa, invece, parte. Come il
concetto di "popolo". Il quale, quando ricorre in modo tanto esplicito e
frequente, nel linguaggio pubblico, denuncia, semmai, che qualcosa non funziona
nella nostra democrazia "rappresentativa". Perché il "popolo" non trova canali
di rappresentanza efficaci. I rappresentanti e i leader non dispongono di
legittimazione e consenso adeguati. Perché il governo e le istituzioni non sono
"efficienti" e non suscitano "passione". Così non resta che il populismo.
Sintomo e al tempo stesso diagnosi del malessere democratico. Meglio non
limitarsi a scacciarlo con fastidio. Per guarire dal populismo occorre curare la
nostra democrazia.
«Generalmente sono di
piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso
vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono
ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si
presentano in 2 e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano
4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono
utilizzati per chiedere l'elemosina; spesso davanti alle chiese donne e uomini
anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che
faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al
furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché poco
attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le
donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle
frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano
nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o,
addirittura, di attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i
lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare.
Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le famiglie
rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è
riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia.
Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La
nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».
____________________________
Fonte: Relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione
del Congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani, ottobre 1919.
Razzismo, la gaffe di
Germano: falso il testo letto ai bimbi rom.
Elio Germano, attore figo,
impegnato e perciò di sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla
mobilitazione contro Salvini. Ma ha fatto una clamorosa gaffe, scrive Giampaolo
Rossi su “Il Giornale”. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di
sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione delle
anime belle contro Salvini e il pericolo della destra intollerante e,
soprattutto, ignorante. Per questo ha realizzato un video contro il razzismo; ha
preso un gruppo di bambini Rom sullo sfondo di una roulotte, si è seduto in
mezzo a loro e ha iniziato a leggere un documento con tono recitato (come si
addice ai grandi attori) e l’aria di chi sta svelando al mondo una verità
nascosta ma scontata. Il testo è una descrizione offensiva e razzista degli
italiani emigrati in America agli inizi del ‘900, definiti ladri, puzzolenti,
stupratori, abituati a vivere dentro baracche fatiscenti e organizzati secondo
regole di clan. Elio Germano spiega che quel testo è un documento dell’allora
Ispettorato per l’Immigrazione degli Stati Uniti. L’obiettivo dell’attore è
ovvio: dimostrare che certi italiani di oggi sono razzisti verso gli immigrati e
i Rom, come lo erano gli americani verso gli italiani all’inizio del secolo.
Tutto molto bello e politically correct, se non fosse che, a quanto pare, quel
documento è una patacca, un falso. Il testo, che gira da molti anni su internet,
fu già utilizzato nel 2013 da Roberto Saviano (uno che di patacche se ne
intende) nel salottino televisivo di Fabio Fazio. Più recentemente, Carlo
Giovanardi, l’agguerrito deputato di centrodestra, ha pubblicato il vero
documento originale della Commissione Dillingham sull’Immigrazione, che non
contiene nulla di quanto letto dagli antirazzisti di mestiere, ma al contrario è
un’attenta analisi dell’immigrazione italiana del periodo. Che giudizi
sprezzanti e spesso offensivi contrassegnassero l’opinione pubblica americana
nei confronti degli italiani (soprattutto meridionali) è cosa appurata
storicamente da diversi studi. Ma quel documento che i fulgidi artisti di
sinistra si passano di mano in ogni occasione per dare del razzista a chiunque
contesti l’immigrazione clandestina, è una patacca degna della loro inutile
demagogia.
Saviano va in tv a spiegare
che una volta eravamo noi italiani gli zingari d’America.
Ma è una bufala. Giugno 12,
2013 Carlo Giovanardi. Ospite di Fabio Fazio, lo scrittore cita «un documento
dell’Ispettorato per l’immigrazione Usa» che tratta gli italiani come zecche.
Peccato che sia una patacca Domenica 26 maggio Roberto Saviano, intervistato da
Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, per combattere quella da lui
definita l’ondata di «odio morale verso gli immigrati» ha letto un testo. Cito
testualmente le sue parole: «Avevo visto e trascritto qui alcune parole della
relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso americano, quindi un
documento ufficiale del governo americano del 1912, così descrive gli italiani».
Ecco il testo letto da Saviano: «Gli italiani sono generalmente di piccola
statura e di pelle scura, non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché
tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno
e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Si presentano di solito in due, cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi
giorni diventano quattro, sei, dieci, tra loro parlano lingue a noi
incomprensibili probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono
utilizzati per chiedere l’elemosina, fanno molti figli che poi faticano a
mantenere. Dicono siano dediti al furto, e le nostre donne li evitano non solo
perché poco attraenti e selvatici, ma perché si parla di stupri o agguati in
strade periferiche. Propongo che si privilegino le persone del nord, veneti e
lombardi, corti di comprendonio e ignoranti, ma disposti più degli altri a
lavorare». Concludeva poi Saviano: «Incredibile che il nostro paese tutto questo
non lo ricordi, non ne faccia memoria attiva, ma lo trasferisca quando si
rivolge ad altre comunità o “etnie”». Conosco bene la storia dell’emigrazione
italiana e delle terribili discriminazioni e umiliazioni di cui i nostri
connazionali sono stati vittime all’estero ma, trovandomi per caso quella sera
davanti alla tv di Stato, mi è parso del tutto evidente il fumus di “patacca”
che emanava da frasi così volgari ed offensive in un documento ufficiale del
Senato degli Stati Uniti nei confronti di un intero popolo. Una rapida ricerca
su Google mi ha permesso di scoprire che già Paolo Attivissimo sul sito del
CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale),
aveva a suo tempo verificato che di quel testo erano in circolazione varie
versioni, una delle quali, lanciata da Rainews24, citava come fonte il
giornalista e conduttore televisivo Andrea Sarubbi che nel 2009 aveva
pubblicato un articolo con quella citazione. Sarubbi, interpellato, aveva
precisato di non aver tratto la citazione direttamente dal documento
statunitense originale. La sua frase: «Ho fra le mani un documento
dell’Ispettorato per l’immigrazione», non era quindi letterale, ma derivava da
una fonte italiana, «un articolo pubblicato un anno fa sul giornale Il Verona
dall’avv. Guarenti». Guarenti, a sua volta, dichiarava di averlo trovato «in un
libro di un anno fa» ma non era in grado di citare il titolo del libro.
Insomma, concludeva Attivissimo: «Siamo di fronte ad una situazione almeno di
terza mano di cui non si sa la fonte intermedia». Sulla traccia di Attivissimo
ho interpellato pertanto formalmente l’ambasciata americana che mi ha risposto
il 30 maggio: «La commissione sull’immigrazione degli Stati Uniti conosciuta
come la Dillingham Commission dal nome del senatore del Vermont che l’ha
presieduta ha lavorato dal 1907 al 1911 e ha pubblicato 41 volumi di rapporti
contenenti dati statistici sull’immigrazione negli Stati Uniti, l’occupazione
degli immigrati, le condizioni di vita, la scolarizzazione dei bambini, le
organizzazioni sociali e culturali, delle comunità degli immigrati e la
legislazione sull’immigrazione a livello statale e federale». Continuava poi
l’ambasciata americana: «Questi sono gli unici rapporti ufficiali
sull’immigrazione elaborati in quegli anni e disponibili al pubblico. Da una
visione superficiale, la citazione da lei riportata nella sua mail non appare in
nessuno di questi rapporti, ma per esserne certi bisognerebbe eseguire una
ricerca più accurata, per la quale purtroppo noi non siamo in grado di aiutarla
in questo momento». Aiutati che Dio ti aiuta, ho consultato tramite la mail
inviatami dall’Ambasciata tutti i volumi senza trovar traccia del documento
citato da Saviano, ma viceversa una interessantissima disamina sull’immigrazione
dell’Italia che ho fatto tradurre dall’inglese e si può leggere sul sito
www.carlogiovanardi.it. Per il resto ringrazio Saviano che mi permette di
aggiungere il XII ed ultimo capitolo al libro intitolato Balle che sto
pubblicando, dove spiego come l’opinione pubblica italiana fonda le sue
convinzioni su vere e proprie bufale che vengono troppo spesso disinvoltamente
spacciate come verità.
61ª legislatura, Documento n.
662, RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL'IMMIGRAZIONE. DIZIONARIO DELLE RAZZE O
POPOLI. Presentato da DILLINGHAM il 5 dicembre 1910 alla Commissione
sull'immigrazione [...] ITALIANO. La razza o
il popolo dell'Italia. L'Ufficio dell'immigrazione [Bureau of Immigration]
divide questa razza in due gruppi: Italiani settentrionali e Italiani
meridionali. Fra i due gruppi vi sono delle differenze materiali, riconducibili
a lingua, aspetto fisico e carattere, e delle differenze relative, rispetto alla
distribuzione geografica. Il primo gruppo identifica gli italiani nativi del
bacino del Po (compartimenti del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emelia [sic],
i distretti italiani in Francia, Svizzera e Tirolo (Austria) e i loro
discendenti. Tutti i popoli della penisola geograficamente definita e delle
isole della Sicilia e della Sardegna sono Italiani meridionali. Anche Genova è
meridionale.
Linguisticamente,
l'italiano
rappresenta una delle grandi divisioni del gruppo di lingue romanze derivate dal
ceppo latino della famiglia ariana. Esso è articolato in molti dialetti, la cui
separazione e conservazione è favorita dalla configurazione geografica
dell'Italia. Hovelacque divide questi dialetti in tre gruppi: superiore,
centrale ed inferiore. Il primo comprende i dialetti genovese, piemontese,
veneto, emiliano e lombardo; il gruppo centrale comprende toscano, romanesco e
còrso; il gruppo inferiore comprende napoletano, calabrese, siciliano e sardo.
Questi dialetti differiscono fra di loro molto più che i dialetti inglesi o
spagnoli. Si dice che è difficile per un Napoletano o un Sardo farsi capire da
un nativo della pianura padana. Forse più che in qualsiasi altro paese, le
classi colte restano tenacemente aggrappate all'uso del dialetto in àmbito
familiare, preferendolo alla forma letteraria nazionale della lingua. Tale forma
letteraria è rappresentata dal dialetto toscano di Firenze, come codificato
nella letteratura di Dante, Petrarca e Bocaccio [sic] nel XIV secolo.
Anche altri dialetti, tuttavia, hanno una considerevole letteratura, soprattutto
il veneto, il lombardo, il napoletano e il siciliano. Quest'ultimo ha una poesia
particolarmente ricca. Tutto il gruppo superiore di dialetti – per restare alla
definizione di Hovelacque – tranne il genovese, è settentrionale. Tali dialetti
contengono molti elementi gallici o celtici e mostrano affinità con le lingue
provenzali e retoromanze (ladino e friulano), con le quali confinano ovunque
tranne che al sud. Il genovese e i dialetti del gruppo centrale ed inferiore
sono parlati dagli Italiani meridionali.
Fisicamente,
gli Italiani sono una
razza tutt'altro che omogenea. La catena montuosa degli Appennini forma una
linea geografica che costituisce un confine fra due gruppi etnici distinti. La
regione a nord di questa linea, la valle del Po, è abitata da persone – i
Settentrionali – abbastanza alte e con la testa larga (la razza "alpina"). Gli
abitanti delle zone orientali ed occidentali di questa regione mostrano apporti
teutonici in Lombardia ed un'infusione di sangue slavo in Veneto. Tutta l'Italia
a sud dell'Appennino e tutte le isole adiacenti sono occupate da una razza
"mediterranea", di bassa statura, scura di pelle e con il viso lungo. Si tratta
dei "Meridionali", che discenderebbero dall'antica popolazione italica dei
Liguri, strettamente imparentati con gli Iberici della Spagna e i Berberi del
Nordafrica. Il principale etnologo italiano, Sergi, li fa derivare dal ceppo
amitico (v. Semitico-Amitico) del Nordafrica. Bisogna ricordare che gli
Amitici non sono negritici, né veri africani, sebbene si possa rintracciare un
apporto di sangue africano in alcune comunità in Sicilia e in Sardegna, oltre
che in Nordafrica. L'Ufficio dell'immigrazione pone gli Italiani settentrionali
nella divisione "celtica" e quelli meridionali in quella "iberica". La
commistione fra i due gruppi etnici è stata relativamente scarsa, anche se molti
Italiani settentrionali hanno doppiato gli Appennini ad est, facendo ingresso
nell'Italia centrale. Pertanto, la linea di demarcazione fra Emiliani e Toscani
è molto meno netta che fra Piemontesi e Genovesi. Un sociologo italiano,
Niceforo, ha indicato che questi due gruppi etnici differiscono profondamente
fra di loro, da un punto di vista sia fisico sia caratteriale. Egli descrive il
Meridionale come irritabile, impulsivo, molto fantasioso, testardo; un
individualista poco adattabile ad una società ben organizzata. Al contrario,
descrive il Settentrionale come distaccato, risoluto, paziente, pratico e capace
di grandi progressi nell'organizzazione politica e sociale della civiltà
moderna. Sia i Settentrionali sia i Meridionali sono dediti alla famiglia,
d'animo buono, religiosi, artistici ed industriosi. Sono quasi tutti di
religione cattolica. La maggior parte dell'immigrazione italiana negli Stati
Uniti è reclutata fra le classi contadine ed operaie. In America, tuttavia, essi
non hanno conseguito successo come agricoltori, con l'eccezione della
frutticoltura e dell'enologia, soprattutto in California, dove figurano ai primi
posti.
L'esperto di statistica
italiano Bosco ammette che l'Italia è tuttora al primo posto in termini di
numero di reati contro la persona, anche se questi sono diminuiti notevolmente
in seguito al miglioramento del sistema di istruzione e all'ampio flusso di
emigrazione. Su questo versante l'Italia è seguita nella graduatoria
dall'Austria, dalla Francia e, a una certa distanza, dall'Irlanda, la Germania,
l'Inghilterra e la Scozia. Niceforo indica, sulla base dei dati statistici
italiani, che tutti i reati, soprattutto i crimini violenti, sono molto più
numerosi tra i Meridionali che tra i Settentrionali. Il gioco d'azzardo è
diffuso. Il gioco del lotto è un'istituzione nazionale che viene utilizzata per
alimentare le casse dello Stato. Il brigantaggio è ormai pressoché estinto,
fatta eccezione per alcune parti della Sicilia. Le organizzazioni segrete come
la Mafia e la Comorra [sic], istituzioni molto influenti tra la
popolazione che esercitano la giustizia in proprio e sono responsabili di molta
parte della criminalità, prosperano nell'Italia meridionale. La maggiore
difficoltà nella lotta alla criminalità sembra risiedere nella propensione degli
Italiani a non testimoniare contro alcuno in tribunale e a riparare i torti
ricorrendo alla vendetta (v. Còrsi).
E' indicativo il fatto che
l'Italia sia uno dei paesi con il maggiore tasso di analfabetismo in Europa. Nel
1901 il 48,3% della popolazione dai sei anni in su non sapeva leggere e
scrivere. In quell'anno in Calabria, la parte più meridionale della penisola, il
tasso di analfabetismo tra le persone dai sei anni in su era pari al 78,7%. Il
tasso di analfabetismo più basso si registra nella valle del Po, nell'Italia
settentrionale. I Lombardi e i Piemontesi sono gli italiani più istruiti. La
situazione è tuttavia migliorata dopo che il governo ha reso l'istruzione
gratuita e obbligatoria tra i 6 e i 9 anni nei comuni dove vi erano le sole
scuole elementari e dai 6 ai 12 anni nei comuni dove erano presenti scuole di
più alto grado.
Tra le classi più umili la
povertà è estrema; le persone vivono in alloggi miseri e hanno accesso a
un'alimentazione carente, basata principalmente su granoturco mal conservato.
Perfino a Venezia sembra che un quarto della popolazione viva ufficialmente di
carità.
I confini geografici della
razza italiana sono più ampi di quelli dell'Italia. Gruppi numerosi sono
presenti in paesi vicini come Francia, Svizzera ed Austria. Le province del
Tirolo e dell'Istria, in Austria, sono per un terzo italiane. Ampi gruppi sono
inoltre presenti nel Nuovo Mondo. L'Italia stessa è quasi interamente italiana.
Ha una popolazione di 34 milioni di persone e comprende solo piccoli bacini di
altre razze (circa 80.000 Francesi nell'Italia nordoccidentale, 30.000 Slavi
nell'Italia nordorientale, circa 30.000 Greci nell'Italia meridionale, circa
90.000 Albanesi in Italia meridionale e in Sicilia e 10.000 Catalani (Spagnoli)
in Sardegna. Un certo numero di Tedeschi, forse meno di 10.000, è presente nelle
Alpi italiane. Circa due quinti della popolazione dell'Italia si trovano nella
valle del Po, ovvero in meno di un terzo della lunghezza del paese. Suddivisa
approssimativamente in compartimenti, la popolazione di quest'area, occupata da
Italiani settentrionali, conta circa 14 milioni di persone. Questa cifra include
i Friulani dell'Italia nordorientale i quali, pur parlando una lingua latina
distinta dall'italiano, sono difficilmente distinguibili dagli Italiani
settentrionali. Il loro numero si situerebbe, a seconda delle diverse stime, tra
50.000 e 450.000. La popolazione dei distretti meridionali è di circa 19.750.000
persone, di cui 125.000 appartengono ad altre razze. La maggior parte degli
Italiani della Francia, della Svizzera e dell'Austria sono sul piano della
razza Italiani settentrionali. Quelli della Corsica, isola appartenente alla
Francia, sono Italiani meridionali.
Distribuzione degli Italiani
(stima riferita al 1901)
In Europa:
Italia 33.200.000
Francia 350.000
Svizzera 200.000
Austria 650.000
Corsica 300.000
Altre parti d'Europa 300.000
Totale 35.000.000
Altrove:
Brasile 1.000.000
Rep. Argentina 620.000
Altre parti del Sudamerica
140.000
Stati Uniti 1.200.000
Africa 60.000
Totale 3.020.000
Totale nel mondo (cifra
approssimata) 38.000.000
A partire dal 1900, in alcuni
anni oltre mezzo milione di italiani è emigrato nelle diverse regioni del mondo.
All'incirca la metà di tale flusso ha come destinazione altri paesi europei ed è
di carattere temporaneo, in quanto riguarda sopratutto la popolazione maschile.
Dal 1899 fino a tutto il 1910 negli Stati Uniti sono stati ammessi 2.284.601
immigrati italiani, ed è stata altresì consistente l'immigrazione italiana
verso l'America del Sud. La maggior parte delle persone che giunge negli Stati
Uniti rientra successivamente in patria. Tuttavia, soprattutto a New York e
negli altri Stati dell'Est il numero di coloro che rimangono è elevato. Nel 1907
gli immigrati provenienti dall'Italia meridionale sono stati oltre 240.000, un
numero più che doppio rispetto alla razza di immigrazione che come consistenza
si colloca subito dopo quella degli immigrati italiani meridionali. Il numero
degli arrivi di Italiani settentrionali è solo un quinto di tale cifra. La
notevole capacità della razza italiana di popolare altre parti del mondo risulta
evidente dal fatto che la presenza italiana supera numericamente quella degli
Spagnoli nell'Argentina spagnola e dei Portoghesi in Brasile, nonostante
quest'ultimo sia un paese "portoghese". (vedi Ispanoamericani).
Attualmente, ai fini dello studio del fenomeno dell'immigrazione il flusso
migratorio degli Italiani verso gli Stati Uniti è forse il più significativo, e
non solo perché risulta essere molto più consistente di ogni altro gruppo
nazionale in qualunque anno di riferimento e perché è elevata la percentuale
degli Italiani per ogni mille immigranti che entra sul territorio degli Stati
Uniti. Ancora più significativo è il fatto che questa razza è più numerosa di
qualsiasi altra tra la decina di razze che figurano ai primi posti come tasso di
immigrazione. In altre parole, in virtù di una popolazione di 35.000.000 e di un
elevato tasso di natalità, questa razza continuerà a primeggiare anche quando la
spinta delle altre razze, attualmente responsabili dell'ondata di immigrazione,
tra cui gli Ebrei (8.000- 000[sic]), gli Slovacchi (2.250.000) e il gruppo
Sloveno-Croato (3.600.000), sarà esaurita, come di fatto sta già avvenendo per
gli Irlandesi. Un fatto non necessariamente noto è che nel decennio 1891-1900
l'Italia era il principale paese di origine dell'immigrazione in America.
All'inizio degli anni ottanta, ovvero quasi trent'anni fa, l'Italia aveva già
cominciato a guadagnare terreno rispetto ai paesi dell'Europa settentrionale.
Tuttavia bisognava attendere il 1890 per vedere gli Stati Uniti sorpassare
l'America meridionale come destinazione privilegiata dei flussi migratori
provenienti dall'Italia. Nel decennio precedente e nei periodi antecedenti il
Brasile ha accolto più italiani della Repubblica Argentina, sebbene si ritenga
erroneamente che sia quest'ultima ad ospitare la più grande comunità italiana
dell'America meridionale. Nel 1907 gli Stati Uniti hanno accolto 294.000 dei
415.000 Italiani emigrati oltreoceano. Nello stesso anno le persone emigrate,
per lo più temporaneamente, dall'Italia verso altri paesi europei sono state
288.774. L'immigrazione italiana negli Stati Uniti è stata finora
prevalentemente di carattere temporaneo. Mosso calcola che il periodo medio di
permanenza degli Italiani negli Stati Uniti sia di otto anni. L'emigrazione più
consistente verso oltreoceano dall'Italia ha la sua origine nelle regioni a sud
di Roma, abitate dagli Italiani meridionali. Gli emigrati provengono soprattutto
dalla Sicilia e dalla Calabria, ovvero dai territori meno produttivi e meno
sviluppati del paese. L'emigrazione dalla Sardegna (Vedi) è scarsa. Il
compartimento della Liguria, territorio di provenienza dei Genovesi, anch'essi
appartenenti alla razza degli Italiani meridionali, registra più emigrazione di
qualsiasi altra provincia dell'Italia settentrionale. Il flusso complessivo
dell'immigrazione verso l'America da alcuni compartimenti italiani ha raggiunto
proporzioni ingenti, al punto da superare più volte il tasso di crescita
naturale della popolazione. Questo ha già causato il parziale spopolamento di
alcuni distretti agricoli. Se confrontati con altre razze di immigrati e con il
numero assoluto degli arrivi, gli Italiani meridionali sono i più numerosi:
1.911.933 nei dodici anni compresi tra il 1899 e il 1910, seguiti dagli Ebrei,
1.074.442, dai Polacchi, 949.064, dai Tedeschi, 754.375 e dagli Scandinavi,
586.306. I Settentrionali sono al nono posto nell'elenco relativo allo stesso
periodo: 372.668, subito dopo gli Inglesi e gli Slovacchi, ma prima dei Magiari,
dei Croati e degli Sloveni e dei Greci. Per quanto riguarda il tasso del
movimento transatlantico, è piuttosto evidente un contrasto tra Settentrionali e
Meridionali: ad esempio, nel 1905 l'emigrazione dalla Calabria è stata undici
volte maggiore di quella proveniente dal Veneto. Nel 1907 l'indice dello
spostamento dei Settentrionali verso gli Stati Uniti è stato di circa il 3 per
1000 della relativa popolazione presente in Italia, mentre quello degli Italiani
meridionali è stato del 12 per 1000. L'indice di movimento dei Settentrionali è
stato più o meno lo stesso di quello degli Svedesi e dei Finlandesi, è stato il
triplo di quello dei Tedeschi, ma solo la metà di quello dei Ruteni provenienti
dall'Austria-Ungheria. Il tasso di movimento dei Meridionali verso gli Stati
Uniti, d'altra parte, è superato solo dal gruppo Croato-Sloveno, che nel 1907 è
stato del 13 per mille della popolazione, e dagli Ebrei e dagli Slovacchi che,
nello stesso anno, è stato del 18 per mille della popolazione. Gli immigrati
italiani giungono negli Stati Uniti, oltre che dall'Italia, principalmente dai
seguenti paesi: il Nordamerica britannico (3.800 nel 1907), l'Austria-Ungheria
(1.500), il Regno Unito (600), il Sudamerica (600) e la Svizzera (200). Quelli
provenienti dalla Svizzera e dall'Austria-Ungheria generalmente sono
Settentrionali.
Nei dodici anni tra il 1899 e
il 1910, le principali destinazioni negli Stati Uniti dei due gruppi di Italiani
sono state le seguenti:
Settentrionali
New York 94.458
Pennsylvania
59.627
California 50.156
Illinois 33.525
Massachusetts
22.062
Connecticut
13.391
Michigan 13.355
New Jersey 12.013
Colorado 9.254
Meridionali
New York 898.655
Pennsylvania
369.573
Massachusetts
132.820
New Jersey
106.667
Illinois 77.724
Connecticut
64.530
Ohio 53.012
Louisiana 31.394
Rhode Island
30.182
West Virginia
23.865
Michigan 15.570
California 15.018
Una poesia per i pataccari
di sinistra,
scrive “L’Anarca” (Giampaolo Rossi ) su “Il Giornale”. I discepoli intellettuali
del politically correct hanno l’abitudine di prendersi troppo sul serio; succede
sopratutto quando si cimentano nel nobile mestiere dell’impegno sociale mettendo
la loro fama e la loro arte a disposizione della lotta all’oscurantismo
reazionario. È successo anche a Elio Germano, l’attore militante che ha
realizzato il video-patacca contro il razzismo di cui abbiamo denunciato il
falso in questo articolo di ieri. Il video si conclude con l’attore che legge,
ad un gruppo di bambini Rom visibilmente annoiati e usati come scudi della sua
vanità ideologica, una poesia di Trilussa in romanesco. Per non essere da
meno, ho deciso di scrivere una poesia anche io, proprio nel dialetto di
Trilussa, dedicandola a Elio Germano, ai maestrini radical-chic e alle loro
false “verità assolute” diffuse come un virus. Un piccolo omaggio ironico
all’abitudine pataccara della sinistra intellettuale e artistica di spargere
scemenze spacciandole per verità.
L’ARTISTA DE SINISTRA
Il razzismo, se sa, è brutta
robba.
È segno de incivile
intolleranza tipica de chi ragiona co’ la panza.
Ma, di certo, ‘na cosa assai
più brutta
è l’intellettuale quanno
rutta.
Quanno se erge cor dito
moralista
e come er Padreterno,
dei buoni e dei cattivi fa la
lista.
Filosofo o scrittore, poeta o
cantautore, attore o saltimbanco,
è come se la storia
s’inchinasse all’astio livoroso e intelligente
de chi se crede sempre er più
sapiente.
Spesso nun sa manco de che
parla, ma parla per parla’
e per l’impegno preso e
coltivato con lo sdegno
de chi è convinto che deve
lascià un segno.
L’artista de sinistra in
tracotanza,
dall’alto del suo ego
trasformato,
diventa un drogato de
arroganza.
Lui se convince de esse come
un Faro,
invece, spesso, è solo un gran
Cazzaro.
Con gli islamisti non si
può dialogare.
Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di sicurezza;
un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia, scrive Piero
Ostellino su “Il Giornale”. Rispetto al fondamentalismo islamico, e all'esigenza
di conviverci senza danni per noi, alcuni studiosi americani suggeriscono che
l'Occidente prenda ad esempio la propria storia degli ultimi cinquecento anni.
Gli Asburgo, la maggior dinastia europea, «erano dei principi - scrive John M.
Owen in Confronting political Islam, Six lessons from the West's Past - non dei
preti». E si comportarono di conseguenza. Di fronte al radicalismo genericamente
anticattolico del protestantesimo, non fecero di ogni erba un fascio,
confondendo eretici estremisti ed eretici moderati e trattandoli allo stesso
modo, ma constatarono che il protestantesimo era diviso fin dalla nascita in
varie fazioni - luterani, calvinisti, anabattisti - e si acconciarono a
sfruttarne le divisioni. Fu un grosso rischio? L'approccio non era meno
rischioso di quello di fare la faccia feroce ad entrambi, ma ha funzionato.
Parimenti, nel XX secolo, gli Stati Uniti dovettero fronteggiare la moderna
sinistra politica, ostile alla democrazia liberale, al capitalismo e al libero
mercato. Ma non la considerarono, e per lo più non la trattarono, come faceva la
destra, come fosse un monolite, bensì utilizzarono ciò che divideva i socialisti
dai comunisti. E hanno avuto la meglio sul comunismo. L'islamismo moderato - a
differenza di quello fondamentalista, che ricorre volentieri alla violenza -
utilizza i mezzi pacifici e legali della democrazia liberale per diffondere la
sharia, la morale islamica. Non è liberale, ma rimane una teocrazia che ha fatto
una scelta strategica contro la violenza. Ciò non significa, ovviamente, che
l'Occidente possa, e debba, instaurare con esso «un dialogo», come suggeriscono
certe nostre anime belle. La stessa storia della cooperazione fra gli Asburgo,
cattolici, e i protestanti contro i calvinisti insegna che distinguere fra
fondamentalisti e moderati non è sempre facile e, se può rivelarsi positivo nel
breve termine, minaccia di essere fallimentare nel lungo. La prudenza non è mai
troppa. Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di
sicurezza; un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia; che,
rispetto alla democrazia liberale, rimane pur sempre una soluzione clericale.
Forse, c'è un altro esempio che l'Occidente dovrebbe seguire: quello di Edmund
Burke, il liberal-conservatore che difese il diritto delle colonie americane di
tassare i propri cittadini solo secondo i dettami delle proprie assemblee e non
secondo quelli del Parlamento di Londra. «I vostri affari - aveva scritto Burke
ai suoi amici francesi a proposito della Rivoluzione del 1789 - riguardano voi
soli; noi ce ne siamo occupati come uomini, ma ce ne teniamo alla larga perché
non siamo cittadini della Francia». È il linguaggio che, auspicabilmente,
l'Occidente dovrebbe usare nei confronti dell'islamismo...
Niente paura, leggete il
Corano. Ci troverete le radici del Male.
Per 56 anni ho creduto che l'islam potesse essere riformabile grazie a musulmani
moderati come me. Mi sbagliavo. Il libro sacro è la negazione della civiltà,
scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. «Allah Akhbar! Allah Akhbar!
Ash-hadu an-la ilaha illa Allah, Ash-hadu anna Muhammad-Rasul Allah». «Allah è
Grande! Allah è Grande! Testimonio che non c'è altro dio all'infuori di Allah,
Testimonio che Maometto è il Messaggero di Allah». Per vent'anni la mia giornata
è stata cadenzata dall'adhan, l'appello alla preghiera diffuso dall'alto dei
minareti nella mia città natale, Il Cairo, ribattezzata la «Città dai mille
minareti». Per 56 anni mi sono impegnato più di altri, da musulmano moderato, ad
affermare un «islam moderato» in Italia, aderendo e sostenendo sostanzialmente
la tesi del Corano «creato», che per l'ortodossia islamica pecca ahimè di una
fragilità teologica che scade nell'eresia. Perché così come il cristianesimo è
la religione del Dio che si è fatto Uomo e che s'incarna in Gesù, l'islam è la
religione del loro dio Allah che si è fatto testo e che si «incarta» nel Corano
dopo essere stato rivelato a Maometto attraverso l'Arcangelo Gabriele. Per i
musulmani quindi il Corano è Allah stesso, è della stessa sostanza di Allah,
opera increata al pari di Allah, a cui ci si sottomette e che non si può
interpretare perché si metterebbe in discussione Allah stesso. Per contro, la
tesi del Corano «creato», che sottintende che solo Allah è increato, consente
l'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti del Corano, che possono
essere oggetto di culto da parte della fede ma anche oggetto di valutazione e
critica; così come consente la contestualizzazione nel tempo e nello spazio dei
versetti rivelati per distinguere ciò che è da considerarsi attuale e lecito da
ciò che è invece è da ritenersi prescritto e caduco; ci mette in ultima istanza
nella possibilità di poter affermare la dimensione «plurale» dell'islam e, in
questo contesto di pluralismo, ci consente di far primeggiare la scelta
dell'«islam moderato» che concili la prescrizione coranica con il rispetto dei
valori fondanti della nostra comune umanità. Per 56 anni ho scelto di battermi
in prima persona, costi quel che costi, per affermare la bontà del Corano quale
testo sacro dell'islam pur nella denuncia del terrorismo islamico. Nel 2003,
dopo aver conosciuto Oriana Fallaci ed aver instaurato con lei un rapporto che,
al di là della reciproca stima professionale, della condivisione della denuncia
del terrorismo islamico e della pavidità dell'Occidente, si fondava su un
affetto sincero e una solida amicizia, tuttavia il nostro rapporto fu turbato
dal mio rifiuto di abbandonare l'islam e di concepire che la radice dell'islam
risieda nel Corano. Mi sentivo contrariato quando scriveva: «L'islam è il
Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la
Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani.
È incompatibile col concetto di civiltà». Eppure, all'indomani della mia
conversione al cristianesimo il 22 marzo 2008, ho scritto: «Ho dovuto prendere
atto che, al di là della contingenza che registra il sopravvento del fenomeno
degli estremisti e del terrorismo islamico a livello mondiale, la radice del
male è insita in un islam che è fisiologicamente violento e storicamente
conflittuale». L'errore in cui incorsi fu di immaginare che l'islam potesse
essere riformabile al suo interno grazie all'impegno dei musulmani moderati.
Alla fine, dopo oltre cinque anni trascorsi da condannato a morte dai terroristi
islamici e reiteratamente minacciato dagli estremisti islamici, mi sono arreso
di fronte all'evidenza: si può essere musulmani moderati come persone, ma non
esiste un islam moderato come religione. Oggi più che mai dobbiamo avere l'acume
intellettuale e il coraggio umano di leggere ad alta voce il Corano e di
affermare pubblicamente i suoi contenuti. Non possiamo essere vittime, da un
lato, dei musulmani moderati che difendono aprioristicamente e acriticamente
l'islam pur di salvaguardare la loro credibilità ed onorabilità, dall'altro,
degli occidentali che per paura di offendere i musulmani sostengono in modo
altrettanto aprioristico e acritico che il Corano insegna l'amore e la pace, che
i terroristi islamici non centrano nulla con l'islam. Solo leggendo il Corano
scopriamo la specificità di una religione che condanna di eresia l'ebraismo e il
cristianesimo; la realtà di Allah che era il dio supremo del Pantheon politeista
arabo, clemente e misericordioso con chi si sottomette all'islam ma vendicativo
e violento con i miscredenti; la verità di Maometto che è stato un guerriero
vittorioso che ha fondato una «Nazione di credenti» combattendo e uccidendo i
suoi nemici per ordine di Allah. Solo leggendo il Corano potremo capire le
radici di un'ideologia che legittima l'odio, la violenza e la morte, che ispira
il terrorismo islamico ma anche la dissimulazione praticata dai «musulmani
moderati», perseguendo il comune obiettivo di sottomettere l'intera umanità
all'islam, che è fisiologicamente incompatibile con la nostra civiltà laica e
liberale negando la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e
donna, la libertà di scelta. Solo leggendo il Corano potremo capire chi siamo
veramente noi, se siamo ancora o non più in grado di riscattare la civiltà di
verità e libertà, di fede e ragione, di valori e regole. L'Italia non ha subito
gravi attacchi dal terrorismo islamista, ma non può considerarsi al sicuro se si
tiene conto che da anni diversi imam predicano odio, dozzine di centri islamici
sono impegnati nel proselitismo e nel finanziamento a gruppi terroristici e che
il Paese sta esportando combattenti nei teatri della jihad. Lo rileva un
rapporto del Centro militare di studi strategici del ministero della Difesa. La
comunità islamica italiana è composta da 1,6 milioni di persone, un terzo degli
stranieri presenti, cui si aggiungono 60-70mila convertiti. Sono una ventina le
organizzazioni principali, più di 100 le moschee, 159 i centri islamici, decine
le scuole coraniche, tanti i siti internet. Secondo il dossier, «la
radicalizzazione della comunità islamica rappresenta una potenziale seria
minaccia». Dal 2001 ad oggi, circa 200 persone sono state arrestate con l'accusa
di terrorismo. Milano è l'epicentro del radicalismo islamico in Italia.
Ecco l'Italia che trasforma
il Tricolore in uno straccio.
La bandiera nazionale va esposta per legge davanti a scuole e uffici pubblici.
Ma nessuno se ne cura. E lo spettacolo è avvilente, scrive Nino Materi su “Il
Giornale”. L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui la Bandiera nazionale,
invece che garrire al vento, rantola in aria. Come un impiccato sul pennone più
alto. Tanto in alto che nessuno si premura di prendersene cura. Triste,
tristissima la vita del nostro glorioso Tricolore: tradizionale simbolo di
(dis)amor di Patria. Un vessillo di cui ci ricordiamo solo in occasione dei
Mondiali di calcio, almeno quelli in cui gli Azzurri non fanno figuracce. Ma poi
nella vita di tutti i giorni il vessillo Bianco, Rosso e Verde tende a virare in
commedia, assumendo i toni del bianco, rosso e verdone. Un film tragicomico (più
tragico che comico) che va «in onda» quotidianamente su ogni edificio pubblico:
scuole, biblioteche e uffici. Da Nord a Sud l'Unità d'Italia è fatta, ma si
incarna in quel pezzo di stoffa che viene vergognosamente esposto alla stregua
di uno straccio con cui si è appena smesso di fare le pulizie. E dire che nella
Costituzione figura un preciso dettato normativo sancito dalla Legge 5-02-1998
n.22 e dal Dpr 07-04-2000 n. 121, il cui capo IV (punto 9) recita testualmente:
«Le Bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate». Roba che
se la violazione venisse effettivamente perseguita, dovrebbe essere denunciata
la maggior parte dei funzionari statali. Non fanno eccezione neppure gli edifici
sedi di istituzioni «prestigiose» come prefetture, questure, tribunali. Ma anche
qui il Tricolore sventolante appare in salute come un moribondo. Non c'è
spettacolo più avvilente per un cittadino orgoglioso di essere italiano che
vedere la Bandiera della propria nazione ansimare sporca e stracciata. Fateci
caso. Quando entrate in un ufficio alzate lo sguardo e, nove volte su dieci,
sulla vostra testa vedrete curvo su se stesso un Tricolore sdrucito e sozzo.
Nessun direttore, funzionario, dirigente, impiegato, segretario (fin giù a
all'ultimo degli inservienti) che si ponga il problema non dico di lavare una
bandiera annerita o sostituirne una a brandelli. No. Si cambiano con periodica
perizia le merendine dalle macchinette degli uffici, ma del Tricolore non frega
nulla a nessuno. Lui può morire d'inedia nell'indifferenza generale. Beh, quasi
generale. Considerato che, almeno una persona, ha deciso di levare un urlo di
dolore in difesa di un simbolo per il quale sono morti migliaia di soldati. Si
tratta del Maggiore Gennaro Finizio, dell'Unuci (Unione ufficiali in congedo)
che in una lettera aperta al sito Basilicata24 denuncia lo scandalo-Bandiera:
«Se si vuol valutare l'orgoglio di un Popolo e pesarne il livello di diffusione
e condivisione del concetto di identità nazionale, è sufficiente osservare se,
ed in quale modo, espone la propria Bandiera; nel nostro caso, il Tricolore.
Ebbene, le condizioni in cui sono esposte le nostre Bandiere, sulle facciate
degli edifici pubblici e sedi di Istituzioni, riflettono chiaramente il livello
di crisi sociale e di sfiducia, segnalando la dimensione di un Paese che ha
perso i suoi punti di riferimento; un Paese impoverito nei Valori». Chi disonora
il Tricolore, infanga la propria Storia. E poi: «Non sfuggirà, all'osservatore
attento, che un po' ovunque sono presenti Tricolori laceri, sporchi e, nella
migliore delle situazioni, esposti in modo errato; Bandiere offese
indecorosamente sino al punto da sembrare private della forza di sventolare.
Come si legge questo degrado sociale? Abbiamo, forse, perso la nostra dignità e
la volontà di sentirci orgogliosamente italiani? Forse non crediamo più nel
nostro simbolo, perché derubricato a semplice icona della Nazionale di calcio?».
Il Maggiore Finizio prova anche a dare delle risposte: «Temo che tutto questo
sia da ascrivere a semplice, ma deleteria, incuria e mancanza di sensibilità.
Quella stessa sensibilità che troviamo ad esempio negli statunitensi, negli
inglesi, francesi e tedeschi». Da noi, invece, fino a qualche tempo fa, l'ex
leader della Lega poteva impunemente urlare in piazza contro una signora che
esponeva il Tricolore alla finestra: «Signora, con quella bandiera può anche
pulirsi il culo...».
Un Paese invivibile,
scrive Livio Caputo su “Il Giornale”. Nei due mesi scorsi mi sono dedicato a un
esercizio che si è rivelato molto deprimente: ho chiesto a cinquanta amici e
conoscenti quanti di loro avessero subito, negli ultimi tre anni, scippi, furti
in casa o in strada, truffe, vandalismi, violenze,richieste di pizzi o
tangenti, o altri “attacchi” da parte dei vari tipi di delinquenza, organizzata
e non. Ebbene, il risultato è stato 47, cioè quasi il 95 cento. Tra i racconti
che ho raccolto c’era di tutto e di più, perfino quello di due sedicenti
dipendenti comunali che si sono introdotti con un pretesto nell’abitazione di
una signora e, forse ipnotizzandola, forse drogandola, l’hanno persuasa a
consegnare “spontaneamente” tutti i suoi preziosi. Comunque, il campionario dei
reati subiti, che peraltro avrei potuto mettere insieme anche compulsando
attentamente la cronaca nera dei giornali, era talmente vario da poterci
scrivere un trattato di criminologia. L’impressione complessiva, comunque, era
che il Paese, nonostante le statistiche che danno un certo numero di reati in
calo, sia sempre più fuori controllo e che un senso di insicurezza si sia ormai
impadronito della maggioranza dei cittadini. Un altro dato inquietante emerso
dalla mia indagine è che buona parte delle vittime ha ormai rinunciato a
denunciare i reati subiti se non ci sono esigenze assicurative di mezzo. Che
senso, infatti, ha perdere tempo a denunciare il furto di una bicicletta, lo
scippo subito in un parco, una casa svuotata dagli zingari, quando le
possibilità di recuperare la refurtiva sono pari a zero? E, comunque, che
soddisfazione ricava il cittadino se l’autore del reato, nell’ipotesi remota che
venga individuato e arrestato, viene poi subito messo in libertà, libero di
reiterare il suo crimine anche l’indomani? O, se anche viene processato, se la
cava con pene lievi con la condizionale, o esce comunque di galera assai prima
di quanto dovrebbe per condoni, buona condotta, eccessivo affollamento delle
carceri o quant’altro? Una delle mie interlocutrici si è particolarmente
infuriata leggendo che una donna rom che l’aveva derubata è stata arrestata – mi
pare – una dozzina di volte e sempre rilasciata. In effetti, una delle cause
principali per cui non solo aumenta la delinquenza nazionale, ma bande di ladri,
rapinatori e scassinatori arrivano da ogni parte d’Europa per operare nel nostro
Paese è la quasi impunità di cui, alla fine, finiscono di godere. Come reagiamo
di fronte a questi fenomeni, che ci rendono tutti più timorosi e insicuri?
Riducendo i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine, abbastanza numerose
se confrontate con quelle degli altri grandi Paesi occidentali, ma spesso
impegnate in altre funzioni, come le scorte a politici, ex politici e compagnia
cantante, che li distolgono dai loro compiti primari. Depenalizzando una serie
di reati cosiddetti minori, che in realtà colpiscono la cittadinanza nella sua
esistenza quotidiana anche peggio di altri. Svuotando periodicamente le carceri
perché eccessivamente affollate e non in grado di garantire i diritti dei
detenuti, invece di costruirne di nuove o utilizzando quelle già esistenti, ma
lasciate vuote per carenza di guardie penitenziarie. Tenendoci gli innumerevoli
stranieri che delinquono (la loro percentuale tra i detenuti è molto superiore a
quella degli italiani) invece di espellerli appena espiata la pena. Se la
percentuale di cittadini carcerati rispetto alla popolazione è metà di quella
della Francia e della Gran Bretagna e addirittura un decimo di quella degli
Stati Uniti non ci si può poi meravigliare se il tasso di delinquenza,
denunciata e non denunciata, è così alto. Un altro scandalo è quello dello
scarsissimo numero di cosiddetti colletti bianchi, e in particolare di esponenti
di rilievo della burocrazia e della finanza, anche accusati di reati infamanti,
di furti e truffe milionari o di reati particolarmente dannosi per la comunità
che finiscono effettivamente in galera. Tra appelli, prescrizioni, condoni, sono
pochissimi, e nei (rari) casi in cui ciò avviene fa addirittura notizia. La
maggior parte, anche se, sulla carta, condannata ad anni di reclusione, continua
a godersi la vita in perfetta libertà, con un effetto negativo sulla credibilità
della giustizia, specie tra i giovani, che può riuscire devastante. La durata
infinita dei processi, e i mille cavilli che la nostra legislazione consente di
usare agli avvocati difensori, non fanno che rendere la situazione ancora più
insostenibile. Potrei continuare per pagine e pagine, riprendendo episodi
incredibili che si incontrano quasi ogni giorno sui giornali, ma sarebbe
superfluo. La conclusione sarebbe comunque la stessa, che la qualità della vita
dei cittadini onesti va continuamente peggiorando. Ricordo che, ormai molti anni
fa, un mio amico inglese, corrispondente di un grande giornale da Roma, soleva
dirmi:”Il vostro è il Paese in cui si vive meglio in Europa, basta non avere a
che fare con l’autorità (intendendo fisco, burocrazia, vigili, tribuanli, ecc.).
Oggi non è più vero. Bisogna aggiungere “….se si ha la fortuna, sempre più rara,
di non imbattersi in qualche malfattore”.
I nuovi mostri dei Soliti
Idioti "L'Italia? Un inferno da ridere".
Biggio e Mandelli rivisitano Dante nel film: «Abbiamo raccontato con affetto le
deformità di ciascuno di noi», scrive Cinzia Romani su “Il Giornale”. Nati non
foste a viver come bruti. Lo rammentano i Soliti Idioti con la rappresentazione
plastica degli abominevoli peccati italiani al giorno d'oggi. Tipo abbruttirsi
al bar alle otto di mattina, uccidere per questioni di traffico all'ora di
punta, travolgere gli altri al supermercato, stare sempre connessi o farsi
irretire dalla pubblicità invasiva. Per forza, poi, ci vuole il Ministero della
Bruttezza a dirimere le controversie dei consumatori di laidume. Così col loro
terzo film, La solita Commedia. Inferno (da giovedì in sala), Fabrizio Biggio e
Francesco Mandelli puntano alla versione 2.0 de I nuovi mostri , accatastando
sketch e personaggi come in pista sul web, dal quale provengono. Pur essendo
relativamente giovani (Biggio è classe '74, Mandelli è del '79), gli infernali
registi, qui in tandem con Martino Ferro, nonché protagonisti e sceneggiatori
d'un racconto corale, rimpiangono il passato. Quando si usava il telefono a
gettoni, come fa Minosse (Mandelli) per chiamare il suo superiore, un Dio che
tracanna whiskey e fuma. O quando si picchiavano i tasti della macchina per
scrivere, come fa un tenente (Biggio), pronto a scagionare due poliziotti dal
reato di abuso di potere nei confronti d'una macchinetta che non dà resto.
Perché prima era tutto più bello, ancora non ci aveva invasi la Grande
Bruttezza: altro che Isis. Siamo dalle parti della surrealtà più dichiarata, con
tanti attori che interpretano dai 21 ai 7 ruoli a testa per raccontare una
società malata. E c'è pure Tea Falco, già musa di Bertolucci, nei panni d'un
Gesù tosto, quando sequestra a un precario di nome Virgilio (ancora Biggio) i
suoi attributi. Che riavrà se accompagnerà Dante (ancora Mandelli) a catalogare
i nuovi peccati commessi sulla terra, segnatamente a Milano, postaccio caotico
zeppo di hackers, pornomani e tecno-incontinenti. «Volevamo raccontare con
affetto l'Italia e gli italiani. E la mostruosità di ognuno di noi, guardando a
I nuovi mostri », dice Biggio. Ironia a parte, alcune categorie vengono prese di
petto. Quella dei poliziotti, per esempio, raffigurati come paranoici violenti.
Diverte l'interrogatorio stile Csi della macchinetta del caffè, rea di non
rendere gli spicci ai piedipiatti, ma fa pensare a un certo tipo di giudizio.
«Ci piace provocare e dar fastidio, però non vogliamo descrivere tutta la
polizia così. Come ci piace l'idea d'un Dio indaffarato nei suoi casini. Il
nostro padre Pio, non me ne voglia Castellitto, è il migliore. Non temiamo le
risposte dei cattolici», spiega Mandelli. E in effetti, l'idea d'intruppare i
santi in una specie di Camera, a decidere come procedere per catalogare nuovi
peccati terreni, non è male. «Ci piace forzare il pubblico, vedere come
rispondono i cattolici», butta lì Biggio. Di sicuro, il duo comico è maturato e
cerca un nuovo sbocco. «Ci avevano proposto di fare il terzo film dei Soliti
idioti , ma ci siamo messi alla prova con una cosa diversa. Chi fa il nostro
mestiere, cerca sempre di uscire dalla zona comfort. Come abbiamo fatto a
Sanremo: stare su quel palco, è stata una sfida», puntualizza Mandelli.
Colpisce, a ogni modo, che per smarcarsi dall'ennesima commedia all'italiana, i
Soliti Idioti abbiano realizzato un'idea semplice e geniale: sciorinare i più
brutti vezzi italioti contemporanei, in stile Nanni Loy, dopo aver riferito tic
e nevrosi del Bel Paese nei loro lavori precedenti. È andato in questo senso
pure Maccio Capatonda con Italiano medio e non a caso il duo pensa a una
collaborazione col comico abruzzese. Costato 3 milioni e finanziato pure dalla
Film Commission del Lazio (la maggior parte delle scene, tuttavia, si svolge a
Milano),il film è prodotto dalla Wildside di Mario Gianani, marito della Madia e
di Lorenzo Mieli, figlio di Paolo. E non a caso il Ministero della Bruttezza
Biggio&Mandelli lo affiderebbero «a Gasparri, Alfano e Salvini», che non è gente
di sinistra.
L’italiano medio è volgare
e squallido, ma diverte. La
recensione di Marita Toniolo su “Best Movie”. Sbarca al cinema l’opera prima del
comico Maccio Capatonda, che vuole farci ridere e vergognare di come siamo
diventati. Dopo i successi stratosferici di Zalone al botteghino, si torna a
puntare forte su un volto “televisivo” con
Maccio Capatonda
e il suo
Italiano medio,
prossimo a sbarcare al cinema con 400 copie al suo esordio (il 29 gennaio).
Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia, è un fenomeno di culto del web
amatissimo dai cinefili grazie ai suoi trailer parodia: un centinaio di secondi
e poco più in cui Capatonda riesce a comprimere mirabilmente genio e follia,
cinefilia e non-sense, giochi di parole e travestimenti, raggiungendo una
popolarità che lo ha portato a sbarcare anche su MTV con la serie
Mario.
Lo attendeva al varco la sfida più tosta: il lungometraggio. Riuscire a essere
altrettanto esplosivo in un tempo dilatato. Italiano medio, diretto, scritto e
interpretato da Maccio, è infatti lo sviluppo del finto trailer di
Limitless
con Bradley Cooper: due minuti, in cui era un uomo intelligente e socialmente
responsabile, che assumeva una pillola che gli cambiava totalmente la vita.
Parodisticamente, rispetto alla Lucy di Besson che si ritrova ad avere a
disposizione il 100% del cervello, Maccio deve capire cosa riuscire a fare con
solo il 2%… E proprio da questa domanda prende il via il racconto.
Giulio Verme è il perfetto
emblema dell’uomo socialmente impegnato: allergico alla televisione sin da
bambino, avverso a ogni massificazione, vegano convinto, sempre pronto ad
aiutare gli emarginati, con la fissa per l’ambiente e le scelte etiche ed
ecosostenibili. Addetto allo smistamento dei rifiuti a Milano, cerca di
inculcare un po’ di senso civico nei colleghi, che gli rispondono a suon di
scoregge. La radicalità delle sue scelte finisce per creare un muro tra lui e le
persone che lo circondano: i genitori in primis, gli amici, i vicini e persino
la fidanzata Franca, esasperata dal suo atteggiamento da uomo frustrato e
ostile, ma fondamentalmente passivo. Giulio si ritrova isolato e disperato,
sopraffatto dal “lerciume” che lo circonda, sempre più nevrotico e ansioso.
Finché nella sua vita non approda l’amico
Alfonzo,
un ex compagno antipatico delle elementari che gli offre
una pillola straordinaria, che
gli permetterà di usare solo il 2% del cervello,
invece che il 20%. La metamorfosi sarà da
Dottor Jekyll e Mr Hyde:
da attivista rompiscatole e fanatico, Giulio diventerà un tronista beota con il
mantra fisso dello “scopare”, della disco e del lusso cafonal, volgare e
ignorante, carnivoro e menefreghista, guadagnandosi – impresa becera dopo
l’altra – il diritto alla partecipazione al reality show più di culto del
momento. L’apoteosi dell’italiano medio. Capatonda ha messo tutto se stesso in
questa opera prima e il primo punto a favore gli deriva dall’enorme cura del
dettaglio che il film mostra. Nulla è lasciato al caso, a partire dagli
esilaranti titoli di
testa (Tratto
da una storia finta), che fanno
partire in quinta il film e che denunciano da subito il pedigree cinefilo
dell’autore. Che ha di fatto disseminato tutto il film citazioni filmiche facili
da riconoscere via via. Tuttavia, il triplo salto carpiato dai video di 1/2
minuti al lungo di 100 equivalgono a passare dallo sguazzare in una piscina a
nuotare nell’oceano. C’è un traccia coerente di fondo, ma i raccordi tra una
scena comica e l’altra si stiracchiano troppo, portando con sé come conseguenza
negativa la reiterazione di situazioni e tormentoni per allungare il brodo (amechemmenefregame,
Sant’Iddio, Scopare…).
Raccontare una metamorfosi in un video di 130 secondi risulta efficace,
dilatarla con un continuo sdoppiamento di personalità ed esplicitando la lotta
interiore sempre più opprimente che Verme si ritrova a combattere tra i suoi
istinti primari da bifolco e gli intenti nobili, produce l’effetto di frammenti
anche geniali, ma non ben incollati in un mosaico coerente. Se la struttura
narrativa è il punto debole più evidente di
Italiano medio,
va invece segnalata – come altro punto a suo favore – il peso specifico delle
riflessioni, per nulla superficiali. Lo sguardo di Maccio sull’Italia e i suoi
concittadini è amaro e disilluso, quasi crudele. Con un disgusto e un disprezzo
maggiore di quello dello storico
Fantozzi
verso l’impiegato piccolo piccolo, Maccio non risparmia colpi a colti e
ignoranti, ricchi e poveri, impegnati e menefreghisti. Giulio Verme sdoppiato
sintetizza le sublimi vette dell’arte
del compromesso toccate
dell’italiano, capace di essere vegano e mangiare il pollo fritto; andare in
chiesa e avere mogli e amanti; difendere il bio e inquinare. Opposti
apparentemente inconciliabili, che – come vedremo nel finale – invece, per gli
abitanti del Bel Paese sono assolutamente ricomponibili, abituati come siamo ad
accettare obbrobri edilizi che radono al suolo parchi bio, scandali
sexual-politici, indecenze cultural-mediatiche dei reality (memorabili lo
scandalo del bianchino nel privè, che ha portato all’esclusione di Kevin, e la
“prova pippotto”), come se fossero parte integrante e inalienabile del sistema.
Maccio non ce le manda a dire, ma stigmatizza tutti i nostri vizi,
costringendoci a ridere (amaramente) di essi. Come sempre, è circondato dai
soliti attori fidati: l’inseparabile
Herbert Ballerina,
che si trasforma in tre personaggi diversi;
Rupert Sciamenna,
imprenditore squalo con i capelli rosa;
Ivo Avido,
anche lui triplice. Molti i colleghi che si sono prestati per differenti camei:
lo Zoo di 105,
Raul Cremona,
Andrea Scanzi,
Pierluigi Pardo
e il principe assoluto del non sense
Nino Frassica.
L’impiego degli stessi attori in più ruoli e con costumi diversi, pur se
giustificato dal surrealismo che ìmpera, genera spesso un effetto cabaret
innestato nel cinema che non giova alla dimensione estetica del film. Sebbene
gli vada anche riconosciuta una fotografia curata (di Massimo Schiavon), che
alterna colori diversi quando la personalità di Giulio cambia, non abbiamo
sempre la sensazione di trovarci di fronte a un film
tout court,
limite più forte dei comici italiani importati dalla Tv. Eppure, pensiamo che
l’opera prima di Maccio vada premiata (anche per incoraggiamento, affinché
continui a perfezionarsi, per giungere a una scrittura più equilibrata), perché
regala sane risate, momenti di genio surreale (il folle “piano” finale degli
attivisti) ed è una satira feroce che invita alla riflessione, come non accadeva
da tempo in un film comico italiano. Da Rodotà-tà-tà a onestà-tà-tà, viaggio
pre-Quirinale nella spaesata piazza grillina senza capo né nome, scrive Marianna
Rizzini su “Il Foglio”. Da Rodotà-ta-tà a onestà-tà-tà. Dopo quasi due anni di
Parlamento e alla vigilia di una nuova elezione presidenziale, la piazza a
Cinque Stelle parla d'altro ( la "mafia capitale" da non dimenticare: da cui la
pubblica lettura delle intercettazioni tratte dall'omonima inchiesta – per la
gentile interpretazione di Claudio Santamaria e Claudio Gioè, attori e volti da
romanzi criminali su piccolo e grande schermo). Onestà-tà-tà, dunque, al posto
del nome che non si farà, non si vuole fare e non si vuole neanche ascoltare (il
deputato e membro del direttorio a Cinque Stelle Alessandro Di Battista a un
certo punto legge e fa leggere alla pizza la dichiarazione-gran rifiuto: caro
Renzi ecco la risposta del popolo – e pare quasi di sentir parlare un robot, la
famosa futuribile app che renderà possibile conversare con amici virtuali come
nel film "Her" con Scarlett Johansson nella parte dell'amante fatta di web, solo
che qui il tono non è suadente: lei ha già deciso, Renzi, e al Nazareno non
veniamo). Onestá-tá-tá, e altre parole di un lessico chiama-applauso in una
Piazza del Popolo che all'inizio era mezza vuota e percorsa da interesse per
l'altrove del sabato pomeriggio: gente che faceva vedere l'acquisto da saldo e
giovani rapper -break dancer con tappeto di plastica per performance
estemporanea sul selciato. "La gente è arrivata", esclama una signora quando il
suo wishful thinking, finalmente, diventa realtá, e arriva pure Sabina Guzzanti
comica non più comica, ché, prevale, nel suo intervento, l'invettiva-imitazione
in teoria civile in realtá elitaria contro Maria De Filippi, emblema del paese
in cui da vent'anni, dice Guzzanti, si è perduto ogni " stimolo intellettuale",
e sembra impossibile fare qualcosa: le persone colte riescono a stare insieme
per combinare qualcosa, è il concetto espresso da Sabina, le persone ignoranti
no. Colpa della tv, è la sentenza che alla fine dell'invettiva tutti si
aspettano, e le ragazze del bar all'angolo della piazza si domandano perché mai
"Sabina se la prenda con la De Filippi". Ma gli applausi a quel punto sono già
stati tributati alla divinità nascosta che la piazza omaggia a intervalli
regolari: l'onestà, rieccola, parola buona per tutto e piena in fondo di niente,
se non della generica riprovazione per le altre bestie nere della serata
(persino il rapper Fedez le dice e non le canta: corruzione, resistenza,
vergogna, marciume, e mafia mafia mafia). Tutto è mafia, dicono i deputati,
senatori e consiglieri comunali grillini che sfilano sul palco (Roberta
Lombardi, la veterana dei primi streaming a Cinque Stelle, dice che una mattina
si è svegliata e ha trovato non l'invasore ma una città che diventa proprio
quello che ora, chissà perchè, tutti evitano di ricordare: il teatro della mafia
capitale. La senatrice stornellista Paola Taverna, in strana inversione di ruoli
con Fedez, pare quasi una rapper quando intona lo slogan degli slogan: fuori la
mafia dallo Stato. Fedez invece, sempre senza cantare, dice la frase che
qualcuno nel pubblico trova "un po' cosi" nel giorno in cui l'Isis decapita un
altro ostaggio, di nazionalità giapponese: abbiamo il nemico in casa ma non è di
fede musulmana, dice Fedez, e le grandi stragi sono di matrice italiana. Il più
grande nemico dell'Italia sono gli italiani, continua, e a quel punto
l'applauso arriva, forse per riflesso condizionato (sono già due ore che gli
astanti sentono dire peste e corna dell'universo mondo nazionale). "Fuori i
nomi, Renzi"', grida il tribuno Di Battista, e alla fine Beppe Grillo esce per
dire la stessa cosa, ma con il marchio di fabbrica: vaffanculo! (Vaffanculo e
fate i nomi). Il resto è uso traslato (e a volte insensato) di termini
impossibili a odiarsi: valori, costituzione, libertà, partecipazione (povero
Gaber), cultura. Grillo invece parla di sottocultura, insultando qui e lì
Giorgio Napolitano per non aver riconosciuto "il miracolo" a cinque stelle,
anche se il miracolo Grillo se l'è sfasciato da solo. Resta solo da dire no al
"Nazareno", demone antropomorfo. Ed è subito sabato sera mentre gli attivisti
sbaraccano, e sulla piazza che si svuota si diffonde, incongrua, la più classica
canzone dei Pink Floyd ("another brick in the wall").
Il linciaggio di Pansa: a
sinistra era un dio a destra è un infame.
Per anni i salotti di sinistra hanno acclamato Pansa come un dio. Ma da quando
non dice più quello che piace loro, lo hanno relegato tra i reietti della penna,
scrive Vittorio Feltri su Il Giornale. Giampaolo Pansa, noto giornalista che ha
lavorato alla Stampa, al Giorno, al Corriere della Sera, alla Repubblica,
all'Espresso, al Riformista (ora è a Libero ), ha scritto un altro libro: La
destra siamo noi. Ne ha pubblicati tanti e ne ho perso il conto. Il titolo
dell'ultimo fa capire subito il contenuto: pendiamo tutti da qualche parte,
dipende dai momenti e dalla convenienza. Giampaolo è stato povero. Da ragazzo
era molto studioso, obbediente alla famiglia e si è laureato con una tesi
pubblicata da Laterza (che è un editore e non il numero delle scopate messe a
segno in un sol giorno dall'autore). Finita l'università trovò subito un posto
in redazione e cominciò l'attività di cronista, quella in cui è riuscito meglio.
Si è guadagnato da vivere con le virgole, ha svirgolato per anni e anni e
seguita a svirgolare come un pazzo. Credo che per lui riempire fogli di parole
sia come bucarsi per un drogato: non può farne a meno. Senza la «roba» nero su
bianco, Pansa non campa. Se sta tre ore senza picchiettare sui tasti, va in
crisi di astinenza. Il mestiere di scrivere è il peggiore. Quando ti dedichi a
esso, ti ammali di una malattia grave, pensi che la tua esistenza abbia un senso
solo se la racconti; altrimenti non ha significato, sei morto. Giampaolo è stato
un maestro inimitabile di giornalismo finché ha dato l'impressione di essere di
sinistra, stando cioè dalla parte dei vincitori, sempre di moda. I suoi articoli
sul Corriere e sulla Repubblica erano considerati gioielli, giustamente. Egli in
effetti si era inventato un modo di narrare i fatti italiani e le gesta dei
protagonisti talmente originale da piacere a chiunque, anche a coloro che lo
invidiavano. Per lustri e lustri fu indicato al popolo come il più bravo della
categoria. Poi, dato che il tempo è democratico, invecchiò e iniziarono per lui
i guai. Guai si fa per dire. Poiché non era direttore (l'unica figura
professionale non soggetta a licenziamento per questioni anagrafiche), fu
cortesemente invitato a sloggiare dall' Espresso , testata che fornisce a chi vi
lavora il certificato di autentico progressista. Se ne andò in pensione, ma non
smise di scrivere. E furono libri, uno dietro l'altro, uno più dissacrante
dell'altro e, per giunta, di successo. Il sangue dei vinti ebbe sui lettori un
effetto clamoroso: quelli di destra lo apprezzarono, soddisfatti di constatare
che finalmente uno scrittore dicesse il contrario rispetto alla vulgata
sinistrorsa; quelli di sinistra, automaticamente, lo condannarono con una
sentenza inappellabile: Pansa si è rovinato, è diventato fascista. Da quel
momento, il maestro è stato collocato fra i reietti della corporazione degli
scribi, espulso dall'elenco degli autori di qualità, meritevole di uscire dal
club dei grandi maestri e di entrare in quello dei cattivi maestri. I libri di
Giampaolo si vendono, eccome se si vendono, ma sono giudicati dagli
intelligentoni merce avariata. La vicenda di quest'uomo talentuoso e perbene è
paradigmatica dell'imbecillità italiana; il tuo voto in pagella non dipende da
ciò che fai, bensì dalla consorteria cui appartieni. Pansa di sinistra era un
dio; Pansa di destra è una grandissima testa di cazzo. I cittadini (non solo
italiani) hanno opinioni variabili, tanto è vero che una volta votano di qua e
un'altra di là, ma si arrogano il diritto di dare della banderuola ai
giornalisti che mutano fede pur non avendone una e che si limitano a osservare
la realtà con spirito laico, riferendo ciò che vedono e sentono, filtrando il
tutto attraverso il proprio spirito critico. Una realtà complessa e in continuo
divenire la cui valutazione non può avvenire sempre con lo stesso metro, ma
necessita di costanti revisioni e aggiornamenti. Non c'è nulla di statico a
questo mondo, tantomeno il cervello degli uomini che s'imbottisce
quotidianamente di nuove informazioni e, perché no, suggestioni. Pansa, che
conosco da 40 anni, non è mai stato fermo nelle proprie convinzioni come un
paracarro; è stato ed è un coltivatore di dubbi, disponendo di un'intelligenza
superiore alla media. Quando era di sinistra aveva qualche pensiero di destra;
ora che dicono sia di destra ha qualche inclinazione a sinistra e la manifesta
senza ipocrisia. Non fosse che per questo, Giampaolo è da ammirare. Uno della
cui onestà bisogna fidarsi. La sua prosa non è contraddittoria; è frastagliata,
ricca di umori e di amori. Va accettata per quello che è: lo specchio del casino
nel quale ci dibattiamo in Italia da secoli.
Giampaolo Pansa su “Libero
Quotidiano”: Ma il Caselli aggredito dai No Tav si fida di questa sinistra?
Ho sempre avuto stima e simpatia per il magistrato Gian Carlo Caselli. Per una
serie di motivi a cominciare dalle origini famigliari abbastanza simili alle mie
e dall’età che lo vede in vantaggio di poco: tra un paio di mesi compirà 76
anni. Lui ha origini alessandrine, io monferrine. Noi del Monferrato non siamo
mai andati troppo d’accordo con i mandrogni. Ma esistevano altri fatti a
renderci vicini. I nonni contadini a Fubine, il papà operaio, la laurea a
Torino. Oggi Caselli è in pensione, ma ha conservato la figura asciutta e il
carattere forte di quando dava la caccia al terrorismo rosso. All’inizio degli
anni Settanta era giudice istruttore a Torino. E dobbiamo pure a lui se le prime
Brigate rosse, quelle fondate e capeggiate da Renato Curcio, furono sconfitte.
Il mitico Renè venne catturato. L’unico errore dei magistrati fu di rinchiuderlo
nel piccolo carcere di Casale Monferrato. Per la moglie Mara Cagol si rivelò uno
scherzo entrare in quella prigione e portarsi via il marito, senza sparare un
colpo. Caselli è sempre stato un coraggioso. Le Br miravano anche ai magistrati.
A Genova, nel giugno 1976, accopparono il procuratore generale Francesco Coco e
i due carabinieri che lo scortavano. Penso che pure Caselli rischiasse la pelle.
Ma una volta fatto il proprio dovere a Torino, nel 1992, dopo l’assassinio di
Giovanni Falcone, si candidò all’incarico di procuratore capo a Palermo e si
trasferì lì per un bel po’ di anni, comportandosi con onore. Insomma, siamo di
fronte a un uomo che ha fatto tanto per la nostra sicurezza. Gli italiani gli
debbono molto. Voglio dirlo adesso che la magistratura sta declinando come il
resto del paese. E non si può fingere che gli uomini e le donne in toga siano
senza responsabilità. Perché questi brevi cenni sul percorso di Caselli? Perché
accade che Gian Carlo sia preso di mira da gruppi di antagonisti violenti. A
cominciare dai guerriglieri anti Tav e per finire ai loro compagni di Firenze,
non vogliono che lui parli in pubblico. L’hanno preso di mira e non smetteranno.
Caselli e i suoi tanti sostenitori non s’illudano. Mi sembrano vane le lezioni
di democrazia che lui tenta di impartire a certe bande. L’ultima è apparsa
venerdì sul Fatto quotidiano. Il dotto articolo di Caselli era intitolato: «Il
bavaglio. La storia riscritta dagli squadristi». Uno sforzo inutile. Spiegare al
sordo che è sordo non serve a nulla: lui non ti sentirà. Lo dico perché sono
passato anch’io per le stesse forche caudine imposte a Caselli. Con la
differenza che lui viene difeso, sia pure inutilmente, dalle molte sinistre. Il
Pansa, invece, fu lasciato solo, tanto da essere costretto a rinunciare di
parlare in pubblico. Ossia a uno dei diritti che la Costituzione garantisce a
tutti, specialmente a chi fa politica, ai magistrati ormai fuori carriera, a chi
scrive sui giornali e pubblica libri. La mia colpa erano proprio i libri. Nel
2003 avevo pubblicato «Il Sangue dei vinti», una ricostruzione senza errori di
quanto era accaduto in Italia dopo il 25 aprile 1945. Era un libro che abbatteva
il muro di omertà che aveva sempre nascosto la sorte dei fascisti sconfitti. E
per questo ebbe subito un successo imprevisto e strabiliante. I violenti rossi
dell’epoca lì per lì non se ne accorsero, forse perché non leggono i giornali e
non frequentano dei luoghi chiamati librerie. Se ne resero conto soltanto tre
anni dopo. Così, a partire dall’ottobre 2006, cominciarono a darmi la caccia,
non appena pubblicai un altro dei miei lavori revisionisti, «La Grande bugia».
Il primo assalto lo sferrarono il 16 ottobre 2006. Una squadra capeggiata da un
funzionario di Rifondazione comunista, arrivata apposta da Roma con un pulmino,
cercò di impedire la prima presentazione in un hotel di Reggio Emilia. Mentre
stava per iniziare il dibattito tra me e Aldo Cazzullo, generosa firma del
Corriere della sera, la squadra ci aggredì. Ci lanciarono contro copie del
libro, poi tentarono di coprirci con un lenzuolo tinto di rosso, che recava la
scritta «Triangolo rosso, nessun rimorso». Volevano farci scappare, ma a
tagliare la corda furono gli aggressori, cacciati dalla reazione del pubblico.
Il giorno successivo ero atteso in una grande libreria di Bassano del Grappa. Ma
nella notte i balilla rossi avevano bloccato con il silicone le serrature degli
ingressi. Una squadra di fabbri lavorò a lungo per liberarle. Allora tentarono
di entrare e di leggere un loro proclama, ma la polizia lo impedì. Il giorno
dopo, a Castelfranco Veneto, nuovi fastidi. L’indomani mi riuscì di parlare a
Carmignano sul Brenta, protetto da agenti della polizia guidati dal capo della
squadra mobile di Padova. Era un dirigente giovane, intelligente ed esperto. Mi
avvisò che in Veneto avrei incontrato dappertutto gli stessi problemi. Aggiunse:
«Comunque verrà sempre difeso da noi. Conosciamo bene questi gruppi e li terremo
a bada». Fu allora che mi posi un problema di etica pubblica. Chiesi a me
stesso: «Quale diritto ho di mobilitare reparti di polizia e di carabinieri per
proteggere le presentazioni dei miei libri? Le forze dell’ordine hanno compiti
ben più importanti, dal momento che tanta gente è vittima di furti, rapine,
scippi, aggressioni». Se ci ripenso a nove anni di distanza, sono ancora
convinto che fosse una domanda sensata. E altrettanto fu la risposta che mi
diedi. Studiai l’agenda e mi resi conto che erano previsti una trentina di
incontri per la «Grande Bugia». Ne annullai quattordici, in città come Bologna,
Ferrara, Piacenza, Parma, Crema, Treviso, Vicenza, Padova, Valdagno. A decidermi
furono le parole di un amico: «Tu vieni nella mia libreria, protetto dai
poliziotti. Presenti il tuo libro, poi riparti. Ma noi restiamo qui, senza
difese». A qualcuno capitò di vedersi sfasciare la vetrina. A una grande
libreria emiliana spararono un colpo di rivoltella contro una vetrina. L’aspetto
più sgradevole della faccenda stava nel fatto che in quegli stessi momenti
c’erano giornali che mi attaccavano per i miei libri revisionisti, tentando di
farmi il vuoto attorno. Si andava da Liberazione, il quotidiano rifondarolo,
alla Stampa di Torino e a Repubblica, passando per una serie di giornali
provinciali del Gruppo Espresso. Alla Stampa c’era un collega che non mi poteva
soffrire. Voglio farne il nome perché oggi conta più di allora: Massimo
Gramellini, il socio televisivo di Fabio Fazio. Era un vicedirettore della
«Bugiarda», così la chiamavano gli operai torinesi. E arrivò a telefonarmi con
arroganza melliflua per sapere se avevo letto la pagina contro di me, vantandosi
di averla confezionata con le sue manine. Dopo l’assalto di Reggio, il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, stilò un comunicato in mia
difesa. Ricevetti in via privata le telefonate di Romano Prodi, Piero Fassino e
Walter Veltroni. Sul versante della sinistra furono i soli a farsi vivi. Sono
campato lo stesso e i miei libracci hanno sempre avuto molti lettori. Ma
l’esperienza di allora mi induce a rivolgere una domanda a Gian Carlo Caselli:
ti fidi ancora delle sinistre italiane che oggi ti portano sugli scudi? Con
l’aria che tira, e sotto i bombardamenti pesanti del Cremlino renzista, avranno
bisogno di raccattare tutti i voti possibili. Tu conti per uno soltanto. Prima o
poi ti molleranno, a favore delle bande che occupano gli atenei. Troppo
tollerate e persino blandite.
Il grido di allarme ignorato:
al Tribunale di Taranto condanna certa, perché è impedito difendersi e
criticare. La rivelazione di Antonio Giangrande. Dalla relazione fatta per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 dal presidente vicario della Corte
d’Appello di Lecce, Mario Fiorella, il numero di processi proprio a carico di
magistrati, anche tarantini, sono ben 113. Il dato ufficiale si riferisce ai
procedimenti aperti nel 2013 ed il Distretto di Corte d'Appello comprende i
Tribunali di Taranto, Brindisi e Lecce. Come riporta Chiara Spagnolo su “la
Repubblica”, sono stati infatti quelli i numeri degli iscritti nel registro
degli indagati, inchieste poi trasferite per competenza a Potenza, mentre 92
sono i magistrati che risultano parti offese. I dati sono fuorvianti, in quanto,
a ben vedere si scoprirà, che le accuse agli imputati magistrati si tramuteranno
in archiviazioni tacite, mentre le accuse in cui i magistrati sono parti offese
si trasformeranno in condanne certe e roboanti: perché così va il mondo.
Magistrati giudicandi, ma ingiudicati!
Per esempio, il 5 marzo 2015
si tiene a Potenza l’ennesima udienza contro Antonio Giangrande, presieduta dal
giudice monocratico Lucio Setola, già sostituto procuratore di quel Foro.
Processo per diffamazione e calunnia su denuncia del giudice di Taranto, Rita
Romano, persona offesa costituita parte civile.
La colpa di Antonio Giangrande
è di aver esercitato il sacrosanto diritto di difesa, per non vedersi esser
condannato ingiustamente, e per gli effetti aver presentato 3 richieste di
ricusazione contro la Rita Romano, perché questa non si era ancora astenuta nei
tre processi in cui giudicava il Giangrande, nonostante nel procedere in altri
processi collegati già si era espressa in sentenza addebitando la responsabilità
all’imputato, sebbene questi non fosse sotto giudizio, e contro il quale già
aveva manifestato il suo parere in sentenze di altri processi definendolo in più
occasioni, di fatto, soggetto testimonialmente inattendibile. La ricusazione
oltre che fondata era altresì motivata con una denuncia allegata presentata
contro la stessa Rita Romano ed a Potenza risultata archiviata, nonostante la
fondatezza delle accuse e delle prove. Inoltre gli avvocati difensori De Donno e
Gigli per la ricusazione presentata hanno rinunciato alla difesa. Fatto sta che
i processi ricusati, con la decisione di altri giudici, però, hanno prodotto il
proscioglimento per l’imputato. Sulla attendibilità di Antonio Giangrande, poi,
parlano le sue opere ed i riscontri documentali nelle cause de quo.
Altro esempio è che il 30
aprile 2015 si tiene presso il Tribunale di Potenza l’ennesima udienza contro
Antonio Giangrande, presieduta dal giudice monocratico Natalia Catena. Processo
per diffamazione su denuncia presentata da Alessio Coccioli, quando era
sostituto procuratore a Taranto prima di passare a Lecce, perché la Gazzetta del
Sud Africa, e non Antonio Giangrande, pubblicava un articolo in cui si definiva
il Tribunale di Taranto il Foro dell’ingiustizia, elencando tutti i casi di
errori giudiziari, e per aver pubblicato l’atto originale della richiesta di
archiviazione, poi accolta dal Gup, e le relative motivazioni attinenti una
denuncia per un concorso truccato per il quale il vincitore del concorso a
comandante dei vigili urbani di Manduria era colui il quale aveva indetto e
regolato lo stesso concorso.
Come si vede le denunce a
carico dei magistrati di Taranto sono 113 quelle presentate in un solo anno a
Potenza e di seguito archiviate, e non sono di Antonio Giangrande, però Antonio
Giangrande è uno dei tanti imputati su denuncia dei magistrati di Taranto a
sottostare a giudizio, e sicuramente a condanna, per aver esercitato il suo
diritto di critica e o il suo diritto/dovere di difesa. Diritti garantiti dalla
Costituzione ma disconosciuti sia a Taranto, sia a Potenza.
Una delle frasi più amare del grande scrittore
Franz Kafka è:
“Qualunque impressione faccia
su di noi, egli è servo della Legge e come tale sfugge al giudizio umano”.
Viene da pensare a questa frase quando a venire giudicato è chi dovrebbe
amministrare una giustizia chiara ed imparziale, scrive Roberto De Salvatore su
“Lecce Cronaca”. Dicendo questo mi riferisco alla vicenda che ha visto Antonio
Giangrande (nella foto), presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie e di
Tele Web Italia, chiamato a rispondere davanti al tribunale di Taranto di
diffamazione e calunnia. Il motivo che aveva dato origine alla vicenda era un
caso di corruzione per un concorso truccato per un posto di comandante dei
vigili urbani a Manduria, a detta del Giangrande ampiamente documentata. La
vicenda processuale ha prodotto una serie di procedimenti nei confronti di ben
113 magistrati tarantini, ma non solo. Sono questi come riporta Chiara Spagnolo
su “la Repubblica”, i numeri degli iscritti nel registro degli indagati,
inchieste poi trasferite per competenza a Potenza, mentre 92 sono i magistrati
che risultano parti offese. I dati sono fuorvianti, in quanto, a ben vedere si
scoprirà, che le accuse agli imputati magistrati si tramuteranno in
archiviazioni tacite, mentre le accuse in cui i magistrati sono parti offese si
trasformeranno in condanne certe e roboanti: perché così va il mondo. Magistrati
giudicandi, ma ingiudicati!
Ciascuno dovrebbe aver diritto
ad un equo processo, a prescindere dalla categoria cui appartiene, nella
convinzione (forse ingenua) che quanto si legge scritto sui muri dei tribunali
‘la legge è uguale per tutti’ non sia solo uno slogan. Non sappiamo giudicare
dove sia il torto e dove la ragione, né siamo abilitati a farlo se non
esprimendo un parere da cittadini, nella speranza che ancora sia permesso
esprimere una opinione liberamente, ancorché però non sfoci nella calunnia.
Viene in mente la recente legge sulla responsabilità dei magistrati e la levata
di scudi della categoria contro questa legge rea a loro dire di mettere il
bavaglio alla magistratura. A mio avviso invece è una legge civile a
salvaguardia della certezza del diritto.
Certo speriamo che i potenti
non siano gli unici beneficiari di tale legge, ma che serva di monito a compiere
il proprio dovere senza preconcetti, o peggio ancora ispirati da concezioni
politiche che con la democrazia non hanno nulla a che fare. I magistrati devono
essere assimilabili a qualunque categoria del pubblico impiego per le quali chi
sbaglia è giusto che paghi. Non hanno nulla da temere coloro che fanno da sempre
il loro dovere, ma i tempi dei Viscinsky di staliniana memoria devono terminare,
i normali cittadini sono stanchi di considerare la magistratura qualcosa di
assolutamente divino e di intoccabile. E basta con le toghe rosse, nere o
grigie, la toga di un magistrato non deve avere un colore, ma rappresentare un
baluardo di imparzialità verso tutti.
Decine di saggi di inchiesta
suddivisi per tema o per territorio dove la cronaca diventa storia e dove luoghi
e protagonisti sono trattati allo stesso modo e sullo stesso piano.
Vi siete mai chiesti perché
non conoscete Antonio Giangrande? Perché egli, pur avendo scritto di Mafia,
Massoneria e Lobbies, non abbia la notorietà generalista di Roberto Saviano, lo
stesso che a Scampia gli hanno dedicato un motto: “Scampia-moci da Saviano”? Vi
siete mai spiegati il motivo sul perché, avendo Antonio Giangrande scritto
decine di saggi di inchiesta e ben due libri sul delitto di Sarah Scazzi ed
essendo egli stesso avetranese, mai sia stato invitato nei talk show televisivi
a render presente la posizione anti giustizialista, a differenza della Roberta
Bruzzone che presenzia in qualità di esperta in conflitto di interessi essendo
ella autrice di un libro su Sarah Scazzi ed allo stesso tempo presunta parte
offesa in un procedimento connesso?
Il motivo è chiaro. Egli non è
allineato, conforme ed omologato e scrive fuori dal coro sistematico ed
ideologico. Di fatto è stato estromesso dai salotti buoni e di conseguenza
ignorato dal pubblico generalista.
La sua storia è paradigmatica
dell'imbecillità italiana, dove il tuo valore si misura non per ciò che fai,
bensì dalla consorteria cui appartieni e dove dipende tutto dai momenti della
convenienza. Devi per forza dare il senso di appartenenza a sinistra, difendere
lo status quo ed osannare i magistrati. Non puoi dire il contrario rispetto alla
vulgata sinistrorsa. I cittadini devono essere imbottiti non di informazioni ma
di suggestioni.
Come dire: sui social network
girano le foto di otto cadaveri appesi a testa in giù ad una struttura metallica
di Hawija, nella provincia di Kirkuk, allora si parla di barbarie dell’Isis,
come è giusto che sia. Quando i comunisti appesero Mussolini e la Petacci in
Piazzale Loreto o infoibarono gente innocente nel Carso, si parlò di atti di
eroismo dei partigiani.
Se qualcuno racconta la verità
e presto tacciato di mitomania o pazzia. Quando non dici più quello che piace al
sistema, composto da amici e compari, ti relegano tra i reietti della penna o
della tastiera, se non addirittura dietro le sbarre di una prigione: Così va
questa Italia!
Questa recensione non è un
tentativo di promuovere uno spot gratuito per interessi economici.
I libri di Antonio Giangrande
li trovi su Amazon.it o su Lulu.com o su CreateSpace.com o su Google Libri. Ma
si possono leggere parzialmente free su Google Libri ove vi sono circa 60.000
mila accessi al dì, come si possono leggere gratuitamente anche su
www.controtuttelemafie.it
, il sito web della “Associazione Contro Tutte le Mafie”, sodalizio nazionale
antimafia antagonista a Libera di Don Ciotti e della CGIL.
Si provi a leggere solo
l’articolato dei capitoli per rendersi conto che in quei libri si troveranno le
malefatte della mafia, ma anche gli abusi dell’antimafia. In quei libri si parla
dell’Italia e degli italiani e di tutti coloro che a torto si mettono dalla
parte della ragione e si lavano la bocca con la parola “Legalità”, pur vivendo
nell’illegalità. Si troverà per argomento o per territorio quanto si fa fatica a
scrivere. Si provi a leggere quanto nella propria città succede ma non si dice.
Fino a che la maggior parte di
giornalisti, scrittori, editori, saranno succubi dell’ignavia, della politica e
dell’economia, ci sarà sempre bisogno di leggere i saggi di Antonio Giangrande,
giusto per conoscere una versione diversa dei fatti, così come raccontati da
quelle solite esposizioni omologate che si vedono in tv e si leggono sui libri,
o sui giornali, o sui siti web o blog dei soliti noti.
La caduta (parziale) degli
Dei, scrive Piero Sansonetti su "Il Garantista". Il segretario dell’Anm, il
dottor Maurizio Carbone, dice che la riforma delle norme sulla responsabilità
civile dei magistrati, approvata l’altro ieri dal Parlamento, «è un tentativo di
normalizzare la magistratura». Lo ha dichiarato ieri, durante la conferenza
stampa dell’ Anm, che è su tutte le furie per questa piccola riforma. Già:
«normalizzare». Cioè rendere normale. Oggi la magistratura non è normale: è
l’unica istituzione dello Stato ad essere al di sopra dello Stato, della legge,
ad essere – nell’esercizio delle sue funzioni – immune dalla legge, e
insindacabile, e non dipendente dallo Stato ma sovraordinata allo Stato.
«Normalizzare» la magistratura, cioè toglierle la sua caratteristica di ”deità”
(che non è la ”terzietà” di cui spesso l’Anm parla) non sarebbe una cosa
cattiva. Libererebbe forse l’Italia da un sovrappeso ”feudale” che ancora ne
condiziona profondamente la struttura democratica, e che probabilmente è in
contrasto con lo spirito della Costituzione, che è una Costituzione Repubblicana
e che prevede l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Alcuni
magistrati dicono: ma noi siamo magistrati, non cittadini. E su questa base
pretendono di non dover sottostare alla legge. Ritengono – temo in buona fede –
che la saldezza di una società, e la sua moralità, e il suo essere ”società
etica” (successivamente si passa all’idea dello ”Stato Etico”) non possono che
essere affidati ad una entità e ad un gruppo di persone migliori degli altri (”aristoi”)
i quali siano in grado di ”sapere” la vita degli altri, valutarla, giudicarla,
punirla. Non è questa una funzione – pensano – che possa essere affidata alla
democrazia, o al libero svolgimento delle relazioni umane e sociali, perché la
democrazia è un buon sistema di governo ma è viziato da corruzione. E l’eccesso
della libertà, della deregolamentazione, sono pericolose per la collettività. La
democrazia deve essere ”corretta”, o comunque controllata, e anche la società,
da qualcosa di superiore e di ”certamente morale”: e cioè da i giudici.
Contestare questa funzione dei giudici vuol dire contestare la loro
indipendenza. E mettere in discussione l’indipendenza dei giudici vuol dire
correre il rischio che la magistratura finisca per non essere più autonoma dalla
politica. L’autonomia dalla politica non è vista come una condizione di
funzionamento della magistratura, o come un elemento necessario nell’equilibrio
dei poteri, ma come un valore assoluto al quale una società ”morale” deve
sottomettersi, e in assenza del quale la società diventa ”immorale” e la
democrazia, e le istituzioni, scendono in una condizione di subalternità alla
politica. La politica è ”il male” , la giustizia (lo dice la parola stessa) è il
bene, e il bene può governare il male, e può redimerlo, correggerlo,
sottometterlo. Il male non solo non può governare il bene, ma non può aspirare
ad essere alla pari col bene. Ecco, questo ragionamento è alla base delle molte
dichiarazioni rilasciate ieri dal dottor Carbone, e anche dal presidente
dell’Anm Sabelli. Il quale ha rimproverato al governo di avere promesso una
riforma della Giustizia in 12 punti, e di avere realizzato invece l’unico punto
che non va bene, e cioè la riforma della responsabilità dei giudici. I
magistrati invece – ha spiegato – vogliono cose diverse: per esempio la
riduzione della prescrizione, l’estensione dei poteri speciali ”antimafia” anche
ad altri reati, il processo telematico (cioè la cancellazione del diritto
dell’imputato ad essere presente al suo processo), la riduzione dei gradi di
giudizio, eccetera. In sostanza, la proposta dell’Anm (che più o meno è stata
organicamente strutturata nella proposta di riforma del dottor Nicola Gratteri)
è quella di escludere norme che riportino alla normalità la magistratura,
ristabilendo la legittimità dello Stato liberale e dell’equilibrio dei poteri,
ma, viceversa, decidere un forte aumento dei poteri della magistratura, un
ridimensionamento drastico dei diritti dell’imputato, e un rafforzamento della
condizione di preminenza e di insindacabilità dei pubblici ministeri. Sabelli ha
anche annunciato che l’Anm ha chiesto un incontro al Presidente della
Repubblica. Per dirgli cosa? Per esprimere le proprie rimostranze contro il
Parlamento. Già nella richiesta dell’incontro c’è un elemento di scavalcamento
dell’idea (puramente platonica in Italia) dell’indipendenza dei poteri. La
magistratura ritiene che il suo compito non sia quello semplicemente di
applicare le leggi, ma di condizionarne il progetto e la realizzazione.
L’associazione magistrati chiede al Presidente della Repubblica di frenare, o
condizionare, o rimproverare il Parlamento. E vuole discutere nel merito delle
leggi. La magistratura considera inviolabile la propria indipendenza dagli altri
poteri, e inaccettabile la pretesa di indipendenza degli altri poteri dalla
magistratura. Devo dire che la passione con la quale i magistrati hanno reagito
alla miniriforma della responsabilità civile mi ha colpito soprattutto per una
ragione: questa riforma è quasi esclusivamente simbolica. La responsabilità dei
giudici resta limitatissima. L’unica vera novità è la rimozione del filtro che
in questi vent’anni aveva permesso solo a 4 cittadini di ottenere un
risarcimento per la mala-giustizia (nello stesso periodo sono stati processati e
condannati 600.000 medici). Tutte le altre barriere restano. I magistrati
saranno giudicati solo in caso che sia accertata una colpa grave, o addirittura
un dolo nel loro comportamento, saranno giudicati non da una autorità esterna ma
dai loro colleghi (visto che oltretutto non esiste una divisione delle carriere)
e se alla fine saranno ritenuti colpevoli pagheranno con una sanzione che in
nessun caso potrà superare la metà dell’ammontare di un anno di stipendio. Voi
conoscete qualche altra categoria professionale protetta fino a questo punto? La
probabilità di essere condannati per i magistrati è così bassa, e l’esiguità
della pena così forte, che chiunque può mettersi al riparo pagando una
assicurazione con poche decine di euro. Cosa che non vale per i medici, o gli
ingegneri (non parliamo dei giornalisti) che essendo espostissimi al rischio di
condanna (anche senza dolo e senza colpa grave) se vogliono sottoscrivere una
assicurazione devono pagare migliaia e migliaia di euro. Diciamo che il
privilegio non è affatto toccato da questa riformetta. Appena appena scalfito. E
allora? Il fatto è che comunque la riforma ha un valore ideale, è una specie di
metafora. Il Parlamento, per una volta, non si è inginocchiato davanti alla
magistratura. E’ questa la novità che ha messo in allarme i settori più
corporativi della magistratura. Il timore è che davvero possa cambiare il clima
politico e possa essere aperta una via alle riforme vere, e al ridimensionamento
della ”Divina Giustizia”. No, la riforma non comporterà la caduta degli Dei.
Solo che gli Dei non sopportano gli oltraggi. Sono permalosi. E’ sempre stato
così, dai tempi di Omero. E questa legge è uno sberleffo inaccettabile, anche se
innocuo.
Magistrati: ecco perché non
pagheranno mai.
La nuova riforma della responsabilità civile dei magistrati? Non cambierà nulla.
Perché l’arma è già spuntata in partenza, scrive Maurizio Tortorella su
“Panorama”. Vi hanno detto che adesso cambia tutto? È un bluff. Non hanno pagato
un euro negli ultimi 26 anni e non pagheranno nemmeno domani. Il 25 febbraio la
Camera ha approvato la nuova legge sulla responsabilità civile, e da allora
magistrati e giudici gridano all’indipendenza violata, strepitano all’attentato
alla Costituzione. I più vittimisti ne parlano addirittura come di una «punitiva
ditata negli occhi». Tutti paventano «uno tsunami di ricorsi». Ma è solo una
pantomima. Ne sono convinti molti giuristi e ne sono certi soprattutto gli
avvocati, che continueranno a non utilizzare lo strumento. Perché non funziona e
non funzionerà. Sergio Calvetti, penalista di Vittorio Emanuele di Savoia, ha
appena incassato 39 mila euro dalla Corte d’appello di Roma che ha riconosciuto
al suo cliente l’ingiusta detenzione del 2006, più danni accessori e d’immagine.
Calvetti, però, non è riuscito nell’impresa invocando la responsabilità civile
del magistrato che a Potenza condusse l’indagine, quell’Henry John Woodcock che
fu star di cento inchieste tanto roboanti quanto avare di risultati: «Abbiamo
ottenuto questo risultato come risarcimento da ingiusta detenzione» spiega il
legale «e questo anche se subimmo la pervicace volontà di trattenere in quella
sede il processo, pur senza alcuna competenza territoriale». Francesco Murgia,
con Calvetti difensore storico di Vittorio Emanuele, aggiunge che in realtà una
citazione per responsabilità civile fu presentata nei confronti di Woodcock nel
dicembre 2011, quando cadde l’ultima accusa contro il loro cliente. Ma fu
dichiarata inammissibile perché il tribunale stabilì fosse «non tempestiva»:
avrebbe dovuto partire nel giugno 2006, ai tempi dell’ordine di custodia
cautelare. Perché questo, assurdamente, prevede la legge (e oggi viene
confermato dalla sua riforma): che per agire il cittadino aveva due anni, ora
tre in base alla riforma. Con il trucco, però: perché l’orologio scatta dal
momento in cui l’arresto o il primo provvedimento cautelare viene respinto. «Ma
come faccio a iniziare un’azione di responsabilità, se sono ancora sotto
scacco?» protesta Murgia. È con ostacoli come questo che la Legge Vassalli,
varata il 13 aprile 1988 come (inadeguata) risposta al referendum radicale che
un anno prima, con l’80 per cento di sì, aveva cancellato tre articoli del
codice che proteggevano come un castello medievale magistrati e giudici dalle
azioni civili dei cittadini, ha continuato a garantire piena protezione alla
categoria. Da allora sono state appena 410 le azioni intentate da vittime di
malagiustizia, e sono state più che decimate dalla valutazione di ammissibilità,
il cosiddetto «filtro»: un giudizio preventivo svolto nel tribunale competente
per territorio. C’è chi, come Piercamillo Davigo, giudice di Cassazione e
fondatore della nuova corrente giudiziaria Autonomia e indipendenza, nonché
nemico della riforma, analizza il dato con sarcasmo: «La responsabilità civile
dei magistrati non è un problema, visto che i cittadini fanno poche domande».
Altri numeri in realtà dimostrano che in Italia un problema di malagiustizia
esiste, ed è grave. Prima della Legge Vassalli, dal 1945 al 1988, l’Eurispes e
l’Osservatorio permanente sulle carceri calcolano 4,5 milioni di errori
giudiziari. Possibile che dopo il 1988 il fenomeno sia scomparso? Certo che no.
Il punto è che le citazioni per responsabilità civile sono state poche perché la
legge non ha mai funzionato. Dal 1988 a oggi la Cassazione ha stabilito sette
risarcimenti in tutto, uno ogni 7,5 milioni di processi penali aperti nel
periodo. C’è il caso di un’azienda agricola grossetana fallita nel 1998 per
l’errato sequestro di una tenuta, deciso in un’inchiesta per reati ambientali
(500 mila euro risarciti). C’è il caso di un pm siciliano che nel 2002 non tenne
nel debito conto una serie di lettere, acquisite dai Carabinieri, che avrebbero
potuto evitare un omicidio-suicidio di coppia: i familiari della donna uccisa,
nel 2009, hanno ottenuto 95 mila euro. Ma in nessun caso, mai, lo Stato si è
rivalso sui pm o sui giudici ritenuti colpevoli di dolo o colpa grave. Nessuno
di loro ha mai pagato nulla. L’ultima pronuncia, per ora ferma al primo grado,
riguarda un’inchiesta guidata nel 2004 dall’ex pm calabrese Luigi De Magistris,
poi migrato in politica. Lo scorso 3 dicembre il Tribunale di Roma ha condannato
lo Stato a pagare meno di 25 mila euro a Paolo Antonio Bruno, un magistrato di
Cassazione che nel 2004 fu ingiustamente accusato di associazione mafiosa da De
Magistris. Si vedrà come finirà il caso. Non ha mai nemmeno pensato di avvalersi
della Legge Vassalli, invece, l’imprenditore calabrese Antonio Saladino, che
pure dal 2006 si proclama vittima di un’altra, mitica inchiesta di De Magistris:
la «Why not», che nel 2006 piazzò Saladino al centro di una ragnatela di
presunte corruttele ma poi si risolse praticamente in nulla: «Citarlo in
giudizio? Quell’inchiesta mi ha rovinato economicamente» dice Saladino «però io
non ci ho mai nemmeno pensato. Sarebbe stata una povera battaglia contro i
mulini a vento, e credo lo sarebbe anche oggi». È così. Avvocati e presunte
vittime di giustizia hanno presto capito che la Legge Vassalli era utile come un
cucchiaio bucato e hanno scelto altre strade. Dal 1991, per esempio, cioè da
quando esistono i risarcimenti per l’ingiusta detenzione, in 23.326 hanno
ottenuto un risarcimento: in 23 anni lo Stato ha versato loro 581 milioni di
euro. La riforma, purtroppo, rischia di non cambiare nulla. «Oggi i magistrati
si lamentano, ma è lo stesso vacuo bla-bla di 26 anni fa, con le medesime parole
d’ordine» dice Gian Domenico Caiazza, penalista romano e presidente della
Fondazione Piero Calamandrei. Caiazza è un’autorità, in materia. Nell’aprile
1988 era nel collegio che, a nome di un Enzo Tortora morente di cancro, chiese
il risarcimento per il disastro giudiziario che cinque anni prima, a Napoli,
aveva coinvolto il giornalista in un’inchiesta su camorra e droga. Era stato
proprio il caso di Tortora, riconosciuto innocente dopo sette mesi di custodia
cautelare e una gogna aberrante, a dare il là al referendum e a garantirne il
successo. Nell’aprile 1988 la Legge Vassalli, appena varata, conteneva un
articolo che ne impediva l’applicazione retroattiva. Poiché il referendum aveva
abrogato le norme antecedenti, i difensori di Tortora si trovarono nella
peculiare situazione di agire senza limiti. «Per la prima e forse unica volta
nella storia di questo Paese facemmo causa ai magistrati come se fossero normali
cittadini» ricorda Caiazza. «Ma poi il Tribunale di Roma passò la palla alla
Consulta. Questa stabilì che l’articolo sulla irretroattività della Legge
Vassalli era incostituzionale nella sola parte che riguardava il filtro sulla
fondatezza delle nostre pretese: quella mancanza violava il principio
d’indipendenza e autonomia della magistratura». Insomma: il filtro del giudizio
di ammissibilità doveva esserci, per forza. Risultato? «A quel punto per il
risarcimento avremmo dovuto partire daccapo» dice Caiazza «ma con quella
pagliacciata avevamo perso due anni. Decidemmo di lasciar perdere». Il ricordo
dell’avvocato di Tortora è preciso (la sentenza della Consulta è la n. 468 del
22 dicembre 1990) e oggi fa scoppiare come una bolla di sapone la principale,
presunta innovazione della riforma appena varata. Caiazza ne è certo: «La
questione sull’abolizione del filtro potrà essere sottoposta in ogni momento
alla Corte costituzionale, che con tutta probabilità confermerà il suo
orientamento di 25 anni fa». Anche Davigo è d’accordo: «La Consulta si è già
pronunciata: l’eliminazione del filtro, con tutta evidenza, è costituzionalmente
illegittima». Suona quindi troppo ottimista il tweet di Gaia Tortora, che la
sera in cui è stata varata la riforma l’ha salutata come una vittoria alla
memoria di suo padre (e il premier Matteo Renzi si è subito appropriato di
quella generosa certificazione con un re-tweet). Anche perché intanto il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si sbraccia per tranquillizzare
l’Associazione nazionale magistrati. Il Guardasigilli ha già garantito alla
categoria che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che il governo «non ha alcun
intento punitivo», che «resterà deluso chi si aspetta che i giudici siano
condannati ogni due per tre», e addirittura che tra sei mesi sarà fatto «un
tagliando» per verificare «eventuali eccessi». Nella storia d’Italia non s’era
mai vista una legge con «retromarcia integrata». Beniamino Migliucci, presidente
dei penalisti, è critico: «Il tagliando è un’assurdità giuridica e politica. E
chi ipotizza una valanga di ricorsi fa disinformazione. Perché un imputato non
può citare il suo giudice: il ricorso è improcedibile, impossibile, fino a
quando non c’è una sentenza di Cassazione». Anche Giuseppe Di Federico, docente
emerito di diritto penale a Bologna e tra i maggiori giuristi italiani, è
scettico: «Non credo cambierà nulla. La nostra giustizia è del tutto
deresponsabilizzata: la valutazione delle carriere dei magistrati fa passare
tutti, al contrario di quanto accade in altri Paesi, e manca un vero sistema
sanzionatorio. E poi voglio proprio vederli, gli avvocati, che si espongono a
fare causa al loro giudice…». Una causa, oggi, non la farebbe nemmeno Pardo
Cellini, il penalista che pure ha scoperchiato il più grave errore giudiziario
italiano di tutti i tempi: quello che è costato 39 anni di processi a Giuseppe
Gulotta, un muratore trapanese che nel 1976, a 18 anni, fu arrestato per
l’omicidio di due carabinieri e solo dopo 22 anni di carcere, nel febbraio
2012, è stato riconosciuto innocente e liberato. Fin dalle prime udienze Gulotta
dichiarò che la confessione gli era stata estorta con violenze e torture da
parte dei Carabinieri. «E i suoi processi sono stati viziati da errori e lacune»
dice Cellini. «Però abbiamo preferito chiedere il risarcimento come danno da
errore giudiziario». Perché? Ma perché l’avvocato conosce a perfezione quali
siano le tortuosità della responsabilità civile: «È un sistema che non funziona
e non funzionerà» sospira. Il problema di Gulotta, che a 57 anni oggi vive della
carità di un parroco, è che sono trascorsi già 36 mesi dalla sua riabilitazione
ma non ha ancora visto un euro: l’avvocatura dello Stato si oppone, insiste
nella tesi paradossale che il processo fu originato dalla sua confessione, per
quanto estorta.«La vicenda Gulotta» conclude Cellini «mostra la resistenza dei
tribunali e il disinteresse delle istituzioni. E io non vorrei proprio dirlo, ma
temo che casi come il suo potrebbero accadere ancora. Per questo la
responsabilità civile va rivoluzionata». Più positivo, a sorpresa, è un
penalista che non ha mai simpatizzato con la magistratura: «La nuova legge è
equilibrata e migliorerà la situazione» dice Maurizio Paniz, ex deputato del Pdl
e avvocato di Elvo Zornitta, l’ingegnere veneto che fu ingiustamente accusato di
essere «Unabomber», l’autore di una serie di 30 attentati dinamitardi dal 1994
al 2004, con sei feriti. Scagionato nel 2009, oggi Zornitta sta per chiedere il
risarcimento allo Stato: non per responsabilità civile, però, ma ancora una
volta come riparazione di un errore giudiziario. Per partire, Paniz aspetta le
motivazioni della Cassazione che in dicembre ha condannato Ezio Zernar, il
poliziotto che confezionò false prove per incastrare Zornitta. «La nuova
responsabilità civile è migliore della vecchia» dice Paniz «perché specifica
come cause di punibilità la manifesta violazione della legge e il travisamento
delle prove. È un bene: a me sono capitati diversi processi in cui, a volte
dolosamente, una prova veniva valutata in modo errato». La morale? La tira
Grazia Volo, tra i più noti penalisti italiani: «Questa riforma arriva troppo
tardi, 28 anni dopo il referendum. È una riforme sfilacciata, scritta da un
legislatore superficiale e giustizialista, che intanto aumenta insensatamente le
pene. E non cambierà nulla». Una morale ancora più severa? Dice Carlo Nordio,
procuratore aggiunto di Venezia, da sempre controcorrente: «Il magistrato che
manda in galera un indagato contro la legge non deve pagare. Dev’essere buttato
fuori dalla magistratura». Chissà se il ministro Orlando ne terrà conto, nel suo
«tagliando».
Ma ora i magistrati saranno
più responsabili?
La legge sulla responsabilità civile cambia poco. Con un rischio:
l'eliminazione del giudizio preventivo di ammissibilità potrà ingolfare i
tribunali, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Uno legge le cronache
giudiziarie di oggi, perse come sono tra gli altissimi lamenti sulla fine
dell'autonomia della magistratura e le infinite proteste di categoria, e pensa:
caspita, che rivoluzione dev'essere questa riforma della responsabilità civile.
Poi va a leggersi i 7 articoletti della legge e pensa: caspita, ma qui cambia
davvero poco. Perché, in base alla legge varata ieri in via definitiva dalla
Camera, da oggi in poi dovrebbe venire punito il magistrato che si macchia di
una "violazione manifesta della legge", oppure di un "travisamento del fatto o
delle prove". Ma questo cambia obiettivamente molto poco rispetto alla Legge
Vassalli dell'aprile 1988. Questa, fino a ieri, prevedeva che ogni cittadino
potesse chiedere i danni allo Stato se un magistrato adottava un atto o un
provvedimento giudiziario "con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue
funzioni, ovvero per diniego di giustizia"; e dava facoltà al cittadino "di
agire contro lo Stato" anche "per ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della
libertà personale". Differenze? Mah... Ecco, sì, la nuova legge specifica meglio
che da oggi il cittadino può chiedere anche la punizione del magistrato che ha
sbagliato nell'emissione di "un provvedimento cautelare personale o reale fuori
dai casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione". Quanto al resto,
poco cambia. Sì, è vero, si allungano di un anno (da due a tre) i termini per
avviare l'azione legale. E oggi il governo è obbligato a esercitare l'azione di
rivalsa nei confronti del magistrato ritenuto colpevole. Aumenta anche la quota
di stipendio che il magistrato stesso dovrà restituire allo Stato: al massimo
metà del suo stipendio di un anno (prima era un terzo), senza però che si possa
superare un terzo del suo stipendio mensile nel caso di pagamenti mediante
trattenuta. Ma queste non sono certo modifiche sostanziali. E allora? Non cambia
davvero nulla? No: una modifica sostanziale riguarda il cosiddetto "filtro". La
Legge Vassalli all'art. 5 prevedeva infatti che la domanda di risarcimento
presentata dal cittadino dovesse ricevere una valutazione preventiva di
ammissibilità: in tre gradi di giudizio (fra tribunale, corte d'appello e
Cassazione) i giudici dovevano stabilire se la domanda fosse o no
"manifestamente infondata". Così, per stabilire se un magistrato dovesse
effettivamente pagare per un suo errore, servivano così nove gradi di giudizio:
tre per stabilire l'ammissibilità del giudizio, tre per stabilire il fatto in
sé, e altri tre per la rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato
che aveva agito con dolo o colpa grave. È per questo che pochissimi finora hanno
pagato. Per darvi un'idea: tra 1988 e 2014 tale è stata la fiducia degli
italiani nella Legge Vassalli che sono state presentate in tutto 410 domande,
davvero poche. Quelle ritenute "ammissibili" sono state appena 35, nemmeno una
su dieci, e di queste soltanto sette alla fine sono state accolte (per
l'esattezza 2 a Perugia e una a testa a Brescia, Caltanissetta, Messina, Roma,
Trento). La riforma, però, abolisce il giudizio di ammissibilità e l'art. 5.
Questo riduce a sei i gradi di giudizio. Secondo alcuni c'è il rischio che
questo possa esporre i tribunali italiani a una valanga di ricorsi. Tant'è vero
che i magistrati sono riusciti a strappare al governo l'impegno a fare un
"tagliando" della riforma tra sei mesi. Sul punto è abbastanza scettico invece
Giuseppe Di Federico, uno dei primi giuristi italiani (è docente emerito di
diritto penale a Bologna ed ex membro del Csm), che nel 1987 fu tra i promotori
del vittorioso referendum radicale sulla responsabilità civile, poi rintuzzato
dalla Legge Vassalli. "Non mi attendo uno tsunami di ricorsi" dice a Panorama.it
"perché mi domando quanti avvocati saranno disposti a esporsi in casi di questo
genere. E comunque prevedo un estremo rigore da parte dei tribunali".
Berlusconi, vent’anni di
rapporti con la magistratura. Dalle «toghe rosse» ai ringraziamenti per i
giudici della Cassazione che hanno confermato l’assoluzione nel processo Ruby.
Dal 22
novembre 1994 - data in cui Berlusconi, capo del governo, riceve un invito a
comparire dalla Procura di Milano che sta indagando sulle tangenti alla Guardia
di finanza - fino a oggi, sono stati altalenanti e spesso conflittuali i
rapporti del leader di Forza Italia con la magistratura, scrive “Il Corriere
della Sera”.
1. Il pool «Mani Pulite» e
l’avviso di garanzia del 1994.
Il primo interessamento della
giustizia nei confronti di Berlusconi risale al 1983 quando la Guardia di
finanza segnalò un suo presunto coinvolgimento in un traffico di droga con la
Sicilia. L’inchiesta venne archiviata. La prima condanna, invece, è del 1990: la
Corte d’appello di Venezia, dichiara Berlusconi colpevole di aver giurato il
falso davanti ai giudici, a proposito della sua iscrizione alla lista P2. Nel
settembre 1988, infatti, in un processo per diffamazione da lui intentato contro
alcuni giornalisti, Berlusconi aveva dichiarato al giudice: «Non ricordo la data
esatta della mia iscrizione alla P2, ricordo che è di poco anteriore allo
scandalo». Nonostante la Corte d’appello di Venezia dichiari Berlusconi
colpevole (il giudice era Luigi Lanza), il reato è considerato estinto per
l’amnistia del 1989. Il 22 novembre del 1994 Berlusconi, capo del governo,
mentre presiede la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità
transnazionale, riceve un invito a comparire dalla Procura di Milano che stava
indagando sulle tangenti alla Guardia di finanza. Le tangenti servivano per
alleggerire le verifiche alle società Mondadori, Mediolanum, Videotime, Telepiù:
in primo grado Berlusconi è stato condannato a 2 anni e 9 mesi; in appello,
grazie alle attenuanti generiche, è scattata la prescrizione.
2. All Iberian, dalle
accuse alla prescrizione.
Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi, l’ex segretario del Psi
Bettino Craxi, l’amministratore delegato di Mediaset Ubaldo Livolsi vengono
rinviati a giudizio con altre nove persone per l’ inchiesta sul presunto
finanziamento illecito della Fininvest, attraverso la società All Iberian, al
Psi nel 1991. Il processo inizia il 21 novembre 1996 davanti ai giudici della
seconda sezione penale del tribunale di Milano. Il pm Francesco Greco chiede per
Berlusconi 5 anni e 6 mesi di reclusione e 12 miliardi di multa poi, dopo lo
stralcio del reato di falso in bilancio, riformula la richiesta in due anni e
mezzo di reclusione e 12 miliardi di multa. Nel 1998 Berlusconi viene condannato
in primo grado (2 anni e 4 mesi). «I giudici hanno riscritto il codice penale
per allineare le norme alle esigenze repressive della procura» dichiara
Berlusconi. In appello però, nel 2000, sempre per le attenuanti generiche scatta
la prescrizione.
3. Colombo, il caso Lentini
e la prescrizione.
C’e’ anche un capitolo «sportivo»: versamento in nero di una decina di miliardi
dalle casse del Milan a quelle del Torino, per l’acquisto di Gianluigi Lentini.
Il dibattimento si conclude con la dichiarazione che il reato è prescritto,
grazie alla legge che abolisce il falso in bilancio. È lo stesso pubblico
ministero Gherardo Colombo a chiedere l’applicazione della prescrizione, dopo
che il tribunale respinge la sua eccezione di incostituzionalità della normativa
varata nel marzo 2002 in materia di falso in bilancio.
4. Il tribunale civile e il
risarcimento a De Benedetti.
Berlusconi è poi coinvolto in
una lunga serie di processi per la corruzione dei giudici romani in relazione al
Lodo Mondadori e al caso Sme. Sono i processi che hanno protagonista Stefania
Ariosto, il teste «Omega» e Cesare Previti. Condanne per Cesare Previti e il
giudice Metta. Per quanto riguarda il Lodo Mondadori, dopo una guerra durata
vent’anni, si stabilisce che Berlusconi deve risarcire De Benedetti. Luigi de
Ruggiero, Walter Saresella e Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della
seconda sezione civile della Corte d’Appello di Milano che emettono la sentenza
nell’ambito della vicenda del Lodo Mondadori che condanna Fininvest al pagamento
di circa 560 milioni di euro. La cifra diventa 494 milioni dopo la Cassazione.
5. De Pasquale e l’accusa
nel caso Mills, ma è prescrizione.
Le procure di Caltanissetta e Firenze che hanno indagato sui mandanti a volto
coperto delle stragi del 1992 e del 1993 hanno svolto indagini sull’eventuale
ruolo che Berlusconi e Dell’Utri possono avere avuto in quelle vicende.
L’inchiesta è stata chiusa con l’archiviazioni nel 1998 (Firenze) e nel 2002
(Caltanissetta). La procura di Palermo, inoltre, ha indagato su Berlusconi per
mafia: concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco.
Nel 1998 l’indagine e’ stata archiviata per scadenza dei termini massimi
concessi per indagare. Definitiva la prescrizione per il caso Mills, l’avvocato
inglese che avrebbe ricevuto 600 mila euro da Berlusconi per testimonianze
reticenti ai processi per All Iberian e tangenti alla Gdf. A sostenere l’accusa
contro Berlusconi il pm Fabio De Pasquale.
6. Caso Ruby, Boccassini è
pubblica accusa.
Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, insieme al pm
Antonio Sangermano, rappresenta la pubblica accusa nel processo di primo grado
sul caso Ruby. I rapporti di Berlusconi con Boccassini sono conflittuali. L’ex
premier respinge le accuse e condanna l’operato dei pm di Milano.
7. Tre donne per la
condanna in primo grado.
Il 24 giugno 2013, nel processo Ruby, Silvio Berlusconi viene
condannato in primo grado a 7 anni per entrambi i reati contestati: concussione
per costrizione e prostituzione minorile. Il collegio della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano che giudica Berlusconi è composto da donne: la
presidente Giulia Turri, che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per
il “fotografo dei vip” Fabrizio Corona; Carmen D’Elia, che già nel 2002 aveva
fatto parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato,
tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi; Orsola De Cristofaro, la terza
componente del collegio, con un passato da pm e gip, già giudice a latere nel
processo che ha portato alla condanna a quindici anni e mezzo di carcere per
Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica, imputato con
altri medici per il caso della clinica Santa Rita.
8. L’assoluzione in
appello. Il presidente si dimette.
Il processo d’appello per il caso Ruby si tiene davanti alla seconda Corte
d’Appello: Enrico Tranfa è il presidente, Concetta Lo Curto e Alberto Puccinelli
i giudici a latere. Berlusconi viene assolto dal reato di concussione «perché il
fatto non sussiste» e dal reato di prostituzione minorile «perché il fatto non
costituisce reato». L’ex Cavaliere commenta che «la maggioranza magistrati è
ammirevole». Enrico Tranfa, il presidente, si dimette subito dopo aver firmato
le motivazioni della sentenza, in dissenso con la sentenza presa a maggioranza
con il sì degli altri due giudici. E così, dopo 39 anni di servizio, a 15 mesi
dalla pensione, il magistrato lascia anzitempo la toga. Tranfa ha esercitato la
professione in gran parte a Milano. Negli anni 90 è stato all’ufficio Gip. Come
giudice delle indagini preliminari, nel periodo di Mani Pulite, si era occupato
di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Anas e di quella sulla centrale
dell’Enel a Turbigo per cui dispose l’arresto, tra gli altri, dell’ex assessore
lombardo in quota alla Dc Serafino Generoso. Nel 2002 è stato nominato
presidente del Tribunale del Riesame sempre di Milano. Come giudice d’appello ha
confermato, tra l’altro, la condanna a tre anni di carcere per Ubaldo Livolsi
per la bancarotta di Finpart. Concetta Lo Curto, entrata in magistratura nel
1990, è stata giudice al Tribunale di Milano, prima all’ottava sezione penale e
poi alla terza dal 1995 al 2013 quando poi è passata in Corte d’Appello. Nel
2010 assolse l’allora deputato del Pdl Massimo Maria Berruti, imputato per la
vicenda Mediaset (la sua posizione era stata stralciata da quella di Berlusconi
e degli altri). Puccinelli, entrato in magistratura nell’89, è stato il giudice
relatore al processo di appello che si è concluso con la prescrizione per
Berlusconi, imputato per la vicenda del «nastro Unipol».
9. Processo Ruby, il pg De
Petris contro l’assoluzione.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione confermato l’assoluzione, che
diventa definitiva, di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Il sostituto
procuratore della Corte d’Appello Pietro De Petris aveva fatto ricorso in
Cassazione contro l’assoluzione.
10. Processo Mediaset,
l’accusa di De Pasquale e Spadaro.
Il 18 giugno 2012 i pm di
Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro chiedono una condanna a 3 anni e 8
mesi di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato di frode fiscale nel processo
sulle presunte irregolarità nella compravendita dei diritti tv da parte di
Mediaset. Il 26 ottobre 2012 l’ex premier viene condannato a 4 anni di
reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e tre anni di
interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.
11. Pena più severa di
quanto richiesto.
Il presidente del collegio che condanna Berlusconi in primo grado è Edoardo
D’Avossa con i giudici a latere Teresa Guadagnino e Irene Lupo). La pena è
maggiore di quanto chiesto dai pm. Berlusconi commenta: «È una condanna
politica, incredibile e intollerabile. È senza dubbio una sentenza politica come
sono politici i tanti processi inventati a mio riguardo».
12. Il giudice Galli
conferma in appello.
L’8 maggio 2013, dopo quasi sei ore di camera di consiglio, i
giudici della seconda Corte d’Appello di Milano, presieduti da Alessandra Galli
(nella foto Brandi/Fotogramma), confermano la condanna a 4 anni di reclusione,
di cui tre coperti da indulto, per Silvio Berlusconi, accusato di frode fiscale
nell’ambito del processo sulla compravendita dei diritti tv Mediaset. Berlusconi
parla di «persecuzione» da parte della magistratura che vuole eliminarlo dalla
scena politica.
13. Esposito, la Cassazione
e l’intervista contestata.
Il primo agosto 2013 la Cassazione conferma la condanna a quattro anni di
carcere. A leggere la sentenza sul processo Mediaset è il presidente della
sezione feriale della corte di cassazione Antonio Esposito. Nei giorni
successivi, il giudice Esposito finisce nella bufera per un’intervista a «Il
Mattino» in cui parla della sentenza sul processo Mediaset-Berlusconi. Lo stesso
magistrato farà seguire una smentita riguardo ad alcuni passaggi. In
particolare, Esposito smentisce anche «di aver pronunziato, nel colloquio avuto
con il cronista - rigorosamente circoscritto a temi generali e mai attinenti
alla sentenza, debitamente documentato e trascritto dallo stesso cronista e da
me approvato - le espressioni riportate virgolettate: “Berlusconi condannato
perché sapeva non perché non poteva non sapere».
10 marzo 2015. La Corte di
Cassazione assolve.
Questa donna (la Boccassini) ha distrutto il Paese Ma resterà impunita. Anche un
magistrato come Emiliano si indigna: "Chieda scusa". E nonostante tutto Ilda
Boccassini rimarrà al suo posto come sempre, scrive Alessandro Sallusti su “Il
Giornale”. Per La Repubblica, Berlusconi non è un innocente perseguitato ma un
«colpevole salvato», come si evince dal titolo che racconta con stizza
dell'assoluzione definitiva in cassazione sul caso Ruby. Il Corriere della Sera
affida invece al suo segugio Luigi Ferrarella la difesa senza se e senza ma
dell'operato dei pm milanesi. Un ufficio stampa della procura non avrebbe saputo
fare di meglio e, ovviamente, Ferrarella tace sul fatto che lui stesso e
autorevoli colleghi del suo giornale nel corso di questi anni avevano già emesso
la sentenza di colpevolezza in centinaia di articoli nei quali si spacciavano
per prove certe i farneticanti teoremi dell'accusa. Non sappiamo invece il
commento di Ilda Boccassini, la pm che ha fatto da redattore capo di quella
grande messa in scena truffaldina ed esclusivamente mediatica che è stata
l'inchiesta Ruby. Una cosa però conosciamo. E cioè che la Boccassini, grazie a
questa inchiesta, è stata inclusa dalla rivista statunitense Foreign Policy al
57esimo posto nella lista delle personalità che nel corso del 2011 hanno
influenzato l'andamento del mondo nella politica, nell'economia, negli
esteri.Non stiamo parlando di un dettaglio. Anche dall'altra parte dell'Oceano
erano giunti alla conclusione che le notizie costruite dalla procura di Milano e
spacciate da Corriere e Repubblica non costituivano un mero fatto giudiziario ma
avevano contribuito in modo determinante a modificare giudizi sull'Italia con
ricadute decisive financo sul piano internazionale. Oggi, grazie alla sentenza
di Cassazione, sappiamo che si trattò di una iniziativa scellerata,
completamente falsa, paragonabile a un complotto per destabilizzare un Paese
sovrano. Complotto ordito da magistrati e sostenuto da complici, o almeno utili
idioti, nelle redazioni dei giornali nazionali ed esteri, nelle stanze di
governi stranieri e in quelle della politica di casa. A partire da quella più
prestigiosa del Quirinale, allora abitata da Giorgio Napolitano. Il quale non
solo non mosse un dito per fermare il linciaggio del suo primo ministro, ma,
proprio sull'onda di quella destabilizzazione, ricevette in segreto banchieri,
editori e imprenditori di sinistra per organizzare un controgoverno (Monti, per
intenderci) nonostante quello in carica godesse ancora della piena fiducia del
Parlamento. Alla luce di tutto questo, e in attesa che la Corte europea faccia
giustizia di un'altra bufala giudiziaria (la condanna di Berlusconi per evasione
fiscale, avvenuta grazie al trucco di assegnare la sentenza non al giudice
naturale, ma a un collegio costruito ad hoc, guarda caso su sollecitazione del
Corriere della Sera ), ora si pongono problemi seri che meritano risposte veloci
e all'altezza di un Paese libero e democratico. Riguardano la permanenza nelle
loro delicate funzioni dei responsabili e la riabilitazione politica della
vittima Berlusconi. Nessuno, su questo, può permettersi di fare il pesce in
barile.
Il giallo Tranfa e quei
Servizi rimasti muti,
scrive Giovanni Maria Jacobazzi su “Il Garantista”. Il processo Ruby non è stato
un processo come tanti. Molti aspetti, oscuri, hanno connotato questa vicenda
penale che ha portato alla caduta di un governo e allo sfascio di un partito.
Tralasciando lo sputtanamento internazionale e il ludibrio planetario che hanno
investito Silvio Berlusconi e, di riflesso, il Paese. Due, principalmente, sono
gli episodi che fanno riflettere e che ad oggi non hanno avuto risposta. Episodi
che riguardano proprio l’inizio e la fine dell’inchiesta. Il primo riguarda le
modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari da parte della
Procura della Repubblica di Milano. Il secondo le dimissioni del giudice Enrico
Tranfa, il presidente del collegio che in appello ha assolto Silvio Berlusconi
dopo la condanna in primo grado a sette anni. Per scoprire cosa accadesse la
sera nella residenza di Arcore, la Procura di Milano non ha lesinato energie.
Con un dispiegamento di forze senza pari in relazione ai tipo di reato
perseguito, una ipotesi di prostituzione minorile e di concussione, i
pubblici ministeri milanesi hanno posto in essere un numero elevatissimo di
intercettazioni telefoniche. Tranne Silvio Berlusconi che, essendo parlamentare,
non poteva essere intercettato, chiunque entrasse in contatto con Villa San
Martino si ritrovava il telefono sotto controllo. Decine di ragazze, ma non
solo, furono intercettate per mesi. Ogni loro spostamento
accuratamente monitorato. Centinaia i servizi di osservazione, controllo e
pedinamento come si usa dire in gergo questurile. All’epoca dei fatti, il 2009,
Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio. Il suo uomo più fidato,
Gianni Letta, sottosegretario di Stato con delega ai Servizi. Come è stato
possibile effettuare una attività investigata di queste proporzioni, migliaia
le intercettazioni effettuate, senza che nessuno, in maniera
ovviamente riservata, facesse arrivare il “messaggio” all’indagato eccellente
di prestare attenzione alle persone frequentate ed ai comportamenti da tenere?
Nessuna indicazione dai gestori telefonici? Nessun dubbio circa questa anomala
concentrazione di utenze sotto controllo proprio nella residenza privata del
presidente del Consiglio, sottoposta a misure di massima sicurezza secondo la
legge 801 che disciplina il segreto di Stato? Ma il rapporto anomalo con
gli apparati di sicurezza è anche alla base dell’accusa più grave caduta sulla
testa di Berlusconi. Quella di concussione nei confronti del capo di gabinetto
della Questura di Milano. Come mai il presidente del Consiglio, residente a
Milano, città dove ha il centro dei suoi interessi e dove vive la sua famiglia,
non si rivolge, per motivi di opportunità e riservatezza, direttamente
al Questore ma passa attraverso il suo capo di gabinetto, peraltro chiamatogli
al telefono dal suo capo scorta? Essendo il Consiglio dei ministri preposto alla
nomina dei questori delle città, non si può proprio dire che l’allora premier
non conoscesse chi fosse al vertice della pubblica sicurezza del capoluogo
lombardo. E infine le dimissioni improvvise e inaspettate del giudice
Enrico Tranfa, il presidente del collegio di Appello che ha assolto
Silvio Berlusconi, subito dopo il deposito delle 330 pagine delle motivazioni
della sentenza. Come si ricorderà, dopo aver depositato la sentenza di
assoluzione, Enrico Tranfa fece domanda per essere collocato in pensione.
Poteva restare in servizio altri quindici mesi. Decise di anticipare l’uscita
dalla magistratura. Campano di Ceppaloni, il paese che ha dato i natali anche a
Clemente Mastella, collocabile nella corrente di Unicost, Tranfa era dal 2012 a
Milano in Corte d’Appello come presidente della seconda sezione penale.
Equilibrato, molto preparato, mai una parola fuori posto. Un persona mite. Nulla
che potesse far prevedere una reazione del genere. Le sue dichiarazioni, a chi
gli chiedeva il perché di una simile decisione, furono soltanto “è una decisione
molto meditata, perché in vita mia non ho fatto niente di impulso. Tutti
sono utili, nessuno è indispensabile”. Per poi aggiungere: “Il compito di un
giudice non è quello di cavillare con i tecnicismi, ma prendere un fatto,
valutarlo alla luce delle norme, e poi fare un atto di
volontà, decidendo. Altrimenti è la giustizia di Ponzio Pilato”. Sul caso montò
la contrapposta lettura politica: “Solidarietà” dal Pd e dure critiche da Forza
Italia. Le dimissioni in polemica con l’assoluzione scatenarono anche le ire del
presidente della Corte d’Appello Giovanni Canzio. “Se dettate da un personale
dissenso per l’assoluzione di Silvio Berlusconi non appaiono coerenti con le
regole ordinamentali e deontologiche che impongono l’assoluto riserbo sulle
dinamiche della Camera di consiglio”, disse Canzio, “trattasi di un gesto
clamoroso e inedito”. Se per ogni disaccordo in un collegio il magistrato
dovesse dimettersi, in magistratura rimarrebbero in pochi. Ma quell’anomalia,
come la prima, con ogni probabilità rimarrà senza risposta.
Processo Ruby, pool di
Milano: le lettere segrete delle toghe rosse alla giudice che assolse Silvio
Berlusconi, scrive “Libero
Quotidiano”. Le toghe rosse di Milano si attendevano l'annullamento
dell'assoluzione in secondo grado. Volevano
Silvio Berlusconi
di nuovo alla sbarra nel processo Ruby. Ma così non è andata. Confermata
l'assoluzione. E dopo la conferma, oltre al Cav, ci sono state diverse persone
che si sono levate dei sassolini dalle scarpe. Una di queste era la giudice
Concetta Locurto,
toga stimata e progressista, già coordinatrice milanese di Area, il cartello tra
le correnti di sinistra di Magistratura Democratica. Una, insomma, che aveva il
"pedegree" giusto per condannare Berlusconi in secondo grado. Già, perché la
Locurto la scorsa estate era la relatrice della sentenza di assoluzione del Cav
nel processo Ruby. L'assoluzione scatenò
un vespaio di polemiche
in magistratura, culminate con le dimissioni del suo collega e presidente del
collegio,
Enrico Tranfa, che con il
passo indietro volle dissociarsi da un verdetto che non condivideva. La Locurto,
al tempo, non volle commentare. E non ha voluto commentare neppure dopo la
conferma dell'assoluzione che, nei fatti, ha confermato la bontà del suo
operato. E il silenzio le deve essere costato, perché come spiega il
Corriere della Sera
la toga che ha assolto Berlusconi ha vissuto
mesi da incubo,
tra "attacchi e implicite insinuazioni di cosa di oscuro potesse essere accaduto
attorno al processo" per spingere Tranfa alle dimissioni. Ha taciuto, la Tranfa.
Almeno in pubblico. Già, perché secondo quanto scrive sempre il
Corsera,
la toga avrebbe scritto una piccola lettera ai colleghi (agli stessi colleghi
che nei mesi precedenti tempestavano la sua email parlando di "torsione del
diritto"). Il
Corsera ha provato a chiederle
del contenuto della lettera, ma la Tranfa, fedele alla sua riservatezza,
ha scelto di non
parlare. Eppure qualcosa è
emerso. Nonostante il rifiuto della giudice, è stato ricostruito quanto abbia
detto interpellando i destinatari della missiva. La Tranfa non giudicava la
bontà della sentenza, ma metteva in guardia dai rischi di "una
malevola dietrologia faziosa",
del "pregiudizio", dei "pensieri in libertà da chiacchiera da bar" della quale è
stata vittima per mesi per aver fatto il suo lavoro, che nella fattispecie
prevedeva di assolvere Berlusconi. La Tranfa avrebbe scritto dei "magistrati che
giudicano senza conoscere, finendo - proprio loro - per
partecipare al tiro al
piccione senza alcun
rispetto per l'Istituzione e le persone". E il piccione, in quel momento, era
proprio lei. E il "piccione", ora, si toglie le sue soddisfazioni. Nella missiva
avrebbe aggiunto l'invito ai colleghi ad "andarsi a rileggere i provvedimenti
redatti nel corso dell'intera carriera, piccoli o grandi che fossero, per avere
certezza dell'identità di
metro di valutazione
utilizzato indifferentemente per extracomunitari e potenti". Quel metro di
giudizio imparziale che però, i colleghi, le rimproverano: se c'è il Cav alla
sbarra deve essere condannato.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: logica da
pm. Se Silvio Berlusconi conosce Noemi Letizia, è colpevole. La Cassazione
doveva confermare o non confermare l’assoluzione di
Silvio Berlusconi
(caso Ruby) per concussione e prostituzione: dopodiché, lo schema era il solito.
La Corte che si riunisce nel primo pomeriggio, i giornalisti italiani e
stranieri che ciacolano, la consueta assicurazione che la sentenza arriverà «in
serata» e che perciò potranno scriverne, hurrà. Ma forse i giudici non erano
aggiornati: non sapevano che i quotidiani hanno le chiusure sempre più
anticipate, mannaggia: come possono non tener conto delle sacre esigenze
mediatiche? Come possono aver saltato i telegiornali della sera? I giudici
(presidente
Nicola Milo, consiglieri
Giorgio
Fidelbo,
Stefano
Mogini
e Gaetano
De
Amicis)
dovevano prendere esempio dal procuratore generale Eduardo Scardaccione, che nel
pomeriggio aveva esposto una requisitoria mediaticamente perfetta. Niente di
strano che abbia chiesto di annullare - con rinvio in Appello - l’assoluzione di
Berlusconi per entrambi i reati: è ciò che ci si attendeva da lui, un’apologia
di quel processo che in primo grado aveva condannato il Cav a sette anni. Mentre
invece le assoluzioni di luglio scorso - pochi mesi fa: la giustizia italiana sa
essere velocissima - secondo Scardaccione andavano polverizzate: altro che «il
fatto non sussiste» (concussione) e «il fatto non costituisce reato»
(prostituzione minorile). Sin qui tutto normale. Ma sono altri argomenti che ha
adottato - poi - a farci pensare ancora una volta che taccuini e telecamere
andrebbero tenuti lontani dai palazzi di giustizia. Scardaccione ha detto che le
accuse sono «pienamente provate» (vabbeh) e che la Corte d’appello non doveva
riaprire il processo bensì rideterminare la pena di primo grado: e ci sta anche
questo. Poi lo show: «L’episodio nel quale Berlusconi racconta che Ruby è la
nipote di Mubarak è degno di un film di
Mel
Brooks
e tutto il mondo ci ha riso dietro». Uhm. Purtroppo «il mondo» non ha
testimoniato a processo. E neppure Mel Brooks. A ogni modo
il procuratore Scardaccione
ha proseguito spiegando che la concussione c’è stata, anzi «c’è stata una
violenza irresistibile» per ottenerla. Lo proverebbe il fatto che dal momento in
cui ha ricevuto la telefonata di intervento da Berlusconi il capo di gabinetto
della Questura di Milano «non capisce più nulla e fa ben 14 telefonate: c’è
spazio per ritenere che la pressione fosse resistibile?... No... L’intervento ha
avuto una potenza di fuoco tale da annullare le scelte autonome del
funzionario». Par di capire che qualsiasi telefonata di Berlusconi in quel
periodo - essendo lui premier ed essendo Berlusconi - avesse una potenziale
valenza concussoria: chiunque ne riceveva una
andava praticamente in palla e
veniva annullato nella volontà,
una forma di ipnosi. Il procuratore generale non ha contemplato che i dirigenti
della Questura fossero banalmente eccitati all’idea di poter fare un favore al
presidente del Consiglio: cosa che avrebbe avuto una valenza più che ambigua se
solo avessero fatto qualcosa che non dovevano fare. Ma ciò che fecero
(identificazione di Ruby, foto segnalazione e ricerca di una comunità per
l’affido) corrispondeva alla prassi in vigore. Ma secondo Scardaccione no, c’è
stata «una violenza grave, perdurante e irresistibile anche a margine della
consegna di Ruby a Nicole Minetti». Il dettaglio è che l’idea di consegnare Ruby
alla Minetti non fu un’idea di Berlusconi bensì una soluzione escogitata in
questura. Ma - possiamo dirlo? - ci sta anche questo. È passando al reato di
prostituzione minorile che si giunge all’incredibile: perché Scardaccione ha
tirato in ballo
Noemi Letizia, una ragazza
che non c’entra un accidente - mai tirata in ballo in nessun processo, in nessun
modo - perché la circostanza che Noemi e Ruby fossero due minorenni «non
è una coincidenza» e rende
«non credibile» che Berlusconi non sapesse della minore età di Ruby.
Scardaccione ha ricordato quanto aveva detto Ruby in un’intercettazione: «Noemi
è la sua pupilla e io il suo culo». Cioè: il fatto che due amici di Berlusconi
avessero una figlia minorenne non poteva essere un caso. E chissà - aggiungiamo
noi - quanti
milioni di elettori di Forza Italia,
negli ultimi vent’anni, hanno avuto figlie minori. Insomma: se Berlusconi sapeva
che la figlia di due suoi amici era minorenne, beh, doveva sapere anche l’età di
tutta la carovana di signorine che la sera gli portavano a casa con la carriola.
Pagandole, certo: perché Franco Coppi, l’avvocato di Berlusconi, ieri non l’ha
negato: «La sentenza d’appello ammetteva che ad Arcore
avvenivano fatti di
prostituzione, cosa che non
contestiamo nemmeno noi difensori: ma manca, in fatto, la prova che Berlusconi
prima del 27 maggio sapesse che Ruby era minorenne». Sempre che i processi si
facciano ancora con le prove.
Il caso Ruby c’è costato
mezzo milione.
Per i pm le spese ammontano a 65mila euro, ma facendo altri calcoli si sfiorano
i 600mila, scrive Simone Di Meo su “Il Tempo”. Quanto è costata l'inchiesta Ruby
alle casse dello Stato? La classica domanda da un milione di dollari ha una
doppia risposta. La versione minimalista, accreditata dai conti della Procura
della Repubblica di Milano contenuti nel faldone 33 del procedimento, parla di
appena 65mila euro così suddivisi: in sei mesi sono stati pagati 26mila euro per
le intercettazioni e 39mila euro per trascrizioni di interrogatori, traduzioni
dall’arabo, per il noleggio auto, la più costosa delle quali - una Golf - è
stata pagata 4mila euro, e per l’acquisto di registratori digitali. Pochi
spiccioli anche per le trasferte dei poliziotti in alcuni hotel di Rimini: poco
meno di 200 euro per tre diversi viaggi. Insomma, per questa scuola di pensiero
il procedimento penale del pm Ilda Boccassini non ha prosciugato le casse del
ministero della Giustizia ma si è mantenuto addirittura al di sotto dello
standard della Direzione distrettuale antimafia. Questione risolta, allora? Mica
tanto perché a questa immagine light dell'inchiesta se ne contrappone una più
approfondita che zavorra con almeno uno zero la cifra iniziale portandola a
oltre mezzo milione di euro. Ci sono alcuni costi che, nel computo del pubblico
ministero, non vengono infatti elaborati. Sarà sicuramente una distrazione, ma
bisogna fare chiarezza. Stiamo parlando dei cosiddetti costi fissi che
riguardano l'utilizzo della polizia giudiziaria per condurre un'indagine fatta a
pezzi dalla Corte d'appello e dalla Cassazione dopo una prima condanna a sette
anni nei confronti di Silvio Berlusconi. Un'indagine fondata su due capi di
imputazione che tecnicamente non hanno retto al vaglio delle toghe. Perché è
vero che un poliziotto o un carabiniere viene ugualmente stipendiato dallo Stato
(e ci mancherebbe) ma c'è un particolare di cui non tutti si ricordano: il
poliziotto o il carabiniere in questione avrebbe potuto essere impiegato su un
altro versante giudiziario, magari più interessante e utile. E questo - dal
punto di vista aziendalistico - è un costo che non può essere omesso se si vuole
davvero fare una descrizione esatta del valore contabile del fascicolo Ruby.
Dare per scontate queste voci di costo è un errore. Così come è un errore non
calcolare il noleggio dell'apparecchiatura utilizzata per geolocalizzare i
cellulari che hanno agganciato la cella di Arcore alla ricerca delle utenze
delle partecipanti alle "cene eleganti". Un'attrezzatura che, secondo quanto
risulta a Il Tempo costa in media 1000 euro al giorno: è probabile che fosse già
in dotazione agli uomini del Servizio centrale operativo cui sono state delegate
le attività investigative, ma il suo utilizzo, in termini economici, dev'essere
adeguatamente riportato nello schema della Procura. I "target" di
intercettazioni e acquisizioni di traffico telefonico e di tabulati sono stati
circa trenta per oltre 115mila conversazioni monitorate. Nell'intera operazione
è presumibile che siano stati impegnati oltre cento poliziotti che, per la
durata delle indagini, sono stati distolti da altri fascicoli, ovviamente. Non
sbirri qualunque, ma uomini dello Sco, l'organo investigativo di punta del
Viminale che solitamente dà la caccia a mafiosi, narcotrafficanti e serial
killer. Per dire: i due superlatitanti del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e
Michele Zagaria, sono stati presi anche con la collaborazione del Servizio
centrale. Che, nel caso in esame, è stato invece sguinzagliato sulle tracce
delle olgettine e del ragionieri Spinelli, lauto pagatore ufficiale del Cav.
Anche i loro stipendi, anche i loro straordinari, anche i loro ticket sono dei
costi a carico dello Stato (e quindi dei cittadini) che devono essere inseriti
nel bilancio Ruby. Alla fine, calcoli alla mano, l'indagine di "Ilda la rossa"
tra costi fissi (quelli appena descritti, che riguardano l'intera struttura) e
costi variabili (i famosi 65mila euro, che dipendono appunto dalle necessità
investigative del momento) ha gravato sulle casse dello Stato per circa 600mila
euro. È una stima prudenziale ma che ha un suo fondamento considerato che un
poliziotto viene pagato in media 100 euro lordi al giorno. Qualcuno ci
aggiungerebbe anche i costi dei processi (stipendi dei giudici, dei cancellieri,
del personale amministrativo, fotocopie) ma entriamo nel fantastico mondo delle
ipotesi e allora tutte le ricostruzioni sono possibili.
Signori del Csm,
quell’inchiesta è senza ombre?
Scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista. Sono politici, non morali, i motivi per
cui è andato in onda per cinque anni il Pornofilm del Bungabunga che ha messo
nel tritacarne un presidente del Consiglio, preso a picconate il suo partito,
distrutto la sua reputazione nel mondo, insieme alla sua immagine personale e i
suoi affetti. Tutto nasce non tanto dal fermo, in una serata di maggio del 2010,
di una giovane marocchina. Né dalla successiva telefonata di Berlusconi alla
questura di Milano. Casomai dall’uso che dell’episodio venne fatto dalla Procura
della Repubblica più famosa e discussa d’Italia. E’ negli uffici del quarto
piano del palazzo di giustizia di Milano, già allenati dalla caccia
al cinghialone ai tempi di Craxi e di Tangentopoli, che parte la crociata di
stampo talebano che prende di mira il presidente del Consiglio per i suoi
costumi sessuali. Ma il Pornofilm è solo l’involucro, un uovo di pasqua con
sorpresa. La sorpresa è tutta politica. Se il Consiglio superiore della
magistratura volesse occuparsene, potrebbe rilevare parecchie anomalie, dentro
quell’uovo. Prima cosa: Ruby viene fermata e rilasciata in una notte di
fine maggio. Che cosa è successo tra quella data e quella in cui Silvio
Berlusconi viene iscritto nel registro degli indagati (21 dicembre 2010) e
in seguito raggiunto da un invito a comparire (14 gennaio 2011)? Succede che
Ruby viene ripetutamente interrogata, una serie di persone che frequentavano la
casa di Arcore viene monitorata e intercettata e si tende la tela del ragno che
deve catturare la preda. Che la preda sia un Arcinemico di certa magistratura e
certi Pubblici ministeri non è un segreto. Che dalle parti di Milano si usino
metodi disinvolti sulle competenze territoriali (un presidente del Consiglio non
dovrebbe essere giudicato dal Tribunale dei ministri?) è cosa altrettanto
nota. Ma quel che succede a Milano è qualcosa di ben più mostruoso: per
sette-otto mesi vengono fatte indagini su un contesto che ha al centro
una persona che non è indagata, vengono disposte intercettazioni a persone che
parlano al telefono con un parlamentare senza che sia chiesta, come prescrive la
legge, l’autorizzazione alla Camera di appartenenza. Nei fatti si indaga su
una persona in violazione delle normali procedure di legge. A nulla valgono le
proteste degli avvocati, le interrogazioni parlamentari del deputato di Forza
Italia Giorgio Stracquadanio, la curiosità che comincia a serpeggiare
nella stampa italiana e anche straniera. La Procura di Milano tira dritto.
Apparentemente arrogandosi il diritto di moralizzare i costumi altrui, in realtà
con obiettivi ben più ambiziosi. Ma un’altra anomalia esplode clamorosa a
un certo punto, la rissa da cortile tra il procuratore capo Bruti Liberati e il
suo aggiunto Robledo sulle competenze tematiche e le assegnazioni delle
inchieste. Perché le indagini su Berlusconi e il “caso Ruby” vengono assegnate a
Ilda Boccassini, titolare delle inchieste sulla mafia e non a Robledo che si
occupa di Pubblica Amministrazione? Berlusconi non è forse accusato di aver
abusato del suo potere di presidente del Consiglio, con quella famosa telefonata
in questura che gli costerà la condanna in primo grado per concussione? Questo
aspetto della vicenda giace nelle scartoffie (nei fatti archiviate) del Csm
sulla querelle Bruti-Robledo, che nessuno pare avere la curiosità di esaminare
più. Sarebbe bene, invece, che l’organo di autogoverno di Pm e giudici
riaprisse gli occhi, su questo punto, e si chiedesse “perché” fosse così
importante quella sostituzione di Robledo con Boccassini in un’inchiesta dal
sapore squisitamente politico. Questo è il succo della vicenda: forzature
e anomalie per il raggiungimento di uno scopo. Addirittura il procuratore
generale di Milano, pur di fare il ricorso in Cassazione, si è appellato a
questioni di merito, trascurando il fatto che il terzo grado di giudizio
può riguardare solo questioni di legittimità. Un’altra delle anomalie
“lombarde”, che la Cassazione avrebbe dovuto rilevare subito, rigettando
il ricorso in dieci minuti. Nove ore di discussione sono un bel tributo
alle tricoteuses di tutta Italia. In ogni caso,tutto il resto è contorno, il
Pornofilm, il Bungabunga, sparsi a piene pani tramite un ventilatore in funzione
permanente con lo scopo dello Sputtanamento. Oggi, con Berlusconi che porta
a casa con una certa velocità (quattro anni per tre gradi di giudizio
sono un’altra, piacevole, anomalia) l’assoluzione piena da due reati infamanti,
resta il reato di Sputtanamento ancora vivo e vegeto nelle immagini del
Pornofilm, tanto che gli avvocati sono stati costretti a dire (un po’ andando di
fantasia) che, in fondo si, forse un po’ di prostituzione ad Arcore c’è stata,
per rafforzare la realtà dei fatti sulla non conoscenza dell’età di una
quasi-diciottenne che dimostrava, a detta di tutti, almeno venticinque anni. E
che probabilmente era più una mantenuta che una prostituta. Anche in questo il
processo Ruby è stato speciale. Ma non può finire qui. Il Csm ci deve spiegare
se tutte queste violazioni sono consentite, se anche il nuovo corso
“renziano” ha intenzione di chiudere gli occhi, come già si fece 20 anni fa con
Tangentopoli, su questi metodi machiavellici, per cui la finalità politica può
fare a pezzi le regole dello Stato di diritto e prevale sempre la filosofia del
“tipo d’autore” (individuo la tipologia del colpevole, poi colpisco la persona),
per cui la responsabilità penale non è più personale ma esplicitamente politica.
Alla faccia dell’obbligatorietà dell’azione penale.
«Cittadini impotenti
davanti ai magistrati», scrive
Daniel Rustici su “Il Garantista”.
«Il Csm cominci a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per
usare un eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati
fuori dal coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione.
Il caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei
più clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. Il Csm dovrebbe essere
meno indulgente e ”perdonista” nei confronti dei magistrati che commettono gravi
errori».
Chi parla è uno dei giudici più intransigenti e celebri per le sue feroci
polemiche contro pezzi del mondo politico, e a difesa della magistratura:
Antonio Ingroia.
In un’intervista al nostro giornale ha detto che bisogna difendere i cittadini
che talvolta sono troppo deboli di fronte ai magistrati e ai loro
eventuali errori. Ha parlato anche di carcerazione preventiva, e ha detto che
«in un Paese in cui i tempi
per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi
ad utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione della
pena prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizio».
Ingroia, stanno
facendo molto rumore le sue dichiarazioni sulla responsabilità civile dei
giudici. Ha parlato di cittadini «impotenti» davanti al potere della
magistratura. Detto da un’ex toga…
«Voglio
precisare prima di tutto che sono contrario alla responsabilità civile dei
magistrati. Penso invece che per garantire i diritti dei cittadini
bisognerebbe che il Csm cominci a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi
ha svolto, per usare un eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i
magistrati fuori dal coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della
professione. Il caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i
giudici di uno dei più clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. La
verità è che all’interno della magistratura troppo spesso si va avanti sulla
base dell’appartenenza a questa o a quella corrente piuttosto che grazie al
merito».
Cosa non la convince
del disegno di legge del governo sulla punibilità dei giudici?
«La
responsabilità civile non è uno strumento idoneo per difendere i cittadini. In
primo luogo non lo è perché può portare il magistrato ad assumere una posizione
di soggezione davanti all’imputato, specie se questo è ricco e potente. E non lo
è perché moltiplicherebbe il lavoro nei tribunali e quindi, dilatando ancora di
più i mostruosi tempi della nostra giustizia, paradossalmente andrebbe contro
gli interessi degli imputati stessi. Lo ripeto, il vero problema è il Csm che
dovrebbe essere meno indulgente e ”perdonista” nei confronti di chi commette
gravi errori».
Sparare sul Consiglio
nazionale della magistratura ora che ha smesso i panni di pm,non è troppo
facile?
«Queste
cose le ho sempre dette. Qualcuno potrebbe anche dire che parli male del Csm per
come sono stato tratto io, per le parole contro le mie partecipazioni a
manifestazioni pubbliche. Allora non parliamo di me, ma di un altro magistrato:
Di Matteo. Perchè il Csm ostacola la sua nomina alla Procura nazionale antimafia
e favorisce invece personaggi obiettivamente con meno competenze in materia?»
Perché?
«La
risposta è semplice: ci si muove in base a logiche burocratiche e correntistiche
invece che di sostanza».
Faceva prima
riferimento alle sue contestate partecipazioni a manifestazioni politiche
quando era ancora magistrato. È una scelta che rivendica?
«Sì.
Mi è capitato di fare il pm nella stagione sbagliata. Trent’anni fa nessuno si
scandalizzava se Terranova partecipava ai convegni del Pci e negli anni
70 nessuno si sognava di mettere in discussione la professionalità di Borsellino
perché andava a parlare di giustizia nei consessi del Movimento sociale
italiano. Resto convinto che un magistrato vada giudicato per quello che fa
nell’orario di lavoro e che abbia tutto il diritto di esprimere le proprie
opinioni. Io però sono stato subissato da attacchi, sia da parte del mondo
politico sia dalla magistratura stessa…»
Nelle scorse settimane
si è molto discusso delle ferie dei giudici. Ha ragione Renzi a
volerle tagliare?
«Penso
si tratti di un falso problema. Effettivamente 45 giorni sono tanti ma io, ad
esempio, non ho mai goduto dell’intero periodo di ferie e come me la maggior
parte dei giudici. Sostenere che la lentezza della giustizia italiana dipenda
dalle toghe fannullone è solo un modo di trovare un capro espiatorio».
Quali sono invece le
ragioni di questa lentezza e come si può intervenire per accelerare i tempi dei
processi?
«Credo
sia arrivata l’ora di mettere in discussione l’esistenza del processo d’appello.
Con un grado secco di giudizio e un unico processo che decreti l’innocenza o la
colpevolezza di un imputato si risparmierebbero un sacco di soldi e di energie.
Ritengo poi necessario mettere fine alla corsa alla prescrizione,
limitando l’abuso di questo strumento».
A proposito di abusi,
cosa pensa dell’uso molto disinvolto della carcerazione preventiva che spesso
viene fatto dai giudici?
«In
un Paese in cui i tempi per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi,
è facile che si arrivi ad utilizzare la carcerazione preventiva come una
sorta di anticipazione di quella prevista in caso di condanna dopo i tre gradi
di giudizi».
Sì, ma è
incostituzionale: esiste la presunzione d’innocenza.
«Certo
nessuno vuole mettere in discussione la sacralità della presunzione d’innocenza
ma ribadisco, finché i tempi della giustizia saranno questi credo che la
carcerazione preventiva verrà ancora usata con questa frequenza».
Ora che esercita la
professione di avvocato, come è cambiata la sua prospettiva sul mondo
giudiziario?
«Cambiando
osservatorio, sono rimasto delle mie opinioni: viviamo in un Paese
profondamente ingiusto perché indulgente con i potenti e forte con i deboli».
Cosa significa per lei
la parola ” garantismo”?
«Garantismo
significa dare la garanzia a tutti i cittadini di un processo giusto e
assicurare il diritto di difesa. Chi vede il garantismo come un modo per
disarmare i pm però sbaglia. Essere garantisti significa anche fare in modo che
la legge sia davvero uguale per tutti e permettere di punire chi ha sbagliato».
Ha dichiarato di
essere pronto a tornare in politica e di guardare con attenzione a
Landini. Pensa si aprirà davvero un nuovo spazio politico a sinistra del Pd?
«Credo
che il nostro Paese abbia bisogno che emerga una nuova soggettività politica
progressista, popolare e di sinistra. Mi sento politicamente vicino a Landini e
Rodotà, e sono pronto a dare il mio contributo per la costruzione di una
coalizione sociale per l’equità, la lotta alla criminalità organizzata e ai
reati dei colletti bianchi».
Ok, basta coi
professionisti dell’Antimafia. Ma adesso chi combatterà le mafie?
E’ la domanda che si pone
Gaetano Savatteri su “Gli Stati Generali”. L’antimafia è morta. L’antimafia dei
movimenti, delle associazioni di categoria, dei bollini e dei certificati, ma
anche quella dei magistrati e della politica. L’antimafia, quella che abbiamo
visto e conosciuta fino ad oggi, è definitivamente sepolta. Perché le ultime
vicende – l’arresto di Roberto Helg per una mazzetta conclamata o l’indagine per
mafia sul presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante, per
dichiarazioni di pentiti ancora tutte da chiarire e che potrebbero nascondere
una manovra di delegittimazione – sanciscono in ogni caso e definitivamente la
fine di un modello che per molto tempo, e fino all’altro ieri, è stato visto con
favore e incoraggiato perché segno di una “rivoluzione” che metteva in prima
linea la cosiddetta società civile. Attilio Bolzoni su Repubblica, lo stesso
giornale che ha sparato per primo la notizia dell’indagine su Montante, ha posto
un interrogativo: “Forse è arrivato il momento di una riflessione su cos’è
l’Antimafia e dove sta andando”. Ma probabilmente la domanda più corretta è
un’altra: potrà esserci ancora un’antimafia? Peppino Di Lello, a lungo
magistrato del pool antimafia di Palermo, quello di Falcone e Borsellino, scrive
sul Manifesto che “i bollini, le autocertificazioni, gli elenchi incontrollati e
incontrollabili degli antimafiosi doc sono ormai ciarpame e bisogna voltare
pagina riappropriandosi di una qualche serietà nella scelta di esempi di
antimafia vera, scelta fondata sulla prassi, sui comportamenti che incidono
realmente in questa opera di contrasto”. Di Lello, giustamente, attacca la
retorica dell’antimafia, citando non a caso l’ormai storico articolo del 1987 di
Leonardo Sciascia sui “professionisti dell’antimafia”. Ma le ultime vicende e un
sottile veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del movimento
antimafia (don Luigi Ciotti ha fornito qualche anticipazione: “Mi pare di
cogliere, e poi non sono in grado di dire assolutamente altro, che fra pochi
giorni avremo altre belle sorprese, che sono in arrivo, che ci fanno soffrire.
Perché riguardano personaggi che hanno sempre riempito la bocca di legalità, di
antimafia”) percuotono chi, per entusiasmo o per mestiere o, usiamo pure questa
parola, per “professionismo”, si è iscritto negli ultimi anni nel fronte
antimafia. Serpeggia il disorientamento tra quanti si chiedono: e adesso,
infranti alcuni simboli dell’antimafia, non si rischia di veder naufragare il
lavoro fatto in tanti anni, compresi i buoni esempi concreti realizzati?
L’indagine della Commissione parlamentare antimafia sull’antimafia, per
individuare quando questa sia stata reale o di facciata – paradosso segnalato da
Giuseppe Sottile sul Foglio – pone una questione centrale. Se molti movimenti,
associazioni, progetti nelle scuole, iniziative si sono riempiti, nella migliore
delle ipotesi, di un tot di vuota retorica e, nella peggiore, di piccoli o
grandi interessi economici sotto forma di finanziamenti, privilegi, guadagni,
chi dovrà stabilire da ora in poi la genuinità della natura antimafia? La
struttura dello Stato italiano, per oltre centosessant’anni, ha costruito
soggetti e ruoli incaricati di definire e individuare le mafie, arrivando a
darne nel 1982 perfino una definizione normativa con l’articolo 416bis del
codice penale. Ma l’Italia non ha, e forse non poteva avere, strumenti per
individuare con esattezza la natura antimafiosa di soggetti, singoli o plurali,
se non in termini di opposizione: in parole semplici, era antimafioso chi
combatteva la mafia. Con opere o parole. Così, per lungo tempo, l’antimafia
sociale – cioè quella non costituita da magistrati e poliziotti incaricati, per
ragioni d’ufficio, dell’azione di contrasto e repressione – finiva per
autodefinirsi. E’ bastata, per un lunghissimo periodo, la petizione di principio
di dichiararsi antimafia per essere considerati tali. In un Paese che fino a una
quarantina d’anni fa ancora sosteneva, spesso anche nelle sedi giudiziarie, che
la mafia non esisteva, già il fatto stesso di dichiararne l’esistenza e di porsi
in posizione alternativa a essa, era sufficiente per attribuirsi o vedersi
attribuita la patente antimafia. Se oggi questo non basta più, quale sarà il
criterio futuro per definire la nuova antimafia? I fatti, i comportamenti e la
prassi, dice Di Lello. Tutto ciò è facilmente verificabile, ad esempio,
nell’attività delle associazioni antiracket che convincono i loro associati a
testimoniare nei processi, li sorreggono, si costituiscono accanto a loro parte
civile. Ma questo principio può valere per associazioni culturali, singoli di
buona volontà, gruppi di opinione, insegnanti la cui unica forza risiede solo
nella dichiarazione d’intenti? E’ ovvio che laddove le parole non coincidano
con i fatti (come nel caso della tangente che ha fatto finire in galera Helg),
la contraddizione è talmente stridente che non ci sono dubbi. Ma anche in questo
caso, è una dimostrazione al contrario: il fatto (cioè la mazzetta) mostra la
non appartenenza di qualcuno al fronte autenticamente antimafioso. Ma quale può
essere il fatto che, giorno dopo giorno, possa dimostrarne invece
l’appartenenza? Per Confindustria Sicilia, ad esempio, sembrava già
rivoluzionario e significativo che un’associazione di categoria che per molto
tempo aveva ignorato la mafia o ci aveva convissuto, con molti casi di
imprenditori contigui o aderenti a Cosa Nostra, avviasse una inversione di rotta
pubblica, con l’annuncio di espulsioni dei propri soci che non avessero
denunciato le estorsioni. Era certamente un fatto capace di attribuire identità
antimafiosa a quell’associazione. Naturalmente, il movimento antimafia nel suo
complesso si è nutrito di errori e di eccessi. E questi nascono probabilmente
dall’evidenza che ogni movimento antimafioso, per sua natura, tende ad occupare
tutti gli spazi morali a sua disposizione. La discriminante etica, ragione
fondante, tende ad allargarsi e spostarsi sempre più avanti in nome della
purezza antimafia, escludendo altri soggetti e movimenti. Qualsiasi movimento
antimafia, poiché si costituisce e si struttura in alternativa e in opposizione
a qualcosa, in primo luogo la mafia e i comportamenti che possono favorirla o
sostenerla, non può tentare di includere tutto, ma deve per forza di cose
escludere. Ecco perché dentro il mondo dell’antimafia non c’è pace, e ciascun
gruppo di riferimento tende a vedere negli altri gruppi degli avversari, se non
dei nemici insidiosi o subdoli. L’antimafia spontaneistica e aggregativa dal
basso si contrappone a quella ufficiale in giacca e cravatta e viceversa, quella
sociale si contrappone a quella di Stato e viceversa. La vocazione alla
supremazia della leadership del mondo antimafioso, diventa allarmante quando
l’antimafia non è più esclusivo appannaggio di gruppi sociali d’opposizione (i
preti di frontiera contro la Chiesa ufficiale timorosa, le minoranze politiche
contro le maggioranze o i governi prudenti o contigui, gli studenti contro la
burocrazia scolastica troppo paludata, tanto per fare alcuni esempi), ma
comincia a diventare bandiera dei gruppi dominanti. Al potere economico o
politico, finisce così per sommarsi il potere di esclusione di potenziali
concorrenti, che può essere esercitato anche facendo baluginare legami oscuri o
poco trasparenti. L’antimafia può servire al politico di governo per demonizzare
gli avversari. Siamo di fronte a quel meccanismo che viene indicato come “la
mafia dell’antimafia”, definizione che non amo perché rischia di far dimenticare
che nel recente passato in Sicilia, e non solo, politici, imprenditori e
funzionari contigui o affiliati alla mafia facevano eliminare i loro avversari
direttamente a colpi di kalashnikov. In questi giorni, in queste ore, il mondo
dell’antimafia, soprattutto quello siciliano, il più antico e radicato, il più
organizzato e selezionato negli anni delle stragi e delle mattanze mafiose, si
trova davanti a molte domande. Chi dovrà stabilire, nel futuro prossimo, la
genuinità dei comportamenti antimafia? I giornali? La tv? Il governo? Il
Parlamento? Non esistono organismi o autorità morali in grado di fornire
garanzie valide per tutti. La domanda principale finisce per riguardare
l’esistenza stessa di un’antimafia diffusa. Se l’antimafia, per come è stata
fino ad oggi, è morta, potrà esserci ancora qualcosa o qualcuno in grado di
dichiararsi antimafia? Ma, soprattutto, chi potrà crederci ancora?
Imprenditori e giornalisti
cantori dell’antimafia, non ci mancherete per niente.
Abbiamo letto su queste colonne l’annuncio della morte dell’antimafia. Un
annuncio articolato. Esteso, ragionato, scrive Salvatore Falzone su “Gli Stati
Generali”. Forse però vale la pena allungare il necrologio, non foss’altro che
per rispetto del de cuius e delle sue gesta. Il decesso, diciamocelo, è
stato causato da colpi di toga. Ancora una volta, purtroppo. Perché se non
spuntano i primi fascicoli con l’intestazione “Procura della Repubblica”, nel
Belpaese tutto è lecito e tutto va bene. Prima di leggere paroline come
“arresto”, “tangente”, “indagine”, “pentiti”, nessuno s’interroga, nessuno ha
dubbi. Succede così che da qualche anno a questa parte un’antimafia che non è
antimafia ha messo le mani sulla città, per dirla con Rosi, per fare affari e
costruire carriere. Nel nome della legalità, s’intende, e con l’avallo di una
torma di pensatori, magistrati, prefetti, questori e alti ufficiali che non
hanno fatto altro che alimentare una colossale bugia (Giovanbattista Tona,
consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta: “Come il mafioso di paese
otteneva rispetto perché passeggiava col sindaco, col parroco, col maresciallo e
col barbiere, l’antimafioso 2.0 può esercitare potere su tutto sol perché in
confidenza con ministri, magistrati e autorità”. Giuseppe Pignatone, capo della
Procura di Roma: “Bisogna fare l’esame di coscienza: non è che tra magistrati e
forze dell’ordine ci sono soltanto santi, eroi e martiri. Ci sono, come in tutte
le categorie, persone per bene e persone meno perbene”). C’era bisogno di
scoprire Helg con la mazzetta in mano? Dovevamo leggere Bolzoni su Repubblica –
che ha dato notizia di un’inchiesta per mafia a carico del presidente di
Confindustria Sicilia Antonello Montante – per accorgerci che dalle parti di
Caltanissetta l’antimafia ha i pennacchi impastati di gel? E’ mai possibile che
quel “cretino” del professor Laurana continua a morire in una zolfara
abbandonata, “sotto grave mora di rosticci”, senza sapere ciò che tutti sanno?
Già, perché tutti sanno, e tutti sapevano. Ecco perché la meraviglia e il
disorientamento del giorno dopo sono espressioni vuote, bianche come quelle di
certe statue. La Sicilia è un salone da barba. E anche Roma lo è. E pure Milano.
Mentre in questi anni si firmavano protocolli ai tavoli delle prefetture, mentre
si stilavano codici etici, mentre procuratori generali inauguravano l’anno
giudiziario magnificando le imprese dei nuovi paladini dell’antimafia, dal
barbiere si sussurrava e si rideva. Si rideva (con gli occhi) e si facevano
smorfie (con la bocca). Ora ci si chiede se, dopo le scosse telluriche delle
ultime settimane, possa esserci ancora un’antimafia. E perché no? Un’antimafia
ci sarà. Ma non questa. Non questa che ha mandato in solluchero, da nord a sud,
cronisti e narratori, i “cuntastorie – come ha scritto Sergio Scandura su Gli
Stati Generali – dello storytelling epopea che danno voce ai Pupi: ora con
la prodezza, la tenacia e l’enfasi di battaglia, ora con l’incanto-disincanto e
la passione della bella Angelica di carolingia memoria”. Sì, ci sarà un’altra
antimafia. Anzi, c’è già. C’è sempre stata da quando esiste la mafia.
Silenziosa, non remunerativa. E’ l’antimafia del proprio dovere quotidiano, che
non fa regali, che non compra e che non paga. Un siciliano illuminato, Cataldo
Naro, l’arcivescovo di Monreale scomparso nel 2006, parlava di legalità e
santità nelle parrocchie tra Partinico e Corleone. A proposito di Chiesa e
mafia, diceva che il cristiano non può non vivere secondo il Vangelo, e che il
Vangelo è di per sé incompatibile con la mafia: il discorso vale per tutti,
spiegava il presule, per il carabiniere, per il politico, per il professore, per
il bidello, per il magistrato, per la guardia municipale… Ma lasciamo stare i
santi e torniamo ai diavoli. Adesso che succede, adesso che l’antimafia in
ghingheri traballa e che non ci sono ammortizzatori che tengono? Il tema non è
“il veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del movimento
antimafia”, né l’esistenza o meno di una “manovra di delegittimazione” ai danni
del leader degli industriali siciliani. E neppure i progetti delle scuole, le
navi della legalità che attraccano a Palermo in un’esplosione di cappellini o
altre simpatiche pagliacciate. Il tema è molto più – come dire? – terra terra:
ed è quello del proverbio “predicare bene e razzolare male”. Il tema è la
trasparenza delle azioni di chi afferma di combattere il malaffare. E’ la
concretezza – oltre che la qualità – dell’impegno sul fronte della legalità
(parola che Michele Costa, il figlio del procuratore di Palermo ucciso nel 1980,
propone giustamente di abolire). Da questo punto di vista non c’è bisogno di
attendere misure cautelari o sentenze definitive per mettere in discussione
l’operato non dei “professionisti” (lasciamolo in pace il maestro di Racalmuto)
ma degli “imprenditori dell’antimafia”: etichetta, quest’ultima, che ben si
attacca alle giacchette dei nostri eroi. Perché debbono scriverla i giudici la
storia di questa ennesima truffa? La scrivano gli artisti, se ce ne sono ancora.
O gli intellettuali, ma non quelli “col senno del poi”. La raccontino le
inchieste dei giornalisti e degli scrittori che non prendono soldi, i registi di
cinema e di teatro… Materiale ce n’è in abbondanza. Certo per raccoglierlo
bisogna superare lo Stretto, penetrare nell’entroterra incontaminato, fra
colline che d’inverno sono così verdi che sembra di stare in Irlanda, e fare un
salto nella “Piccola Atene”, la Caltanissetta dove la leggenda vuole che a metà
degli anni duemila sia nata la rivoluzione degli imprenditori (che qualcuno, con
parole misurate, ha definito copernicana). Ma va detto che nella Caltanissetta
delle mitologie c’è stato pure chi in questi anni ha lavorato sul serio
resistendo alle bordate sia dalla mafia che dall’antimafia. Il pm Stefano
Luciani, in una requisitoria a conclusione di un processo in cui la Procura
riteneva di avere scoperto estorsioni non denunciate dagli imprenditori e
accordi tra imprenditori e mafiosi proprio in terra nissena, aveva evidenziato
che ancora si aspettava l’effetto dell’impegno di Confindustria sul
comportamento della categoria. Era il 23 gennaio 2012. Bè, dopo pochi giorni il
giornalista Filippo Astone scriveva un pezzo intitolato “Le incredibili
dichiarazioni del pm nisseno Stefano Luciani”: l’accusa era che il magistrato,
non riconoscendo i meriti degli imprenditori antimafia, non si rendeva conto di
aiutare oggettivamente la mafia. Dunque l’antimafia è morta? Macché. Se
l’antimafia è quella di Helg e di Montante possiamo stracciare il necrologio e
stappare champagne. Perché non è morta l’antimafia. Ma un sistema di potere che
ha occupato tutti gli spazi (non morali), che controlla ogni angolo del
territorio, che dai tempi di Raffaele Lombardo gestisce nell’Isola il potente
assessorato alle Attività Produttive, che tiene in pugno giornali e giornalisti:
l’ordine di Sicilia ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti elargiti dalla
Camera di Commercio di Caltanissetta, di cui Montante è presidente, a testate e
pubblicisti. “Potrà dunque esserci un’antimafia?” Sì. “Chi dovrà stabilire nel
futuro prossimo la genuinità dei comportamenti antimafia?”. Non certo questi
signori. Gaetano Savatteri, sempre su Gli Stati Generali, si è chiesto
chi potrà credere ancora all’antimafia… Ma la domanda va forse ribaltata: chi ci
ha mai creduto a questa antimafia? E se qualcuno ci ha creduto, perché?
Detto questo sembra evidente
che si abbisogna di una legge di tutela per i cittadini contro i magistrati che
delinquono indisturbati.
ALTRO CHE RIVOLUZIONE: E'
L'ITALIA DEI FESTIVAL!
Le cose vanno di male in
peggio, ma per gli italiani non vale l’evoluzione della specie. Si scannano per
la politica ed il calcio. Il loro pensiero è per il diveretimento. Nulla fanno
per garantire un futuro migliore per i loro figli.
A QUANDO LA RIVOLUZIONE IN
ITALIA? Si
chiede Sergio Di Cori Modigliani su “Informare per resistere”. Quand’è che si
verifica una rivoluzione? E come si fa, a innescarla, una rivoluzione? La parola
“rivoluzione” non viene dalla politica, bensì dall’astronomia. E’ stata
giustamente presa in prestito perchè identifica con esattezza uno specifico
processo politico. Indica il movimento dei corpi celesti che ruotano su se
stessi e fanno un giro intorno alla stella cui fanno riferimento. Quando
ritornano nella posizione originaria, sono diversi, anche se magari non sembra,
proprio perchè si è verificata la rivoluzione. La si usava anche per indicare i
giri che i dischi al vinile compivano sul piatto d’acciaio: 78 rivoluzioni al
minuto, oppure 33, più tardi anche 45. La caratteristica della rivoluzione, che
la rende un concetto così affascinante, consiste nel fatto che vince sempre.
Tanto è vero che si sa con matematica e millimetrica certezza che “si è
verificata una rivoluzione” soltanto dopo, mai prima. Nessuno, a meno che non
sia un pazzo o un mitomane, può pensare di sè (o dirlo o scriverlo) di essere un
rivoluzionario durante il percorso, o prima. Se vince, allora è diventato un
rivoluzionario. Se non vince, è rimasto un rivoltoso. Le rivolte sono tutte
rivoluzioni mancate. Non è mai esistito, nella Storia dell’umanità, il ricordo
di una rivoluzione che non abbia vinto, altrimenti non sarebbe tale. Il
rivoluzionario, quindi, è un vincente. Sempre. Ma lo sa dopo, a giochi fatti.
Finchè dura la partita corre sempre il rischio di essere un semplice rivoltoso,
il che è tragico. Per comprendere e definire questo concetto, basterebbe pensare
alla frase di George Bush sr., allora direttore della CIA, nel 1978, quando,
dopo una riunione con i vertici della sua agenzia con i quali stava affrontando
la crisi iraniana da loro sottovalutata, disse imprecando: “Cazzo! Questa non è
una rivolta, ma è una rivoluzione. Imbecilli che non siete altro!”. Lo aveva
capito. E aveva ragione. Gli iraniani non lo sapevano ancora, negli ultimi 30
anni avevano vissuto ben sei rivolte, nessuna delle quali era riuscita a
diventare una rivoluzione. Se ne sono accorti cinque minuti dopo, come avviene
sempre nelle rivoluzioni. La rivoluzione politica, quindi, si realizza quando si
verifica un cambiamento epocale che modifica l’asse strutturale di una società,
riportando l’equilibrio solo e soltanto dopo che si sono verificate delle
trasformazioni impensabili fino a poco prima. Tutto ciò per introdurre il tema
del post: tutte queste chiacchiere sulle cosiddette o - ancora peggio -
presupposte riforme, le trovo (oltre che noiose da morire) ridicole e
fuorvianti. La situazione dell’Italia è talmente disastrosa che nessuna riforma,
ormai, in nessun campo, sarebbe in grado di poter risolvere alcun problema
strutturale. Per cambiare il paese in meglio, è necessaria una rivoluzione. Ne
esistono di due tipi: una violenta e sanguinosa, che abbatte il sistema politico
vigente e lo sostituisce con uno diverso, come sono state quelle castrista,
cinese, sovietica, francese, inglese, americana. Non mi piace, non la auspico,
non la voglio. L’altra, invece, è di tipo pacifico e armonioso, quella mi piace
e la voglio. Ma non voglio una rivolta, bensì la rivoluzione. Quella che si
manifesta senza colpo ferire, senza neppure una vittima, un incendio, un
incidente, che opera nella realtà e la cambia, perchè va a incidere nella
struttura reale della società. Galileo Galilei è stato, ad esempio, un grande
rivoluzionario; anche il Dottor Fleming (colui che ha scoperto la penicillina)
lo è stato; anche Dante Alighieri, Dostoevskij, Le Corbusier, Enrico Fermi,
Alessandro Volta, i fratelli Meliès, ecc. Il mondo è pieno, grazie a Dio, di
rivoluzionari. La rivoluzione pacifica, in ambito politico, comporta -altrimenti
rimaniamo nel campo della mitomania o della rivolta e quindi ci si condanna alla
sconfitta e alla perdizione- una modificazione comportamentale di 360 gradi, per
ritornare alla posizione di equilibrio ma su basi diverse. Per dirla in parole
povere: rivoltati come calzini. La differenza tra il rivoltoso e il
rivoluzionario consiste nel fatto che il rivoltoso è mosso dalla rabbia, dal
livore, dalla disperazione e ha un’idea molto chiara in testa: la realtà che sta
vivendo lo ripugna, lui è indignato, non ne può più, vuole abbattere tutto,
senza avere la minima idea di dove andrà a parare; il rivoluzionario, invece,
pensa al dopo, ovvero alla progettualità, alla strategia, al cambiamento
operativo pragmatico che vuole attuare secondo modalità che il sistema appena
abbattuto non consentiva. Detto questo, mi sembra che non vi sia ombra di dubbio
sul fatto che l’Italia è (forse in tutto l’occidente) il paese più lontano in
assoluto da qualunque forma di rivoluzione necessaria. Ne parlano, si usa il
termine, ma il fine consiste nell’usurare la parola, svilirla, disossarla, e far
credere alla gente che. Gli italiani, per motivi ancora non del tutto chiari
fino in fondo, hanno deciso di bersela. Lo hanno fatto con Berlusconi, con
Prodi, con Monti, con Letta, con Renzi. Lo avevano fatto anche con Berlinguer.
Tutte queste persone elencate, sono state citate, vissute, e identificate come
rivoluzionari. Il che è falso. Sono tutti dei falliti, in quanto rivoluzionari,
ma hanno avuto un enorme successo (ciascuno secondo le proprie modalità) come
dei rivoltosi sui generis. I conti con le rivoluzioni si fanno dopo: non
esistono rivoluzioni abortite, rivoluzioni a metà, rivoluzioni così così, mezze
mezze. O la rivoluzione c’è o non c’è. A questo punto è immancabile l’intervento
di qualcuno che dice: “eh! Si sa, il mondo va così, le rivoluzioni non esistono
più ormai”. Non è vero. Esistono eccome, e seguitano a esistere. Il fatto che
non le si conoscano non vuol dire che non ci siano. Le rivoluzioni si possono
anche esportare, mai imporre. Si esporta il modello che serve come stimolo, il
cui fine consiste nell’alimentare l’ispirazione che poi produce cambiamenti
autoctoni. I Beatles, ad esempio, sono stati dei rivoluzionari, non vi è alcun
dubbio. In America (per gli americani) lo è stata a suo tempo anche Madonna
perchè il modello identificativo proposto ha comportato un radicale mutamento
nella comportamentalità degli statunitensi, soprattutto il genere femminile. Gli
americani, in questo momento, stanno vivendo una fase molto interessante del
loro percorso e da oltreoceano arrivano di continuo segnali confortanti (per
loro) che indicano un cambiamento di rotta epocale, per alcuni tratti
rivoluzionario. Qui, non se ne parla neppure. Basterebbe porsi una domanda
secca: “Come mai noi italiani dagli Usa abbiamo sempre importato soltanto il
peggio? Come mai noi ci ingozziamo come tacchini di tutte le schifezze
colonialiste che l’America produce e ci impone con la violenza e il ricatto ma
non siamo capaci e in grado di importare anche il loro vento rivoluzionario
quando esso si manifesta? Perchè ci becchiamo soltanto gli osceni F35 ma non gli
scatti evolutivi e risolutivi?”. In California stanno avvenendo diversi episodi
di grande rilevanza dal punto di vista sociale, iniziati alla fine dell’autunno
del 2012. La California è da sempre un gigantesco laboratorio sperimentale. In
Usa si dice: “Quando arriva una novità dalla California, esultano il diavolo e
il buon Dio: sanno che uno dei due vincerà di sicuro”. Perchè il peggio e il
meglio della civiltà occidentale, negli ultimi 50 anni, è venuto da lì. Noi,
qui, importiamo soltanto la parte diabolica, quella mercatista, consumista, la
peggiore. Raccontai l’episodio cardine quando si verificò, il 5 novembre del
2012, ma non ebbe alcuna risonanza. L’Italia è molto lontana da quella modalità
d’approccio. Ecco il fatto: la California è uno stato molto ricco, contribuisce
per il 22% al pil nazionale. Se fosse una nazione, sarebbe la quinta potenza al
mondo. Il loro pil è pari a quello dell’Italia, Spagna, Portogallo e Grecia
messi insieme, intorno ai 3.500 miliardi di dollari l’anno. Nel 2012, in seguito
alla crisi, il bilancio statale ha sofferto di una crisi di liquidità che ha
spinto il governatore ad attuare tagli lineari nell’istruzione pubblica, nella
ricerca scientifica e negli incentivi per giovani laureati provenienti da
famiglie disagiate. Si è scatenato un grande dibattito tra le forze politiche e
intellettuali californiane che ha dato vita a un referendum votato il 4 novembre
del 2012. Il testo diceva: “Siete favorevoli o contrari all’aumento fiscale di
un’aliquota una tantum, nell’ordine del 12%, per tutti i residenti i cui
introiti superino 1 milione di dollari all’anno, con la specifica che la somma
ottenuta verrà investita al 100% per impedire la privatizzazione
dell’istruzione, impedire la chiusura di 450 centri universitari consentendo di
elargire 25.000 borse di studio a giovani laureandi meritevoli e d’eccellenza?”.
I primi sondaggi (effettuati alla fine di settembre) davano il 70% a coloro che
erano contrari alla tassazione. Nessuno va a votare chiedendo un aumento delle
tasse, era dato per scontato. L’astensione era data intorno al 65%. Ma a ottobre
avvengono episodi inauditi. Le più ricche e famose famiglie di Los Angeles,
Santa Monica, Malibu, a proprie spese, cominciano a fare campagna elettorale a
favore della tassazione, soprattutto attrici e attori di Hollywood, da George
Clooney a Jane Fonda, da Sigourney Weaver a Matt Damon, da Steven Spielberg a
Nicholas Cage, i quali spiegavano in televisione che per loro era inaccettabile
l’idea di vivere da super ricchi circondati da un insostenibile disagio
esistenziale. Negli altri stati, soprattutto a New York e in Florida, li
prendevano in giro con accanimento sostenendo che in California si era diffusa
una nuova droga che dava allucinazioni. Il referendum ha visto l’abbattimento
dell’astensionismo e la vittoria della mozione pro-tasse con il 59% dei voti.
Una settimana dopo, il governatore annunciava di aver radunato 24 miliardi di
dollari grazie all’esito referendario, sufficienti a salvaguardare l’intero
sistema di gestione dell’istruzione pubblica sia umanistica che scientifica fino
al 2017. Nessun media ha neppure parlato dell’argomento, considerata una
stranezza californiana. Ma due mesi dopo, i più attenti, si sono resi conto che
era stato piantato il germe di una rivoluzione pacifica. E come in ogni
rivoluzione che si rispetti, lo si sa sempre dopo. Quell’evento ha determinato
un cambiamento radicale di ottica e di prospettiva che ha incentivato gli
investimenti restituendo ottimismo pragmatico perchè il dibattito è passato
dalla discussione su “come abbattere il debito pubblico dello Stato” a quello,
invece reale “come affrontare il problema della re-distribuzione della
ricchezza”. Questa è la rivoluzione. Perchè questo è l’unico vero problema. Non
80 euro regalati a un mese dalle elezioni, che valgono quanto la carità vaticana
nel 1500. Sarebbe possibile cominciare a parlare in Italia di eventi simili,
copiabili? Non credo. Papa Francesco ha suggerito di “mettere in campo la
creatività per affrontare i gravi problemi del disagio sociale”. La creatività è
questa, inventata nel luogo che ha inventato il tablet, yahoo, amazon. Serve un
nuovo parametro sociale, un nuovo approccio sociologico, una diversa
comportamentalità esistenziale. Servirebbe un sindacato che annuncia con geniale
creatività rivoluzionaria di aver scelto di restituire collettivamente allo
Stato gli 80 euro con la dizione “non vogliamo la carità, vogliamo una strategia
strutturale” e quindi aprire un dibattito tra tutte le forze politiche per
andare a riempire il tragico e gigantesco vuoto prodotto dal genocidio culturale
perpetrato negli ultimi 25 anni. Il sindacato, in Italia, non lo farebbe mai,
non è certo un caso che siano proprietari di uno spropositato numero di immobili
sui quali non pagano tasse. Basta questo, per rendersi conto della confusione
che regna in questo paese. Ci vogliono idee operative, immediate, efficaci ed
efficienti. Un grado e un grammo di meno portano indietro il paese. Buon Senso e
Buona Volontà - valori della tradizione moderata italiana - paradossalmente sono
diventati in questo paese il vero nutrimento della rivoluzione di cui abbiamo
bisogno. O cambia il comportamento esistenziale dal punto di vista psicologico
di tutti, a cominciare dalla classe dirigente, imprenditoriale, sindacale,
oppure seguiteremo a passare da una illusione a un’altra, da una mossa
truffaldina a un’altra mossa truffaldina. E se alle prossime elezioni europee
vinceranno ancora Berlusconi, Renzi e i soliti noti, allora vorrà dire che gli
italiani, in realtà, non esistono più. E’ nata una nuova etnia, ignorante e poco
intelligente, cosa che gli italiani non erano. Come sosteneva Charles Darwin,
“la specie che si evolve, quella più intelligente, non è la più forte o la più
sana, ma quella che più di ogni altra è in grado di sapersi adattare ai
cambiamenti”. Quindi, ci si adatta al cambiamento e si evolve. Tutti insieme.
Oppure ci si adatta alle chiacchiere degli imbonitori di turno, Berlusconi o
Renzi, l’uno vale l’altro. Si salveranno in pochi, pochissimi. A mio avviso, non
si tratta di soldi, di qualche euro in più o in meno. Si tratta della
sopravvivenza di una intera civiltà. Ma non potete aspettarvi che ve lo vengano
a spiegare quelli che la stanno distruggendo, perchè dal dissolvimento della
Bella Italia ne traggono un loro squallido vantaggio finanziario. Tutto qui.
California dreaming! Festeggiare il 25 aprile come data della liberazione
dall’invasione nemica e come la fine della guerra, a me sembra un ossimoro
pornografico che mi indigna e mi scandalizza. Nella guerra ci siamo dentro fino
al collo: è lo scontro tra chi vuole imporre una idea monarchica della vita,
pretendendo dai propri sudditi deferenza e riverenza, e i cittadini ai quali
dare la guazza di qualche briciola, purchè se ne stiano buoni e zitti: obiettivo
finale della guerra è quello di non modificare in alcun modo l’assetto
strutturale del sistema vigente. La guerra c’è, solo che non si vede. A questo
serve la truppa asservita della cupola mediatica: a nascondere la realtà.
Intanto, sul pianeta Terra, c’è già chi ha capito come fare e cosa fare per
evolversi verso nuove forme di sopravvivenza collettiva, esistenzialmente
sostenibili, spiritualmente forti, culturalmente corpose. Perchè non cominciamo
anche noi a pretendere di andare verso il futuro? Se non cambiamo noi, dentro,
come possiamo pretendere che cambi la nostra realtà? Buon week end a tutti.
Altro che rivoluzione. Gli italiani pensano solo a divertirsi. O comunque così
sono indotti a farlo.
"Panem et circenses" è la
metafora con cui si descrive un metodo di governo,
scrive Paolo Casalini su “Informa Arezzo”. La frase è usata per descrivere la
creazione di approvazione pubblica ormai conosciuta col nome di "consenso", non
attraverso esemplare o eccellente servizio pubblico e amministrazione dello
stato, ma attraverso la diversione, la distrazione, o la semplice soddisfazione
delle esigenze immediate, di una popolazione che ha esigenze "palliative" . E’
stata coniata da Giovenale, che la usa per denigrare in modo indiretto il
governo di Roma, preoccupato solo di creare strumenti di controllo,
semplicistici ma efficaci, nei confronti della gente comune. La frase implica
anche l'erosione o l'ignoranza del dovere civico, tra le mancate preoccupazioni
del popolo di Roma. Nell'uso moderno, la frase è presa per descrivere un popolo
che valorizza aspetti superficiali della vita pubblica, non quanto le virtù
civiche. Secondo Giovenale, in tutto lo spettro politico dell’epoca
repubblicana, si connota una supposta banalità e frivolezza che caratterizza il
periodo prima del suo declino e che la spingerà inevitabilmente nel successivo
Impero Romano. Probabilmente Giovenale si riferisce ad un epoca passata per non
incorrere nelle ire di quella presente, ma la critica resta valida in ogni
tempo, poiché sempre le stesse sono le dinamiche di gestione delle masse. Con
intenzione simile, si è usata l'espressione "Feste, farina e forca" per definire
la vita nella Napoli del periodo borbonico, in cui all'uso di feste pubbliche e
di distribuzioni di pane, si accompagnava la pratica di numerose impiccagioni
pubbliche, come dimostrazione circense della capacità del potere politico di
assicurare il mantenimento della legalità. E’ questa l’evoluzione moderna del
concetto di "circenses", laddove anche l’amministrazione della giustizia diventa
forma di intrattenimento, argomento di conversazione, e quindi strumento di
distrazione di massa. Una forma di distrazione che si accompagna al bisogno di
trovare sempre un capro espiatorio che si presti a farsi carico delle disgrazie
comuni, e su cui il popolo possa facilmente scaricare, come su un parafulmine,
le energie rivoluzionarie o di semplice rivolta…Spiega molto bene Giovenale:
dare il cibo a buon mercato e offrire forme di intrattenimento, "panem et
circenses", è stato il modo più efficace per salire al potere (e per
conservarlo) [...] iam pridem, ex quo suffragia Nulli / uendimus, effudit curas;
nam Sie Dabat Olim / imperium, fascio littorio, legiones, omnia, nunc se /
continet atque duas tantum res anxius optat, / Panem et circenses . [...]
(Giovenale, Satire 10,77-81)Dopo duemila anni, il senso è sempre lo stesso:
mentre il popolo è impegnato a fare il tifo per i gladiatori di turno, c’è chi
scorrazza allegramente tra le sedie del potere. Accade così, anche ai giorni
nostri, che in nome di una presunta ristrutturazione e mentre il popolo è troppo
assorbito dai circenses estivi, stanno smantellando sotto i nostri occhi il
nostro territorio, spostando uno alla volta i nostri uffici, le nostre società
comunali, la nostra sanità, l’acqua che beviamo, i cibi che mangiamo, il
coordinamento della gestione dei rifiuti, i trasporti pubblici,
l’amministrazione dell’energia e creando altrove una cittadella del potere e del
denaro (Montepasconia) che ci amministrerà per i decenni a venire: ci stanno
infilzando una “supposta” alla volta, ben cosparsa di vasellina, ma ciò che è
peggio, è che mentre vengono a raccontarci tutto questo (evviva la democrazia),
i guardiani della comunicazione sono tutti o quasi, impegnati ad ascoltare
osannanti le schitarrate o i racconti di una Italia lontana. In nome del
risparmio stanno smantellando le strutture provinciali, per conferire la
gestione del territorio alle Aree Vaste, sotto stretto controllo partitocratico.
Ci stanno spogliando di ogni bene comune, smantellando il nostro territorio e
lentamente, ma inesorabilmente, ci stiamo trasformando in sudditi... ma l’unica
cosa che ci interessa sono i circenses: da mesi riusciamo solo a parlare di
Icastica, Giostra del Saracino, sagre paesane e concertini vari, più o meno
importanti. La forza di un territorio non sono solo i suoi politici, ma anche,
anzi soprattutto i suoi cittadini. E la forza dei politici, dipende dal grado di
coesione e dalla forza che ricevono dal consenso popolare. Inutile lamentarsi
dello scarso peso politico di chi ci governa, quando siamo proprio noi,
disinteressandoci della cosa pubblica, a togliere peso e forza all’azione
politica. Un popolo interessato solo a trovare il modo come passare il tempo,
avrà una classe politica che farà il possibile per accontentarlo, giustificando
il suo impegno in nome del turismo, di una fantomatica offerta culturale, della
promozione del territorio, di una offerta economica che non arriva e non
arriverà certo in nome di una festicciola. Mentre si smantellano le università,
mentre si alleva un popolo di capre nell'illusione che la cultura sia ovunque,
facile, a buon mercato e senza sacrificio alcuno, in nome di un turismo che non
si interessa affatto al nostro agitarsi nella melma fangosa in cui stiamo
affondando, stiamo lasciandoci addormentare cullati da un concertino, pogando
felici delle nostre illusioni e del nostro nulla. Per il nostro bene
naturalmente!
Italiani, un popolo di
festaioli, scrive Mario Rossini a Beppe Severgnini.
Gentile Beppe, vorrei approfittare della tua conoscenza del mondo per chiederti
una conferma, o una smentita, sul fatto che noi italiani siamo piuttosto
festaioli, altro che tristi e depressi. Facciamo questo conto. Il periodo delle
festività natalizie è il più lungo dell'anno, ma non è il solo. Natale,
Capodanno, ponte dell'Epifania consentono a molti di godersi dei giorni
spensierati, per non parlare degli studenti che non studiano. Appena ripresi
dalla botta di vita arriva San Valentino, festa minore promossa di ruolo, poi il
buon vecchio Carnevale, che da qualche parte è ancora una bella e sentita
tradizione. Seguono la Festa della Donna e la festa del Papà, da non
sottovalutare. Poi Pasqua, da associare con un bel ponte e con le ultime
settimane bianche, iniziate a metà gennaio, o con le prime uscite tipo capitali
estere. Il 25 Aprile ed il 1° Maggio completano le feste primaverili, da bollino
rosso del traffico. La festa della Mamma c'è ancora, in questo mese gli studenti
stanno viaggiando in lungo ed in largo con le gite scolastiche, che tutto sono
meno che culturali. Arrivano la festa della Repubblica, l'agognata fine delle
lezioni ed il rompete le righe, tutti al mare o in montagna. L'estate italiana è
calda ed allegra, colma di occasioni di divertimento. A fine agosto si rientra
con il magone ma non per molto. Hanno inventato Halloween, ne avevamo proprio
bisogno, associato al ponte di inizio novembre permette di ri-abituarsi
gradatamente allo stress da divertimento. L'8 dicembre, ponte dell'Immacolata,
dà il via alla stagione della neve, si respira l'aria natalizia che porta con sè
cene aziendali, regali, caccia all'occasione di viaggio (secondo le ferie
stabilite) per l'imminente periodo di festività. Il cerchio si chiude e
ricomincia un altro giro di giostra. Se poi questi giorni cadono a metà
settimana hai voglia, la festa aumenta. Con dei periodi così spezzettati ne
risente il lavoro, non certo il divertimento. Forse ho dimenticato quà e là
qualche tradizione locale, ma più o meno credo di aver messo tutto.
L'Italia è il Paese dei
Festival,
scrive “La Stampa”. Abbiamo più eventi di qualunque Stato d'Europa. Immaginate
che bello un viaggio attraverso l’Italia in cui ogni città sia una festa, piena
d’incontri culturali, spettacoli gratuiti, gente interessante per le strade e
offerte convenienti. Nel Paese dei festival un percorso del genere è possibile,
anche se un tantino lungo, caotico ed arzigogolato. Tanto che per farcela entro
l’anno bisognerebbe saltare qualche tappa. Perché i festival sono ormai
innumerevoli e si accavallano. Anche senza contare quelli di musica e di cinema,
le fiere, i saloni, le rassegne e le lezioni di storia a Roma o Milano, il
viaggio è complicatissimo. Si potrebbe cominciare dal Festival della Formazione,
fino al 30 a Mirano. Fabio Chiusi, 30 anni, laureato alla London School of
Economics, ne cura la parte social network: «Facciamo live blogging, siamo su
Twitter e su YouTube e cerchiamo di far vivere l’evento anche in Rete».
All’inizio di luglio farà lo stesso al Festival Caffeina di Viterbo, curato da
Filippo Rossi di FareFuturo, ed è appena tornato dal Festival del Giornalismo di
Perugia. «C’è un popolo che si muove tra i festival – racconta - per ovviare
alla banalità della tv, da un lato, e dall’altro alla noia dell’accademia». Poi
scappa via perché c’è da prendere l’aperitivo spritz di gruppo che a Mirano
scandisce l’ora del prima di cena, mentre al mattino c’è il caffè e il
pomeriggio il tè con gli ospiti della manifestazione. Se invece vi piace il
gelato, a Firenze fino al 31 c’è il festival dedicato, in contemporanea col
Maggio musicale. Quello dell’Economia di Trento è invece fissato dal 3 al 6
giugno. Direttore scientifico il professor Tito Boeri, coinvolto anche in
Economia e Società Aperta, un evento della Bocconi per la città di Milano.
Ancora a Firenze, dal 9 al 12 giugno, c’è il Festival del viaggio, da non
confondere con quello della letteratura di viaggio dal 24 al 27 settembre a
Roma. A luglio i festival si diradano, la gente va in vacanza. Ma
l’eccezionalità italiana, il campanilismo reso evento, si conferma lo stesso per
tutta l’estate alla Versiliana di Forte dei Marmi e certo a Cortinincontra.
Sempre in Toscana c’è il Foto Festival dall’8 al 17 luglio a Massa. E a Fiuggi
il Family Festival dal 24 al 31. Finalmente arriva settembre e, tornati dal
mare, si può ricominciare a viaggiare. Il Festival della Mente a Sarzana è il
primo appuntamento dal 3 al 5. Giulia Cogoli, l’organizzatrice, nel mucchio non
ci sta: «I veri festival sono unici, hanno un’unità di tempo, di luogo e spesso
di tema. La Milanesiana o gli incontri letterari nella Basilica di Massenzio a
Roma io li considererei rassegne». Però sempre lei inaugura proprio in questi
giorni i Dialoghi sull’uomo a Pistoia. A settembre c’è pure il genitore di tutti
questi eventi: il Festivaletteratura, proprio così. Tutt’attaccato, perché pure
nei nomi, fateci caso, si cerca di renderli diversi l’uno dall’altro, nonostante
siano tantissimi. Ad esempio, il Festival Filosofia di Modena manca del “della”
ed è dal 18 al 20 settembre. Scherza Michelina Borsari, la direttrice in
partenza per Saint Emilion in Francia, uno degli otto Paesi con cui organizza
eventi del genere: «La Siae registra 1500 festival, ma i più solidi sono una
cinquantina. Alcuni sono di teatro, danza, cinema; in ogni caso, forme
contemporanee di sapere che riportano la parola nello spazio pubblico.
Un’esigenza che non caratterizza soltanto l’Italia ma che qui è stata più
acuta». Forse pure troppo, già che gli eventi eccezionali son diventati perenni.
Ecco il Festival Internazionale di Poesia dal 9 al 21 giugno a Genova, Parma
Poesia dal 15 al 19 dello stesso mese, Parco poesia a settembre a Riccione, il
Poesia Festival a fine settembre in provincia di Modena e il Festival della
Poesia civile a novembre a Vercelli. C’era pure Bergamo poesia, ma ora rimane
solo Bergamo scienza ad ottobre. In compagnia del Festival della Scienza dal 29
ottobre al 7 novembre a Genova, del Festival delle Scienze a gennaio
all’Auditorium di Roma, di Scienza in piazza dall’11 al 21 marzo a Bologna. A
Perugia invece, dal 30 settembre al 3 ottobre, c’è il Science Festival. Infine a
Milano, dal 22 al 28 marzo, c’è il Vedere la Scienza Festival. Non va meglio con
la letteratura, che non contenta di Mantova aggiunge dal 18 al 20 giugno a
Bassano del Grappa il Piccolofestival Letteratura, dal 20 maggio al 22 giugno il
Festival Letterature a Roma, dal 29 giugno all’1 luglio il FestivAltura a
Verbania sui temi della montagna, dal 18 al 21 novembre a Cuneo Scrittori in
città e dal 15 al 19 settembre Pordenone legge. Ed esiste pure Pordenone pensa.
Se non vi bastasse.
Quanto vanno forte i
festival Tra
letteratura e scienza, riparte la stagione delle rassegne. Che non conoscono
crisi, grazie ai finanziatori più assortiti, scrive Francesca Sironi su
“L’Espresso”. Piazza Grande gremita per la lezione magistrale di Enzo Bianchi al
Festival Filosofia 2014 Avanti, cultura! Con il debutto delle Scienze
all’Auditorium di Roma è iniziato il lungo calendario dei festival, una corsa
fra almeno 67 eventi - alcuni studi ne censiscono fino a 209 - dedicati a libri
e astronauti, economisti e filosofi ma anche cuochi e tradizioni. Nonostante la
crisi, gli appuntamenti culturali spopolano: per allungare la stagione
turistica, a maggio come in autunno, non c’è ormai sindaco che non desideri
affollare la propria città di fan di un grande scrittore o di uno scienziato
illuminato. Gli happening intellettuali hanno successo di pubblico. E di
sponsor, istituzionali e privati: attraggono investimenti che superano i 24
milioni di euro all’anno, 400mila in media per ogni rassegna secondo le stime di
Guido Guerzoni della Bocconi di Milano. Ma i soldi arrivano anche dall’Unione
Europea: solo come “fondi strutturali” per lo sviluppo del Mezzogiorno, le
regioni del Sud hanno ricevuto in cinque anni da Bruxelles 72 milioni di euro
per portare in piazza arti e saperi. Dalla fine degli anni ‘90 i festival
culturali hanno conquistato la scena in tutta Italia, grazie alla loro capacità
di avvicinare lettori ed esperti, di coinvolgere autori, ricercatori, studenti,
fondazioni ed enti locali. Solo per la letteratura, seguendo l’esempio della
manifestazione più antica, quella di Mantova (che ha compiuto 18 anni), ce ne
sono oggi almeno 33. BookCity a Milano si è conclusa nel 2014 vantando come
l’anno prima “130 mila visitatori” e centinaia di incontri. L’agenda
s’infittisce ogni stagione. «L’impatto economico positivo per le città è stato
confermato da innumerevoli studi», commenta Pierluigi Sacco, professore
ordinario di Economia alla Iulm. Ma se la forza commerciale è certa, lo è meno
quella sociale: la voglia di sapere testimoniata da questi appuntamenti non è
ancora riuscita a innescare un cambiamento nazionale, almeno stando alle
statistiche che ci vedono in coda all’Europa per consumi culturali. Perché?
Prima del dibattito, la radiografia. Quanto costano i festival impegnati? I big,
come Mantova o Genova per la Scienza, hanno un budget che va dagli 1,5 ai due
milioni di euro. Pochi però possono contare su investimenti così consistenti:
meno di uno su 10, stando all’ultimo rapporto di Guido Guerzoni,
“Effettofestival”. Un quarto degli eventi si mantiene invece con un bilancio fra
i 250 e i 500mila euro. Quasi la metà se la cava con meno. E chi li paga?
Principalmente gli enti locali. Praticamente ogni festival ha almeno un comune,
una provincia o una regione fra i sostenitori, a cui si affiancano spesso le
camere di commercio. Il municipio di Milano, ad esempio, nel 2013 ha finanziato
29 kermesse, per un totale di un milione e 400 mila euro di contributi. Il
grosso è andato a rassegne di cinema e teatro, ma ci sono anche eventi come la
Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (direttore editoriale di Bompiani) a cui sono
stati assicurati 80mila euro. “Collisioni”, la manifestazione che unisce
letteratura e musica a Barolo, ha ricevuto dal Piemonte 70mila euro. Il
Pirellone del leghista Roberto Maroni ha dato il suo supporto alle tradizioni
padane: con 5mila euro al Festival celtico dell’Insubria 4mila al Festival
internazionale del Folclore. Invece i dialoghi di Trani, in Puglia, per
l’edizione 2013 hanno potuto contare su 46mila euro dall’Unione Europea e altri
32mila da Stato e Regione. Briciole rispetto ai 104 mila euro arrivati da
Bruxelles al “festival della Magia” di Crotone attraverso il dipartimento
calabrese all’Istruzione. Ed è ancora niente rispetto ai 118 mila euro garantiti
dai “Fondi strutturali europei” per l’ultimo Diamante Festival nel Cosentino,
dove fra mostre, convegni e concerti si celebra sua maestà il Peperoncino:
aggiungendo i contributi nazionali, lo show “piccante” ha ricevuto 348mila euro
a stagione, e ne ha raccolti quasi altrettanti dai privati. A parte la sponda
europea, solida soprattutto al Mezzogiorno, è difficile contare sul settore
pubblico in tempi di spending review. Al festival della Letteratura di viaggio
di Roma il Campidoglio ha dimezzato l’anno scorso le sovvenzioni: da 80 a 48mila
euro. «Noi abbiamo subìto tagli del 35 per cento», racconta Vittorio Bo,
creatore del primo e più importante Festival della Scienza, quello di Genova. La
Provincia era fra i fondatori del progetto: ancora nel 2009 aveva garantito
100mila euro. «Un contributo importante, ora azzerato», spiega Bo: «Manteniamo
per fortuna il sostegno degli altri, fra cui il ministero dell’Istruzione. E le
riduzioni in generale sono state proporzionali a quelle decise dai privati».
Quali privati? Le più presenti, anche se si trovano a metà tra pubblico e
profit, sono le fondazioni bancarie. L’ente filantropico della Cassa di
risparmio di Torino, ad esempio, ha finanziato nel 2013 ben 72 festival per
975mila euro. Gli aiuti sono andati a iniziative consolidate come
Scrittorincittà, organizzata dall’assessorato alla Cultura di Cuneo, ma anche a
un “Festival nazionale Luigi Pirandello” (stessi fondi: 20mila euro) allestito
da un’agenzia di comunicazione torinese, del cui evento nella vicina Coazze
resta in Rete giusto una pagina Facebook con 134 “mi piace”. E ancora: gli
incontri sulla Scienza a Genova sono stati possibili anche grazie ai 360mila
euro della fondazione di Compagnia di San Paolo. Mentre dal ramo solidale del
Banco di Sardegna sono arrivati 40mila euro al noto festival di Gavoi e
altrettanti a “Leggendo Metropolitano” di Cagliari. Accanto alle fondazioni, è
aumentata in questi anni la presenza delle multiutility e delle società di
servizi locali, che vogliono così radicare la loro influenza sul territorio.
Hera, il colosso che controlla rifiuti, acqua ed energia in Emilia Romagna e in
parte del Nord Est, ha speso nel 2013 quasi tre milioni di euro in
sponsorizzazioni, un milione e 100 solo per la cultura. A Bologna, dove ha la
sede principale, ha sostenuto di recente un festival poetico, uno di fumetti,
diversi di cinema e alcuni musicali. L’emiliana Iren ha messo in bilancio 4
milioni e 700mila euro per sostenere iniziative benefiche, sportive e
letterarie. Per il suo Nord-Ovest, A2A ha investito un milione e 750mila euro.
La romana Acea poco meno di tre milioni. Ci sono poi grandi aziende come Eni, 21
milioni e 438 mila euro spesi destinati alla cultura nel 2013 – anche se con
l’arrivo di Claudio Descalzi la generosità è in corso di revisione –,
Finmeccanica, Coop (che ha partecipato al festival della Tv di Dogliani, a
quello di Mantova e all’“Ilaria Alpi” di Riccione), Vodafone e Telecom. Infine,
ci sono i partner locali. Dalle banche agli aeroporti, sino a pastifici, bar,
trattorie, hotel, artigiani, autoricambi, caseifici, arredatori e vivai. Il
Festival di Mantova riceve dai privati il 75 per cento del budget (dipendendo
solo per l’11 dalle istituzioni mentre il resto viene dai biglietti), e ha 150
sponsor, che vanno da Hera a Persol passando per studi di commercialisti o “il
raviolificio sotto casa”: «Alcune grosse aziende si sono allontanate perché
mettiamo tutti gli sponsor sullo stesso piano», racconta Marzia Corraini: «Ogni
incontro ha il suo pannello con i loghi dei promotori, a prescindere dalla
dimensione della società. Certo: c’è chi è presente per più giorni. Ma per noi
tutti i partner, grandi e piccoli, sono uguali: è in questo la nostra libertà. E
la nostra forza sul territorio». I contributi possono essere sia economici che
“strumentali”: dagli sconti per i partecipanti alla pubblicità per gli eventi.
Il “Centro Latte Rapallo” ad esempio ha messo a disposizione «le etichette di
oltre 100 mila bottiglie di “Latte Fresco Tigullio Alta Qualità”, distribuite in
tutta la provincia di Genova» per pubblicizzare il festival di Comunicazione di
Camogli. Comunicazione riuscita: ad ascoltare Umberto Eco e gli altri ospiti
sembra siano arrivate 20 mila persone. Perché ai privati interessa tanto
investire sulle riflessioni in pubblico del filosofo Remo Bodei o del romanziere
Andrea de Carlo? Perché sono seguite da un sacco di gente. Anche se stabilire
con certezza quanta, è impossibile. I festival più trasparenti comunicano solo
le presenze: ovvero non i visitatori, ma il numero complessivo di partecipanti,
che conta due volte chi segue due convegni. Ed eccoli: 66mila biglietti venduti
a Mantova; 130mila spettatori per gli eventi gratuiti di BookCity, 90mila
ascoltatori al Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo (220mila
considerando anche gli incontri non filosofici), 45mila al raduno della Mente di
Sarzana, 14mila a LetterAltura sul Lago Maggiore, 13mila a Bergamoscienza, e
così via. C’è però anche chi si limita, nei comunicati, a indicare “migliaia di
spettatori” (Popsophia, Tolentino), oppure segnala soltanto il numero di click
online o ancora dichiara laconicamente “sale piene”. Quello che è certo è che il
pubblico non ha conosciuto crisi. «Devo ammettere: avevamo un po’ di paura
l’anno scorso, considerate le difficoltà economiche delle famiglie», racconta
Marzia Corraini, fra i fondatori del FestivaLetteratura di Mantova: «Ma ancora
una volta ci siamo stupiti: i visitatori sono aumentati». E non è solo dal
numero di sedie riempiti che si può valutare il successo. Ci sono eventi piccoli
come “Dedica” di Pordenone, che raggiunge solo le cinquemila presenze ma riesce
ogni anno ad approfondire un autore nuovo, producendo contenuti di spessore. E
poi c’è il contesto. Quello che una rassegna dà al suo territorio. Lo spiega
bene lo scrittore e presidente dell’Associazione “L’Isola delle storie” Marcello
Fois in una ricerca su “L’Italia creativa” di Annalisa Cicerchia: «L’ultima
edizione del Festival di Gavoi», racconta, «è stata visitata da 30mila
spettatori, in un paese di tremila abitanti. Arrivano grandi scrittori che non
ricevono alcun tipo di cachet. La manifestazione costa 220 mila euro e in questi
anni il Pil del Comune è cresciuto del 24 per cento. Ciò significa che si sono
aperti alberghi dove non esistevano, si è riavviato un camping che da 25 anni
era chiuso. Il turismo si è espanso per tutto l’anno, compreso l’inverno. In
Barbagia». Che i conti tornino, per i commercianti locali, lo ha dimostrato
anche il Festival per l’Economia di Trento (chi se non loro?), che nel 2008 ha
affidato ai propri partecipanti una card con cui segnalare le spese in
pernottamenti, ristoranti, negozi e musei: scontrini da 154mila euro al giorno.
«Tocca chiederci oggi: cosa resta di tutto questo fermento?», si domanda
l’economista Pierluigi Sacco: «I grandi eventi danno grandi ritorni - sul breve
periodo - per grandi investimenti. Ma dobbiamo confrontarci sul loro scopo:
riescono a cambiare la politica dei luoghi in cui avvengono? Ad avere un impatto
sull’istruzione? Sui consumi? Sulle abitudini della popolazione?». Secondo
Sacco, la risposta è: più o meno no. Nel senso che hanno dimostrato di servire
poco nella loro forma-standard, che vuole un grande scrittore, o un noto
intellettuale davanti a un pubblico passivo e felice. L’unico modo perché della
cultura “resti attaccata”, sostiene il docente, è puntare sull’interazione.
Sullo scambio. Come avviene, insiste, nei laboratori per studenti del Festival
di Genova, che permettono ai bambini di “mettere le mani” nella scienza. Secondo
lui, il dialogo da attivare fra gli adulti e gli autori dovrebbe essere diverso:
un confronto, più che una conferenza. «È vero, il nostro pubblico è composto
per più della metà da scuole», risponde Vittorio Bo, «ma non dobbiamo snobbare
gli incontri frontali, anzi: c’è un pubblico adulto che ha bisogno di sedersi e
ascoltare persone intelligenti. Il dialogo forse non si sente. Ma perché è
interiore e profondo».
Dura dodici mesi l’anno la
stagione dei festival letterari in Italia,
scrive "Italia.it". Con
formule collaudate o innovative da presentare agli operatori, agli appassionati
di buone letture e al grande pubblico, il panorama dei festival letterari mette
in risalto “firme”emergenti e scrittori già affermati a livello nazionale e
internazionale. Il panorama di queste manifestazioni che si susseguono tutto
l'anno lungo la penisola è molto variegato sia nelle proposte che nella formula
tematica, territoriale o commerciale. I festival letterari rappresentano spesso
un vero e proprio connubio tra il fatto culturale e l’evento spettacolare. Il
festival è infatti un momento unico in cui l'autore può creare un contatto
diretto con il proprio pubblico. Diversi per storia e origini, nati per
iniziativa di intellettuali, fondazioni o librai, i festival letterari
rappresentano vere e proprie realtà di riferimento per la narrativa italiana.
Saldi al momento nella loro leadership e forti della loro lunga storia, si
possono elencare il Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fiera della
piccola e media editoria Più libri più liberi di Roma,
il Festival della Letteratura di Mantova e quello degli autori di Lucca,
il Festival Internazionale di Poesia di Genova e
quello organizzato da Internazionale a Ferrara. Accanto ai capisaldi della
letteratura spiccano kermesse autoriali che si contraddistinguono per la
particolarità della location. Accolte in piccoli borghi o un suggestive piazze,
queste manifestazioni rappresentano vere e proprie chicche nel calendario di
incontri letterari italiani. Cortina d'Ampezzo, per esempio, ospita nei
tradizionali spazi delle Poste e nella nuova e suggestiva cornice della
“Conchiglia” di piazza Venezia, una rassegna dedicata alla letteratura ma che dà
spazio anche ai dibattiti, al teatro e alla musica. E ancora, scendendo lungo la
penisola, nelle ridenti cittadine di mare di Toscana, Romagna e,
già fino alle Marche e all’Abruzzo sono
decine e decine le occasioni di incontro con gli autori di saggi, romanzi e
cataloghi. A cominciare dalla frequentatissima vetrina di Capalbio libri, che si
tiene ogni anno nel cuore del borgo medievale. Dalla costa tirrenica a quella
Adriatica. A San Benedetto del Tronto va in scena Scrittori sotto le Stelle,
l’appuntamento estivo in riva al mare. A Palermo,
nello splendido palazzo Steri, si rinnova l'appuntamento dedicato all'editoria
indipendente, Una Marina di Libri. La capitale ospita uno dei festival più
suggestivi: Letterature, festival Internazionale di Roma, apprezzata kermesse
presso la Basilica di Massenzio al Foro Romano. Lungo tutta la penisola vi è poi
un filone di manifestazioni che fondono tra loro vari "generi": scienza,
filosofia, noir, fumetto. Genova si è affermata in questo senso come punto di
riferimento per la divulgazione scientifica,
mentre Modena, Carpi e Sassuolo sono diventate capitali della filosofia con
il Festivalfiolosofia. Courmayeur da oltre
vent'anni dà spazio al giallo con Noir in Festival, mentre Trento è
la vetrina in cui presentare libri sull'economia e accendere dibattiti a tema.
Ce n'è per tutti i gusti.
L'Italia dei
festival cinematografici,
scrive “Italia.it”.
L’Italia, patria di grandi registi, ma anche luogo di innumerevoli set italiani
e stranieri, ospita ogni anno diverse rassegne cinematografiche di carattere
internazionale. Sicuramente la più importante è la Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica che ha luogo nell’incantevole Venezia,
all’interno dello storico Palazzo del Cinema, sul Lungomare Marconi, al
Lido di Venezia. Il festival, che si svolge tra la
fine di agosto e l'inizio di settembre, è il secondo festival cinematografico
più antico del mondo dopo il Premio Oscar (la prima edizione si tenne, infatti,
nel 1932). Si svolge sempre in un’altra bellissima città d’arte italiana, il
Torino film festival. Nata nel 1982 nella città
della mole antonelliana, che ospita anche il Museo
del cinema, la rassegna è dedicata soprattutto alle realizzazioni indipendenti
e, oltre al cinema d’autore e di genere, prende in considerazione anche
cinematografie straniere e produzioni video. Dal 2006 anche la Città
Eterna ha la sua rassegna cinematografica; si tratta
del Festival internazionale del film di Roma che si tiene in autunno a
Roma presso l'auditorium Parco della Musica. Nella
città considerata la capitale del cinema italiano e dell'industria
cinematografica, location prediletta dai grandi registi e sede della cosiddetta
“fabbrica dei sogni”, Cinecittà, non poteva
mancare un festival dedicato alla Settima Arte. Sempre a Roma ha luogo anche il
RIFF - Rome independent film festival. Nato nel 2000, ha lo scopo di promuovere
il circuito cinematografico indipendente, con particolare attenzione alle opere
prime italiane. Il festival si tiene presso il nuovo cinema Aquila, la Casa del
Cinema a Villa Borghese e il Kino. Degni di interesse anche festival
cinematografici minori che hanno un certo riscontro di pubblico e critica e che
si svolgono, tra l'altro, in bellissime zone di villeggiatura. A cominciare
dall'Ischia Film Festival nel Castello Aragonese di Ischia,
a luglio. La manifestazione, in cui si premiano le opere, i registi, i direttori
della fotografia e gli scenografi che valorizzano “location” italiane o
straniere, organizza anche il Convegno Nazionale sul cineturismo. C'è poi il
“Taormina film fest”, storico festival cinematografico internazionale che si
tiene nel suggestivo Teatro antico di Taormina.
La rassegna ha anche ospitato la premiazione dei “David di Donatello”, il premio
cinematografico italiano per eccellenza, e i Nastri d'argento del sindacato
giornalisti cinematografici. Infine, la Mostra internazionale del Nuovo Cinema
di Pesaro, altro importante festival cinematografico che nasce nel 1964, si
tiene nella splendida città costiera delle Marche.
Una menzione a parte, poi, per il Giffoni film festival, una rassegna di cinema
per i ragazzi che ha luogo a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno
dal 1971. Le giurie del
Festival sono composte da giovani italiani e stranieri che vengono ospitati
dalle famiglie di Giffoni e dintorni e che, oltre a visionare i film, discutono
con registi, autori e interpreti. Grandissimi nomi partecipano ogni anno a
questa rassegna della quale il regista François Truffaut, nel 1982, ha lasciato
scritto: “Di tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più
necessario”.
L’Italia dei Festival del
cinema scrive Ambra Vannicelli
su “50epiù”. Da quello di Venezia, il più antico del mondo, agli oltre 150
Festival sparsi in tutto il Paese. Prossimo appuntamento è con il Festival
Internazionale del Film di Roma. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
di Venezia, in corso fino al 6 settembre, è il festival più vecchio del mondo.
Ha 71 anni e non sentirli, visto che ancora oggi si conferma un importante punto
di riferimento per la produzione cinematografica mondiale. L’Italia ha
all’attivo un numero assai sostanzioso di Festival dedicati al cinema,
cortometraggi inclusi. Il calendario è fittissimo. Basti pensare che una volta
chiusa la Mostra di Venezia seguirà una sfilza di rassegne cinematografiche. Il
primo appuntamento che segnaliamo è con il Festival Internazionale del Film di
Roma. Tra gli ultimi arrivati (nasce nel 2006), si tiene dal 16 al 25 ottobre.
Torna a ottobre anche il Napoli Film Festival che quest’anno celebra
Michelangelo Antonioni in occasione dei 50 anni di “Deserto Rosso”, il film che
vinse il Leone d’Oro a Venezia nel 1964. A seguire Torino Film Festival, alla
32° edizione, in programma dal 21 al 29 novembre. Da Torino a Firenze con il
Festival dei Popoli, dedicato al cinema documentario, che si tiene dal 28
novembre al 5 dicembre. E poi sarà la volta del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno, uno dei più antichi, nato all'indomani della Seconda Guerra
Mondiale, nel 1946. In Italia, secondo un elenco parziale stilato da wikipedia,
si contano oltre 150 festival cinematografici, nessun Paese ne vanta così tanti,
nemmeno gli Stati Uniti nonostante l’imponente industria cinematografia. Alcune
rassegne sono molto longeve e ancora attive. Nel 1949 ne debuttano ben due: il
Filmvideo festival internazionale del cinema di Montecatini Terme (Pt), rassegna
che propone il meglio dei cortometraggi, che si terrà dal 12 al 19 ottobre, e il
Valdarno cinema FEDIC a San Giovanni Valdarno (Fi), dedicato al cinema
indipendente. Nel 1952 invece nasce Trento Film Festival. La rassegna presenta
e promuove film e video di ogni nazionalità, genere e durata con al centro la
montagna, l’avventura e l’esplorazione. L’appuntamento con la 63° edizione è dal
30 aprile al 10 maggio 2015. Andando avanti con le rassegne più longeve nostrane
e ancora in attività, tra le più prestigiose c’è il Taormina Film Fest, erede
della Rassegna Cinematografica di Messina e Taormina nata nel 1955. A questo
punto impossibile non ricordare i Premi David di Donatello, destinati alla
migliore produzione cinematografica italiana e straniera. La prima cerimonia di
premiazione si è tenuta 1956 a Roma al Cinema Fiamma. Nel 2007 il David è
diventato Accademia del Cinema Italiano. Il 25 novembre 2009 Gian Luigi Rondi,
classe 1921, viene nominato presidente a vita. Altri Festival dedicati al cinema
nasceranno nel corso degli anni, sempre più internazionali, originali, ma anche
di “nicchia”. Tra i tanti meriti, quello di far conoscere i film di giovani
registi, opere prime, pellicole che hanno avuto poca fortuna nella
distribuzione. Al riguardo 50&Più con la sua sede di Roma fa la sua parte
sponsorizzando sin dall’inizio il Santamarinella Film Festival (Rm), nato dieci
anni fa. La rassegna è dedicata al giovane cinema italiano d’autore, vetrina
per quei registi esordienti che non trovano adeguati spazi per presentare le
proprie opere. Infine, oltre al primato del Festival cinematografico più vecchio
del mondo, l’Italia vanta un Festival molto particolare. Si tratta del Festival
di Giffoni (Sa). Nato da un’idea dell’attore Claudio Gubitosi per promuovere e
far conoscere il cinema per ragazzi. Una delle particolarità di questo Festival
sono i giurati: hanno dai 18 anni in giù e provengono da ogni parte del mondo.
Più festival che scandali,
ed è tutto dire,
scrive Beppe Severgnini dal Corriere della Sera. Della Letteratura. Delle
Letterature. Del Libro. Dei Libri. Del Libro Usato. Del Libro Internazionale.
Del Libro per Ragazzi. Del Libro all’Orizzonte. Dell’Autore. Degli Autori. Del
Libro con gli Autori. Dell’Inedito. Della Piccola e Media Editoria.
Dell’Editoria Indipendente. Della Microeditoria. Del Giornalismo. Della Poesia.
Della Marina. Del Noir. Del Giallo. Del Fumetto e dell’Animazione. Della Penna
d’Oca (e del Byte). Dei Bambini (o Children che dir si voglia). Del Racconto.
Delle Parole dello Schermo. Del Viaggio. Del Pensiero. Della Filosofia. Della
Comunicazione. Di Cinema e Letteratura. Dell’Innovazione. Del Mondo Antico.
Della Scienza. Della Mente. E poi: Internazionale, In Riva al Mare, A Piedi
Nudi nel Parco, Sotto le Stelle, Sul Fiume, sulle Bocche. Questa selezione
dimostra una cosa: in Italia produciamo più festival che scandali, ed è tutto
dire. Alcuni sono diventati i migliori d’Europa nel loro genere (Mantova per la
letteratura, Perugia per il giornalismo). Molti sono buoni. Tutti sono
volonterosi e, quasi sempre, pieni di gente. Il fenomeno è stato studiato,
discusso, copiato. Le rivalità italiane si sono, infatti, festivalizzate. Se una
città ha un festival, la città vicina non può farne da meno. Cosa spinge il
pubblico verso questi incontri? Il piacere di stare insieme, la confusione
gioiosa, la gratuità e un po’ di serendipity: la voglia di trovare ciò che non
si sta cercando (un libro, un’idea o un fidanzato, dipende). Nelle sagre –
caposaldo della vita sociale italiana – si mangia, si beve, si balla. Nei
festival si può ascoltare e guardare. Per chi ha problemi di colesterolo e
coordinazione, una dignitosa soluzione. Cosa spinge le amministrazioni locali a
organizzare, sostenere, sponsorizzare i festival? La possibilità di ottenere
molto con poco. Gli autori, a differenza di ogni professionista dello
spettacolo, si offrono gratuitamente. Il verbo non è scelto a caso: per molti di
noi il richiamo dell’approvazione è irresistibile. In tanti, ormai, sono in
grado di riempire una piazza; e chi non ci riesce si consola, a cena, pensando
d’essere un intellettuale. E’ questa umanissima debolezza il carburante del
sistema. Gli scrittori sono manodopera gratuita, zelante, incontenibile. Nessuno
attraversa l’Italia per vendere venti copie d’un libro; molti sono disposti a
farlo in cambio di una distesa di occhi attenti e dell’applauso finale. Parlate
con un editore. Vi dirà: per impedire a certi autori di partecipare ai festival
dovremmo incatenarli! E sarebbe fatica inutile. Si presenterebbero così sul
palco, con un nuovo titolo, “Novello Prometeo”. A proposito: se qualcuno fosse a
Firenze, oggi tocca a me (Festival del Viaggio). Sabato ad Asti apro invece
Passepartout (direttore scientifico Alberto Sinigaglia). Poi chiudo coi
microfoni fino a settembre. Sarà una lunga estate d’astinenza. Se parlerò ai
ginepri della Gallura nel maestrale, vuol dire che sono proprio conciato male.
Sanremo:I grandi scandali
del passato,
scrive Gigi Vesigna su “Marida Caterini”. Non solo canzonette. Le
polemiche, il gossip, gli scandali, veri o costruiti ad arte, sono sempre stati
ingredienti fondamentali per il Festival di Sanremo. Nel corso degli anni molti
sono stati gli avvenimenti rimasti nascosti al grande pubblico che hanno
coinvolto i protagonisti. Ho scelto cinque edizioni, tra le sessantadue della
storia della kermess, e di queste vi svelo alcuni episodi curiosi che sono
venuti alla luce soltanto anni dopo. Cominciamo quasi dagli inizi.
Siamo nel 1955
. Claudio Villa è il vincitore annunciato del Festival, prima ancora che
cominci. Alla vigilia della serata finale, colpo di scena: Villa si dà malato,
colpito da una bronchite fulminante che gli impedisce di cantare. Lo fotografano
a letto, nella sua camera all'Hotel Nazionale, dove appare sofferente: poi
arriva l'annuncio ufficiale:non canterà la sera della finale. Sconforto tra i
molti fan del Reuccio, ma la verità è un'altra. Sua moglie Miranda. nota
doppiatrice (sua la voce italiana di Sherley Temple) ha scoperto che Claudio
l'ha tradita e si è precipata a Sanremo, minacciando di fargli una scenata in
diretta tv. Panico tra gli organizzatori, poi il regista Vito Molinari ha
un'idea risolutiva: le telecamere inquadrano un giradischi con il disco
"Buongiorno tristezza" canzone che, naturalmente, vince, mentre Villa segue il
festival in tv. Solo dopo un incontro senza testimoni, riferiscono che è
scoppiata la pace. Claudio Pica e Miranda si erano sposati nel 1952 e si
separeranno nel 1962...
Undici anni dopo: è il 1966.
Arbore e Boncompagni arrivano al Festival in macchina da Roma con l'amica Carla
Puccini e si inventano una beffa ai danni dell'ormai mitico Mike Bongiorno che
presenterà la manifestazione con lei e con Paola Penni. A un certo punto Carla
dovrà svenire in scena e beccarsi un bel po' di pubblicità. Ma Mike fiuta
l'inganno e quando, con la coda dell'occhio, vede che alla sua destra Carla sta
per accasciarsi, chiama la telecamera sul suo primo piano e la mantiene sinchè
il palco non è sgombrato dalla "salma". Grande Mike che con gli undici Festival
presentati, merita ampiamente il monumento che sarà collocato a Sanremo in via
Escoffier, angolo via Matteotti, a due passi dall'Ariston e inaugurato da Fabio
Fazio il 15 febbraio. Alto un metro e 96, a Sanremo non è costato un euro
perchè ha pagato tutto la moglie Daniela. Un altro monumento, dedicato a Michael
Nicholas Salvatore Bongiorno ( è il suo nome per intero) si trova a Breuil,
vicino Corina, dove Mike aveva una casa e andava a sciare.
Arriviamo al 1974.
E' il festival più scassato della storia: vince una certa Gilda che fa
l'infermiera a Torino. Si scatenano i rumours: secondo alcuni, Gilda, una bella
ragazza bionda, sarebbe "fidanzata" con il potente assessore al turismo
Napoleone Cavaliere, secondo altri protetta da camorra o 'ndrangheta. La realtà
è molto più banale. Il suo agente, Nello Marti, ha saputo che le giurie
sarebbero state dislocate soltanto in caserme e così, prima del Festival, Gilda
fece una tournèe proprio nelle caserme italiane. E vinse facile.
Eccoci al 1990.
Grazie al patron Adriano Aragozzini, al festival si torna a cantare dal vivo, ma
la sede è il nuovo Palafiori, una cattedrale nel deserto voluto per motivi
politici da un potente gruppo democristiano. Dentro fa un freddo glaciale, sulla
volta volano sciami di pipistrelli. Vincono i Pooh con "Uomini soli", ma la
vittoria se la sarebbe meritata Toto Cutugno che canta "Amori" con Ray Charles.
Ma già alla vigilia i Pooh avevano in tasca la vittoria: era la condizione
perchè, per la prima volta, si mettessero in gioco al Festival.
E siamo nel terzo millennio: è
il 2001. Come quest'anno è vigilia di elezioni e tocca a Raffaella Carrà la
presentazione del festival. Lei è riluttante: da sempre sa- gliel'ha
preannunciato un profetico pendolino- che Sanremo per lei sarebbe stata
sicuramente una sciagura. Ma la Rai praticamente la costringe: subito dopo il
Festival si va alle urne e in viale Mazzini sanno bene che con lei non ci
saranno comportamenti politicamente scorretti. Il rischio era che il Festival
potesse andare in malora. Cosa che non succede, grazie alla vittoria di Elisa e
al secondo posto di Giorgia. Le canzoni salvano le elezioni. Un dèjà vu?
Speriamo.
Estate 2015: gli italiani
ammazzano i festival?
Si chiede “Rockol”. Ci sono, sì, realtà solide e funzionali sul panorama
musicale estivo dal vivo in Italia, e rassegne ormai istituzionali come il Rock
in Roma o il Lucca Summer Festival (o festival emergenti come l'Home Festival di
Treviso, per citarne uno), dopotutto, sono lì a dimostrarlo. L'estate rock
all'aperto italiana, però, negli ultimi anni ha perso dei pezzi difficili da
rimpiazzare (e, al proposito, di una nuova edizione di Mondo Ichnusa al momento
non si hanno notizie), e presto potrebbe perderne altri. Perché da una parte ci
sono dei promoter e degli imprenditori pronti a tenere duro, e dell'altra dei
comitati di quartiere sul piede di guerra o delle giunte comunali che di
collaborare, proprio, non ne vogliono sapere. Così, mentre all'estero si
annunciano i sold-out nelle prevendite e le ultime definizioni nei cartelloni
dei maggiori eventi per la prossima estate, qui da noi manifestazioni di primi
piano ancora lottano nella speranza di poter aprire i battenti. C'è chi è
fortunato, come il Milano City Sound, che proprio in queste ore dovrebbe
ufficializzare la propria edizione 2015, e c'è chi ancora naviga a vista - Rock
in Idro e Arezzo Wave - nella speranza che qualosa, di qui a breve - perché se
Roma non è stata costruita in un giorno, nemmeno un festival di prima grandezza
si può organizzare in una settimana - si muova. Ecco, quindi, cosa abbiamo
rischiato, o ancora stiamo rischiando, di perderci per la prossima estate. Il
Rock in Idro, dopo anni passati a migrare tra le aree periferiche al capoluogo
lombardo, pareva aver trovato un porto sicuro nell'Arena Joe Strummer del Parco
Nord, a Bologna: la conferenza stampa - e le dichiarazioni degli attori
coinvolti (municipalità e promoter) - prima, durante e dopo l'edizione 2014
parlavano di un contratto triennale che avrebbe messo in sicurezza il festival
almeno fino al 2017. Poi, a inizio del 2014, l'amara sorpresa: un ripensamento
del Comune avrebbe indotto l'agenzia organizzatrice, Hub Music Factory, a
tornare sui suoi passi e cercare - compatibilmente con le tempistiche necessarie
per organizzare una manifestazione di tali proporzioni - una location
alternativa. "Siamo rimasti soli, ancora una volta, nella ricerca di una
location che di diventare stabile - purtroppo - non ne vuole sapere", ci ha
confessato una decina di giorni fa il co-fondatore della Hub, Alex Fabbro,
allora prossimo a una riunione con l'assessorato che sulla carta avrebbe potuto
essere dirimente. Ma che, ad oggi, di sbrogliare la situazione non è stata
ancora in grado. Problemi, ma connessi ai comitati di quartiere, li ha avuti
anche il Milano City Sound, il tribolato festival milanese un tempo ospitato
dall'Arena Civica poi spostatasi - negli ultimi due anni - all'Ippodromo, sempre
nel capoluogo lombardo, e che dal 2015 troverà spazio in una porzione del parco
di Monte Stella, sempre nel quartiere di San Siro: dopo ripetuti sopralluoghi
tecnici da parte delle autorità, la rassegna organizzata da Vittorio Quattrone
dovrebbe ufficializzare la nuova edizione a giorni. Ancora top secret, al
momento, il cast per la prossima estate, anche se il promoter ha già anticipato
- per sommi capi - quali saranno le caratteristiche della rassegna prossima
ventura: nell'area concerti di trentamila metri quadri complessivi, oltre a due
aree per altrettanti palchi - della capienza di 18mila presenze per il main
stage e 3mila per il palco secondario - troveranno spazio anche posti ristoro,
strutture sportivi e spazi polifunzionali per incontri, corsi e altro. "Ci hanno
accusato di voler cementificare uno spazio verde", ha risposto Quattrone alle
accuse dei comitati che hanno dato battaglia perché il Comune non concedesse lo
sfruttamento del parco attiguo all'ex area del PalaSharp: "Per la verità il
discorso portato avanti da chi ci osteggia vede nel pubblico dei concerti
un'orda di criminali. Il nostro scopo, invece, è solo quello di valorizzare -
per due mesi su dodici - una porzione di uno spazio verde di Milano, che
comunque resterà a disposizione del pubblico. Il piano sottoposto ai tecnici del
comune, che, tra l'altro, non hanno mai rilevato irregolarità, non prevede
nessun intervento che possa arrecare danni permanenti (come, ad esempio,
l'utilizzo di piastre in acciaio o in cemento per gli allestimenti), ma include
il ripristino a nostro carico del manto erboso dopo la manifestazione in zone
che ne prevedano l'eventuale rinnovamento". Ancora più ricca di ostacoli, che ne
starebbero seriamente ipotecando la realizzazione, è la strada che potrebbe
condurre al prossimo Torino Traffic Free Festival. Le ultime, in merito, sono
state riferite a metà gennaio dal giornalista della Stampa Gabriele Ferraris:
nonostante un progetto molto ambizioso, che potrebbe vedere iscritti nel
cartellone i nomi nientemeno che di Thom Yorke e Bjork, l'impossibilità da parte
del municipio del capoluogo piemontese, unita alla confusione creatasi in giunta
dopo la presentazione di almeno tre progetti, due da parte degli organizzatori
storici (divisisi in due gruppi, con da una parte Gianluca Gozzi e il
chitarrista dei Subsonica Max Casacci, e dall'altra il direttore artistico del
locale Hiroshima Mon Amour Fabrizio Gargarone e il giornalista Alberto Campo) e
uno (quasi subito abortito) da parte della giunta, non avrebbe fatto altro che
complicare ulteriormente il processo di organizzazione, già dalle fasi
preliminari. Non va meglio dall'altra parte dell'Italia, a Napoli, dove il
Neapolis Festival, già lo scorso anno, fu costretto a chiudere i battenti. E
anche per la prossima esatte Sigfrido Caccese, che della manifestazione è uno
degli organizzatori, vede nero. E ripete riflessioni che gli addetti ai lavori
conoscono fin troppo bene: "Sembra che la formula festival, in Italia, di
funzionare non ne voglia sapere. Soprattutto in una città come Napoli, che oggi
come non mai sta mostrando una scarsa inclinazione verso questi spettacoli. Ed è
un vero peccato, non solo per gli appassionati, perché un festival come il
Neapolis crea un grande indotto". Scarsa vocazione festivaliera a parte, il muro
di gomma contro al quale rimbalzano i tentativi degli organizzatori pare essere
il solito: "La mancanza di collaborazione da parte delle istituzioni è totale",
denuncia Caccese, "Ormai, ad averli come interlocutori, non ci proviamo nemmeno
più. Per il resto noi non molliamo, e a organizzare il festival ci proviamo.
Magari su soli due giorni, invece di tre, come successo in occasione delle
passate edizioni, magari più in piccolo: se non quest'anno, l'anno prossimo la
formula giusta per imbastire la manifestazione la si troverà". E se dovessimo
dare una percentuale di possibilità di una riapertura dei battenti già per la
prossima estate? "Il 20, 30%. Non di più...". E non c'è storia o tradizione,
quando si tratta di mettere in piedi un festival, a tenere. Lo sanno bene gli
organizzatori di Arezzo Wave, una delle sigle storiche sul panorama tricolore,
che da un paio d'anni a questa parte sembrava aver ritrovato il suo spazio -
seppure decentrato, nel 2013, quando si tenne in Valdichiana, rispetto alle
edizioni storiche - nella città che gli aveva dato i natali: l'edizione del 2015
della manifestazione ideata da Mauro Valenti è a rischio. Il problema? Il
solito: istituzioni estremamente lente nel fornire risposte e comitati di zona
sul piede di guerra. A spiegarlo è stato lo stesso Valenti, in una lettera
aperta inviata al Corriere di Arezzo: "Nelle edizioni 2012 e 2014 (nel 2013 non
ci è stata data la possibilità di farlo ad Arezzo) abbiamo investito più di
1.200.000 euro senza ricevere un euro dal Comune, portando risorse nel
territorio e mettendo Arezzo come capitale delle politiche musicali giovanili
del nostro paese. Ciò nonostante ogni nostra richiesta è ignorata, cosa strana
visto anche il marchio di proprietà comune tra fondazione e amministrazione e
l'obiettivo teorico della sua valorizzazione".
Storia di un fallimento
(perchè l’Italia non ha un grande festival),
si chiede Daniele Salomone, Direttore di Onstage. Perché l’Italia non ha
un grande festival? Perché non riusciamo ad organizzare un evento all’altezza di
quelli che invidiamo ai paesi europei e agli Stati Uniti? Domande simili sono
tornate di moda quest’anno perché è saltato l’Heineken Jammin’ Festival e
abbiamo assistito al caso eclatante dell’A Perfect Day, annullato dopo che la
line up completa era stata annunciata. Ma questo problema in Italia ha radici
molto profonde: è un grave fallimento del sistema-paese. Se non abbiamo un
festival degno di questo nome le responsabilità sono di tutti. Dei privati,
delle istituzioni e del cosiddetto popolo. Il lungo periodo di recessione non
aiuta, ma non può essere un alibi: in questo campo faticavamo molto anche quando
il paese cresceva. I privati. Eventi come Glastonbury e Sziget contano su
organizzazioni che lavorano 12 mesi l’anno sulle proprie creature, mentre da noi
sono sempre stati i promoter a tentare di mettere in piedi i grossi festival.
Un’anomalia che produce effetti negativi: intanto è possibile che una struttura
impegnata nella produzione di concerti abbia poche risorse per organizzare
raduni lunghi e di una certa dimensione. Poi c’è un conflitto d’interesse: il
promoter tende a privilegiare l’artista del suo roster nella costruzione del
cast, anche se la scelta si rivela controproducente per la qualità del cast
stesso. Ma soprattutto esiste un problema imprenditoriale: nessuno è riuscito a
proporre un prodotto-festival all’altezza del mercato. Per esempio, le location
si sono sempre rivelate inadatte e l’offerta di ristorazione non si è mai
evoluta: non è più accettabile stare in coda due ore per bere una birra e non
poter mangiare altro che un panino freddo con la salsiccia scotta. Dovreste
vedere come funzionano questi servizi nei festival europei. Non dimentichiamoci
che stiamo parlando di eventi destinati a una fascia di popolazione benestante.
Le istituzioni. Non è una novità che la classe politica italiana abbia problemi
con la gestione del patrimonio e delle iniziative culturali. L’amministrazione
pubblica non riesce a prendersi cura di un tesoro dell’umanità come Pompei,
figuriamoci se può comprendere l’utilità di un festival musicale per l’economia
di un territorio e di una collettività. Per il Sziget si mobilitano gli enti di
promozione turistica ungheresi: non è un caso che degli oltre 350mila
spettatori, la stragrande maggioranza sia straniera. Budapest spalanca le porte
ai turisti e mostra all’Europa il suo profilo migliore. Noi non sappiamo farlo,
eppure di turismo dovremmo essere campioni. E non posso fare a meno di chiedermi
come si comporterebbe un Comune di fronte alla possibilità di organizzare un
grande festival nel proprio territorio, se qualche abitante protestasse perché
contrario. A giudicare da quanto avviene a Milano, dove un piccolo comitato di
residenti condiziona la programmazione e la qualità (acustica) dei concerti a
San Siro, ho come il sospetto di conoscere la risposta. Gli abitanti sono voti.
Il pubblico. Noi. Noi che viviamo la musica come il calcio, con le tifoserie di
artisti e generi che rifiutano tutto quello che è “avversario”. Noi che non
abbiamo il minimo interesse per quello che non conosciamo e persino ai concerti
dei nostri idoli non degniamo di uno sguardo gli artisti spalla. Noi che diamo
la colpa agli organizzatori se il prezzo del biglietto ci pare troppo alto,
quando invece dipende quasi sempre dal cachet degli artisti. Noi che se il
prezzo è giusto ci lamentiamo del cast (e, appunto, ignoriamo le richieste dei
big). Noi che tra un weekend al mare e tre giorni dentro una tenda non abbiamo
dubbi. Noi che ai festival italiani non ci andiamo, ma all’estero si perché è
più figo. In effetti. Ho citato Glastonbury e Sziget perché sono realtà virtuose
che propongono modelli opposti. Il primo punta tutto sulla qualità (e la
quantità) della proposta musicale, ma state certi che vostro figlio di due anni
troverà tutte le strutture necessarie per passare una splendida giornata. E se
vi si dovessero rompere le acque mentre ascoltate i Rolling Stones, non c’è
problema. Tanto per capirci, in 40 anni di storia, Glasto si è costruito una
tale credibilità che i biglietti finiscono 8 mesi prima dell’evento, quando
nessun artista è stato annunciato. A Budapest invece hanno puntato
sull’esperienza: andare al Sziget significa farsi una settimana di vacanza in un
parco a tema (musicale) situato dentro un’isola sul Danubio. Concerti di tutti i
generi e dimensioni, dj-set, ma anche giostre, meditazione, sport e infinite
altre attività. Peace&Love. L’ingresso costa relativamente poco ma la struttura
guadagna offrendo tutti i servizi necessari con efficienza ed efficacia. E
Budapest gioca di sponda. Sia in Inghilterra che in Ungheria, pur in epoche e
contesti diversi, hanno pensato a un prodotto (magari aggiustandolo in corsa),
l’hanno posizionato presso un pubblico che lo chiedeva e non hanno incontrato
resistenze sul territorio. Guadagnano, creano lavoro e fanno divertire un sacco
di gente. Così succede negli Stati Uniti per eventi come Coachella e il South By
Southwest. Noi, d’estate, dobbiamo accontentarci dei cosiddetti concert
series, cioè manifestazioni che offrono più o meno uno show a sera in un
determinato periodo e nella stessa location. Va bene perché comunque ci portano
grandi nomi, soprattutto internazionali. Accontentiamoci, ma non nascondiamo la
testa sotto la sabbia.
LA CONTROSTORIA DELLE CASE
EDITRICI ALTERNATIVE.
"Controstoria", ecco il
dossier sulle case editrici alternative,
scrive Gaetano Farina su “Affari Italiani”. Poiché va tanto di moda pubblicare
“dossier”, anche noi abbiamo deciso di elaborarne uno per scavare nell’“oscuro”
mondo della Controinformazione. In tutti questi anni di Governo– Berlusconi, il
problema dell’indipendenza dell’informazione è inevitabilmente rimasto centrale
nel dibattito del nostro Paese. I recenti avvenimenti – più o meno scandalosi -
“Veline in Parlamento”, “Compleanno Noemi”, “Escort a Palazzo Grazioli”,
“Festini ad Arcore”, “Guerra contro Anno Zero”, “Nuove Case ai Terremotati
Abruzzesi”, “Querele a Repubblica, Unità e Manifesto”, “Decreto
Intercettazioni”, “P3”, “Appaltopoli” e “Lodi vari”, anzi, hanno acceso, se non
avvelenato, ancor di più il dibattito. E allora, dopo aver “recensito”, sempre
su Affari Italiani, le testate on-line e cartacee cosiddette “alternative”, i
tempi ci sembrano appropriati anche per proporre un ampio dossier sulle case
editrici votate alla controinformazione, a pochi giorni dalla conclusione della
seconda edizione del Salone dell’Editoria Sociale, nuovo punto di riferimento
per l’editoria indipendente in contrapposizione alla Fiera del Libro di Torino
sempre più assomigliante ad un “megagalatticomarket” spudoratamente allineato
agli interessi ed alle strategie dei più forti marchi editoriali e dei numerosi
sponsor bancari. Dunque, proviamo qui a riunire tutte quelle case editrici che -
seppur con un profilo e un approccio differente - ricercano, molto più delle
altre, le Verità oltre quelle ufficiali, istituzionali e veicolate dai media
convenzionali; s’impegnano a diffondere storie ed informazioni taciute,
scarsamente rappresentate o liberate dalla manipolazione mediatica. Un modus
operandi che, in Italia, viene etichettato come Controinformazione. Un’etichetta
paradossale dato che, dagli anni dello stragismo terroristico, passando per i
delitti di Mafia, sino ad oggi, all’epopea del trionfante berlusconismo, la
controinformazione è spesso coincisa con la vera informazione. Esplorare la
produzione di queste agenzie culturali significa, contemporaneamente,
ripercorrere i fatti e gli avvenimenti, analizzare i problemi cruciali della
storia contemporanea d’Italia e del resto del mondo, al riparo dalle censure, le
manipolazioni, le omissioni, le finalità propagandistiche, i limiti ed i difetti
propri dei normali organi d’informazione, asserviti ai grandi poteri
istituzionali ed economici. Le produzioni che tratteremo e la
controinformazione, in generale, possono essere accusati di “dietrologia” o di
alimentare “teorie complottiste”, ma, alla lunga, qui in Italia, riguardo alle
grandi stragi, ai problemi legati alle grandi opere, agli sprechi miliardari,
alla corruzione, alla connivenza Mafia-Politica, hanno quasi sempre avuto
ragione. Hanno anticipato verità e futuri scenari, o, comunque, hanno
contribuito a suggerirci altre strade di ricerca della verità, oltre a quelle
battute dagli organi d’inchiesta (inclusi media) istituzionali o convenzionali.
Inoltre, la controinformazione ha il merito di dar voce a culture, movimenti,
comunità, aggregati di pensiero e di espressione alternativi al modello
cultural-ideologico dominante che, spesso, per autopreservarsi, è costretto a
nascondere, mistificare, dissimulare. Del resto, strati sempre più ampi della
popolazione e dell’opinione pubblica faticano a identificare i giornali e
l’informazione universale come un “contropotere”. Quando, al contrario, il
ruolo, il mestiere, la vocazione del giornalista dovrebbe essere quella di
controllare il Potere che, per natura, tende a strabordare, a violare quelli che
dovrebbero essere i suoi limiti, che, per autoalimentarsi e riprodursi, tende a
mettere in secondo piano gli interessi della collettività. La controinformazione
è un “fenomeno” che ha origine dagli anni ’60-’70, grazie al lavoro ed alla
militanza di quella che viene battezzata “Sinistra Antagonista”, massima
contestatrice, almeno a quell’epoca, delle basi economiche e culturali su cui si
regge il nostro sistema sociale. Oggi, tante cose sono cambiate, sembra quasi
che la Sinistra sia collassata o preferisca/sia costretta ad essere assente,
sebbene si continui a sostenere che la cultura, l’istruzione, l’intellettualismo
“siano più cose di sinistra”. In verità, è un sentimento diffuso la nostalgia
per la controinformazione ed il giornalismo d’inchiesta di una volta, si lamenta
la perdita (e la mancanza) di intellettuali veri ed onesti e di giornalisti
coraggiosi e liberi. Compito del vero (autentico) giornalista, a servizio non
del suo giornale, ma della comunità e della Verità, dovrebbe esser quello di
richiamare il Potere ai suoi doveri - in ogni settore e in ogni articolazione -,
smascherarlo e denunciarlo se agisce contro il bene comune, se ricorre a trucchi
ed accordi sottobanco per mantenersi intatto. Da un po’ di anni, fortunatamente
(a dispetto di chi promuove campagne contro i movimenti d’opinione diffondibili
sui social-network), ci è venuto in soccorso il Web ed i potentissimi strumenti
che ci offre permettono di addestrarci e prepararci ad una rivoluzione
nell’indagine giornalistica e nel modo di fare informazione, in generale. Nel o
sul web, e quindi ad ogni lato ed angolo del planisfero, i fatti, le notizie, le
foto, le immagini, i video, i grafici, i dati statistici, i commenti, le
opinioni, i giudizi, le descrizioni, le osservazioni, le critiche, le
riflessioni e le denunce circolano ad una rapidità tale che sono molto difficili
da monitorare e quindi da “censurare”. Tanto che, grazie al lavoro e ai
contributi condivisi in rete da qualsiasi area del mondo, si sono sviluppati –
dal basso - network indipendenti di influenza globale come Indymedia.
Estremamente utili, se non fondamentali, per chi cerca ricostruzioni non
veicolate da media o da fonti giornalistiche “di parte”. Per chi vuole bypassare
i network controllati o, almeno, condizionati da poteri economici e politici,
asserviti, anche geneticamente o inconsapevolmente, alla cultura e al pensiero
dominante, lottizzati, limitati ad una “visione occidentale” della realtà o a
una sua visione “economica”-“capitalistica”, escludendo a priori l’ approccio
“umanistico”, snobbisti dei “Sud” del mondo. Per chi è alla ricerca di fatti e
notizie che normalmente sono oscurati o ignorati, per chi è interessato a quelle
azioni, istanze, richieste, proposte e rivendicazioni provenienti da critici e
contestatori dello status quo economico-sociale e dei modelli su cui si fonda,
alle minoranze, ai gruppi sociali discriminati, alle controculture, ai portatori
di valori e di sistemi di pensiero minoritari. Tutte le 7000 case editrici
sparpagliate sul nostro territorio si possono avvalere dei prodigi di Internet,
ossia dell’estrema facilità e velocità con cui si possono ricercare e reperire
analisi, documenti, commenti, interpretazioni, confronti, dibattiti,
approfondimenti, proposte, idee su determinate questioni e problematiche. Tanto
che è sempre più fiorente la produzione di quelli che vengono chiamati “Istant
Book” su problemi, vicende politiche e giudiziarie, catastrofi, tragedie,
delitti e fatti criminosi di particolare gravità ancora all’ordine del giorno.
Certo, nel catalogo di quasi tutte le case editrici, anche di colossi come
Arnoldo Mondadori per intenderci, si ritrovano opere che - per come solitamente
viene intesa rispetto ai criteri che abbiamo descritto sinora - si possono
definire di “controinformazione” o che, in diversa maniera e misura, non
risparmiano critiche feroci o sbattono in faccia verità scomode ai poteri forti
e/o ai “padroni del mondo”. Tuttavia, in quello stesso catalogo se ne possono
trovare, contemporaneamente, tante altre (di opere) che sostengono questi poteri
o esaltano idee e tesi a loro favorevoli. Nell’elenco che fra qualche riga vi
presenteremo, abbiamo voluto visibilizzare, invece, quelle realtà che,
sfruttando lo strumento-libro, sono nate per/ si pongono l’obiettivo di
sostenere e diffondere una visione, un’interpretazione, una lettura alternativa
della società, del presente e del passato, dei fatti, degli avvenimenti, dei
problemi più complessi. “Alternativa” che si può tradurre in: contropotere,
controculturale, antistituzionale, anticapitalistica e antimperialistica,
antilobby, nonviolenta, fuori dal pensiero dominante, umanistica, improntata
alla centralità assoluta dei diritti umani, al dialogo ed alla solidarietà fra i
popoli, alla ricerca della verità oltre le rappresentazioni ufficiali,
all’incontro con la “diversità”, che non si fida dei media convenzionali –
solitamente di proprietà di rilevanti gruppi economici -, che non si fida delle
promesse e degli appelli dei politici e della politica, di chi ci governa, che è
per il rispetto dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile. Certo, come
ammonisce il giornalista-attivista Paolo Barnard, bisogna stare attenti a
identificare alcuni scrittori, giornalisti, giornali ed editori come degli “Eroi
Anti-Sistema”. Altrimenti si rischia di prendere per “oro colato” tutto quello
che dicono, quando, invece, anche nei confronti di chi ci appare “amico” o
“fidato” occorre mantenere costantemente una distanza critica. Alla lunga, in
tanti si possono rilevare dei finti eroi, interessati esclusivamente a crearsi
un determinato tipo di pubblico a cui destinare in vendita i propri “prodotti” e
nulla più. Qui di seguito troverete quasi 300 schede di case editrici più o meno
conosciute; alcune, in verità, sono completamente nuove al grande pubblico e
possono risultare delle “semplici” associazioni culturali. Ciò significa che
hanno bisogno ancor di più di questa “vetrina”…In ogni scheda proposta viene
sintetizzata la biografia e l’ “identità” della casa editrice, ma, soprattutto,
sono recensite alcune sue pubblicazioni, diciamo, “rappresentative” o che siamo
riusciti ad analizzare. Considerando anche il grado di collaborazione delle case
editrici interpellate, possono essere presentati uno o più titoli per ogni
scheda. In universo così magmatico come quello dell’editoria italiana, in cui
navigano oltre 7000 editori, ammettiamo di aver potuto perdere la bussola,
qualche volta: pertanto, ci scusiamo, fin da ora, con chi abbiamo dimenticato o
“non recuperato”. Siamo pronti ad essere redarguiti ed, eventualmente, a
“riparare” in qualche modo, rivisitando e “ristrutturando” periodicamente il
dossier. Ma, insomma, avendo a disposizione gli spazi offertici da Affari
Italiani, ci sembrava doveroso contribuire alla riaffermazione degli attori,
delle agenzie, dei laboratori e delle correnti culturali impegnati nella
contro-informazione e offrire un minimo di visibilità a quei marchi che,
soffocati e stritolati nel mercato editoriale da grandi colossi quali Mondadori,
Rizzoli o Feltrinelli, meriterebbero più considerazione per le storie e le
Verità che ci propongono.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI
STAVA PEGGIO.
Si stava meglio quando si
stava peggio? Italia, declino inevitabile: dove andremo a finire?
A leggere i giornali od a
seguire i Tele Giornali o i talk show in tv cerco di carpire qualche notizia che
parli di me: di me cittadino. Cerco qualcuno che parli dei miei problemi.
La pagina politica parla delle
solite promesse, dei soliti sprechi e dei soliti privilegi.
La pagina della giustizia
parla dei soliti morti, dei soliti arresti e delle solite condanne, oltre che
della solita mafia: una rassegna dei successi di magistrati e forze dell’ordine,
insomma.
La pagina degli esteri parla
delle solite guerre e dei soliti cattivi da eliminare.
La pagina finanziaria parla di
default, tasse e soldi per lo Stato che non bastano mai e della ovvia evasione
fiscale dei soliti ricchi.
Per lo spettacolo e lo sport
la solita rassegna di pettegolezzi di star e starlette senza arte né parte.
A parer dei media sembra che
la vita scorra monotona lungo questi binari, salvo qualche problema che, però, a
parer dei lettori e telespettatori, appare colpire solo gli altri.
Ma non è così. A spulciare
nelle notizie, c’è tutta una quotidianità di cui nessuno parla: la lotta alla
sopravvivenza delle famiglie italiane nella assoluta solitudine e nel generale
sottaciuto abbandono.
Chi ha qualche anno di vita,
(chi troppi, chi pochi) ricorda che:
prima il potere era del
popolo: oggi non più, il potere è delle mafie, delle caste, delle lobbies e
delle massonerie deviate;
prima c’era meno illegalità,
meno obblighi, meno sanzioni e c’erano meno leggi da rispettare, specie quelle a
carattere emergenziale: oggi anche un giurista insigne pecca di ignoranza
giuridica;
prima nel nome della legalità
c’era meno illegalità ed iniquità: oggi l’ingiustizia abbonda e gli abusi di
potere strabordano;
prima c’era più rispetto e
credibilità negli anziani, nei magistrati e nelle istituzioni: oggi non ci sono
più esempi degni da seguire e non abbiamo stima nemmeno per noi stessi;
prima pur con tangentopoli,
c’era meno ladrocinio e le mafie non avevano invaso l’Italia: oggi la corruzione
e l’abuso di potere è la normalità e la mafia è dappertutto;
prima l’usuraio era l’amico:
oggi non più, usuraio è lo Stato o le banche;
prima si pagava un decimo di
tributi rispetto ad oggi e si otteneva 10 volte tanto in termini di servizi;
prima nella disgrazia potevi
parlare con il politico che votavi ed il minimo che succedeva era che ti
ascoltava ed il favore lecito, spesso, ci scappava: oggi non è più così, perché
i politici sono tutti degli emeriti sconosciuti e se ti rapporti con loro
disattendono il loro mandato;
prima nell’errore speravi
nella coscienza delle istituzioni e tutto si aggiustava secondo equità: oggi non
è più così, perché più che il principiò di legalità vale l’interesse estremo a
punire, per salvaguardia finanziaria del proprio status di sanzionatore;
prima c’era più Empatia, ci si
metteva nei panni dell’altro, si condividevano sentimenti, emozioni e
sofferenze: oggi non più, c’è più Dispatia, ovvero l'incapacità o il rifiuto di
condividere i sentimenti o le sofferenze altrui, ovvero c’è più Alessitimia,
ossia il disturbo specifico nelle funzioni affettive e simboliche che spesso
rende sterile e incolore lo stile comunicativo delle persone;
prima nell’avversità c’era
qualcuno che pubblicamente denunciava sui giornali la tua questione: oggi la
notizia è omologata nella censura e se, al contrario, è resa pubblica, lo
scandalo non produce effetti;
prima nell’avversità c’era una
famiglia, spesso numerosa e con genitori pensionati, che ti sosteneva: oggi
siamo soli nell’indifferenza, nell’indisponenza, nell’insofferenza e gli anziani
non hanno più figli al capezzale ma solo badanti straniere;
prima si era più ricchi di
affetti e di beni materiali: oggi amici non ne hai ed i parenti meglio non
averli e se hai un bene materiale te lo toglie la criminalità o lo Stato;
prima nel bisogno il lavoro
era tutelato e comunque si trovava, anche negli uffici di collocamento, o
addirittura anche a nero o sottopagato: oggi non più assolutamente, nonostante i
centri per l’impiego e le agenzie interinali;
prima a veder un clandestino
era un’eccezione, oggi è la regola;
prima gli unici ad essere
discriminati erano i meridionali: oggi si discrimina tutto e tutti e si uccide
per questo (religione, razza, sesso, ideologia politica, tifo sportivo, gusti
sessuali, ecc.);
prima si era più sinceri e
diretti: oggi si è politicamente corretti, perbenisti e buonisti, ossia più
demagoghi, utopistici, falsi e bugiardi;
prima nell’intraprendenza
l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, nonostante i disastri meteorologici,
erano attività in cui si riusciva ad andare avanti: oggi le campagne sono
abbandonate, troppi, cavilli, oneri e spese;
prima nel rischio le imprese,
grandi o piccole, riuscivano a produrre reddito: oggi non più, perché sono
vessate dallo Stato da controlli, oneri, cavilli e balzelli e tributi e comunque
da questo Stato non tutelate dalla competitività estera, o taglieggiate dalla
criminalità, o sequestrate e portate al fallimento dallo stesso Stato perché
accusate di essere colluse con la criminalità, o, seppur operanti da decenni,
chiuse ora perché inquinanti;
prima le professioni si
potevano esercitare: oggi non più, perché hanno chiuso gli ospedali ed i
tribunali ed impediscono di esercitare. Prendiamo per esempio la professione di
avvocato. Hanno chiuso moltissimi tribunali. Hanno impedito la tutela legale per
i sinistri stradali e le sanzioni amministrative. Settori utili per i neo
professionisti. Non sono certo, però, diminuite, come promesso, le polizze
assicurative. Hanno eliminato di fatto il gratuito patrocinio, con condanne
inevitabili per gli indigenti, ed in generale il ricorso all’autorità
giudiziaria, con il contributo unico unificato elevato. Tra Giudici onorari di
Tribunale, Giudici di Pace, Conciliazione obbligatoria e Negoziazione assistita
hanno eliminato quasi tutto il lavoro dei magistrati togati, impegnati come sono
a fare esclusivamente politica, ma la lentezza della giustizia è rimasta. Hanno
imposto ai giovani avvocati in tempo di crisi l’iscrizione alla Cassa Forense ed
imposto in tempo di vacche magre l’esercizio della professione legale in maniera
continuativa e prevalente. Ecco i punti fissati dal Governo:
a) la titolarità di una
partita Iva;
b) l’uso di locali e di almeno
un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale,
anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale,
associazione di studio con altri colleghi);
c) la trattazione di almeno 5
affari per ogni anno dei 3 presi in considerazione, anche se l’incarico è stato
inizialmente conferito ad altro legale;
d) la titolarità di un
indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;
e) l’avere assolto l’obbligo
di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;
f)la stipula di una polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio
della professione;
g)la corresponsione dei
contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;
h) il pagamento delle quote
alla Cassa di previdenza forense.
Sig. direttore, lei, meglio di
me, sa che prima si poteva criticare e protestare: oggi non più perché abbiamo
un bavaglio. Tra la legge sulla privacy e lo spauracchio delle norme penali
sulla diffamazione tutto ciò è impedito.
Oggi non puoi nemmeno
recriminare con una imprecazione: “Italia di Merda” perchè segue una condanna
certa.
Allora… si stava meglio quando
si stava peggio? E dove andremo a finire? E comunque, per gli italiani perché
non vale la teoria sull’evoluzione migliorativa naturale della specie?
Europa, i napoletani
guadagnano meno dei polacchi. E in altre zone d'Italia non va meglio.
Secondo i dati più recenti dell'istituto di statistica europeo il reddito medio
in provincia di Napoli è ormai inferiore a quello medio della Polonia. Nei primi
si ferma a 16.100 euro l'anno, mentre per i secondi è più alto di 300 euro,
scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. Se un amico di Napoli vi confida che
vuole emigrare in Polonia, non chiedetegli se è diventato matto: per come vanno
le cose l'idea potrebbe quasi avere senso. Secondo i dati dell' Istituto di
statistica europeo , aggiornati al 2011, il reddito medio dei napoletani è ormai
inferiore a quello dei polacchi. Nei primi si ferma a 16.100 euro l'anno, mentre
per i secondi è più alto di 300 euro. L'area d'Europa con il PIL più alto è
invece la parte occidentale di Londra, cuore finanziario della Gran Bretagna,
dove la media supera i 150mila euro. Ma in Italia c'è chi è messo ancora peggio.
Nella provincia di Medio Campidano, in Sardegna, il reddito è di 11.200 euro
l'anno: poco meno che in Bulgaria. Seguono Caserta e Agrigento, intorno ai
13mila e qualche centinaio di euro in più rispetto a un abitante medio della
Romania. Resta forte la divisione nord-sud, anche se in quest'ultimo spicca la
provincia di Catanzaro che supera i 20mila euro l'anno – fatto praticamente
unico nel meridione –, mentre al centro si distingue Rieti; chi vi abita ha in
media un reddito più basso di quello dei vicini. Roma è un caso a parte. Essere
il centro della burocrazia italiana, con il relativo carico di retribuzioni
elevate, non può che portare a risultati maggiori: un elemento che in qualche
misura sposta i redditi – ma non per forza quanto poi si produce davvero – verso
l'alto. Al nord invece i milanesi hanno un reddito medio di 45.600 euro, quasi
il doppio della media europea. Un valore senz'altro elevato, ma forse neppure
troppo per quello che dovrebbe essere il centro della borghesia produttiva
italiana. Senza neppure arrivare a Londra, in cui i tanti stranieri della City
finanziaria renderebbero il confronto poco sensato, basta andare in Francia o in
Germania – a Monaco, Parigi o Bonn – per trovare diverse aree in cui il reddito
si aggira o supera i 60-70mila euro a persona. I dati non considerano solo
quanto le persone producono, ma tengono in conto anche il diverso costo della
vita. Affitti più alti e beni più economici, servizi a buon mercato o meno:
tutti fattori che nella vita concreta contano almeno quanto lo stipendio che
riceviamo. Si tratta del modo più accurato per capire qual è il reale tenore di
vita delle persone in un regione piuttosto che in un'altra. Come succede di
consueto quando si calcola il PIL, è inclusa anche una stima (più o meno
accurata) dell'evasione fiscale. Eppure basta tornare qualche anno indietro per
capire come i problemi italiani siano tutt'altro che nuovi. La crisi non ha
fatto che pesare su un sistema già affaticato – in alcune zone più che in altre.
Basilicata, Puglia e Calabria, per esempio, già prima della recessione del 2008
crescevano poco – meno dell'1% l'anno. Emilia Romagna, Marche e Lazio avevano
invece un ritmo più elevato, intorno al 2%. Il motore pare inceppato da tempo:
già intorno al 2002-2003 in diverse regioni il reddito ha fatto un salto
indietro, per poi calare a picco dal 2008. In Molise la recessione ha fatto più
danni: fino al 2011 l'economia è decresciuta in media del 2,9% l'anno; meno in
Campania, con una caduta dell'1,8%. Seguono Calabria (-1,7%), Sicilia e
Basilicata (-1,6%). Quando gli altri cadono – magra consolazione – anche restare
fermi è un segnale positivo. È il caso di Lombardia e provincia di Bolzano, dove
invece le cose sono rimaste stabili oppure la diminuzione è stata minima.
Guardando a come vanno le cose provincia per provincia abbiamo un quadro più
dettagliato, ma anche meno recente – per il momento i dati arrivano solo al
2011. Che napoletani e siciliani abbiano recuperato qualcosa, nel frattempo?
L'unico modo per farsi un'idea è guardare a come sono andati i paesi nel loro
complesso. Anche così, però, l'Italia resta quella che fa peggio. Non solo
l'economia non recupera quanto aveva perso dall'inizio della recessione, ma
continua a cadere ancora. Nel 2012 e 2013 la crescita media è stata molto
negativa: la Spagna arretra ma meno, Francia e Germania crescono – molto poco –
mentre nel Regno Unito va abbastanza meglio. Nulla di impressionante, certo,
eppure nel regno dei ciechi l'orbo è re. Dunque è ancora vero che i napoletani
guadagnano meno dei polacchi? Una cosa è certa: negli ultimi due anni questi
ultimi sono andati avanti, mentre l'Italia è tornata ancora più indietro. Non
solo il divario potrebbe essere rimasto, ma ci sono buone ragioni per pensare
che sia aumentato. Chi più in fretta, chi trascinando i piedi, resta il fatto
che diversi paesi stanno cominciando a uscire dalla crisi. Molti, ma non
l'Italia. Chissà che l'amico napoletano non abbia tutti i torti.
Disoccupazione, i numeri
fanno paura. Quella verità nascosta nelle statistiche.
Fermarsi a leggere solo il
dato generale di chi non ha un lavoro è un errore: i numeri in nostro possesso
mostrano fenomeni meno noti, che interessano soprattutto donne e giovani.
Mentre il titolo di studio sembra ancora l'unico antidoto al rimanere senza
impiego. Naviga i nostri grafici interattivi, scrive Davide Mancino su
“L’Espresso”. Una manifestazione del 2011 contro la disoccupazione giovanile
Quando si parla di disoccupazione la cosa più semplice è elencare il solito
numero - i soliti due numeri - e fermarsi lì. Sono quelli che sono stati
ripetuti negli ultimi giorni: il tasso di disoccupazione generale è al 12,6 per
cento, quello dei giovani fra 15 e 24 anni è al 43,3 per cento. Al crescere
dell'età le cose migliorano, certo, ma restano tutt'altro che confortanti.
Eppure la realtà è più complicata, e se si scava più a fondo nelle statistiche
il quadro diventa forse ancora più buio: sicuramente più sfaccettato. Eurostat e
Istat raccolgono informazioni sul lavoro anche a livello regionale, aggiornate
al 2013; e sono dati che mostrano l'enorme differenza che esiste non solo fra
paesi europei, ma anche all'interno degli stessi. Eppure, nel fare confronti fra
paesi, i dati vanno guardati con prudenza. Il tasso di disoccupazione indica
infatti quante sono le persone senza lavoro, ma solo fra quelle che un lavoro lo
stanno cercando. Più di tre milioni, secondo le ultime stime: certo non un
italiano su dieci o un giovane su due, come si sente dire ogni volta, ma
comunque troppo. Il paragone naturale è con i vicini spagnoli. Ma proprio in
Spagna, che nella mappa della disoccupazione risalta come una grande macchia
rossa, secondo la Banca Mondiale la partecipazione al mercato del lavoro è più
alta - in particolare per le donne e nelle aree più povere. In questi gruppi,
ovvero, sono molti coloro che dichiarano di essere alla ricerca di un impiego.
In Italia vale l'opposto: sono meno le persone che risultano alla ricerca di un
lavoro e questo spinge il dato della disoccupazione verso il basso. D'altra
parte in Italia e Spagna il numero di persone effettivamente occupate, rispetto
al totale della popolazione, è più o meno lo stesso. Dunque la differenza, tutto
sommato, è molto minore di quello che sembra. Non è il solo caso. In generale,
prima di fare paragoni, bisogna fare attenzione a quei paesi in cui, per
esempio, donne e giovani tendono a partecipare di più al mercato del lavoro. È
il caso di Germania, Francia e - appunto - della stessa Spagna. Questo però non
vuol dire che la situazione sia grave ovunque allo stesso modo; al contrario.
Proprio in Italia considerare solo il tasso di disoccupazione generale nasconde
le situazioni più diverse: soprattutto in alcune province, soprattutto per i
giovani - e ancora di più per le donne. Tutti casi in cui la realtà è molto più
difficile di quello che sembra. Prendiamo tre persone diverse: Luca, 40 anni, di
Milano; Giulia, una trentenne romana; Sofia, appena diplomata a Napoli. Il primo
è riuscito a trovare lavoro, e come lui diversi amici e amiche: a Milano essere
uomo o donna non fa grande differenza. Giulia salta da un breve impiego
all'altro, ma con la crisi le cose sono diventate più complicate. Trovare un
nuovo lavoro è difficile, e non solo per lei: a Roma succede lo stesso a una
donna su sei nelle sue condizioni. Sofia invece vorrebbe cominciare a lavorare
subito dopo aver finito la scuola, ma non può. A Napoli per andare avanti ci
vuole fortuna e bravura - o entrambe - quando tre ragazze su cinque come lei,
pur cercandolo, un lavoro non lo trovano. Altrimenti la soluzione è la solita:
emigrare. Anche qui però bisogna fare attenzione: fra i 15 e i 24 anni molti
ragazzi studiano ancora, quindi non cercano lavoro né sono - tecnicamente -
disoccupati. Un gruppo che rientra nella categoria degli “inattivi”, come li
chiama l'Istat, composto da poco meno di quattro milioni e mezzo di persone. Il
problema vero riguarda invece 685mila giovani di quell'età che, usciti da
scuola, un lavoro lo vorrebbero ma non ce l'hanno. I dati smentiscono anche un
altro luogo comune: che studiare non serve. Di nuovo, è vero l'opposto. Le
persone con titoli di studio più elevati sono quelle meno esposte alle
disoccupazione, e questo vale sia per gli uomini che per le donne. Una
differenza che - soprattutto al sud - è enorme: le laureate calabresi, per
esempio, hanno un tasso di disoccupazione di 8 punti percentuali più basso delle
diplomate, mentre le campane arrivano a 10. Per gli uomini è lo stesso, basta
guardare la differenza fra laureati e diplomati siciliani: fra questi ultimi, ai
tempi della crisi, il tasso di disoccupazione è doppio. Altro che perdita di
tempo: uno degli antidoti alla crisi, se mai ce ne fosse uno, sembra proprio lo
studio.
CONCORSI ED ESAMI. LE
PROVE. TRUCCO CON I TEST; TRUCCO CON GLI ELABORATI.
Le Prove. La Prova scritta.
La prova scritta è in genere
un tema o una griglia di test a risposta sintetica o una prova pratica.
Solitamente è svolta in 1 o più giornate differenti su materie differenti, e può
essere indifferentemente un giorno un tema ed il successivo una prova pratica, o
una prova a risposta sintetica ed un tema ecc. ecc. Come nella prova
preselettiva al candidato vengono consegnate due buste, una con il materiale
d’esame e l’altra con il cartoncino su cui indicare il proprio nome, cognome e
data di nascita. Lo scritto va fatto – brutta e bella – utilizzando
esclusivamente i fogli messi a disposizione, che poi il candidato inserirà nella
busta grande insieme alla busta piccola (chiusa) contenente il cartoncino con le
generalità. Il bando dà indicazioni sui testi che è possibile portare con sé –
normalmente il dizionario di italiano ed i codici senza commenti se la prova è
di tipo giuridico. Attenzione, all’ingresso i testi possono venire aperti per un
controllo e, se non rispondono per qualche ragione a quanto previsto, non
vengono fatti entrare. Eliminate perciò fogli di appunti, temi, schemi
ecc…Evitate per quanto possibile di portare fotocopie, che possono subire la
stessa sorte. Se sono proprio necessarie, portatele ben rilegate. Tenete conto
che le operazioni di controllo all’ingresso possono durare a lungo, specialmente
nei concorsi con grande affluenza. E’ quindi molto frequente che dall’orario di
convocazione – in genere le 9 del mattino – all’ora in cui ha effettivamente
inizio la prova, possono passare 2,3,4 ore. Se aggiungete a queste le ore di
durata effettiva della prova, capite quanto può essere importante avere con sé
qualcosa da mangiare e da bere. Solitamente non è possibile alzarsi per le prime
due ore.
Domande a risposta
sintetica.
Si tratta di un numero limitato di domande (di solito non più di sei) che hanno,
oltre alla classica opzione della risposta multipla, anche alcune righe per la
risposta sintetica. E’ un tipo di prova molto comune soprattutto sulle materie
giuridiche ed è un tipo di scritto abbastanza ostico. Scrivere di diritto non è
facile, essere sintetici ancora meno. Il testo scritto deve essere breve (tra le
dieci e le venti righe), coinciso e il più possibile chiaro. Non deve
semplicemente ripetere con altri termini la risposta già scelta tra le riposte
fornite dal test, ma deve aggiungere qualcosa: la motivazione della risposta già
data, il contesto, casi specifici ed eccezioni, ecc. Nell’allenarsi alla prova a
risposte sintetiche, è sconsigliabile tentare di imparare quelle contenute nei
testi di preparazione: quasi sempre niente ritorna alla memoria al momento
opportuno, mentre è utilissimo allenarsi a scrivere testi brevi, utilizzando
qualunque tipo di domanda a risposta multipla.
Prova pratica.
E’ una prova pratica quella ispirata alla verifica delle reali capacità
operative del candidato nel ruolo specifico che gli verrà affidato. Essendo
diversa da mansione a mansione è quindi qui impossibile estrapolare degli esempi
(la sua applicazione va dalla multa al caso clinico). Di solito quando un
concorso prevede una prova di questo tipo, le editrici specializzate inseriscono
uno schema all’interno dei testi di preparazione. Il suggerimento anche qui è di
utilizzare il buon senso: la prova serve a verificare quanto il candidato riesca
effettivamente ad utilizzare nella pratica le nozioni che ha acquisito, quindi
va benissimo imparare schemi (moduli, procedure ecc), ma questi vanno utilizzati
tenendo in debito conto del quesito proposto (che come sempre va letto molto
attentamente) ed anche della nozioni teoriche sottese (implicate).
Tema.
Il tema è una composizione scritta abbastanza lunga ed articolata – circa 3/5
facciate di foglio protocollo - ampiamente utilizzata nelle prove di concorso.
Nei concorsi per diplomati, è più spesso di cultura generale, storia, italiano;
si tratta quindi di uno scritto del tipo di quelli che si fanno alle scuole
superiori. In questo caso quello che conta è che l’elaborato sia in italiano
corretto e che sia chiaro e non contenga informazioni errate. Se invece il tema
è di argomento giuridico la faccenda cambia. Il tema di diritto mette in
difficoltà un po’ tutti, chi è laureato in materie giuridiche infatti è
raramente abituato a scrivere, chi ha fatto altri percorsi di studio teme di non
saper utilizzare adeguatamente il linguaggio giuridico. In tutti i casi, non c’è
da perdersi d’animo: ci si riabitua a scrivere semplicemente allenandosi. Certo,
specialmente chi non ha un background giuridico fa bene a seguire dei corsi, per
affinare la terminologia in modo da non incorrere in errori concettuali gravi.
Se chiarezza e completezza sono le carte vincenti, non vanno dimenticate la
calligrafia – che deve essere il più possibile leggibile, e la lunghezza totale,
che non deve essere eccessiva.
Diario di un commissario del
concorso per magistrato: i trucchi per copiare, dal bagno alla nursery, scrive
Lionello Mancini su “Il Sole 24ore”. Nelle ore immediatamente successive alla
prova scritta per un posto da magistrato, uno dei 29 commissari, ha voluto
riassumere in quattro paginette di appunti la sua esperienza al padiglione
fieristico di Rho-Pero e aggiungere alcuni suggerimenti per rendere meno
macchinosa, più corretta e trasparente la selezione dei togati. Ecco alcuni
passi degli appunti del commissario, una probabile traccia per l'audizione
davanti alla IX commissione del Csm. Durante i tre giorni delle prove scritte, a
seguito di violazioni delle regole concorsuali, la commissione ha deciso diverse
espulsioni, pare 70, anche se non conosco il numero esatto. Io stesso ho espulso
un buon numero di candidati in poche ore. La maggior parte delle irregolarità
consisteva nella detenzione di testi non consentiti. Ho sentito dire da più
parti che con ogni evidenza il controllo dei codici non ha funzionato. Ma è
proprio così? Per non drammatizzare inutilmente, basterebbe un semplice
conteggio: ogni concorrente si presenta alla prova scritta con almeno 5 "pezzi"
tra codici, raccolte di leggi, stampe da Internet ecc. Moltiplicando questa
cifra (ottimistica) per 5.600 partecipanti, risulta che noi commissari abbiamo
controllato non meno di 28mila testi. Se solo 2 su 1.000 sono sfuggiti al
controllo – frazione senz'altro fisiologica se non virtuosa – possiamo
concludere che una sessantina di casi sono apparentemente tanti, ma sono invece
relativamente pochi. Esistono molte edizioni dei codici, quasi tutte volutamente
ai limiti dell'ammissibilità e spesso con tanto di scritta in copertina che
rassicura l'acquirente sul fatto che potrà usarlo durante la prova scritta. Ed è
così: l'irregolarità non è per niente scontata e dipende dall'interpretazione
della norma che esclude i testi con "note, commenti, annotazioni anche a mano".
E allora perché tante edizioni border line? Alcuni di questi tomi sfruttano
l'indice analitico che arriva così a occupare centinaia di pagine ed è talmente
strutturato da poter fungere da tracce di elaborati; altri volumi recano
abbondanza di richiami che non possono essere vietati perché riportati da tutte
le edizioni, "Gazzetta Ufficiale" compresa. I candidati sono suddivisi per
lettera in tante file e consegnano i testi ad altrettanti desk con un
commissario che decide i casi dubbi. È ovvio che per evitare disparità di
giudizi che finiscano in difformità sui criteri di sequestro, la soglia di
ammissibilità è tenuta bassa. Anche perché, spesso si tratta di codici costosi,
non pacificamente inammissibili, magari curati da colleghi magistrati, spesso
recanti scritte rassicuranti e persino timbri di concorsi precedenti.
Soprattutto, sequestrare i codici a Rho-Pero in prossimità della prova,
significa di fatto lasciare il candidato senza testi da consultare perché, data
la distanza dalla città, non è possibile andare in una libreria a Milano e
tornare in tempo per l'esame. Oltre alle edizioni border line, è sempre più
frequente che i candidati si presentino con pacchi di stampe dal computer:
formati ammissibili, ma di difficile controllo. Ci sono poi i testi annotati a
mano, non vietati automaticamente ma da valutare nel loro contenuto. Ci sono
candidati disposti, per evitare il sequestro, a strappare o sigillare le parti
vietate e rendere così utilizzabile un codice (sulla cui copertina resterà
comunque scritto "commentato", cioè di fatto vietato). E va considerato che la
legge di fatto incoraggia i tentativi di introdurre materiale illegale perché in
sede di controllo pre-esame consente solo l'esclusione del testo e non anche del
candidato: insomma, abbiamo dovuto vedere in aula candidati che il giorno prima
avevano cercato di introdurre un vocabolario di italiano farcito con temi di
diritto. È stato escluso il tomo, ma non il suo detentore. A parte i
difficoltosi controlli dei giorni precedenti, anche il giorno della prova il
materiale irregolare entra facilmente: la polizia penitenziaria esegue una
perquisizione "leggera" all'ingresso, ma le piccole fotocopie nascoste sotto gli
abiti ovviamente passano. I servizi igienici sono usati sia per scambiarsi
parole veloci durante le code per entrare, sia per passare il materiale da una
inaccessibile fodera a una comoda tasca. Da qui il divieto di andare al bagno
prima di una certa ora, cui vengono opposte continue affermazioni di gravi
problemi fisici, difficili da contestare in assenza di un commissario-medico.
Ecco il motivo delle numerose deroghe al divieto, pur accompagnate da
precauzioni aggiuntive come le perquisizioni prima e dopo, a meno che il
candidato non accetti di lasciare la porta del bagno aperta, vigilato da un
agente dello stesso sesso. Altro luogo "tentatore" è la nursery cui hanno
diritto le candidate con infante da allattare. Ovviamente il bimbo è accudito da
un parente, magari adatto a consultazioni o che si presta a "importare"
materiale proibito.
Questo succede durante le
prove scritte. Nessuno sa quello che succede dopo. La verità si scopre
attraverso i ricorsi al Tar.
LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI.
Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed
eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di
tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la
commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura della busta grande
contenente gli elaborati;
• lettura del tema da parte
del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione degli errori di
ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di chiarimenti,
valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente evidenzino
un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e
dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il profilo più
strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle problematiche
giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto approccio a
problematiche complesse;
• consultazione collettiva,
interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio numerico complessivo,
motivazione, sottoscrizione;
• apertura della busta piccola
contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati corretti;
• redazione del verbale.
Queste sono solo fandonie
normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il nome, se è un
prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno leggerli.
Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei stabilito
illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei diventati
tali “a fortuna”.
La riforma del 2003 ha
cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in
qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso
altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato
del proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od
osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame sono mancanti delle componenti
necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Le Commissioni
d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari.
Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni abbiamo messo in relazione
l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un indice di frequenza del
cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni avvocato abbiamo calcolato
la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il rapporto tra quante volte quel
cognome vi appare sul totale degli iscritti, in relazione alla frequenza dello
stesso cognome nella popolazione. In media, il cognome di un avvocato appare
nell’albo 50 volte di più che nella popolazione. Chi ha un cognome
sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa avvocato prima. Infine
vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero aperto, hanno tutto
l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la concorrenza: a detta
dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono persone che hanno tutto
da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e più competenti».
Paola Severino incoraggia gli
studenti e racconta: “Anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per
diventare avvocato”. Raccontare una propria disavventura per infondere coraggio
alle nuove generazioni. Questa è la tecnica adottata dal Ministro della
Giustizia Paola Severino con i ragazzi della «Summer School» promossa dalla
Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri. “Cari
ragazzi, non dovete scoraggiarvi perché anch’io la prima volta fui bocciata
all’esame per diventare avvocato… Quella volta ero con il mio futuro marito: lui
fu promosso e io non ce la feci… Ma eccoci ancora qua. Siamo sposati da tanti
anni” ha raccontato di fronte ai futuri avvocati puntando tutto sulla love story
e omettendo che, nonostante quella bocciatura, sarà titolare fino a novembre di
uno degli studi legali più importanti d’Italia (con cifre che si aggirano
intorno ai 7 milioni di euro). Una piccola consolazione non solo per i laureati
in legge, ma anche per tutte le future matricole che sosterranno i test di
ammissione. In fondo anche Albert Einstein venne bocciato. E a quanto pare anche
la Severino. Bisognerebbe, però, chiedere al ministro: gli amorosi l’aiuto se lo
son dato vicendevolmente ed i compiti sicuramente erano simili, quindi perché un
diverso giudizio?
In quei mesi di tormenti a
cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova dunque a
scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”: «La mia
famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio
padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare
l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione
era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri
pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri,
nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto
demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a
Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano
incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese
c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che
nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad
Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il
23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo
quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era
forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo
deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi
agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia.
Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Quello per giudici e pm resta
uno dei concorsi più duri. Dopo la laurea occorrono oltre due anni di
preparazione negli studi forensi. Oppure nelle scuole universitarie di
specializzazione per le professioni legali. Sui 3.193 candidati che nel novembre
2008 hanno consegnato i tre scritti di diritto amministrativo, penale e civile,
la commissione ha mandato agli orali soltanto 309 aspiranti magistrati. Per poi
promuoverne 253. Nonostante i quasi due anni di prove e correzioni e i soldi
spesi, il ministero non è nemmeno riuscito a selezionare i 500 magistrati
previsti dal concorso. E tanto attesi negli uffici giudiziari di tutta Italia.
Se questi sono i risultati dei corsi di formazione post-laurea, il fallimento
degli obiettivi è totale. Eppure almeno cinque tra i 28 commissari sono stati
scelti dal ministro Alfano proprio tra quanti hanno insegnato nelle scuole di
specializzazione per le professioni legali. "I componenti della commissione
rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso", dice
l'avvocato Anna Sammassimo, dell'Unione giuristi cattolici: "Ma alla lettura
degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i
curricula dei candidati esclusi destano ammirazione. Dal verbale da me
visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun
candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre
temi di tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra
obiettivamente un po' poco". Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano
Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il
concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in
base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3
minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta
chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno
dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad
ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della
commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame
divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane
Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione
forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1
agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura,
dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata
fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti
degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei
commissari con abuso del pubblico ufficio.
Di scandali per i compiti non
corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.
Nel 2008 un consigliere del
Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga
di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove,
scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine.
"Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno
letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto
che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i
concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto
stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il
magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non
aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. L'esposto viene palleggiato
da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la presidenza del Consiglio dei
ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità" serpeggiano anche tra alcuni
consiglieri. "Il bando sembra introdurre l'ulteriore requisito dell'anzianità
quinquennale" ha messo a verbale uno di loro durante una sessione dell'organo di
presidenza: "Giovagnoli era stato dirigente presso la Corte dei conti per circa
6 mesi (...) Il bando non sembra rispettato su questo punto". Per legge, a
decidere se i concorsi siano stati o meno taroccati, saranno gli stessi membri
del Consiglio. Vedremo.
In effetti, con migliaia di
ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono inaffidabili. La carenza,
ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in
contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli
elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque la
infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la
corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta
discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione
degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio
composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza. Dai Verbali
si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione, quando il
Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per leggere
l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido il
concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa magistratura,
il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato tutto, alla faccia
degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli orali nonostante errori
da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata
verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed
europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi agli orali. Al
Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di
accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di
ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008,
che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per
manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Riguardo la
magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha
battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992.
Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei
compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della
busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai
esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il
Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria
mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per
gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri,
proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente
del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici
e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo dei giornalisti
professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio
radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta
per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul
file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario esaminatore, aveva
preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere. E ancora lo
scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A
finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del
concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di
comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che
molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro
genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in
cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati
nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di
nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta»,
«Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele
di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le
tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.
GLI ESCLUSI, RIAMMESSI.
Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo
al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si
presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio
Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il
Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino
non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex
procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era
il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari
componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo
fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di
Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli
orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un
falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in
una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima
non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti
per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione
diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani
nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale
gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato
(una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale
episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo
stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali
pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari
attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere
particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella
commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
Medicina, storia del
concorso delle polemiche. "Test copiati, quiz rimossi e compiti modificati".
L'esame per
l'accesso alle scuole di specializzazione dello scorso novembre 2014 doveva
eliminare il problema dei baronati. Ma dopo le polemiche sulle domande
sbagliate, l'Espresso ha visionato il ricorso presentato dai candidati al Tar. E
dentro viene denunciato davvero di tutto, scrive Martino Villosio su
“L’Espresso”. Doveva essere il concorso del merito, della trasparenza, dei
parametri standard di valutazione, immune finalmente da localismi e al riparo
dalle grinfie dei baroni. Tutti i candidati, dal Friuli alla Sicilia, davanti a
un pc, niente carta e penna, un salvataggio a fine prova, un meccanismo di
correzione costruito per essere impermeabile a qualunque ipotetico sospetto di
violazione dell'anonimato. A distanza di tre mesi, invece, la lista completa di
verbali, atti e documenti relativi al primo concorso pubblico per l'accesso alle
specializzazioni di medicina gestito a livello nazionale con graduatoria unica
svela il tracollo di premesse e promesse. Un tradimento che ha già portato tanti
giovani medici ad abbandonare l'Italia, ancor prima di attendere le decisioni
della giustizia amministrativa sommersa dai ricorsi. Punteggi sbagliati, pc in
rete. Sedi non idonee, controlli non omogenei delle singole commissioni, router
nascosti nei cappotti e pc collegati in rete durante le prove in alcuni atenei,
foto che mostrano chiaramente come in certe aule i candidati fossero seduti a
distanza ravvicinata tanto da costringere il Miur a sferzare le commissioni con
una circolare dopo il primo giorno di test. E ancora singole aule in cui tutti i
candidati hanno totalizzato punteggi stellari e perfettamente combacianti,
centinaia di black out e guasti ai computer che hanno consentito ai più
fortunati di veder raddoppiato il tempo a disposizione per rispondere alle
domande, "bachi" nel sistema informatico, punteggi affissi in graduatoria
diversi da quelli visualizzati dai candidati al termine delle prove e ricorretti
in fretta e furia solo grazie all'attenzione e alle proteste degli interessati.
Computer così vicini da permettere di copiare. A suggello di tutto le mani non
meglio identificate di chi, denunciano gli avvocati dei ricorrenti, ha potuto
incredibilmente entrare nelle prove di tutti i candidati modificandole
dall'interno in violazione dello stesso principio che il nuovo concorso era nato
per salvaguardare: proprio quello dell'anonimato. Tutto questo viene oggi ad
aggiungersi a quanto di clamoroso emerse a inizio novembre, a concorso appena
finito: il pasticcio dell'inversione dei quesiti di due differenti aree del test
(quella medica e quella dei servizi clinici) da parte del consorzio Cineca
incaricato di preparare le prove, il ministero dell'Università e della Ricerca
che prima annuncia la scelta di annullare quelle oggetto dell'errore poi, dopo
due giorni, fa marcia indietro e sentito il parere dell'Avvocatura sceglie di
abbonare quattro domande (in seguito diventate sei) a tutti i candidati, dando
loro il massimo punteggio a prescindere dalla maggiore o minore correttezza
delle risposte fornite. Uno scandalo già rimosso. Un caso dai contorni surreali,
l'ultimo pugno nello stomaco di una generazione di aspiranti camici con la
valigia in mano, archiviato dai media e dal dibattito politico con molta più
fretta di quanto ci si sarebbe potuti aspettare nell'Italia che insegue la
svolta all'insegna della gioventù e della meritocrazia. L'Espresso ha potuto
visionare in anteprima questa galleria di irregolarità e superficialità, alla
vigilia dell'udienza del 12 febbraio davanti al Tar del Lazio chiamato a
prendere in esame parte dei ricorsi presentati per l'annullamento delle
graduatorie. Una lista contenuta nella lunga memoria depositata lo scorso 26
gennaio dall'avvocato Michele Bonetti, il legale che tra l'estate e l'autunno
dello scorso anno ha già ottenuto l'ammissione con riserva ai corsi di laurea
delle facoltà di medicina di tutta Italia di 5.000 studenti respinti ai test
d'ingresso e che, insieme al collega Santi Delia, ha curato anche i ricorsi
degli aspiranti specializzandi. Insomma un elenco fornito da una parte con
precisi e concreti interessi nella partita, ma puntellato da un corposo dossier
di carte ufficiali finito all'attenzione della magistratura in sede penale. Aule
inidonee, punteggi stellari. Il primo cardine su cui doveva poggiare il nuovo
concorso, ovvero l'omogeneità della selezione a livello nazionale, ha retto a
stento davanti alle carenze organizzative di alcune aule. L'articolo 2 comma 4
del bando disponeva che almeno 20 giorni prima della prova di esame il Miur
dovesse comunicare sedi e orario di svolgimento. Le aule però sarebbero state
reperite solo qualche giorno prima dei test, non solo nelle università ma anche
in centri di formazione professionale e istituti privati. Come emerge da alcuni
verbali e dalle foto pervenute al sito de "l'Espresso", in alcune di esse i
candidati erano talmente vicini da consentire a tutti di poter leggere
tranquillamente dallo schermo del collega. Un monitor che, a differenza dei
classici fogli A4 contenenti 4 o 5 domande, proiettava a visione intera un solo
quesito alla volta con la relativa risposta del candidato. Più piccole erano le
aule, riporta l'avvocato Bonetti nella sua memoria, più palese è stato il numero
di concorrenti con punteggi identici. Come a Catania, dove nell'aula 10 -
durante l'ultimo giorno di prova - su 12 partecipanti concorrenti per Anestesia,
in 10 hanno avuto l'identico alto punteggio di 17,4 su 20. O a Bari, dove il 31
ottobre durante la prova dell'area dei servizi di fatto non di competenza dei
candidati (perché si scoprirà che le domande erano state invertite con quelle di
area medica) in un'aula 12 candidati su 14 ottengono lo stesso score: di nuovo
17,4 su 20. A Milano i candidati chiedono che sia messo a verbale che i pc sono
troppo vicini e corrono voci di "copiature frequenti e uso di cellulari presso
altre sedi". A Trieste è addirittura la stessa commissione ad alzare bandiera
bianca: "Risulta materialmente impossibile", recita il verbale del 30 ottobre
per l'aula F, "collocare tutti i candidati in modo alternato, si decide di far
prendere posto ai candidati seduti necessariamente vicini nelle posizioni di
massima visibilità". Black out, web libero e bug informatici. Sono centinaia i
casi a verbale di black out energetici in diverse sedi di concorso. In alcune i
candidati, dopo aver letto le domande e addirittura aver terminato la prova,
hanno potuto ripeterla visto che i pc si spegnevano o non rispondevano ai
comandi. Aule intere hanno subito la sospensione dell'energia dopo che erano
state lette le domande della prova. Durante le operazioni di ripristino, a
Chieti, i candidati hanno addirittura potuto riprendere i propri cellulari
collegati in rete. In altre sedi, come risulta a verbale, i pc erano invece
collegati via cavo alla rete LAN o avevano accesso alla rete wi-fi consentendo
la navigazione sul web attraverso router portatili lasciati dai candidati nei
cappotti. Uno di questi casi è documentato a Napoli, presso l'università Suor
Orsola Benincasa. Alla Seconda Università di Napoli, il 31 ottobre, dopo 16
episodi di malfunzionamento dei pc la prova viene interrotta e fatta ripetere ai
candidati. A Ferrara addirittura salta un'intera fila di computer, obbligando
ormai a fine prova a far rifare il test a tutti i candidati della fila.
Tragicomici, poi, alcuni degli episodi segnalati sempre a verbale: come a
Padova, dove durante la prova un candidato - ricontrollando i test - si rende
conto a un certo punto che in alcuni casi le risposte da lui date risultano
modificate. Colpa di un bug informatico che fa sì che il concorrente, anche
semplicemente muovendo il mouse sulla parte bianca dello schermo, intervenga
sull'opzione appena spuntata senza rendersene conto. Un'anomalia denunciata
anche a La Sapienza. Centinaia anche le segnalazioni di aspiranti specializzandi
che hanno trovato un punteggio affisso diverso da quello visualizzato dopo la
prova e regolarmente salvato. Come a Genova, dove lo score di una candidata era
stato prima salvato come 34,1 e poi - il giorno dopo - riverificato essere 33,8.
Se l'interessata non avesse chiesto di eseguire un controllo, essendo convinta
del suo risultato iniziale, l'accaduto non avrebbe mai potuto essere
ricostruito. Pipì nel cestino. Anche nella severità con cui le commissioni hanno
fatto rispettare i regolamenti emergono forti discrepanze. Nonostante il bando
del 4 agosto 2014 specifichi chiaramente che "il Ministero definisce ogni elenco
d'aula avendo cura di distribuire i candidati secondo l'ordine anagrafico", in
alcune sedi è stato concesso agli aspiranti specializzandi di scegliere
liberamente il posto. In un verbale dell'ateneo di Udine viene riferito
candidamente che "ciascun candidato si colloca a sua scelta in una delle
postazioni disponibili". A Palermo la commissione controbatte addirittura a un
candidato che, bando alla mano, chiedeva il rispetto dell'ordine alfabetico.
D'altro canto persino il video esplicativo sulla procedura di accesso alle aule
del Miur, disponibile sul sito , indicava la possibilità di scegliere
liberamente dove sedersi in piena contraddizione con il bando. Il video è stato
poi successivamente modificato a concorso concluso. Il rigore in ordine sparso
delle varie commissioni ha riguardato anche la possibilità di andare in bagno: a
Pisa e Pavia è stato consentito, a Firenze invece un candidato è stato costretto
a urinare nel cestino della carta. Le domande abbonate: nuovi interrogativi. Non
è la prima volta che il consorzio interuniversitario Cineca, incaricato di
somministrare i test nei concorsi, combina errori che impattano su vite e
carriere. Basti pensare al "famoso" concorso del 2012 per l'accesso ai TFA, i
tirocini formativi per l'abilitazione all'insegnamento, nel quale 25 domande su
60 furono annullate. Questa volta l'anomalia è avvenuta nella fase di
preparazione delle buste: le domande che avrebbero dovuto essere sottoposte ai
candidati per le scuole di area medica il 28 ottobre sono state invece
somministrate il 31 ottobre nella prova per l'area dei servizi clinici, e
viceversa. Il primo novembre il Miur annuncia con un comunicato stampa sul sito
che le prove in questione sono da ripetere. Due giorni dopo, al termine di una
riunione tra il ministro Stefania Giannini e la Commissione nazionale incaricata
di validare le domande dei quiz, sempre tramite nota stampa arriva il
contrordine: siccome l'inversione ha riguardato solo le 30 domande comuni a
ciascuna delle due aree, e non i 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di
scuola (cardiologia, necrologia, endocrinologia etc.), l'esito dei test si può
salvare "neutralizzando" le sole due domande per ciascuna area che sono state
giudicate non pertinenti dalla Commissione di esperti. In pratica a tutti i
candidati, a prescindere dalla maggiore o minore correttezza della risposta
fornita, viene assegnato per quelle domande il massimo punteggio. Da quel
momento, e dopo le dimissioni rassegnate dal presidente del Cineca Emilio
Ferrari, si chiude il sipario mediatico sulla vicenda. Adesso però, dai verbali
delle singole commissioni sparse per l'Italia, da quello della riunione del 3
novembre tra Miur e Commissione nazionale e da una perizia di parte del dottor
Gianluca Marella (docente a Tor Vergata e consulente tecnico della procura di
Roma) emergono elementi nuovi. Emerge chiaramente, ad esempio, come in diversi
casi gli stessi candidati abbiano riscontrato e segnalato ai commissari
l'inversione dei quiz già nel corso delle prove, che tuttavia non sono state
interrotte. Nel verbale della riunione di Roma del 3 novembre, inoltre, si legge
che "delle 30 domande contenute nella prova di area medica del 29 ottobre, 27
sono riconducibili ai 5 settori scientifici disciplinari comuni tra l'area
medica e quella dei servizi, 1 quesito è riferibile al settore scientifico
disciplinare della farmacologia". Tradotto: le domande non pertinenti all'area
medica, e quindi da abbonare, in base a quanto dichiarato dalla stessa
Commissione nazionale non sono due ma tre. Perché allora il quesito di
farmacologia non è stato abbonato? Non solo. Nel verbale del 3 novembre la
Commissione conclude che la scelta di invalidare le quattro domande di area non
influisce sulla validità complessiva dei test, perché le domande più importanti
- quelle relative alle scuole di specialità cui sono attribuiti il doppio dei
punti - non hanno determinato problematiche. Eppure, dopo la stesura dell'atto,
sulla base di un altro verbale, che conclude una riunione del 4 novembre cui
prendono parte solo il presidente della medesima Commissione nazionale e un
rappresentante della società Selexi, si provvederà ad abbonare altre due
domande: stavolta relative proprio ad altrettante scuole di specializzazione
(una di Cardiologia e un'altra di Endocrinolgia). Un totale di 6 quesiti
abbonati attraverso dei semplici verbali, senza l'intervento di un apposito
provvedimento ministeriale indispensabile - sostengono gli estensori dei ricorsi
- per modificare un bando di concorso approvato con decreto. Prove modificate
dall'interno. Alla scelta di abbonare le sei domande, accusano i legali dei
ricorrenti, è seguita una procedura inedita. Invece di limitarsi ad aggiungere
il punteggio delle domande in questione alla graduatoria finale, Cineca e Miur
sono entrati nei singoli compiti inserendo a livello informatico i codici
fiscali e hanno modificato dall'interno le risposte dei candidati, che non hanno
in questo modo neanche più la certezza di quali risposte abbiano fornito, visto
che le prove erano soltanto digitali. La decisione di intervenire sulle prove
già svolte è avvenuta dopo che i punteggi dei singoli candidati erano già
pubblici e le graduatorie già in mano al Cineca: cioè dopo che ad ogni compito
era stato dato un nome. E così, tra accessi non verbalizzati nei compiti e
interventi postumi sulle domande, lo scopo principale del nuovo concorso a
graduatoria nazionale, quello di garantire la segretezza e la trasparenza della
selezione e l'anonimato dei candidati, potrebbe essere stato compromesso.
Mancano i soldi. Davanti a questo nutrito elenco di contestazioni, l'Avvocatura
dello Stato ha messo le mani avanti. "Nella denegata ipotesi in cui i ricorsi
relativi al contenzioso venissero accolti", recita un documento redatto dal Miur
e da poco depositato davanti al Tar del Lazio, "una ammissione in sovrannumero
comporterebbe ripercussioni economiche considerevoli, in quanto imporrebbe allo
Stato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di
ulteriori contratti di formazione specialistica". "Anche l'ammissione di un solo
medico in più", prosegue minaccioso il documento, "comporterebbe l'onere di
reperire risorse aggiuntive da stanziare tramite appositi provvedimenti
legislativi (circa 125.000 euro in più per ogni specializzando)". Una mossa
legittima, anche se i giovani ricorrenti meriterebbero forse un giudizio -
decisivo per il loro futuro - capace di entrare nel merito delle irregolarità
denunciate senza fermarsi davanti allo spauracchio della spesa pubblica. Dal
Paese che li spinge in massa verso l'estero dopo anni di sacrifici sui libri,
meriterebbero maggiore considerazione e trasparenza.
Concorsi pubblici, tutti i
casi sospetti.
Il pasticciaccio delle scuole di specializzazione in medicina, per il quale i
giovani medici manifestano a Roma, è l’ultimo episodio di un lungo elenco di
irregolarità, favoritismi e trucchi. Dalla Farnesina alla Polizia penitenziaria
nessuno è escluso. A partire dalle selezioni per insegnanti e ricercatori,
scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. Una manifestazione di specializzandi di
medicina a Roma. Le prove, l’errore e il dietrofront. Dopo giorni di polemiche,
il ministero dell’Istruzione cerca di mettere una pezza al pasticciaccio del
concorsone per l’accesso alla scuole di specializzazione in medicina. Un test
fondamentale per accedere alle oltre cinquemila borse di studio diventato
tristemente famoso per l'annullamento che ha colpito più di 11mila candidati.
Dopo avere rilevato una “grave anomalia” il ministro Stefania Giannini ci
ripensa e annuncia: «Le prove per l’accesso del 29 e 31 ottobre non dovranno
essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i
test». Una pezza dopo l’annuncio di una valanga di ricorsi. Le dimissioni di
Emilio Ferrari, il responsabile del Consorzio universitario che ha preparato il
test di ingresso, non sono servite a stoppare la manifestazione davanti al Miur.
In piazza i giovani medici che la settimana scorsa hanno partecipato alle
selezioni. Non è la prima volta che un concorso pubblico finisce con una
figuraccia e una protesta di piazza. Tra caos, ricorsi, graduatorie ritoccate e
interventi della Magistratura non c’è settore della pubblica amministrazione
immune all’aiutino. Il prestigioso posto di ambasciatore junior del ministero
degli Esteri si è trasformato, secondo le critiche, in una corsia preferenziale
per chi ha parentele famose. In ballo 35 posti per il gradino più basso della
carriera alla Farnesina: la questione è finita con otto interrogazioni
parlamentari e ombre pesanti sul ministero degli Esteri. Perfino alle prove per
diventare poliziotti si scoprono bluff. Lo scorso maggio alla scuola di
formazione della Polizia penitenziaria di Roma si aprono le porte ai concorrenti
al concorso pubblico per 208 posti di agente. Test e prove attitudinali per
andare a lavorare nelle carceri italiane. Durante gli scritti la commissione
esaminatrice scopre tre aspiranti con in tasca le risposte esatte ai quiz di
selezione. L’elenco delle valutazioni sballate, superficialità e grossolani
errori per scegliere gli insegnanti della scuola italiana è lungo. Nel 2010 nel
concorso per dirigente scolastico il Ministero mette online i temi delle prove e
arrivano una valanga di segnalazioni. Tanti, troppi errori e un quiz su sei
viene ritirato. Nonostante gli accorgimenti all‘apertura delle buste nei cento
quiz c’erano ancora degli strafalcioni. Per i tirocini formativi attivi (Tfa)
obbligatori per diventare insegnanti si replica con ancora quiz errati e si
ottiene ammissione dei ricorrenti alle prove scritte. Per l’ultimo concorso a
cattedra la Giannini è stata costretta a un decreto correttivo. «Ogni volta è la
stessa storia», commenta Marcello Pacifico del sindacato Anief:«Non sono le
dimissioni di un presidente ma la gestione delle prove selettive che non trova
mai un responsabile. Non è possibile che proprio le domande e le risposte per
accertare il merito contengano degli errori». Tra le maglie delle selezioni
anche casi clamorosi di familismo amorale e concorsi truccati su misura. A
Palermo la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex preside della facoltà
di Medicina Giacomo De Leo e di Salvatore Novo, professore ordinario e direttore
della scuola di specializzazione in Cardiologia dell'università locale insieme
ad Alberto Balbarini, docente di malattie cardiovascolari a Pisa. Complici e
menti (con l’accusa di truffa, soppressione di atto pubblico e falsità
ideologica) di un presunto concorso truccato per un posto da ricercatore
universitario nel loro dipartimento bandito nel lontano 2004. Il concorso,
secondo gli inquirenti, venne truccato per consentire alla figlia di Novo,
Giuseppina, l'aggiudicazione del posto. L'inchiesta parte da Bari, e indaga su
una serie di concorsi truccati in diverse facoltà della Penisola. Secondo gli
investigatori, ci sarebbe stato un vero e proprio accordo tra Novo e De Leo per
far vincere il concorso alla figlia del cardiologo. A garantire il posto
assegnato a tavolino doveva essere Mario Mariani, altro docente universitario di
Pisa, nominato membro della commissione esaminatrice. All'ultimo momento, però,
Mariani scopre di essere indagato dai pm baresi e fa un passo indietro. È allora
che, secondo i magistrati, i due docenti distruggono il verbale con cui Mariani
era stato designato commissario d'esame e lo sostituiscono con uno identico in
cui mettono il nome di Balbarini. Quest'ultimo, vicino a Mariani, sarebbe stato
al corrente di tutto. Dopo dieci anni la ricercatrice ha fatto carriera e oggi
può vantare il titolo di docente alla scuola di specializzazione in
cardiochirurgia. L’ateneo? Quello di Palermo, naturalmente.
VA TUTTO BEN MADAMA LA
MARCHESA. INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO E LAVAGGIO DEL CERVELLO.
Il “Tutto va ben, madama la
marchesa” trae le sue origini da una vecchia canzone francese che narra di
un servitore che cerca di rassicurare una marchesa al telefono, mentre le
comunica che il suo palazzo è andato a fuoco in seguito al suicidio del marito.
Questa è la cultura
contemporanea.
Editto Bulgaro, Bertolino:
«Me lo aspettavo». Verro (Cda
Rai) nel 2010 scrisse a Berlusconi. Nel mirino 8 trasmissioni. Tra cui
Glob.
Il comico e conduttore: «Ora capisco tante cose. La satira dà ancora fastidio»,
scrive Francesca Buonfiglioli su “Lettera 43”. Enrico Bertolino cade dalle
nuvole. «Sa che si dice che anche il suo programma
Glob
fosse nella lista nera di Antonio Verro, consigliere di amministrazione Rai?».
«Francamente no, ero all'estero. Me lo sta dicendo lei», risponde il comico e
autore a
Lettera43.it.
Ma non è stupito più di tanto. «Adesso ho capito perché hanno cancellato il
programma», aggiunge ridacchiando amaro. «Me lo aspettavo». Poi scherza: «Adesso
faremo i martiri per un po' di tempo». La lettera scritta da Verro all'allora
premier Silvio Berlusconi nel 2010 - e scoperta da
Il Fatto Quotidiano
- è già stata ribattezzata «Editto bulgaro bis». Il consigliere
d'amministrazione Rai esprimeva la sua preoccupazione all'allora ancora Cav
circa «otto trasmissioni» che lo preoccupavano. Delle quali aveva addirittura
allegato schede sintetiche. Nel mirino, ci sarebbero state anche
Annozero
di Michele Santoro,
Parla con me di
Serena Dandini, Che
tempo che fa di Fabio Fazio,
Ballarò
di Giovanni Floris
In 1/2 Ora di Lucia Annunziata,
Report
di Milena Gabanelli e
Lineanotte di
RaiTre. Tutti programmi pericolosi perché, è la spiegazione, «fortemente
connotati da teoremi pregiudizialmente antigovernativi». La missiva si
concludeva poi con un «grosso abbraccio» che tradisce quali fossero i rapporti
ben oltre l'istituzionale tra il gran capo di Mediaset e parte del Servizio
Pubblico. Ma se il condannato Berlusconi ora è all'opposizione, Verro si trova
ancora al suo posto. «Ora mi spiego perché nel 2010 siamo stati fermi un
giro...», dice Bertolino. «Spero solo che questa lettera non valga ancora».
DOMANDA. Che effetto
fa essere un sovversivo?
RISPOSTA.
Piacevolissimo. Soprattutto perché qui in Italia non ci sono le modalità di
lotta alla satira francesi. Diciamo che siamo più cautelati.
D. Secondo lei perché
Glob
era considerato scomodo?
R.
Perché, a differenza di altri programmi, veniva seguito da destra e da sinistra.
Insomma, ci rivolgevamo agli indecisi. Quelli più influenzabili.
D. La satira, anche
sulla comunicazione, fa ancora paura?
R.
La satira sì. La politica per molto tempo ha chiesto e sopportato solo la
parodia.
D. Cioè?
R.
Le imitazioni. Quelle celebrano, mentre la satira dà fastidio.
D. Con costi ridotti
riuscivate a ottenere comunque un discreto successo.
R.
Le decisioni della Rai raramente seguono logiche industriali.
Glob
tra l'altro costava un'unghia, era una produzione Itc-Rai, quindi interna, ed è
stato una fucina di autori...
D. E lo share?
R.
Andavamo in onda in tardissima serata. E poi, va detto, come tutte le
trasmissioni, vivevamo di traino. C'erano serate difficili e serate in cui
riuscivamo a portare a casa percentuali a doppia cifra.
D. Solo merito del
traino?
R.
No, sono convinto che gli spettatori crescessero perché si addormentavano col
telecomando in mano (ride,
ndr).
D. Lei pare
affezionato agli editti bulgari.
R.
Già, ero già finito nel mirino. Ma non sono certo paragonabile a Daniele
Luttazzi o Sabina Guzzanti che hanno pagato pensantemente...
D. Non era simpatico a
Berlusconi.
R.
Ma arrivavo dopo Gene
Gnocchi e Dario Vergassola.
D. L'allora direttore
generale di Viale Mazzini Mauro Masi la apostrofò con «quel comico bergamasco».
Uno smacco?
R.
Un po'. Però fu una grande pubblicità. Come quella volta che ci cacciarono da un
teatro di Imperia...
D. Perché?
R.
Scajola aveva organizzato una manifestazione con Berlusconi e fummo sfrattati
dal teatro.
D. Un
cursus honorum
il suo. E adesso chi disturberebbe
Glob?
R.
Adesso mi incuriosisce molto lo stile di Matteo Salvini.
D. E che stile
sarebbe?
R.
Molto social. Come altri politici twitta gli appuntamenti che ha in tivù e poi
interroga la Rete su cosa ha detto.
D. Salvini veramente
twitta anche durante i talk...
R.
E io proibirei l'uso dei cellulari e dei tablet durante le trasmissioni.
D. Sempre che i talk
sopravvivano...
R.
Negli Stati Uniti si sta sperimentando un nuovo linguaggio televisivo. Basta con
le Ophra e i Letterman.
D. Restiamo a casa: da
osservatore cosa nota nei salotti nostrani?
R.
Mi incuriosiscono le persone sedute dietro i politici. Quelli che annuiscono.
Con cui gli ospiti interagiscono per cercare una complicità diretta. Un esempio?
Salvini che ha mostrato in diretta la felpa con la scritta «Renzi a casa» a una
signora del pubblico.
D. Ma quello del talk
non è un format è da rottamare?
R.
Di sicuro non si sa più come vivacizzare le trasmissione. Io avrei una idea...
D. Dica.
R.
Vorrei presentarmi da
Ballarò
vestito da Batman per illustrare i problemi di Gotham City con alle mie spalle
Robin che annuisce.
D. E a parte gli
scherzi?
R.
Il problema è che ormai la televisione è piena da mattino a sera di
opinionologhi.
D. Opinio che?
R.
Opinionologhi. Se gli opinionisti hanno una loro idea, gli opinionologhi se ne
creano una alla bisogna. Sono sempre gli stessi in video da
Omnibus
a
Lineanotte.
E twittano in continuazione. Vorrei capire quando scrivono sui giornali...
D. Un po' tuttologi.
R.
Mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno su un determinato tema dicesse di non
avere un'opinione precisa. Ma il maestro di tutto questo è Gianfranco Funari.
D. Funari?
R.
Una volta mi presentai a una sua trasmissione su Telemontecarlo. Quella con due
tribune contrapposte. Mi disse: «Te, con gli occhi azzurri mettete da sta
parte». Scoprì successivamente che dovevo sostenere la tesi di chi non si fa
operare da un chirurgo donna.
D. E lei che fece?
R.
Gli dissi che non ero d'accordo.
D. E lui?
R.
Mi rispose: «E che te frega, mettete là e inventate qualcosa. Facciamo un po' di
confusione».
D. Non è cambiata
molto la televisione...
R.
No, Funari in questo era un maestro, un demiurgo.
Mail di Oliviero Beha a
Dagospia.
Caro Dago, ho seguito con molto interesse la vicenda del Consigliere Rai di ora
e di allora Antonio Verro, dal cognome e la facies di antico romano, ripresa
qui da Vulpio e per interposto “Libero” da Facci. Il mio interesse non si deve
alla cosa in sé, alle solite menate Rai, all’ipocrisia dilagante da sempre ecc.,
tutto repertorio di pessima qualità che conosco come le mie tasche fino alla
noia, bensì alle reazioni polemiche allo “scoop” ritardato, a partire da quella
di Santoro. Se uno non sapesse come stanno davvero le cose in un Paese orrendo
di mafie, mafiette, clan e camarille, di sedicenti buoni contro cattivi
dichiarati in un’interpretazione partitocratica per bande fatte di banditi nei
due significati, potrebbe pensare che la vita in carriera di Santoro sia stata
un autentico calvario, con qualche salita e discesa dal Golgota. Non credo che
sia andata biograficamente proprio così. Ha fatto egregiamente gli affari suoi
per un quarto di secolo, ha travestito ottime trasmissioni spesso di parte da
impegno politico in realtà vendendo (e benissimo) una merce, in primis se
stesso, è entrato e uscito da Rai e Mediaset e Parlamento europeo (non credo
esattamente da “intellettuale disorganico”…), ha detto rientrando in Rai dieci
anni fa che si sarebbe battuto per gli epurati e non è accaduto, adesso ritira
fuori il nome di Luttazzi strumentalizzando anche il bravissimo esiliato. Va
tutto bene insomma, ma forse il nostro Michele ventrale (tv di pancia…) non è
proprio la figura adatta, con le carte in regola, per parlare di censura, editto
o non editto bulgaro. Anzi, presumo non sappia neppure dove stia di casa, la
censura, concetto relativo che viene adoperato a proprio uso e consumo di volta
in volta. Se vuole, ne possiamo parlare, anche pubblicamente… In tutto questo
Verro, Tarantola (e Grilli, l’allora Ministro di competenza, e Ponzellini, e la
Bpm, e l’indagine “sabbiosa” della Banca d’Italia ai suoi tempi, cara
Presidente? Non sono cose che stanno insieme e che nessuno racconta agli
italiani distratti ?), Gubitosi e tutto il profumato presepe Rai restano sullo
sfondo, come retaggio di un costume che nessuno sa o vuole rottamare… Ma per
favore, almeno prudenza nell’indignazione: chi ha davvero la faccia per parlare
senza essere sputtanato?
L'antisemitismo di Vauro in
tribunale non esiste. Ma ci perseguita da sempre.
Naso a becco e stella di Davide: nella vignetta usata la simbologia dei
razzisti. I giudici lo assolvono, io lo citerò alla Corte per i diritti umani,
scrive Fiamma Nirenstein su “Il Giornale”. Quando guardo la vignetta di Vauro
con la mia caricatura, che di nuovo un tribunale italiano ha assolto accusando
invece contro ogni logica Peppino Caldarola che ne ha denunciato il significato,
penso: bravo Vauro, ha saputo compendiare tutto il significato
dell'antisemitismo contemporaneo in una sola immagine. Ambiguo, polivalente,
saldamente ancorato nella tradizione antisemita classica, io col naso a becco,
un mostro, un essere deumanizzato, con la stella di Davide cucita come esigevano
i nazisti con gli ebrei, e moderno, consapevole del fatto che basta trovare una
qualche ragione popolare per odiare gli ebrei e appiccicarglielo, come quel
distintivo del Pdl accanto al fascio littorio appiccicato a me. Proprio a me?
Sono Fiamma? Con la mia storia di femminismo? Diritti umani? Iraniani
perseguitati? Tanti libri? Tanta storia? No, sono l'ebrea di Vauro.
L'antisemitismo all'Onu, forse non è un fatto molto noto, non si enuncia mai in
quanto tale dopo la Shoah: nel '64 la parola «antisemitismo» non venne ammessa
come riferimento nella «convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale», perchè, si disse, era un problema di
intolleranza religiosa. Fra le intolleranze religiose, non fu ammessa perchè era
un problema razziale. Non ci sono effetti o conseguenze nelle risoluzioni
dell'Onu per gli antisemiti, perchè non esistono. Anche Vauro non è antisemita:
non esistono. Ovunque l'odio è seminato da vignette come quelle di Vauro, una
delle tante aggressioni antisemite che ho ricevuto nella vita. Ma io posso
parlare, scrivere e viaggiare, una scorta della polizia italiana mi ha protetto
per tanti anni da minacce insistenti e reiterate, ma stavolta bisogna che dica a
Vauro: basta con l'incitamento. Io la citerò alla Corte europea dei diritti
umani, e cercherò giustizia perché come dice Shylock, mangiamo lo stesso cibo,
siamo feriti dalle stesse armi e se si punge un ebreo, forse che non sanguina?
Io sanguino, quel naso è mio, quello spregio al corpo femminile nella sua
vignetta è al mio proprio corpo di donna, la stella di Davide è sul mio petto,
quelle ferite per evocare Frankenstein di fatto inconsciamente lei le ha
disegnate su un corpo ossuto come quelli dei morti ad Auschwitz, come quelli dei
miei nonni. Io so cos'è l'antisemitismo: ho scritto parecchio sull'argomento,
fra cui un libro intitolato L'antisemita progressista. Non ce n'è uno che
ammetta di esserlo. È dal 2008, quando Vauro stampò la vignetta sul Manifesto,
che mi porto quella stella di David, la sua, e non va bene. Invece lo schiaffo è
stato reiterato dalla sentenza in appello. L'antisemitismo oggi è inconsapevole,
e anche giustificato, Vauro di certo mi ha messo quel fascio addosso perchè
decide lui se un ebreo possa scegliere di candidarsi con il Pdl. Altri decisero
a suo tempo, se poteva avere un negozio, o una cameriera cristiana, o se poteva
andare a scuola con gli altri studenti, o lavorare in Banca, come mio nonno che
ne fu cacciato. Anche la bambina che alle elementari mi chiese se avevo la coda
non sapeva affatto di essere antisemita, lo chiedeva per curiosità. Non lo sanno
quelli che mi hanno accusato di essere la capa della lobby sionista in Italia e
alla Camera finché ci sono rimasta, e persino tutti quelli che mi hanno
minacciato di morte. I più recenti che mi hanno preso di mira citano la
mostrificazione che fa di me Vauro. Basta giuocare la battaglia sul campo
contiguo, quello in cui non si parla di niente, e l'antisemitismo è un giuoco
ideologico. Eppure i morti ci sono.
"La sinistra è come l'islam
chi dissente è perseguitato".
Il vignettista Forattini va all'attacco: "Mi hanno fatto fuori, si possono
toccare tutti tranne loro", scrive Eleonora Barbieri su “Il Giornale”. Giorgio
Forattini è a Parigi. «Ho casa da vent'anni, qui nel Marais, a ridosso del
quartiere ebraico». Non lontano dalla redazione di Charlie Hebdo . «Io mi sono
disegnato a cavallo, con la matita in una mano che regge la bandiera francese e
la scritta: Allons enfants de la satyre ».
In questi giorni hanno
difeso tutti la libertà di satira, in piazza è scesa anche la sinistra. Lei fa
vignette da quarant'anni. Che ne pensa?
«Intendiamo la sinistra
italiana?».
La sinistra italiana.
«E che cosa vuole che ne
pensi? Mi hanno sempre perseguitato: puoi toccare tutti, tranne loro. Detto ciò
quello che è successo è una cosa atroce, tutti sono con tutti i satirici, fra
l'altro quelli di Charlie Hebdo sono di sinistra. Ma la nostra sinistra credo
sia ipocrita».
Perché dice che è
stato perseguitato?
«Come in Unione Sovietica, o
sotto il fascismo, la sinistra si muove come un partito totalitario,
dittatoriale: o sei di sinistra o sei fascista, qualunquista, blasfemo,
berlusconiano. Così mi hanno combattuto, mi hanno fatto subire processi,
servendosi dei giudici che sono dalla loro parte, perché non hanno davvero
l'idea della satira libera».
Ha ricevuto una
ventina di querele, non si sarà lamentata solo la sinistra.
«Qualche cosa dalla Dc, dal
Vaticano... ma i guai sempre da sinistra. Quando Berlusconi era al governo l'ho
fatto in tutti modi: non mi ha mai querelato. A Repubblica avevano paura anche a
sfottere Stalin».
Il caso più celebre è
quello di D'Alema.
«Da allora la mia vita è
cambiata. Nel '99 feci questa vignetta sull'affare Mitrokhin. Mi chiese tre
miliardi, c'erano ancora le lire. Ero a Repubblica : non mi difese nessuno».
Nessuna solidarietà?
«Macché. Li ho avuti contro. E
neanche l'Ordine mi ha difeso».
Neanche un po' di
solidarietà dai colleghi?
«Molti sì, ma me lo dicevano a
voce. Dai vertici niente, si tirarono indietro. Ma io sono un uomo libero e per
me la satira è libertà».
Quindi?
«Quindi presi e andai via. Sa,
tre miliardi di danni sono come uccidere un uomo. Per fortuna l'Avvocato mi fece
un contratto splendido alla Stampa . E allora D'Alema ritirò la querela».
Quindi non si è
scusato?
«No, non mi sono mai scusato,
per carità. E ne sono fiero. Del resto sono uno dei pochi vignettisti e satirici
indipendenti, tutti sono legati ai partiti».
Ma D'Alema l'ha più
incontrato?
«Una volta, per strada. Io
l'ho salutato, ma lui ha tirato dritto. Comunque anche da Repubblica non mi
hanno più richiamato, davo fastidio».
Prima però non aveva
avuto problemi.
«Davo fastidio anche prima. A
volte mi dicevano: "Questa vignetta non possiamo pubblicarla", e io: "Non ne
faccio un'altra, metteteci la foto del direttore". Oppure a una certa ora
Scalfari mi diceva: "Allora, hai finito questa vignetta?" e io: "Un momento
direttò, non mi si è ancora asciugato il bianchetto"... Poi sono stato
sostituito da gente che stava agli ordini, io non facevo mai vedere prima la mia
vignetta. Il fatto è che l'Italia e gli italiani non sono abituati alla satira».
In Francia è diverso?
«Quando raccontavo quello che
succedeva, qui a Parigi si mettevano a ridere. C'è totale libertà. Anche per
vignette molto violente, cattive. I politici non si sono mai azzardati a toccare
gli autori, solo gli islamici l'hanno fatto, perché loro non si identificano con
la Francia, ma solo con l'islam. Come da noi la sinistra».
In che senso?
«Per la sinistra o sei con
loro o sei il nemico e ti perseguitano. Non puoi parlare di loro, come per gli
islamici non puoi parlare dell'islam».
Ma lei ha fatto
vignette sull'islam?
«Sì, in passato, contro i
fanatici musulmani. Le ho fatte anche sulla Chiesa, ho preso in giro il Papa,
qualche cardinale si è lamentato, ma nessuna minaccia o querela. Non sono
arrivate le guardie svizzere a prendermi a casa».
A chi si è ispirato
fra i vignettisti?
«Jacovitti. Un maestro. Sa, io
ho grande solidarietà verso i disegnatori, ma non ne ho ricevuta nessuna da
parte di quelli italiani».
Con chi ce l'ha?
«Per esempio Giannelli, l'ho
messo io al Corriere . Il direttore Stille mi chiamò, ma all'epoca io stavo bene
a Repubblica e così gli consigliai il numero uno di quelli che lavoravano con me
a Satyricon , cioè Giannelli».
E poi?
«Poi lui mi fece disegnato da
balilla e io lo mandai al diavolo. Mi telefonò e gli risposi che non bisogna mai
essere schiavi dei partiti, che devi essere indipendente... Poverino».
C'è più censura oggi o
quando ha iniziato negli anni Settanta?
«Più oggi. Perché la sinistra
ha preso il potere. Io ho iniziato tardi, a 40 anni, sono entrato con un
concorso a Paese sera , poi ho iniziato a occuparmi di politica e in
contemporanea a fare vignette per Panorama , per anni sotto la Dc lavoravo
tranquillo, ma anche con Berlusconi. Facevo Spadolini tutto nudo... Ora vede,
nel mio ultimo libro ho fatto Renzi come Pinocchio, e Napolitano è mastro
Geppetto».
Perché Renzi è
Pinocchio?
«Gli ha mai sentito dire cose
che si sono avverate? Come dicono a Roma, pure lui nun ce capisce niente. E poi
ha quel naso lì».
I politici più
permalosi?
«D'Alema il massimo. Craxi
solo una volta mi ha chiesto 70 milioni, ma Repubblica lì mi aveva difeso».
Spadolini?
«Noo, aveva la raccolta dei
miei disegni».
Andreotti?
«Pure. Lui stesso mi sfotteva,
col suo humour».
Di Pietro?
«Ah, lui non mi ha mai
perdonato. Ho ricevuto anche una condanna».
È vero che vedeva in
anteprima le vignette?
«Qualcuno gliele faceva avere
prima, sì, e lui era anche capace di non fare uscire i giornali... Un vero
democratico. Io non faccio il santo, ma sono un italiano puro: non ho mai
colpito l'Italia. Amo la Patria. E per questo sono fascista? No, sono un
italiano vero».
Senta, Berlinguer?
«Un altro. Ammazza se
s'arrabbiava. Tremendo».
Beh, l'ha disegnato
che sorseggiava il tè in salotto, durante un corteo di operai...
«Certo, certo, quello il
partito non l'ha mai sopportato».
Però ha anche fatto un
sacco di soldi, coi difetti dei politici.
«Sì. Ma li avrei fatti lo
stesso, anche libero da minacce. Querelare è un senso di non libertà».
Anche quando c'è un
insulto?
«Io non ho mai insultato.
Magari ho fatto qualcosa di forte, ma ho sempre rispettato la persona. Poi io ho
fatto ventimila vignette, qualche decina di querele sono niente. Ma chi le fa,
ecco, non sa che cosa sia la satira, non è un uomo libero».
Il limite qual è?
«L'onestà di chi disegna. Non
deve essere espressione di un movimento politico, ma di estrema libertà».
C'è qualcosa di tabù?
«Il buongusto, il fare
umorismo: è sberleffo, ma mai condanna, uccisione del nemico, anche con una
vignetta. Non deve essere persecuzione ma facciamoci una risata, anche su di
voi».
Quando la satira non
fa ridere?
«Spesso. In Francia fa ridere,
ma in Italia si fa per fare politica, per affossare la parte avversa».
È militante?
«Brava. Ma la satira militante
non può essere satira. C'è qualcuno che fa satira, ma sono pochi e si
autocensurano. Perché se no la sinistra e i giudici ti tappano la bocca: se uno
ti chiede tre miliardi di danni, è come una condanna a morte».
Non esagera? Visto
quello che è successo.
«È una battuta, certo, ma è
come togliere il lavoro a una persona. E poi un capo del governo che colpisce
per una vignetta, che cosa farebbe in una dittatura? Perciò si assimila molto
agli islamici che la pensano così, che vogliono la distruzione del nemico, la
ghigliottina per chi non la pensa come loro».
È ancora amico di
Scalfari?
«Io sono stato tra i quaranta
fondatori di Repubblica , fu lui a chiamarmi. Ma da quando ho lasciato non ci
siamo più visti. Non abbiamo litigato, ma lui non mi ha difeso e io non posso
perdonarlo. È ancora vivo?».
È vero che va sempre
dal parrucchiere?
«Sì, tengo molto ai miei
capelli. Li porto lunghi perché mi considero un uomo del Settecento. Però ogni
tanto mia moglie mi bacchetta, e allora vado a tagliarli».
Ma i vignettisti, come
si dice dei comici, sono sempre tristi?
«Sì, sono molto triste. Ho
anche perso mio figlio pochi anni fa, aveva cinquant'anni, ci eravamo
riavvicinati. Non mi sono più tirato su. Riesco a fare le vignette, faccio
qualche battuta, ma mi ha cambiato la vita. Comunque è vero, in genere i
satirici non sono degli allegroni. Come il nuovo numero di Charlie Hebdo , è
pieno di vignette ma è anche pieno di lacrime».
La satira? Roba da
miliardari comunisti! Scrive
Bruno Giurato su “Il Giornale”.
La satira non ha a che vedere col dire le parolacce: pupù e pipì e pisellino e
fessurina. Quella è
solo (e non necessariamente) la forma dell’espressione. L’oscenità o la
blasfemia non sono garanzia di buona satira, perché la
satira, prima di tutto, ha a che vedere con una cosa: dire la verità.
Se non dice a verità, se non svela in inedito incontrovertibile, se non apre una
radura di luce tra le stecchite boscaglie del luogo comune, il lavoro del
satirico è una retorica come un’altra: seriosa, doverosa, pallosa.
Ed ecco che arriva un grande e
vero satirico e la verità la dice, tutta. Parliamo di Maurizio Milani.
Uno che usa la maschera dell’umorismo surreale (immancabilmente definito
“stralunato”, che noia!), e lombardo-padano per dire verità, anche pesantissime.
A Modena BUK Festival domenica prossima, viene presentato il libro
Je Suis Charlie? La satira
riflette su se stessa ma le viene da ridere
(Sagoma Editore, pp. 128, 9,50 euro). Il volume ospita contributi da Dario
Vergassola a Moni Ovadia, da David Riondino a Staino, Marco Carena, Rita
Pelusio, gli Skiantos, Pietro Sparacino, Cochi Ponzoni, Max Pisu.
E poi c’è lui. Milani. Che in questo testo smonta bel bello tutta la retorica
del “satiro” come eroe del nostro tempo.
E per fortuna che c’è lui, Milani, che, come sempre facendo di tutto per NON
essere preso sul serio scrive cose come: “In Italia la satira è sempre stata in
mano ai comunisti. In trent’anni di cabaret ho partecipato a diversi show in tv
e in teatro e non mi è mai capitato di conoscere un autore o un produttore della
Democrazia cristiana”. Oppure: “Adesso è saltato fuori il problema di quanto la
satira debba essere libera. Benissimo!
Bel dibattito, molto completo,
che lascio volentieri ai miliardari comunisti nelle loro tenute agricole in
campagna. Dove si fa tutto
Ogm free. Tanto per loro il raccolto è lo 0,5% del reddito che incassano con
l’indotto.
Indotto fatto per anni a scherzare su Mara Carfagna o Sandro Bondi, tutte
persone notoriamente pericolose
per le reazioni sproporzionate che potrebbero avere”. Ed è un colpo magnifico a
tutto il birignao della satira di sinistra, ai
“satiri” di professione, a
quelli che citano etimologie latine e Dari Fo a ogni colpo di pedale sulla
cyclette del già detto. Ci
voleva Milani. Uno che la verità la dice davvero. E senza nemmeno un
pipì-pupù-pisellino-fessurina. Senza nemmeno una parolaccia una.
La nostra satira? Attacca
Bondi, altro che martiri. Quanta ipocrisia nei comici italiani neo paladini
della libertà d'espressione: sono gli stesso gli stessi che emarginano da sempre
chi è diverso e non la pensa come loro, scrive Maurizio Milani su “Il Giornale”.
In Italia la satira è sempre stata in mano ai comunisti. In trent'anni di
cabaret ho partecipato a diversi show in tv e in teatro e non mi è mai capitato
di conoscere un autore o un produttore della Democrazia cristiana, il mio
partito. Il più bello e il più completo. Dicevo: tutti, dico tutti, erano e sono
comunisti. Qualcuno come me si adeguava, facendo finta di essere comunista. Non
per vantarmi, ma fin da ragazzo sono sempre stato falso. Oggi, poi, ancora
peggio. Se posso, truffo sempre il mio simile. Adesso è saltato fuori il
problema di quanto la satira debba essere libera. Benissimo! Bel dibattito,
molto completo, che lascio volentieri ai miliardari comunisti nelle loro tenute
agricole in campagna. Dove si fa tutto Ogm free. Tanto per loro il raccolto è lo
0,5% del reddito che incassano con l'indotto. Indotto fatto per anni a scherzare
su Mara Carfagna o Sandro Bondi, tutte persone notoriamente pericolose per le
reazioni sproporzionate che potrebbero avere. Non per vantarmi, ma il mio
problema è tirar su mille o millecinquecento euro al mese. Senza contare che
finisco per farmi compatire e sbeffeggiare nelle pubbliche mense di Milano dove
sono in fila: «Guarda come si è ridotto a non fare la tessera del Pd, aveva così
un bel posto alla Rai». Un altro: «Ma è un povero scemo». Io: «Avete ragione, a
questo punto parlo e faccio il pentito di cabaret. Dirò tutto: come si diventa
affiliati, chi c'è dietro ai comici di regime e dove finisce parte dei
compensi». Che io sappia, dovrei essere uno dei primi pentiti di cabaret. E
visti i tempi che corrono, credo di poter rientrare nel programma di protezione
della Dia. In alternativa, potrei assicurare ai satirici di Capalbio
irreversibili vuoti di memoria in cambio di cinquantamila modesti euro in nero,
da consegnare entro domani a piazza Eleonora Duse, dove ho il covo. Nel
frattempo sono stato giustamente scaraventato fuori dal mondo del cabaret. Per
cui mi arrangio con il bracconaggio. Cosa che facevo già prima, ma come hobby.
E, già che siamo in confidenza, se avete biciclette rubate, o altro che sia
facile da smerciare, portatele da me, sempre a piazza Duse al 2. Dispiace dirlo
qui, però a questo punto parlo e vuoto il sacco: «Sì! Sono un ricettatore». Per
queste affermazioni sono stato rinviato a giudizio per auto-calunnia, che è
quello che volevo; mettermi in mostra verso l'opinione pubblica ed essere
nominato al Parlamento in quota gruppo misto. Ma accetto anche una candidatura
nel movimento di Grillo. Certo, parlo nel mio interesse; ma come ho fatto il
ruffiano una volta, potrei farlo ancora. Cioè, tradire il mandato elettorale
passando alla concorrenza. Che è sempre stato il mio sogno: deludere i miei
amici facendo la spia.
La satira piace alla
sinistra solo se è contro la destra.
La Boldrini rimprovera
Virginia Raffaele: «La sua ministra Boschi è sessista», scrive Sarina Biraghi su
“Il Tempo”. L’insostenibile leggerezza della satira. A sinistra. E sì, perché
per la Sinistra non esiste la parità, né di genere né di satira. Come dire, gli
imitatori possono essere irriverenti, inopportuni, feroci e autonomi soltanto
quando il potere è a Destra. Infatti, l’imitazione fatta dall’attrice e comica
Virginia Raffaele del ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elena Boschi,
andata in onda martedì su Ballarò, non è stata affatto digerita, neanche dalla
diretta interessata. A manifestare questo storico disagio, ieri, un’altra donna,
la presidente della Camera Laura Boldrini, ospite di «In Mezzora». «Mi è
dispiaciuto vedere la satira della Boschi - ha detto Boldrini - Ci sono tanti
modi per fare satira, ma quando si cede al sessismo diventa altro e l’apprezzo
di meno». Per la verità, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata, Boldrini
ha detto anche che in passato alcune parlamentari di Forza Italia hanno «subito
dei torti» dello stesso tipo. Quanto all’imitazione di Francesca Pascale,
Boldrini ha aggiunto: «Non l’ho vista ma se aveva gli stessi accenti sessisti mi
sarebbe dispiaciuto». A donna Laura è semplicemente dispiaciuto, ma ai Democrat
ha dato molto fastidio visto che il renziano Michele Anzaldi, segretario della
commissione di vigilanza Rai, ha scritto addirittura una lettera alla presidente
Anna Maria Tarantola chiedendole se l’imitazione della Boschi fosse «servizio
pubblico». Si sa che le imitazioni sono sempre feroci, ma quella della bella
ministra fiorentina non ci è parsa così cattiva. La Raffaele l’ha descritta come
una maestrina che sa a memoria il programma di governo ma quando un giornalista
le rivolge qualche domanda concreta, parte in sottofondo l’indimenticabile
colonna sonora di «Un uomo e una donna» e lei si trasforma: occhioni da
cerbiatta, bolle di sapone, una sirena ammaliatrice che diventa una miagolante
gattina. Certo, quando si è giovani non si sopporta di essere considerate più
belle che brave, ma Maria Elena deve farci il callo, proprio lei che per il
giuramento al Colle sfoggiò un tailleur pantalone blu elettrico attillato con
decollete tacco 12 (giusto per non passare inosservata) e, ancor prima, nella
famosa riunione della Leopolda, altro tacco 12 ma leopardato. E se a Ballarò, la
sua compagna di partito Alessandra Moretti rideva di gusto, quando la Raffaele
imitava Francesca Pascale con tanto di Dudù in braccio, non si è alzato nessun
sinistro sgomento tanto da scomodare i vertici Rai... Certo bisogna riconoscere
che l’onorevole Mara Carfagna, oltre ad essere bellissima, giovane e
affascinante, è anche molto sportiva considerate le battute grottesche con cui
veniva bersagliata da Enrico Lucci o dalle battute maschiliste di Neri Marcorè o
dalle pure offese di un’altra donna come Sabina Guzzanti... Senza parlare di
Nicole Minetti o Daniela Santanchè. Va bè, diciamolo, a sinistra la bellezza è
più bellezza, la bravura è più bravura, la serietà è più serietà...la sinistra è
diversa nella misura in cui è superiore perché le donne belle della Destra sono
«messe lì» da qualche uomo ma non sono intelligenti e preparate, invece quelle
della Sinistra sono brave, preparate, impegnate, conquistano per meriti le
cariche in politica e soltanto incidentalmente possono essere belle donne...
però battute sulla bellezza non si devono fare. Inutile poi rilevare il
doppiopesismo anche nelle reazioni alla satira sulla Boschi. Perché Anzaldi può
scrivere alla Tarantola e mettere in dubbio il servizio pubblico della Rai e
l’eventuale deformazione nella considerazione delle donne, però quando il
centrodestra insorgeva contro la satira dei fratelli Guzzanti durante il secondo
governo Berlusconi era «inopportuna», o quando Berlusconi interveniva sugli
attacchi, sempre sulle reti del servizio pubblico, di Biagi, Luttazzi e Santoro
allora era «censura», era «editto bulgaro». Infine, il dem Anzaldi, sempre nella
missiva alla presidente Rai, non risparmia una lezioncina sulla satira che
«normalmente, secondo la definizione fatta propria anche dalla Cassazione, punta
a “castigare ridendo mores”, ovvero a mettere in risalto in maniera comica
caratteristiche esecrabili e discutibili di un personaggio pubblico. In questo
caso la colpa del ministro sarebbe quella di essere affascinante?». E allora,
mentre oggi si voterà la parità di genere nella riforma della legge elettorale,
i comici sono avvertiti: le imitazioni soltanto di donne brutte altrimenti, di
uomini.
Renzi, Grillo, Travaglio,
Salvini: Ecco a voi i “nuovi Farinacci”,
scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Il capo del quarto ( o terzo)
partito italiano, Matteo Salvini, l’altro ieri non è andato al colloquio con il
presidente della Repubblica e ha motivato questa sua (legittima) decisione con
una frase offensiva contro Mattarella (”Cosa dovevo andare a chiedergli, il
numero di telefono del suo parrucchiere?”). Il Presidente del Consiglio
chiama gufi i dirigenti del suo partito che esprimono dissenso nei suoi
confronti, e dopo una riunione della Direzione del Pd nella quale ritenne di
aver sconfitto Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio, commentò
esprimendosi in questi termini: ”Lo ho asfaltato”. Volete che citi qualche
dichiarazione di Marco Travaglio? Non c’è bisogno, credo, basta dire che il suo
giornale una volta ha pubblicato un editoriale intitolato (”La repubblica delle
troie”) e che lui abitualmente usa polemizzare storpiando il nome del suo
interlocutore, o affibbiandogli un soprannome insolente. Di Grillo cosa posso
dirvi? Che chiama Berlusconi il nano, Bersani lo chiamava, mi pare, Zombi o
Gargamella, Renzi lo chiama ”bimbo-minchia”. Fermiamoci qui. Anche perché queste
poche citazioni non servono in alcun modo a rappresentare il campionario
vastissimo, dilagante, dell’uso dell’offesa, camuffata da sberleffo, per
sostituire la polemica politica di sostanza. Io dico: sostituire. Non
dico: rafforzare. La durezza dello scontro politico non è una novità,
esisteva già nella prima Repubblica, quando la battaglia si inaspriva e i
dissensi politici si allargavano e si drammatizzavano. Però, allora, lo spunto
era il dissenso, la diversità di opinioni su una grande questione, e l’offesa
era un di più. Ora l’offesa è la sostanza e il dissenso sfuma, non si vede o
quantomeno è secondario. Mi ricordo, trent’anni fa, fu Claudio Martelli, educato
filosofo milanese, a rompere le righe e usare il termine ”neuro-comunismo”(al
posto di ”euro-comunismo”) per insultare Enrico Berlinguer. E successe il
finimondo, perché fu considerato uno strappo alla buona educazione politica.
Martelli lo fece nel corso di un intervento in Parlamento mentre era in corso un
ostruzionismo del Pci contro il taglio della scala mobile che durò tre mesi e si
concluse solamente, il 7 giugno del 1984, perché Berlinguer fu colpito da un
ictus che poi ne provocò la morte. Lo scontro era feroce: ma su un tema sociale,
non sulla ricerca dell’urlo, della clamorosità, della ferocia, dell’esaltazione
dell’odio come strumento per radunare le proprie truppe. Anche l’ostruzionismo
del Pci era uno strumento per radunare le truppe, ma non sull’adesione a
un’invettiva bensì sulla difesa di un interesse di gruppo (di classe, si diceva
allora) e cioè sul terreno del più puro e drammatico scontro sociale. La
”beatificazione” della volgarità, del trivio, del bullismo estremo, come metodo
di lotta politica è invece una eredità del fascismo. C’era un famoso gerarca,
che si chiamava Roberto Farinacci, origini popolari e poi breve carriera
giornalistica in alcuni giornali locali prima socialisti e poi fascisti, che
veniva definito dai suoi stessi camerati ”Farinacci il selvaggio”, era uno
specialista in questo tipo di polemica politica. Annientare gli avversari,
colpire basso, senza riguardi, puntare all’umiliazione, alla demolizione
dell’interlocutore. E poi sorridere, e chiamare l’applauso del circo dei propri
sostenitori. Salvini, Grillo, Travaglio e vari altri giornalisti, lo stesso
Matteo Renzi, amano questo agonismo politico. Ieri il premier ne ha fatta
un’altra. Ha detto che presto l’Italia supererà la Germania come potenza
industriale, e diventerà la prima potenza industriale d’Europa. Voi sapete che
Mussolini dichiarò: «Spezzeremo le reni alla Grecia». E che quella frase
infelice (anche perché l’Italia in Grecia finì con le reni rotte) è diventata un
po’ il simbolo della spacconeria politica idiota. Beh, a dire il vero aveva più
probabilità Mussolini di vincere la guerra con la Grecia che Renzi di portare
l’industria italiana a superare quella tedesca. Lo stile però è quello.
Considerare la politica un campo nel quale si fa spettacolo, vince chi recita
meglio. E questa scelta porta all’imbarbarimento del linguaggio, che è un
imbarbarimento di sostanza. L’imbarbarimento prende il posto dello scontro tra
visioni diverse, o dello scontro di classe, o della battaglia ideologica. Non
c’è niente da fare, torna il mito di Farinacci. Sgrammaticato, un poco
ignorante, digiuno della politica vera, ma aggressivo e capace di fare
dell’aggressività la bandiera del fascismo. Io non credo che in Italia esista un
pericolo fascista. Altre volte ho polemizzato contro la retorica antifascista,
che è stata per settant’anni lo scudo dietro il quale la sinistra ha coperto le
sue difficoltà politiche, e che ha usato per ricucire trame di unità quando era
più divisa. Penso che quell’antifascismo, spesso illiberale, sempre retorico,
militaresco, blindato, sia qualcosa da buttar via. Pericoloso, perché è un
antifascismo che scimmiotta il fascismo. Quello del Pd, o dei centri sociali, è
lo stesso. Oggi nella società ci sono tanti e diversissimi ”semi” illiberali,
autoritari, razzisti, che attraversano come una lunghissima cicatrice tutto il
campo politico, dalla sinistra estrema a Casapound. Senza distinzioni profonde.
Condizionano il pensiero e il senso comune di partiti e di larghi ceti
professionali e sociali, dalla borghesia al proletariato, dalla magistratura,
alla chiesa, alla scuola, all’intellettualità. Dove mi pare che il fascismo – lo
spirito di quello che a me sembra il fascismo moderno – emerge con più chiarezza
è proprio in questo linguaggio della ”demolizione” e dell’odio. Farinacci aveva
usato l’invettiva triviale – in parte degradando alcuni temi dannunziani o
futuristi – con uno scopo rivoluzionario. Riteneva che quel linguaggio spezzasse
luoghi comuni, rovesciasse tabù, potesse accompagnare un fortissimo rivolgimento
sociale. ”Sparava sul quartier generale”, come più tardi fecero gli adepti di
Mao Tse Tung nella rivoluzione culturale cinese. Il risultato – in un caso e
nell’altro – fu la vittoria di chi odiava la libertà, la dignità, la storia.
L’estrema conseguenza di quelle lotte triviale furono i falò di libri. Oggi non
è molto diverso. Grillo e Travaglio, e con loro Salvini dicono che stanno
radendo al suolo il quartier generale. Renzi dice che lui sta rottamando. Lo so
che non lo sanno di esser fascisti. Lo so che molti possono ritenere che questo
non sia un male. Io dico solo questo: che assomigliano tutti, maledettamente, a
Farinacci ( per il quale, peraltro, ho molto rispetto: perché morì, eroicamente,
fucilato senza processo da un tribunale del popolo).
Poi con questa cultura di
sinistra tutto ha un altro colore.
Gino Paoli, i soldi in nero
per la Festa dell'Unità (e quel fermo in frontiera in Svizzera),
scrive “Libero Quotidiano”. Ombre (nere) su
Gino Paoli,
sospetto "furbetto" fiscale,
accusato di evasione
per aver trasferito un vero e proprio tesoretto in Svizzera. E nel day-after
dello scandalo, ecco arrivare altri particolari succulenti sulla vicenda. Tra
questi, uno forse lo è più degli altri: il cantautore avrebbe intascato soldi
(in nero) per partecipare alle
feste dell'Unità, quelle
della sinistra per intendersi. E non solo: alla
frontiera svizzera
è stato fermato mentre cercava di rientrare in Italia con una
eccessiva (e sospetta)
quantità di contanti, e per
questo è stato multato dai doganieri. Gino Paoli, 81 anni, è finito nell'occhio
di ciclone. Lui tenta la difesa tramite il suo avvocato,
Daria Pesce,
che spiega: "E' assurdo che questa vicenda sia finita in pasto al pubblico, e
comunque sono tutte balle e lo dimostrerò". Ma tant'è. L'attuale presidente
della Siae nonché ex deputato del Partito comunista italiano, secondo la procura
di Genova, in Svizzera avrebbe un conto da
circa 2 milioni di euro.
Mica bruscolini. Come detto, una parte consistente di questo denaro deriverebbe
dai compensi ricevuti in nero per concerti svolti in tutta Italia e alle feste
dell'Unità. Ma sui pagamenti in nero dei "compagni" non ci sono soltanto i
sospetti. Già, perché ci sono quelle che assomigliano a granitiche certezze. Lo
stesso Paoli, infatti, ha spiegato che all'epoca - tra il 2000 e il 2010 - era
stato "costretto" ad accettare dei pagamenti in nero "alle feste dell'Unità, e
adesso - aggiunge - quei soldi
vorrei riportarli indietro".
Parole e musica che emergono da una telefonata intercettata nei primi mesi del
2004. All'epoca il cantautore non era intercettato, ma lo era invece
Andrea Vallebuona,
commercialista di cui Paoli era cliente, finito in manette a maggio per truffa e
riciclaggio di soldi proprio in Svizzera. La vicenda-Paoli si arricchisce poi
con l'episodio dello scorso dicembre: il cantautore è stato
fermato dai finanzieri
a uno dei valichi di confine con la Svizzera. Stava tornando in Italia, ed è
stato perquisito. Il risultato? Sono state trovate
parecchie banconote.
Troppe banconote, troppe almeno rispetto a quanto è consentito dalla legge:
secondo le indiscrezioni si trattava di diverse migliaia di euro. Così è
scattata una segnalazione fiscale e una sanzione pecuniaria.
Da Bandiera rossa ai fondi
neri, scrive
Renato Farina su “Il Giornale”. La Guardia di finanza ha appurato, dicono, che
Gino Paoli ha portato in Svizzera due milioni di euro: evasione fiscale della
più bella specie. In parte queste entrate occultate a Lugano, ripetono, si
riferiscono a pagamenti in nero per esibizioni alle Feste dell'Unità. La nostra
solidarietà va a Gino Paoli e alle Feste dell'Unità. Perché? Lo ha spiegato
giovedì sera a Virus , intervistato da Nicola Porro, Vincenzo Visco, il famoso
ministro delle Finanze di Romano Prodi. Ha detto Visco: «L'evasione fiscale è
chiaramente di destra, perché le tasse servono a finanziare i servizi pubblici,
e su questi temi la sinistra è chiaramente più sensibile». Chiaramente, il
ragionamento non fa una grinza, anzi un Grinzane. Per questo solidarizziamo:
Gino Paoli e il giornale fondato da Antonio Gramsci, con relativa festa, sono
dei nostri, quinte colonne in territorio nemico, pronti a sacrificarsi agli
ideali dell'evasione fiscale, che com'è notorio sono la nostra bandiera,
espressione della nostra civiltà. Avevo a dire il vero già vissuto un'esperienza
personalmente molto istruttiva un paio di decenni fa, andando per una sera a
bere birra al Leonkavallo, il centro sociale guidato allora dal mio quasi
omonimo Daniele Farina, attuale deputato anti-evasione di Sel. La bionda era
buona, la scura meno, ma con il cavolo che vidi l'ombra di uno scontrino
fiscale. Sono cose borghesi. Imparai allora una legge molto semplice e che è
confermata dalle testimonianze di questi giorni: l'evasione fiscale è di destra,
per dirla come Visco, «chiaramente di destra», ma gli evasori sono chiaramente
di sinistra. Sono arrivato a maturare l'idea che sia una perfida astuzia dei
(...)(...) compagni. Si noti: l'evasione di Gino Paoli e della Festa dell'Unità
è del 2008. Chi andò allora al governo? Berlusconi. Dunque una forma di lotta
politica antiberlusconiana poteva benissimo essere quella di incrementare
l'evasione fiscale per darne la colpa a Silvio. Questa è pura dialettica
marxista. O forse, andando alle purissime origini del marxismo-leninismo,
bisogna risalire alla fase svizzera del bolscevismo. Quando Parvus e Stalin, al
tempo in cui Lenin risiedeva lì, accumularono fondi neri per la rivoluzione nei
forzieri delle banche di Zurigo, grazie a rapine, grassazioni finanziarie e
matrimoni con ricche ereditiere. Così forse Gino Paoli, di cui si ricorda
l'esperienza di deputato comunista, naturalmente indipendente. Esperienza che lo
ha accomunato a Corrado Augias, ora anche lui - sia chiaro, da presunto
innocente - accusato di essere golosissimo di prebende in nero
dall'organizzatore del premio Grinzane-Cavour. Il rosso ama molto il nero,
specie se è un artista, ed è una buona premessa per la riconciliazione
nazionale. Ci resta una domanda. Chi sono stati, dagli anni dei Ds a quelli del
Pd e fino al 2008 (anno del presunto transito di talleri da Genova alla
Svizzera), i direttori dell' Unità la quale dava il suo bel nome alle sobrie
feste dove girava allegro il nero tra le bandiere rosse? Ce ne sono tre: Furio
Colombo fino al 2004, poi Antonio Padellaro fino ad agosto del 2008, quindi
Concita De Gregorio. Idea: siete giornalisti ancora più famosi di allora.
Mettete su una bella inchiesta su come si è costruito e occultato il falso in
bilancio, sfruttando come testimonial le vostre facce di certo pulitissime?
Domandatevi come mai quello che secondo Gino Paoli era un sistema a cui era
impossibile sottrarsi è invece sfuggito persino al fiuto sgamatissimo dei vostri
reporter così abili a prendersela con gli idraulici, i commercianti e i piccoli
imprenditori. Un mito intoccabile, le Feste dell'Unità. Quando dopo la fine dei
Ds e la nascita del Pd qualcuno minacciò di sopprimerle, cambiandone il nome,
intervenne proprio Antonio Padellaro. Scrisse un memorabile panegirico in difesa
della loro purezza, condita proletariamente di grasso e sudore colanti da
salsicce e da militanti. Dopo aver ovviamente citato come minimo un premio
Nobel, nel nostro caso per la precisione Elias Canetti, sentenziò: «Le Feste
dell'Unità sono le Feste dell'Unità». Una delle poche verità, si suppone,
apparse su quelle pagine dalla fondazione gramsciana. Aggiunse che non si può
«cancellare qualcosa che resta comunque nel cuore di milioni di persone».
Qualcosa resta nel cuore di milioni di persone; qualche milione resta nel conto
svizzero di alcuni più persone degli altri. Ecco, Visco parla anche di falso in
bilancio a Virus . Sostiene che «era preoccupatissimo fino all'altro ieri», ma
poi con «l'allentamento del Patto del Nazareno» è più tranquillo. In che senso,
scusi? Qualcuno lo informi: evasione è ideale di destra, ma falso ed evasione
sono pratiche di sinistra. La morale? Come scrisse Montanelli: «Ho conosciuto
molti mascalzoni che non erano moralisti, ma non ho mai conosciuto un moralista
che non fosse un mascalzone».
Il M5S chiede le dimissioni di Gino Paoli, Grillo
si scusa e lo difende, scrive “Il Secolo D’Italia”. «Premetto che
Gino Paoli
è mio amico e quindi potrei essere considerato poco obiettivo. Ma a questo gioco
al massacro di una persona di 80 anni non pregiudicato, mai inquisito, per
alcunché, che mi risulti, io non ci sto! I cittadini sono diventati vittime
sacrificali, mostri da sbattere in prima pagina senza che possano difendersi».
Così
Beppe Grillo
sul suo blog, si schiera col cantante indagato per evasione fiscale, che a quano
pare ha
sostenuto di essere stato
“costretto” a incassare soldi a nero alla feste dell’Unità. Grillo è dalla sua
parte: «Io non ho mosso i miei contro Gino Paoli. Aspetto la magistratura prima
di emettere qualunque giudizio, alla faccia degli sciacalli dell’informazione».
Il leader del movimento 5 stelle in mattinata aveva chiamato Paoli “per scusarsi
con lui dopo gli attacchi del Movimento 5 stelle”. Lo ha riferito il legale del
cantautore
Andrea Vernazza. Nella
giornata di ieri il gruppo alla Camera del M5s aveva infatti diffuso un
comunicato nel quale si chiedeva a Paoli di “valutare seriamente le dimissioni
dalla sua carica” alla presidenza della Siae. Una mossa non gradita a Grillo,
che oggi spiega: «Il Secolo XIX ha pubblicato un titolo di condanna che non
ammette replica: “Maxi evasione in Svizzera, blitz della Finanza a casa di Gino
Paoli” dal quale un lettore distratto evince che Paoli avrebbe evaso senza alcun
dubbio cifre persino superiori al Costituzionalista di Arcore condannato per
truffa fiscale», scrive Grillo che parla di “un articolo costruito su delle
ipotesi che si para il culo con l’uso dei condizionali”. «Sbatti il mostro in
prima pagina. Nel caso Paoli
risulti innocente,
e questo lo decideranno i giudici e non i giornalisti, chi lo risarcirà?».
Grillo continua: «Il Secolo XIX si sdegna per “la mancanza di rispetto
dell’amico Beppe Grillo. Ieri il Movimento 5 Stelle che ha chiesto le dimissioni
di Paoli da presidente della Siae. La fretta con la quale Grillo ha mosso i
suoi, però, è sintomo di un giustizialismo cinico, per nulla democratico”. Io –
scrive però il leader M5s in un post che si conclude con “Sapore di sale” – non
ho “mosso i miei” contro Gino Paoli.
Beppe Grillo difende Gino Paoli: "E' un mio amico,
non si massacra così un ottantenne", scrive “Libero Quotidiano”. "Io non ci
sto".
Beppe Grillo
affida a un post sul suo blog la difesa di
Gino Paoli,
finito nell'occhio del ciclone per una presunta evasione fiscale milionaria.
"Premetto che Gino Paoli è mio amico da molti anni e che spesso le nostre
famiglie si incontrano vivendo nella stessa zona di Genova. Quindi potrei essere
considerato poco obiettivo", scrive il leader del Movimento Cinque Stelle. "Ma a
questo gioco al massacro di una persona di 80 anni non pregiudicato, mai
inquisito, per alcunché, che mi risulti, io non ci sto!". Nel suo articolo, dal
titolo
#SaporeDiSale,
Grillo denuncia: "I cittadini sono diventati vittime sacrificali, mostri da
sbattere in prima pagina senza che possano difendersi in alcun modo". "Il
Secolo XIX
- prosegue Grillo - ha pubblicato un titolo di condanna che non ammette replica:
'Maxi evasione in Svizzera, blitz della Finanza a casa di Gino Paoli' dal quale
un lettore distratto evince che Paoli avrebbe evaso senza alcun dubbio cifre
persino superiori al Costituzionalista di Arcore condannato per truffa fiscale.
Nell’articolo si legge 'Le Fiamme gialle stanno indagando su una presunta maxi
evasione in Svizzera'. Quindi per ora 'l’evasione è presunta'. Continuiamo:
'Paoli risulta indagato: a metterlo nei guai sarebbero alcune intercettazioni di
conversazioni avvenute con il suo commercialista'. Quindi 'sarebbero', che in
italiano vuol dire forse che si, forse che no. Poi in una sola frase che vuole
essere di condanna senza appello si introducono ben tre dubbi amletici: 'Secondo
l’accusa il cantautore genovese (che attualmente ricopre la carica di presidente
della Siae) avrebbe trasferito nel 2008 due milioni di euro all’estero, si
ipotizza in Svizzera' Secondo l’accusa a cui si potrebbe ribattere il contrario
scrivendo 'Secondo la difesa', 'avrebbe trasferito' e dagli con il condizionale.
Paoli ha trasferito illegalmente i soldi o no? E infine la perla: 'si ipotizza
in Svizzera', ma per questo si potrebbe ipotizzare qualunque posto nel mondo,
per esempio dove hanno trasferito (qui senza condizionale) soldi pubblici i
partiti. L’immagine che si vuole traferire", prosegue Grillo, "è quella di Paoli
'spallone' con un sacco pieno di euro che valica le Alpi, magari di notte con la
luna piena. Nell’articolo è compresa anche una ricca fotogallery della visita
dei finanzieri e giornalisti vari a casa di Paoli e poi un’altra coppia
sensazionale di condizionali nel resto dell’articolo: 'L’evasione fiscale,
secondo gli investigatori, ammonterebbe quindi a circa 800 mila euro e non
sarebbero stati dichiarati nel 2009'.'L’evasione fiscale ammonterebbe ... che
non sarebbero'". Secondo Grillo, "un articolo costruito su delle ipotesi che si
para il culo con l’uso dei condizionali. Sbatti il mostro in prima pagina. Nel
caso Paoli risulti innocente, e questo lo decideranno i giudici e non i
giornalisti, chi lo risarcirà? Il Secolo XIX si sdegna per 'la mancanza di
rispetto dell’amico Beppe Grillo. Ieri il Movimento 5 Stelle che ha chiesto le
dimissioni di Paoli da presidente della Siae. La fretta con la quale Grillo ha
mosso i suoi, però, è sintomo di un giustizialismo cinico, per nulla
democratico". Io non ho "mosso i miei" contro Gino Paoli. Come ho scritto,
aspetto la magistratura prima di emettere qualunque giudizio, alla faccia degli
sciacalli dell’informazione. Sapore di sale".
Due pesi e due misure. Beppe Grillo difende Gino
Paoli, furia del M5s: e il post sparisce dal blog, scrive “Libero Quotidiano”.
Il post di
Beppe Grillo
con il quale difendeva
Gino Paoli
è sparito dal suo blog. Il post scritto dal leader M5S per difendere l'amico
indagato con l’accusa di aver evaso il fisco, non è più visibile in home page né
tantomeno nei link accessibili dalla colonna sulla destra. È possibile leggere
la difesa di Grillo tramite apposita ricerca sul blog, ma il post non è più
visibile agli internauti che aprono
beppegrillo.it. Una mossa
probabilmente dettata dall'esigenza di smorzare le polemiche degli attivisti che
sotto il post lo avevano attaccato accusandolo di usare due pesi e due misure.
"Tu hai espulso per molto meno", gli ricorda un militante con un commento sotto
l'artico contro gli sciacalli dell’informazione' che sbattono il mostro in prima
pagina. Un altro sottolinea che "difendere gli amici o attaccarli prima della
certezza del reato a mio parere è sbagliato". Un altro dice perentorio: "No. No
agli amici degli amici. L’onestà deve andare di moda, anche se i disonesti li
conosciamo di persona". C’è chi è ancora più tranchant: "Grillo ma cosa stai
dicendo? Ora siccome è tuo amico lo difendi? Stai prendendo una bella
cantonata". E chi senza mezzi termini scrive: "Mi stai disgustando, e pensare
che ti ho votato". E ancora, chi sarcastico spiega: "Anch’io vorrei spezzare una
lancia a favore di un mio caro amico, Pepp’ò stuort, anche lui di 80 anni ed
anche lui delegittimato da uno Stato che gli rema contro. I condizionali, i
congiuntivi e bla, bla, bla...". Un altro attivista M5S attacca: "Beppe, a
rischio di essere da te accusato di invecismo, ti dirò che invece ci dovresti
proprio stare, anche se davvero si trattasse di gioco al massacro! È vero o non
è vero che il M5S ha chiesto le dimissioni di Paoli dalla presidenza SIAE?! È
vero! E allora?! Allora non dire che non ci stai quando ci sei già stato!". Un
alto punta il dito: "Se ha rubato, e penso che lo abbia fatto, amico di Grillo o
no è un ladro come i politici i vari merdosi pieni di soldi. Se non lo ha fatto,
la verità uscirà, il Movimento non protegge gli amici di Grillo o amici di altri
se ha rubato in galera". Anche perchè, come scrive un altro militante 5 stelle,
"chi evade con intenzione e volontà le tasse è un ladro, non importa quanto. Chi
protegge un ladro è un complice. Chi ruba un pezzo di pane per non morire di
fame è un disperato, e molto probabilmente lo è proprio per colpa dei primi
due". Tra i pochi commenti che si schierano al fianco di Grillo, invece, c’è chi
se la prende con il giornalismo che "ormai in Italia è tutta una farsa, scrivono
sempre per ipotesi, tanto se dopo la persona è innocente i giornalisti se ne
fregano. Io da 5 anni non compro nessun giornale". E c’è chi fa dietrologia:
"Gino Paoli ha commesso il gravissimo errore di aver detto, durante
un’intervista recente, di condividere tutto ciò che dice Grillo. La stampa di
regime non poteva non fargliela pagare". O anche: "Insomma anche
Tiziano Ferro
e la Giannini
e chissà quanti altri hanno problemi con il fisco... Ho l’impressione - è la
tesi - che siano 'bombe' mediatiche per distrarre l’opinione pubblica dal
disastro renziano".
CINQUE STELLE CADENTI.
Beppe Grillo fa il garantista Ma solo con gli amici. Il comico assolve
Paoli ma condanna gli altri,
scrive Alberto Di Majo su “Il Tempo”. Ha chiesto le dimissioni di tutti. O
quasi. Non ha mai guardato in faccia nessuno. Dal presidente della Repubblica
(Napolitano) in giù. Non parliamo poi degli indagati. Li ha condannati su due
piedi, sul suo blog o in Parlamento. Non ha perdonato nemmeno i «suoi»: ha
espulso al volo dal MoVimento i consiglieri regionali finiti nelle inchieste
sulle presunte spese pazze dei gruppi politici. Ben prima che le indagini
finissero. Eppure stavolta, Beppe Grillo si scopre, improvvisamente, garantista.
Tanto da spiazzare gli stessi esponenti del MoVimento. Di fronte a Gino Paoli,
indagato per evasione fiscale, il comico è costretto a smentirsi da solo.
L’ammette lui stesso all’inizio del suo post: «Premetto che Gino Paoli è mio
amico da molti anni e che spesso le nostre famiglie si incontrano vivendo nella
stessa zona di Genova. Quindi potrei essere considerato poco obiettivo». Poi
aggiunge: «A questo gioco al massacro di una persona di 80 anni non
pregiudicato, mai inquisito, per alcunché, che mi risulti, io non ci sto! I
cittadini sono diventati vittime sacrificali, mostri da sbattere in prima pagina
senza che possano difendersi in alcun modo». Ovviamente se la prende con i
giornali: «Il Secolo XIX ha pubblicato un titolo di condanna che non ammette
replica: "Maxi evasione in Svizzera, blitz della Finanza a casa di Gino Paoli"
dal quale un lettore distratto evince che Paoli avrebbe evaso senza alcun dubbio
cifre persino superiori al Costituzionalista di Arcore condannato per truffa
fiscale. Nell’articolo si legge "Le Fiamme gialle stanno indagando su una
presunta maxi evasione in Svizzera". Quindi per ora "l’evasione è presunta".
Continuiamo: "Paoli risulta indagato: a metterlo nei guai sarebbero alcune
intercettazioni di conversazioni avvenute con il suo commercialista". Quindi
"sarebbero", che in italiano vuol dire forse che sì, forse che no». Ma tutte
queste precisazioni (giuste, visto che «indagato» non significa «condannato»)
perché Grillo non le ha mai sollevate per i politici che, negli anni, ha preso
di mira? Il comico attacca: «Nel caso Paoli risulti innocente, e questo lo
decideranno i giudici e non i giornalisti, chi lo risarcirà?». E chi risarcirà i
politici additati come «mafiosi» o «corrotti» da lui e dai 5 Stelle (ultimo il
ministro dell’Interno Alfano) senza che siano state emesse le sentenze? O chi
risarcirà gli ex 5 Stelle cacciati perché indagati? «Aspetto la magistratura
prima di emettere qualunque giudizio, alla faccia degli sciacalli
dell’informazione». In fondo, meglio tardi che mai.
Evadere sarà roba di destra
ma gli evasori sono di sinistra.
Visco spara sui moderati, ma dovrebbe guardare in casa propria. In quanti hanno
avuto guai con le tasse, scrive Gian Maria De Francesco su “Il Giornale”. «Le
tasse servono a finanziare i servizi pubblici e su questi temi la sinistra è
chiaramente più sensibile». L'ex ministro dell'economia, Vincenzo Visco, in
un'intervista concessa a Virus giovedì scorso, ha riproposto la propria
personale teoria sociologica (che poi è la stessa di tutti coloro che hanno il
cuore a sinistra e il portafogli dall'altra parte): «l'evasione è di destra».
Senza se e senza ma, per Bacco. A sentir queste parole parrebbe di capire che la
propensione a evadere sia un correlato genetico dell'uomo di destra. Esempio
fulgido ne sarebbero i veneti. «Un popolo per natura antistatalista», ebbe a
dire nel 2007 l'inventore del Grande Fratello fiscale che ficca il naso nel
nostro conto in banca e in tutte i meandri della nostra vita. Ma il
social-moralismo di Visco e dei suoi fans è una brutta bestia: l'etica e
l'estetica (come la fisica) si fondano su schemi e tesi soggettive che
l'esperienza spesso si incarica di smentire. E questo è il caso del nostro ex
ministro che ha parlato proprio nel giorno nel quale a Gino Paoli è stata
contestata una presunta evasione fiscale di 800mila euro per aver trasferito 2
milioni di euro in Svizzera senza dichiararlo. Le ironie sul web si sono
sprecate (tipo «Il cielo in una banca, quattro amici al bar e due milioni in
Svizzera») nei confronti dell'attuale presidente della Siae nonché ex deputato
Pci che poi s'è giustificato pure affermando «alle feste dell'Unità ero
costretto a prendere i soldi in nero» e, dunque, voleva rimpatriare i capitali
non scudati in maniera regolare. Ecco, basterebbe già questo forse per
dimostrare che un'icona della musica italiana e santino della sinistra (come
tutta la scuola cantautorale genovese) non sia poi moralmente e geneticamente
diverso da tutti gli altri. Però, se si analizzano alcuni fatti di cronaca più o
meno recenti, non è che nelle citazioni si ritrovino solo personaggi con la
tessera di Forza Italia o della Lega Nord negli elenchi, come Visco vorrebbe
darci a intendere. Tornando indietro di qualche giorno, nelle dichiarazioni
dell'inventore del Premio Grinzane Cavour, Giuliano Soria, emerge uno spaccato
non proprio edificante del rapporto tra sinistra politico-intellettuale e il vil
danaro. «Ho sostenuto l'allora sindaco Sergio Chiamparino in due occasioni», ha
dichiarato ai giudici della Corte d'Appello aggiungendo che la ex presidente
della Regione Mercedes Bresso «lo usava per le sue attività». Soldi per tutti
giornalisti, attori e artisti. «Corrado Augias, era assillante sui pagamenti in
nero: era vorace», ha aggiunto specificando che «partivo per Stresa con 100mila
euro per gli attori», tra i quali viene citata Stefania Sandrelli, oltre che ex
compagna di Gino Paoli nonché attiva partecipante ad alcune iniziative di Ds e
Margherita. Tutti coloro che sono stati citati da Soria hanno respinto al
mittente le accuse definendole calunnie. Sarà il magistrato a stabilire e ad
accertare. Ma non si può non rilevare come il governatore piemontese, Sergio
Chiamparino, abbia una storia tutta interna alla sinistra. E così pure per
Corrado Augias che ogni giorno su Repubblica offre ai lettori la sua
Weltanschauung. A proposito di Repubblica. Al gruppo Espresso, del quale è
presidente la tessera numero uno del Pd Carlo de Benedetti, è stata contestata
una presunta evasione fiscale da 225 milioni di euro. Un po' troppo per un
editore che in tutti questi anni ha imputato a Silvio Berlusconi di aver
corrotto la morale degli italiani. Ma, si sa, in Italia c'è chi è «inagibile» e
chi invece ha la fortuna di battere strade meno impervie. Eppure per lanciare
una fatwa bisognerebbe essere sopraffini esegeti, ma probabilmente nei testi
sacri dell'Ingegnere manca qualche pagina. Idem per il direttore del quotidiano
di Largo Fochetti, Ezio Mauro, «pizzicato» qualche anno fa a pagare parzialmente
in nero (circostanza mai smentita) un immobile a Roma. Anche il noto giornalista
utilizza spesso toni moraleggianti. Più che di etica della sinistra si potrebbe
parlare di etica luterana. Pecca fortiter sed crede fortius , diceva l'eretico
tedesco, ossia «Pecca fortemente, ma credi con ancora maggior vigore». Basta
strologare sulla destra e si è perdonati. Qualche atto di contrizione in più
dovrà recitarlo l'ex governatore sardo ed europarlamentare piddino, Renato Soru,
alias Mister Tiscali. All'imprenditore, in quanto presidente del gruppo tlc, è
stata attribuita una presunta evasione su un'operazione di prestito con una
controllata britannica. Il dibattimento inizia il 6 marzo, ma intanto sul buon
Soru pende una cartella Equitalia da 9 milioni dopo aver disatteso un accordo
con il fisco. Lo dicevamo all'inizio, essere di «sinistra» in Italia è come
avere uno speciale passaporto per l'oblio di tutto ciò che non è bellezza,
rigore, solidarietà, misura, amore per il prossimo, impegno. Vale per Lorenzo
«Jovanotti» Cherubini, referente ideologico del veltronismo che nel 1999
patteggiò una condanna per il reato di frode fiscale con un'ammenda di 1,2
milioni di vecchie lire: meno di 600 euro per chiuderla con un'omessa
dichiarazione di circa ventimila euro. «Io lo so che non sono solo anche quando
sono solo». Chissà se l'avrà cantata anche Pierino Tulli, imprenditore romano a
capo di un gruppo di cooperative al quale è stata contestata una maxievasione da
1,7 miliardi. E dire che Veltroni lo voleva presidente della Lazio al posto di
Claudio Lotito.
BELLA CIAO: INNO COMUNISTA
E DI LIBERTA’ DI SINISTRA.
Il testo di “Bella Ciao”.
Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in
montagna,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
E le genti che passeranno
Mi diranno «Che bel fior!»
«È questo il fiore del
partigiano»,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
«È questo il fiore del
partigiano
morto per la libertà!»
I testi di Faccetta nera e
Giovinezza che mai faranno cantare a scuola.
FACCETTA NERA
Se tu dall'altopiano guardi il
mare,
moretta che sei schiava tra
gli schiavi,
vedrai come in un sogno tante
navi
e un tricolore sventolar per
te.
Faccetta nera, bell'abissina
aspetta e spera che già l'ora
s'avvicina
quando saremo vicino a te
noi ti daremo un'altra legge e
un altro Re.
La legge nostra è schiavitù
d'amore
il nostro motto è libertà e
dovere
vendicheremo noi camice nere
gli eroi caduti liberando te.
Faccetta nera,
bell'abissina...
Faccetta nera, piccola
abissina,
ti porteremo a Roma liberata
dal sole nostro tu sarai
baciata
sarai in camicia nera pure tu.
Faccetta nera sarai romana,
la tua bandiera sarà sol
quella italiana,
noi marceremo insieme a te
e sfileremo avanti al Duce,
avanti al Re.
GIOVINEZZA
testo del 1922
Su, compagni in forti schiere,
marciam verso l'avvenire
Siam falangi audaci e fiere,
pronte a osare, pronte a
ardire.
Trionfi alfine l'ideale
per cui tanto combattemmo:
Fratellanza nazionale
d'italiana civiltà.
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza,
nel fascismo è la salvezza
della nostra libertà.
Non più ignava nè avvilita
resti ancor la nostra gente,
si ridesti a nuova vita
di splendore più possente
Su, leviamo alta la faccia
che c'illumini il cammino,
nel lavoro e nella pace
sia la vera libertà.
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza,
nel fascismo è la salvezza
della nostra libertà.
Nelle veglie di trincea
cupo vento di mitraglia
ci ravvolse alla bandiera
che agitammo alla battaglia.
Vittoriosa al nuovo sole
stretti a lei dobbiam lottare,
è l'Italia che lo vuole,
per l'Italia vincerem.
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza,
nel fascismo è la salvezza
della nostra libertà.
Sorgi alfin lavoratore
giunto è il dì della riscossa
ti frodarono il sudore
con l'appello alla sommossa
Giù le bende ai traditori
che ti strinsero a catena;
Alla gogna gl'impostori
delle asiatiche virtù.
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza,
nel fascismo è la salvezza
della nostra libertà
GIOVINEZZA
testo successivo
Salve o popolo di eroi,
salve o Patria immortale,
son rinati i figli tuoi
con la fe' nell'ideale.
Il valor dei tuoi guerrieri
la virtù dei pionieri
la vision dell'Alighieri
oggi brilla in tutti i cuor.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
della vita nell'asprezza, il
tuo canto squilla e va.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
del Fascismo è la salvezza per
la nostra libertà.
Dell'Italia nei confini
son rifatti gli Italiani,
li ha rifatti Mussolini
per la guerra di domani
Per la gloria del lavoro
per la pace e per l'alloro
per la gogna di coloro
che la Patria rinnegar.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
della vita nell'asprezza, il
tuo canto squilla e va.
I poeti e gli artigiani
i signori e i contadini,
con orgoglio di Italiani
giuran fede a Mussolini.
Non v'è povero quartiere
che non mandi le sue schiere,
che non spieghi le bandiere
del fascismo redentor.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
della vita nell'asprezza, il
tuo canto squilla e va.
Bella Ciao. A 4 anni.
Stamattina sono andato alla festa di fine anno dell’asilo di mio figlio qui a
Milano, scrive Nicola Porro. Ha quattro anni e come i suoi coetanei ha indossato
una maglietta colorata. Mi siedo e ascolto i cori che fanno le diverse classi:
canzonette regionali rappresentative dell’unità d’Italia. Il tema generale erano
i 150 anni dell’Italia e i bambini erano vestiti con magliette che formavano il
tricolore. La recita va avanti con un repertorio di classici: Va pensiero, il
Piave. E finalmente, si fa per dire, arriva Bella ciao. Si finisce poco dopo con
l’inno d’Italia. Vi devo dire che non è mi è piaciuta. Che razza di scuola
insegna ad un bambino di 4 anni, Bella Ciao?
Polemiche alle elementari
di Porta Nuova sulla decisione di far cantare agli alunni un
ritornello ispirato all' inno
partigiano. Bella ciao a scuola. «E noi disertiamo la festa». Alcuni genitori
minacciano di boicottare la recita di fine anno. Il preside: non è un canto
sovversivo, scrive Sacchi Annachiara su “Il Corriere della Sera”. Canteranno in
coro « Scuola ciao » . Per salutare i bambini di quinta elementare e dare l'
arrivederci a compagni e insegnanti. Si metteranno in ordine per classe, come
hanno imparato durante le prove. Il ritornello farà così: « Scuola ciao, scuola
ciao, scuola c i a o c i a o ciao » , sulle note della canzone partigiana Bella
ciao . E, a quel punto, un gruppetto di genitori minaccerà di andarsene.
Portandosi via anche i figli. Festa di fine anno con polemica, quella di oggi
alle elementari dei Bastioni di Porta Nuova. L' inno della Resistenza, scelto
come « base » per il commiato dei bambini, ha incontrato prima qualche
perplessità tra alcuni docenti e genitori per scatenare, poi, una vera e propria
ostilità. « Le maestre sono state povere di idee: potevano scegliere qualsiasi
altro motivo » . A parlare è la mamma d i uno dei 260 bambini iscritti. « Sono
di origini friulane, per me quella canzone ha un significato forte. Certo, qui a
Milano non ci sono ricordi drammatici come i nostri, ma è stato comun que un
errore clamoroso, una grave leggerezza. E la cosa peggiore è che questa vicenda
sarà strumentalizzata politicamente » . Polemiche o no, i bambini canteranno
comunque. La festa seguirà fedelmente il programma: giochi all' aperto, mostra
di manufatti e il grande coro finale. Lo ha deciso il preside dell' istituto,
Alberto De Donno: « Bella ciao non è un canto sovversivo o anticostituzionale,
fa parte della tradizione popolare. Certo, forse si poteva scegliere Ciao Mare ,
ma in ogni caso il nostro è un messaggio di auguri. Lo ripeto: non c' è nessuna
volontà di dividere o di colorare politicamente la festa dei bambini. Il brano è
stato scelto perché è molto orecchiabile » . Parole ribadite in una lettera
scritta dal preside a insegnanti e famiglie: « È un canto innocente » . E per
una nuova polemica ne riaffiora un' altra passata, quella sul presepe. « Sotto
Natale, all' ultimo minuto - è la replica di alcune mamme - ci è stato spiegato
che il presepe poteva offendere i bambini di religione non cristiana .
Risultato: non si è fatto. Ma se siamo noi quelli offesi, allora non succede
niente » . Sospira i l preside: « L' anno prossimo cercheremo di rendere più
unita la scuola: questi, evidentemente, sono segnali di sofferenza. Sono
dispiaciuto perché la festa voleva unire, non dividere. Speriamo solo che i
genitori non ritirino i bambini al momento del canto » .
Il caso segnalato da “La
Gazzetta di Modena”. “A scuola no ai canti di natale ma via libera a Bella
Ciao?”. Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) incredulo: «"Bella Ciao" insegnata ai
bambini delle elementari dove invece è vietato insegnare canti natalizi o
pasquali di matrice religiosa. Siamo in Italia o in Corea del Nord?». È quanto
si chiede incredulo Michele Barcaiuolo capogruppo Fratelli d'Italia - Alleanza
Nazionale che intende così denunciare pubblicamente qualcosa che non condivide.
«In questi giorni sono stato contattato da molti genitori che scandalizzati, mi
hanno segnalato l'atteggiamento che ormai in molte scuole modenesi gli
insegnanti hanno assunto nei confronti delle svariate festività civili o
religiose. - spiega - E' ormai noto a molti che sono moltissime le scuole
modenesi , che per non urtare "altre sensibilità" scelgono, in occasione di
festività come il S. Natale e la S. Pasqua di non insegnare ai bambini nessun
canto, nessuna poesia che abbia qualsiasi riferimento alla matrice religiosa
delle festività. Trovo questo atteggiamento e queste scelte incomprensibili,
sopratutto in Italia dove perfino un ultrà laico come Benedetto Croce sosteneva
"non possiamo non dirci cristiani per l'enorme influenza che la cultura, l'arte
e l'architettura cristiana hanno in una Nazione come l'Italia". Ma se possibile
, in questi giorni si sta facendo di peggio : in diverse scuole elementari di
Modena ci sono insegnati che stanno insegnando ai bambini a cantare "Bella Ciao"
come canzone prodromica a giustificare tutto ciò che e' stato fatto dai
partigiani. Non sono certo bambini di 7, 8 o 9 anni a dover approfondire le
pagine buie e le ombre della resistenza (cit. Giorgio Napolitano) ;ma certo
indottrinare dei bambini con la vulgata storica voluta da chi in questa città da
70 anni continua a fare il bello e il cattivo tempo non e' il modo migliore per
consegnare il domani alle nuove generazioni, sembra invece che a Modena ci siano
aspetti educativi che più che a guardare alla formazione dei bambini guardino
alla Corea del Nord». Voi che ne pensate?
“Bella Ciao. Controstoria
della Resistenza”.
Autore Giampaolo Pansa. Il 25 aprile chi va in piazza a cantare "Bella ciao" è
convinto che tutti i partigiani abbiano combattuto per la libertà dell'Italia. È
un'immagine suggestiva della Resistenza, ma non corrisponde alla verità. I
comunisti si battevano, e morivano, per un obiettivo inaccettabile da chi
lottava per la democrazia. La guerra contro tedeschi e fascisti era soltanto il
primo tempo di una rivoluzione destinata a fondare una dittatura popolare, agli
ordini dell'Unione Sovietica. Giampaolo Pansa racconta come i capi delle
Garibaldi abbiano tentato di realizzare questo disegno autoritario e in che modo
si siano comportati nei confronti di chi non voleva sottomettersi alla loro
egemonia. Quando si sparava, dire di no ai comunisti richiedeva molto coraggio.
Il Pci era il protagonista assoluto della Resistenza. Più della metà delle
formazioni rispondeva soltanto a comandanti e commissari politici rossi. "Bella
ciao" ricostruisce il cammino delle bande guidate da Luigi Longo e da Pietro
Secchia sin dall'agosto 1943, con la partenza dal confino di Ventotene. Poi le
prime azioni terroristiche dei Gap, l'omicidio di capi partigiani ostili al Pci,
il cinismo nel provocare le rappresaglie nemiche, ritenute il passaggio
obbligato per allargare l'incendio della guerra civile. La controstoria di Pansa
svela il lato oscuro della Resistenza e la spietatezza di uno scontro tutto
interno al fronte antifascista. E riporta alla luce vicende, personaggi e
delitti sempre ignorati.
Dalla piazza greca di Tsipras alla Francia di
Charlie Ebdo, dalle manifestazioni antigovernative in Turchia a quelle contro
Yanukovich in Ucrainia, fino ai cortei di Occupy Hong Kong.
Bella Ciao
viene cantata in tutto il mondo. Ma come è nata? Quando? Perché è diventata
globale?
Tutto il mondo (Italia
esclusa) canta in piazza Bella ciao. La storia Da Atene a Parigi, da Istanbul a
Hong Kong, la canzone della Resistenza diventa inno di libertà. Mentre nel
nostro Paese è ritenuta a torto solo un manifesto comunista, scrive Francesco
Merlo su “La Repubblica” A Parigi l'emozione di Bella Ciao è la resistenza della
libertà d'espressione alla barbarie dei kalashnikov, ad Atene accompagna
l'utopia populista di Tsipras, a Hong Kong scandisce l'opposizione alla Cina
comunista, a Istanbul canta la rivolta contro l'Islam autoritario di Erdogan.
Solo in Italia Bella Ciao è all'indice, confusa con Bandiera rossa e
L'Internazionale , e mai cantata, come si dovrebbe, con l'alzabandiera del 25
aprile, ma trattata come un inno comunista, degradata da canto laico della
liberazione e della concordia repubblicana a ballata dei trinariciuti, a
manifesto del Soviet italiano. E invece, nel mondo, la canzone della Resistenza
ha fatto la sua resistenza, e ha vinto, anche contro se stessa. È infatti evasa
dalla gabbia del braccio armato e del pugno chiuso con la forza della melodia
tradizionale, con quelle due parole "ciao" e "bella" che sono le password della
nostra identità, con i timbri e i toni che sono il meglio della leggerezza di
Sanremo, con la dolce malinconia del bel fiore sulla tomba, e ovviamente con il
partigiano morto per la libertà e non per "la rossa primavera" della falce e
martello e neppure per il sol dell'avvenire della filosofia classica tedesca.
Insomma Bella ciao ce l'ha fatta a riaccendere le emozioni originarie che la
resero colonna sonora della guerra partigiana al nazifascismo, quando fu
preferita a Fischia il vento , proprio perché, "era più ecumenica ". E la sua
storia e la sua memoria "la accreditano come la canzone che unifica le speranze
e le attese della democrazia" ha scritto Stefano Pivato in Bella ciao. Canto e
politica nella storia d'Italia ( Laterza, 2005). Fu insomma la canzone delle
forze politiche costituenti, tutte laburiste antifasciste e repubblicane, anche
se in modi diversi e tra loro conflittuali, ma tutte Bella ciao: un fiore di
montagna come educazione civica. E per capire che è tornata ad essere un inno
internazionale di libertà basta rivedere su Repubblica. it tutte quelle labbra
che a Parigi scandiscono "Una mattina / mi son svegliato / e ho trovato
l'invasor". Nessun professore comunista li dirige, nessun libro marxista li
ispira quando fondono Bella ciao e La Marsigliese dondolando e mixando "sotto
l'ombra di un bel fior" con gli evviva alla memoria degli artisti di Charlie
Hebdo, e senza mai andare né fuori tempo né fuori moda. Ed è emozionante la
compostezza del coro un po' stonato di Istanbul con tutti quei turchi che
battono il tempo con le mani: "E se io muoio / da partigiano / tu mi devi
seppellir " diventa resistenza al martirio di Kobane, agli arresti dei
giornalisti, all'oscurantismo religioso. È un contagio che arriva sino ad Atene,
si diffonde senza radio e senza Ipod, ricorda l'epoca euforica degli anni
Sessanta: Bella ciao come i Beatles, il vecchio canto della libertà italiana
come la musica dei progetti, delle illusioni e degli azzardi, il nostro fiore di
montagna contro il terrorismo in Europa, contro la mortificazione delle donne in
Turchia. E sorprende e diverte a Hong Kong la voce di un italiano contro la
violenza di quel terribile mondo arcaico che è la Cina. Certo, la storia di
Bella ciao era già una specie di leggenda. Agli inizi del Novecento fu il canto
delle mondine nelle umide risaie attossicate: "Oh mamma che tormento / io mi
sento di morir". E ci sarebbe persino una versione Yiddish incisa a New York nel
1919. Mille ricerche sono state fatte sul giro del mondo di questa canzone che è
stata folk, ebrea, swing e tradotta anche in giapponese Ma, come accade talvolta
in filologia, le ricerche riportano sempre al punto di partenza: Reggio Emilia,
1940. Nella geografia della memoria Bella ciao è infatti il luogo della
Resistenza condivisa, il ritmo della lotta antifascista che fu comunista,
cattolica e azionista, come la Costituzione. Ed è, Bella ciao, come "la
ballatetta" di Guido Cavalcanti, che "va leggera e piana" e "porterà novelle di
sospiri ... quando uscirà dal core ". Il dolce stil novo sapeva già, prima del
pop, che la canzonetta è una febbre musicale, e come l'acqua fresca sembra
niente ma è tutto, e se c'è nebbia fa vedere il sole, e dà coraggio a chi ha
paura. E, infatti, fischiettata o cantata in coro, Bella ciao ha sconfitto
quell'altra Bella Ciao , spacciata per eversione e per rivoluzione. Insomma il
fiore del partigiano fu, a torto, classificato, non come uno dei pochi canti
della democrazia , ma come politica cantata, accanto agli inni del movimento
operaio, "Su fratelli su compagni / su venite in fitta schiera", e alle canzoni
dolenti degli anarchici, "Addio Lugano bella / o dolce terra mia", e all'orrendo
inno che la Dc fece suo: "O bianco fiore / simbolo d'amore / con te la pace /
che sospira il core". I comunisti risposero: "Il 25 aprile / è nata una puttana
/ e le hanno messo nome / Democrazia cristiana ". Ecco, Bella ciao è un'altra
storia, e sembrava che lo avessero capito tutti. La cantarono infatti Claudio
Villa e Yves Montand, Gigliola Cinquetti, Francesco De Gregori e Giorgio Gaber,
canzone impegnata e canzone scanzonata. Finché i leghisti al governo di alcune
città del Nord (Treviso, Pordenone ...) proibirono di suonarla il 25 aprile. E
Berlusconi, più potente, tentò di abolire la festa della liberazione dal
nazifascismo sostituendola con la festa della liberazione da tutte le dittature.
E gli pareva che "Forza Italia/ perché siamo tantissimi " fosse più
nazionalpopolare di "È questo il fiore / del partigiano / morto per la libertà".
Le ha proprio viste tutte, la nostra Bella ciao . È stata persino stonata in tv
da Michele Santoro dopo l'editto bulgaro che lo cacciava dalla Rai con Biagi e
Luttazzi. In quell'Italia pazza la solita serva Rai arrivò persino al tentativo
di festeggiare i 150 anni dell'Unità suonando a Sanremo sia Bella ciao sia
Giovinezza, e di nuovo la canzone della Repubblica fu spacciata per inno
comunista attraverso il gioco della somiglianza- contrapposizione con l'apologia
del fascismo, suonata per par condicio... Ebbene Bella ciao ha superato anche
quell'oltraggio. E adesso che ha conquistato il mondo, forse riconquisterà anche
l'Italia.
Il fenomeno. "Bella ciao", da canto partigiano a
inno globalizzato. Dalla campagna elettorale di Tsipras alla solidarietà a
Charlie Hebdo, la canzone folk più nota della Resistenza varca i confini e si fa
sempre più attuale, scrive “la Gazzetta di Reggio”. "Bella ciao" eterna, anzi
sempre più attuale. La canzone folklorica cantata dai simpatizzanti del
movimento partigiano italiano durante e dopo la seconda guerra mondiale, che
combattevano contro le truppe fasciste e naziste, si è trasformata negli ultimi
anni in
un inno alla libertà,
risuonato un po' ovunque: dalle piazze in rivolta ai funerali, dalle
manifestazioni di piazza agli studi televisivi. Solo in Italia, scrive
Repubblica in articolo di Francesco Merlo, il canto è ancora oggi etichettato
come un "manifesto comunista". La circolazione di Bella ciao, durante la
Resistenza è documentata e sembra circoscritta soprattutto in Emilia. Dopo la
Liberazione la versione partigiana di Bella Ciao venne poi cantata e tradotta e
diffusa in tutto il mondo grazie alle numerose delegazioni partecipanti al Primo
festival mondiale della gioventù democratica che si tenne a Praga nell’estate
1947, dove andarono giovani partigiani emiliani che parteciparono alla rassegna
canora “Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace”, dove inventarono il
tipico ritmico battimano.
Giovanna Marini ricorda che
tutto nacque a Reggio Emilia,
dalla mondina Giovanna Daffini. Nelle scorse ore,
"Bella ciao" ha chiuso ad Atene la campagna elettorale per le elezioni politiche
di Alexis Tsipras, nella
versione dei Modena City Ramblers. «Siamo sempre molto colpiti dall'entusiasmo
che suscita Bella Ciao anche fuori dall'Italia. È la canzone che porta con sé
valori molto forti e sinceri». E se Tsipras dovesse vincere, la folk band
modenese annuncia che «canteremo Bella Ciao in greco». La famosissima versione
dei MCR era stata suonata anche all'ultima edizione di Festareggio al Campovolo.
Come inno alla libertà, "bella ciao" è stata rispolverata anche all'indomani
degli attentati terroristici di Parigi, ecco christophe Aleveque che la canta in
una trasmissione tivu di
solidarietà a Charlie Hebdo
e alle sue vittime. A Istanbul, "Bella ciao" è risuonata in piazza nell'ottobre
2013, adottata da Occupy Gezi: cantata in turco, ma con il ritornello in
italiano. E sempre nella capitale turca, ecco la band rivoluzionario-socialista
Yorum che la suona dal vivo con decine di artisti sul palco. Persino a Hong
Kong, il canto è stato rispolverato dalla Rivoluzione degli ombrelli, cantato
dal prete italiano Franco Mella.
Bella Ciao? Oggi la potrebbe
cantare anche Marine Le Pen, scrive Stefano Baldolini su L'Huffington Post.
Cantata in piazza Omonia dai sostenitori del divo Tsipras, a Parigi dai
cittadini colpiti a morte dalla strage di Charlie, "Bella Ciao" è tornata. O
meglio (fortunatamente?) non se n'è mai andata. Protagonista anche in passato,
in luoghi e situazioni improbabili e molto lontane tra loro, ma oggi la
coincidenza è evidente. È un destino dei classici esser rivisitati e non perdere
colpi, assumere connotati e senso diverso in funzione del contesto e del tempo.
È stato così anche per il nostro inno di Mameli, tabù della sinistra negli anni
in cui i nazionalismi erano tutti di destra e oggi intonato nei comizi e nelle
direzioni del Pd. Vittima del frullatore post ideologico, "Bella Ciao" può
essere cantata e strattonata da tutti, è talmente intensa e diretta da non
finire sgualcita. Ma cosa reclama "Bella Ciao" oggi? Certo, non può prescindere
da un afflato di libertà che è sempre preceduta da forme vitali di resistenza e
protesta ("È questo il fiore del partigiano Morto per la libertà"). Solo, che
oggi, da piazza Taksim a Occupy Wall Street, da Charlie a piazza Omonia, l'inno
partigiano è rivendicazione - in primis - di sovranità. Di rivendicazione della
propria sovranità di cittadini e popoli contro scelte imposte da altri, potenti
con nome e cognome o istituzioni senza volto. Erdogan o i lupi di Wall Street, i
terroristi integralisti che vogliono occupare lo spazio libero delle idee, la
Bce. Chiunque attenti all'occupazione - percepita come abusiva - dello spazio
individuale e collettivo, mentale o fisico, è considerato invasore. Da cacciare,
da respingere. Ecco perché non dovrebbe sorprenderci se un giorno, vicino o
lontano, un'esponente come Marine Le Pen, potrebbe cantarla. Non suoni come mera
provocazione, ma solo come una logica conseguenza. Non foss'altro per semplice
proprietà transitiva: se Marine Le Pen simpatizza per Tsipras e i sostenitori di
Tsipras cantano Bella Ciao, il passo successivo è nelle cose. Perché l'obiettivo
è lo stesso: quello di recuperare la sovranità del popolo contro "l'invasore"
sovra-nazionale. L'ha cantata, per scherno e impropriamente, Matteo Salvini,
contro "l'invasione degli immigrati", ma lo potrebbe fare - persino con maggiore
legittimità - la sua amica leader del Front National.
LIBERTA'. TERMINE VACUO.
PATRIA, ORDINE E LEGGE: SLOGAN CHE UNISCE DESTRA E SINISTRA.
Patria-ordine-legge lo slogan
che unifica destra e sinistra, scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”.
Quando si decide di fronteggiare l’emergenza terrorismo con nuove leggi speciali
– in uno Stato che annega, da anni, nelle leggi speciali – in realtà si realizza
un’operazione molto semplice: quella di approfittare dell’insorgenza di un
problema di sicurezza per ridurre il grado di libertà dell’intera comunità
nazionale. E’ così da sempre. Da sempre le classi dirigenti – o , almeno, una
parte consistente delle classi dirigenti – ritiene che per governare una società
complessa sia necessario evi- tare livelli troppo alti di libertà. Alle classi
dirigenti piace poco la libertà, per- ché la libertà, quando non è ingabbiata e
controllata e plasmata, crea problemi di ogni genere: di sicurezza, di
efficienza, di produttività, di gestione dell’economia, di difesa dei profitti.
E la libertà, rafforzata da un sistema di diritti eccessivamente sviluppato,
rende molto complicato il funzionamento – cioè il governo – sia dell’economia,
sia dello Stato, sia – più in generale – del potere. Quando dico le classi
dirigenti, non penso solo al ceto politico. Penso ai grandi manager, ai
capitalisti, ai giudici, ai militari, e a un pezzo molto molto vasto
dell’intellettualità e del giornalismo. E’ questo blocco, molto composito – sia
politicamente, sia socialmente, sia come formazione culturale – quello che si
compatta e diventa una testuggine che ogni volta produce nuove misure di
”blindatura” della libertà e di riduzione dello Stato di diritto. Una volta –
tanti anni fa – questo blocco era essenzialmente un blocco reazionario, che si
ispirava al principio di patria-ordine-legge. Ora le cose sono molto
diverse. La parte più robusta e propositiva del blocco, e che svolge la funziona
dirigente, è – seppure vagamente – catalogabile nella sinistra politica. La
parola d’ordine, più o meno, resta la stessa: patria-ordine-legge. Il
trasferimento in questo blocco di gran parte della sinistra politica
(sia moderata che radicale, con qualche sfumatura nelle parole d’ordine, perché
la sinistra radicale ha in uggia la patria, sopporta appena l’ordine, e ama solo
la legge, che usa chiamare ”legalità”) ha cambiato radicalmente il terreno dello
scontro politico sui questi temi. Anzi, ha più o meno cancellato sia il terreno
che lo scontro. Una volta c’era l’urto tra la destra legalista e la sinistra
libertaria. Ora lo scontro è tra un agglomerato fortissimo di pensiero unico,
che unisce – ad esempio- giornali diversissimi come Il Giornale e ”Il Fatto”, e
una piccola minoranza di ”sovversivi” , assolutamente minoritari anche dentro
l’opinione pubblica. Quando è avvenuta questa svolta? In realtà è successo
tanti, tanti anni fa. Quando in Italia imperversava la lotta armata – dico negli
anni settanta – e il più importante partito della sinistra, e cioè il Pci,
decise di schierarsi al fianco della magistratura per battere l’eversione. Il
risultato fu quello di lasciar passare senza fiatare, anzi, con un po’ di
godimento, un gran numero di leggi speciali, dette leggi d’emergenza, che hanno
modificato il Dna del nostro stato di diritto. Iniziò nel 1975, se non ricordo
male, con la famosa legge-Reale, che dava grandi poteri alla polizia, e
aumentava anche il potere della magistratura, e fu usata per stroncare i
movimenti di lotta di quel decennio. La Legge-Reale fu approvata quando la lotta
armata era ancora allo Stato nascente, e certo non servì per colpire la lotta
armata, servì per colpire l’estrema sinistra. Il Pci sostenne quella legge, con
la sola opposizione di uno dei suoi padri nobili – un personaggio eccezionale e
amabilissimo che ormai non si ricorda più nessuno, aveva 80 anni suonati e si
chiamava Umberto Terracini. D quel momento è stata una cascata di leggi
speciali. Contro il terrorismo, contro la mafia, contro la politica corrotta,
contro qualunque cosa capitasse a tiro. Leggi antiterrorismo, leggi sui pentiti,
ampliamento delle intercettazioni, carcere duro (41 bis) eccetera. E il nostro
paese, dove regnava il conflitto sociale ma anche un certo grado di libertà e di
liberalismo, divenne sempre più arcigno. I pentiti e le intercettazioni, come
sapete, oggi sono gli unici due strumenti di indagine giudiziarie. Sebbene tutti
sappiano che i pentiti quasi sempre mentono e che le intercettazione sono
immensamente discutibili, interpretabili, manipolabili o del tutto
incomprensibili. Ora siamo al nuovo atto. Lo spunto sono gli attentati francesi.
L’obiettivo dichiarato è la Jihad. Il risultato sarà un ulteriore arretramento
della nostra civiltà giuridica. Voi pensate che questa sia la strada per entrare
nella modernità?
OMOFOBIA E CACCIA ALLE
STREGHE. CARLO TAORMINA. QUANDO L’OPINIONE E’ DISCRIMINATA.
Taormina condannato per
aver detto “Non assumo gay”, libertà d’opinione a rischio,
scrive Riccardo Ghezzi su “Quelsi” L’avvocato Carlo Taormina è stato condannato
a pagare 10.000 euro di danni per una frase pronunciata durante una trasmissione
radiofonica. A comminarla è stato il giudice del lavoro di Bergamo, Monica
Bertoncini. Una notizia anomala, che crea pure un precedente nebuloso. Intanto
non è chiaro per quale motivo sia stato messo in mezzo un giudice del lavoro,
visto che non sussiste un caso di mobbing o di licenziamento per ingiusta causa.
Proprio per questo non si capisce chi sia davvero la parte lesa. Andiamo con
ordine: durante la trasmissione “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani e
David Parenzo, l’avvocato Taormina aveva definito i gay insopportabili,
fastidiosi e contro natura, sottolineando che non ne avrebbe mai assunto uno per
farlo lavorare nel proprio studio. Attenzione però: non ha licenziato un gay
solo a causa della sua omosessualità. Ha semplicemente formulato un’ipotesi,
esprimendo un’opinione. Taormina quindi è stato condannato per un reato
d’opinione, tipico dei paesi autoritari. Ma neppure per diffamazione, ma da un
giudice del lavoro. Dovrà pagare 10.000 euro. A chi? Al gay che ha licenziato?
No, perché non esiste. La parte lesa è “Avvocatura per i diritti Lgbt – Rete
Lenford”, una delle tante associazioni gay-friendly che strizzano l’occhio alla
sinistra, ma che forse proprio per questo si dimenticano di quelle libertà
individuali che dovrebbero far parte del loro patrimonio e dei loro ideali.
Associazioni che chiedono e rivendicano spesso giusti diritti, ma pretendono di
farlo cancellando la libertà di opinione e mettendo bavagli. Appurato che
iniziative giudiziarie di questo tipo sono utili anche a fare arricchire tali
associazioni, grazie a giudici compiacenti che gli danno ragione e condannano i
malcapitati querelati, proviamo ad analizzare quali sarà il reale impatto della
sentenza del giudice del lavoro:
1) Taormina continuerà a non
voler assumere gay, essendo questo il suo orientamento. E probabilmente non ne
assumerà mai qualcuno. Semplicemente, d’ora in poi eviterà di dirlo in pubblico.
Non a caso si chiamano “reati di opinione”.
2) L’omofobia vera o presunta
continuerà a esistere. I gay potrebbero continuare a essere discriminati
all’interno del mondo del lavoro, ma se non sono appoggiati dall’associazionismo
di sinistra non ne caveranno un ragno dal buco. Mentre i gay vengono
discriminati, ardite associazioni lgbt chiedono risarcimenti danni a personaggi
pubblici che parlano in radio ma non è dimostrato che facciano veramente ciò che
dicono. A meno che la Rete Lenford e il giudice del lavoro di Bergamo non
abbiano le prove che Taormina abbia discriminato omosessuali sul posto del
lavoro. 3) Si può ipotizzare che un gay che dichiari di non voler assumere
eterosessuali non verrebbe mai querelato né condannato, perché certe
discriminazioni vere o presunte non smuovono il magico mondo
dell’associazionismo
4) Un datore di lavoro che non assume gay o li discrimina sul posto di lavoro,
ma evita di dirlo in radio, continuerà a passare inosservato e ad apparire come
una persona di larghe vedute.
Ci sono poi risvolti
“tecnici”. Ad ipotizzarli è il sito Horsemoon Post, secondo cui Taormina potrà
chiedere il risarcimento per dolo o colpa grave. Il giudice del lavoro di
Bergamo non solo non ha tenuto conto dell’articolo 21 della Costituzione
italiana, ma ha del tutto frainteso il concetto di discriminazione. A questo
punto poco importa se Taormina abbia agito con scienza e coscienza per tendere
un trappolone alla magistratura usando i gay come “cavallo di Troia”, come
ipotizzato dall’Horsemoon Post, oppure se abbia espresso una sua reale opinione,
discutibile e antipatica finché si vuole, e solo ora s’è accorto di poter
diventare il paladino della libertà di opinione. Quello che conta è che questa
sentenza potrebbe fare storia, con implicazioni pesanti anche su quella che è la
responsabilità civile dei magistrati.
«Non assumo gay», Taormina
condannato per discriminazione.
La difesa del noto avvocato: «Esiste la libertà d’espressione, sancita dalla
Costituzione», scrive “Il Corriere della Sera”. Condanna per discriminazione
anche in appello per l’avvocato Carlo Taormina. La Corte d’appello di Brescia ha
infatti confermato la condanna che nell’agosto scorso il tribunale di Bergamo
aveva inflitto all’ex parlamentare: risarcimento di 10mila euro ad
un’associazione che tutela i diritti delle persone omosessuali e pubblicazione
sul Corriere della Sera della sentenza. Nell’ottobre del 2013, durante la
trasmissione «La Zanzara» di Radio 24, alla domanda del conduttore Giuseppe
Cruciani se avrebbe mai assunto un omosessuale nel suo studio, l’avvocato
Taormina aveva risposto «sicuramente no», precisando anche che «nel mio studio
faccio una cernita adeguata in modo che questo non accada». Anche nel caso si
fosse presentato nel suo studio un laureato a Yale, per Taormina non avrebbe
potuto lavorare nel suo studio: «Perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è
così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello
studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede», ha detto durante
la trasmissione. L’associazione «Avvocatura per i diritti Lgbti», rappresentata
dagli avvocati Caterina Caput e Alberto Guariso, aveva denunciato per
discriminazione Taormina e in primo grado aveva vinto. Ora la conferma della
condanna in appello. Secondo i giudici bresciani l’avvocato Taormina «ha
manifestato, pubblicamente, una politica di assunzione discriminatoria» e «si
tratta quindi di espressioni idonee a dissuadere gli appartenenti a detta
categoria di soggetti dal presentare le proprie candidature allo studio
professionale dell’appellante e quindi certamente ad ostacolarne l’accesso al
lavoro ovvero a renderlo maggiormente difficoltoso». Il fatto poi che Taormina
sia famoso e’ un’aggravante: «Questo non può che attribuire maggiore risonanza
alle sue dichiarazioni, e quindi, parallelamente, maggiore dissuasività».
Taormina nel ricorso in appello ha sostenuto che durante la trasmissione aveva
solo espresso un’opinione e che la libertà di espressione è sancito dalla
Costituzione. Per i giudici di Brescia, «è pure vero che l’articolo 21 della
Costituzione garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con
qualsiasi mezzo di diffusione, ma è altrettanto vero che questa libertà incontra
i limiti degli altri principi e diritti che godono di garanzia e tutela
costituzionale. E’ quindi evidente che la libertà di manifestazione del pensiero
non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati».
«Particolarmente contenta del risultato raggiunto». Così Maria Grazia Sangalli,
Presidente dell’associazione avvocatura per i diritti lgbti, associazione difesa
dagli avvocati Caterina Caput e Alberto Guariso. L’avvocato Caput ricorda come i
giudici abbiano affermato che l’articolo 21 «non può spingersi a violare altri
principi costituzionali che ha individuato nell’articolo 2 (tutela del singolo
cittadino nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, ovvero il
luogo di lavoro), 3 (principio di uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 35
(tutela del lavoro). La Corte ha interpretato le norme anti-discriminatorie alla
luce della stessa normativa europea e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, mentre in Italia, caso unico in Europa, si fatica ancora ad approvare
una legge che sanzioni penalmente i reati d’odio verso le persone omosessuali e
transessuali e a dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone
dello stesso sesso».
Omofobia, l'avvocato
Taormina condannato anche in appello: "Niente gay nel mio studio".
La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del giudice del lavoro
di Bergamo. Il legale dell'Avvocatura per i diritti Lgbt: "Finora in Italia non
avevamo registrato decisioni analoghe", scrive Ilaria Carra su “La Repubblica”.
L'avvocato Carlo Taormina «Niente omosessuali nel mio studio», aveva detto
l’avvocato Carlo Taormina. E anche in secondo grado i giudici lo condannano per
discriminazione. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza con la
quale, nell’agosto scorso, il giudice del lavoro di Bergamo aveva imposto all’ex
parlamentare di Forza Italia un risarcimento di 10mila euro a
un’associazione che tutela i diritti delle persone omosessuali. «Se la tenga lei
l’omosessualità... io non ne ho alcune né in simpatia né in antipatia, non me ne
frega niente, l'importante è che non mi stiano intorno (...). Mi danno fastidio.
(...) Parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente, è
una cosa assolutamente... eh... assolutamente insopportabile, guardi. È contro
natura»: sono alcuni stralci delle affermazioni che Taormina aveva rilasciato il
16 ottobre 2013 rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani e David Parenzo,
conduttori della trasmissione radiofonica La Zanzara in onda su Radio24.
Frasi nelle quali, secondo i giudici bresciani, manifestano «pubblicamente una
politica di assunzione discriminatoria», «espressioni idonee a dissuadere gli
appartenenti a detta categoria di soggetti dal presentare le proprie candidature
allo studio professionale dell’appellante e quindi certamente ad ostacolarne
l’accesso al lavoro ovvero a renderlo maggiormente difficoltoso». Aggrava il
fatto che Taormina sia noto al pubblico: «Questo non può che attribuire maggiore
risonanza alle sue dichiarazioni e quindi, parallelamente, maggiore
dissuasività». Esulta l’avvocato Alberto Guariso (Avvocatura per i diritti
Lgbt): «È un bel risultato, una sentenza importante perché sancisce la tutela
generalizzata delle persone che possono subire uno svantaggio anche da semplici
dichiarazioni. Annunci pubblici che secondo il giudice hanno un effetto di
limitare un’opportunità di lavoro, oltre che di una umiliazione personale. Sono
due gradi di giudizio conformi: sentenze analoghe in Italia finora non ce
n’erano». Come riporta il partale Redattore sociale, Taormina nel ricorso
in appello ha
sostenuto che durante la
trasmissione aveva solo espresso un'opinione e che la libertà di espressione è
sancita dalla Costituzione. Per i giudici di Brescia, invece, "è pure vero che
l'articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestare il proprio
pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, ma è altrettanto vero che questa
libertà incontra i limiti degli altri principi e diritti che godono di garanzia
e tutela costituzionale".
La reazione dei
lettori de Il Giornale alla condanna di Taormina, scrive “Gay
Burg”. Un tribunale ha condannato
Carlo Taorima per discriminazione nei confronti dei gay, ma i lettori de Il
Giornale pare non l'abbiano presa molto bene.
Ed è così che ch'è chi accusa la giustizia di voler imporre che i gay debbano
piacer per forza, chi invoca la responsabilità civile dei giudici per chiedere
la condanna chi ha emesso la sentenza o chi sostiene che non si sia nulla di
discriminatorio nel dire che «non si assumerebbero fr*ci». Qualcuno aggiunge:
«Ancora non esiste la legge contro la cosiddetta omofobia e già c'è chi la
applica?», lasciando evidentemente intendere che quegli insulti dovrebbero
rientrare nella tanto sventolata «libertà d'opinione». Non manca poi chi
sottolinea che lo studio dell'avvocato sia privato e rivendica come «in casa sua
uno possa decidere chi fare entrare». «Questi magistrati non hanno altro da
fare? -scrive un altro- Mi pare che ci siano cose ben più gravi da perseguire».
Già... perché perdere tempo con una causa in difesa dei gay quando la si
potrebbe lasciar andare in prescrizione per occuparsi delle più meritevoli cause
lanciate dai Giuristi per la Vita contro chiunque osi parlare di
omosessualità? A coronare il quadro non poteva mancare chi si dice pronto a
sostenere che i gay si auto-discrimino per il solo fatto di esistere: «Fino a
prova contraria -dice- chi ha fatto della "discriminazione" il suo verbo sono i
gay. Sono loro che si discriminano esattamente come afferma Taormina col loro
modo i esprimersi, col loro vestire, con le loro pagliacciate che vanno sotto il
nome di gaypride e l'elenco potrebbe continuare. L'orientamento sessuale
dovrebbe essere una cosa prettamente personale e intima, lo sbandierare la
propria omosessualità facendone un vanto è un insulto al buon gusto prima ancora
che all'intelligenza. Ma evidentemente è di moda e sopratutto "rende", infatti
ogni gay deve essere considerato come un discendente diretto di Pico della
Mirandola se non si vuole essere subito tacciati di omofobia. Ormai i gay hanno
ragione a prescindere e se sul lavoro sono nulli vietato dirlo e rimarcarlo».
Non è bello far notare le cose, ma quest'ultimo personaggio dovrebbe forse
notare come con il suo messaggio stia sbandierando la sua eterosessualità che,
stando al suo ragionamento, dovrebbe essere una cosa prettamente personale e
intima...Ma più di tutto è sempre interessante notare come a scrivere queste
frasi inaccettabili siano le stesse persone che si dico convinte che la legge
contro l'omofobia sia superflua dato che in Italia non c'è né omofobia, né
discriminazione.
Difesa liberale di Taormina
dal gay-correct, scrive di
Corrado Ocone su “L’Intraprendente”. C’è da restare allibiti. Non ho altre
parole per commentare la sentenza di
condanna
dell’avvocato
Carlo Taormina a 10.000
euro di multa per aver affermato, nell’irriverente trasmissione radiofonica
La zanzara,
che nel suo studio non avrebbe
mai assunto gay perché la
loro è una tendenza sessuale “contro natura”. Sia beninteso, sono anche allibito
del fatto che qualcuno pensi seriamente queste cose oggi, nell’anno di grazia
2014. Ma a parte il fatto che la vita è bella perché è varia, dovrebbe essere
chiaro che la libertà di opinione è un valore non negoziabile, è la libertà
senz’altro. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole e come vuole. E, se
non si è d’accordo con le idee di qualcuno, le si può sempre criticare. O, al
limite, evitare di andare a cena con lui. È
l’abc
del liberalismo e dell’Occidente,
direi. Tutto il resto è chiacchiera che lascerei alle Boldrini di turno. Ma già
sento l’obiezione dei
moralisti e
quella dei legulei appellantesi ad una legge realmente esistente e voluta da
alcuni sciagurati rappresentante di un Parlamento già da tempo delegittimato.
Costoro si appelleranno alla legge contro la “discriminazione”
e affermeranno che una cosa è avere un’opinione e altra cosa metterla in atto
favorendo nel mercato del lavoro un determinato tipo di persone. Quasi come se
il mercato del lavoro, così come ogni altro mercato, non fosse un luogo di
libera contrattazione ove tutti volta a volta produciamo, acquistiamo o vendiamo
prodotti o servizi in base ai nostri gusti e preferenze. Che se sono contrarie
alle idee dell’avvocato Taormina possono sempre censurarle nell’unico modo
possibile in un regime di libertà: non acquistando da lui i suoi
servizi legali,
anche se (è da dimostrare) fossero efficaci. Il fatto è che qui, in questo caso
da manuale, si saldano in una miscela esplosiva tutti i vizi italici: l’odio per
il privato (ognuno dovrebbe essere libero di fare quel che vuole a casa sua, in
questo caso nel suo studio di avvocato); una concezione sostanzialistica della
giustizia, a cui non viene semplicemente affidato il compito di far rispettare
poche leggi formali e universali ma addirittura quello di cambiare il mondo e di
punire per educare; una legislazione demagogica e velleitaria, volta a
soddisfare
ipocritamente il moralismo
di un’opinione pubblica spesso immatura; il
protagonismo di certi
magistrati. È con
l’acquiescenza stupida di un’opinione pubblica che, quando non è immatura, è
sicuramente dormiente, che, poco alla volta, ci costruiamo le catene che
limiteranno sempre più in futuro la nostra libertà. Sarebbe necessario fermarsi,
ora che siamo ancora in tempo..
Libertà di pensiero. Anche per Carlo Taormina.
Fatali le frasi contro i gay pronunciate a Radio24, scrive
Alessandro Mlòn su “Il
Tempo”. E' partita la caccia al Taormina. Brutto, sporco e cattivo. E pure
razzista, becero e discriminante. Sarà. Forse sì. O magari no. Sta di fatto che
la
condanna
da 10.000 euro inflitta all'Avvocato Professore, già Principe di Filettino, è
ridicola e grave al tempo stesso. Ridicola, perchè Taormina ha espresso
un'opinione prettamente personale, senza passare ai fatti. Grave, perchè crea un
pericoloso precedente in materia di discriminazione per
motivi razziali, etnici, religiosi e di natura sessuale. O presunti tali. Le
affermazioni del Proff - pronunciate a La
Zanzara il 26 ottobre 2013
(Niente omosessuali nel mio studio) - seppure condite dall'oramai consueta ed
inconfondibile coloratissima irriverenza del Taormina 2.0 - non possono e non
debbono in alcun modo rappresentare prova inconfutabile di reato per chicchessia
cittadino del Belpaese. Incluso il Principato di Filettino. Perchè basterebbe
semplicemente addurre che l'avvocato non è in alcun modo passato ai fatti per
contraddire e confutare l'assoluta ipocrisia di una condanna che ha tutte le
sembianze di esser stata più punitiva che legislativa. Come aver voluto dare una
bella e sana lezione morale ed educativa al malvagio e disumano professor
Carlo. Mentre una norma si applica a rigor di legge, in punta di codice, e
attraverso il tanto acclamato e propagandato Stato di diritto. Non certamente
perchè un individuo, tanto discutibile e spietato per quanto l'opinione pubblica
possa dipingerlo, risulti simpatico od antipatico, buono o cattivo, liberale o
conservatore, pro o contro i gay. Questo è il punto, cara giudice del lavoro di
Bergamo Monica
Bertoncini, che ne
ha ordinato l'irrisoria e simbolica ammenda (roba che se voleva dar l'esempio
almeno 100.000 dovevano essere, gli euri) e pure lei, cara Associazione per i
diritti Lgbt-Rete
Lenford, cui vanno i
diecimila danari, oggi così trionfalista e su di giri per questa
illusoria quanto controproducente vittoria anti-omofobia. Il punto è che anche
il cittadino privato Carlo Taormina ha l'assoluta facoltà di esprimere la sua.
Potendo in tutta libertà pronunciarsi su qualsivoglia argomento, dal calcio alla
politica, dall'economia alle case chiuse, dalle lesbiche ai transessuali. E' ha
tutto il fottutissimo diritto di aborrare i matrimoni gay, di schifare con tutta
l'anima il Gay Pride, di ritenere gli omosessuali malati e contro natura, e pure
di dichiarare al mondo intero di non voler assumere lavoratori omosex. Con buona
pace del più esimio ed autorevole Ordine professionale, e anche delle infinite
sigle d'associazionismo gay. Perchè Carlo Taormina è un privato cittadino, e non
deve dare ne' fornire alcun esempio morale od educativo, se non nel rispetto
della propria deontologia professionale. Perchè Carlo Taormina ha lo stesso
potere di parola ed espressione che ha ogni altro libero cittadino italiano.
Incluso quello di dire e manifestare la propria ripugnanza ed abominio, o quello
che ai più viene considerato una sparata, una boiata pazzesca, una mostruosità.
E, ancora, perchè Carlo Taormina ha detto semplicemente ciò che pensava, e che
pensa. Senza sbatter la porta in faccia ad alcun gay. Senza pestare due uomini
che si baciavano. Senza bloccare o fermare alcun carneval
pride. E questo, Signori della
Corte, si chiama libera
manifestazione del proprio
pensiero. E non può essere considerato reato. Perchè non rappresenta reato.
Questa condanna, da ascrivere in toto alla più classica ed insopportabile
ipocrisia made in Italy, rischia seriamente (eufemismo) di sortire l'effetto
opposto ai sensi della lotta all'omofobia che le associazioni gay si prefiggono.
Primo, perchè viene fatta pubblicità gratuita alle frasi di Taormina, che ora
può avvalersi di tutto lo spazio possibile per rilanciare, passando da carnefice
a vittima predestinata del sistema. Secondo, perchè comunque l'avvocato potrà
sempre 'respingere' le candidature gay che si presentano nel proprio studio,
adducendo le più svariate e plausibilissime giustificazioni, senza che nessuno,
tanto meno Grillini &
co., possa venirne a conoscenza, e senza che ciò costituisca in alcun modo
discriminazione alcuna. Terzo, perchè alle parole si risponde con le parole, mai
con le sentenze. Ultimo, ma non per importanza, perchè tutto questo ennesimo non
richiesto polverone sulle presunte questioni omofobe, non fa altro che
discriminarli, i gay. Perchè la legge li considera 'hors
categorie'. Perchè così appiano
come una lobby, o ancora peggio come una casta. E perchè gli si toglie la loro
legittima e sudatissima conquistata normalità. Etichettandoli dentro un
ghetto giuridico e morale che anche loro - siamo pronti a scommetterci -
rifiutano e combattono quanto noi.
LA SCUOLA
DELL'INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO.
La sinistra si batte per
eliminare ogni simbolo che inneggia all'italica tradizione ed appartenenza in
nome di una sudditanza ideologica e strumentale.
Storia del crocifisso nelle
scuole pubbliche italiane di Rosci Valentina su “Diritto”. L’esposizione dei
crocifissi nelle scuole pubbliche viene disposta mediante circolare con
riferimento alla Legge Lanza del 1857 per la quale l’insegnamento della
religione cattolica era fondamento e coronamento dell’istruzione cattolica,
posto che quella era la religione di Stato. L’esposizione del crocifisso negli
uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n.
250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e
Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “Collocazione del
crocifisso nelle aule di udienza”, che recita: “Prescrivo che nelle aule
d’udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re
sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra tradizione. Il simbolo venerato
sia solenne ammonimento di verità e giustizia. I capi degli uffici giudiziari
vorranno prendere accordi con le Amministrazioni Comunali affinché quanto
esposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte quale si conviene
all’altissima funzione della giustizia”. In materia scolastica si ricordano, le
norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 del 1924 (relativamente agli
istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 1928
(relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni
aula abbia il crocifisso. Con circolare n. 367 del 1967, il Ministero
dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento della scuola
dell’obbligo anche i crocifissi. Nei Patti Lateranensi e successivamente nelle
modifiche apportate al Concordato con l’Accordo ratificato e reso esecutivo con
la L. 25 marzo 1985 n.121, nulla viene stabilito relativamente all’esposizione
del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule
del tribunale e negli altri luoghi nei quali il crocefisso trova ad essere
esposto. Con parere n. 63 del 1988, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito
che le norme dell’art 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. del
26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule
scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova
regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica. Ha
argomentato il Consiglio di Stato: premesso che “il Crocifisso, o più
esattamente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il
simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come
valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le
norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e
non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche
considerare – continua il Consiglio di Stato – che la Costituzione Repubblicana,
pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive
alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il
Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del
patrimonio storico”. Le norme citate dovrebbero, però, ritenersi implicitamente
abrogate dal d.lgs. 297/94 in cui all’art. 107, nell’elencazione puntuale delle
suppellettili che compongono l’arredo si fa riferimento esplicito solamente
all’attrezzatura, l’arredamento e il materiale da gioco per la materna. In modo
più chiaro ed esplicito l’art. 159 stabilisce “Spetta ai comuni prevedere al
riscaldamento, all’illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle
spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale
didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le
biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri
e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari…”. L’art. 190
stabilisce che “i Comuni sono tenuti a fornire (…) l’arredamento” dei locali
delle scuole medie. Nessun riferimento al crocifisso. Sicchè si potrebbe
sostenere che le norme dell’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C
del R.D. n. 1297 del 1928, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art.
15 preleggi, perché il d.lgs. 297/ 94 regola l’intera materia scolastica.
Tuttavia restano in vigore in forza dell’art. 676 dello stesso decreto
intitolato “norme di abrogazione” il quale dispone che “le disposizioni inserite
nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle
non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od
incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Orbene, alla
specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali “arredi”
ovvero “arredamenti” contenute negli artt. 107, 159 e 190 concorrono le due
disposizioni regolamentari citate, comprendendovi anche il “crocifisso”. Così si
può affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, come specificate dalle
norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici.
Conclusivamente, poiché non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità
con norme sopravvenute, né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera
materia, già regolata da norme anteriori, né, come ha ritenuto il Consiglio di
Stato, attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono
attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, le
disposizioni di cui all’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e quelle allegato C
del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, devono ritenersi legittimamente operanti. La
Corte di Cassazione (Sez. III, 13-10-1998) ha affermato in particolare, che non
contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione,
la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche: “Il principio della libertà
religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a
nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso
ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando
che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la
prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un
contenuto contrastante, con l’espressione di detta libertà: condizione questa,
non ravvisabile nella fattispecie”, nella quale si discuteva della lesività del
principio di libertà religiosa proprio ad opera dell’esposizione del crocifisso
nell’aula scolastica adibita a seggio elettorale. In una recente decisione,
invece, la Cassazione ha ritenuto contraria al principio di laicità
l’esposizione dei crocifissi nei seggi elettorali, prendendo ad esempio una
decisione del Tribunale Costituzionale tedesco del 1995. Escluso che l’articolo
9 del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica – in cui la Repubblica italiana
prende atto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano” – possa costruire idoneo fondamento normativo alla prassi
amministrativa in materia, la Suprema Corte rigetta anche la “giustificazione
culturale”, contraddicendo espressamente l’avviso del Consiglio di Stato. Non è
sostenibile, infatti, “la giustificazione collegata al valore simbolico di
un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva”, per il contrasto in essa
implicito con il divieto delle differenziazioni per motivi religiosi. È lecito
esporre un crocifisso in un’aula scolastica, in un tribunale o in un ufficio
pubblico, questa scelta può offendere la coscienza del non credente o
dell’appartenente ad una confessione religiosa contraria a tale simbologia?
L’esposizione contraddice la “laicità dello Stato”? E a che tipo di simbologia
deve essere ascritto il crocifisso: identità religiosa o culturale? Nel corso
dell’anno scolastico 2002-2003, Adel Smith, cittadino italiano di religione
musulmana, domanda all’insegnante della scuola di Ofena (in provincia di
L’Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla
parete o, in subordine, di appendervi un quadretto con la sura del Corano.
L’insegnante accondiscende a questa seconda richiesta, ma viene smentita dal
dirigente scolastico il quale impone di rimuovere il quadretto. Assistito da un
avvocato, Adel Smith ricorre al Tribunale di L’Aquila per ottenere un
pronunciamento d’urgenza. Investito della questione, il Tribunale ribadisce il
carattere laico della Repubblica italiana e delle sue istituzioni e il 23
ottobre decreta la rimozione del crocifisso. Un’ordinanza successiva ha invece
revocato tale rimozione poiché ha ritenuto che l’istanza presentata non
integrasse una domanda “meramente risarcitoria”, ma si concretizzasse nella
richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella
gestione del servizio scolastico, dal che la sussistenza della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La rimozione del crocifisso scatena
un’aggressiva polemica pubblica e una vera e propria campagna per il rilancio
del crocifisso così che la maggior parte degli italiani hanno fatto questo tipo
di ragionamento: “L’offesa è grande. Insopportabile. Una prevaricazione. Un
esproprio. Un Tizio entra nel tuo alloggio, si accomoda in poltrona, ha libero
accesso al frigorifero, usa il tuo bagno e invece di ringraziare per
l’ospitalità, ti ingiunge di togliere dalla parete quel “coso” lì. Sarà anche un
coso ma permetti decido io se deve restare lì o sparire”. Un ragionamento un po’
rozzo ma tale vicenda ci fa comprendere che oggi la questione dei simboli
religiosi, a partire dal sostrato argomentativo connesso alla rivendicazione
della libertà di coscienza e della neutralità dello Stato, può trasformarsi in
un momento di “scontro tra religioni e civiltà”. Una questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata dal TAR del Veneto, avente ad oggetto gli artt.
159 e 190 del d. lgls. n. 297 del 1994, come specificati dall’art. 119 allegato
C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n.
965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi scolastici,
nonché l’art. 676 d.lgs. 297/94, nella parte in cui conferma la vigenza degli
artt. 119 allegato C del R.D. 1297/28 e 118 del R.D. 965/24. Il Tribunale
remittente sostiene che il crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso
cristiano, di univoco significato confessionale, che l’imposizione della sua
affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio
supremo di laicità, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, e
con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse
confessioni che lo Stato deve mantenere; che la presenza del crocifisso, che
verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti,
delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle
altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di
privilegio. La Corte Costituzionale con ordinanza 389/2004 ha ritenuto di non
doversi pronunziare in quanto le norme in esame hanno natura regolamentare,
norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato
di legittimità costituzionale, né conseguentemente, un intervento
interpretativo. In questa prospettiva, l’ordinanza della Corte, con le sue
argomentazioni tecniche, pare suggerire un inasprimento di toni senza rinunciare
a continuare ad interrogarsi. Tuttavia il dibattito in corso sull’esposizione
del crocifisso pare sempre meno legato alla religione, alla religiosità e alla
fede e invece strumentalizzato dai politici di destra e di sinistra.
Crocifisso a scuola, assolta
l'Italia. Ribaltata la condanna del 2009. Chi ha ragione? si chiede G. Galeazzi
su su “La Stampa”. Il crocefisso può restare appeso nelle aule delle scuole
pubbliche italiane. Questo è quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti
dell’uomo, che con una sentenza definitiva della Grande Camera, votata da 15
giudici su 17, ha dichiarato che la presenza in classe di questo simbolo non
lede nè il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie
convinzioni, nè il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o
di religione. Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria
a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di
manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento
delle tradizioni sia molto ampio. Ma i quindici giudici che hanno votato a
favore della piena assoluzione delle autorità italiane sono andati oltre. Nella
sentenza si legge infatti come la Corte non abbia trovato prove che la presenza
di un simbolo religioso in una classe scolastica possa influenzare gli alunni. E
come nonostante la presenza del crocefisso (definito simbolo passivo) conferisca
alla religione maggioritaria una visibilità preponderante nell’ambiente
scolastico, questo non sia sufficiente a indicare che sia in atto un processo di
indottrinamento. Si sottolinea infatti che nel giudicare gli effetti della
maggiore visibilità data al cristianesimo nelle scuole si deve tener conto che
nel curriculum didattico non esiste un corso obbligatorio di religione cristiana
e che l’ambiente scolastico italiano è aperto ad altre religioni. Nessun
commento dall’avvocato Nicolò Paoletti, difensore di Soile Lautsi, la cittadina
italiana di origini finlandesi che aveva presentato ricorso alla Corte.
Dichiarazioni euforiche, invece, di coloro che hanno strenuamente difeso
l’importanza della presenza del crocifisso nelle scuole italiane. «È una pagina
di speranza per tutta l’Europa», ha commentato monsignor Aldo Giordano appena il
presidente della Corte di Strasburgo, Jean Paul Costa, è uscito dall’aula dopo
la lettura della sentenza. Il rappresentante della Santa Sede presso il
Consiglio d’Europa ha quindi sottolineato come la Corte abbia preso una
posizione coraggiosa e abbia tenuto conto delle preoccupazioni che in questo
momento gli europei esprimono nei riguardi delle loro tradizioni, dei loro
valori e della loro identità. Gli ha fatto eco il vice ministro della giustizia
russo, Georgy Matyushkin, che è intervenuto davanti alla Grande Camera in favore
dell’Italia ed è volato appositamente da Mosca per assistere alla lettura della
sentenza. Il minisro russo si è detto «molto soddisfatto per l’approccio della
Corte». Ma anche il direttore dello European Centre for Law and Justice, Gregor
Puppinck, ha definito la sentenza «un colpo che mette un freno alle tendenze
laiciste della Corte di Strasburgo e che costituisce un cambiamento di
paradigma». Lo European Centre for Law and Justice era una delle organizzazioni
no profit che si erano costituite parte terza a favore dell’Italia nel
procedimento. Alla lettura della sentenza, che è avvenuta in un’aula piena di
studenti e funzionari del Consiglio d’Europa, erano presenti anche
l’ambasciatore italiano Sergio Busetto, oltre agli ambasciatori cipriota e greco
e ai rappresentanti della diplomazia armena, lituana, e di San Marino. Tutti
Paesi che assieme a Bulgaria, Romania, Malta e Principato di Monaco erano
intervenuti a favore dell’Italia. La sentenza emessa oggi mette la parola fine
al ricorso «Lautsi contro Italia». Un fascicolo che fu aperto dalla Corte nel
2006 e che nel 2009, con una sentenza in primo grado a favore delle tesi della
ricorrente, suscitò una vera alzata di scudi contro la Corte. L’indignazione fu
tale che il governo italiano ricorse immediatamente, chiedendo e ottenendo la
revisione del caso da parte della Grande Camera. In questo suo appello, andato a
buon fine, l’Italia ha potuto contare non solo sui dieci Paesi che
«ufficialmente» si sono presentati come parti terze davanti alla Corte, ma anche
sul contributo di diverse ong, di parlamentari italiani ed europei e del lavoro
diplomatico condotto dal rappresentante della Santa Sede. «Esprimo profonda
soddisfazione per la sentenza della Corte di Strasburgo, un pronunciamento nel
quale si riconosce la gran parte del popolo italiano. Si tratta di una grande
vittoria per la difesa di un simbolo irrinunciabile della storia e dell’identità
culturale del nostro Paese», ha dichiara il ministro dell’Istruzione,
Mariastella Gelmini. «Il Crocifisso sintetizza i valori del Cristianesimo, i
principi sui cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà occidentale: il
rispetto della dignità della persona umana e della sua libertà. È un simbolo
dunque che non divide ma unisce e la sua presenza, anche nelle aule scolastiche,
non rappresenta una minaccia nè alla laicità dello Stato, nè alla libertà
religiosa. Oggi è un giorno importante per l’Europa e le sue istituzioni che
finalmente, grazie a questa sentenza, si riavvicinano alle idee e alla
sensibilità più profonda dei cittadini», ha concluso il ministro.
Toglie il crocifisso
dall’aula. «Non me ne faccio nulla». Il simbolo religioso scompare pochi giorni
dopo l’inizio della scuola. Gragagnani (Pdl): «Va rimesso, è una questione di
libertà», scrive Francesco Alberti su “Il Corriere sella Sera”. Il caso di
un’insegnante in una prima elementare. Il simbolo religioso scompare pochi
giorni dopo l’inizio della scuola. Gragagnani (Pdl): «Va rimesso, è una
questione di libertà». Via un altro. L’ennesimo. Tolto dalla parete a cui era
appeso da anni. E scoppia la polemica. C’è chi parla di «strage dei crocifissi».
E chi, più laicamente, si rifugia nel concetto di tolleranza e invita al
reciproco rispetto. Siamo a Bologna, nella scuola elementare «Bombicci», classe
prima B. Il simbolo religioso scompare pochi giorni prima dell’inizio delle
lezioni. Qualcuno, probabilmente dall’interno della scuola, avverte l’ex
parlamentare pdl Fabio Garagnani, personaggio piuttosto combattivo in materia,
che parte in quarta, informando della rimozione il ministro dell’Istruzione,
Maria Chiara Carrozza, e il vicedirettore regionale dell’ufficio scolastico,
Stefano Versari. Per nulla scandalizzato invece il preside del comprensivo di
cui fa parte la scuola, Stefano Mari: «Non esiste alcuna legge dello Stato che
impone l’obbligo di ostensione del crocifisso, ma solo un regolamento del 1928
sugli arredi scolastici, poi superato nel 1999 da norme che conferiscono
autonomia ai singoli istituti: dipende dalla sensibilità dei docenti». A riprova
di ciò, prosegue il dirigente, «negli istituti che fanno parte del mio
comprensivo, che riunisce 1.400 studenti tra elementari e medie, in moltissime
aule il crocifisso non c’è mai stato o è stato tolto, mentre in altre è
presente». Un processo graduale, aggiunge, «avvenuto negli ultimi anni e quasi
passato inosservato in un clima di reciproca tolleranza tra chi lo avrebbe
voluto e chi no». Fino ad oggi. Ora la polemica rischia di montare. Il giornale
dei vescovi, Avvenire , censura l’episodio, ricorda l’ordinanza del 2011 della
Corte di Strasburgo che impose a una scuola media di Abano Terme (Padova) di
riappendere il crocifisso, ma soprattutto riporta le parole di un calibro da
novanta come il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli,
il cui parere giuridico è agli antipodi di quello del preside Mari: «Non è
rimesso alla scelta di qualcuno se togliere o meno il crocifisso - afferma il
giurista -, non ci possono essere interpretazioni da scuola a scuola. Se è vero
che la regolamentazione vigente sui simboli religiosi, che li vuole affissi
nelle aule, può sembrare datata, è altrettanto vero che, chiamato a esprimersi,
il Consiglio di Stato ne ha riaffermato la validità». Ma il preside insiste:
«Credo che la questione vada risolta a livello amministrativo, è finito il tempo
in cui tutto veniva deciso centralmente dal ministero». L’insegnante che ha
tolto il crocifisso preferisce non esporsi. Raccontano che a chi le chiedeva
spiegazioni sulla rimozione del simbolo avrebbe sbrigativamente risposto «di non
farsene nulla». Il preside fa da scudo: «È inevitabile che sia turbata dalle
polemiche, ma continua il suo lavoro e per ora non si registrano proteste dalle
famiglie degli alunni». Ma Garagnani incalza: «È un problema di libertà, i
genitori non si facciano intimidire».
Ma non solo oil crocifisso si
vuol togliere. Anche il Presepe.
Il sottosegretario
all'Istruzione: "Sì al presepe a scuola; vietarlo non aiuta l'integrazione".
Gabriele Toccafondi, coordinatore regionale Ncd Toscana, sottosegretario di
Stato all’Istruzione, e l'intervento su La Nazione: "Non interrompiamo le nostre
tradizioni". Caro direttore, ho seguito con attenzione le inchieste dedicate da
La Nazione ai “presepi vietati” nella nostra città. Questo tema ci permette di
affrontare un dibattito sul rapporto tra identità e cultura nei Paesi
occidentali secolarizzati e multiculturali, sui concetti di accoglienza e di
dialogo. L’idea che per rispettare le altre culture e religioni sia necessario
rinunciare alle proprie tradizioni, o rinnegarle, è un’idea decisamente
bizzarra, che mai ha fatto parte della storia delle civiltà, e che si è
affacciata nel mondo occidentale solo da pochissimi anni. Vietare il presepe non
aiuta né il dialogo né l’integrazione, ma anzi sottolinea le differenze,
allontana mondi che invece dovrebbero conoscersi e avvicinarsi. Come facciamo a
dialogare con gli immigrati di altre culture e tradizioni, che vengono a vivere
da noi, se non siamo in grado di trasmettere loro la nostra civiltà, le nostre
usanze e le nostre credenze, ciò che abbiamo di bello? Il Natale è la memoria di
un fatto storico e non solo un avvenimento di fede per molti credenti. E’
talmente un fatto riconosciuto e universale che ai bambini non puoi nascondere
che si festeggia qualcosa durante Dicembre e così pur di nascondere la nascita
di Gesù dentro una grotta in alcune scuole ci si inventa qualcosa da
festeggiare: dall’albero di natale, alla neve fino a bizzarre creazioni come il
topolino che porta i doni ai poveri o al pesciolino rosso dentro l’acquario. Non
sarebbe più semplice dire le cose come stanno? E poi, sono davvero così sicuri,
questi presidi e insegnanti che vietano il presepe, che gli alunni stranieri e
le loro famiglie siano contrarie alla realizzazione della capannuccia negli
istituti educativi? Io ricordo che proprio qui, a Firenze, esponenti di rilievo
della comunità islamica locale dissero, qualche anno fa, che era opportuno e
formativo che i loro figli potessero conoscere usanze e tradizioni del Paese in
cui erano venuti a vivere. Impedire la realizzazione di un presepe in una scuola
è un atto che reputo privo di ragioni, di un malinteso senso di laicità, che si
nasconde dietro la presenza di alunni stranieri o di altre religioni, ma che
nulla ha a che vedere con una sana laicità positiva, in grado di accogliere e
valorizzare, non di censurare. Come stabilito anche dalla sentenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo del 2011, neppure il crocifisso esposto nelle aule
scolastiche viola il principio della laicità degli istituti educativi. Che male
può fare un simbolo come il presepe? Mi auguro che i docenti e dirigenti
scolastici che hanno impedito a tanti bambini di avere una capannuccia nelle
loro scuole, riconsiderino la loro decisione, in questi ultimi giorni prima del
Natale: perché un vero dialogo con chi appartiene a tradizioni culturali diverse
si può impostare solo valorizzando e facendo conoscere le radici più profonde
della nostra identità.
Il presepe, bersaglio
sbagliato, scrive Edoardo Crisafulli su “Avanti On line”. Un Preside ha vietato
il Presepe, “un focus cerimoniale e rituale che può risultare soverchiante”: gli
alunni di origine straniera, cospicua minoranza nella sua scuola, subirebbero
l’imposizione di “ciò che non appartiene” loro. Concordo sul fatto che “la
scuola pubblica è di tutti e non va creata alcuna occasione di discriminazione.”
Ma questa decisione mi pare assurda. Il Presepe fa parte della cultura italiana
come l’arte sacra, la musica barocca e la Divina Commedia. Non è un mero simbolo
di fede. Sarebbe folle pretendere che l’alunno islamico (o buddista o quel che
è) si converta al cristianesimo. Ma chi vuole integrarsi in Italia deve
assimilare la nostra cultura. Altrimenti sarà un cittadino privo di un’identità.
Non c’è bisogno di credere nella resurrezione di Cristo per ammirare la pittura
di Giotto e la poesia di Dante, così come non occorre compiere sacrifici a Giove
per apprezzare la mitologia classica. Il cristianesimo, inteso come fenomeno
culturale, non deve apparire estraneo, o alienante, a chi ha scelto di vivere a
casa nostra. I cristiani d’Oriente non studiano forse il Corano, un vero e
proprio capolavoro linguistico, nonché testo di base della civiltà
arabo-islamica, cui anche loro appartengono? Nessun cristiano colto nega che
l’arabo classico — la koiné di tutti gli arabi – è, essenzialmente, una lingua
coranica. Se c’è un simbolo più religioso che culturale, quello è il crocefisso.
Ma il Preside, che ha “cose più importanti” di cui occuparsi, ha deciso di
lasciarlo “appeso ai muri”. Se lo togliesse, i credenti ne farebbero “una
questione di Stato”. Più facile bandire l’innocuo Presepe, che spunta a ridosso
del Natale, per poi svanire subito dopo l’Epifania. Una volta affermato il
principio demenziale che il Presepe offende la sensibilità islamica, dove
arriveremo? Proibiremo la lettura a scuola del Canto XXVIII dell’Inferno
dantesco, perché il Profeta Maometto vi compare nella veste sommamente offensiva
di un dannato squarciato dal mento fin dove si “trulla”; punizione vergognosa,
riservata agli scismatici, ai seminatori di discordia, come erano reputati i
musulmani nel Medioevo? E metteremo alla berlina il Manzoni cristiano in quanto
credente in una divinità falsa e bugiarda? No, non è questo il compito di una
scuola laica, che forma i cittadini della polis secolare. Il vero laico è un
liberale, un libertario. La laicità è una neutralità attiva: lo Stato laico non
propaganda né una singola religione né l’ateismo; crea semplicemente le
condizioni politiche che garantiscono la libertà di culto. La censura del
Presepe non è un’affermazione di laicità, e non è neppure frutto della
degenerazione di uno spirito laico intollerante. È piuttosto figlia del
politically correct saccente e confusionario che imperversa da anni negli Stati
Uniti, e che ora è approdato sulle nostre coste. Un multiculturalismo di bassa
lega, con una spruzzata di giacobinismo a senso unico (l’unica tradizione da
azzerare è la nostra), viene spacciato come una riedizione dell’Illuminismo
progressista. I sacerdoti del politically correct, in nome della tolleranza
verso lo straniero e il diverso, impongono forme subdole di censura o di
auto-censura: chi non si adegua ai loro dettami subisce una gogna mediatica. Il
multiculturalista serio è fatto di tutt’altra pasta: ama la diversità, perché è
consapevole che il pluralismo religioso/culturale arricchisce la società civile.
A una condizione, però: che venga rispettata la libertà e la dignità di tutti.
Solo così il principio liberale è adattabile al mondo cosmopolita d’oggi. La
cifra del laico autentico, peraltro, è la coerenza: anche quando degenera nella
polemica anti-religiosa, ha il coraggio di prendersela ex aequo con preti,
rabbini, imam e monaci: per lui, tutte le religioni positive sono ricettacoli di
superstizione e di fanatismo. Mica rinnega la sua tradizione culturale per
esaltarne una straniera, esotica, perché così va di moda nei circoli
radical-chic! In certi ambienti di sinistra invece si usano due pesi e due
misure: si insorge (giustamente) quando viene offeso l’islam, ma si tace o si
gongola se qualcuno dissacra il cristianesimo o inveisce contro il Papa (da
questo punto di vista, Oriana Fallaci non aveva tutti i torti). Agli apostoli
del multiculturalismo suggerisco la lettura di Innamorato dell’Islam, credente
in Cristo, di Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapito dai jihadisti in Siria, il
quale ha dedicato la sua vita al dialogo interreligioso basato sulla
reciprocità. Se noi dobbiamo rispettare l’islam, i musulmani devono fare
altrettanto con noi. Il dialogo interreligioso è una faccenda maledettamente
seria: Dall’Oglio, forse, ci ha rimesso la pelle. Ho avuto l’onore di conoscerlo
a Damasco, nel 2011. È stato lui a insegnarmi una grande verità, valida anche
per chi non è credente: per confrontarmi con chi crede in un Dio diverso dal
mio, non devo rinnegare la mia religione. Tutt’altro: la devo professare (o
difendere) con orgoglio. Cosa fare, allora? Abolire l’insegnamento del
cattolicesimo nella scuola pubblica (unico vero vulnus alla laicità), oppure
garantire, per equità, la medesima importanza a tutte le religioni professate
dai cittadini italiani? A mio avviso, l’educazione religiosa, fatto di coscienza
individuale, spetta alle famiglie, non allo Stato. Sarebbe sbagliato inaugurare
una sorta di carnevale variopinto di tutte le fedi. Lo Stato, però, ha il dovere
di insegnare la storia del cristianesimo, quale disciplina curricolare. Che sia
un docente di lettere o di storia a insegnarla, laicamente. La nostra civiltà ha
radici cristiane, oltreché pagane (greco-romane) – e qui consiglio, a chi
pencola verso le tesi dei teocon, il saggio di Luciano Pellicani, Le radici
pagane d’Europa. Il vero scandalo, oggi, non è il Presepe: è l’ignoranza: i
nostri figli non conoscono le parabole evangeliche e le narrazioni bibliche.
Senza quei codici culturali, tanta parte della nostra letteratura e della nostra
tradizione artistica risulta incomprensibile. Anche la polemica sui crocefissi
la risolverei in chiave culturale: sostituiamo quelli bruttissimi di plastica
con riproduzioni di Giotto o di Cimabue. Che ogni classe adotti una croce
dipinta della tradizione pittorica italiana. Trasformare un fenomeno artistico,
qual è il Presepe, in un simbolo religioso, è anche un grave errore politico. I
fascio-leghisti non si sono fatti sfuggire l’occasione per specularci sopra:
“Ecco la sinistra che plaude all’Eurabia islamizzata!’ Non lasciamo la difesa
delle nostre tradizioni alla Lega e a Casa Pound: la rappresentazione della
natività – l’espressione più poetica della religiosità popolare italiana – fu
inventata da San Francesco d’Assisi. Per testimoniare, ogni anno, la nascita in
assoluta povertà e umiltà di Cristo. Un messaggio formidabile per i
creso-cristiani d’ogni tempo, che difendono a parole la cristianità mentre la
tradiscono trescando con i potenti di turno. Riappropriamoci, noi socialisti,
del Presepe e denunciamo l’uso politico distorto che ne fanno coloro che
annacquano lo spirito rivoluzionario, sovversivo del cristianesimo. Ecco perché
io, agnostico e laico-socialista, amo il Presepe e lo voglio esposto nei luoghi
pubblici, così com’è: un bambino adagiato in una mangiatoia, in una grotta. E a
chi sparge a piene mani il seme dell’odio e dell’intolleranza ricordo i bei
versi di Trilussa “Ve ringrazio de core, brava gente/ pe’ ‘sti presepi che me
preparate,/ ma che li fate a fa? Se poi v’odiate,/ si de st’amore non capite
gnente…”.
La sinistra a favore dei
mussulmani contro i cristiani. L'Islam astio al principio di reciprocità.
La persecuzione dei cristiani
in Medio Oriente, scrive Salvatore Lazzara. Gesù nel Vangelo, ricorda ai
discepoli: “Beati voi quando, vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”. La promessa di Gesù
non prevede per i suoi seguaci vita facile. E’ il mistero della sequela, un
cammino che costa a quanti aderiscono, un prezzo altissimo. In alcuni casi è
richiesto il dono della vita, per testimoniare la fede nel Signore morto e
Risorto. Già nel nuovo testamento sono registrati i primi attacchi contro i
cristiani: dopo la morte in croce del maestro, i discepoli ebbero paura ad
annunciare ciò che avevano visto e udito, per paura di essere uccisi. E’
necessario che il Risorto stesso indichi ai discepoli con le apparizioni nel
giorno dopo il sabato, la via da seguire. Durante una riunione a porte chiuse,
presente la Madre di Gesù Maria, ricevono il dono dello Spirito Santo, il quale
li abilita a proclamare che Gesù è il Signore, e quanti ascoltano la loro
parola, gli abitanti di Tiro, di Sidone, della Cappadocia, intendono nella loro
lingua il messaggio del Dio fatto carne e crocifisso per la salvezza degli
uomini. Da questo punto in poi, i discepoli vivranno incomprensioni, delusioni,
tradimenti, fino a versare il sangue per la fede. Il primo martire di cui
abbiamo notizia è Stefano, il quale viene ucciso brutalmente perché si rifiutava
di rinnegare Gesù. Sono esemplari le ultime parole pronunciate da questo
discepolo del Signore, che ricalcano quelle dette da Gesù sulla croce prima di
morire. La tradizione dei primi secoli ha tramandato alcuni atti dei primi
martiri della fede, molto suggestivi e pieni di spunti di riflessione. Le
persecuzioni si scatenano contro i cristiani quando non vogliono cedere ai
compromessi o alle false divinità. Tutto ciò produce odio, perché la parola di
Dio condanna il male e ciò che di brutto il mondo possiede. Cito per tutti
san’Ignazio di Antiochia, il quale catturato non volle essere liberato per
diventare nelle mandibole dei leoni frumento di Cristo macinato per la salvezza
del mondo. Certamente non possiamo analizzare i motivi e le lunghe persecuzioni
cruente dei cristiani nell’arco dei 2000 anni, ma possiamo sintetizzare i vari
periodi per comprendere il faticoso annuncio della Parola di Dio all’umanità.
Fino al quarto secolo, i vari imperatori romani nel vasto territorio sotto la
loro giurisdizione, tentarono in tutti i modi di eliminare il Cristianesimo che
si diffondeva sempre più attraverso le vie commerciali, con la complicità di
alcuni ufficiali militari, che avendo sentito ciò che Gesù aveva fatto ad alcuni
colleghi, come ad esempio la guarigione del figlio del centurione, -il quale
prima dell’ingresso del Signore nella sua casa esclamò-: “Guarda io non sono
degno che tu entri nella mia casa, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito…”-, suscitava in quanti ascoltavano sentimenti profondi di commozione e
di partecipazione. La “nuova fede”, fece breccia sugli schiavi, i quali vedevano
nel Cristianesimo, la liberazione dalla condizione di oppressi. Sappiamo dai
racconti, che molti di essi erano a servizio dei potenti del tempo. Venendo a
contatto con loro, cominciarono a convertirsi per la fedeltà che i servi
mostravano verso la nuova religione. Tutto ciò turbava gli equilibri politici,
sociali e religiosi del tempo. Sentendo odore di minaccia al potere costituito
il cristianesimo, cominciò ad essere perseguitato in tutto l’impero con le
grandi campagne messe in atto da Diocleziano, Tito, Nerone, il quale accusò i
cristiani di essere responsabili del famoso rogo-incendio di Roma, che lui
stesso aveva fatto appiccare. Per giustificare le efferate esecuzioni e
sbarazzarsi di questa nuova forma di religiosità, Nerone non ebbe scrupoli ad
addebitare ai cristiani un atto che non avevano commesso, soltanto per placare
la sua coscienza ed affermare il personale potere nei confronti dei sudditi. Con
la conversione di Costantino al cristianesimo, cominciò un era di pace e di
libertà. Cominciarono le costruzioni delle Basiliche, e il culto era permesso
alla luce del sole. Il cristianesimo a poco a poco cominciò a diventare parte
strutturale della società, arrivando a permeare la vita dei fedeli in modo
totalizzante. Certamente non siamo qui ad esaminare tutti gli aspetti positivi e
negativi del processo storico descritto, ciò che conta e comprendere la
difficoltà in cui ad esempio si trova oggi l’espansione dell’Islam, alla luce di
quanto ho affermato. Ai tempi di Costantino, il potere sociale e religioso erano
uniti indissolubilmente. L’imperatore era il depositario, il custode del creato,
perché da Dio riceveva la potestà di governare. Dunque dalla religione partiva
ogni input per regolare la vita della società. Ogni cosa era subordinata alla
Bibbia, e dalla Scrittura si prendeva ispirazione per stabilire le leggi etiche
e morali. Questo sistema naturalmente ha subito parecchie modifiche nel tempo,
fino ad arrivare ai tempi odierni, portando dietro di se integralismi,
fondamentalismi, e tante volte scelte sbagliate che hanno causato la morte di
tanta gente innocente. Dobbiamo purtroppo dire che lo schema citato, ha portato
a persecuzioni accanite contro i cristiani e viceversa. Questa struttura
ancora oggi è usata dall’Islam nei paesi a maggioranza musulmana. E’ il Corano
con le sue leggi a determinare il corretto svolgimento della vita dei cittadini.
Ogni cosa prende spunto e trae ispirazione dalla parola di Allah. Tutto ciò che
non coincide con il predicato religioso islamico, deve essere abbattuto con ogni
mezzo. Ogni musulmano è chiamato ad osservare il Corano, e da esso prendere
spunto per la vita familiare e relazionale. Le società islamiche oggi vengono
classificate in moderate e radicali. E’ una divisione che a me personalmente
crea diverse perplessità e problemi. Cosa significa essere moderati? Forse non
usare la violenza per convertire? Oppure cosa significa radicali? Usare la
violenza come via per raggiungere la conversione degli infedeli a scapito del
dialogo e della civile e pacifica convivenza con chi non accetta l’Islam? Sono
domande complicate, da cui nasce la confusione e la persecuzione di cui noi oggi
siamo testimoni contro i cristiani in generale e le minoranze religiose. Nei
paesi musulmani, generalmente ai cristiani è riconosciuta la libertà di
professare la loro fede, ma con limitazioni in alcuni paesi. In Arabia Saudita è
formalmente vietata ogni religione che non sia quella musulmana; la presenza di
stranieri cristiani è tacitamente tollerata, ma essi non possono in alcun modo
manifestare la propria fede. Persino il possesso della Bibbia è considerato un
crimine. In generale nei paesi arabi i cristiani sono oggetto, da parte della
popolazione musulmana, di forme di discriminazione più o meno gravi, che negli
ultimi decenni hanno portato molti di loro a emigrare o a convertirsi all’Islam.
La popolazione cristiana è in calo pronunciato in tutti i paesi del Medio
Oriente. La conversione di musulmani al cristianesimo è poi vista come un
crimine (apostasia) e, anche nei paesi in cui la legge la consente, i convertiti
sono spesso oggetto di minacce e vendette da parte della popolazione. Mentre in
Occidente si combatte ogni forma di religiosità di carattere cristiano in nome
di una falsa laicità aggressiva, in alcuni paesi a maggioranza islamica il
percorso è inverso. I musulmani al potere cercano in tutti i modi di
“islamizzare” gli stati in cui sono a maggioranza con leggi che favoriscono lo
sviluppo dell’Islam, ma che penalizzano di molto le altre religioni, le quali
strette nella morsa della persecuzione diventano sempre più minoritarie. In
Europa la confusione ideologica porta allo smantellamento culturale, causando
effetti devastanti: la costruzione di moschee, il Real Madrid ha dovuto togliere
la croce della scudetto perché il maggiore azionista della squadra è diventato
un famoso emiro musulmano, le continue polemiche contro l’allestimento dei
presepi, l’insegnamento della religione nelle scuole, il crocifisso nelle aule
pubbliche, le difficoltà relazionali in alcune città europee importanti a
maggioranza musulmana che avanza silenziosa, la natalità, gli investimenti
economici, fanno parte di una persecuzione precisa e metodica contro i cristiani
portata avanti dai cosiddetti moderati, che pur non prevedendo il sacrificio
cruento con lo spargimento del sangue, condiziona la libertà del cristianesimo
in nome della tolleranza e dell’accoglienza. A questo punto possiamo fare un
accenno all’epoca delle Crociate, considerate a torto come persecuzioni contro i
non cristiani, ma il tempo a disposizione è poco. Contrariamente a quanto è
stato affermato dai libri di storia foraggiati dai nemici del cristianesimo,
-come possiamo vedere dall’immagine- (foto 1), avevano uno scopo chiaro e
limpido: difendere i luoghi santi dalle invasioni islamiche. Mentre le conquiste
musulmane avevano ed hanno come obiettivo la conquista dei territori, per
convertire all’Islam gli infedeli, contrariamente i crociati difendevano e
riconquistavano con la forza i luoghi santi. Certamente non tutto è stato rose e
fiori…. Ma permettetemi di dire che bisognerebbe rivedere con onestà queste
pagine di storia senza i pregiudizi di quanti avversano in tutti i modi la
presenza cristiana nel mondo. I cristiani a Gerusalemme e a Nazareth sono ormai
il 2 per cento, mentre la nazione con il maggior numero di cristiani resta il
Libano. Se ne contano approssimativamente il 35 per cento, ma in diminuzione
rispetto a qualche anno fa. “Più i cristiani lasciano il Paese, più i cristiani
diventano un’esigua minoranza, più alcuni principi della modernità, come ad
esempio i diritti umani, vengono a cadere”, avverte il gesuita egiziano padre
Samir, esperto di questioni mediorientali. “Con la diminuzione degli elementi
cristiani si fa un passo indietro nell’economia ma, ancor di più nella politica,
e soprattutto in tutto ciò che è legato ai diritti umani: la situazione della
donna, la libertà religiosa, la libertà tout court, il progresso sociale, i
diritti sociali per i più poveri e i deboli”. Anche per questo motivo sentiamo
tra i musulmani – intellettuali e non solo, politici e anche gente di media
cultura – dire: “Per favore, non andatevene! Rimanete! Abbiamo vissuto insieme
per secoli!”. Dal 2000 ad oggi i cristiani vittime di persecuzioni sono stati
160.000 ogni anno. Ogni 5 minuti un cristiano viene ucciso a causa della propria
fede.
Don Salvatore Lazzara -
Sacerdote da 17 anni, è cappellano militare all’Accademia Aeronautica di
Pozzuoli. Da Cappellano Militare ha svolto i seguenti incarichi: Maricentro (MM)
La Spezia, Nave San Giusto con la campagna addestrativa nel Sud Est Asiatico, X°
Gruppo Navale in Sinai per la missione di Pace MFO. Successivamente trasferito
alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Ha partecipato alla missione in Bosnia
con i Carabinieri dell’MSU. Di ritorno dalla missione è stato trasferito alla
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Dopo l’esperienza nei Carabinieri è
tornato a Palermo presso i Lanceri d’Aosta (Esercito). Per Da Porta Sant’Anna
curava inizialmente la rubrica “Al Pozzo di Sicar”; da Luglio 2014 ha assunto il
ruolo di Direttore del Portale.
E poi c'è lei. Peppa Pig.
Oggetto di strali dei benpensanti.
E' attualmente il cartone
animato più famoso e visto al mondo, ma anche dai genitori che, in caso di
stanchezza giornaliera, piazzano i figli davanti alla tv, incantati dal
maialinio super star. Ma ora Peppa Pig finisce nell'occhio del ciclone. Tutto
per una presunta parolaccia pronunciata dal maialino in un nuovo episodio. E ora
le mamme protestano: "Siamo scioccate". A denunciare l'episodio è Natalie, una
mamma inglese di 30 anni che si è resa conto del turpiloquio di Peppa Pig dopo
che la sua bambina aveva ripetuto una strana parola. L'episodio incriminato è in
un DVD in cui si fa un riferimento a una band. Da "Rocking Gazzelle" diventano
"Fucking Gazelle", almeno secondo quanto ha capito la mamma. "Sono scioccata",
ha detto la donna al Daily Mail. "Quando ho sentito mia figlia dire certe parole
l'ho rimproverata ma poi mi sono resa conto che era tutta colpa del cartone". La
donna si sente responsabile e colpevole e conclude dicendo che non permetterà
mai più ai suoi bambini di vedere il cartone. Anche Peppa Pig potrebbe rimanere
vittima dell’elevato livello di attenzione per la prevenzione degli attentati.
La simpatica maialina rosa potrebbe essere messa al bando. Le nuove linee guida
della Oxford University Press, la casa editrice dell'ateneo inglese che pubblica
testi scolastici e prodotti editoriali educativi. Secondo queste indicazioni c’è
il divieto di pubblicazione di riferimento al maiale e alla sua carne per non
offendere i musulmani e gli ebrei. L’Università è un’autorità negli ambienti
culturali inglesi e, se dovessero essere accolti i suggerimenti, il cartone
animato che fa impazzire i bambini di tutto il mondo potrebbe essere messo al
bando. La censura dell’Università arriva subito dopo gli attentati di Parigi.
Sulla questione sono intervenute perfino le comunità ebraiche e musulmane che
hanno definito la vicenda un tentativo “politically correct senza senso”.
Liberateci da Peppa Pig: sta
rovinando i nostri bambini, scrive di Lucia Esposito su “Libero Quotidiano”.
C'era una volta Heidi che faceva "ciao" alle caprette e aiutava l'amica Clara in
carrozzina, c'erano i Barbapapà animalisti ed ecologisti che ci lasciavano di
stucco coi loro "barbatrucchi" e le trasformazioni più improbabili. C'era Winnie
the Pooh, l'orsetto grasso che lievitava all'ombra del bosco dei cento acri
bevendo ettolitri di miele ma capace di grandissimi gesti di amicizia. C'era la
cagnetta Pimpa che perdeva per strada le sue macchie rosse ma che faceva la
felicità del suo padrone Armando… Mai si erano visti in televisione dei maiali
che ruttano senza ritegno, grugniscono in continuazione, si rotolano nel fango
allegramente e che, quando ridono, si ribaltano sul pavimento sbellicandosi come
idioti. Liberatemi, vi prego, dalla famiglia Pig. Qualcuno mi spieghi cosa c'è
di educativo in questo cartone che sta lentamente trasformando mio figlio di tre
anni in un suino. «Tu sei mamma Pig», mi dice quando si sveglia. «No, Francesco
io non sono un maiale», gli rispondo piccata. Lui arriccia il naso, dice «oink»
e scappa via. Quando al mattino va a scuola, si guarda attorno con la stessa
attenzione con cui un bracco ungherese cerca i tartufi nel bosco e, appena
intercetta una pozza d'acqua, si fionda per saltarci dentro. «Come Peppa Pig»
salta e ride mentre i suoi occhi roteano come biglie per individuare un altro
specchio d'acqua fangoso in cui rotolarsi come un porcellino. Inutile provare a
spiegargli che i maialini sono sporchi e puzzano e che la loro casa, il porcile,
è un posto lurido e nauseabondo. Lui dice che «Patata City» (la città in cui
vive la maledetta famiglia Pig) è bella e pulita. Per non parlare del rutto tra
una portata e l'altra, diventato la colonna sonora dei miei pasti. Davvero non
so come sia capitato ma lo spirito della famiglia Pig si è impossessato di lui e
viene fuori senza alcun ritegno proprio quando tutti tacciono e non si può far
finta di non aver sentito. «Non si fa, i maiali lo fanno» e lui: «Ma io sono
Peppa Pig». Allontanarlo dal tavolo non fa che scatenare il processo di
identificazione con la famiglia di suini perché invece di piangere, invece di
starsene umiliato in camera, va in bagno, prende il braccio della doccia fa
cadere acqua sul pavimento e si mette a saltare nella pozza. Per chi è fuori da
questo incubo perché non ha figli tra i due e gli otto anni, Peppa Pig è un
cartone animato che ogni sera ipnotizza mezzo milione di bimbi. È la storia di
una famiglia di maiali (mamma Pig, papà Pig, il fratellino George di due anni e
la protagonista Peppa di quattro anni). I suini non vivono in un porcile ma, pur
mantenendo comportamenti propri della specie, sono umanizzati. Il povero signor
Pig, il padre, è un pasticcione inetto, incapace di fare qualsiasi cosa (in un
episodio per piantare un chiodo, fa crollare una parete) che si fa prendere in
giro dai figli senza dire un «oink» sia perché è più grasso del normale sia
perché è un fallimento che cammina. Lui e sua moglie non sono in grado di dare
una sola regola comportamentale ai figli e, quando ci provano, non sono
credibili. Non si fanno rispettare. Peppa e George fanno quello che vogliono,
inzozzano di fango la casa, rompono il pc con cui la mamma lavora. Viziati e
ribelli, trasmettono ai bambini l'idea che tutti sono uguali, che la loro
parola-grugnito vale quanto quella dei genitori. Vogliamo poi parlare di George?
A due anni dice solo e sempre «dinosauo», attaccato come una cozza al suo
peluche verde ripete ossessivamente le stesse cose da centinaia di puntate senza
che nessuno (tranne Peppa Pig che lo chiama «tontolone») si faccia delle domande
sull'evoluzione del linguaggio del piccolo, senza che nessuno gli spieghi che si
dice «dinosauro» e gli dia qualche informazione in più sull'animale preistorico.
I dialoghi sono semplici, il vocabolario basico, i personaggi ripetono sempre le
stesse parole, il disegno dei cartoni è elementare, eppure i bambini sono pazzi
di questi porcellini. Molti esperti dicono che Peppa Pig piace tanto perché
riproduce un modello di “famiglia normale”: i genitori che vanno al lavoro, i
figli affidati ai nonni, le gite della domenica, i capricci a cui non seguono
punizioni... Adesso, gli psicologi avranno anche le loro ragioni ma io da un po'
ho vietato al mio bimbo di vedere «Peppa Pig»: perché per me non è normale che a
cena rutti con lo stesso orgoglio di chi prende dieci in pagella. Ridatemi i
barbatrucchi di Barbapapà!
E poi Peppa Pig è un maiale e
non è corretto parlarne in un'Italia Islamica voluta dalla sinistra contro gli
italiani cattolici.
Follia islam, fatwa per fatwa.
Vietati rock, calcio, cani e bici. Le scomuniche religiose possono costare la
vita. Ma osservarle tutte vuol dire non vivere più, scrive Massimo M. Veronese
su “Il Giornale”. Ha una fama sinistra ma la fatwa, o fatawi al plurale, in
fondo, è solo un codice di comportamento quotidiano e non è obbligatorio
rispettarlo. Per avere valore deve uscire dalla bocca di un'autorità religiosa,
ma in troppi, hanno denunciato alcuni analisti algerini, si attribuiscono un
ruolo nell'Islam e si sentono autorizzati a dettare legge a caso. Le fatawi
vietano gadget, oroscopi, la riproduzione di cd e dvd. Per non dire del nuovo
profumo «Victoria's Secret: Strawberries and Champagne» ritirato dal governo
dagli scaffali di Doha senza bisogno di una fatwa perchè «va contro le
abitudini, le tradizioni e i valori religiosi del Qatar». Ma in questi anni
abbiamo visto anche di peggio.
Le palle di neve. É l'ultima
in ordine di apparizione: vietato costruire pupazzi di neve in Arabia Saudita,
fatwa dell'imam Mohammad Saleh Al Minjed. Dice che realizzare uomini o animali
di neve è contrario all'Islam. Unica eccezione, riporta Gulf News , i pupazzi di
neve raffiguranti soggetti inanimati cioè navi, frutta o case. La reazione però
è stata piuttosto gelida.
I pokemon. Pikachu, Meowih,
Bulbasaur, sono stati accusati di complotto giudaico-massonico, e messi al bando
dallo sceicco saudita Yusuf al-Qaradawi, ideologo dei Fratelli musulmani.
Vietata la loro vendita in tutta l'Arabia Saudita. I Pokemon, sentenzia la
fatwa, si sono coalizzati per far diventare ebrei i musulmani. Bastasse un
cartoon.
I tatuaggi. Fresca anche
questa. La Direzione Affari Religiosi di Turchia guidata dal Gran Mufti Mehmet
Gormez, principale autorità religiosa islamica del paese, ha emesso una fatwa
contro i tatuaggi: «Allah ha maledetto coloro che cambiano il loro aspetto
creato da Dio». Spacciati Materazzi e Belen.
Il calcio. La fatwa dello
sceicco Abdallah Al Najdi si basa sul principio che vieta ai musulmani di
imitare cristiani ed ebrei. Si può giocare ma con regole diverse: niente linee
bianche in campo, niente squadre di 11 giocatori, porte senza traverse, chi
grida gol va espulso e niente arbitro perchè superfluo. Come del resto nel
nostro campionato...
I croissant. Ad Aleppo una
commissione sulla sharia ha emanato un editto religioso contro il consumo di
croissant, considerati il simbolo della colonizzazione dell'Occidente. Il babà
invece va bene ma solo se si chiama alì...
La chat. Chi chatta online
attraverso i social network con persone dell'altro sesso commette peccato. Lo
stabilisce la fatwa dello sceicco Abdullah al-Mutlaq, membro della Commissione
saudita degli studiosi islamici. Poi hanno fatto retromarcia: si riferiva a un
caso isolato da non generalizzare. Non mi piace.
Il rock. L'ha decisa in
Malaysia la Commissione del consiglio per gli affari islamici secondo la quale
la musica rock va spenta perché fa male allo spirito. E c'è una variante, il
black metal, che essendo dominata dall'immaginario occulto, ha il potere di
traviare e stravolgere le anime dei giovani musulmani. Il liscio non si sa.
Il sesso. Fare l'amore si può.
Ma non nudi. «Esserlo durante l'atto sessuale invalida il matrimonio» la fatwa
imposta dallo sceicco Rashar Hassan Khalil. Non tutti sono d'accordo. Il
presidente del comitato delle fatwa di alAzhar, Abdullah Megawer, ha corretto,
come si suol dire, il tiro: nudità ammesse, ma a patto che i partner non si
guardino.
La bicicletta. A lanciarla è
stata la guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei in
persona: proibisce nel modo più assoluto la bici alle donne iraniane.
Il cane. Nonostante sia per
l'Islam un animale impuro, il cane è molto diffuso come animale domestico in
Iran. Così il grande ayatollah Nasser Makarem-Shirazi ha emesso la sua fatwa:
«Non c'è dubbio che il cane sia un animale immondo». Pur ammettendo che il
Corano non dice nulla in proposito. E allora?
Lo yoga. Oltre 10 milioni di
persone hanno partecipano in India a una lezione di massa di yoga per il
Guinness dei Primati. La cosa però non è piaciuta ai vertici religiosi musulmani
di Bhopal che hanno lanciato una fatwa per condannare l'esercizio come
«antislamico» e «pagano» per il riferimento al dio Surya.
La festa di compleanno.
Celebrare compleanni e anniversari di nozze non può avere spazio nell'Islam. Lo
dice il Gran Muftì dell'Arabia Saudita, Sheikh Abdul Aziz Al-Alsheikh. «Un
musulmano dovrebbe solo ringraziare Allah se i suoi figli stanno bene e se la
sua vita matrimoniale è buona». Le classiche nozze con i fichi secchi.
L'eclisse. Una fatwa lanciata
dal gran mufti d'Egitto proibisce ai musulmani di osservare l'eclissi. «Mette in
pericolo la vista dell'essere umano e poiché l'islam proibisce all'uomo di
mettere in pericolo la sua vita è peccato guardare l'eclisse». E con questa
siamo al buio pesto.
La sinistra tace sulla
mercificazione dei bambini.
Nuovo video shock Isis,
bambino spara ai prigionieri. Ragazzino di 10 anni giustizia due uomini, scrive
Benedetta Guerrera su “L’Ansa”. Non c'è limite all'orrore jihadista: dopo le
bambine kamikaze in Nigeria, costrette dai terroristi di Boko Haram a farsi
saltare in aria imbottite di esplosivo, un nuovo terribile video dell'Isis
mostra un ragazzino che impugna una pistola e fredda due ostaggi come un boia
consumato. Immagini scioccanti, che dimostrano come la follia del terrore non si
fermi più davanti a nulla. Nei nuovi otto minuti di orrore, pubblicati sui siti
jihadisti e rilanciati dal Site (il sito Usa di monitoraggio dell'estremismo
islamico sul web), la scena è simile a tante altre diffuse in questi mesi di
atroce propaganda da parte degli assassini dell'Isis. Solo che in questo caso,
il boia ha il volto pulito di un bambino che non avrà neanche 10 anni. "L'Isis
ha raggiunto un nuovo livello di depravazione morale: usano un bambino per
giustiziare i loro prigionieri", ha commentato postando un fermo immagine del
video sul suo account Twitter Rita Katz, la direttrice del Site. Le vittime
vengono presentate come due kazaki, di 38 e 30 anni, accusati di essere "spie
russe". Prima della loro esecuzione i due confessano di essere "agenti del Fsb",
i servizi russi, inviati in Siria per raccogliere informazioni sui jihadisti e
soprattutto sui 'foreign fighter' russi. Dalle parole delle due spie si evince
che sono stati in Turchia sulle tracce di qualche 'pezzo grosso' dell'Isis, il
cui nome è però omesso. Il più giovane dei due 'rivela' anche di essere stato
reclutato per uccidere "un leader dello Stato islamico". Il filmato, intitolato
"Uncovering the enemy within" (Scoprire il nemico interno) e targato al Hayat
media center - la 'casa di produzione' dello Stato Islamico - è di ottima
qualità e ha un montaggio quasi cinematografico. Al momento dell'esecuzione ad
opera del bambino, i due uomini appaiono inginocchiati a terra e hanno le mani
legate dietro la schiena. Non indossano la tradizionale tuta arancione dei
prigionieri di Guantanamo, che di solito i jihadisti fanno mettere agli ostaggi
occidentali, ma una divisa azzurra. Alle spalle dei due condannati ci sono il
ragazzino armato di pistola e un terrorista con la barba lunga e il kalashnikov
che parla in russo. E' lui che spinge il bambino verso le sue vittime. Proprio a
questo punto, quasi a voler enfatizzare il momento, le immagini vengono
trasmesse al rallentatore e con un gioco di dissolvenze, mentre il terrorista
ripete le ennesime minacce ai "nemici di Allah": il ragazzino, che ha un vistoso
orologio al polso e indossa una felpa nera e pantaloni mimetici come il suo
'superiore', solleva la pistola e spara un colpo alla testa di ciascuno dei due
prigionieri. Un colpo secco, sulla nuca, con incredibile freddezza. I due cadono
a terra, il ragazzino si avvicina e ne finisce uno con altri due spari. Poi
solleva il braccio con la pistola in segno di vittoria e sorride. Un video
agghiacciante, che potrebbe essere una squallida messa in scena, costruita ad
arte dai jihadisti dell'Isis, abili comunicatori del terrore. Nonostante le due
vittime vengano colpite alla testa infatti, non si vede il proiettile uscire, né
il sangue sgorgare dalla nuca o dal collo. Ma sono immagini che comunque
lasciano sgomenti. Anche perché subito dopo la sequenza dell'uccisione parte il
frammento di un altro video che era già stato pubblicato dall'Isis a novembre in
cui lo stesso ragazzino appare in un gruppo di bambini kazaki che si addestrano
a usare i kalashnikov. "Sarò uno di quelli che vi sgozzerà, kafiri", diceva il
ragazzino. Anche in quel caso il filmato era scioccante, quasi irreale. Una
ventina di bambini che smontavano e riassemblavano kalashnikov e poi miravano
inginocchiati ai loro bersagli. "Sono la nuova generazione, saranno loro che
scuoteranno la Terra", recitava una voce fuori campo.
Quanti sono i bambini soldato
nel mondo. Il report redatto dall'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni
Unite prende in esame i paesi dove è stata confermato l'utilizzo di minori
arruolati sia dalle forze governative che da altri gruppi armati, e riporta i
dati, ove ci sono, dei nuovi reclutamenti confermati nel 2013, scrive Cristina
Da Rold su “L’Espresso” Il fenomeno dei bambini soldato pesa sempre di più, ma
non si può contare. Le stime riportate da Amnesty International parlano di 300
mila bambini coinvolti in conflitti armati nel mondo, il 40% dei quali sarebbero
bambine. L'Onu ne stima 250 mila. Se si cerca di definire con maggior dettaglio
i contorni del fenomeno, il profilo diventa infatti subito sfumato. UNICEF,
Human Right Watch, Child Soldier International, Amnesty International, le
Nazioni Unite e molte altre realtà che si occupano di salvaguardare le
condizioni dei minori nelle aree colpite dalla guerra, riportano la presenza
ancora oggi come cinquant'anni fa, di bambini soldato, maschi e femmine, in
molti paesi del mondo, dall'Africa al Sud America, al Medio Oriente. Secondo le
stime UNICEF per esempio sarebbero 9000 i bambini soldato coinvolti in Sud
Sudan, 2500 in India e addirittura 10000 quelli che avrebbero abbracciato le
armi nella Repubblica Centrafricana. Tuttavia non ci sono dati certi e le stime
spesso divergono di molto fra di loro, soprattutto in ragione della fluidità del
fenomeno. Ogni anno infatti vengono effettuati numerosi raid fra la popolazione
civile, più o meno noti alle milizie internazionali, dove vengono reclutati
nuovi bambini da inserire nelle file degli eserciti, governativi e non. Al tempo
stesso però altri vengono sottratti alle forze armate grazie all'azione di
realtà come le Nazioni Unite. Il bilancio è dunque difficile. Il punto di
riferimento più recente e più dettagliato in questo senso è un Report redatto
dall'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite Children and armed
conflict, che prende in esame i paesi dove è stata confermato l'utilizzo di
bambini soldato sia dalle forze governative che da altri gruppi armati, e
riporta i dati, ove ci sono, dei nuovi reclutamenti confermati nel 2013. Come
emerge dalla mappa però, solo per una parte di questi paesi, quelli evidenziati
in rosso, le Nazioni Unite sono in grado di fornire dei numeri. Per gli altri,
quelli colorati in nero, la presenza di bambini soldato per quanto accertata,
non è quantificata con esattezza.
Armi giocattolo e fiabe sui
martiri, niente tv. Ecco come si educa un bambino al jihad. Nel manuale per la
donna jihadista, i consigli pratici per diventare la mamma perfetta. E insegnare
ai figli ad essere «combattenti e ad avere paura solo di Allah: la chiave è
iniziare a istillare questi valori quando sono ancora piccoli», scrive Daniele
Castellani Perelli “L’Espresso”. Niente tv. Sì a pistole giocattolo e freccette.
E prima di andare a nanna una bella favola sul jihad. Queste sono solo alcune
delle regole che deve seguire una mamma perfetta per educare un piccolo
jihadista. Il testo è uno di quelli per cui un mese fa Runa Khan, una donna di
Luton, mamma di 6 bambini, è stata condannata in Inghilterra a cinque anni per
aver incitato su Facebook al terrorismo. Fa parte di un vero manuale per la
donna jihadista, chiamato “Il ruolo della Sorella nel Jihad”. Ma la sezione più
interessante è sicuramente quella dedicata all'educazione dei bambini, una
specie di “Emilio” rousseauiano pensato per il jihad. Lo è alla luce del ruolo
centrale che i bambini sembrano avere nella strategia e nella propaganda dei
terroristi islamici, quasi fossero impegnati nella costruzione di un uomo nuovo,
fin dai primi anni. Lo confermano ora due notizie macabre degli ultimi giorni:
il video del bambino kazako che, puntando una pistola, ucciderebbe per lo Stato
Islamico due presunte spie russe e poi festeggia il suo gesto (in realtà dal
video non è dmostrato che sia stato lui a ucciderli), e l'uso di almeno una
bambina ricoperta di esplosivo per degli attentati compiuti da parte
dell'organizzazione nigeriana Boko Haram. Ma già in precedenza erano note le
tante foto di bambini vestiti con i simboli dell'Isis che circolano da tempo su
Twitter e gli altri social media, tra cui quelle del britannico Siddhartha Dhar
in posa con neonato e fucile, ma anche quella di Ismail, di Longarone, in
Veneto, che il padre Ismar Mesinovic ha portato con sé in guerra strappandolo
alla madre cubana. Alla stessa Runa Khan, 35 anni, sono state trovate foto dei
figli con pistole e spade, ma aveva anche indicato dettagli del modo in cui
raggiungere la guerra in Siria dall'Inghilterra e su un sito per estremisti si
era augurata che un giorno suo figlio diventasse un jihadista. Il manuale era
già noto da qualche anno agli specialisti, ma secondo l'istituto americano Memri
(Middle East Media Research Institute) ora è tornato particolarmente in auge
proprio per l'Isis. Lo dimostra lo stesso caso di Runa Khan, che quel testo l'ha
pubblicato su Facebook nel settembre del 2013. Ma cosa dice esattamente il
manuale? Nel capitolo “Come educare bambini mujahid (combattente nel jihad,
ndr)” si descrive questo compito come «forse il più importante per le donne». Si
deve insegnare ai bambini, che siano maschi o femmine, «ad avere paura solo di
Allah»: «La chiave è iniziare a istillare questi valori quando sono ancora
piccoli. Non aspettate che raggiungano i sette anni, potrebbe essere troppo
tardi!». Poi ecco i consigli: «Racconta loro storie della buonanotte che parlino
dei martiri e dei mujahideen. Sottolinea che non devono colpire i musulmani,
anzi perdonarli, e che devono esprimere la loro rabbia sui nemici di Allah che
combattono contro i musulmani. Magari crea un surrogato di nemico, ad esempio un
sacco da colpire, e incoraggia i bambini, specialmente i maschi, a usarlo, a
costruire la propria forza così come a imparare a controllarsi e a saper
dirigere la propria rabbia». E per quanto riguarda lo svago? «Elimina se puoi
completamente la tv, che perlopiù insegna cose senza vergogna, anarchia e
violenza casuale. Inoltre la tv instilla pigrizia e passività, e contribuisce a
un abbandono mentale e fisico. Se non puoi proprio eliminarla, usala per video
che trasmettano l'amore per Allah e per il jihad. Ce ne sono alcuni anche
sull'addestramento militare». Per i videogiochi il discorso è simile. Meglio di
no, ma se proprio non può farne a meno allora sì a quelli militari. Il manuale
invita poi a comparare «queste caratteristiche con gli aspetti salutari del
gioco e dello sport, da cui può trarre beneficio in termini di disciplina e
forza fisica». Qualche esempio? Il tiro al bersaglio con armi giocattolo, il
tiro con l'arco e le freccette, «che permettono di sviluppare un buon
coordinamento mano-occhio», e giochi militari che siano divertenti. Quanto agli
sport, sì a arti marziali, nuoto, equitazione, ginnastica, sci, e poi altre
attività come la guida di veicoli, l'orientamento nei boschi, il campeggio e
l'addestramento per la sopravvivenza. Ci sono anche consigli di lettura, ovvero
libri militari («meglio se con le figure») e siti web, il tutto già a partire da
quando il bambino ha «due anni o anche meno»: «Non sottovalutate l'effetto
duraturo di ciò che quelle piccole orecchie e quei piccoli occhi possono
assimilare nei primi anni di vita!». Il manuale ricorda che «i bambini imitano
quello che fanno gli adulti», e invita a iniziare sin dai primi anni perché così
«non affronteranno poi battaglie interne quando diventeranno più grandi e
saranno più coinvolti nel mondo». Ma a giudicare dalle notizie degli ultimi
giorni bisogna dire che questo è un testo a suo modo moderato, laddove ad
esempio raccomanda di non tenere le armi vere alla portata dei bambini, e di non
usarle davanti a loro, oppure di non uccidere altri musulmani. Vuol dire che
Isis e Boko Haram hanno alzato ancora più in là l'asticella. È la conferma che
il jihadista di oggi è ancora più spietato di quello di ieri. È una nuova
generazione.
Non solo apologia dell'Islam,
ma anche tentativo di resuscitare una ideologia morta in nome di una falsa
tolleranza.
I partigiani e la lezione di
comunismo alle elementari. In Romagna l'Anpi celebra il Pci in un libro per le
elementari. E le famiglie romene insorgono, scrive Paolo Bracalini su “Il
Giornale”. «Papà cosa vuol dire "utero in affitto"?». Domande che ti vengono,
all'età di dieci anni, solo se ti capita di leggere di femminismo, comunismo,
guerra partigiana e D'Alema, in un libretto gentilmente donato dall'Anpi locale
alle scuole elementari di Cervia, nella rossa Romagna, nel corso di una serie di
lezioni. L'autore del librettino è Giampietro Lippi, presidente
dell'Associazione nazionale partigiani a Cervia, «esponente del Pd» secondo un
genitore di una delle scuole coinvolte, Raffaele Molinari, che sul suo blog
denuncia l'«indottrinamento di partito» a spese dei bambini. Nel libretto
distribuito nelle classi di quinta elementare, nel corso di vari incontri a
scuola, non si rievocherebbe solo la storia dei partigiani e delle staffette,
perché «tutte le storie sono raccontate per rendere idilliaco il ricordo del
Pci, con innumerevoli note dove si citano personaggi del grande Partito
comunista, le immagini col pugno alzato... Insomma comunismo ovunque», lamenta
Molinari. Il quale riporta alcuni passi del libretto per rendere meglio l'idea:
«Ho incontrato allora tanta brava gente. Tra i tanti, uno che ricordo con stima
e simpatia, era il padre del nostro D'Alema, che aveva come nome di battaglia
"Braccio"». O anche quest'altro: «Le portava l'Unità , perché la leggesse e
incominciasse ad interessarsi alle cose vere della vita, ed Anna poco alla volta
capì che era importante scegliere il fronte politico con il quale accasarsi e
scelse il Pci». I genitori hanno chiesto spiegazioni alla scuola: «Dalle
informazioni raccolte in un colloquio con la maestra - spiega Molinari - è
risultato che Lippi è stato autorizzato ufficiosamente dalla direzione didattica
di Cervia. Non una visita occasionale, ma un vero e proprio programma di
lezioni, per tre settimane. Una sorta di arruolamento in vista del settantesimo
anno della liberazione di Cervia». Il presidente dell'Anpi di Cervia, invece, è
sconcertato dalle accuse: «Assurde, fuori luogo, senza senso - ci spiega al
telefono - Io non faccio politica, racconto la storia, se le staffette
partigiane erano comuniste o socialiste cosa devo farci, nasconderlo? Io sono un
ex democristiano, si figuri, anche se adesso sì, sono iscritto al Pd. Questa
iniziativa nelle scuole è nata insieme all'amministrazione comunale (guidata dal
Pd, ndr ) e alla direzione didattica, per coinvolgere le scuole nel settantesimo
anniversario della Liberazione a Cervia. C'è una bella differenza tra fare
propaganda di partito e parlare delle staffette partigiane! Sono sconcertato dal
livello culturale di certa gente, non meravigliamoci se l'Italia va male». I più
arrabbiati per la sua iniziativa sono i genitori immigrati dall'Europa dell'Est,
che del comunismo hanno un ricordo più vivo. Sui cancelli della scuola hanno
appeso dei cartelli: «No al comunismo nelle scuole», «Il comunismo rovina i
nostri figli», in romeno e altre lingue slave. E, mentre si parla di denunce
partite all'indirizzo del presidente Anpi, oggi i genitori inscenano un corteo
silenzioso nel centro della città: «In piedi, senza schiamazzi, senza rumore,
reggendo in mano un libro di storia come segno della nostra protesta».
"Sì agli immigrati, convinci
un leghista". Così la scuola indottrina i nostri figli. Bufera per il tema
assegnato da un insegnante agli allievi di una scuola vicentina. Il Carroccio:
"È inaccettabile", scrive Giovanni Masini su “Il Giornale”. Un clamoroso caso di
indottrinamento politico: è questa l'accusa con cui la Lega Nord del Veneto si
scaglia contro un insegnante dell'istituto "Ceccato" di Thiene, in provincia di
Vicenza, reo di aver assegnato agli studenti un tema dal titolo "Persuadi un tuo
compagno leghista che l'immigrazione non è un problema bensì una risorsa". In
difesa del Carroccio si è levata l'europarlamentare Mara Bizzotto, che della
Lega è anche vicepresidente regionale: "Quanto successo all'istituto Ceccato è
molto grave e conferma come esistano purtroppo insegnanti che mischiano, in modo
scorretto e inaccettabile, i propri convincimenti politici con l'insegnamento -
continua l'onorevole Bizzotto - La scuola dovrebbe essere un luogo di libertà e
una palestra di educazione e di vita, non un luogo di indottrinamento politico
secondo i convincimenti politici del professore di turno". "Bene hanno fatto i
genitori e gli studenti che hanno segnalato questo grave comportamento da parte
dell'insegnante che, mi auguro, sarà severamente ripreso dagli organi competenti
- conclude la Bizzotto - I nostri ragazzi hanno bisogno di una scuola che
insegni, che funzioni e che svolga il proprio ruolo: i professori che vogliono
far comizi o proselitismi politici li devono fare rigorosamente fuori dalle
classi e fuori dalle scuole!". L'episodio risale a qualche giorno prima delle
ferie natalizie. "Un professore si permette - ha rincarato la dose il
consigliere regionale leghista Nicola Finco - di dare giudizi politici in classe
su un partito come se il problema in questi giorni non fosse l'islam; nel
frattempo i benpensanti radical chic di sinistra si scandalizzano perchè
l'assessore regionale all'Istruzione scrive alle scuole affinchè in classe si
tratti del problema del terrorismo islamico che è solo e unicamente cronaca".
Tema: «Immigrati sono una
risorsa convinci un tuo compagno leghista». La bufera sulla traccia assegnata
agli studenti dell'istituto Ceccato di Thiene. Salvini: «Pazzesco».
L’europarlamentare Fontana: Pd regali tessera al prof, scrive Elfrida Ragazzo su
“Il Corriere della Sera”. La parola «leghista» nel testo di un’esercitazione di
italiano scatena la polemica. A sollevarla è il Carroccio attraverso Michele
Pesavento, della segreteria politica del partito di Vicenza. Sotto accusa è una
traccia per un esercizio di argomentazione proposto da un’insegnante di lettere
agli alunni di una classe terza dell’istituto tecnico Ceccato di Thiene. «Dopo
aver preso in considerazione i dati sull’immigrazione in Italia e dopo aver
letto l’articolo – si legge nel documento diffuso - scrivi un testo
argomentativo in cui persuadi un tuo compagno leghista che il fenomeno
migratorio non è un problema, bensì una risorsa». Venuto a conoscenza
dell’accaduto da alcuni genitori, Pesavento attacca: «Quella traccia è offensiva
e razzista, l’insegnante di lettere ha trasformato quell’aula in un “pensatoio
politico”». Ed invita il preside a «vigilare su chi ha confuso l’istituto
Ceccato con una tribuna elettorale» e la docente in questione «a lasciare a casa
tessera e ideologie politiche». Interviene anche il segretario federale della
Lega Matteo Salvini: «Pazzesco!», Scrive in un tweet. Il consigliere regionale
della Lega Nord Nicola Finco ricorda il caso sollevato da lui stesso sulla
presenza dell’eurodeputata Alessandra Moretti, candidata alle elezioni regionali
venete per il Pd, ad una festa di un istituto comprensivo di Arzignano prima di
Natale. «Basta con la politica in classe. Le aule scolastiche non sono circoli
del Partito democratico o della sinistra, serve rispetto – dice – Altrimenti i
veri fondamentalisti non sono i leghisti, bensì certi professori di cui si può
fare volentieri a meno. Invece di preoccuparsi di leghisti da persuadere, il
docente potrebbe spiegare ai ragazzi cosa accade nel mondo in queste ore».
L’europarlamentare della Lega Nord Lorenzo Fontana commenta sarcastico il caso
di Thiene, Fontana chiosa serio: «La scuola è luogo di istruzione e formazione,
non di propaganda politica, anche se è noto come sia un vizio storico della
sinistra metterci becco. E poi quel professore dà per scontato l’assunto che
l’immigrazione è una risorsa. E se un alunno non la pensasse così che succede?
Mi piacerebbe conoscere i metodi di questo prof». E conclude: «Quel professore
se proprio ha la fregola della politica può sempre iscriversi al Pd, sempre che
non lo sia già. Ma fossi del Partito democratico gli regalerei la tessera.
Motivazione: alti servigi al partito e alla causa della sinistra».
«Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e canoscenza» (Dante Alighieri).
"La scuola italiana in tutti i
suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del Fascismo, educhi la
gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel e a vivere nel
clima storico creato dalla Rivoluzione fascista". Benito Mussolini. Il fascismo,
fin dai primi anni in cui prese il potere si preoccupò di rafforzare le proprie
basi ideologiche e il consenso sociale. Uno dei mezzi utilizzati era
l'indottrinamento ideologico a partire dalla scuola. Dal neo-governo fascista
venne, infatti, approvata la Riforma Gentile che proponeva una nuova forma di
organizzazione scolastica, con l'introduzione dell'Esame di Maturità e la
Religione come materia obbligatoria. Il partito si preoccupò anche di garantire
un'impostazione dei vari programmi secondo un criterio nettamente di parte,
introducendo testi scolastici come il noto libro di testo unico per le
Elementari. All'organizzazione scolastica si aggiungevano varie forme di
indottrinamento legate soprattutto all'attività fisica e alle parate.
Poi le cose son cambiate. E’
nato l’indottrinamento comunista e di sinistra in generale.
Scrive Giorgio Israel. Un
ragazzino di 13 anni mi dice di detestare la letteratura. Il suo sguardo
scettico, mentre gli vanto la bellezza dei classici e gli parlo della Divina
Commedia, mi spinge a una sfida temeraria: «Te ne leggo un canto». Procedo
temerariamente, aspettandomi sbadigli e il rigetto finale condito del tipico
insofferente sarcasmo adolescenziale. E invece funziona. Tanto funziona che il
ragazzino mi chiede se non potremmo fare altri incontri e continuare, e poi
chiede: «Ma perché a scuola non ci fanno leggere testi così? Guarda invece cosa
mi è toccato in questi giorni». È un brano di Gino Strada sugli “effetti
collaterali delle guerre”. Lo leggo tutto e non ha niente di letterariamente
valido: è una predica ideologica noiosa scritta in modesto italiano. Colgo
l’occasione per sfogliare l’antologia del ragazzino: c’è da restare a bocca
aperta. Al brano di Strada seguono due pagine di “competenze di lettura” dove
l’alunno deve mostrare di aver capito il testo apponendo crocette nelle caselle
giuste. Seguono pagine di indottrinamento sotto il titolo “che cosa succede nei
paesi dove c’è la guerra”; poi ancora competenze di lettura e scrittura “contro
la guerra”, per finire con una pagina incredibile. Contiene una serie di
immagini, per lo più banali o stucchevoli, come quella di un gruppo di bambini a
cavalcioni su un cannone, e prescrive il seguente compito: «osserva i cartelli
contro la guerra, poi scrivi per ognuno una frase-slogan»…
Come la dobbiamo chiamare?
Competenza di manifestazione di piazza? È finita qui?
Niente affatto. Seguono le
“competenze grammaticali”, in cui l’alunno è invitato a mostrare di saper far
uso della locuzione “sarebbe meglio”: riempi lo spazio con i puntini nella frase
«Invece di fare la guerra, sarebbe meglio…», e così via. Seguono le “competenze
di cittadinanza attiva”, in cui l’alunno deve dar prova di aver assimilato i
concetti di conflitto, guerra e pace, costruendo una “mappa concettuale” sul
tema. E, come se non bastasse, l’acme di un tormentone di decine di pagine è una
“verifica di fine unità” e… una prova Invalsi. Non capisco in base a quale
diritto la scuola pretenda di indottrinare i ragazzi all’idea che tutte le
guerre siano egualmente sporche. Dovrei forse accettare che i miei figli
considerino la guerra di liberazione dal nazifascismo – grazie alla quale sono
potuti venire al mondo – alla stregua della guerra scatenata dalle armate
hitleriane? Non saprei immaginare una prepotenza più oscena. Ma andiamo avanti.
Ometto di fare un elenco completo degli autori che popolano l’antologia, per non
offendere nessuno, anche se credo che né Jovanotti né Luciano Violante abbiano
mai compreso nelle loro aspirazioni quella di competere con Tolstoj e
Pirandello. Consiglio di sfogliare alcune delle antologie che circolano nelle
nostre scuole per constatare che ormai questa è la concezione della letteratura
che le ispira. E pongo alcune semplici domande.
Qualcuno può davvero
seriamente pensare che questo sia un modo valido per instillare l’interesse per
la letteratura, per la lettura, per la scrittura? Non è giunto il momento di
interrogarsi seriamente sulla deriva che sta prendendo la funzione istituzionale
dell’istruzione?
L’attuale dibattito sulla
vicenda della lettura del romanzo di Melania Mazzucco in un liceo romano è tutto
centrato attorno al dilemma se sia giusto o no scegliere dei testi adatti a
combattere le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità
di genere o se tale scelta sia mera pornografia. Pare che per molti, inclusi
alcuni dirigenti scolastici e insegnanti, la funzione della scuola sia ormai
meramente ideologica. Si dirà che Melania Mazzucco è una vera scrittrice a
differenza di Strada ma, la vera questione è se, a fronte del panorama
sterminato di letteratura di livello indiscutibilmente alto, e con cui si
potrebbero riempire decine di antologie, si preferisce cancellare Leopardi a
vantaggio di testi il cui unico indiscutibile merito è di avere una funzione
ideologica. Le denunce legali, che finiranno puntualmente nel nulla, sono
un’azione senza senso. È più appropriato denunciare (in termini non legali) la
deriva di una scuola che sta rinunciando all’educazione al bello, e la guarda
con sarcasmo come se fosse orpello di altri tempi; che rinuncia ad appassionare
i ragazzi al piacere di leggere prose e poesie di valore universale, a
discuterli in classe senza questionari di competenze e senza pagine pieni di
imbecilli quesiti a crocette; lasciando che la determinazione di posizioni su
temi come il sesso, la famiglia, la guerra o l’ambiente, sia conseguenza della
formazione libera di una personalità strutturata sull’amore per la conoscenza,
la cultura, la bellezza artistica in tutte le sue forme. La scuola non dovrebbe
impicciarsi di imbastire “lotte” contro questo o quello, di educare a pensare in
questo o quel modo, di insegnare a compilare cartelli da portare in piazza,
selezionando la letteratura su questi criteri. Perché, così facendo, la sua
funzione educativa si trasforma in ciò che vi è di più brutto: l’indottrinamento
ideologico. Brutto e diseducativo, perché è caratteristico delle società
totalitarie e come tale stimola le peggiori forme di intolleranza.
Non potrò mai dimenticare che,
all’indomani della caduta del Muro di Berlino, Alberto Lecco, un grande
romanziere dimenticato – dal cui capolavoro “Anteguerra” si potrebbero trarre
brani antologici ben più validi di quelli che vengono propinati – fece questo
commento: «Il comunismo finito? Comincia solo adesso…». Aveva ragione. Il
comunismo dei soviet, dei comitati centrali e delle commissioni centrali di
controllo è finito da un pezzo. Ma il comunismo come costruttivismo sociale,
come aspirazione a una società basata sull’indottrinamento ideologico, è più
vivo che mai, metastatizzato nella forma del “politicamente corretto” che, sotto
la veste di una bontà ipocrita e falsa, propina incessantemente le prescrizioni
soffocanti di un conformismo sociale costruito a tavolino, in cui non c’è più
spazio per il libero sviluppo della personalità.
L’intellighenzia sinistra non
finisce mai di stupire, scrive “Il Fazioso”. Certi professoroni dei nostri
licei, dopo l’abituale giro in sezione, si impegnano al massimo per trovare
occasioni per fare della sana propaganda nelle scuole. E sono veramente
fantasiosi se per il loro scopo piazzano a tradimento persino delle versioni di
latino contro Berlusconi. Ora la prof mattacchiona tenta di difendersi in ogni
modo, spiegando l’alta importanza didattica della versione. Il preside difende
la docente parlando di tentativo di incuriosire gli studenti con l’attualità,
ovviamente nessuno ha pensato all’opportunità di una versione palesemente contro
il premier. Ma che sarà mai? Ci spiegheranno che non c’è dietrologia politica ma
piuttosto educazione d’avanguardia. Il prossimo passo è portare Berlusconi nella
matematica con qualche problema sul suo patrimonio finanziario (ovviamente
condito da qualche passaggio denigratorio). Quanto sono furbi questi sinistri.
Istruzione o Indottrinamento?
Si chiede David Icke su “Crepa nel Muro”. La "istruzione" esiste allo scopo di
programmare, indottrinare e inculcare un convincimento collettivo in una realtà
che ben si addica alla struttura del potere. Si tratta di subordinazione, di
mentalità del non posso, e del non puoi, perché è questo ciò che il sistema
vuole che ciascuno esprima nel corso nel proprio viaggio verso la tomba o il
crematorio. Ciò che noi chiamiamo istruzione non apre la mente: la soffoca. Così
come disse Albert Einstein, “l’unica cosa che interferisce con il mio
apprendimento, è la mia istruzione.” Egli disse anche che "la istruzione è ciò
che rimane dopo che si è dimenticato tutto quanto si è imparato a scuola."
Perché i genitori sono orgogliosi nel vedere che i loro figli ricevono degli
attestati di profitto per aver detto al sistema esattamente quanto esso vuole
sentirsi dire? Non sto dicendo che le persone non debbano perseguire la
conoscenza ma – se qui stiamo parlando di libertà – noi dovremmo poterlo fare
alle nostre condizioni, non a quelle del sistema. C’è anche da riflettere sul
fatto che i politici, i funzionari del governo e ancora giornalisti, scienziati,
dottori, avvocati, giudici, capitani di industria e altri che amministrano o
servono il sistema, invariabilmente sono passati attraverso la stessa macchina
creatrice di menti (per l’indottrinamento), cioè la università. Triste a dirsi.
Molto spesso si crede che la intelligenza e il passare degli esami siano la
stessa cosa ... Una sera mi trovavo in discoteca, e la pista da ballo era vuota
perché il DJ aveva messo su della musica che le persone non volevano ascoltare.
Questo insopportabile egocentrico si rifiutò di cambiarla, e io chiesi se fosse
una scelta così intelligente, date le circostanze. Quello si indignò. Aveva la
prova di essere intelligente, avendo un diploma! Che ridere. La intelligenza
fondamentalmente consiste nel rendersi conto che le persone non ballano perché
la musica fa schifo, e nel mettere al suo posto qualcosa che piaccia; un diploma
consiste nel dire al sistema ciò che esso ti ha detto di dire. Cosa c’è di
intelligente in questo? Il sistema relativo alla istruzione, o Programma di
Distribuzione Automatico di Salsicce è parte essenziale dello ipnotismo
sistemico. Il programma della istruzione è organizzato in modo sistematico con
tre principali obiettivi:
1 – Impiantare nella realtà un
convincimento in linea con la illusione della Matrice. Questo è abbastanza
semplice. Non devi fare altro che offrire agli studenti la versione ufficiale
della scienza, della storia, della religione e del mondo in generale. Questo
viene fatto programmando gli insegnanti attraverso la scuola, la università e la
facoltà di magistero; poi li si manda fuori a programmare la generazione
successiva con le stesse fesserie che è stato detto loro di insegnare e di
credere. Come disse Oscar Wilde: “Quasi tutte le persone sono altre persone. I
loro pensieri sono le opinioni di qualcun altro, le loro esistenze una parodia,
le loro passioni una citazione.” La maggior parte degli insegnanti, come anche
dei medici, degli scienziati, della gente del mondo della informazione, e così
via,è ciò che il mio amico Mark Lambert definisce ‘i ripetitori’. Essi non fanno
che ripetere ciò che qualcun altro ha detto loro, invece di accedere attraverso
la coscienza alla propria verità. Si tratta di una realtà di seconda mano. Il
procedimento è simile a quello dello scaricamento di informazioni su disco
(insegnante) seguito dalla sua riproduzione in un gran numero di copie (ragazzi
e studenti). Nell’ambito di scuole e istituti superiori si ha il permesso di
discutere poco o nulla che esuli da questa versione convenzionale della vita, e
i punti di riferimento alternativi dai quali osservare questa realtà
indottrinata da una altra prospettiva sono scarsi, sempre ammesso che ve ne
siano. I ragazzi passano attraverso questo distributore automatico mentale e nel
frattempo vivono con adulti (altri ripetitori) che hanno già assorbito la stessa
programmazione, e in più guardano mezzi di informazione (altri ripetitori) che
ripete a pappagallo la stessa storia ‘ufficiale.’ Non c’è da meravigliarsi se i
ragazzi credono che la illusione sia reale quando ogni fonte di ‘informazione’
dice loro che è così.
2 – Trasformare i ragazzi in
robot che seguano gli ordini dell'insegnante (sistema). Ciò richiede il
Programma del Bastone e della Carota. Si rende molto più facile ai ragazzi la
accettazione del volere degli insegnanti (personificazione del sistema),
piuttosto che il mettere in discussione la autorità ed i concetti in cui essi
dicono di credere. Ricompensa uno e punisci l’altro. "Fa come ti dico e credi a
ciò che ti racconto" viene instillato fin dalla più tenera età in quello
indottrinamento che chiamiamo scuola, istituto superiore e università. Gli esami
rappresentano il sistema che richiede di sentirsi dire ciò che ti hanno detto
che devi pensare. Sono la prova che conferma se un download sia andato o meno a
buon fine. Quando fate il download di qualcosa su un computer, appare un piccolo
box con la scritta: "Vuoi aprire questo file adesso?" Voi lo aprite per
assicurarvi che i dati siano stati scaricati correttamente. E’ questo che sono
gli esami. I bambini indipendenti, che rifiutano il download, vengono
considerati una influenza distruttiva. Avete notato che – mentre possono esserci
disaccordi su come si insegna ai ragazzi – raramente vi sono discussioni su cosa
viene loro insegnato? Questo perché la Matrice ha una tale presa sulla realtà
umana che il cosa venga insegnato è accettato pressoché universalmente. In
verità, se le scuole introducessero corsi sulla spiritualità in relazione alla
Unità di tutto e alla illusione della forma, i genitori controllati dal
Programma Divino protesterebbero furiosamente contro questa offesa alla loro
fede cristiana, islamica, ebraica, ecc. ai bambini non solo viene somministrato
del veleno per bocca, ma anche attraverso la mente.
3 – Soffocare nella
popolazione/bersaglio (ragazzi) qualsiasi idea di unicità e spontaneità. Le
scuole sono per lo più zone proibite alla spontaneità e al libero pensiero
perché sono consumate dalle regole. Questa è una perfetta preparazione al mondo
degli adulti, il quale è strutturato nello stesso modo. La unica differenza è
che gli insegnanti per adulti si chiamano agenti di polizia, funzionari statali,
ispettori del fisco, più tutti gli altri cloni - per la maggior parte ignari –
al servizio della Matrice. Stavo leggendo che in Inghilterra, in una scuola
secondaria, è stato proibito agli alunni di tenere per mano o abbracciare il
proprio fidanzatino / fidanzatina allo interno dello edificio. Il preside si è
giustificato dicendo che un tale comportamento non sarebbe stato consentito ad
adulti sul luogo di lavoro. I ragazzi vengono plasmati per diventare una mente
collettiva ad alveare, piuttosto che espressioni di unicità. Comportatevi allo
stesso modo, e credete allo stesso modo. Un’ultima cosa: perché agli adulti non
dovrebbe essere permesso di baciarsi e abbracciarsi sul luogo di lavoro?
Accidenti, solo nella matrice lo affetto poteva essere sottoposto ad un
regolamento.
Come ottenere l’obbedienza.
L'indottrinamento scolastico, scrive Corrado su “Scienza Marcia”. Immaginiamo
una ristretta cerchia di persone, un’oligarchia, che voglia mantenere il proprio
potere politico/economico sopra una nazione sfruttandone il popolo: quali sono i
metodi migliori per consolidare tale potere e renderlo inattaccabile? I metodi
sono diversi, anche perché ci sono due strategie di fondo per mantenersi al
potere:
1) Quella di esercitare il
potere in maniera ferrea e dittatoriale, mostrando palesemente che chi si oppone
rischia di venire incarcerato, torturato, ucciso;
2) Quella di fingere di fare
tutto il possibile per il popolo, peccato che ci siano i nemici esterni, i
nemici interni, le calamità naturali, le crisi ricorrenti del sistema economico,
le recessioni, fattori difficilmente controllabili che vanificano gli sforzi che
il potere fa “per il bene del popolo”.
Ovviamente questi sono due
schemi di massima, che in realtà non si realizzano mai in maniera “pura”. Anche
le dittature esplicite nel corso della storia hanno cercato di presentarsi di
volta in volta come “necessarie per il bene del popolo, della repubblica, del
regno, della nazione” ed hanno cercato di fingere di fare del bene per i propri
sudditi. Anche le dittature implicite (come le odierne “democrazie”) pur
fingendo di agire per il bene dei sudditi utilizzando il pungo duro con gli
avversari più irriducibili, quelli che hanno capito l’ipocrisia del sistema
politico e la denunciano, la combattono. Anche nelle nostre finte democrazie che
si oppone radicalmente al sistema di potere smascherandone le menzogne rischia
di essere incarcerato, torturato, ucciso. In tutti i casi però ci sono degli
strumenti che vengono utilizzati da quasi tutte le oligarchie/dittature
(esplicita o implicita) per mantenersi saldamente al potere:
- la creazione di finti
nemici;
- la divisione del popolo in
due o più fazioni che si contrappongono su tematiche di poca importanza (come
dicevano i romani “divide et impera” ossia “dividi e governa”);
- il grande risalto dato a
manifestazioni di nessun valore, giochi, sport, intrattenimenti futili (ai tempi
dei romani c’erano i “circenses”, ossia i giochi del circo);
- la garanzia della
sopravvivenza alimentare, senza la quale si rischia una seria rivolta (per
governare i romani distribuivano “panem et circenses”, “pane e giochi circensi);
- l’infiltrazione nei
movimenti di opposizione di massa per manovrarli a loro insaputa;
- l’utilizzo di tecniche di
controllo di massa (tramite l’applicazione delle più raffinate tecniche derivate
dallo studio della psicologia di massa, della sociologia);
- il controllo dell’emissione
della moneta;
- il controllo sulla
formazione della cultura;
- il controllo della scuola;
- il controllo
dell’informazione (il cui utilizzo distorto serve anche a nascondere agli occhi
della gente la maniera in cui si utilizzano tutti gli altri strumenti di
controllo).
Quando avrò più temo forse mi
metterò a dimostrare che le nostre “democrazie” sono oligarchie mascherate, che
i veri poteri forti che stanno dietro ai burattini che siedono in parlamento non
hanno scrupolo ad usare le peggiori forme di violenza e di coercizione contro
chi si oppone ad essi. Basterebbe ricordare il clima di violenza e di
repressione totalitaria che si è respirato a Genova nel 2001 (governo di
destra), e a Napoli pochi anni prima (governo di sinistra) in occasione di due
manifestazioni dei no-global per rendersi conto che il potere che comanda le
nostre “democrazie” è violento per natura (detto questo non mi confondete con un
aderente ai movimenti no-global per carità, non rientro né in quella né in altre
etichette). Quando avrò più tempo mi impegnerò a dimostrare come i governi
utilizzino tutte le strategie sopra elencate. Per adesso mi limito ad una sola
affermazione: sarebbero stupidi se non le utilizzassero. Volete che governi che
utilizzano le migliori e più raffinate tecnologie scientifiche (ad esempio per
spiare e controllare tutto e tutti) e non usino le più sottili e raffinate
strategie di controllo sociale, pensate davvero che si astengano
dall’infiltrarsi nei gruppi di opposizione per pilotarli nascostamente ed
utilizzarli per i propri fini? Non vi rendete conto che il leader della
cosiddetta “opposizione no-global” è un medico che porta acqua al mulino del
Nuovo Ordine Mondiale diffondendo il pregiudizio che l’AIDS sia causato
dall’HIV? Non vi ricordate di quando il TG della RAI disse che “i servizi
segreti italiani erano a conoscenza del piano per il rapimento di Aldo Moro due
settimane prima che avvenisse la strage di Via Fani?”. Non vi ricordate di come
in quei giorni arrivò una soffiata sul posto in cui era nascosto Moro e di come
la polizia evitò di controllare l’informazione? Lo so, l’informazione dei
mass-media non aiuta certo a ricordare certi “dettagli” di fondamentale
importanza. Se riuscirò un giorno parlerò di come vengono utilizzate tutte
queste tecniche di manipolazione/controllo/dominio, ma oggi voglio parlarvi di
una di esse in particolare, perché ci lavoro: la scuola. Cosa c’è di meglio
della scuola per indottrinare le persone? Se n’era accorta subito la chiesa
quando lo Stato Italiano ha deciso di istituire una scuola elementare pubblica.
“Orrore! Orrore! - hanno gridato il papa e tutti i preti in coro - sacrilegio!
L’istruzione l’abbiamo sempre gestita noi fino ad ora, guai a chi la sottrae al
nostro controllo”. Con questo non voglio certo affermare che lo stato abbia
inaugurato una scuola pubblica incentrata sulla libertà, perché se l’educazione
gestita dai preti era sicuramente di parte, anche la scuola pubblica serviva ad
inculcare nei futuri cittadini tutta una serie di idee preconcette: “lo stato è
buono”, “il potere è buono”, “il re è buono”, “il re è bello”, “il papa è
santo”, “è giusto morire per la patria”, “non ribellarti al potere”. Un tipico
esempio è quello della Germania/Prussia ai tempi di Bismarck , il quale affermò
senza giri di parola che voleva utilizzare la scuola per infondere uno spirito
militaresco nei allievi. A giudicare dai risultati che si sono ottenuti nel giro
di 50 anni (Hitler, il nazismo, la seconda guerra mondiale) bisogna dire che
quell’indottrinamento militare è stato decisamente “proficuo”. Cosa pensate che
sia cambiato da quei lontani termini? La forma sì, certamente la forma è
cambiata, ma la sostanza? Nel 2001 ad esempio è stato decretato dal ministro
dell’istruzione Moratti l’osservanza di tre minuti di silenzio per commemorare i
morti delle torri gemelle a New York, squallida manovra per indurre
un’approvazione della guerra USA contro l’Afghanistan e della partecipazione
Italiana al conflitto (sebbene in una maniera minore e molto subdola, inviando
un contingente al comando degli USA solo dopo l’occupazione militare di quella
Nazione e la caduta del vecchio governo). Forse qualcuno pensa che la scuola,
almeno quella pubblica, garantisca un confronto fra diversi modi di pensare,
diverse opinioni politiche, idee contrapposte. In realtà questo succede
limitatamente al fatto che i professori e i maestri hanno diversi orientamenti
politici, votano per partiti differenti, e quindi si lasciano sfuggire discorsi
e battute contro questo o quell'uomo politico. Per il resto l'omologazione
all'interno della classe docente é fortissima, soprattutto quando entrano in
gioco la storiografia e la scienza ufficiale, oppure il "sentimento religioso"
ed il cosiddetto "amor patrio" (che raramente coincide con il vero amore per la
propria terra e per i propri connazionali, mentre troppo spesso é bieco
nazionalismo). In tutti questi casi non solo vi é un quasi totale allineamento
dei docenti sulle stesse posizioni, ma chi tenta di esprimere il suo dissenso
viene spesso trattato come un folle o come un fastidioso rompiscatole. Nei primi
anni del 2000 nella scuola italiana (a partire dal già menzionato episodio
relativo ai morti dell’11 settembre 2001) si é preso il brutto vizio di indire
dei minuti di silenzio per commemorare la morte di alcune persone, facendo così
una ben curiosa distinzione fra morti da commemorare e su cui riflettere, e
morti su cui é meglio non soffermarsi col pensiero. A quanto pare qualcuno vuole
inculcare nelle menti delle persone, e dei alunni in particolare, l'idea che le
vite degli esseri umani non abbiano tutte uguale dignità e valore. Per due volte
l'iniziativa é stata imposta direttamente dal governo, ma le altre volte sono
stati i singoli dirigenti scolastici a decidere "autonomamente" (le virgolette
sono dovute al fatto che lo hanno fatto praticamente tutti adeguandosi ad un
andazzo nazionale). Di conseguenza l'istituzione scolastica ha cercato di
imporre una particolare visione politica della realtà secondo la quale, ad
esempio, i 3000 morti delle torri gemelle sono da ricordare e commemorare e sono
più importanti sia del milione di iracheni uccisi dalla guerra e dall'embargo
negli anni '90, sia dei 3000 bambini che muoiono di fame ogni giorno. Alla
stessa maniera i militari italiani (superpagati e volontari) morti a Nassirya
sono da ricordare e commemorare per il loro "sacrificio per la pace" a
differenza degli operai (sottopagati e sfruttati) che muoiono quotidianamente
negli incidenti sul lavoro. In quell'occasione una mia timida espressione di
dissenso é stata stigmatizzata dal preside (che era persino contrario alla
guerra in Iraq). Non credo che abbia capito che, per quanto mi dispiacesse per
la morte di quelle persone, non ritenevo opportuno che la scuola venisse
utilizzata per imporre simili commemorazioni dal fine prettamente politico.
Avete mai visto una simile commemorazione quando sono morti 10 operai di una
fabbrica? A quanto pare per i mass media e per le istituzioni, scuola compresa,
la vita di un operaio é meno importante di quella di un militare. Per altro
molti militari inviati in Iraq facevano sfoggio nei loro alloggi di simboli
fascisti, ed é quindi più che legittimo dubitare del fatto che fossero lì a
rischiare la vita per la pace; forse molti di loro si sono ritrovati in Iraq
perché attratti dall'alta paga e dalla voglia di un'avventura esotica. Ma la
scuola con le sue commemorazioni calate dall'alto impone implicitamente un punto
di vista, ed invece che organizzare una riflessione sul conflitto iracheno, una
discussione sull'opportunità di quella missione militare all'estero, fa
semplicemente da grancassa al trambusto mediatico, e contribuisce al risorgere
di quel discutibile "sentimento della patria" che nasconde il rilancio della
funzione offensiva dell'esercito; un esercito che, in barba alla costituzione, è
stato impiegato in 15 anni per ben 4 volte in operazioni militari al seguito
delle guerre statunitensi. Anche quando c'è stata la strage dei bambini in una
scuola della Cecenia si è ripetuta a scuola la commemorazione silenziosa;
curiosamente questa volta non é stata imposta direttamente dal governo, ma
organizzata dal solito trambusto dei mass-media. Ma il copione non è per questo
cambiato di molto: siccome i terroristi Ceceni venivano presentati come islamici
e siccome gli USA ed i loro alleati erano impegnati in una serie di guerre
contro il “terrorismo islamico” qualcuno deve avere deciso di utilizzare anche
questo triste avvenimento per orientare la coscienza delle masse, e degli alunni
in particolare. E che dire del Papa commemorato col solito minuto di silenzio e
ricordato come "uomo di pace"? Proprio lui che col riconoscimento precipitoso
delle repubbliche secessioniste della ex-Jugoslavia aveva accelerato un processo
che avrebbe portato alla guerra fratricida? Proprio lui che dei preti uccisi
nella guerra civile spagnola, aveva beatificato solo quelli fedeli al fascista
Franco? E non parliamo delle sue discutibili scelte in ambito religioso per
evitare di scrivere un trattato sull'argomento. Intendiamoci, non mi interessa
in questa sede discutere sulla bontà o sulla presunta santità del defunto Papa
Giovanni Paolo II, quello che intendo rilevare é che la scuola rendendo omaggio
alla memoria di alcune persone e dimenticandosi invece di altre, fa una scelta
che ha dei significati politici ben precisi, e che puzza tanto di
indottrinamento. "La scuola dell'indottrinamento scientifico". Quanto al resto,
o meglio, per quanto riguarda tutti gli aspetti controversi della cultura
ufficiale che vengono esaminati in questo sito, di confronto e di
contrapposizione ce n'é ben poca, ma quello che é peggio è che il confronto o
viene vietato o viene ostracizzato in ogni maniera. Se é comprensibile il fatto
che i docenti siano stati ingannati da un certo sistema di gestione del potere e
della cultura e che quindi non discutano quasi mai argomenti che mettano in
dubbio certe presunte verità (in particolare sull'affidabilità della medicina
ufficiale, sugli espianti, sull'aids, sulla psichiatria, sulla preistoria), ben
diverso é il fatto che quando ci si prova a prospettare un confronto su questi
tempi si scatenino i peggiori isterismi che portano perfino a vietare
l'approfondimento di certe tematiche controverse. La mia pluriennale esperienza
di docente nella scuola superiore mi ha permesso purtroppo di verificare che su
certe questioni l'atteggiamento di rifiuto del dissenso e di condanna di chi
esprime opinioni difformi é del tutto generalizzato. Ecco un primo esempio.
Espianti e trapianti. Liceo
scientifico di Caravaggio, agli inizi del 2000, su proposta di una professoressa
la scuola approva una visita ad un ospedale per andare ad assistere in diretta
ad un'operazione di trapianto. Al di là del fatto che una simile iniziativa si
potrebbe subito giudicare di cattivo gusto, la cosa peggiore è stata la maniera
in cui la scuola ha reagito alle proteste contro tale iniziativa. In seguito ad
un volantinaggio di protesta della "Lega nazionale contro la predazione degli
organi" che cosa ha pensare di fare l'istituzione scolastica per garantire una
serena discussione di approfondimento su questo tema controverso? Semplice, ha
chiamato un medico favorevole ai trapianti per tenere una conferenza rivolta
soprattutto agli alunni delle ultime classi, senza pensare minimamente a
prevedere alcun contraddittorio. Come lo volete chiamare questo? … "orientamento
guidato"? ...Il caso ha voluto che il giorno stesso in cui era prevista quelle
conferenza a favore dei trapianti io fossi stato invitato nella stessa scuola a
tenere una relazione sull'embargo in Iraq. Si trattava di iniziative all'interno
di quella che viene (spesso impropriamente) chiamata "autogestione", uno spazio
di alcuni giorni dedicato a dibattiti, discussioni, approfondimenti su tematiche
sociali e politiche di attualità. Finita la mia relazione sull'Iraq sono venuto
a sapere che subito dopo iniziava la conferenza sui trapianti. Allora ho chiesto
ad alcuni alunni responsabili dello svolgimento di quella "autogestione" se
potevo partecipare alla conferenza per esprimere pareri opposti a quelli del
conferenziere e permettere un contraddittorio. Per essere corretto non sono
entrato nella sala in cui si svolgeva la conferenza prima di chiedere ed
ottenere un permesso. Risultato: dopo 10 minuti in cui ho contestato alcune
affermazioni del relatore ufficiale arriva il vicepreside ha "espellermi". Ma
come, non era un'autogestione? No, risponde il vicepreside, in realtà si
trattava di una "co-gestione", ossia un'iniziativa gestita dalla direzione
scolastica in collaborazione con gli studenti, ed il mio intervento non era
previsto. L'idea di approfittare della presenza di un esperto che potesse
ravvivare il dibattito e creare un contraddittorio é ovviamente fuori dalla
portata di certe persone. Dopo qualche anno è successo il bis in una scuola in
cui insegnavo, quando con una collega di Italiano abbiamo affrontato il tema dei
trapianti, facendo leggere articoli pro e contro la donazione degli organi (da
notare che la mia collega è moglie di un medico che ha lavorato in rianimazione
e certificato alcune “morti cerebrali”), ed a fine anno abbiamo pure organizzato
una presentazione ai genitori ed alla scuola il lavoro da noi svolto. In questo
“happening di fine anno” sono stati anche presentati i dati:
fra gli alunni di quella
classe (primo liceo) che hanno approfondito l’argomento, nonché fra i genitori
che erano stati coinvolti nella discussione, l’80% era contrario alla “donazione
degli organi”;
fra gli alunni di un’altra
classe (sempre una prima liceo), che non aveva mai approfondito la tematica,
nonché fra i loro genitori, l’80% era favorevole alla “donazione degli organi”.
In quell’occasione io ho anche
espresso (cercando persino di moderarmi a causa della mia “veste istituzionale”)
alcune mie perplessità sulla donazione degli organi, mentre un dottore (il
marito della mia collega) ha espresso la sua convinzione sulla correttezza della
dichiarazione di “morte cerebrale” pur facendo alcuni distinguo sulle modalità
con cui avveniva la “donazione”. Risultato: il preside mi ha additato al
pubblico disprezzo come indottrinatore durante una riunione collegiale dei
docenti della scuola (lo ringrazio per avermi considerato così bravo da
indottrinare e convincere non solo i miei alunni ma persino i loro genitori che
hanno solo ricevuto dei materiali di opposte tendenze sul trapianto e la
donazione degli organi). Come se non bastasse durante un colloquio personale mi
ha precisato che i docenti che avevano fatto propaganda esplicita alla donazione
degli organi hanno agito bene, mentre io che ho provato (con tutti i miei
limiti) ad informare sul pro e sul contro della questione ho agito male ed ho
indottrinato gli studenti !!! Ah dimenticavo, il mio preside si vantava di
“essere di sinistra” (e che vuol dire)? Ah dimenticavo, due anni dopo hanno
fatto in un’altra classe un lavoro di ricerca sui trapianti, avendolo saputo mi
sono offerto come collaboratore per contribuire ad una informazione non
settaria. Non solo mi hanno escluso, ma nei lavori dei ragazzi non ho visto
traccia del dubbio, nemmeno del dubbio, che trapianti/espianti potessero essere
poco utili e poco etici. Avete capito come funziona la scuola?
E poi c'è ancora un'altra
storia.
"Raccogliamo soldi contro il
cancro". Sempre nella stessa scuola mi sono opposto alla raccolta di fondi per
un’associazione che “lotta contro la leucemia”, che sostiene i trapiantati di
midollo (e che quindi propaganda, sebbene indirettamente, il trapianto di
midollo). Ho provato per 4 anni a chiedere su quali basi scientifiche si potesse
affermare che il trapianto di midollo fosse utile nella cura della leucemia, e
devo dire che a volte ho litigato ferocemente con alcuni docenti (povero me,
com’ero ingenuo a quei tempi!). Per 4 anni mi hanno detto che “le prove ci
sono”, “te le porteremo prima o poi”. Poi ho chiesto per telefono
all’associazione “contro la leucemia” e avessero tali dati. “Non ne abbiamo - è
stata la risposta - si rivolga ai medici dell’Ospedale”. Poi finalmente mi sono
rivolto a Internet (perché non ci ho pensato prima?) e ho scoperto che la
mortalità per leucemia è del 67%, quella per trapianto di midollo … indovinate!
Intorno al 66% (con la maggior parte dei decessi nei primi due anni dal
trapianto). Un’ottima cura quella del trapianto non c’è che dire, tanto è vero
che in quella scuola si usava raccogliere fondi per “la lotta alla leucemia” in
memoria di una ragazza leucemica che era stata trapiantata ben due volte ed era
morta. Due insuccessi non sono bastati per aprire gli occhi. E adesso cosa
credete che sia successo quando ho stampato quei dati (presi dal sito del
ministero della sanità e dal sito dell’Istituto nazionale dei tumori) e li ho
mostrati ai miei colleghi? Niente, niente di niente, tutto come prima. E si
continuano a raccogliere fondi. Avete capito come funziona la scuola?
No, no, non è finita, perchè è
la volta del'AIDS!
AIDS: Vietato dissentire.
Sempre la solita scuola, propongo di realizzare in alcune classi un lavoro di
confronto pro e contro l'ipotesi che l'HIV causi l'AIDS, mi riesco persino a
procurare due medici relatori di opposte tendenze. Inizio ad approntare il
materiale di studio, pro e contro, presento il progetto in presidenza (anche per
i finanziamenti, per quanto piccoli, del caso), e per correttezza lascio (con
grande anticipo) una copia del progetto ai colleghi di scienze per stimolare il
dibattito e per verificare se da parte loro ci fossero eventuali perplessità.
Risultato: i colleghi di scienze non dicono niente fino alla riunione del
collegio docenti in cui si discutono i vari progetti ... poi d'improvviso in
quell'occasione esplodono tuonando contro di me e dicendo che il mio progetto è
pericoloso. E d'altronde come dargli torto? Sì, è pericoloso, i ragazzi potrebbe
iniziare a pensare con la loro testa. Ma di cosa avevano paura? Se l'AIDS fosse
sicuramente una malattia virale ci vorrebbe poco a smontare le tesi di chi pensa
che siano altri i fattori che scatenano tale mortale sindrome. Se fosse tutto
così vero, così sicuro, un approfondimento tematico da parte degli studenti,
persino un confronto coi fautori di teorie differenti li rassicurerebbe sul
fatto che l'AIDS è una malattia infettiva e che bisogna difendersi con ogni
mezzo dal contagio dell'HIV. Eppure ... vietato, sissignori, vietato! I dogmi
sull'AIDS non si possono discutere. Ovviamente tutti i colleghi intimoriti dalla
levata di scudi del team di scienze cosa pensate che abbiano votato? Vietato,
vietato, proposta da bocciare! Però questa volta c'è il lieto fine. Uno dei
colleghi di scienze ha avuto il coraggio di approfondire la questione, leggere i
libri dei "dissidenti" e degli "eretici", confrontare le loro tesi con quelle
ufficiali, e poi alla fine dell'anno dichiarare di fronte ai docenti tutti che
si era convinto che l'AIDS non fosse una malattia infettiva. Un'altra collega a
fine anno mi ha confessato che aveva più dubbi che certezze sull'argomento. Due
docenti di scienze su 5 non è poco, specie se sono gli unici che si mettono in
discussione, perchè in tal caso la percentuale sale al 100%. Poi ho scopeto che
una docente di scienze era particolarmente contraria al mio progetto: aveva
lavorato come volontaria in Africa per "curare i malati di AIDS"! Penso proprio
che non avrebbe mai accettato di mettere discussione il proprio operato.
Ooops, non è finita! Che ne
dite di Telethon?
Soldi per la ricerca genetica.
A me non piace per niente (a dire poco) perchè finanzia la vivisezione, perchè
la ricerca genetica credo abbia finalità ben diverse da quelle dichiarate,
perchè i geni sono solo una parte del problema ma è fondamentale l'interazione
con l'ambiente: ci sono diversi casi di malattie "genetiche" che non si
manifestano se si segue una certa alimentazione. Ma la lista sarebbe è lunga.
Per farla breve, in un'altra scuola (tanto il problema è sempre lo stesso)
l'anno scorso si sono raccolti fondi per Telethon, io ero contrario, ho
comunicato la mia contrarietà ai docenti che hanno sostenuto l'iniziativa (tali
iniziative ovviamente non vengono discusse in nessuna sede, vengono approvate
tout court!) e al preside. Dietro mia richiesta e insistenza l'unica motivazione
che sono riusciti a produrre per una tale raccolta di fondi è che "si spera che
queste ricerche alla fine producano qualche risultato positivo". Qualcuno mi ha
detto che però "i ragazzi sono stati informati", non hanno donato soldi a
scatola chiusa. "Informati come?" chiedo io. "Con gli opuscoli Telethon!" è
l'ingenua risposta. A quanto pare quando si parla di medicina la par condicio
non esiste, la scienza ufficiale non si tocca. Avete capito come funziona la
scuola?
“Si cambia partendo dai
bambini”: prove tecniche di indottrinamento? Scrive il Comitato Articolo 26.
Prima di questo, si consiglia di leggere l’articolo precedente (200 milioni per
l'educazione di genere) per comprendere i presupposti a partire dai quali
vengono sviluppati i ragionamenti qui riportati.
Istruzione: 200 milioni per
l’educazione di genere! Introduzione dell’educazione di genere e della
prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del
sistema nazionale di istruzione e nelle università è il nome di una nuova
proposta di legge che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di prevenire il
femminicidio e di combattere le discriminazioni. Cosa ci potrai mai essere di
male in una iniziativa simile e chi potrebbe non condividere finalità così
nobili? Per esempio chi, informandosi e approfondendo, ha visto cadere il velo
dell’apparenza e ha ormai chiaro che per “genere” non si intende (solo) il sesso
femminile contrapposto al maschile, ma tutta una concezione della sessualità e
della persona. Al contrario, chi si limiterà a restare in superficie
accontentandosi di qualche slogan senza volersi affacciare ai contenuti più
profondi della “rivoluzione gender”, forse continuerà a ritenere le voci
critiche come posizioni incomprensibili e reazionarie, ma con il rischio
concreto di venire manipolato da un’ideologia che cerca di far credere che
neppure esista. L’attuale classe politica avrà una responsabilità enorme nel
caso in cui voglia volgere lo sguardo altrove per non vedere che dietro ai
concetti di “educazione alla parità” o di “decostruzione degli stereotipi
sessisti”, in realtà si cela una visione radicale ed inaccettabile della
persona, dell’identità sessuale e della famiglia. Lo ripetiamo: se l’unica
finalità di questi programmi fosse educare al rispetto tra maschi e femmine,
valorizzare il ruolo delle donne nella storia o criticare l’oggettivazione dei
corpi femminili nelle pubblicità, ne saremmo tutti ben lieti. Ma come è ormai
manifesto nelle gender theories, come viene recepito da svariati documenti
internazionali e poi messo in pratica anche in molte scuole di casa nostra,
educare “alle differenze di genere” troppo spesso sottintende condurre i giovani
all’indifferentismo sessuale e al non concepirsi come donne o uomini, ma come
individui per i quali la caratterizzazione sessuale, l’identità di genere e
l’orientamento sessuale sono fluidi, continuamente modificabili e in fin dei
conti irrilevanti. E’ emblematico il fatto che quando si parla di stereotipi di
genere, si finisca sempre a parlare di stereotipi in base all’orientamento
sessuale (come del resto fa anche la risoluzione n.2011/2116 per l’eliminazione
degli stereotipi di genere in Europa, che la suddetta proposta di legge
richiama). Il percorso classico è partire sottolineando le differenze
individuali (una donna camionista o un ragazzo amante del cucito) per arrivare
ad affermare che le differenze non esistono affatto, vale a dire che non esiste
un quid che sostanzia naturalmente l’umanità come divisa in maschi e femmine.
Cosa ne deriva? Che non solo sarebbe indifferente come nasciamo, ma anche il
nostro orientamento sessuale, pena il diventare discriminanti. E a partire da
questo presupposto, la mamma che fa la torta o la bambina che culla la bambola
diventano immagini che indurrebbero ad una disparità tra maschi e femmine e
alimenterebbero una cultura misogina: ecco quindi che vanno eliminate dalle
teste (e dai testi) degli studenti. Un esempio di educare alle differenze
sarebbe il libro “Mi piace Spider Man”, che viene consigliato alla scuola
materna dai 4 anni (?!?). La piccola protagonista deve combattere non pochi
“stereotipi” per conquistare la sua cartella “da maschio” che le piace tanto. E
va bene; ma perché qualche pagina dopo, le fanno dire – a lei che di anni ne
avrebbe sei – che ha capito che “da grande potrà avere un fidanzato o una
fidanzata”? A sei anni? Come ha scritto pochi giorni fa Karen Rubin su “Il
Giornale” a tal proposito, non si considera che “di un universo femminile che
contempla più volti, i bambini piccoli conoscono solo la parte che li riguarda…
Poco importa che faccia l’astronauta o la dottoressa: la mamma il piccolo la
vorrebbe sempre con sé. E’ degradante tutto ciò?… Si sogna una società dove
padri e madri siano interscambiabili e le torte non siano più menzionate,
neanche fossero droghe pesanti… C’è un errore in tutto questo. La mamma che
cucina e la bambina che culla la bambola non sono stereotipi, sono ruoli di
genere che si legano strettamente all’identità di ogni essere umano. Se la mamma
prepara il cibo per il suo piccolo non trasmette debolezza ma amore. Se il padre
è virile perché protegge i figli e la moglie manda un messaggio di forza e
coraggio. Se invece picchia la sua compagna non è una questione da ridurre a
stereotipi”. E come conclude la Rubin “duecento milioni di euro – questo
l’esborso per questa riforma scolastica a carico nostro, che siamo abituati ad
autotassarci per dotare di carta igienica le scuole dei nostri figli - sono
davvero sprecati per censurare le immagini. Usiamoli per educare gli uomini e
lasciamo in pace i bambini“.
In un paese democratico sui
banchi di scuola ci si dovrebbe sedere per imparare l’arte lunga e difficile
della vera libertà, e non per subire un indottrinamento, che appoggia per altro
su discutibili basi filosofico-teoretiche spacciate per scientifiche. Da quanto
si evince da una recente intervista apparsa su La Repubblica, non la pensa così
Valeria Fedeli, PD, vicepresidente del Senato, che parla proprio di un
insegnamento che si vuole rendere normativo e vincolante e il cui contenuto
ormai dichiarato è l’ideologia gender. In questa intervista con poche parole
viene liquidata un’intera civiltà, basata sulla legge di natura e sulla forma
corrispondente di razionalità: “i luoghi comuni che inchiodano maschi e femmine
a stereotipi, che ignorano quanto l’altra metà del cielo ha fatto in tutti
campi”. Come se la porzione più consistente di questi importanti conseguimenti
femminili non fosse stata realizzata all’interno della suddetta civiltà. Ci
viene da chiederci se la Fedeli si renda conto che la società che programma di
decostruire partendo dalla scuola è proprio quella che l’ha condotta a ricoprire
il ruolo di vicepresidente del Senato (mentre una donna presiede la Camera e si
riscontra una parità tra ministri di sesso maschile e femminile); citando delle
frasi della sua intervista ci viene da tranquillizzarla, perché i fatti già
dicono altro: oggi parlare come fa lei di passività delle donne può giusto
essere un vecchio ricordo stereotipato, mentre il tempo di crisi che le famiglie
concrete stanno affrontando ha già messo in fuga tutti i principi azzurri su
piazza, per cui i sogni delle femminucce si sono adeguati diventando molto più a
buon mercato. L’educazione di genere – che dando credito a qualcuno neppure
esisterebbe, quasi fosse una teoria del complotto di pochi reazionari – verrebbe
così introdotta tramite un apposito disegno di legge nelle scuole e nelle
università nell’intento di spazzare via, in nome di una libertà banalizzata,
l’inaccettabile adeguarsi alla verità dei programmi educativi tradizionali,
elaborati dalla razionalità del buon senso naturale e presupponenti la
differenza sessuale come dato di fatto autoevidente ed inamovibile. E’
incredibile il prezzo che si è disposti a pagare pur di distorcere la realtà. E’
impressionante il modo semplicistico con il quale il sistema scolastico venga
etichettato come anticaglia da cestinare: le elementari vengono banalizzate come
fucina di storielle discriminatorie e non come primo stadio della
scolarizzazione, più che mai rispettoso della differenza sessuale, non in nome
di un’ideologia conservatrice, ma perché indirizzato ad esseri umani, molto
vulnerabili e manipolabili, che trovano in tale differenza il loro primo solido
orientamento identitario. Nell’intervista della Fedeli si parla di parità, di
uguaglianza, di rispetto, di libertà. Parole altisonanti, politicamente
corrette, che incantano lettori ed ascoltatori, che mettono d’accordo tutti, ma
lasciate come sono del tutto prive di contenuto, diventano oggetto di una
manipolazione semantica gravissima, venendo in modo subdolo riempite di
contenuti razionalmente inaccettabili. Ma la cosa più paradossale è che questo
peana per la libertà si conclude, nel massimo dispregio del principio di non
contraddizione, con un’affermazione programmatica dal sinistro tenore
totalitario e liberticida: “si cambia partendo dai bambini, gli uomini di
domani“. L’avrebbe condivisa Pol Pot. Si parte dai bambini, arrivando a
sottrarne l’educazione sessuale ai violenti e retrogradi genitori, perché solo
in esseri indifesi e non ancora formati dal punto di vista razionale può sperare
di attecchire in profondità una visione dell’uomo tanto priva di base
scientifica e per questo lontana dalla realtà come quella propugnata
dall’ideologia ipersessualizzata del gender. E vorremmo chiudere permettendoci
una riflessione, un appello che speriamo che la prima firmataria della legge
voglia ascoltare: è stato preso in considerazione il fatto che il fenomeno della
violenza contro le donne è fortemente connesso al fenomeno
dell’ipersessualizzazione della società e del mondo maschile? Domanda: siamo
certi che l’investimento dei 200 milioni di euro per tirare la volata al gender
e agli standard OMS con la loro sovra-esposizione al sesso fin dalla più tenera
età non si riveli un doloroso boomerang proprio per il mondo femminile che si
vorrebbe proteggere?
L’ideologia oggi è la mancanza
di serietà. Una prof racconta, scrive Marina Valensise su “Il Foglio”. Anna
Maria Ansaloni è una prof un po’ speciale, è vero. Insegna al Leonardo da
Vinci-Duca degli Abruzzi, il liceo tecnico di via Palestro, quartiere centrale.
E’ convinta che la scuola non debba fare quello che “vogliono le famiglie”, ma
“formare il cittadino”, e pensa anzi che le famiglie oggi siano spesso ignare
dei veri problemi della scuola. Ma su un punto conviene con l’allarme lanciato
dal presidente del Consiglio, quando difende l’insegnamento libero contro
l’indottrinamento ideologico. “I genitori sanno che i loro figli escono dalla
scuola sprovvisti delle competenze che invece loro avevano alla stessa età. Per
questo, insistono perché la scuola sia più seria, più attenta alle conoscenze di
base, più centrata sulla disciplina e sul rigore”. Anna Maria Ansaloni è
un’entusiasta, è un’insegnante che adora insegnare. E’ convinta che l’egemonia
di sinistra non sia altro che un ricordo sbiadito: “E’ semplicemente morta. La
sinistra non esiste più, nel mondo della scuola è irrilevante, mi pare. Tieni
conto che la maggioranza degli insegnanti oggi quarantenni ha vissuto gli ultimi
vent’anni con Berlusconi. L’ideologia semmai sopravvive come abitudine di
costume, nell’occupazione, che non è un fatto politico, ma un rituale di
passaggio”. La prof Ansaloni insegna Italiano e storia in una seconda e terza
classe, ha le idee chiare e i mezzi per realizzarle: “Il vero dramma è la scuola
media, dove i ragazzi disimparano ciò che apprendono alle elementari. Vedo
ragazzi che scrivono a matita perché poi così possono cancellare, ma scrivono
compiti di otto pensierini che non sono da scuola superiore. Io perciò lavoro
molto sul costruire le regole. I ragazzi purtroppo sono molto lenti e
disordinati. Vanno educati a un certo ordine nell’esporre gli argomenti, a una
notevole quantità di compiti sistematicamente valutati e compresi, alla
chiarezza dal punto di vista linguistico. Fraintendimento e intendimento per
loro sono la stessa cosa. Per lavorare sul senso delle parole e sulla forma
scritta, devi tornare ai testi appresi a memoria, perché senza chiarezza non c’è
conoscenza. Devi fargli capire che la fatica è inevitabile, mettere sanzioni
chiare e rispettarle”. La professoressa Ansaloni, dunque, ha rafforzato i
programmi di lettura. Una volta al mese riunisce gli studenti di 14 e 15 anni
nella biblioteca della scuola per discutere con signore di 60 o 70 anni dello
stesso libro, e a volte incontrare l’autore. “Mi piace tantissimo parlare con
queste signore, mi ha detto un ragazzino, non sono mica come mia madre. Non è
l’alunno a parlare, ma il lettore e il lettore è trasversale”. In questo modo si
accrescono le competenze linguistiche, si supera un problema didattico. “Noi
adottiamo libri di testo inadeguati ai ragazzi” dice infatti la prof Ansaloni.
“Per capirli devi decodificarli, e per questo cerco di costruire una sintesi, di
fare scrivere i miei allievi su quel testo, di fargli poi valutare cosa
realmente ne hanno capito. Dobbiamo ampliare il lessico. Una volta i nostri
figli parlavano con 300 parole, ora ne usano 50. Perciò io punto a rafforzare il
programma scolastico col lavoro di lettura e di scrittura e la verifica
attraverso i questionari. E’ vero che molti miei colleghi non mi seguono,
"lasciami stare, mi dicono, con 1.600 euro al mese, per mantenere moglie e due
figli devo fare tre lavori". Ma risultati ci sono. Se dico ai miei ragazzi,
guarda, quel tizio non ha né artigli né zanne, loro continuano, sì però non
voleva essere sbranato. Vuol dire che qualcosa dei ‘Promessi Sposi’ è rimasto:
il lessico e la lettura gli si è sedimentata dentro e in modo naturale”. C’è
anche un altro handicap dei giovani d’oggi: nessuno scrive più in corsivo. “Il
corsivo è scomparso. Abituati col computer e l’sms scrivono tutti in
stampatello, alcuni non sanno più come si scrivono certe maiuscole in corsivo.
Non è solo una questione di grafia o calligrafia. In stampatello, usano frasi
sintetiche di comunicazione, non di espressione: vado, vengo, anziché – penso di
venire, avrei intenzione di andare, con una struttura della frase paratattica,
senza principali e secondarie, ma con una sfilza di principali spesso con la
stessa forma verbale. Il corsivo invece prevede un certo tempo in cui pensi,
elabori, unisci le lettere, ti dà una capacità riflessiva, permette
un’elaborazione concettuale che implica l’uso di articoli, aggettivi, la
punteggiatura, la varietà di forme verbali e l’espressione di sé. Oggi i ragazzi
è proprio questo che vogliono evitare: non sanno né vogliono scrivere di sé,
esprimere emozioni, anche se ce le hanno dentro. Allora devi aiutarli. Io per
esempio quando leggiamo un sonetto di Dante, ‘Tanto gentile e tanto onesta
pare’, chiedo ai ragazzi di cercare dei raffronti con l’immensità, con Dio, con
la spiritualità. Loro li trovano nelle canzoni di Vasco Rossi o Jovanotti, e per
me è un successo”. La maggiore soddisfazione, però, Ansaloni dice di averla
“tutti i giorni quando entro in classe, perché insegnare mi diverte da morire,
quando i ragazzi trascorrono un’ora senza rendersene conto, quando vedo
all’intervallo quello con la cresta che ti cita una frase di Manzoni. Adesso sta
leggendo il ‘Postino di Neruda’ di Skármeta, e una sua allieva rumena, brava e
determinata, che dopo la scuola lavora come babysitter, quasi non ci crede:
‘Professoressa, le metafore le possiamo fare anche noi…’”.
Scuola: arriva il divieto per
gli insegnanti di fare propaganda politica e ideologica. Chi sgarra sarà
sospeso. Un deputato del Pdl ha proposto un'aggiunta al testo unico sulla scuola
per impedire agli insegnanti di fare propaganda politica. Secondo lui questo
avverrebbe soprattutto in Emilia Romagna. A vigilare dovranno essere i dirigenti
scolastici, scrive Marta Ferrucci su “Studenti”. Fabio Garagnani, deputato del
Pdl, ha proposto una aggiunta al testo unico sulla scuola: il divieto per gli
insegnanti di fare propaganda politica e ideologica. Dovranno essere i
dirigenti scolastici a vigilare e per chi sgarra è prevista la sospensione da 1
a 3 mesi. "L'importante era inserire nel Testo unico sulla scuola il divieto di
fare propaganda politica o ideologica per i professori". Per quanto riguarda le
sanzioni queste dovranno essere contenute poi in dettaglio in un provvedimento
attuativo della legge. La propaganda politica" -secondo garagnani- "non può
trovare tutela nel principio della libertà dell'insegnamento enunciato
dall'Articolo 33 della Costituzione. Un conto infatti è tutelare la libertà di
espressione del docente, un'altra è quella di consentire che nella scuola si
continui a fare impunemente propaganda politica". E sarebbero molti i casi in
cui i professori oltrepassano questo limite; per Garagnani accade soprattutto in
Emilia Romagna, tra i professori iscritti alla Cgil". Per Mimmo Pantaleo,
segretario generale della Flc-Cgil si tratta di una proposta "delirante" ed ha
aggiunto che "gli insegnanti educano, non inculcano". Ha ragione Garagnani o si
tratta di una proposta "delirante"?
"Troppi libri comunisti a
scuola", Pdl: Ci vuole una commissione d'inchiesta, scrive Agenzia Dire su
“Orizzonti Scuola” - Iniziativa di 19 deputati guidati da Gabriella Carlucci,
all'indice i testi di storia: "Gettano fango su Berlusconi". Dopo i giudici,
anche i libri di testo contro Silvio Berlusconi. Secondo 19 deputati del Pdl,
capitanati da Gabriella Carlucci, i testi scolastici di storia, su cui studiano
migliaia di ragazzi, nasconderebbero "tentativi subdoli di indottrinamento" per
"plagiare" le giovani generazioni "a fini elettorali" dando "una visione
ufficiale della storia e dell'attualità asservita a una parte politica", il
centrosinistra, "contro la parte politica che ne è antagonista", ossia il
centrodestra. Di fronte a questa situazione definita "vergognosa", secondo i
parlamentari del Pdl, il parlamento "non può far finta di non vedere" e per
questo chiedono, attraverso una proposta di legge, l'istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta "sull'imparzialità dei libri di testo
scolastici". Il progetto di legge è stato depositato alla Camera da Carlucci il
18 febbraio 2011 e assegnato alla commissione Cultura il 14 marzo. In attesa
dell'avvio dell'esame, in questi giorni la proposta è stata sottoscritta da
altri colleghi di partito (ieri si sono aggiunte nuove firme e altre ancora ne
stanno arrivando), tra cui il capogruppo Pdl in commissione Cultura, Emerenzio
Barbieri. Nella premessa, gli esponenti di maggioranza si chiedono: "Può la
scuola di Stato, quella che paghiamo con i nostri soldi, trasformarsi in una
fabbrica di pensiero partigiano?" E la "battaglia partigiana", secondo il
firmatari, viene messa in atto "osannando l'attuale schieramento di sinistra" e
"gettando fango sui loro avversari". Per "capire la gravità del problema",
sostengono i 19 deputati, "basta sfogliare la maggior parte dei libri che oggi
troviamo nelle scuole, sui banchi dei nostri figli". Scopo della Commissione
d'inchiesta? "Verificare quali sono i libri faziosi - spiega Barbieri
interpellato dalla Dire - e dargli il tempo di adeguarsi prima di farli ritirare
dal mercato, mica mandarli al macero...". Gli altri firmatari della proposta di
legge Carlucci, che mette all'indice i libri di testo definiti "partigiani",
sono: Barani, Botta, Lisi, Scandroglio, Bergamini, Biasotti, Castiello, Di Cagno
Abbrescia, Di Virgilio, Dima, Girlanda, Holzmann, Giulio Marini, Nastri, Sbai,
Simeoni e Zacchera. Nella premessa, si fanno alcuni esempi dei testi
incriminati, specificando che "in Italia, negli ultimi cinquant'anni, lo studio
della storia è stato spesso sostituito da un puro e semplice tentativo di
indottrinamento ideologico" retaggio "dell'idea gramsciana della conquista delle
casematte del potere" che "si è propagato attraverso l'insegnamento della storia
e della filosofia nelle scuole". Si cita La storia di Della
Peruta-Chittolini-Capra, edito da Le Monnier, che descrive "tre personaggi
storici: Palmiro Togliatti, un uomo politico intelligente, duttile e capace di
ampie visioni generali; Enrico Berlinguer, un uomo di profonda onestà morale e
intellettuale, misurato e alieno alla retorica; Alcide De Gasperi, uno statista
formatosi nel clima della tradizione politica cattolica". Ma anche Elementi di
storia di Camera-Fabietti, edito da Zanichelli, reo, ad avviso del Pdl, di
sostenere che "l'ignominia dei gulag sovietici non è dipesa da questo sacrosanto
ideale (il comunismo), ma dal tentativo utopico di tradurlo immediatamente in
atto o peggio dalla conversione di Stalin al tradizionale imperialismo". E
ancora, la Storia, volume III, di De Bernardi-Guarracino, edito da Bruno
Mondadori, per il quale dal 1948 "l'attuazione della Costituzione sarebbe
diventato uno degli obiettivi dell'azione politica delle forze di sinistra e
democratiche". E si arriva ai tempi più recenti. "Con la caduta del Muro di
Berlino e con la fine dell'ideologia comunista in Italia - si precisa nella
premessa alla proposta - i tentativi subdoli di indottrinamento restano tali" e
anzi "si rafforzano e si scagliano" contro "la parte politica che oggi è
antagonista della sinistra", quella guidata da Berlusconi. Nella proposta di
legge Carlucci, sottoscritta alla Camera da altri 18 deputati Pdl per istituire
una Commissione d'inchiesta per verificare "l'imparzialità dei libri di testo
scolastici", la messa all'indice viene supportata infine dai passaggi che
descrivono gli ultimi 15/20 anni di storia politica italiana, ossia l'era
berlusconiana. Uno degli esempi che, secondo i firmatari, "osanna" agli occhi
degli studenti i partiti di centrosinistra lo si ritrova ne La storia di Della
Peruta-Chittolini-Capra, edito da Le Monnier, a proposito del Partito
democratico della sinistra: "Il Pds - è scritto - intende proporsi come il polo
di aggregazione delle forze democratiche e progressiste italiane" con "un
programma di riforme politico sociali miranti a rendere più governabile il
Paese". Si tira poi in ballo la descrizione che L'età contemporanea di
Ortoleva-Revelli, edito da Bruno Mondadori, fa di Oscar Luigi Scalfaro: "Dopo
aver abbandonato l'esercizio della magistratura per passare all'attività
politica nel partito democristiano" si è segnalato "per il rigore morale e la
valorizzazione delle istituzioni parlamentari". Ma il testo che più si distingue
"per la quantità di notizie partigiane e propagandistiche" è, secondo i 19
deputati Pdl, quello di Camera e Fabietti. In Elementi di storia, citano, viene
descritta l'attuale presidente del Pd, Rosy Bindi, come la "combattiva
europarlamentare" che, ai tempi della militanza nella Democrazia cristiana,
sollecitava ad "allontanare dalle cariche di partito" tutti "i propri esponenti
inquisiti". E come viene descritto l'antagonista Berlusconi? Nel 1994, citano
ancora i parlamentari dalle pagine del libro di testo, "con Berlusconi
presidente del Consiglio, la democrazia italiana arriva a un passo dal
disastro". Secondo gli autori, "l'uso sistematicamente aggressivo dei media, i
ripetuti attacchi alla magistratura, alla Direzione generale antimafia, alla
Banca d'Italia, alla Corte costituzionale e soprattutto al presidente della
Repubblica condotti da Berlusconi e dai suoi portavoce esasperarono le tensioni
politiche nel Paese". L'elenco dei libri "naturalmente potrebbe continuare
ancora per molto - conclude il Pdl - ma bastano questi esempi per capire la
gravità della questione".
Bagnasco contro i "campi
d'indottrinamento" gender. Scrive Massimo Introvigne su “La Nuova BQ”. Lunedì 24
marzo 2014, aprendo il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale
Italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, che la presiede ha affrontato con grande
determinazione la problematica della famiglia e dell’ideologia di genere. «La
preparazione alla grande assise del sinodo sulla famiglia, che si celebrerà in
due fasi nel 2014 e nel 2015, nonché il recente concistoro sul medesimo tema –
ha detto Bagnasco – hanno provvidenzialmente riposto l’attenzione su questa
realtà tanto “disprezzata e maltrattata”, come ha detto il Papa: commenterei,
“disprezzata” sul piano culturale e “maltratta” sul piano politico». Il
cardinale ha inquadrato la natura ideologica del problema: la famiglia è
diventata il nemico da abbattere. «Colpisce che la famiglia sia non di rado
rappresentata come un capro espiatorio, quasi l’origine dei mali del nostro
tempo, anziché il presidio universale di un’umanità migliore e la garanzia di
continuità sociale. Non sono le buone leggi che garantiscono la buona convivenza
– esse sono necessarie – ma è la famiglia, vivaio naturale di buona umanità e di
società giusta». Il cardinale è andato oltre: non è rimasto sul generico, ma ha
citato come esempio dei maltrattamenti che la famiglia subisce un episodio
specifico, su cui – lo ricordiamo per la cronaca, senza rivendicare
primogeniture – per prima «La nuova Bussola quotidiana», nel silenzio generale,
aveva attirato l’attenzione. «In questa logica distorta e ideologica – ha detto
Bagnasco –, si innesta la recente iniziativa – variamente attribuita – di tre
volumetti dal titolo “Educare alla diversità a scuola”, che sono approdati nelle
scuole italiane, destinati alle scuole primarie e alle secondarie di primo e
secondo grado. In teoria le tre guide hanno lo scopo di sconfiggere bullismo e
discriminazione – cosa giusta –, in realtà mirano a “istillare” (è questo il
termine usato) nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la
fede religiosa, la differenza tra padre e madre… parole dolcissime che sembrano
oggi non solo fuori corso, ma persino imbarazzanti, tanto che si tende a
eliminarle anche dalle carte». Durissimo il commento del presidente dei vescovi
italiani «È la lettura ideologica del “genere” – una vera dittatura – che vuole
appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l’identità di uomo e
donna come pure astrazioni. Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare
della scuola dei “campi di rieducazione”, di “indottrinamento”. Ma i genitori
hanno ancora il diritto di educare i propri figli oppure sono stati esautorati?
Si è chiesto a loro non solo il parere ma anche l’esplicita autorizzazione? I
figli non sono materiale da esperimento in mano di nessuno, neppure di tecnici o
di cosiddetti esperti. I genitori non si facciano intimidire, hanno il diritto
di reagire con determinazione e chiarezza: non c’è autorità che tenga». Parole
chiarissime: altri vescovi prendano esempio. La strategia enunciata
esplicitamente da Papa Francesco nell’esortazione apostolica «Evangelii gaudium»
– il Papa di certe questioni, comprese quelle (citate in nota nel documento come
esempio delle «questioni» cui si allude) della famiglia e del gender, non parla,
chiede che siano gli episcopati nazionali a intervenire – non piace a tanti
nostri lettori, e dalle strategie, che non sono Magistero neppure ordinario, si
può certo legittimamente dissentire. Però qualche volta le strategie funzionano:
dove tace il Papa, i vescovi parlano. È successo negli Stati Uniti, in Polonia,
in Croazia, in Portogallo, in Slovacchia. Ora succede anche in Italia, e non si
può non ricordare che – come sempre avviene nel nostro Paese – prima di aprire
con questa relazione il Consiglio Permanente della CEI venerdì scorso Bagnasco è
andato in udienza dal Papa, cui questi testi sono di regola previamente
sottoposti. Vediamo se questa rondine farà, come ci auguriamo, primavera.
Genitori, reagite
all'imposizione dell'ideologia gender!. L'edizione di domenica di RomaSette, il
settimanale della diocesi di Roma, evidenzia e valorizza l'azione del Comitato
Articolo 26 contro i molteplici tentativi di introdurre nelle scuole l'ideologia
gender, scrive Giuseppe Rusconi su Zenit.org. Per questa domenica iniziale
d’Avvento RomaSette - l'inserto settimanale di Avvenire - ha scelto come
articolo di apertura un testo sull’ormai allarmante dilagare anche nelle scuole
romane – dagli asili nido in poi - dell’imposizione dell’ideologia del gender,
secondo la quale la differenza tra maschile e femminile è solo una costruzione
culturale e dunque va “decostruita” nel senso che ognuno non è quel che è e si
vede, ma ciò che si sente e pensa di essere. Il titolo è “Gender a scuola. La
protesta dei genitori”. In un box si danno indicazioni su un modulo, da inviare
al dirigente scolastico dell’istituto dei propri figli, per la richiesta di
consenso informato sulle iniziative ‘educative’ improntate all’ideologia
del gender. Nella stessa pagina, appare su quattro colonne anche un articolo
molto chiaro dal titolo: “Strategia Lgbt, i consulenti sono a senso unico”,
accompagnato dall’occhiello: “Ventinove associazioni del mondo gay a fianco
dell’Unar (Ndr: il noto Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per la
formazione, otto nei progetti finanziati dalla Regione Lazio. Proposta politica
con una bozza di ordine del giorno per il Consiglio comunale: indottrinamento
tra i banchi”. Si noterà qui subito che proprio la Regione Lazio – retta da
Nicola Zingaretti - ha sborsato 120mila euro per i progetti pro-gender, mentre
non si risparmia neppure la giunta Marino di Roma Capitale, grazie anche al
sostegno entusiasta dell’assessore alla Scuola Alessandra Cattoi, che ha
affidato all’associazione lgbt “Scosse” la formazione delle educatrici degli
asili nido e delle scuole materne comunali della città. Nell’articolo di Roma
Sette si ricorda il caso scoppiato presso l’asilo nido comunale “Castello
Incantato”, in zona Bufalotta, laddove ai pargoli si legge ad esempio la
“Piccola storia di una famiglia” (casa editrice Stampatello): tale cosiddetta
“famiglia” comprende due donne che si fanno donare il “semino” necessario alla
procreazione da una clinica olandese, tanto che alla fine la nascitura avrà “due
mamme: solo una l’ha portata nella pancia, ma entrambe, insieme, l’hanno messa
al mondo. Sono i suoi genitori”. E’ proprio dal tristo episodio del “Castello
Incantato” che ha preso spunto l’idea di alcuni genitori di costituire il
“Comitato Articolo 26”. Perché 26? Ci si riferisce all’articolo 26 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: I genitori hanno il diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Il
Comitato è aperto a genitori, docenti, professionisti dell’educazione, di
diverso credo religioso e filosofico, che “rifiutano con decisione
l’indottrinamento gender nelle scuole italiane di ogni ordine e grado e che
rivendicano, in maniera costruttiva, la priorità delle famiglie in tema di
affettività e sessualità”. Tra gli obiettivi “diffondere un’informazione
oggettiva e scientifica in merito alla cosiddetta ideologia gender”, “vigilare e
segnalare gli aspetti ideologici pedagogicamente infondati e pericolosi, di
progetti educativi e scolastici relativi a educazione sessuale e/o affettività,
educazione alle differenze, lotta alla discriminazione tra bambini e bambine,
lotta all’omofobia e/o al bullismo omofobico”, “sostenere e accompagnare il
diritto dei genitori ad affermare e perseguire la priorità della propria
missione educativa nei confronti dei figli”. Nell’articolo di Roma Sette sulla
strategia Lgbt si ricorda inoltre che “a livello nazionale è in piena
attuazione” tale strategia triennale, partorita due anni fa dall’Unar “istituito
in seno al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio”.
Era il tempo di Monti, poi venne Letta e la strategia andò avanti, così come con
Renzi. Del resto è dei giorni 26 e 27 novembre 2014 il corso per dirigenti
scolastici organizzato a Roma dal ministero dell’Istruzione e dall’Unar con la
collaborazione del Servizio lgbt di Rete nazionale delle Pubbliche
amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di
genere. Il Gruppo nazionale di lavoro è composto da 29 associazioni di settore,
tutte rigorosamente lgbt. Il 23 febbraio scorso, il settimanale della diocesi di
Roma aveva già dedicato quasi tutta la prima pagina all’ “operazione ideologica”
del “gender in classe”, con un editoriale chiaro, pacato e fermo di don Filippo
Morlacchi, in cui il direttore dell’Ufficio pastorale scolastica del Vicariato
scriveva: “Anche in altri Paesi europei la potente minoranza favorevole
al gender ha dettato l’agenda degli impegni scolastici; ma le associazioni di
genitori hanno alzato la voce e prodotto agili pubblicazioni per avvertire le
famiglie del fenomeno. Forse è tempo che anche in Italia non solo i cattolici,
ma tutti gli uomini convinti della bontà della famiglia naturale si esprimano
pubblicamente”. Un auspicio che è stato concretizzato in questi mesi da diverse
associazioni e comitati a livello cittadino, regionale, nazionale (in
primis la Manif pour tous Italia e le Sentinelle in piedi), in buona parte
nell’area cattolica ma aperte a tutti. A livello di diocesi, ricordiamo poi
l’esemplare "Nota su alcune urgenti questioni di carattere antropologico ed
educativo" dei vescovi del Triveneto per la Giornata della vita 2014, la grave
preoccupazione della Conferenza Episcopale toscana e di alcuni altri
vescovi. Nelle ultime settimane sono successi altri fatti gravi, oltre alle
intimidazioni fisiche e verbali con cui sono state bersagliate in diverse città
le Sentinelle. Ad esempio una docente di religione cattolica dell’Istituto
Pininfarina di Moncalieri è stata fatto oggetto ingiustamente di una
pesantissima campagna di stampa originata dalle affermazioni (pare del tutto
inventate) di uno studente attivista lgbt. Esposta al pubblico ludibrio dai
mass-media, nelle prime reazioni a caldo non è stata certo difesa neppure
dall’estemporaneamente remissivo arcivescovo di Torino. Grazie ad Avvenire è
stata poi ristabilita la verità almeno per i lettori del quotidiano della Cei,
oltre che per l’ambiente locale. La diocesi di Milano dal canto suo è incappata
in un paio di decisioni che hanno destato molta perplessità tra non pochi
cattolici: le scuse ufficiali per un’indagine statistica non certo segreta
(rivolta a oltre seimila docenti di religione cattolica) e la negata solidarietà
per un docente di religione (sospeso dalla scuola, con l’Ufficio scuola della
Curia che ha aperto un procedimento di verifica) colpevole di aver mostrato a
nove alunni di una terza liceo un documentario molto realistico, “L’urlo
silenzioso”, su quel che succede durante un aborto. E’ stata la fiera
dell’ipocrisia interessata, se si pensa alle tante immagini crude sfornate da tg
e trasmissioni varie per ragione di audience. Intanto, in pieno sviluppo
dell’applicazione della strategia totalitaria lgbt, l’Unione degli atei e
agnostici razionali (Uaar), l’Arcigay, la Rete degli studenti medi ha trovato
modo il 18 novembre di inviare una lettera allarmata al Ministro
dell’Istruzione, all’Unar e alla Presidenza del Consiglio per denunciare che
“stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco nei confronti degli studenti e
del sistema scolastico tutto, da parte di una frangia conservatrice e omofoba
del nostro Paese”. Proclamano e minacciano i firmatari: “Il Ministero, e il
Governo tutto, devono avere il coraggio di superare i tabù e di non fare della
battaglia alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale un
mero spot propagandistico. Riteniamo che il Ministero debba adoperarsi affinché
tutte le scuole prevedano programmi didattici strutturati, destinati agli
studenti, sull’educazione alle differenze, in cui si parli di identità di
genere, orientamento sessuale e sesso biologico, e che investa nella formazione
degli insegnanti, fornendo loro gli strumenti necessari così da evitare che casi
come quelli sopracitati si ripetano”. Non è finita. Tuonano infatti atei,
“studenti medi” e Arcigay: “Chiediamo, infine, di coinvolgere nei tavoli
ministeriali le realtà sociali, le associazioni e le organizzazioni studentesche
che da anni combattono le discriminazioni e l’omofobia e di far sì che questi
percorsi producano finalmente soluzioni concrete”. La lettera contiene poi già
una velata minaccia per gli istituti cattolici paritari, che certamente
la lobby sogna costretti ad accettare l’auspicato indottrinamento oppure a
chiudere. Nel resto d’Europa tentativi di tal genere sono già in corso, come in
Gran Bretagna o sono minacciati, come in Francia. Insomma: la legge
“antiomofobia” a firma Scalfarotto ancora non è stata approvata e già produce i
suoi effetti liberticidi, dato che – oltre alle intimidazioni continue – i
propugnatori dell’ideologia del gender si fanno sempre più sfrontati. Il rischio
è che, considerato quanto è successo fin qui, molti scelgano il silenzio per
evitare di essere lapidati dai media della nota lobby. Quel che è capitato del
resto a Guido Barilla è estremamente significativo. Sbilanciatosi l’anno scorso
in favore della famiglia del ‘Mulino Bianco’, è stato coperto di insulti e
minacce; ha così ritenuto molto opportuno profondersi in mille scuse e agire in
modo tale che oggi la Barilla è pienamente riabilitata. Come scrive
il Washington Post ha ottenuto 100/100 nella classifica delle
imprese gay-friendly, avendo in un anno fatto “una marcia indietro radicale,
aumentando i benefit sanitari per i dipendenti transgender e le loro famiglie,
donando soldi per le cause dei diritti gay", oltre che ingaggiare consulenti
come il “gay più potente d’America”, David Mixner, fiero dei risultati ottenuti.
Ora per la Barilla del Guido rieducato mancano solo gli spot con protagoniste
coppie omosessuali. Non temete, verranno presto. Si dovrà poi vedere se qualcuno
non preferirà a quel punto assaporare un altro tipo di pasta.
L’ISLAM NON SI TOCCA.
L’assessore scambia l’Islam
per terrorismo. Gli studenti: "Si deve dimettere". All’indomani della strage di
Parigi Elena Donezzan, responsabile per l’Istruzione della giunta veneta, scrive
un appello ai presidi per parlare di terrorismo, accostandolo alla religione
islamica. Scoppia il caso e la rete degli studenti chiede che lasci il suo posto
con pubbliche scuse e il ritiro delle frasi incriminate, scrive Michele Sasso
“L’Espresso”. Una frase ha scatenato un putiferio: «Se non si può dire che tutti
gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e
che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e
culturale ben precisa». È giovedì 8 gennaio 2015 e a vergare l’appassionata
lettera è l’assessore all’Istruzione della Regione Veneto, Elena Donezzan, che
pochi giorni prima aveva promosso un family day a scuola per difendere la
famiglia naturale. Scossa per il massacro nella redazione di Charlie Hebdo a
Parigi, torna alla carica non pensandoci troppo sopra. Una circolare indirizzata
a tutti i presidi della sua regione intitolata “Terrorismo islamico: parliamone
soprattutto a scuola” con passaggi forzati carichi di livore: «Alla luce della
presenza dei tanti alunni stranieri nelle nostre scuole e dei loro genitori
nelle nostre comunità, soprattutto a loro dobbiamo rivolgere il messaggio di
richiesta di una condanna di questi atti, perché se hanno deciso di venire in
Europa devono sapere che sono accolti in una civiltà con principi e valori,
regole e consuetudini a cui devono adeguarsi e che la civiltà che li sta
accogliendo con il massimo della pienezza dei diritti ha anche dei doveri da
rispettare». Se il fine è la conoscenza e il dibattito dell’attualità tra i
banchi il risultato di questa mossa è disastroso. Via change.org è partita una
petizione dell’associazione studenti universitari e della rete degli studenti
per chiedere le sue dimissioni con pubbliche scuse allegate e il ritiro delle
frasi incriminate. In più di quattromila hanno sottoscritto le motivazioni:
«Nella circolare si chiede a tutti i dirigenti di far discutere di quanto
accaduto, condannando non solo i fatti e chiedendo a genitori e studenti
stranieri di dissociarsi, ma anche la cultura islamica, che alimenta, secondo
l’assessore, la genesi di tali attacchi terroristici». A scaldare gli animi
l’accostamento della Donezzan tra il massacro di Parigi (e tutto quello che è
seguito per 55 ore di paura) con l’aggressione alle porte di Venezia di un
quattordicenne tunisino che ha accoltellato il padre di uno studente vittima di
bullismo. «Fare un paragone tra un gesto di bullismo e un massacro con armi da
fuoco è simbolo di un becero razzismo che non possiamo accettare, specialmente
se proveniente da una figura con una certa carica istituzionale», continua la
petizione: «Viene da domandarsi se questo parallelo sia frutto di una
strumentalizzazione cosciente dei fatti oppure da semplice ignoranza: i casi di
bullismo sono diffusi in tutto il Paese, non importa l’origine culturale del
ragazzo». Dietro gli studenti anche la Cgil regionale ha preso posizione: «La
lettera lascia stupefatti per il forte fondamentalismo ideologico sotteso nelle
indicazioni impartite. La scuola deve formare le intelligenze e lo spirito
critico di quelli che saranno i cittadini di domani, è un luogo di discussione e
riflessione anche per capire quanto accaduto in Francia».
Basta coi finti Charlie. La
sinistra si appropria dei simboli di ciò che ha sempre combattuto, scrive
Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. La mia libertà vale più o meno di quella
dei colleghi di Charlie? La nostra libertà, quella di ognuno di noi, compresi la
Le Pen e Salvini, quanto vale? E ancora: chi decide la classifica delle libertà?
Mi chiedo questo perché stiamo assistendo al più ipocrita degli spettacoli e al
più surreale dei dibattiti. Giornalisti, intellettuali e politici di sinistra si
sono stretti - dico io giustamente - attorno ai colleghi sterminati dalla furia
islamica. Ma, contemporaneamente, dagli stessi è partita una campagna contro
chi, come noi, sostiene che il pericolo viene proprio dal Corano, dall'islam e
dai suoi imam. In queste ore, in tv e sui giornali, ci stanno facendo passare
per dei provocatori, dei seminatori di odio, degli incendiari. Ma dico: se c'è
qualcuno che, in decimo, ha sostenuto e scritto negli anni ciò che Charlie ha
divulgato con la sua tecnica, siamo proprio noi. Noi siamo Charlie, la Fallaci è
Charlie, Magdi Allam è Charlie, Piero Ostellino è Charlie. I liberali tutti sono
Charlie. Voi di sinistra siete solo degli approfittatori, vi siete impossessati
del corpo di un nemico ucciso per quella libertà di opinione che voi di sinistra
negavate prima della strage (satira religiosa sì, ma solo contro il Papa e Gesù)
e che ancora ora vorreste negare a noi. Se questo Giornale avesse pubblicato una
sola di quelle vignette blasfeme saremmo stati linciati come razzisti, fascisti,
pazzi irresponsabili e messi al gabbio dalla solerte magistratura italiana per
islamofobia (ci siamo andati comunque vicini, nonostante il reato non esista nei
nostri codici). E invece, da domani, sarà gara anche a sinistra per pubblicare
le nuove frecciate del primo numero di Charlie Hebdo post attentato. Perché
Charlie domani potrà dire sull'islam ciò che pensa e noi dovremmo invece
allinearci al politicamente corretto? Non condivido molte cose che sostengono la
Le Pen e Salvini, ma se uno «è Charlie» deve essere anche Le Pen e Salvini. Cioè
deve essere uomo libero e garantire la libertà di chiunque. Cara sinistra, è
facile sostenere i diritti dei morti. Anche perché, se fossero vivi, quelli di
Charlie vi farebbero un mazzo tanto, quantomeno una pernacchia lunga da Parigi a
Roma.
Se la sinistra odia il popolo,
scrive Alessandro Catto su “Il Giornale”. La marcia di Parigi, come da
programma, ha scatenato apprezzamento e condanna, sentimenti di simpatia e
lontananza. Un’ondata di contraddizioni provenente in primis da quelli che, da
questa marcia, avrebbero dovuto sentirsi rappresentati, ovvero i cittadini
europei. Un evento che più che storico per meriti fisiologici, si è voluto
rendere storico nella sua formulazione, nella sua presentazione ai media, nel
dipingerlo come unica risposta possibile ad un attacco verso l’Occidente e i
suoi valori. Premetto che per me non è stata una marcia trionfale, tantomeno un
successo, soprattutto per quanto riguarda la testa di quel corteo. Coi suoi
leaders in giacca e cravatta, i capi di stato, sembrava una pratica di
circostanza tremendamente ipocrita e fasulla, qualcosa di fatto perché così c’è
scritto che bisogna fare. Un qualcosa incapace di rappresentarmi e di
rappresentare moltissime persone come me che dovrebbero, in teoria, essere e
sentirsi cittadini europei. Alla testa di quel corteo è andata in scena
l’ipocrisia di numerosissimi politici europei che hanno grosse responsabilità
riguardo la situazione mediterranea e mediorientale. Vi erano personaggi che
fino a ieri ci mostravano i benefici della primavera araba di turno, il suo
carattere evangelico ed evangelizzante. Vi erano gli alfieri della democrazia
per esportazione, gli alfieri di una Europa che non unisce. C’era un trionfo di
bandiere in Piazza della Repubblica, ma bandiere europee ce n’erano pochissime.
Quella manifestazione ha avuto più il carattere di un secondo funerale ai morti
di Charlie Hebdo che non quello di una rivendicazione di orgoglio, di identità e
di appartenenza. Ce l’ha avuto a partire dalla sua formulazione, dall’aver fatto
fin dal principio figli e figliastri. Quella manifestazione stessa è figlia pure
di una porzione politica che, fin da quando il terribile agguato alla sede
parigina di Charlie è avvenuto, si è preoccupata più di fare tribuna politica
contro il Salvini o la Le Pen di turno che di offrire tutto il proprio supporto
alle vittime. Pare esserci stata più veemenza nell’attaccare i capipartito di
destra che sensibilità nel puntare il dito contro i responsabili del fatto di
sangue. Ieri non è andata in scena la marcia di una Europa unita ma semmai
quella di molte nazioni divise, divise pure al loro interno. Nel sud della
Francia, mentre le anime belle europee marciavano a colpi di foto e riprese, è
andata in scena la marcia sponsorizzata da Marine Le Pen e dal Front National.
La marcia dei dannati, degli ultimi, degli esclusi da tutto. Di quelli che non
vanno di moda, che fa sempre prurito ospitare in qualche salotto, di quelli che
non parlano di Europa, di Diritti e Democrazia, di concetti maiuscolati. Un
partito ed una leader scomodi, che è meglio cancellare ed evitare se si vuole
andare in piazza imbellettati e col sorriso. Strano però, perché a suon di
parlare di democrazia ci siamo forse dimenticati di farla a casa nostra, e ci
siamo dimenticati che quel partito così odiato, temuto, becero per bocca dei
professori dei nostri tempi, è il primo partito di Francia per consenso
elettorale. Marciamo per la libertà dei popoli dimenticandoci di cos’è il
popolo, del suo diritto ad essere rappresentato. Si è preferito usare un fatto
tragico per trasformare il tutto nella solita, trita e oramai inascoltabile
retorica sul rifiuto dei fascismi, dei razzismi, sull’accoglienza, sulla
condanna di una ipotetica strumentalizzazione. Qui l’unica strumentalizzazione
che ho visto, personalmente, è stata quella di chi, a cadaveri ancora caldi, ha
subito messo in piedi un gioco orribile per colpire l’avversario politico, di
chi ha approfittato dell’occasione per provare, tristemente, a ritornare
rappresentante del popolo dopo l’usurpazione. La sinistra non dimentica, è
vendicativa, non tollera usurpazioni. E quella del Front in Francia e pure della
Lega in Italia è una usurpazione in piena regola. In termini elettorali,
politici e in termini di consenso. La rabbia monta in partiti di sinistra che
non riescono più a farsi intercettori delle istanze popolari più umili, che non
sanno dar loro rappresentazione, che si ritrovano smarriti. In questi casi
allora si tenta sempre di barrare la strada a chi può divenire l’intercettore
della protesta al proprio posto. Può esservi la risposta più scaltra, quella di
un centrosinistra in salsa renziana che tenta di attirare gli apparati più
moderati della nazione. Ma c’è anche la risposta più rabbiosa, più puerile, e
sta alla sua sinistra: quella di chi ha perso tutto, ha perso la propria
dimensione elettorale, ha perso il passo nei confronti delle istanze del popolo,
di chi come unica arma conserva una sola cosa: l’assalto indiscriminato
all’avversario e al suo successo, con tutti i mezzi possibili. La sinistra di
oggi pare odiare ferocemente il popolo perché l’ha smarrito, perché sa benissimo
che moltissimi operai, cassaintegrati, esodati, sia in Francia che in Italia non
vogliono salotti, sofismi, filosofie, teosofie, psicodrammi e buonismi. Vogliono
soluzioni immediate, presenze tangibili, capacità di dialogo e rappresentazione,
vogliono poter confessare le proprie paure e le proprie necessità, anche quelle
politicamente scorrette. E questo ormai, in Europa, non lo si fa nella piazza di
Parigi, lo si fa nella piazza di Beaucaire con la Le Pen, lo si fa a Musile di
Piave con Salvini. Il popolo è lì, consegnato in toto al nemico a son di
cianciare di populismo e demagogia. Parlando proprio di rapporto tra Islam e
Occidente sentivo ieri, in una nota trasmissione serale di La7, un giovane dire
che “non si può far parlare chi non arriva agli ottocento euro al mese”. Un
giovane in giacca, occhiali da hipster, erre arrotata, espressione massima del
ben pensare de sinistra in salsa europea. Non me la sento di attaccarlo perché
esprime chiaramente quello che è la sinistra oggi. Rifiuto del più povero e del
più debole, al quale si può pure tappare la bocca. Negazione del disagio, elogio
del buonismo. Rifiuto per le classi più povere e disprezzo delle stesse. Non c’è
cosa più trendy, al giorno d’oggi, di usare il termine populismo come offesa. E’
un qualcosa che potrebbe tranquillamente essere adottato come criterio di
iniziazione per un percorso che parte dalle giovanili del PD, dalle università,
dagli apericena meticci, dai lupanari dell’accoglienza. La sinistra oggi è
questa, e sfila in giacca e cravatta dopo aver tentato di esportare la sua
democrazia in giro per il mondo. Permetteteci di dissentire, e di preferire la
piazza di Beaucaire. Che forse ha ancora il diritto di venir chiamata piazza, e
non palcoscenico.
Alessandro Catto, laureato in
Storia, collabora anche con l’Intellettuale Dissidente. Si occupa di politica e
società. Nemico del pensiero unico, tradizionalista per reazione, popolare per
collocazione, identitario per protesta, controcorrente per natura, nemico
dichiarato della dittatura culturale da sinistra salottiera. Nato a
Camposampiero (Padova) il 22/11/1991.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO.
E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
Le vera mafia è lo Stato che
ci vessa. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di avere il
coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato, scrive Magdi Cristiano
Allam su “Il Giornale”. Per la prima volta un Papa ha scomunicato la mafia.
Benissimo! È arrivato il momento di far luce su chi sia la mafia. Chi potrebbe
non essere d'accordo con la condanna assoluta di chi usa la violenza nelle sue
varie forme, psicologica, economica e fisica, per sottomettere le persone al
proprio arbitrio, al punto da violare i diritti inalienabili alla vita, alla
dignità e alla libertà? Ma chi è veramente il Male che sta devastando la nostra
esistenza? È la criminalità organizzata che impone il pizzo ai commercianti e fa
affari con il traffico di droga e dei clandestini? È la massoneria che gestisce
in modo più o meno occulto il potere ovunque nel mondo? È il Gruppo Bilderberg
che associa chi più conta nella finanza e nell'economia sulla Terra? Certamente
queste realtà interferiscono con la nostra vita con conseguenze tutt'altro che
trascurabili. Ma si tratta di realtà che o non riguardano tutti noi o non ne
conosciamo bene i contenuti e i risvolti. Viceversa siamo tutti, ma proprio
tutti, più che consapevoli delle vessazioni che tutti i giorni lo Stato ci
impone attraverso leggi inique e pratiche del tutto arbitrarie. Chi è che ci ha
imposto una nuova schiavitù sotto forma del più alto livello di tassazione al
mondo, fino all'80% di tasse dirette e indirette? Chi è talmente spregiudicato
da speculare sulla nostra pelle legittimando e tassando il gioco d'azzardo, gli
alcolici e le sigarette? Chi è a tal punto disumano da tassare la casa, il bene
rifugio dell'80% delle famiglie italiane? Chi è che condanna a morte le imprese
applicando un centinaio di tasse e balzelli in aggiunta a un centinaio di
controlli amministrativi? Chi è che sta accrescendo la disoccupazione e la
precarietà in tutte le fasce d'età e lavorative? Chi ha permesso che 4 milioni e
100mila italiani non abbiano i soldi per comperare il pane? Chi protegge le
grandi banche e le grandi imprese che continuano a privatizzare gli utili e a
socializzare le perdite? Chi ha finora istigato al suicidio circa 4.500 italiani
attraverso le cartelle esattoriali di Equitalia o coprendo le vessazioni delle
banche quando non erogano credito o ingiungono di rientrare negli affidamenti
entro 24 ore? Chi ha svenduto la nostra sovranità monetaria, legislativa e
giudiziaria all'Europa dei banchieri e dei burocrati? Chi è responsabile della
crescita inarrestabile del debito pubblico e privato dal momento che siamo
costretti a indebitarci per ripianare il debito acquistando con gli interessi
una moneta straniera? Chi sta devastando le famiglie obbligando entrambi i
genitori a lavorare sodo per riuscire a sopravvivere? Chi ci ha portato
all'ultimo posto di natalità in Europa e ci sta condannando al suicidio
demografico? Chi sta incentivando l'emigrazione dei nostri giovani più
qualificati perché in Italia non hanno prospettive? Chi sta danneggiando gli
italiani promuovendo l'invasione di clandestini e umiliando i più poveri tra noi
favorendo gli immigrati nell'assegnazione di case popolari, posti all'asilo nido
e assegni sociali? Chi sta consentendo l'islamizzazione del nostro Paese
riconoscendo il diritto a moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e
finanziari islamici a prescindere dal fatto che confliggono con i valori
fondanti della nostra civiltà, indifferenti al fatto che sull'altra sponda del
Mediterraneo i terroristi islamici stanno massacrando i cristiani e riesumando
dei califfati in cui il diritto alla vita è garantito solo a chi si sottomette
ad Allah e a Maometto? Ebbene è questo Stato che si è reso responsabile
dell'insieme di questi comportamenti che ci stanno impoverendo e snaturando,
trasformandoci da persone con un'anima in semplici strumenti di produzione e di
consumo della materialità, assoggettati al dio euro e alla dittatura del
relativismo. Ecco perché è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e
di avere il coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato. Di ciò sono
certi tutti gli italiani perché è una realtà che pagano sulla loro pelle giorno
dopo giorno. Quindi caro Papa Francesco lei ha scomunicato le alte personalità
che ha ricevuto in Vaticano, a cui ha stretto la mano e ha augurato successo.
Per noi sono loro i veri mafiosi che stanno negando agli italiani il diritto a
vivere con dignità e libertà.
Magdi come la Fallaci
processati per le loro idee. La scrittrice finì alla sbarra in Italia, Francia e
Svizzera per i suoi scritti sul pericolo islamico E anche lei diceva: «Non mi
faccio intimidire», scrive “Il Giornale”. Li chiamava «i miei trofei». E di
«trofei», alias processi per reato d'opinione a causa delle idee sull'islam
espresse in libri e articoli, Oriana Fallaci ne ha subiti diversi nel corso
della sua vita, in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera. E naturalmente
pure in Italia, anche se l'ultimo, a Bergamo, è cominciato a giugno del 2006,
due mesi prima che lei morisse, il 15 settembre. Oriana Fallaci come Magdi
Cristiano Allam, anzi molto di più. A parte «l'amicizia complessa», così la
definì Allam quando lei morì, che li legava sul fronte comune della denuncia dei
pericoli del fondamentalismo islamico e del suo radicamento in Europa, c'è anche
la persecuzione per via giudiziaria delle opinioni che li accomuna. Per Allam,
oggi, si tratta di un procedimento avviato dal Consiglio di disciplina nazionale
dell'Ordine dei giornalisti che lo accusa di «islamofobia». Per la Fallaci,
all'epoca, erano invece veri e propri processi penali, per vilipendio all'islam,
razzismo, xenofobia. La sostanza, però, non cambia: vietato essere critici nei
confronti dei musulmani, pena la gogna, anche giudiziaria. Si arrabbiava, la
Fallaci, per quei quattro processi: due in Francia, a partire dal 2002 (quello
per «razzismo», nel 2003, si chiuse con la sua assoluzione) e uno in Svizzera,
tutti legati a La rabbia e l'orgoglio ; e un altro in Italia, nel 2006, finito
con la sua morte. Li chiamava sì trofei ma li riteneva profondamente ingiusti.
Ecco come lei stessa li raccontava a novembre del 2005 nel discorso di
ringraziamento per il conferimento dell' Annie Taylor Award , il cui testo è
stato pubblicato qualche giorno fa da Libero : «I trofei che chiamo processi. Si
svolgono in ogni Paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano
voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei
processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle , la Patrie
du Laïcisme , la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité , dove per vilipendio
all'islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di
quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste , dove
tre anni fa gli ebrei francesi della Licra (associazione ebrea di Sinistra che
ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica in fronte) si
unì ai musulmani francesi del Mrap (associazione islamica di Sinistra che ama
manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove
insieme chiesero al Codice penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et
l'Orgueil (La rabbia e l'orgoglio, ma la richiesta fu respinta, ndr ) o venderla
con il seguente ammonimento sulla copertina: “Attenzione! Questo libro può
costituire un pericolo per la vostra salute mentale”. Oppure a Berna, in
Svizzera. Die wunderschöne Schweits , la meravigliosa Svizzera di Guglielmo
Tell, dove il ministro della Giustizia osò chiedere al mio ministro della
Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo
processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di
condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell'islam
viene impartita nel mio paese». Era furibonda, la Fallaci, per il processo di
Bergamo, legato ad alcune affermazioni contenute in La forza della ragione . Un
processo travagliato, partito dalla denuncia, nel 2004, di Adel Smith, il
presidente all'epoca del'Unione dei Musulmani d'Italia che aveva definito il
crocifisso un «cadaverino nudo inventato per spaventare i bambini musulmani». Il
pm aveva chiesto l'archiviazione per la Fallaci, ma il gip l'aveva rigettata,
imponendo l'imputazione coatta. Ecco cosa scriveva la stessa Fallaci a luglio
del 2005, sul Corriere della Sera, nel celebre articolo dopo gli attentati di
Londra «Il nemico che trattiamo da amico» : «Mi ascolti bene, signor giudice di
Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'islam ma che non ha mai
incriminato il mio persecutore per vilipendio al cristianesimo. Nonché per
istigazione all'omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga
pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono
nemmeno ai terroristi islamici beccati con l'esplosivo in cantina. Il suo
processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto
nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi
faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle
denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal
proteggermi, anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio
intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere
la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere.
Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato italiano mi ha
cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo Van
Gogh? Glielo chiedo perché il ministro dell'Interno dice che nelle nostre
carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che
di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia». Al processo,
iniziato il 9 giugno del 2006, la Fallaci non si presentò per scelta. Per quel
processo ricevette attestati di solidarietà da mezzo mondo, pure dall'ex
presidente polacco Lech Walesa. E quel processo finì nel nulla. Alla fine lo
beffò la morte della giornalista e scrittrice, il 15 settembre del 2006.
L’ordine dei giornalisti
contro Allam così si calpesta la libertà di opinione, scrive Pierluigi Battista
su “Il Corriere della Sera”. Trasformare in un crimine un’opinione, per quanto
criticabile, non dovrebbe rientrare nei compiti di uno Stato che voglia
conservare la sua anima liberale, figurarsi di un Ordine professionale come
quello dei giornalisti. E invece mettere sotto accusa le opinioni di un
commentatore come Magdi Cristiano Allam è diventato l’occupazione estiva
dell’Ordine dei giornalisti. Una parodia dell’Inquisizione che fa di
un’associazione di categoria, nata durante il fascismo e senza eguali in
nessun’altra democrazia liberale con l’eccezione del post-salazariano
Portogallo, un tribunale abusivo che si permette di interpretare a suo modo i
princìpi della libertà di espressione e che si permette di emettere verdetti
sulle opinioni espresse da un proprio associato. Già l’Italia è caricata da una
pletora di reati d’opinione mai smaltiti in tutti gli anni della Repubblica
post-fascista. Non c’è bisogno di processi aggiuntivi istruiti da chi si arroga
il diritto di giudicare le opinioni altrui solo perché munito del tesserino di
un Ordine professionale. Se un giornalista commette un reato, dovrà essere
giudicato come tutti gli altri cittadini da un Tribunale della Repubblica.
Piccoli tribunali del popolo che si impancano a misuratori dell’eventuale
«islamofobia» di Allam sono invece pallide imitazioni di epoche autoritarie che
non distinguevano tra reato e opinione. Mentre la libertà d’opinione, dovremmo
averlo imparato, è indivisibile e non dovrebbe essere manipolata a seconda delle
predilezioni ideologiche. Si vuole criticare Allam? In Italia c’è il pluralismo
della critica e dell’informazione e il conflitto delle idee è il sale di una
democrazia liberale. La giustizia fai da te, i tribunali delle corporazioni che
si permettono di intromettersi non su un comportamento, o su una grave
negligenza professionale, bensì sul contenuto di un articolo, sono invece il
residuo di un’intolleranza antica, e che non sopporta la diversità delle
opinioni, anche delle più estreme. Per cui i censori dell’Ordine potrebbero
rimettere nel cassetto i loro processi, togliersi la toga dell’inquisitore e
ammettere di aver commesso un errore. Non è mai troppo tardi per la scoperta
della libertà.
Caso Allam, una decisione
sconcertante. Su "Il Giornale", il presidente dell'Odg: "Magdi potrà
difendersi". Ma la vicenda resta sconcertante risponde Alessandro Sallusti.
Caro direttore, leggo i
servizi dedicati all'Odg in relazione a una vicenda che riguarda Magdi Cristiano
Allam. Debbo dirti che alcuni toni e non poche espressioni mi sconcertano.
L'idea che ci siano degli intoccabili non appartiene alla mia cultura né, a
leggere il Giornale, alla tua. Potrei tacere, perché solo un ignorante (nel
senso che non conosce le cose) può non sapere che il Consiglio nazionale di
disciplina è organismo autonomo, voluto come tale da una legge dello Stato. Ma,
come ben sai personalmente, non amo le fughe, tanto da essere stato -
doverosamente, a mio avviso, ma ugualmente andando contro «corrente» - accanto a
te quando a Milano eri sotto processo. Se non si trattasse di Allam mi verrebbe
il sospetto che questa vicenda vien cavalcata per riaccendere l'attenzione su un
impegno personale e politico. Ma le cose non stanno esattamente come si afferma,
pur citando correttamente i passaggi di un capo di incolpazione. Non so, essendo
estraneo all'organismo, come finirà. Ma so che ad Allam sono state accordate,
doverosamente, tutte le opportunità di acquisire i documenti, contenuti nel
fascicolo, che riterrà utili. Di più: ha eccepito che i termini di 30 giorni non
gli erano sufficienti e gli uffici, mi assicurano, gli hanno formalizzato un
prolungamento che, mi riferiscono, è stato di sua soddisfazione. Ma si tende a
trasmettere una informazione distorta. Allam non è stato processato. Ci si è
limitati a ritenere «non manifestamente infondato» un esposto presentato da una
associazione (sconosciuta, perchè sul web non c'è traccia), «Media e diritto»,
che si duole per alcune affermazioni contenute suoi articoli. Personalmente non
mi sarei sentito oltraggiato (ma non mi sento «intoccabile», come scritto in
premessa), ma, anzi, avrei colto la notizia non tanto (né solo) come
l'opportunità di rivendicare la possibilità di dire quel che penso, ma anche per
argomentarne più approfonditamente le ragioni. Ancor di più, non mi sarei
scandalizzato perché questa procedura conferma che non ci sono «intoccabili» e
che le ragioni di tutti vengono valutate con attenzione. Una differenza non
marginale, ad esempio e senza generalizzazioni, con chi vive di una giustizia,
sommaria e tutta sua, sgozzando davanti alla telecamera un giornalista. Enzo
Iacopino, Presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti.
Caro presidente, in effetti ho
provato sulla mia pelle la tua solidarietà e te ne sono riconoscente e grato. Il
che non ha impedito che nostri solerti colleghi mi ri-processassero, nonostante
la «grazia» che mi ha concesso il presidente Napolitano, e condannassero a due
mesi di sospensione (l'appello, come saprai è a giorni). Ma questa è un'altra
storia. È vero, come dici, che non ci devono essere intoccabili, ma chissà
perché chi la pensa in un certo modo è più toccato di altri. E quando ad
allungare le mani sono colleghi od organi che sia pure autonomi riconducibili
all'Ordine dei giornalisti, allora mi preoccupo. Mi piacerebbe che l'Ordine, e
tutto ciò che ruota attorno ad esso, si battesse sempre e comunque per la
libertà di pensiero ed espressione, di chiunque. Perché è questo, per stare in
tema, che distingue la nostra società da quella islamica, il più delle volte
fondata sulla sharia. A quei signori che hanno fatto l'esposto bastava spiegare
questa semplice verità non trattabile: ci spiace, ma da noi si è liberi di
pensare, dire e scrivere, ciò che si crede, per eventuali reati rivolgersi alla
magistratura ordinaria. Alessandro Sallusti.
Vogliono toglierci la libertà
di critica. Il cardine della democrazia è mettere in discussione (anche) le
religioni, scrive Ida Magli su "Il Giornale". Islamofobia: strano concetto da
usare in un procedimento disciplinare. «Fobia» è, infatti, termine medico che
definisce un particolare disturbo psichico, presente in genere nelle
nevrastenie, e che si presenta come paura, ripulsione non infrenabile nei
confronti di un qualsiasi fenomeno della realtà. Freud ha aggiunto poi, con le
teorie psicoanalitiche sull'inconscio, una spiegazione ulteriore del
comportamento fobico affermando che il paziente è indotto a razionalizzare la
propria fobia attribuendola agli aspetti negativi degli oggetti o delle persone
di cui teme. Siamo sempre nel campo della psichiatria. Da qualche anno tuttavia,
in Europa, e in Italia in particolar modo, le accuse di «fobia» si sprecano. Non
si può aprire bocca su un qualsiasi argomento senza incorrere in questo rischio.
Sarebbe bene, invece, cominciare a ricordarsi quanto cammino abbiamo fatto,
quante lotte intellettuali e fisiche abbiamo dovuto sostenere, soprattutto noi,
gli italiani, per giungere alla civiltà cui oggi apparteniamo. Abbiamo sofferto
e pagato con il carcere e con il sangue non tanto la libertà concreta, quanto la
certezza della ricerca scientifica e delle sue conoscenze, disgiunta dal
pensiero filosofico, da quello politico e da qualsiasi fede religiosa.
Finalmente siamo giunti anche noi, italiani, a poter godere di una democrazia
totalmente laica in cui il rispetto per le convinzioni dei singoli cittadini non
comporta l'impossibilità di discuterle. Questo è il punto fondamentale di una
democrazia sicura di se stessa e della forza della propria libertà: ogni
cittadino può e deve poter parlare con tutti gli altri di qualsiasi argomento
perché vive in un gruppo ed è la vita di gruppo che forma una società e un
popolo. È secondo questi principi di convivenza nella democrazia che si ha il
diritto, ma soprattutto il dovere, di discutere delle religioni. Oggi nessuno
ritiene, in nessuna parte del mondo, che le religioni non facciano parte
integrante delle culture e delle società. E ogni religione, proprio perché
religione (religio è legame fra più individui) non è un fatto privato, né può
essere trattato da nessuno, né singoli né governi né istituzioni, come un fatto
privato. In Italia, poi, per la sua particolare storia, le discussioni e le
critiche, anche fortissime, ad associazioni cattoliche, a vescovi, a parroci, a
Papi, non sono mai mancate. Sarebbe sufficiente ricordarsi i dibattiti
appassionati per la legislazione sul divorzio e sull'aborto. I cattolici hanno
fatto allora tutto il possibile per sostenere le loro tesi che erano appunto
fondate su norme dettate da un testo sacro, il Vangelo; altrettanto hanno fatto
i partiti laici, e alla fine si sono svolti con assoluta libertà i relativi
referendum. Cosa sarebbe stato dell'Italia, della democrazia in Italia, se
qualcuno avesse pensato che i giornalisti non potevano discutere delle norme di
un testo sacro, che bisognava porre loro il bavaglio, o intimorirli con
provvedimenti disciplinari? Ho citato esplicitamente il Vangelo perché gli
italiani possono supporre che il Corano, scritto diversi secoli dopo la venuta
di Gesù, debba in qualche modo somigliargli, riprendere qualcuna delle sue tesi
fondamentali. Siccome è vero il contrario perché il Corano è fondato sull'Antico
Testamento, sulla legge del taglione, sulla vendetta contro i nemici,
sull'obbligo di convertire gli infedeli, sui tabù dell'impurità, è quindi agli
antipodi del Vangelo e agli antipodi della civiltà in cui viviamo. Visto che i
musulmani sono già numerosissimi sul suolo italiano e aumentano ogni giorno, è
dovere e diritto degli italiani sapere quali siano le norme di comportamento
imposte da Maometto ai suoi fedeli, i quali, appunto in quanto fedeli,
dovrebbero ritenerle giuste e averle fatte proprie. Ma chi dovrebbe informarli
se non i giornalisti? L'ipocrisia non è nell'interesse di nessuno oggi in
Italia. Intervengano i musulmani o i loro giornalisti (non gli imam) insieme a
noi sui giornali e ci assicurino che, pur essendo fedeli a Maometto, ritengono
sbagliate la giustizia del taglione, le norme sull'inferiorità e l'impurità
delle donne, sulla fustigazione degli omosessuali, sulla lapidazione delle
adultere, sull'uccisione degli infedeli... Noi gli crederemo.
Haisam Sakhanh, il jihadista
che andava in tv all'Infedele di Gad Lerner, scrive “Libero Quotidiano”.
L'orrore dei tagliagole, giorno dopo giorno, ora dopo ora,
sconvolge l'Occidente. Solo poche ore fa, il video delle quattro sospette spie
decapitate dai fanatici dell'Islam. Immagini strazianti, terrificanti, e che
fanno ancor più paura perché è sempre più chiaro che i seguaci della jihad ce li
abbiamo in casa. Sono molti, alcuni noti, altri no. C'è un Imam che giura: "Ci
prenderemo il Vaticano". E c'è anche chi invece, in passato, andò in
televisione. Due anni fa, per la precisione. Stiamo parlando di Haisam Sakhanh,
nome di battaglia Abu Omar, che un tempo viveva nel milanese e che, una volta,
si fece vedere negli studi de L'Infedele, la trasmissione di Gad Lerner su La7.
Da mercoledì la procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui:
la sua foto, ora, appare su tutti i giornali. Eppure era chiaro da tempo chi
fosse, questo Abu Omar. Come ricorda Il Giornale, già nell'aprile del 2013 fu
girato un video in cui il siriano-milanese si rese protagonista dell'orrore:
assieme ad altri militanti prese parte all'esecuzione di 7 soldati
filo-governativi, un colpo e testa e via, gli uomini in ginocchio vengono
ammazzati. Nel 2012, inoltre, le autorità italiane non ritennero necessario
svolgere qualche approfondimento su mister Haisam, ex elettricista a Cologno
Monzese, e la sua rete: fu arrestato al termine di un assalto all'ambasciata di
Roma. Haisam e i suoi vengono interrogati, indagati per danneggiamento,
violazione di domicilio e violenza privata aggravata e rinviati a giudizio per
direttissima. Ma non accadde nulla: tornò libero e riprese a fare proselitismi,
nel nostro Paese, a Milano e hinterland. La replica di Lerner, via blog, arriva
nel pomeriggio ed è velenosa. "Fra gli altri siriani che parteciparono alla
trasmissione come pubblico, senza intervenire, scopriamo ora da una fotografia
pubblicata su Facebook che si infiltrò un elettricista di Cologno Monzese, tale
Haisam Sakhanh, che nel frattempo è entrato nella milizia Isis col nome di
battaglia Abu Omar". "Naturalmente - spiega Lerner - io non ho invitato proprio
nessun jihadista in trasmissione, né tre anni fa né mai. Tanto meno costui ha
mai preso la parola all'Infedele. Ma per certe testate ogni occasione è buona
per insultare".
Noi censurati, il jihadista
invitato in tv da Lerner. L'elettricista di Cologno andato a combattere per
l'Isis in Siria è indagato per terrorismo, ma due anni fa in Italia veniva
trattato da eroe della rivolta, scrive Gian Micalessin su "Il Giornale. I
tagliagole amici e complici dell'Isis li avevamo in casa. Vivevano e
manifestavano a Milano, mentre a Roma godevano delle migliori coperture. E così
quando polizia della Capitale li arrestava mentre assaltavano e devastavano le
sedi diplomatiche, i magistrati li rimettevano in libertà. Del resto i ministri
del governo Monti, gli stessi che rispedivano i nostri marò nella trappola
indiana, ricevevano i loro capi politici alla Farnesina trattandoli alla stregua
di eroi. Gad Lerner, nel frattempo, li invitava nel suo salotto televisivo. E
Pier Luigi Bersani, allora segretario del Pd, non si faceva problemi ad
appoggiarli concionando da un palco adornato con la bandiera dei ribelli. La
stessa bandiera in cui s'avvolgevano le sprovvedute attiviste Vanessa Marzullo e
Greta Ramelli inghiottite qualche settimana fa dall'inferno siriano. Ma siamo
nel Belpaese. Un paese dove l'Ordine dei Giornalisti indaga chi critica l'Islam,
ma si guarda bene dall'obbiettare se qualcuno da voce ad un terrorista. E dunque
non succedeva nulla. E così anche quando Il Giornale , si permetteva di mostrare
i volti e documentare le atrocità di questi signori tutti facevano vinta di non
vedere, di non sapere, di non capire. Guardate questo signore. Il suo vero nome
è Haisam Sakhanh, il suo nome di battaglia è Abu Omar. Da mercoledì, da quando
l'assai sollecita procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui,
tutti fanno a gara a parlarne. La sua foto campeggia dal Corriere della Sera a
Repubblica e i telegiornali fanno a gara nel descriverlo come il reclutatore dei
jihadisti di Milano e dintorni. Bella scoperta. Sul Giornale la sua foto era già
comparsa l'11 gennaio accanto a un titolo che recitava «Cercate killer islamici?
Eccone uno». Come lo sapevamo? Semplice. A differenza degli «ignari» magistrati,
politici, diplomatici e di tanti colleghi, sempre pronti a chiuder gli occhi
quando le notizie non sono politicamente corrette, non c'eravamo fatto scrupoli
a identificare i protagonisti dell' agghiacciante video girato nell'aprile 2013
nella provincia siriana di Idlib e pubblicato lo scorso settembre sul sito web
del New York Times . In quel video il siriano-milanese Sakhanh-Abu Omar è
protagonista, assieme ad altri militanti guidati dal comandante Abdul Samad
Hissa, della spietata esecuzione di 7 soldati governativi appena catturati. Nel
filmato indossa un giubbotto marroncino, impugna il kalashnikov e ascolta il
comandante che spiega a lui e altri nove militanti perché sia giusto e doveroso
ammazzare i prigionieri. Subito dopo preme il grilletto e infila un proiettile
nella nuca di un soldato denudato e fatto inginocchiare ai suoi piedi. A gennaio
dopo la nostra denuncia nessuno muove un dito. Ma questa non è una novità. Ben
più grave è che nessuno si curi di accertare i contatti e i collegamenti di
Haisam alias Abu Omar nel febbraio 2012 quando il militante viene arrestato al
termine di un vero e proprio assalto all'ambasciata siriana di Roma. Un assalto
durante il quale guida alcuni complici all'interno degli uffici della sede
diplomatica devastandoli e malmenando alcuni impiegati. Interrogati dal giudice
Marina Finiti e indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza
privata aggravata Haisam e i suoi vengono rinviati a giudizio per direttissima.
Ma anche allora non succede nulla. Lui torna libero, continua a far proseliti e
a guidare il suo gruppetto basato a Milano e dintorni. Tra questi si distingue
l'amico Ammar Bacha che il 19 agosto 2012 non si fa problemi a pubblicare un
video in cui i decapitatori dell'Isis (Stato Islamico dell'Iraq e del levante)
illustrano la propria attività con il consueto corollario di atrocità e
violenze. Anche stavolta tutti fanno finta di non vedere. Del resto solo pochi
mesi prima, il 13 maggio 2012, il ministro Giulio Terzi ha incontrato alla
Farnesina il Presidente del Consiglio Nazionale Siriano (Cns), Bourhan Ghalioun,
capo politico di quei ribelli già allora finanziati dal Qatar e monopolizzati
dall'estremismo di Al Qaida e dell'Isis. E così qualche mese dopo pm e polizia
si guardano bene dal fermare il signor Sakhanh e il suo sodale. E loro fuggono
in Turchia e poi in Siria. Dove possono finalmente dedicarsi alla loro attività
più congeniale. Ovvero uccidere e massacrare.
Le decapitazioni di Isis e gli
allarmi della Fallaci. Il video dell'uccisione di James Foley riporta alla mente
le parole (inascoltate) della scrittrice, scrive Marco Ventura su Panorama. E
quindi non è "un conflitto di civiltà" quello che è sotto gli occhi di tutti in
Iraq, Siria, Africa? Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, sempre così
graziosamente politically correct, nega in Parlamento la matrice di "civiltà"
nei sanguinosi eventi di queste ore e nella risposta di Stati Uniti e Europa,
quasi dovessimo vergognarci di difendere i valori dell'Occidente contro una
versione esasperata e integralista dell'Islam globale. Ma è così? Arancione e
nero. Sapete a cosa penso guardando quell’immagine surreale, terribilmente
cinematografica, del giornalista americano James Foley in tuta arancione come i
prigionieri di Guantanamo inginocchiato davanti a un paesaggio desertico, il
busto eretto e il mento dritto, la postura fiera incongruente con le parole che
deve pronunciare, e poi guardando quella figura di morte nera accanto a lui, in
piedi, quel tagliagole mascherato dell’Is, coltello in mano, che si rivolge
direttamente in inglese a Barack Obama (“You, Obama”) prima di decapitare la sua
vittima? Penso, ecco, a Oriana Fallaci. Ai profeti inascoltati che l’Italia ha
avuto, e al fatto che per vedere meglio nel futuro si sono dovuti trasferire
all’estero, negli Stati Uniti, e da lì vaticinare, puntare l’indice, declamare
il j’accuse, le loro omelie laiche da italiani che amano l’Italia e disprezzano
però una certa Italia (e Europa). La Fallaci come Prezzolini, isolato nel suo
esilio americano (e svizzero). Penso a quanti hanno criticato la Fallaci degli
ultimi anni considerando i suoi scritti, le sue invettive finali (o definitive)
contro l’invasione islamica, il pericolo islamico, la brutalità islamica, una
sorta di metastasi del pensiero, quasi un cancro dello spirito parallelo al male
che le consumava il corpo. Ascoltate (sì, ascoltate) quello che Oriana scriveva
“Ai lettori” all’indomani dell’11/9, in apertura de “La rabbia e l’orgoglio”
(Rizzoli): “Dall’Afghanistan al Sudan, dall’Indonesia al Pakistan, dalla Malesia
all’Iran, dall’Egitto all’Iraq, dall’Algeria al Senegal, dalla Siria al Kenya,
dalla Libia al Ciad, dal Libano al Marocco, dalla Palestina allo Yemen,
dall’Arabia Saudita alla Somalia, l’odio per l’Occidente cresce. Si gonfia come
un fuoco alimentato dal vento, e i seguaci del fondamentalismo islamico si
moltiplicano come i protozoi d’una cellula che si scinde per diventare due
cellule poi quattro poi otto poi sedici poi trentadue. All’infinito”. Ognuno di
quei paesi evoca oggi qualcosa di terribile che è avvenuto (che avviene). I
talebani comandano ancora in Afghanistan (fino in Pakistan). In Egitto la
primavera araba è morta con l’avvento dei Fratelli musulmani, finalmente
stroncati dalla restaurazione del generale Al-Sisi. In Libia gli islamisti
proclamano il Califfato di Bengasi, guerreggiano e spargono odio e caos anche se
nelle elezioni hanno dimostrato di valere poco più del 10 per cento. Tra Somalia
e Kenya i guerriglieri islamisti di Al Shabaab fanno incursioni omicide lungo le
strade, stragi nei centri commerciali a Nairobi. In paesi come la Nigeria che la
Fallaci non citava (la sua lista oggi sarebbe più lunga) i massacri islamisti e
i rapimenti delle studentesse sono firmati dalle milizie di Boko Haram. Nello
Yemen dei sequestri operano cellule di Al-Qaeda. In Palestina, Hamas usa i
civili come scudi umani e lancia razzi su Israele con l’obiettivo di cancellare
lo Stato ebraico dalle mappe. Con l’Iran rimane il contenzioso nucleare. Di Iraq
e Siria sappiamo. In Libano spadroneggiano gli Hezbollah. L’Arabia Saudita e gli
altri paesi del Golfo non sono ancora usciti dall’ambiguità, chi più e chi meno,
di sostenere o chiudere un occhio sui finanziamenti alle formazioni
integraliste. E così via. Dal 2001 sono passati 13 anni e le parole de “La
rabbia e l’orgoglio” si avverano. “Non capite o non volete capire che se non ci
si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Jihad vincerà. E
distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a
migliorare, a rendere un po’ più intelligente cioè meno bigotto o addirittura
non bigotto. Distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza,
la nostra morale, i nostri valori, i nostri piaceri…”. Oriana tuonava contro “i
nuovi Mori”. Dietro le figure in nero, che c’erano anche allora, vedeva i
colletti bianchi, che ci sono ancora. Ascoltiamola. “I nuovi Mori con la
cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti. Per questo
diventano sempre di più, pretendono sempre di più. E se non stiamo attenti, se
restiamo inerti, troveranno sempre più complici. Diventeranno sempre di più,
otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più. Fino a soggiogarci
completamente. Fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è
impossibile. Ragionarci, impensabile. Cullarci nell’indulgenza o nella
tolleranza o nella speranza, un suicidio. E chi crede il contrario è un illuso”.
Chissà che non dovremo darle ragione, nonostante il nostro perbenismo
intellettuale, pure sui rischi dei flussi migratori. Proprio in conclusione del
suo pamphlet la Fallaci scrive infatti dell’Italia che “nonostante tutto esiste.
Zittita, ridicolizzata, sbeffeggiata, diffamata, insultata, ma esiste. Quindi
guai a chi me la tocca. Guai a chi me la invade, guai a chi me la ruba. Perché
(se non l’hai ancora capito te lo ripeto con maggiore chiarezza) che a invaderla
siano i francesi di Napoleone o i tedeschi di Hitler o i compari di Osama Bin
Laden, per me è lo stesso. Che per invaderla usino i cannoni o i gommoni, idem”.
E per finire: “Stop. Quello che avevo da dire l’ho detto… Ora basta. Punto e
basta”.
Oriana Fallaci, la sua lezione
su Libero Quotidiano: Maestra di libertà. la profezia sull'Islam fanatico, gli
insulti della sinistra, i processi. Il testo di cui oggi iniziamo la
pubblicazione - per gentile concessione di Edoardo Perazzi, nipote e erede della
Fallaci - è quello di un discorso pronunciato da Oriana Fallaci nel novembre del
2005. La grande toscana fu insignita del Annie Taylor Award, un premio conferito
dal Centro Studi di cultura popolare di New York. Il suo discorso, in versione
integrale inglese, fu pubblicato pochi giorni dopo da Il Foglio. Poi, il primo
dicembre del 2005, Libero ne pubblicò la versione italiana, col permesso della
stessa Fallaci, che volle rivederne personalmente la forma (modificandola
tramite memorabili telefonate con l'allora responsabile delle pagine culturali
Alessandro Gnocchi). Abbiamo deciso di ripubblicare questo testo perché pensiamo
che oggi, a quasi dieci anni di distanza, sia più attuale che mai. Bé: un premio
intitolato a una donna che saltò sopra le Cascate del Niagara, e sopravvisse, è
mille volte più prezioso e prestigioso ed etico di un Oscar o di un Nobel: fino
a ieri gloriose onorificenze rese a persone di valore ed oggi squallide parcelle
concesse a devoti antiamericani e antioccidentali quindi filoislamici. Insomma a
coloro che recitando la parte dei guru illuminati che definiscono Bush un
assassino, Sharon un criminale-di-guerra, Castro un filantropo, e gli Stati
Uniti «la-potenza-più-feroce, più-barbara,
più-spaventosa-che-il-mondo-abbia-mai-conosciuto». Infatti se mi assegnassero
simili parcelle (graziaddio un’eventualità più remota del più remoto Buco Nero
dell’Universo), querelerei subito le giurie per calunnia e diffamazione. Al
contrario, accetto questo «Annie Taylor» con gratitudine e orgoglio. E pazienza
se sopravvaluta troppo le mie virtù. Sì: specialmente come corrispondente di
guerra, di salti ne ho fatti parecchi. In Vietnam, ad esempio, sono saltata
spesso nelle trincee per evitare mitragliate e mortai. Altrettanto spesso sono
saltata dagli elicotteri americani per raggiungere le zone di combattimento. In
Bangladesh, anche da un elicottero russo per infilarmi dentro la battaglia di
Dacca. Durante le mie interviste coi mascalzoni della Terra (i Khomeini, gli
Arafat, i Gheddafi eccetera) non meno spesso sono saltata in donchisciotteschi
litigi rischiando seriamente la mia incolumità. E una volta, nell’America
Latina, mi sono buttata giù da una finestra per sfuggire agli sbirri che
volevano arrestarmi. Però mai, mai, sono saltata sopra le Cascate del Niagara.
Né mai lo farei. Troppo rischioso, troppo pericoloso. Ancor più rischioso che
palesare la propria indipendenza, essere un dissidente cioè un fuorilegge, in
una società che al nemico vende la Patria. Con la patria, la sua cultura e la
sua civiltà e la sua dignità. Quindi grazie David Horowitz, Daniel Pipes, Robert
Spencer. E credetemi quando dico che questo premio appartiene a voi quanto a me.
A tal punto che, quando ho letto che quest’anno avreste premiato la Fallaci, mi
sono chiesta: «Non dovrei esser io a premiare loro?». E per contraccambiare il
tributo volevo presentarmi con qualche medaglia o qualche trofeo da consegnarvi.
Mi presento a mani vuote perché non sapevo, non saprei, dove comprare certa
roba. Con le medaglie e i trofei ho un’esigua, davvero esigua, familiarità. E vi
dico perché. Anzitutto perché crediamo di vivere in vere democrazie, democrazie
sincere e vivaci nonché governate dalla libertà di pensiero e di opinione.
Invece viviamo in democrazie deboli e pigre, quindi dominate dal dispotismo e
dalla paura. Paura di pensare e, pensando, di raggiungere conclusioni che non
corrispondono a quelle dei lacchè del potere. Paura di parlare e, parlando, di
dare un giudizio diverso dal giudizio subdolamente imposto da loro. Paura di non
essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili, e venire scomunicati
attraverso l’esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il
cittadino. Paura di essere liberi, insomma. Di prendere rischi, di avere
coraggio. «Il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà è
il coraggio», diceva Pericle. Uno che di queste cose se ne intendeva. (Tolgo la
massima dal secondo libro della mia trilogia: La Forza della ragione. E da
questo prendo anche il chiarimento che oltre centocinquanta anni fa Alexis de
Tocqueville fornì nel suo intramontabile trattato sulla democrazia in America).
Nei regimi assolutisti o dittatoriali, scrive Tocqueville, il dispotismo
colpisce il corpo. Lo colpisce mettendolo in catene o torturandolo o
sopprimendolo in vari modi. Decapitazioni, impiccagioni, lapidazioni,
fucilazioni, Inquisizioni eccetera. E così facendo risparmia l’anima che intatta
si leva dalla carne straziata e trasforma la vittima in eroe. Nelle democrazie
inanimate, invece, nei regimi inertamente democratici, il dispotismo risparmia
il corpo e colpisce l’anima. Perché è l’anima che vuole mettere in catene.
Torturare, sopprimere. Così alle sue vittime non dice mai ciò che dice nei
regimi assolutisti o dittatoriali: «O la pensi come me o muori». Dice: «Scegli.
Sei libero di non pensare o di pensare come la penso io. Se non la pensi come la
penso io, non ti sopprimerò. Non toccherò il tuo corpo. Non confischerò le tue
proprietà. Non violenterò i tuoi diritti politici. Ti permetterò addirittura di
votare. Ma non sarai mai votato. Non sarai mai eletto. Non sarai mai seguito e
rispettato. Perché ricorrendo alle mie leggi sulla libertà di pensiero e di
opinione, io sosterrò che sei impuro. Che sei bugiardo, dissoluto, peccatore,
miserabile, malato di mente. E farò di te un fuorilegge, un criminale. Ti
condannerò alla Morte Civile, e la gente non ti ascolterà più. Peggio. Per non
essere a sua volta puniti, quelli che la pensano come te ti diserteranno».
Questo succede, spiega, in quanto nelle democrazie inanimate, nei regimi
inertamente democratici, tutto si può dire fuorché la Verità. Perché la Verità
ispira paura. Perché, a leggere o udire la verità, i più si arrendono alla
paura. E per paura delineano intorno ad essa un cerchio che è proibito
oltrepassare. Alzano intorno ad essa un’invisibile ma insormontabile barriera
dentro la quale si può soltanto tacere o unirsi al coro. Se il dissidente
oltrepassa quella linea, se salta sopra le Cascate del Niagara di quella
barriera, la punizione si abbatte su di lui o su di lei con la velocità della
luce. E a render possibile tale infamia sono proprio coloro che segretamente la
pensano come lui o come lei, ma che per convenienza o viltà o stupidità non
alzano la loro voce contro gli anatemi e le persecuzioni. Gli amici, spesso. O i
cosiddetti amici. I partner. O i cosiddetti partner. I colleghi. O i cosiddetti
colleghi. Per un poco, infatti, si nascondono dietro il cespuglio.
Temporeggiano, tengono il piede in due staffe. Ma poi diventano silenziosi e,
terrorizzati dai rischi che tale ambiguità comporta, se la svignano. Abbandonano
il fuorilegge, il criminale, al di lui o al di lei destino e con il loro
silenzio danno la loro approvazione alla Morte Civile. (Qualcosa che io ho
esperimentato tutta la vita e specialmente negli ultimi anni. «Non ti posso
difendere più» mi disse, due o tre Natali fa, un famoso giornalista italiano che
in mia difesa aveva scritto due o tre editoriali. «Perché?» gli chiesi tutta
mesta. «Perché la gente non mi parla più. Non mi invita più a cena»). L’altro
motivo per cui ho un’esigua familiarità con le medaglie e i trofei sta nel fatto
che soprattutto dopo l’11 Settembre l’Europa è diventata una Cascata del Niagara
di Maccartismo sostanzialmente identico a quello che afflisse gli Stati Uniti
mezzo secolo fa. Sola differenza, il suo colore politico. Mezzo secolo fa era
infatti la Sinistra ad essere vittimizzata dal Maccartismo. Oggi è la Sinistra
che vittimizza gli altri col suo Maccartismo. Non meno, e a parer mio molto di
più, che negli Stati Uniti. Cari miei, nell’Europa d’oggi v’è una nuova Caccia
alle Streghe. E sevizia chiunque vada contro corrente. V’è una nuova
Inquisizione. E gli eretici li brucia tappandogli o tentando di tappargli la
bocca. Eh, sì: anche noi abbiamo i nostri Torquemada. I nostri Ward Churchill, i
nostri Noam Chomsky, i nostri Louis Farrakhan, i nostri Michael Moore eccetera.
Anche noi siamo infettati dalla piaga contro la quale tutti gli antidoti
sembrano inefficaci. La piaga di un risorto nazi-fascismo. Il nazismo islamico e
il fascismo autoctono. Portatori di germi, gli educatori cioè i maestri e le
maestre che diffondono l’infezione fin dalle scuole elementari e dagli asili
dove esporre un Presepe o un Babbo Natale è considerato un «insulto ai bambini
Mussulmani». I professori (o le professoresse) che tale infezione la raddoppiano
nelle scuole medie e la esasperano nelle università. Attraverso
l’indottrinazione quotidiana, il quotidiano lavaggio del cervello, si sa. (La
storia delle Crociate, ad esempio, riscritta e falsificata come nel 1984 di
Orwell. L’ossequio verso il Corano visto come una religione di pace e
misericordia. La reverenza per l’Islam visto come un Faro di Luce paragonato al
quale la nostra civiltà è una favilla di sigaretta). E con l’indottrinazione, le
manifestazioni politiche. Ovvio. Le marce settarie, i comizi faziosi, gli
eccessi fascistoidi. Sapete che fecero, lo scorso ottobre, i giovinastri della
Sinistra radicale a Torino? Assaltarono la chiesa rinascimentale del Carmine e
ne insozzarono la facciata scrivendoci con lo spray l’insulto «Nazi-Ratzinger»
nonché l’avvertimento: «Con le budella dei preti impiccheremo Pisanu». Il nostro
Ministro degli Interni. Poi su quella facciata urinarono. (Amabilità che a
Firenze, la mia città, non pochi islamici amano esercitare sui sagrati delle
basiliche e sui vetusti marmi del Battistero). Infine irruppero dentro la chiesa
e, spaventando a morte le vecchine che recitavano il Vespro, fecero scoppiare un
petardo vicino all’altare. Tutto ciò alla presenza di poliziotti che non
potevano intervenire perché nella città Politically Correct tali imprese sono
considerate Libertà di espressione. (A meno che tale libertà non venga
esercitata contro le moschee: s’intende). E inutile aggiungere che gli adulti
non sono migliori di questi giovinastri. La scorsa settimana, a Marano, popolosa
cittadina collocata nella provincia di Napoli, il Sindaco (ex seminarista, ex
membro del Partito Comunista Italiano, poi del vivente Partito di Rifondazione
Comunista, ed ora membro del Partito dei Comunisti Italiani) annullò tout-court
l’ordinanza emessa dal commissario prefettizio per dedicare una strada ai
martiri di Nassiriya. Cioè ai diciannove militari italiani che due anni fa i
kamikaze uccisero in Iraq. Lo annullò affermando che i diciannove non erano
martiri bensì mercenari, e alla strada dette il nome di Arafat. «Via Arafat». Lo
fece piazzando una targa che disse: «Yasser Arafat, simbolo dell’Unità (sic) e
della Resistenza Palestinese». Poi l’interno del municipio lo tappezzò con
gigantesche foto del medesimo, e l’esterno con bandiere palestinesi. La piaga si
propaga anche attraverso i giornali, la Tv, la radio. Attraverso i media che per
convenienza o viltà o stupidità sono in gran maggioranza islamofili e
antioccidentali e antiamericani quanto i maestri, i professori, gli accademici.
Che senza alcun rischio di venir criticati o beffati passano sotto silenzio
episodi come quelli di Torino o Marano. E in compenso non dimenticano mai di
attaccare Israele, leccare i piedi all’Islam. Si propaga anche attraverso le
canzoni e le chitarre e i concerti rock e i film, quella piaga. Attraverso uno
show-business dove, come i vostri ottusi e presuntuosi e ultra-miliardari
giullari di Hollywood, i nostri giullari sostengono il ruolo di buonisti sempre
pronti a piangere per gli assassini. Mai per le loro vittime. Si propaga anche
attraverso un sistema giudiziario che ha perduto ogni senso della Giustizia,
ogni rispetto della giurisdizione. Voglio dire attraverso i tribunali dove, come
i vostri magistrati, i nostri magistrati assolvono i terroristi con la stessa
facilità con cui assolvono i pedofili. (O li condannano a pene irrisorie). E
finalmente si propaga attraverso l’intimidazione della buona gente in buona
fede. Voglio dire la gente che per ignoranza o paura subisce quel dispotismo e
non comprende che col suo silenzio o la sua sottomissione aiuta il risorto
nazi-fascismo a fiorire. Non a caso, quando denuncio queste cose, mi sento
davvero come una Cassandra che parla al vento. O come uno dei dimenticati
antifascisti che settanta e ottanta anni fa mettevano i ciechi e i sordi in
guardia contro una coppia chiamata Mussolini e Hitler. Ma i ciechi restavano
ciechi, i sordi restavano sordi, ed entrambi finirono col portar sulla fronte
ciò che ne L’Apocalisse chiamo il Marchio della Vergogna. Di conseguenza le mie
vere medaglie sono gli insulti, le denigrazioni, gli abusi che ricevo
dall’odierno Maccartismo. Dall’odierna Caccia alle Streghe, dall’odierna
Inquisizione. I miei trofei, i processi che in Europa subisco per reato di
opinione. Un reato ormai travestito coi termini «vilipendio dell’Islam, razzismo
o razzismo religioso, xenofobia, istigazione all’odio eccetera». Parentesi: può
un Codice Penale processarmi per odio? Può l’odio essere proibito per Legge?
L’odio è un sentimento. È una emozione, una reazione, uno stato d’animo. Non un
crimine giuridico. Come l’amore, l’odio appartiene alla natura umana. Anzi, alla
Vità. È l’opposto dell’amore e quindi, come l’amore, non può essere proibito da
un articolo del Codice Penale. Può essere giudicato, sì. Può essere contestato,
osteggiato, condannato, sì. Ma soltanto in senso morale. Ad esempio, nel
giudizio delle religioni che come la religione cristiana predicano l’amore. Non
nel giudizio d’un tribunale che mi garantisce il diritto di amare chi voglio.
Perché, se ho il diritto di amare chi voglio, ho anche e devo avere anche il
diritto di odiare chi voglio. Incominciando da coloro che odiano me. Sì, io odio
i Bin Laden. Odio gli Zarkawi. Odio i kamikaze e le bestie che ci tagliano la
testa e ci fanno saltare in aria e martirizzano le loro donne. Odio gli Ward
Churchill, i Noam Chomsky, i Louis Farrakhan, i Michael Moore, i complici, i
collaborazionisti, i traditori, che ci vendono al nemico. Li odio come odiavo
Mussolini e Hitler e Stalin and Company. Li odio come ho sempre odiato ogni
assalto alla Libertà, ogni martirio della Libertà. È un mio sacrosanto diritto.
E se sbaglio, ditemi perché coloro che odiano me più di quanto io odi loro non
sono processati col medesimo atto d’accusa. Voglio dire: ditemi perché questa
faccenda dell’Istigazione all’Odio non tocca mai i professionisti dell’odio, i
mussulmani che sul concetto dell’odio hanno costruito la loro ideologia. La loro
filosofia. La loro teologia. Ditemi perché questa faccenda non tocca mai i loro
complici occidentali. Parentesi chiusa, e torniamo ai trofei che chiamo
processi. Si svolgono in ogni paese nel quale un figlio di Allah o un traditore
nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei
processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle, la Patrie
du Laïcisme, la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité, dove per vilipendio
dell’Islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di
quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste, dove
tre anni fa gli ebrei francesi della LICRA (associazione ebrea di Sinistra che
ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica sulla fronte)
si unì ai mussulmani francesi del MRAP (associazione islamica di Sinistra che
ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove
insieme chiesero al Codice Penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et
l’Orgueil o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: «Attenzione!
Questo librò può costituire un pericolo per la vostra salute mentale». (Insieme
volevano anche intascare un grosso risarcimento danni, naturalmente). Oppure a
Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweitz, la meravigliosa Svizzera di
Guglielmo Tell, dove il Ministro della Giustizia osò chiedere al mio Ministro
della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il
prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra
ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio
dell’Islam viene impartita nel mio paese. (Un paese dove senza alcuna
conseguenza legale qualsiasi mussulmano può staccare il crocifisso dai muri di
un’aula scolastica o di un ospedale, gettarlo nella spazzatura, dire che il
crocifisso
«ritrae-un-cadaverino-nudo-inventato-per-spaventare-i-bambini-mussulmani». E
sapete chi ha promosso il processo di Bergamo? Uno dei mai processati quindi mai
condannati specialisti nel buttare via i crocifissi. L’autore di un sudicio
libretto che per molto tempo ha venduto nelle moschee, nei Centri Islamici,
nelle librerie sinistrorse d’Italia. Quanto alle minacce contro la mia vita cioè
all’irresistibile desiderio che i figli di Allah hanno di tagliarmi la gola o
farmi saltare in aria o almeno liquidarmi con un colpo di pistola nella nuca, mi
limiterò a dire che specialmente quando sono in Italia devo essere protetta
ventiquattro ore su ventiquattro dai Carabinieri. La nostra polizia militare. E,
sia pure a fin di bene, questa è una durissima limitazione alla mia libertà
personale. Quanto agli insulti, agli anatemi, agli abusi con cui i media europei
mi onorano per conto della trista alleanza Sinistra-Islam, ecco alcune delle
qualifiche che da quattro anni mi vengono elargite: «Abominevole. Blasfema.
Deleteria. Troglodita. Razzista. Retrograda. Ignobile. Degenere. Reazionaria.
Abbietta». Come vedete, parole identiche o molto simili a quelle usate da Alexis
de Tocqueville quando spiega il dispotismo che mira alla Morte Civile. Nel mio
paese quel dispotismo si compiace anche di chiamarmi «Iena», nel distorcere il
mio nome da Oriana in «Oriena» e nello sbeffeggiarmi attraverso sardoniche
identificazioni con Giovanna d’Arco. «Le bestialità della neo Giovanna d’Arco».
«Taci, Giovanna d’Arco». «Ora basta, Giovanna d’Arco».
Scontro di (in)civiltà. Oriana
Fallaci: le galline della sinistra in ginocchio dagli islamici. Per gentile
concessione dell’erede Edoardo Perazzi, continuiamo la pubblicazione del
discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005, quando fu insignita del «Annie
Taylor Award», prestigioso riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci
affronta sono quelli delle sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. Lo scorso
agosto venni ricevuta in udienza privata da Ratzinger, insomma da Papa Benedetto
XVI. Un Papa che ama il mio lavoro da quando lesse Lettera a un bambino mai nato
e che io rispetto profondamente da quando leggo i suoi intelligentissimi libri.
Un Papa, inoltre, col quale mi trovo d’accordo in parecchi casi. Per esempio,
quando scrive che l’Occidente ha maturato una sorta di odio contro sé stesso.
Che non ama più sé stesso, che ha perso la sua spiritualità e rischia di perdere
anche la sua identità. (Esattamente ciò che scrivo io quando scrivo che
l’Occidente è malato di un cancro morale e intellettuale. Non a caso ripeto
spesso: «Se un Papa e un’atea dicono la stessa cosa, in quella cosa dev’esserci
qualcosa di tremendamente vero»). Nuova parentesi. Sono un’atea, sì.
Un’atea-cristiana, come sempre chiarisco, ma un’atea. E Papa Ratzinger lo sa
molto bene. Ne La Forza della Ragione uso un intero capitolo per spiegare
l’apparente paradosso di tale autodefinizione. Ma sapete che cosa dice lui agli
atei come me? Dice: «Ok. (L’ok è mio, ovvio). Allora Veluti si Deus daretur.
Comportatevi come se Dio esistesse». Parole da cui desumo che nella comunità
religiosa vi sono persone più aperte e più acute che in quella laica alla quale
appartengo. Talmente aperte ed acute che non tentano nemmeno, non si sognano
nemmeno, di salvarmi l’anima cioè di convertirmi. Uno dei motivi per cui
sostengo che, vendendosi al teocratico Islam, il laicismo ha perso il treno. È
mancato all’appuntamento più importante offertogli dalla Storia e così facendo
ha aperto un vuoto, una voragine che soltanto la spiritualità può riempire. Uno
dei motivi, inoltre, per cui nella Chiesa d’oggi vedo un inatteso partner, un
imprevisto alleato. In Ratzinger, e in chiunque accetti la mia per loro
inquietante indipendenza di pensiero e di comportamento, un compagnon-de-route.
Ammenoché anche la Chiesa manchi al suo appuntamento con la Storia. Cosa che
tuttavia non prevedo. Perché, forse per reazione alle ideologie materialistiche
che hanno caratterizzato lo scorso secolo, il secolo dinanzi a noi mi sembra
marcato da una inevitabile nostalgia anzi da un inevitabile bisogno di
religiosità. E, come la religione, la religiosità finisce sempre col rivelarsi
il veicolo più semplice (se non il più facile) per arrivare alla spiritualità.
Chiusa la nuova parentesi. E così ci incontrammo, io e questo gentiluomo
intelligente. Senza cerimonie, senza formalità, tutti soli nel suo studio di
Castel Gandolfo conversammo e l’incontro non-professionale doveva restare
segreto. Nella mia ossessione per la privacy, avevo chiesto che così fosse. Ma
la voce si diffuse ugualmente. Come una bomba nucleare piombò sulla stampa
italiana, e indovina ciò che un petulante idiota con requisiti accademici
scrisse su un noto giornale romano di Sinistra. Scrisse che il Papa può vedere
quanto vuole «i miserabili, gli empi, i peccatori, i mentalmente malati» come la
Fallaci. Perché «il Papa non è una persona perbene». (A dispetto di ogni
dizionario e della stessa Accademia della Crusca, il «perbene» scritto "per
bene"). Del resto, e sempre pensando a Tocqueville, alla sua invisibile ma
insuperabile barriera dentro-la-quale-si-può-soltanto-tacere-o-unirsi-al-coro,
non dimentico mai quello che quattro anni fa accadde qui in America. Voglio dire
quando l’articolo La Rabbia e l’Orgoglio (non ancora libro) apparve in Italia. E
il New York Times scatenò la sua Super Political Correctness con una intera
pagina nella quale la corrispondente da Roma mi presentava come «a provocateur»
una «provocatrice». Una villana colpevole di calunniare l’Islam... Quando
l’articolo divenne libro e apparve qui, ancora peggio. Perché il New York Post
mi descrisse, sì, come «La Coscienza d’Europa, l’eccezione in un’epoca dove
l’onestà e la chiarezza non sono più considerate preziose virtù». Nelle loro
lettere i lettori mi definirono, sì, «il solo intelletto eloquente che l’Europa
avesse prodotto dal giorno in cui Winston Churchill pronunciò lo Step by Step
cioè il discorso con cui metteva in guardia l’Europa dall’avanzata di Hitler».
Ma i giornali e le TV e le radio della Sinistra al Caviale rimasero mute, oppure
si unirono alla tesi del New York Times. Tantomeno dimentico ciò che è avvenuto
nel mio paese durante questi giorni di novembre 2005. Perché, pubblicato da una
casa editrice che nella maggioranza delle quote azionarie appartiene ai miei
editori italiani, e da questi vistosamente annunciato sul giornale che
consideravo il mio giornale, in un certo senso la mia famiglia, un altro libro
anti- Fallaci ora affligge le librerie. Un libro scritto, stavolta, dall’ex
vice-direttore del quotidiano che un tempo apparteneva al defunto Partito
Comunista. Bé, non l’ho letto. Né lo leggerò. (Esistono almeno sei libri su di
me. Quasi tutti, biografie non-autorizzate e piene di bugie offensive nonché di
grottesche invenzioni. E non ne ho mai letto uno. Non ho mai neppure gettato lo
sguardo sulle loro copertine). Ma so che stavolta il titolo, naturalmente
accompagnato dal mio nome che garantisce le vendite, contiene le parole «cattiva
maestra». So che la cattiva maestra è ritratta come una sordida reazionaria, una
perniciosa guerrafondaia, una mortale portatrice di «Orianismo». E secondo l’ex
vice-direttore dell’ex quotidiano ultracomunista, l’Orianismo è un virus. Una
malattia, un contagio, nonché un’ossessione, che uccide tutte le vittime
contaminate. (Graziaddio, molti milioni di vittime. Soltanto in Italia, la
Trilogia ha venduto assai più di quattro milioni di copie in tre anni. E negli
altri ventun paesi è un saldo bestseller). Ma questo non è tutto. Perché nei
medesimi giorni il sindaco milanese di centro-destra mi incluse nella lista
degli Ambrogini: le molto ambite medaglie d’oro che per la festa di
Sant’Ambrogio la città di Milano consegna a persone note, o quasi, nel campo
della cultura. E quando il mio nome venne inserito, i votanti della Sinistra
sferrarono un pandemonio che durò fino alle cinque del mattino. Per tutta la
notte, ho saputo, fu come guardare una rissa dentro un pollaio. Le penne
volavano, le creste e i bargigli sanguinavano, i coccodè assordavano, e lode al
cielo se nessuno finì al Pronto Soccorso. Poi, il giorno dopo, tornarono
strillando che il mio Ambrogino avrebbe inquinato il pluriculturalismo e
contaminato la festa di Sant’Ambrogio. Che avrebbe dato alla cerimonia del
premio un significato anti-islamico, che avrebbe offeso i mussulmani e i
premiati della Sinistra. Quest’ultimi minacciarono addirittura di respingere le
ambite medaglie d’oro e promisero di inscenare una fiera dimostrazione contro la
donna perversa. Infine il leader del Partito di Rifondazione Comunista dichiarò:
«Dare l’Ambrogino alla Fallaci è come dare il Premio Nobel della Pace a George
W. Bush». Detto questo, onde rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio, devo chiarire qualcosa che certo dispiacerà ad alcuni o alla
maggioranza di voi. Ecco qua. Io non sono un Conservatore. Non simpatizzo con la
Destra più di quanto non simpatizzi con la Sinistra. Sebbene rifiuti ogni
classificazione politica, mi considero una rivoluzionaria. Perché la Rivoluzione
non significa necessariamente la Presa della Bastiglia o del Palais d’Hiver. E
certamente per me non significa i capestri, le ghigliottine, i plotoni di
esecuzione, il sangue nelle strade. Per me la Rivoluzione significa dire «No».
Significa lottare per quel «No». Attraverso quel «No», cambiare le cose. E di
sicuro io dico molti «No». Li ho sempre detti. Di sicuro vi sono molte cose che
vorrei cambiare. Cioè non mantenere, non conservare. Una è l’uso e l’abuso della
libertà non vista come Libertà ma come licenza, capriccio, vizio. Egoismo,
arroganza, irresponsabilità. Un’altra è l’uso e l’abuso della democrazia non
vista come il matrimonio giuridico dell’Uguaglianza e della Libertà ma come
rozzo e demagogico egualitarismo, insensato diniego del merito, tirannia della
maggioranza. (Di nuovo, Alexis de Tocqueville...). Un’altra ancora, la mancanza
di autodisciplina, della disciplina senza la quale qualsiasi matrimonio
dell’uguaglianza con la libertà si sfascia. Un’altra ancora, il cinico
sfruttamento delle parole Fratellanza-Giustizia-Progresso. Un’altra ancora, la
nescienza di onore e il tripudio di pusillanimità in cui viviamo ed educhiamo i
nostri figli. Tutte miserie che caratterizzano la Destra quanto la Sinistra.
Cari miei: se coi suoi spocchiosi tradimenti e le sue smargiassate alla
squadrista e i suoi snobismi alla Muscadin e le sue borie alla Nouvel Riche la
Sinistra ha disonorato e disonora le grandi battaglie che combatté nel Passato,
con le sue nullità e le sue ambiguità e le sue incapacità la Destra non onora
certo il ruolo che si vanta di avere. Ergo, i termini Destra e Sinistra sono per
me due viete e antiquate espressioni alle quali ricorro solo per abitudine o
convenienza verbale. E, come dico ne La Forza della Ragione, in entrambe vedo
solo due squadre di calcio che si distinguono per il colore delle magliette
indossate dai loro giocatori ma che in sostanza giocano lo stesso gioco. Il
gioco di arraffare la palla del Potere. E non il Potere di cui v’è bisogno per
governare: il Potere che serve sé stesso. Che esaurisce sé stesso in sé stesso.
Maestra di libertà. Oriana
Fallaci e l'Islam: "Diventeremo l'Eurabia. Il nemico è in casa nostra e non
vuole dialogare". Per gentile concessione dell'erede Edoardo Perazzi,
continuiamo la pubblicazione del discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005,
quando fu insignita del Annie Taylor Award, prestigioso riconoscimento
statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle sue celebri
opere, tutte edite da Rizzoli. Questo può apparir demagogico, semplicistico, e
perfino superficiale: lo so. Ma se analizzate i fatti vedrete che la mia è pura
e semplice verità. La verità del bambino che nella fiaba dei Grimm, quando i
cortigiani lodano le vesti del re, grida con innocenza: Il re è nudo. Pensateci
ragionando sull'attuale tragedia che ci opprime. Perbacco, nessuno può negare
che l'invasione islamica dell'Europa sia stata assecondata e sia assecondata
dalla Sinistra. E nessuno può negare che tale invasione non avrebbe mai
raggiunto il culmine che ha raggiunto se la Destra non avesse fornito alla
Sinistra la sua complicità, se la Destra non le avesse dato il imprimatur.
Diciamolo una volta per sempre: la Destra non ha mai mosso un dito per impedire
o almeno trattenere la crescita dell’invasione islamica. Un solo esempio? Come
in molti altri paesi europei, in Italia è il leader della Destra ufficiale che
imita la Sinistra nella sua impazienza di concedere il voto agli immigrati senza
cittadinanza. E questo in barba al fatto che la nostra Costituzione conceda il
voto ai cittadini e basta. Non agli stranieri, agli usurpatori, ai turisti col
biglietto di andata senza ritorno. Di conseguenza, non posso essere associata né
con la Destra né con la Sinistra. Non posso essere arruolata né dalla Destra né
dalla Sinistra. Non posso essere strumentalizzata né della Destra né della
Sinistra. (E guai a chi ci prova). E sono profondamente irritata con entrambe.
Qualunque sia la loro locazione e nazionalità. Attualmente, per esempio, sono
irritata con la Destra americana che spinge i leader europei ad accettare la
Turchia come membro dell’Unione Europea. Esattamente ciò che la Sinistra europea
vuole da sempre. Ma le vittime dell’invasione islamica, i cittadini europei, non
vogliono la Turchia a casa loro. La gente come me non vuole la Turchia a casa
sua. E Condoleezza Rice farebbe bene a smetterla di esercitare la sua
Realpolitik a nostre spese. Condoleezza è una donna intelligente: nessuno ne
dubita. Certo, più intelligente della maggioranza dei suoi colleghi maschi e
femmine, sia qui in America che al di là dell’Atlantico. Ma sul paese che per
secoli fu l’Impero Ottomano, sulla non-europea Turchia, sulla islamica Turchia,
sa o finge di sapere assai poco. E sulla mostruosa calamità che rappresenterebbe
l’entrata della Turchia nell’Unione Europea conosce o finge di conoscere ancora
meno. Così dico: Ms. Rice, Mr. Bush, signori e signore della Destra americana,
se credete tanto in un paese dove le donne hanno spontaneamente rimesso il velo
e dove i Diritti Umani vengono quotidianamente ridicolizzati, prendetevelo voi.
Chiedete al Congresso di annetterlo agli stati Uniti come Cinquantunesimo Stato
e godetevelo voi. Poi concentratevi sull’Iran. Sulla sua lasciva nucleare, sul
suo ottuso ex-sequestratore di ostaggi cioè sul suo presidente, e concentratevi
sulla sua nazista promessa di cancellare Israele dalle carte geografiche. A
rischio di sconfessare l’illimitato rispetto che gli americani vantano nei
riguardi di tutte le religioni, devo anche chiarire ciò che segue. Come mai in
un Paese dove l’85 per cento dei cittadini dicono di essere Cristiani, così
pochi si ribellano all’assurda offensiva che sta avvenendo contro il Natale?
Come mai così pochi si oppongono alla demagogia dei radicals che vorrebbero
abolire le vacanze di Natale, gli alberi di Natale, le canzoni di Natale, e le
stesse espressioni Merry Christmas e Happy Christmas, Buon Natale, eccetera?!?
Come mai così pochi protestano quando quei radicals gioiscono come Talebani
perché in nome dei laicismo un severo monumento a gloria dei Dieci Comandamenti
viene rimosso da una piazza di Birmingham? E come mai anche qui pullulano le
iniziative a favore della religione islamica? Come mai, per esempio, a Detroit
(la Detroit ultra polacca e ultra cattolica le ordinanze municipali contro i
rumori proibiscono il suono delle campane) la minoranza islamica ha ottenuto che
i muezzin locali possano assordare il prossimo coi loro Allah-akbar dalle 6 del
mattino alle 10 di sera? Come mai in un paese dove la Legge ordina di non
esibire i simboli religioni nei luoghi pubblici, non consentirvi preghiere
dell’una o dell’altra religione, aziende quali la Dell Computers e la Tyson
Foods concedono ai propri dipendenti islamici i loro cortili nonché il tempo per
recitare le cinque preghiere? E questo a dispetto del fatto che tali preghiere
interrompono quindi inceppano le catene di montaggio? Come mai il nefando
professor Ward Churchill non è stato licenziato dall’Università del Colorado per
i suoi elogi a Bin Laden e all’11 Settembre, ma il conduttore della Washington
radio Michael Graham è stato licenziato per aver detto che dietro il terrorismo
islamico v’è la religione islamica? Ed ora lasciatemi concludere questa serata
affrontando altri tre punti che considero cruciali. Punto numero uno. Sia a
Destra che a Sinistra tutti si focalizzano sul terrorismo. Tutti. Perfino i
radicali più radicali. (Cosa che non sorprende perché le condanne verbali del
terrorismo sono il loro alibi. Il loro modo di pulire le loro coscienze non
pulite). Ma nel terrorismo islamico non vedo l’arma principale della guerra che
i figli di Allah ci hanno dichiarato. Nel terrorismo islamico vedo soltanto un
aspetto, un volto di quella guerra. Il più visibile, sì. Il più sanguinoso e il
più barbaro, ovvio. Eppure, paradossalmente, non il più pernicioso. Non il più
catastrofico. Il più pernicioso e il più catastrofico è a parer mio quello
religioso. Cioè quello dal quale tutti gli altri aspetti, tutti gli altri volti,
derivano. Per incominciare, il volto dell’immigrazione. Cari amici: è
l’immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia che ha penetrato
l’Occidente e trasformato l’Europa in ciò che chiamo Eurabia. È l’immigrazione,
non il terrorismo, l’arma su cui contano per conquistarci annientarci
distruggerci. L’arma per cui da anni grido: «Troia brucia, Troia brucia».
Un’immigrazione che in Europa-Eurabia supera di gran lunga l’allucinante
sconfinamento dei messicani che col beneplacito della vostra Sinistra e
l’imprimatur della vostra Destra invadono gli Stati Uniti. Soltanto nei
venticinque paesi che formano l’Unione Europea, almeno venticinque milioni di
musulmani. Cifra che non include i clandestini mai espulsi. A tutt’oggi, altri
quindici milioni o più. E data l’irrefrenabile e irresistibile fertilità
mussulmana, si calcola che quella cifra si raddoppierà nel 2016. Si triplicherà
o quadruplicherà se la Turchia diventerà membro dell’Unione Europea. Non a caso
Bernard Lewis profetizza che entro il 2100 tutta l’Europa sarà anche
numericamente dominata dai musulmani. E Bassan Tibi, il rappresentante ufficiale
del cosiddetto Islam Moderato in Germania, aggiunge: «Il problema non è
stabilire se entro il 2100 la stragrande maggioranza o la totalità degli europei
sarà mussulmana. In un modo o nell’altro, lo sarà. Il problema è stabilire se
l’Islam destinato a dominare l’Europa sarà un Euro-Islam o l’Islam della
Svaria». Il che spiega perché non credo nel Dialogo con l’Islam. Perché sostengo
che tale dialogo è un monologo. Un soliloquio inventato per calcolo dalla
Realpolitik e poi tenuto in vita dalla nostra ingenuità o dalla nostra
inconfessata disperazione. Infatti su questo tema dissento profondamente dalla
Chiesa Cattolica e da Papa Ratzinger. Più cerco di capire e meno capisco lo
sgomentevole errore su cui la sua speranza si basa. Santo Padre: naturalmente
anch’io vorrei un mondo dove tutti amano tutti e dove nessuno è nemico di
nessuno. Ma il nemico c’è. Lo abbiamo qui, in casa nostra. E non ha nessuna
intenzione di dialogare. Né con Lei né con noi. Di Oriana Fallaci.
Montanelli Fallaci, libro a 4
mani. Finì a “ti disprezzo” e “ti credevo migliore”, scrive Riccardo Galli su
Blitz Quotidiano. Il titolo lo si sarebbe potuto trovare facilmente e avrebbe
potuto, magari, suonare più o meno così: “L’impossibile libro a 4 mani”. E’,
anzi era il progetto editoriale targato Rizzoli che poco meno di mezzo secolo fa
avrebbe voluto dare i natali ad un libro scritto da due monumenti del
giornalismo italiano: Indro Montanelli e Oriana Fallaci. Un progetto naufragato
però ancor prima di reificarsi a causa delle personalità delle due “penne”.
Personalità a dir poco ingombranti e, di certo, poco disponibili ad una
posizione di non protagonista assoluto. Foss’anche nella stesura di un libro. Un
progetto abortito e sconosciuto, almeno sino a che Paolo Di Paolo, raccogliendo
materiale per un libro su Montanelli, non si è ritrovato tra le mani una lettera
della Fallaci. Una lettera in cui la giornalista, da New York, scriveva alla
moglie di Montanelli parlandole proprio del libro in questione: “Niente schemi
rigidi, niente cattedre da una parte o dall’altra”. Da questo frammento è
partita una ricerca che ha svelato la storia, o almeno parte di essa, del libro
mai nato. Una storia che Di Paolo racconta sul Corriere della Sera. “Cinque anni
prima – agosto 1971 – erano stati (Montanelli e la Fallaci ndr.) sul punto di
scrivere un volume a quattro mani, ma il progetto naufragò. Questo libro mai
nato rischiava di essere un capo lavoro: provate ad immaginare due penne simili
– così sopra la media di chiunque scriva oggi, così brillanti, così feroci e
libere – nello stesso spazio editoriale”. “’Niente schemi rigidi, niente
cattedre da una parte o dall’altra’ precisa la Fallaci scrivendo alla moglie di
Indro, Colette Rosselli, il 7 agosto del ’71,. Mentre lavoravo ad un libro su
Montanelli – racconta Di Paolo sul Corriere – ho ritrovato questa curiosa
lettera: l’Oriana racconta a Colette di aver tardato ad iniziare il lavoro per
una serie di ragioni – una febbre tropicale presa durante un servizio in Asia,
la malattia della madre e dello zio Bruno, ma anche una ‘comprensibile paura,
una comprensibile timidezza che un po’ per volta mi aveva invaso’”. Da questa
traccia si possono quasi immaginare i due, Montanelli e la Fallaci, uno al di
qua e una al di là dell’Atlantico, da New York dove viveva, scambiarsi
appassionate lettere. Internet, e con lui le e-mail, erano ancora lontani da
venire e, per comunicare, i due dovevano per forza di cose ricorrere all’unico
sistema allora efficiente: carta e penna. E allora lettere. Lettere in cui la
Fallaci confida un pizzico di timore reverenziale alla moglie di quello che
comunque, complici i 20 anni di differenza, considera in qualche modo un
maestro. E lettere in cui il “maestro” manifesta comunque l’ammirazione per
quella che ai suoi occhi è una “ragazzina”, seppur piena di talento. Lettere in
cui dalla timidezza si passa alle idee e, rapidamente, allo scontro e alla fine
ai veri e propri insulti. Una parabola in cui si possono riconoscere i caratteri
dei due che, idee politiche a parte, hanno effettivamente contribuito a fare la
storia del giornalismo italiano. La rabbia e l’orgoglio che, prima di divenire
il titolo del libro probabilmente più celebre della Fallaci, erano parte
integrante e caratterizzante della giornalista. E poi l’indisponibilità ad
accettare lezioni da una “ragazzina” e le differenti visioni del mondo e,
soprattutto, della Resistenza che Montanelli e che la Fallaci hanno e che
saranno alla base della rottura tra i due. Dall’idea di un lavoro fatto insieme
infatti a questo si arriva: ad una rottura praticamente definitiva tra i due.
Anche se, entrambi, non smetteranno di riconoscere il valore dell’altro. “Ti
disprezzo”, scriverà Montanelli. “Ti credevo migliore” le risponderà la Fallaci.
Epitaffio di una collaborazione che avrebbe potuto essere magnifica ma che non
poteva in realtà essere.
E poi c'è quello che nessuno
ha mai detto. L'Oriana Fallaci che visse la storia di Gesù in diretta. "Stampo
da mezzo secolo L'Evangelo di Maria Valtorta, 10 volumi. Contiene dettagli
inediti che solo una testimone oculare può aver visto", scrive Stefano
Lorenzetto su “Il Giornale”. Immaginate un'Oriana Fallaci al fianco di Gesù,
pronta a osservare e a riferire tutto ciò che vede, con una dovizia di
particolari da lasciare attoniti; una cronista dalla penna insuperabile, molto
più attenta di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, i quattro evangelisti che
narrarono la vita del Nazareno in modo succinto o riferendo episodi dei quali
non furono testimoni diretti. Quella donna è esistita. Si chiamava Maria
Valtorta. La cosa incredibile è che nacque a Caserta il 14 marzo 1897 e morì a
Viareggio il 12 ottobre 1961. Ciononostante ha lasciato 122 quaderni di scuola -
in tutto 13.193 pagine - compilati in uno stato di ascesi mistica fra il 1943 e
il 1947, nei quali descrive per filo e per segno l'infanzia, la predicazione, i
miracoli, la passione, la morte, la resurrezione e l'ascensione al cielo del
Salvatore, citando luoghi, personaggi e dialoghi che nei Vangeli non compaiono.
Ho potuto vedere alcuni di questi quaderni: la grafia, sgorgata da sette penne
stilografiche tuttora conservate, è nitida, regolare, senza ombra di correzioni
o tremori. Eppure la Valtorta era paraplegica, rimase inchiodata nel letto per
27 anni, fino al decesso, e come scrittoio doveva usare le proprie ginocchia
arcuate, che infatti al momento di chiuderla nella bara erano ancora piegate in
quella posa innaturale. Emilio Pisani, 79 anni, laureato in giurisprudenza, è da
sempre il curatore e l'editore unico dell'opera monumentale ricavata da questi
quaderni, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Sono 10 volumi, per un totale di
5.000 pagine. Oltre 10 milioni di caratteri. Ciò significa che il racconto
valtortiano è 25 volte più lungo dei quattro Vangeli canonici. «Quante copie
sono in circolazione? Non lo so, c'è chi dice milioni», si sottrae pudico lo
stampatore. Una cosa è certa: dal 1956 a oggi è stato tradotto persino in arabo,
cinese, coreano, giapponese, russo, lituano, ucraino, croato, indonesiano,
vietnamita, malayalam, tamil, rwandese e swahili. Oltre una trentina di lingue.
Pisani, fondatore del Cev, il Centro editoriale valtortiano, va considerato un
editore unico anche per il fatto che nessun altro suo collega al mondo ha in
catalogo un solo autore. Né mi era mai capitato d'incontrare un editore che arde
nel caminetto di casa i manoscritti inediti di questo suo autore. In gioventù
Maria Valtorta perse il padre molto presto e così si risolse a scrivere un
romanzo autobiografico, Il cuore di una donna, dal quale sperava di ricavare
qualche soldo per la famiglia. In realtà non volle mai pubblicarlo e ordinò a
Marta Diciotti, la governante-infermiera che la assistette dal 1935 sino alla
fine, di distruggerlo. La donna non ebbe però il coraggio di farlo. «Nel 2001,
prima di morire, la Diciotti consegnò il testo a me e a mia moglie», rievoca
Pisani. «Lo aprimmo soltanto 10 anni più tardi. Erano pagine fittissime. Senza
leggere neppure una riga , ci parve giusto bruciarle. Le ceneri le spargemmo qui
fuori, nell'aiuola delle rose, che da allora fioriscono ancora più rigogliose».
La villetta dei Pisani è nel giardino in cui ha sede la casa editrice, a Isola
del Liri. Dal 2012 è più vuota: Claudia Vecchiarelli, insegnante di lettere e
traduttrice che aveva aiutato il marito a diffondere il verbo della Valtorta, è
morta di tumore. Il suo Emilio, un uomo mite dagli occhi limpidi come l'acqua
delle cascate che si ammirano nel paesino della provincia di Frosinone, le ha
dedicato un libro, Lettera a Claudia, in cui ripercorre la straordinaria
avventura capitata a entrambi. Insieme hanno dato vita alla Fondazione Maria
Valtorta Cev onlus, che amministra l'eredità materiale e spirituale della
veggente e che ha acquistato dai Servi di Maria la sua casa di Viareggio, ora
trasformata in museo. Per testamento sono finiti a loro tutti i documenti
autografi della «evangelista», inclusi i famosi quaderni, oggi custoditi a Isola
del Liri. Proprio in questi giorni gli italiani Marco Ruopoli e Matteo Ferretti
e il mauritano Mor Amar, della cooperativa Sophia di Roma, hanno ultimato di
digitalizzarli in alta definizione, per cui presto saranno consultabili in Pdf.
Dopodiché gli originali finiranno in un caveau climatizzato, isolati dalla luce
e dalla polvere.
Com'è diventato l'editore di
Maria Valtorta?
«Cominciai come correttore di
bozze con mio padre Michele, che negli anni Venti aveva aperto insieme al
cognato Arturo Macioce una tipografia specializzata nella stampa di vite dei
santi e trattati di teologia per il Vaticano e gli istituti religiosi. Una copia
dell' Evangelo, dattilografata con la carta carbone dal direttore spirituale
della Valtorta, il servita padre Romualdo Migliorini, fu data in lettura a
Camillo Corsanego, notaio dei conclavi e decano degli avvocati concistoriali per
le cause dei santi, il quale, benché sposato e padre di 6 figli, poteva
fregiarsi del titolo di monsignore. Un'altra copia andò all'arcivescovo Alfonso
Carinci, che era stato insegnante del futuro Pio XII all'Almo Collegio
Capranica. Un'altra ancora al famoso endocrinologo Nicola Pende, che rimase
impressionato dalla “perizia con cui la Valtorta descrive, nella scena
dell'agonia di Gesù sulla croce, una fenomenologia che solo pochi medici
consumati saprebbero esporre”. Quando i Servi di Maria chiesero al Sant'Uffizio
il permesso di pubblicare il testo, la risposta fu negativa. Al che mio padre,
che era stato convocato a Roma per stamparlo, si assunse l'onere di farlo come
editore in proprio e nel 1952 firmò il primo contratto di edizione con la
Valtorta».
Lei l'ha conosciuta?
«Certo. Andai a trovarla a
Viareggio, dove il Venerdì santo del 1943 ebbe la prima rivelazione e il primo
dettato».
Fu una visione? O udì una
voce?
«Penso a un fenomeno
interiore. Diceva di vedere Gesù e Maria accanto a sé e di essere stata
fisicamente presente agli episodi narrati nei Vangeli. Leggendo la sua
Autobiografia, mi ero convinto che fosse una grande donna. Giaceva nel letto e
ripeteva spesso: “Che sole c'è qui!”, anche se fuori pioveva. Era in uno stato
di isolamento psichico, come se avesse offerto il suo intelletto a Dio. Non le
interessava comunicare con il resto dell'umanità. Quando nel 1956 ebbe fra le
mani il primo volume del suo Evangelo che avevamo appena stampato, lo guardò
distrattamente e lo appoggiò sulla coperta, come se non le appartenesse».
Che cosa sa della mistica?
«Era la figlia unica di
Giuseppe Valtorta, mantovano, ufficiale di cavalleria, e di Iside Fioravanti,
cremonese, docente di francese. A 4 anni, nell'asilo delle orsoline a Milano, le
sue coetanee erano spaventate da un Cristo deposto dalla croce, raffigurato con
crudo verismo nella cappella dell'istituto. Lei, invece, avrebbe voluto aprire
l'urna in cui era deposto per mettergli nella mano trafitta dal chiodo il
confetto che la nonna le dava ogni mattina accompagnandola a scuola. Studiò nel
collegio Bianconi di Monza e nel 1917 entrò nel corpo delle infermiere
volontarie che a Firenze curavano i feriti della Grande guerra. Si fidanzò due
volte e per due volte sua madre, una donna fredda, dispotica, terribile, le
mandò a monte il matrimonio. Nel 1920 fu aggredita per strada da un giovane
facinoroso, che le diede una mazzata sui reni gridando: “Abbasso i signori e i
militari!”. A causa dell'aggressione, nel 1934 rimase paralizzata dalla cintola
in giù».
Ma che ha di speciale
L'Evangelo ?
«Introduce personaggi e
racconti che nei Vangeli sinottici non appaiono. Giovanni dice solo che Giuda
era un ladro. Nell' Evangelo si spiega che rubò del denaro a Giovanna di Cusa,
moglie di un intendente di Erode. Lo stesso Giuda si accorge che il Maestro
piange dopo aver resuscitato il figlio della vedova di Nain, al quale la
Valtorta dà per la prima volta un nome, Daniele. Interrogato dal discepolo
traditore sul motivo di quelle lacrime, Gesù risponde: “Penso a mia madre”. L'
Evangelo presenta figure sconosciute, come Giovanni di Endor, ex ergastolano, e
Sintica, schiava greca assai colta, convertiti al cristianesimo. Per una
delazione di Giuda al sinedrio, vengono esiliati ad Antiochia, da dove inviano
lettere al Nazareno in cui descrivono la città della Siria con immagini e
toponimi che hanno sbalordito lo studioso francese Jean-François Lavère e il
mineralogista Vittorio Tredici. Quest'ultimo era di casa in Palestina e annotò
come la Valtorta superasse “la normale cognizione geografica o panoramica”
facendola diventare “addirittura topografica e più ancora geologica”».
L'autrice potrebbe aver
attinto questi particolari in qualche biblioteca.
«E quale, considerato che non
era in grado di muoversi? I libri che teneva in casa li ho io e nessuno di essi
tratta della città di Seleucia Pieria, o dei monti Casio e Sulpio, o dei
colonnati di Erode. Ma la cosa più strabiliante è che la Valtorta riporta in
modo minuzioso la pianta e persino il colore rosso delle pareti di un palazzo
che Lazzaro di Betania, resuscitato da Gesù a quattro giorni dalla morte,
possedeva sulla collina di Sion. Soltanto nel 1983 un'équipe di archeologi
diretta dal professor Nahman Avigad della Hebrew University di Gerusalemme
ritrovò i resti della dimora, perfettamente corrispondenti alla descrizione
fattane dalla mistica 40 anni prima».
Mi sfugge il senso di tanta
meticolosaggine narrativa.
«Ma non sfugge a Gesù, che il
25 gennaio 1944 impartì alla Valtorta - è lei a riportarlo - questo comando:
“Ricorda di essere scrupolosa al sommo nel ripetere quanto vedi. Anche una
inezia ha un valore e non è tua, ma mia. Più sarai attenta ed esatta e più sarà
numeroso il numero di coloro che vengono a Me”».
L'Osservatore Romano il 6
gennaio 1960 bollò L'Evangelo come «una vita di Gesù malamente romanzata».
«Inevitabile. Pochi giorni
prima, il 16 dicembre 1959, era stato condannato dal Sant'Uffizio. Fu l'ultima
opera messa nell' Indice dei libri proibiti, prima che Paolo VI lo abolisse: per
non liberare il carcerato, demolirono il carcere. Il tutto a causa di qualche
passaggio giudicato scabroso, come il racconto di Aglae, un'ex prostituta che
confida a Maria di Nazaret il modo in cui un soldato romano la adescò dopo
averla vista nuda».
Però nel 1985 l'allora
cardinale Joseph Ratzinger ribadì la condanna.
«Con un distinguo: spiegò che
la pubblicazione fu a suo tempo vietata “al fine di neutralizzare i danni che
può arrecare ai fedeli più sprovveduti”. Quindi ai fedeli più avveduti non può
arrecare danno, non essendovi in essa nulla contro la fede. Il cardinale Dionigi
Tettamanzi, quand'era segretario della Cei, avrebbe preteso che inserissi nel
colophon una postilla per avvertire i lettori che l'opera non è di origine
soprannaturale. Ma chi sono io per arrogarmi questa autorità?».
È vero che Pio XII stimava la
Valtorta?
«È vero che lesse l' Evangelo
in dattiloscritto e che disse a padre Migliorini: “Pubblicatelo così com'è. Chi
legge capirà”. Di sicuro lo capì San Pio da Pietrelcina. La bolognese Rosi
Giordani nel 1989 mi scrisse che Elisa Lucchi di Forlì chiese al frate in
confessione: “Padre, ho udito parlare dei libri di Maria Valtorta. Mi
consigliate di leggerli?”. La risposta fu: “Non te lo consiglio, ma te lo
ordino!”».
Ha notato che i veggenti, così
numerosi nei secoli scorsi, sono spariti?
«Non sono mai stato né a
Lourdes, né a Fatima, né a Medjugorje, pur rispettando chi ci va. Non
aggiungerebbero nulla alla mia fede. La Valtorta non ambì mai a farsi conoscere.
Il suo Evangelo doveva camminare nel mondo senza essere del mondo; pretese
persino che la prima edizione uscisse in forma anonima. Una sola volta lo
reclamizzai con un'inserzione a pagamento su Tuttolibri della Stampa: ebbene,
nelle settimane seguenti ricevetti un unico ordine, evento mai capitato in
precedenza. Come se l'opera rifiutasse la pubblicità».
Sorprendente.
«Le dico di più. Nel 1973 la
salma della Valtorta fu esumata a Viareggio per essere traslata a Firenze, nella
Basilica della Santissima Annunziata, dove vi è il celebre affresco della
Madonna, a lei molto caro, che secondo Pietro Bargellini sarebbe stato
completato da un angelo. Il servita Corrado Berti si aspettava un evento
straordinario, per esempio il ritrovamento del corpo incorrotto. Invece
affiorarono poche ossa, che fecero l'estremo viaggio con me alla guida
dell'auto, mia moglie accanto e la governante Marta sul sedile posteriore».
Perché me lo racconta?
«Perché sul letto di morte la
Valtorta aveva la mano sinistra già bluastra, mentre la destra, quella con cui
aveva scritto L'Evangelo, era ancora rosea, come se fosse viva: nel 1961 fu
considerato un segno del cielo. E la vuol sapere una cosa? Le uniche ossa che
mancavano quando la disseppellimmo erano proprio quelle della mano destra.
Dissolte. Come se la mistica volesse dirci per l'ultima volta: “Non pensate a
me. Pensate a Lui”».
INCOSCIENTI DA SALVARE?
COME SI FINANZIA IL TERRORISMO ISLAMICO.
Papa Francesco condanna la
strage di Charlie Hebdo, ma "non si può insultare la fede", scrive “Libero
Quotidiano”. "È una aberrazione uccidere in nome di Dio" ma "non si può
insultare la fede degli altri". Con queste parole, pronunciate a bordo
dell’aereo diretto nelle Filippine e riferite da Radio Vaticana, Papa Francesco
interviene sull’azione dei terroristi islamici a Parigi contro Charlie Hebdo.
"Non si può prendere in giro la fede", avverte il Papa. "C’è un limite, quello
della dignità di ogni religione". Per Bergoglio, sia la libertà di espressione
che quello di una fede a non essere ridicolizzata "sono due diritti umani
fondamentali". Alla domanda di un cronista francese che gli chiedeva "fino a che
punto si può andare con la libertà di espressione", il Pontefice ha chiarito: sì
alla libera espressione "ma se il mio amico dice una parolaccia sulla mia mamma,
si aspetti un pugno". Questo il limite che secondo il Papa regola la libertà
religiosa: "Non si giocattolizza la religione degli altri", dice Bergoglio.
Francesco ha ricordato che la "libertà di espressione è un diritto, ma anche un
dovere". Neppure, dice il Papa, "si offende la religione", ma in questo caso
"non si reagisce con violenza". Poi ha spiegato, "senza mancare di rispetto a
nessuno" che "dietro ogni attentato suicida c'è uno squilibrio, non so se
mentale, ma certamente umano". In una nota diramata subito dopo la strage
Bergoglio aveva condannato "ogni forma di violenza, fisica e morale, che
distrugge la vita umana, viola la dignità delle persone, mina radicalmente il
bene fondamentale della convivenza pacifica fra le persone e i popoli,
nonostante le differenze di nazionalità, di religione e di cultura". Il Papa
aveva precisato che "qualunque possa esserne la motivazione, la violenza omicida
è abominevole, non è mai giustificabile e la vita e la dignità di tutti vanno
garantire e tutelate con decisione. Ogni istigazione all’odio va rifiutata, il
rispetto dell’altro va coltivato". E ancora: tre giorni fa Bergoglio,
ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, aveva detto che "la tragica
strage avvenuta a Parigi" è una dimostrazione che "gli altri non sono più
percepiti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma
vengono visti come oggetti: l’essere umano da libero diventa schiavo, ora delle
mode, ora del potere, ora del denaro e perfino di forme fuorviate di religione".
Rispetto alle minacce dirette dai terroristi fondamentalisti di matrice islamica
contro il Vaticano e il pontefice, Papa Francesco assicura di affrontare questo
pericolo "con una buona dose di incoscienza". Il Papa - come riferisce ancora
Radio Vaticana - afferma semmai di "temere soprattutto per l’incolumità della
gente", con migliaia di fedeli che tradizionalmente affollano le sue udienze
generali in piazza San Pietro e gli ’Angelus’ dal Palazzo Apostolico e
sottolinea che "il miglior modo per rispondere alla violenza è la mitezza".
Ferrara su Papa Francesco: "Le
sue parole su Charlie non sono una gaffe. Sono molto peggio", scrive “Libero
Quotidiano”. "Se dici una parolaccia su mia mamma ti devi aspettare un pugno",
ha detto ieri Papa Francesco a proposito della libertà di espressione e della
blasfemia. "È aberrante uccidere in nome di Dio", ha detto il gesuita Bergoglio,
ma è sbagliato anche "insultare le religioni". Parole molto forti pronunciate
mentre era in aereo in volo verso le Filippine che hanno in qualche modo hanno
stupito cattolici e non. E proprio a quelle parole Giuliano Ferrara dedica oggi
il suo editoriale sul Foglio sottolineando che "il fantasma di Voltaire e della
sua irrisione delle religioni, dai maomettani ai papisti agli ebrei, il fantasma
di un Charlie del Settecento, è ancora troppo vivo, nonostante si faccia finta
di averne cancellato anche il ricordo con il Concilio ecumenico vaticano II".
"Perché il Papa ha parlato in modo da essere identificabile come il tutore dell'
autodifesa della dignità delle religioni invece che come il custode della
sacralità della vita umana e del diritto alla libertà d' espressione?", si
chiede il direttore del Foglio. La risposta arriva un paragrafo più sotto: "Non
credo sia una gaffe, modalità a parte, ché il magistero posta aerea è
effettivamente un po' troppo colloquiale per valere erga omnes. Non ha perso la
brocca, il Papa, il che sarebbe umano, possibile, riparabile. C' è dell'altro.
C'è la convinzione, comune al Papa e a molta cultura irenista occidentale, che
si debba convivere con l'orrore, che il distacco concettuale e spirituale
dell'islam dalle pratiche violente del jihad è una conquista che spetta
eventualmente all'islam di realizzare, che non esiste alternativa alla
sottomissione o all'abbandono al dialogo interreligioso". Del resto, spiega
Ferrara nell'articolo firmato con l'elefantino rosso, "per quanto si voglia
essere Papa del secolo e nel secolo, per quanti omaggi si facciano, anche per i
creduloni, alla libertà piena di coscienza come fondamento della fede, della
possibilità della fede, alla fine quel che conta è non perdere il contatto con
l'universo islamico, e la chiesa sa bene, ben più e meglio di altri, che il
nemico violento non è il terrorismo ma l'idea coranica radicalizzata di cui il
terrorismo è il frutto". "Parole e gesti del Papa, le risate risuonate nella
carlinga del suo aereo, la metafora del pugno risanatore che colpisce e ripara
l'offesa alla dignità, la declamazione tra pause teatrali del concetto "è
normale, è normale", tutto questo non è gaffe", conclude Ferrara. "E' di più e
peggio". "La piazza araba militante, gli imam che predicano nelle moschee e
riluttano a un rigorosa condanna della decimazione con fucile a pompa di
redazioni di giornale e negozi ebraici, da ieri si sentono meno isolati, meglio
protetti dalla convergenza con il Papa di Roma".
Giuliano Ferrara:
"#JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly, vi spiego perché provo pena e ammirazione
per gli stragisti di Parigi", scrive “Libero Quotidiano”. Controcorrente.
Sempre. Sin dal principio della questione, che ne è anche il presupposto, ossia
quell'idea di essere in "guerra santa" contro l'islam gridata negli studi di
Servizio Pubblico, idea espressa pochi minuti dopo l'attacco al Charlie Hebdo in
un videoeditoriale sul sito del Il Foglio. "Guerra santa", appunto, il
presupposto di Giuliano Ferrara, un concetto rifiutato con sdegno da gran parte
dell'auditorio, da chi opera dei distinguo forse necessari, ma non per
l'Elefantino. E sul tema, Ferrara, ci torna nel suo editoriale su Il Foglio di
lunedì, pur prendendolo da una prospettiva diametralmente opposta che emerge sin
dal - controverso - titolo: "#JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly: ecco perché". Il
direttore parafrasa lo slogan #JeSuisCharlie e lo dedica ai tre protagonisti
dell'orrore di Parigi, ai tre terroristi islamici. Ferrara spiega nell'attacco:
"Una pena profonda e un'ammirazione per il loro fanatico coraggio mi legano ai
nemici, ai fratelli Said e Sherif Kouachi e Amely Coulibaly. In un certo senso
di origine cristiana, #JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly". L'Elefantino prosegue:
"Hanno assassinato persone più o meno come me, libertini della mia razza
culturale e civile, gente che disegnava e rideva e sbeffeggiava, con una tinta
blasfema che non ho ma che comprendo perfettamente nella dismisura anarchica e
fragile e folle del loro essere artisti in una società secolarizzata e
nihilista". Il direttore traccia nitidamente i contorni del suo sentimento,
della "pena" e dell'"ammirazione", e sottolinea: "Mi vengono non da quella
abbondanza di misericordia e di accoglienza che è diventata una pappa senza
intimo rigore logico, senza giustizia linguistica, senza verità che non sia
sentimentale. Non dal cuore ma dalla testa. Perché non è vero che tutto questo,
come ha infelicemente detto Francois Hollande e come ripete lo stolto collettivo
sul teatro mondiale della correttezza politica, non ha nulla a che fare con
l'islam". I dettagli multiculturali - Ferrara nel suo editoriale si addentra nel
"diritto come sharia, come legge divina", parla di Egitto, di Torquato Tasso
dell'eroe cristiano Tancredi. Un lungo presupposto per rimarcare come "i
dettagli meno multiculturali della storia tragica di Parigi sono come
scomparsi". E secondo lui, senza comprendere a fondo quei "dettagli", non si può
comprendere a fondo l'intera vicenda, che come Ferrara ha ripetuto negli ultimi
giorni non è "terrorismo", bensì "guerra santa". Tornando sui terroristi,
l'Elefantino ricorda come "hanno scelto di eseguire un ordine divino che impone
di castigare la blasfemia come è accaduto a Charlie Hebdo". E ancora: "Hanno
scelto la morte degli altri, e la loro, in un rito culturale di conversione e
arruolamento, di esecuzione della legge coranica, al quale hanno saputo
corrispondere fino alla fine nella follia della testimonianza di gioventù,
uscendo allo scoperto e sparando all'impazzata davanti alla falange dei gendarmi
di cuoio, oppure pregando alle cinque, ora del blitz, e correndo poi verso
l'esecuzione nel negozio kosher". I dettagli, appunto. Ferrara insiste ancora
sui dettagli, e nella conclusione dell'articolo di fondo ribadisce: "Sono
dettagli importanti, sono il punto di vista che conta, più della rapida capacità
di allineamento menzognero al mainstream politico islamo conformista di un capo
Hezbollah o di un presidente iraniano che si dissociano a sorpresa". Il punto,
per il direttore, è che il pensiero buonista e dominante rischia di far perdere
il fuoco dell'obiettivo. Così Ferrara sottolinea, riferendosi ai terroristi: "Se
li degradate a lupi, degradate voi stessi. Disconoscete il nemico. Non sarete
mai capaci di combatterlo né di amarlo. Al posto del vangelo, libro eccelso,
primitivo e terribile e selvaggio, metterete il prontuario della cultura del
piagnisteo, una specie di ideologia che fa dello scontro di religione e di
civiltà in atto una storiaccia di cronaca nera e di impazzimento terrorista". Ma
per Ferrara, bene ribadirlo ancora una volta, è tutt'altro: è "guerra santa".
Mario Giordano: Basta, ecco
perché non posso più dire "Je suis Charlie Hebdo", scrive su “Libero
Quotidiano”. Scusate, ma devo dire una cosa un po’ difficile, forse persino un
po’ dolorosa. Anche per me stesso. Però devo dirvela: è da stamattina che non mi
sento più tanto Charlie. Anzi, proprio per nulla. Je ne suis pas Charlie. Je ne
suis plus Charlie. Ne ho avuto la netta sensazione sfogliando il nuovo numero
del settimanale satirico francese appena arrivato in edicola. Guardavo le
pagine, diventate loro malgrado il simbolo della nostra civiltà offesa, e
pensavo: ma possono essere davvero il simbolo della nostra civiltà offesa?
Abbiate pazienza, ma io in quelle vignette non mi riconosco. Nemmeno un po’.
Anzi, al contrario: penso che qui dentro, dentro questi fogli della sinistra
sessantottarda, dentro questa cultura anarchica e distruttiva, dentro questi
schizzi blasfemi che fanno a pezzi i nostri valori, dentro gli sberleffi che
mettono alla berlina i nostri credi, ci sia il motivo vero della debolezza
occidentale. Il motivo per cui siamo in balia di un nemico così terribile come
quello islamico. Sia chiaro: da questo nemico terribile Charlie Hebdo va difeso
con ogni mezzo perché dobbiamo salvare la libertà di espressione. Ed è stato
giusto, per una settimana, essere diventati tutti Charlie, con quello slogan che
ha riempito le piazze, Je suis Charlie, Nous sommes Charlie... Ma un conto è
difendere la libertà di esprimersi, un conto è difendere ciò che viene espresso:
la differenza, ne converrete, non è nemmeno così sottile. Siamo pronti alla
battaglia per garantire la libertà di Charlie Hebdo di disegnare e scrivere ciò
che vuole. Ma allo stesso modo dobbiamo essere liberi di dire che quello che
Charlie Hebdo disegna e scrive non ci piace. Nemmeno un po’. Perché Charlie
Hebdo incarna in sé il peggio del nichilismo post-Sessantotto, il peggio del
gauchisme radical-nullista, il peggio della rivoluzione permanente ed effettiva.
Si sono messi contro gli islamici perché amano da sempre mettersi contro tutto:
contro gli ebrei, contro i cattolici, contro la Patria, contro l’esercito,
contro le istituzioni, contro la famiglia, contro l’ordine, contro la sicurezza,
contro la polizia, contro il commercio, contro le imprese, contro l’idea stessa
di nazione e contro ogni Dio. Amano, cioè, mettersi contro tutto quello che
costituisce il fondamento stesso di questa società occidentale, che pure oggi li
difende a spada tratta. Ma da cui loro - ne siamo sicuri - continuano a sentirsi
estranei. Anzi: avversari. Perché, diciamocela tutta, questa società occidentale
che li difende a spada tratta a loro fa un po’ schifo. E allora Je suis Charlie,
sicuro, fin che devo difendere il diritto di questi colleghi a dire la loro
opinione. Ma Je ne suis plus Charlie se devono identificarmi con loro, che
bestemmiano Dio, insultano le tradizioni, e usano il sacrosanto diritto di
opinione per minare la società che glielo garantisce. Dunque, da oggi, visto che
il settimanale è di nuovo uscito, scusate ma Je ne suis plus Charlie. Je ne suis
plus Charlie perché non voglio e non posso accettare che i simboli della nostra
società attaccata dal terrore islamico diventino proprio coloro che la nostra
società la odiano. Coloro che la vorrebbero abbattere. E che la mettono in
pericolo ogni giorno attaccandola nei suoi valori fondamentali. Se, in questa
battaglia, dobbiamo metterci in fila dietro una bandiera, mi piacerebbe che essa
fosse la bandiera della libertà dell’Occidente. Non un foglio che l’Occidente,
al contrario, lo disprezza. Invece si sta compiendo proprio questo. Un po’ per
interesse (operazione Hollande), un po’ per soggezione culturale (la
predominanza della sinistra), alla fine la difesa dell’Europa colpita al cuore
si è trasformata nella difesa tout court dei contenuti (assai discutibili) di
una rivista. Fateci caso: anche se nella carneficina di Parigi sono morti
agenti, ebrei, custodi di palazzo, alla fine tutto si riduce al simbolo di
Charlie Hebdo. Al suo messaggio irresponsabile e irriverente. Questo è l’errore
fondamentale. Perché non dobbiamo dimenticare che nella guerra contro il
fondamentalismo islamico la loro forza è la nostra debolezza. Se loro osano
alzare le armi contro di noi è perché noi siamo in ginocchio, se credono di
poterci sottomettere ai loro valori è perché noi abbiamo rinunciato ai nostri,
se ritengono di poterci imporre le loro tradizioni è perché noi abbiamo
rinunciato alle nostre. E di questa rinuncia il settimanale francese è la
dimostrazione più lampante. Perciò, dopo essere stato per una settimana Cabu,
Charb, Wolinski, Tignous, da oggi mi sento in dovere di dirvi: maintenenat non
plus. Ora non più. Per difenderci davvero non possiamo essere Charlie.
Dopo Charlie Hebdo: perché
bisogna fermare la censura dei buoni. Si comincia a ritenere che chi critica
vignette blasfeme sia contro la libertà. E chi ha una posizione culturale ben
definita ostacoli l'integrazione, scrive Marco Cobianchi su “Panorama”. Temo che
dalla grandiosa marcia parigina nasca un nuovo tipo di censura. La censura dei
buoni. La censura di quelli che vogliono abbassare i toni; quelli che se dici
che siamo di fronte ad una guerra e non a dei terroristi, fomenti l’odio; quelli
che sanno ciò che è opportuno dire e cosa no e se non collabori, allora sei un
guerrafondaio, un estremista, un fondamentalista anche tu. Oppure un cretino. La
censura dei buoni è funzionale al disegno del potere: nessun leader europeo
(Hollande è scusato) ha osato esprimere un’opinione diversa dal “sono
terroristi, la religione non c’entra” e così i assassini diventano “sedicenti
islamici” e a chi fa notare che mentre macellavano innocenti gridavano “Allah
Akbar” viene tacciato di perseguire lo scontro di civiltà. Ecco perché i
terroristi sono diventati "sedicenti islamici". Davanti a chi ha una posizione
diversa i buoni sono pronti a sventolare il ditino inquisitore spiegando che
così non si fa il bene dell’umanità che consiste nell’integrazione e nel
dialogo. E siccome l’ostacolo maggiore al dialogo sarebbe avere una posizione
culturale, religiosa, sociale ben definita, allora la colpa della mancata
integrazione è tua. L’unica posizione culturale accettata diventa così quella
laica che, indifferente a tutto, non fomenta l’odio. Perciò bisogna, adesso più
di prima, stare attenti a non cadere nell’eccesso contrario facendo passare
l’idea che Charlie Hebdo è un giornale di anarchici scapigliati e va difeso
mentre chi ritiene le sue vignette volgari, blasfeme e ripugnanti sta armando le
mani degli assassini. Bisogna stare attenti a non accusare chi esercita la
propria libertà di critica di intelligenza con il nemico. Bisogna vigilare,
perché questo tipo di censura dei buoni è in grado di devastare lo spazio
pubblico togliendo libertà a chi non è allineato con il pensiero mainstream.
Quello secondo il quale solo chi non crede in niente accetta tutto ed è pronto a
dialogare con chiunque. Per dirsi cosa, poi, non si sa. La censura dei buoni è
quella che pensa che la pace nel mondo, che si raggiunge con l’integrazione, è
un fine talmente nobile che della libertà della singola persona si può anche
fare a meno.
Solidarietà già finita:
"Charlie se l'è cercata". E Greta e Vanessa no? Buonismo addio, per i
vignettisti trucidati spuntano i distinguo. Per le nostre cooperanti amiche dei
nostri nemici, invece..., scrive Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Dire che
non siamo sorpresi ci farebbe apparire presuntuosi, nonostante avessimo
segnalato, già dal giorno della strage di Parigi, il diffondersi dell'opinione
che i giornalisti di Charlie Hebdo se lo sono cercata. Certo, nel mondo
dell'islam radicale hanno esultato perché chi ha offeso Maometto, secondo il
loro delirante pensiero, va punito con la morte. Ma scoprire che, anche in
Europa, ci sia più d'uno che definisca l'orrendo massacro solo una brutale
conseguenza delle continue provocazioni del settimanale satirico, ci fa
inorridire. Perché questo significa abbracciare le tesi dei fondamentalisti e
diventare, di fatto, loro fiancheggiatori. Esageriamo? Tutt'altro. È come se si
giustificassero le stragi delle foibe, perpetrate dai partigiani di Tito contro
la popolazione italiana di Venezia Giulia e Dalmazia alla fine della seconda
guerra mondiale: il regime fascista è stato brutale durante l'occupazione
dell'ex Jugoslavia, quindi è naturale e giusto che tutti gli italiani,
indistintamente, siano sterminati. Una tesi riprovevole, anche se tanto cara,
fino a pochi anni fa, ai comunisti nostrani. Ma Charlie Hebdo non è stato
neppure un regime brutale. Ha esagerato nella sua satira anti religiosa? Secondo
la legge, no. E, fino a prova contraria, nei Paesi del Vecchio Continente sono
in vigore norme in sintonia con la democrazia moderna e non con la sharia. Se la
maggioranza dei cittadini deciderà in futuro di modificare le leggi sulla
libertà d'espressione, allora giornali e tv si adegueranno. Ma guai a farlo per
compiacere qualcuno o nel nome del «politicamente corretto». Se uno crede che la
satira superi i limiti della decenza, può sempre rivolgersi a un tribunale e
chiedere giustizia. Nei Paesi civili funziona così, almeno fino a quando anche
in Europa, grazie alla politica delle porte aperte, non nasceranno le prime
teocrazie. È comprensibile che Papa Francesco ritenga inaccettabile che la fede
sia ridicolizzata, lui è un leader religioso. Meno accettabile è che lo
sostengano esponenti laici, garanti della libertà d'espressione o, addirittura,
fondatori di giornali satirici, come Henri Roussel, uno dei padri di Charlie
Hebdo , che ha criticato il direttore assassinato per le sue scelte editoriali.
La blasfemia non è più un reato, grazie alla laicità dello Stato, e in Francia
questo è accaduto già nel 1789. Non sappiamo se a spingere queste persone sia la
paura o altro, ma il loro modo di interpretare le stragi del terrorismo
jihadista è uno schiaffo ai nostri valori e un assist a chi dell'estremismo
continua a fare la sua bandiera. Se si usasse la stessa malevolenza, oggi si
dovrebbe dire che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli andavano lasciate al loro
destino perché se la sono cercata. Sono entrate illegalmente in Siria attraverso
la Turchia, sapevano di andare in un Paese dove era in corso una guerra civile,
hanno fatto una scelta di parte diventando amiche del «nemico». Cosa si
aspettavano, che sventolare una bandiera anti Assad avrebbe fornito loro
l'immunità?
Siria, Candiani (Ln):
Magistratura indaghi onlus per circonvenzione d'incapaci, scrive “Libero
Quotidiano”. “Nella vicenda di Greta e Vanessa consiglierei ai magistrati di
aprire un filone di indagine anche per ‘circonvenzione d’incapaci’: devono
essere perseguite anche quelle associazioni ed onlus poco serie che spingono le
persone a rischiare la vita, senza le adeguate tutele e i minimi requisiti di
sicurezza”. A dirlo il senatore leghista Stefano Candiani, in relazione alla
liberazione delle due cooperanti. “La magistratura faccia approfondite indagini
sui ‘reclutatori’ che, indottrinando al terzomondismo, mandano allo sbaraglio i
giovani e li espongono così ai peggiori pericoli”. Candiani punta il dito contro
“l’atteggiamento irresponsabile e colpevole di chi fa ideologia a basso costo,
mettendo a rischio la vita di attivisti, militanti, cooperanti, e di chi è poi
chiamato a occuparsi dei rapimenti”. “Oggi i cattivi maestri sono responsabili
di aver messo a repentaglio vite umane e, nella malaugurata ipotesi (peraltro
non smentita da Gentiloni) che sia stato pagato un riscatto, anche di tutti gli
italiani nel mondo, che oggi rischiano di essere prede facili del crimine
internazionale, che ha capito la scarsa serietà del paese italico”.
Ma così siamo il bancomat dei
terroristi, scrive Francesco Maria De Vigo su “Il Giornale”. Sono libere. Sono
vive. È una buona notizia e, ora più che mai, ne abbiamo bisogno. Ma ci sono
tanti “ma”. E non si possono tacere. Il primo è che se loro stanno bene, in
compenso, il nostro stato non gode di altrettanta buona salute. Il governo
infatti avrebbe pagato dodici milioni di euro di riscatto per Greta e Vanessa.
Un conto salatissimo in un Paese che, per legge, congela i beni dei parenti di
chi è stato sequestrato. Ma qui i parenti, si fa per dire, sono lo Stato, siamo
noi. Ed è noto che per lo Stato non valgono le leggi dello Stato. Bene, dunque
dobbiamo farci una domanda: è giusto pagare i terroristi? Perché è chiaro che se
noi – gli italiani, gli occidentali -, paghiamo il riscatto per ogni nostro
concittadino, ogni nostro concittadino – italiano, occidentale -, diventa un
salvadanaio deambulante per qualsiasi tagliagola. Una slot machine facile da
sbancare. Ma così ci trasformiamo nel bancomat dei terroristi. Ed è abbastanza
stupido. Dodici milioni sono tanti, abbastanza per armare un plotone di
jihadisti (nel deep web con 1500 euro si compra un kalashnikov). Non possiamo
dare la paghetta, e che paghetta!, a chi ci vuole sbudellare. Parliamoci chiaro:
possiamo farci carico di tutti gli sprovveduti che pensano di farsi una “vacanza
intelligente” in una zona di guerra, di fare il buon samaritano a spese nostre?
No. Non lo dico solamente perché le due ragazze pensavano che Assad fosse il
babau e i suoi nemici dei chierichetti vessilliferi della libertà più specchiata
(questo lo pensava – erroneamente o con complicità – anche buona parte della
stampa internazionale). Lo dico perché lo Stato italiano non può fare da badante
a qualunque suo cittadino, che si tratti del più stupido o del più intelligente,
si cacci nei guai nell’ultimo pertugio del mondo. Specialmente in un periodo in
cui non riesce a garantire la minima sussistenza anche a chi se ne sta
comodamente seduto sul divano di casa sua. Ma avanza un’altra domanda: perché lo
Stato che non ha trattato (giustamente) con le Br tratta con gli jihadisti?
Trattare significa arrendersi. E in questo momento è l’ultima cosa da fare.
L’Italia finanzia il
terrorismo internazionale a forza di riscatti, scrive Giusi Brega su “L’Ultima
Ribattuta”. Il nostro Governo ha l’abitudine di pagare i riscatti chiesti dai
terroristi per restituirci i nostri connazionali rapiti. In questo modo
contribuisce a finanziare le organizzazioni eversive internazionali come l’Isis
e innesca un circolo vizioso. In queste ore stanno avendo luogo le trattative
per il rilascio di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti italiane
rapite in Siria e apparse, il 31 dicembre, in un video postato su YouTube nel
quale le ragazze supplicano il nostro governo di riportarle a casa prima che
vengano uccise. Le fonti non escludono che il video sia stato girato per
dare alle autorità italiane la prova in vita delle due ragazze e che
successivamente è stato reso pubblico dai rapitori per «alzare il prezzo del
riscatto». Riscatto che l’Italia è sicuramente pronta a pagare visto che,
ogniqualvolta il nostro Governo si ritrovi a trattare con il terrorismo
internazionale per la liberazione degli ostaggi, finisce sempre con l’aprire il
portafogli: i prigionieri tornano a casa e, anche se le Istituzioni si guardano
bene dal confermarlo, è risaputo che dietro alla liberazione c’è stato il
pagamento di un riscatto che va a confluire dritto dritto nelle tasche delle
organizzazioni eversive: un giro di affari che a livello internazionale è
stimato in 125 milioni di dollari (dal 2008 ad oggi) a cui l’Italia contribuisce
in maniera considerevole. Fare i terroristi costa. Il business degli ostaggi
rende parecchio. Ed è un guadagno facile. Soprattutto se si ha a che fare con un
Paese come l’Italia sempre pronta a pagare quanto chiesto. Fonti di stampa
sostengono, infatti, che dal 2004 ad oggi il nostro Paese abbia pagato
complessivamente 61 milioni di euro per 14 ostaggi catturati dai
terroristi operativi nelle zone a rischio del mondo. Qualche esempio: per
liberare lo scorso maggio il cooperante italo-svizzero Federico Motka, il nostro
governo ha versato nelle casse degli jihadisti qualcosa come 6 milioni di euro.
Anche per il rilascio del giornalista Domenico Quirico (sequestrato in Siria il
9 aprile 2013 e rilasciato l’8 settembre) sembra sia stato pagato un riscatto di
oltre 4 milioni di dollari. Ricordate Giuliana Sgrena? La giornalista del
Manifesto fu rapita nel febbraio del 2004 in Iraq e liberata un mese dopo grazie
al sacrificio del funzionario del Sismi Nicola Calipari e a fronte del pagamento
di 6 milioni di dollari. E le due Simone? Simona Pari e Simona Torretta furono
rilasciate nel settembre 2004 dopo aver fatto pagare un riscatto di 11 milioni
di dollari. E poi Marco Vallisa (il tecnico italiano rapito in Libia nel luglio
scorso) per il quale sembra sia stato pagato un riscatto di 4 milioni di
dollari. I nostri governi dal 2004 ad oggi si sono guadagnati la fama di
“pagatori di riscatti” elargendo milioni di euro di denaro pubblico finanziando
così la follia omicida di organizzazioni come l’Isis pronte a usare il denaro
per uccidere e torturare, mettendo a repentaglio la sicurezza e la democrazia
mondiale. Come se ciò non bastasse, questo atteggiamento mette a repentaglio
l’incolumità dei nostri connazionali all’estero trasformandoli in “merce
preziosa”. Per fare in modo che i sequestri non siano più considerati una
risorsa di finanziamento e rompere questo circolo vizioso basterebbe
applicare le norme internazionali in vigore che proibiscono di pagare riscatti
ai terroristi come stabilito da una risoluzione delle Nazioni Unite (approvata
dopo l’11 settembre 2001) e da un accordo sottoscritto dai Paesi del G8. D’altra
parte se il sequestro avviene in Italia, la magistratura blocca i beni del
sequestrato. Non si capisce perché se il sequestro avviene all’estero si finisca
sempre col pagare un riscatto milionario (con i soldi dell’erario, cioè i
nostri).
Vanessa e Greta: I commenti di
Magdi Allam e Adriano Sofri, scrive Niccolò Inches su “Melty”. Il video
messaggio di Vanessa e Greta, detenute in Siria dal gruppo jihadista Al Nusra,
ha scatenato il dibattito sull'opportunità dell'iniziativa umanitaria delle due
attiviste. Il punto di vista di Adriano Sofri e Magdi Cristiano Allam. La
pubblicazione del video messaggio di Vanessa e Greta, le due attiviste
umanitarie scomparse nel luglio scorso mentre si trovavano in Siria, ha
confermato l'ipotesi del rapimento. Le due ragazze sarebbero nelle mani del
gruppo jihadista Al Nusra, cellula legata ad Al Qaeda, attiva nel paese arabo in
cui è in corso una guerra civile tra i corpi militari fedeli al regime di Bachar
Al Assad e i ribelli, tra i quali non figurano solo forze democratiche ma anche
numerosi nuclei del fondamentalismo islamico. In Siria era detenuto anche il
giornalista de “La Stampa” Domenico Quirico, liberato nel 2013 quando soffiava
il vento di una “guerra lampo” pensata dagli Stati Uniti di Barack Obama (poi
mai realizzata per via della resistenza della Russia di Putin e della Cina). Su
Quirico, però, non si scatenò il vespaio di commenti offensivi e sessisti
apparsi sul web per attaccare la presunta irresponsabilità delle due giovani
cooperanti. Ogni conflitto porta con sé il rischio di sequestri e violenze nei
confronti di cittadini stranieri: il caso di Vanessa e Greta si accoda a quanto
successo in passato a Giuliana Sgrena, le due Simone, Daniele Mastrogiacomo e
altri in Iraq. Come puntualmente si verifica ad ogni notizia di rapimento,
inoltre, scoppia dunque la polemica tra i partigiani dell'intransigenza, quelli
che il racconto della guerra o un aiuto umanitario non possono valere il prezzo
di un riscatto (specialmente se dovesse servire a riempire le casse dei
terroristi), e coloro che tessono le lodi di una – pur rischiosa – iniziativa,
in nome di valori universali e cosmopoliti. Sul rapimento di Vanessa e Greta
(ecco chi sono le due cooperanti) sono intervenuti due illustri rappresentanti
di entrambi i fronti, all'interno di due editoriali: la critica di Magdi
Cristiano Allam, autore di “Non perdiamo la testa” (pamphlet di denuncia della
presunta cultura violenta veicolata dall'Islam) e firma del Giornale da una
parte, dall'altra l'ossequio dell'ex esponente di Lotta Continua – condannato
per l'omicidio Calabresi - Adriano Sofri, oggi penna di Repubblica. Ne
riportiamo alcuni passaggi.
Magdi Allam: i riscatti
finanziano i terroristi. “Le due ragazze erano simpatizzanti degli stessi gruppi
islamici che le avrebberosequestrate. In un cartello in arabo con cui si sono
fatte immortalare nel corso di una manifestazione svoltasi in Italia si legge:
«Agli eroi della Brigata dei Martiri - Grazie dell'ospitalità - Se Allah vorrà
presto Idlab sarà liberata - E noi ci torneremo». La «Brigata dei Martiri», in
arabo Liwa Shuadha, è un gruppo di terroristi islamici il cui capo, Jamal
Maarouf, ha ammesso di collaborare con Al Qaida. Si stima che dal 2004 l'Italia
abbia pagato complessivamente 61 milioni di euro per liberare Simona Pari e
Simonetta Torretta, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio,
Giuliana Sgrena, Clementina Cantoni, Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria
Sandra Mariani, Sergio Cicala e Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico
Quirico (…) Il governo vieti alle nostre associazioni civili di operare nelle
zone dove imperversano il terrorismo islamico o i conflitti armati. È ora di
dire basta alle sedicenti associazioni «senza scopo di lucro» che lucrano con il
denaro degli italiani, soldi pubblici e privati, per sostenere la causa dei
nemici della nostra civiltà. E poi ci tocca pure pagare ingenti riscatti quando
vengono sequestrati o si fanno sequestrare. Basta!”
Adriano Sofri difende le due
cooperanti. “Furono istruttive certe reazioni al sequestro. Con tanti auguri di
uscirne sane e salve, per carità, ma con un abietto versamento di insulti, a
loro e famiglie. Stiano a casa a giocare con le bambole, sono andate a farsi il
selfie coi terroristi, non ci si sogni di riscattarle con “i nostri soldi”,
paghino gli irresponsabili genitori… Un genitore si sentì costretto a spiegare
che sua figlia era maggiorenne, che lui l’aveva dissuasa, che non poteva
legarla… Io mi sforzerei di dissuadere una ragazza che, per amore dei bambini
senza cibo senza medicine e senza amore, volesse partire per la Siria. Non
potrei legarla, e soprattutto non potrei fare a meno di ammirarla (...) Greta e
Vanessa [sono] donne, e giovani: troppo giovani e troppo donne, verrebbe da
dire, in questa euforica infantilizzazione anagrafica universale. Avevano alle
spalle un’esperienza da invidiare di conoscenza e aiuto al proprio prossimo in
Africa e in Asia, e della stessa Siria erano veterane. Questa volta andavano ad
Aleppo col proposito preciso della riparazione di tre pozzi, per gente privata
anche dell’acqua (…) I ritratti che ne fanno delle creaturine in balia di slogan
e smancerie sono contraddetti da una loro mania contabile scrupolosa ed
efficiente, e dall’idea che la rivoluzione sia l’autorganizzazione di ospedali,
scuole, mense… (…) Gli insulti contro Vanessa e Greta avevano argomenti come il
tifo per Bashar al Assad e il precetto di farsi gli affari propri: farsi gli
affari di Bashar al Assad, insomma (…) perché riscattare vite a pagamento?
Perché sì, perché la minaccia che incombe su una persona, la mano già alzata sul
suo capo –era vero per Aldo Moro- viene prima della preoccupazione sul vantaggio
che il carnefice trarrà dall’incasso di oggi”.
Vanessa Marzullo e Greta
Ramelli: vittime del cuore o “incoscienti da salvare”? Scrive “Blitz
Quotidiano”. Il sequestro ad Aleppo di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli ha
provocato sul Giornale un titolo di prima pagina un po’ fuori falsariga
nazionale: “Due italiane rapite in Siria. Altre incoscienti da salvare”. È il
titolo a un articolo di Luciano Gulli, sulla stessa linea, che si stacca dal
tono generale degli articoli sul rapimento ad Aleppo di Vanessa Marzullo e Greta
Ramelli che ha suscitato un turbine di solidarietà e notizie, mentre certamente
i servizi segreti italiani hanno iniziato a prelevare, dai conti segreti e fuori
della giurisdizione del Fisco, i milioni di euro che serviranno per pagare il
loro riscatto. Proprio pochi giorni fa il New York Times aveva messo in fila
tutti i rapimenti opera di gruppi terroristici, indicando tutti i paesi che
hanno alimentato le casse di Al Qaeda con i riscatti per liberare connazionali.
La cosa sorprendente è che non solo L’Italia paga, ma anche Francia, Austria,
Svizzera e la rigorosissima Germania. Vicende angosciose come i rapimenti si
risolvono in bagni di lacrime collettive e pagamenti occulti, exploit come ai
tempi di Maurizio Scelli, e poi tutti tornano ai loro problemi di tutti i
giorni, in attesa del prossimo. Luciano Gulli invece va giù piatto e definisce
Vanessa Marzullo e Greta Ramelli “due incoscienti da salvare sull’orlo del
baratro” scrivendo così: “Solidarietà, certo, mancherebbe. Come si fa a non
essere vicini, a non sperare il meglio per due ragazze che invece di andarsene
al mare con gli amici decidono di passare l’estate in Siria, tra le macerie,
sotto le bombe, ogni giorno col cuore in gola per dare una mano ai bambini di
quel martoriato Paese? Meno bello – e questo è l’aspetto che varrà la pena
sottolineare, quando tutto sarà finito – è gettare oltre l’ostacolo anche i
soldi dei contribuenti per pagare riscatti milionari o imbastire complesse,
rischiose, talvolta mortali operazioni di recupero di certe signorine che oltre
alla loro vita non esitano a mettere a repentaglio anche quella degli altri.
Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, sparite nel nulla sei giorni fa ad Aleppo,
sequestrate da una banda di tagliagole torneranno, ne siamo certi. Ma quando
saranno di nuovo tra noi qualcuno dovrà spiegar loro che la guerra, le bombe,
quei territori «comanche» dove morire è più facile che vivere sono una cosa
troppo seria, troppo crudele per due ragazzine. Che sognare di andare in
battaglia «per dare una mano», per «testimoniare», come troppe volte abbiamo
visto fare a tante anime belle, dalla Bosnia all’Irak di Saddam, è una cosa che
si può sognare benissimo tra i piccioni di piazza del Duomo, un selfie dopo
l’altro, abbracciate strette strette, quando il rischio maggiore è di beccarsi
un «regalo» dai pennuti. Ma senza i nervi, la preparazione, il carattere,
l’esperienza che ti dice cosa fare e cosa non fare; senza quel rude pragmatismo
che ti viene dopo aver battuto i marciapiedi di tante guerre è meglio stare a
casa. Non ci si improvvisa reporter di guerra e non ci si improvvisa neppure
cooperanti senza aver imparato come si fa, come ci si comporta, come è fatto il
sorriso che ti salverà la vita quando ti troverai di fronte a un mascalzone che
vuole i tuoi soldi e le tue scarpe, o al ragazzino che sbuca dall’angolo di una
casa, e per rabbia, per vendetta, o anche solo per paura, lascia partire una
raffica di mitra che può spedirti all’altro mondo in un amen. Sono le stesse
cose che scrivemmo nel settembre di dieci anni fa, quando a Bagdad vennero
liberate Simona Torretta e Simona Pari. Le «due Simone» uscirono incolumi da
un’avventura durata tre settimane. Non così andò l’anno dopo, quando sempre a
Bagdad rapirono la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Per liberarla,
quella volta, morì l’agente del Sismi Nicola Calipari. Che dire di più, in
queste ore? Niente. Fermiamoci qui. Intrecciamo le dita, sperando di rivedere
presto queste altre «Simone»”.
Vanessa e Greta a Roma:
l'incubo è finito, scrive Giulia Vola su “Magazine delle donne”. Greta Ramelli e
Vanessa Marzullo, le volontarie rapite in Siria a luglio sono tornate in
Italia questa mattina. Ad accoglierle il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.
A far discutere il maxi riscatto che l'Italia avrebbe pagato per la loro
liberazione. Libere. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le volontarie ventenni
rapite in Siria lo scorso luglio sono tornate in Italia questa mattina all'alba
accolte all'aeroporto di Ciampino dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni: è
festa grande a Gavirate (Varese), il paese di Greta, e a Brembate (Bergamo),
quello di Vanessa. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di giovedì con un
tweet di Palazzo Chigi, seguito dalla conferma - alla Camera - del ministro per
le Riforme Maria Elena Boschi. Nel frattempo il premier Matteo Renzi aveva
chiamato la famiglia di Greta per anticipare quella notizia che ha cambiato la
vita di due famiglie che per mesi hanno temuto il peggio ma non hanno mai perso
la fiducia. Nemmeno quando, lo scorso 31 dicembre, erano apparse in quel video
diffuso dai rapitori in supplicavano "il nostro governo di riportarci a casa".
Ieri la richiesta è stata esaudita e nei due piccoli centri lombardi le campane
hanno suonato a festa spezzando quell'attesa straziante durata sei mesi, da
quando le tracce delle due ragazze si erano perse ad Abizmu, poco lontano da
Aleppo, nel Nord della Siria. Eppure, mentre in Lombardia si festeggia, a Roma
c’è (già) chi fa polemica. Soprattutto dopo che la tv di Dubai al Aan - ripresa
anche dal Guardian - ha parlato di 10 milioni di dollari, poco più di 12 milioni
di euro versati nelle tasche dei rapitori. Il segretario della Lega Nord Matteo
Salvini tuona contro l’eventualità che si sia pagato un riscatto: "Se veramente
per liberare le due amiche dei siriani il Governo avesse pagato 12 milioni
sarebbe uno schifo" ha commentato senza mezzi termini seguito a ruota dal
compagno di partito Roberto Calderoli e dalla forzista Maria Stella Gelmini,
tutti accomunati dalla stessa domanda: è legittimo pagare sapendo che il denaro
finanzierà gruppi terroristi? Nella polemica è entrato anche Roberto Saviano. Lo
scrittore anticamorra, che vive una vita da sequestrato in casa, ha affidato a
Facebook una lettera sfogo: “Care Greta e Vanessa, sono felice per la vostra
liberazione, e come me lo sono in tanti. Ma vi aspetterà anche un’Italia odiosa,
che vi considera ragazzine sprovvedute che invece di starsene a casa sono andate
a giocare in Siria. Diranno che sono stati spesi molti soldi, molto più del
valore della vostra vita". Secondo Saviano quelle dichiarazioni sono frutto del
"senso di colpa per non avere coraggio, dell’insofferenza dell’incapace che
fermo al palo cerca di mitigare la propria mediocrità latrando contro chiunque
agisca". D'altra parte, anche di Saviano, costretto a uno strettissimo regime di
protezione che annulla la sua libertà personale, molti hanno detto che se l’è
andata a cercare sfidando la camorra con il suo lavoro. "Spero saprete sottrarvi
a questo veleno - scrive alle due volontarie -. Un’altra parte di questa Italia
è convinta che il vostro sia stato un atto di coraggio e di umanità, e che
nessuno possa essere considerato causa del proprio rapimento”. I commenti al
post di Saviano sono il ritratto di un paese in difficoltà con il concetto di
eroe e di coraggio: madri e padri trepidanti che condividono la gioia delle
famiglie si mescolano a insulti contro le due ragazze e recriminazioni sul
presunto riscatto. Uno scenario che si ripete: dopo Je suis Charlie, ora è la
volta di Je suis Greta e Vanessa, identità che sui Social, in questi momenti, va
per la maggiore. Il governo italiano naturalmente nega di aver pagato (ma non
potrebbe fare diversamente). Resta il fatto che la La Jabhat al-Nusra, "il
fronte di sostegno per il popolo siriano" vicino ad al Qaeda che aveva in
custodia Greta e Vanessa e gli altri gruppi terroristici più o meno affiliati
incassano, secondo il New York Times, circa 2 milioni di euro a ostaggio
liberato. Denaro versato "in gran parte dagli europei" sottolinea il quotidiano
del Paese che ha scelto la linea dura rifiutandosi di pagare. Ma oggi è il
giorno della felicità e delle prime dichiarazioni che le ragazze faranno in
Procura a Roma. Per le recriminazioni e le polemiche c'è tutto il tempo:
''Quando la vedrò le darò un grande abbraccio - ha commentato emozionato
Salvatore Marzullo, il papà di Vanessa -. Portiamola a casa e poi ci saranno
tante cose da dirle''.
15 gennaio 2015. Vanessa e
Greta liberate: si festeggia? No! Scrive Alberta Ferrari su “L’Espresso”. E’
ufficiale da poche ore: Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, giovanissime
cooperanti sequestrate a luglio in Siria da terroristi jihadisti sono state
liberate; stanotte giungeranno in volo dalla Turchia in Italia. Prima di sapere
il loro destino e ignorando volutamente la querelle sollevata da chi metteva in
discussione motivazioni e/o imprudenza delle delle ragazze, avevo stigmatizzato
l’inaudita violenza sessista che “la pancia” degli italiani riversava nei loro
confronti in rete, con modalità becere e inaccettabili indipendentemente dal
merito delle questioni. Come da previsioni e in linea con la politica estera
italiana (differente, per esempio, da quella degli USA) è ovvio che sia stato
pagato un riscatto, del quale iniziano a circolare cifre non confermate: 12
milioni di euro. E immediatamente, con le giovani non ancora a casa, persino tra
i commentatori più pacati oltre il 90% esprime aperto malumore. Qualcuno
premette che è un sollievo che siano state liberate, ma la maggior parte si
limita a commenti come questo: “un solo pensiero nella mente di tutti gli
italiani: E IO PAGOOOOOOOOOO”. Su facebook, cloaca massima di eiezioni senza
filtro cerebrale, il concetto comincia a prender forma con le tristemente note
modalità: invettiva, insulto, augurio di torture stupro morte etc. che rendono
impossibile ogni civile argomentazione. Facciamocene una ragione perché questo
background culturale si applica a tutte le donne: un caso apparentemente
lontanissimo come l’annuncio di Emma Bonino di avere un tumore al polmone è
stato gratuitamente accolto con analoga marea di triste commentario insultante e
sessista, in cui la malattia diventa l’arma con cui colpire e augurare ogni
male. Questo è il popolo che si riversa senza filtro sui social ed è bene
conoscere, non ignorare. Perché il fenomeno denuncia che il degrado della pancia
degli italiani sta arrivando alla barbarie e che le donne sono tipicamente
oggetto delle più violente invettive. Nessuno stupore se nel nostro Paese i
femminicidi non accennano a diminuire. Chi poi politicamente a questa “pancia”
fa facile riferimento titillandone i riflessi pavloviani, ricordi che le masse
strumentalizzate sono pericolose e volubili: si innamorano dell’uomo forte,
pronti a rinnegarlo e sputare addosso al suo cadavere quando cambia il vento.
Accusata personalmente da un commentatore di “becero buonismo” per il fatto che
additavo la barbarie degli insulti alle ragazze senza addentrarmi in giudizi sul
loro comportamento, oggi che sono in salvo mi permetto di esprimere anche
riflessioni nel merito. Purchè rimanga ben chiaro che invettive e insulti
rimangono condannabili in sè. Bene, Vanesssa e Greta: bentornate. Potrei essere
vostra madre e forse a 20 anni ero più fulminata di voi. Tuttavia vi prego:
appena scese dall’aeroporto non dite (come si è sentito in passato) “siamo
pronte a tornare”. Non andate a fare le eroine nei talk show. Magari invece,
riflettete con persone autorevoli, che si intendono di volontariato e di Paesi
in guerra e fate tesoro, magari autocritica, di questa esperienza a lieto fine.
Perché vedete, il problema dei milioni di euro di riscatto contiene sì tanta
ipocrisia (basterebbe rinunciare a una costosa arma bellica o recuperare denaro
da chi delinque o evitare gli sprechi che sono la vera piaga del nostro Paese),
ma non merita per questo indifferenza: è pur sempre denaro dei vostri
concittadini, che di questi tempi non se la passano troppo bene. Inoltre come
pensate che verrà usato? Le vostre vite salvate al prezzo di altre, quando
questo denaro diventerà altre armi (che sono arrivate e arrivano nonostante voi,
ridimensioniamo anche questa ricorrente e ipocrita colpevolizzazione). Io non
sono esperta del settore, quindi mi sono documentata attraverso contatti a me
molto vicini; persone esperte che ideologicamente avrebbero ogni motivo per
sostenere la vostra posizione. Il problema è che la vostra posizione non è
sostenibile. perché, come sostiene la collega Chiara Bonetti (un anno in
Mozambico, 6 mesi in Uganda, un anno in Tibet): nella scelta di andare
all’estero in qualità di membro onlus o ong governativa, è fondamentale evitare
personalismi e schieramenti. All’estero in veste ufficiale non sono ammesse
improvvisazioni: si va nel mondo a titolo non personale, bensì a rappresentare
il proprio Paese (che infatti si fa carico dei tuoi rischi), una civiltà e un
modo di lavorare. Nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di esporsi a pericoli
inaccettabili: proprio perché il prezzo del rischio non si paga di persona ma
coinvolge potenzialmente tutti coloro che svolgono un’attività anche
lontanamente simile, nonché i contribuenti del vostro Paese. All’estero esistono
regole molto diverse da quelle con cui si è cresciuti: è imperativo non
improvvisare. Ci vuole umiltà, cultura (tanta), una rete d’appoggio, esperienza.
Tutte cose che a 20 anni con una onlus fai-da-te (con un terzo individuo che si
è smarcato ed è rimasto a casa) sono ampiamente mancate. Ragazze, io
diversamente da altri non entro nel merito della vostra buona fede, della
nobiltà dei vostri obiettivi: non posso sapere. Ma l’avventatezza è analoga a
quella di sciatori fuoripista/scalatori imprudenti che si mettono nei guai dopo
aver contravvenuto a regole da bollino rosso o per semplice, sventata
inesperienza: possono provocare smottamenti che uccideranno altre persone,
oppure mettere a repentaglio la vita di chi deve soccorrerli in condizioni
estreme. Termino lasciandovi le riflessioni di due grandi uomini, Walter Bonatti
e Reinhold Messner, fini acrobati tra coraggio e paura: “Non esiste il coraggio
senza la paura – dice Bonatti – bisogna aver paura delle cose paurose, di ciò
che è sconosciuto, ma per combattere il terrore bisogna cercare di conoscere ciò
che fa paura. Bisogna costruire il coraggio e poi usarlo”. “La paura – dice
Messner – ti spiega bene il limite che non devi superare: fin qui va bene,
oltre… scendi. Come è successo a te, davanti alla parete del Pilier d’Angle”.
“Ho provato una paura spaventosa – confessa Bonatti – ed ero già molto esperto.
Quella notte sono arrivato con il mio compagno, Luigi Zampieri, sotto al Col de
la Fourche, a un’ora dall’attacco sono rimasto impietrito di fronte a quella
parete che con un gioco di riflessi lunari mi è apparsa una lavagna
levigatissima. L’unica cosa evidente che spiccava erano i grandi seracchi pronti
a caderti addosso. Ho avuto una paura folle e sono stato un bel po’ a pensare, a
chiedermi come fare. Fino a quando, saggiamente, ho concluso che era meglio
tornare a casa. E sono tornato a casa. Qualche mese dopo sono tornato, la
montagna non era più in condizioni così favorevoli, ma era favorevole il mio
spirito, ero pronto. L’abbiamo attaccata e l’abbiamo spuntata”. Buon rientro
ragazze, sono felice di riavervi a casa.
Le “stronzette di Aleppo” se
la sono cercata, scrive Alberta Ferrari. Vanessa Marzullo e Greta Ramelli sono
due giovanissime cooperanti italiane di 20 e 21 anni rapite in Siria a luglio
2014. Sulla loro presenza in una zona tanto pericolosa e in assenza di una
solida organizzazione alle spalle le polemiche sono state sempre accese, spesso
con toni grossolani e cinici (vedi “le stronzette di Aleppo” di Maurizio
Blondet). Il tema di fondo: “due incoscienti sprovvedute” ci mettono nei guai.
Linguaggio offensivo, squalificante e, stupore!, sessista: “con la guerra non si
scherza e da bambine è bene che non si giochi alle piccole umanitarie, ma con la
barbie”. Tra i commenti più soavi. Le due ragazze avevano fondato con il 47enne
Roberto Andervill il progetto Horryaty per raccogliere aiuti destinati alla
popolazione civile in Siria. Certo sprovvedute queste giovanissime entusiaste,
ma non improvvisate. Vanessa, di Brembate, studia mediazione linguistica e
culturale all’Università di Milano. Greta, di Besozzo, studentessa, è una
volontaria della Croce Rossa e ha già prestato attività di cooperazione in
Zambia e in India. Partono per la Siria a febbraio 2014 e vi tornano a luglio
attraversando il confine turco con il giornalista de “Il Foglio” Daniele
Ranieri. Tre giorni dopo vengono rapite ad Abizmu dopo essere state attirate
nella casa del “capo del Consiglio rivoluzionario” locale, mentre Ranieri riesce
a fuggire e a dare l’allarme. Per inciso, tocca notare un silenzio assordante –
diversamente dai commenti al vetriolo riservati alle ragazze – su questo
accompagnatore più che adulto che riesce a darsela a gambe. Nessuno che si
stracci le vesti: “incosciente, quella è guerra vera e hai pure coinvolto due
ragazze, ma stare a casa a giocare ai soldatini no? minimo meritavi il sequestro
pure tu”. Sull’identità dei rapitori si avvicendavo ipotesi: jihadisti
dell’Isis, gruppi criminali intenzionati a chiedere un riscatto, compravendita
delle ragazze. Capodanno ci sorprende con un importante aggiornamento. Un video
su youtube chiarisce che le giovani sono sequestrate dal gruppo jihadista
al-Nusra. Le ragazze sono state private del loro abbigliamento e vestono la
tunica nera abaya. Parla Greta Ramelli senza mai alzare lo sguardo
(“supplichiamo il nostro governo e i suoi mediatori di riportarci a casa prima
di Natale. Siamo in estremo pericolo e potremmo essere uccise”) mentre Vanessa
Marzullo espone un cartello che riporta la data del 17 dicembre 2014.
Personalmente, cercando di non cadere in trappole di superficiale buonismo,
ritengo che l’eccessivo rischio e le relative conseguenze che ora non possiamo
non fronteggiare, siano ragionevolmente da attribuire più alla responsabilità di
chi autorizza e deve controllare viaggi in Paesi sede di guerre da bollino rosso
che non all’entusiasmo giovanile dell’impegno fai-da-te. Mi ha turbato,
leggendola come segno di imbarbarimento, l’impressionante sequenza di commenti
intrisi di cinismo e grettezza che ho letto su Facebook, a commento della
notizia del video riportata da Ilfattoquotidiano.it. In base al giornale,
commentatori più “collocati a sinistra”, in teoria.
Riporto un campione di questi
commenti: del resto fortemente ripetitivi.
Gianni C. ALTRI EURI di chi fa
fatica buttati a PUTTANE…………
Fabrizio T. Riportarli a casa
in cambio di armi? ? Mai!! Così per colpa di queste 2 idiote ne muoiono 1000.
Gianni P. io penso che “quelli
che se la cercano” se la debbano poi sbrogliare.
Maria C. Se le tenessero.
Nessuna pietà per chi si caccia nei guai, pur sapendolo.
Fiorni R. Quelle son andate
per far carriera, vedi la nostra boldrinazza, vedi simona pari e dispari.
Giuseppe T. Che se le
tenessero!
Giulio S. Tenetevele.
Donatella N. Ah si?
Tenetevele.
Antonio M. Spero proprio di
non avere figli così stupidi.
Angelo M. Per queste due
nessuna pietà. ….all’inizio erano contente del sequestro ora che le scarpe gli
vanno strette chiedono aiuto. ….tempo scaduto adesso subite il velo e la
schiavitù di questo popolo musulmano.
Michele C. Ma fanculo stateve
a casa.
Leone B. La guerra nn è un
gioco per bambine in cerca di visibilità.
Lamberto C. SE NE STAVANO A
CASA LORO NN GLI SAREBBE SUCCESSO NULLA. Se la son cercata.
Bartolomeo A. …. due
incoscienti che non possono essere lasciate sole, due imbecilli che
da presuntuose epocali, hanno pensato che i loro bei visini, accompagnati dai
soliti buoni propositi terzomondialisti o giù di lì, potessero intenerire le
carogne in generale che si contendono la siria e non solo…
Enrico D. sono andate li per
supportare i tagliagole. se dovessero essere liberate dovrebbero essere
processate per aver appoggiato dei terroristi! luride scrofe!
Carlo F. adesso la bandiera
arcobaleno non la sventolano più ahahhahahhaahahhaaha.
Antonella R. Visto che non le
ha obbligate nessuno ad andare la !!! Sono solo cavoli loro !! A me non me ne
importa niente!!
Mino T. Credo che i buonisti,
che sono la vera metastasi di questo paese , dovrebbero dare il buon esempio e
partire per la Siria a loro spese (…) Per quanto mi riguarda hanno avuto ciò che
si meritano.
Graziella T. Prima i nostri
maro’, visto che sono andati per lavoro? Loro nonostante che gli si è detto di
NON ANDARE, loro sono andate …se la sono cercata.
….. qualche timida voce fuori
dal coro si trova ….
Roberto D. Per estendere il
concetto, molti hanno perfino contrastato il ritorno in italia del medico
italiano che curava l’ebola in africa. Il concetto è: “fai il medico in africa?
WOW sei mitico… cosa? ti sei ammalato e vuoi tornare qui e così ci infetti
tutti? Ma stai in africa, d’altronde…te la sei andata a cercare”. Ecco di questa
gente stiamo parlando.
Daniela C. Son state delle
sprovvedute ma vanno portate a casa.
Dominique B. Leggendo gran
parte delle risposte invece, mi chiedo chi siano le bestie, quelli che hanno
sequestrato le ragazze o quelli che commentano qui…
Emma R. Non ho mai letto tanta
cattiveria pressapochismo crudeltà cinismo etc etc nei commenti ad un solo post
!!!!! Complimenti a tutti.
Marianna L. Cercasi umanità
Concludo facendo mio il
commento al video di Marina Terragni: “Che queste ragazze possano tornare a casa
presto e levarsi quegli stracci dalla testa”.
“Menefreghismo assoluto per le
attiviste rapite in Siria” e I CARE, continua la Ferrari Poiché i commenti
violenti, odiosi e sessisti da me segnalati con stupore e raccapriccio due
giorni fa verso le due cooperanti Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite in
Siria si sono rivelati vero allarme di una deriva crescente, qualcuno ieri alle
13.00 ha avuto l’idea geniale di creare una pagina Facebook che raccogliesse il
turpe dileggio e le offese rivolte in questi giorni con sadico e ottuso
accanimento . A seguire uno de tanti post della pagina. In 24 ore 1250 like alla
pagina. Per darvi un’idea: io nella mia pagina professionale, che si occupa di
salute della donna e i particolare di tumore al seno, il più frequente nel sesso
femminile ad ogni età, non sono arrivata a 5000 like in oltre 2 anni. Il che
dimostra chiaramente il potere d’attrazione che l’invettiva sessista esercita su
gran parte di persone becere, quelli che girano sul social e si esprimono come
al bar, offrendo un affresco sociologico veramente degno d’attenzione e
preoccupazione. Sul mio post precedente, che segnalava la violenza brutale
montante contro le due ragazze ricercandone retroterra culturali e
contraddizioni (sugli adulti che le hanno aiutate / accompagnate, silenzio
totale), si è aperto con mio sollievo un nutrito dibattito. I commenti hanno
riguardato varie criticità della questione, compresa la scelta delle ragazze di
addentrarsi in una zona di guerra senza protezione e la loro presunta simpatia
per una fazione di combattenti (gli stessi peraltro che le avrebbero rapite),
tuttavia il confronto di punti di vista differenti si è svolto in modo civile,
contribuendo ad affrontare il problema con più strumenti conoscitivi. A chi
invoca il menefreghismo, che evoca il triste “me ne frego” passato alla storia
senza gloria né onore, contrappongo, fuori da un contesto religioso ma come
espressione basilare di umanità, l’invito di Sabrina Ancarola (che giustamente
non dimentica gli altri ostaggi in Siria) che ci ricorda il motto di don Milani:
I Care.
Le stronzette di Aleppo,
scrive Maurizio Blondet su “Il Punto di Prato”. Vanessa e Greta. Anni 20 e
21.Andate in Aleppo presso i ribelli anti-regime per un progetto umanitario.
Progetto che,a quanto è dato dedurre, consisteva in questo:farsi dei selfie e
postarli sui loro Facebook:su sfondi di manifestazioni anti-Assad, sempre
teneramente abbracciate (Inseparabili, lacrimano i giornali), forse per fare
intendere di essere un po’ lesbiche (è di moda), nella città da tre anni
devastato teatro di una guerra senza pietà e corsa da milizie di tagliagole. La
loro inutilità in un simile quadro è palese dalle loro foto, teneramente
abbracciate, con le loro tenere faccine di umanitarie svampite, convinte di
vivere dalla parte del bene in un mondo che si apre, angelicamente, grato e
lieto al loro passo di volontarie. Una superfluità che i giornali traducono
così: Le due ragazze avevano deciso di impegnarsi in prima persona per dare una
risposta concreta alle richieste di aiuto siriane. Vanessa è studentessa di
mediazione linguistica e culturale, Greta studentessa di scienze
infermieristiche: niente-popò-di-meno! Che fiori di qualifiche! Due studentesse
( m’hai detto un prospero!), che bussando a varie Onlus erano riuscite a far
finanziare il Progetto Horryaty, da loro fondato. Secondo una responsabile della
Onlus che ha sganciato i quattrini alle due angeliche, il loro progetto era
finalizzato ad acquistare kit di pronto soccorso e pacchi alimentari,da
distribuire al confine. Ostrèga, che progettone! Nella loro ultima
telefonata,chiedevano altri fondi. Pericolo per le loro faccine angeliche, o le
loro tenerissime vagine? No,erano sicure:avevano capito una volta per tutte che
i cattivi erano quelli di Assad,e loro stavano coi buoni,i ribelli. E i buoni
garantivano per loro. Si sentivano protette. Nell’ultima telefonata hanno detto
che avevano l’intenzione di restare lì. Un Paese serio le abbandonerebbe ai
buoni, visto che l’hanno voluto impicciandosi di una guerra non loro di cui non
capiscono niente, in un mondo che a loro sembra ben diviso tra buoni e cattivi.
Tutt’al più, candidarle al Premio Darwin (per inadatti alla lotta per la vita),
eventualmente alla memoria… Invece la Farnesina s’è sùbito attivata, il che
significa una cosa:a noi contribuenti toccherà pagare il riscatto che i loro
amici, tagliagole e criminali, ossia buoni, chiederanno. E siccome le sciagure
non vengono mai sole, queste due torneranno vegete, saranno ricevute al
Quirinale, i media verseranno fiumi di tenerezza, e pontificheranno da ogni
video su interventi umanitari, politiche di assistenza, Siria e buoni e cattivi
di cui hanno capito tutto una volta per tutte. Insomma, avremmo due altre
Boldrini.
La liberazione di Greta
Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti italiane rapite in Siria sei mesi
fa, ha innescato due reazioni contrapposte: sollievo e soddisfazione espresse
dalle istituzioni (lungo applauso in Parlamento dopo l'annuncio del ministro
Boschi in Aula), polemiche e livore da rappresentanti delle opposizioni a cui è
seguita una corsa all'emulazione sui social network, scrive “Ibtimes”. Non
poteva mancare il commento di Matteo Salvini: "La liberazione delle due ragazze
mi riempie di gioia ma l'eventuale pagamento di un riscatto che permetterebbe ai
terroristi islamici di uccidere ancora sarebbe una vergogna per l'Italia.
Presenteremo oggi stesso un'interrogazione al ministro degli Esteri per appurare
se sia stato pagato un solo euro per la liberazione delle due signorine". Ma la
palma dell'uscita più strumentale è del capogruppo di Forza Italia in
Emilia-Romagna, Galeazzo Bignami: "Le due ragazze amiche dei ribelli siriani e
sequestrate dai ribelli siriani sono state liberate immagino dietro pagamento di
lauta ricompensa ai ribelli siriani. Ora che sono libere penso si possa dire con
chiarezza che di chiaro in questa storia non c'è nulla. A partire dal fatto che
questo sequestro pare proprio un gran favore fatto dalle loro amiche ai ribelli.
Per inciso si liberano queste qui mentre chi porta la divisa e rappresenta lo
stato è ancora in arresto in india. Bello schifo". Altri esponenti di
centrodestra hanno puntato l'indice sulla questione riscatti. "Finita la fase
di legittima soddisfazione, serve che il ministro Boschi ci dica se è in grado
di escludere che da qualunque fonte di finanziamento pubblico sia stato un
centesimo per riportare le due ragazze a casa" le parole di Massimo Corsaro
(Fratelli d'Italia). "Doveroso chiederci se un eventuale riscatto pagato a dei
terroristi non sia una fonte di finanziamento per portare la morte in Europa e
altrove" sostiene anche l'ex ministro Maria Stella Gelmini. Le
strumentalizzazioni hanno dato il là a commenti simili anche degli utenti sui
social network. "Un riscatto milionario per due sceme", "sia chiaro a tutti che
sono ben altri i cervelli da far rientrare". Altri ancora imitano Bignami
nell'improprio parallelo con la vicenda dei marò. Oppure si leggono frasi sulla
guerra "non adatta" alle donne. O ancora che non è giusto pagare 12 milioni di
dollari (questa la presunta cifra pagata per liberare le due ragazze) per gente
che "va in vacanza". Legittimo discutere sugli effetti collaterali delle
possibile impreparazione delle cooperanti in zone di guerra, che si pongono in
una situazione di oggettivo pericolo e mettono in difficoltà il paese. Ma non in
quanto donne, né si può sostenere che le due fossero in Siria per prendere il
sole. Strumentale, improprio e spesso in malafede, ogni altro genere di discorso
o commento. Cosa c'entra la vicenda dei due marò, accusati di omicidio in India?
Suggeriscono forse di corrompere gli indiani allo scopo di ottenere la
liberazione di Latorre e Girone? Ipocrita anche la reazioni sul pagamento del
riscatto, non perché sul tema non ci sia da discutere ma perché viene da pensare
"da che pulpito parte la predica?". Il fatto che l'Italia (come Francia, Spagna
o Svizzera) abbiano pagato in passato riscatti milionari ai sequestratori è il
segreto di Pulcinella. Simona Pari e Simona Torretta (altre due cooperanti,
stavolta in Iraq, 2004), Giuliana Sgrena (2005), Clementina Cantoni (2005),
Rossella Urru (2011) e Mariasandra Mariani (2011) sono tutti sequestri che si
sono probabilmente conclusi con il pagamento di un riscatto (ad Al-Qaeda o altre
organizzazioni legate al fondamentalismo). Chi governava in quegli anni? Quel
centrodestra che oggi attacca a testa bassa.
Ostaggi italiani, non sempre è
finita bene, scrive “La Voce D’Italia”. Il primo rapimento recente di italiani
nel mondo a lasciare il segno nella memoria collettiva è del 2004, in Iraq.
Vengono sequestrati a Baghdad 5 contractor, Fabrizio Quattrocchi, Umberto
Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Quattrocchi viene ucciso, gli
altri liberati. Indimenticabile il video in cui la vittima dice ai carnefici:
“vi faccio vedere come muore un italiano”. Lo stesso anno sempre in Iraq vengono
rapiti il freelance Enzo Baldoni, ucciso poco dopo, e le due cooperanti Simona
Torretta e Simona Pari, liberate dopo 19 giorni. Nel 2005 tocca alla giornalista
del Manifesto Giuliana Sgrena. Subito dopo la sua liberazione, un militare
americano uccide per sbaglio il funzionario del Sismi Nicola Calipari che era
andato a prenderla. Nel 2007 in Afghanistan viene rapito dai talebani il
giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, poi liberato. In Mali nel 2009
Al Qaida rapisce due coniugi italiani, Sergio Cicala e Philomene Kabouré.
Vengono liberati l’anno dopo. L’inviato della Stampa Domenico Quirico viene
rapito due volte: la prima volta nel 2011 in Libia per due giorni (con i
colleghi Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, entrambi del Corriere della
Sera, e Claudio Monici di Avvenire); la seconda volta nel 2013 in Siria per
cinque mesi. I pirati somali nel 2011 catturano due navi mercantili italiane, la
Savina Caylyn, con 5 italiani a bordo, e la Rosalia D’Amato, con 6 italiani. Gli
ostaggi vengono liberati insieme alle unità lo stesso anno, dopo mesi di
prigionia. Nel 2011 nel Darfur in Sudan viene catturato dai ribelli locali il
cooperante di Emergency Francesco Azzarà, liberato dopo 124 giorni. Lo stesso
anno gli shabaab somali catturano al largo della Tanzania l’italo-sudafricano
Bruno Pellizzari, mentre si trova sulla sua barca a vela con la fidanzata
sudafricana. Viene liberato dopo un anno e mezzo con un blitz dell’esercito
somalo. In Algeria nel 2011 i terroristi islamici sequestrano la turista Sandra
Mariani e la cooperante Rossella Urru. Entrambe vengono liberate nel 2012. In
quello stesso anno finisce invece tragicamente il rapimento in Nigeria
dell’ingegnere Franco Lamolinara, sequestrato dai jihadisti nel 2011: l’italiano
viene ucciso dai sequestratori durante un blitz delle forze speciali di Londra,
che volevano liberare un ostaggio britannico tenuto con lui. Nessuna notizia
dopo oltre tre anni del cooperante Giovanni Lo Porto, sequestrato in Pakistan
nel 2012 mentre lavorava per una ong tedesca, né del gesuita padre Paolo
Dall’Oglio. Quest’ultimo scompare in Siria nel 2013, mentre cerca di mediare a
Raqqa per la liberazione di un gruppo di ostaggi. Voci contrastanti lo danno
prima per morto, poi prigioniero dell’Isis. Nel 2014 in Libia vengono rapiti due
tecnici italiani, in due diversi episodi: l’emiliano Marco Vallisa e il veneto
Gianluca Salviato, entrambi liberati dopo diversi mesi.
Greta e Vanessa a casa,
polemiche sul riscatto: «Pagati 10 milioni di dollari», scrive “Il
Messaggero”. È stata la tv di Dubai al Aan a ipotizzare che possa essere stato
pagato un riscatto di 12 milioni di dollari (poco più di 10 milioni di euro) ai
qaedisti anti-Assad del Fronte al Nusra per il rilascio di Greta Ramelli e
Vanessa Marzullo, le due giovani italiane rapite in Siria nel luglio scorso e
liberate giovedì. La voce, denunciata in Italia dal leader della Lega Matteo
Salvini, è ripresa anche dal Guardian online, secondo cui si tratta di
«un'informazione non confermata». «Se veramente per liberare le due amiche dei
siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno
schifo!», scrive in un tweet Salvini. Il governo italiano, come d'uso, nega di
avere pagato un riscatto e incassa intanto l'ennesimo successo sul fronte della
liberazione di ostaggi (sono stati oltre una dozzina negli ultimi 10 anni gli
italiani sequestrati all'estero). A dare consistenza alle voci sul pagamento
tuttavia in questo caso c'è anche un tweet di un account ritenuto vicino ai
ribelli siriani anti-Assad in cui si parla di un "riscatto di 12 milioni di
dollari” per la liberazione delle due italiane. La Jabhat al-Nusra, «il fronte
di sostegno per il popolo siriano», è cresciuto esponenzialmente grazie alle
vittorie sul campo ma anche a una incredibile disponibilità di armi e fondi per
combattere contro le forze del presidente siriano Bashar al Assad. La sua fonte
principale di finanziamento, oltre alle generose donazioni che arrivano
dall'estero, è proprio quello che arriva dai riscatti: il New York Times ha
stimato che al Qaida e i gruppi affiliati abbiano incassato oltre 125 milioni di
dollari negli ultimi 5 anni, la massima parte versati «dagli europei». Il Fronte
è stato fondato alla fine del 2011, nel pieno della rivolta contro il governo
siriano, quando l'allora emiro di al Qaida in Iraq, e ora leader dell'Isis, Abu
Bakr al-Baghdadi, inviò i primi combattenti in Siria. Considerato "meno
sanguinario" del ramo iracheno di al Qaida, il Fronte si è attribuito diversi
attacchi anche contro i civili: nei primi tre mesi del 2012 si rende
protagonista di diversi attentati, alcuni kamikaze, a Damasco e Aleppo contro le
forze governative siriane, decine i morti. Nel 2013 Nusra finisce al centro di
quello che evolverà in scontro violento tra Baghdadi e Ayman al Zawahri: il
califfo dichiara che al Nusra è parte di al Qaida in Iraq nella nuova formazione
Isis. Ma a giugno il leader di al Qaida lo smentisce. L'ostilità tra Nusra e
Isis sfocia in aperti combattimenti che secondo alcune fonti lasciano sul campo
3.000 uccisi tra i jihadisti dei due fronti. Alla fine dell'anno Nusra rapisce
13 monache da un monastero cristiano che verranno rilasciate nel marzo del 2014.
Pochi mesi dopo, il 27 agosto, mentre l'Isis guadagna le prime pagine per la
barbara esecuzione di James Foley, Nusra in controtendenza libera lo scrittore
americano Peter Theo Curtis, rapito due anni prima. Il Qatar gioca un ruolo di
primo piano nelle trattative per il rilascio. Alla famiglia era stato chiesto un
riscatto di 3 milioni di dollari «cresciuti fino a 25». Il giorno dopo la
liberazione dell'americano, il 28, il Fronte gruppo avanza in Golan e cattura 45
peacekeeper dell'Onu, che vengono liberati l'11 settembre. L'ultima stima dei
think tank Usa è che il Fronte possa contare su oltre 6.000 combattenti ben
addestrati, dislocati soprattutto nella regione di Idlib. Nelle zone controllate
da Nusra vige la Sharia e sono state introdotte le corti islamiche.
Due video «cifrati» in 15
giorni. Così i rapitori hanno alzato il prezzo. I ribelli: «Pagati 12 milioni di
dollari». La banda di terroristi non è legata all’Isis. Le stragi di Parigi
usate per alzare la posta. La cifra diffusa sembra comunque esagerata, scrive
Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Lo scambio sarebbe avvenuto tra
domenica e lunedì, dopo l’arrivo di un video che forniva la nuova prova in vita
delle due ragazze rimaste prigioniere in Siria quasi sei mesi. Un filmato per
sbloccare definitivamente la trattativa, con la consegna della contropartita ai
sequestratori. Sembra esagerata la cifra di dodici milioni di dollari indicata
dai ribelli al regime di Assad, ma un riscatto è stato certamente pagato, forse
la metà. E tanto basta a scatenare la polemica, alimentata da chi sottolinea
come il versamento sarebbe avvenuto proprio nei giorni degli attentati a Parigi.
È l’ultimo capitolo di una vicenda a fasi alterne, con momenti di grande
preoccupazione, proprio come accaduto dopo la strage di Charlie Hebdo e del
supermercato kosher, quando i mediatori avrebbero tentato di alzare
ulteriormente la posta. Saranno Greta Ramelli e Vanessa Marzullo a fornire ai
magistrati i dettagli della lunga prigionia, compreso il numero delle case in
cui sono state tenute. Ieri sera, dopo essere arrivate in un luogo sicuro -
probabilmente in Turchia - e prima di essere imbarcate sull’aereo per l’Italia,
sono state sottoposte al «debriefing» da parte degli uomini dell’ intelligence ,
come prevede la procedura che mira a ottenere notizie preziose sul gruppo che le
ha catturate il 31 luglio scorso e su quelli che le hanno poi gestite nei mesi
seguenti. Attivare i primi contatti per il negoziato non è stato semplice, anche
se si è avuta presto la certezza che a rapirle era stata una banda di criminali,
sia pur islamici, e non i jihadisti dell’Isis. A metà agosto, quando il Guardian
ha rilanciato l’ipotesi che fossero tra gli ostaggi internazionali del Califfo
Abu Bakr al-Baghdadi, i mediatori italiani si sono affrettati a smentire proprio
nel timore che la trattativa potesse fermarsi. Circa un mese dopo è arrivata la
prima prova per dimostrare che le ragazze stavano bene. E da quel momento è
partita la trattativa degli 007, coordinata da Farnesina e Palazzo Chigi.
Secondo le notizie iniziali a organizzare il sequestro è il «Free Syrian Army»,
l’esercito di liberazione della Siria. Ma la gestione delle prigioniere avrebbe
avuto fasi alterne, con svariati cambi di «covo» e nell’ultima fase ci sarebbe
stata un’interferenza politica di «Jabat al-Nusra», gruppo della galassia di Al
Qaeda che avrebbe preteso un riconoscimento del proprio ruolo da far valere
soprattutto rispetto alle altre fazioni e contro l’Isis. Non a caso, poco dopo
la conferma dell’avvenuto rilascio delle due giovani, un uomo che dice di
chiamarsi Muahhed al Khilafa e si firma sulla piattaforma Twitter con l’hashtag
dell’Isis posta un messaggio per attaccare «questi cani del fronte al-Nusra che
rilasciano le donne crociate italiane e uccidono i simpatizzanti dello Stato
Islamico». Del resto è proprio la situazione complessa della Siria ad alimentare
sin da subito la sensazione che il sequestro non possa avere tempi brevi. E
infatti la «rete» attivata per dialogare con i sequestratori ha a che fare con
diversi interlocutori, non tutti affidabili. Con il trascorrere del tempo le
richieste diventano sempre più alte, viene accreditata la possibilità che i
soldi non siano sufficienti per chiudere la partita, che possa essere necessario
concedere anche altro. A novembre si sparge la voce che una delle due ragazze ha
problemi di salute, si parla di un’infezione e della necessità che le vengano
dati farmaci non facilmente reperibili in una zona così segnata dalla guerra.
Qualche giorno dopo arrivano invece buone notizie, un emissario assicura che
Greta e Vanessa sono in una casa gestita esclusivamente da donne. Informazioni
controverse che evidentemente servono a far salire la tensione e dunque il
valore della contropartita per la liberazione. A fine novembre c’è il momento
più complicato. I rapitori cambiano infatti uno dei mediatori facendo sapere di
non ritenerlo più «attendibile». Si cerca un canale alternativo e alla fine si
riesce a riattivare il contatto, anche se in scena compare «Jabat al-Nusra» e la
trattativa assume una connotazione più politica. La dimostrazione arriva quando
si sollecita un’altra prova in vita di Greta e Vanessa e il 31 dicembre compare
su YouTube il video che le mostra vestite di nero, mentre chiedono aiuto e
dicono di essere in pericolo. È la mossa che mira ad alzare il prezzo rispetto
ai due milioni di dollari di cui si era parlato all’inizio. Quel filmato serve a
chiedere di più, ma pure a lanciare il segnale che la trattativa può ormai
entrare nella fase finale. Anche perché contiene una serie di messaggi occulti
che soltanto chi sta negoziando può comprendere, come il foglietto con la data
«17-12-14 wednesday» che Vanessa tiene in mano mentre Greta legge il messaggio,
che sembra fornire indicazioni precise. Si rincorre la voce che entro qualche
giorno possa avvenire il rilascio. Ma poi c’è una nuova complicazione. Il 7
gennaio i terroristi entrano in azione a Parigi, quattro giorni dopo arriva un
nuovo video. Questa volta viaggia però su canali riservati. L’intenzione dei
sequestratori sembra quella di alzare ulteriormente la posta, la replica
dell’Italia è negativa. Si deve chiudere e bisogna farlo in fretta. L’
intelligence di Ankara fornisce copertura per il trasferimento oltre i confini
siriani delle due prigioniere. Ieri mattina gli 007 avvisano il governo: è
fatta, tornano a casa.
Greta e Vanessa, malate e
maltrattate nelle mani dei sequestratori, scrive “Libero Quotidiano”. Sono stati
mesi molto duri quelli trascorsi da prigioniere. Greta Ramelli e Vanessa
Marzullo ora sono finalmente libere, ma ciò che hanno dovuto subire durante il
sequestro le ha molto provate sia psicologicamente che fisicamente. A rivelarlo
sono gli 007 che hanno trovato fin dall'inizio della vicenda un canale di
mediazione e dunque un interlocutore che ha permesso ai nostri servizi di
"monitorare" costantemente le cooperanti per tutta la durata della trattativa.
Hanno vissuto momenti molto difficili, rivela al Messaggero chi ha seguito in
questi mesi la sorte di Greta e Vanessa. Una delle due è stata poco bene in
salute, ma le sono stati forniti i medicinali e gli antibiotici per curarsi.
Hanno subito soprusi, sorvegliate di continuo da uomini armati. L'intelligence
spiega che le due ragazze erano nelle mani di banditi comuni e che Jahbat Al
Nusra, il movimento vicino ad al Quaeda in Siria al quale era stato attribuito
erroneamente il sequestro, avrebbe solo fornito soprattutto copertura politica,
proprio perché quella parte di territorio a Nord della Siria è totalmente nelle
loro mani. A sequestrarle, in realtà, sarebbero stati membri del Jaish
al-Mujahideen, sigla che racchiude una decina di gruppi islamisti (alleati del
Free Syrian Army, l' esercito siriano libero), una forza armata che combatte
contro il governo di Bashar al-Assad. Poi sarebbero state "vendute" più volte,
senza mai finire, fortunatamente, nelle mani dell' Isis, né in territori
controllati da loro. Tutto quello che hanno passato resterà indelebile nella
loro mente e nel loro cuore, ma oggi è il momento della gioia. All'alba Greta e
Vanessa sono arrivate a Ciampino accolte dal ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni, che alle 13 riferirà sulla vicenda alla Camera. Poi sono state
condotte all’ospedale militare del Celio per gli opportuni controlli medici. Più
tardi saranno ascoltate in procura a Roma. Solo al termine della deposizione
potranno tornare finalmente nelle loro città che ieri, dopo mesi di tensione e
angoscia, alla notizia della loro liberazione sono esplose di gioia. "E' un
momento di grande felicità - ha detto il fratello della ragazza, Matteo Ramelli
-, speriamo che Greta possa tornare presto a casa. La Farnesina ha fatto un
lavoro fantastico, e anche i nostri concittadini sono stati meravigliosi".
Alcuni automobilisti, passando davanti alla casa di Greta a Gavirate, un paese
affacciato sul lago di Varese, hanno suonato il clacson, in segno di giubilo per
la liberazione. E ieri sera il parroco del paese, don Piero Visconti, ha voluto
"ringraziare il Signore" durante in momento di preghiera nell'oratorio di
Gavirate. "Se tutti i giovani sapessero rischiare come ha fatto Greta - spiega -
il mondo sarebbe un posto migliore. Spero che il suo esempio possa sostenere
anche le tante altre persone che vogliono vivere donando amore agli altri". Il
sindaco del paese, Silvana Alberio, ha incontrato i genitori, per esprimere la
vicinanza di tutta la comunità. "Siamo felicissimi - racconta la madre di Greta
- non vediamo l'ora di riabbracciarla". Altrettanta gioia è stata espressa dai
familiari di Vanessa. "E' una grande gioia - dice emozionato Salvatore Marzullo,
il papà che lavora in un ristorante di Verdello, il paese dove da qualche tempo
vive appunto con la figlia. Appresa la notizia è scoppiato in lacrime. Dopo
"un'angoscia unica", è arrivata "una gioia immensa che aspettavamo da mesi e che
non si può descrivere", ha aggiunto. Momenti di sfiducia? "No - ha risposto -
c'era preoccupazione e tristezza, ma abbiamo avuto sempre fiducia nel risultato.
La Farnesina ci rassicurava sempre, devo ringraziare loro che sono riusciti a
farci restare sempre ottimisti". "Quando la vedrò - ha concluso - le darò un
grande abbraccio. Portiamola a casa e poi ci saranno tante cose da dirle".
Greta e Vanessa liberate in
Siria, il retroscena sulla trattativa: i banditi, Al Nusra, il riscatto
milionario, scrive “Libero Quotidiano”. La trattativa per liberare e riportare
in Italia Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le giovani cooperanti lombarde
rapite in Siria lo scorso 31 luglio e atterrate nella notte tra giovedì e
venerdì a Ciampino, accolte dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.
Nonostante la smentita dell'intelligence italiana, tutte le ricostruzioni non
escludono l'ipotesi di un riscatto di 12 milioni di dollari pagato dalle nostre
autorità ai rapitori, anzi. Innanzitutto, però, occorre fare chiarezza su chi
siano i "rapitori". "Banditi verniciati da islamisti": così li avrebbero
etichettati i servizi italiani che hanno lavorato al caso di Greta e Vanessa. Di
sicuro, non erano né dello Stato islamico né della fazione jihadista rivale, Al
Nusra. A dare supporto logistico a questa banda più o meno improvvisata
sarebbero stati i ribelli anti-Assad del Syrian Free Party, l'esercito libero
siriano. Attraverso mediatori vicini ai ribelli "buoni" siriani Farnesina e
intelligence hanno cercato per mesi un canale per risolvere positivamente la
vicenda. A dicembre, però, improvvisamente si complica tutto. Tra 23 e 31,
riporta Repubblica, a inizio mese secondo il Corriere della Sera, vengono meno i
contatti. Poi, la sera di Capodanno, spunta in rete il video delle due italiane
vestite di nero dal covo dei rapitori. Sarebbe stato un segnale al governo
italiano: per liberare Greta e Vanessa servono soldi, più di quanti ipotizzati.
La posta, insomma, si è alzata e il perché si scopre presto: sarebbero cambiati
i mediatori. I rapitori si sarebbero infatti avvicinati ad Al Nusra, i "rivali"
dell'Is che qualcuno, in maniera molto ottimistica, definisce "meno feroci" dei
tagliagole del Califfato. L'unica differenza in realtà è che se questi ultimi i
prigionieri li sgozzano in diretta video, i primi preferiscono venderli per fare
soldi, molti soldi. Che servono ad acquistare armi, addestrare milizie (anche
kamikaze), corrompere governi ed eserciti. Insomma, alimentare l'industria del
terrore. Al Nusra fa pubblicare quel video, la notte del 31 dicembre, contro la
volontà dei servizi italiani. Seguono giorni frenetici, fino agli attentati di
Parigi che emotivamente potrebbero portare il governo di Roma a pagare ancora di
più per non avere sulla coscienza la morte atroce di due ragazze. I jihadisti lo
sanno, e alzano la posta. L'Italia chiede un'altra prova che le rapite siano
vive e gli uomini di Al Nusra girano un secondo video, questa volta riservato e
non pubblicato sul web. E' il segnale: Greta e Vanessa stanno bene e si possono
liberare. A che prezzo, forse non lo si scoprirà. Lo scrittore Erri De Luca, che
già in passato ha espresso posizioni controverse sulla questione della linea
Alta velocità Torino-Lione, ha commentato la liberazione dal suo account
twitter. "Se è stato pagato un riscatto - ha scritto -, per una volta sono stati
spesi bene i soldi pubblici". A tal proposito, il leader della Lega Matteo
Salvini ha affermato: "La liberazione delle due ragazze mi riempie di gioia ma
l'eventuale pagamento di un riscatto che permetterebbe ai terroristi islamici di
uccidere ancora sarebbe una vergogna per l'Italia". Come dire: i terroristi
islamici si finanziano anche con questi riscatti.
Vanessa e Greta, samaritane
innamorate del kalashnikov. Sui loro profili Facebook frasi pesanti e immagini
forti. E amicizie con combattenti che posano con i cadaveri, scrive Fausto
Biloslavo su “Il Giornale”. Fotomontaggi con il kalashnikov avvolto dai fiori,
l'appello per salvare un barcone di clandestini, insulti alle Nazioni Unite e
amici combattenti in Siria sono le tracce lasciate su Facebook di Vanessa
Marzullo e Greta Ramelli prima di sparire. Non proprio profili di buone
samaritane, ma piuttosto di attiviste che appoggiano la lotta armata contro il
regime di Damasco. Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino
i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio. Adesso
che è apparsa la «prova in vita», ovvero il primo video delle due sequestrate,
raccontiamo chi sono Vanessa e Greta attraverso le loro stesse parole o immagini
postate in tempi non sospetti. Marzullo pubblica sul suo profilo la foto di un
gruppo di soldatini di plastica. In mezzo c'è una ballerina dipinta di rosa, che
imbraccia un fucile mitragliatore. Il primo ottobre 2013, un certo Ahmad Lion of
Islam scrive in inglese: «Carina. Così adesso vieni a combattere con noi eroina.
In qualsiasi momento sei la benvenuta». Un altro post mostra il fotomontaggio di
un kalashnikov avvolto dai fiori ed il 24 luglio 2013 Vanessa si rivolge al
presidente siriano, Bashar al Assad, con una frase che lo invita a darsi fuoco,
dopo aver bruciato tutto nel suo Paese. Il primo aprile non ha dubbi e scrive:
«Assad non è siriano, non è musulmano, non è laico (…). Assad non è neppure
umano». L'8 febbraio, posta un inequivocabile «Onu di merda. Posso descrivere
solo così il mio stato d'animo in questo momento». La deriva a favore dei
ribelli siriani è evidente anche dalle risposte ad uno strano questionario in
inglese che chiede cosa bisognerebbe fare in Siria? La prima risposta è «armare
l'Esercito libero siriano». I giornalisti come Monica Maggioni, direttore di Rai
news 24 che osa intervistare Assad, vengono insultati e sbeffeggiati. Il
pensiero a senso unico delle due ragazze in ostaggio in Siria risulta evidente
dalle immagini postate su Facebook. Un cartello del novembre 2012 è rivolto
all'Occidente con la seguente scritta in inglese: «Allah o Akbar è un grido di
vittoria. Nessun panico». Oppure un diretto «Cari Onu…Usa…Nato Vi odio». Il 3
giugno Vanessa lancia un appello «urgente» salva clandestini di Nawal
Syriahorra, che chiede a «siriani/arabofoni di contattare» un telefono
satellitare «presente sull'imbarcazione di cui ha parlato in questi giorni, con
almeno 450 persone a bordo abbandonate al mare. Chiamare sperando che qualcuno
risponda e chiedere: sono tutti vivi? c'è gente in acqua? la donna ha partorito?
sono stati raggiunti da italiani o maltesi? Al più presto!». Il vero cognome di
Nawal potrebbe essere Sofi, una fervente attivista della fallita primavera araba
di Damasco di origine marocchina, che favorirebbe l'arrivo dei profughi siriani
in Italia. La pasionaria partecipava alle stesse manifestazioni dove è stato
fotografato Hassam Saqan, che in Siria si è fatto immortalare in un video di
brutale esecuzione di soldati governativi prigionieri dei ribelli. Vanessa su
Facebook ha postato una frase in italiano non perfetto scritta su un muro e
firmata da Nawal Sofi: «Qui in Siria unico terrorista Bashar el Assad 15/3/2013
Mc- Italy».Greta Ramelli non è da meno come amicizie in rete con combattenti in
Siria. Le piace molto una foto con dei miliziani in mimetica nella zona di
Idlib, dove probabilmente le due ragazze sono trattenute in ostaggio. La
didascalia non è proprio un esempio di pacifismo: «La bellezza e la forza
sconvolgente della natura: tanto è stato il sangue versato che ora al suo posto
spuntano dei meravigliosi fiori rossi». Abu Wessam, un giovane ribelle
mascherato, amico in rete di Greta, posta le foto delle due ragazze in piazza
Duomo a Milano con la bandiera dell'Esercito siriano libero. Su Facebook l'amico
più importante dell'attivista «umanitaria» è Mohammad Eissa, il comandante delle
Brigate dei martiri di Idlib, che in rete si fa fotografare davanti a una
dozzina di corpi di nemici uccisi. Il gruppo islamista ha avuto rapporti
altalenanti con l'Esercito libero, formazione laica e filoccidentale della
guerriglia, ma pure con Al Nusra, la costola di Al Qaida in Siria, che rivendica
il rapimento. Probabilmente il barbuto comandante aveva garantito protezione
anche nei viaggi precedenti in Siria alle due ragazze innamorate della rivolta
siriana. Questa volta qualcosa è andato storto e gli «amici» ribelli di Vanessa
e Greta si sono trasformati in carnefici, o almeno così sembra.
Greta e Vanessa, il
giornalista del Foglio: "Non mi trovavo con loro". Daniele Raineri scrive che,
quando avvenne il sequestro delle due italiane, era ad alcuni chilometri di
distanza. "Cercavano anche me", scrive Lucio Di Marzo su “Il Giornale”. C'era
anche Daniele Raineri con Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, la sera che le due
italiane sono state rapite in Siria? Questo si è detto dal giorno del loro
sequestro, sostenendo che l'inviato del Foglio fosse riuscito a fuggire
dall'abitazione dove si trovavano tutti e tre, mentre le due volontarie venivano
catturate. Una storia su cui oggi ha detto la sua anche il diretto interessato,
che in un articolo pubblicato sul quotidiano di Giuliano Ferrara sostiene invece
che no, quella notte non si trovava con le due ragazze italiane. "Ero a circa
venticinque chilometri dalla casa dov'erano loro", scrive Raineri. In una casa
di campagna, usata come base dai ribelli, "a sud di Aleppo". La versione del
giornalista sembra dunque smentire uno dei dettagli legati al sequestro,
spiegando che nell'abitazione ("Il capo della casa era un ex soldato delle forze
speciali di Assad") ci è rimasto fino al mattino alle cinque. Poi alcuni colpi
alla porta e la notizia, portata da due siriani, del sequestro di Greta e
Vanessa, per mano di un gruppo che in quel momento non si riesce a identificare.
Forse - prova a ricostruire il Fatto Quotidiano, grazie ad alcuni documenti del
Ros - sono "rimaste vittime proprio di quelli che volevano soccorrere", se è
vero che il loro progetto era anche in funzione di supporto a quell'Esercito
libero composto da gruppi che l'Occidente ha spesso identificato come moderati.
Greta e Vanessa, due ingenue o
due fiancheggiatrici del terrorismo? Si chiede Milano Post. Greta e Vanessa, due
ragazze ventenni, lombarde volontarie del Progetto Horryaty, una Onlus fondata
da Roberto Andervill poche settimane prima del presunto rapimento delle due
cooperanti. Progetto Horryaty opera in maniera del tutto svincolata dalle varie
Ong presenti in territorio siriano e, stando alle dichiarazioni ufficiali dei
responsabili della Onlus, in Italia si occupano di raccolta fondi e
sensibilizzazione, in Turchia comprano gli aiuti, teoricamente materiale
sanitario, che vengono poi distribuiti in zone diverse della Siria. Questo
ufficialmente, scavando e cercando la verità troviamo un Roberto Andervill nel
cui profilo Facebook, al momento chiuso, si leggevano frasi di odio verso i
presidenti delle Comunità Ebraiche italiane, contro Magdi Allam e, giusto per
non deludere la sua sinistra ideologia, messaggi di pace (eterna) verso gli
Ebrei. Detto questo passiamo direttamente ad osservare Greta e Vanessa e vi
siete mai chiesti cosa c’è scritto sul cartello che reggono in quella famosa
foto in cui vengono ritratte avvolte dalla bandiera siriana in Piazza Duomo?
Sveliamo l’arcano, il quel
cartello c’è scritto:” Agli eroi di Liwa Shuhada grazie per l’ospitalità e se
D-o vuole vediamo la città di Idlib libera quando ritorneremo”. Chi sono gli
eroi di Liwa Shuhada? Presto detto: Liwa Shuhada Al-Islam, in italiano Brigata
dei martiri dell’Islam, è un’organizzazione, secondo i maggiori esperti di
terrorismo internazionale, terroristica di stampo jihadista, molto vicina al
Fronte Al-Nusra, il nome di Al-Qaeda in Siria per intenderci, e responsabile di
numerosi attentati a Damasco. Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni, pare,
dalle varie intercettazioni in mano ai R.O.S., che le due ragazze avesse già
intessuto da tempo rapporti con cellule del fronte anti-Assad, in Italia,
cellule che oggi chiamiamo “foreign fighters” e che in Francia hanno seminato
morte e terrore pochi giorni fa. Quindi ho forti dubbi che si trattasse di due
ventenni ingenue e sprovvedute, considerato che erano già state in Siria, che
avevano già dato aiuti ai “guerriglieri” e che si stavano recando ancora in
Siria per distribuire kit di pronto soccorso ai membri della Brigata dei Martiri
dell’Islam, probabilmente gli stessi che le hanno “rapite”, o sarebbe meglio
dire nascoste da occhi indiscreti, messe all’ingrasso per poi richiedere il
solito riscatto per la “liberazione” dei presunti ostaggi. Certo però che
rispetto alle due Simone, in Iraq, e della Sgrena, Greta e Vanessa sono state
decisamente più “professionali”. Mentre le prime hanno fruttato alla causa del
terrorismo “solo” undici milioni di dollari (5 per le due cooperanti e 6 per la
Sgrena), Greta e Vanessa hanno da sole fatto regalare ai terroristi ben 12
milioni di dollari, anche se negati dal ministro degli Esteri Gentiloni, si sa
che Italia, Francia, Germania e Spagna preferiscono pagare. “Non c’è nulla per
cui si debba chiedere scusa” queste le parole del padre di Vanessa. Eh no caro
signore, c’è invece da chiedere scusa. Sua figlia e la sua amica devono chiedere
scusa ai cittadini italiani, visto che i soldi pagati per “liberarle” da una
prigionia a pane e kebab, provengono dalle tasse che egli italiani pagano.
Devono porgere le loro scuse, implorando il perdono, a tutte quelle famiglie che
perderanno un loro caro ed a tutte le innocenti vittime che quei 12 milioni di
dollari, regalati al terrorismo islamico, causeranno in Medio Oriente o in
Europa.
Vanessa e Greta, cosa non
torna nella loro storia: le quattro accuse di Maurizio Belpietro su “Libero
Quotidiano”. Il governo si è dato da fare per smentire di aver pagato un
riscatto in cambio della liberazione di Vanessa e Greta. «Solo illazioni» ha
dichiarato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il quale subito dopo ha
però aggiunto che nel caso delle due cooperanti italiane l’esecutivo si è
comportato come i precedenti (che infatti pagavano), precisando che per Palazzo
Chigi e dintorni dà la priorità al salvataggio di vite umane (tradotto: pazienza
se ci sono costate 12 milioni, tanto sono soldi dei contribuenti). Con il
rientro delle due ragazze e le rassicurazioni del ministro si vorrebbe così
chiudere la faccenda, mettendo una pietra sopra l’imbarazzante trattativa con i
terroristi. Si dà il caso che però la vicenda sia tutt’altro che archiviabile ma
necessiti di ulteriori approfondimenti, soprattutto dopo la rivelazione di una
serie di antefatti. Ieri in un articolo del Fatto quotidiano si dava conto
dell’esistenza di una informativa dei Ros sulla missione siriana di Vanessa e
Greta. Non un rapporto compilato dopo la sparizione delle due ragazze, ma una
nota predisposta prima della partenza. Quanto prima? Leggendo l’articolo non è
dato sapere, ma si capisce che la relazione del reparto operativo dei
carabinieri risale al periodo in cui le due giovani lombarde stavano
organizzando il viaggio. Vi state chiedendo perché l’Arma si occupasse di due
esponenti di un’organizzazione non governativa intenzionate a partire per la
Siria? Perché le due entrano in contatto con un pizzaiolo emiliano che i Cc
tengono d’occhio ritenendolo un militante islamico. Così, per caso, intercettano
Vanessa e Greta che si mettono d’accordo con il tipo e a lui raccontano nel
seguente ordine due cose: di voler partire per la Siria per consegnare kit di
pronto soccorso alla popolazione civile ma anche ai combattenti islamici, così
che gli oppositori al regime di Assad possano curarsi in caso di ferite.
Secondo, Greta in una conversazione spiega di godere di una specie di
lasciapassare, in quanto sostenitrice della rivoluzione e protetta dall’Esercito
Libero. La ragazza non dice al telefono di essere in contatto con gente dello
stato islamico, anzi, assicura che quelli dell’Esercito Libero non impongono
neppure il velo alle donne. Come è finita si sa, con un sequestro che le ha
consegnate nelle mani di una banda vicina ad Al Qaeda, cioè l’organizzazione che
poi l’avrebbe rapita. Nell’articolo si fa cenno anche a un universitario in
collegamento con i ribelli ed anche ad un medico. Risultato: leggendo il Fatto
si apprendono le seguenti informazioni. La prima, forse scontata ma fino a ieri
non molto documentata, è che sul territorio italiano operano dei militanti che
inviano denaro e aiuti ai combattenti islamici. Due: Vanessa e Greta non sono
partite per la Siria per andare ad aiutare i bambini, per lo meno non solo: in
Siria sono andate per consegnare kit di pronto soccorso ai miliziani, che se non
è un aiuto a chi combatte poco ci manca. Tre: le giovani appoggiavano la
rivoluzione e consegnando i medicinali volevano contribuire materialmente a
sostenerla. Quattro: se sono finite nelle mani di tagliagole che le hanno rapite
e segregate per più di cinque mesi, liberandole solo in cambio di un riscatto
multimilionario, è perché qualcuno dei loro amici le ha tradite. Ne consegue che
i carabinieri sapevano tutto, del viaggio e anche dei contatti con i militanti
islamici, ma nessuno ha fatto niente, lasciando partire le ragazze e dunque
facendole finire nelle mani dei rapitori. Non solo: qualcuno in Italia si dà
addirittura da fare per agevolare la partenza e poi forse per agevolare anche il
sequestro, così che la fiorente industria dei rapimenti ad opera dei militanti
islamici possa prosperare e soprattutto finanziare la guerriglia e il
terrorismo. Infine, come spiegava ieri il nostro Francesco Borgonovo, risulta
evidente da questo rapporto che molte delle organizzazioni non governative in
apparenza dicono di voler aiutare chi soffre, ma nella sostanza hanno rapporti
poco trasparenti con chi combatte. Altro che ragazzine finite in un gioco più
grande di loro. Greta e Vanessa pensavano di fare la rivoluzione e invece sono
finite in una prigione dalle parti di Aleppo, perché la rivoluzione non è un
pranzo di gala e se poi è islamica si va a pranzo con il boia. Risultato: la
faccenda è tutt’altro che chiusa e il governo non può pensare di cavarsela con
l’intervento reticente del ministro Gentiloni. Essendoci di mezzo la sicurezza
nazionale (la gente che aiuta i combattenti l’abbiamo in casa) e soprattutto i
soldi dei contribuenti vorremmo andare fino in fondo. E state sicuri che per
quanto ci riguarda faremo di tutto per farlo.
Crolla l'alibi pacifista. Ecco
tutte le prove delle amicizie jihadiste. Altro che pacifiste: i kit di pronto
soccorso portati in Siria somigliano più a quelli militari. Ed erano destinati a
gruppi di combattimento, scrive Gian Micalessin su “Il Giornale”. Il ministro
Paolo Gentiloni, protagonista in Parlamento di una difesa a spada tratta di
Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, avrebbe fatto meglio a consultarsi prima con i
carabinieri del Ros. Carabinieri che, magari, avrebbero potuto mostrare pure a
lui le intercettazioni delle telefonate, pubblicate da Il Fatto Quotidiano , tra
le due suffragette lombarde e alcuni fiancheggiatori dei gruppi jihadisti
siriani. Telefonate assai scomode e imbarazzanti. Telefonate da cui emerge con
chiarezza come le due ragazzine non ambissero al ruolo di crocerossine neutrali,
ma piuttosto a quello di militanti schierate e convinte. Militanti tradite dai
propri stessi «amichetti» e riportate a casa solo grazie al trasferimento nella
cassaforte della formazione al qaidista di Jabat Al Nusra, o di qualche altro
gruppetto jihadista, di una decina di milioni di euro sottratti ai cittadini
italiani. Milioni con cui i fanatici siriani, o quelli europei passati per le
loro fila, potrebbero ora organizzare qualche atto di terrorismo in Italia o
altrove nel Vecchio Continente.
Che Greta e Vanessa
progettassero di mettere in piedi qualcosa di diverso da una normale
organizzazione umanitaria, Il Giornale lo aveva intuito subito dopo il
sequestro. Esaminando su Facebook le gallerie fotografiche di «Horryaty» -
l'associazione creata assieme al 46enne fabbro di Varese Roberto Andervill -
quel che più saltava agli occhi era l'aspetto chiaramente «militare» dei «kit di
pronto soccorso» distribuiti da Greta e Vanessa in Siria. I kit, contenuti in
tascapane mimetici indossabili a tracolla, assomigliavano più a quelli in
dotazione a militanti armati o guerriglieri che non a quelli utilizzati da
infermieri o personale paramedico civile. Anche perché la prima attenzione di
medici e infermieri indipendenti impegnati sui fronti di guerra non è quella di
mimetizzarsi ma piuttosto di venir facilmente identificati come personaggi
neutrali, non coinvolti con le parti in conflitto. Un concetto assolutamente
estraneo a Greta Vanessa. Nelle telefonate scambiate prima di partire con
Mohammed Yaser Tayeb - un 47enne siriano trasferitosi ad Anzola in provincia di
Bologna ed identificato nelle intercettazioni del Ros come un militante
islamista - Greta Ramelli spiega esplicitamente di voler «offrire supporto al
Free Syrian Army», la sigla (Esercito Libero Siriano) che riunisce le formazioni
jihadiste non legate al gruppo alaaidista di Jabat Al Nusra o allo Stato
Islamico. L'acquisto dei kit di pronto soccorso mimetici da parte di Greta e
Vanessa è documentato dalle ricevute pubblicate sul sito di Horryaty il 12
maggio di quest'anno, subito dopo la prima trasferta siriana delle due
«cooperanti». La ricevuta, intestata a Vanessa Marzullo, certifica l'acquisto in
Turchia di 45 kit al costo di 720 lire turche corrispondenti al cambio
dell'epoca a circa 246 euro. La parte più interessante è però la spiegazione
sull'utilizzo di quei kit. Nel rapporto pubblicato su Horryaty, Greta e Vanessa
riferiscono con precisione dove hanno spedito o portato latte, alimenti per
bambini, medicine e ogni altro genere di conforto non «sospetto». Quando devono
spiegare dove sono finiti quei tascapane mimetici annotano solo l'iniziale «B.»
facendo intendere di parlare di un avamposto militare dei gruppi armati il cui
nome completo non è divulgabile per ragioni di sicurezza. Nelle telefonate con
l'«amichetto» Tayeb registrate dai Ros, Greta Ramelli si spinge invece più in
là. In quelle chiacchierate Greta spiega che i kit verranno distribuiti «a
gruppi di combattimento composti solitamente da 14 persone». Spiegazione
plausibile e circostanziata visto che in ambito militare una squadra
combattente, dotata di uno specialista para-medico, conta per l'appunto dalle 12
alle 15 unità. L'elemento più inquietante, annotato dai Carabinieri del Ros a
margine delle intercettazioni, sono però i contatti tra l'«amichetto» Tayeb e
Maher Alhamdoosh, un militante siriano iscritto all'Università di Bologna e
residente a Casalecchio del Reno. Con Maher Alhamdoosh s'erano coordinati -
guarda un po' il caso e la sfortuna - anche Amedeo Ricucci, Elio Colavolpe,
Andrea Vignali e Susan Dabous, i giornalisti italiani protagonisti nella
primavera 2013 di un reportage in Siria conclusosi anche in quel caso con un bel
sequestro. Un sequestro seguito da immancabile ed esoso riscatto pagato, anche
allora, dai generosi contribuenti italiani. Quel silenzio su Giovanni Lo Porto
rapito tre anni fa in Pakistan. Il cooperante palermitano sparito il 19 gennaio
2012 durante una missione per conto della ong tedesca Welt Hunger Hilfe, scrive
Gianluca Mercuri su “Il Corriere della Sera”. Oggi 19 gennaio 2015 sono tre anni
che Giovanni Lo Porto è sparito. Era arrivato da tre giorni in Pakistan per fare
il suo lavoro - ridare alloggi alle popolazioni colpite dall’alluvione del 2010
- per conto della ong tedesca Welt Hunger Hilfe. Il 19 gennaio 2012 l’hanno
rapito insieme al collega Bernd Muehlenbeck, che lo scorso ottobre è stato
liberato dalle forze speciali di Berlino: si sa che non era più insieme a
Giovanni da un anno e nulla di più. Intorno al cooperante palermitano, un
silenzio che ha oscillato tra la prudenza d’obbligo e la reticenza pelosa. Il
governo chiede il basso profilo, parenti e amici non ci stanno e lanciano
appelli che raccolgono migliaia di adesioni. Un segnale è arrivato finalmente
dal ministro degli Esteri, che rispondendo venerdì in Parlamento su Greta e
Vanessa ha ricordato sia padre Dall’Oglio sia Giovanni, «due vicende alle quali
lavoriamo con discrezione giorno per giorno». Lo Porto ha un profilo
inattaccabile perfino dagli sciacalli del web: 40 anni, studi solidi tra Londra
e Giappone, esperienze sul campo in Croazia, Haiti e anni prima nello stesso
Pakistan, dove nel 2012 era tornato con un progetto finanziato dall’Ue. Insomma,
tutto fuorché un avventuriero. Gentiloni va preso alla lettera, fino a prova
contraria: l’Italia non lascia indietro nessuno dei suoi cittadini e per nessuno
lesina mezzi. Tre anni dopo, è il minimo che si deve a Giovanni Lo Porto.
Greta e Vanessa tradite da chi
volevano aiutare, scrive “Libero Quotidiano”. Greta e Vanessa sarebbero state
rapite proprio da chi volevano aiutare. Le due ragazze infatti, riporta il
Fatto, erano partite per la Siria non per aiutare i civili, le vittime della
guerra, ma per sostenere i combattenti islamici anti-Assad con kit di
salvataggio. E' il retroscena sul sequestro delle due volontarie che si legge in
alcune informative del Ros dove vengono riportate alcune intercettazioni di
aprile tra Greta Ramelli - che stava organizzando il suo viaggio in Medioriente
- e un siriano di Aleppo di 47 anni, Mohammed Yaser Tayeb, pizzaiolo di Anzolo
in Emilia, che gli investigatori considerano un militante islamista legato ad
altri siriani impegnati in "attività di supporto a gruppi di combattenti
operativi in Siria a fianco di milizie contraddistinte da ideologie jihadiste".
In sostanza il progetto delle due cooperanti era "rivolto a offrire supporto al
Free Syrian Army ora supportato dall'occidente in funzione anti Isis ma
anch'esso composto da frange di combattenti islamisti alcuni dei quali vicini ad
Al Qaeda", a sostenere "un lavoro in favore della rivoluzione", e non a dare un
aiuto neutrale. Si legge nell'informativa una telefonata tra Greta e Mohammed
Yasser Tayeb così sintetizzata: "Greta precisa che un primo corso si terrà in
Siria con un operatore che illustrerà ai frequentatori (circa 150 persone tra
civili e militari) i componenti del kit di primo soccorso e il loro utilizzo. la
donna dice che ha concordato con il leader della zona di Astargi di consegnare
loro i kit e cje a loro volta li distribuiranno ai gruppi di combattenti
composti da 14 persone in modo che almeno uno degli appartenenti a questi gruppi
fosse dotato del kit e avesse partecipato al corso". Tayeb secondo gli
investigatori si attivò concretamente per aiutarle e le mise in contatto con un
altro siriano residente a Budrio, Nabil Almreden, nato a Damasco, medico
chirurgo in pensione. Tayeb gli chiede di inviare in siria una lettera di
raccomandazione per Vanessa, "verosimilmente - annota il ros - un accredito
presso una non meglio istituzione all'interno del territorio siriano".
Greta Ramelli e Vanessa
Marzullo sono libere. Incassato con sollievo l'annuncio di Palazzo Chigi, con le
due giovani cooperanti italiane rapite in Siria lo scorso 31 luglio e già di
ritorno in Italia, il mondo politico e non solo già si divide, perché in ballo
ci sono 12 milioni di dollari, scrive “Libero Quotidiano”. Quelli che secondo i
ribelli siriani sarebbero stati pagati per la liberazione delle italiane,
notizia che i nostri servizi hanno smentito seccamente. "Se veramente per
liberare le due amiche dei siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12
milioni, sarebbe uno schifo!", ha incalzato il segretario della Lega Nord Matteo
Salvini. E c'è chi come il capogruppo di Forza Italia alla Regione Emilia
Romagna, Galeazzo Bignami, arriva a chiedere un "contrappasso" per le giovani
volontarie temerarie: "Adesso le due tipe si mettano a lavorare gratis fino a
quando non ripagheranno all'Italia quanto noi abbiamo dovuto versare, in nome
della loro amicizia, ai ribelli siriani". "Sono state liberate immagino dietro
pagamento di lauta ricompensa ai ribelli siriani - scrive Bignami su Facebook -.
Ora che sono libere penso si possa dire con chiarezza che di chiaro in questa
storia non c'è nulla. A partire dal fatto che questo sequestro pare proprio un
gran favore fatto dalle loro amiche ai ribelli". Sui social network e sui siti,
il commento di molti utenti è critico. E anche tra i lettori di
Liberoquotidiano.it l'umore non è di sola soddisfazione per la liberazione delle
due giovani. E' tutto il centrodestra ha porre la questione al governo. Secondo
Mariastella Gelmini di Forza Italia, è "doveroso chiederci se un eventuale
riscatto pagato a dei terroristi non sia una fonte di finanziamento per portare
la morte in Europa e altrove. Non vorrei che l'Occidente finisse vittima di un
corto circuito provocato dai terroristi che dispensano la morte e la vita a
secondo delle convenienze". Se la Gelmini chiede spiegazioni al ministro degli
Esteri Paolo Gentoloni ("Lui e il governo faranno bene a chiarire rapidamente la
vicenda in tutti i suoi aspetti rilevanti"), sulla stessa linea si pone Massimo
Corsaro di Fratelli d'Italia: Greta e Vanessa "hanno esposto loro stesse e
l'intero Stato italiano a una situazione di rischio e difficoltà coscientemente
con la loro volontaria presenza in un Paese in gravi condizioni e una pesante
presenza del terrorismo, il ministro Boschi ci dica se è in grado di escludere
che da qualunque fonte di finanziamento pubblico sia stato un centesimo per
riportare le due ragazze a casa".
"Pagato riscatto da 12
milioni" Quante armi compreranno? Giallo sui soldi, un tweet dei rapitori fa
scoppiare la polemica Dal 2004 a oggi abbiamo versato già 61 milioni ai
terroristi, spiega Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Non possiamo che
gioire per la liberazione di Vanessa Marzullo e di Greta Ramelli, le quali, dopo
essere state quasi sei mesi nelle mani dei tagliagole jihadisti, potranno oggi
finalmente riabbracciare le loro famiglie. Fatta questa doverosa premessa, non
possiamo esimerci dall'esprimere un senso di vergogna e di disapprovazione per
le modalità con cui il governo ha risolto la questione. È vero che siamo da anni
abituati a pagare riscatti a talebani, pirati e terroristi per riportare a casa
chi si avventura in zone altamente pericolose, ma averlo fatto consapevoli di
foraggiare l'industria dei sequestri è perlomeno riprovevole. «Dodici milioni di
dollari» proclamano i rapitori del Fronte Al Nusra, cioè circa dieci milioni di
euro per riempire le casse del gruppo qaedista siriano, che fa dei sequestri una
delle sue principali fonti di finanziamento per procurarsi armi e reclutare
combattenti. C'è poco da scherzare o da sorridere. Secondo una stima fatta dal
New York Times , Al Qaeda e i gruppi affiliati avrebbero incassato negli ultimi
cinque anni almeno 125 milioni di dollari, versato in gran parte dai governi
europei. I riscatti pagati dalla sola Italia dal 2004 a oggi a vari gruppi
combattenti, ammontano a 61 milioni di euro. Un'industria fiorente, con un
fatturato considerevole, alimentato proprio dai quei Paesi disposti e abituati a
sborsare denaro per soddisfare le richieste dei terroristi. Quali clienti
migliori per i piccoli eredi di Osama bin Laden. E l'Italia è un obiettivo
«privilegiato». E pensare che Amedy Coulibaly, il terrorista islamico
protagonista della strage nel supermercato ebraico di Parigi, aveva chiesto un
mutuo di poco più di 30mila euro per finanziare la sua azione e quella dei
fratelli Kouachi nella redazione di Charlie Hebdo. Fate una semplice calcolo di
quanti Coulibaly si potrebbero mettere in pista con i dieci milioni di euro
pagati dal nostro governo…. Inevitabili quindi, le proteste e le polemiche
scaturite subito dopo l'annuncio del pagamento di un riscatto per liberare
Vanessa e Greta. Lega, Fdi e Forza Italia hanno subito chiesto chiarimenti in
Parlamento. «La liberazione delle due ragazze mi riempie di gioia - ha detto il
leader del Carroccio Matteo Salvini -. Ma l'eventuale pagamento di un riscatto,
che permetterebbe ai terroristi di uccidere ancora, sarebbe una vergogna per
l'Italia». La Lega presenterà un'interrogazione al ministro degli Esteri proprio
«per appurare se sia stato pagato un solo euro per le due signorine». «Un fatto
assai grave - gli ha fatto eco il deputato leghista Molteni -. Il primo pensiero
va alle famiglie. Va detto però che noi non abbiamo mai condiviso né
giustificato le motivazioni della loro missione pseudomondialista». Chiede
chiarezza anche Mariastella Gelmini, vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia.
«Quando si riconquista la libertà e la vita, ogni persona ragionevole non può
che esultare - ha affermato - Adesso, con altrettanta ragionevolezza, il governo
e il ministro degli Esteri devono riferire sulle modalità di questa
liberazione».
Ora li paghiamo pure per farci
mettere il velo. Il governo deve riportarle a casa. Ma ci costerà milioni e così
finanzieremo i terroristi. Vietiamo alle Ong di andare in quei posti, scrive
Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Tranne improbabili e comunque non
auspicabili colpi di scena, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo rientreranno presto
in Italia. Le trattative volgono alla fine e concernono esclusivamente, così
come è stato sin dall'inizio del loro singolare sequestro lo scorso 31 luglio,
l'entità della cifra da pagare. Le due ragazze erano simpatizzanti degli stessi
gruppi islamici che le avrebbero sequestrate. In un cartello in arabo con cui si
sono fatte immortalare nel corso di una manifestazione svoltasi in Italia si
legge: «Agli eroi della Brigata dei Martiri - Grazie dell'ospitalità - Se Allah
vorrà presto Idlab sarà liberata - E noi ci torneremo». La «Brigata dei
Martiri», in arabo Liwa Shuadha, è un gruppo di terroristi islamici il cui capo,
Jamal Maarouf, ha ammesso di collaborare con Al Qaida. Comunque sia, nel caso
degli ostaggi italiani detenuti dai terroristi islamici i riscatti si misurano
in milioni di euro, per la precisione dai 5 milioni in su per i sequestri in
Siria e Irak, «solo» un milione o poco più per i sequestri finora verificatisi
in Libia. Si stima che dal 2004 l'Italia abbia pagato complessivamente 61
milioni di euro per liberare Simona Pari e Simonetta Torretta, Maurizio Agliana,
Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, Giuliana Sgrena, Clementina Cantoni,
Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria Sandra Mariani, Sergio Cicala e
Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico Quirico. Per avere un riferimento
dell'entità della cifra da corrispondere ai terroristi islamici che detengono le
due ragazze italiane, teniamo presente che l'ultimo ostaggio italo-svizzero,
Federico Motka, sequestrato anche lui in Siria il 12 marzo 2013, è stato
rilasciato il 26 maggio scorso dietro il pagamento di un riscatto di 6 milioni
di euro. Nel video postato su YouTube Greta e Vanessa sono sostanzialmente
tranquille, recitano un copione impartito loro, i loro sguardi s'incrociano con
quelli dei carcerieri dietro la telecamera per assicurarsi di essere state
diligenti. È un video diretto a noi cittadini italiani per prepararci
psicologicamente ad abbracciare le due ragazze in cambio del pagamento di un
lauto riscatto. Sostanzialmente diverso era il video del 2005 che ci mostrò
Giuliana Sgrena disperata e in lacrime supplicando le autorità di intervenire
per il suo rilascio. Ebbene quel drammatico messaggio era diretto al governo,
forse inizialmente restio a sborsare la cifra richiesta tra i 6 e gli 8 milioni
di euro. Saremo tutti contenti di riavere vive Greta e Vanessa. Però è ora di
porre fine a queste tragiche farse il cui conto salatissimo paghiamo noi
italiani. Il governo vieti alle nostre associazioni civili di operare nelle zone
dove imperversano il terrorismo islamico o i conflitti armati. È ora di dire
basta alle sedicenti associazioni «senza scopo di lucro» che lucrano con il
denaro degli italiani, soldi pubblici e privati, per sostenere la causa dei
nemici della nostra civiltà. E poi ci tocca pure pagare ingenti riscatti quando
vengono sequestrati o si fanno sequestrare. Basta!
Finché "mandiamo" ostaggi
siamo più vulnerabili. Che cosa aspetta il nostro ministero degli Esteri a
vietare tassativamente a tutti i cittadini italiani di recarsi nei Paesi dove
imperversa il terrorismo? Continua Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Che
cosa aspetta il nostro ministero degli Esteri a vietare tassativamente a tutti i
cittadini italiani di recarsi nei Paesi dove imperversa il terrorismo islamico,
a cominciare da Irak, Siria, Libia, Nigeria e Somalia? Nel caso specifico
dell'Italia dobbiamo farlo sia perché avendo dato prova di essere un «buon
pagatore», finiamo per alimentare le risorse finanziarie con cui i terroristi
islamici accrescono i loro efferati crimini, sia perché le recenti decapitazioni
di quattro ostaggi occidentali (due americani e due britannici) evidenziano che
i terroristi islamici sono del tutto indifferenti al fatto che fossero degli
«amici», solidali con i musulmani. Si stima che dal 2004 l'Italia abbia pagato
complessivamente 61 milioni di euro per liberare Simona Pari e Simonetta
Torretta, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, Giuliana
Sgrena, Clementina Cantoni, Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria Sandra
Mariani, Sergio Cicala e Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico Quirico.
Con noi i terroristi islamici vanno sul sicuro: hanno la certezza che il governo
italiano pagherà. Esattamente l'opposto della politica adottata dagli Stati
Uniti e dalla Gran Bretagna. La prova: mentre l'italo-svizzero Federico Motka,
sequestrato il 12 marzo 2013 insieme al britannico David Haines, entrambi
operatori umanitari, è stato rilasciato il 26 maggio scorso dietro il pagamento
di un riscatto di 6 milioni di euro, Haines è stato decapitato dai terroristi
dell'Isis (Stato Islamico dell'Irak e del Levante) il 14 settembre scorso.
Diciamo che probabilmente i terroristi islamici considerano più vantaggioso
sfruttare gli ostaggi italiani per finanziare la loro guerra criminale, rispetto
al tornaconto politico che potrebbero avere dalla reazione alla loro
decapitazione prendendo realisticamente atto che l'Italia conta poco sulla scena
internazionale. Eppure avrebbero dovuto ringraziare Haines per l'aiuto dato ai
musulmani. Era stato ribattezzato lo «scozzese matto» per la sua estrema
disponibilità e dedizione a favore dei bisognosi. Aiutava tutti, soprattutto i
musulmani. Anche l'altro britannico, Alan Henning, decapitato lo scorso 3
ottobre, semplice autista di taxi di Eccles, vicino Manchester, era amico dei
musulmani. Sua moglie Barbara aveva invano implorato i terroristi dell'Isis:
«Alan è un uomo pacifico, altruista, che ha lasciato la sua famiglia e il suo
lavoro per portare un convoglio di aiuti in Siria, per aiutare chi ha bisogno,
insieme con i suoi colleghi musulmani e i suoi amici». Anche il giornalista
americano James Foley, decapitato dai terroristi dell'Isis lo scorso 19 agosto,
era un simpatizzante dei gruppi islamici che combattono il regime di Assad in
Siria. La madre Diane, appresa la barbara esecuzione del figlio, ha detto:
«Ringraziamo Jim per tutta la gioia che ci ha dato. È stato straordinario, come
figlio, fratello, giornalista e persona, ha dato la propria vita cercando di
mostrare al mondo le sofferenze del popolo siriano». Ugualmente il secondo
giornalista americano, Steven Sotloff, decapitato lo scorso 3 settembre, era un
ebreo affascinato dal mondo islamico. La madre Shirley si era rivolta
direttamente al Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi: «Steven è un giornalista che è
venuto in Medio Oriente per raccontare la sofferenza dei musulmani nelle mani
dei tiranni. È un uomo degno di lode e ha sempre aiutato i più deboli. Chiedo
alla tua autorità di risparmiare la sua vita e seguire l'esempio del Profeta
Maometto che ha protetto i musulmani». La prossima vittima preannunciata dei
terroristi islamici, l'americano Peter Edward Kassig, di soli 26 anni, è anche
lui un cooperante che ha fondato l'organizzazione umanitaria Special emergency
response and assistance (Sera), addirittura convertito all'islam. Ebbene,
nell'attesa che si ottenga la liberazione di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli,
cooperanti simpatizzanti dei terroristi islamici rapite lo scorso 31 luglio, e
padre Paolo Dall'Oglio, anche lui filo-islamico, rapito il 29 luglio 2013, il
governo vieti tassativamente i viaggi degli italiani in questi Paesi sia per
porre fine alla vergogna dei riscatti pagati ai terroristi islamici sia per
prevenire l'assassinio dei nostri connazionali.
Greta e Vanessa libere: il
dilemma davanti alla loro generosità. Pagare i riscatti per i prigionieri dei
jihadisti è sbagliato e ingiusto. Eppure davanti alle due ragazze ci dobbiamo
interrogare sull'indicibile, scrive Marco Ventura su “Panorama”. Questo articolo
è stato scritto il 3 gennaio quando Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due
amiche rapite in Siria, erano apparse in tv vestite di nero con il capo coperto.
Lo riproponiamo oggi che le due giovani sono state liberate. Una riflessione su
giudizi, generosità e difficoltà di decidere se e quando un riscatto va pagato.
"Noi siamo Greta Ramelli e Vanessa Marzullo". Greta e Vanessa. Due amiche, unite
dal desiderio di portare aiuto ai bambini in Siria. Ingenue, avventate, forse.
Non giudichiamole. Ma noi non abbiamo il diritto di giudicarle. Mi urtano i
(troppi) commenti che le dipingono in un linguaggio sprezzante come invasate
manipolate e sprovvedute la cui prigionia crea un problema e pone un dilemma a
chi deve gestirla (pagare o non pagare il riscatto? finanziare o no i rapitori?
favorire o no con la trattativa altri sequestri?). Il capodanno e compleanno di
Vanessa è stato terribile. Greta e Vanessa sono due giovani donne maggiorenni
(il 31 dicembre Vanessa ha compiuto 22 anni, Greta ne ha uno di meno) che non
fanno parte della schiera di chi non si cura degli altri, di chi bada solo a se
stesso, di chi concepisce la propria esistenza fra routine e saltuari bagordi di
fine settimana o fine anno. Il capodanno e compleanno di Vanessa è stato
terribile. Ma è quella la strada che Vanessa, e con lei Greta, ha scelto. Voglio
pensare che Vanessa e Greta fossero consapevoli di quel che facevano. Ma se
anche non lo fossero state, credo nella verità dei loro intenti. Generosi. E
coraggiosi. L'incoscienza che fa parte della vita. E se pure condivido il
sospetto di molti, che non fossero del tutto lucide quando hanno valutato i
rischi, credo che difficilmente si possano prevedere tutte le conseguenze di una
decisione, nel momento della scelta. E, anzi, che una certa incoscienza faccia
parte della vita, se la si vuole vivere. C’è chi ha parlato di plagio,
insinuando una qualche adesione delle due giovani donne a un messaggio
ideologico di chissà quale banda di predoni o gruppo islamico estremista che le
tiene in ostaggio. Da quel video cosa si vede? Chi le guarda così, da lontano,
da inesperto, le vede diversamente da come esemplarmente le ha viste (e ne ha
scritto su “La Stampa”). Domenico Quirico, costretto pure lui da ostaggio, da
“schiavo”, a registrare un messaggio. Dice Quirico che quel giorno lui era
felice, perché il video era un modo per avvicinarsi alla famiglia e alla
liberazione. Ma il commento si conclude con la distanza tra quelle immagini di
Greta e Vanessa e la verità dell’avvicinamento, solo in quanto di nuovo
visibili, alla loro vita di prima, alla famiglia. A se stesse. Ma da quel video
si può solo dedurne il loro essere vive in quel momento. Gli anglosassoni non
pagano riscatti. È una regola chiara. Un dovere forte. Sì, colpisce vedere la
fotografia di Greta e Vanessa sorridenti, una accanto all’altra come lo sono
nelle foto da amiche del cuore nei giorni di festa (e magari di protesta) e il
fotogramma di quei 23 lunghissimi secondi in cui si ritrovano ancora vicine ma
senza sorriso, vestite di nero col capo coperto, Greta che recita il messaggio
rigorosamente a occhi bassi, Vanessa che mostra un foglietto ambiguo con una
data non verificabile (il 17 dicembre) e per ben due volte alza gli occhi, prima
subito riabbassandoli consapevole d’aver infranto una regola o commesso
un’imprudenza, poi guardando di lato, quasi astraendosi dal messaggio, dal luogo
e dall’ora, e assumendo un’espressione seria (ma da bambina, così simile a certe
espressioni vaghe dei nostri figli, delle nostre figlie). Un dilemma terribile.
Gli anglosassoni non pagano riscatti. È una regola chiara. Un dovere forte.
Perché il riscatto finanzia il terrore. Perché pagando si incentiva il business
dei rapimenti. Perché chi si vede pagata la liberazione ha la vita salva e gli
altri, di altre nazionalità, no e questo non è giusto. E perché chi è adulto e
affronta il pericolo deve anche esser pronto a subirne le conseguenze (il
problema è di chi viene sequestrato, non del governo, soprattutto se non si ha
indosso l’uniforme e non si svolge un ruolo istituzionale, da militare,
ambasciatore, 007). E tuttavia, ci interroga la generosità di quelle giovani
donne andate in Siria, credendoci. E mai come in questo caso si pone un dilemma
terribile per chi è chiamato a fare di tutto per liberarle. C’è, qui, un fossato
incolmabile tra il detto e l’indicibile.
5 motivi per cui non bisogna
pagare riscatti. È bellissimo che Greta e Vanessa siano libere. Ma versare
denaro ai sequestratori è sbagliato: condanna a morte altri ostaggi e
indebolisce il paese, scrive Marco Ventura su “Panorama”. In Italia i rapimenti
sono finiti grazie al blocco dei beni. Decisione terribile e a prima vista
disumana. Ma giusta. Ma nel caso di Greta e Vanessa che sono tornate libere (ed
è bellissimo che questo sia successo, che i genitori possano riabbracciarle, che
siano vive), ci sono mille altre ragioni perché non accada mai più che venga
pagato un riscatto. Ecco perché.
1 - Dare un tesoretto ai
sequestratori. Che siano stati pagati 12 milioni, di meno, o di più, il punto è
che le bande di sequestratori, che sono anche manipoli di guerriglieri nei
teatri dell’avanzata islamista in Iraq e Siria, hanno oggi un tesoretto da
investire in armi o in nuovi rapimenti. Esattamente come in Italia (in Sardegna,
in Calabria) qualche decennio fa. Ricordate l’anonima sequestri?
2 - La condanna a morte degli
altri ostaggi. Il pagamento del riscatto per gli ostaggi italiani condanna a
morte gli ostaggi degli altri Paesi. Chi rifiuta categoricamente di trattare con
i sequestratori (soprattutto se terroristi) vede sistematicamente i propri
ostaggi uccisi, sgozzati, decapitati, mentre magari i loro compagni di “cella”
vengono rilasciati a suon di quattrini. È giusto?
3 - Il presente costruisce il
futuro. Il presente costruisce il futuro. Chi paga oggi, pagherà domani. E
allora perché non continuare a rapire tutti gli sprovveduti/e italiani/e che
mossi da sentimenti di generosità verso i sofferenti delle zone più sventurate
del pianeta si tuffano a sprezzo del pericolo in tutte le avventure umanitarie?
(Ovvio che qui si pone un serio problema di equilibrio tra volontariato e
sicurezza: se lo pongono l’ONU e i grandi organismi internazionali, a maggior
ragione dovrebbero porselo i singoli e le piccole associazioni fai-da-te).
4 - Chiudere la fabbrica degli
ostaggi. L’ostaggio è sempre lo strumento di un ricatto. Un’arma. Lo Stato deve
quindi porsi a sua volta la questione di come “chiudere” la fabbrica degli
ostaggi. Può farlo sposando la tesi (che personalmente condivido) di Stati Uniti
e Gran Bretagna, di dire in anticipo (e poi agire di conseguenza e
coerentemente) che nessun riscatto sarà mai pagato. O lo si può fare cercando il
più possibile di impedire che italiani si trovino nelle zone a rischio dove la
probabilità di essere rapiti, date certe condizioni, è troppo alta.
5 - Sottomettersi o vincere.
Perché uno Stato paga riscatti? Per mancanza di senso dello Stato dei suoi
governanti. L’uccisione di un ostaggio, per un’opinione pubblica come quella
italiana, è una sconfitta della quale ha colpa il governo, mentre la sua
liberazione è una vittoria. Sbagliato. Qui gli errori sono due. Di chi ci
governa, perché dimostra non saper essere leader. E di noi che non abbiamo la
maturità nazionale dei Paesi anglosassoni che affrontano le guerre con lo
spirito di chi vuol vincerle e non di chi si sottomette.
In Italia i rapimenti sono
finiti grazie al blocco dei beni. Decisione terribile e a prima vista disumana.
Ma giusta. Ma nel caso di Greta e Vanessa che sono tornate libere (ed è
bellissimo che questo sia successo, che i genitori possano riabbracciarle, che
siano vive), ci sono mille altre ragioni perché non accada mai più che venga
pagato un riscatto. Ecco perché.
Vanno allo sbaraglio e noi
paghiamo. L'unico consiglio a chi sogna un soggiorno in Medioriente per aiutarne
i popoli è questo: lasciate perdere, scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. La
vedova di Enzo Baldoni, ucciso dieci anni orsono in Irak da assassini islamici
(la cui umanità è nota), in un'intervista rilasciata alcuni giorni fa alla
Repubblica , afferma di non essersi dimenticata di me e di Renato Farina che,
all'epoca dei fatti, fummo molto critici con il povero pubblicitario-pubblicista
perché aveva deciso di trascorrere le ferie nel Paese di Saddam Hussein (con
l'ambizione di redigere un reportage) anziché - poniamo - a Rimini, dove non
avrebbe rischiato nulla. Comprendo lo stato d'animo della signora e il suo
rancore nei nostri confronti, visto come si è tragicamente conclusa l'avventura
in Medioriente di suo marito. Ovvio, davanti alla morte, anche se avvenuta in
circostanze sulle quali si può discutere, è giusto che prevalgano le ragioni del
cuore su quelle del cervello. Ora il problema incarnato da Baldoni si ripropone
negli stessi termini: mi riferisco al rapimento avvenuto in Siria di due ragazze
italiane (alcune settimane fa) che si sono recate in quelle terre infuocate nei
panni di cooperatrici. La storia di queste fanciulle è analoga a quella delle
famose due Simone, loro coetanee, che, in occasione della seconda guerra del
Golfo, erano andate a Bagdad per aiutare non si sa bene chi, e furono
sequestrate dalle solite teste calde imbevute di Corano. La loro vicenda terminò
felicemente. Nel senso che i nostri servizi segreti si mossero abilmente,
trattarono sul riscatto, lo pagarono con i soldi dello Stato italiano, e
liberarono entrambe le scriteriate turiste. Meglio così. Poi fu la volta di
Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto, anch'essa finita ostaggio degli
islamici e scarcerata grazie al pagamento di una somma rilevante versata
dall'Italia ai banditi. Ma sorvoliamo per non farla tanto lunga. Ciò che ci
preme osservare è l'inutilità dell'esperienza. C'è gente che, nonostante i
precedenti, continua incoscientemente a sfidare il destino - notoriamente cinico
e baro - e a mettere a repentaglio la pelle correndo in soccorso di chi non
desidera essere soccorso, in Paesi in cui vige la legge del taglione, che non è
neppure una legge, bensì una minaccia verso chiunque non adori Allah. Infatti,
Greta Ramelli (di Varese) e Vanessa Marzullo (Brembate, lo stesso Comune di
Yara, la tredicenne morta ammazzata 4 anni addietro), senza riflettere un
secondo, quando hanno avuto l'opportunità di trasferirsi qualche giorno in
Siria, sono partite piene di entusiasmo, appoggiate da un'organizzazione
umanitaria, convinte di fare del bene. A chi? Ai siriani martoriati dalla
guerra, dalle violenze che subiscono quotidianamente vittime di ingiustizie
atroci. Ottime intenzioni, non abbiamo dubbi. Ma possibile che non ci sia
nessuno in grado di far presente a chi si appresta a raggiungere il Vicino
Oriente che non è il caso di affrontare certi viaggi densi di insidie? Possibile
non informare i volontari che, persuasi di contribuire a salvare il mondo, in
realtà vanno incontro a situazioni da cui è improbabile uscire vivi? Questo è il
punto. Non condanniamo assolutamente coloro che, ignari delle trappole
disseminate nei territori dove si combatte, vi si recano per il nobile scopo di
aiutare persone in drammatiche difficoltà. Ma consentiteci di deplorare almeno
quei pazzi che incitano tanti giovani a emigrare, sia pure temporaneamente, in
luoghi nei quali uccidere una mosca o un cristiano è lo stesso. È sbagliato
pensare che un atto d'amore sia sufficiente a rabbonire chi ti odia da secoli
perché rappresenti, fisicamente, il nemico da eliminare. Occorre rieducare i
diseducatori che in modo subdolo trascinano i giovani, e perfino vari adulti, a
compiere imprudenze che non raramente portano all'irreparabile: sequestri ed
esecuzioni capitali con metodi tribali. È un'operazione complicata e forse
velleitaria. Ma non c'è altro da fare. Descrivere come eroi i Baldoni, le
Simone, le Sgrene e anche le due ragazze tuttora in mano ai folli islamisti,
cioè Greta e Vanessa, significa distorcere la realtà e la logica. Volare laggiù
nel deserto, a qualsiasi titolo, equivale a percorrere l'autostrada contromano.
Non si può pretendere di farla franca. L'evento più probabile è crepare
ammazzati. Baldoni, pace all'anima sua, abbacinato da non si sa chi e che cosa,
andò incontro alla propria fine senza valutare che in taluni casi la generosità
sconfina nella stoltezza; le due Simone si salvarono perché al tempo avevamo
ancora dei servizi segreti efficienti; idem la Sgrena; mentre Greta e Vanessa
sono state abbandonate a se stesse. Auguriamo loro di tornare, ma non contino
sui nostri 007, ormai disarmati e privi di forza contrattuale. L'unico consiglio
a chi sogna un soggiorno in Medioriente per aiutarne i popoli è questo: lasciate
perdere. Le vacanze più intelligenti hanno quale meta Viserbella o Milano
Marittima, almeno finché non saranno state invase dai cammellieri.
Scandalizzarsi è un'ipocrisia
Quante vite salvate da un patto. Dai sequestri De Martino e Cirillo ai rapimenti
di Mastrogiacomo e Sgrena: i negoziati con camorra, Br e terroristi islamici
hanno consentito di evitare spargimenti di sangue, scrive “Il Giornale”. Esiste
uno Stato immaginario che non si piega e non scende a patti, e anche nei momenti
più difficili preferisce affrontare le conseguenze più tragiche anziché trattare
col nemico. Ed esiste poi uno Stato reale che ufficialmente fa la faccia feroce
ma sotto traccia incontra, dialoga, si aggiusta. Che promette, e a volte
mantiene. Che riceve promesse, e quasi sempre qualcosa incassa. Se davvero -
perché di questo in fondo si tratta - qualcuno ha trattato con Cosa Nostra la
consegna di Totò Riina, beh, non sarà stata né la prima né l'ultima volta che il
do ut des ha fatto la sua silenziosa comparsa nella guerra tra Stato e
antistato. Il catalogo è lungo e ricco, e appartiene in buona parte alle
cronache del terrorismo: quello domestico, all'epoca della furia omicida delle
Brigate rosse e dei loro epigoni, quanto quello islamico in giro per il mondo.
Ma non è che le vicende del crimine organizzato non portino anch'esse traccia di
accordi sottobanco: nella sentenza d'appello ai calabresi che nel 1997 rapirono
a Milano Alessandra Sgarella, una piccola nota a piè di pagina dà atto che a un
boss in carcere vennero promessi benefici penitenziari in cambio delle sue
pressioni per la liberazione dell'ostaggio. Si poteva fare, non si poteva fare?
Si fece e basta, e la Sgarella tornò a casa dopo quasi un anno di terribile
prigionia. Non fu, giurano gli addetti ai lavori, l'unica volta che un sequestro
dell'Anonima si risolse così. D'altronde esiste un precedente storico anche se
poco esplorato, il memorabile sequestro di Guido De Martino, figlio del
segretario del Psi, rapito nel 1977 dalla malavita napoletana e rilasciato dopo
una colletta tra banche, partiti, servizi. Nei rapporti con il terrorismo di
ogni risma ed etnia, la trattativa sotterranea è invece - almeno in Italia - una
prassi e quasi un'arte, spesso esercitata quasi alla luce del sole. A partire
dal caso più noto e peggio concluso, quando intorno al sequestro del presidente
democristiano Aldo Moro sorse addirittura un «partito della trattativa» che
agiva per pubblici proclami senza che nessuno si indignasse o aprisse inchieste;
e persino gli emissari della trattativa nel fronte brigatista avevano nomi e
cognomi di pubblico dominio, e pubblicamene discusse se erano le possibili
contropartite alla liberazione di Moro. Poi finì come finì, ma nessuno finì
sotto inchiesta per avere cercato di salvare Moro. Nessuno venne incriminato per
avere trattato sottobanco con frange di brigatisti la consegna di James Lee
Dozier, il generale americano sequestrato subito dopo Moro. Si indagò, invece,
ma senza quagliare granché, sulla più spudorata delle trattative, quella che
portò alla liberazione dell'assessore napoletano Ciro Cirillo, sequestrato anche
lui dalle Brigate Rosse, e tornato a casa dopo che per salvarlo si era mosso una
specie di circo fatto di agenti segreti, politici, imprenditori, tutti a baciare
la pantofola di Raffaele Cutolo, il capo della Nuova camorra organizzata che nel
supercarcere dove era richiuso riceveva visite una dopo l'altra. Il pasticcio
era tale che qualche anno fa Cirillo, ormai ottuagenario, disse di non voler
raccontare nulla fino alla morte. «È tutto scritto in un memoriale da un
notaio». Ma dove la decisione di scendere a patti è stata una costante, tanto
notoria quanto inconfessata, è quando l'Italia si è trovata a fare i conti con
il terrorismo islamico: una prassi così costante da suscitare l'indignazione
degli alleati e della loro intelligence, ma resa inevitabile dalla commozione
con cui vengono seguiti i casi dei nostri connazionali rapiti qua e là per il
mondo. Per i poveri Quattrocchi e Baldoni, rapiti e ammazzati in Irak, per
allacciare una trattativa mancò il tempo, non la volontà. Da allora in poi, è
quasi incalcolabile il fiume di fondi riservati dei servizi segreti finiti nelle
tasche della jihad pur di riportare in patria i malcapitati. Si racconta che la
telefonata a casa che i rapitori concessero a Domenico Quirico, l'inviato della
Stampa sequestrato in Siria, sia costata all'erario una robusta bolletta. E
cifre ben maggiori sono servite per ottenere il rilascio delle due Simone, la
Pari e la Torretta, sequestrate nel 2004 a Baghdad, o dell'inviato speciale di
Repubblica Daniele Mastrogiacomo. Qualche dettaglio emerse a margine della
vicenda finita tragicamente della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena: il
4 marzo 2005 un funzionario del Sismi consegnò a un emissario dei rapitori il
riscatto, in Kuwait o negli Emirati Arabi. L'emissario diede il via libera, a
Baghdad la giornalista venne liberata e consegnata a un'altra squadra del Sismi.
Ma sulla strada per l'aeroporto l'auto dei nostri 007 fu attaccata per errore da
un posto di blocco degli americani, nell'uragano di colpi il capodivisione
Andrea Calipari perse la vita, il suo collega Andrea Carpani venne centrato al
petto, anche l'autista venne sfiorato, e solo la Sgrena uscì miracolosamente
incolume. Nonostante lo choc e le polemiche, neanche i retroscena di quella
trattativa sono mai stati ufficialmente resi noti. La sostanza è che si tratta,
da sempre. E forse anche nel 1992, quando magistrati e poliziotti venivano fatti
saltare in aria col tritolo insieme a interi tratti di autostrada, ci fu chi
decise di tastare gli umori dell'altra parte, e non arretrò inorridito quando la
testa di Riina venne offerta in cambio di questa o quella concessione.
L'ideologia contro
Quattrocchi: "I killer non erano terroristi". La Corte d'Assise riconsidera le
motivazioni dell'esecuzione del contractor in Irak. Come se le uniche vite
preziose fossero quelle della Sgrena o delle due Simone, scrive Gian Micalessin
su “Il Giornale”. Incredibile e raccapricciante. Non vi sono altri aggettivi per
definire le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma che manda
assolti due degli assassini di Fabrizio Quattrocchi, la guardia privata rapita
in Irak assieme a Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino che il
14 aprile 2004 davanti agli aguzzini pronti a freddarlo con un colpo alla nuca
urlò «Vi faccio vedere come muore un italiano». Quell'atto di coraggio e di
dignità gli valsero una medaglia d'oro al valor civile che il presidente della
Repubblica Azeglio Ciampi così motivò: «Vittima di un brutale atto terroristico
rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria,
affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo
Paese». Ma gli atti di un Presidente della Repubblica non valgono nulla.
Motivando la sentenza che lascia impuniti Ahmed Hillal Qubeidi e Hamid Hillal
Qubeidi, due responsabili del rapimento catturati durante la liberazione di
Stefio, Agliana e Cupertino, i giudici spiegano che l'identità dei due non è
comprovata, il loro collegamento con gruppi eversivi non è evidente e - dulcis
in fundo - l'esecuzione non è un atto di terrorismo. Insomma i due imputati,
catturati mentre facevano la guardia a Stefio, Agliana e Cupertino, passavano di
lì per caso e non sono stati identificati con precisione neppure durante gli
anni trascorsi nella galera irachena di Abu Ghraib. I nostri giudici
evidentemente la sanno più lunga degli inquirenti americani e iracheni che
interrogarono i due imputati vagliandone generalità e responsabilità. Verrebbe
da chiedersi come, ma porsi domande troppo complesse non serve. Dietro questa
sentenza e le sue motivazioni non c'è il codice penale, ma l'ideologia. La
stessa ideologia formulata dal giudice Clementina Forleo che nel gennaio 2005
assolse dall'accusa di terrorismo il marocchino Mohammed Daki e i tunisini Alì
Toumi e Maher Bouyahia pronti a trasformarsi in kamikaze islamici in Irak. Nella
motivazione del caso Quattrocchi quell'ideologia raggiunge la perfezione. Pur di
mandare liberi due assassini i giudici arrivano a mettere in dubbio che
l'uccisione di un eroe italiano decorato con la medaglia d'oro sia un atto
terroristico. E per convincerci scrivono che «non è chiaro se quell'azione
potesse avere un'efficacia così destabilizzante da poter disarticolare la stessa
struttura essenziale dello stato democratico». Una motivazione sufficiente a far
assolvere anche gli assassini di Moro visto che neppure quell'atto bastò a
disarticolare lo stato italiano. Ma i magistrati superano se stessi quando
tentano di convincerci che il collegamento dei due sospettati con i gruppi
eversivi non è provato. L'assassinio di Quattrocchi viene deciso, come tutti
sanno, per far capire al nostro governo che solo accettando il ritiro dall'Irak
verrà garantita la salvezza degli altri rapiti. Ma evidentemente ricattare
l'Italia uccidendo un suo cittadino e tenendone prigionieri altri tre per 58
giorni non è un atto sufficientemente eversivo. E a far giudicare eversori e
terroristi gli assassini di Quattrocchi non basta neanche l'ammissione di uno
degli aguzzini che racconta all'ostaggio Cupertino di aver partecipato
all'attentato di Nassirya costato la vita a 19 italiani. Quelle per i magistrati
sono semplici vanterie. Ma non stupiamoci troppo. Il problema anche qui non è la
giustizia, bensì l'ideologia. In Italia, persino nelle aule giudiziarie,
qualcuno continua a ritenere che le uniche vite preziose siano quelle di chi la
pensa come lui. Soprattutto se quelli come lui sono «umanitari» di sinistra come
le due Simone o giornaliste «democratiche» come Giuliana Sgrena. Le vite di chi
non la pensa allo stesso modo invece valgono poco o nulla. Per questo uccidere
l'eroe Fabrizio Quattrocchi non è reato.
Ostaggi «buoni» e «cattivi».
Scontro tra destra e sinistra, scrive Paolo Conti su “Il Corriere della Sera”
Possono esistere «buoni» e «cattivi», giudicati a seconda della necessità
polemica da destra e da sinistra, persino tra gli italiani rapiti dai terroristi
iracheni? Ora nelle loro mani, e sul video di Al Jazira, c'è Enzo Baldoni. Ma
proviamo a fare un passo indietro, a tornare ad aprile, quando gli ostaggi si
chiamavano Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino, quando
Fabrizio Quattrocchi venne trucidato dalle Falangi di Maometto. Sui giornali
della sinistra campeggiarono per intere settimane le stesse parole chiave:
«mercenari», «vigilantes». Il manifesto parlò di «privatizzazioni da
combattimento», l'Unità di «Mestiere della guerra». Scoppiò una durissima
polemica quando Vauro, il giorno dopo l'assassinio di Fabrizio Quattrocchi,
nella sua vignetta del giorno sul manifesto mostrò un dollaro penzolante da un
pennone e sotto il titolo «morire per denaro» commentò con la battuta:
«Banconote a mezz'asta». Liberazione insistette sulla tesi della collaborazione
dei quattro italiani con i servizi segreti e irrise Piero Fassino che parlò di
uccisione di un «civile inerme» («Viene da dire: ma di che cosa stanno
parlando?»). Quando il centrodestra definì «eroico» il famoso ultimo momento di
vita di Quattrocchi («ti faccio vedere come muore un italiano») ancora il
manifesto titolò immediatamente «Eroi di scorta». Ora il rito in parte si
ripete, specularmente opposto. La provocazione ieri è venuta da Libero: grande
foto del pacifista Baldoni sotto il titolo «Vacanze intelligenti» e giù, nel
sommario: «Aveva detto: "cerco ferie col brivido". E' stato accontentato». In
perfetta linea con la titolazione il commento di Renato Farina. Si chiede come
mai sia così rilassato nel video di Al Jazira: «Perché dovrebbero fargli del
male? E' un giocherellone della rivoluzione... Dopo le ferie intelligenti,
cominciamo a fare quelle sconvolgenti». Poi, più in là: «Signori di Al Qaeda,
proprio dal vostro punto di vista, non vale la pena di ammazzarlo.
Restituitecelo, farà in futuro altri danni all'Occidente come testimonial della
crudeltà capitalistica». Quanto a Il giornale, è stato l'unico quotidiano a
relegare la notizia in centro pagina, ben al di sotto di due inchieste. Commenta
Franco Debenedetti, senatore ds: «Credo sia giusto cercare una logica nelle
azioni di qualcuno, comprendere il senso delle scelte per esempio nel caso di un
rapimento perché tutto questo può contribuire alla liberazione di un ostaggio.
Ma i commenti così diversi propongono davvero una gran bella gara...» Qual è il
suo giudizio su questo contrasto? «Ricordo che ai tempi dei tre rapiti, questo
insistere sul loro ruolo di "mercenari" suggeriva quasi l'idea che si fossero
andati a cercare una simile sorte. Un modo per esorcizzare il problema, di
allontanarlo, come se il lavoro di vigilante non fosse onorevole come tanti
altri, e anzi spesso indispensabile nella complessa ricostruzione dell' Iraq. E
magari fosse meno nobile di un'occupazione intellettuale come quella del
reporter». E quanto invece alla reazione di Libero? «Sinceramente mi sembra solo
e soltanto agghiacciante. Comunque sia, insisto, mi pare davvero una bella
gara...». Concorda Marcello Veneziani, intellettuale apprezzato dalla destra:
«La figura di Quattrocchi combaciava con una mentalità che aveva caro il senso
dell'onore e l'amor patrio. Invece Baldoni coltiva, lo abbiamo letto, valori
dichiaratamente pacifisti. Motivazioni diverse, lontane, che hanno spinto le
"tifoserie" a schierarsi da una parte e dall'altra, visto che in questa faccenda
sembra contare ancora una labile appartenenza ideologica». E allora, Veneziani?
«Allora sono state eccessive entrambe le reazioni. Voglio dire che sulla
motivazione che spinge qualcuno a una scelta ci possono essere divisioni,
diversità di vedute. Ma sulla vicenda in sé no: sono di rigore in ogni caso
attenzione, rispetto, solidarietà...».
De Luca, quando la rivolta è
un "marchio" da vendere. Dopo decenni di marxismo, sopravvive l'idea che uno
scrittore debba essere militante. Ma di tanto impegno restano solo narcisismo e
nostalgia attira-lettori, scrive Massimiliano Parente su “Il Giornale”.
L'hashtag è #iostoconerri, e ci mancherebbe non stessi con lui, processato per
essersi pronunciato contro la TAV e aver detto che secondo lui sabotarla è
giusto. Uno potrà dire quello che vuole? Si può dire che gli Stati Uniti si sono
abbattuti le Torri Gemelle da soli, si può essere perfino pro-Isis, Giulietto
Chiesa è ancora stalinista, e portiamo in tribunale Erri De Luca? E poi sfiliamo
con i cartelli Je suis Charlie? Ecco, Je suis Errì. Oddio, che effetto. E però
che bello. È uno di quegli scrittori che invidio, e in Italia ce ne sono
tantissimi. Non hanno bisogno di scrivere grandi opere, neppure opere medie.
Errì poi scrive dei librini così tascabili che in tasca ce ne vanno venti, una
pacchia. L'ultimo di Errì si intitola La parola contraria . Quattro euro e ve lo
portate via, generosa la Feltrinelli. Piccolo ma denso: dentro c'è tutta la
coscienza contraria di Errì. Per esempio Errì spiega che «può darsi che nella
mia educazione emotiva napoletana ci fosse la predisposizione a una resistenza
contro le autorità». Una cosa tipo: «Io i tass' nun le pag, ma vattenne và, accà
niusciun'è fess». Oppure: «Chiust'o tren' che sa vò muov' veloce sa da fermà,
compà». Je suis Errì, e un'altra cosa assurda è l'accusa di istigazione: ma vi
pare che Errì possa aver istigato qualcuno a fare qualcosa? Casomai è stato
istigato lui a diventare Errì. Come sono istigati tutti gli scrittori italiani,
convinti da centocinquant'anni di marxismo intellettuale che si debba essere
impegnati civilmente per essere intelligenti. Anzi peggio ancora: intellettuali.
Non per altro perfino Aldo Busi, che non è di Napoli ma di Montichiari, su Alias
denuncia il progresso tecnologico e rimpiange i casellanti. E Antonio Moresco,
che non è di Napoli ma di Mantova, ha organizzato una nuova marcia della nota
serie Cammina Cammina, la Repubblica Nomade, per essere tutti migranti. Che
cagate. No, pardon, Je suis Errì. Che figate. Je suis Errì, e quanto erano belli
i tempi di Lotta Continua. Dove c'erano tutti i migliori intellettuali, scrive
Errì. Anche Pasolinì. E lo stesso Errì. Io non sono mai stato di Lotta Continua,
neppure a favore di Lotta Continua, ma poi per caso ho scoperto che il mio amore
Sasha Grey si è dichiarata simpatizzante di Lotta Continua. E quindi perfetto,
je suis Errì, non voglio più essere Parente, che schifo. «Voglio essere lo
scrittore incontrato per caso, che ha mischiato le sue pagine ai nascenti
sentimenti di giustizia che formano il carattere di un giovane cittadino». Uno
di quegli scrittori «che fa alzare d'improvviso e lasciare il libro perché è
montato il sangue in faccia, pizzicano gli occhi e non si può continuare a
leggere». E io che pensavo fosse l'allergia e stavo cercando un antistaminico.
Invece è perché je suis Errì, il libro sta cominciando a fare effetto, mi sto
trasformando in un giovane cittadino con dei sentimenti di giustizia e
un'educazione emotiva napoletana con il sangue montato in faccia. A questo serve
la letteratura. Per cui, siccome je suis Errì, ho buttato il libro e mi sono
messo a protestare contro uno che ha parcheggiato sulle strisce pedonali, per
sentimento di giustizia. Però poi mi sono accorto che il proprietario della
macchina era negro, pardon di colore, e siccome je suis Errì mi sono scusato,
sarà arrivato sicuramente da Lampedusa, e Errì dice che «dare cibo, acqua,
vestiti, alloggio, premura per gli ammalati, i prigionieri, i morti: le sette
opere di misericordia sono state compiute da loro, che vivono sul mare e usano
leggi opposte. E non sono LampeduSanti, ma semplicemente LampeduSani. La rima
nord e sud, Val di Susa e Lampedusa, riscatta oggi il titolo di cittadini da
prepotenze che li vogliono sudditi». Ma come gli vengono, a Errì, questi giochi
di parole? Val di Susa/Lampedusa, un genio. E poi ho pensato: chissà cosa
succederebbe a scaricare qualche migliaio di profughi al mese direttamente da
Lampedusa in Val di Susa, chissà dove lo manderebbero Errì, i valsusini. Ma poi
ho pensato che era una malignità, i valsusini accoglierebbero tutti con rose e
fiori e canti popolari e cantantando je suis Errì. Perché, questo il senso
profondo delle parole del libro di Errì, «a ogni lettore spetta la sorpresa di
fronte alla mescola improvvisa tra i suoi giorni e le pagine di un libro».
E quando avrete finito di
leggere il libro avrete una bellissima mescola, vi assicuro. E anche voi potrete
dire: Je suis Errì.
LE CROCIATE: ORGOGLIO
CRISTIANO!
La legittimità storica,
religiosa e morale delle crociate.
Ultimamente - per ovvie ragioni - girano vari articoli e interventi sulle
crociate, scrive Massimo Viglione il 25 agosto 2014 su “Il Giudizio Cattolico”.
Ci permettiamo allora di riproporre un articolo specificamente incentrato sulle
ragioni della legittimità storica, religiosa e morale delle crociate, che
speriamo possa essere utile per rispondere alle usuali accuse. E lo facciamo nel
giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di san Luigi IX Re di Francia, il Re
crociato per antonomasia, che di crociate ne fece di sua iniziativa addirittura
due, trovando la morte nella seconda (1270). Per la formulazione di un giudizio
idealmente e storicamente corretto sul fenomeno delle crociate nel suo insieme e
sull’idea di Crociata in sé, occorre a monte richiamarsi ad alcuni princìpi
imprescindibili e attenersi a dati storici precisi: I territori di quella che
per gli ebrei prima di Cristo era la “Terra Promessa” appartenevano appunto agli
ebrei dai tempi di Mosè. I vari conquistatori (e per ultimi i Romani), nel corso
dei secoli, non avevano intaccato questo principio: sebbene sotto conquista
straniera, la Palestina/Israele era di fatto e di diritto la terra degli ebrei,
il Regno di David, l’unico ricevuto e consacrato da e a Dio. Da un punto di
vista religioso e cristiano, gli ebrei, non riconoscendo – e condannando a morte
– il Messia, perdettero per sempre il ruolo di “popolo eletto”, e, di
conseguenza, il diritto a possedere la Terra Promessa, non essendo e costituendo
più di fatto la “sinagoga/Chiesa” di Dio. Con la distruzione del Tempio di
Gerusalemme (unico centro religioso e civile degli ebrei) ad opera dei Romani
(Tito, 70 d.C.) e con la loro cacciata definitiva dalla Palestina (Adriano, 132
d.C.), cambia per sempre la situazione: gli ebrei dovettero in massa abbandonare
la loro terra (diaspora), di cui di fatto (cioè storicamente e politicamente)
persero il controllo e il possesso. Nel frattempo, la Palestina (non più
Israele) da un lato continuò per secoli ad essere una provincia romana,
dall’altro divenne per i cristiani la “Terra Santa” per eccellenza, dove il
Figlio di Dio era nato, vissuto, aveva patito ed era morto e risorto per il
riscatto di ogni uomo dal male e dal peccato, divenendo il Salvatore
dell’umanità. Ciò significava, idealmente e in concreto, che la Palestina era
ora appunto la “Terra Santa” in quanto terra di salvezza di ogni battezzato al
mondo. Ciò fu ancora più evidente a tutti quando nel 380 d.C. l’Imperatore
Teodosio a Tessalonica proclamò il Cristianesimo “Religione dell’Impero”. Roma
si era fatta cristiana e lo stesso Vicario di Cristo risiedeva a Roma: era
chiaro insomma che la Terra Santa apparteneva a Roma non più solo politicamente
e militarmente, ma anche spiritualmente. Con la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente (476 d.C.), la Terra Santa rimase ancora per due secoli provincia
dell’Impero Romano d’Oriente, quindi “romana” e “cristiana” allo stesso tempo.
Nella prima metà del VII secolo nasce una nuova religione, l’Islam, e nella
seconda metà i musulmani conquistano la Terra Santa. Ora, è evidente a tutti che
quella che era stata prima la Terra Promessa per gli ebrei, poi il Regno di
Israele, poi provincia romana, infine la Terra Santa dei cristiani, nulla aveva
a che vedere con gli arabi-islamici, se non per diritto di violenza. L’avevano
conquistata manu mulitari, e perseguitavano i cristiani ivi residenti e i
pellegrini. Questa premessa era necessaria per chiarire due principi a monte:
1) l’inesistenza assoluta da parte islamica di un diritto al possesso della
Terra Santa, se non la mera forza della violenza; 2) la perduta legittimità da
parte ebraica al possesso della Terra Santa, con il passaggio dall'Antico al
Nuovo Testamento. Questa premessa era necessaria per chiarire due principi a
monte: 1) l’inesistenza assoluta da parte islamica di un diritto al possesso
della Terra Santa, se non la mera forza della violenza; 2) la perduta
legittimità da parte ebraica al possesso della Terra Santa con il passaggio
dall’antico al nuovo Testamento. 2) la perduta legittimità da parte ebraica al
possesso della Terra Santa, con il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento. A
tali questioni di principio, occorre poi unire il dato storico degli eventi dei
secoli susseguenti, vale a dire il fatto che dal VII all’XI secolo l’Islam ha
sistematicamente attaccato e invaso manu militari gran parte delle terre di
quello che era l’Impero Romano d’Occidente (premendo nel contempo senza sosta
alle porte di quello d’Oriente), conquistando gran parte del Medio Oriente,
l’Africa del Nord, la Penisola Iberica, tentando di varcare i Pirenei, poi
occupando la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, risalendo con scorrerie fino a
Lione e poi in Svizzera e alle Alpi, ponendo delle enclave fisse vicino Roma (le
basiliche di San Pietro e San Paolo e l’abbazia di Montecassino furono
distrutte), ma soprattutto terrorizzando per secoli le popolazioni cristiane
mediterranee, specialmente quelle italiane. Quattro secoli di invasioni militari
(massacri di uomini, deportazioni di donne negli harem, conversione forzata dei
bambini) e razzie, di cui nessuno mai potrà fare il calcolo non tanto dei danni
materiali, quanto del numero dei massacrati e del dolore immenso causato a
intere generazioni di cristiani, senza che questi potessero in alcun modo
contrattaccare. Gli stessi pellegrini che andavano in Terra Santa venivano
spesso massacrati, specie a partire dall’XI secolo, con l’arrivo del dominio dei
turchi selgiuchidi. Tutto quanto detto deve essere tenuto presente prima di
emettere qualsivoglia giudizio storico e morale sulla crociate: non si può
infatti presentare i crociati come una “banda di matti fanatici” e ladri che
calò improvvisamente in Palestina per rubare tutto a tutti e uccidere i poveri
musulmani indifesi. Ciò è solo ridicolo, evidentemente sostenuto da chi non
cerca la verità storica ma è mosso solo dal suo odio anticristiano (o dalla sua
simpatia filoislamica). Come sempre ufficialmente dichiarato dalla Chiesa
tramite la voce dei Papi e dai teorici del movimento crociato (fra questi, san
Bernardo di Chiaravalle) e dai teologi medievali (fra gli altri, san Tommaso
d’Aquino e anche santa Caterina da Siena), lo scopo e la legittimità delle
crociate risiedono nei seguenti princìpi fondamentali:
Il diritto/dovere assoluto
della Cristianità a rientrare in possesso dei Luoghi Santi;
La difesa dei pellegrini (e a
tal fine nacquero gli Ordini monastico-cavallereschi);
La legittima difesa dai
secolari assalti della Jahad islamica. Come si può notare, tutti e tre i
princìpi indicati si fondano pienamente sul diritto naturale: quello del
recupero della legittima proprietà privata lesa, quella della difesa del più
debole dalla violenza ingiustificata, quello della legittima difesa da un nemico
ingiustamente invasore. È interessante notare a riguardo che le fonti islamiche
sulle crociate, pur accusando i crociati di atti barbarici e stragisti di ogni
genere, mai mettono però idealmente in dubbio il loro diritto alla riconquista
dei Luoghi della Redenzione di Cristo. Da conquistatori, essi sanno che il
diritto del più forte, su cui essi si fondano, prevede anche il contrattacco. A
questi tre princìpi poi, santa Caterina da Siena ne aggiunge un altro: il
doveroso tentativo di conversione degli infedeli alla vera Fede, per la loro
salvezza eterna, bene supremo di ogni uomo. Per necessaria completezza, occorre
tener presente poi che il movimento crociato non si esaurì nell’ambito dei due
secoli (1096-1291) in cui avvennero la conquista e la perdita della Terra Santa
da parte cristiana (crociate tradizionali); infatti, a partire dal XIV secolo, e
fino agli inizi del XVIII, con l’avanzata inarrestabile dei turchi ottomani, di
crociate se ne dovettero fare in continuazione; questa volta però non per
riprendere i Luoghi Santi, ma per difendere l’Europa stessa (l’Impero Romano
d’Oriente cadde in mano islamica nel 1453) dalla conquista musulmana. I soli
nomi di Cipro, Malta, Lepanto, Vienna (ancora nel 1683) ci dicono quale immane
tragedia per secoli si è consumata anche dopo le stesse crociate “tradizionali”
e ci testimoniano un fatto incontrovertibile e di importanza capitale: per
quattro secoli prima e per altri quattro secoli dopo le crociate “tradizionali”,
il mondo cristiano è stato messo sotto attacco militare dall’Islam (prima arabo,
poi turco), subendo quella che può definirsi la più grande e lunga guerra
d’assalto mai condotta nella storia, in obbedienza ai dettami della Jahad
(Guerra Santa) voluta e iniziata da Maometto stesso. Mille anni di guerre. Per
questo, occorre essere sereni, preparati e giusti nei giudizi. Le crociate
furono insomma anzitutto guerre di legittima difesa e di riconquista di quanto
illegittimamente preso da un nemico invasore. Pertanto, ebbero piena legittimità
storica e ideale (ciò non giustifica, ovviamente, tutte le violenze gratuite
commesse da parte cristiana nel corso dei secoli). Ancor più ciò è valido a
partire dal XIV secolo, quando l’unico scopo del movimento crociato divenne la
difesa della Cristianità intera aggredita dai turchi.
COME GLI STORICI ARABI
RACCONTARONO LE CROCIATE.
Ho letto
libri e notizie sulle Crociate ma gli avvenimenti storici sono sempre visti dal
lato cattolico. Esistono libri sullo stesso argomento in cui la vicenda è vista
da storici islamici? Scrive Giuseppe Santarelli su “Il Corriere della Sera” il 5
agosto 2012. Caro Santarelli, N el 1829 apparve a Parigi un libro intitolato
Chroniques arabes. Era opera di un grande arabista francese, Joseph Toussaint
Reinaud, e presentava al lettore un’antologia di brani tratti da opere di
cronisti arabi dell’epoca delle crociate. Reinaud fu maestro di Michele Amari
(ministro della Pubblica istruzione dal 1862 al 1864, autore di una Storia dei
musulmani in Sicilia) e aveva lungamente lavorato per la sua opera su
manoscritti arabi conservati nella Biblioteca del Re. Più tardi, fra il 1872 e
il 1906, molti testi integrali apparvero in un grande Recueil des historiens des
Croisades a cura di Charles Barbier de Meynard. Fu allora possibile leggere le
cronache di molti storici noti nel mondo arabo fra cui Ibn al-Athir, Bahà
ad-din, Abu Shama, Abu l-Fidà. Ho tratto queste notizie dalla introduzione di
Francesco Gabrieli (uno dei maggiori arabisti italiani del secolo scorso) a un
libro, Storici arabi delle Crociate, apparso presso Einaudi nel 1963. Gli autori
scelti e tradotti da Gabrieli sono quindici fra cui Imàd ad-din al-Isfahani che
fu segretario del Saladino e autore di una storia della conquista di Gerusalemme
continuata sino alla morte del grande combattente curdo. I toni e gli accenti
delle storie arabe non sono diversi da quelli delle storie cristiane: lo stesso
ardore religioso, lo stesso amore per i propri luoghi santi (il Santo Sepolcro
per gli uni, la Santa Roccia da cui Maometto salì in cielo per gli altri), la
stessa caratterizzazione spregiativa dei nemici: cani saracini nelle cronache
cristiane, porci cristiani nelle cronache arabe. Fra i testi tradotti da
Gabrieli vi è quello di una delle molte tregue che furono firmate dai
contendenti durante le loro interminabili guerre. Si compone di due documenti
paralleli nei quali ciascuno dei due firmatari invoca tre volte il proprio Dio,
i propri sacri testi, il proprio messia e promette di punire se stesso, se
romperà la tregua, con una stessa penitenza: trenta pellegrinaggi alla Mecca per
il negoziatore arabo, trenta pellegrinaggi a Gerusalemme per il negoziatore
cristiano. Ciascuno dei due negava la verità della fede professata dall’altro,
ma entrambi accettavano un patto in cui ogni firmatario aveva giurato in nome
del proprio Dio. Non si combattevano, in altre parole, perché erano radicalmente
diversi. Si combattevano perché erano straordinariamente simili.
"Le
crociate non furono aggressione colonialista ma legittima difesa", scrive
Dino Messina su "Il
Corriere della Sera” il 16 settembre 2008. La rivista <storia in rete> pubblica
un estratto dal libro di Robert Spencer edito da Lindau (pagina 336, euro 19)
intitolato <Guida (politicamente scorretta) all’Islam e alle Crociate>.
L’autore elenca una serie di aggressioni compiute dai musulmani ai danni dei
cristiani già a partire dal VII secolo: la conquista islamica di Gerusalemme nel
638, le violenze contro i pellegrini cristiani come quelli giustiziati dal
governatore musulmano di Cesarea; il saccheggio del monastero di San Teodosio
a Betlemme avvenuto nel 789 con la decapitazone di diversi religiosi; la jihad
invocata dal califfo di Baghdad per rispondere all’avanzata dei bizantini
guidati da Niceforo Foca, eccetera. Nel 1009, scerive Spencer, il
califfo al-Hakim <pronunciò contro i cristiani la sua più clamorosa
disposizione: ordinò la distruzione della chiesa del Santo Sepolcro di
Gerusalemme insieme a quella di molte altre chiese>. Dopo grandi affermazioni e
conquiste al-Hakim allentò la presa ma gli scontri proseguirono dopo la sua
morte. Nel 1071 i musulmani sbaragliarono i bizantini a Manzicerta e fecero
prigioniero l’imperatore Romano IV Diogene. <Le porte dell’intera Asia Minore –
scrive Spencer – si spalancarono e l’avanzata dei musulmani divenne
inarrestatibile. Nel 1076 conquistarono la Siria, nel 1077 Gerusalemme>. Fu in
questa situazione che maturò l’apello lanciato da Alessio I Comneno (1081-1118)
, al quale papa Urbano II (nell’immagine) rispose nel 1095 al Concilio di
Clermont bandendo la Prima crociata. Nell’appello del papa non si faceva
riferimento a conversioni forzate o a espansioni territoriali ma soltanto a
riconquistare terre in precedenza cristiane. Non tutti i crociati, osserva
Spencer, erano mossi dalle migliori intenzioni. Però è falso <il dogna
politicamente corretto secondo cui le crociate sarebbero ingiustificate azioni
imperialiste contro una pacifica popolazione indigena di religione musulmana (…)
e più che un’autentica ricerca storica riflette una certa ripugnanza per la
civiltà occidentale>.
Così Obama offende la
storia.
Sostenere che i terroristi
islamici e i crociati cristiani siano la stessa cosa, significa essere ignorante
della realtà dell'islam, scrive Magdi Cristiano Allam Sabato 07/02/2015 su “Il
Giornale”. Obama ci odia. Sostenere che i terroristi islamici e i crociati
cristiani siano la stessa cosa, significa sia essere ignorante della realtà
dell'islam arrivando a glorificarlo, sia coltivare un pregiudizio nei confronti
del cristianesimo arrivando a criminalizzarlo. Nel suo intervento alla Casa
Bianca in occasione della «Preghiera nazionale», Obama ha detto che «durante le
Crociate e l'Inquisizione la gente ha commesso atti terribili in nome di
Cristo», e che «nel nostro Paese la schiavitù e Jim Crow (leggi sulla
segregazione razziale) troppo spesso sono state giustificate nel nome di
Cristo». Per contro Obama ha assolto l'islam, affermando che «coloro che
perpetrano la violenza e il terrore sostenendo di farlo nel nome dell'islam, in
realtà tradiscono l'islam». È del tutto evidente che Obama non sa che Allah nel
Corano legittima il terrorismo, la decapitazione e le mutilazioni corporee al
punto da rivendicarne la paternità: «Getterò il terrore nei cuori dei
miscredenti: colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi! (...)
Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi» (8, 12-17).
Così come non sa che Maometto in un suo detto, confessa: «Ho vinto grazie al
terrore» (Bukhari 4:52.220). Soprattutto non sa che Maometto praticò il
terrorismo partecipando di persona alla decapitazione di circa 800 ebrei della
tribù dei Banu Qurayza nel 627 alle porte di Medina. Giustamente il senatore
repubblicano Jim Gilmore ha detto che Obama «ha offeso ogni credente cristiano
negli Stati Uniti. Siamo arrivati al punto che Obama non crede nell'America né
condivide i valori che noi tutti condividiamo». Ricordiamo che Obama è di
famiglia islamica, il suo secondo nome è Hussein, ha un fratellastro, Malik
Obama, che è un sostenitore dei Fratelli musulmani che si sono infiltrati nella
sua amministrazione. Il 13 maggio 2004 Benedetto XVI, quando era ancora il
cardinale Joseph Ratzinger, fece una lucida e profetica descrizione del suicidio
dell'Occidente che calza a pennello all'Obama relativista e islamofilo: «C'è qui
un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo come
qualcosa di patologico; l'Occidente tenta sì in maniera lodevole di aprirsi
pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso; della sua
propria storia vede oramai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre
non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro». Proprio ieri il
vescovo armeno-cattolico di Aleppo, monsignor Boutros Marayati, ha lanciato una
pesante accusa: «Noi, come cristiani, abbiamo questo sentimento: che siamo
dimenticati, siamo tralasciati, siamo traditi dall'Occidente». A parte il fatto
che le Crociate, combattute tra l'XI e il XIII secolo, furono sferrate tre
secoli dopo l'invasione violenta della sponda orientale e meridionale del
Mediterraneo e la sottomissione forzata all'islam dei cristiani che
rappresentavano il 99% della popolazione, e dopo la conquista islamica della
Spagna e della Sicilia, così come furono concepite come una guerra di
liberazione del Santo Sepolcro, ebbene nessun crimine commesso dai cristiani può
essere legittimato sulla base delle opere di Gesù o dei testi dei Vangeli.
All'opposto i crimini perpetrati dagli islamici sono legittimati da Allah, dal
Corano e da Maometto. Consigliamo ad Obama, prima di reiterare l'esaltazione
dell'islam, di leggersi il Corano. Ed è la cura che consigliamo a tutti coloro
che amano a tal punto i musulmani da finire per odiare se stessi.
Se l'espressione "crociato"
diventa simbolo di vergogna.
Il ministro
degli Esteri Gentiloni obbedisce ciecamente alla vulgata dei nemici della
cristianità. Ma quei cavalieri rischiavano vita, soldi e prestigio grazie a una
fede oggi inconcepibile, scrive Camillo Langone Giovedì 19/02/2015 su “Il
Giornale”. «Non siamo crociati» dice il ministro Paolo Gentiloni. Purtroppo,
dico io. Storicamente per farsi crociati bisognava avere molta fede, molta
speranza e molto denaro: basta questo per escludere la possibilità che gli
italiani di oggi, increduli, depressi e squattrinati, possano imbarcarsi in
simili vaste operazioni. «Intraprendete questo cammino in remissione dei vostri
peccati», disse Papa Urbano II nel famoso appello di Clermont, rivolgendosi a
una cristianità che in quel tempo al peccato ci credeva davvero, e capisco che
la cosa sia difficile da comprendere per un tardo sessantottino come Gentiloni,
cresciuto politicamente nel Movimento studentesco di Mario Capanna e poi nel
Pdup, il Partito di unità proletaria, non so se mi spiego. Le crociate non
furono quindi solo spedizioni militari ma anche espiazioni e pellegrinaggi.
Pellegrinaggi armati, certo, perché allora, come del resto oggi, nelle terre
sottomesse al Corano i cristiani rischiavano la pelle. Qualche esempio:
all'inizio dell'ottavo secolo sessanta pellegrini vennero crocefissi; pochi anni
dopo uno dei soliti sciagurati califfi fece marchiare sulla mano tutti gli ebrei
e tutti i cristiani di Gerusalemme, anticipando così la famigerata stella gialla
di hitleriana memoria; la domenica delle Palme del 937 i musulmani distrussero
le chiese del Calvario e della Resurrezione; eccetera. Libertà di religione,
questa sconosciuta. Fra un bagno di sangue e l'altro, e quindi nei momenti in
cui al potere c'erano i musulmani cosiddetti moderati, i cristiani venivano
semplicemente taglieggiati, tartassati, forzati alla conversione,
impossibilitati a trasmettere la fede ai propri figli. Robe così. Ho detto che i
crociati erano animati da una fiducia in Cristo talmente forte da essere oggi
inconcepibile non solo da un Gentiloni ma anche da un cattolico praticante
medio, e poi dalla speranza di una ricompensa ultraterrena, e infine da una
notevole capacità di spesa. Non c'erano voli low cost, il viaggio era
lunghissimo e ognuno doveva armarsi a proprie spese: avete idea di quanto
costasse un'armatura? Le corazze erano gli F-35 dell'epoca, altissima ed esosa
tecnologia. Goffredo di Buglione, che non era uno scalzacani bensì un potente
signore feudale i cui possedimenti andavano dal Lussemburgo a Bruxelles, il
cuore dell'odierna Europa atea e inerte, dovette vendere o più probabilmente
svendere buona parte delle sue terre. Altro che occasione di arricchimento, per
tanti partecipanti le crociate significarono la rovina economica. E pure
politica: i pochi cavalieri che fecero ritorno in Europa, i pochi sopravvissuti
ai disagi, alle malattie e alle scimitarre, si trovarono soppiantati nelle
posizioni di potere dall'emergente borghesia urbana. Insomma i crociati erano
dei nobili idealisti che difendevano, con i metodi spicci propri dell'epoca, i
pellegrini e la libertà religiosa, eppure Gentiloni con loro non vuole
mescolarsi. Io dico che, se fosse vivo, Riccardo Cuor di Leone non vorrebbe
mescolarsi con lui. Il nostro ministro degli Esteri, cuor di renziano e quindi
propenso ai machiavellismi più che agli eroismi, riguardo alla crisi libica ha
detto alla Camera che «l'unica soluzione possibile è quella politica». Come dire
che non c'è soluzione alcuna e che dobbiamo rassegnarci a venire invasi da Sud.
Secondo lui dovremmo mediare, dialogare, negoziare: ma con chi? Per interloquire
bisogna avere di fronte un interlocutore e in Libia gli interlocutori sono
centomila e nessuno. Non c'è nemmeno un Saladino con cui tentare di venire a
patti: solo bande di tagliagole barbuti e governicchi che non governano nemmeno
le periferie delle città in cui hanno sede. E meno male che, secondo un collega
piddino, il titolare della Farnesina è «uno sgobbone, uno che approfondisce i
dossier fino all'ultima pagina». Pare fosse studiosissimo anche ai tempi della
scuola, del prestigioso liceo Tasso e della Sapienza, ma i libri non bisogna
soltanto leggerli e magari ripeterli a pappagallo il giorno dell'esame, bisogna
anche capirli. Un ministro europeo non dovrebbe aderire così ciecamente, così
masochisticamente alla vulgata antieuropea del nostro nemico. Qualcuno dovrebbe
avvisarlo che nel XII secolo lo scrittore musulmano Ibn Jubayr osservò che i
musulmani preferivano vivere nelle terre amministrate dai crociati piuttosto che
nei vari califfati: proprio come oggi molti musulmani preferiscono vivere nella
civile Europa anziché in Siria o in Irak. La smettesse di vituperare qualcosa
che non conosce, Gentiloni, e comunque si rassicuri: no, noi non siamo crociati,
non siamo degni delle Crociate noi.
Le crociate? I buoni
eravamo noi,
scrive Rino Cammilleri Lunedì 29/03/2010 su “Il Giornale”. Chi ha
visto il film di Ridley Scott Le crociate è stato confermato nell'idea che
dall'Illuminismo in poi l'Occidente ha sul tema: a) i crociati erano rozzi e
crudeli, mentre gli islamici erano raffinati e tolleranti; b) l'imperialismo
europeo attaccò senza provocazione i pacifici musulmani; c) Saldino era un
galantuomo e i crociati dei farabutti; d) da allora i musulmani ci odiano con
ragione. Questo mucchio di corbellerie è ribaltato nel più bel libro che mai sia
stato scritto sull'argomento: Gli eserciti di Dio. Le vere ragioni delle
crociate (Lindau, pagg. 365, euro 24,5) di Rodney Stark. Sì, perché è vero
l'esatto contrario di tutti i punti summenzionati. Innanzitutto, i musulmani
cominciarono a interessarsi alle crociate solo quando l'Occidente le mise loro
in testa, cioè alla fine del XIX secolo. Non solo gli arabi contemporanei quasi
non se ne accorsero, perché si trattava solo di invasioni periodiche durate poco
e per nulla rivolte contro l'islam in quanto tale. Anzi, i musulmani sudditi dei
regni latini di Palestina e Siria erano pure contenti perché i cristiani non li
consideravano dhimmi (diversamente da quanto facevano i governanti islamici con
cristiani ed ebrei) e le tasse che pagavano erano più leggere che nei
circostanti regni musulmani. «Per molti arabi, inoltre, le crociate non furono
che attacchi sferrati contro gli odiati turchi». Infatti, fu quando arrivarono,
a mano armata, i turchi - che massacravano i pellegrini - che ebbero inizio le
crociate. Le quali ebbero il merito, per la civiltà europea, di fermare
l'espansionismo turco per due secoli, dopo i quali l'Europa si ritrovò a doversi
difendere fin dentro casa per i successivi quattro. Per quanto riguarda il
Saladino, il romanticume sulla sua figura ammaliò anche il Kaiser, Guglielmo II,
il quale depose sulla sua tomba una corona bronzea d'alloro (che poi Lawrence
d'Arabia, come tutti gli arabi nemico dell'Impero ottomano, fece sparire). Nel
film succitato il giudizio è identico. Eppure, dopo la disfatta inflitta ai
cristiani ad Hattin, così il suo segretario, Imad ad-Din, descrisse quel che fu
fatto ai templari e agli ospitalieri catturati: «Ordinò che fossero decapitati,
preferendo l'ucciderli al farli schiavi. C'era presso di lui tutta una schiera
di dottori e sufi, e un certo numero di devoti e asceti: ognuno chiese di
poterne ammazzare uno», cosa che Saladino concesse volentieri. Non è vero che
mandò liberi tutti gli abitanti di Gerusalemme: metà di questi non poté pagare
l'esoso riscatto e fu venduta schiava. Stark dice la sua anche sulla famosa
Quarta crociata, quella che conquistò Costantinopoli anziché la Terrasanta. E
anche qui rimette le cose a posto. Fin dalla prima spedizione, i bizantini
avevano sempre mantenuto un atteggiamento sleale nei confronti dei crociati,
tradendoli a più riprese. Addirittura, l'imperatore Isacco II si era alleato col
Saladino contro i latini per favorire i greco-ortodossi; presa la Terrasanta,
Saladino, secondo i patti, aveva consegnato a questi ultimi ogni chiesa latina.
Ora, ancora un volta, la richiesta d'aiuto era partita da Costantinopoli e
ancora una volta gli europei avevano risposto. E ancora una volta, giunti sul
posto, erano stati traditi. Così, stimarono che l'unico sistema per non essere
pugnalati alle spalle era insediare uno di loro a Costantinopoli. Un'altra
leggenda nera da sfatare è il massacro seguito alla presa di Gerusalemme da
parte di Goffredo di Buglione alla prima crociata: la città conteneva sui
diecimila abitanti, dei quali caddero solo duemila. Nulla a che vedere con i
massacri indiscriminati compiuti dai musulmani, specialmente quelli di Baibars e
dei mamelucchi, che causarono la fine dei regni latini in Oriente. Massacri, per
giunta, tutti compiuti in dispregio della parola data: ambasciatori decapitati,
i monaci del Monte Carmelo interamente trucidati, eccetera. Il «peggiore
massacro dell'intera epoca delle crociate» fu quello di Antiochia, perpetrato
dal musulmano Baibars. Eppure, eccone il ricordo da parte degli storici
occidentali: «Steven Runciman gli dedica ben otto righe; Hans Eberhard Mayer
una; Cristopher Tyerman, che si era dilungato per molte pagine sugli efferati
dettagli del massacro di Gerusalemme nella prima crociata, liquida la
carneficina di Antiochia in quattro parole; Karen Armstrong riserva dodici
parole al resoconto della strage, di cui attribuisce poi la colpa agli stessi
crociati, poiché era stata la loro minaccia a creare un "nuovo islam"». Perché
fallirono le crociate? Dopo aver fatto presente che i regni latini d'Oltremare
pur ebbero la stessa durata degli odierni Stati Uniti, Stark punta il dito sulle
tasse: mantenerli dissanguava l'Europa. Circondati dalla marea ostile, lontani
migliaia di chilometri da casa, richiedevano continui rifornimenti di uomini e
mezzi, nonché spedizioni ricorrenti per difenderli o riconquistarli. La fede
(sì, la fede) aveva reso sopportabile ogni sacrificio e ogni defaillance era
stata imputata ai peccati dei cristiani. Ma quando un santo come Luigi IX vi
fallì (e morì) nel corso di ben due delle spedizioni in assoluto meglio
organizzate, i cristiani si chiesero se davvero «Dieu le volt» o non era il caso
di lasciare per sempre i Luoghi Santi al loro destino.
“No alla damnatio memoriae
sulle crociate”. Parla lo storico Tyerman, scrive
Giulio Meotti il 15 Ottobre 2012 su “Il Foglio”. Per i crociati sembra
non valere neppure il detto “de mortuis nihil nisi bonum”. Non è un caso che la
magnifica trilogia di Sir Steven Runciman, la bibbia della storiografia crociata
adottata dalle università di mezzo mondo, sia stata pubblicata negli anni della
decolonizzazione del medio oriente. Fu allora che il senso di colpa divenne un
ottimo combustibile anche nella scrittura sulle crociate. Da allora una
letteratura ostile a tutta quell’epopea storica si radicò nell’immaginazione
occidentale. Riccardo Cuor di Leone, Tasso, i romanzi di Walter Scott e i drammi
di Paul Claudel sono stati ridotti al rango di pizzi elisabettiani. Ma adesso
arriva uno storico di Oxford, il medievista Christopher Tyerman, che in Italia
esce per le edizioni Einaudi con “Le guerre di Dio”. Il libro è frutto del
meglio della storiografia anglosassone: potenza stilistica e sintesi paziente
delle fonti storiche. “Ogni tipo di storiografia è ‘postmoderna’ per
definizione, costruita dagli osservatori anziché sulla realtà”, dice Tyerman al
Foglio. “Tuttavia, sulle crociate ci sono stati quasi soltanto stereotipi come
il binomio arabi civilizzati contro cristiani barbari. C’è stata una damnatio
memoriae. I protestanti del XVI secolo condannarono le crociate come un esempio
della corruzione della fede cattolica, gli illuministi le videro come esempio di
ignoranza e di superstizione, mentre i materialisti del XIX secolo hanno visto
le crociate come una forma di imperialismo occidentale ante litteram. Con questo
studio ho voluto combattere i molti miti e pregiudizi”. Il mito prevalente, dice
Tyerman, è che “le crociate fossero un assalto barbarico su un islam pacifico,
superiore e sofisticato, una forza benigna rovinata da questi maligni di
occidentali. E’ un non senso. Le guerre della croce sono divenute un cattivo
odore persistente in una dimora di lusso appena restaurata”. In questo le
crociate sono state svilite “come un fenomeno puramente distruttivo”, frutto di
un modo di pensare post illuministico secondo Tyerman, che deriva
“dall’incomprensione che ha fatto seguito all’illuminismo sul ruolo pubblico
della religione”. Dietro alle crociate c’era “una visione idealizzata della
chiesa, l’idea che la corruzione avesse consentito la conquista dei luoghi
cristiani da parte dell’islam, la riconquista delle terre perse in Spagna,
Sicilia e mediterraneo orientale e il rinnovamento attraverso la grazia”. Le
crociate non furono “un’eccentrica barbarie”, dice lo storico, ma “un momento
rivelativo per la fiducia della civiltà occidentale”. Tyerman non vuole certo
esaltarle, ma riportarle al loro contesto originario. “E’ necessario tornare a
valorizzare la dimensione religiosa e spirituale delle crociate senza
appiattirle sul fenomeno puramente materiale”. Che significa? “Non c’era ragione
strategica per i cavalieri occidentali di andare nelle colline della Giudea,
erano là per ragioni ideologiche e religiose. Degli aristocratici un terzo morì
in battaglia, altri dicono fino al settanta per cento. Il loro profitto, almeno
così lo vedevano, erano l’indulgenza spirituale e la prospettiva del paradiso,
non la terra. Se pensiamo alle crociate di Gerusalemme e a quelle sul Baltico, i
principi non avevano alcun interesse economico per lanciarsi alla conquista di
quelle terre, reclutare truppe, fondi e armi. Se volevano delle terre, i
principi non avevano che da scegliere fra quelle vicine alla propria città.
Molti dei finanziatori delle crociate persero intere fortune in guerra”. Non
solo, ma secondo lo storico “le crociate, lungi dall’essere un anacronismo,
furono uno stimolo all’epoca europea della scoperta”. Tyerman biasima dunque
questo “multiculturalismo storiografico” che ha alimentato un senso di colpa. “E
l’enfasi sulla colpa ha spinto i cristiani a un atteggiamento remissivo sul
proprio passato, quando ci troviamo di fronte a un ideale che fu capace di
ispirare sacrifici di portata e intensità a volte quasi inimmaginabili”.
Nel nono centenario della
conquista di Gerusalemme, la "Civiltà Cattolica" si dissocia dai "mea culpa"
della Chiesa: "Quante interpretazioni superficiali". I gesuiti: "Le Crociate,
una storia da rivalutare". Messori: "Finalmente" Cardini: "Dal ' 700 troppi
equivoci". In coincidenza con il nono centenario della conquista cristiana di
Gerusalemme, avvenuta nel 1099, con la vittoriosa conclusione della prima
spedizione in Terrasanta condotta da Goffredo di Buglione (il "difensore del
Santo Sepolcro"), La Civiltà Cattolica, rivista dei gesuiti, rivaluta le
Crociate. Questa non sarebbe una notizia, se la Chiesa Cattolica negli ultimi
tempi non avesse mostrato segni di "pentimento" nei confronti degli attacchi
medievali contro i musulmani, nel corso di quella che e' stata definita la
"cristianizzazione armata". Il mea culpa sulle crociate non e' una posizione
isolata della Chiesa, ma fa parte di una linea che nel suo percorso tocca
eretici come Savonarola e Giordano Bruno, le vittime dell'Inquisizione e gli
ebrei. Ecco perchè l'attuale pensiero della Compagnia di Gesù sulle spedizioni
in Terrasanta suona come una inversione di tendenza. "Ben lungi dall'essere
state inutili o nefaste, le Crociate contribuirono a creare situazioni storiche
positive, che sfociarono in processi internazionali tuttora aperti e di vitale
importanza", si legge su Civiltà Cattolica, la quale critica le valutazioni
"troppo superficiali sull'evento storico" e invita gli studiosi ad accostarvisi
liberi dai condizionamenti ideologici. E' il gesuita Carmelo Capizzi, docente di
storia medievale alla Pontificia Università Gregoriana a "riscattare" le
Crociate da quella che egli considera una storiografia d'impronta laicistica e
perciò fortemente condizionata. Ci furono degli errori, ammette Capizzi, ma essi
non giustificano la condanna delle Crociate, che, a suo parere, sono da
considerare un fattore di progresso sociale e culturale. "Sbagliano", conclude
Capizzi, "coloro i quali attribuiscono alla Crociata finalita' che essa non si
propose mai, come ad esempio quella di propagandare la fede a mano armata". "Era
ora", commenta sarcastico lo scrittore cattolico Vittorio Messori. E spiega:
"Siamo al paradosso. Ormai tutta la Chiesa è in ginocchio a chiedere perdono
perchè esiste ancora, promettendo di essere più buona. Dal Papa al vice parroco
sono lì a battere il vestra culpa sul petto di coloro che non possono più
difendersi". Messori è esplicito: "Siamo indignati e scandalizzati per le
Crociate, mentre si dimentica che a Gerusalemme quando vi arrivarono i musulmani
vi abbatterono tutte le chiese della cristianità, così come fecero nel Nord
Africa, in Turchia, nella parte di Spagna che occuparono per ottocento anni. Ora
perfino i gesuiti si sono accorti che a chiedere scusa non devono essere i
cristiani, ma altri, quelli che dove sono arrivati hanno distrutto la
cristianità". Per lo storico Franco Cardini gli equivoci su questo problema
nascono da una visione riduttiva della storia: "Si enuclea il fatto militare (la
Crociata) da un contesto profondamente denso e positivo". Per meglio valutare la
questione, aggiunge Cardini, "bisognerebbe reinserirla nel suo contesto storico
e allora molte polemiche non avrebbero più ragione d'essere". "D'altra parte",
spiega lo storico medievalista, "la parola Crociata è un'espressione moderna
che, sistematicamente, si usa soltanto dal XVIII secolo. Fino ad allora c' erano
termini che definivano il "crociato", ma non esisteva la parola astratta. Questo
significa che parlando di Crociate dal 1700 a oggi si e' fatta tutta una serie
di generalizzazioni ingannatorie". Matteo Collura
E in Israele l'intellettuale
Meron Benvenisti ridimensiona l'importanza delle truppe di Goffredo di Buglione
"I soldati del Papa? Furono solo turisti" Meron Benvenisti la chiama "la
strumentalizzazione paradossale delle Crociate". E la riassume così: "Gli arabi
portano ad esempio la caducità dell'invasione cristiana per dire che l’impresa
sionista farà la stessa fine. Gli israeliani, al contrario, esaltano gli 88 anni
della presenza crociata a Gerusalemme e quasi 200 nella regione per dimostrare
che questa è stata una terra di continue invasioni e relativizzare così i 1.400
anni di dominio musulmano". E' l'ennesima provocazione di questo intellettuale
che fu vicesindaco di Gerusalemme nei primi anni Settanta, ma è conosciuto
soprattutto per i suoi libri di denuncia delle ingiustizie ai danni della
popolazione araba e contro l'occupazione israeliana di Cisgiordania e Gaza. Ma è
anche un esperto del periodo crociato e ne ha scritto sul quotidiano Ha' arez
denunciando lo "stravolgimento dei fatti avvenuti 900 anni fa". Vuol dire che i
crociati furono molto meno importanti per la storia del Medio Oriente di quanto
venga presentato oggi? "Mi limito a sottolineare l'uso e l'abuso, magari non
intenzionale, che una parte dei nostri storici fa delle Crociate. La loro è
spesso una lettura funzionale al progetto sionista. Mirano cioè a dimostrare che
questa terra dalla distruzione del Secondo Tempio nel 70 dopo Cristo al Mandato
britannico è stata costantemente invasa da popolazioni straniere. In questo modo
gli ebrei appaiono come i legittimi proprietari della regione che, scacciati dai
vari invasori per 2.000 anni, adesso tornano a casa". Aggiunge Benvenisti: "Si
tende anche a dimenticare che decine di palazzi e castelli indicati da noi come
"crociati" esistevano già, oppure vennero in seguito ampliati dai musulmani.
Anche nel periodo d'oro dei regni crociati i loro abitanti cristiani non furono
mai più di 120.000 e oltre 400.000 i musulmani. Così larga parte della città di
Cesarea e del celebre castello di Belvoir sono indicati dalle nostre guide
turistiche come tipicamente crociati: in realtà esistevano sul posto monumentali
strutture del primo periodo musulmano, ma gli archeologi le distrussero perchè
non disturbassero la loro lettura storica". Anche da parte araba c'è una
strumentalizzazione per sottolineare la caducità della presenza ebraica in
Palestina. "Sì, è una lettura popolare del passato, ma nessun vero storico le dà
credito. Non ha senso paragonare Israele al regno crociato: i crociati qui
rimasero sempre dei turisti, una presenza temporanea incapace davvero di
assimilarsi nella regione. Nulla a che vedere con Israele". Lorenzo Cremonesi
Ma la liberazione del sepolcro
di Gesù provocò troppi lutti e distrusse una cultura Fra Roma e Bisanzio
s'ingaggia una battaglia costante, che colorerà di sangue l'Europa nei secoli, a
partire dai primi dissapori: i Pontefici strappano a uno a uno i caratteri
politici specifici dell'Impero romano, anche i più maledetti dai cristiani.
Bisanzio resterà nello scontro secolare sempre sconfitta e ingannata. Smarrirà
via via le sue province e quando le sarà sottratto il dominio politico, ben
presto la Chiesa romana imporrà la sua liturgia, strappando il cuore alla Messa
bizantina: il suo aspetto segreto ed esoterico, dove si celebra un richiamo alla
formazione del cosmo dietro l'iconostasi. La storia della Calabria fu uno
strappo crudele delle liturgie bizantine, fino alla loro pressochè totale
scomparsa, perfino fra gli Albanesi venuti profughi dopo la conquista turca. Il
culmine si celebrerà quando i Franchi conquisteranno Bisanzio stessa nel secolo
decimo quarto, occupando Santa Sofia e oltraggiandola. Furti spaventosi
spoglieranno la grande capitale. Venezia si ornerà di statue bizantine.
Gerusalemme aveva subito la conquista turca nel 1073 e la popolazione restò
esterrefatta dinanzi alla loro mitezza esemplare: riedificarono la chiesa sul
luogo natale di Maria. Venne allora a Gerusalemme il sommo teologo al -
Ghazzalì, convertito al sufismo, e vi scrisse la "Vivificazione delle scienze
religiose". Accanto a lui visitò Gerusalemme al - Arabi e vi si trattenne per
tre anni, partecipando con entusiasmo ai dialoghi che vi si accendevano fra
islamici, cristiani ed ebrei. Quando scoppiarono scontri violenti nel 1077, egli
annotò che "nella moschea di Al Aqsa nessuna discussione si interruppe". Ma nel
giugno 1099 l'esercito di Goffredo di Buglione circondava con cieco furore ed
esultanza le mura di Gerusalemme. Anche in questa novità era lo scontro fra Roma
e Bisanzio che si esprimeva. L' imperatore di Bisanzio Alessio I Comneno
calcolava che con una campagna adeguata avrebbe potuto strappare Gerusalemme ai
Turchi. Commise l'errore di ricorrere al Pontefice romano Urbano II all'inizio
del 1095 per ottenere dei mercenari normanni. Ma Urbano II, invece, al concilio
di Clermont esortò clero, poverelli e cavalieri a marciare su Gerusalemme e a
liberare il sepolcro di Gesù. La folla gridò "Dio lo vuole!", innamorandosi di
colpo dell'idea. Nacquero le Crociate. Racconta con arte questa svolta
fondamentale Karen Armstrong in "Gerusalemme. Storia di una città tra ebraismo,
cristianesimo e islam". Una torma di predicatori accese gli animi percorrendo
l'Europa intera suscitando la mobilitazione improvvisa di cinque eserciti, quasi
sessantamila uomini. Giunsero in parte a Bisanzio, dove la principessa Anna
Comnena annotava sgomenta come tutta l'Europa, dall' Adriatico alle Colonne d'
Ercole, irrompesse così in Asia. L'imperatore restò sgomento ancor più di lei:
aveva chiesto alcuni mercenari normanni e la Chiesa gli rovesciava addosso uno
stuolo incalcolabile di uomini. In autunno un esercito ancor più numeroso s'era
radunato, accompagnato da una quantità di sacerdoti. Il sepolcro di Gesù aveva
acceso l'entusiasmo delle centinaia di migliaia di crociati. Molti di loro,
percorrendo la Germania, avevano sterminato le comunità ebraiche a Spira, Worms
e Magonza. Era la prima volta che tale eccidio diventava una "necessita"
sentimentale: il sangue ebreo accendeva di entusiasmo le folle di cristiani
erranti. Ma, quando l'esercito maggiore giunse a Bisanzio, si offrì di
combattere per l'Impero d'Oriente. Attraversò l'Anatolia, sconfisse i piccoli
eserciti islamici che incontrò a Nicea e a Dorileo. Strinse d'assedio Antiochia
nell'inverno 1097 - 8 e vi subì la perdita d'un settimo dei membri; metà,
inoltre, disertò. Alla fine però Antiochia fu conquistata e data in feudo al
normanno Boemondo d'Altavilla. I Turchi a Gerusalemme provvidero alla difesa, e
ben poco avrebbero potuto fare i crociati se le navi genovesi attraccate a
Giaffa non avessero travolto le difese islamiche e permesso a Goffredo di
Buglione l'occupazione della città il 15 luglio 1099. La furia dei cristiani fu
raccapricciante: ammazzarono tutti gli islamici, uomini e donne, e tutti gli
ebrei. Scrisse un crociato: "Nel tempio e nel portico di Salomone si cavalcava
nel sangue fino alle ginocchia e alle briglie. Senza dubbio fu una punizione
giusta e splendida che questo luogo fosse cosi' ricolmo del sangue dei non
credenti, dopo aver sofferto così a lungo dei loro atti blasfemi". I Franchi
erano il nuovo popolo di Dio. Roberto il Monaco dichiarò che questo era stato
l'evento maggiore dopo la crocifissione: presto sarebbe arrivato l'Anticristo e
avrebbe suscitato la battaglia finale. Chi si spingeva in quei primi tempi a
Gerusalemme rimaneva soffocato dal fetore dei cadaveri. I cavalieri elessero
Goffredo di Buglione a difensore del sacerdote latino, massima autorità. Doveva
arrivare ben presto un emissario del Pontefice romano, che avrebbe scacciato
dalla chiesa del sepolcro i cristiani ortodossi armeni, greci, georgiani,
nestoriani, giacobiti. Incominciava un'epoca nuova, la dominazione romana di
Gerusalemme. Elemire Zolla a * Il libro: "Gerusalemme. Storia di una città tra
ebraismo, cristianesimo e islam", di Karen Armstrong, Mondadori, 456 pagine,
60.000 lire.
Collura Matteo, Cremonesi
Lorenzo, Zolla Elemire Pagina 35 (16 luglio 1999) - Corriere della Sera.
Domenica 15 novembre 2015,
Massimo Giletti, conduttore de L'Arena su Rai 1 in riferimento al massacro di
Parigi: «Non è più il tempo delle marce, del Je Suis Charlie, ma non abbiamo più
il coraggio di essere cristiani, di prendere la nostra identità e affermare con
forza contro questa barbarie». «Basta marce e hashatag, qui bisogna fare una
riflessione molto più profonda». «Un'Europa che fa fatica ad avere una via unica
e che non può più eludere la domanda su da che parte stiamo? Quello che è
successo a Parigi era imprevedibile?».
Gli dèi del
caos vogliono Roma. È questa la storia della Chiesa,
scrive il 16 Novembre 2015 Daniele
Guarneri su “Tempi”.
Un libro per ricordarci che sopra la tomba di Pietro si combatte una battaglia
secolare. E che dalla libertà del Santo Padre dipende la nostra. Parla Angela
Pellicciari. Nel poema La
ballata del cavallo bianco Chesterton
scrive: «Gli dèi del caos urlano per la caduta di Roma». E gli dèi del caos
urlano da un paio di millenni e oltre, aggiungiamo noi. Da che Cristo ha messo
piede su questo mondo. Lo evidenzia bene Una
storia della Chiesa (Cantagalli)
di Angela Pellicciari. Certo, l’autrice non intende risolvere duemila anni di
storia in 350 pagine. Ma traccia una sintesi che aiuta a comprendere le
principali sfide e difficoltà che la Chiesa si è trovata ad affrontare nel corso
del tempo. Ed è sorprendente accorgersi delle analogie, non esplicitate nel
testo ma che ognuno può scoprire, con ciò che sta accadendo oggi alla Chiesa e
al suo popolo, dal Medio Oriente fino a Roma. Perché parliamo di Roma? Perché,
lo vedremo, tutto il mondo è terra di Roma, e se qualcuno vuole sottomettere i
popoli, prima deve conquistare la città, casa della cristianità. «Come i pagani
presero spunto dal sacco di Roma per incolpare i cristiani e il loro Dio, così
avviene oggi: ai fedeli di Cristo vengono imputate tutte le colpe, come se loro
fossero la causa dei mali di tutto il mondo. Ma questo è falso, lo dice la mia
esperienza, io sono stata salvata dalla Chiesa. La discrepanza tra quello che
viene detto e la mia vita mi ha portato a scrivere questo ultimo libro», dice a Tempi Angela
Pellicciari. Ieri come oggi, Satana combatte la Chiesa su due fronti, spiega
l’autrice: «La terrorizza con lo spettro della persecuzione e attacca il
magistero petrino cercando di corromperne la dottrina». L’attacco, come vedremo,
può arrivare dall’esterno ma anche dall’interno. Può essere fisico ma pure
materiale. La prima persecuzione imperiale ai cristiani è quella di Nerone, nel
46, ma il primo martire è santo Stefano, lapidato nel 36. Anche i giudei per
motivi religiosi e i pagani per ragioni economiche si accanirono contro i
seguaci del nazareno. Poi fu il turno degli islamici, che «reiteratamente
applicano alla lettera quello che c’è scritto nel Corano. Quello che accade oggi
in Siria e Iraq per mano dell’Isis, è già accaduto in maniera non meno violenta
in passato: la data non è sicura, ma, molto probabilmente nel 1091, l’imperatore
Alessio Comneno scrive a Roberto I, conte di Fiandra, per raccontare qualcosa di
quello che succede ai cristiani che vivono sotto il dominio turco o che vanno in
Terra Santa come pellegrini: “Essi circoncidono i ragazzi e (…) in disprezzo di
Cristo versano il sangue della circoncisione nei battisteri, e poi li
costringono a urinare negli stessi; li trascinano nelle chiese e li costringono
a bestemmiare il nome e la fede della Santa Trinità. Coloro che si rifiutano li
affliggono con innumerevoli pene e alla fine li uccidono. (…) Corrompono
turpemente le vergini, ponendole in faccia alle loro madri, e le costringono a
cantare canzoni viziose e oscene, finché non hanno terminato i loro vizi; uomini
di ogni età e ordine, ragazzi, adolescenti, giovani, vecchi, nobili, servi, e,
ciò che è peggio e più vergognoso, chierici e monaci, e – che dolore! – ciò che
dall’inizio dei tempi non è stato mai detto o sentito, vescovi, sono oltraggiati
con il peccato di Sodoma, e un vescovo sotto questo osceno peccato perì.
Contaminano e distruggono i luoghi sacri in innumerevoli modi, e ne minacciano
altri di peggiore trattamento. E chi non piange di fronte a ciò? Chi non ne
prova orrore? Chi non prega? (…) Agite pertanto finché avete tempo, per non
perdere il regno dei cristiani e, ciò che è più grande, il Sepolcro del Signore,
e quindi abbiate non il giudizio eterno, ma la giusta ricompensa nei cieli.
Amen”». Ciò che l’autrice ha voluto evidenziare è che l’opera di Satana è
cominciata fin da subito: la Chiesa, anche quando non contava nulla, non aveva
uno Stato, i suoi fedeli erano nemmeno un centinaio, cioè nulla considerata
l’estensione dell’impero romano, anche allora era perseguitata. Perché? «Perché
la Chiesa è il corpo di Cristo e Satana lo odia, quindi fin dall’inizio la
perseguita, non c’entra se è grande o piccola, se i fedeli sono tanti o pochi.
Satana fin dall’inizio combatte il corpo di Cristo». Oltre al terrore portato da
imperatori, barbari e islamici, l’attacco a Cristo arriva anche dall’interno
della stessa Chiesa con le eresie che cercano di corromperne la dottrina. «Fin
dall’inizio gli apostoli mettono in guardia i fedeli dal male che può arrivare
dall’interno. San Matteo scrive: “Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi
in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci”; san Paolo: “Persino in mezzo a
voi sorgeranno alcuni a insegnare perverse dottrine”; san Pietro: “Ci saranno in
mezzo a voi falchi”». Vale la pena riportare quello che l’autrice scrive nel
libro, a proposito di queste eresie, per parlare di Lutero: «Da cinquecento
anni, a partire dal libero esame di Lutero che esalta la relazione individuale
con Dio a scapito di quella comunitaria, la modernità punta sulla centralità
dell’individuo con i suoi desideri, le sue necessità e i suoi bisogni, col
risultato che l’uomo è solo. Ma “Non è bene che l’uomo sia solo”, scrive la
Genesi. La comunità cristiana è il gioiello pensato da Dio per dare speranza e
consolazione al mondo. E la Chiesa riparte. Anno dopo anno la virata del
pontefice la scuote, la certezza della verità la muove e lo Spirito Santo le
ridona coraggio». «Oggi a forza di esaltare libertà e diritti individuali non
siamo forse arrivati alla disintegrazione della persona?», aggiunge Pellicciari.
«Mentre la Chiesa ripropone l’unico modello che rende felice l’uomo: la
famiglia, la comunità. È la comunità cristiana che dà la forza ai fratelli di
resistere alle persecuzioni, perché la bellezza della proposta di Dio passa
dalla comunità, non può finire con l’individuo». In una delle sue prime lettere
Giovanni scrive: «Come avete udito che deve venire l’anticristo, di fatto ora
molti anticristi sono apparsi: sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei
nostri». Oggi i lupi rapaci vogliono tutto dalla Chiesa. Gli slogan che
quotidiani e televisioni ripetono da un paio di settimane non fanno altro che
ricordare agli uomini di Chiesa che Cristo è nato e morto povero, mentre ci sono
vescovi e cardinali che vivono nel lusso. È evidente che un po’ di sobrietà in
alcuni casi non guasterebbe, ma è altrettanto chiaro che questi attacchi alla
Santa Sede (uno degli stati più antichi al mondo, che ha regnato su Roma per
oltre mille anni) servono a screditarla agli occhi dei fedeli e del mondo
intero. Per magari farle perdere i suoi beni preziosi. È già accaduto anche
questo in passato. «Nel Risorgimento in nome della purezza della fede e della
vera morale, in nome di Gesù nato e morto povero, moltissimi ordini religiosi
sono stati soppressi e la Chiesa è stata espropriata di palazzi, conventi,
chiese, oggetti d’arte, biblioteche, terreni. Pio IX, ha ripetutamente ricordato
ai fedeli le ragioni che rendono importante, per la Chiesa, il possesso di uno
Stato. Nell’allocuzione Quibus
quantisque,
redatta nel 1849 da Gaeta mentre a Roma infuria la repubblica, il Papa scrive:
“I fedeli, i popoli, le nazioni e i regni non presterebbero mai piena fiducia e
rispetto al Romano Pontefice se lo vedessero soggetto al dominio di qualche
Principe o Governo, e non già pienamente libero. Ed invero i fedeli, i popoli ed
i regni non cesserebbero mai dal sospettare e temere assai che il Pontefice
medesimo non conformasse i suoi atti al volere di quel Principe o Governo nel
cui Stato si trovasse, e perciò, con questo pretesto, sovente non avrebbero
scrupolo di opporsi agli stessi atti”». Nel 1872, a Papa ridotto a prigioniero
in Vaticano, Pio IX indirizza al segretario di stato Antonelli la lettera
“Costretti nelle attuali tristissime circostanze” in cui scrive: «La libertà
religiosa dei cattolici ha per condizione indeclinabile la libertà del Papa, ne
segue che se il Papa, giudice supremo ed organo vivo della fede e della legge
dei cattolici, non è libero, essi non potranno giammai rassicurarsi sulla
libertà ed indipendenza dei suoi atti». Ecco perché è così importante che ancora
oggi il Papa possieda uno Stato: il minuscolo ma importante stato del Vaticano.
C’è un ultimo particolare di Una
storia della Chiesa.
Il libro della Pellicciari, a parte al principio dove si parla di Gerusalemme
come luogo della manifestazione di Dio, poi si concentra su Roma, perché tutto
il mondo è terra di Roma, scrive Chesterton all’inizio del XX secolo.
«L’intuizione del poeta inglese che collega a Roma il cuore della battaglia fra
luce e tenebre, ordine e caos, vita e morte, esplicita il filo conduttore che
accompagna la cultura cristiana durante i secoli», spiega Pellicciari. «La
Chiesa è romana. L’attacco a Pietro è a Roma. E Roma, all’epoca è il mondo. La
Chiesa di Roma è sempre stata attaccata nel corso dei secoli e ancora lo è. Ma
qual è la caratteristica che differenzia i cattolici dall’islam, dal
protestantesimo, dalla massoneria? Che Cristo vince in croce. Mentre gli altri
vogliono dominare il mondo, la Chiesa no. La Chiesa sa che Cristo ha vinto in
croce, quindi ai suoi fedeli tocca la testimonianza fino al sangue. San Giovanni
Paolo II lo ha fatto fino alla sua ultima ora. Non si può sottomettere il mondo
se non si domina Roma, perché lì c’è Pietro. Ci hanno provato i protestanti, i
massoni, i comunisti che sono arrivati ad attentare alla vita di Giovanni Paolo
II. L’islam è da 1.500 anni che afferma di voler conquistare Roma, lo ha
dichiarato anche l’Isis. Anche gli jihadisti lo sanno bene: senza sconfiggere
Roma e quindi la Chiesa, il mondo non sarà mai sottomesso. Cristo ci ha
insegnato che il potere non è la risposta alla vita. E questo insegnamento è più
efficace delle spade».
Ecco chi
occuperà il vostro vuoto. «I musulmani sono convinti che vi conquisteranno con
fede e fecondità»,
scrive il 16
Novembre 2015 Rodolfo
Casadei su “Tempi”.
Parla il patriarca maronita Bechara Rai: «Per i musulmani il matrimonio è
un’istituzione divina, e Dio è per la procreazione». «Al Sinodo l’ho detto: “I
problemi del matrimonio e della famiglia di cui sento parlare in tanti
interventi, da noi non esistono. I nostri problemi sono totalmente diversi”.
L’uomo orientale e l’uomo occidentale restano molto differenti. Da noi il
matrimonio continua a essere un’istituzione divina: è quello che pensano sia i
musulmani sia i cristiani. Per noi si tratta di un sacramento, per i musulmani
di un’istituzione divina, perciò le legislazioni salvaguardano il matrimonio
come realtà religiosa: da noi non esiste nemmeno il matrimonio civile,
figuriamoci le convivenze e i matrimoni fra persone dello stesso sesso!».
Bechara Boutros Raï, da quattro anni Patriarca di Antiochia dei Maroniti e da
tre cardinale, è uomo che conosce il mondo. Quando va in Francia – e succede
spesso – il presidente François Hollande lo riceve quasi come un capo di Stato.
Come tutti i libanesi, soprattutto quelli cristiani, vive a cavallo fra Oriente
e Occidente e pertanto è ambasciatore naturale fra i due mondi. «L’uomo in
astratto non esiste, esiste l’uomo concreto condizionato dalla cultura religiosa
e civile del luogo in cui vive. La cultura delle persone che vivono nel Vicino
Oriente è determinata da una componente musulmana e da una componente cristiana.
Per gli orientali la persona umana è totalmente definita dalla sua religione, e
questo si riflette sul matrimonio: questioni come la custodia dei figli, i
diritti ereditari, eccetera, sono definiti dal diritto familiare confessionale.
Le convivenze fuori dal matrimonio e l’omosessualità sono semplicemente problemi
morali, sono eccezioni che nulla hanno a che fare con l’istituzione familiare».
Il patriarca ovviamente non si esprime solo come antropologo culturale, ma
come pastore: «All’assemblea sinodale dell’anno scorso ho detto: “Gli stati
legiferano senza alcun riguardo per la legge divina: né per quella rivelata, né
per quella naturale; e poi la Chiesa deve raccogliere i cocci dei danni che
queste leggi producono! Facciamo un appello agli stati perché rispettino la
legge naturale”. Ammetto che fra i cristiani molti sono influenzati dal
secolarismo, nel loro intimo vorrebbero quel tipo di libertà che vedono in
Occidente riguardo ai rapporti affettivi e sessuali, ma le leggi in vigore li
trattengono, e noi come Chiese lavoriamo per ricondurli ai valori cristiani».
L’uomo orientale, ancor oggi antropologicamente diverso dall’uomo occidentale,
in maggioranza aderisce all’islam. «I musulmani sono convinti che conquisteranno
l’Occidente, anche quelli fra loro che non sono jihadisti o estremisti. Gliel’ho
sentito dire molte volte: “Conquisteremo l’Europa con la fede e con la
fecondità”. Professare la fede per loro è il principio essenziale della vita,
nessuno che appartenga a una religione può astenersene. Che da parte loro la
professione sia genuina o puramente sociologica è questione controversa, ma un
fatto è certo: è generalizzata, nessuno può astenersene. Allora quando vengono
in Europa e vedono le chiese vuote, e constatano l’incredulità degli europei,
immediatamente pensano che loro riempiranno quel vuoto. Poi c’è la questione
della natalità: per i musulmani il fatto che il matrimonio sia un’istituzione
divina significa che la volontà di Dio è la procreazione. Perciò le famiglie
devono essere numerose. In Europa vedono che i matrimoni e le nascite sono
sempre meno, e questo li convince che loro prenderanno il vostro posto. I
musulmani non concepiscono il celibato, nemmeno quello consacrato: considerano
ogni forma di celibato scandalosa, perché contraria alla volontà di Dio, che
vuole la procreazione». Ma i cristiani con cui i musulmani entrano più
spesso a contatto non sono quelli europei, bensì quelli dei loro stessi paesi.
«È un rapporto più complesso di quello che molti di voi immaginano», spiega il
patriarca maronita. «Nel loro intimo, i musulmani pensano che i cristiani
debbano fare il passo che li porterebbe a diventare musulmani: nel disegno
divino il cristianesimo doveva soppiantare l’ebraismo, e l’islam è l’ultima
rivelazione, quella che soppianta il cristianesimo. Perciò i cristiani non sono
mai veramente accettati come tali. Eppure nella vita quotidiana i musulmani
hanno più fiducia in noi che negli altri musulmani. Ci apprezzano per il nostro
livello culturale, per le nostre capacità professionali e per le nostre qualità
morali. Siamo ricercati per queste caratteristiche. Nei paesi del Golfo i
lavoratori immigrati che ricoprono i posti di maggiore responsabilità sono
cristiani, orientali od occidentali: gli emiri e gli altri dirigenti sanno che
siamo professionalmente qualificati, onesti e non ci immischiamo nelle questioni
politiche. Per loro è cosa pacifica: i cristiani sono “migliori” di loro sotto
tutti gli aspetti. Quando la realtà non corrisponde alle aspettative, reagiscono
molto male. Un’altra situazione nella quale noi cristiani orientali ci troviamo
in difficoltà, è quando ci sono tensioni fra i paesi musulmani e gli Stati Uniti
o i paesi europei: allora le politiche dell’Occidente vengono etichettate come
“cristiane”, e noi veniamo tacciati di essere i resti dei crociati e del
colonialismo, anche se in realtà eravamo già lì alcuni secoli prima che
apparisse l’islam!». Ma pare che ci sia una questione, molto recente, per la
quale i musulmani vanno dai cristiani col cappello in mano. «La maggioranza dei
musulmani è moderata, posso dirlo perché ne conosco tanti sia fra le autorità
religiose sia fra la gente comune. Lo avete visto anche voi in Egitto: quando i
Fratelli Musulmani hanno cominciato a governare, la gente s’è stancata subito.
Però difficilmente prendono posizione contro gli estremisti. Qualche tempo fa
c’è stato un intervento autorevole di condanna delle azioni dell’Isis, ma non
tanto forte. Per due ragioni. La prima è che per loro l’appartenenza religiosa
viene prima di quella al paese, e quindi se c’è una motivazione religiosa
musulmana negli atti di qualcuno, non se la sentono di condannare. La seconda è
che, almeno in Libano, i musulmani sunniti hanno i loro referenti nell’Arabia
Saudita e nei paesi del Golfo, gli sciiti nell’Iran, perciò non prendono
posizioni se non arrivano direttive. Alla fine succede che molti leader
religiosi musulmani vengono da noi e ci chiedono di dichiarare pubblicamente le
cose che loro vorrebbero ma non possono dire». Naturalmente la cosa che
preoccupa di più il patriarca è la guerra nella confinante Siria e in Iraq, e le
sue conseguenze. «Tutta la comunità internazionale deve attivarsi per mettere la
parola fine a queste guerre. Si discute di come ripartire il flusso dei profughi
fra i paesi europei, ma non si discute di come chiudere il rubinetto che produce
quel flusso! Se continua l’esodo, se ne andranno le forze migliori dal Vicino
Oriente, se ne andranno i cristiani e resteranno solo gli estremisti. Senza
cristiani l’Oriente perde lo strato più profondo della sua identità, questo lo
sanno anche i musulmani». «Dovete aiutarci a restare, non a emigrare!
Questa omissione di interventi efficaci ci fa sospettare che esista un piano di
distruzione del mondo arabo. Com’è possibile che dopo dieci anni di guerra in
Iraq e quattro in Siria ancora non si cerchi una soluzione politica, ma si
insista con quella militare? L’ho detto apertamente agli ambasciatori di alcuni
paesi arabi a proposito del conflitto siriano: dove volete arrivare? Perché
siete disposti a pagare qualsiasi prezzo per eliminare Bashar el Assad? State
spendendo 100 mila dollari per qualcosa che ne vale mille! Il Libano è il paese
più minacciato dalla crisi, perché ormai un abitante su quattro da noi è un
profugo siriano. La pressione sull’economia, sui servizi, sulle infrastrutture
sta diventando insopportabile». Gli si fa presente che il Libano ha anche un
problema istituzionale: dal maggio 2014 il paese non ha un presidente. Tempo di
riformare la costituzione nazionale? «No», risponde. «La costituzione è già
stata riformata nel 1989, in concomitanza con gli accordi per la fine della
guerra civile. Adesso al massimo servirebbe qualche ritocco. Ma tutto è bloccato
a causa della rivalità regionale fra Arabia Saudita e Iran, che sono le due
potenze dietro alle due principali coalizioni politiche libanesi: la “14 marzo”
e la “8 marzo”. Non solo il futuro della Siria, anche quello del Libano dipende
dall’esito di quella rivalità».
Una frattura generazionale
nelle moschee.
Molti giovani disertano quella nel cuore della capitale dove gli imam predicano
la moderazione e si ritrovano nei capannoni trasformati in sale di preghiera. E
qui domina lo spirito salafita, scrive Domenico Quirico su “La Stampa” il 16
novembre 2015. Sono venuto in questa strada dieci anni fa: allora adolescenti
incendiavano le notti delle periferie, bruciando le vecchie auto dei padri,
assaltando le mediocri ricchezze di supermercati discount. Ho ritrovato ancora
sui muri di La Courneuve manifesti che ricordano l’anniversario: «Dalla rivolta
delle banlieues alla rivoluzione mondiale», inneggiava, ottimista, «il blocco
rosso-maoista»! La Francia conserva davvero tutto, mette sotto naftalina i muri
la cultura i ricordi gli uomini. Dieci anni dopo altri ragazzi giovanissimi
imbracciano fucili, uccidono a qualche isolato da qui sognando un remoto
califfato universale. Sì, quella di dieci anni fa fu davvero l’occasione
perduta. Una generazione musulmana chiese, disperatamente, che ci si accorgesse
di lei, urlò la propria emarginazione, il dispetto e la voglia di sfidare quello
Stato onnipotente che la ignorava. Come i loro coetanei musulmani dall’altra
parte del mare, le primavere arabe, altre rabbie, le stesse illusioni. Anche
loro sono diventati islamisti, per rabbia, soldati in Siria e in Iraq lo stesso
destino. Demolita l’integrazione nei
quartieri di periferia si è diffuso il radicalismo basato sulla religione. Nel
2006 erano poche decine i francesi partiti per l’Iraq e la guerriglia contro gli
americani. Ora sono centinaia. E tornano. Il cuore del problema francese è a
qualche fermata di metrò dal centro, non in Siria o nel Sahel. Sono andato in
rue Daubenton, alla grande moschea della capitale. Il centro teologico, la
scuola: tutto è chiuso, i corsi annullati. Ma nel piccolo giardino gli uccellini
ti assordano dolcemente e il tè servito dai camerieri è ben zuccherato: come
sempre. Questo è il cuore dell’islam alla francese, che dovrebbe invitare
cinque, sei milioni di musulmani alla tavola della République: l’islam del
Consiglio del culto fatto di notabili, di dotti, annunciato come miracoloso
concordato tra religione e laicità, una scorciatoia per annegare la differenza
nella burocrazia della preghiera, tenere le moleste periferie sotto il
travettismo di notabili coccolati e controllabili, spegnere i sussulti del
fondamentalismo nei cunicoli di una piramide amministrativa. Nei capannoni
trasformati in sale di preghiera non si udivano prediche moderatissime e
obbedienti ripaganti la fiducia governativa. Risuonavano le sillabe perniciose
del «tabligh», movimento pietista e settario che descrive il mondo con strutture
paranoico-persecutrici; e i salafiti che predicano il loro ritorno alle origini,
anticamera spirituale del califfato totalitario. Nel piccolo giardino della
moschea l’unico musulmano è un vecchio signore che estrae da una borsa una
piccola biblioteca di libri e giornali, la mette in ordine e inizia a leggere un
libro che conosco, l’autobiografia di Hamid Abu Zaid, studioso egiziano del
Corano accusato di apostasia negli anni novanta, vittima degli oscurantisti.
Parliamo: l’emigrazione della sua famiglia dall’Algeria non ha conosciuto
barconi e clandestinità, aveva documento di lavoro e poi cittadinanza: «Eppure
questi ragazzi che uccidono sono nostri figli… noi siamo colpevoli, portiamo la
responsabilità per quello che sono diventati... non la Francia i bianchi, noi
che li abbiamo allevati… ognuno cerca di aggrapparsi a qualcosa, tutti corrono
per non essere quello che rimane senza posto…». La superba Francia delle
librerie dei salotti dei bistrot delle languide bellezze bionde che occhieggiano
dai tavolini dei caffè: immobile, capace di avvolgere i suoi vizi e le sue
tarlature, gigantesco museo di se stessa: il Califfo, per fortuna si illude, non
riuscirà a metterle il turbante, a creare l’emirato della Senna. L’atmosfera
eternamente plasmatrice di questo Paese può assopire qualsiasi Jihad. Eppure a
La Corneuve scopri che il popolo musulmano vive in un altrove. L’anima, il di
dentro, la fodera è quello che sfugge tenacemente alla integrazione, che l’ha
fatta fallire. Gli uomini appartengono alle abitudini, dove sono le loro
memorie. È quella la loro casa. Ogni cinque negozi c’è una macelleria
«euroafricana», halal: giganteschi murales mostrano trionfalmente animali
lobotomizzati, impressionanti nature morte. Al «mercato delle quattro strade»
mele angurie banane gigantesche dipinte con colori iperrealisti: come nei
mercati di Bamako e di Niamey. I confini più complicati sono quelli che non si
vedono, che non hanno garitte gendarmi filo spinato controllo di passaporti.
Esci in rue Jaurés, quattro passi appena… e ti sei lasciato dietro la Francia.
L’ha scrupolosamente inghiottita un lento quotidiano terremoto, bruciata dallo
zolfo del tribalismo, fatta e pezzi e trasferita in qualche altro continente, il
nord Africa, l’islam. Non vedo tricolori a mezz’asta qui. Poi in un negozio di
alimentari… ecco: pende una piccola bandiera a cui hanno aggiunto un nastro
nero. Entro: sono indiani. Tutto è islamico: la gente i negozi i caffè i
barbieri le abitudini i vizi e le virtù. Attenzione: ho incontrato solo un
barbuto apostolo maomettano con i regolari pantaloni sopra la caviglia, molti
moltissimi veli ma nessun burqa. Nessuno mi ha minacciato, questo non è un
jihadistan. Semplicemente un altro mondo. Il francese è rimasto
pateticamente aggrappato ai nomi delle strade: rue Rimbaud, rue Danton, rue
Maurice Bureau. Sui marciapiedi ogni tanto incroci qualche povero bianco,
sopravvissuti del naufragio: da questi quartieri nessuno ha cacciato nessuno, la
semplice, implacabile omogeneizzazione delle abitudini, del modo di vivere,
giorno dopo giorno i musulmani sono diventati maggioranza. Sui muri
intristiscono manifesti elettorali per le regionali, un deputato Dupont -Aignan
promette di prendersi cura degli automobilisti «maltrattati». C’era già dieci
anni fa: come Sarkozy, Hollande… La strategia del ghetto usata dai radicali ha
funzionato: allargare la fenditura tra i musulmani e la Francia fino a farli
scoprire estranei e nemici. Entro in un bistrot dal nome evocativo: Medina. Il
proprietario alla cassa ha un’aria lesta ma non quella di un fanatico. Solo
uomini ai tavoli, anzi ragazzi: nessuno sembra aver qualcosa da fare, tutti
sembrano presi nel circolo vizioso di una inedia quasi totale. Come ad Algeri o
Marrakesh: i caffè arabi, dove nessuno spende, la gente sembra lì solo per
chiacchierare. I ragazzi accanto parlano un arabo dialettale, dove spuntano,
affiorano parole francesi come relitti di un naufragio linguistico. Capisco che
parlano di me: «céfran, céfran», che vuol dire francese e giù, rovesciano
ghignando insulti su antenati e eredi, ma non è odio, sembra più un gioco greve
di adolescenti. Alla televisione scorrono immagini: dieci iman che cantano la
marsigliese davanti al luogo dell’attentato e parlano di «Islam patriottico», e
scende un gran silenzio. E poi immagini dell’arresto dei parenti di uno dei
kamikaze in un’altra cité: «schifosi flic» dice un ragazzo, le voci si alzano.
Il padrone del bar cambia perentorio canale. Adesso ci sono le immagini della
serie «cucine da incubo». «Noi siamo algerini, algerini e musulmani - dice
quello dall’aria più ribalda - hai capito? E viviamo da algerini e musulmani. I
francesi sono stati un secolo da noi, hai mai sentito dire che vivessero da
algerini? Qui nessuno fa la guerra». La chiesa di Saint Yved è una brutta
costruzione novecentesca come avverte l’inevitabile targa. È domenica ma è
vuota. Il prete allarga le braccia: questa è terra di missione…».
Ecco la lista dei crimini
per i quali il califfato ci vuole uccidere. Cosa
stavano facendo di così offensivo nei confronti dell'Islam le persone falcidiate
dai fondamentalisti negli ultimi anni? Il periodico americano The Atlantic ha
provato ha stilare una lista, parziale, di ciò che per l'Is merita la morte,
scrive F.S su “L’Espresso” il 15 novembre 2015.
Quali sono i "crimini" per i quali gli islamisti fanatici del Califfato hanno
deciso fosse legittimo uccidere? Al di là delle cause profonde, che lasciamo
agli storici e agli esperti, cosa stavano facendo di così offensivo nei
confronti dell'Islam le persone falcidiate dai fondamentalisti negli ultimi
anni? Il magazine Atlantic ha provato a stilare una lista provvisoria di questi
"gravissimi" comportamenti. Come ogni lista, è parziale. Ma questa, in
particolare, qualcosa ci dice: che i cristiani, gli ebrei, gli induisti, gli
atei, le donne, i gay, e i milioni di musulmani che rifiutano il dettato
conservatore del Corano interpretati da al Qaeda e Isis, possono essere puniti
se guardati con gli occhi di chi vorrebbe riportare il Medioevo al mondo. Ecco
dunque la lista dei "crimini" che sono valsi la pena di morte:
Andare in
vacanza in Egitto
Fare shopping a
Nairobi
Andare in
ufficio a New York
Volare in
aeroplano negli Stati Uniti
Muoversi in
treno a Madrid
Muoversi in bus
a Londra
Partecipare a un
matrimonio ad Amman
Custodire un
memoriale in Canada
Pregare in una
moschea non approvata
Essere ebrei
Visitare una
discoteca a Bali
Andare a scuola
in Russia
Andare a scuola
a Peshawar
Disegnare
vignette
Essere un
giornalista del Wall
Street Journal in Pakistan
Parlare
liberamente in Bangladesh
Essere un
ingegnere francese in Pakistan
Lavorare in
banca a Istanbul
Muoversi in
traghetto nelle Filippine
Bere un caffè a
Mumbay
Realizzare un
film critico sull'atteggiamento dell'Islam nei confronti delle donne
Pubblicare
bibbie in Turchia
Dormire in hotel
a Islamabad
Stare fuori una
stazione di reclutamento a Little Rock
Pregare in
Chiesa in Egitto
Fare shopping
per i regali di Natale in Svezia
Comprare pesce
in Nigeria
Fare un
pellegrinaggio in Iraq
Guardare la
maratona di Boston
Essere una
ragazza cristiana in Nigeria
Prendere il sole
in Tunisia
Fare il
giornalista
E i crimini
delle persone che sono state uccise a Parigi venerdì: ascoltare la musica, bere,
mangiare.
La Musica, l'Islam, la strage di Parigi e il Rock,
scrive Ernesto Assante su “La Repubblica” il 15 novembre 2015. La
strage al Bataclan merita particolare attenzione. Perchè se gli attacchi allo
stadio e ai ristoranti hanno fatto vittime "casuali", al contrario le vittime
del concerto dei californiani Eagles od death metal non erano affatto casuali.
Perché per l'Islam ascoltare musica rock è peccato. Anzi, ascoltare gran parte
della musica è peccato. Suonare musica è peccato. Vale la pena leggere quanto
scrive Mufti Muhammad Ibn Adam al-Kawthari, lo trovate facilmente su Internet,
il testo completo è ancora più interessante di questo piccolo estratto: "Musica
e Canto? Il caso è lo stesso con la musica ed il canto illecito. Essi sono stati
definitivamente proibiti nella Shari`ah, come dimostreranno le prove citate più
avanti. Eppure vi sono persone non pronte a credere che sia Haram. Nell’epoca
moderna, la musica si è diffusa al punto tale che nessuno ne è libero. La gente
si trova ad affrontare situazioni in cui è costretta ad ascoltare musica. E’
accesa in quasi tutti i centri commerciali e supermercati. Se ti siedi in un
taxi, fai una telefonata o anche solo cammini per la strada, non sarai al sicuro
da questo male. Certi giovani musulmani guidano le loro auto con la musica a
tutto volume. La crescente popolarità della musica, comune nella nostra società,
rappresenta una grande minaccia per i musulmani. La musica è un chiara
stratagemma dei non Musulmani. Una delle principali cause del declino dei
Musulmani è il loro coinvolgimento in intrattenimenti inutili. Vediamo oggi che
i musulmani sono coinvolti, e forse in prima linea, in molte immoralità e mali.
La forza spirituale che era un tempo la peculiarità del Musulmano non si vede da
nessuna parte. Uno dei motivi principali di ciò è la musica e l’intrattenimento
inutile". I terroristi che sono andati a uccidere i ragazzi al concerto al
Bataclan non hanno scelto a caso il luogo dove andare a uccidere, non solo gli
"infedeli", i "crociati", ma i peccatori in blocco, i ragazzi che ascoltano
rock, l'intrattenimento inutile. La pensano così anche in Iran, tanto per dire
di uno stato che, a quanto pare, sta schierando i soldati contro l'IS ma che al
tempo stesso vieta gran parte della musica entro i suoi confini, "musica che non
è compatibile con i valori dell'Islam", dice l'ayatollah Khamenei. Bene hanno
fatto gli U2, il cui concerto parigino è stato cancellato, ad andare a deporre
fiori davanti al Bataclan, magnifico è stato il musicista che ha portato il
pianoforte in strada per suonare Imagine. Così come all'indomani della strage
nella redazione di Charlie Hebdo era (ed è) importante dire che ogni matita può
essere un'arma che combatte in favore della libertà, oggi è importante dire che
ogni chitarra, ogni strumento musicale, è un'arma che combatte in favore della
libertà. E contro chi pensa che la musica corrompa l'anima e il corpo e che per
questo debba essere vietata.
Perchè la sinistra parteggia
per l'islam contro la cristianità? Perchè....
L'Isis è l'ultima forza
anticapitalistica del mondo.
La teocrazia
islamica è antimoderna. E qualcuno, anche in Occidente, ne sente il fascino,
scrive Vittorio Macioce - Lunedì
16/11/2015 su “Il Giornale”. L'Isis lo sa come si frantuma l'Occidente,
conosce i suoi punti deboli. La prima strategia è seminare paura, nei luoghi
della vita quotidiana, il ristorante, il teatro, lo stadio, le strade, i
supermercati, fin sotto casa. Non sarete mai più tranquilli. Come se tutti le
terre aliene allo Stato islamico fossero Israele, vivere come a Gerusalemme,
quando la mattina ti svegli e non sai se tornerai a casa. Questo significa
seminare paura. Ma per l'Occidente c'è qualcosa in più, una crepa, un fantasma
sul quale fare sponda. L'Isis ti vuole convincere di una cosa: la colpa è
vostra, di quello che siete. Il guaio è che ci sta riuscendo, senza neppure
tanti affanni. Lo senti nelle parole di alcuni opinionisti in tv, prima con
imbarazzo e sottotono, poi via via sempre con più convinzione e netti e chiari
nei social network. È vero questi sparano, ammazzano, con una decimazione che
lascia alla sorte la sopravvivenza o la morte, ma in fondo ce la siamo cercata.
È colpa dell'America, è colpa dell'Europa, è colpa soprattutto di una civiltà
malata di denaro, di individualismo, di valori corrotti, della caccia al
petrolio, dei padroni del mondo, avidi e incappucciati. Come se noi, povera
gente, e i fondamentalisti islamici fossimo vittima di uno stesso complotto.
Quelli che ammazzano sono carnefici ma in qualche modo vittime come noi. E qui
si arriva a indicare il vero male. Di chi è la colpa di tutto questo? Facile,
del capitalismo, sempre lui. Quello che per i nemici non è mai stato solo un
sistema di produzione, ma il Satana dei valori degenerati. È quel capitalismo
che bene o male ha fatto deragliare l'Occidente dalle società tradizionali. È
quella divergenza nella storia, che parte dai mercanti delle città medievali
italiane, lì dove si fuggiva dal feudo in cerca di libertà e passa per la prima
e seconda rivoluzione industriale, per arrivare qui e adesso. È quel capitalismo
sopravvissuto alle profezie di Marx e all'utopia del comunismo. È lo stesso
capitalismo che odiavano gli studenti del '68 nel nome del libretto rosso di
Mao. È una vecchia storia, insomma. I nemici del capitalismo in fondo hanno
sempre avuto nostalgia di una società non corrotta dalla modernità. È lo stesso
sogno di Platone e di Rousseau, siccome la storia è decadenza bisogna tornare a
una società arcaica, dove la morale non è corrotta dal denaro. L'ideologia di
una teocrazia islamica in fondo, a modo suo, promette proprio questo. È per
questo che l'odio contro il capitalismo può diventare l'alleato più profondo
dell'Isis.Eppure se gente con il Kalasnikov entra in un ristorante e spara non è
colpa dell'Occidente. Se in nome di un dio seminano e onorano la morte e si
fanno profeti del nulla, bé neppure questo è colpa dell'Occidente. Se invece
riusciamo a non rinnegare Voltaire il merito è, questa volta sì, dell'Occidente.
Allora bisogna scegliere: cosa propone come alternativa chi condanna
l'Occidente? Il califfato come disperata nuova utopia.
Islam assassino: non ci
arrendiamo.
È una guerra
contro il nostro stile di vita e la libertà. E per difenderci ora dobbiamo
attaccare, scrive Alessandro Sallusti - Domenica
15/11/2015 su “Il Giornale”. La parola «guerra» rimbalza da Parigi nelle
capitali europee. Si mobilitano servizi segreti, polizie e, per la prima volta
in Italia, si mette in allerta l'esercito. I morti di Parigi scuotono un'Europa
che da tempo assiste compiaciuta al suo decadimento, che ha commesso l'errore
fatale di dare il via libera a una invasione ostile (uno dei terroristi di
venerdì era sbarcato da un barcone come profugo poche settimane fa) e che poi si
è più preoccupata di mettere a tacere le presunte «destre xenofobe» piuttosto
che combattere l'Islam assassino. La vera «emergenza umanitaria» del nostro
tempo non sono le ondate di clandestini che ci arrivano addosso ma la difesa
delle nostre vite di occidentali e cristiani, di quelle dei nostri figli da ieri
mai più al sicuro nelle loro città, nei loro stadi, teatri, ristoranti, sugli
aerei. La vera «umanitá» in pericolo siamo noi. Invece le sinistre e la
burocrazia europea hanno azzerato le nostre difese con leggi permissive, hanno
emesso sentenze giudiziarie che introducono le «attenuanti culturali» per
giustificare crimini commessi da una civiltà inferiore, quella islamica, in nome
di un dio, Allah, feroce e spietato, hanno fatto chiudere le nostre mostre
d'arte con opere a sfondo cristiano e cancellato il Natale per non offendere il
conquistatore. E adesso piangiamo, da veri coccodrilli, la morte dei nostri
figli e amici, in una escalation di orrore che, come giurato ieri dall'Isis, è
solo all'inizio. In dieci mesi si è passati dai dodici morti di Charlie Hebdo,
ai duecento dell'aereo russo partito da Sharm, ai 129 (bilancio provvisorio)
della notte di Parigi. Quanti saranno quelli della prossima strage, e dove?
Impossibile dirlo, il fronte di questa guerra non è un confine, siamo noi,
ovunque ci troviamo. Ragazzi kamikaze contro ragazzi che bevono una birra a casa
loro. Non c'è storia, vinceranno loro questa guerra impari fatta di agguati e di
attese tra una strage e l'altra. Colpire con missioni suicide e poi sparire è
una tecnica militare sperimentata dai vietcong in Vietnam e dai talebani in
Afghanistan, contro la quale non hanno potuto nulla i più potenti eserciti del
mondo, quello americano e quello sovietico, usciti sconfitti dall'estenuante
confronto. Figuriamoci cosa possono fare forze dell'ordine eroiche ma
sottodimensionate, male attrezzate e poco pagate, spesso imbrigliate da regole
di ingaggio e leggi che sembrano fatte per favorire il nemico.L'unico spiraglio
di salvezza ora sta in quella parola «guerra» pronunciata ieri sia dal
presidente Hollande che da Papa Francesco, entrambi in ritardo rispetto ai
profetici scritti di Oriana Fallaci, fatta passare anche per questo per una
pazza visionaria. Se è vero che c'è una guerra in corso bisogna essere
conseguenti, sia sul piano delle relazioni internazionali (per esempio la Russia
di Putin sarebbe un alleato decisivo e non un nemico da punire con sanzioni) che
sul fronte interno, europeo e nazionale. Dalla libera circolazione tra stati
alle politiche sull'accoglienza, tutto va rivisto in chiave emergenziale,
sospendendo se è il caso anche alcune libertà o principi democratici come
accadde in America all'indomani degli attacchi alle Torri Gemelle. In guerra, il
nemico - dichiarato o potenziale - lo si tiene fuori dai confini, non lo si fa
circolare liberamente per casa, non lo si aiuta a mettere radici. Se qualcuno
trova tutto questo esagerato lo invito ad ascoltare e riascoltare gli audio -
disponibili su internet - del fragore delle bombe che esplodono allo stadio di
Parigi, le urla dei ragazzi trucidati nel teatro. Domani - che Dio non voglia -
potrebbero essere le voci dei nostri figli e nipoti. Per questo noi non ci
arrendiamo all'Islam assassino né ai suoi sciagurati complici occidentali, che
negando l'evidenza ci mettono tutti a rischio. Siamo in guerra e combattiamo con
l'arma che abbiamo in dotazione: la libertà di dire ciò che pensiamo.
Quegli "islamici moderati"
che giustificano i terroristi.
Nelle
comunità delle nostre città dominano distinguo, condanne tiepide e c'è chi dà
persino la colpa agli "infedeli". Una zona grigia di omertà e di complicità,
scrive Fabrizio De Feo Lunedì
16/11/2015 su “Il Giornale”. Uscire dalla zona grigia, esprimere la
propria dissociazione in maniera decisa, senza «se» e senza «ma», dimostrare di
non condividere nulla della jihad, mostrare un volto diverso dell'Islam.
È questa la richiesta-appello
che - ogni qualvolta il terrorismo di matrice islamica torna a colpire il mondo
occidentale - viene indirizzata verso le comunità musulmane presenti in Europa.
Le risposte non sempre sono convincenti, soprattutto quando si va a indagare
negli umori popolari. L'ultimo servizio che ha provato a sondare le opinioni
della comunità islamica presente in Italia è stato quello messo in onda da Porta
a Porta due sere fa. Francesca Ronchin è andata per le strade di Tor Pignattara,
quartiere romano con la maggiore concentrazione di stranieri e di persone di
religione islamica, per chiedere cosa pensassero del feroce attacco subito da
Parigi. Il risultato? Deludente, anche a detta di Bruno Vespa che al ritorno in
studio ha rinviato la palla al presidente di Ucoii, Izzedin Elzir, schierato su
una posizione di ferma condanna della strage avvenuta nella capitale
transalpina. I commenti raccolti dalla giornalista si attestano su un crinale
scivoloso e incerto. Di certo, come sottolinea Elzir - che è anche l'Imam di
Firenze - in parte contribuisce il fattore della lingua, la scarsa conoscenza
dell'italiano che non favorisce l'articolazione compiuta di alcune opinioni. Per
questo Elzir invita tutti gli islamici presenti in Italia a imparare bene la
nostra lingua e chiede di non dare giudizi sommari sull'insieme della comunità.
In altri casi, però, dominano i distinguo, le condanne tiepide o l'omertà, con
molti «se» e molti «ma». «Non so se avete sentito di questo attentato a Parigi
che ha provocato più di 120 vittime?» chiede la giornalista di Porta a Porta.
«No, dove?», la prima risposta. «A Parigi». «Dov'è Parigi?». Il secondo
intervistato si attesta sulla stessa linea. «Non ho sentito nulla». Più
articolato il pensiero del successivo che mette sullo stesso piano l'America e
l'Isis. «Se vogliono risolvere il problema devono sapere chi finanzia e chi dà
armi. La colpa è dell'America che compra il petrolio dall'Isis. L'Isis e
l'America hanno la stessa radice». Un altro intervistato ammette, dissociandosi
da loro, che «tante persone sono contente di quello che è successo in Francia».
Un altro assume una posizione più netta: «Io sono un vero musulmano e un vero
musulmano non uccide i bambini». Un altro ammette che «è difficile da islamico
vivere in un Paese democratico», tra «gli infedeli». E c'è anche chi condanna,
ma risponde «sì» alla domanda se si possa a volte uccidere in nome della
religione.Un servizio dai contenuti simili, firmato da Alessio Fusco, va in onda
anche durante Quinta Colonna di Paolo Del Debbio. Interviste citate anche da
Massimo Giletti che nella puntata di ieri de L'Arena si è schierato in maniera
forte contro ogni ambiguità. «Ho ascoltato quanto detto da cittadini di
religione islamica sia da Vespa che da Del Debbio» spiega a il Giornale. «Di
fronte a una strage di quella portata, al dolore di centinaia di persone
innocenti non ho visto l'atteggiamento che mi sarei aspettato, non ho letto
sulle labbra di chi ha parlato la solidarietà che sarebbe stata opportuna. Avrei
voluto sentir dire di fronte a questa tragedia immane che è una vergogna che i
terroristi usino l'Islam come copertura di una follia. Io sono stanco delle
marce, delle candele, degli slogan. Sono stato in Irak due mesi fa e ho raccolto
le testimonianze tragiche di chi vive sotto l'Isis, è un'esperienza che mi ha
cambiato. I raid aerei occidentali finora sono stati limitatissimi. Oggi le
parole non contano più. Siamo in una situazione di guerra ed è necessario
procedere a una vera opera di prevenzione a tutti i livelli, mettendo da parte
anche la nostra privacy. Oggi è giusto anche sospendere alcune libertà o
principi democratici come accadde negli Stati Uniti dopo l'11 Settembre.
Dobbiamo farlo, prima che sia troppo tardi».
Massimo D'Alema: "Dobbiamo
schiacciare l'Isis", scrive
“Libero Quotidiano” il 15 novembre 2015.
Massimo D'Alema non
ha dubbi: "Bisogna schiacciare l'Isis". Lo dice ai microfoni del Tg3 ricordando
anche l'aereo russo abbattuto qualche giorno fa. er D’Alema la risposta deve
quindi essere dura, perché "a minaccia non può essere contenuta. È in corso una
guerra e quando c’è una guerra bisogna organizzarsi per vincerla". D'Alema indica
anche la strada: "Credo che prima di tutto bisogna avere un'idea chiara di chi è
il nostro nemico che va individuato con precisione e non in modo confuso".
Spiega le differenze tra Al Qaeda e l'Isis e prosegue spiegando che "bisogna
cercare la collaborazione con tutti quelli disposti a combattere questi nemici".
L'Isis si differenzia da al Qaeda per "l’ambizione territoriale, l’esistenza di
alcuni nuclei di califfato che hanno peraltro una forza di attrazione e
mobilitazione anche sui giovani europei. Una parte dell’Iraq, una parte della
Siria, una piccola parte della Libia. Lì c’è l’Isis, lì bisogna schiacciarli,
non con bombardamenti, ma eliminandoli da questi territori". Quando gli fanno
notare che è la stessa posizione di Matteo Salvini lui ribadisce di pensarla
nella sostanza come lui, che i problemi con l'Isis vanno risolti con la forza,
ma spiega anche che "la discriminante è nell'uso della politica e
dell'intelligenza". E ancora: "Quando si fanno le guerre, ci si mette attorno a
un tavolo, si elabora una strategia lo scenario non è quello dell’occidente che
combatte l’Isis, ed è quindi fondamentale che ci siano i musulmani, per non
cadere nella trappola della guerra di religione".
Se l'intellettuale di
sinistra ha belle idee di destra.
Dopo anni di
accuse e invettive, le tesi della Fallaci e le battaglie sull'Islam della Le Pen
o di Salvini vengono riprese da chi le condannava. Ovviamente cambiando le
parole e facendo finta di niente, scrive Luigi
Mascheroni - Lunedì
16/11/2015 su “Il Giornale”. È già da tempo che, lentamente, a volte con
imbarazzo altre con improvvisi salti della barricata, pezzi più o meno piccoli
della sinistra benpensante cominciano a rivedere le proprie convinzioni in tema
di Islam, scontro di civiltà, integrazione. E, pur senza prendere tessere
politiche o ideologiche nel campo avversario, finiscono per scivolare su
posizioni che qualcuno per comodità tende a definire reazionarie e altri per
semplificare «di destra». È il progressismo che vira verso la conservazione.
L'utopia rivoluzionaria che si piega al pragmatismo del buon senso. E così
l'intellighenzia si scopre a confessare a denti stretti che forse, però, in
fondo (certo condannando sempre con fermezza la xenofobia e il razzismo!) tutto
sommato quelle teste calde che in tempi non sospetti mettevano in guardia dai
rischi del fondamentalismo religioso e preannunciavano che il confronto fra
Occidente liberale e il fanatismo islamico si sarebbe trasformato in guerra,
ecco a ben guardare non avevano poi tutti i torti. Succede da tempo e tanto più
succede ora, dopo i sanguinosi fatti si Parigi. Accade in Francia, che ha già
pagato sulla sua pelle l'illusione di un convivenza pacifica e di una
reciprocità dei diritti tra l'Europa laico-capitalista e l'Islam radicale. E
accade in Italia, che non è ancora stata colpita in casa ma sente la minaccia
sul collo. Da noi capita sempre più spesso di ascoltare politici e intellettuali
di solidissima fede democratica dire (attenzione, ecco il trucco, con parole
diverse) le medesime cose che da anni in maniera magari meno elegante e più di
pancia ripete la Lega o una certa destra. Era un po' curioso e un po' comico,
sabato sera, a 24 ore dalla strage di Parigi, ascoltare a Otto e mezzo Massimo
Cacciari e Gianni Letta sostenere - salvo irriderlo per le sue semplificazioni e
grossolanità - ciò che Matteo Salvini ripete da anni, a partire dalla necessità
di un intervento militare internazionale contro l'Isis fino all'ammissione che
sui barconi di profughi diretti in Europa dall'Africa e dal Vicino Oriente ci
siano anche potenziali terroristi. Così come capita di trovare persino su un
sito come l'Huffington Post Italia articoli (vedi quello di sabato di Giuseppe
Fantasia e relativi commenti di decine e decine di lettori) che celebrano «la
Cassandra dell'Informazione» Oriana Fallaci, riscoperta come «profetessa» da una
parte di quella sinistra che per un quindicennio l'ha derisa e ghettizzata.
Ieri, sul Corriere della sera, Pierluigi Battista, dopo aver letto forse
l'Huffigton forse altri siti, ha scritto un pezzo intitolato «Scusaci Oriana,
avevi ragione», Il risarcimento postumo è online. E se la vecchia pazza - si
chiedono molti democratici cittadini in Rete - non fosse così pazza? Battista,
peraltro, è uno che non deve scusarsi di nulla, avendo più volte, anche a costo
di pesanti attacchi, difeso e citato i libri della scrittrice toscana. Più
sorprendente, forse, poche pagine dopo sullo stesso quotidiano, l'articolo La
lezione da apprendere del teatro Bataclan firmato da Paolo Mieli, il quale, in
maniera molto lucida ma un po' in ritardo rispetto a centinaia di pezzi scritti
da esempio sul Giornale da anni, scoperchia l'ipocrisia di tanti #JeSuisCharlie
dalla memoria corta e denuncia i danni micidiali che causa il «politicamente
corretto» applicato all'islam radicale. Benvenuto nel club di chi crede che il
buonismo è solo una forma perversa della cattiveria.Tutto ciò capita,
finalmente, anche in Italia. E capita da tempo, ben prima del massacro di due
giorni fa, in Francia. Dove a suo tempo editori come Gallimard e Grasset si
rifiutarono di pubblicare La Rage et l'Orgueil della Fallaci, considerata
fascista, razzista e xenofoba. E dove oggi, mentre il romanzo Sottomissione di
Michel Houellebecq si rivela profetico tanto quanto i pamphlet della Fallaci -
sono sempre di più i Maître à penser della gauche sedotti dalla destra radicale.
Come il filosofo Michel Onfray, alfiere della sinistra laica, o come
l'economista di estrema sinistra Jacques Sapir, o l'ex sessantottino Alain
Finkielkraut che invoca l'identità nazionale davanti all'invadenza del velo
islamico... Certo, non danno i loro voti al Front National, ma spesso danno
ragione a Marine Le Pen. Quando parla di Europa, di Islam e di immigrazione.
Asilo e sussidi ai
terroristi. Il lungo suicidio dell'Europa.
L'Italia è
stata il primo Paese a considerare "rifugiato" un capo di Al Qaida. E da
vent'anni il buonismo permette ai jihadisti di scorrazzare indisturbati, scrive
Fausto Biloslavo
Lunedì 16/11/2015 su "Il Giornale”. Da una
parte ci tagliano la gola o predicano la guerra santa. Dall'altra sfruttano il
buonismo europeo incassando sussidi di stato e ottenendo l'asilo politico.
Decine di terroristi o cattivi maestri, in Italia e negli altri paesi europei,
hanno fatto finta di essere agnellini perseguitati. Almeno uno dei kamikaze di
Parigi aveva il passaporto di un rifugiato sbarcato in Grecia pochi mesi fa e
passato per la Serbia dove ha chiesto asilo politico. Abdul Rahman Nauroz è un
islamista già in carcere per altri reati spuntato nell'inchiesta che questa
settimana ha scoperchiato la rete jihadista europea guidata daL mullah Krekar.
Nauroz viveva a Merano dove aveva ottenuto l'asilo politico e gli erano stati
garantiti un appartamento ed il sussidio versato dalla provincia di Bolzano.
L'appartamento di Merano era pagato dai servizi sociali. Lo stesso capo rete,
mullah Krekar, era arrivato in Norvegia nel 1991 dal nord dell'Iraq ottenendo lo
status di rifugiato e la cittadinanza per moglie e figli. Solo 11 anni dopo gli
è stato revocato l'asilo per il suo coinvolgimento nella guerra santa.L'Italia
si fece fregare da un pezzo grosso della costellazione jihadista, Es Sayed
Abdelkader, referente di Al Qaida nel nostro paese a fine anni Novanta. A Roma
era arrivato il 24 maggio '98 dove ottenne lo status di rifugiato «rendendo alle
autorità italiane dichiarazioni mendaci o incomplete sulla sua situazione di
perseguitato politico», secondo un rapporto della Digos di Milano. Non sapendo
di essere intercettato Abdelkader raccontava ridendo ad un compagno di lotta di
aver trasformato «un semplice incidente stradale», nel quale sarebbe morta sua
figlia, in un attentato dei servizi segreti egiziani. In seguito partito per
l'Afghanistan sarebbe morto sotto i bombardamenti Usa dopo l'11
settembre.Un'altra figuraccia buonista l'abbiamo fatto con i terroristi tunisini
Sami Ben Khemais Essid e Mehdi Kammoun. I due erano finiti in una famosa
inchiesta sul terrorismo dell'allora pm Stefano Dambruoso. Fra il 2008 e 2009
sono stati entrambi espulsi verso la Tunisia. Il ricorso presentato alla Corte
europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia perché li abbiamo spediti a
casa loro dove vige la pena di morte. Diverse organizzazioni come Amnesty
International hanno duramente protestato con il governo italiano denunciando il
rischio che gli espulsi jihadisti venissero torturati. In realtà lo scoppio
della primavera araba a Tunisi li ha rimessi in libertà. E dal 2012 hanno
continuato a cavalcare la guerra santa. I due terroristi sono stati immortalati
in una famosa foto con alle spalle la bandiera nera dello Stato islamico assieme
ad Abu Iyad, fondatore di Ansar al Sharia, l'organizzazione integralista messa
fuori legge in Tunisia. L'Inghilterra aiuta tutti a cominciare dalle sue serpi
in seno. Abu Anas Al Liby, il terrorista catturato dagli americani a Tripoli lo
scorso anno, poi morto in carcere, aveva ottenuto asilo politico a Londra nel
1995. Peccato che dopo fece i sopralluoghi fotografici per far saltare in aria
le ambasciate Usa in Kenya e Tanzania tre anni più tardi. Abu Hamza, il
predicatore radicale con l'uncino, perché aveva perso un braccio ed un occhio
combattendo in Afghanistan, otteneva il sussidio per le menomazioni di guerra
dal governo inglese. Abu Qatada, ispiratore di terroristi kamikaze, ha vissuto
con i sussidi di povertà fino al 2001 quando gli hanno scoperto un conto di
oltre 262mila euro utilizzato per finanziare se stesso e la guerra santa
internazionale. Nel 2005, dopo il secondo attacco alla metropolitana di Londra,
Hamdi Adus Issac, uno dei terroristi falliti, è stato arrestato a Roma. Dalle
casse britanniche fra assegni di disoccupazione, appartamenti gratis, benefit
per la moglie ed i figli riceveva oltre 32mila euro l'anno. Gli altri 4
componenti della cellula africana ottenevano in sussidi un totale superiore ad
84mila euro l'anno.
Giampaolo Pansa su “Libero Quotidiano del 16
novembre 2015, dopo la strage di Parigi la loro ferocia, la nostro viltà.
Confesso che la strage di Parigi non mi ha affatto sorpreso. Sono uno dei tanti
che guardano con realismo al conflitto tra l'Occidente e quello che chiamiamo lo
Stato islamico. Una entità statuale con molti protagonisti, a cominciare dall'
Isis, il Califfato nero. Non abbiamo di fronte soltanto un terrorismo di tipo
nuovo, connotato da una ferocia che in altre epoche non si è rivelata in tutta
la sua geometrica potenza. Siamo alle prese con una guerra che non abbiamo mai
dichiarato, ma che i combattenti abituati ad andare all' assalto urlando «Allah
è grande!», stanno da tempo conducendo contro di noi. Esiste una verità che è da
suicidi fingere di non vedere. Gli islamici sono in vantaggio perché possiedono
un'arma che noi non abbiamo: la ferocia, anche contro se stessi, come confermano
i tanti kamikaze. Noi siamo sconfitti, almeno per ora. Poiché il nostro
connotato è la viltà, con tutto quello che segue: le divisioni, le incertezze,
le beghe fra stati, l'egoismo, la pavidità. L'arma numero uno del nuovo
terrorismo è il fattore umano. E la sua determinazione di distruggerci, anche a
prezzo di rimetterci la vita. L' ho compreso sino in fondo leggendo sulla Stampa
del 12 novembre un lungo colloquio fra un jihadista quasi professionale e un
giornalista che stimo molto. È Domenico Quirico, 64 anni, astigiano, un
reporter, ma forse è meglio definirlo un inviato speciale di grande coraggio e
forte esperienza. Tanti giovani colleghi forse lo riterranno un vecchio signore,
senza rendersi conto che è un loro maestro. Abituato a inoltrarsi in territori
che i media odierni osservano soltanto da lontano. Quirico l'ha fatto di
continuo. È già stato sequestrato due volte: nel 2011 mentre tentava di arrivare
a Tripoli e nel 2013 in Siria. In entrambi i casi, l'ha scampata, la seconda
volta dopo una brutta detenzione durata cinque mesi. Perché quel suo articolo mi
ha colpito? Perché ci mette di fronte a un problema dal quale possono dipendere
le nostre vite. Lui scrive: «Ci sono professionisti della guerra santa che con
la violenza stanno scardinando il mondo e che noi non conosciamo. Riempiono i
giornali, le televisioni e la Rete, e non li conosciamo. Ci prepariamo a
combatterli, forse, e non li conosciamo». Il jihadista che Quirico ha
interrogato è un tunisino quarantenne, Abu Rahman che si è arruolato con Al
Quaeda, prima in Iraq e adesso in Siria. Ha famiglia, un mestiere, il
commerciante, ma il suo scopo esistenziale è combattere gli infedeli: «Uccido in
nome di Dio, per dovere e non per scelta. Così aiuto i fratelli musulmani». Abu
chiede a Quirico: «Vuoi sapere che cosa provo a uccidere? E se ricordo chi è il
primo che ho ammazzato? È stato in Iraq, al tempo degli americani. Ho detto:
grazie, Dio. Ti ringrazio perché hai guidato la mia mano». «Dopo quattro mesi
trascorsi in Siria, sono passato con Al Nusra, gli uomini di Al Quaeda. Quelli
sono i veri combattenti. I loro emiri sono grandi uomini. Guerrieri puri, i
migliori, i più dotti nell' islam. La Siria è piena di gruppi di banditi, gente
che dice di essere musulmana, ma in realtà cerca denaro e traffici. Non ci sono
pensieri impuri in quelli di Al Nusra. Hanno molta forza, altrimenti non
saprebbero reggere alle difficoltà della guerra santa». «La jihad è dura! Non c'
era nulla da mangiare, spesso per giorni. Eravamo assediati, abbiamo mangiato
l'erba come le bestie e i frutti verdi degli alberi. Uno di noi era un contadino
e ha impiantato un piccolo orto. Per bere raccoglievamo l'acqua piovana. Faceva
freddo su quelle montagne, le montagne dei curdi dannati, c' era un freddo da
morire e noi non avevamo vesti pesanti. In tutto il villaggio esisteva un solo
televisore. E quando non cadevano le bombe, noi si andava a vedere Al Jazeera».
«Tu mi chiedi della jihad. Per me è un dovere. Non c' è scelta. La terra
musulmana è in mano ai senza Dio, agli sciiti infami. Dobbiamo riprendercela.
Per questo la guerra santa viene prima dei figli, del mangiare, della casa, del
paese. Devi combattere gli sciiti con la parola, i soldi, le armi, le leggi.
Morire, vivere… Parole! Ci sono mujaheddin che combattono da trent' anni e sono
ancora vivi, altri che sono morti dopo un'ora. A decidere è Dio. Quello che voi
occidentali non potete capire. Avete perso la voglia di combattere per la fede.
La religione per voi funziona come per me il commercio». «Voi occidentali siete
più forti per il denaro, i mezzi, le armi che possedete. Ma proprio per questo
avete paura di morire. E volete vivere a tutti i costi. Noi no. Vedi la saggezza
di Dio? Attraverso la debolezza, lui ci rende più forti di voi». «Sai perché
sono venuto via dalla Siria e non sono rimasto lì a morire, come è successo al
mio amico Adel Ben Mabrouk, una delle guardie del corpo di Bin Laden,
sopravissuto a otto anni di carcere duro a Guatanamo? Perché è arrivato Isis, il
Califfato nero. I loro capi non sono veri musulmani come siamo noi. Sono ex
funzionari dei servizi segreti di Saddam Hussein o ex ufficiali dell'esercito
iracheno. Non vogliono concorrenti. Ma se decidi di lasciarli, ti uccidono. I
loro emiri non sanno nulla del Corano, sono ignoranti. Anche i combattenti
dell'Isis sono giovani ignoranti, affascinati dalla loro propaganda». «Ecco
perché sono venuto via dalla Siria. Non posso stare in un posto, e morire, dove
i sunniti, la gente di Dio, combattono non contro gli sciiti e gli americani, ma
tra di loro. Non so se tornerò, forse andrò da un'altra parte. Voglio combattere
per far nascere un governo islamico in Siria. E dopo andremo a liberare la
Palestina dai giudei. I russi ci bombardano? Che importa. Noi combattiamo per
una fede, loro no. Per questo perderanno». Così parlava a Quirico Abu Rahman,
guerrigliero o terrorista islamico. E noi occidentali, noi italiani siamo
disposti a batterci? E per che cosa? Se penso all' Italia del 2015 mi sento
tremare. Vedo nel mio paese un governo che non sa domare neppure i califfi di
casa nostra. Guidato da un ceto politico che vuole soltanto accrescere il potere
del proprio cerchio magico. Vedo il dilagare del menefreghismo, della
corruzione, dell'evasione fiscale, dell'assenteismo. Vedo maestroni incapaci di
trasmettere ai giovani un po' di moralità, di abnegazione, di rinunce. Vedo un
territorio sfasciato, scuole che vanno in pezzi, città senza acqua potabile.
Vedo finti statisti e aspiranti dittatori. Vedo montagne di promesse a vuoto.
Vedo molta boria, e ras arroganti che spingono sulla scena battaglioni di
cortigiani. Vedo penalizzare la competenza e mettere da parte l'esperienza
onesta. Gli altri, quelli di Allah è grande, sono feroci. Hanno scatenato la
guerra a Parigi. E prima o poi tenteranno di portare il terrore anche in Italia.
Del resto, il Califfato nero l'ha già annunciato. Il loro obiettivo è di
arrivare a Roma. Il Vaticano è un piatto prelibato che vogliono mangiarsi. Il
vicino Giubileo della misericordia è una grande torta che attirerà nugoli di
uccelli feroci. Il Vaticano di papa Bergoglio si affanna a inseguire chi ha
ispirato due libri che ritiene degni di essere messi all' indice. Ma ben altro è
il pericolo che minaccia San Pietro. Il vero rischio è di cadere nell'orrore
scatenato a Parigi la sera di un tranquillo venerdì di novembre.
Giampaolo Pansa
Magdi Allam su “Il Giornale”
del 15 novembre 2015: L’invasione è già iniziata: la civiltà europea va
difesa. Per fronteggiare il terrorismo islamico è necessario chiudere le
moschee illegali, bloccare ai confini i clandestini e abrogare lo ius soli. Poi
potenziare e addestrare le forze dell’ordine. Siamo in guerra. Parigi è stata
trasformata in un campo di battaglia. Dopo toccherà a Roma. È una guerra
scatenata dal terrorismo islamico, ormai autoctono ed endogeno. Una guerra
intestina, europei musulmani contro europei miscredenti, che si consuma in
Europa. Una guerra che registra il fallimento dello Stato, dei suoi servizi
segreti e della magistratura, che non hanno saputo elaborare una strategia
politica, prevenire e reprimere il terrorismo islamico. Una guerra dove in
realtà il principale nemico da combattere siamo noi stessi, la nostra ingenuità,
la nostra ignoranza, la nostra paura, il condizionamento degli interessi
materiali, la collusione ideologica di una maggioranza che concepisce l’islam
come una religione di pace e immagina i terroristi islamici come una scheggia
impazzita che tradirebbe il «vero islam». Inevitabilmente il trauma prodotto da
terroristi islamici che si fanno esplodere, che massacrano e che giustiziano uno
ad uno i nemici dell’islam, ci costringe a prendere atto che siamo in guerra. Ma
non abbiamo la lucidità intellettuale e il coraggio umano di affermare che i
terroristi che perpetrano degli efferati crimini invocando «Allah è il più
grande», sono i musulmani che più di altri dicono e fanno alla lettera e nella
sua integralità quanto Allah ha prescritto nel Corano, quanto ha detto e ha
fatto Maometto. Un attimo dopo aver toccato con mano le atrocità dei terroristi
islamici archiviamo il fatto nei meandri impenetrabili della ragione.
Perché abbiamo paura di
guardare in faccia la realtà. Quanti continueranno a occuparsi delle stragi di
Parigi tra una settimana o dieci giorni? La verità è che temiamo di prendere
atto che la radice del male è l’islam, ritenendo che dovremmo scontrarci con
tutti i musulmani, moderati, integralisti e terroristi che, con modalità
diverse, difendono la bontà dell’islam. Ebbene non si tratta di fare la guerra a
un miliardo e mezzo di musulmani, ma di salvaguardare il nostro legittimo
dovere, prima ancora che diritto, di difendere la nostra civiltà per essere
pienamente noi stessi dentro casa nostra. Cosa dovremmo fare concretamente? Se
fossi il ministro dell’Interno, nell’ambito della proclamazione dello stato
d’emergenza indispensabile per fronteggiare la guerra del terrorismo islamico,
attuerei immediatamente i seguenti provvedimenti:
1) chiudere le moschee
illegali, a partire da quelle che sono registrate come centri culturali, le
moschee e i siti jihadisti collusi con il terrorismo, che legittimano nel nome
di Allah l’odio, la violenza e la morte nei confronti di ebrei, cristiani, atei,
apostati, adulteri e omosessuali.
2) Bloccare le frontiere
all’ingresso dei clandestini, che sono in stragrande maggioranza giovani
musulmani che arrivano dalle coste libiche, filtrati dal terrorismo islamico,
ponendo fine all’attività della criminalità organizzata straniera e italiana che
lucra con il traffico e l’accoglienza dei clandestini. L’Italia non può
continuare a essere l’unico Stato al mondo che legittima la clandestinità e che
investe le proprie risorse per l’auto invasione di clandestini.
3) L’adeguamento delle Forze
dell’ordine assumendo 40mila giovani che riequilibrino l’organico e consentano
di abbassare l’età media che è di 45 anni; avviare un corso di formazione anti
terrorismo per almeno 12mila agenti; l’ammodernamento delle armi e dei mezzi;
l’aumento sostanziale delle retribuzioni che sono mediamente di 1.350 euro; la
tutela giuridica che favorisca le forze dell’ordine nell’esercizio del loro
dovere di garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni.
4) Abrogare lo ius soli e
limitare la concessione della cittadinanza agli stranieri che abbiano dimostrato
con i fatti di rispettare le leggi, di condividere i valori della sacralità
della vita di tutti, della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di
scelta compresa la libertà del musulmano di abiurare l’islam senza essere
automaticamente condannato a morte per apostasia e, soprattutto, di operare
concretamente per costruire un’Italia migliore.
Chiedo al ministro
dell’Interno Alfano di smetterla di dirci che non ci sono riscontri
dell’imminenza di attentati. Con questo terrorismo islamico microcellulare, dove
8 terroristi sono stati in grado di mettere a soqquadro la capitale di un
importante Stato europeo, non ci saranno mai riscontri che consentano di
prevenire gli attentati. Alfano deve ugualmente smetterla di fare proclami
altisonanti per l’espulsione di singoli imam violenti. Sono la punta
dell’iceberg, è una mera operazione mediatica. Solo scardinando l’iceberg, la
filiera che attraverso il lavaggio di cervello trasforma le persone in robot
della morte, potremo vincere la guerra del terrorismo islamico. È questa la
specificità e la vera arma del terrorismo islamico. Oggi tutte le nostre
istituzioni sono inadeguate a fronteggiare la guerra del terrorismo islamico.
Dobbiamo cambiare. Fortificarci dentro. Subito. Quando conteremo i nostri morti
sarà troppo tardi. Siamo in guerra. O combattiamo per vincere o saremo sconfitti
e sottomessi all’islam.
FRANCIA: ALMENO SMETTIAMOLA CON LE CHIACCHIERE.
Da anni, ormai, si sa che cosa bisogna fare per fermare l'Isis e i suoi
complici. Ma non abbiamo fatto nulla, e sono arrivate, oltre alle stragi in
Siria e Iraq, anche quelle dell'aereo russo, del mercato di Beirut e di Parigi.
La nostra specialità: pontificare sui giornali, scrive Fulvio Scaglione il 15
novembre 2015 su “Famiglia Cristiana”. E’ inevitabile, ma non per questo meno
insopportabile, che dopo tragedie come quella di Parigi si sollevi una nuvola di
facili sentenze destinate, in genere, a essere smentite dopo pochi giorni, se
non ore, e utili soprattutto a confondere le idee ai lettori. E’
la nebbia di cui approfittano i politicanti da quattro soldi, i loro
fiancheggiatori nei giornali, gli sciocchi che intasano i social network. Con
i corpi dei morti ancora caldi, tutti sanno già tutto: anche se gli stessi
inquirenti francesi ancora non si pronunciano, visto che l’unico dei terroristi
finora identificato, Omar Ismail Mostefai, 29 anni, francese, è stato
“riconosciuto” dall’impronta presa da un dito, l’unica parte del corpo rimasta
intatta dopo l’esplosione della cintura da kamikaze che indossava. Ancor meno
sopportabile è il balbettamento ideologico sui colpevoli, i provvedimenti da
prendere, il dovere di reagire. Non a caso risuscitano in queste ore le
pagliacciate ideologiche della Fallaci,
grande sostenitrice (come tutti quelli che ora la
recuperano) delle guerre
di George W. Bush, ormai
riconosciute anche dagli americani per quello che in realtà furono: un cumulo di
menzogne e di inefficienze che servì da innesco a molti degli attuali orrori del
Medio Oriente. Mentre gli intellettuali balbettano sui giornali e in Tv, la
realtà fa il suo corso. Dell’Isis e delle sue efferatezze sappiamo tutto da
anni, non c’è nulla da scoprire. E’
un movimento terroristico che ha sfruttato le repressioni del dittatore siriano
Bashar al Assad per
presentarsi sulla scena: armato, finanziato e organizzato dalle monarchie del
Golfo (prima fra tutte l’Arabia Saudita) con la compiacenza degli Stati Uniti e
la colpevole indifferenza dell’Europa. Quando l’Isis si è allargato troppo, i
suoi mallevadori l’hanno richiamato all’ordine e hanno organizzato la coalizione
americo-saudita che, con i bombardamenti, gli ha messo dei paletti: non
più in là di tanto in Iraq, mano libera in Siria per far cadere Assad. Il
tutto mentre da ogni parte, in Medio Oriente, si levava la richiesta di
combatterlo seriamente, di eliminarlo, anche mandando truppe sul terreno.
Innumerevoli in questo senso gli appelli dei vescovi e dei patriarchi cristiani,
ormai chiamati a confrontarsi con la possibile estinzione delle loro comunità.
Abbiamo fatto qualcosa di tutto questo? No. La Nato, ovvero l’alleanza militare
che rappresenta l’Occidente, si è mossa? Sì, ma al contrario. Ha
assistito senza fiatare alle complicità con l’Isis della Turchia di Erdogan, ma
si è indignata quando la Russia è intervenuta a bombardare i ribelli islamisti
di Al Nusra e delle altre formazioni. Nel frattempo l’Isis, grazie a Putin
finalmente in difficoltà sul terreno, ha esportato il suo terrore. Ha abbattuto sul
Sinai un aereo di turisti russi (224
morti, molti più di quelli di Parigi) ma a noi (che adesso diciamo che quelli di
Parigi sono attacchi “conto l’umanità”) è importato poco. Ha rivendicato una strage
in un mercato di Beirut, in
Libano, e ce n’è importato ancor meno. E poi si è rivolto contro la Francia.
Abbiamo fatto qualcosa? No. Abbiamo
provato a tagliare qualche canale tra l’Isis e i suoi padrini? No. Abbiamo
provato a svuotare il Medio Oriente di un po’ di armi? No, al contrario
l’abbiamo riempito, con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti ai primi
posti nell’importazione di armi, vendute (a loro e ad altri) dai cinque Paei che
siedono nel Consiglio di Sicurezza (sicurezza?) dell’Onu: Usa, Francia, Gran
Bretagna, Cina e Russia. Solo l’altro giorno, il nostro premier Renzi (che come
tutti ora parla di attacco all’umanità) era in Arabia Saudita a celebrare gli
appalti raccolti presso il regime islamico più integralista, più legato all’Isis
e più dedito al sostegno di tutte le forme di estremismo islamico del mondo. E
nessuno, degli odierni balbettatori, ha speso una parola per ricordare (a Renzi
come a tutti gli altri) che il
denaro, a dispetto dei proverbi, qualche volta puzza.
Perché la verità è questa: se
vogliamo eliminare l’Isis, sappiamo benissimo quello che bisogna fare e a chi
bisogna rivolgersi. Facciamoci
piuttosto la domanda: vogliamo davvero eliminare l’Isis? E’ la nostra priorità?
Poi guardiamoci intorno e diamoci una risposta. Ma che sia sincera, per favore.
Di chiacchiere e bugie non se ne può più.
Rondolino, rissa con
Emergency: "Boicottiamola" e sul web si scatena la tempesta di insulti,
scrive “Libero Quotidiano” il 15 novembre 2015. È scoppiata una rissa di tweet
tra Fabrizio Rondolino,
oggi collaboratore de l'Unità,
e i sostenitori di Emergency.
A onor del vero a cominciare è stato il giornalista del giornale Dem che su
Twitter ha scritto: "Emergency è un'organizzazione politica antioccidentale
mascherata da ospedale ambulante. Va isolata e boicottata". I sostenitori
dell'associazione di Gino
Strada ha
voluto dimostrare a Rondolino tutta la propria stima per le opinioni diverse
dalle proprie, così lo hanno devastato di insulti e minacce. Fino all'ultima,
quella di farlo cacciare con una petizione dell'Unità. Tanto che lo stesso
Rondolino ha scritto, con un tag a Cecilia
Strada: "Per aver twittato
l'ovvio (Emergency fa politica contro l'Occidente) da ieri i piccoli talebani di
Cecilia Strada urlano di cacciarmi dall'Unità". La Strada è stata più volte
tirata in ballo anche dai suoi stessi followers, ma è stata lei a snobbare la
vicenda: "Ho cose più serie da fare".
Emergency fa cassa con i
morti: chiede le eredità dei sostenitori. E nel bilancio Gino Strada può
sorridere, scrive “Libero
Quotidiano” il 3 marzo 2015. A Emergency fanno
cassa anche sui morti. La nuova iniziativa dell'organizzazione sanitaria non
governativa fondata nel 1994 da Gino
Strada e operante in zone
di guerra tra Africa e Medio Oriente, è una vera e propria campagna testamenti
che punta su uno slogan ad effetto: "Guarda al futuro anche dopo di te". Come
sottolinea il
Giornale, la strategia
(condivisa anche da altre aziende) è chiaro: invitare i sostenitori e i
simpatizzanti a devolvere i loro lasciti ed eredità ad Emergency affinché "i
tuoi valori possono continuare a vivere nel lavoro dei nostri medici e dei
nostri infermieri". Iniziativa peraltro non nuova, visto
che già nel 2013 Strada aveva lanciato il medesimo appello riscuotendo
un grande successo.
Tutti i numeri dell'azienda Strada -
Nel 2013, anno dell'ultimo bilancio disponibile, Emergency ha incassato 31,2
milioni di euro, (2,4 in
più rispetto al 2012), con risultato di esercizio di 3,4
milioni. Si è trattato
della "raccolta fondi più alta di sempre", hanno fatto sapere da Emergency.
Un incremento legato "principalmente alle maggiori entrate ricevute nell'anno
dai contributi del 5 x 1000 (11
milioni, in aumento
rispetto ai 10,7 del 2012, ndr),
dai fondi istituzionali (governativi e non) e dai lasciti testamentari". Ecco,
appunto, oltre alle donazioni e iniziative private (che hanno fruttato 10,2
milioni rispetto
ai 9,9 del 2012) ci sono i lasciti, che hanno fatto guadagnare a Strada e
compagni 1,9
milioni di euro (il
30,5% in più rispetto agli 1,4 del 2012). Parallelamente, i testamenti sono
cresciuti come incidenza sugli incassi, rappresentandone nel 2013 il 6,03%
contro il 5% del 2012.
Cecilia Strada: "Pago le
tasse, perchè dovrei ospitare a casa un immigrato?"
Scrive “Libero Quotidiano” il 14 giugno 2015. In questi giorni di emergenza
immigrati, in molti sui social network devono averle chiesto, magari in modo
provocatorio, come mai lei non ospitava un profugo a casa sua. Per via del padre
Gino, che di aiuto ai profughi ha fatto una missione nella vita e una
professione. Figura "ingombrante", un padre così. E forse per questo oggi
Cecilia Strada, la figlia del fondatore di Emergency, ha voluto replicare:
"Risposta collettiva per tutti quelli che 'perché non ospiti i profughi a casa
tua, eh?' ha esordito la figlia di Gino Strada sul suo profilo Facebook. "E
perché dovrei? Vivo in una società e pago le tasse. Pago le tasse così non devo
allestire una sala operatoria in cucina quando mia madre sta male. Pago le tasse
e non devo costruire una scuola in ripostiglio per dare un'istruzione ai miei
figli". E continua: "Pago le tasse e non mi compro un'autobotte per spegnere gli
incendi. E pago le tasse per aiutare chi ha bisogno. Ospitare un profugo in casa
è gentilezza, carità. Creare - con le mie tasse - un sistema di accoglienza
dignitoso è giustizia. Mi piace la gentilezza, ma preferisco la giustizia".
La Francia e la guerra:
Nostradamus aveva predetto tutto. Ecco le sue parole.
"La grande guerra inizierà
in Francia e poi tutta l’Europa sarà colpita, lunga e terribile essa sarà per
tutti… poi finalmente verrà la pace ma in pochi ne potranno godere". Così
parlò Nostradamus nel suo libro, e l'eco sinistra di quelle parole si sovrappone
alle immagini tremende degli eccidi di Parigi di venerdì scorso. Secondo un
altro passo del volume Le Profezie, il libro più famoso astrologo
francese, attivo nel 1500, ecco cosa succede: "Ci saranno tanti cavalli dei
cosacchi (popolazioni nomade tartare che abitavano nelle steppe russe) che
berranno nelle fontane di Roma". Non solo: "…Roma sparirà e il fuoco cadrà dal
cielo e distruggerà tre città. Tutto si crederà perduto e non si vedranno che
omicidi; non si sentirà che rumori di armi e bestemmie. I giusti soffriranno
molto. (…) Roma perderà la fede e diventerà il seggio dell’Anticristo. I demoni
dell’aria, con l’Anticristo, faranno dei grandi prodigi sulla terra e nell’aria
e gli uomini si pervertiranno sempre di più…"
Dialogo con un mussulmano
in Italia.
«Perché tu sei così radicale?
Perché non abiti in Arabia
Saudita???
Perché hai abbandonato già il
tuo Paese musulmano?
Voi lasciate Paesi da voi
definiti benedette da Dio con la grazia dell’Islam e immigrate verso Paesi da
voi definiti puniti da Dio con l’infedeltà.
Emigrate per la libertà …
per la giustizia …
per il benessere …
per l’assistenza sanitaria ...
per la tutela sociale …
per l’uguaglianza davanti alla
legge …
per le giuste opportunità di
lavoro …
per il futuro dei vostri figli
…
per la libertà di espressione
...
quindi non parlate con noi con
odio e razzismo ...
Noi vi abbiamo dato quello che
non avete …
Ci rispettate e rispettate la
nostra volontà, altrimenti andate via».
Qualcuno afferma che queste
frasi le abbia pronunciate Julia Gillard (primo ministro australiano) ed abbia
rilasciato queste affermazioni nel 2005 rivolgendosi ad un Islamista radicale
estremista in Australia.
Qualcun altro decreta che sia
una bufala e che Julia Gillard non abbia mai proferito quelle frasi.
Se nessuno fino ad oggi ha
dato paternità a queste frasi, allora dico: sono mie!
Vittorio Sgarbi: "Come il
Nazismo e noi siamo gli ebrei".
Puntata molto accesa, quella del 15 novembre 2015, a Domenica
Live. Barbara
d'Urso dedica l'intera
puntata al terrorismo dell'Isis e agli attacchi a Parigi. Sono ospiti, tra gli
altri, Matteo
Salvini, Magdi
Allam e Vittorio
Sgarbi. Quest'ultimo, dopo
che la d'Urso dice "pace, pace, pace", attacca: "La religione islamica è
intollerante, vuole che tutto il mondo sia convertito. L'Islam non ha in sè il
male ma vuole solo Allah. Hanno lo stesso atteggiamento di Hitler con gli ebrei,
e noi siamo gli ebrei". E ancora: "Da 40 anni Israele si difende con la forza.
Oggi tutta l'Europa è come Israele che deve difendersi. Gesù non ha mai ucciso.
Maometto ha ucciso, ha sterminato, io non sono un uomo di Maometto". La d'Urso
non gradisce le frasi di Sgarbi e commenta: "Non sono musulmani quelli che hanno
attaccato, lo capisci questo?". E dice: "Basta bombe, basta bombe, basta bombe".
Niente paura, leggete il
Corano Ci troverete le radici del Male.
Per 56 anni ho
creduto che l'islam potesse essere riformabile grazie a musulmani moderati come
me. Mi sbagliavo. Il libro sacro è la negazione della civiltà, scrive Magdi
Cristiano Allam Lunedì 02/03/2015 su “Il Giornale”. «Allah Akhbar! Allah Akhbar!
Ash-hadu an-la ilaha illa Allah, Ash-hadu anna Muhammad-Rasul Allah». «Allah è
Grande! Allah è Grande! Testimonio che non c'è altro dio all'infuori di Allah,
Testimonio che Maometto è il Messaggero di Allah». Per vent'anni la mia giornata
è stata cadenzata dall'adhan, l'appello alla preghiera diffuso dall'alto dei
minareti nella mia città natale, Il Cairo, ribattezzata la «Città dai mille
minareti». Per 56 anni mi sono impegnato più di altri, da musulmano moderato, ad
affermare un «islam moderato» in Italia, aderendo e sostenendo sostanzialmente
la tesi del Corano «creato», che per l'ortodossia islamica pecca ahimè di una
fragilità teologica che scade nell'eresia. Perché così come il cristianesimo è
la religione del Dio che si è fatto Uomo e che s'incarna in Gesù, l'islam è la
religione del loro dio Allah che si è fatto testo e che si «incarta» nel Corano
dopo essere stato rivelato a Maometto attraverso l'Arcangelo Gabriele. Per i
musulmani quindi il Corano è Allah stesso, è della stessa sostanza di Allah,
opera increata al pari di Allah, a cui ci si sottomette e che non si può
interpretare perché si metterebbe in discussione Allah stesso. Per contro, la
tesi del Corano «creato», che sottintende che solo Allah è increato, consente
l'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti del Corano, che possono
essere oggetto di culto da parte della fede ma anche oggetto di valutazione e
critica; così come consente la contestualizzazione nel tempo e nello spazio dei
versetti rivelati per distinguere ciò che è da considerarsi attuale e lecito da
ciò che è invece è da ritenersi prescritto e caduco; ci mette in ultima istanza
nella possibilità di poter affermare la dimensione «plurale» dell'islam e, in
questo contesto di pluralismo, ci consente di far primeggiare la scelta
dell'«islam moderato» che concili la prescrizione coranica con il rispetto dei
valori fondanti della nostra comune umanità. Per 56 anni ho scelto di battermi
in prima persona, costi quel che costi, per affermare la bontà del Corano quale
testo sacro dell'islam pur nella denuncia del terrorismo islamico. Nel 2003,
dopo aver conosciuto Oriana Fallaci ed aver instaurato con lei un rapporto che,
al di là della reciproca stima professionale, della condivisione della denuncia
del terrorismo islamico e della pavidità dell'Occidente, si fondava su un
affetto sincero e una solida amicizia, tuttavia il nostro rapporto fu turbato
dal mio rifiuto di abbandonare l'islam e di concepire che la radice dell'islam
risieda nel Corano. Mi sentivo contrariato quando scriveva: «L'islam è il
Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la
Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani.
È incompatibile col concetto di civiltà». Eppure, all'indomani della mia
conversione al cristianesimo il 22 marzo 2008, ho scritto: «Ho dovuto prendere
atto che, al di là della contingenza che registra il sopravvento del fenomeno
degli estremisti e del terrorismo islamico a livello mondiale, la radice del
male è insita in un islam che è fisiologicamente violento e storicamente
conflittuale». L'errore in cui incorsi fu di immaginare che l'islam potesse
essere riformabile al suo interno grazie all'impegno dei musulmani moderati.
Alla fine, dopo oltre cinque anni trascorsi da condannato a morte dai terroristi
islamici e reiteratamente minacciato dagli estremisti islamici, mi sono arreso
di fronte all'evidenza: si può essere musulmani moderati come persone, ma non
esiste un islam moderato come religione. Oggi più che mai dobbiamo avere l'acume
intellettuale e il coraggio umano di leggere ad alta voce il Corano e di
affermare pubblicamente i suoi contenuti. Non possiamo essere vittime, da un
lato, dei musulmani moderati che difendono aprioristicamente e acriticamente
l'islam pur di salvaguardare la loro credibilità ed onorabilità, dall'altro,
degli occidentali che per paura di offendere i musulmani sostengono in modo
altrettanto aprioristico e acritico che il Corano insegna l'amore e la pace, che
i terroristi islamici non centrano nulla con l'islam. Solo leggendo il Corano
scopriamo la specificità di una religione che condanna di eresia l'ebraismo e il
cristianesimo; la realtà di Allah che era il dio supremo del Pantheon politeista
arabo, clemente e misericordioso con chi si sottomette all'islam ma vendicativo
e violento con i miscredenti; la verità di Maometto che è stato un guerriero
vittorioso che ha fondato una «Nazione di credenti» combattendo e uccidendo i
suoi nemici per ordine di Allah. Solo leggendo il Corano potremo capire le
radici di un'ideologia che legittima l'odio, la violenza e la morte, che ispira
il terrorismo islamico ma anche la dissimulazione praticata dai «musulmani
moderati», perseguendo il comune obiettivo di sottomettere l'intera umanità
all'islam, che è fisiologicamente incompatibile con la nostra civiltà laica e
liberale negando la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e
donna, la libertà di scelta. Solo leggendo il Corano potremo capire chi siamo
veramente noi, se siamo ancora o non più in grado di riscattare la civiltà di
verità e libertà, di fede e ragione, di valori e regole. L'Italia non ha subito
gravi attacchi dal terrorismo islamista, ma non può considerarsi al sicuro se si
tiene conto che da anni diversi imam predicano odio, dozzine di centri islamici
sono impegnati nel proselitismo e nel finanziamento a gruppi terroristici e che
il Paese sta esportando combattenti nei teatri della jihad. Lo rileva un
rapporto del Centro militare di studi strategici del ministero della Difesa. La
comunità islamica italiana è composta da 1,6 milioni di persone, un terzo degli
stranieri presenti, cui si aggiungono 60-70mila convertiti. Sono una ventina le
organizzazioni principali, più di 100 le moschee, 159 i centri islamici, decine
le scuole coraniche, tanti i siti internet. Secondo il dossier, «la
radicalizzazione della comunità islamica rappresenta una potenziale seria
minaccia». Dal 2001 ad oggi, circa 200 persone sono state arrestate con l'accusa
di terrorismo. Milano è l'epicentro del radicalismo islamico in Italia.
Magdi Allam alla libreria
Postumia di Piacenza ha presentato nel tardo pomeriggio del 13 novembre 2015 il
suo ultimo libro "Siamo in guerra. L'Islam non è una religione moderata".
Solo poche ore dopo, alle 21.30, Parigi era sotto attacco dell'Isis. In tutto
128 i morti e centinaia i feriti, scrive Renato
Passerini il
14 Novembre 2015 su “Il Piacenza”.
Magdi Allam alla libreria Postumia di Piacenza ha presentato nel tardo
pomeriggio del 13 novembre il suo ultimo libro "Siamo in guerra. L'Islam non è
una religione moderata". Solo poche ore dopo, alle 21.30 Parigi era sotto
attacco dell'Isis. In tutto 128 i morti e centinaia i feriti. L'ultima fatica
dello giornalista scrittore inviso ai musulmani per ciò che da anni sostiene,
edito da Il Giornale e distribuito da Mdf, è stato presentato in città dopo una
breve introduzione di Maurizio Dossena. Allam in questo saggio sociopolitico non
concede nulla al buonismo di maniera e alla voglia di rassicurazione. La sua
analisi sull’attacco dell’Islamismo alla nostra civiltà si sviluppa su 290
pagine con titoli rivelatori quali “La terza guerra mondiale, ’Islam è
fisiologicamente violento, Il suicidio dell’Occidente che odia se
stesso, L’Islamizzazione demografica, La resa della chiesa all’Islam”. Nel suo
percorso di critica radicale indica l’Islam quale responsabile di avere
scatenato la Terza guerra mondiale e instaurato un clima di terrore e
sottomissione. È fondamentale riconoscere che c’è un solo Islam e che legittima
l’odio, la violenza e la morte contro i “miscredenti”, ovvero tutti i non
musulmani. Anche i sedicenti musulmani “moderati” perseguono l’obiettivo di
sottometterci costruendo delle roccaforti Islamiche dentro casa nostra - ha
insistito richiamando anche i recenti fatti di Merano crocevia di aspiranti
jihadisti - attraverso il riconoscimento dell’Islam come religione di pari
valore del Cristianesimo, la diffusione delle moschee, il condizionamento della
finanza Islamica, l’Islamizzazione demografica, l’invasione di clandestini
musulmani, la codificazione del reato di Islamofobia. L’Italia non ha una
presenza Islamica di entità pari a quella che c’è in Francia o in Gran Bretagna,
ma è egualmente a rischio. Rimane, nel nostro, come in altri Paesi europei, un
problema fondamentale di compatibilità tra culture finché i musulmani non
cominceranno a fare riferimento, non solo al Corano, ma anche al valore della
laicità dello Stato che è a fondamento della nostra società. L’Occidente ha
follemente scatenato le guerre in Iraq, Libia e Siria, per rimuovere dei regimi
laici e sostituirli con delle dittature Islamiche, ora vede l’Europa invasa da
centinaia di migliaia di clandestini, in gran parte musulmani. Gli abitanti dei
29 Paesi membri dell'Unione Europea sono circa 500 milioni e solo il 16 per
cento, pari a 80 milioni di abitanti, hanno meno di 30 anni. Viceversa su circa
500 milioni di abitanti della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo
(sommando le popolazioni dei 22 Stati arabofoni più quelle della Turchia e
dell'Iran) ben il 70 per cento ha meno di 30 anni, pari a 350 milioni di
abitanti. Quando si mettono su un piatto della bilancia 80 milioni di giovani
europei, cristiani in crisi d'identità con una consistente minoranza musulmana,
e sull'altro 350 milioni di giovani mediorientali, al 99 per cento musulmani,
convinti che l'Islam è l'unica «vera religione» che deve affermarsi ovunque nel
mondo, il risultato indubbio è che gli europei sono destinati ad essere
sopraffatti demograficamente e colonizzati ideologicamente dagli Islamici. A un
certo punto i musulmani non avranno più bisogno di farci la guerra o ricorrere
al terrorismo. Potranno sottometterci all'Islam limitandosi ad osservare le
regole formali della nostra democrazia, che premia il soggetto politico più
organizzato e influente, in grado di condizionare e di accaparrare il consenso
della maggioranza, astenendosi dall'entrare nel merito dei contenuti delle
ideologie e delle religioni, soprattutto dell'Islam. L’Italia è l’unico stato al
mondo che ha legittimato la clandestinità e con le missioni nel Mediterraneo ed
è l’unico stato che promuove l’autoinvasione, dando privilegi agli immigrati e
li neghiamo agli italiani. Se perdiamo in controllo del territorio, cessiamo di
essere padroni in casa nostra. La conclusione di Allam: dobbiamo scegliere se
vogliamo combattere per difendere le nostre libertà, essere padroni in casa
nostra, essere consapevoli che, o si combatte per vincere, o finiremo sottomessi
all’Islam. Magdi Cristiano Allam è
nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Da musulmano, per 56
anni, ha creduto in un “Islam moderato”, fino a quando non è stato condannato a
morte sia dai terroristi Islamici sia dai “musulmani moderati”. Nel 2008 si è
convertito al cattolicesimo e nel 2013 si è dissociato dalla Chiesa per la sua
legittimazione dell’Islam. È editorialista del Giornale e autore di libri di
successo sul terrorismo Islamico. È stato il primo giornalista a subire un
procedimento disciplinare per “Islamofobia” da parte dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti e a vincerlo, facendo trionfare il principio che è lecito criticare
l’Islam.
Dobbiamo chiamarlo Stato
Islamico, Isis o Daesh?
L’Occidente non ha deciso come combatterlo, ma neanche come
nominarlo. Dall’appellativo che gli diamo, dipende anche il ruolo che gli
riconosciamo, scrive Francesco Zaffarano su “La Stampa” il
16/11/2015.
L’Occidente non ha ancora deciso come combatterlo, ma se è per questo non sa
neanche come chiamarlo. Sulle pagine di questo giornale abbiamo sempre usato il
termine Isis, ma questa
fetta di radicalismo islamico non ha un solo nome. Scegliere come
chiamarlo non è un aspetto superfluo: saper dare un nome alle cose è il primo
passo per capirle. La disputa, in questo caso, è tra chi lo chiama
Stato Islamico e chi
preferisce il termine Daesh.
Nel primo gruppo c’era il Dipartimento di Stato americano, che dal 2014 ha
deciso di usare Islamic State of Iraq and the Levant (Isil) come nome del
gruppo; nel secondo, tra gli altri, c’è il presidente Francois Hollande, che ha
usato il termine Daesh parlando dei responsabili degli attentati di Parigi.
Barack Obama ha sempre utilizzato il primo nome: da qualche giorno, invece, il
segretario di stato John Kerry ha iniziato ad usare il termine Daesh.
STATO ISLAMICO.
Quando parliamo di Stato Islamico (vale anche per le varianti Is, Isis, Isil) ci
riferiamo a uno Stato a tutti gli effetti, come
almeno pretende di essere quello guidato da Abu Bakr al-Baghdadi. Il
cosiddetto Isis, un tempo, era una sezione irachena di al-Qaida, diventata poi
Stato Islamico in Iraq, Stato Islamico dell’Iraq e della Siria e, infine, autoproclamatasi
Stato Islamico. L’appiattimento del nome fino ad arrivare al semplice
Stato Islamico è semplicemente un tentativo di rimuovere le particolarità
geografiche, fornendo una sola entità Stato. Basti pensare che un altro modo per
indicare lo Stato Islamico è al-Dawla,
letteralmente «Lo Stato». Peccato che questo Stato non abbia
dei veri e propri confini omogenei, né un territorio unito. Non a caso, i
nomi precedenti all’autoproclamazione voluta da Abu Bakr al-Baghdadi nel 2014
comprendono specifiche aree geografiche, come Stato Islamico in Iraq e al-Sham
(termine arabo che si può tradurre con Grande Siria) o come quel Isil in cui la
“L” sta per Levante, cioè potenzialmente anche i territori di Israele,
Palestina, Giordania e Libano.
DAESH.
Come Isis, anche Daesh è un acronimo: significa al-Dawla
al-Islāmiyya fī
ʿIrāq
wa l-Shām,
cioè “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante”, o “della Grande Siria”.
Apparentemente il significato è lo stesso ma l’accezione attribuita a Daesh (oDāʿish,
per essere precisi) è
spesso dispregiativa, perché somiglia a un altro termine arabo che
significa «portatore di discordia». Secondo il The
Guardian ,
addirittura, la Francia avrebbe preferito il termine Daesh perché simile al
francese dèche,
cioè «rompere». Che il termine sia disprezzato dai seguaci di Abu Bakr
al-Baghdadi è confermato anche dalle testimonianze di chi racconta di
punizioni corporali per chi utilizza pubblicamente il nome Daesh.
MA QUINDI?
Decidere tra Stato Islamico e Daesh significa dare forma a quella realtà.
Praticamente tutte le testate giornalistiche optano per Isis, per una questione
di semplicità e di uniformità. Ma a suggerire una risposta, dopo gli attentati
del 13 novembre, è stato Enrico
Letta, ex premier italiano e attuale direttore dell’Istituto di studi
politici di Parigi. Letta: «Smettiamola di chiamarlo Stato Islamico, sono
terroristi e come tali vanno trattati #Daesh».
Un nemico, tanti nomi. Era
Isis, adesso è Daesh.
Ecco perché Hollande e Obama
preferiscono usare un'altra definizione per lo Stato islamico, scrive Andrea
Cuomo Venerdì 20/11/2015 su “Il Giornale”. Non esistono più i nemici di una
volta. Per dire: i nazisti o i comunisti. Un bel nome definito, da scolpire nel
marmo dell'odio e del disprezzo, da pronunciare trattenendo il fiato. Ora invece
chi ci uccide e ci minaccia, come si chiama? Is, Isis o Daesh? Sono la stessa
cosa o sono cose diverse? Abbiamo o non il diritto di saperlo? La questione non
è di lana caprina. Dare il nome alle cose è il primo passo per identificarle e
conoscerle. E conoscerle serve quindi, magari, combatterle. Il fatto che i
terroristi islamici cambino ragione sociale in continuazione come fossero una
pizzeria di quartiere o una ditta ci spiazza e ci smarrisce, non ci dà punti di
riferimento, rende tutto più oscuro, più minaccioso. Facciamo chiarezza. La
nuova definizione con cui stiamo appena prendendo confidenza è Daesh. L'hanno
usata il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian all'indomani dgli
assalti di Parigi, lo stesso presidente francese François Hollande, il
segretario di stato Usa John Kerry, perfino il presidente americano Barack
Obama. Tutti si riferivano a quella entità che fino a ieri eravamo abituati a
chiamare Isis. Anche Daesh è una sigla: riassume in una parola spendibile nei
titoli (e con qualche aggiustamento nella traduzione e nella traslitterazione)
la formula araba al Dawla al Islamiya fi al Iraq wa al Sham. Che vuol dire
«Stato islamico dell'Irak e del Levante», locuzione quest'ultima che si
ricollega al toponimo che veniva usato un tempo per indicare quella regione
chiamata anche grande Siria e che comprende il Sud Est della Turchia, la Siria,
la Giordania, la palestina, Israele e il Libano. Un retaggio coloniale che
contiene peraltro un ulteriore sfregio per l'islam in arme. Non molto diverso da
Isis, sigla questa volta inglese della locuzione «Stato islamico dell'Irak e
della Siria». e allora perché Daesh? Per due ragioni: perché adottare una sigla
di una frase in arabo rende meno «agibile» il concetto di Stato islamico, un po'
come prendere le distanze da una definizione che, in quanto tale, può sembrare
una legittimazione. E poi perché Daesh ha un suono che, per gli arabi, richiama
il concetto di distruzione, calpestìo, sbattere contro qualcosa. Un po' come
chiamare qualcosa «Crash». E si sa, dare un brutto nome a qualcosa è già quasi
come condannarla alla «damnatio memoriae». Non è un caso che, come ha riferito
l'Associated Press, a Mosul, città siriana controllata dall'Isis (o comunque
vogliamo chiamare i simpatici seguaci del Califfo) alcuni miliziani avrebbero
minacciato di tagliare la lingua a quanti usino la parola Daesh in riferimento
allo Stato islamico. Adotteremo anche noi in Italia questo disprezzo onomastico?
Ci proveremo, forse. Ma con un po' di rammarico. Si sa, noi siamo abitudinari.
C'eravamo appena abituati all'Isis, e alcuni di noi già si sgomentano quando sui
giornali leggiamo la sigla accorciata Is, quella in cui scompare ogni
riferimento geografico. Sigla peraltro prediletta dai tagliagole, che vedono
così esaltato l'aspetto istituzionale della loro esistenza.A complicare tutto
esistono poi altre sigle. Ad esempio Isil, usata da molti giornati americani,
che altro non è che la traduzione inglese di «Stato islamico dell'Irak e del
Levante». Poi c'è Sid: Stato islamico del Califfato, scelto in alcune occasione
dai jihadisti per definirsi. E poi ecco comparire Nins, una sigla acronimo di
«Not Islamic not State» (traduzione: non-Stato-non-islamico»), scelta
negazionista fatta da Ban Ki-moon, segretario generale dell'Onu, che per la
verità non ha conosciuto alcuna fortuna. Anzi, ha finito per generare ulteriore
confusione.
Lettera sull'Islam a Oriana
Fallaci di Magdi Allam prima della sua conversione al
cristianesimo. «La tesi secondo cui esisterebbe solo un islamismo
integralista fa in realtà il gioco dei terroristi. I fermenti democratici in
Medio Oriente dimostrano che quelli come me non sono minoranza».
Per la prima
volta Magdi Allam racconta se stesso, musulmano laico nato e cresciuto
nell'Egitto di Nasser ed emigrato in Italia nel 1972: "Partendo dal mio vissuto
posso testimoniare che soltanto quarant'anni fa la situazione in Medio Oriente
era radicalmente diversa. La società e le istituzioni erano laiche. La cultura
dell'odio e della morte, che l'Occidente oggi associa ai musulmani, non è nel
Dna dell'islam". Allam, in questo libro, ha deciso di togliersi tutti i
"sassolini", denunciando apertamente sia gli integralisti che l'hanno condannato
come "nemico dell'islam", sia i loro complici occidentali che alimentano uno
scenario di scontro e di odio. Una testimonianza forte, sofferta, estrema.
Di Magdi
Allam. Il 31 maggio 2006 arriva in libreria “Vincere la paura” di Magdi Allam
(Mondadori). Panorama ne anticipa un capitolo. "Cara Oriana, finora mi sono
sempre astenuto, sotto l'impulso di un rispetto reverenziale che nutro nei
confronti delle persone a cui ho voluto bene e che ho stimato, dal formulare dei
giudizi netti sulle tue idee sull'Islam e sui musulmani che, piacciano o no,
meritano la massima attenzione perché hanno plasmato il sentimento e forgiato il
pensiero di milioni di italiani. Ma non avrei potuto esimermi dal farlo qui e
ora, mentre mi accingo a scrivere sulla paura dell'Islam, dei musulmani e della
loro eterogenea quinta colonna insediata anche in Occidente, una paura di cui il
mio animo tracima, che domina la mia mente, che condiziona pesantemente la mia
vita, che pervade e viola come un cancro inguaribile e inarrestabile l'esistenza
di gran parte dell'umanità contemporanea. (...) Sono convinto che hai svolto un
ruolo straordinario nel contribuire a formare un sentimento di riscossa civile e
di orgoglio nazionale nell'era della guerra globale del terrorismo islamico,
dell'ideologismo nichilista all'insegna dell'antiamericanismo e
dell'antiebraismo, del pacifismo militante, pregiudiziale, egoistico e perfino
violento, dell'Italia in preda ai teatranti della politica. In qualche modo hai
suonato forte il campanello d'allarme facendoti interprete di una necessità
collettiva che si sprigiona da un profondo malessere di cui i più sono incapaci
di decifrare le cause e individuare la via d'uscita. Ti sei assunta il ruolo
dell'avanguardia rivoluzionaria che sprona le masse a ribellarsi alle forze del
male, a prendere nelle proprie mani il proprio destino, ammonendo contro le
tragiche conseguenze di un eventuale cedimento. Ti sei offerta fino in fondo
agli italiani e molti di loro l'hanno capito, hanno contraccambiato con sincero
affetto e ti hanno manifestato una immensa gratitudine. (...) Sono felice di
averti conosciuta. Mi sono sentito colmo d'orgoglio quando mi hai cercato
telefonicamente nell'estate del 2003, mentre eri immersa nella scrittura di La
forza della ragione, per chiedermi ragguagli e dibattere sulla tematica
dell'integralismo e del terrorismo islamico, partendo dai miei articoli
pubblicati prima sulla Repubblica e poi sul Corriere della sera. Eri discreta,
tenera, piena di premure nei miei confronti. (Continua)Mi sono commosso leggendo
i tuoi affettuosissimi messaggi che talvolta suonavano come un «testamento» di
stima e amicizia eterna: «Davvero, quando avrò (bene o male) concluso questo
lavoretto, la primissima copia sarà per te. Più ti leggo, più ci penso, più
concludo che sei l'unico su cui dall'alto dei cieli o meglio dai gironi
dell'inferno potrò contare. (Bada che t'infliggo una grossa responsabilità)».
L'ho considerato un attestato di simbiosi spirituale e intellettuale che
conserverò nel mio cuore. Ti ho voluto veramente bene, ti ho abbracciata
intensamente, ti ho accolta pienamente nel mio animo. Ma, cara Oriana, io sono
costretto a fermarmi qui. Non potrei, come immaginano di fare taluni, andare
oltre. Passando dal risentimento all'odio, dallo sdegno alla mobilitazione,
dalla denuncia alla ribellione, dalle parole ai fatti. Perché significherebbe
suicidarmi. Come potrei scagliarmi contro l'Islam che mi ha generato, che
volente o nolente rappresenta il mio riferimento identitario, immaginandolo come
il Male incontrovertibile e irrecuperabile? Come potrei infierire contro me
stesso, io che sono musulmano, percependomi come figlio naturale e degenere del
Male? Sai bene che non condivido la tesi dell'Islam come blocco monolitico, con
un'anima integralista e che permane immutato nel tempo. All'opposto sono
convinto che l'Islam, e ancor più i musulmani come persone, sono realtà che si
coniugano al plurale sul piano della fede, dell'ideologia, della politica, della
cultura, delle tradizioni nazionali e del vissuto individuale che, pur nella
similitudine, assicura l'unicità del singolo. Amorevolmente, nella breve
stagione in cui ci siamo incontrati, conosciuti, voluti bene e reciprocamente
stimati, tu mi hai offerto una via d'uscita, hai individuato per me la porta
della salvezza: «Tu sei un laico, tu non sei un vero musulmano». Una possibilità
di redenzione dal Male di cui potrebbe fruire una minoranza di eletti,
personalità straordinarie che si riscattano grazie alla fortunosa concomitanza
di virtù personali e circostanze ambientali. Cara Oriana, non capisci che in
realtà mi hai offerto una mela avvelenata? Che dalla porta che mi spalanchi si
intravedono non la Luce e la Vita, bensì il Buio e la Morte? Al di là delle
buone e amorevoli intenzioni che ti inducono a concedermi la grazia, il tuo
ragionamento finisce per risultare simmetrico a quello degli integralisti
islamici che mi hanno condannato a morte e dei terroristi islamici che mi danno
la caccia. Anche loro dicono: «Magdi Allam non è un vero musulmano». E mentre tu
aggiungi con tono positivo e con una finalità costruttiva: «Tu sei un laico e
hai diritto di cittadinanza nella comune civiltà dell'uomo» loro sentenziano con
tono negativo e con una finalità distruttiva: «È un apostata che merita la morte
per ordine di Allah», «È un nemico dell'Islam che va eliminato e spedito
all'inferno». La simmetria del ragionamento risiede nel fatto che, sia tu sia i
nostri nemici, intendo i miei ma anche i tuoi nemici perché siamo comunque sulla
stessa barca, partite da una ideologia ammantata di religione anziché dal
vissuto della persona. Immaginate che il musulmano sarebbe una sorta di clone
prodotto in serie in modo automatico e acritico da una interpretazione
ideologica dell'Islam assurta a Verità assoluta, universale ed eterna. Di fatto
la vostra percezione dell'Islam e dei musulmani cancella la realtà storica di
secoli di civiltà islamica, umana, prospera e costruttiva, nega la più recente
realtà di stati nazionali musulmani moderni, così come sconfessa la realtà del
vissuto di masse di musulmani che per millenni sono stati sostanzialmente laici.
Ma ti rendi conto cara Oriana che la tesi secondo cui esisterebbe un solo Islam
o comunque un solo modo di interpretare il Corano e secondo cui, quindi, i veri
fedeli sarebbero solo gli integralisti e gli estremisti islamici, mentre i non
praticanti, i moderati, i laici, gli agnostici sarebbero dei falsi musulmani, si
traduce nella mia condanna a morte? Certamente nel mio ostracismo identitario e
civile che comunque farebbe di me un dead man walking, un morto vivente? Nella
versione più edulcorata io sarei un orfano, un figlio di nessuno rimasto senza
radici; nella versione più infamante sarei un rinnegato, un traditore che ha
sconfessato la propria fede. Il punto è che non si tratta affatto di un caso
personale e singolo. Bensì della realtà della maggioranza dei musulmani che
probabilmente in modo non sempre cosciente, esplicito e libero testimonia un
vissuto sostanzialmente laico. Pensa agli straordinari fermenti di democrazia
liberale e laica che si registrano in Medio Oriente, dall'Iraq al Marocco, che
smentiscono il luogo comune sull'Islam e il pregiudizio sui musulmani che li
vuole incompatibili con il sistema di valori fondanti della civiltà occidentale.
Che vogliamo fare di questa maggioranza di musulmani che non corrisponde in
tutto e per tutto al cliché dell'integralista e dell'estremista islamico?
Vogliamo costringere 1 miliardo 300 milioni di musulmani a rinnegare la loro
fede in Allah e nel profeta Mohammad, magari per diventare cristiani o, perché
no, atei? Vogliamo dichiarare guerra a un quinto dell'umanità perché sarebbe
geneticamente ostile e irrimediabilmente perso? Vogliamo massacrarli in massa
come hanno fatto i terroristi islamici in Algeria e come vorrebbero fare in
Iraq? (Continua)Comprendi che questa visione manichea, che non ammette un «Islam
buono» ed esclude «un vero musulmano buono», finisce per fare il gioco di Osama
Bin Laden che nella sua perfidia e follia si è arrogato il ruolo di novello
califfo dell'Islam e ha diviso l'umanità in musulmani veri e miscredenti?
Mettiti nei panni della maggioranza di musulmani: da un lato sono fisicamente
aggrediti dai kamikaze e dai tagliatori di teste islamici, così come sono
costretti a subire il lavaggio di cervello dell'ideologismo comunque nichilista
dei regimi teocratici e autocratici al potere; dall'altro si sentono additati in
modo indistinto e acritico come il nemico e il pericolo mortale per l'umanità
dal resto del mondo. Ebbene cosa dovrebbe fare questa maggioranza di musulmani:
stare inerte in mezzo a due fuochi fino alla sua totale eliminazione? (...) Tu
stessa, nella tua recente opera L'Apocalisse, ammetti l'esistenza di una
«minoranza esigua» di musulmani moderati, tra cui citi Abdel Rahman al-Rashed,
direttore della televisione di sole news Al Arabiya, perché in un coraggioso
editoriale pubblicato sul quotidiano saudita Asharq Al-Awsat ha denunciato il
fatto che «anche se non tutti i musulmani sono terroristi, la gran parte (e non
“tutti”) dei terroristi sono musulmani». Ebbene ti invito a riflettere sul fatto
che al-Rashed, che leggo avidamente tutti i giorni e come me fanno tantissimi
arabofoni, scrive in lingua araba, pubblica su un quotidiano arabo, è letto da
un pubblico arabo, è stato scelto come miglior giornalista arabo dalle masse
arabe. Al-Rashed non è insomma un pesce fuor d'acqua, perché diversamente non
potrebbe godere del prestigio e dell'ampio seguito che si è conquistato. Casomai
è la punta di un iceberg di una immensa voglia di libertà e di civiltà umana che
lentamente trapela, si intravede e si afferma tra le maglie dell'oppressione
politica e dell'oscurantismo ideologico a cui per troppo tempo sono stati
costretti i popoli musulmani. Se oggi Al Arabiya, schierandosi apertamente a
favore dei popoli iracheno e libanese in lotta contro il terrorismo e per la
libertà, ha superato il record di ascolti di Al Jazeera, che è diventata il
megafono dell'estremismo islamico e dell'oltranzismo ideologico, la lezione da
trarre è che il direttore al-Rashed ha avuto l'intelligenza e il coraggio di far
emergere ciò che cova nell'animo e nella mente delle masse, rappresentando
mediaticamente la realtà ideale e politica della maggioranza dei musulmani.
Al-Rashed non è come tu immagini l'esponente di una «minoranza esigua» di
musulmani moderati, addirittura «non un vero musulmano (il corsivo è mio), un
tipo come me, un fuorilegge, un eretico»; all'opposto egli è l'interprete e il
precursore della maggioranza di musulmani moderati. La verità è che ti sei
innamorata del personaggio di al-Rashed, così come era successo anche con me. Ma
non ho dubbi che il tuo idillio con l'uomo al-Rashed non andrebbe oltre
l'effimero battito d'ali di una farfalla, così come è successo con me. Perché tu
semplicemente non ti confronti, non sei interessata a confrontarti su un piede
di parità con le persone in carne e ossa, nella loro dimensione globale e nel
loro processo di continua evoluzione. Il mondo è fatto di persone, nella vita ci
si confronta con persone. Il risultato è che tu non conosci correttamente
l'ampia e complessa realtà odierna del vissuto dei musulmani. (Continua)Comunque
dovresti sapere che non è sufficiente fare copia e incolla dalle pagine dei
giornali, condendo il tutto con sarcasmi e malignità, per rappresentare
onestamente la realtà di tanti esseri umani in carne e ossa. E in ogni caso
dovresti quantomeno porti il problema delle conseguenze concrete che le tue
parole potrebbero avere sulla vita dei tuoi tanti affezionati lettori e dei non
pochi bersagli designati. Ci vorrà sicuramente del tempo. Il parto della
democrazia liberale in terra islamica non sarà né rapido né indolore. Ci sono
tante forze ostili, annidate anche in seno all'Occidente, che vorrebbero
arrestare e far fallire il processo dei musulmani verso la libertà e la civiltà
umana. In questo difficile contesto storico, i giornalisti e gli intellettuali
musulmani laici e liberali sono nell'occhio del mirino degli integralisti, dei
terroristi islamici e dei loro complici. Ecco perché cara Oriana io mi
attenderei da te e da tutti i sinceri amici la massima solidarietà. Non le
malcelate critiche e gli irriguardosi sarcasmi che mi hai riservato nella tua
Apocalisse, senza avere il coraggio di chiamarmi con nome e cognome. Io che ho
già collezionato una serie di minacce e di condanne a morte, da parte dei
terroristi islamici e della loro quinta colonna, e che ciononostante continuo a
stare in mezzo alla gente e non mi sottraggo al dialogo e al confronto, non ho
alcuna remora a dirti in faccia per filo e per segno che cosa penso di te nel
bene e nel male. Quando il tuo discorso scivola nel qualunquismo, spoglio di un
contesto etico, quando arrivi a immaginare che solo tu capisci e sei legittimata
a emettere sentenze, mentre tutti gli altri, indistintamente, sarebbero degli
sciocchi, degli ingenui, dei buffoni, dei traditori, dei demoni, allora tutto si
riduce a un cumulo di parole vane, più o meno sarcastiche, più o meno lecite,
più o meno dannose. Permettimi di aggiungere che c'è una bella differenza tra
l'elaborazione di un pensiero astratto che vaga dalle pagine di un giornale o di
un libro all'altro (parole ammirevoli e altisonanti che si confrontano e si
ritengono appagate dal riferimento a parametri logici, culturali e religiosi che
appartengono alla nostra civiltà, intendo la comune civiltà dell'uomo incentrata
sul rispetto del valore della sacralità della vita di tutti) e il vissuto di una
persona musulmana perbene, che è costretta volente o nolente a confrontarsi con
altre persone musulmane tutt'altro che perbene, cresciute in contesti assai
diversi, portatrici di altri parametri spesso illogici, fautrici di un
ideologismo che esalta la cultura della morte. So bene che fino a quando la
salute te l'ha permesso, e ti auguro di cuore di averne ancora tanta, sei stata
in prima fila nei fronti caldi delle crisi internazionali. Anch'io ho apprezzato
e imparato dalle tue molteplici testimonianze, pur esercitando il legittimo
diritto alla critica. Tuttavia un conto è prestarsi pro tempore per adempiere la
nobile missione di osservatore e commentatore dei grandi eventi che segnano il
nostro tempo, anche rischiando in prima persona ma riservandosi sempre la
facoltà di tirarsi fuori quando lo si ritiene opportuno, e un conto è essere
dentro uno specifico contesto di conflitto religioso, politico, ideologico e
terroristico senza avere la possibilità di sottrarvisi. Perché vedi cara Oriana
io non sono un visitatore esterno, casuale, provvisorio della realtà
dell'integralismo e del terrorismo islamico, bensì un protagonista impegnato,
come giornalista e come uomo, a testimoniare gli orrori della cultura dell'odio
e della morte, a favorire l'affermazione della comune civiltà dell'uomo anche,
ma non solo, tra i popoli e le comunità musulmane. Il mio pegno non è la penna
ma tutto me stesso, in gioco non c'è la carriera professionale ma la mia vita.
Magdi Cristiano Allam:
"Rovinato da giudici e islamici, mi vogliono muto",
scrive "Libero Quotidiano" il 29 luglio 2015. Lui la chiama "Jihad by Court",
guerra santa in tribunale. Lui è Magdi
Cristiano Allam, che
è stato rovinato dai tribunali. Negli ultimi giorni l'ultima condanna per
diffamazione, per le toghe avvenuta nel corso della trasmissione Porta
a Porta e
nei confronti del presidente dell'Unione comunità islamiche d'Italia (Ucoi), Ezzedinz
Elizr. Una condanna in
primo grado, che però lo costringe a pagare, subito, 18mila euro. Così, negli
ultimi tre anni, il
totale sale a 70mila euro per
cause civili. "Sono vittima della persecuzione giudiziaria da parte degli
estremisti islamici taglia-lingue - spiega Allam -, coloro che ti condannano se
dici, scrivi o fai qualcosa che urta la loro suscettibilità, che si scontra con
la loro strategia di islamizzazione subdola, strisciante e inarrestabile
dell'Italia e dell'Europa".
La storia - Allam
ha abbandonato la fede islamica a 56 anni, quando nel 2008 si è convertito al
cattolicesimo. Quindici anni fa è entrato nel mirino dell'islam, attirandosi
anche una condanna
a morte firmata
da Hamas. Nel suo passato è stato inviato de La
Repubblica, vicedirettore del
Corriere della Sera e
parlamentare europeo dell'Udc, e oggi è editorialista de Il
Giornale. Nel corso della sua
battaglia contro l'estremismo islamico si è attirato minacce di morte e denunce.
Spiega sempre Allam: "Prima erano denunce penali, ora solo civili. Per loro sono
un nemico da eliminare in quanto apostata e traditore. L'arma
prediletta è il denaro: ti
denunciano per farti pagare più possibile fino a costringerti alla resa,
mettendoti con le spalle al muro. Investono un fiume di denaro per zittirmi.
Mobilitano avvocati nostrani che spulciano ogni minima sfumatura dei miei
interventi pubblici, andando a ritroso nel tempo fino a quando non subentra la
prescrizione". L'ultima causa persa, simile a tante altre, è stata intentata
perché Allam sostiene che l'Ucoii rappresenta in Italia i Fratelli Musulmani,
proprio come fa Hamas nei territorio palestinesi. Per aver affermato questa sua
teoria in tv è stato (nuovamente) bastonato), anche se, sottolinea, "lo
ho fatto in modo argomentato,
riferendomi a posizioni assunte dall'Unione". Un tempo, Magdi, anche grazie allo
stipendio di parlamentare riusciva a far fronte ai risarcimenti da decine di
migliaia di euro che gli venivano imposti in tribunale. Ora però i tempi sono
cambiati, e le
difficoltà sono cresciute.
Così ha fondato l'Associazione "Amici di Magdi Cristinao Allam", chiedendo aiuto
finanziario per lui e per chi è nelle sue stesse condizioni, per chi subisce
quello che definisce "il ricatto del denaro". Allam conclude: "Sono stato il
primo giornalista in Italia a subire una denuncia dell'avvocato degli islamici e
un provvedimento disciplinare per islamofobia dall'Ordine nazionale dei
giornalisti. Vorrebbero
impormi il bavaglio, ma non
ho intenzione di tacere".
Giudici e islamici hanno
rovinato Magdi "Mi vogliono muto".
La sua
battaglia gli è valsa un mare di denunce dai musulmani. E sentenze sempre
punitive. Condannato a pagare oltre 70mila euro di danni, scrive
Anna Maria Greco
Mercoledì 29/07/2015 su “Il Giornale”. La
guerra santa islamica si fa anche tramite i tribunali, parola di Magdi Cristiano
Allam. Lui la chiama «Jihad by Court», come dicono negli Stati Uniti. In questi
giorni ha subito l'ennesima condanna per diffamazione nella trasmissione tv
«Porta a porta» del presidente dell'Ucoi (Unione comunità islamiche d'Italia)
Ezzedin Elzir e, pur essendo in primo grado, dovrà subito pagare ben 18 mila
euro. Negli ultimi anni ne ha sborsati circa 70 mila per cause civili tutte di
questo tipo, molti di più complessivamente da quando, 15 anni fa, è entrato nel
mirino dei musulmani che attaccava duramente, attirandosi anche una condanna a
morte di Hamas. «Sono vittima della persecuzione giudiziaria - dice - da parte
degli estremisti islamici taglia-lingue, coloro che ti condannano se dici,
scrivi o fai qualcosa che urta la loro suscettibilità, che si scontra con la
loro strategia di islamizzazione subdola, strisciante e inarrestabile
dell'Italia e dell'Europa». Allam, giornalista e scrittore egiziano
naturalizzato italiano, già inviato de La Reubblica, vicedirettore del Corriere
della Sera, parlamentare europeo con l'Udc e ora editorialista de Il Giornale,
ha abbandonato la fede musulmana dopo 56 anni per convertirsi nel 2008 al
cattolicesimo, pur criticando poi aspramente la Chiesa per la sua
«legittimazione dell'Islam come vera religione». Da quando ha iniziato la sua
«crociata» si è attirato pesanti minacce e un mare di denunce. «Prima - spiega -
erano penali, ora solo civili. Per loro sono un nemico da eliminare in quanto
apostata e traditore. L'arma prediletta è il denaro: ti denunciano per farti
pagare più possibile fino a costringerti alla resa, mettendoti con le spalle al
muro. Investono un fiume di denaro per zittirmi. Mobilitano avvocati nostrani
che spulciano ogni minima sfumatura dei miei interventi pubblici, andando a
ritroso nel tempo fino a quando non subentra la prescrizione». L'ultima causa
persa ne ricalca tante altre, perchè Allam sostiene che l'Ucoii rappresenta in
Italia i Fratelli Musulmani, come fa Hamas nei territori palestinesi. É per aver
detto questo in tv, che è stato condannato ancora una volta. «L'ho fatto in modo
argomentato - afferma -, riferendomi a posizioni assunte dall'Unione, comunicati
stampa a favore di Hamas e contro Israele. Nessuna diffamazione, ma è stata
interpretata come calunnia personale del presidente, lesione della sua
onorabilità. Purtroppo in Italia certi magistrati anche di fronte a documenti
che attestano la correlazione con i Fratelli musulmani condannano, mentre altri
considerano le affermazioni libera espressione del pensiero». Il fatto è che una
volta, anche per lo stipendio di parlamentare, Allam riusciva a far fronte ai
risarcimenti di decine di migliaia di euro per cause perse a volte in
contumacia, ma ora i tempi sono cambiati e ha molte difficoltà in più. Così, ha
fondato l'Associazione «Amici di Magdi Cristiano Allam», chiedendo aiuto
finanziario non solo per lui ma per altri nelle stesse condizioni, che subiscono
ciò che chiama il «ricatto del denaro». «Sono stato il primo giornalista in
Italia - ricorda- a subire una denuncia dell'avvocato degli islamici e un
procedimento disciplinare per islamofobia dall'Ordine nazionale dei giornalisti.
Vorrebbero impormi il bavaglio, ma non ho intenzione di tacere».
Dante aveva già capito
tutto: ecco dove e come aveva messo Maometto,
scrive “Libero Quotidiano” il 10 gennaio 2015. C'è una satira anti-Maometto più
feroce di quella di Charlie Hebdo. Circola liberamente in Europa e non solo da
secoli. A scriverla fu uno dei più grandi scrittori della storia dell'Occidente.
E la si studia anche in tutte le scuole. Mette il profeta musulmano e Alì, suo
cugino, genero e successore come Califfo, nientemeno che all'inferno, nel canto
XXVIII dedicato ai seminatori di discordia. Lui, l'anti-Maometto, è nientemeno
che Dante e l'opera è la Divina Commedia. In cui Maometto viene messo nella
boglia più "sozza" che si possa immaginare, piena di corpi mutilati e
orrendamente sfigurati. C'è che secondo le convinzioni dell'epoca, condivise
evidentemente da Dante, l'islam era il risultato di uno scisma nell'ambito della
cristianità: come riporta il Corriere della Sera, il cardinale o monaco
Maometto, amareggiato per non aver conseguito il papato, avrebbe fondato una
nuova dottrina. Per questo Dante lo immagina nella nona bolgia, squarciato dal
mento all'ano, "infin dove si trulla" (ovvero dove si scorreggia). Alì con la
faccia spaccata dal mento alla fronte. Questo perchè, secondo Dante, i
seminatori di discordia nell'aldilà erano condannati a subire il contrappasso
adeguato, soffrendo nel loro corpo le stesse mutilazioni di cui sono stati
artefici in vita.
Divina Commedia: Inferno
Canto XXVIII.
Cenni sul Canto XXVIII. Il ventottesimo canto dell’Inferno è
dedicato alla descrizione della nona
bolgia dell’ottavo cerchio, dove sono puniti i
seminatori di discordia e scismi: come in vita divisero persone e famiglie,
separarono fazioni politiche e crearono scismi religiosi, ora sono mutilati da
un diavolo armato di spada, che provvede a riaprire le ferite non appena si sono
rimarginate. Dante comincia sottolineando l’impossibilità di descrivere la
condizione dei dannati e si serve di una lunga similitudine: non si riuscirebbe
a eguagliare la situazione della bolgia nemmeno radunando tutti i morti e i
feriti delle guerre che hanno straziato il sud Italia nei tempi antichi e
moderni. Dopodiché, Dante inizia la descrizione dei singoli dannati. Il primo
che prende in esame è Maometto,
che, secondo ciò che si pensava nel Medioevo, aveva compiuto uno scisma
all’interno del Cristianesimo. Maometto ha un lungo taglio dal mento all'ano,
che apre con le mani per impietosire il poeta, facendo fuoriuscire tutti gli
organi interni, descritti in modo alquanto volgare. Una volta saputo che Dante è
ancora vivo, il dannato gli affida un messaggio per Fra Dolcino: se non vuole
essere sconfitto dai Novaresi, da cui era braccato, durante il ritiro sul monte
Rubello dovrà rifornirsi di molti viveri, per passare indenne il rigido inverno.
Detto questo, Maometto si avvia lungo la bolgia, accompagnato da Alì,
il califfo che proseguì la sua opera, che infatti ha un taglio sul viso, dal
mento alla fronte, proseguimento di quello di Maometto. L’attenzione di Dante
ora è attirata da un dannato, a cui sono stati tagliati il naso e un orecchio,
che ha un grosso buco in gola dal quale può parlare senza muovere le labbra,
schizzando però molto sangue in giro. È Pier da Medicina, che affida al poeta un
altro messaggio per il mondo dei vivi: dovrà avvisare Guido del Cassero e
Angioliello da Carignano che il tiranno di Rimini, Malatestino Malatesta, ha
intenzione di assassinarli con l’inganno, usando la scusa di invitarli a un
incontro diplomatico. Su richiesta di Dante, Pier da Medicina svela l’identità
di un altro dannato lì presente, menzionato poco prima in relazione alla terra
di Rimini: in una scenetta tragicomica, Pier afferra la testa del dannato e gli
apre forzatamente la bocca, mostrando al poeta la sua lingua mozzata. Il
peccatore in questione è Gaio
Scribonio Curione, che convinse Giulio
Cesare a marciare contro Roma.
A questo punto entra in scena un altro dannato, Mosca
de’ Lamberti, che agita verso Dante i polsi monchi e grondanti sangue,
imbrattandosi tutta la faccia. Mosca ricorda il suo peccato, cioè l’aver messo
l’una contro l’altra le famiglie dei Buondelmonti e degli Amidei, ed è
immediatamente zittito da Dante con una risposta per le rime, che lo fa
allontanare. L’ultimo dannato presentato in questa bolgia è anche quello più
importante, una figura così terrificante che Dante ha paura di non essere
creduto nel raccontarla: è un corpo decapitato che tiene per i capelli la sua
testa mozzata, come normalmente si tiene una lanterna. Per parlare con Dante la
solleva in alto, verso di lui, e rivela la sua identità. Si tratta di Bertran
de Born, e il suo contrappasso è tanto grave quanto la sua colpa: in vita
aveva spinto Enrico III, principe d’Inghilterra, a ribellarsi contro suo padre,
il re Enrico II.
Testo del Canto XXVIII.
Canto XXVIII, nel quale tratta le qualita di de la nona bolgia, dove l'auttore
vide punire coloro che commisero scandali, e' seminatori di scisma e discordia e
d'ogne altro male operare.
...Già veggia, per mezzul
perdere o lulla,
com' io vidi un, così non si
pertugia,
rotto dal mento infin dove si
trulla.
Tra le gambe pendevan le
minugia;
la corata pareva e 'l tristo
sacco
che merda fa di quel che si
trangugia.
Mentre che tutto in lui veder
m'attacco,
guardommi e con le man
s'aperse il petto,
dicendo: «Or vedi com' io mi
dilacco!
vedi come storpiato è
Mäometto!
Dinanzi a me sen va piangendo
Alì,
fesso nel volto dal mento al
ciuffetto.
E tutti li altri che tu vedi
qui,
seminator di scandalo e di
scisma
fuor vivi, e però son fessi
così....
"No allo studio di Dante
nelle scuole. È islamofobo".
Un'associazione vuole abolire la Divina Commedia nelle scuole: "Nel XXVIII canto
dell'Inferno si diffama Maometto", scrive Nino Materi Lunedì 19/01/2015 su “Il
Giornale”. A due settimane da quel maledetto mercoledì 7 gennaio, nelle scuole
italiane l'attentato contro Charlie Hebdo rimane una ferita aperta. Di cui
discutere. Magari scontrandosi. Com'è accaduto in un'aula di un istituto tecnico
di Faenza, dove una volantino di solidarietà per le vittime di Parigi è stato
stracciato da uno studente di fede islamica. Quella che si «combatte» tra i
banchi non è una guerra di religione - Bibbia contro Corano -, ma i sintomi di
un disagio crescente si notano eccome. I giovani musulmani che frequentano le
medie e le superiori nel nostro paese sono aumentati negli ultimi 5 anni di
circa il 20%. Anche la nostra sta diventando (e non da oggi) una scuola sempre
più multietnica e questo sarebbe positivo in uno Stato che vedesse nella
Pubblica Istruzione un'OPA su sui investire in termini di crescita culturale ed
educazione civica; ma questo, purtroppo, non è il caso dell'Italia, dove la
scuola è da sempre considerata l'ultima ruota del carro. Sarà per questo che la
nostra scuola nel bene (poco) e nel male (tanto) rimane lo specchio fedele di un
Paese sempre più afflitto dalla «sindrome del gambero», tra continui passi
indietro perfino sul fronte di quelle che dovrebbero essere le nostre più
radicate tradizioni in termini di civiltà cattolica. E invece in Parlamento è
tutto un fiorire di proposte di segno opposto: come ad esempio il progetto di
sostituire l'ora di religione con una nuova materia, Storia delle religione, nel
tentativo demagogico di garantire la «par condicio» con le altre fedi. È di
pochi giorni fa la notizia di una lettera scritta da vari storici delle
religioni per chiedere un tavolo di confronto alla ministra dell'Istruzione,
Stefania Giannini «al fine di valutare la possibilità di introdurre la materia
da loro insegnata all'interno dell'ordinamento scolastico italiano». Un'apertura
che, fatte salve le buone intenzioni di quanti la auspicano, rischia di generare
mostri. Come dimostra l'associazione Gherush92 che chiede di censurare lo studio
dei Dante in quanto «discriminatorio e offensivo». Il capolavoro di Dante
conterrebbe - a giudizio di Gherush92, cui aderiscono molti docenti - «accenti
islamofobici»: «Nel canto 28° dell'Inferno - si legge in articolo del
Corriere.it ripreso dal sito studentesco Scuolazoo -, Dante descrive le orrende
pene che soffrono i seminatori di discordie, cioè coloro che in vita hanno
operato lacerazioni politiche, religiose e familiari. Maometto è rappresentato
come uno scismatico e l'Islam come una eresia. Al Profeta è riservata una pena
atroce: il suo corpo è spaccato dal mento al deretano in modo che le budella gli
pendono dalle gambe, immagine che insulta la cultura islamica. Alì, successore
di Maometto, invece, ha la testa spaccata dal mento ai capelli. Nella
descrizione di Maometto vengono impiegati termini volgari e immagini
raccapriccianti tanto che nella traduzione in arabo della Commedia del filologo
Hassan Osman sono stati omessi i versi considerati un'offesa». Intanto è notizia
di ieri che nella Scuola Svizzera di Bergamo l'ora di religione cattolica è
stata cancellata: al suo posto si studierà «etica». Una novità che ha sorpreso
genitori e Diocesi: «Questa decisione è un clamoroso errore». La Scuola Svizzera
è l'unica scuola plurilingue di tutta la Bergamasca (comprende classi medie,
elementari, e dell'infanzia) dove una metà degli iscritti è italiani e l'altra
metà è straniera. In nome di Dio. Allah permettendo.
La tomba di Dante nel
mirino dell'Isis: il poeta nemico del Califfato.
Il monumento
dedicato al padre della Divina Commedia nella lista di luoghi sensibili stilata
dal Viminale, scrive Carola Parisi - Martedì 14/07/2015 su “Il Giornale". C'è
anche la tomba di Dante tra i possibili obiettivi dell'Isis. Sembrerebbe quasi
uno scherzo. Eppure, nella nota riservata del capo della polizia Alessandro
Pansa, datata 7 luglio ed inviata alle questure più importanti d’Italia, c'è una
lista dei monumenti e luoghi d’arte che i combattenti islamici potrebbero
prendere di mira dopo l’escalation di violenza contro gli occidentali in
Medioriente e in nord Africa. E, dopo l'attentato al consolato italiano del
Cairo, i controlli aumentano. Tra i luoghi maggiormente sotto il controllo delle
autorità, compare anche la tomba di Dante Alighieri. Il mausoleo si trova nel
cuore di Ravenna, nella "zona del silenzio" che va da piazza San Francesco ai
chiostri francescani. Dante sarebbe considerato un nemico dal Califfato per il
trattamento offensivo riservato a Maometto nella Divina Commedia. Il Profeta
compare nel canto XXVIII dell’Inferno fra i seminatori di discordia e di scisma
insieme col genero e cugino Ali, ed il castigo al quale è sottoposto è la
mutilazione. In effetti, un diavolo scatenato, con un colpo di spada, lo spacca
dal mento fino all’addome, perché in vita ha spaccato e diviso la religione
cristiana.
Tutti i luoghi nel mirino
dei tagliagole del Califfo.
I terroristi
punterebbero sulla tomba di Dante a Ravenna, San Petronio a Bologna e Palazzo
Pitti a Firenze. Il motivo? Offendono Maometto, scrive
Simone Di Meo
Domenica 12/07/2015 su “Il Giornale”. Povero Dante.
I tagliagole del Califfo Al Baghdadi non gli perdonano il sacrilegio di aver
ridicolizzato il Profeta nel XXVIII canto dell'Inferno, raffigurandolo squartato
a metà da un diavolo armato di spada perché «seminator di scandalo e di scisma».
E a distanza di sette secoli e mezzo, i demoni della Sharia vogliono vendicarsi
della Divina Commedia. Nell'unico modo che conoscono. La tomba del Sommo Poeta,
a Ravenna, è in pericolo. Il capo della polizia Alessandro Pansa, in una nota
riservata del 7 luglio scorso, inviata agli uffici info-investigativi delle
Questure più importanti d'Italia, ha stilato un elenco dei luoghi d'arte che la
follia islamista potrebbe prendere di mira dopo l'escalation di violenza contro
gli occidentali in Medioriente e in nord Africa. Dante deve pagare per quelle
terzine sul Profeta che, tra le fiamme della IX Bolgia, gli va incontro insieme
al genero Ali aprendosi il petto e mostrandogli le interiora che gli pendono tra
le gambe. Il suo monumento funebre è un'offesa al popolo di Allah che dev'essere
lavata col sangue. Ma sono tutte le «decorazioni e le raffigurazioni» di
Maometto e le scene dei «trionfi degli eserciti cristiani» sui musulmani che
preoccupano gli analisti del Dipartimento di pubblica sicurezza. Affreschi,
quadri e dipinti sacri che, per l'iconoclastia dell'Isis, rappresentano un
oltraggio insopportabile così come le miniature e le illustrazioni su «turchi e
islamici» dannati nel giorno del Giudizio universale, conservati in biblioteche
e musei. Bisogna aumentare il livello di controllo su questi obiettivi
sensibili, ordina Pansa. Elencandoli uno a uno, da Nord a Sud: la Basilica di
San Marco a Venezia, il Palazzo del Principe a Genova, la tomba di Dante a
Ravenna, appunto; la Basilica di San Petronio a Bologna, Palazzo Pitti a
Firenze, il Santuario del Sacro Speco a Subiaco (Roma), il Vaticano e l'Oratorio
del Rosario di S. Cita a Palermo. Le immagini dei terroristi dell'Isis che
radono al suolo le antiche abbazie cristiane in Siria, polverizzando un
patrimonio storico-archeologico unico al mondo perché appartenente ai « kafir »,
i miscredenti, hanno allarmato le agenzie di sicurezza occidentali che temono
azioni dimostrative da parte di «lupi solitari» interessati a conquistare il
sogno dell'immortalità con un gesto eclatante. Tant'è che, negli ambienti
dell'intelligence, cresce la preoccupazione anche per la città di Pompei, nel
Napoletano. Il sito archeologico più visitato del pianeta e dimora del Santuario
dedicato alla Madonna che ogni anno accoglie decine di migliaia di fedeli per il
mese mariano. Il luogo dove sacro e profano convivono pacificamente. Il posto
perfetto per colpire. L'Italia è uno dei temi ricorrenti della propaganda
jihaidista. Ne parla la combattente italiana convertita Maria Giulia Sergio su
Skype coi genitori prima del loro arresto, promettendo che le armate di Allah
arriveranno nella Città Eterna. Sui social network dei terroristi viaggiano i
fotomontaggi del Colosseo in fiamme. E la copertina di «Dabiq», la rivista
ufficiale dello Stato Islamico, qualche tempo fa ha immaginato la bandiera nera
del Califfato issata sull'obelisco di piazza San Pietro. L'inferno islamista è
alle porte ma non è quello di Dante. E non basterà una Beatrice per salvarsi.
La censura talebana
all’inferno di Maometto,
scrive Vittorio Sgarbi Lunedì 30/07/2007 su "Il Giornale". È vero che
l'abitudine alla violenza e all'orrore, se non scalfisce l'indignazione, ci
rende però meno sensibili e meno disponibili allo stupore; ma, quando mi sono
state fatte conoscere le dichiarazioni di un importante esponente della Quercia
(benché indebolita) bolognese, e di un autorevole docente della Facoltà di
Scienza delle Comunicazioni, sono rimasto molto colpito e, oltre che indignato,
incredulo. Già più di dieci anni fa qualche esponente della comunità musulmana
aveva, non senza destare preoccupazione in tempi meno difficili di questi,
manifestato l'intenzione di cancellare, nella Basilica di San Petronio,
l'affresco di Giovanni da Modena in Cappella Bolognini, ove si vedeva Maometto
mortificato e umiliato da un diavolo intento a deturpargli il volto, come
descritto nel canto XVIII dell'Inferno. La protesta e la minaccia avevano
determinato unanimi reazioni di sdegno e di tutela non solo dei valori
cristiani, ma soprattutto di quelli artistici. E io ricordo di aver manifestato
con altri, oltre al cardinal Biffi, la più ferma condanna per un atteggiamento
di cui non avevo memoria prima di allora. Assai difficile pensare che per
ragioni religiose si potesse pensare di distruggere un'opera d'arte con la
sensibilità moderna così attenta alla conservazione del patrimonio artistico. Ma
ancora più sorprendente che, dopo la crescita esponenziale della violenza,
motivata da fanatismo religioso, le stesse dichiarazioni, lo stesso
atteggiamento distruttivo e iconoclastico dei musulmani sia sostenuto da due
intellettuali italiani con i medesimi argomenti. Merighi ha dichiarato che
milioni di musulmani sono insultati da quest'opera e Roberto Grandi ha
confermato la legittimità delle osservazioni di Merighi. Fatico a credere che
persone con responsabilità politiche e istituzionali come Merighi e Grandi
abbiano potuto senza vergogna pensare e dire che l'affresco con l'immagine di
Maometto in San Petronio a Bologna è offensivo per milioni di musulmani e merita
di essere censurato o distrutto. Questa pratica della censura per una ragione o
per l'altra e sempre con una motivazione religiosa, in Occidente e in Italia, mi
sembra inquietante. Cancellare, negare la storia, ferire o alterare una parte
della mirabile Basilica di San Petronio è comunque un gesto barbaro, a metà
strada tra il comportamento dei nazisti e quello dei talebani. Tutto ciò che sta
in San Petronio è consegnato alla storia, che non si può processare, ma
semplicemente osservare con il diverso spirito dei tempi. La condanna di una
espressione artistica, ispirata all'inferno di Dante, non è comprensibile né
accettabile nella colta e civile città di Cesare Gnudi, Francesco Arcangeli,
Ezio Raimondi, Carlo Volpe, Angelo Guglielmin che hanno educato all'arte e alla
storia. La prospettiva dei musulmani rispetto all'argomento, di per sé fallace,
e adottata da due intellettuali occidentali (e cittadini bolognesi) appare
mostruosa, come di chi non patisca ma faccia un attentato. Distruggere
l'affresco di San Petronio, con le motivazioni di Merighi e di Grandi, equivale
a un atto di terrorismo. Non si può censurare il passato. Non si può processare
la storia. Tutto ciò che è nella Basilica di San Petronio, come in tutte le
chiese italiane, non ha soltanto un significato religioso e un rilievo storico
artistico, ma è consegnato alla storia e deve essere rispettato e considerato
come testimonianza di un'epoca. Misurarlo con la sensibilità di oggi, non
considerarne il collegamento con le posizioni di Dante (a cui l'affresco
bolognese è ispirato) significa assumere la posizione dei barbari e ancor peggio
di chi crede di potere agire contro l'uomo e contro il pensiero dell'uomo in
nome di Dio. I tempi ci avrebbero preparati anche a questo inaccettabile
fanatismo. Ne rimane terribile testimonianza nell'immagine esibita
provocatoriamente dei Buddha di Bamyan fatti saltare con l'esplosivo dai
talebani, per dimostrazione e disprezzo e di insensata potenza. Un gesto
dimostrativo, gratuito, non essendovi più un solo buddista in tutto
l'Afghanistan. Soltanto un relativismo idiota, da parte di due occidentali (ma
ci provò anche Rondolino) per insensatezza può trovare giustificazioni e anzi
motivazioni ad atteggiamenti e comportamenti come questi. Essi, con diverse
motivazioni, hanno lo stesso fondamento della violenza nazista. Come pensare che
due ragionevoli occidentali, educati nelle scuole italiane, con alte
responsabilità possano essere arrivati alle stesse posizioni dei nazisti e dei
talebani? Abbiamo motivate ragioni di essere turbati e preoccupati.
Gli antagonisti attaccano
Quinta Colonna: minacce a giornalisti e residenti,
scrive Franco Bianchini martedì 17 novembre 2015 su "Il Secolo d’Italia".
Un’altra prova della “democrazia” a uso e consumo dei centri sociali. Quinta
Colonna è
un programma che dà fastidio? Bisogna bloccarlo con la violenza, così come si fa
con le manifestazioni del centrodestra o con qualunque cosa non sia in linea con
i diktat degli antagonisti. Ecco allora che la giornalista Nausicaa Della Valle,
inviata della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, è rimasta bloccata
all’interno di un bar nel quartiere di Centocelle, a Roma, proprio per
l’irruzione di un gruppo di giovani appartenenti ai centri sociali. Nel mirino
anche i cittadini che dovevano prendere la parola nei collegamenti di Quinta
Colonna. «Durante la diretta
con il programma di Retequattro – dice una nota – una cinquantina di persone ha
inveito contro la giornalista e i suoi ospiti, abitanti della zona, insultandoli
e obbligandoli a interrompere il collegamento». «Solidarieta a Nausicaa Della
Valle, collega di Quinta Colonna, che non ha potuto svolgere un collegamento in
esterna in diretta da Roma perché minacciata da alcuni antagonisti» è stata
espressa da Pierfrancesco Gallizzi, consigliere della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana, a nome del Movimento Liberi Giornalisti. «Inammissibile e
inaccettabile – aggiunge Gallizzi – che non si possa svolgere il proprio lavoro
perché un gruppo di violenti decide di “interrompere le trasmissioni”. La
libertà d’espressione e il diritto di cronaca non possono essere un optional».
Tra gli ospiti in studio della puntata c’era Magdi
Cristiano Allam,
giornalista e scrittore, che su facebook aveva ribadito: «Per sconfiggere i
terroristi islamici bisogna combatterli militarmente nei loro covi in Libia,
Siria e Iraq, così come dobbiamo scardinale i loro luoghi fisici e virtuali, che
significa moschee e siti jihadisti, dove si pratica il lavaggio di cervello che
trasforma le persone in robot della morte».
Le vignette arabe sulla
strage di Parigi: così sfottono Francia ed Europa,
scrive “Libero Quotidiano" il 16 novembre 2015. Se si osservano le vignette
satiriche sui quotidiani arabi, sarà praticamente impossibile trovare traccia di
solidarietà alla Francia o magari, così anche di sfuggita, un cenno di condanna
per gli attacchi terroristici a Parigi che hanno ammazzato almeno 129 persone.
Per i disegnatori arabi è l'occasione per pungolare la Francia e l'Occidente
sulla "doppia morale", come scrive Maurizio Molinari su La
Stampa, cioè su quanto
siano stati ben più gravi i fatti di sangue avvenuti negli anni nei Paesi arabi,
rispetto alla tragedia parigina. C'è per esempio il vignettista
Ala al-Luqta che
vede la Francia come un signore grasso con una freccia infilzata nella schiena,
seguito da un palestinese colpito da una decina di frecce e che alza un po'
scocciato un cartello con la scritta: "Rifiutiamo il terrorismo a Parigi".
Oppure ci sono vignette che raffigurano la Francia ferita a un dito, ricoverata
in ospedale nella stessa stanza della Siria ferita a morte. Rincara la dose Arab21News che
pubblica una vignetta con la Morte che bussa alla porta dell'Unione Europea
portando un carico di teschi, restituendoli al mittente.
I vignettisti
arabi sfottono la Francia piagnucolosa,
scrive Maurizio Molinari su "La Stampa", lunedì 16 novembre 2015. Solidarietà
per la Francia aggredita da Isis, ma anche ironia, sarcasmo e una raffica di
accuse di doppio standard morale nel giudicare vittime musulmane e occidentali:
sono le vignette pubblicate da numerosi giornali del Medio Oriente per
descrivere le reazioni al massacro di Parigi, spesso segnate da critiche assai
aspre. Per il vignettista giordano Osama Hajjaj la Francia è una bella donna
afflitta dal pianto per l’aggressione subita, con sullo sfondo la Torre Eiffel
che su «Al Araby» è raffigurata come la vittima dell’abbraccio violento di una
kamikaze. Ma si tratta di eccezioni. Per il vignettista Ala al-Luqta
la Francia è piuttosto un panciuto signore europeo con un’unica freccia nella
schiena seguito da un palestinese bersagliato da dozzine di frecce che innalza
controvoglia il cartello «rifiutiamo il terrorismo a Parigi» in un’evidente
immagine di umiliazione per tutti gli arabi. È un messaggio simile a quello
delle vignette che paragonano la Francia ad un ferito ad un singolo dito,
ricoverata nella stessa corsia di un ospedale dove si trova la Siria ridotta in
fin di vita. Per suggerire la sproporzione dell’Occidente nel valutare le
differenti tragedie. «Arab21News» si spinge fino a descrivere i killer di Parigi
come una Morte che bussa alla porta dell’Unione europea con il suo carico di
teschi sulle spalle, recapitandoli al mittente. E Carlos Latuff, noto
disegnatore arabo-brasiliano, chiama in causa il presidente Hollande,
raffigurandolo mentre dà fuoco alla Siria innescando l’incendio che produce il
genio malefico dell’Isis che accoltella la Francia. Per l’iraniano Al-Alam la
lettura invece è tutta anti-saudita perché il titolo della vignetta sull’attacco
alla Francia è «Il terrore wahhabita colpisce Parigi». Ovvero: Isis è un
prodotto dei rivali sunniti del Golfo.
Siamo (quasi) tutti
Valeria. La
studentessa uccisa dalle bestie. Tutti solidarizzano, ma chi non vuole
denunciare la barbarie islamica non la commemora e non può nemmeno restare tra
noi, scrive Alessandro Sallusti Lunedì
16/11/2015 su “Il Giornale”. Adesso è ufficiale. Valeria Solesin, 28
anni, è tra le vittime - unica italiana - delle stragi parigine. Lo diciamo con
sincerità e senza retorica: oggi siamo tutti Valeria, morta innocente come nelle
guerre convenzionali accadeva ai civili sotto i bombardamenti. Il fatto che la
ragazza fosse stata un'attivista dell'organizzazione pacifista Emergency di Gino
Strada rende la sua morte ancora più assurda e paradossale, ed è la prova della
ferocia di un nemico al quale non interessa neppure distinguere per appartenenza
ideologica o politica. Siamo tutti bersagli in quanto occidentali, in quanto
infedeli. Per questo il nostro «siamo tutti Valeria» ha bisogno di qualche
delimitazione per evitare ipocrisie e complicità. Al di là di come la pensasse
la ragazza, oggi non può dirsi Valeria chi crede che gli attentati di Parigi
siano l'inevitabile risposta a presunte nefandezze dell'Occidente. In
particolare non sono Valeria quei numerosi islamici moderati che, interpellati
in queste ore dai giornalisti per strada e all'uscita delle moschee, riempiono
di «se» e di «ma» la loro già tiepida presa di distanza dai terroristi che hanno
ucciso in nome di Allah. Ieri abbiamo scritto: se è vero che siamo in guerra è
necessario adottare misure straordinarie a costo di sospendere alcune garanzie
oggi scontate. Per esempio, penso che si debba ritirare il permesso di soggiorno
a chi solidarizza direttamente o indirettamente con chi uccide i nostri figli.
Se mettiamo in galera cittadini italiani per l'ambiguo e discusso reato di
concorso esterno in associazione mafiosa (è sufficiente avere avuto contatti con
persone mafiose) non vedo perché non si debba introdurre lo stesso trattamento
nei confronti di chi strizza l'occhio a degli assassini che ci hanno dichiarato
guerra. In queste ore c'è il sacro terrore a parlare di guerra di religione. Ma
siccome, purtroppo, è così, non si può più accettare la commistione tra islamici
moderati e islamici radicali che, come dimostrano numerose inchieste
giudiziarie, avviene quotidianamente in molte moschee e comunità di immigrati.
Quando si è in guerra bisogna scegliere senza «se» e senza «ma»: o di qua, o di
là. E chi è di là, ovviamente, non può essere con Valeria né con noi. Di più:
non può stare tra noi.
Mandiamo Di Battista e
Boldrini a trattare con l’ISIS.
Caro Beppe e cari Italians, ricordate “Je suis Charlie”? E le fiaccolate nelle
vie delle città per onorare quella dozzina di morti? E le interminabili e
inconcludenti tavole rotonde? E le condanne “decise e sdegnate” di governi e
istituzioni? E le prediche del Papa che scomunicava a largo spettro ed implorava
l’intervento di Dio? E oggi? Siamo puntualmente daccapo. Anzi, ancora peggio.
Oggi ripartiamo dalle centinaia di morti e dalla litania del “Je suis Paris”.
Probabilmente aspettando le incoming entries “I’m London” e “Noi siamo Roma”. Ma
davvero qualcuno pensa che con quelle bestie che decapitano e macellano uomini e
donne in quanto “infedeli”, e ci avvertono che questo è solo l’inizio, esista
uno spiraglio di trattativa? Era nel giusto Di Battista quando ci bacchettava
perché non ci sforziamo di capire le loro ragioni? O la Boldrini che inorridisce
all’idea di reagire con la forza perché, come dimostra la sua apodittica analisi
storica, “i bombardamenti non hanno mai risolto nessun problema”? Io proverei
galileianamente a sperimentare l’efficienza della logica buonista dei nostri
“onorevoli”. Potremmo incaricarli, a nome del popolo italiano, di contattare
direttamente l’ISIS. Se riuscissero a convincerli che forse il totale genocidio
degli infedeli non è propriamente una cosa politically correct, al loro rientro
in patria li accoglieremmo con il dovuto trionfo e con la perenne gratitudine
nostra e dei nostri figli. E se non tornassero? Beh, sperando che l’ISIS,
riconoscente, abbia risparmiato loro la vita, cercherei di farmi una ragione di
quell’insopportabile distacco da noi.
Lorenzo Basano su “Italians" de “Il Corriere della Sera”.
La verità scomoda di Putin:
“All’Isis soldi da Paesi del G20”.
Il leader russo mette in imbarazzo sauditi, Qatar, Emirati e
Turchia. Finanziamenti “privati” e complicità nel traffico illegale di petrolio,
scrive Maurizio Molinari su “La Stampa” il
17/11/2015.
«Isis è finanziato da individui di 40 Paesi, inclusi alcuni membri del G20»:
Vladimir Putin sceglie la chiusura del summit di Antalya per far sapere ai
leader attorno al tavolo che la forza dello Stato Islamico è anche in una zona
grigia di complicità finanziarie che include cittadini di molti Stati. Con un
colpo di teatro, sono gli sherpa russi a consegnare alle altre delegazioni i
«dati a nostra disposizione sul finanziamento dei terroristi». Si tratta di
informazioni che il Dipartimento del Tesoro di Washington raccoglie dal 2013 ed
hanno portato, nella primavera 2014, a pubblicare un rapporto che chiama in
causa «donazioni private» da parte di cittadini del Qatar e dell’Arabia Saudita
trasferite a Isis «attraverso il sistema bancario del Kuwait». Un rapporto della
«Brookings Institution» di Washington indica nei carenti controlli delle
istituzioni finanziarie del Kuwait il vulnus che consente a tali fondi «privati»
di arrivare a destinazione «nonostante i provvedimenti dei governi kuwaitiano,
saudita e qatarino per bloccarli». Fuad Hussein, capo di gabinetto di Massoud
Barzani leader del Kurdistan iracheno, ritiene che «molti Stati arabi del Golfo
in passato hanno finanziato gruppi sunniti in Siria ed Iraq che sono confluiti
in Isis o in Al Nusra consentendogli di acquistare armi e pagare stipendi». «Una
delle ragioni per cui i Paesi del Golfo consentono tali donazioni private -
aggiunge Mahmud Othman, ex deputato curdo a Baghdad - è per tenere questi
terroristi lontani il più possibile da loro». David Phillips, ex alto
funzionario del Dipartimento di Stato Usa ora alla Columbia University di New
York, assicura: «Sono molti i ricchi arabi che giocano sporco, i loro governi
affermano di combattere Isis mentre loro lo finanziano». L’ammiraglio James
Stavridis, ex comandante supremo della Nato, li chiama «angeli investitori» i
cui fondi «sono semi da cui germogliano i gruppi jihadisti» ed arrivano da
«Arabia Saudita, Qatar ed Emirati». L’Arabia Saudita appartiene al G20 ed è
dunque probabile che la mossa di Putin abbia voluto mettere in imbarazzo il re
Salman protagonista di una dichiarazione pubblica dai toni accesi contro i
«terroristi diabolici da sconfiggere». Ma non è tutto perché fra i «singoli
finanziatori di Isis» nelle liste del Cremlino c’è anche un cospicuo numero di
turchi: sono nomi che in parte coincidono con quelli che le forze speciali Usa
hanno trovato nella casa-bunker di Abu Sayyaf, il capo delle finanze di Isis
ucciso in un raid avvenuto lo scorso maggio. Abu Sayyaf gestiva la vendita
illegale di greggio e gas estratti nei territori dello Stato Islamico - con
entrate stimate in 10 milioni al mese - e i trafficanti che la rendono possibile
operano quasi sempre dal lato turco del confine siriano. Ankara assicura di aver
rafforzato i controlli lungo la frontiera ma un alto ufficiale d’intelligence
occidentale spiega che «la Turchia del Sud resta la maggior fonte di
rifornimenti per Isis». «Ci sono oramai troppe persone coinvolte nel business
nel sostegno agli estremisti in Turchia - conclude Jonathan Shanzer, ex analista
di anti-terrorismo del Dipartimento del Tesoro Usa - e tornare completamente
indietro è diventato assai difficile, esporrebbe Ankara a gravi rischi interni».
Lo sgambetto di Putin è stato dunque anche a Recep Tayyp Erdogan, anfitrione del
summit.
Tutti per Parigi, nessuno
per i morti del jet russo.
Quei morti, colpevoli di avere
un passaporto russo, hanno suscitato una minore empatia, scrive Annalisa
Chirico - Martedì 17/11/2015 su “Il Giornale”. Il mio profilo Twitter è fermo al
13 novembre, me ne accorgo soltanto ora. All'indomani della carneficina francese
non ho sillabato cinguettii virtuali, non ho postato una foto della Marianne
lacrimante, non ho ritwittato il simbolo della pace con la torre Eiffel al
centro, non ho rilanciato l'hashtag #PrayforParis. Mi sono astenuta. Non è stata
una scelta deliberata ma un moto spontaneo e inconsapevole. Il tempo delle
preghiere è terminato. Le parole sono esaurite. Rimane il dolore per le persone
ingiustamente strappate alla loro esistenza dalla furia jihadista. Rimane il
silenzio, rabbioso, per la nostra libertà definitivamente perduta, per le nostre
vite irrimediabilmente cambiate. Fino a quando sopporteremo? Quanti fratelli e
sorelle dovremo piangere prima che l'Europa si desti dal vile torpore? La scia
di sangue è lunga. Lo scorso 31 ottobre un aereo civile russo esplode nei cieli
del Sinai. A bordo ci sono 224 persone uomini e donne, famiglie, bambini,
professionisti e studenti che da Sharm-el-Sheikh si dirigono verso San
Pietroburgo. C'è chi legge un libro, chi conversa con il vicino, chi ascolta la
musica. All'improvviso un boato, non hai il tempo di prendere coscienza che sei
risucchiato nel vuoto. È ormai certo che l'autore della strage sia il leader
egiziano di una formazione islamica integralista attiva nel Sinai e legata
all'Isis. Ammettiamolo: la strage aerea russa non ha suscitato un tripudio di
solidarietà neppure paragonabile. Le manifestazioni di vicinanza a vittime e
familiari sono state centellinate, su Twitter non è circolato l'hashtag
#PrayforMoscow. Conta certamente l'ostilità verso lo zar Putin che governa la
Russia con il pugno di ferro e contro l'Isis non si limita a dichiarazioni ma
manda armi e truppe per fare la guerra. Quei morti, colpevoli di avere un
passaporto russo, hanno suscitato una minore empatia. Era forse la prima volta
che contavamo i corpi carbonizzati dal jihad islamico? Nel 2004 piangiamo i 192
morti di Madrid, insieme a duemila feriti, dispersi su binari e treni regionali
a seguito dello scoppio delle bombe jihadiste. L'anno dopo le bombe scoppiano a
Londra: 52 pendolari restano uccisi in quattro attentati suicidi presso tre
stazioni della metropolitana e su un autobus. Stati Uniti e Gran Bretagna, si
dice allora, guidano la coalizione dei volenterosi in Irak e Afghanistan, in
fondo se la sono cercata. Lo scorso anno un ex militare francese legato all'Isis
uccide a colpi di kalashnikov quattro persone al museo ebraico di Bruxelles.
Pochi mesi dopo, il parlamento del Canada è assediato, un soldato di guardia
viene ucciso: ha solo 24 anni, è più giovane di Valeria Solesin, l'italiana che
voleva abbracciare la vita crudelmente interrotta al Bataclan da una mitragliata
alle spalle. All'inizio dell'anno assistiamo alla mattanza nella redazione di
una rivista satirica colpevole di blasfemia. Il coro globale del «Je suis
Charlie» è interrotto dalle pallottole di un commando armato che irrompe ad un
convegno sulla libertà d'espressione a Copenaghen. La violenza nel nome di Allah
colpisce poi un volo aereo colmo di turisti e, da ultimo, un teatro della movida
parigina. Che cos'è se non un bollettino di guerra? Perdonateci se non abbiamo
più lacrime, le parole scarseggiano, le marce simboliche ci risultano indigeste,
la voglia di pregare si è dileguata e i tweet... al diavolo i tweet.
Una data lega i terroristi
da Charlie Hebdo al Bataclan,
scrive Pierangelo Maurizio su “Libero Quotidiano” il 16 novembre 2015. Va bene
Je suis Paris e Je suis qualunque cosa, ma forse non basta. E le scritte
pacifiste a piazza Farnese a cornice dell'immensa corona di fiori forse
dimostrano che non abbiamo le idee chiare. Una cosa soprattutto è ormai
insopportabile. Apprendere tutte le volte che i massacratori risultino essere
conosciuti dai servizi di sicurezza di Parigi che però sono sempre colti alla
sprovvista. Non è credibile. Basta fare una piccola ricostruzione di 3 anni di
stragi jihadiste in Francia e i risultati sono sconcertanti. Morale, i servizi
francesi non ce la raccontano giusta. Certo, c' è sempre da capire quale - tra
le mille segnalazioni - è quella attendibile. La Francia ha il problema della
comunità musulmana più grande d' Europa. Ma non basta a spiegare i flop d'
Oltralpe. Uno dei macellai di venerdì è un francese di 30 anni, «conosciuto dai
servizi». È stato identificato dalle impronte digitali. Schedato dalla Dgsi, la
Direction generale de la securité interieure, dal 2010: occhio all' anno.
Sarebbe bastato intercettare lui. Senza contare il "profugo" siriano - un
pericolo ovvio denunciato allo sfinimento da Libero, una delle poche voci - tra
i carnefici, tre attentatori che vengono dallo stesso quartiere degli stragisti
di gennaio nonché la pista belga già emersa allora. Non proprio fantasmi. Anche
l'autore degli attentati di Tolosa e Mountaban (tre militari uccisi) e della
strage alla scuola ebraica (4 morti) nel marzo 2012 era «conosciuto dai
servizi». A Mohamed Merah si è risaliti grazie alla targa di uno scooter e all'
ip del computer di una donna, madre di «due sospetti già sotto osservazione dei
servizi antiterrorismo». E pure i killer di Charlie Hebdo, Said e Chérif
Kouachi, e il complice Adamy Coulibaly dell'assalto al supermercato kosher (7-9
gennaio 2015) «erano conosciuti dai servizi». Uno dei fratelli Kouachi, Chérif,
era stato arrestato nel 2008 come membro di un gruppo che reclutava combattenti
da mandare in Iraq. I due fratelli Kouachi riescono ad addestrarsi in Yemen nel
2011 quando sono «persi di vista dai servizi». Coulibaly dall' età di 17 anni
finisce in gattabuia cinque volte per rapina e spaccio. Una perizia psichiatrica
ne evidenzia «la personalità immatura e psicopatica», «scarse capacità di
introspezione». Nel 2010 - ancora - viene arrestato perché implicato nel
tentativo di far evadere il terrorista Smain Ait Alit Belkacem (un simpaticone
che nel '95 voleva far saltare il metrò di Parigi). Indagini che hanno coinvolto
anche i Kouachi. Tutti con una sfilza di precedenti per reati comuni
"politicizzatisi" in carcere (dunque facilmente agganciabili e controllabili).
Tutti scarcerati poco dopo le condanne per terrorismo. Coulibaly e i fratelli
Kouachi, grandi amici, sono conosciuti con altri come "quelli di
Buttes-Chaumont", dal Parco dove si ritrovano e si allenano in esercizi
para-militari. En plein air. Non proprio dei grandi cospiratori. A Coulibaly
mancava solo di scriverlo sul biglietto da visita, che voleva andare a
combattere in Siria. E gli attentati del dicembre 2014 - un automobilista si
butta col furgone sui passanti, un altro assalta con un coltello un
commissariato - (14 feriti), antipasto di quello che verrà a gennaio, a sua
volta antipasto di quello che è arrivato venerdì sera? L' autore dell'assalto al
posto di polizia, ucciso dopo aver ferito tre agenti, Betrand Nzohabonayo, passa
per uno squilibrato. Però fratello di un «radicale islamista», che aveva cercato
di andare in Siria, e due giorni prima sulla sua pagina facebook ha pubblicato
la bandiera nera dell'Isis. Anche loro due «erano conosciuti». No, i servizi
francesi non ce la raccontano giusta. Non è verosimile che gli 007 di Parigi,
tra i migliori del mondo e con una delle storie più blasonate, ogni volta «si
facciano sorprendere» e facciano acqua da tutte le parti. Non è pensabile.
Questo è un dato di fatto. Trovare una risposta è più difficile. La più
probabile è che queste cellule facciano parte del network infiltrato e di cui i
francesi si sono serviti per fare il lavoro sporco in Siria, in Libia come in
Iraq. Poi sono sfuggite di mano. Qualcosa tipo Bin Laden e gli Usa, giusto per
capirci. A rafforzare l'ipotesi, gli assassini, da Coulibaly all' attentatore di
venerdì, sono schedati dal 2010, come fosse una stessa "nidiata". Andare fino in
fondo con le indagini o anche solo con una versione credibile significherebbe
con buona probabilità far emergere la rete della barbe finte - cosa che nessuna
intelligence può permettersi - ma anche responsabilità non solo politiche. Al
governo di Parigi non si può certo chiedere - e ora poi - di mettere a
repentaglio la propria sicurezza nazionale. Ma i fratelli francesi facciano
almeno ammenda sugli errori - tragici - compiuti in Libia per detronizzare
Gheddafi, ai quali ha tentato di opporsi solo un Berlusconi ormai troppo
indebolito, e per destabilizzare la Siria di Assad. Poi, con la massima
solidarietà, si faccia la guerra vera al terrore islamico. Giocarci, con questa
guerra, per interessi e fini di parte è molto pericoloso. In gioco ormai sono la
sicurezza di tutti i giorni, le vite dei nostri figli, il futuro dell'Europa.
L'antica liaison tra
Francia e mondo arabo,
scrive il 16 novembre 2015 Toni De Santoli su “La Voce di New York”. Poteva
gli attentati di Parigi essere evitati? Poteva essere evitato l’avvento
dell’integralismo islamico? Il problema è che stiamo parlando di mandanti ed
esecutori cresciuti nel più assoluto oscurantismo, allevati nell’odio cieco e
schiavi inconsapevoli di se stessi, che nulla sanno dell’antica liaison tra
Francia e universo arabo...Che i francesi detestino gli arabi, o i musulmani in
generale, è uno dei luoghi comuni più triti e ritriti in assoluto, come quello
della “freddezza” inglese, della “pigrizia” italiana, della “ingenuità”
americana. La Storia degli ultimi centocinquanta o centosessanta anni dimostra
il contrario: verso il mondo musulmano, verso il mondo arabo, la Francia ha
sempre nutrito un profondo interesse culturale, attratta com’era dalla “psiche”
algerina, tunisina, marocchina e, in secondo luogo, siriana. Ne è dimostrazione
una pubblicistica sterminata, nella quale campeggiano scritti di Camus, Malraux,
Gide, di altri autori francesi ancora. La Francia sedotta, eccome, dalla
comunicativa araba, dalla luminosità araba, dall’imperscrutabilità araba. La
resistenza stessa dei conservatori francesi (ma anche di parecchi socialisti)
alla lotta indipendentistica algerina intendeva sostenere l’istanza di una
fratellanza comune in un solo Stato, in una sola Nazione, “da Calais a
Tamanrasset”, come recitava uno slogan nazionalista assai in voga fra il 1959 e
il 1962; vale a dire “un solo” popolo dal porto francese sulla Manica all’angolo
meridionale dell’Algeria. Alla quale Algeria nel 1962 Charles De Gaulle,
Presidente della Repubblica, volle concedere l’indipendenza poiché
quell’indipendenza doveva essere concessa. Nemmeno la massiccia immigrazione
nordafricana in Francia, con la conseguente nascita delle “banlieue”, ha saputo
spezzare il legame creatosi fra francesi e musulmani nordafricani: nei “bistrò”
parigini, nelle “brasserie” del Quartiere Latino, di Saint-Cloud, Montmartre,
Madeleine, Havre-Caumartin, “rive gauche” o “rive droite” già quaranta o
cinquant’anni fa incontravamo francesi che flirtavano con arabe, arabi che
flirtavano con ragazze francesi. La musica che piaceva ai francesi di pelle
bianca era la stessa che elettrizzava giovani nordafricani: la musica della
Piaf, di Gilbert Bècaud, Charles Aznavour, Mireille Mathieu. Il marocchino Bob
Zagouri, che sposò Brigitte Bardot, divenne seduta stante una celebrità in tutta
la Francia e non solo in Francia: nessuno ebbe da ridire sulla decisione di
“Babette”. Liberi professionisti, bianchi e cristiani, avevano la loro “brava”
amante araba, così come la signora parigina di Place des Vosges o di Avenue
Hoche poteva contare su bei virgulti arrivati dall’Atlante marocchino o da
Algeri, Bona, Tunisi…. Figlie di piccoli proprietari terrieri dell’Alvernia o
del Poitou-Charantes sposavano arabi di belle promesse, rampolli di famiglie
parigine o marsigliesi sposavano bellezze berbere o tunisine. Il Cinema francese
s’interessava al mondo arabo, giovani arabi s’iscrivevano in università francesi
e non inglesi, non americane, non italiane, neppure olandesi o tedesche o
austriache; salvo casi rari. In anni ancor più recenti, nessun ateneo francese
ha mai respinto uno studente perché arabo, perché musulmano, perché “diverso”.
Ma venerdì 13 novembre 2015, come il 7 gennaio 2015 (strage nella redazione del
periodico satirico Charlie Hebdo), la furia arabo-musulmana s’è abbattuta
sulla Francia: s’è ancora una volta abbattuta su Parigi. Non a caso gli
attentatori hanno scelto come obiettivi due luoghi di notevole significato, ma
l’uno diverso dall’altro: “La Bastille” (undicesimo “arrondissement”), in quanto
emblema della Francia moderna, quella nata appunto dalla Rivoluzione del 1789;
della Francia egalitaria, sì, giacobina, ma ancor più espansionistica di quella
di Re Sole; e Place des Vosges, quartiere residenziale, perciò assai chic, il
quartiere dei ricchi, il quartiere delle signore francesi che commettono
adulterio con la stessa facilità con cui a colazione consumano caffellatte e
croissants. Mandanti ed esecutori comunque nulla sapevano dell’antica “liaison”
fra la Francia e l’universo arabo: quello che intendevano appunto colpire con
ancor più veemenza di prima era la nazione considerata quale carceriera,
sfruttatrice, padrona delle masse islamiche d’un tempo e tuttora una delle punte
di diamante dell’Occidente “anti-musulmano”. Mandanti ed esecutori cresciuti nel
più assoluto oscurantismo. Allevati nell’odio cieco. Schiavi inconsapevoli di se
stessi. Squallide entità tuttavia capaci di commettere atroci delitti. Ma poteva
tutto questo essere evitato? Poteva essere evitato l’avvento dell’integralismo
islamico con la presa del potere in Iran da parte dell’ayatollah Khomeini nel
1979, presa del potere ispirata e favorita dagli Stati Uniti sotto l’influenza
delle solite “teste d’uovo”? Non c’è nulla di inevitabile nella Storia,
assolutamente nulla: ci si sarebbe dovuti chiedere a che cosa si sarebbe andati
incontro col rovesciamento dello Scià di Persia, Rheza Palhevi…. Da allora non
assistiamo che all’incalzare continuo, martellante, sanguinario dell’estremismo
islamico. Ma, attenzione: oggi come oggi ogni musulmano sotto i quarant’anni
d’età è un potenziale agente e strumento del terrorismo. Oggi Parigi, ancora una
volta Parigi; e domani? Domani potrebbe toccare a Roma. Stalin chiederebbe, con
tagliente ironia: “Di quante Divisioni dispone il Papa?
COS'E' IL TERRORISMO?
TERRORISTI E FIANCHEGGIATORI.
Parigi, 13
novembre 2015: il racconto della strage.
La storia della Francia e dell'Europa è cambiata in 40 minuti. E' passata una
settimana, 130 innocenti uccisi in sei attacchi, anche i jihadisti sono morti.
Resta però il mistero su uno di loro. Ecco la cronaca di una notte che nessuno
potrà dimenticare, scrivono Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Anais Ginori,
Daniele Mastrogiacomo, Fabio Tonacci, su “La Repubblica” il 20 novembre 2015.
La chiamano l'Estate di san Martino. E la sera di Parigi è mite.
La temperatura è di 15 gradi. Assenza di vento. Allo Stade de France, banlieue
nord di Saint-Denis, è in programma alle 21.00 l'amichevole Francia-Germania.
I caffè hanno i tavolini all'aperto. Nella città che non ha terrazzi, le
chiamano terrasse. Il cartellone del teatro Bataclan,
al 50 di Boulevard Voltaire, ha in programma il concerto degli "Eagles of Death
Metal", gruppo garage rock californiano. Prima tappa di una tournée che deve
toccare altre città della Francia. Da settimane non si trova più un solo
biglietto.
Alle 19.30
il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve è a Montrouge, periferia sud di
Parigi, per consegnare le onorificenze agli agenti della polizia municipale che,
l'8 gennaio, ventiquattro ore dopo la strage di Charlie Hebdo, hanno per primi
intercettato Amedy Coulibaly, l'assassino della vigilessa Clarissa
Jean-Philippe, impedendogli di consumare una carneficina che, purtroppo, avverrà
il giorno successivo.
Alle 20.30,
il ministro è di ritorno a Place Beauveau, sede del Ministero dell'Interno. I
giorni di Charlie sono lontani. O almeno così
sembra. Cazeneuve discute brevemente con i suoi collaboratori dei due falsi
allarmi terrorismo della giornata. Alla Gare de Lyon, in parte evacuata, e al
"Molitor", vecchio hotel art decò sulla riva sinistra della Senna che ospita la
nazionale tedesca. Non c'è motivo di ansia. "#Diemannschaft ist zuruck im Hotel.
Voller Fokus auf #Frager", "Siamo tornati in albergo. La testa è solo alla
Francia", twitta la nazionale tedesca. A duecento metri da Place Beauvau,
il presidente François Hollande sta lasciando l'Eliseo diretto allo stadio. I
titoli del telegiornale danno notizia dello sciopero dei medici contro la
riforma del Governo e dell'annunciata uccisione di Jihadi John in Siria.
Consigliano di anticipare i regali di Natale, annunciano la riapertura del museo
Rodin e l'attesa per la partita della sera. "Il primo match contro la Germania
dopo l'eliminazione ai quarti nel mondiale del Brasile". Almeno nove uomini si
salutano per l'ultima volta e salgono su tre macchine di colore nero. Una
Volkswagen Polo, una Seat Leon, una Renault Clio. Hanno tutte e tre targa e
immatricolazione belga. Sono state affittate pochi giorni prima in un'agenzia di
noleggio auto di Bruxelles a nome Salah Abdeslam e Ibrahim Abdeslam. Due
fratelli residenti nel quartiere Kareveld di Molenbeek. Sono arrivate a Parigi
giovedì sera a distanza di dieci minuti l'una dall'altra, in convoglio. Hanno
depositato i loro passeggeri in un appartamento di Bobigny affittato per una
settimana attraverso il sito homeholidays e in due stanze al terzo piano del
residence Apart'City Paris di Alfortville. In avenue Jules Rimet, il vialone che
costeggia il settore est dello Stade de France, un giovane siriano è chiuso in
un bomber nero. Ha un passaporto in cui dice di chiamarsi Ahmad Almohammad, nato
il 10 settembre 1990 a Edlib, Siria. Ha raggiunto l'Europa cinque settimane
prima. Il 3 ottobre, un barcone di profughi lo ha sbarcato sull'isola di Leros.
Le autorità greche lo hanno fotografato, gli hanno preso le impronte digitali e
riconosciuto un lasciapassare temporaneo nello spazio di Schengen. Un timbro che
gli ha consentito di raggiungere la Serbia e, da lì, la Croazia. L'ultimo tratto
di strada verso i fratelli che lo aspettano a Molenbeek, Bruxelles, Belgio. La
città di Abdelhamid, di Salah, di Ibrahim. La porta verso il Paradiso. Ahmad non
ha il biglietto. La partita Francia-Germania è cominciata da 10 minuti. Il
risultato è sullo 0-0. Hollande, in tribuna, contempla lo spettacolo degli 80
mila dello Stade. Ahmad ha caldo. È fradicio di sudore. Entra nei bagni della
birreria di fronte al cancello D. Il bomber che nasconde la cintura imbottita di
perossido di acetone (Tatp) e bulloni lo soffoca. Si dirige verso i lavabi. Si
appoggia con le braccia tese di fronte allo specchio. Incrocia lo sguardo di
Blay Mokono, un uomo di colore. Il cronometro del tabellone segna il minuto 10
della partita. Blay recupera il figlio tredicenne Ryan e l'amico Rashid al
bancone della birreria. Sono in ritardo. Devono entrare. Ahmad lo urta con la
spalla. Non chiede scusa. Prosegue verso i tornelli e la biglietteria del
cancello D. Lo affronta con garbo uno degli steward. "Non può entrare, monsieur
". Ahmad rincula. Ma non si dà per vinto. Avanza di nuovo di qualche passo.
"Monsieur, le ho già detto che non può entrare senza biglietto". Ora il
tabellone indica il minuto 16 e 24 secondi. Sull'ala sinistra, lavora il pallone
Martial con un profondo retropassaggio. Il boato è avvertito in tutto il catino
ed è confuso con un petardo. Un innocente è morto in un lampo di fuoco e
bulloni. Si chiama Manuel Dias. Ha 63 anni. E' il primo di 130 vittime. La folla
ondeggia in una ola. Sulle tribune si alzano felici i 1.000 impiegati della
compagnia aerea GermanWings in trasferta premio, per cancellare il lutto dello
schianto sulle Alpi francesi. Il pallone ora è dei tedeschi. Un rimpallo lo
riconsegna a Evra. Diciannovesimo minuto e 35 secondi. Di fronte al cancello H,
lungo le vetrine di Decathlon, in corrispondenza dell'insegna Gaumont, un altro
"fratello" muove i suoi ultimi passi. Un secondo boato. Un uomo della sicurezza
presidenziale si avvicina in tribuna ad Hollande. Si china leggermente e
sussurra all'orecchio del Presidente. "Monsieur le Président le Quick a sauté".
Il presidente sa cosa significa. Per sessanta secondi fissa il vuoto. Quindi si
alza senza una parola. Frank Walter Steinmeier, ministro degli Esteri tedesco
seduto alla sua sinistra, lo insegue con lo sguardo mentre prende la via dei
sotterranei. Un corteo di macchine nere esfiltra Hollande verso Place Beauvau.
Dieci chilometri lo separano dal bunker del ministero dell'Interno.
21.53.
A Bilal Hadfi resta l'ultimo giro di orologio dei suoi vent'anni. In piedi,
sotto un palo arrugginito fissa le indicazioni stradali. Autostrada A86, La
Courneuve centre, Aubervilliers, S33. Lo stadio è un rumore di fondo lontano un
chilometro. Quasi quanto il ricordo dei mesi da foreign fighter in Siria. Bilal
pigia l'interruttore che lo spegne per sempre. Un brandello di carne e sangue
imbratta le indicazioni per la S33. Negli spogliatoi dello Stade, Sebastian
Lowe, ct della Germania e Didier Dechamps, collega francese, annuiscono uno di
fronte all'altro con accanto i funzionari Uefa e agenti della polizia. Ora
sanno. Ma non devono dire. Ne va della vita degli 80mila. Per nessuna ragione al
mondo devono sapere. La partita deve continuare. All'angolo tra rue Bichat e rue
Alibert, Ouidad Bakkali, 29 anni, assessore alla cultura di Ravenna, marocchina
di seconda generazione nata in Italia, ordina una birra. Intorno a lei, ai
tavolini del "Carillon" una folla di universitari ride tra uno "waikiki" e
l'altro di rhum e pera. Shot da due euro a bicchierino. Tra Bastille e canale
Saint Martin, questo spicchio dell'undicesimo arrondissement non parla più della
sapienza dei faubourg artigiani. Ha la gioia e l'energia della movida e
la più alta densità di locali della città. Nella Seat Leon nera con targa belga
GUT 18053, tre uomini hanno di fronte 4 chilometri,
15 minuti e 39 vite umane da prendersi. Una vita ogni 100 metri. Al tavolo di
Ouidad e del suo fidanzato sono arrivate le birre. Accanto ai due ragazzi, una
coppia sta litigando. Una macchina fa manovra in corrispondenza dell'ingresso
del locale. È una mamma con la bambina sul sedile posteriore. Deve togliersi di
mezzo. Non fa in tempo. Il calibro 7.62 del kalashnikov imbracciato dall'uomo
sceso dalla Seat le stacca la testa. Ouidad pensa a un petardo. Poi sedie e
tavolini cominciano a volare. I ragazzi urlano. Il sangue imbratta l'asfalto. Le
rose delle raffiche sono ad alzo zero. Da destra a sinistra. Da sinistra a
destra. Sull'altro lato della strada, il proprietario del "Petit Cambodge" tira
furiosamente giù la saracinesca e invita tutti a stendersi a terra dentro il
locale. L'uomo col fucile si avvicina. Le raffiche sbriciolano il cartongesso
del muro. Ouidad vede cadere due ragazze come fantocci. Prega e piange. La Seat
riparte sulla rue Alibert lasciando dietro di sé 100 bossoli e 15 cadaveri.
21.32.
In rue della Fontaine au Roi, ai piccoli tavoli della pizzeria
"Casa Nostra", la pioggia di schegge di vetro anticipa di qualche secondo la
morte che porta la Seat. Una donna, seduta all'esterno, si rannicchia a terra.
"C'est pour la Syrie", sente gridare. L'uomo che le si avvicina alza il
kalashnikov e lo rivolge verso il basso. Appoggia la canna al cranio della
donna. Tira il grilletto. Una, due volte. L'arma è inceppata. Risale in auto.
Non c'è tempo. E cinque cadaveri possono bastare.
21.36.
Nella sua casa dell'undicesimo arrondissement, il primo ministro
Manuel Valls ha appena chiuso la telefonata che lo avvisa che qualcuno ha
dichiarato guerra alla Francia. Che il Presidente sta raggiungendo il bunker del
ministero dell'Interno e che si sta sparando nel quartiere in cui il premier
abita. Ancora. Ancora una volta a dieci mesi di distanza da quella mattina di
Charlie Hebdo. Stesso quartiere. Stesso odio. In rue de Charonne, alla "Belle
Equipe" si festeggia Houda Saadi. Compie 36 anni e si è presa una sera fuori. I
suoi bambini sono a casa. Al tavolo con lei, insieme alla sorella, c'è, con
altri amici, Ludovic Bombasse. Ha 40 anni, è nato in Congo, ama i libri e gli
restano pochi secondi di vita. La Seat è alla sua ultima stazione di morte.
Houda non ha il tempo di capire. Né lo ha sua sorella. Ludovic decide di fare
scudo a Chloé, una ragazza che conosce appena e che le siede affianco. Nascosto
dietro il bancone, Gregory Reibenberg, il proprietario del locale, stringe a sé
sua moglie Djamila. La sente andarsene via, trafitta da una raffica. Lei è
musulmana. Lui ebreo. La contabilità dell'orrore ha spuntato la sua
trentanovesima vita. All'esterno della "Belle Equipe", una ragazza è seduta al
tavolino. Nella mano stringe un calice di vino. La testa è reclinata sul tavolo.
Come dormisse. La Seat nera è ripartita. Un poliziotto di quartiere corre con la
pistola in pugno verso quel tavolo. E' del commissariato dell'undicesimo. Lo
stesso che è intervenuto la mattina di Charlie. Il poliziotto si china sulla
ragazza, che ha ancora gli occhi sbarrati. Crolla in ginocchio. Piange. Sul
maxi-schermo televisivo del "Comptoir Voltaire", il rumore delle raffiche nel
quartiere non ha fatto in tempo ad arrivare, né a farsi strada tra le risate e
il vociare che accompagnano le immagini della partita. Ibrahim Abdeslam è sceso
per l'ultima volta dalla Seat che prosegue verso Montreuil. E per l'ultima volta
ha guardato negli occhi suo fratello Salah. Si siede a un tavolo.Catherine, la
cameriera, gli chiede cosa gradisca. Ibrahim non muove un muscolo. Non le
risponde. Si alza lentamente e dopo due passi salta in aria. C'è sangue
dappertutto. La tv continua ad andare. Ha segnato Giroud. Da qualche minuto, in
Rete, gira il tweet con la foto delle luci del caffè "Comptoir Voltaire". E'
un'immagine singolare e sgranata. Scattata dal tetto di un edificio che guarda
boulevard Voltaire e postata, alle 21.16, dal profilo twitter "OP_IS90".
L'acronimo è corredato da una foto di al-Zarqawi, il macellaio di Falluja. In
una Polo nera con targa belga, parcheggiata di fronte al teatro "Bataclan",
degli uomini sono chiusi da due ore dentro l'abitacolo. I due sui sedili
anteriori smanettano sul cellulare. E' arrivato il tweet di "OP_IS90". Si
chiamano Ismael Mostefai, 29 anni e Samy Amimour, 28. Hanno lo stesso passaporto
francese. Sono nati nella stessa città, Parigi, ma in due banlieue diverse.
Hanno avuto due vite diverse. Samy, nel 2013, è fuggito dalla Francia verso i
campi di Daesh. Non fuma più. Ha sposato la donna che le ha assegnato il
Califfato. L'ultima volta che ha visto il padre, un venditore ambulante di
vestiti, era ancora in Siria e gli ha riconsegnato la lettera con cui la madre
lo implorava di tornare e i 100 euro che quella lettera nascondeva. "Non ne ho
più bisogno", ha detto. Anche Ismael ha toccato l'orrore siriano. Ma, al
contrario di Samy, che è inseguito da un mandato di cattura internazionale per
terrorismo, lui è un invisibile. Dai tavoli del ristorante "Cellar", Cristophe
continua a osservare quella Polo, dentro vede quattro ragazzi. Due ore prima ha
chiesto loro di spostarla. Ma non ha avuto neppure risposta. Li ha fissati per
un attimo negli occhi e ha avuto la sensazione di aver incrociato lo sguardo
vuoto di zombie. Non ha insistito più. Anche se non può fare a meno di chiedersi
per quale diavolo di motivo, da due ore, quella macchina in sosta abbia le luci
spente ma il motore sempre acceso. Cristophe guarda per l'ultima volta
l'orologio. Sono le 21.30. Decide di andarsene. È la migliore decisione della
sua vita. Nella sala del Bataclan il concerto è cominciato. Da mezz'ora Jesse
Hughes pesta sulla sua chitarra. La folla è felice. In mille e cinquecento tra
platea e galleria ondeggiano e ballano facendo tremare le strutture in legno di
questo bizzarro edificio dell'Ottocento. Una guazzabuglio architettonico che
incrocia suggestioni cinesi. I flash dei cellulari che scattano selfie
lampeggiano insieme alle luci stroboscopiche del palco. La band è su di giri
come chi ascolta. Jesse ha piantato un coltello in uno degli amplificatori. Il
rock degli Eagles and Death Metal è anche questa roba qui.
21.42.
Il motore della Polo in sosta in boulevard Voltaire si spegne. I
quattro uomini scendono dall'auto. Il cellulare torna a illuminarsi. Il
messaggio ha 18 battute di testo. "On est parti. On commence". Siamo partiti.
Cominciamo. Il destinatario del messaggio è Abdelhamid Abaaoud.
Il mastermind della cellula. Lo psicopatico di
origini marocchine con passaporto belga che trascina cadaveri nel deserto di
Raqqa con il suo fuoristrada. L'uomo sfuggito in gennaio all'operazione che ha
smantellato la cellula di Verviers. Quello che la Francia dà per certo in Siria,
ma che in Francia è tornato per chiudere il conto. "Vite, vite! Partez, ça
tire". Veloci, veloci, sparano. "Didi" è un'istituzione al Bataclan. Un po'
buttafuori, un po' butta dentro, un po' angelo custode per chi, a notte, non si
regge più in piedi per l'alcool. Ne ha viste tante. Non le ha viste tutte. Non
quello che gli si è appena parato di fronte agli occhi. Due ragazzi usciti per
fumare sono stati giustiziati da quei cavalieri dell'Apocalisse che ora puntano
a passo svelto verso l'interno del teatro. Sono pochi passi. Tra la strada e la
"fosse" dove si balla, si grida, si suda, sono pochi metri. Una porta a vetri,
il guardaroba, due ante girevoli. "I meet the Devil and this is his song".
Incontro il Diavolo e questa è la sua canzone, canta Jesse Hughes annunciando
una delle loro hit, "Kiss the devil". Bacia il diavolo. La prima raffica
sulla platea ne falcia una decina, ma suona come un effetto speciale. La seconda
mette in fuga Hughes, mentre il chitarrista, Dave Catching, continua ancora per
qualche istante a tenere il centro della scena. Poi, l'intera band si rifugia
nel retro palco. La musica si interrompe e ora si sentono solo grida. Di dolore,
di terrore, di implorazione. Le raffiche non cessano un solo istante. Chi non è
riuscito a fuggire usando le uscite di emergenza sui lati della platea ora è
sdraiato a terra. Sono centinaia. Qualcuno si finge morto. Qualcuno si copre con
i morti. Altri strisciano in un lago di sangue e brandelli di carne. Gli uomini
del commando hanno il volto di bambini e la voce da orchi vendicatori. "Avete
ucciso i nostri fratelli in Siria, ora siamo qui". "È colpa del vostro
presidente Hollande". In due, cominciano ad aggirarsi tra i corpi stesi. "Se
qualcuno muove il culo, lo ammazziamo". Ma è una minaccia infame. Perché loro
ammazzano anche chi resta immobile. Con un piede colpiscono chi è a terra per
verificare se sia in vita o meno. E al primo cenno di reazione fanno fuoco alla
nuca. Chi non è più in platea è in cerca di un qualunque nascondiglio. Le
intercapedini del teatro, i camerini, i bagni, i locali della attrezzeria. In
una delle toilette, un gruppo di ragazzi e ragazze sfonda il controsoffitto e si
infila nei condotti della areazione. Una donna incinta si appende ad una delle
finestre. Qualcuno salta giù chiudendo gli occhi fracassandosi gambe e bacino.
Una colonna umana riesce ad arrampicarsi fino ai sottotetti. Qualcuno,
guadagnate le scale antincendio, raggiunge il tetto del teatro e di lì salta sul
palazzo prospiciente. Bussa disperatamente a porte e finestre.
22.01.
Bfm, la televisione all news francese, annuncia: "Una sparatoria a colpi di
kalashnikov ha provocato diversi morti in un ristorante nel decimo
arrondissement di Parigi".
22.18.
L'agenzia di stampa Reuters batte il primo take che annuncia l'orrore fuori dai
confini del Paese.
"Two dead, seven wounded in shooting in restaurant in central Paris".
Due morti, sette feriti in sparatoria nel centro di Parigi.
Nessuno immagina. Nessuno sa. Tranne chi è dentro il teatro e chi verso il
teatro sta correndo impugnando una pistola. È un commissario di quartiere che ha
raccolto il primo allarme e che resterà un angelo senza nome. Entra
nell'edificio scavalcando decine di cadaveri. E nella hall distingue la sagome
di uno dei macellai. Lo protegge soltanto un giubbotto antiproiettile. E quando
le raffiche cominciano a raggiungerlo risponde al fuoco. Uno dei tre con il
kalashnikov salito sul palco, crolla. Gli altri due fuggono verso la galleria.
All'esterno del Bataclan arriva il furgone blindato nero della BRI la "Brigade
recherche intervention", l'unità di élite della polizia giudiziaria. Gli uomini
che ne scendono sono al comando di Christophe Molmy. È uno sbirro che,
dieci mesi prima, ha condotto il blitz all'Hypercacher di Porte de
Vincennes dove si era asserragliato Amedy Coulibaly. Ha scritto un
romanzo, Loups blessés, lupi feriti, sull'umanità storta che ha
combattuto per una vita: banditi, tossici, rapinatori. Gli mancano i martiri di
Allah. Li ha trovati. Molmy è un uomo colto. Sa dare alle cose il loro nome. "E'
l'inferno di Dante ", comunica alla centrale dall'interno del teatro. Pile di
corpi smembrati, lamenti. Un silenzio di morte bucato dal concerto di decine di
suonerie di cellulari che squillano a vuoto accanto a ragazze e ragazzi che non
possono più rispondere. I due martiri in galleria si sono barricati in un locale
con venti ostaggi. Vorrebbero negoziare. O almeno così dicono. Ma non si capisce
cosa. Né a che prezzo. Molmy e le teste di cuoio che sono salite in galleria
dove tutto è ancora buio e le uniche luci sono quelle dei puntatori laser dei
fucili di precisione della BRI, raggiungono la porta che li separa dai due
terroristi e dagli ostaggi. Uno di loro grida "Fermatevi o ci uccideranno
tutti!". Convincono gli assediati a prendere un cellulare attraverso cui
comunicare con il negoziatore della BRI. Lo stesso che aveva inutilmente
trattato per ore con Coulibay. Con i due martiri va ancora peggio. Non riesce
neppure il primo degli step del protocollo del negoziatore. Quello che impone di
stabilizzare l'interlocutore. Raffreddarlo. Sgonfiarlo di adrenalina.
Riportargli i battiti cardiaci a una condizione di lucidità. Dall'altra parte
della porta si farfuglia soltanto di Siria e Hollande. Si minacciano
decapitazioni e non si negozia nulla. Molmy capisce che i 20 ostaggi non sono e
non saranno moneta di scambio. Sono solo animali sacrificali. E anche per questo
quando i due provano a chiamare Bfm fanno cadere la linea del cellulare. Non
vogliono che quello che sta per accadere vada in diretta televisiva e in
mondovisione. Sono le 23.45. Negli ospedali di Parigi sono stati riaperti tutti
i blocchi operatori d'emergenza e tutti i chirurghi richiamati. Dalle ambulanze
vengono sbarcate lettighe su cui sono stesi uomini e donne che sembrano usciti
da una trincea. Sul marciapiede di boulevard Voltaire il prefetto di Parigi
Michel Cadot è in linea con Hollande e il ministro dell'Interno Cazeneuve. Il
presidente ha appena parlato in tv alla nazione, visibilmente sconvolto. "Quello
che vogliono è farci paura". Al telefono il Prefetto Cadot annuisce. La
decisione è presa. Si dia l'assalto. Anticipate da lunghi minuti di scambio di
fuoco, due deflagrazioni scuotono il piano superiore del Bataclan. È finita.
Bisogna solo evacuare i feriti e contare i morti. Ottantanove. Ai tavolini del
"Les Béguines", un pub nel cuore di Molenbeek, Bruxelles,Mohamed Hamri e Hamza
Attou stanno fumando l'ennesima canna e buttando giù l'ennesima birra. Il locale
ha riaperto da qualche giorno dopo essere stato chiuso dalla polizia belga per
droga. Da due anni il proprietario èIbrahim Abdeslam. Da qualche ora, di
quel proprietario è rimasto un tronco d'uomo carbonizzato in boulevard Voltaire.
Ma questo Mohamed e Hamza non lo sanno. O, almeno, racconteranno di non saperlo.
Squilla il cellulare. E' Salah, il fratello di Ibrahim. Chiama da Parigi. "Dimmi
fratello". "Sono qui a Parigi. Ho bisogno che tu mi venga a prendere. Ora. Pago
io la benzina e l'autostrada. Ti aspetto. Ci vediamo a Barbès", il quartiere
arabo del diciottesimo arrondissement, dove verrà ritrovata la terza auto. La
Clio nera. Alle tre del mattino una Volkswagen Golf 3 grigia targata ILJV 973
che percorre l'autostrada A2 Bruxelles-Parigi passa la frontiera tra il Belgio e
la Francia. A bordo, Mohamed e Hamza, che dell'auto è il proprietario. Non c'è
ombra di gendarme lungo la strada. La Francia ha appena annunciato la chiusura
delle frontiere, ma il dispositivo fatica a mettersi in moto. Alle 5, la Golf è
a Parigi e carica Salah.
Alle 9,15
del mattino di sabato 14 novembre, la Golf grigia va in senso
inverso. All'altezza di Cambrai, accosta all'invito di una pattuglia della
Gendarmerie francese. I quattro uomini mostrano i documenti. L'agente li
controlla al terminale della banca dati del ministero dell'Interno. Tra le mani
si ripassa il documento di quell'uomo indicato come Salah Abdeslam. Risultano
precedenti per furto e spaccio di droga. Il gendarme torna alla Golf e
restituisce i documenti ai tre uomini. "Bon voyage Monsieur".
L'attacco agli Usa dell'11
settembre 2001: gli schianti, il fumo e le vittime che cadono dal cielo,
scrive la Redazione di Tiscali L'America subiva il peggior attacco della sua
storia. E oggi quell'11 settembre del 2001 è ancora vivo perché alimentato da
nuovi timori. Ecco la successione, minuto per minuto, della tragedia che ha
cambiato anche gli equilibri politici internazionali. L'ora indicata è quella di
New York e Washington, indietro di sei ore rispetto a quella italiana.
7.59 - Il volo American
Airlines 11 decolla dal Logan International Airport di Boston. Sul Boeing 767,
diretto a Los Angeles, vi sono 95 persone.
8.14 - Il volo United Airlines
175 decolla dallo stesso aeroporto con 65 persone a bordo. Anche questo è un
Boeing 767 e anche questo è diretto a Los Angeles.
8.15 - Primo segnale di
allarme. Il volo AA11 non rispetta le disposizioni dei controllori di volo.
8.15 - Il volo American
Airlines 77 decolla dal Dulles Airport di Washington. E' un Boeing 757 con 64
persone a bordo, diretto a Los Angeles.
8.40 - Boston informa il Norad
(North American Aerospace Defense Command) che il volo AA11 è stato
probabilmente dirottato.
8.42 - Il volo UA93 decolla da
Newark (New Jersey) alla volta di San Francisco. E' un Boeing 757, con a bordo
44 persone.
8.43 - La Faa (Federal
Aviation Administration) notifica al Norad che anche il volo UA175 è stato
dirottato.
8.46 - Il volo AA11 si
schianta contro la Torre Nord del World Trade Center di New York. Il Norad
ordina il decollo immediato di due caccia F-15 dalla base di Falmouth
(Massachusetts).
8.49 - La Cnn interrompe le
trasmissioni. "Un aereo ha colpito una delle torri del World Trade Center".
8.50 - La prima autopompa dei
vigili del fuoco giunge al Wtc.
9.00 - Il presidente George W.
Bush, in visita a una scuola elementare a Sarasota (Florida), viene informato
dal consigliere per la sicurezza nazionale Condoleezza Rice che un aereo ha
colpito un grattacielo del Wtc.
9.03 - Il volo UA175 colpisce
la Torre Sud.
9.07 - Bush è informato dal
capo di gabinetto Andrew Card che "un secondo aereo ha colpito la seconda
torre".
9.16 - La Faa informa il Norad
che anche il volo UA93 è stato dirottato.
9.21 - Le autorità di New York
chiudono i ponti e i tunnel di accesso a Manhattan.
9.24 - Il Norad apprende che
anche il volo AA77 è stato dirottato.
9.26 - La Faa ordina il blocco
di tutti i decolli negli aeroporti Usa.
9.30 - Bush in Florida:
"L'America è sotto attacco".
9.32 - Wall Street interrompe
le operazioni.
9.37 - I controllori di volo
di Washington avvertono che un aereo non identificato è diretto verso la
capitale.
9.43 - Il Volo AA77 colpisce
il Pentagono.
9.45 - La Casa Bianca viene
evacuata. Il vicepresidente Dick Cheney è portato nel bunker blindato sotto la
residenza. La Faa blocca il traffico aereo sugli Usa.
9.55 - L'Air Force One con a
bordo Bush decolla dalla Florida. Bush telefona a Cheney e ordina l'allerta
delle forze militari Usa nel mondo.
9.58 - I passeggeri del volo
UA93, informati di quanto accaduto agli altri velivoli, si scagliano contro i
dirottatori per prendere il controllo dell'aereo.
9.59 - Crolla la Torre Sud.
10.03 - Il volo UA93 precipita
in un campo della Pennsylvania, nei pressi di Shanksville.
10.28 - Crolla anche la Torre
Nord.
10.45 - Le autorità ordinano
l'evacuazione di tutti gli edifici federali di Washington.
12.36 - Bush parla alla
nazione da Barksdale, Indiana. "La nostra libertà è stata attaccata da un
codardo senza volto. La determinazione della nostra grande nazione è stata messa
alla prova. Supereremo questa prova".
13.02 - Il sindaco di New York
Rudolph Giuliani ordina l'evacuazione di Manhattan a sud di Canal Street.
13.27 - Dichiarato lo stato di
emergenza a Washington.
14.50 - Bush si sposta in
aereo al quartier generale del Comando Strategico Usa nella base aerea Offut
(Nebraska) dove presiede una video-conferenza con i membri del Consiglio per la
Sicurezza Nazionale a Washington.
17.20 - Crolla anche il Seven
World Trade Center, un edificio di 47 piani.
18.45 - Bush rientra alla Casa
Bianca.
20.30 - Il presidente parla a
reti unificate alla nazione. "I responsabili la pagheranno. L'America non farà
distinzioni tra i terroristi e coloro che li ospitano".
21.00 - Bush torna a riunirsi
con il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Viene discusso anche un primo piano
di rappresaglia militare contro i terroristi.
Orgoglioso di essere
cristiano e cattolico.
I sinistroidi e similari (5
Stelle) non si limitano a condannare la barbarie islamica di Parigi, punto e
basta. Si sforzano di mistificare la realtà delle cose, contrapponendo le
ipotetiche malefatte cristiane alla barbarie terroristica mussulmana, come per
giustificare o sovvertire le responsabilità. Nascondono nei tg quel “Allah
akbar” gridato nello stadio di Istanbul in Turchia il 17 novembre 2015 nella
partita Turchia-Grecia durante il minuto di raccoglimento per le vittime degli
attentati di Parigi, che inneggia ai terroristi, o quell’appoggio morale ai
terroristi dato da parte dei mussulmani in Italia, interpellati sulla vicenda.
Nei social network post che pubblicano le responsabilità occidentali per la
vendita delle armi in medio oriente o gli eccidi commessi da occidentali da
singoli (vedi attentati di Norvegia con autore Anders Behiring Breivik) o in
seguito ai bombardamenti sui territori occupati dai taglia gole degli ostaggi
innocenti. Atei che parteggiano per i mussulmani in tempi oscurati dalla morte
di innocenti. Islamici, da loro ritenuti ultimo baluardo contro l’occidentalismo
ed il capitalismo. Lì, dove il comunismo ha fallito. Sinistroidi che in nome
della loro fede disprezzano la loro identità, cultura e tradizioni, imponendoci
un politicamente corretto. Non sono i mussulmani ad invaderci ed ad imporre a
casa nostra la loro fede, cultura e tradizioni, senza colpo ferire, ma sono i
sinistroidi a permettere che ciò avvenga. La cultura dei sinistroidi è la
discultura e l’oscurantismo. Atei che si spingono a farsi rapire per foraggiare
il terrorismo con i loro riscatti o che condannano le guerre o gli attacchi per
ritorsione, ma poi speculano finanziariamente con milioni di euro di
finanziamenti sulla cura delle vittime delle stesse guerre.
Le puntualizzazioni
saccenti della sinistra a sinistra.
DISINFORMAZIONE. Non tutti gli
islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici. Doppia
disinformazione: da una parte una frase associata ad Oriana Fallaci, ma non è
sua, mentre il contenuto di quella frase è stato alterato riportando una
considerazione errata sul terrorismo, scrive il 18 novembre 2015 David Tyto
Puente su “Bufale”. Da qualche giorno, ma già a inizio 2015 in seguito
all’attentato terroristico contro Charlie Hebdo, viene largamente condivisa
questa frase associata erroneamente ad Oriana Fallaci e citata da Giuliano
Ferrara durante una puntata di Servizio Pubblico: Non
tutti gli islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici.
In realtà si tratta di una frase del musulmano saudita Abdel Rahman al Rashed
(all’epoca direttore della televisione Al Arabiya) tratta da un suo editoriale e
riportata nel libro “Oriana Fallaci intervista se stessa – L’apocalisse”:
Anche se non tutti i musulmani sono terroristi, la gran parte dei
terroristi sono musulmani. Tornando alla frase
diffusa online e citata da Ferrara a inizio 2015, in questo articolo
raccoglieremo qualche esempio di terrorismo di matrice non islamica.
Che cos’è il terrorismo? Prima
di parlare di terroristi bisogna capire che cos’è il terrorismo:
Il terrorismo è una forma di lotta politica che consiste in una successione
diazioni criminali violente, premeditate ed atte a suscitare clamore come
attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, ai danni di enti quali
istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici,
gruppi politici, etnici o religiosi. Le organizzazioni dedite a tale pratica
vengono definite “organizzazioni terroristiche”, mentre l’individuo è definito
come terrorista, termine che in storiografia indica un membro del governo in
Francia durante il periodo del Regime del Terrore. In realtà non esiste una
definizione accettata da tutti del terrorismo, ma ne è stata data una, nel 1937,
dalla Società delle Nazioni: “fatti criminali diretti contro lo Stato in
cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone”.
Fatti criminali in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in
gruppi di persone. Teniamolo a mente.
Le statistiche. Secondo
gli studi svolti dall’FBI, nell’arco di tempo tra il 1980 e il 2005, il 94%
degli atti terroristici negli Stati Uniti non sono di matrice islamica. In
questo grafico possiamo vedere che il 6% è di matrice islamica, il 7% di matrice
ebraica, il 42% dei latinos e via dicendo. È innegabile il fatto che il numero
di vittime dell’11 settembre sia ben superiore rispetto agli altri episodi.
Ricordiamo che per atti terroristici non si considerano solo esplosioni o
kamikaze. Ecco le tipologie di atti terroristici registrati dallo studio
dell’FBI: Tutti i terroristi sono musulmani è come dire che tutti gli italiani
sono mafiosi. Tra tutti i pregiudizi che calano sugli italiani il peggiore è
senz’altro l’assioma “italiani=mafiosi”. All’estero incontriamo sempre
qualcuno che appena sa che siamo italiani casca in questo luogo comune che, in
un modo o nell’altro a seconda della pazienza di ognuno di noi, ci fa
imbarazzare per la sua stupidità. Sentirci dare dei “mafiosi” è un insulto, per
molti anche molto grave. Per chi non se ne è reso ancora conto, la Mafia è un
gruppo terroristico a tutti gli effetti e di certo non è di religione musulmana.
Il terrorismo in Italia – Gli
“anni di piombo”. La storia del terrorismo italiano è ben impressa nella memoria
del nostro Paese, terrorismo ad opera degli stessi italiani nostri connazionali.
Il periodo tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni ottanta viene
ricordato con il nome “anni di piombo” di cui ricordiamo la “strategia della
tensione” (strategia politica da realizzare mediante un disegno eversivo, tesa
alla destabilizzazione o al disfacimento di equilibri precostituiti). Non
possiamo assolutamente dimenticarci le stragi di quei periodi:
Strage di piazza Fontana a
Milano (diciassette vittime e ottantotto feriti);
Strage di Gioia Tauro (sei
vittime e sessantasei feriti);
Strage di Peteano a
Gorizia (tre vittime e due feriti);
Strage della Questura di
Milano (quattro vittime e una quarantina di feriti);
Strage di Piazza della Loggia
a Brescia (otto vittime e centodue feriti);
Strage dell’Italicus (Strage
sull’espresso Roma-Brennero, dodici vittime e centocinque feriti);
Strage della stazione di
Bologna (ottantacinque vittime e oltre duecento feriti);
Così come non possiamo
dimenticarci le Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica di estrema
sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta armata
rivoluzionaria per il comunismo.
Il terrorismo in Italia – La
Mafia. Come dicevamo in precedenza, non si può negare in alcun modo che la mafia
sia un gruppo terroristico a tutti gli effetti, la storia ne è testimone. Non
bisogna dimenticare le stragi compiute ad atto della malavita organizzata:
Strage del Rapido 904 (17
morti e 267 feriti);
Strage di
Pizzolungo (l’obiettivo era il magistrato Carlo Palermo, ma invece vennero
uccisi una donna e dei suoi due figli gemelli);
Strage di via dei
Georgofili (cinque morti e una quarantina di feriti);
Strage di via Palestro (cinque
morti);
La strage di
Capaci (dove rimasero uccisi il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e
tre agenti di scorta, mentre una decina di persone restarono ferite);
La strage di via
d’Amelio (dove rimasero uccisi il giudice Borsellino e cinque agenti di scorta,
mentre ventitré persone restarono ferite).
Il terrorismo cristiano. Nella
storia non esistono solo terroristi di religione islamica o ebraica, ma anche di
fede cristiana: Il Terrorismo
Cristiano comprende atti di terrorismo compiuti da gruppi o individui che citano
obiettivi o motivazioni da loro interpretati come "cristiani", o entro un
contesto di base di violenza tra diverse fazioni e/o pregiudizi quali
l’intolleranza religiosa. Come altre forme di terrorismo religioso, i terroristi
cristiani hanno indicato interpretazioni di principi di fede – in questo caso
interpretazioni del Vecchio Testamento (bibbia) – come propria ispirazione per
giustificare violenza e omicidi.
Il massacro di Utøya. Non
possiamo dimenticarci del Massacro di Utøya, in Norvegia, ad opera del
terrorista cristiano protestante Anders Behring Breivik,
dichiarato anti-multiculturalista, anti-marxista e anti-islamista. Lui stesso si
autodefinisce “salvatore del Cristianesimo” e “il più grande difensore della
cultura conservatrice in Europa dal 1950“. Il suo gesto portò alla morte ben 77
persone, ma l’obiettivo di Breivik fu quello di mandare un segnale al popolo
norvegese contro il Partito Laburista e fermare la distruzione della cultura
norvegese causata dall’immigrazione musulmana.
Il movimento ultracattolico
Christian Identity e il gruppo Army of God. Un gruppo ultracattolico che ritiene
i cattolici ariani la “Razza Eletta del Signore”, guidati dal terrorista Eric
Robert Rudolph (foto sotto), furono i colpevoli dell’attentato alle Olimpiadi di
Atlanta nel 1996 (111 feriti ed un morto), della bomba contro la clinica per
aborti ad Atlanta ed il bar Otherside Lounge (bar frequentato da clientela
lesbica) nel 1997, della bomba contro la clinica per aborti di Birmingham nel
1998. Negli Stati Uniti d’America è presente anche un gruppo terroristico
chiamato “Army of God“, a cui era associato anche il terrorista Eric Robert
Rudolph, i quali rivendicarono gli attentati del 1997 contro le cliniche per
aborti ed inviarono oltre 500 lettere contenenti polvere bianca, spacciata per
antrace, a 280 operatori nel 2001. Nel 1999 furono arrestati e deportati da
Israele i membri del gruppo ultracristiano Concerned Christians grazie
all’operazione “Operation Walk on Water”, la quale aveva sventato il loro
attentato contro la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Il gruppo terroristico
ultracristiano era convinto di compiere un atto necessario per il ritorno di
Gesù Cristo. Da non dimenticare il famoso gruppo terroristico americano Ku Klux
Klan. Il gruppo terroristico americano giustificava la sua azione contro i neri
e contro gli ebrei attraverso l’interpretazione di alcuni versetti della Bibbia
tra cui quello della Genesi 9, 24-27: «Quando Noè
si fu risvegliato dall’ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore;
allora disse: Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi
fratelli! Disse poi: Benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo!
Dio dilati Iafet e questi dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo!»
Per quanto possa sembrare strano, nella simbologia del KKK c’era anche la croce
che brucia, simbolo usato per indurre terrore.
Il terrorismo ebraico. Non
bisogna dimenticare il gruppo paramilitare sionista Irgun Zvai Leumi giudicato
terrorista dal Regno Unito che operò durante il controllo britannico
della Palestina dal 1931 al 1948, anno in cui il gruppo fu disciolto e i suoi
membri vennero integrati nelle neo-costituite Forze Israeliane di Difesa. Da
citare anche il gruppo paramilitare sionista Lohamei Herut Israel (chiamato dai
britannici Banda Stern), di cui bisogna ricordare il massacro di Massacro di
Deir Yassin, dove vennero uccise più di 100 arabi costringendo i superstiti a
lasciare l’insediamento. Da non dimenticare l’attentato contro il King David
Hotel di Gerusalemme nel 1946 (foto sotto), dove vennero uccise 91 persone di
varie nazionalità. L’Italia se li dovrebbe ricordare soprattutto per l’attentato
compiuto a Roma il 31 ottobre 1946, dove tre giovani terroristi
attaccarono l’ambasciata britannica situata presso Porta Pia facendo esplodere
due ordigni che causarono la totale distruzione dell’edificio.
L’Esercito di Resistenza del
Signore in Uganda. Non tutti conoscono l’esistenza dell’Esercito di resistenza
del Signore, un gruppo ribelle di guerriglia di matrice cristiana (che opera
anche nel nord dell’Uganda, nel Sudan del Sud, nella Repubblica Democratica del
Congo e nella Repubblica Centrafricana). Il gruppo è guidato da Joseph
Kony (foto sotto), il quale si dichiara fondamentalista cristiano contro
all’Islam e a favore della creazione di una teocrazia basata sui Dieci
Comandamenti.
I massacri degli islamici in
Africa centrale. Parliamo dei massacri ad opera dei cristiani ed animisti
anti-Balaka nello Stato di Centr’Africa, dove la minoranza musulmana viene
massacrata. Nel solo mese di gennaio 2014 vi furono circa 1000 vittime, ma il
conflitto dura da anni. A denunciare questi massacri fu Amesty International nel
2014. Ciò causò la fuga di numerosi credenti musulmani verso i paesi vicini.
Libano e Palestina. Non
bisogna dimenticare il Lebanese Phalanges Party, il “partito delle falangi” di
matrice cristiana, le cui milizie compirono i massacri di Sabra e del campo
profughi di Shatila ai danni delle popolazioni musulmane e palestinesi durante
la guerra civile libanese (1975-1990).
Eppure Ayman Al-Zawahiri,
terrorista egiziano, leader di Al-Qā'ida: ha pronunciato queste frasi:«Il
nostro messaggio per voi è chiaro, forte e definitivo: non vi sarà alcuna
salvezza fino a quando non vi ritirerete dalla nostra terra, smetterete di
rubare il nostro petrolio e le nostre risorse, porrete fine al vostro supporto
agli infedeli e alla corruzione dei governanti....E' un fatto certo che non
tutti i musulmani sono terroristi, ma è altrettanto certo, ed eccezionalmente
doloroso, che quasi tutti i terroristi sono musulmani.....Siamo una nazione
fatta di pazienza. E noi resisteremo per combattervi, se Dio vorrà, fino
all'ultimo minuto....Dobbiamo dissanguare economicamente l'America provocandola,
in modo che continui a spendere massicciamente sulla sicurezza. [Dichiarazione
del 13 settembre 2013].
Maurizio Belpietro su “Libero
Quotidiano” del 19 novembre 2015: invece di denunciare l'Isis manifestano
contro di noi. La Francia ieri si è svegliata con le notizie del blitz delle
teste di cuoio contro i terroristi islamici e in tutta Europa, Italia compresa,
si è seguito in tv l'evolversi dell'assedio di Saint Denis. Tuttavia, mentre in
ogni diretta televisiva si parlava dell'azione delle forze speciali francesi e
di quella ragazza che ha scelto di farsi esplodere per evitare l'arresto, Maryan
Ismail si preoccupava di far sapere a tutti di aver organizzato a Milano una
fiaccolata sotto la sede di Libero. Sì, avete letto bene. Un raduno davanti alla
redazione perché io e i colleghi chiedessimo scusa ai musulmani per il titolo di
sabato scorso, «Bastardi islamici». Mentre in Europa ci sono tizi che, nel nome
di Allah, vanno in giro ad ammazzare centinaia di persone colpevoli di vivere in
Occidente - e dunque di andare allo stadio, a teatro o al ristorante -, la
signora Ismail si preoccupava del titolo di Libero. Non chiedeva a ogni islamico
di condannare gli attentatori, di invitare ogni imam a tenere un sermone contro
gli assassini, di lanciare una fatwa contro il califfo Al Baghdadi e i suoi
seguaci. Domandava a noi di scusarci con i musulmani per aver accostato ai
bastardi che hanno sparato contro giovani inermi il riferimento all'islam. Vi
chiedete chi sia Maryan Ismail? La signora, di cui fino a ieri ignoravo
l'esistenza, è nata a Mogadiscio, in Somalia, ma da anni vive a Milano. Figlia
di un diplomatico e politico somalo, è arrivata in Italia in qualità di
rifugiata politica e la politica da quel che si capisce è la sua passione, tanto
da averla indotta a iscriversi al Pd, entrando a far parte della segreteria
cittadina del partito. (...) La sua biografia l'ho desunta da Internet, dove tra
l'altro si trova una sua polemica a proposito della costruzione della moschea
nel capoluogo lombardo. A Maryan non va giù l'idea che il comune, guidato come è
noto da un sindaco sostenuto dal Pd, abbia fatto un bando per assegnare un lotto
di terreno su cui edificare il luogo di preghiera degli islamici locali. La
signora avrebbe preferito che l'amministrazione comunale invece di cedere a
questa o a quella associazione la costruzione e la gestione della moschea,
gestisse in proprio il sito, in modo da averne il controllo. Fosse passata la
sua tesi, oltre agli asili e alle scuole comunali, a Pisapia sarebbe toccato
pure fare l'imam o il muezzin, chiamando a raccolta i fedeli. Perfino i suoi,
cioè quelli del Pd, l'hanno giudicata una follia, al punto che il segretario
cittadino le ha risposto un po' piccato, facendole capire che la moschea non è
l'Atm e non tocca all'amministrazione municipale occuparsi del servizio. La
sensazione è che Maryan sia in cerca di un po' di visibilità, soprattutto in
vista delle prossime elezioni comunali, quando cioè in primavera si dovrà
eleggere il nuovo sindaco. E allora, cosa c'è di meglio se non organizzare una
bella fiaccolata in nome della pace per fare la guerra a Libero? Di certo
sfilando in piazza dichiarandosi vittime di un'offesa a mezzo stampa non si
rischia una pistolettata. Per quanto le nostre parole e i nostri titoli non
piacciano, mi risulta che non abbiano ancora ammazzato nessuno. Cosa ben diversa
invece è contestare integralisti e terroristi, che come si sa, e come si è visto
in questi giorni, non vanno troppo per il sottile, anche con quelli che in
apparenza dovrebbero essere fratelli. Come ha scritto l'altro ieri Ernesto Galli
della Loggia, nel mondo islamico, anche quello moderato che non si riconosce
nelle tesi più radicali e nello Stato islamico, si fa molta fatica a condannare
senza se e senza ma le fazioni più estremiste che si ispirano al Corano. A parte
le dissociazioni post attentati, non esistono infatti prese di posizione nette
contro gli integralisti. Ho provato anche a chiedere a Stefano Dambruoso, uno
che da pm si è occupato di terrorismo, quante volte gli sia capitato di ricevere
da appartenenti alla comunità islamica delle denunce contro persone sospette di
predicare odio o di intrattenere rapporti con organizzazioni terroristiche. La
risposta è stata: mai. A volte si ottiene qualche confidenza, nella speranza che
si chiuda un occhio su altre faccende, ma vere e spontanee dichiarazioni
all'autorità neppure il magistrato che per primo si è occupato di integralisti
ne ha mai ottenute. E allora siamo sempre al punto di partenza: ci si indigna
per un titolo che associa i terroristi e gli islamici, ma anche tra chi si
dichiara moderato si fa poco o nulla per fermare i soggetti più pericolosi. Per
certi versi par di vedere l'atteggiamento della sinistra ai tempi degli anni di
piombo, quando qualcuno sosteneva che i brigatisti erano sedicenti. Vedrete, tra
un po' ci diranno che anche quelli del Bataclan sono sedicenti islamici. Eh sì,
sta a vedere che i jihadisti invece che figli di Maria sono figli della Cia.
Libero e Bastardi islamici,
ecco cosa pensa Vittorio Feltri, scrive “Libero Quotidiano” il 19 novembre 2015.
Nel lungo elenco di persone dotate di razionalità e onestà intellettuale che
hanno difeso la scelta di Libero del titolo "Bastardi islamici" va doverosamente
aggiunto il fondatore di questo quotidiano, Vittorio Feltri, che a Un giorno
da pecora su Raidue ha prima ironizzato: "E come vogliamo chiamarli, discoli
o birichini? Non credo sia esagerato definire bastardi i terroristi che hanno
compiuto una strage come quella di Parigi". Poi Feltri ha spiegato: "Bisogna
leggere oltre il significato delle parole: bastardi è un termine che si riferiva
a tutti i terroristi, non a tutti gli islamici. Il titolo - ha aggiunto - si
riferiva al fatto che i terroristi che hanno colpito in Francia non sono dei
frati trappisti o degli scout, ma degli islamici". Feltri risponde anche alla
provocazione della conduttrice Geppi Cucciari, quando chiede se in caso di
attentati terroristi compiuti da italiani bisognerebbe fare un titolo "Bastardi
cristiani". Feltri dice: "Se ci fossero dei terroristi cristiani che vanno in un
Paese a compiere degli attentati, perché non definirli cristiani? Se lo
facessero si potrebbe fare, ma non lo fanno, quindi non possiamo definire i
cristiani terroristi. Mentre quelli a Parigi, guarda caso, sono islamici o
islamisti".
Giorgia Meloni su “Libero
Quotidiano” del 17 novembre 2015, perché difendo il titolo di Libero: dagli
altri giornali l'Islam è sparito. "Caro direttore, leggo delle polemiche
scatenate da "Bastardi islamici", titolo di apertura del suo giornale all'
indomani degli attentati di Parigi. C' è chi è arrivato a chiedere le sue
dimissioni, altri hanno paventato denunce. L' hanno insultata, chiesto la sua
radiazione dall' ordine dei giornalisti, qualcuno ha addirittura invocato la
galera. Ma sono la sola ad aver visto dietro quel titolo, che colpisce come un
pugno perché appare come un insulto sfrontato, un significato molto più profondo
di quello che gli è stato attribuito da chi si lascia condizionare dai
pregiudizi della propria visione ideologica? Perché personalmente ho
interpretato quel «bastardi» come illegittimi, fasulli, impostori: «Bastardi
islamici» ovvero «Impostori islamici», islamici deviati. Un messaggio che
addirittura potrebbe piacere ai fan del politicamente corretto. Per intenderci,
se lo stesso titolo lo avesse pubblicato il manifesto gli stessi che oggi
attaccano Libero starebbero plaudendo al genio comunicativo. A proposito del
manifesto, titoli ad effetto come questo che colpiscono allo stomaco e
costringono a riflettere, ne fa parecchi (il titolista non lo conosco ma è un
genio vero). Mi viene in mente il titolo «Niente asilo» sopra la foto del
piccolo Aylan, il bambino siriano morto sulle spiagge turche. Il messaggio era
chiaro: gli è stato negato il diritto di asilo politico, e ora che è morto non
potrà andare all' asilo come gli altri bambini. Nessuno è stato così idiota da
credere che il manifesto stesse facendo sarcasmo o insultando un bambino morto.
Lo stesso sforzo di perspicacia non guasterebbe anche per cercare di capire i
titoli (choc) dei quotidiani vicini alla destra. E quindi, col solito
anticonformismo che ci contraddistingue, le scrivo direttore per esprimere a lei
e al suo giornale la nostra solidarietà. Piuttosto approfitterei per fare una
riflessione su titoli e prime pagine di altri quotidiani, come ad esempio
Repubblica: non troverete mai le parole «islam» e «musulmani», quasi che gli
attacchi a Parigi fossero stati compiuti da indefiniti gruppi terroristici di
matrice sconosciuta. Ma questa è un'altra storia (e un altro giornalismo).
Giorgia Meloni
E LI CHIAMANO MODERATI...Islam,
sondaggio tra i musulmani in Italia: il 20% non condanna la strage di Parigi,
scrive “Libero Quotidiano" il 20 novembre 2015. Qual è la reazione dei musulmani
(moderati) alla strage di matrice islamica di Parigi. Bruno Vespa oggi su Il
Giorno illustra un sondaggio che ha mostrato a Porta a porta condotto
da Ipr su un campione dei due milioni di musulmani residenti in italia (di cui
800mila ormai cittadini italiani). Di questi, l'80% condanna la strage di
Parigi, il 12% la giustifica e l'8% dice di non avere una opinione in merito. Il
75% degli intervistati dice che i terroristi si comportano male, il 15% sostiene
che sbagliano, ma li comprende e un 5% dice che agiscono bene, perché bisogna
combattere la cultura occidentale. Secondo il sondaggio, un musulmano su 4 pensa
che la colpa degli attacchi sia degli occidentali e meno della metà dice che si
tratta di singoli terroristi che non hanno niente a che fare con la religione
islamica. Il 40% ritiene che Francia sbaglia a reagire e ad attaccare
militarmente "perché così si fomenta il terrorismo". Ma voi denuncereste un
terrorista o qualcuno che lo favorisce? Il 70% risponde di sì. Quanto
all'integrazione, il 25% non si sente parte del tessuto italiano, mentre la metà
non ha alcuna intenzione di farlo.
Portavoce Ppe:
"I terroristi voterebbero allegramente la sinistra". Fratoianni: "Frase
gravissima".
L'articolo sul sito internet del Partito popolare europeo che attacca la
sinistra. L'esponente di Sinistra Italiana contro le affermazioni di Monika
Hohlmeier: "L'eurodeputata tedesca sfrutta le tragedie di questi giorni per
sponsorizzare la restrizione delle libertà e dei diritti costituzionali per i
cittadini europei". Forenza (L'Altra Europa con Tsipras): "Ci aspettiamo delle
scuse", scrive Monica Rubino su “La Repubblica” 19 novembre 2015.
Sul sito del Partito popolare europeo, nella sezione "Comunicati stampa", c'è un
articolo dal titolo "I terroristi voterebbero allegramente la sinistra". Il
pezzo riferisce che l'eurodeputata tedesca Monika Hohlmeier, coordinatrice del
Comitato delle Libertà civili degli Affari Interni al Parlamento Europeo, ha
criticato i colleghi di sinistra per il loro atteggiamento "lassista" nei
confronti del terrorismo. Segue poi un virgolettato della Hohlmeier, che
giustifica il titolo del comunicato: "Sembra che per i socialisti, i liberali, i
verdi e i comunisti - sostiene l'esponente del Ppe - non ci sia nessuna lezione
da trarre dagli attacchi di Parigi. Questi gruppi di sinistra invitano i
terroristi a sfruttare le lacune della nostra legislazione sulla sicurezza al
fine di perpetrare altri attentati". Per poi concludere: "Le buone intenzioni
per prevenire il terrorismo non sono più sufficienti, è necessario cambiare le
leggi". Il nesso stabilito dalla Hohlmeier fra i terroristi e il "lassismo della
sinistra", come lei stessa dichiara, ha mandato su tutte le furie Sinistra
Italiana, che interviene per bocca del deputato Nicola Fratoianni: "Trovo
gravissime le affermazioni di Monika Hohlmeier - afferma l'esponente di SI - La
deputata tedesca afferma senza vergogna che i terroristi voterebbero
allegramente la sinistra, ed utilizza i morti e le tragedie di questi giorni per
sponsorizzare la restrizione delle libertà e dei diritti costituzionali per i
cittadini europei, il respingimento dei profughi che scappano da Daesh, la
chiusura delle frontiere. Esattamente le stesse posizioni che hanno i terroristi
che insanguinano il Medioriente e le nostre città". "La destra estrema -
prosegue il coordinatore di Sel - evidentemente ha fatto egemonia all’interno
del Ppe. Quello che mi impressiona di più è quanto le posizioni della destra
europea finiscano per fare il gioco dei terroristi, che nella loro agghiacciante
propaganda scommettono proprio su questo: ridurci alle leggi speciali, alla
paura, all’indifferenza verso chi soffre. I terroristi stanno già votando la
destra estrema in Europa, a suon di morti e paura. Perchè odiano la democrazia.
La signora Hohlmeier - conclude Fratoianni - farebbe bene a pensarci prima di
parlare”. "Le parole della collega deputata europea Monika Hohlmeier – dichiara
Eleonora Forenza, capodelegazione dell’Altra Europa con Tsipras al Parlamento
europeo – sono inaccettabili. Da militante di sinistra ed europarlamentare del
gruppo Gue/Ngl, voglio dire all’esponente popolare che noi siamo da sempre, e
realmente, contro i terroristi, contro ogni forma di terrorismo: perchè
lavoriamo per politiche di pace e giustizia sociale, difendiamo i diritti dei
migranti, siamo contro chi usa la paura e l’odio per affermare la propria idea
di società. Anche per queste ragioni ci opponiamo alle politiche della grande
coalizione di cui fa parte il Ppe: fondare l’Europa sul neoliberismo e sulla
solidarietà militare. Mi aspetto da Hohlmeier delle scuse per questa indecente
dichiarazione, che strumentalizza in modo bieco e maldestro il dramma di
Parigi".
Toni Capuozzo: "L'islam
moderato non esiste",
scrive Alessandra Menzani su “Libero Quotidiano” del 30 novembre 2015. Ex
operaio a Marghera, ex contestatore, ex Lotta Continua, figlio di un poliziotto,
friuliano, Toni Capuozzo oggi è un cane sciolto che attacca la destra per
i Marò e la sinistra sulla guerra in Siria. Non ha bandiera né etichette. Fa
fatica a stare fermo. Al lavoro di redazione preferisce quello sul campo, per
questo ha raccontato, da inviato, quasi tutte le guerremoderne o i conflitti,
dalle Falkland nel 1982 all'ex Jugoslavia, dall'America Latina all'Afghanistan.
Le sue sono le occhiaie più famose della tv. Dal 2001 conduce Terra,
l'approfondimento che prima era delTg5, di cui era vicedirettore, e oggi
va in onda su Rete4. Stasera, per l'ultimo appuntamento della stagione,
parla dei cristiani perseguitati in Siria e Iraq.
Perché questa puntata?
«Perché non se ne parla
abbastanza. La Siria oggi è il buco nero del mondo, crea e distrugge alleanze.
In Iraq, nella regione del nord, fino a Massul che è nelle mani dell'Isis,
intere famiglie scappano ma vivono un conflitto: andiamo in Europa o restiamo?
Il dilemma dilania la comunità cristiana, una minoranza, perché chi fugge vivrà
un esilio per sempre».
Quanto all'Islam, pensa che
esista quello moderato?
«No. È una contraddizione in
termini. È ovvio che non tutti gli islamici sono terroristi ma non si può
parlare di Islam moderato. Ha mai sentito parlare di cattolico moderato o di
protestante moderato? È come dire che si può essere molto islamici o poco
islamici. I fratelli musulmani sono moderati? No. Hamas lo è? No».
Gli islamici «buoni»,
chiamiamoli così, potevano essere più decisi nel dissociarsi dagli attentati di
Parigi?
«Io parlo con molti musulmani
e sento le solite litanie: colpa degli occidentali, colpa di Israele, l'Isis è
stata finanziata dagli Usa. Parole per nulla moderate, o no? I terroristi
uccidono nel nome di Allah. Faccio un esempio. Se tuo figlio violenta una
ragazza è ancora tuo figlio. Il vostro rapporto diventa difficile, ti chiedi
dove hai sbagliato come genitore, ma è sangue del tuo sangue. Troppo comodo dire
che è colpa di altri se ha sbagliato».
Il Papa dice che questa è
una Guerra mondiale a puntate. Se è vero, quale sarà la prossima?
«Temo ancora per l'Europa.
Come possiamo difenderci? Con la forza, la fantasia e la lucidità di immaginare
un nuovo assetto mediorientale».
Cameron promette le bombe,
la Merkel manda le truppe, Putin è il più bellicoso. La risposta cauta
dell'Italia come la giudica?
«Se facciamo egoisticamente i
codardi diminuiamo il rischio di attentati in Italia. Questo è ovvio. Certo non
è una gran soddisfazione. Quello che può consentire all'Italia di salvare la
faccia è di prendersi più responsabilità in Libia che è di fronte a casa e fa
parte della piccola sfera di influenza italiana. Comunque la vigliaccheria
italiana di non mandare aerei è la vigliaccheria internazionale di non fare la
guerra di terra e far fare ai curdi il lavoro sporco».
Tra tutte le guerre che ha
seguito per lavoro, dall'ex Jugoslavia all'Afghanistan, quale le ha lasciato il
ricordo più doloroso?
«Quella dei Balcani. La più
vicina a noi. Nel cuore dell'Europa. Quando una guerra è lontana pensi che noi
siamo riparati, protetti. "Da noi queste cose non si fanno". Invece sì: assedi,
stupri, pulizia etnica. L'assedio di Sarajevo è durato quattro anni».
E poi ha anche un ricordo
molto personale.
«Un figlio, lo chiamo così.
Portai un bambino piccolo via da Sarajevo assediata, l'ho nascosto in una
macchina. Aveva perso la mamma, non aveva una gamba, e l'ho tenuto 5 anni. Poi è
tornato là. È quasi più figlio degli altri, è come se l'avessi partorito io.
Adesso ha 22 anni e attraversa un periodo difficile».
Quanti altri figli ha?
«Due. Il ragazzo, il più
piccolo, studia. Mia figlia è laureata in marketing e lavora nel settore
turistico a Londra».
È stato un padre assente?
«Un po'. Stare lontano per
lunghi periodi a volte complica, a volta facilita le cose. Certo, salti qualche
compleanno, qualche pagella scolastica. Quando sono piccoli i figli ti vedono
come la persona più forte del mondo. Crescendo il rapporto diventa più
complesso. Oggi è decisamente buono. Sono felice che non facciano i giornalisti,
comunque. Con la mia ex moglie ho un rapporto bellissimo, oggi sono legato da
otto anni a un'altra donna che fa l'ufficio stampa».
È difficile essere
fidanzata con Toni Capuozzo?
«Non più che stare con un
impiegato di banca… È vero che ogni tanto si vogliono cambiare gli altri, ma ho
sempre fatto questa vita, sono sempre stato così. E poi a parte il lavoro faccio
una vita tranquilla, il massimo dell'evasione per me è andare allo stadio nella
bella stagione a vedere il Milan».
Dice che è felice che i
suoi figli non facciano i giornalisti. Oggi - con Twitter, i blog, Youtube - ha
ancora senso un lavoro come il suo? L'inviato, il giornalismo di guerra?
«Le cose non si escludono. La
rete ha portato una ventata di aria fresca e di democrazia ma allo stesso tempo
la professionalità, la ricerca dei fatti, la garanzia di un lavoro artigiano,
contano molto. A volte la rete è come il cesso di un autogrill. Nessuno ha mai
telefonato a Samantha il cui numero appare nel cesso di un autogrill. Perché sai
che è uno scherzo. Nell'anonimato ti muovi con circospezione. Un giornalista
invece ha quella tracciabilità che a volte garantisce autorevolezza».
Però lei ama scrivere su
Facebook.
«Ci sono le risposte, i
feedback, è divertente anche se non è pagato. Quando avevo la rubrica sul Foglio
era una specie di confessionale in cui avevo una libertà maggiore rispetto alla
tv, in cui è giusto tenere un maggiore equilibrio. In televisione parlo a gente
che non c'è, che non vedo. Su Facebook mi esprimo, c'è un dibattito».
Nell'ultimo libro, Il
segreto dei Marò, edito da Mursia, scrive la sua convinzione innocentista.
Perché è sempre rimasta una voce tutto sommato isolata?
«Il sentire comune è
fortemente influenzato dall'informazione, l'informazione è influenzata dalla
classe politica. E la politica sui Marò ha fatto una figuraccia. Nemmeno il
centrodestra se la cava. Quella dei due fucilieri è la storia di un insuccesso
italiano. Come dicevo l'informazione ha fatto la sua parte, non ho mai visto
Bruno Vespa con il plastico dell'Oceano Indiano o Nuzzi e Sottile interpellare
psicologi sul caso. Meglio parlare di Meredith…».
Perché si è appassionato
tanto al caso Marò?
«Per motivi personali e
giornalistici. Conoscevo Latorre dal 2006, quando a Kabul aveva comandato una
scorta che mi accompagnava durante un servizio in elicottero. Un professionista
serio, non un Rambo che spara a inermi pescatori scambiandoli per pirati. Poi
volevo ricondurre tutti ai fatti, vedere i documenti dell'inchiesta indiana,
parlare del caso in modo oggettivo e senza pregiudizi politici».
Come definirebbe il suo
rapporto con la politica?
«Come quello dell'ex alcolista
con il vino: non ne sopporto la vista. Non voto da un quarto di secolo. Non è un
messaggio, non ne sono fiero. L'ho anche tenuto nascosto a mia figlia per lungo
tempo».
Quali altri sono i suoi
difetti, se si possono chiamare così?
«Fumo, in modo accanito. Odio
la vita d'ufficio. Non tengo la foto dei figli sulla scrivania. Non faccio
selfie, tranne l'altro giorno con Gerry Scotti: lui mi è simpatico e ho messo la
foto su Facebook. Non ho il gusto per il potere. Non sono portato per
l'organizzazione, soprattutto del lavoro altrui. Quando ero vice direttore del
Tg5 dicevo che avevo solo potere su me stesso. Non frequento stanze dei bottoni
o salotti importanti».
Ma scusi, le sembrano
difetti?
«Ora che mi ci fa pensare più
che difetti sono pregi».
Oriana Fallaci, l'ultima
lezione: "Non esiste un Islam moderato. Il Corano è il loro Mein Kampf" su
"Libero Quotidiano dell'1 settembre 2014. Per gentile concessione
dell'erede Edoardo Perazzi, pubblichiamo l'ultima parte del discorso che Oriana
Fallaci tenne nel 2005, quando fu insignita del Annie Taylor Award, prestigioso
riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle
sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. "...Punto numero tre.
Soprattutto non credo alla frode dell'Islam Moderato. Come protesto nel libro Oriana
Fallaci intervista sé stessa e ne L'Apocalisse, quale Islam
Moderato?!? Quello dei mendaci imam che ogni tanto condannano un eccidio ma
subito dopo aggiungono una litania di «ma», «però», «nondimeno»? È sufficiente
cianciare sulla pace e sulla misericordia per essere considerati Mussulmani
Moderati? È sufficiente portare giacche e pantaloni invece del djabalah,
blue jeans invece del burka o del chador, per venir definiti Mussulmani
Moderati? È un Mussulmano Moderato un mussulmano che bastona la propria moglie o
le proprie mogli e uccide la figlia se questa si innamora di un cristiano? Cari
miei, l'Islam moderato è un'altra invenzione. Un'altra illusione fabbricata
dall'ipocrisia, dalla furberia, dalla quislingheria o dalla Realpolitik di chi
mente sapendo di mentire. L'Islam Moderato non esiste. E non esiste perché non
esiste qualcosa che si chiama Islam Buono e Islam Cattivo. Esiste l'Islam e
basta. E l'Islam è il Corano. Nient'altro che il Corano. E il Corano è il Mein
Kampf di una religione che ha sempre mirato a eliminare gli altri. Una
religione che ha sempre mirato a eliminare gli altri. Una religione che si
identifica con la politica, col governare. Che non concede una scheggia d'unghia
al libero pensiero, alla libera scelta. Che vuole sostituire la democrazia con
la madre di tutti i totalitarismi: la teocrazia. Come ho scritto nel saggio Il
nemico che trattiamo da amico, è il Corano non mia zia Carolina che ci
chiama «cani infedeli» cioè esseri inferiori poi dice che i cani infedeli
puzzano come le scimmie e i cammelli e i maiali. È il Corano non mia zia
Carolina che umilia le donne e predica la Guerra Santa, la Jihad. Leggetelo
bene, quel «Mein Kampf», e qualunque sia la versione ne ricaverete le stesse
conclusioni: tutto il male che i figli di Allah compiono contro di noi e contro
sé stessi viene da quel libro. È scritto in quel libro. E se dire questo
significa vilipendere l’Islam, Signor Giudice del mio Prossimo Processo, si
accomodi pure. Mi condanni pure ad anni di prigione. In prigione continuerò a
dire ciò che dico ora. E continuerò a ripetere: «Sveglia, Occidente, sveglia! Ci
hanno dichiarato la guerra, siamo in guerra! E alla guerra bisogna combattere».
Visto? Potrei andare avanti per sempre quando sermoneggio di queste cose. Così
la smetto e dico: caro David, caro Daniel, caro Robert, cari compagni d'arme con
cui condivido questo premio, cari amici del Center for the Study of Popular
Culture: davvero noi esercitiamo un dovere molto faticoso e molto doloroso. Il
dovere di raccontare la verità. E, raccontando la verità, dar voce a chi non ha
voce. Alla gente male informata o nient'affatto informata. Alla gente che dorme
o non pensa con la propria testa e che tuttavia, quando viene informata, bene
informata, si sveglia e pensa con la propria testa (anzi si accorge di pensare
ciò che non sapeva di pensare ma pensava già). O alla gente che pur pensando non
parla per inerzia o timidezza o paura. Non siamo molti, lo so. Ma esistiamo.
Siamo sempre esistiti. E sempre esisteremo. Sotto ogni fascismo, ogni nazismo,
ogni bolscevismo, ogni islamismo, ogni maccartismo, ogni cancro del cervello,
ogni cancro dell'anima. E nonostante gli insulti, le messe alla gogna, le
persecuzioni, le beffe, le galere, i gulag, le forche che stroncano il corpo non
l’anima. Ah! Per quanto sia amaro considerarci fuorilegge-eretici-dissidenti in
una società che a parole si definisce libera e democratica, noi siamo davvero i
nuovi eretici. I nuovi fuorilegge. I nuovi dissidenti. Quindi lasciate che mi
congedi con la seguente confessione. Io non sono giovane ed energica come voi.
Non ho la salute che spero voi abbiate. A dirla in modo brusco e brutale, sono
disperatamente malata. Ho raggiunto ciò che i dottori chiamano la Fine della
Strada, e non durerò a lungo. Ma sapere che voi fate quello che fate, pensare
che voi sarete qui quando io non ci sarò più, mi aiuta parecchio a esercitare
quel dovere contro il nemico. A non dargli pace finché avrò un filo di fiato.
Meglio: come ho detto quando ho incominciato a parlare, io non accarezzo affatto
l'idea di imitare Annie Taylor. Mica son pazza. Ma se necessario, proprio
necessario, davvero necessario, bé… tirerò un gran respiro, chiuderò gli occhi,
forse mi farò il segno della Croce, (non si sa mai), e salterò anche sopra le
Cascate del Niagara. Ok? Grazie per avermi ascoltato. Oriana Fallaci
Marco Travaglio: "Oriana
Fallaci non era una grande giornalista",
scrive “Libero Quotidiano il 27 novembre 2015. "Chiedere scusa a Oriana
Fallaci? No. Era una grandissima scrittrice, ma non una grande giornalista,
perché aveva un rapporto con la verità piuttosto soggettivo". Così Marco
Travaglio nel corso di Otto e Mezzo su La7. Il direttore del Fatto
Quotidiano ha risposto così ad Alessandro Sallusti, che nel corso della
puntata aveva chiesto a Marco Manetta di scusarsi per le accuse di "islamofobia"
rivolte alla Fallaci. Nessuna scusa, però. Anzi, un nuovo insulto, reso ancor
più grottesco dal fatto che sia Travaglio a parlare di "obiettività". "Non c'era
un intervistato di Oriana Fallaci che si riconoscesse nelle sue interviste - ha
aggiunto -. Perché lei intervistava sempre se stessa. Scriveva sicuramente da
Dio, il che l'autorizzava a dire anche delle cose molto iperboliche".
Beppe Grillo:
meglio la Fallaci che i «fighetti del giornalismo»
(tipo Severgnini
e Riotta), scrive Beppe Severgnini su Italians de “Il Corriere della Sera” del
19 settembre 2006. Ciao Beppe! Nel
caso ti fosse sfuggita, ecco questa «perla» del blog di Beppe Grillo. «Morta
Oriana Fallaci quanti giornalisti liberi di nazionalità italiana rimangono in
giro? La Fallaci ha scritto cose che non condividevo e altre su cui ero
d'accordo. Ma si è presa sempre dei rischi. Diceva la sua verità, ci metteva la
sua faccia. Lascia, più che un vuoto, un baratro nel giornalismo italiano. Fare
il giornalista non è facile, ci vuole il protettore. Giornalisti senza padroni
non ce ne sono più, e quelli che resistono sono sempre più anziani. E anche
ripetitivi, ma non ditelo a Eugenio Scalfari. Bisogna andare nella biblioteca
comunale e leggersi vecchi pezzi di Montanelli per tirarsi un po' su. E
Travaglio? Mi si chiederà. Ma Travaglio non è un giornalista. Essere giornalista
e non anche servo è una questione di astuzia. Io comunque preferisco il
giornalista schierato senza se e senza ma. E' più pulito, mi è quasi simpatico.
Anche se nessuno lo prende sul serio, come un ubriaco al bar, e tutti gli
vogliono bene. Fa la pubblicità, ma non è una pubblicità ingannevole. Feltri,
Fede, Ferrara, Rossella, la vecchia guardia, gente semplice, una razza in
estinzione. Insidiata dagli opinionisti che hanno, soprattutto, una grande
opinione di se stessi. I fighetti del giornalismo, intellettualmente onesti, con
la cravatta giusta e la rubrica. Leggi i loro articoli e alla fine ti rimane un
senso di vuoto. Non hanno più bisogno di mentire per coprire i fatti. Li
annullano con il nulla. E non fanno neppure fatica. I Riotta, i Severgnini,
Mentana. Oriana, ci mancherai».
La grande balla
dell'islamofobia,
scrive di Francesco
Borgonovo su “L’Intraprendente del 1 dicembre 2015. Pubblichiamo un
estratto di Tagliagole, Jihad corporation di Francesco Borgonovo
(Bompiani, pagg. 684, 15 euro). L’autore, caporedattore di Libero e
autore de La Gabbia, effettua un’ampia ricognizione sul fenomeno del
terrorismo islamico e in particolare dell’Isis, analizzando tra l’altro le
abilità propagandistiche dell’esercito del Califfo, capace di attirare aspiranti
jihadisti da tutto il mondo. “L’islamofobia aiuta a rafforzare lo
Stato islamico”, ha dichiarato durante un intervento nella sede del parlamento
europeo a Strasburgo re Abd Allah II di Giordania. A sua altezza verrebbe da
rispondere, con il massimo rispetto ovviamente, che le cose non stanno così.
Piuttosto, ad aiutare lo Stato islamico è chi continua a sostenere
che l’islamofobia non solo esiste, ma è pure in aumento. In tutti i documenti
propagandistici diffusi sul web, i tagliagole dell’Isis insistono sul fatto che
i musulmani nel mondo vengono perseguitati. In Black Flags from Rome – in
cui si promette, fra le altre cose, l’invasione dell’Italia – compare un
capitolo abbastanza corposo dove si spiega come l’Europa sia sprofondata in una
“età oscura” e come, per far sfogare la popolazione esasperata dalla crisi, si
organizzino campagne discriminatorie nei confronti dei musulmani. In nome
dell’islamofobia sono stati portati in tribunale anni fa Oriana Fallaci e Michel
Houellebecq, colpevoli soltanto di avere espresso le loro opinioni. Di
islamofobia sono stati accusati i redattori di Charlie Hebdo. Da vittime
di una strage assurda sono diventati colpevoli. Il giornale satirico
è diventato, appunto, il simbolo dell’islamofobia occidentale. Peccato che si
tratti di una menzogna. Che cosa sia la cosiddetta “islamofobia” lo spiega bene
lo storico Walter Laqueurin un saggio intitolato Gli ultimi giorni
dell’Europa, che si presenta come “epitaffio per un vecchio continente”,
tanto per restare in tema di morti viventi. Come ricostruisce bene lo studioso,
il termine islamofobia “cominciò a essere usato correntemente nel 1998 dopo la
pubblicazione di un rapporto del Runnymede Trust, una fondazione inglese che ha
la missione di combattere la discriminazione razziale e di mantenere
buone relazioni fra le minoranze etniche. Il gruppo di lavoro che affrontò il
problema della paura e dell’odio per l’islam e i musulmani era guidato dal
professor Gordon Conway, biologo, vicerettore dell’Università del Sussex e poi
presidente della Rockefeller Foundation”.
L’idea è che esisterebbe, in
Occidente, un odio diffuso nei confronti dei musulmani, che sarebbero
discriminati in virtù della loro appartenenza religiosa. Da questo
presupposto deriva un’ulteriore convinzione, pericolosissima. Ovvero che,
sentendosi sotto pressione e odiati nei Paesi in cui vivono, i musulmani siano
spinti a radicalizzarsi. Questo presupposto è alla base del romanzo Il
fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid, da cui è stato tratto il film
omonimo di Mira Nair. Il protagonista, Changez, di origini pakistane, si laurea
a Princeton e, grazie alle sue indubbie capacità professionali, trova un impiego
in una società prestigiosa di analisi finanziarie. Ma ecco che
interviene l’islamofobia: dopo l’11 settembre, il giovane sente nei suoi
confronti una crescente diffidenza da parte dei colleghi e, più in generale, da
parte degli americani. Non potendone più di sopportare i pregiudizi, torna
in patria e diviene un professore universitario. Non solo: si radicalizza, come
se le pressioni subite da parte degli occidentali ne avessero provocato
l’esplosione. Il pensiero che permea il romanzo di Hamid è lo stesso che il re
di Giordania ha sintetizzato nel suo intervento al parlamento europeo.
L’islamofobia diventa così una scusa per giustificare i radicali e
gli estremisti. È per via delle stupidaggini che si raccontano a proposito
dell’“odio per i musulmani” che, come ho raccontato in precedenza, c’è
persino chi ha la faccia tosta di giustificare un macellaio come Jihadi John,
come ha fatto Asim Qureshi della fondazione britannica Cage. Grazie al discorso
sull’islamofobia, si sposta l’attenzione dalle vere vittime – per esempio i
giornalisti e i vignettisti di Charlie Hebdo massacrati senza pietà o gli
ostaggi sgozzati – e la si concentra su vittime presunte, arrivando perfino a
giustificare un assassino seriale. Grazie al discorso sull’islamofobia, inoltre,
si autorizzano associazioni musulmane più o meno radicali a dire le cose più
atroci. Per evitare di passare per islamofobi, governi come quello inglese
o quello francese (che pure, storicamente, si è sempre mostrato incredibilmente
tollerante e inclusivo nei confronti degli islamici) hanno appaltato interi
quartieri, lasciandoli nella mani dei predicatori estremisti o favorendo di
fatto l’instaurazione della shari’a nel cuore di metropoli come Londra. Che la
questione dell’islamofobia sia una montatura a uso e consumo degli estremisti (o
semplicemente di chi vuole imporre la propria cultura senza rispetto) lo
dimostra il semplice buon senso. La vicenda del processo a Houellebecq, che ho
già citato, è chiarissima. L’islamofobia, tanto per cominciare, non è razzismo.
Perché se davvero ci fosse un odio diffuso nei confronti degli islamici, allora
ne sarebbero vittime tutti i convertiti, che abbiano o meno la barba e che
indossino o meno palandrane. Se esiste un atteggiamento di timore, semmai, è nei
confronti degli arabi o di quei musulmani che, in virtù del loro aspetto,
possono venire inquadrati come radicali. Ammesso che questo timore esista e sia
diffuso, si tratta comunque di un sentimento che poggia su presupposti per lo
meno comprensibili. Lo spiega bene Laqueur: “Se in anni recenti c’è stata
in Europa una ostilità nei confronti dei musulmani, essa non è stata in risposta
alla loro religione, ma al fatto che per lo più gli attentati terroristici sono
stati compiuti da musulmani: ‘terrorofobia’ sarebbe un termine più esatto. Se
quelli che sono stati coinvolti in atti di terrorismo fossero stati eschimesi,
l’orrore e la paura sarebbero stati diretti a loro, anche se la maggioranza
degli eschimesi non fosse stata coinvolta. È naturalmente sleale generalizzare a
un intero gruppo etnico la condanna meritata da pochi, ma probabilmente ciò è
inevitabile, specialmente se una porzione significativa del gruppo non
prende chiaramente le distanze dagli ‘attivisti’ né si esprime contro la
violenza, ma al contrario sostiene o almeno dichiara comprensione per
i terroristi”. Ed è difficile negare che quest’ultimo sia stato l’atteggiamento
tenuto da una larga fetta del mondo musulmano (islamici che vivono in Europa e
America compresi). “Nel 2006”, scrive ancora Laqueur, “una ricerca del Pew
Research Center ha concluso che in Paesi prevalentemente musulmani gli abitanti
sono molto più critici degli occidentali di quanto accada in senso opposto
in Occidente, e che lo stesso vale, anche se in misura minore, per le
comunità musulmane in Europa: in altre parole, c’è molto più una fobia
antioccidentale che una islamofobia”.
Eppure…
Terrorismo, per Laura
Boldrini l'Isis siamo noi:
"Abbiamo seminato odio", scrive su “Libero Quotidiano” di Enrico Paoli il 19
novembre 2015. L’Europa parla di guerra, di attacco senza precedenti. Ed è un
linguaggio che non è più isolato, fuori sincrono rispetto alle scene che ci
passano davanti agli occhi nei telegiornali e nei servizi dedicati alla Francia.
È semplicemente la dura realtà che i fatti di Parigi hanno messo al centro del
dibattito politico di tutti i Paesi. Eppure l’illuminata e progressista
presidentessa della Camera, Laura Boldrini, ha sentito ancora una volta
l’urgenza, se non proprio l’impellenza, di marcare il proprio territorio, di
mettersi fuori dal coro. Come se starci dentro fosse un problema, un neo da
rimuovere. Quando il neo in questione, a dire il vero, è il fenomeno del
terrorismo con tutte le sue complicazioni. Ma la Boldrini è così, un eterno
salmone anche quando la storia richiederebbe ben altro. In una lunga intervista
al settimanale L’Espresso, in edicola oggi, la terza carica dello Stato sostiene
che la guerra all’Isis si combatte «con la politica», dialogando con gli attori
in campo, esclusa ovviamente la stessa Isis». La presidente della Camera fa
notare che «dopo cinque anni di guerra in Siria ci sono state 250mila vittime,
oltre la metà della popolazione è fuori casa forzatamente», sostiene la
Boldrini, «ci sono quattro milioni di profughi di cui due in Turchia». «La
guerra è nefasta, crea odio e disfacimento», sostiene l’inquilina di
Montecitorio, «abbiamo seminato odio, abbiamo creato contrapposizione. Abbiamo
predicato lo scontro di civiltà, l’errore più grave di tutti. Ora proseguire su
questa strada sarebbe miopia politica». Insomma, le forze della coalizione, la
stessa Europa, l’America in particolare, avrebbero provocato il processo di
reazione che si sta traducendo in atti terroristici, in stragi che colpiscono i
civili nella loro quotidianità. La colpa è nostra, sembra essere la sintesi
estrema del ragionamento fatto dalla Boldrini. Non solo. La presidente della
Camera, sottolineando come la sua sia «una posizione realista, non buonista»,
rimarca il fatto di non essere mai stata «contro gli interventi militari a
prescindere, mi è capitato anche di lavorare in situazioni in cui erano l’unico
modo per fermare il massacro di civili innocenti. Ma bisogna evitare di creare
odio su odio», sostiene la Boldrini, «fermarsi a riconsiderare gli strumenti con
cui vogliamo combattere questa guerra. Tagliare i finanziamenti. Non comprare
più il petrolio che arriva dai territori occupati dai tagliagole, un milione di
dollari al giorno. Rafforzare l’intelligence: fare un salto nell’integrazione
europea significa anche avere una sola politica di sicurezza e di difesa». Tutte
belle ricette, tutte belle idee, ma che fanno drammaticamente a cazzotti con la
realtà. Nel momento in cui prendi uno schiaffo, non puoi fermarti a chiedere
perché, puoi solo reagire, con una forza simile se non addirittura superiore.
Poi arriva il momento del dialogo, dunque della politica. Perché veniamo
attaccati, perché hanno insanguinato Parigi è già passato. Le domande riguardano
già il futuro. L’Europa, in questo momento non ha tutto questo tempo. Parigi ha
dimostrato che siamo in una fase di emergenza. Soprattutto di carattere tecnico
militare, inteso come sicurezza dei cittadini. E poi c’è il capitolo
socio-economico, che la Boldrini ama in modo particolare. «I rifugiati sono le
prime vittime del terrore. Chi vuole rimandarli indietro fa un regalo all’Is che
si presenterebbe come l’unica protezione», sostiene la terza carica dello Stato,
«chi dice che tutti i musulmani sono uguali consegna a poche migliaia di
miliziani la rappresentanza di miliardi di persone. Una follia. Si pensa sempre
che il nemico venga da fuori», fa notare la Boldrini, «invece è qui, in casa
nostra. Le ricette semplici sono un inganno. E sono anche le meno efficaci.
Perché il terrorismo è una minaccia globale, che colpisce ad ogni latitudine: a
Parigi come a Beirut, ad Ankara come a Nairobi». Ecco, se le cose stanno
esattamente così, è evidente la contraddizione in termini contenuta nel
ragionamento della Boldrini, che spegne le ipotesi di risposta militare come
soluzione ma parla di nemico già presente in casa nostra. Dobbiamo tenercelo?
«Il governo ha finora tenuto una posizione ragionevole che condivido. Sulla
lotta al terrorismo», ribadisce la Boldrini, «serve senso di responsabilità da
parte di tutti». Già, la responsabilità. Noi riflettiamo, loro attaccano.
Ancora.
Bufera dopo il post del
portavoce di Gabellone, la Sinistra chiede la rimozione.
La polemica, nata sul web prosegue a colpi di comunicati stampa. Dopo il post
delle scorse ore del portavoce del presidente della provincia di Lecce Antonio
Gabellone ne chiedono la rimozione dall'incarico il gruppo “Salento bene
comune”, Abaterusso e Carlo Salvemini. Gabellone non risponde, per
l'interessato: mera strumentalizzazione, scrive “TeleRama il
18 novembre 2015.
Continua a far discutere il post su Facebook scritto dal portavoce del
presidente della Provincia Cosimo Carulli sulla morte di Valeria Solesin, negli
attacchi terroristici a Parigi. “Non
portava la kefiah, non agitava bandiere della pace, dunque sarà dimenticata in
fretta .–
si legge – Solo una ragazza normale e studiosa,
figuriamoci se la feccia della nostra società le riconoscerà qualche onore. Sta
circolando tra le agenzie di stampa la notizia sulla morte di una nostra
connazionale. Valeria, studentessa modello alla Sorbona di Parigi per mano di
bastardi senza scrupoli; ma certamente non farà nessun effetto ai nostri tanti
connazionali caproni comunisti vestiti del loro finto egualitarismo con il
portafoglio pieno e del loro dialogo del niente con gente come loro, puzzolente
e stragista, brigatista e violenta quanto loro. Scenderanno in campo per le
varie Vanessa e Greta, le cooperanti in gita di piacere in Siria (piacere in
tutti i sensi….), per la Sgrena a cui bastò un rapimento per un seggio in
Parlamento e non per i Quattrocchi morti per l’Italia. Insomma, restano quelli
che sono: il tumore maligno dell’Italia”.
Il Movimento 5 Stelle, da
sempre dalla parte del terrorismo,
scrive “Il Corriere del Giorno” il 16 novembre 2015.
Degli attivisti del Movimento5Stelle dal baso della loro evidente “ignoranza”
ci accusano di percepire contributi dello Stato, quando in realtà chi viene
retribuito con i soldi pubblici (ed altro che gli sbandierati e promessi 2.500
euro in campagna elettorale!) sono i loro deputati e consiglieri comunali e
regionali, ed i loro “portaborse”, che spesso sono loro parenti diretti o
indiretti! Ma questa volta vogliamo ricordarvi alcuni comportamenti dei loro
rappresentanti nelle sedi istituzionali.
Era il 12 novembre 2013 e
la deputata Emanuela Corda, esponente del Movimento 5 Stelle, non poteva
trovare giorno migliore… per commemorare a modo suo, l’attentatore kamikaze che
ha ucciso 19 Carabinieri a Nassiriya. Infatti quel giorno, 12 novembre,
ricadeva il decennale di quella strage. Con squallido e volgare tempismo,
l’onorevole “grillina” ha voluto spendere parole d’affetto e di comprensione nei
confronti del giovane attentatore. Nel suo discorso, pronunciato davanti agli
attoniti colleghi deputati, Emanuela Corda ha ricordato, dopo una doverosa
introduzione in memoria dei 19 italiani e 9 iracheni uccisi: “Nessuno ricorda
il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage.
Quando si parla di lui se ne parla come di un assassino, e non anche come
vittima, perché anch’egli fu vittima oltre che carnefice”. Parole squallide,
allucinanti, quasi incredibili, cui la deputata grillina sembra porre rimedio: “Una
ideologia criminale l’aveva convinto che quella strage fosse un gesto eroico e
lo aveva mandato a morire“, ma l’apparente rinsavimento durò poco,
perché Emanuela Corda continuò così: “e non è escluso che quel giovane come
tanti kamikaze islamici fosse spinto dalla fame, dalla speranza che quel suo
sacrificio sarebbe servito per far vivere meglio i suoi familiari, che spesso
vengono risarciti per il sacrificio del loro caro“. Avete letto bene. Si lo
ha giustificato in quanto “spinto dalla fame”. Come se per logica
conseguenza si potesse uccidere per fame. Anche il giovane marocchino, ricordato
“affettuosamente” dalla deputata grillini, è stato una vittima. Vero, è morto
anch’egli nell’attentato. Ma ha scelto di uccidere 28 persone. Commemorarlo in
un giorno come questo, in ricordo delle vittime di Nassiriya, appare tanto fuori
luogo quanto di cattivo gusto. Ancor più in una istituzione come il Parlamento
italiano. Cosa ne penseranno i delusi dalla politica, che votando Movimento 5
Stelle hanno contribuito a portare persone come Emanuela Corda in Parlamento?
Il 12 novembre 2014,
l’anno successivo e questa volta, sempre in occasione della ricorrenza
dell’anniversario di Nassirya, è stato un consigliere regionale (candidato
Governatore) della Regione Lazio per il M5S, a manifestare la sua “vicinanza”
ideologica al terrorismo. Infatti, durante il minuto di silenzio che il
presidente del Consiglio Regionale del Lazio Daniele
Leodorifece osservare, tutti i consiglieri si sono alzati in piedi tranne quello
del M5S, Davide Barillari. Il consigliere del Ncd, Giuseppe Cangemi, tra l’altro
ex paracadutista, subito dopo gli si e” fatto sotto e stava per attaccarlo
fisicamente se non fosse stato trattenuto da alcuni consiglieri, tra i
quali Gino De Paolis di Sel e Daniele Mitolo di Per il Lazio. Barillari provo a
replicare: “Vorrei alzarmi per ogni morto che abbiamo nel Lazio, in ogni
scenario di lotta, comprese le morti bianche. Dovremmo alzarci continuamente.
Semmai è questione di chiedersi perchè muoiono queste persone. Queste persone
sono morte a causa di una guerra”.
Le reazioni “Il
consigliere Barillari si dovrebbe vergognare: rimanere seduto durante il minuto
di silenzio per l’undicesimo anniversario della strage di Nassiriya e per la
Giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali è una
provocazione inaccettabile”. E’ quanto dichiarò Giuseppe Cangemi,
consigliere Ncd della Regione Lazio. “Il consigliere grillino- aggiunse- ha
oltraggiato la memoria dei militari che hanno perso la vita, dileggiato la
sofferenza delle loro famiglie e offeso tutti gli italiani che si sono inchinati
davanti alle bare dei nostri caduti a Nassiriya. Barillari dovrebbe chiedere
scusa oppure dimettersi”. Lo sdegno nei confronti dell’esponente del M5S fu
“bipartizan”. Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico al
termine del minuto di silenzio per commemorare l’eccidio dei militari italiani a
Nassiriya, dichiarò: “Il consigliere del M5SBarillari questa mattina si e”
reso responsabile di un gesto grave che offende l’istituzione regionale,
l’Italia e l’intera comunità internazionale. I nostri militari caduti a
Nassiriya, e in altri teatri di guerra, erano in missione di pace, impegnati a
difendere la popolazione civile. Strumentalizzare come ha fatto il consigliere
Barillari, la barbarie di Nassiriya, rappresenta uno dei peggiori episodi per
l’Aula consiliare della Regione Lazio che stigmatizzo e condanno con forza.
Desidero esprimere, infine, a nome del gruppo del Partito democratico,
solidarietà e vicinanza ai nostri militari, ringraziandoli per l’impegno
quotidiano a difesa della pace nelle missioni internazionali”.
Era il 13 agosto
2014 ed i deputati “grillini” della Commissione Esteri si erano espressi contro
la scelta di Farnesina e Ministero della Difesa di appoggiare, anche
militarmente, il tentativo del governo del Kurdistan iracheno di contenere
l’espansionismo del Califfato islamico. “Mogherini e Pinotti giocano a fare
la guerra in Iraq senza aver consultato il Parlamento preventivamente. Si
fermino e vengano a riferire in Aula prendendosi le loro responsabilità di
fronte al Paese. Bombardamenti e forniture di armi non fanno altro che
alimentare gli stessi fenomeni che si vogliono contrastare. Praticamente è come
curare un diabetico con iniezioni di glucosio.” “Il duo Ue-Usa decide di
bombardare per mettere pace, con la giustificazione che tutto ciò serva a
prevenire il genocidio, mentre per uguali situazioni nel vicinissimo Medio
oriente non si procede certo con misure analoghe – concludevano – Violenza
genera violenza e l’articolo 11 della costituzione non è un optional.” Una
posizione molto netta, ribadita anche dal capogruppo M5S in commissione Esteri
alla Camera Manlio Di Stefano in un’intervista a La Stampa: “Noi
occidentali abbiamo dato per scontato che la nostra fosse l’unica democrazia
possibile. Affrontare le cause con rispetto significa interrogarsi se non ci
siano altre forme di governo e di democrazia che vanno bene per i posti dove
sono.” Di Stefano attaccò anche gli Stati Uniti e il loro “interventismo
accanito contro alcuni territori e il totale oblio di altri territori” (il
riferimento era alla Palestina, ndr). Come soluzione, propose “un
intervento diplomatico forte”, o al massimo interventi di corpi non armati e
interventi umanitari, invece dei “bombardamenti veri e propri” che “polarizzano
ulteriormente le divisioni”. “Vero, sono terroristi – concludeva Di
Stefano – Ma siamo sicuri che ogni terrorista morto non ne nascano altri cento?
Quella provocazione del Califfato di arrivare fino a Roma significa questo: più
voi intervenite, più noi reagiremo.” Solo pochi giorni prima Di Stefano era
stato al centro di una polemica politica dopo aver attaccato Israele, definendo
“genocidio” quello in atto in questi mesi a Gaza. Contro di lui si erano
espressi portavoce delle comunità ebraiche e anche l’ambasciata d’Israele in
Italia.
Era il 16 agosto 2014 ed un
post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, i cui proventi pubblicitari non
entrano nelle casse del M5S ma del loro “padre-padrone-comico-guru”, il
deputato Alessandro Di Battista scriveva: “Dovremmo smetterla di considerare
il terrorista un soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una
discussione”. Non a caso in quei giorni i deputati grillini della
Commissione Esteri si erano espressi contro la scelta di Farnesina e Ministero
della Difesa di appoggiare, anche militarmente, il tentativo del governo del
Kurdistan iracheno di contenere l’espansionismo del Califfato islamico invitando
alla “calma” e al “rispetto” per capire “fenomeni radicali come
Isis“, adesso è la volta di Di Battista che nel post pubblicato sul blog di
Grillo scriveva: “L’obiettivo politico (parlo dell’obiettivo politico non
delle assurde violenze commesse) dell’ISIS, ovvero la messa in discussione di
alcuni stati-nazione imposti dall’occidente dopo la I guerra mondiale, ha una
sua logica“. Ma l’apice del lunghissimo post arrivava quando il grillino
parlava del terrorismo: “Dovremmo smetterla di considerare il terrorista un
soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una discussione. Questo è un
punto complesso ma decisivo. Nell’era dei droni e del totale squilibrio degli
armamenti il terrorismo, purtroppo, è la sola arma violenta rimasta a chi si
ribella. È triste ma è una realtà. Se a bombardare il mio villaggio è un aereo
telecomandato a distanza io ho una sola strada per difendermi a parte le
tecniche nonviolente che sono le migliori: caricarmi di esplosivo e farmi
saltare in aria in una metropolitana. Non sto ne giustificando né approvando,
lungi da me. Sto provando a capire. Per la sua natura di soggetto che risponde
ad un’azione violenta subita il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni,
ma elevandolo ad interlocutore”, scriveva Di Battista. Non era la prima
volta che il M5S difende le posizioni più estreme dell’Islam. Ancor prima
di impegnarsi attivamente in politica Beppe Grillo, durante i suoi spettacoli,
attaccava le politiche occidentali e giustificava quelle islamiche. Fino ad
arrivare all’intervista del 2012 a un giornale israeliano in cui si prodigava in
una strenua difesa dell’Iran di Ahmadinejad: “Quelli che scappano, sono
oppositori. Ma chi è rimasto non ha le stesse preoccupazioni che abbiamo noi
all’estero. L’economia lì va bene, le persone lavorano. È come il Sudamerica:
prima si stava molto peggio. Ho un cugino che costruisce autostrade in Iran. E
mi dice che non sono per nulla preoccupati”. Non contento…. il deputato M5s
disse la sua anche sull’11 settembre : “L’attentato alle Torri Gemelle fu una
panacea per il grande capitale nordamericano. Forse anche a New York qualcuno
“alle 3 e mezza di mattina rideva dentro il letto” come capitò a quelle merde
dopo il terremoto a L’Aquila. Quei 3.000 morti americani vennero utilizzati come
pretesto per attaccare l’Afghanistan, un paese con delle leggi antitetiche
rispetto al nostro diritto ma che con il terrorismo internazionale non ha mai
avuto a che fare”. Quelle parole di Di Battista riuscirono ad unire tutta
la politica italiana, accomunata dallo sdegno: da Forza Italia al Partito
Democratico, passando per l’Udc e Scelta Civica. Il coro fu unanime: “Siamo
al game over per la credibilità e per il margine di tollerabilità del Movimento
5 Stelle” (Forza Italia). “Di Battista a ferragosto deve aver preso un
brutto colpo di sole” (Italia dei Valori), “l’ignoranza di Di
Battista fa pena” (Ncd). Ma questa volta, alla luce dell’attentato di
Parigi, riecheggiano le parole di Di Battista. Ma cosa aspettarsi da uno che ha
un padre che partecipando ad una manifestazione dei grillini, dichiarò: “Io
di destra? Sono fascista, è un’altra cosa”. Ecco, cari lettori, da chi è
composto il Movimento 5 Stelle. Con loro l’Italia ha definitivamente toccato il
fondo.
Filippo
Facci su “Libero
Quotidiano” del 20 novembre 2015 umilia Vauro: "Coniglio e bastardo: ti spiego
pure perché". Allora sei un bastardo anche tu, Vauro Senesi, e di che religione
non importa, anzi sei un coniglio, un coniglio mannaro, uno che mette sullo
stesso piano i lettori di Libero e i plauditori della strage di Parigi, uno che
ha trovato la soluzione allo scontro di civiltà, e cioè questa: arrestare
Maurizio Belpietro e le sue sporche truppe. Ma prego, Vauro, a te la parola,
come hai fatto nella mattinata di ieri nel vacuo parolaio che è L' aria che tira
su La7: avevano appena trasmesso un servizio su un islamico di Catania (uno
tutto contento per i morti di Parigi) e poi eccoti: «Sono il primo a condannare
il pazzo che a Catania dice quelle cose, però...». C' è un però: «Quando quel
pazzo lì sarà arrestato, perché è un fomentatore di odio, ma allora: il signor
Belpietro? Quando lo arrestiamo il signor Belpietro, che scrive un titolone così
"Bastardi islamici?"». Perché, che ha fatto in concreto Belpietro? «Il signor
Belpietro mette a rischio la mia sicurezza, e la sicurezza di ognuno di noi,
perché al pari - che non è al pari, perché quello è un poveraccio ignorante,
mentre il signor Belpietro dovrebbe essere un intellettuale (voci che si
sovrappongono, ndr) ... è criminale, mette in pericolo la vita dei nostri figli,
perché se domani un cretino fomentato dal titolo di Belpietro prende a
accoltella il primo che incontra... (voci che si sovrappongono, ndr) ... la
paura che ho, è che quelli che ci dovrebbero difendere dal terrorismo sono gli
stessi che hanno creato il terrorismo». Riassunto: il terrorismo l'ha creato
Belpietro o quelli come lui, il quale, non pago, vuole altro sangue e allora
aizza gli islamici col titolo «Bastardi islamici» dopo che degli islamici
(bastardi) hanno fatto a pezzi dei civili; Belpietro dunque mette in pericolo i
figli di Vauro e tutti gli altri. Parentesi: è record, perché l'altro giorno
Giafar al Siqilli (come si è ribattezzato ridicolmente Pietrangelo Buttafuoco)
aveva scritto sul Fatto che «se il musulmano è un bastardo, un coltello prima o
poi se lo ritrova», ora invece arriva Vauro e aggiunge che lo stesso titolo
«mette in pericolo la vita dei nostri figli». Insomma, con un solo titolo fai
fuori tutti. Ecco spiegata vignetta che Vauro ha piazzato in prima pagina sul
Fatto di lunedì: la scritta «Il sangue non si è ancora asciugato» e Belpietro e
Salvini che dicono «possiamo sguazzarci». Ma dicevamo de La7 e de L' aria che
tira: nel bailamme a quel punto interveniva la conduttrice Myrta Merlino (le cui
pettinature sono l'unica giustificazione all' esistenza dell'Isis) e con vacuo
cerchiobottismo cercava di sedare: «Belpietro ha fatto un titolo sbagliato,
ma...». Ma. Però. Tuttavia. È anche vero che. Insomma, povero Vauro, forse no,
forse non sei un bastardo: mettere sullo stesso piano Libero e gli assassini di
Parigi è da bastardi e basta, ma è solo che hai una fottuta paura. Ce l'avevi
nel 2006, quando attaccasti le vignette danesi anti-Maometto perché, detto con
parole tue, «messaggi violenti provocano reazioni violente». Poi però andasti da
Santoro con la maglietta di solidarietà, che nel tuo caso avrebbe dovuto essere:
«Siano tutti Charlie, da oggi». E poi via, al calduccio a fare vignette su
Berlusconi e su Renzi. Ti teneva compagnia Maurizio Crozza, secondo il quale era
meglio sfottere il Papa o Bush «perché loro influenzano il nostro modo di
vivere». I bastardi musulmani, in effetti, influenzano il nostro modo di morire.
Niente Adeste Fideles a
scuola: "È troppo cristiana".
Il brano della tradizione natalizia “Adeste fideles”? "Troppo cristiano, non
si può suonare". La pensa così, almeno, il dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo di Casazza, la professoressa Maria Antonia Savio, che,
nell’imminenza del consueto appuntamento annuale della festa della scuola, ha
fatto pervenire i suoi rilievi al Corpo parrocchiale musicale che sarà
protagonista dell’appuntamento, riservato ai ragazzi e alle loro famiglie,
scrive Mario Valenza Lunedì 23/11/2015 su "Il Giornale". Il brano della
tradizione natalizia “Adeste fideles”? "Troppo cristiano, non si può suonare".
La pensa così, almeno, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di
Casazza, la professoressa Maria Antonia Savio, che, nell’imminenza del consueto
appuntamento annuale della festa della scuola, ha fatto pervenire i suoi rilievi
al Corpo parrocchiale musicale che sarà protagonista dell’appuntamento,
riservato ai ragazzi e alle loro famiglie. Una presa di posizione, quella della
preside, che naturalmente non ha mancato di suscitare polemiche nel paese
bergamasco. "Cosa significa “troppo cristiano”?", sbotta qualche anziano nella
piazza all’ombra del campanile della chiesa. "Dovremo forse chiedere il permesso
a qualcuno per intonare i nostri canti di Natale? E un concerto di Natale se non
è cristiano cosa è?". Secondo la dirigente Savio, bisogna attingere a un
repertorio meno legato alla sensibilità cristiana, visto che l’istituto è
frequentato anche da figli di immigrati. Una spiegazione che tuttavia appare
poco convincente. Così come la preside appare più realista del re, visto che
nessuno tra le famiglie degliu alunni aveva sollevato il problema. "Ci è stato
fatto presente - dice Silvia Micheli, 28enne componente del consiglio direttivo
della banda al Giorno - che, siccome Casazza è un paese multiculturale, occorre
non urtare la sensibilità di nessuno. La richiesta ci ha un po’ sorpresi perché
noi siamo una banda parrocchiale. In ogni caso, essendo ospiti, abbiamo deciso,
senza polemica, di optare per “Jingle bell rock”, meno connotato". Infine il
consigliere regionale della Lega Nord, Silvana Santisi Saita, ha subito
rilanciato la notizia sulla propria pagina Facebook rilevando che "La scuola,
che dovrebbe formare e integrare, dopo il Presepe adesso censura anche la
musica".
Altro che corano: citiamo
il Padre Nostro.
A un terrorista islamico che puntandoti il mitra ordina di recitare versetti
coranici, chiunque di noi, laico o fedele che sia, dovrebbe rispondere con le
parole del Padre Nostro, che è preghiera di libertà e carità, scrive Alessandro
Sallusti Sabato 21/11/2015 su "Il Giornale". E tre. Dopo l'aereo russo e la
notte di Parigi, lo stragismo islamico fa tappa in Africa, a Bamako, capitale
del Mali. Nel grande hotel degli occidentali si contano i morti e in Europa si
rinnova la falsa indignazione di chi a parole fa il duro ma in realtà si tiene
ben alla larga dall'affrontare il nemico come si dovrebbe in una situazione come
quella che stiamo vivendo. Fa paura pensare che una religione dichiari guerra
agli infedeli, ma - coerentemente con quanto scritto nel Corano - è esattamente
quello che sta accadendo. Che non si tratti di tutto l'islam o solo di una
parte, non so quanto minoritaria, è rebus che lasciamo agli esperti di
statistica. Perché, per quanto riguarda la sostanza, i fatti parlano sempre più
chiaro. Ieri a Bamako è successo che i terroristi hanno sottoposto 170 ostaggi
all'esame di Corano: chi sapeva recitare i versetti del profeta ha avuto salva
la vita, chi no è finito nella lista dei condannati a morte. In questa tragedia
c'è una beffa atroce, perché se i terroristi islamici avessero voluto - per
paradosso - graziare anche i conoscitori dei vangeli, credo che in pochi
l'avrebbero scampata, tanta è l'ignoranza di un Occidente che si è voluto
auto-scristianizzare in nome del multiculturalismo, fenomeno bello in astratto
ma, nei fatti, bomba (in tutti i sensi) pronta a esplodere quando meno te lo
aspetti, come infatti sta accadendo. Non parlo della mancanza di fede, che è
fatto personale. Parlo della consapevolezza della storia che ci ha generato, che
invece dovrebbe essere patrimonio collettivo e collante di civiltà. A un
terrorista islamico che puntandoti il mitra ordina di recitare versetti
coranici, chiunque di noi, laico o fedele che sia, dovrebbe rispondere con le
parole del Padre Nostro, che è preghiera di libertà e carità. Se non altro per
dimostrare a questa gentaglia «come muore un occidentale» o «come muore un
cristiano», sulla scia della celebre frase pronunciata in faccia al boia da
Fabrizio Quattrocchi durante la guerra in Irak. Ma forse è chiedere troppo. In
un Paese dove Laura Boldrini è presidente della Camera non è tempo di eroi, è il
tempo di coccole per i 200mila immigrati islamici «moderati» che in cuor loro
tifano Isis. Che brutti tempi.
In Europa crescono i
crimini legati all'odio contro i cristiani.
È questo uno dei trend che emerge dai dati sugli "hate crimes" diffusi
dall'Osce/Odihr per l'anno 2014: in Europa sempre più spesso ad essere colpiti
da questo tipo di crimini sono gli appartenenti alla maggioranza della comunità,
scrive Alessandra Benignetti Lunedì 23/11/2015 su "Il Giornale". Chi lo ha detto
che sono solo le minoranze ad essere perseguitate? Dal rapporto dell’OSCE/ODIHR,
che qualche giorno fa ha reso pubblici i dati del 2014 sui cosiddetti“hate
crimes” in 46 paesi del mondo, compresa l’Italia, emerge un quadro ben diverso.
Uno dei dati più interessanti di questo rapporto infatti, che ogni anno
raccoglie dati sugli "hate crimes", ovvero quei crimini contro persone o beni
che sono motivati da un pregiudizio o discriminazione, è infatti quello sui
crimini contro i cristiani negli stessi Stati europei. Questo trend è
evidenziato dai dati collezionati dall’Osce attraverso un duplice sistema di
raccolta informazioni, che coinvolge, da un lato i punti di contatto nazionali
ufficiali di 43 Paesi, e dall’altro le segnalazioni di 122 ONG legate alla
società civile. Secondo i dati forniti da questi diversi attori, si evince che
almeno in tre grandi Stati dell'Europa occidentale, come Francia, Germania ed
Italia, le aggressioni fisiche e materiali con alla base pregiudizi contro la
fede cristiana, supererebbero in certi casi sia quelle nei confronti di altri
gruppi religiosi, sia quelle derivanti da pregiudizi di altra natura. In Italia,
infatti, nel 2014 gli “hate crimes” a sfondo religioso, anche contro i
Cristiani, vengono subito dopo quelli legati alla xenofobia. A confermare questo
trend si aggiungono anche i dati che riguardano, ad esempio, gli “hate crimes”
in Francia nell’anno 2013, dove si sono registrati 602 casi di crimini motivati
da pregiudizio contro i Cristiani, tra cui 197 casi di profanazione di cimiteri
e 405 casi di danneggiamento di chiese. Nello stesso anno in Francia, “solo” 301
sono stati invece, secondo l’Osce/Odihr, gli “hate crimes” contro i musulmani.
Anche i dati che riguardano la Germania per il 2014 riportano centinaia di casi
di violenza nei luoghi di preghiera, nelle chiese, la profanazione di un
cimitero e, nel 2013, anche alcuni casi di aggressione fisica. "Benché i dati
pubblicati dall'OSCE/ODIHR siano tra i più completi a livello internazionale,
certamente vi è un ampio numero oscuro di “hate crimes” non registrati”, ha
commentato Mattia Ferrero, delegato per le attività internazionali dell’Unione
Giuristi Cattolici Italiani, sentito al telefono da ilGiornale.it,
“tuttavia, è possibile svolgere alcune considerazioni sui trend riscontrabili”.
“Uno degli aspetti di maggiore interesse consiste nel fatto che gli “hate
crimes” colpiscono tanto le minoranze, quanto le maggioranze. In particolare,
gli “hate crimes” contro i Cristiani, anche e soprattutto nell'Europa
occidentale, rappresentano un numero molto significativo, comparabile, se non
superiore in alcuni casi, a quelli nei confronti di altre comunità religiose”
continua l’avvocato Ferrero, “in secondo luogo, essendo gli “hate crimes”
motivati da odio religioso, principalmente degli atti di violenza contro luoghi
di culto e non violenze contro le persone, le vittime e le autorità sono portati
a sottovalutarli, ed è quindi necessario aumentare l'attenzione, sia a livello
politico e di opinione pubblica, sia da parte delle autorità, verso gli “hate
crime” anticristiani”. Inoltre il delegato dell’Unione Giuristi Cattolici ha
sottolineato come occorra “valutare con molta attenzione gli "hate crimes" più
ricorrenti, ovvero quelli motivati da odio etnico, razziale, nazionalistico e
religioso, perché si tratta di fenomeni che sono in grado di portare ad un
escalation di violenza a livello interno ed internazionale”. “La prevenzione di
conflitti ed instabilità dell'area europea passa anche attraverso la prevenzione
e lotta di questo tipo di hate crimes" ha affermato l’avvocato. Un altro trend
che emerge dai dati del report, è quello che vede, in quasi tutti i Paesi
esaminati, i casi di hate crimes contro persone LGBT, sottostare in valore
numerico ai casi di violenza motivati da odio etnico e religioso, che sono
invece predominanti. È quanto ha evidenziato in una nota stampa
l’associazione Pro Vita Onlus, tramite il portavoce dell’associazione Alessandro
Fiore. “Alcune associazioni e molti organi di stampa presentano il fenomeno dei
crimini d'odio contro persone LGBT come un'assoluta emergenza nazionale, i dati
oggettivi a nostra disposizione ci restituiscono un quadro diverso”, ha
dichiarato il portavoce. Come ha affermato l’Osce nella decisione di Atene n.9
del 2009, quindi, anche gli individui appartenenti alla maggioranza della
comunità possono essere vittime di “hate crimes”, ed è importante per questo, si
legge nella decisione della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa, contrastare i crimini di odio a tutti i livelli. Sono soprattutto questo
tipo di crimini spesso, infatti, a minacciare la “sicurezza dei singoli e la
coesione sociale”, fino a sfociare in “conflitti e violenza su larga scala”.
Filippo Facci su “Libero
Quotidiano del 21 novembre 2015 umilia Antonio Di Pietro: ecco la prova, parla
arabo. Islam moderato, titoli moderati: trovare un linguaggio comune è la cosa
più importante. Chi meglio di Antonio Di Pietro? Ecco il suo contributo
(iperstestuale) espresso ieri mattina a «Coffee Break», su La7: «Guardi, si fa
presto a riempirsi la bocca... ehm... di... ergh... agenti segreti, la
sicurezza, la la... il controllo del territorio... tra i dire e il fare non è
mica facile, eh, perché prendi case di questo genere, per poi accorgersi
semplicemente quando è già fatta la frittata, non è facile andare all’interno...
ma prevenire: bisogna prevenire, ma bisogna anche avere il senso del... ergh...
la responsabilità di dire fino a che punto è possibile, ecco perché io ritengo,
quel che sta succedendo, che succederà questa manifestazione che fanno... Ergh…
domani, sia importante per un motivo molto semplice: perché deve far capire al
popolo italiano che... l’islam è una cosa... bh... è una cosa, ebeh... l’Isis è
un’altra, che... ergh... la religione musulmana è una cosa, che coloro che...
usz.. zhezhe... si riempono la bocca di questa parola ma che in realtà...
ergh... sono problemi psichiatrici, sono problemi mentali, sono problemi che...
per risolverli bisogna semplicemente isolarli e cercare che qualcuno dica di chi
li conosce, di chi ha rapporti con lui, ci dica qualchecosa. Ecco perché sotto
questo aspetto io ritengo che il messaggio che viene mandato in questo momento
dalle istituzioni, anche dal governo Renzi che io ho sempre contrastato con
tante altre (incomprensibile) sia un messaggio corretto... in questo momento
dobbiamo stare tutti uniti. Questo momento cominciare a fare polemica quello non
va bene quello non va bene quello non va bene, serve semplicemente a creare
confusione... il... quel che a me preoccupa qual è? È il proselitismo... quel
che a me preoccupa è che ci sono menti malate che vedendo tutto quel che sta
vedendo, lo voglio fare anch’io, lo voglio fare anch’io. Perché viene in mente a
fare tutto questo. Ecco, in questo senso che cosa può avvenire? Il controllo del
territorio siamo innanzitutto noi stessi, senza stare seduto sulla sedia e
pensare: perché quello non ha fatto quello? Ma mica è Mandrake, il poliziotto,
bisogna che qualcuno glielo dico, e allora quando succedono queste cose, come
quelle che avete visto adesso in questa ragazza, sicuramente, nel suo entourage,
nel suo ambiente, nel suo territorio, tante persone hanno capite che qualcosa
non andava, e allora facciamo una cosa: d’ora in poi ogni volta che capiamo
qualcosa che non va, meglio una una segnalazione in più, magari sbagliata... non
chiudiamoci... perché i migliori agenti in sicurezza di noi stessi siamo noi
stessi. Dobbiamo essere tutti partecipi tutti insieme. Io mi metto a dire male
del governo Renzi perché poteva mettere più poliziotti: ma se ci stai pure tu a
vederle e segnala il fatto, no?». Così disse il noto moderato Antonio Di Pietro:
perché trovare un linguaggio comune - tra l’italiano e l’arabo - è la cosa più
importante.
L’ISLAM, LA SINISTRA E LA
SOTTOMISSIONE.
Orgoglioso di essere cristiano
e cattolico.
I sinistroidi e similari (5
Stelle) non si limitano a condannare la barbarie islamica di Parigi, punto e
basta. Si sforzano di mistificare la realtà delle cose, contrapponendo le
ipotetiche malefatte cristiane alla barbarie terroristica mussulmana, come per
giustificare o sovvertire le responsabilità. Nascondono nei tg quel “Allah
akbar” gridato nello stadio di Istanbul in Turchia il 17 novembre 2015 nella
partita Turchia-Grecia durante il minuto di raccoglimento per le vittime degli
attentati di Parigi, che inneggia ai terroristi, o quell’appoggio morale ai
terroristi dato da parte dei mussulmani in Italia, interpellati sulla vicenda.
Nei social network post che pubblicano le responsabilità occidentali per la
vendita delle armi in medio oriente o gli eccidi commessi da occidentali da
singoli (vedi attentati di Norvegia con autore Anders Behiring Breivik) o in
seguito ai bombardamenti sui territori occupati dai taglia gole degli ostaggi
innocenti. Atei che parteggiano per i mussulmani in tempi oscurati dalla morte
di innocenti. Islamici, da loro ritenuti ultimo baluardo contro l’occidentalismo
ed il capitalismo. Lì, dove il comunismo ha fallito. Sinistroidi che in nome
della loro fede disprezzano la loro identità, cultura e tradizioni, imponendoci
un politicamente corretto. Non sono i mussulmani ad invaderci ed ad imporre a
casa nostra la loro fede, cultura e tradizioni, senza colpo ferire, ma sono i
sinistroidi a permettere che ciò avvenga. La cultura dei sinistroidi è la
discultura e l’oscurantismo. Atei che si spingono a farsi rapire per foraggiare
il terrorismo con i loro riscatti o che condannano le guerre o gli attacchi per
ritorsione, ma poi speculano finanziariamente con milioni di euro di
finanziamenti sulla cura delle vittime delle stesse guerre.
L’Islam è generato da un
profeta guerriero ed il suo fine è la morte. I suoi adepti uccidono in nome di
Allah materialmente o apologicamente con il loro sostegno o con il loro
silenzio. Tutti seguaci di un Dio cattivo perché permette morte, sofferenza,
odio, ignoranza, disuguaglianza, intolleranza e retrogradia. Una religione che
nega ogni piacere terreno ed ogni libertà. Alle donne non è riconosciuto un
paradiso paritario in cielo ed in terra condannate all’inferno: assoggettate
all’uomo solo come strumento di piacere ed utilità. Per i diversi non c’è
scampo. Imposizione della loro fede e rifiuto di reciprocità di libertà
religiosa. Quando un mussulmano uccide gli innocenti, e lo fa spesso con viltà
usando il terrorismo, lo fa gridando “Allah akbar” (Dio è il più grande). Il
progresso è usato solo come strumento di morte (vedi il nucleare). La cultura
dell’Islam è solo la conoscenza del Corano e la divulgazione in tutti i modi del
suo messaggio. Prima annettono e poi annientano ogni traccia o testimonianza o
storia di altre culture. Il loro strumento di morte è il terrorismo. Viatico di
viltà, non di sacrificio.
Il cristianesimo è nato con
l’avvento di Gesù Cristo: per alcuni, un profeta di pace; per altri, Dio buono e
figlio di un Dio buono che aborra violenza e morte. Un credo per la vita, la
libertà e la felicità. I cristiani hanno i loro peccati: veniali e capitali. Mai
nessuno, però, ha mai ucciso in nome di Cristo, ricevendo approvazione da parte
degli altri cristiani, se non in un’epoca oscura ed oggi rinnegata come quella
dell’inquisizione. I sedicenti cristiani hanno ucciso con terrorismo e
genocidio, ma non in nome della fede, ma solo in nome di una ideologia:
indipendentismo e colonialismo in minima parte; per il restante, totalitarismo
di sinistra: nazista, fascista e comunista. I cristiani hanno ucciso mussulmani,
affianco ed alleati di mussulmani, ma solo per ritorsione e fanno la guerra a
viso aperto. Non usano il terrorismo. Le Crociate sono l’orgoglio dei cristiani
veri. Strumento di liberazione di luoghi santi e difesa dei fedeli in quei
luoghi trucidati per la loro confessione religiosa. Le crociate hanno scaturito
solo progresso e libertà. La cultura occidentale è rappresentare in ogni modo
tutte le manifestazioni del creato. Per questo è immensa e sublime. La scienza e
la tecnica sono strumenti di vita, benessere e progresso. Le armi di distruzioni
di massa, da sempre, sono solo strumento di dissuasione o usati a fine di pace
come nella seconda guerra mondiale.
Io da parte mia ho scritto
“Culturopoli. L’Italia della Discultura e dell’Oscurantismo”. Sta ai mussulmani
ed ai sinostroidi, attingere un po’ di sapere per aprirsi la mente e vedere il
mondo da un’altra prospettiva.
Parigi. 13 novembre 2015,
ore 21 circa. Attacco all’occidente.
Attentati Parigi: 129 morti
e 352 feriti, Isis rivendica. «Più di cinque arresti» in Belgio. Hollande: «Atto
di guerra». Quattro italiani feriti. Sette terroristi morti, hanno agito in tre
team. L'esplosivo la «Madre di Satana». Perquisizioni e arresti a Bruxelles.
Valls: «È guerra, ci saranno altri attacchi». Evacuato volo Air France ad
Amsterdam. Un francese arrestato a Londra,
scrive "Il Corriere della
Sera” il 14 novembre 2015. Il clima di paura che attanaglia Parigi dopo la serie
di attentati di venerdì notte non si è quietato nemmeno a 24 ore di distanza
dalla carneficina. Sabato sera la polizia ha fatto evacuare la zona della Tour
Eiffel e decine di poliziotti hanno circondato e ispezionato l'Hotel Pullman,
proprio accanto alla celebre attrazione, comunque chiusa dopo gli attacchi della
vigilia. Chiusa anche la vicina stazione della metropolitana e della ferrovia
Champ de Mars in quello che, però, si è rivelato un falso allarme bomba, ma che
è un chiaro segnale della tensione che attanaglia la Francia. La capitale
francese si è svegliata sabato mattina in un clima spettrale dopo la tragedia in
quello che sembrava un venerdì di divertimento, spensieratezza e di sport. La
puntuale rivendicazione da parte dell’Isis (è «solo l’inizio della tempesta»),
arrivata sabato mattina e che la Casa Bianca ritiene attendibile, ha contribuito
ad abbattere il clima. «Quello che è successo venerdì a Parigi è un atto di
guerra commesso da un’armata jihadista contro i valori che noi difendiamo e che
siamo: un Paese libero», ha detto il presidente François Hollande in un discorso
televisivo. «La Francia è stata aggredita in modo vergognoso e violento, sarà
spietata contro la barbarie dello Stato islamico, agirà con tutti i mezzi, sul
fronte interno ed esterno». Sabato sera il primo ministro Manuel Valls, in
diretta su Tf1, ha ribadito la posizione di Hollande: «Siamo in guerra.
Sarà lunga e difficile. E per questo dico che dobbiamo attenderci altri
attacchi». Il procuratore di Parigi non ha escluso che alcuni terroristi siano
sfuggiti e siano in fuga e in un’operazione legata agli attentati «almeno 5
arresti» sono stati effettuati in Belgio. L'esplosivo usato è stato il Tatp,
perossido di acetone, un potente esplosivo primario talmente instabile da essere
soprannominato «la madre di Satana». Si tratta dello stesso tipo di esplosivo
impiegato anche negli attacchi di Londra che, il 7 luglio 2005, causarono 52
vittime su metropolitane e autobus. Una miscela di acqua ossigenata, acetone e
acido solforico o acido cloridrico, sostanze facilmente reperibili in commercio,
che risulta molto sensibile al calore, all'attrito e agli urti, come spiega
il Centro nazionale antiterrorismo americano. Il bilancio, «sfortunatamente
ancora provvisorio e in continua evoluzione», è pesantissimo: 129 morti e 352
feriti, di cui 99 in stato di urgenza assoluta, 177 in urgenza relativa, ha
riferito il procuratore della Repubblica François Molins. Delle vittime, 89
provengono solo dalla sala concerti Bataclan. Sette i terroristi morti e non
otto, come affermato in un primo momento. Di questi sei sono riusciti ad
azionare i detonatori delle loro cinture esplosive, uno è stato invece ucciso
dalla polizia. Nella capitale francese sabato le scuole di ogni ordine e grado,
i musei e gli istituti di cultura, ma anche i luoghi simbolo come la Tour Eiffel
o il parco di Eurodisney sabato sono rimasti chiusi. Con loro i principali
grandi magazzini. Undici stazioni del metrò sono rimaste chiuse, tra queste lo
snodo di Place de la République presso i luoghi delle principali sparatorie. Se
le scuole - sospese in tutto lo Stato - dovrebbero riaprire lunedì, per i luoghi
culturali non è ancora stata presa una decisione. Inoltre, diversi eventi
musicali e mondani sono stati cancellati dalle star: gli U2, che avrebbero
dovuto suonare sabato sera all’Accorhotels Arena e in diretta tv, hanno rinviato
il concerto; Natalie Portman non sarà più alla prima del film «Jane got a gun»;
è stato cancellato il photo call di «Bridge of spies» con Steven Spielberg, Mark
Rylance e Amy Ryan, previsto domenica; i Foo Fighters, che avrebbero dovuto
suonare sabato sera a Torino e lunedì a Parigi, hanno addirittura annullato la
tournée. Gli attentatori «Erano bianchi, erano giovani sui 25 anni». E ancora:
«Sembravano soldati delle forze speciali». Tra loro potrebbe esserci una donna.
Ecco le prime informazioni fornite da alcuni testimoni sull’identità
degli attentatori di Parigi che sarebbero arrivati in auto sui luoghi delle
stragi. Di certo hanno agito «quasi sicuramente» in tre squadre d’attacco, ha
spiegato Molins, invocando «Siria e Iraq» sia all’interno del Bataclan sia negli
scambi con le forze dell’ordine. Indossavano tutti cinture esplosive che
contenevano anche bulloni per massimizzare il numero di vittime. Di certo uno
degli assalitori, che ha agito al teatro Bataclan, si chiamava Ismaël M., aveva
30 anni ed era di nazionalità francese, residente a Chartres, nel centro del
Paese. Ma soprattutto era schedato negli archivi dei servizi di informazione
francesi dal 2010 per «radicalismo». Aveva avuto problemi di giustizia, ma per
reati di tipo comune. «Non era mai stato incarcerato». In serata fonti vicine
all'inchiesta hanno riferito che il padre e il fratello di uno dei kamikaze sono
sotto custodia: secondo l'Agenzia France Presse sono in corso perquisizioni
presso i domicili dei due, a Romilly-sur-Seine e a Bondoufle. Anche in questo
caso sarebbero parenti di un cittadino francese, non è stato chiarito se si
tratti di Ismaël M. Un altro terrorista, di cui non sono ancora stati resi noti
nome e nazionalità, aveva tentato di entrare dentro lo Stade de France, dove
stava per iniziare l’amichevole Francia-Germania, con la cintura esplosiva sotto
ai vestiti. Sarebbe stato fermato all’ingresso dagli addetti ai controlli e
avrebbe fatto detonare l’esplosivo. Lo riferisce il Wall Street Journal.
Altri tre sarebbero stati belgi, provenienti dal quartiere di Molenbeek di
Bruxelles, zona già interessata dai blitz in Belgio seguiti alle stragi di
gennaio a Charlie Hebdoe nel supermercato Hyper Kosher. Un’operazione di
polizia è stata effettuata a Bruxelles nel quartiere di Molenbeek e «più di
cinque arresti» sono stati effettuati, secondo il ministro della Giustizia belga
Koen Geens. Il premier Charles Michel ha poi precisato che uno dei fermati
venerdì sera era a Parigi. La pista belga è nata a caldo, visto che già venerdì
sera, in alcune testimonianze, si parlava di due auto nere, con alla guida
18-20enni: una delle due vetture, una Polo con targa appunto belga, sarebbe
stata ritrovata con nel cruscotto biglietti per il parcheggio del quartiere di
Molenbeek a Bruxelles. L’uomo che l’aveva presa a noleggio, un cittadino
francese residente in Belgio, è stato arrestato al confine tra i due Paesi. È
invece confermata la notizia del ritrovamento di un passaporto siriano sul corpo
di uno dei kamikaze morti allo Stade de France: si tratta di un uomo «nato nel
settembre 1990 in Siria, non noto ai servizi di informazione francese». Il
documento appartiene a un rifugiato registrato sull'isola di Lero, in Grecia lo
scorso 3 ottobre, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno di Atene
Nikolaos Toskas. E sono sempre le autorità greche a far sapere che anche un
altro degli attentatori è probabile sia entrato in Europa passando dalla Grecia.
Sono state le autorità francesi, chiedendo l'identificazione attraverso le
impronte digitali, a chiedere informazioni ad Atene a riguardo. Secondo
l'emittente Mega si tratterebbe di un uomo arrivato in agosto, sempre a Lero.
Prende forza un possibile legame con un arresto effettuato il 5 novembre scorso
in Baviera. Un uomo era stato arrestato durante un controllo di routine in
autostrada e nell’auto sono stati trovati «esplosivi, molte mitragliatrici e
pistole». Si tratta di un montenegrino di 51 anni in viaggio proprio per Parigi
che, per il premier del Land tedesco Horst Seehofer, ci sarebbe regione di
ritenere legato alle stragi di Parigi. Il ministro degli interni tedesco Thomas
de Maizière ha spiegato che «ci sono indagini in corso su un’eventuale
connessione», precisando che l’arresto era stato segnalato alle autorità
francesi. Falso, invece, l’allarme di sabato mattina per un’automobile con
quattro persone armate a bordo che avrebbe forzato un casello autostradale nelle
Yvelines, a sud-ovest di Parigi. Tra le vittime risultano diversi non francesi:
due sorelle tunisine; una cittadina americana; due romeni; due belgi; uno
spagnolo; un portoghese; un bulgaro. Il Regno Unito ha fatto sapere che un suo
cittadino è stato identificato, ma che teme che tra le vittime ce ne siano
altri. Diverse persone, tra cui almeno uno svedese, risultano dispersi. Tra loro
c’è un’italiana, Valeria Solesin. Tra i feriti non gravi anche quattro giovani
italiani: i fratelli Andrea e Chiara Ravagnani, di Dro, in Trentino, che erano
con Soresin, e Massimiliano Natalucci e Laura Appolloni di Senigallia, in
provincia di Ancona. In questo caso la donna è stata raggiunta alla spalla da
una scheggia o da un proiettile ed è già stata operata, Natalucci è stato
medicato. Ambedue non sono in pericolo di vita. Tra i feriti anche un cittadino
della Romania. Gli attacchi sono avvenuti negli stessi minuti in diversi luoghi
diversi della capitale: cinque nella parte est tra il X e l’XI arrondissement
nella zona tra Place de la Republique e la Bastiglia (una delle aree più
affollate del divertimento parigino del venerdì sera), un altro nei quartieri
settentrionali all’esterno dello Stade de France mentre si stava svolgendo
l’incontro amichevole di calcio Francia-Germania, alla presenza di Hollande e
del ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier). Questa la
cronologia:
- 21,20: un primo kamikaze
si fa esplodere in Avenue Jules Rimet, la strada che fiancheggia lo Stade de
France: morta una persona oltre all’attentatore. L’esplosione è udita
distintamente all’interno, la partita viene momentaneamente sospesa poi prosegue
fino la termine.
- 21,25: sparatoria nelle
terrazze dei ristoranti Le Carillon e Le Petit Cambodge, nel X
arrondissement tra Rue Bichat e Rue Alibert provoca almeno quindici morti e
dieci feriti.
- 21,30: un secondo
kamizake si fa esplodere in Avenue Jules Rimet fuori dallo stadio: anche qui
morto un passante e l’attentatore.
- 21,32: un’altra
sparatoria in un ristorante vicino al primo causa almeno cinque morti: si tratta
della birreria À la Bonne Bière in Rue de la Fontaine au Roi, XI
arrondissement: 5 morti, 8 feriti gravi.
- 21,36: al bar La Belle
Équipe all’incrocio di Rue de Charonne con Rue de Faidherbe nell’XI
arrondissement una nuova sparatoria provoca 19 morti, nove feriti gravi.
- 21,40 circa: un
kamikaze si fa saltare in aria dentro al ristorante «Le Comptoir Voltaire» sul
boulevard Voltaire, sempre nel XI, ferendo gravemente una persona.
- 21,40: tre terroristi
armati entrano nella sala di concerti Le Bataclan mentre
è in corso il concerto della band americana Eagles of Death Metal:
qui avviene la peggiore strage, 89 morti, centinaia di feriti (tra i quali i due
italiani). Qui, secondo alcuni testimoni, avrebbe agito anche una donna. Nel
contrattacco delle forze di sicurezza i tre terroristi vengono uccisi: due sono
riusciti ad azionare le loro cinture esplosive.
- 21,53 un terzo terrorista
si fa esplodere presso il McDonald’s che si trova nei pressi dello Stade de
France:
oltre al jihadista muore un passante.
- 00,20 del 14 novembre: le
forze di sicurezza lanciano il blitz al
Bataclan cercando di liberare gli ostaggi. Un terrorista viene ucciso, gli altri
due si fanno saltare in aria.
Il presidente Hollande è stato
subito portato via dallo Stade de France e ha raggiunto immediatamente l’Eliseo,
dove ha presieduto una riunione di emergenza del governo nella quale è stata
decisa la dichiarazione dello stato di emergenza e la chiusura delle frontiere.
Poi l’Eliseo ha precisato meglio le parole del presidente: le frontiere non sono
chiuse ma saranno aumentati i controlli. Le procedure Schengen erano infatti già
state sospese dal 13 novembre al 13 dicembre per il vertice sul clima Cop21 di
Parigi. «La Francia è più forte e può essere ferita, ma oggi si rialza.
Difendiamo la nostra patria, ma anche i valori dell’umanità: la Francia saprà
assumersi le sue responsabilità». Il presidente ha annunciato che si rivolgerà
alle Camere in seduta congiunta a Versailles, una procedura prevista dalla
Costituzione francese per situazioni eccezionali. Hollande ha anche annunciato
che non parteciperà al G20 in programma in Turchia nel fine settimana. Sempre
sabato mattina a Londra il terminal nord dell’aeroporto di Gatwick è stato
evacuato per «misura precauzionale» a causa di un pacchetto sospetto,
riprendendo le attività solo intorno alle 16 (le 17 italiane). Un francese di 41
anni, originario di Vendôme (Loira), è stato fermato perché avrebbe compiuto
gesti che hanno insospettito le forze di sicurezza e sarebbe stato trovato in
possesso di un’arma.
Dal comunicato dell’Isis sulla
rivendicazione degli attacchi di Parigi è possibile capire molto sul linguaggio
dell’organizzazione terroristica. È Repubblica a fare un’analisi del bollettino
di guerra che si apre con la sura Al-Hasr, il bando che fa riferimento
all’elemento sorpresa che recita: “quelli fra la gente della Scrittura che erano
miscredenti. Voi non pensavate che sarebbero usciti, e loro credevano che le
loro fortezze li avrebbero difesi contro Allah. Ma Allah li raggiunse da dove
non se lo aspettavano e gettò il terrore nei loro cuori: (…). Traetene dunque
una lezione, o voi che avete occhi per vedere”. Non si parla dunque di non
attaccare luoghi noti, ma i più nomali, dove loro “non se lo aspettano” come per
esempio il Bataclan, un luogo, secondo i terroristi, si teneva “una festa della
perversione” dove c’erano “centinaia di idolatri”. I bersagli sono stati scelti
“minuziosamente” anche se poco importa che tipo di musica si stesse suonando in
quel momento, l’importante era colpire la cultura occidentale. È proprio questa
precisione che fa ritenere alla polizia francese che tra i terroristi vi fossero
pure dei francesi già schedati come potenzialmente pericolosi. Il comunicato,
poi, prosegue con l’elogio ai martiri che si sono fatti esplodere allo stadio
dove si giocava l’amichevole Francia-Germania, a cui assisteva “l’imbecille”
Hollande. Paesi come la Francia che lottano con ijihadisti nelle zone calde
saranno “i principali bersagli dello stato islamico” e sentiranno ancora
‘l’odore della morte’ per aver insultato il Profeta, con un nuovo sottile
riferimento implicito a Charlie Hebdo. L’attacco alla laicista Francia,
rivendica il documento, è una ripercussione per aver bombardato lo Stato
islamico, un atto che non è servito a nulla “quando l’attacco è stato portato
nelle maleodoranti strade di Parigi”. Un bollettino che si chiude col versetto 8
della sura 63: “La potenza appartiene ad Allah, al Suo Messaggero e ai credenti,
ma gli ipocriti non lo sanno”, con chiaro riferimento a quei musulmani moderati
che credono solo a parole.
"Libero Quotidiano" 14
novembre 2015: Bastardi islamici. Maurizio Belpietro: "Altro
che siamo tutti Charlie Hebdo: siamo tutti in pericolo, perché il terrorismo
islamico non fa distinzione tra uomini e donne, fra combattenti e innocenti. Il
terrorismo islamico vuole non solo uccidere, terrorizzare, colpire chiunque sia
ritenuto un infedele. Il 2015 è cominciato a Parigi sotto i peggiori auspici,
con l’irruzione di due fratelli imbottiti di armi e di odio religioso. E a
distanza di meno di un anno il 2015 si conclude nello stesso modo: con
un’irruzione in un ristorante, in una sala da concerti e persino allo stadio,
con ostaggi e altri morti. La contabilità delle vittime a notte non è ancora
nota, ma si parla di decine di cadaveri, né è conosciuta con chiarezza la
dinamica, quanti siano i terroristi in campo, di quali fazioni si professino
militanti, da dove vengano e come siano potuti sfuggire ai controlli
dell'antiterrorismo. Ma in fondo che serve sapere tutto ciò? L'unica cosa che
c'è da sapere e che serve a qualcosa è che l'Occidente ha sbagliato tutto e
continua a sbagliare".
Maurizio Belpietro e i
bastardi: ecco perché difendo quei titoli.
Ieri sul titolo di Libero "Bastardi
islamici" ha scatenato una serie di polemiche e accuse. Oggi, nel suo editoriale
il direttore Maurizio Belpietro difende la scelta e si difende dalle accuse
partendo soprattutto dalla lingua italiana. "È come se un cattolico uccidesse
delle persone e qualcuno scrivesse bastardi cattolici, ci è stato obiettato. Non
tutti gli islamici sono terroristi, non tutti i cattolici sono persone
pacifiche. Vero. Ma noi non abbiamo scritto che tutti gli islamici sono
terroristi né lo abbiamo pensato (...) Noi non abbiamo insultato gli islamici in
generale", scrive Belpietro. E ancora: "Noi abbiamo scritto: Bastardi
(sostantivo) islamici (aggettivo). La lingua italiana è chiara, non lo è solo
per chi è in malafede e non vuole vedere la realtà".
Querelati dal genero di
Gino Strada. Pirla on line, tutti gli insulti: farete la fine di Charlie.
Il rosario d'insulti è lungo quanto una quaresima, scrive "Libero Quotidiano" il
15 novembre 2015. Ce n'è per tutti i gusti e, soprattutto, è stato saccheggiato
l'intero vocabolario delle parolacce. Ovviamente all' appello non mancano quelli
che incitano alla violenza pura. Anzi, all' azione fisica. Come fa Alessandro
Guerri che su Facebook scrive: «Io li ammazzerei tutti, come quelli di Charlie,
d' altronde mica si può scrivere quel che si vuole...poi sai che belle magliette
con su scritto Je suis Libero, me comprerei non una ma due». Prego, si accomodi
pure. Però il top lo toccano il giornalista Maso Notarianni, genero di Gino
Strada, che ha deciso di denunciare il direttore di Libero. Sulla stessa
lunghezza Hamza Roberto Piccardo, tra i fondatori dell'Unione delle Comunità e
organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii). Intervistato dal quotidiano on line
Lettera43, diretto da Paolo Madron, ha affermato di provare «nausea, schifo,
dolore più che rabbia», per il titolo di Libero. «Non si rendono conto del male
che stanno facendo», chiosa Piccardo, «questi vogliono la guerra civile per
interessi politici». Resta uno solo enorme dubbio: contro gli assassini c' è la
stessa vibrata indignazione? A volte il dubbio diventa certezza, vista la
rapidità dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Il presidente, Gabriele
Dossena, ha segnalato il titolo «Bastardi islamici», al Consiglio di disciplina
territoriale perché faccia una approfondita valutazione del caso e per
verificare se ci siano state o no violazioni delle Carte deontologiche della
professione giornalistica. E poi c' è la rete che non si smentisce mai. Su
Twitter Barbara Collevecchio chiede di dare a quelli dell'Isis «l' indirizzo di
Belpietro». E saremmo noi i «seminatori d' odio». Andrea Giambartolomei, invece,
«30 anni, scrivo per @ilfattoquotidiano. Frequento tribunali e librerie. Le
opinioni sono mie. Rt#endorsement. info sul blog», tocca l' apice: «Se dovesse
succedere qualcosa a Maurizio Belpietro non scriverò mai qualcosa tipo
#jesuisBelpietro. Ecco». Vorremmo tanto sapere come la pensano al Fatto
Quotidiano di personaggi così. E siccome è sempre meglio esagerare una
giornalista del Tg2, Chiara Prato, Chiarap su Twitter, oltre a mostrare la prima
pagina di Libero ripresa da un sito arabo non ufficialmente Isis ma
«simpatizzante», arriva al punto di sostenere che saremmo addirittura «complici
dei terroristi». Se qualcuno vuol confondere le idee ai lettori e ai
telespettatori ci riesce benissimo. Per fortuna Giuseppe Cruciani, conduttore de
La Zanzara su Radio 24, prova raddrizzare la barra. «Non tutti gli islamici sono
bastardi, ma quelli che ammazzano sono islamici bastardi», scrive sul social
network dei cinguettii. Sempre su Twitter, dove in queste ore «#Libero» è trend
topic, si legge: «#Libero sciacallo: persona che per rubare approfitta delle
disgrazie altrui», attacca un utente, accusando Belpietro. «Come aggiungere odio
all' odio #Libero #vergogna», aggiunge Carlotta. Tanti chiedono poi di
intervenire contro Belpietro: «Prima pagina di #Libero su #ParisAttacks. Ma come
vi salta in mente? Radiare Belpietro dall' ordine dei giornalisti. Subito»,
scrive Stefano Sanguineti. Ma c' è anche chi difende la scelta di Libero. «Per
la #fecciarossa il vero problema è il titolo di #Libero», ribatte un altro
utente. Mentre un secondo scrive: «Non sarà censurando #Libero che si vincerà la
guerra in atto contro l'#ISIS».
Per farsi notare denuncia
Belpietro per “istigazione all’odio religioso”,
scrive Francesco Severini
sabato 14 novembre 2015 sul “Il Secolo D’Italia”. Maurizio Belpietro, direttore
di Libero, è stato denunciato dal giornalista Maso Notarianni, ex caporedattore
del quotidiano di Rifondazione comunista, Liberazione, per il titolo della prima
pagina di oggi, Bastardi islamici, riferita agli attentati di Parigi. Un titolo
volutamente “forte”, frutto di una corale indignazione ma che ha suscitato non
poche polemiche. Un dibattito, quello sul linguaggio da utilizzare in situazioni
tragiche come quelle che l’Occidente sta vivendo, passato in secondo piano
dinanzi alle drammatiche notizie che arrivano da Parigi. Un dibattito che
sicuramente tornerà a fare capolino anche se sarebbe utile che tutte le energie
intellettuali disponibili, anche quelle di Notarianni, siano spese per
approfondire e comprendere la fase che stiamo vivendo anziché ingaggiare una
guerra delle parole con il direttore di un giornale evidentement sgradito agli
esponenti della sinistra. “La legge italiana stabilisce dei confini per la
libertà di satira e di stampa, io – spiega Notarianni – credo quel titolo sia
un’istigazione all’odio religioso con l’aggravante dell’insulto a una religione.
Quel tipo di comunicazione è pericolosa oltre che criminale, credo sia stato
sensato fare una denuncia”. Ora, mentre il mondo si interroga sulle strategie da
adottare per fronteggiare la bestialità dei jihadisti, il pericolo è davvero
rappresentato dai titoli, sia pure opinabili, di Maurizio Belpietro? “Qualcuno
ci dà degli ignoranti – replica Belpietro – per il titolo Bastardi islamici.
Ignoranti son quelli che non sanno che bastardo significa figlio illegittimo”. A
Belpietro ha risposto, tra gli altri, Cecilia Strada: “Unghie sugli specchi a
parte, siete seminatori di odio. Che genera odio. Non ve l’ha insegnato la
mamma? Siete pericolosi”. Pericolosi, dunque, sarebbero i giornalisti di Libero.
Su altri e ben più concreti pericoli, invece, meglio sorvolare. Questa è la
logica di una sinistra sempre più disconnessa dalla realtà.
La sinistra non condanna
l’estremismo islamico, ma attacca la destra.
La colpa degli attentati di
Parigi è dell’Islam, perché islamici i suoi esecutori. Ma se il centrodestra lo
dice, per la sinistra sta facendo sciacallaggio. Loro lo chiamano sciacallaggio,
noi buonsenso. Condannare l’Islam, tutto l’Islam, per i terribili attentati
di Parigi non significa cavalcare “i corpi ancora caldi”. I tweet di Salvini,
quelli di Daniela Santanché, le condanne del centrodestra a un’Europa che si è
svegliata schiava del buonismo sono segno di ragionevolezza. Non opportunismo
politico. Per l’intellighenzia radical-chic, invece, no. Nemmeno il tempo di
dormire qualche ora con le immagini del massacro ancora davanti agli occhi, ed
ecco che l’Espresso pubblica in pompa magna un articolo in cui anziché biasimare
l’Islam attacca il centrodestra. La sua colpa, secondo i signori buonisti, è
quella di avere “il tweet già salvato da qualche parte, pronto in canna per
essere lanciato al momento opportuno”. Certo. Non è l’islamismo il problema, non
lo sono le bombe né i 128 morti. Il problema sono i tweet di Salvini, i titoli
dei giornali di centrodestra. “La serie di attentati che ha sconvolto Parigi –
scrive su l’Espresso Mauro Munafò – è diventata l’occasione perfetta per i
politici italiani di Lega e destra per riversare il loro odio su social network,
prendendosela genericamente con tutto l’Islam, attaccando chiunque chiedesse di
ragionare prima di sparare a zero, appoggiando interventi e soluzioni rapide
giusto per fare incetta di like e, nelle loro speranze, voti”. Maledetto
prosciutto negli occhi. Nemmeno di fronte al fatto compiuto riescono ad
ammettere che le porte aperte, il relativismo, la favola della differenza tra
Islam radicale e moderato hanno generato un mostro, quotidianamente allattato.
Uno sgorbio ormai troppo grande da estirpare. “Buonisti=complici”, ha scritto
ieri sera Matteo Salvini. “L’Islam festeggia i nostri morti”, aggiungeva Daniela
Santanché. E la sinistra, lei sì sciacalla, affonda il colpo. Cosa c’è di
sbagliato, ci chiediamo. L’Islam “moderato” ha dimostrato di non essere
all’altezza. Non esiste nessuna “degenerazione” o “follia” jihadista. I
terroristi hanno agito con cognizione di causa, sapevano dove colpire. Sapevano
cosa colpire: i luoghi dello svago, il tempo del calcio. L’Europa si è di fatto
sottomessa a tutto questo. Accettando finanche di limitare la propria libertà
pur di affermare l’ideologia buonista. Crocifissi nell’urina e mostre cristiane
negate sono solo la punta dell’iceberg. La guerra è brutta, ma il pacifismo,
ormai, è inutile. Il centrodestra da tempo ha lanciato l’allarme. Ma non c’è
peggior sordo di chi non vuol sentire. Fonte: il giornale.
Così la sinistra
radical-chic del web insulta la Fallaci.
C'è chi la
paragona al vitel tonné e chi attacca Salvini per aver proposto la lettura
obbligatoria dei suoi libri nelle scuole, scrive Francesco Curridori Sabato
14/11/2015 su “Il Giornale”. Sui social, a distanza di anni, si rende il dovuto
tributo alla scrittrice Oriana Fallaci, vista come un'infallibile Cassandra. Ma
non mancano quelli che bistrattano i suoi lettori come degli ignoranti che
condividono acriticamente i suoi pensieri. Proprio sulla pagina Facebook
dell'Espresso, come testo di accompagnamento a un articolo sui fatti di Parigi,
si può leggere: “Prima di condividere acriticamente citazioni di Oriana
Fallaci e status di Salvini, leggete questo - dal blog Il Paese che non ama".
In molti, poi, ricordano la lettera che Tiziano Terzani gli indirizzò che
terminava con queste parole: "La natura è una grande maestra, Oriana, e
bisogna ogni tanto tornarci a prendere lezione. Tornaci anche tu. Chiusa nella
scatola di un appartamento dentro la scatola di un grattacielo, con dinanzi
altri grattacieli pieni di gente inscatolata, finirai per sentirti sola davvero;
sentirai la tua esistenza come un accidente e non come parte di un tutto molto,
molto più grande di tutte le torri che hai davanti e di quelle che non ci sono
più. Guarda un filo d’erba al vento e sentiti come lui. Ti passerà anche la
rabbia. Ti saluto, Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare pace. Perchè se
quella non è dentro di noi non sarà mai da nessuna parte". Altri utenti
di Facebook scrivono: "Aveva ragione Oriana Fallaci", su internet tornano le
frasi della scrittrice fiorentina. "Certo, non basterà un #JeSuisParis a
risolvere i problemi. Ma citare i deliri razzisti di Oriana Fallaci peggiora
solo la situazione" oppure di Twitter: "La Fallaci viene citata da chi dubito
l'abbia mai letta. Io invece spero che ragione, eguaglianza e voglia di creare
un mondo migliore vincano su paura del diverso, ignoranza e violenza". Una delle
frasi più offensive forse è questa: "Oriana Fallaci è come il Vitel Tonné a
Capodanno: a nessuno piace, ma qualcuno insiste sempre a tirarlo fuori per
l'occasione". Le più politicamente rilevanti però sono i tweet che i
followers di Matteo Salvini hanno scritto in risposta all'invito di rendere
obbligatoria la lettura dei libri della Fallaci. Il commento più significativo
viene dal matematico e filosofo Francesco Maria Fontana:
"Salvini ha torto. E Fallaci ha grandi responsabilità: ha
predicato l'odio razziale e religioso. E l'odio genera odio".
Gli attentati di Parigi e
la Fallaci. «Scusaci Oriana, avevi ragione». Il risarcimento postumo è online.
Aspra ma vera, violenta ma realista. Fallaci protagonista su Facebook e Twitter,
scrive Pier
Luigi Battista su “Il Corriere della Sera” del 15 novembre 2015. Su Twitter, su
Facebook, sui social network, dopo l’apocalisse di Parigi è tutto uno «scusaci
Oriana». Anzi, tutto no. La parte opposta se la prende aspramente,
rancorosamente, con «il delirio della Fallaci», con «l’odio fallaciano». Uno ha
scritto, come in una disputa teologica, contro il «fallacianesimo». Ma insomma,
da una parte e dall’altra fioriscono le citazioni di Oriana Fallaci. Si vede nel
massacro di Parigi il frutto della «profezia di Oriana». Si citano brani interi
de La rabbia e l’orgoglio, un libro che ha venduto un numero
incalcolabile di copie, che ha intercettato un umore popolare, che ha dato voce
a un sentimento diffuso. E oggi, dopo anni di dimenticanza e di
marginalizzazione, lo «scusaci Oriana» sembra essere la ricompensa postuma, il
risarcimento per una sordità, quasi a considerare Oriana Fallaci come una
intrattabile estremista. Mentre ora si vede che le sue diagnosi non erano poi
così insensate. Un passo della Fallaci molto citato: «Intimiditi dalla paura di
andar controcorrente cioè d’apparire razzisti, non capite o non volete capire
che qui è in atto una Crociata alla rovescia. Abituati come siete al doppio
gioco, accecati come siete dalla miopia, non capite o non volete capire che qui
è in atto una guerra di religione». «Brava Oriana», «Scusaci Oriana», «Non ti
hanno voluto ascoltare Oriana», si batte e si ribatte sui social network. E giù
anche con gli improperi di Oriana Fallaci sull’Italia molle e arrendevole,
«l’avamposto che si chiama Italia» come lo definiva beffardamente lei:
«avamposto comodo strategicamente perché offriamo buonismo e collaborazionismo,
coglioneria e viltà». E sulla «coglioneria» s’alza la standing ovation dei
fallaciani dell’ultimissima ora, o forse della prima perché compravano
avidamente i suoi libri ma non avevano il palcoscenico di Internet sul quale
esibirsi. E la profezia della Fallaci che viene rilanciata, e poi contestata, e
poi brandita come un’arma della guerra culturale, e poi vituperata, e poi
sventolata come una bandiera: «Ma presto si scateneranno. Molti italiani non ci
credono ancora. Si comportano come i bambini per cui la parola Morte non ha
alcun significato. O come gli scriteriati cui la morte sembra una disgrazia che
riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una disgrazia che li colpirà per
ultimi. Peggio: credono che per scansarla basti fare i furbi cioè leccarle i
piedi». E poi, la previsione più precisa, geograficamente circostanziata, in
perfetta connessione con l’orrore che ha scosso la Francia: «Parigi è persa, qui
l’odio per gli infedeli è sovrano e gli imam vogliono sovvertire le leggi laiche
in favore della sharia». La Francia che non ha mai amato Oriana Fallaci. E
bisognerebbe anche ricordare che in Francia la Fallaci, assieme a Michel
Houellebecq molto prima che uscisse Sottomissione, fu messa sul banco
degli accusati con l’imputazione, che assomiglia a una scomunica ideologica, di
«islamofobia»: un’impostura intellettuale che diventa reato e che in Francia,
nella Parigi che ieri è stata sconvolta dalla follia fanatica dei combattenti
jihadisti, è diventata un’arma di ricatto per tacitare la «parola contraria»,
come direbbe Erri De Luca in un contesto peraltro completamente diverso. La
Fallaci del dopo 11 settembre ha sempre diviso l’opinione pubblica: l’hanno
amata e l’hanno odiata, hanno comprato milioni di suoi libri e l’hanno bollata
come fanatica al contrario, come guerrafondaia scatenata, come una pericolosa
incendiaria quando descriveva Firenze assediata e violentata dagli immigrati che
orinavano sul sagrato del Duomo, con un’immagine aspra, violenta. Senza che
nessuno si chiedesse: aspra ma vera? Violenta ma corrispondente alla realtà?
Oggi, dopo il massacro di Parigi, quelle domande tornano di attualità e vengono
assorbite e fagocitate da quel grande mostro onnivoro che è il mondo dei social
network. «Scusaci Oriana» su Twitter. Neanche una «profezia» della Fallaci
poteva arrivare a tanto.
Gli attentati di Parigi e
quel complesso di colpa che ispira l’equivoco buonista. La violenza va repressa
con la violenza ma anche, e sperabilmente, esorcizzata con l’insegnamento del
rispetto reciproco, instillando la banale ma sacrosanta verità che dire Dio
anziché Allah o viceversa non può offendere nessuno,
scrive Claudio Magris su “Il Corriere della Sera” del 15 novembre 2015. Siamo in
piena Quarta guerra mondiale. Le tre precedenti avevano almeno schieramenti
nettamente contrapposti; anche la Terza, cosiddetta Fredda, fra Occidente e
mondo sovietico, finita con la sconfitta di quest’ultimo e 45 milioni di morti
fra il 1945 e il 1989 nei più diversi Paesi della terra, per nostra fortuna da
noi lontani. In questa Quarta, che poche ore fa ha fatto strage a Parigi dopo
averne fatte molte altre, non si sa bene chi combatta contro chi; nel caos che
infuria nel Medio Oriente, ad esempio, è spesso difficile capire chi sia nostro
alleato o nemico. Assad, ad esempio, è stato indicato ora quale tiranno da
abbattere ora quale possibile alleato. In questo enorme pulviscolo sanguinoso è
difficile combattere chi semina stragi, ovvero l’Isis. Come era lungimirante
l’opposizione di Giovanni Paolo II alla guerra in Iraq, opposizione che non
nasceva certo da simpatia per il feroce despota iracheno né da astratto
pacifismo, che gli era estraneo perché la sua esperienza storica gli aveva
insegnato che la guerra, sempre orribile, è talora inevitabile. Ma il Papa
polacco sapeva che sconvolgere l’equilibrio - precario e odioso, ma pur sempre
equilibrio - di quella Babele mediorientale avrebbe creato un’atomizzazione
incontrollabile della violenza. Come era più intelligente Reagan di quanto lo
sarebbe stato anni dopo George Bush Jr, quando, per stroncare l’appoggio di
Gheddafi al terrorismo, si decise per un’azione brutale ma rapida ed efficace e
non pensò a inviare truppe americane a impantanarsi per chissà quanto tempo nel
deserto libico, mentre l’invasione dell’Afghanistan voluta da Bush Jr. sta
durando quasi tre volte la Seconda guerra mondiale, senza apprezzabili
risultati. Ma l’Isis non è Al Qaeda, non è una società segreta inafferrabile; si
proclama uno Stato, seppur sedicente e non ben definito. Dovrebbe quindi essere
più facile colpirlo in modo sostanziale. Certo la strategia perdente è quella
adottata sinora, soprattutto dagli Stati Uniti, con quei bombardamenti a
singhiozzo che non bastano a togliere di mezzo quel cosiddetto Stato e magari,
con le perdite non sempre precisamente mirate che infliggono, feriscono e
irritano altre forze e compagini politiche. È inutile -- anche inutilmente
violento - dare uno schiaffo; o si colpisce a fondo, per mettere knock out,
oppure ci si astiene. È ovvia l’esecrazione per le stragi compiute a Parigi e
altrove, con la destabilizzazione generale della vita sociale e collettiva che
esse provocano. Si può pure deprecare la scarsa efficacia dei Servizi segreti
dinanzi a nemici così sfuggenti, anche se bisogna riconoscere che è più
difficile scoprire le trame dell’Isis che quelle della Cia o del Kgb. A questa
inaudita violenza si collegano, indirettamente, il nostro rapporto col mondo
islamico in generale e la convivenza con gli islamici che risiedono in
Occidente. A chiusure xenofobe e a barbari rifiuti razzisti si affiancano
timorose cautele e quasi complessi di colpa o ansie di dimostrarsi politicamente
ipercorretti, che rivelano un inconscio pregiudizio razziale altrettanto
inaccettabile. È doveroso distinguere il fanatismo omicida dell’Isis dalla
cultura islamica, che ha dato capolavori di umanità, di arte, di filosofia, di
scienza, di poesia, di mistica che continueremo a leggere con amore e profitto.
Ma abbiamo continuato ad ascoltare Beethoven e Wagner e a leggere Goethe e Kant
anche quando la melma sanguinosa nazista stava sommergendo il mondo, però è
stato necessario distruggere quella melma. Le pudibonde cautele rivelano un
represso disprezzo razzista ossia la negazione della pari dignità e
responsabilità delle culture camuffata da buonismo. È recente la notizia di una
gita scolastica annullata dalle autorità della scuola elementare «Matteotti» di
Firenze perché prevedeva una visita artistica che includeva un Cristo dipinto da
Chagall, nel timore che ciò potesse offendere gli allievi di religione
musulmana. Il Cristo di Chagall è un’opera d’arte, come le decorazioni
dell’Alhambra, e solo un demente o un fanatico razzista può temere che l’uno o
le altre possano offendere fedi o convinzioni di qualcuno. Quei dirigenti
scolastici che hanno annullato per quel motivo la gita dovrebbero essere
licenziati in tronco e messi in strada ad aumentare le file dei disoccupati,
perché evidentemente non sono in grado di svolgere il loro lavoro, come dovrebbe
essere licenziato un insegnante che in una gita scolastica a Granada vietasse ai
suoi allievi di visitare l’Alhambra per non offendere la loro fede cristiana. La
violenza va repressa con la violenza, ma anche - e sperabilmente - esorcizzata
con l’insegnamento del rispetto reciproco, instillando pure nelle zucche più
dure la banale ma sacrosanta verità che dire Dio anziché Allah o viceversa non
può offendere nessuno. Solo Allah, ripetono i versetti sulle pareti
dell’Alhambra, è il vincitore. Le stragi di Parigi e tutte le violenze
dimostrano, purtroppo, che spesso l’imbecille violenza è più forte del Signore,
comunque questi venga chiamato.
Non è solo terrorismo,
l'Islam integralista dell'Isis è come il nazismo.
Dobbiamo affermare che non è più tempo di sentirsi in colpa e fare distinguo
tenendo solo presente che l'Islam non è il terrorismo così come il cristianesimo
non era la sant'inquisizione ma che l'isis è come il nazismo, scrive Marco
Carrai il 15 Novembre 2015 su “Il Foglio”. Le immagini di Parigi di venerdì
notte hanno forse tolto l'ultimo velo alle profetiche parole pronunciate da Papa
Francesco qualche tempo fa e nuovamente ieri: siamo pienamente dentro la terza
guerra mondiale. Immagini che eravamo abituati a vedere da decenni in luoghi
come Kabul, Beirut, Baghdad sono piombate dentro le nostre case, le nostre vie,
i nostri ristoranti, i nostri luoghi di spensierato intrattenimento e ci hanno
improvvisamente svegliato dal torpore talvolta buonista talvolta integralista
che ci ha avvolto da anni. La Francia - paese che, anche grazie alle sue
storiche rivoluzioni ha portato la modernità e la libertà che oggi sentiamo
minacciate - è stata attaccata con atti di guerra terroristica e ha risposto con
la chiusura delle frontiere. Questa scelta è emblematica di quanto ancora non si
sia capito che il nemico lo abbiamo in casa. Coltivato dal buonismo che ha fatto
dell'accoglienza senza se e senza ma un mantra e da un altrettanto uguale
sentimento di intolleranza che ha messo ai margini non integrandoli generazioni
di immigrati che hanno costruito città con proprie regole, dentro città che da
400 anni vivono invece con regole di libertà. Se ancora oggi non possiamo non
dirci tutti francesi allora diciamolo fino in fondo ma traiamone le conseguenze.
La rivoluzione francese nasce per l'eliminazione di privilegi e per costituire
uno stato che abbia una sua propria costituzione dentro la quale i cittadini si
riconoscono. E' come il figlio di una famiglia adottiva. Ha un genitore naturale
ma, cresciuto da un'altra famiglia vive, convive ed accetta gli insegnamenti
della sua famiglia adottiva. Quando non è così succedono solo disastri. Se è
vero che nessuna cultura è superiore ad altre, è anche vero che le culture
subiscono mutamenti e sarebbe solo falso buonismo non affermare con forza che
400 anni della recente storia ha permesso all'occidente di costruire una
piattaforma tollerante di cittadinanza mentre ancora qualcuno decide di uccidere
in nome di Dio. Oggi più che mai, dobbiamo riporre la nostra fiducia nella
nostra Intelligence e capacità di prevenzione anche a costo di veder ridurre
momentaneamente - ma solo momentaneamente perché altrimenti avrebbero vinto loro
- alcuni nostri diritti. Ma qualsiasi attività preventiva seppur fatta al meglio
non servirà da sola se non capiamo che i pazzi non possono trovare posto nella
nostra civiltà e nei nostri Paesi. Forse, anzi di sicuro, con tutta la forza
dobbiamo affermare che non è più tempo di sentirsi in colpa e fare distinguo
tenendo solo presente che l'Islam non è il terrorismo così come il cristianesimo
non era la sant'inquisizione ma che l'isis è come il nazismo. Noi siamo più
forti solo perché abbiamo le nostre regole e le nostre libertà. In definitiva la
nostra cultura. Che va difesa. Ad ogni costo. Così come altre volte è successo
nella storia del 900.
Basta buonismo: fuori le
palle,
scrive Francesco Maria Del Vigo su “Il Giornale” il 14 novembre 2015.
L’Occidente è sotto attacco. Siamo tutti sotto attacco. Parigi, Madrid, Londra o
Casalpusterlengo. Poco cambia. Ai loro occhi siamo tutti uguali. Siamo noi che
ci sentiamo tutti diversi e andiamo avanti in ordine sparso. La mattanza di
Parigi è l’11 settembre – l’ennesimo – dell’Europa. È una carneficina che
macella la nostra carne, le nostre vite e la nostra sgangherata società. Ci
odiano. Ci vogliono annientare. Chiunque essi siano. Questi bastardi che
agiscono in nome di Allah. Non c’è un criterio, non c’è una scelta nella loro
follia. Non c’è niente. Solo la voglia di sangue. Loro sono colpevoli. Ma hanno
dei complici. Oggi è schiantato il multiculturalismo, il sogno
dell’integrazione, l’illusione lisergica del melting pot, la retorica bavosa e
cattocomunista delle porte aperte, l’ipocrisia del terzomondismo col culo degli
altri. Poi c’e l’iniquità politica dell’Europa, che essendo un’Europa delle
banche e degli affari se ne fotte dei cittadini e di quello che gli succede. Non
fa politica estera, al massimo fa commercio estero. E Obama? Questo premio Nobel
per la pace sulla fiducia, questo pessimo politico favorito dalla pigmentazione
della sua pelle, non esiste. È un fantasma. Persevera in una politica estera
nella quale il limite del globo è l’ombelico dell’America. L’11 settembre 2001
siamo stati tutti americani, non solo nelle parole, anche nei fatti. Anche nelle
guerre sbagliate. Sbagliatissime. Ma nessuno, mai, in questi anni si è sentito
veramente europeo davanti all’orrore del terrorismo. Nè gli americani, nè gli
europei. Poi c’è il governo italiano. Che ha il potere, la sovranità, le qualità
di un’amministrazione condominiale e la lungimiranza di una talpa. Siamo nelle
mani di Renzi e di Alfano. E tra meno di un mese c’è un Giubileo che ci stamperà
sulla fronte i cerchi concentrici del bersaglio. Comunque vada, e speriamo bene,
dobbiamo sapere che al momento abbiamo perso. Avremo paura a prendere la
metropolitana, ad andare al lavoro, a girare per Roma e per Milano. Il
terrorismo ci ha mangiato il mondo, lo ha ridotto, ristretto. Facciamo un
discorso stupido: pensate in quanti posti non andreste in vacanza ora? Egitto e
Tunisia. Probabilmente Marocco e Turchia. Iraq, Afganistan e Siria sono
ovviamente impraticabili. Ma anche Parigi e tutte le capitali europee. Tra poco
avremo paura a prendere l’aereo, il treno, l’autobus. Ieri sera sono morti degli
innocenti seduti in un ristorante e in un teatro. Senza colpa. Senza motivo.
Stavano facendo le cose di tutti i giorni. Vogliono rinchiuderci in casa,
toglierci la libertà, vietarci il mondo, impedirci la vita se non ce la fanno a
togliercela. Siamo dei bersagli. Non è più il momento dell’ipocrisia, delle
belle parole, dell’altruismo, dell’accoglienza per tutti. Abbiamo bisogno di un
po’ di egoismo. Siamo in tempo di guerra. E dobbiamo farla. Anche al buonismo
che ci impedisce di difenderci. O saremo sottomessi.
Maometto.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Maometto
(La Mecca, 570 circa – Medina, 8 giugno 632) è stato il fondatore e, per i
musulmani, l'ultimo profeta dell'Islam. Considerato dai musulmani di ogni
declinazione - ad eccezione degli Ahmadi - l'ultimo esponente di una lunga
tradizione profetica all'interno della quale occupa una posizione di assoluto
rilievo, Messaggero di Dio (Allah) e Sigillo dei profeti, per
citare solo due degli epiteti onorifici che gli sono tradizionalmente riferiti,
sarebbe stato incaricato da Dio stesso - attraverso l'arcangelo Gabriele - di
divulgare il suo verbo tra gli Arabi.
Prima della Rivelazione.
Maometto (che nella sua forma originale araba significa "il grandemente lodato")
nacque in un giorno imprecisato (che secondo alcune fonti tradizionali sarebbe
il 20 o il 26 aprile di un anno parimenti imprecisabile, convenzionalmente
fissato però al 570) a Mecca, nella regione peninsulare araba del Hijaz, e morì
il lunedì 13 rabīʿ
I dell'anno 11 dell'Egira (equivalente all'8 giugno del 632) a Medina e ivi fu
sepolto, all'interno della casa in cui viveva. Sia per la data di nascita, sia
per quella di morte, non c'è tuttavia alcuna certezza e quanto riportato
costituisce semplicemente il parere di una maggioranza relativa, anche se
sostanziosa, di tradizionisti. La sua nascita sarebbe stata segnata, secondo
alcune tradizioni, da eventi straordinari e miracolosi. Appartenente a un
importante clan di mercanti, quello dei Banu Hashim, componente della più vasta
tribù dei Banu Quraysh di Mecca, Maometto era l'unico figlio di
ʿAbd
Allāh b. ʿAbd
al-Muttalib ibn Hāshim e di Āmina bint Wahb, figlia del sayyid del clan
dei Banu Zuhra, anch'esso appartenente ai B. Quraysh. Orfano fin dalla nascita
del padre (morto a Yathrib al termine d'un viaggio di commercio che l'aveva
portato nella palestinese Gaza), Maometto rimase precocemente orfano anche di
sua madre che, nei suoi primissimi anni, l'aveva dato a balia a alīma bt. Abī
Dhuʿayb,
della tribù dei Banū Saʿd
b. Bakr, che effettuava piccolo nomadismo intorno a Yathrib. Nell'Arabia
preislamica già esistevano comunità monoteistiche, comprese alcune di cristiani
ed ebrei. A Mecca - dove, alla morte della madre, fu portato dal suo primo
tutore, il nonno paterno ʿAbd
al-Muttalib ibn Hāshim, e dove poi rimase anche col secondo suo tutore, lo zio
paterno Abu Tàlib - Maometto potrebbe forse aver avuto l'occasione di entrare in
contatto presto con quei hanīf, che il Corano vuole fossero monoteisti
che non si riferivano ad alcuna religione rivelata, come si può leggere nelle
sure III:67 e II:135. Secondo una tradizione islamica, egli stesso era un
hanīf e un discendente di Ismaele, figlio di Abramo. La storicità di questo
gruppo è comunque discussa fra gli studiosi. Nei suoi viaggi fatti in Siria e
Yemen con suo zio, Maometto potrebbe aver preso conoscenza dell'esistenza di
comunità ebraiche e cristiane e dell'incontro, che sarebbe avvenuto quando
Maometto aveva 9 o 12 anni, col monaco cristiano siriano Bahīra - che avrebbe
riconosciuto in un neo fra le sue scapole il segno del futuro carisma profetico
- si parla già nella prima biografia (Sīra) di Maometto, che fu curata,
vario tempo dopo la morte, da Ibn Isāq per essere poi ripresa in forma più "pia"
da Ibn Hishām. Oltre alla madre e alla nutrice, due altre donne si presero cura
di lui da bambino: Umm Ayman Baraka e Fātima bint Asad, moglie dello zio Abū
Tālib. La prima era la schiava etiopica della madre che lo aveva allevato dopo
il periodo trascorso presso con Halīma, rimanendo con lui fino a che Maometto ne
propiziò il matrimonio, dapprima con un medinese e poi col figlio adottivo Zayd.
Nella tradizione islamica Umm Ayman, che generò Usama ibn Zayd, fa parte della
Gente della Casa (Ahl al-Bayt) e il Profeta nutrì sempre per lei un vivo
affetto, anche per essere stata una delle prime donne a credere al messaggio
coranico da lui rivelato. Altrettanto importante fu l'affettuosa e presente sua
zia Fātima bint Asad, che Maometto amava per il suo carattere dolce, tanto da
mettere il suo nome a una delle proprie figlie e per la quale il futuro profeta
pregò spesso dopo la sua morte. I numerosi viaggi intrapresi per via
dell'attività mercantile familiare - dapprima con lo zio e poi come agente della
ricca e colta vedova Khadīja bt. Khuwaylid - dettero a Maometto occasione di
ampliare in maniera significativa le sue conoscenze in campo religioso e
sociale. Sposata nel 595 Khadìja bint Khuwàylid (che restò finché visse la sua
unica moglie), egli poté dedicarsi alle sue riflessioni spirituali in modo più
assiduo e, anzi, pressoché esclusivo. Khadìja fu il primo essere umano a credere
nella Rivelazione di cui Maometto era portatore e lo sostenne con forte
convinzione fino alla sua morte avvenuta nel 619. A lui, in una vita di coppia
senz'altro felice, dette quattro figlie - Zaynab, Ruqayya, Umm Khulthūm e Fāima,
detta al-Zahrāʾ
(tutte premorte al padre, salvo l'ultima) - oltre a due figli maschi (al-Qàsim e
ʿAbd
Allah) che morirono tuttavia in tenera età.
Rivelazione.
Nel 610 Maometto, affermando di operare in base a una Rivelazione
ricevuta, cominciò a predicare una religione monoteista basata sul culto
esclusivo di Dio, unico e indivisibile. In effetti il concetto di monoteismo era
diffuso in Arabia da tempi più antichi e il nome Allah (principale nome di Dio
nell'Islam) significa semplicemente "Iddio". Gli abitanti dell'Arabia
peninsulare e di Mecca - salvo pochi cristiani e zoroastriani e un assai più
consistente numero di ebrei - erano per lo più dediti a culti politeistici e
adoravano un gran numero di idoli. Questi dèi erano venerati anche in occasione
di feste, per lo più abbinate a pellegrinaggi (in arabo: mawsim).
Particolarmente rilevante era il pellegrinaggio panarabo, detto ajj, che
si svolgeva nel mese lunare di Dhu l-Hijja ("Quello del Pellegrinaggio"). In
tale occasione molti devoti arrivavano nei pressi della città, nella zona di
Mina, Muzdalifa e di ʿArafa.
Gli abitanti di Mecca avevano anche un loro proprio pellegrinaggio urbano (la
cosiddetta ʿumra)
che svolgevano nel mese di rajab in onore del dio tribale Hubal e delle altre
divinità panarabe, graziosamente ospitate dai Quraysh all'interno del santuario
meccano della Kaʿba.
Maometto, come altri anīf, era solito ritirarsi a meditare, secondo la
tradizione islamica, in una grotta sul monte Hira vicino Mecca. Secondo tale
tradizione, una notte, intorno all'anno 610, durante il mese di Ramadan, all'età
di circa quarant'anni, gli apparve l'arcangelo Gabriele (in arabo Jibrīl
o Jabrāʾīl,
ossia "potenza di Dio": da "jabr", potenza, e "Allah", Dio) che lo esortò a
diventare Messaggero (rasūl) di Allah con le seguenti parole: « (1)
Leggi, in nome del tuo Signore, che ha creato, (2) ha creato l'uomo da un grumo
di sangue! (3) Leggi! Ché il tuo Signore è il Generosissimo, (4) Colui che ha
insegnato l’uso del calamo, (5) ha insegnato all'uomo quello che non sapeva».
Turbato da un'esperienza così anomala, Maometto credette di essere stato
soggiogato dai jinn e quindi impazzito (majnūn, "impazzito",
significa letteralmente "catturato dai jinn") tanto che, scosso da
violenti tremori, cadde preda di un intenso sentimento di terrore. Secondo la
tradizione islamica Maometto poté in quella sua prima esperienza teopatica
sentire le rocce e gli alberi che gli parlavano. Preso dal panico fuggì a
precipizio dalla caverna in direzione della propria abitazione e nel girarsi
vide Gabriele sovrastare con le sue ali immense l'intero orizzonte (per quel
"gigantismo" che caratterizza le "realtà angeliche", anche in contesti diversi
da quello islamico) e lo sentì rivelargli di essere stato prescelto da Dio come
suo messaggero. Non gli fu facile accettare tale notizia ma a convincerlo della
realtà di quanto accadutogli, provvide innanzi tutti la fede della moglie e, in
seconda battuta, quella del cugino di lei, Waraqa ibn Nawfal, che alcuni
indicano come cristiano ma che, più verosimilmente, era uno di quei monoteisti
arabi (anīf) che non si riferivano tuttavia a una specifica struttura
religiosa organizzata. Dopo un lungo e angosciante periodo in cui le sue
esperienze non ebbero seguito (fatra), Gabriele tornò di nuovo a
parlargli per trasmettergli altri versetti e questo proseguì per 23 anni, fino
alla morte nel 632 di Maometto.
È ancora oggetto di disputa la
questione riguardante l'analfabetismo di Maometto. Si nota come la sua
professione di commerciante abbia potuto portarlo in contatto con altre lingue e
altre culture, e come sia intervenuto, secondo una tradizione riportata da
Tabari, per apportare una correzione riguardante la sua firma nel Trattato di
udaybiyya. Ci sarebbe poi una lettera autografa, conservata nel museo Topkapi di
Istanbul. Secondo alcuni, tutto deriverebbe da un equivoco riguardante
l'espressione a lui riferita di al-Nabī al-ummī che può voler dire in
effetti "il profeta ignorante" ma anche, e più verosimilmente, "il profeta della
comunità (araba)" o "il profeta di una cultura non basata su testi sacri
scritti". Altre fonti fanno notare come le personalità in grado di leggere e
scrivere, nel periodo precedente all'Egira, fossero una quindicina, tutte
conosciute per nome, e in effetti il Corano sarebbe il più antico libro arabo in
prosa. Studiosi occidentali fanno notare come le tribù nomadi, compresa quella
di Maometto, disprezzassero la scrittura, privilegiando la trasmissione orale
delle conoscenze. La maggior parte dei musulmani propende per un analfabetismo
del loro Profeta, escludendo pertanto radicalmente che egli abbia potuto leggere
la Bibbia o altri testi sacri, che del resto sarebbero comparsi in forma scritta
solo diverso tempo dopo la sua morte. Maometto cominciò dunque a predicare la
Rivelazione che gli trasmetteva Jibrīl, ma i convertiti nella sua città natale
furono pochissimi per i numerosi anni che egli ancora trascorse a Mecca. Fra
essi il suo amico intimo e coetaneo Abu Bakr (destinato a succedergli come
califfo, guida della comunità islamica che si fondò con lenta ma sicura
progressione malgrado l'assenza di precise indicazioni scritte e orali in
merito) e un gruppetto assai ristretto di persone che sarebbero stati i suoi più
validi collaboratori: i cosiddetti "Dieci Benedetti" (al-ʿashara
al-mubashshara).
La Rivelazione da lui espressa dunque - raccolta dopo la sua morte nel Corano,
il libro sacro dell'Islam - dimostrò la validità del detto evangelico per cui
"nessuno è profeta in patria". Maometto ripeté per ben due volte per intero il
Corano nei suoi ultimi due anni di vita e molti musulmani lo memorizzarono per
intero ma fu solo il terzo califfo ʿUthmān
b. ʿAffān
a farlo mettere per iscritto da una commissione coordinata da Zayd b. Thābit,
segretario del Profeta. Così il testo accettato del Corano poté diffondersi nel
mondo a seguito delle prime conquiste che portarono gli eserciti di Medina in
Africa, Asia ed Europa, rimanendo inalterato fino ad oggi, malgrado lo Sciismo
vi aggiunga un capitolo (Sura) e alcuni brevi versetti (ayat).
Gli ultimi anni a Mecca e
l'Egira. Nel
619, l'"anno del dolore", morirono tanto suo zio Abu Talib, che gli aveva
garantito affetto e protezione malgrado non si fosse convertito alla religione
del nipote, quanto l'amata Khadìja. Fu solo dopo ripetute insistenze che
Maometto contrasse nuove nozze, tra cui quelle con
ʿĀʾisha
bt. Abī Bakr, figlia del suo più intimo amico e collaboratore, Abu Bakr.
L'ostilità dei suoi concittadini tentò di esprimersi con un prolungato
boicottaggio nei confronti di Maometto e del suo clan, con il divieto di
intrattenere con costoro rapporti di tipo economico commerciale, i troppi
vincoli parentali creatisi però fra i clan della stessa tribù fecero fallire il
progetto di ridurre a più miti consigli Maometto. Nel 622 il crescente malumore
dei Quraysh nel veder danneggiati i propri interessi - a causa dell'inevitabile
conflitto ideologico e spirituale che si sarebbe radicato con gli altri arabi
politeisti (che con loro proficuamente commerciavano e che annualmente
partecipavano ai riti della ʿumra
del mese di rajab) - lo indusse a rifugiarsi con la sua settantina di
correligionari, a Yathrib, trecentoquaranta chilometri più a nord di Mecca, che
mutò presto il proprio nome in Madīnat al-Nabī, "la Città del Profeta" (Medina).
Il 622, l'anno dell'Egira (emigrazione), divenne poi sotto il califfo
'Omar ibn al-Khattàb il primo anno del calendario islamico, utile alla tenuta
dei registri fiscali e dell'amministrazione in genere.
La Umma e l'inizio
dei conflitti armati.
Inizialmente Maometto si ritenne un profeta inserito nel solco
profetico antico-testamentario, ma la comunità ebraica di Medina non lo accettò
come tale. Nonostante ciò, Maometto predicò a Medina per otto anni e qui, fin
dal suo primo anno di permanenza, formulò la Costituzione di Medina (Rescritto o
Statuto o Carta, in arabo aīfa) che fu accettata da tutte le componenti
della città-oasi e che vide il sorgere della Umma, la prima Comunità
politica di credenti. Nello stesso tempo, con i suoi seguaci, condusse attacchi
contro le carovane dei Meccani e respinse i loro contrattacchi. L'ostilità di
Maometto nei confronti dei suoi concittadini si concretizzò nel primo vittorioso
scontro armato ai pozzi di Badr, alla successiva disfatta di Uud e alla finale
vittoria strategica di Medina (Battaglia del Fossato) contro i politeisti
Quraysh che lo avevano inutilmente assediato.
L'atteggiamento verso gli
ebrei. In
tutte queste circostanze Maometto colpì in diversa misura anche gli ebrei di
Medina, che si erano resi colpevoli agli occhi della Umma della
violazione del Rescritto di Medina e di tradimento nei confronti della
componente islamica. In occasione dei due primi fatti d'armi furono esiliate le
tribù ebraiche dei Banū Qaynuqāʿ
e dei Banū Naīr, mentre dopo la vittoria nella cosiddetta "battaglia" del
Fossato (Yawm al-Khandaq), i musulmani decapitarono tra i 700 e i 900
uomini ebrei della tribù dei Banū Qurayza, arresasi ai seguaci del Profeta in
conseguenza del fallimento dell'assedio dei Quraysh e dei loro alleati arabi,
protrattosi per 25 giorni. Le loro donne e i loro bambini furono invece venduti
come schiavi sui mercati d'uomini di Siria e del Najd, dove vennero quasi tutti
riscattati dai loro correligionari di Khaybar, Fadak e di altre oasi arabe
higiazene. La cruenta decisione fu probabilmente la conseguenza dell’accusa di
intelligenza col nemico durante l’assedio ma la sentenza non fu decisa da
Maometto che invece affidò il responso sulla punizione da adottare a Saʿd
b. Muʿādh,
sayyid dei Banū ʿAbd
al-Ashhal, clan della tribù medinese dei Banu Aws e un tempo principale alleato
dei B. Quraya. Questi, ferito gravemente da una freccia (tanto da morirne
pochissimi giorni più tardi) e ovviamente pieno di rabbia e rancore, decise per
quella soluzione estrema, non frequente ma neppure del tutto inconsueta per
l'epoca. Che non si trattasse comunque di una decisione da leggere in chiave
esclusivamente anti-ebraica potrebbe dimostrarcelo il fatto che gli altri B.
Quraya che vivevano intorno a Medina, e nel resto del ijāz (circa 25.000
persone), non furono infastiditi dai musulmani, né allora, né in seguito. In
proposito si è anche espresso uno dei più apprezzati storici del primo Islam,
Fred McGrew Donner, che, nel suo Muhammad and the believers (Cambridge,
MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 2010, p. 74), afferma
« dobbiamo... concludere che gli scontri con altri ebrei o gruppi di ebrei
furono il risultato di particolari atteggiamenti o comportamenti politici di
costoro, come, per esempio, il rifiuto di accettare la leadership o il rango di
profeta di Muhammad. Questi episodi non possono pertanto essere considerati
prove di un'ostilità generalizzata nei confronti degli ebrei da parte del
movimento dei Credenti, così come non si può concludere che Muhammad nutrisse
un'ostilità generalizzata nei confronti dei Quraysh perché fece mettere a morte
e punì alcuni suoi persecutori appartenenti a questa tribù. (Fred M. Donner,
Maometto e le origini dell'islam, ediz. e trad. di R. Tottoli, Torino,
Einaudi, 2011, p. 76-77). » Una minoranza di studiosi musulmani rifiutano di
riconoscere l'incidente ritenendo che Ibn Ishaq, il primo biografo di Maometto,
abbia presumibilmente raccolto molti dettagli dello scontro dai discendenti
degli stessi ebrei Qurayza. Questi discendenti avrebbero arricchito o inventato
dettagli dell'incidente prendendo ispirazione dalla storia delle persecuzioni
ebraiche in epoca romana.
La conquista dell'Arabia e la
morte. Nel 630 Maometto era ormai abbastanza forte per marciare su Mecca
e conquistarla. Tornò peraltro a vivere a Medina e da qui ampliò la sua azione
politica e religiosa a tutto il resto del Hijaz e, dopo la sua vittoria nel 630
a unayn contro l'alleanza che s'imperniava sulla tribù dei Banū Hawāzin, con una
serie di operazioni militari nel cosiddetto Wadi al-qura, a 150 chilometri a
settentrione di Medina, conquistò o semplicemente assoggettò vari centri abitati
(spesso oasi), come Khaybar, Tabūk e Fadak, il cui controllo aveva indubbie
valenze economiche e strategiche.
Due anni dopo Maometto morì a
Medina, dopo aver compiuto il Pellegrinaggio detto anche il "Pellegrinaggio
dell'Addio", senza indicare esplicitamente chi dovesse succedergli alla guida
politica della Umma. Lasciava nove vedove - tra cui
ʿĀʾisha
bt. Abī Bakr - e una sola figlia vivente, Fāima, andata sposa al cugino del
profeta, ʿAlī
b. Abī ālib, madre dei suoi nipoti al-asan b.
ʿAlī
e al-usayn b. ʿAlī.
Fatima, piegata dal dolore della perdita del padre e logorata da una vita di
sofferenze e fatiche, morì sei mesi più tardi, diventando in breve una delle
figure più rappresentative e venerate della religione islamica.
Origine del nome. "Maometto" è
la volgarizzazione italiana fatta in età medievale del nome "Muhammad", utile
semplificazione della pronuncia. La parola araba "muhammad", che significa
"grandemente lodato", è infatti un participio passivo di II forma (intensiva)
della radice [h-m-d] (lodare). Secondo lo studioso francese Michel Masson],
invece, nelle lingue romanze, e tra queste l'italiano, si osserva una
storpiatura del nome del profeta in senso spregiativo (e da ciò deriverebbero, a
suo dire, il francese Mahomet e l'italiano Macometto). Allo stesso
modo si esprimono alcuni scrittori italiani che ritengono che il nome "Maometto"
non sarebbe di diretta origine araba, ma "un'italianizzazione" adottata
all'epoca per costituire una sintesi dell'espressione spregiativa di "Mal
Commetto", volta a conferire una connotazione negativa al Profeta dell'Islam.
Maometto secondo i non
musulmani. Dopo un protratto periodo di indifferenza nei confronti dell'Islam,
superficialmente equivocato dalla Cristianità occidentale e orientale, come una
delle tante eresie del Cristianesimo nelle dispute con cristiani, questi ultimi
sottolinearono sovente il carattere sincretistico della religione di Maometto,
basata allo stesso tempo su tradizioni arabe preislamiche (come il culto della
Pietra Nera della Mecca) e su tradizioni cristiane siriache ed ebraiche, e
mossero critiche alla personalità di Maometto, alla formazione e trasmissione
del testo coranico e alla diffusione dell'islam attraverso la spada.
Nell'Occidente medievale Maometto fu considerato per oltre cinque secoli un
cristiano eretico. Dante Alighieri - non consapevole del profondo grado di
diversità teologica della fede predicata da Maometto, per l'influenza su di lui
esercitata dal suo Maestro Brunetto Latini, che riteneva Maometto un chierico
cristiano di nome Pelagio, appartenente al casato romano dei Colonna - lo cita
nel canto XXVIII dell'Inferno tra i seminatori di scandalo e di scisma
nella Divina Commedia assieme ad Ali ibn Abi Tàlib, suo cugino-genero,
coerentemente con quanto da lui già scritto ai versetti 70-73 del canto VIII
dell'Inferno:« ...«Maestro, già le sue meschite / là entro certe ne la valle
cerno, / vermiglie come se di foco uscite / fossero... » in cui le "meschite"
(evidente deformazione della parola del volgare castigliano mezquita,
derivante dall'arabo masjid, che significa moschea) della città di Dite
sono le "vermiglie" abitazioni della città dannata ove dimorano gli eresiarchi
cristiani. È questo (e non altro) il motivo per cui nella basilica di San
Petronio a Bologna, in un celebre affresco, Maometto fu raffigurato all'inferno,
secondo la descrizione di Dante, con il ventre squarciato, come spaccata era la
comunità cristiana a causa dei suoi vari scismi. Il motivo per cui Dante lo
colloca tra i seminatori di discordie e non tra gli eresiarchi è probabilmente
dovuto a una leggenda medievale che parla di Maometto come vescovo e cardinale
cristiano, che poi avrebbe rinnegato la propria fede, deluso per non aver
raggiunto il papato o per altra ragione e avrebbe creato una nuova religione
«mescolando quella di Moisè con quella di Cristo». Secondo una tradizione
diffusa tra i musulmani, il Negus di Abissinia - che ospitò gli esiliati
musulmani quando Maometto era in vita - avrebbe attestato la sua fede in lui
come profeta di Dio.
Si può ridere di Dio?
Mentre il divino evoca risate, il demoniaco spande paura, scrive Paolo Pegoraro
su “Aleteia”. Ricordiamo tutti il monaco cieco che, ne
Il nome della rosa,
avvelena quanti si avvicinano al prezioso scritto nel quale Aristotele difende
la commedia e il riso. È vero che la tristezza intossica, meno che il Medioevo
sia stato un’epoca di cupa e triste penitenza. Eric Auerbach, nel suo immortale
studio
Mimesis,
ha documentato che la struttura portante della narrativa cristiana, a partire
dai Vangeli, è proprio la commedia… non la tragedia. E Dante, con la sua
Comedìa,
ne è la pietra miliare. Lo affianca il prologo che Francois Rabelais – frate
francescano (a suo modo), monaco benedettino (a suo modo), parroco diocesano (a
suo modo) – antepone al
Gargantua et Pantagruel:
«Altra cosa non può il mio cuore esprimere / vedendo il lutto che da voi
promana: / meglio è di risa che di pianti scrivere, / ché rider soprattutto è
cosa umana». Altrettanto si potrebbe dire per il suo predecessore padano, il
monaco, poi ex monaco, infine di nuovo monaco Teofilo Folengo. La tradizione del
grottesco e del caricaturale crebbe febbrilmente in Occidente: dalle deformi
statue gotiche alle pagine grottesche di Flannery O’Connor fino al caricaturale
Vangelo secondo
Biff di Christopher Moore. Per
contrapporsi e disgregare le istituzioni, si dirà. Fosse pure, il fatto è che la
tradizione comico-grottesca crebbe qui come non altrove. Prolificò qui un
umorismo religioso, dissacrante, talora perfino blasfemo. Nessuna sorpresa: le
barzellette più sconce vengono bisbigliate in sacrestia. Come si rapporta,
allora, Dio con il ridere? Il grande poeta irlandese Patrick Kavanagh espose il
suo pensiero in maniera convincente nella composizione
A View of God and the Devil
(Una visione di Dio e del Diavolo
– traduzione dell’autore).
* * *
Ho incontrato Dio Padre sulla
strada e gli aggettivi con cui vorrei descriverlo sono questi: divertente,
sperimentale, irresponsabile sulle frivolezze. Non era un uomo che vorrebbe
essere eletto al Consiglio né impressionerebbe un vescovo o un circolo di
artisti. Non era splendido, spaventoso o tremendo e neppure insignificante.
Questo era il mio Dio che fece l’erba e il sole e i ciottoli nei ruscelli in
aprile; questo era il Dio che ho incontrato in una vecchia cava colma di
denti-di-leone. Questo era il Dio che ho incontrato a Dublino mentre vagavo per
strade inconsapevoli. Questo era il Dio che covò sui campi erpicati di Rooney
accanto alla statale Carrick il giorno che i miei primi versi furono stampati io
lo conobbi e mai ebbi paura di morte o dannazione e seppi che la paura di Dio
era il principio della follia.
Il Diavolo anche il Diavolo ho
incontrato, e gli aggettivi con cui vorrei descriverlo sono questi: solenne,
noioso, conservatore. Era l’uomo che il mondo eleggerebbe al Consiglio, sarebbe
nella lista degli invitati al ricevimento di un vescovo, assomigliava a un
artista. Era il tizio che scrive di musica sui quotidiani andava in collera
quando qualcuno rideva; era grave su cose senza peso; dovevi fare attenzione al
suo complesso d’inferiorità perché era consapevole di non essere creativo.
* * *
Colpisce che il primo aggettivo scelto da Kavanagh
per descrivere il “suo” Dio sia proprio
amusing
(“divertente”) in opposizione a quel povero diavolo che «andava in collera
quando qualcuno rideva». Perché rideva proprio di lui, probabilmente, abituato a
prendersi “dannatamente” sul serio. Mentre il divino sa essere irresponsabile
«sulle frivolezze», il demoniaco è grave «su cose senza peso». Mentre il divino
evoca risate, il demoniaco spande paura. Mentre il divino umorismo ha mille
sfumature, la “dannata” serietà è monolitica e monotona. Il Dio di Kavanagh è un
Dio autoironico. Non è possibile deriderlo semplicemente perché è Lui il primo a
ridere di se stesso. Non si può ridere “di”
Dio semplicemente perché si può ridere soltanto “con”
Lui. Proprio perché così prolificamente creativo (egli “cova” i campi come una
chioccia) e fantasioso, non sorprenderebbe se fosse Lui in persona l’autore
delle migliori storielle su se stesso. Se il demoniaco rivela il proprio
«complesso d’inferiorità» irrigidendosi di continuo, nel vano tentativo di
nascondere la propria sterilità, per contro il sigillo della creatività senza
limiti è l’umiltà (umile,
yet not insignificant!).
E, fra tutte, l’autoironia è la forma di umiltà più bella. Perché l’autoironia è
una forma di umiltà così autentica che proprio non ci riesce, a prendersi sul
serio.
Chiunque sa ridere degli
altri, basta avere un granello d'intelligenza; ma per ridere con loro di se
stessi, occorre un'oncia di santità.
Divina Commedia. Dante
aveva già capito tutto: ecco dove e come aveva messo Maometto.
C'è una satira anti-Maometto più feroce di quella di Charlie Hebdo. Circola
liberamente in Europa e non solo da secoli. A scriverla fu uno dei più grandi
scrittori della storia dell'Occidente. E la si studia anche in tutte le scuole.
Mette il profeta musulmano e Alì, suo cugino, genero e successore come Califfo,
nientemeno che all'inferno, nel canto XXVIII dedicato ai seminatori di
discordia. Lui, l'anti-Maometto, è nientemeno che Dante e l'opera è la Divina
Commedia. In cui Maometto viene messo nella bolgia più "sozza" che si possa
immaginare, piena di corpi mutilati e orrendamente sfigurati. C'è che secondo le
convinzioni dell'epoca, condivise evidentemente da Dante, l'islam era il
risultato di uno scisma nell'ambito della cristianità: come riporta il Corriere
della Sera, il cardinale o monaco Maometto, amareggiato per non aver conseguito
il papato, avrebbe fondato una nuova dottrina. Per questo Dante lo immagina
nella nona bolgia, squarciato dal mento all'ano, "infin dove si trulla" (ovvero
dove si scorreggia). Alì con la faccia spaccata dal mento alla fronte. Questo
perchè, secondo Dante, i seminatori di discordia nell'aldilà erano condannati a
subire il contrappasso adeguato, soffrendo nel loro corpo le stesse mutilazioni
di cui sono stati artefici in vita.
Dante, Maometto e Charlie
Hebdo, scrive “Biuso”.
«Già veggia, per mezzul
perdere o lulla,
com’io vidi un, così non si
pertugia,
rotto dal mento infin dove si
trulla.
Tra le gambe pendevan le
minugia;
la corata pareva e ‘l tristo
sacco
che merda fa di quel che si
trangugia.
Mentre che tutto in lui veder
m’attacco,
guardommi e con le man
s’aperse il petto,
dicendo: ‘Or vedi com’ io mi
dilacco!”
vedi come storpiato è
Mäometto!’»
(Inferno, XXVIII,
22-31).
Così Dante Alighieri descrive
la figura ripugnante dello ‘scismatico’ Maometto, tagliato/squartato come lui
volle tagliare/squartare l’unità cristiana del Mediterraneo. Ancora una volta i
monoteismi confermano tutta la loro carica di violenza, gli uni contro gli
altri. Nel presente i più pericolosi e armati di tali monoteismi sono quello di
Israele e quello degli islamisti. Massacrare i redattori del giornale parigino
Charlie Hebdo perché hanno «offeso il Profeta» è semplicemente
ripugnante. E conferma ancora una volta tutta la violenza insita nell’Identità
senza Differenza, nell’Uno.
«Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione servile. Non avere
altri dèi di fronte a me. […] Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso,
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni
verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti» (Deuteronomio,
cap. 5, versetti 6-10).
«Allah testimonia, e con Lui
gli Angeli e i sapienti, che non c’è dio all’infuori di Lui, Colui Che realizza
la giustizia. Non c’è dio all’infuori di Lui, l’Eccelso, il Saggio». (Corano,
sura III, versetto 18).
«Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto. Non ha
generato, non è stato generato e nessuno è eguale a Lui» (Corano,
sura CXII, versetti 1-4).
«E i miscredenti che muoiono nella miscredenza,
saranno maledetti da Allah, dagli angeli e da tutti gli uomini. Rimarranno in
questo stato in eterno e il castigo non sarà loro alleviato, né avranno
attenuanti. Il vostro Dio è il Dio Unico, non c’è altro dio che Lui, il
Compassionevole, il Misericordioso» (Corano,
sura II, versetti 161-163).
Dante e l’Islam.
È ormai assodata
l’influenza di molte fonti musulmane sull’autore della Divina Commedia. Ma oggi,
turbati dalla violenza fondamentalista, tendiamo a dimenticare i rapporti
profondi tra la cultura araba e quella occidentale, scrive Umberto Eco su
“L’Espresso”. Nel 1919 Miguel Asín Palacios pubblicava un libro (“La escatologia
musulmana en la Divina Comedia”) che aveva fatto subito molto rumore. In
centinaia di pagine identificava analogie impressionanti tra il testo dantesco e
vari testi della tradizione islamica, in particolare le varie versioni del
viaggio notturno di Maometto all’inferno e al paradiso. Specie in Italia ne era
nata una polemica tra sostenitori di quella ricerca e difensori dell’originalità
di Dante. Si stava per celebrare il sesto centenario della morte del più
“italiano” dei poeti, e inoltre il mondo islamico era guardato piuttosto
dall’alto al basso in un clima di ambizioni coloniali e “civilizzatrici”: come
si poteva pensare che il genio italico fosse debitore delle tradizioni di
“extracomunitari” straccioni? Ricordo che alla fine degli anni Ottanta avevamo
organizzato a Bologna una serie di seminari sugli interpreti “deliranti” di
Dante, e quando ne era uscito un libro (“L’idea deforme”, a cura di Maria Pia
Pozzato) i vari saggi si occupavano di Gabriele Rossetti, Aroux, Valli, Guénon e
persino del buon Pascoli, tutti accomunati come interpreti eccessivi, o
paranoici, o stravaganti del divino poeta. E si era discusso se porre nella
schiera di questi eccentrici anche Asín Palacios. Ma si era deciso di non farlo
perché ormai tante ricerche successive avevano stabilito che Asín Palacios forse
era stato talora eccessivo ma non delirante. Ormai è assodato che Dante abbia
subito l’influenza di molte fonti musulmane. Il problema non è se lui le avesse
avvicinate direttamente ma come sarebbero potute pervenirgli. Si potrebbe
cominciare dalle molte visioni medievali, dove si raccontava di visite ai regni
dell’oltretomba. Sono la “Vita di san Maccario romano”, il “Viaggio di tre santi
monaci al paradiso terrestre”, la “Visione di Tugdalo”, sino alla leggenda del
pozzo di san Patrizio. Fonti occidentali, certo, ma ecco che Asín Palacios le
paragonava a tradizioni islamiche, mostrando che anche in quei casi i visionari
occidentali avevano appreso qualcosa dai visionari dell’altra sponda del
Mediterraneo. E dire che Asín Palacios non conosceva ancora quel “Libro della
Scala”, ritrovato negli anni Quaranta del secolo scorso, tradotto dall’arabo in
castigliano e poi in latino e antico francese. Poteva conoscere Dante questa
storia del viaggio nell’oltretomba del Profeta? Poteva averne avuto notizia
attraverso Brunetto Latini, suo maestro, e la versione latina del testo era
contenuta in una “Collectio toledana”, dove Pietro il Venerabile, abate di
Cluny, aveva fatto raccogliere testi arabi filosofici e scientifici - tutto
questo prima della nascita di Dante. E Maria Corti si era molto battuta per
riconoscer la presenza di queste fonti musulmane nell’opera dantesca. Chi oggi
voglia leggere qualcosa su almeno un resoconto della avventura oltremondana del
Profeta trova da Einaudi “Il viaggio notturno e l’ascensione del profeta”, con
una prefazione di Cesare Segre. Il riconoscere queste influenze non toglie nulla
alla grandezza di Dante, con buona pace degli antichi oppositori di Asín
Palacios. Tanti autori grandissimi hanno porto orecchio a tradizioni letterarie
precedenti (si pensi, tanto per fare un esempio all’Ariosto) e tuttavia hanno
poi concepito un’opera assolutamente originale. Ho rievocato queste polemiche e
queste scoperte perché ora l’editrice Luini ripubblica il libro di Asín
Palacios, con il titolo più accattivante di “Dante e l’Islam”, e riprende la
bella introduzione che Carlo Ossola ne aveva scritto per la traduzione del 1993.
Ha ancora senso leggere questo libro, dopo che tante ricerche successive gli
hanno in gran parte dato ragione? Lo ha, perché è scritto piacevolmente e
presenta una mole immensa di raffronti tra Dante e i suoi “precursori” arabi. E
lo ha ai giorni nostri quando, turbati dalle barbare follie del fondamentalismi
musulmani, si tende a dimenticare i rapporti che ci sono sempre stati tra la
cultura occidentale e la ricchissima e progredita cultura islamica dei secoli
passati.
Maometto prima di Dante
all'inferno.
Un viaggio miracoloso che precede e forse ispira la «Commedia».
Ma è solo apologetico, scrive Segre Cesare su “Il Corriere della Sera”. Nei suoi
ultimi dieci anni Maria Corti era tutta presa dal problema dei contatti
arabo-cristiani nella letteratura medievale. Punti di riferimento,
sostanzialmente due: il tema del viaggio di Ulisse oltre le colonne d'Ercole,
forse derivato da tradizioni arabe, e gli eventuali contatti fra la Commedia e
un testo musulmano, il Libro della Scala, che narrava il miracoloso viaggio
notturno di Maometto dalla Mecca a Gerusalemme e la sua successiva visita nei
regni oltramondani. Per i due protagonisti, Ulisse e Dante, l'obiettivo è il
mondo dei morti: sfiorato da Ulisse, attraversato da Dante. Le ricerche della
Corti diedero spunto ad articoli e conversazioni, dibattiti, interviste. Ci si
potrebbe stupire di tanto interesse per problemi che non trovarono del tutto le
soluzioni desiderate, ma davvero stimolante per il lettore era già la
possibilità di immergersi in problematiche di ricerca sempre più raffinate, che,
indipendentemente dalle auspicate conclusioni, attraversavano punti nodali della
cultura del Medioevo.Si sa che fra cultura musulmana e cultura occidentale
esisteva una notevole interrelazione, che l'intensa attività traduttoria rese
ancora più stretta. Si traduceva, naturalmente, dall'arabo al latino e alle
lingue romanze, e non viceversa. Tra le opere tradotte, c'è il cosiddetto Libro
della Scala: l'originale arabo è perduto, così come la sua prima versione
spagnola, opera di un medico ebreo legato al re di Castiglia Alfonso el Sabio,
ma rimangono due traduzioni, una latina e una francese, derivate dalla versione
spagnola e da ascrivere (sicuramente la prima, forse la seconda) a un notaio
toscano, Bonaventura da Siena, esule, dopo il 1260, presso Alfonso.Il Libro
della Scala è forse la traduzione dall'arabo che ha suscitato più interesse, ma
non tanto nel mondo medievale, quanto semmai presso i lettori moderni, e per una
ragione molto semplice: le sue vere o apparenti rassomiglianze con la Commedia.
Che Dante abbia conosciuto e imitato il popolare libro arabo?La prima curiosità
per l'opera si era manifestata dopo l'edizione del testo latino pubblicata da
Enrico Cerulli (1949): nella postfazione, Cerulli insisteva sul problema dei
rapporti tra Libro e Commedia, riferendosi ai concetti di plagio e di imitazione
(due concetti, sia detto per inciso, che ora noi trattiamo diversamente,
parlando piuttosto di intertestualità e interdiscorsività). Poi tutto si calmò,
almeno fino agli studi della Corti. Ora, una nuova edizione del Libro ci
consente di riprendere il discorso, alla luce anche di nuove scoperte e
prospettive. Il problema non è più analizzare le affinità, ma distinguere tra
ciò che accomuna le due opere perché elemento diffuso nella cultura del tempo, e
ciò che è stato trasposto di proposito dall'una all'altra narrazione. Si tenga
conto che nel Medioevo lo scambio d'invenzioni e d'immagini era frequentissimo,
anche tra gli apologeti delle tre fedi monoteistiche.La nuova edizione che ci
propone Anna Longoni, allieva della Corti (Il libro della Scala di Maometto,
Bur, pp. 368, ? 13), ha come pregio maggiore quello di offrirci un'edizione
filologica della versione (o riscrittura) latina, testimoniata da due
manoscritti, uno vaticano, dell'inizio del XIV secolo, e l'altro conservato alla
Biblioteca Nazionale di Parigi, affiancata da una precisa traduzione in italiano
moderno. Ma non vanno trascurati né l'Introduzione, molto informata, né, in
appendice, la ristampa del principale articolo della Corti su Dante e la cultura
islamica.In partenza, direi che gli elementi congiuntivi tra Libro e Commedia
sono soprattutto la strutturazione dei regni ultraterreni e la descrizione delle
pene dei dannati, mentre quello disgiuntivo è lo spirito completamente diverso
che anima le due opere. La Commedia ha finalità didattiche, filosofiche e
narrative, in fondo anche autocelebrative; il Libro della Scala è l'esaltazione
di Allah e della sua potenza, e la consacrazione di Maometto come profeta. In
più, la Commedia è primariamente un'opera d'arte, mentre il Libro della Scala è
opera eminentemente apologetica. Ma ciò che allontana la Scala dalla Commedia è
la diversissima tradizione che caratterizza le due opere. Perché i temi del
«viaggio notturno» e dell'«ascensione al cielo» di Maometto, di cui il Libro
della Scala presenta una redazione particolare, sono maturati attraverso il
tempo: concepiti già all'epoca di Maometto (VII secolo), sono stati rielaborati
precocemente (dice la tradizione) da Ibn'Abbas, cugino del Profeta, riscritti
nel IX secolo. E continuano tuttora a circolare, anche a livello popolare (in
proposito, si può leggere l'edizione del Viaggio di Ibn'Abbas a cura di Ida
Zilio-Grandi, Einaudi 2010). Della Commedia viceversa sappiamo tutto, o quasi,
dato che ci è noto chi l'ha scritta e quando. Nel tessuto dello stesso Libro è
evidente la bipartizione tra il «viaggio notturno» di Maometto per andare dalla
Mecca a Gerusalemme su una specie di ippogrifo, e il «Libro della scala», in
senso stretto, che prevede l'ascensione di Maometto, attraverso la scala di
Giacobbe, dall'inferno al paradiso, sino all'incontro con Allah. A un certo
punto le due parti sono state cucite assieme: si tenga conto che si tratta di
un'opera a tradizione orale, dunque aperta a qualunque contaminazione, anche se
va riconosciuto che il contenuto rimane in fondo unitario. Ma Dante come avrebbe
potuto conoscere il Libro della Scala? S'era inventata una favola ingegnosa,
senza prove: Brunetto Latini, ambasciatore dei guelfi fiorentini alla corte di
Alfonso el Sabio, una volta tornato a Firenze, avrebbe potuto riassumere al suo
discepolo Dante il Libro, o qualche sua parte. Ma oggi gli studi sull'islamismo
medievale sono molto più approfonditi, e sappiamo persino di vere scuole di
arabo, in Inghilterra, a Hereford, o nel Convento di Miramar a Maiorca, oltre
naturalmente alla scuola di Toledo. Il prodotto più consistente di questi
circoli di studiosi è la Collectio Toletana, un'antologia di testi arabi, tra
cui il Corano, tradotti in latino, e ampiamente diffusi nell'Europa medievale.
Anche la convinzione che in Italia il Libro fosse sconosciuto, già smentita dai
versi di Fazio degli Uberti, che nel Dittamondo (1336) cita un «Libro che Scala
ha nome» e riassume in qualche verso i costumi musulmani, è ora solennemente
confutata (2011) da Luciano Gargan, che ha trovato il Libro citato in un
catalogo bolognese del 1312, che elenca i libri di un frate domenicano,
Ugolino.Ma insomma Dante ha conosciuto o no il Libro della Scala? Tutti i
critici, anche la Corti e la Longoni, hanno cercato, con equilibrio, le prove
più consistenti. Certo, Dante, come tutti i grandi, è capace di trovare spunti e
suggerimenti ovunque, e può aver raccattato qualcosa anche da lì. Però bisogna
rendersi conto delle sue prospettive e delle sue presupposizioni culturali. Cosa
poteva trovare in un libro nettamente popolare, dove il gusto dell'iperbole
(«misura in lunghezza quanto potrebbe percorrere un uomo in cinquecento anni»;
«ognuno di questi serpenti ha in bocca diciottomila denti, ciascuno dei quali è
grande tanto quanto una di quelle piante chiamate palme») si mescola con quello
dei colori, sicché Maometto avanza tra quinte di veli colorati? C'è qualche
scena grandiosa, ma l'unico sentimento che suscita è lo stupore. Noi siamo
vittime del gusto moderno per il primitivo, e abbiamo tutto il diritto di
accostare il Libro della Scala alla Commedia. Ma quanto a metterli sullo stesso
piano, a qualcuno è lecito essere riluttante.
«Dante antisemita e
islamofobo. La Divina Commedia va tolta dai programmi scolastici».
L'accusa
di Gherush92 organizzazione di ricercatori consulente dell'Onu, scrive “Il
Corriere della Sera”. in alternativa alcune parti del capolavoro andrebbero
espunte dal testo. La Divina Commedia deve essere tolta dai programmi
scolastici: troppi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La
sorprendente richiesta arriva da «Gherush92», organizzazione di ricercatori e
professionisti che gode dello status di consulente speciale con il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite e che svolge progetti di educazione allo
sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti.
ANTISEMITISMO
- «La Divina Commedia - spiega all'Adnkronos Valentina Sereni, presidente di
Gherush92 - pilastro della letteratura italiana e pietra miliare della
formazione degli studenti italiani presenta contenuti offensivi e discriminatori
sia nel lessico che nella sostanza e viene proposta senza che via sia alcun
filtro o che vengano fornite considerazioni critiche rispetto all'antisemitismo
e al razzismo». Sotto la lente di ingrandimento in particolare i canti XXXIV,
XXIII, XXVIII, XIV. Il canto XXXIV, spiega l'organizzazione, è una tappa
obbligata di studio. Il personaggio e il termine Giuda e giudeo sono parte
integrante della cultura cristiana: «Giuda per antonomasia è persona falsa,
traditore (da Giuda, nome dell'apostolo che tradì Gesù)»; «giudeo è termine
comune dispregiativo secondo un antico pregiudizio antisemita che indica chi è
avido di denaro, usuraio, persona infida, traditore» (così scrive De Mauro, Il
dizionario della lingua italiana). Il significato negativo di giudeo è poi
esteso a tutto il popolo ebraico. Il Giuda dantesco è la rappresentazione del
Giuda dei Vangeli, fonte dell'antisemitismo. «Studiando la Divina Commedia -
sostiene Gherush92 - i giovani sono costretti, senza filtri e spiegazioni, ad
apprezzare un'opera che calunnia il popolo ebraico, imparano a convalidarne il
messaggio di condanna antisemita, reiterato ancora oggi nelle messe, nelle
omelie, nei sermoni e nelle prediche e costato al popolo ebraico dolori e
lutti». E ancora, prosegue l'organizzazione, «nel canto XXIII Dante punisce il
Sinedrio che, secondo i cristiani, complottò contro Gesù; i cospiratori, Caifas
sommo sacerdote, Anna e i Farisei, subiscono tutti la stessa pena, diversa però
da quella del resto degli ipocriti: per contrappasso Caifas è nudo e crocefisso
a terra, in modo che ogni altro dannato fra gli ipocriti lo calpesti».
MAOMETTO
- Ma attenzione. Il capolavoro di Dante conterrebbe anche accenti islamofobici.
«Nel canto XXVIII dell'Inferno - spiega ancora Sereni - Dante descrive le
orrende pene che soffrono i seminatori di discordie, cioè coloro che in vita
hanno operato lacerazioni politiche, religiose e familiari. Maometto è
rappresentato come uno scismatico e l'Islam come una eresia. Al Profeta è
riservata una pena atroce: il suo corpo è spaccato dal mento al deretano in modo
che le budella gli pendono dalle gambe, immagine che insulta la cultura
islamica. Alì, successore di Maometto, invece, ha la testa spaccata dal mento ai
capelli. L'offesa - aggiunge - è resa più evidente perchè il corpo "rotto" e
"storpiato" di Maometto è paragonato ad una botte rotta, oggetto che contiene il
vino, interdetto dalla tradizione islamica. Nella descrizione di Maometto
vengono impiegati termini volgari e immagini raccapriccianti tanto che nella
traduzione in arabo della Commedia del filologo Hassan Osman sono stati omessi i
versi considerati un'offesa».
OMOSESSUALI
- Anche gli omosessuali, nel linguaggio dantesco i sodomiti, sarebbero messi
all'indice nel poema dell'Alighieri. Coloro che ebbero rapporti «contro natura»,
sono infatti puniti nell'Inferno: i sodomiti, i peccatori più numerosi del
girone, sono descritti mentre corrono sotto una pioggia di fuoco, condannati a
non fermarsi. Nel Purgatorio i sodomiti riappaiono, nel canto XXVI, insieme ai
lussuriosi eterosessuali. «Non invochiamo nè censure nè roghi - precisa Sereni -
ma vorremmo che si riconoscesse, in maniera chiara e senza ambiguità che nella
Commedia vi sono contenuti razzisti, islamofobici e antisemiti. L'arte non può
essere al di sopra di qualsiasi giudizio critico. L'arte è fatta di forma e di
contenuto e anche ammettendo che nella Commedia esistano diversi livelli di
interpretazione, simbolico, metaforico, iconografico, estetico, ciò non
autorizza a rimuovere il significato testuale dell'opera, il cui contenuto
denigratorio è evidente e contribuisce, oggi come ieri, a diffondere false
accuse costate nei secoli milioni e milioni di morti. Persecuzioni,
discriminazioni, espulsioni, roghi hanno subito da parte dei cristiani ebrei,
omosessuali, mori, popoli infedeli, eretici e pagani, gli stessi che Dante
colloca nei gironi dell'inferno e del purgatorio. Questo è razzismo che letture
simboliche, metaforiche ed estetiche dell'opera, evidentemente, non rimuovono».
CRIMINI
- «Oggi - conclude Sereni - il razzismo è considerato un crimine ed esistono
leggi e convenzioni internazionali che tutelano la diversità culturale e
preservano dalla discriminazione, dall'odio o dalla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, e a queste bisogna riferirsi; quindi
questi contenuti, se insegnati nelle scuole o declamati in pubblico,
contravvengono a queste leggi, soprattutto se in presenza di una delle categorie
discriminate. È nostro dovere segnalare alle autoritá competenti, anche
giudiziarie, che la Commedia presenta contenuti offensivi e razzisti che vanno
approfonditi e conosciuti. Chiediamo, quindi, di espungere la Divina Commedia
dai programmi scolastici ministeriali o, almeno, di inserire i necessari
commenti e chiarimenti». Certo c'è da chiederci cosa succederebbe se il criterio
proposto da «Gherush92» venisse applicato ai grandi autori della letteratura. In
Gran Bretagna vedremmo censurato «Il mercante di Venezia» di Shakespeare? O
alcuni dei racconti di Chaucer? Certo è che il tema del politicamente corretto
finisce sempre più per invadere sfere distanti dalla politica vera e propria.
Così il Corriere in un articolo del 1996 racconta come, al momento di scegliere
personaggi celebri per adornare le future banconote dell'euro, Shakespeare fu
scartato perchè potenzialmente antisemita Mozart perché massone, Leonardo Da
Vinci perché omosessuale. Alla fine si decise per mettere sulle banconote
immagini di ponti almeno loro non accusabili di nulla.
Dante "razzista", follia
Onu: bandire Divina Commedia.
L'associazione Gherush92, consulente delle Nazioni Unite: "Offende ebrei,
musulmani, gay. Non va studiata a scuola", scrive
di Caterina Maniaci su “Libero
Quotidiano”. L’hanno
recitata a migliaia, ovunque nel mondo; l’hanno citata, letta, studiata,
commentata in milioni di volumi e per intere generazioni. È persino diventata
una sorta di fenomeno sociale, dopo che Vittorio Sermonti prima e Roberto
Benigni poi l’hanno declamata a un pubblico sempre più numeroso, fino ad
approdare in tv. Ma nessuno, fino a oggi, si era mai immaginato di poter parlare
della Divina Commedia in questi termini: ossia come un’opera piena di luoghi
comuni, frasi offensive, razziste, islamofobiche e antisemite che difficilmente
possono essere comprese e che raramente vengono evidenziate e spiegate nel modo
corretto. Definisce così il contenuto di numerose terzine dantesche “Gherush92”,
organizzazione di ricercatori e professionisti che gode dello status di
consulente speciale per il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e
che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei
conflitti, razzismo, antisemitismo, islamofobia. E proprio secondo questa
organizzazione il poema di Dante andrebbe eliminato dai programmi scolastici o,
quanto meno, letto con le dovute accortezze. Sotto la lente censoria sono
finiti, in particolare, i canti dell’Inferno XIV, XXIII, XXVIII e XXXIV. Il
canto XXXIV, spiega l’organizzazione, è una tappa obbligata di studio. Il
personaggio e il termine Giuda e giudeo sono parte integrante della cultura
cristiana: «Giuda per antonomasia è persona falsa, traditore (da Giuda, nome
dell’apostolo che tradì Gesù)»; «giudeo è termine comune dispregiativo secondo
un antico pregiudizio antisemita che indica chi è avido di denaro, usuraio,
persona infida, traditore». Il significato negativo di giudeo è esteso a tutto
il popolo ebraico. Il Giuda dantesco è la rappresentazione del Giuda dei
Vangeli, fonte dell’antisemitismo. E ancora, prosegue l’organizzazione, «nel
canto XXIII Dante punisce il Sinedrio che, secondo i cristiani, complottò contro
Gesù; i cospiratori, Caifas sommo sacerdote, Anna e i Farisei, subiscono tutti
la stessa pena, diversa però da quella del resto degli ipocriti: per
contrappasso Caifas è nudo e crocefisso a terra, in modo che ogni altro dannato
fra gli ipocriti lo calpesti». Il poema, spiega Valentina Sereni, presidente
di Gherush92, «pilastro della letteratura italiana e pietra miliare della
formazione degli studenti italiani, presenta contenuti offensivi e
discriminatori sia nel lessico che nella sostanza e viene proposto senza che via
sia alcun filtro o che vengano fornite considerazioni critiche rispetto
all’antisemitismo e al razzismo». Spiega ancora Sereni: «Nel canto XXVIII
dell’Inferno Dante descrive le orrende pene che soffrono i seminatori di
discordie, cioè coloro che in vita hanno operato lacerazioni politiche,
religiose e familiari. Maometto è rappresentato come uno scismatico e l’Islam
come un’eresia. Al Profeta è riservata una pena atroce: il suo corpo è spaccato
dal mento al deretano, in modo che le budella gli pendono dalle gambe, immagine
che insulta la cultura islamica. Alì, successore di Maometto, invece, ha la
testa spaccata dal mento ai capelli». «L’offesa», aggiunge, «è resa più evidente
perché il corpo “rotto” e “storpiato” di Maometto è paragonato ad una botte
rotta, oggetto che contiene il vino, interdetto dalla tradizione islamica. Nella
descrizione di Maometto vengono impiegati termini volgari e immagini
raccapriccianti tanto che nella traduzione in arabo della Commedia del filologo
Hassan Osman sono stati omessi i versi considerati un’offesa». La stessa
Sereni, da noi ricontattata, ci spiega che lo studio sulla Divina Commedia è
stato eseguito dai ricercatori di Gherush92 «dopo alcuni mesi di riflessione».
Il gruppo «si finanzia con le quote dei soci iscritti». Alla domanda se esistono
nuovi studi su altre opere letterarie, risponde: «Ci stiamo lavorando e più
avanti saranno diffusi». Nessun timore che, utilizzando simili criteri di
analisi, tutta la letteratura italiana delle origini possa essere considerata
razzista, omofoba e antisemita? «Non è colpa nostra se ci sono opere d’arte
italiane eventualmente razziste», ribadisce la Sereni, perché «è l’insegnamento
della Divina Commedia che deve essere contestualizzato e siccome viene insegnata
e proclamata oggi, il contesto è oggi. Oggi possiamo e dobbiamo fare queste
osservazioni sul razzismo nella Divina Commedia e in altre opere d’arte. D’altra
parte il razzismo contro le stesse entità esisteva tanto allora quanto oggi».
Tutto chiaro e preciso. Ma pur essendo Gherush92 consulente dell’Onu, status di
tutto rispetto e cosa che non è concessa proprio a tutte le organizzazioni, la
sede a Roma, segnalata nel sito dell’United Nations Department of Economic and
Social Affairs, è inesistente: a quell’indirizzo non risulta nessuna
organizzazione. Lo abbiamo scoperto personalmente. Una zona di quasi campagna,
nella periferia nord della Capitale, tra villette e piccoli capannoni aziendali.
Il numero civico non corrisponde, anzi non esiste. Chiediamo in giro.
«Associazione Gherush92? Mai sentita, qui non c’è», risponde una ragazza che
esce da un cancello. In effetti, ci viene confermato dalla stessa associazione
che quell’indirizzo non è valido e non ce n’è un altro cui fare riferimento...
Il nemico che trattiamo da amico.
(Questo
articolo fu pubblicato sul Corriere della Sera il 16 luglio 2005).
All’indomani dell’attentato terroristico di matrice islamica che ha insanguinato
la redazione parigina del settimanale satirico Charlie Hebdo, si inseriscono nel
dibattito pubblico di queste ore, le riflessioni di Oriana Fallaci sul rapporto
tra Islam e Occidente. L’articolo fu scritto dopo la strage alla metropolitana
di Londra del 7 luglio 2005
da
Oriana Fallaci.
Ora mi chiedono: «Che cosa
dice, che cosa ha da dire, su quello che è successo a Londra?». Me lo chiedono a
voce, per fax, per email, spesso rimproverandomi perché finoggi sono rimasta
zitta. Quasi che il mio silenzio fosse stato un tradimento. E ogni volta scuoto
la testa, mormoro a me stessa: cos' altro devo dire?!? Sono quattr'anni che
dico. Che mi scaglio contro il Mostro deciso ad eliminarci fisicamente e insieme
ai nostri corpi distruggere i nostri principii e i nostri valori. La nostra
civiltà. Sono quattr' anni che parlo di nazismo islamico, di guerra all'
Occidente, di culto della morte, di suicidio dell' Europa. Un' Europa che non è
più Europa ma Eurabia e che con la sua mollezza, la sua inerzia, la sua cecità,
il suo asservimento al nemico si sta scavando la propria tomba. Sono quattr'
anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare «Troia brucia, Troia brucia» e mi
dispero sui Danai che come nell' Eneide di Virgilio dilagano per la città
sepolta nel torpore. Che attraverso le porte spalancate accolgono le nuove
truppe e si uniscono ai complici drappelli. Quattr' anni che ripeto al vento la
verità sul Mostro e sui complici del Mostro cioè sui collaborazionisti che in
buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Che come nell' Apocalisse dell'
evangelista Giovanni si gettano ai suoi piedi e si lasciano imprimere il marchio
della vergogna.
Incominciai con «La
Rabbia e l'Orgoglio». Continuai
con «La Forza della Ragione». Proseguii con «Oriana Fallaci intervista sé
stessa» e con «L' Apocalisse». E tra l'uno e l'altro la predica «Sveglia,
Occidente, sveglia». I libri, le idee, per cui in Francia mi processarono nel
2002 con l'accusa di razzismo-religioso e xenofobia. Per cui in Svizzera
chiesero al nostro ministro della Giustizia la mia estradizione in manette. Per
cui in Italia verrò processata con l'accusa di vilipendio all'Islam cioè reato
di opinione. (Reato che prevede tre anni di galera, quanti non ne riceve
l'islamico sorpreso con l'esplosivo in cantina). Libri, idee, per cui la
Sinistra al Caviale e la Destra al Fois Gras ed anche il Centro al Prosciutto mi
hanno denigrata vilipesa messa alla gogna insieme a coloro che la pensano come
me. Cioè insieme al popolo savio e indifeso che nei loro salotti viene definito
dai radical-chic «plebaglia di destra». Sì, è vero: sui giornali che nel
migliore dei casi mi opponevano farisaicamente la congiura del silenzio ora
appaiono titoli composti coi miei concetti e le mie parole. Guerra
all'Occidente, Culto della Morte, Suicidio dell'Europa, Sveglia Italia Sveglia.
Sì, è vero: sia pur senza ammettere che non avevo torto l'ex segretario della
Quercia ora concede interviste nelle quali dichiara che questi terroristi
vogliono distruggere i nostri valori, che questo stragismo è di tipo fascista ed
esprime odio per la nostra civiltà».
Sì, è vero: parlando
di Londonistan, il quartiere
dove vivono i ben settecentomila musulmani di Londra, i giornali che prima
sostenevano i terroristi fino all'apologia di reato ora dicono ciò che dicevo io
quando scrivevo che in ciascuna delle nostre città esiste un'altra città. Una
città sotterranea, uguale alla Beirut invasa da Arafat negli anni Settanta. Una
città straniera che parla la propria lingua e osserva i propri costumi, una
città musulmana dove i terroristi circolano indisturbati e indisturbati
organizzano la nostra morte. Del resto ora si parla apertamente anche di
terrorismo-islamico, cosa che prima veniva evitata con cura onde non offendere i
cosiddetti musulmani moderati. Sì, è vero: ora anche i collaborazionisti e gli
imam esprimono le loro ipocrite condanne, le loro mendaci esecrazioni, la loro
falsa solidarietà coi parenti delle vittime. Si, è vero: ora si fanno severe
perquisizioni nelle case dei musulmani indagati, si arrestano i sospettati,
magari ci si decide ad espellerli. Ma in sostanza non è cambiato nulla. Nulla.
Dall'antiamericanismo all'antioccidentalismo al filoislamismo, tutto continua
come prima. Persino in Inghilterra. Sabato 9 luglio cioè due giorni dopo la
strage la BBC ha deciso di non usare più il termine «terroristi», termine che
esaspera i toni della Crociata, ed ha scelto il vocabolo «bombers». Bombardieri,
bombaroli. Lunedì 11 luglio cioé quattro giorni dopo la strage il Times ha
pubblicato nella pagina dei commenti la vignetta più disonesta ed ingiusta ch'io
abbia mai visto. Quella dove accanto a un kamikaze con la bomba si vede un
generale anglo-americano con un' identica bomba. Identica nella forma e nella
misura. Sulla bomba, la scritta: «Killer indiscriminato e diretto ai centri
urbani». Sulla vignetta, il titolo: «Spot the difference, cerca la differenza».
Quasi
contemporaneamente, alla televisione americana
ho visto una giornalista del Guardian, il quotidiano dell' estrema sinistra
inglese, che assolveva l'apologia di reato manifestata anche stavolta dai
giornali musulmani di Londra. E che in pratica attribuiva la colpa di tutto a
Bush. Il criminale, il più grande criminale della Storia, George W. Bush.
«Bisogna capirli». Cinguettava «la politica americana li ha esasperati. Se non
ci fosse stata la guerra in Iraq...». (Giovanotta, l'11 settembre la guerra in
Iraq non c'era. L'11 settembre la guerra ce l'hanno dichiarata loro. Se n'è
dimenticata?). E contemporaneamente ho letto su Repubblica un articolo dove si
sosteneva che l'attacco alla subway di Londra non è stato un attacco
all'Occidente. E' stato un attacco che i figli di Allah hanno fatto contro i
propri fantasmi. Contro l'Islam «lussurioso» (suppongo che voglia dire
«occidentalizzato») e il cristianesimo «secolarizzato». Contro i pacifisti indù
e la magnifica varietà che Allah ha creato. Infatti, spiegava, in Inghilterra i
musulmani sono due milioni e nella metropolitana di Londra non trovi un inglese
nemmeno a pagarlo oro. Tutti in turbante, tutti in kefiah. Tutti con la barba
lunga e il djellabah. Se ci trovi una bionda con gli occhi azzurri è una
circassa». (Davvero?!? Chi l' avrebbe mai detto!!! Nelle fotografie dei feriti
non scorgo né turbanti né kefiah, né barbe lunghe né djellabah. E nemmeno burka
e chador. Vedo soltanto inglesi come gli inglesi che nella Seconda Guerra
Mondiale morivano sotto i bombardamenti nazisti. E leggendo i nomi dei dispersi
vedo tutti Phil Russell, Adrian Johnson, Miriam Hyman, più qualche tedesco o
italiano o giapponese. Di nomi arabi, finoggi, ho visto soltanto quello di una
giovane donna che si chiamava Shahara Akter Islam).
Continua anche la
fandonia dell'Islam «moderato»,
la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del
pluriculturalismo. Vale a dire delle moschee che esigono e che noi gli
costruiamo. Nel corso d' un dibattito sul terrorismo, al consiglio comunale di
Firenze lunedì 11 luglio il capogruppo diessino ha dichiarato: «E' ora che anche
a Firenze ci sia una moschea». Poi ha detto che la comunità islamica ha
esternato da tempo la volontà di costruire una moschea e un centro culturale
islamico simili alla moschea e al centro culturale islamico che sorgeranno nella
diessina Colle val d'Elsa. Provincia della diessina Siena e del suo
filo-diessino Monte dei Paschi, già la banca del Pci e ora dei Ds. Bé, quasi
nessuno si è opposto. Il capogruppo della Margherita si è detto addirittura
favorevole. Quasi tutti hanno applaudito la proposta di contribuire all' impresa
coi soldi del municipio cioé dei cittadini, e l'assessore all'urbanistica ha
aggiunto che da un punto di vista urbanistico non ci sono problemi. «Niente di
più facile». Episodio dal quale deduci che la città di Dante e Michelangelo e
Leonardo, la culla dell' arte e della cultura rinascimentale, sarà presto
deturpata e ridicolizzata dalla sua Mecca. Peggio ancora: continua la Political
Correctness dei magistrati sempre pronti a mandare in galera me e intanto ad
assolvere i figli di Allah. A vietarne l' espulsione, ad annullarne le (rare)
condanne pesanti, nonché a tormentare i carabinieri o i poliziotti che con loro
gran dispiacere li arrestano. Milano, pomeriggio dell' 8 luglio cioé il giorno
dopo la strage di Londra. Il quarantaduenne Mohammed Siliman Sabri Saadi,
egiziano e clandestino, viene colto senza biglietto sull' autobus della linea
54. Per effettuare la multa i due controllori lo fanno scendere e scendono con
lui. Gli chiedono un documento, lui reagisce ingaggiando una colluttazione. Ne
ferisce uno che finirà all'ospedale, scappa perdendo il passaporto, ma la
Volante lo ritrova e lo blocca. Nonostante le sue resistenze, dinanzi a una
piccola folla lo ammanetta e nello stesso momento ecco passare una signora che
tutta stizzita vuole essere ascoltata come testimone se il poverino verrà
processato ed accusato di resistenza. I poliziotti le rispondono signora ci
lasci lavorare, e allora lei allunga una carta di identità dalla quale risulta
che è un magistrato. Sicché un po' imbarazzati ne prendono atto poi portano
Mohammed in questura e qui... Bé, invece di portarlo al centro di permanenza
temporanea dove (anziché in galera) si mettono i clandestini, lo lasciano andare
invitandolo a presentarsi la prossima settimana al processo cui dovrà sottoporsi
per resistenza all' arresto e lesioni a pubblico ufficiale. Lui se ne va,
scompare (lo vedremo mai più?) e indovina chi è la signora tutta stizzita perché
lo avevano ammanettato come vuole la prassi.
La magistrata che
sette mesi fa ebbe il suo piccolo
momento di celebrità per aver assolto con formula piena tre musulmani accusati
di terrorismo internazionale e per aver aggiunto che in Iraq non c'è il
terrorismo, c'è la guerriglia, che insomma i tagliateste sono Resistenti. Sì,
proprio quella che il vivace leghista Borghezio definì «una vergogna per Milano
e per la magistratura». E indovina chi anche oggi la loda, la difende, dichiara
ha fatto benissimo. I diessini, i comunisti, e i soliti verdi. Continua anche la
panzana che l'Islam è una religione di pace, che il Corano predica la
misericordia e l'amore e la pietà. Come se Maometto fosse venuto al mondo con un
ramoscello d'ulivo in bocca e fosse morto crocifisso insieme a Gesù. Come se non
fosse stato anche lui un tagliateste e anziché orde di soldati con le scimitarre
ci avesse lasciato san Matteo e san Marco e san Luca e san Giovanni intenti a
scrivere gli Evangeli. Continua anche la frottola dell' Islam vittima
dell'Occidente. Come se per quattordici secoli i musulmani non avessero mai
torto un capello a nessuno e la Spagna e la Sicilia e il Nord Africa e la Grecia
e i Balcani e l'Europa orientale su su fino all' Ucraina e alla Russia le avesse
occupate la mia bisnonna valdese. Come se ad arrivare fino a Vienna e a metterla
sotto assedio fossero state le suore di sant'Ambrogio e le monache Benedettine.
Continua anche la frode o l'illusione dell'Islam Moderato. Con questa, il
tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un' esigua minoranza e
che quella esigua minoranza vive in paesi lontani.
Bé, il nemico non è
affatto un'esigua minoranza.
E ce l'abbiamo in casa. Ce l'avevamo in casa l'11 settembre del 2001 cioé a New
York. Ce l'avevamo in casa l'11 marzo del 2004 cioé a Madrid. Ce l' avevamo in
casa l'1, il 2, il 3 settembre del medesimo anno a Beslan dove si divertirono
anche a fare il tiro a segno sui bambini che dalla scuola fuggivano
terrorizzati, e di bambini ne uccisero centocinquanta. Ce l'avevamo in casa il 7
luglio scorso cioé a Londra dove i kamikaze identificati erano nati e cresciuti.
Dove avevano studiato finalmente qualcosa, erano vissuti finalmente in un mondo
civile, e dove fino alla sera precedente s'eran divertiti con le partite di
calcio o di cricket. Ce l'abbiamo in casa da oltre trent'anni, perdio. Ed è un
nemico che a colpo d'occhio non sembra un nemico. Senza la barba, vestito
all'occidentale, e secondo i suoi complici in buona o in malafede perfettamente
inserito nel nostro sistema sociale. Cioé col permesso di soggiorno. Con
l'automobile. Con la famiglia. E pazienza se la famiglia è spesso composta da
due o tre mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di botte, pazienza
se non di rado uccide la figlia in blue jeans, pazienza se ogni tanto suo figlio
stupra la quindicenne bolognese che col fidanzato passeggia nel parco. E' un
nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia ci odia e ci disprezza con
intensità. Tale intensità che verrebbe spontaneo gridargli: se siamo così
brutti, così cattivi, così peccaminosi, perché non te ne torni a casa tua?
Perché stai qui? Per tagliarci la gola o farci saltare in aria? Un nemico,
inoltre, che in nome dell' umanitarismo e dell' asilo politico (ma quale asilo
politico, quali motivi politici?) accogliamo a migliaia per volta anche se i
Centri di Accoglienza straripano, scoppiano, e non si sa più dove metterlo. Un
nemico che in nome della «necessità» (ma quale necessità, la necessità di
riempire le strade coi venditori ambulanti e gli spacciatori di droga?)
invitiamo anche attraverso l'Olimpo Costituzionale. «Venite, cari, venite.
Abbiamo tanto bisogno di voi». Un nemico che per partorire non ha bisogno della
procreazione assistita, delle cellule staminali. Il suo tasso di natalità è così
alto che secondo il National Intelligence Council alla fine di quest'anno la
popolazione musulmana in Eurabia risulterà raddoppiata. Un nemico che le moschee
le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento
per i terroristi, e che obbedisce ciecamente all' imam (però guai se arresti
l'imam.
Peggio ancora, se
qualche agente della Cia te lo toglie
dai piedi col tacito consenso dei nostri servizi segreti). Un nemico che in
virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen scorrazza a suo
piacimento per l'Eurabia sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Colonia a
Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Può essere un terrorista
che si sposta per organizzare o materializzare un massacro, può avere addosso
tutto l' esplosivo che vuole: nessuno lo ferma, nessuno lo tocca. (Ma quando in
seguito alla strage di Londra la Francia denuncia il trattato di Schengen e
perfino la Spagna zapatera pensa di imitarla, l'Italia e gli altri paesi europei
rispondono scandalizzati no no). Un nemico che appena installato nelle nostre
città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l' alloggio
gratuito o semi-gratuito nonché il voto e la cittadinanza. Tutte cose che
ottiene senza difficoltà. Un nemico che protetto dalla Sinistra al Caviale e
dalla Destra al Fois Gras e dal Centro al Prosciutto ciancia, appunto, di
integrazione e pluriculturalismo ma intanto ci impone le proprie regole e i
propri costumi. Che bandisce il maiale dalle mense delle scuole, delle
fabbriche, delle prigioni. Che aggredisce la maestra o la preside perché una
scolara bene educata ha gentilmente offerto al compagno di classe musulmano la
frittella di riso al marsala cioé «col liquore». E attenta a non ripeter
l'oltraggio. Un nemico che negli asili vuole abolire anzi abolisce il Presepe e
Babbo Natale. Che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù
dalle finestre degli ospedali, lo definisce «un cadaverino ignudo e messo lì per
spaventare i bambini musulmani». (Parlo, s'intende, dell' arabo con la
cittadinanza italiana che mi ha denunciato per vilipendio all'Islam. Che contro
di me ha scritto un lercio e sgrammaticato libello dove elencando quattro sure
del Corano chiede ai suoi correligionari di eliminarmi, che per le sue malefatte
non è mai stato o non ancora processato). Un nemico che in Inghilterra
s'imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo
Parigi-Miami. (Parlo, s'intende, dell'arabo con la cittadinanza inglese che per
puro miracolo beccarono sulla American Airlines).
Un nemico che ad
Amsterdam uccide
Theo van Gogh colpevole di girare documentari sulla schiavitù
delle musulmane e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci ficca dentro una
lettera con la condanna a morte della sua migliore amica. (Parlo, s'intende,
dell'arabo con cittadinanza olandese che probabilmente anzi spero verrà
condannato all' ergastolo e che al processo ha sibilato alla mamma di Theo: «Io
non provo alcuna pietà per lei. Perché lei è un'infedele»). Il nemico, infine,
per il quale trovi sempre un magistrato clemente cioé pronto a scarcerarlo. E
che i governi eurobei (ndr: non si tratta d'un errore tipografico, voglio
proprio dire eurobei non europei) non espellono neanche se è clandestino.
Continua anche il discorso sul Dialogo delle due Civiltà. Ed apriti cielo se
chiedi qual è l'altra civiltà, cosa c'è di civile in una civiltà che non conosce
neanche il significato della parola libertà. Che per libertà, hurryya, intende
«emancipazione dalla schiavitù». Che la parola hurryya la coniò soltanto alla
fine dell' Ottocento per poter firmare un trattato commerciale. Che nella
democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate. Che
dei Diritti dell'Uomo da noi tanto strombazzati e verso i musulmani
scrupolosamente applicati non vuole neanche sentirne parlare. Infatti rifiuta di
sottoscrivere la Carta dei Diritti Umani compilata dall' Onu e la sostituisce
con la Carta dei Diritti Umani compilata dalla Conferenza Araba. Apriti cielo
anche se chiedi che cosa c' è di civile in una civiltà che tratta le donne come
le tratta.
L' Islam è il Corano,
cari miei. Comunque e dovunque.
E il Corano è incompatibile con la Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è
incompatibile con i Diritti Umani. E' incompatibile col concetto di civiltà. E
visto che ho toccato questo argomento mi ascolti bene, signor giudice di Bergamo
che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'Islam ma che non ha mai
incriminato il mio persecutore per vilipendio al Cristianesimo. Nonché per
istigazione all' omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga
pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono
nemmeno ai terroristi islamici beccati con l' esplosivo in cantina. Il suo
processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto
nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi
faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle
denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal
proteggermi anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio
intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere
la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere.
Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato Italiano mi ha
cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo van
Gogh? Glielo chiedo perché il ministro degli Interni dice che nelle nostre
carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che
di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia. (Quanto a voi,
signori del Parlamento, congratulazioni per aver respinto la proposta del
ministro della Giustizia: abolire il reato di opinione. E particolari
congratulazioni all' onorevole di Alleanza Nazionale che oltre ad aver gestito
quel rifiuto ha chiesto di abolire il reato d' apologia del fascismo). Continua
anche l'indulgenza che la Chiesa Cattolica (del resto la maggiore sostenitrice
del Dialogo) professa nei riguardi dell' Islam. Continua cioé la sua
irremovibile irriducibile volontà di sottolineare il «comune patrimonio
spirituale fornitoci dalle tre grandi religioni monoteistiche». Quella
cristiana, quella ebraica, quella islamica. Tutte e tre basate sul concetto del
Dio Unico, tutte e tre ispirate da Abramo. Il buon Abramo che per ubbidire a Dio
stava per sgozzare il suo bambino come un agnello. Ma quale patrimonio in
comune?!?
Allah non ha nulla in
comune col Dio del Cristianesimo.
Col Dio padre, il Dio buono, il Dio affettuoso che predica l' amore e il
perdono. Il Dio che negli uomini vede i suoi figli. Allah è un Dio padrone, un
Dio tiranno. Un Dio che negli uomini vede i suoi sudditi anzi i suoi schiavi. Un
Dio che invece dell' amore insegna l' odio, che attraverso il Corano chiama
cani-infedeli coloro che credono in un altro Dio e ordina di punirli. Di
soggiogarli, di ammazzarli. Quindi come si fa a mettere sullo stesso piano il
cristianesimo e l' islamismo, come si fa a onorare in egual modo Gesù e
Maometto?!? Basta davvero la faccenda del Dio Unico per stabilire una concordia
di concetti, di principii, di valori?!? E questo è il punto che nell' immutata
realtà del dopo-strage di Londra mi turba forse di più. Mi turba anche perché
sposa quindi rinforza quello che considero l' errore commesso da papa Wojtyla:
non battersi quanto avrebbe a mio avviso dovuto contro l' essenza illiberale e
antidemocratica anzi crudele dell' Islam. Io in questi quattr' anni non ho fatto
che domandarmi perché un guerriero come Wojtyla, un leader che come lui aveva
contribuito più di chiunque al crollo dell' impero sovietico e quindi del
comunismo, si mostrasse così debole verso un malanno peggiore dell' impero
sovietico e del comunismo. Un malanno che anzitutto mira alla distruzione del
cristianesimo. (E dell' ebraismo). Non ho fatto che domandarmi perché egli non
tuonasse in maniera aperta contro ciò che avveniva (avviene) ad esempio in Sudan
dove il regime fondamentalista esercitava (esercita) la schiavitù. Dove i
cristiani venivano eliminati (vengono eliminati) a milioni. Perché tacesse
sull'Arabia Saudita dove la gente con una Bibbia in mano o una crocetta al collo
era (è) trattata come feccia da giustiziare. Ancora oggi quel silenzio io non
l'ho capito e...
Naturalmente capisco
che la filosofia della Chiesa
Cattolica si basa
sull'ecumenismo e sul comandamento Ama il nemico tuo come te stesso. Che uno dei
suoi principii fondamentali è almeno teoricamente il perdono, il sacrificio di
porgere l' altra guancia. (Sacrificio che rifiuto non solo per orgoglio cioè per
il mio modo di intendere la dignità, ma perché lo ritengo un incentivo al Male
di chi fa del male). Però esiste anche il principio dell' autodifesa anzi della
legittima difesa, e se non sbaglio la Chiesa Cattolica vi ha fatto ricorso più
volte. Carlo Martello respinse gli invasori musulmani alzando il crocifisso.
Isabella di Castiglia li cacciò dalla Spagna facendo lo stesso. E a Lepanto
c'erano anche le truppe pontificie. A difendere Vienna, ultimo baluardo della
Cristianità, a romper l' assedio di Kara Mustafa, c'era anche e soprattutto il
polacco Giovanni Sobienski con l' immagine della Vergine di Chestochowa. E se
quei cattolici non avessero applicato il principio dell' autodifesa, della
legittima difesa, oggi anche noi porteremmo il burka o il jalabah. Anche noi
chiameremmo i pochi superstiti cani-infedeli. Anche noi gli segheremmo la testa
col coltello halal. E la basilica di San Pietro sarebbe una moschea come la
chiesa di Santa Sofia a Istanbul. Peggio: in Vaticano ci starebbero Bin Laden e
Zarkawi. Così, quando tre giorni dopo la nuova strage Papa Ratzinger ha
rilanciato il tema del Dialogo, sono rimasta di sasso. Santità, Le parla una
persona che La ammira molto. Che Le vuole bene, che Le dà ragione su un mucchio
di cose. Che a causa di questo viene dileggiata coi nomignoli atea-devota,
laica-baciapile, liberal-clericale. Una persona, inoltre, che capisce la
politica e le sue necessità. Che comprende i drammi della leadership e i suoi
compromessi. Che ammira l' intransigenza della fede e rispetta le rinunce o le
prodigalità a cui essa costringe. Però il seguente interrogativo devo porlo lo
stesso: crede davvero che i musulmani accettino un dialogo coi cristiani, anzi
con le altre religioni o con gli atei come me? Crede davvero che possano
cambiare, ravvedersi, smettere di seminar bombe? Lei è un uomo tanto erudito,
Santità. Tanto colto. E li conosce bene. Assai meglio di me. Mi spieghi dunque:
quando mai nel corso della loro storia, una storia che dura da millequattrocento
anni, sono cambiati e si sono ravveduti? Oh, neanche noi siamo stati e siamo
stinchi di santo: d' accordo. Inquisizioni, defenestrazioni, esecuzioni, guerre,
infamie di ogni tipo. Nonché guelfi e ghibellini a non finire. E per giudicarci
severamente basta pensare a quel che abbiamo combinato sessanta anni fa con l'
Olocausto. Ma poi abbiamo messo un po' di giudizio, perbacco. Ci abbiamo dato
una pensata e se non altro in nome della decenza siamo un po' migliorati. Loro,
no.
La Chiesa Cattolica ha
avuto svolte storiche,
Santità. Anche questo lei lo sa meglio di me. A un certo punto si è ricordata
che Cristo predicava la Ragione, quindi la scelta, quindi il Bene, quindi la
Libertà, e ha smesso di tiranneggiare. D' ammazzare la gente. O costringerla a
dipinger soltanto Cristi e Madonne. Ha compreso il laicismo. Grazie a uomini di
prim' ordine, un lungo elenco di cui Lei fa parte, ha dato una mano alla
democrazia. Ed oggi parla coi tipi come me. Li accetta e lungi dal bruciarli
vivi (io non dimentico mai che fino a quattro secoli fa il Sant' Uffizio mi
avrebbe mandato al rogo) ne rispetta le idee. Loro, no. Ergo con loro non si può
dialogare. E ciò non significa ch'io voglia promuovere una guerra di religione,
una Crociata, una caccia alle streghe, come sostengono i mentecatti e i
cialtroni. (Guerre di religione, Crociate, io ?!? Non essendo religiosa,
figuriamoci se voglio incitare alle guerre di religione e alle Crociate. Cacce
alle streghe io?!? Essendo considerata una strega, un'eretica, dagli stessi
laici e dagli stessi liberals, figuriamoci se voglio accendere una caccia alle
streghe. Ciò significa, semplicemente, che illudersi su di loro è contro
ragione. Contro la Vita, contro la stessa sopravvivenza, e guai a concedergli
certe familiarità.
La strage toccherà
davvero anche a noi,
la prossima volta toccherà davvero a noi? Oh, sì. Non ne ho il minimo dubbio.
Non l'ho mai avuto. Anche questo lo dico da quattro anni. E aggiungo: non ci
hanno ancora attaccato in quanto avevano bisogno della landing-zone, della testa
di ponte, del comodo avamposto che si chiama Italia. Comodo geograficamente
perché è il più vicino al Medio Oriente e all' Africa cioè ai paesi che
forniscono il grosso della truppa. Comodo strategicamente perché a quella truppa
offriamo buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà. Ma presto si
scateneranno. Lo stesso Bin Laden ce lo ha promesso. In modo esplicito, chiaro,
preciso. Più volte. I suoi luogotenenti (o rivali), idem. Lo stesso Corriere lo
dimostra con l'intervista a Saad Al-Faqih, l' esiliato saudita diventato amico
di Bin Laden durante il conflitto coi russi in Afghanistan, e secondo i servizi
segreti americani finanziatore di Al Qaeda. «E' solo questione di tempo. Al
Qaeda vi colpirà presto» ha detto Al-Faqih aggiungendo che l'attacco all'Italia
è la cosa più logica del mondo. Non è l'Italia l'anello più debole della catena
composta dagli alleati in Iraq? Un anello che viene subito dopo la Spagna e che
è stato preceduto da Londra per pura convenienza. E poi: «Bin Laden ricorda bene
le parole del Profeta. Voi costringerete i romani alla resa. E vuole costringer
l'Italia ad abbandonare l'alleanza con l'America». Infine, sottolineando che
operazioni simili non si fanno appena sbarcati a Lampedusa o alla Malpensa bensì
dopo aver maturato dimestichezza con il paese, esser penetrati nel suo tessuto
sociale: «Per reclutare gli autori materiali, c'è solo l' imbarazzo della
scelta».
Molti italiani non ci
credono ancora.
Nonostante le dichiarazioni del ministro degli Interni, a rischio Roma e Milano,
all' erta anche Torino e Napoli e Trieste e Treviso nonché le città d' arte come
Firenze e Venezia, gli italiani si comportano come i bambini per cui la parola
Morte non ha alcun significato. O come gli scriteriati cui la morte sembra una
disgrazia che riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una disgrazia che
li colpirà per ultimi. Peggio: credono che per scansarla basti fare i furbi cioè
leccarle i piedi. Ha ragione Vittorio Feltri quando su Libero scrive che la
decadenza degli occidentali si identifica con la loro illusione di poter
trattare amichevolmente il nemico, nonché con la loro paura. Una paura che li
induce ad ospitare docilmente il nemico, a tentar di conquistarne la simpatia, a
sperare che si lasci assorbire mentre è lui che vuole assorbire. Questo senza
contare la nostra abitudine ad essere invasi, umiliati, traditi. Come dico
nell'«Apocalisse», l'abitudine genera rassegnazione. La rassegnazione genera
apatia. L'apatia genera inerzia. L'inerzia genera indifferenza, ed oltre a
impedire il giudizio morale l'indifferenza soffoca l'istinto di autodifesa cioè
l'istinto che induce a battersi. Oh, per qualche settimana o qualche mese lo
capiranno sì d' essere odiati e disprezzati dal nemico che trattano da amico e
che è del tutto refrattario alle virtù chiamate Gratitudine, Lealtà, Pietà.
Usciranno sì dall'apatia, dall'inerzia, dall' indifferenza. Ci crederanno sì
agli annunci di Saad al-Faqih e agli espliciti, chiari, precisi avvertimenti
pronunciati da Bin Laden and Company. Eviteranno di prendere i treni della
sotterranea. Si sposteranno in automobile o in bicicletta. (Ma Theo van Gogh fu
ammazzato mentre si spostava in bicicletta). Attenueranno il buonismo o il
servilismo. Si fideranno un po' meno del clandestino che gli vende la droga o
gli pulisce la casa. Saranno meno cordiali col manovale che sventolando il
permesso di soggiorno afferma di voler diventare come loro ma intanto fracassa
di botte la moglie, le mogli, e uccide la figlia in blue jeans. Rinunceranno
anche alle litanie sui Viaggi della Speranza, e forse realizzeranno che per non
perdere la Libertà a volte bisogna sacrificare un po' di libertà. Che l'
autodifesa è legittima difesa e la legittima difesa non è una barbarie. Forse
grideranno addirittura che la Fallaci aveva ragione, che non meritava d' essere
trattata come una delinquente. Ma poi riprenderanno a trattarmi come una
delinquente. A darmi di retrograda xenofoba razzista eccetera. E quando l'
attacco verrà, udiremo le consuete scemenze. Colpa degli americani, colpa di
Bush.
Quando verrà, come
avverrà quell'attacco?
Oddio, detesto fare la
Cassandra. La profetessa. Non sono una Cassandra, non sono una profetessa. Sono
soltanto un cittadino che ragiona e ragionando prevede cose che secondo logica
accadranno. Ma che ogni volta spera di sbagliarsi e, quando accadono, si
maledice per non aver sbagliato. Tuttavia riguardo all' attacco contro l' Italia
temo due cose: il Natale e le elezioni. Forse supereremo il Natale. I loro
attentati non sono colpacci rozzi, grossolani. Sono delitti raffinati, ben
calcolati e ben preparati. Prepararsi richiede tempo e a Natale credo che non
saranno pronti. Però saranno pronti per le elezioni del 2006. Le elezioni che
vogliono vedere vinte dal pacifismo a senso unico. E da noi, temo, non si
accontenteranno di massacrare la gente. Perché quello è un Mostro intelligente,
informato, cari miei. Un Mostro che (a nostre spese) ha studiato nelle
università, nei collegi rinomati, nelle scuole di lusso. (Coi soldi del genitore
sceicco od onesto operaio). Un Mostro che non s' intende soltanto di dinamica,
chimica, fisica, di aerei e treni e metropolitane: s' intende anche di Arte.
L'arte che il loro presunto Faro di Civiltà non ha mai saputo produrre. E penso
che insieme alla gente da noi vogliano massacrare anche qualche opera d' arte.
Che ci vuole a far saltare in aria il Duomo di Milano o la Basilica di San
Pietro? Che ci vuole a far saltare in aria il David di Michelangelo, gli Uffizi
e Palazzo Vecchio a Firenze, o il Palazzo dei Dogi a Venezia? Che ci vuole a far
saltare in aria la Torre di Pisa, monumento conosciuto in ogni angolo del mondo
e perciò assai più famoso delle due Torri Gemelle? Ma non possiamo scappare o
alzare bandiera bianca. Possiamo soltanto affrontare il mostro con onore,
coraggio, e ricordare quel che Churchill disse agli inglesi quando scese in
guerra contro il nazismo di Hitler. Disse: «Verseremo lacrime e sangue». Oh, sì:
pure noi verseremo lacrime e sangue. Siamo in guerra: vogliamo mettercelo in
testa, sì o no?!? E in guerra si piange, si muore. Punto e basta. Conclusi così
anche quattro anni fa, su questo giornale.
Oriana Fallaci a una
terrorista. «Un neonato per te è un nemico?».
La giornalista e scrittrice
nel 1970 intervistò Rascida Abhedo, palestinese, che fece esplodere due bombe in
un mercato di Gerusalemme provocando una carneficina, scrive Oriana Fallaci su
“Il Corriere della Sera”. Oriana Fallaci, il terrorismo, il rapporto
dell’Occidente con il mondo islamico. La grande giornalista ha affrontato questi
temi molte volte nei suoi articoli e nelle sue interviste. Con l’iniziativa «Le
parole di Oriana» abbiamo scelto di ripubblicare alcuni di questi suoi
interventi, che mantengono - a distanza di molti anni - una forza, un valore e
un fascino straordinari. Ecco l’intervista del 1970 all’attentatrice palestinese
Rascida Abhedo.
Sembrava una monaca. O una
guardia rossa di Mao Tse-tung. Delle monache aveva la compostezza insidiosa,
delle guardie rosse l’ostilità sprezzante, di entrambe il gusto di rendersi
brutta sebbene fosse tutt’altro che brutta. Il visino ad esempio era grazioso:
occhi verdi, zigomi alti, bocca ben tagliata. Il corpo era minuscolo e lo
indovinavi fresco, privo di errori. Ma l’insieme era sciupato da quei ciuffi
neri, untuosi, da quel pigiama in tela grigioverde, un’uniforme da fatica
suppongo, di taglia tre volte superiore alla sua: quella sciatteria voluta,
esibita, ti aggrediva come una cattiveria. Dopo il primo sguardo, ti apprestavi
con malavoglia a stringerle la mano, che ti porgeva appena, restando seduta,
costringendoti a scendere verso di lei nell’inchino del suddito che bacia il
piede della regina. In silenzio bestemmiavi: «Maleducata!». La mano toccò molle
la mia. Gli occhi verdi mi punsero con strafottenza, anzi con provocazione, una
vocetta litigiosa scandì: «Rascida Abhedo, piacere». Poi, rotta dallo sforzo che
tal sacrificio le era costato, si accomodò meglio contro la spalliera del grande
divano in fondo al salotto dove occupava il posto d’onore. Dico così perché
v’erano molte persone, e queste le sedevan dinanzi a platea: lei in palcoscenico
e loro in platea. Una signora che avrebbe fatto da interprete, suo marito, un
uomo che mi fissava muto e con sospettosa attenzione, un giovanotto dal volto
dolcissimo e pieno di baffi, infine Najat: la padrona di casa che aveva
organizzato l’incontro con lei. Come lei, essi appartenevano tutti al Fronte
Popolare, cioè il movimento maoista che da Al Fatah si distingue per la
preferenza a esercitare la lotta coi sabotaggi e il terrore. Però, al contrario
di lei, eran tutti ben vestiti, cordiali e borghesi: invece che ad Amman avresti
detto di trovarti a Roma, tra ricchi comunisti à la page, sai tipi che fingono
di voler morire per il proletariato ma poi vanno a letto con le principesse. La
signora che avrebbe fatto da interprete amava andare in vacanza a Rapallo e
calzava scarpe italiane. Najat, una splendida bruna sposata a un facoltoso
ingegnere, era la ragazza più sofisticata della città: in una settimana non
l’avevo mai sorpresa con lo stesso vestito, con un accessorio sbagliato. Sempre
ben pettinata, ben profumata, ben valorizzata da un completo giacca-pantaloni o
da una minigonna. Non credevi ai tuoi orecchi quando diceva: «Sono stanca perché
ho partecipato alle manovre e mi duole una spalla perché il Kalashnikov rincula
in modo violento». Stasera indossava un modello francese e il suo chic era così
squisito che, paragonata a lei, la monaca in uniforme risultava ancor più
inquietante. Forse perché sapevi chi era. Era colei che il 21 febbraio 1969
aveva fatto esplodere due bombe al supermercato di Gerusalemme, causando una
carneficina. Era colei che dieci giorni dopo aveva costruito un terzo ordigno
per la cafeteria della Università Ebraica. Era colei che per tre mesi aveva
mobilizzato l’intera polizia israeliana e provocato Dio sa quanti arresti,
repressioni, tragedie. Era colei che il Fronte custodiva per gli incarichi più
sanguinolenti. Ventitré anni, ex maestra di scuola. La fotografia appesa in ogni
posto di blocco: «Catturare o sparare». La patente di eroe. Al suo tono
strafottente, provocatorio, ora s’era aggiunta un’espressione di gran
sufficienza: la stessa che certe dive esibiscono quando devono affrontare i
giornalisti curiosi. Mi accomodai accanto a lei sul divano. Lasciai perdere ogni
convenevole, misi in moto il registratore: «Voglio la tua storia, Rascida. Dove
sei nata, chi sono i tuoi genitori, come sei giunta a fare quello che fai». Alzò
un sopracciglio ironico, tolse di tasca un fazzoletto. Si pulì il naso, lenta,
rimise in tasca il fazzoletto. Si raschiò la gola. Sospirò. Rispose.
«Sono
nata a Gerusalemme, da due genitori piuttosto ricchi, piuttosto conformisti, e
assai rassegnati. Non fecero mai nulla per difendere la Palestina e non fecero
mai nulla per indurmi a combattere. Fuorché influenzarmi, senza saperlo, coi
loro racconti del passato. Mia madre, sempre a ripetere di quando andava a
Giaffa col treno e dal finestrino del treno si vedeva il Mediterraneo che è così
azzurro e bello. Mio padre, sempre a lagnarsi della notte in cui era fuggito con
la mia sorellina su un braccio e me nell’altro braccio. E poi a dirmi dei
partiti politici che c’erano prima del 1948, tutti colpevoli d’aver ceduto,
d’aver deposto le armi, ma il suo era meno colpevole degli altri eccetera. E poi
a mostrarmi la nostra vecchia casa al di là della linea di demarcazione, in
territorio israeliano. Si poteva vederla dalle nostre finestre e penso che
questo, sì, m’abbia servito. Prima di andare a letto la guardavo sempre, con
ira, e a Natale guardavo gli arabi che si affollavano al posto di blocco per
venire dai parenti profughi. Piangevano, perdevano i bambini, i fagotti. Erano
brutti, senza orgoglio, e ti coglieva il bisogno di fare qualcosa. Questo
qualcosa io lo scoprii nel 1962 quando entrai a far parte del Movimento
nazionale arabo, il Fronte Popolare di oggi. Avevo quindici anni, non dissi
nulla ai miei genitori. Si sarebbero spaventati, non avrebbero compreso. Del
resto si faceva poco: riunioni di cellula, corsi politici, manifestazioni
represse dai soldati giordani» .
Come eri entrata in
contatto con quel movimento?
«A
scuola. Cercavano adepti fra gli studenti. Poi venne il 1967: l’occupazione di
Gerusalemme, di Gerico, del territorio a est del Giordano. Io in quei giorni non
c’ero, ero nel Kuwait: insegnavo in una scuola media di una cittadina sul Golfo.
C’ero stata costretta perché nelle scuole della Giordania c’era poca simpatia
pei maestri palestinesi. L’occupazione di Gerusalemme mi gettò in uno stato di
sonnolenza totale. Ero così mortificata che per qualche tempo non vi reagii e ci
volle tempo perché capissi che agli altri paesi arabi non importava nulla della
Palestina, non si sarebbero mai scomodati a liberarla: bisognava far questo da
soli. Ma allora perché restavo in quella scuola a insegnare ai ragazzi? Il mio
lavoro lo amavo, intendiamoci, lo consideravo alla stregua di un divertimento,
ma era necessario che lo abbandonassi. Mi dimisi e venni ad Amman dove mi
iscrissi subito al primo gruppo di donne addestrate dall’FPLP. Ragazze tra i
diciotto e i venticinque anni, studentesse o maestre come me. Era il gruppo di
Amina Dahbour, quella che hanno messo in prigione in Svizzera per il
dirottamento di un aereo El Al, di Laila Khaled, che dirottò l’aereo della TWA,
di Sheila Abu Mazal, la prima vittima della barbarie sionista» .
La interruppi: anche questo
nome m’era familiare perché ovunque lo vedevi stampato con l’appellativo di
eroina e sui giornali occidentali avevo letto che era morta in circostanze
eccezionali. Chi diceva in combattimento, chi diceva sotto le torture.
Rascida, come morì Sheila
Abu Mazal?
«Una
disgrazia. Preparava una bomba per un’azione a Tel Aviv e la bomba scoppiò tra
le sue mani» .
Perché?
«Così»
.
Raccontami degli
addestramenti, Rascida.
«Uffa.
Eran duri. Ci voleva una gran forza di volontà per compierli. Marce, manovre,
pesi. Sheila ripeteva: bisogna dimostrare che non siamo da meno degli uomini! E
per questo in fondo scelsi il corso speciale sugli esplosivi. Era il corso che
bisognava seguire per diventare agenti segreti e, oltre alla pratica degli
esplosivi, prevedeva lo studio della topografia, della fotografia, della
raccolta di informazioni. I nostri istruttori contavano molto sulle donne come
elemento di sorpresa: da una ragazza araba non ci si aspettano certe attività.
Divenni brava a scattar fotografie di nascosto ma specialmente a costruire
ordigni a orologeria. Più di ogni altra cosa volevo maneggiare le bombe, io sono
sempre stata un tipo senza paura. Anche da piccola. Non m’impressionava mai il
buio. I corsi duravano a volte quindici giorni, a volte due mesi o quattro. Il
mio corso fu lungo, assai lungo, perché dovetti anche imparare a recarmi nel
territorio occupato. Passai il fiume molte volte, insieme alle mie compagne. A
quel tempo non era difficilissimo perché gli sbarramenti fotoelettrici non
esistevano, ma la prima volta non fu uno scherzo. Ero tesa, mi aspettavo di
morire. Ma presto fui in grado di raggiungere Gerusalemme e stabilirmici come
agente segreto» .
Dimmi delle due bombe al
supermarket, Rascida.
«Uffa.
Quella fu la prima operazione di cui posso rivendicare la paternità. Voglio dire
che la concepii da sola, la preparai da sola, e da sola la portai fino in fondo.
Avevo ormai partecipato a tanti sabotaggi del genere e potevo muovermi con
disinvoltura. E poi avevo una carta di cittadinanza israeliana con cui potevo
introdurmi in qualsiasi posto senza destare sospetto. Poiché abitavo di nuovo
coi miei genitori, scomparivo ogni tanto senza dare nell’occhio. L’idea di
attaccare il supermarket l’ebbi quattro giorni dopo la cattura di Amina a
Zurigo, e la morte di Abdel. Nella sparatoria con l’israeliano, ricordi, Abdel
rimase ucciso. Bisognava vendicare la morte di Abdel e bisognava dimostrare a
Moshe Dayan la falsità di ciò che aveva detto: secondo Moshe Dayan, il Fronte
Popolare agiva all’estero perché non era capace di agire entro Israele. E poi
bisognava rispondere ai loro bombardamenti su Irbid, su Salt. Avevano ucciso
civili? Noi avremmo ucciso civili. Del resto nessun israeliano noi lo
consideriamo un civile ma un militare e un membro della banda sionista» .
Anche se è un bambino,
Rascida? Anche se è un neonato?
(Gli occhi verdi si accesero
d’odio, la sua voce adirata disse qualcosa che l’interprete non mi tradusse, e
subito scoppiò una gran discussione cui intervennero tutti: anche Najat, anche
il giovanotto col volto dolcissimo. Parlavano in arabo, e le frasi si
sovrapponevan confuse come in una rissa da cui si levava spesso un’invocazione:
«Rascida!». Ma Rascida non se ne curava. Come un bimbo bizzoso scuoteva le
spalle e, solo quando Najat brontolò un ordine perentorio, essa si calmò.
Sorrise un sorriso di ghiaccio, mi replicò).
«Questa
domanda me la ponevo anch’io, quando mi addestravo con gli esplosivi. Non sono
una criminale e ricordo un episodio che accadde proprio al supermarket, un
giorno che vi andai in avanscoperta. C’erano due bambini. Molto piccoli, molto
graziosi. Ebrei. Istintivamente mi chinai e li abbracciai. Ma stavo
abbracciandoli quando mi tornarono in mente i nostri bambini uccisi nei
villaggi, mitragliati per le strade, bruciati dal napalm. Quelli di cui loro
dicono: bene se muore, non diventerà mai un fidayin. Così li respinsi e mi
alzai. E mi ordinai: non farlo mai più, Rascida, loro ammazzano i nostri bambini
e tu ammazzerai i loro. Del resto, se questi due bambini morranno, o altri come
loro, mi dissi, non sarò stata io ad ammazzarli. Saranno stati i sionisti che mi
forzano a gettare le bombe. Io combatto per la pace, e la pace val bene la vita
di qualche bambino. Quando la nostra vera rivoluzione avverrà, perché oggi non è
che il principio, numerosi bambini morranno. Ma più bambini morranno più
sionisti comprenderanno che è giunto il momento di andarsene. Sei d’accordo? Ho
ragione?»
No, Rascida.
La discussione riprese, più
forte. Il giovanotto dal volto dolcissimo mi lanciò uno sguardo conciliativo,
implorante. V’era in lui un che di straziante e ti chiedevi chi fosse. Poi, con
l’aiuto di alcune tazze di tè, l’intervista andò avanti.
Perché scegliesti proprio
il supermarket, Rascida?
«Perché
era un buon posto, sempre affollato. Durante una decina di giorni ci andai a
tutte le ore proprio per studiare quando fosse più affollato. Lo era alle undici
del mattino. Osservai anche l’ora in cui apriva e in cui chiudeva, i punti dove
si fermava più gente, e il tempo che ci voleva a raggiungerlo dalla base segreta
dove avrei ritirato la bomba o le bombe. Per andarci mi vestivo in modo da
sembrare una ragazza israeliana, non araba. Spesso vestivo in minigonna, altre
volte in pantaloni, e portavo sempre grandi occhiali da sole. Era interessante,
scoprivo sempre qualcosa di nuovo e di utile, ad esempio che se camminavo con un
peso il tragitto tra la base e il supermarket aumentava. Infine fui pronta e
comprai quei due bussolotti di marmellata. Molto grandi, da cinque chili l’uno,
di latta. Esattamente ciò di cui avevo bisogno» .
Per le bombe?
«Sicuro.
L’idea era di vuotarli, riempirli di esplosivo, e rimetterli dove li avevo
presi. Quella notte non tornai a casa. Andai alla mia base segreta e con l’aiuto
di alcuni compagni aprii i bussolotti. Li vuotai di quasi tutta la marmellata e
ci sistemai dentro l’esplosivo con un ordigno a orologeria. Poi saldai di nuovo
il coperchio, perché non si vedesse che erano stati aperti e...»
Che marmellata era,
Rascida?
«Marmellata
di albicocche, perché?»
Così... Non mangerò mai più
marmellata di albicocche.
. (Rascida rise a gola spiegata e a tal punto che le venne la
tosse).
«Io
la mangiai, invece. Era buona. E dopo averla mangiata andai a dormire» .
Dormisti bene, Rascida?
«Come
un angelo. E alle cinque del mattino mi svegliai bella fresca. Mi vestii
elegantemente, coi pantaloni alla charleston, sai quelli attillati alla coscia e
svasati alla caviglia, mi pettinai con cura, mi truccai gli occhi e le labbra.
Ero graziosa, i miei compagni si congratulavano: «Rascida!». Quando fui pronta
misi i bussolotti della marmellata in una borsa a sacco: sai quelle che si
portano a spalla. Le donne israeliane la usano per fare la spesa. Uh, che borsa
pesante! Un macigno! L’esplosivo pesava il doppio della marmellata. Ecco perché
negli addestramenti ti abituano a portare pesi» .
Come ti sentivi, Rascida?
Nervosa, tranquilla?
«Tranquilla,
anzi felice. Ero stata così nervosa nei giorni precedenti che mi sentivo come
scaricata. E poi era una mattina azzurra, piena di sole. Sapeva di buon
auspicio. Malgrado il peso della borsa camminavo leggera, portavo quelle bombe
come un mazzo di fiori. Sì, ho detto fiori. Ai posti di blocco i soldati
israeliani perquisivano la gente ma io gli sorridevo con civetteria e, senza
attendere il loro invito, aprivo la borsa: «Shalom, vuoi vedere la mia
marmellata?». Loro guardavano la marmellata e con cordialità mi dicevano di
proseguire. No, non andai dritta al supermarket: dove andai prima è affar mio e
non ti riguarda. Al supermarket giunsi poco dopo le nove. Che pensi? (Pensavo a
un episodio del film La battaglia di Algeri, quello dove tre donne
partono una mattina per recarsi a sistemare esplosivi su obiettivi civili. Una
delle tre donne è una ragazza che assomiglia straordinariamente a Rascida:
piccola, snella, e porta i pantaloni. Passando ai posti di blocco strizza
l’occhio ai soldati francesi, civetta. Chissà se Rascida aveva visto il film.
Magari sì. Bisognava che glielo chiedessi quando avrebbe finito il racconto. Ma
poi me ne dimenticai. O forse volli dimenticarmene per andarmene via prima).
Pensavo... a nulla» .
Cosa accadde quando
entrasti nel supermarket, Rascida?
«Entrai
spedita e agguantai subito il carry-basket, sai il cestino di metallo dove si
mette la roba, il cestino con le ruote. Al supermarket c’è il self-service, ti
muovi con facilità. La prima cosa da fare, quindi, era togliere i due bussolotti
di marmellata dalla mia borsa e metterli nel carry-basket. Ci avevo già provato
ma con oggetti più piccoli, non così pesanti, coi bussolotti grandi no e per
qualche secondo temetti di dare nell’occhio. Mi imposi calma, perciò. Mi imposi
anche di non guardare se mi guardavano altrimenti il mio gesto avrebbe perso
spontaneità. Presto i bussolotti furono nel carry-basket. Ora si trattava di
rimetterli a posto ma non dove li avevo presi perché non era un buon punto. Alla
base avevo caricato i due ordigni a distanza di cinque minuti, in modo che uno
esplodesse cinque minuti prima dell’altro. Decisi di mettere in fondo al negozio
quello che sarebbe esploso dopo. L’altro, invece, vicino alla porta dove c’era
uno scaffale con le bottiglie di birra e i vasetti» .
Perché, Rascida?
«Perché
la porta era di vetro come le bottiglie di birra, come i vasetti. Con
l’esplosione sarebbero schizzati i frammenti e ciò avrebbe provocato un numero
maggiore di feriti. O di morti. Il vetro è tremendo: lanciato a gran velocità
può decapitare, e anche i piccoli pezzi sono micidiali. Non solo, la prima
esplosione avrebbe bloccato l’ingresso. Allora i superstiti si sarebbero
rifugiati in fondo al negozio e qui, cinque minuti dopo, li avrebbe colti la
seconda esplosione. Con un po’ di fortuna, nel caso la polizia fosse giunta alla
svelta, avrei fatto fuori anche un bel po’ di polizia. Rise divertita, contenta.
E ciò le provocò un nuovo accesso di tosse» .
Non ridere, Rascida.
Continua il tuo racconto, Rascida.
«Sempre
senza guardare se mi guardavano, sistemai i due bussolotti dove avevo deciso. Se
qualcuno se ne accorse non so, ero troppo concentrata in ciò che stavo facendo.
Ricordo solo un uomo molto alto, con il cappello, che mi fissava. Ma pensai che
mi fissasse perché gli piacevo. Te l’ho detto che ero molto graziosa quella
mattina. Poi, quando anche il secondo bussolotto fu nello scaffale, comprai
alcune cose: tanto per non uscire a mani vuote. Comprai un grembiule da cucina,
due stecche di cioccolata, altre sciocchezze. Non volevo dare troppi soldi agli
ebrei» .
Cos’altro comprasti,
Rascida?
«I
cetriolini sottaceto. E le cipolline sottaceto. Mi piacciono molto. Mi piacciono
anche le olive farcite. Ma cos’è questo, un esame di psicologia?»
Se vuoi. E li mangiasti
quei cetriolini, quelle cipolline?
«Certo.
Li portai a casa e li mangiai. Non era un’ora adatta agli antipasti e mia madre
disse, ricordo: «Da dove vengono, quelli?». Io risposi: «Li ho comprati al
mercato». Ma che te ne importa di queste cose? Torniamo al supermarket. Avevo
deciso che l’intera faccenda dovesse durare quindici minuti. E quindici minuti
durò. Così, dopo aver pagato uscii e tornai a casa. Qui feci colazione e
riposai. Un’ora di cui non ricordo nulla. Alle undici in punto aprii la radio
per ascoltar le notizie. Le bombe erano state caricate alle sei e alle sei e
cinque, affinché scoppiassero cinque ore dopo. L’esplosione sarebbe dunque
avvenuta alle undici e alle undici e cinque: l’ora dell’affollamento. Aprii la
radio per accertarmene e per sapere se... se erano morti bambini nell’operazione»
.
Lascia perdere, Rascida.
Non ci credo, Rascida. Cosa disse la radio?
«Disse
che c’era stato un attentato al supermarket e che esso aveva causato due morti e
undici feriti. Rimasi male, due morti soltanto, e scesi per strada a chiedere la
verità. Radio Israele non dice mai la verità. La verità era che le due bombe
avevan causato ventisette morti e sessanta feriti fra cui quindici gravissimi.
Bè, mi sentii meglio anche se non perfettamente contenta. Gli esperti militari
della mia base avevano detto che ogni bomba avrebbe ucciso chiunque entro un
raggio di venticinque metri e, verso le undici del mattino, al supermarket non
contavi mai meno di trecentocinquanta persone. Oltre a un centinaio di impiegati»
.
Rascida, provasti anzi
provi nessuna pietà per quei morti?
«No
davvero. Il modo in cui ci trattano, in cui ci uccidono, spenge in noi ogni
pietà. Io ho dimenticato da tempo cosa significa la parola pietà e mi disturba
perfino pronunciarla. Corre voce che ci fossero arabi in quel negozio. Non me ne
importa. Se c’erano, la lezione gli servì a imparare che non si va nei negozi
degli ebrei, non si danno soldi agli ebrei. Noi arabi abbiamo i nostri negozi, e
i veri arabi si servono lì» .
Rascida, cosa facesti dopo
esserti accertata che era successo ciò che volevi?
«Dissi
a mia madre: «Ciao, mamma, esco e torno fra poco». La mamma rispose: «Va bene,
fai presto, stai attenta». Chiusi la porta e fu l’ultima volta che la vidi.
Dovevo pensare a nascondermi, a non farmi più vedere neanche se arrestavano i
miei. E li arrestarono. Non appena il Fronte Popolare assunse la paternità
dell’operazione, gli israeliani corsero da quelli che appartenevano al Fronte.
Hanno schedari molto precisi, molto aggiornati: un dossier per ciascuno di noi.
E tra coloro che presero c’era un compagno che sapeva tutto di me. Così lo
torturarono ma lui resistette tre giorni: è la regola. Tre giorni ci bastano
infatti a metterci in salvo. Dopo tre giorni disse il mio nome, così la polizia
venne ad arrestarmi ma non mi trovò e al mio posto si portò via la famiglia. Mio
padre, mia madre, mia sorella maggiore e i bambini. Mia madre e i bambini li
rilasciarono presto, mio padre invece lo tennero tre mesi e mia sorella ancora
di più. Al processo non ci arrivarono mai perché in realtà né mio padre né mia
sorella sapevano niente» .
E tu cosa facesti, Rascida?
«Raggiunsi
una base segreta e preparai la bomba per la cafeteria dell’Università Ebraica.
Questo accadde il 2 marzo e purtroppo io non potei piazzare la bomba, che non
ebbe un esito soddisfacente. Solo ventotto studenti restaron feriti, e nessun
morto. In compenso le cose peggiorarono molto per me: la mia fotografia apparve
dappertutto e la polizia prese a cercarmi ancor più istericamente. Fu necessario
abbandonare la base segreta e da quel momento dovetti cavarmela proprio da me.
Mi trasferivo di casa in casa, una notte qui e una notte là, per strada mi
sembrava sempre d’esser seguita. Un giorno un’automobile mi seguì a passo d’uomo
per circa due ore. Esitavano a fermarmi, credo, perché ero molto cambiata e
vestita come una stracciona. Riuscii a far perdere le mie tracce e, in un
vicolo, bussai disperatamente a una porta. Aprì un uomo, cominciai a piangere e
a dire che ero sola al mondo: mi prendesse a servizio per carità. Si commosse,
mi assunse e rimasi lì dieci giorni. Al decimo, giudicai saggio scomparire. Ero
appena uscita che la polizia israeliana arrivò e arrestò l’uomo. Al processo,
malgrado ignorasse tutto di me, fu condannato a tre anni. È ancora in prigione»
.
Te ne dispiace, Rascida?
«Che
posso farci? In carcere ce l’hanno messo loro, mica io. E io ho sofferto tanto.
Tre mesi di caccia continua» .
Ci credo, avevi fatto
scoppiare tre bombe! E come tornasti in Giordania, Rascida?
«Con
un gruppo militare del Fronte. Si passò le linee di notte. Non fu semplice,
dovemmo nasconderci molte ore nel fiume e bevvi un mucchio di quell’acqua
sporca. Sono ancora malata. Ma partecipo lo stesso alle operazioni da qui e
l’unica cosa che mi addolora è non poter più mettere bombe nei luoghi degli
israeliani» .
E non vedere più i tuoi
genitori, averli mandati in carcere, ti addolora?
«La
mia vita personale non conta, in essa non v’è posto per le emozioni e le
nostalgie. I miei genitori li ho sempre giudicati brava gente e tra noi c’è
sempre stato un buon rapporto, ma v’è qualcosa che conta più di loro ed è la mia
patria. Quanto alla prigione, li ha come svegliati: non sono più rassegnati,
indifferenti. Ad esempio potrebbero lasciare Gerusalemme, mettersi in salvo, ma
rifiutan di farlo. Non lasceremo mai la nostra terra, dicono. E se Dio vuole...»
Credi in Dio, Rascida?
«No,
non direi. La mia religione è sempre stata la mia patria. E insieme a essa il
socialismo. Ho sempre avuto bisogno di spiegare le cose scientificamente, e Dio
non lo spieghi scientificamente: il socialismo sì. Io credo nel socialismo
scientifico basato sulle teorie marxiste-leniniste che ho studiato con cura.
Presto studierò anche Il Capitale: è in programma nella nostra base.
Voglio conoscerlo bene prima di sposarmi» .
Ti sposi, Rascida?
«Sì,
tra un mese. Il mio fidanzato è quello lì» . (E additò il giovanotto
dal volto dolcissimo. Lui arrossì gentilmente e parve affondare dentro la
poltrona).
Congratulazioni. Avevi
detto che nella tua vita non c’è posto per i sentimenti.
«Ho
detto che capisco le cose solo da un punto di vista scientifico e il mio
matrimonio è la cosa più scientifica che tu possa immaginare. Lui è comunista
come me, fidayin come me: la pensiamo in tutto e per tutto nel medesimo modo.
Inoltre v’è attrazione fra noi ed esaudirla non è forse scientifico? Il
matrimonio non c’impedirà di combattere: non metteremo su casa. L’accordo è
incontrarci tre volte al mese e solo se ciò non intralcia i nostri doveri di
fidayin. Figli non ne vogliamo: non solo perché se restassi incinta non potrei
più combattere e il mio sogno più grande è partecipare a una battaglia, ma
perché non credo che in una situazione come questa si debba mettere al mondo
bambini. A che serve? A farli poi morire o almeno restare orfani?»
(Allora si alzò il fidanzato,
che si chiamava Thaer, e con l’aria di scusarsi venne a sedere presso di me.
Guardandomi con due occhi di agnello, parlando con voce bassissima, dolce come
il suo viso, disse che conosceva Rascida da circa tre anni: quando lei insegnava
nel Kuwait e lui studiava psicologia all’università. «Mi piacque come essere
umano, pei suoi pregi e i suoi difetti. Dopo la guerra del 1967 le scrissi una
lettera per annunciarle che sarei diventato fidayin, per spiegarle che l’amavo,
sì, ma la Palestina contava più del mio amore. Lei rispose: “Thaer, hai avuto
più fiducia in me di quanta io ne abbia avuta in te. Perché tu m’hai detto di
voler diventare fidayin e io non te l’ho detto. Abbiamo gli stessi progetti,
Thaer, e da questo momento mi considero davvero fidanzata con te”.» «Capisco,
Thaer. Ma cosa provasti a sapere che Rascida aveva ucciso ventisette persone
senza un fucile in mano?» Thaer prese fiato e congiunse le mani come a
supplicarmi di ascoltarlo con pazienza. «Fui orgoglioso di lei. Oh, so quello
che provi, all’inizio la pensavo anch’io come te. Perché sono un uomo tenero,
io, un sentimentale. Non assomiglio a Rascida. Il mio modo di fare la guerra è
diverso: io sparo a chi spara. Ma ho visto bombardare i nostri villaggi e mi
sono rivoltato: ho deciso che avere scrupoli è sciocco. Se invece d’essere uno
spettatore obbiettivo tu fossi coinvolta nella tragedia, non piangeresti sui
morti senza il fucile. E capiresti Rascida.») Certo è difficile capire
Rascida. Ma vale la pena provarci e, per provarci, bisogna avere visto i tipi
come Rascida nei campi dove diventano fidajat: cioè donne del sacrificio. Lunghe
file di ragazze in grigioverde, costrette giorno e notte a marciare sui sassi,
saltare sopra altissimi roghi di gomma e benzina, insinuarsi entro reticolati
alti appena quaranta centimetri e larghi cinquanta, tenersi in bilico su
ponticelli di corde tese su trabocchetti, impegnarsi in massacranti lezioni di
tiro. E guai se sbagli un colpo, guai se calcoli male il salto sul fuoco, guai
se resti impigliato in una punta di ferro, guai se dici basta, non ce la faccio
più. L’istruttore che viene dalla Siria, dall’Iraq, dalla Cina, non ha tempo da
perdere con le femminucce: se hai paura, o ti stanchi, ti esplode una raffica
accanto agli orecchi. Hai visto le fotografie. Ch’io sappia, neanche i berretti
verdi delle forze speciali in Vietnam, neanche i soldati più duri dei commandos
israeliani vengono sottoposti ad addestramenti così spietati. E da quelli,
credi, esci non soltanto col fisico domato ma con una psicologia tutta nuova.
Dice che in alcuni campi (questo io non l’ho visto) le abituano perfino alla
vista del sangue. E sai come? Prima sparano su un cane lasciandolo agonizzante
ma vivo, poi buttano il cane tra le loro braccia e le fanno correre senza
ascoltarne i guaiti. Dopo tale esperienza, è dimostrato, al dolore del corpo e
dell’anima non badi più. Al campo Schneller conobbi una fidajat che si chiamava
Hanin, Nostalgia. La intervistai e mi disse d’avere venticinque anni, un figlio
di sei e una figlia di due. Le chiesi: «Dove li hai lasciati, Hanin?». Rispose:
«In casa, oggi c’è mio marito». «E cosa fa tuo marito?» «Il fidayin. Oggi è in
licenza.» «E quando non c’è tuo marito?» «Qua e là.» «Hanin, non basta un
soldato in famiglia?» «No, voglio passare anch’io le linee, voglio andare
anch’io in combattimento.» Poi ci mettemmo a parlare di altre cose, del negozio
di antiquariato che essi possedevano a Gerusalemme, del fatto che non gli
mancassero i soldi eccetera. La conversazione era interessante, si svolgeva
direttamente in inglese, e io non mi curavo del lieve sospiro, quasi un lamento,
che usciva dalle pieghe del kaffiah. I grandi occhi neri erano fermi, la fronte
era appena aggrottata, e pensavo: poverina, è stanca. Ma poi l’istruttore
chiamò, era giunto il turno di sparare al bersaglio, e Hanin si alzò:
nell’alzarsi le sfuggì un piccolo grido. «Ti senti male, Hanin?» «No, no. Credo
soltanto d’essermi slogata un piede. Ma ora non c’è tempo di metterlo a posto,
lo dirò quando le manovre saranno finite.» E raggiunse le compagne, decisa, col
suo piede slogato. Per capire Rascida, o provarci, bisogna anche avere visto le
donne che hanno fatto la guerra senza allenarsi: affrontando di punto in bianco
la morte, la consapevolezza che la crudeltà è indispensabile se vuoi
sopravvivere. In un altro campo conobbi Im Castro: significa Madre di Castro. Im
essendo l’appellativo che i guerriglieri palestinesi usano per le donne, e
Castro essendo il nome scelto da suo figlio maggiore: fidayin. Im Castro era un
donnone di quarant’anni, con un corpo da pugile e un volto da Madonna bruciata
dalle intemperie. Acqua, vento, sole, rabbia, disperazione, tutto era passato su
quei muscoli color terracotta riuscendo a renderli più forti e più duri anziché
sgretolarli. Contadina a Gerico, era fuggita nel 1967 insieme al marito, il
fratello, il cognato, due figli maschi e due femmine. Qui era giunta dopo
Karameh e qui viveva sotto una tenda dove non possedeva nulla fuorché una
coperta e un rudimentale fornello con due pentole vecchie. Le chiesi: «Im
Castro, dov’è tuo marito?». Rispose: «È morto in battaglia, a Karameh». «Dov’è
tuo fratello?» «È morto in battaglia, a Karameh.» «Dov’è tuo cognato?» «È morto
in battaglia, a Karameh.» «Dove sono i tuoi figli?» «Al fronte, sono fidayin.»
«Dove sono le tue figlie?» «Agli addestramenti, per diventare fidajat. » «E tu?»
«Io non ne ho bisogno. Io so usare il Kalashnikov, il Carlov, e queste qui.»
Sollevò un cencio e sotto c’era una dozzina di bombe col manico. «Dove hai
imparato a usarle, Im Castro?» «A Karameh, combattendo col sangue ai ginocchi.»
«E prima non avevi mai sparato, Im Castro? » «No, prima coltivavo grano e
fagioli.» «Im Castro, cosa provasti ad ammazzare un uomo?» «Una gran gioia, che
Allah mi perdoni. Pensai: hai ammazzato mio marito, ragazzo, e io ammazzo te.»
«Era un ragazzo?» «Sì, era molto giovane.» «E non hai paura che succeda lo
stesso ai tuoi figli?» «Se i miei figli muoiono penserò che hanno fatto il loro
dovere. E piangerò solo perché essendo vedova non potrò partorire altri figli
per darli alla Palestina.» «Im Castro, chi è il tuo eroe?» «Eroe è chiunque
spari la mitragliatrice.» Le guerre, le rivoluzioni, non le fanno mai le donne.
Non sono le donne a volerle, non sono le donne a comandarle, non sono le donne a
combatterle. Le guerre, le rivoluzioni, restano dominio degli uomini. Per quanto
utili o utilizzate, le donne vi servono solo da sfondo, da frangia, e neanche la
nostra epoca ha modificato questa indiscutibile legge. Pensa all’Algeria, pensa
al Vietnam dove esse fanno parte dei battaglioni vietcong ma in un rapporto di
cinque a venti coi maschi. Pensa alla stessa Israele dove le soldatesse son così
pubblicizzate ma chi si accorge di loro in battaglia se non sono una figlia di
Moshe Dayan. In Palestina è lo stesso. Dei duecentomila palestinesi mobilitati
da Al Fatah, almeno un terzo son donne: intellettuali come Rascida, madri di
famiglia come Hanin, signore borghesi come Najat, contadine come Im Castro. Però
quasi tutte sono in fase di riposo o di attesa, pochissime vivono nelle basi
segrete, e solo in casi eccezionali partecipano a un combattimento. È
indicativo, ad esempio, che tra i fidayin al fronte non ne abbia incontrata
nessuna e che l’unica di cui mi abbian parlato sia una cinquantaquattrenne che
fa la vivandiera per un gruppo di Salt. È indiscutibile, inoltre, che l’unica di
cui si possa vantare la morte sia quella Sheila cui scoppiò una bomba in mano. A
usare le donne nella Resistenza non ci sono che i comunisti rivali di Al Fatah i
quali le impiegano senza parsimonia per gli atti di sabotaggio e di terrorismo.
La ragione è semplice e intelligente. In una società dove le donne hanno sempre
contato quanto un cammello o una vacca, e per secoli sono rimaste segregate al
ruolo di moglie di madre di serva, nessuno si aspettava di trovarne qualcuna
capace di dirottare un aereo, piazzare un ordigno, maneggiare un fucile. Abla
Taha, la fidajat di cui si parlò anche alle Nazioni Unite per gli abusi che subì
in prigione sebbene fosse incinta, racconta: «Quando mi arrestarono al ponte
Allenby perché portavo esplosivo, gli israeliani non si meravigliarono mica
dell’esplosivo. Si meravigliarono di scoprirlo addosso a una donna. Per loro era
inconcepibile che un’araba si fosse tolta il velo per fare la guerra». La stessa
Rascida, del resto, spiega che al corso di addestramento le donne venivano
incluse come «elemento di sorpresa ». Il discorso cui volevo arrivare, comunque,
la morale della faccenda, non è questo qui. È che la sorpresa su cui gli uomini
della Resistenza palestinese contavano per giocare il nemico, ha colto di
contropiede anche loro. «Tutto credevamo,» mi confessò un ufficiale della
milizia fidayin «fuorché le donne rispondessero al nostro appello come hanno
fatto. Ormai non siamo più noi a cercarle, sono loro a imporsi e pretendere di
andare all’attacco.» «E qual è la sua interpretazione?» gli chiesi. L’ufficiale
non era uno sciocco. Accennò una smorfia che oscillava tra il divertimento e il
fastidio, rispose: «Lo sa meglio di me che l’amore per la patria c’entra solo in
parte, che la molla principale non è l’idealismo. È... sì, è una forma di
femminismo. Noi uomini le avevamo chiuse a chiave dietro una porta di ferro, la
Resistenza ha aperto uno spiraglio di quella porta ed esse sono fuggite. Hanno
compreso insomma che questa era la loro grande occasione, e non l’hanno perduta.
Le dico una cosa che esse non ammetterebbero mai in quanto è una verità che
affoga nel loro subcosciente: combattendo l’invasore sionista esse rompono le
catene imposte dai loro padri, dai loro mariti, dai loro fratelli. Insomma dal
maschio». «E sono davvero brave?» «Oh, sì. Più brave degli uomini, perché più
spietate. Abbastanza normale se ricorda che il loro nemico ha due facce: quella
degli israeliani e la nostra. » «E crede che vinceranno?» «Non so. Dipende dal
regime politico che avrà la Palestina indipendente. Capisce cosa voglio dire?»
Voleva dire ciò che dice, silenziosamente, Rascida. La società araba non è una
società disposta a correggere i suoi tabù sulla donna e sulla famiglia. Le
tradizioni mussulmane sono troppo abbarbicate negli uomini del Medio Oriente
perché a scardinarle basti una guerra o il progresso tecnologico che esplode con
la guerra. Finché dura l’atmosfera eroica, lo stato di emergenza, può sembrare
che tutto cambi: ma, quando sopraggiunge la pace, le vecchie realtà si
ristabiliscono in un battere di ciglia. Lo si è visto già in Algeria dove le
donne fecero la Resistenza con coraggio inaudito e dopo ricaddero svelte nel
buio. Chi comanda oggi in Algeria? Gli uomini o le donne? Che autorità hanno le
Rascide che un tempo piazzavano le bombe? Perfino gli ex guerriglieri hanno
quasi sempre sposato fanciulle all’antica, senza alcun merito militare o
politico. Maometto dura: dura più di Confucio. Sicché tutto fa credere che i
palestinesi, pur essendo tra gli arabi più europeizzati e moderni, commettano in
futuro la stessa scelta o ingiustizia degli algerini: «Brave, bravissime,
sparate, aiutate, ma poi via a casa». Ma, sotto sotto, le loro donne lo sanno e,
poiché la Storia non offre solo l’esempio dell’Algeria, corrono fin da ora ai
ripari. Come? Buttandosi dalla parte di coloro che abbracciano l’ideologia della
Cina maoista: cioè il Fronte Popolare di George Abash. In Cina le donne non sono
mica tornate a lavare i piatti; stanno anch’esse al potere, hanno vinto. Per
vincere è necessario annullare ogni sentimento, incendiare le case dei vecchi,
gli ospedali dei bambini, il più innocuo supermarket? E va bene. Per vincere è
necessario imbruttirsi, sacrificare i genitori, credere nel socialismo
scientifico, rendersi odiose? E va bene. Ciò che conta è non ricadere nel buio
come le algerine, quando la pace verrà. Ciò che conta è non rimettere il velo
quando gli uomini saranno in grado di cavarsela, come sempre, da soli. Può
sembrare un paradosso, e forse lo è. Ma vuotando quei due bussolotti di
marmellata e ficcandoci dentro esplosivo, Rascida non fece che comprarsi il
domani. In fondo le ventisette creature che essa maciullò a Gerusalemme morirono
perché lei si togliesse per sempre il velo e lo trasferisse sul volto dolcissimo
del suo fidanzato, l’ignaro Thaer. Amman, marzo 1970 (Tratto da Intervista
con il potere, Rizzoli 2009)
"Decapitazioni e orrore,
Medusa tra di noi". Il
sentimento di Marco Belpoliti per il 2015. Il suo sguardo era scomparso da
secoli dall’iconografia collettiva, ma le immagini con le decapitazioni
dell’Isis lo hanno fatto tornare. E di nuovo ci pietrifica. Lo scopo dei
carnefici non è solo quello di uccidere, bensì d’infierire sul corpo.
Esattamente come accadeva nei supplizi precedenti l’Illuminismo, scrive
Marco Belpoliti “L’Espresso”
Il primo è stato il fotoreporter americano James Foley. Poi nell’arco di un mese
sono stati decapitati un altro reporter statunitense, Steven Sotoff, e il
cooperante scozzese David Haines. Il rito pressoché identico prevede che il
condannato sia vestito di un camicione arancione, mentre il boia è in nero, con
il capo e il viso occultati. Tiene in mano un coltello esibito come strumento di
morte. La decapitazione ha generato un immediato senso di orrore lasciando
attonita l’intera platea televisiva occidentale.
Le immagini della decollazione
sono state viste da milioni di persone
e commentate da giornali, televisioni, siti internet. Basta? No. Pochi giorni fa
la notizia che un commando di talebani pakistani entra in una scuola a Peshawar
e uccide a freddo 132 bambini e i loro insegnanti, per poi essere a loro volta
uccisi dalle forze di sicurezza. L’orrifico è entrato nelle case degli abitanti
dell’Europa e dell’America. Qualcosa che era scomparso da due secoli almeno
dalle piazze del Vecchio Continente ha fatto così la sua cruenta riapparizione -
per quanto negli ultimi anni ci siano state molte altre decapitazioni, per
esempio nelle guerre combattute nell’ex Jugoslavia così come in altri sequestri
di ostaggi.
Basti ricordare il reporter
americano Daniel Pearl,
sequestrato in Pakistan e decapitato nel 2002, e il giovane imprenditore
Nicholas Berg in Iraq nel 2004: ma non sempre furono così platealmente visibili
all’opinione pubblica, e soprattutto non prevedevano la “serializzazione” che
caratterizza orrendamente le decapitazioni di oggi. Che appaiono quasi come
puntate di una atroce serie, in cui ciascun episodio contiene l’annuncio del
successivo. All’inizio del
suo volume “Sorvegliare e punire” (1975) Michel Foucault racconta un supplizio,
tratto dalla “Gazzetta di Amsterdam”, cui è condannato il 2 marzo 1757 tale
Robert-François Damiens. Il suo corpo è squartato tra terribili tormenti sulla
pubblica piazza a opera di sei cavalli, che tirano le membra da parti opposte.
Nell’arco di pochi decenni da quella data in Europa si smette di amputare, fare
a pezzi e marchiare i condannati;
il corpo non è più oggetto
dello spettacolo pubblico,
così da scomparire come “principale bersaglio della repressione penale”. Salvo
poi fare la sua terribile ricomparsa con il Terrore, attraverso l’uso della
ghigliottina e delle teste mozzate esibite, ancora sulle piazze, durante la
Rivoluzione francese. Nel sistema giuridico americano, dove tutt’ora esiste la
pena di morte cancellata invece in Europa, ha ricordato di recente Giorgio
Mariani, è contemplata l’uccisione del condannato mediante una iniezione letale,
sistema indolore e privo di spettacolarità. Nella cultura puritana di quel
Paese, almeno sul suo territorio, è respinta come barbara ogni forma di
decollazione: la testa non può e non deve essere separata dal corpo, il quale va
conservato nella sua integrità nel momento in cui viene eseguita una sentenza di
morte. L’orrore
che hanno suscitato i filmati dell’Isis proviene anche da questa tradizione,
oltre che dal culto del corpo che negli ultimi settant’anni si è diffuso in
Occidente. Questo nonostante che nei decenni passati in Europa, come in altri
luoghi del Pianeta, siano accaduti fatti terribili,
le guerre e i conseguenti
massacri della ex-Jugoslavia,
o le vicende del genocidio in Uganda, con amputazioni, decapitazioni,
squartamenti. In Europa la decapitazione degli ostaggi americani e inglesi nelle
mani dei membri dell’Isis sono state vissute come un ritorno al passato, a
pratiche medievali, barbariche. Questo nonostante che nella nostra tradizione
iconografica sia ben presente l’immagine della decollazione, quella di san
Giovanni Battista, o quella di Giuditta nei confronti di Oloferne, come ci ha
ricordato non molti anni fa la mostra allestita da Julia Kristeva al Museo del
Louvre, poi raccolta in “La testa senza il corpo” (Donzelli). C’è persino un
santo, San Dionigi, protettore di Parigi, il cui miracolo è consistito nel
mettersi sotto braccio la propria testa tagliata, per mano dei soldati romani, e
risalire la collina che prende ora il suo nome nella capitale francese. Per
quanto espunto dalla nostra giustizia, l’orrore ritorna continuamente nelle
nostre cronache. Si è letto solo pochi giorni fa di una madre che avrebbe ucciso
il proprio bambino. L’orrore è cosa ben diversa dal terrore che con gli atti di
decapitazione l’Isis vorrebbe provocare nel mondo occidentale, qualcosa di più
profondo e radicale.
La parola “orrore”, ricorda Adriana Caravero, viene dal verbo
latino horreo, di incerta
etimologia ma di sicuro significato: indica il rizzarsi dei peli del corpo, il
suo tremolio per via dello spavento. Secondo uno studio, a rizzarsi sarebbero i
capelli, azione inconsueta ma possibile, che si conserverebbe nel significato
della parola italiana “orripilante”. La filosofa nel suo libro “Orrorismo”
(Feltrinelli), il cui titolo costituisce un neologismo, sostiene che esiste una
“fisica dell’orrore”, collegata a quella dell’agghiacciarsi, reazione
fisiologica al freddo, che provoca la cosiddetta “pelle d’oca”. Sono tutti stati
del corpo che colpiscono chi è esposto a spettacoli orripilanti. Primo Levi,
all’inizio della “Tregua”, descrive la reazione dei giovani soldati russi che
raggiungono il Lager dove il deportato si trova nel gennaio del 1945. I russi
osservano dall’alto dei loro cavalli lo spettacolo bestiale dei cumuli dei
cadaveri abbandonati dai nazisti in fuga. Orrore e insieme ripugnanza, qualcosa
di diverso dalla paura, una forma di ribrezzo che in un libro, “Poteri
dell’orrore” (Spirali), Julia Kristeva ha definito “ribrezzo”.
C’è una figura classica che
incarna perfettamente l’orrore di cui si parla: Medusa.
La sua visione agghiaccia, paralizza, pietrifica. L’orrore è tale che chiunque
ne fissi il viso - gli occhi, lo sguardo, ma anche i capelli a forma di serpenti
come l’ha dipinta Caravaggio - viene trasformato in roccia. Quelle che si
presentano al nostro sguardo nei film rilasciati nel web dai carnefici dell’Isis
sono immagini inguardabili, ripugnanti, che fanno ribrezzo. Lo scopo di questi
carnefici non è solo quello di uccidere, bensì d’infierire sul corpo,
esattamente come accadeva nei supplizi che precedono le riforme penali prodotte
dall’Illuminismo nel diritto occidentale. Si vuole distruggere l’unità del corpo
provocando negli spettatori l’orrore. Più questo, ribadisce Caravero, che non il
terrore. C’è un’altra figura mitologica che viene spesso evocata proprio per
definire l’altro aspetto dell’orrore, cui ci hanno abituato le cronache recenti:
Medea.
Ripudiata da Giasone a vantaggio della figlia del re di Corinto,
Medea uccide i suoi figli per
vendetta, come racconta
Euripide nella tragedia. Lei, che aveva aiutato il suo uomo a conquistare il
Vello d’oro, diventa il modello degli infanticidi a seguire. In una versione del
mito citata da Károly Kerényi, Medea taglia a pezzi i corpi delle sue vittime,
evocando così la fantasia orripilante dello smembramento. Adriana Cavarero
sottolinea come non esista un analogo mito maschile per descrivere l’orrore
dell’uccisione dei propri congiunti, e come l’orrore dell’infanticidio sia
ascritto alla madre quale segno di una follia estrema. Per riscattare Medea, o
almeno cercare di capire l’orrore che la abita, la filosofa ricorda un episodio
presente nel libro di W. G. Sebald, “Storia naturale della distruzione”
(Adelphi), dedicato ai bombardamenti con cui gli Alleati distrussero le città
tedesche nel corso del Secondo conflitto mondiale. Durante una fuga dalle
tempeste di fuoco, a una donna si aprì di colpo la valigia che recava. Non
conteneva gioielli o oggetti, ma il cadavere di suo figlio. Sebald riporta altri
casi in cui le madri recarono con loro nella fuga corpi di bambini soffocati dal
fumo o uccisi dai bombardamenti. Nella disperazione, scrive l’autrice, in cui
l’orrore le aveva immerse, queste donne cercavano di curare le loro inermi
creature oltre la stessa morte. Un modo per salvare i corpi dall’orrore
terribile di quella distruzione.
Davanti all’orrore delle
immagini trasmesse dal web o sui canali televisivi,
riportate nelle pagine dei giornali sotto forma di fotografie, a Gaza come in
Afghanistan, in Cecenia come in Siria, possiamo decidere legittimamente di
distogliere lo sguardo, cambiare canale, girare pagina, per non restare
paralizzati, pietrificati da quello che si vede. Per quanto evochino qualcosa di
pornografico – piacere morboso insieme all’orrore, com’è stato giustamente detto
– non possiamo esimerci dal sapere che queste immagini hanno un valore etico,
come ci ha ricordato Susan Sontag in “Davanti al dolore degli altri”
(Mondadori). Fanno sorgere domande decisive e ci rendono consapevoli del fatto
che esseri umani commettono cose terribili nei confronti di altri esseri umani.
Cavarero la chiama “la violenza sull’inerme”, ed è questo il vero orrore che
suscitano in noi.
Fatwa e morte. Così
uccidono la satira,
scrive Simone Di Meo su “Il Tempo”. Si dice che quando l'uomo con
la penna incontra l'uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto.
Si dice, però. Perché la scia di sangue che ha macchiato libri, pellicole e
paginate di giornale fresche d'inchiostro è ben più lunga di quella freschissima
lasciata sulle vignette di Charlie Hebdo. Il settimanale che, ironia del
destino, nel 2006 aveva deciso di mandare in edicola per solidarietà, insieme a
numerosi quotidiani europei, anche italiani, le caricature di Maometto
pubblicate l'anno prima sul quotidiano danese Jyllands-Posten e successivamente
sul giornale norvegese Magazinet. In uno dei disegni, il profeta dell'Islam era
raffigurato con una bomba al posto del turbante (il vignettista Kurt Westergaard
da allora vive sotto costante protezione della polizia e solo per miracolo i
tentativi di assassinio ai suoi danni non sono riusciti). Alla pubblicazione di
quelle immagini, successe il finimondo: dall'Africa, al Medioriente,
all'Afghanistan, all'Indonesia esplosero le proteste di piazza. In Nigeria
morirono 130 persone negli scontri. A quel punto, il premier norvegese Anders
Fogh Rasmussen all'inizio del 2006 raggiunse un accordo con la Lega Araba per la
distribuzione di una lettera che era sostanzialmente di scuse e che, pur
difendendo il principio della libertà di espressione, stigmatizzava la
«demonizzazione» di alcuni gruppi in base all'appartenenza religiosa ed etnica.
Il 30 gennaio giunsero le scuse anche del direttore del Jyllands-Posten. L'8
febbraio, una provocazione dell'allora ministro leghista Roberto Calderoli
legata alle vignette incriminate, portò ad una violenta protesta in Libia e ad
un attacco al consolato italiano di Bengasi, nel quale morirono 11 manifestanti.
Ancor prima, il 2 novembre del 2004, c'era stato l'omicidio di Theo van Gogh, il
regista olandese di “Submission”, un cortometraggio che aveva fatto scandalo nel
mondo islamico per la scelta di scrivere dei versi di una sura del Corano sulla
schiena della protagonista. L'assassino, Mohammed Bouyeri, in possesso della
doppia cittadinanza olandese e marocchina, intercettò van Gogh nel centro di
Amsterdam, esplodendo contro di lui otto colpi di pistola. Gli tagliò anche la
gola e gli piantò nella pancia due coltelli, in uno dei quali era conficcato un
documento contenente minacce ai governi occidentali, agli ebrei e ad Ayaan Hirsi
Ali, deputata di origini somale ed autrice del film insieme a van Gogh. Il film
fu ritirato e anche il produttore, Gijs van Vesterlaken, subì gravi minacce.
Fino ad allora, l'unica condanna a morte nei confronti di un intellettuale
inviso al regime islamico risaliva al 1989 ed era stata spiccata nei confronti
dello scrittore britannico di origine indiana Salman Rushdie, all'epoca già una
star affermata della narrativa internazionale. Nel suo libro, “I versetti
satanici”, aveva fatto allusivamente riferimento alla figura del profeta
Maometto. Fu per questo che a febbraio di quell'anno l'ayatollah Khomeini emanò
una fatwa nella quale condannava a morte Rushdie, colpevole, a giudizio della
massima autorità iraniana, di bestemmia. I killer non riuscirono a trovarlo ma
nel 1991, fu accoltellato a morte da uno sconosciuto il traduttore giapponese
dell'opera, Hitoshi Igarashi; e nello stesso anno, fu ferito anche il traduttore
italiano, Ettore Capriolo, mentre nel 1993 fu la volta dell'editore norvegese
del libro. Dopo la morte di Khomeini, la fatwa fu confermata nel 2005
dall'ayatollah Ali Khamenei, ma lo stesso Rushdie ammise che la condanna a morte
aveva ormai un valore più retorico che reale. Anche se, nel 2012, lo scrittore
fu costretto a rinunciare alla partecipazione al festival internazionale di
letteratura di Jaipur, in India. I fanatici della Mecca erano tornati a farsi
vivi.
Giannelli: «Non sapremo
reagire La nostra società si è assuefatta al peggio»,
scrive “Luca Rocca su “Il Tempo”. L’uccisione dei giornalisti satirici del
Charlie Hebdo, a Parigi, non sorprende Giannelli. Di una cosa il vignettista
appare certo: stanno cercando di intimidirci. Ed è anche convinto, inoltre, che
l’Occidente sia così assuefatto al peggio, che neanche di fronte a una strage di
questa portata sarà in grado di reagire.
Giannelli, tre terroristi
imbracciano un kalashnikov e colpiscono al cuore la nostra libertà.
«In questo mondo non mi
stupisce più niente. La barbarie del nostro tempo supera qualsiasi
immaginazione. Chi mai, fino a pochi anni fa, poteva immaginare che saremmo
entrati in un tunnel così buio? Bisognerebbe scavare a fondo alla vicenda,
capire le radici di questo odio, da dove proviene».
Nella sua carriera, si è
mai imbattuto nell’intolleranza dell’Islam?
«Tanti anni fa, quando
collaboravo con Repubblica, io e Forattini fummo convocati da Eugenio Scalfari,
il quale ci raccomandò di andarci cauti con le vignette sull’Islam. Ho pensato
che avesse ricevuto messaggi allarmanti. Personalmente però non ho mai ricevuto
minacce».
Perché colpire la satira?
«L'integralismo islamico è
intolleranza all'ennesima potenza, non riguarda solo la satira. Ma è vero che
verso lo humor l’Islam ha una chiusura ermetica. Credo, però, che un attacco
come quello al Charlie Hebdo rappresenti soprattutto un’intimidazione. Dopo una
strage come quella avvenuta in Francia, infatti, anche se inconsciamente, prima
di pubblicare un'altra vignetta contro Maometto, ci pensi due volte».
Saremo capaci di reagire?
«Io sono vecchio, ero
ottimista e non lo sono più. Ho la sensazione che le reazioni della nostra
società siano sempre meno frequenti. Siamo capaci di assuefarci a tutto. Ciò che
un tempo ci sarebbe sembrato enorme, adesso ci appare quasi accettabile».
Quello di ieri è l’11
settembre della stampa?
«In un certo qual modo è così,
ma non vedremo la stessa reazione vista dopo l’attacco del 2001 alle Torri
Gemelle. E sa perché? Perché sono passati più di 10 anni, e lentamente ci siamo
abituati a ogni efferatezza».
Krancic: «Per proteggere
l’Islam l’Occidente si sta suicidando»
, scrive “Il Tempo”. È una
tappa del suicidio dell’Occidente. A dirlo, nel giorno in cui gli integralisti
islamici assaltano il cuore dell’Europa uccidendo dei disegnatori di satira che
la loro «libertà di matita» la indirizzavano anche contro Allah, è uno dei
maggiori vignettisti italiani, Alfio Krancic, che si dice sconvolto.
Qual è stato il suo primo
pensiero alla notizia della la strage nella redazione del Charlie Hebdo?
«Sono ancora frastornato. Aver
colpito un settimanale simbolo della trasgressione satirica, è indicativo del
clima di odio che si è scatenato verso le manifestazioni di libertà
dell'Occidente».
Lei ha mai realizzato
vignette sull'Islam?
«Certo, anche sull’Isis e il
“califfo nero” al Baghdadi, prendendo sempre le parti di Assad, Gheddafi,
Saddam. Meglio quei regimi arabi laici che salvaguardano le altre religioni e ci
proteggono dal fanatismo islamico. Perché quando in quei paesi le dittature
cadono, non arriva la democrazia. E lo dimostra anche l'attentato in Francia».
Hai ricevuto minacce per
quelle vignette?
«No. In Italia,
fortunatamente, la minaccia islamica non ha mai preso di mira la satira, ma
qualche giornalista, come Magdi Allam, o qualche politico, come Roberto
Calderoli, rei di avere idee non in linea con il pensiero islamico e di
manifestarle come desiderano».
Perché la satira sull’Islam
provoca morte?
«La colpa è anche del
politicamente corretto. Corretto unilateralmente, visto che protegge alcune
espressioni religiose, come l'Islam, ma non la nostra religione, il
cristianesimo. Una forma sadomasochistica ha pervaso le menti dell'Occidente.
Siamo persino arrivati a contemplare il reato di islamofobia. L'Occidente si sta
suicidando».
Un massacro come quello di
ieri può segnare la fine del multiculturalismo in Europa?
«È molto difficile. Le forze
culturali e intellettuali che dominano in Europa sono troppo forti. Impediranno
ad alcuni movimenti politici e culturali di prendere il sopravvento sul
multiculturalismo. Al contempo, però, la strage inevitabilmente aumenterà
l'intolleranza verso gli intolleranti».
Vauro: «Difendo il diritto
al gioco della libertà e alla libertà del gioco»,
scrive Massimiliano Lenzi su “Il Tempo”. «La satira è tale perché da sempre
sbeffeggia i potenti ed i prepotenti». Vauro, vignettista e satirico a sinistra
da una vita (da Il Manifesto a Servizio Pubblico, su La7) - che trent'anni e
passa fa, come racconta a Il Tempo, «ha lavorato pure al Charlie Hebdo» - il
giorno dopo l'attentato dei fondamentalisti islamici al giornale satirico
francese, è sconvolto ed addolorato. «Sono fuori di me, perché la satira è la
libertà assoluta e nessuno deve violentarla. Mai. Perché la satira è da sempre
contro tutti i tipi ed ogni forma di fondamentalismi».
Gli chiediamo cosa, secondo
lui, toscano che attinge la propria ironia da Cecco Angiolieri in avanti,
rappresenti per le nostre libertà ciò che è successo a Parigi.
«Si è colpita un'arte –
risponde –, la satira, che è la cosa meno violenta che si possa immaginare
perché qualsiasi tema affronti è sempre un gioco. C'è sempre un elemento di
gioia e di poesia nell'ironia satirica e l'irruzione di una violenza così
assurda e demente incarna un attentato contro la fantasia degli uomini e delle
donne. È come se i terroristi assassini avessero fatto irruzione durante l'ora
di ricreazione in una scuola, compiendo una strage efferata di bambini, Erodi
contro ogni libertà, perché vede, la satira ha sempre una propria componente
infantile. E poi devo dirle che che c'è un'altra cosa, ancora, che mi
preoccupa...».
Che cosa?
«Quello che mi preoccupa è che
sento già parlare di scontri e di guerre di religione. Io – aggiunge – vorrei
sperare che la satira non diventi arruolabile da nessuno, mai. Vede, sui social
media ieri mi sono arrivati inviti a fare vignette contro Maometto, per
dimostrare di avere le palle. Ma io non credo si possa fare satira per
dimostrare di avere le palle, perché la forza del ridere deve essere più forte
della fine, anche della morte. Quello che voglio ostinatamente difendere,
continuare a difendere, è il diritto al gioco della libertà ed alla libertà del
gioco. Perché dopo l'attentato vigliacco di Parigi al Charlie Hebdo siamo tutti
meno liberi. Ed anche meno felici».
Vincino: «L’Islam non
c’entra? Certi soloni vadano a quel paese»,
scrive ancora Lenzi. «La cosa tragica e divertente, sa quale è? È ascoltare
certi Soloni dire che l'Islam non c'entra niente, perché è buono e non c'entra
che i killer, uccidendo, hanno gridato di vendicare Maometto, con la frase di
rito "Allah akbar": ma andate tutti quanti a quel paese, ipocriti!». Vincino,
vignettista de Il Foglio ed anticonformista da una vita intera, non si rassegna
all'ecatombe delle libertà che si è consumata ieri nel cuore di Parigi, e alla
mollezza di certe reazioni italiane ed occidentali. «Ieri hanno centrato ed
ucciso un posto come verità, e non come simbolo. Perché il Charlie Hebdo era il
luogo dove è nata la libertà di satira in Europa, ed anche la mia. "Il Male" con
i suoi autori nacque anche grazie a loro, tutte la rubriche delle copertine
rifiutate ad esempio, una colonna straordinaria con 4 vignette terribili in cui
potevi mettere le cose più libere ed inimmaginabili». Poi Vincino si sofferma
sulle persone, e spiega che «all'interno di Hebdo trovavi poeti veri, come
Georges Wolinski, figlio di un polacco e di un'italiana emigrati in Tunisia, un
poeta dell'amore e del sesso. E vedere Wolinski morire durante una riunione di
satira mi commuove». Perché Vincino, sulla satira, come spiega al nostro
giornale, «ha fatto un festival, a Roma, all'epoca di Nicolini. Wolinski era
come tutti i veri umili, semplice e generoso. Ma liberi totalmente. E questo
vale per il Charlie Hebdo, che perciò va a cozzare con le religioni. Sempre.
Poi, oggi, ci sono le religioni che sono un po' più buone ed altre in alcune
parti del mondo, più cattive. Cattivissime. L'Hebdo non ha mai ceduto un
centimetro sulla vivisezione delle religioni, sia cattolica che islamica.
Avevano capito per primi la questione della libertà poste dalle vignette
pubblicate dal giornale danese Jyllands-Posten su Maometto, e seguite da
mobilitazione contro nei paesi arabi. Roberto Calderoli, una vignetta se la mise
su una maglietta sotto la giacca. Noi, comunque sia, speriamo di non finire mai
in una maglietta di Calderoli ma quello che ieri è stato attaccato sono
l'illuminismo e la nostra civiltà».
Ecco i nomi delle dodici
vittime dell'attacco del 7 gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo:
- Stephane Charbonnier, alias
Charb, vignettista e direttore;
- Georges
Wolinski, vignettista;
- Jean Cabut,
alias Cabu, vignettista;
- Bernard
Verlhac, alias Tignous, vignettista;
- Philippe Honoré,
vignettista;
- Bernard Maris, economista ed
editorialista;
- Elsa Cayat, psicologa e
giornalista;
- Michel Renaud, ex
consigliere del sindaco di Clermont Ferrand;
- Mustapha Ourrad, correttore
di bozze;
- Fréderic Boisseau, addetto
alla portineria;
- Franck Brinsolaro,
poliziotto;
- Ahmed Merabet, poliziotto.
Decapitato l’umorismo
francese.
Quattro celebri vignettisti tra le vittime: Charb, Cabu, Tignous e Wolinski
Sull’ultimo numero la caricatura di un terrorista: «Gli auguri entro gennaio»,
scrive Antonio Angeli su “Il tempo”. Cinque minuti di puro terrore, un muro di
piombo e fuoco: alla fine in terra, senza vita, restano in 12. Parigi e il mondo
piangono il più grave e sanguinoso atto di terrorismo degli ultimi anni: sono
rimasti uccisi 8 giornalisti, 2 agenti, un ospite della redazione e il portiere
dello stabile. Delle vittime alcuni sono celebri: vignettisti, inguaribili
umoristi, di quelli che se cerchi di mettergli il bavaglio diventano più tenaci,
e gli è costata cara, soni diventati bersaglio di una violenza inaudita; una
strage che ricorda quella all’inizio di un vecchio film di spionaggio: «I tre
giorni del Condor».
Ucciso il direttore del
settimanale satirico parigino «Charlie Hebdo», Stéphane Charbonnier detto
«Charb» , celebre disegnatore satirico, classe 1967, in passato già
minacciato più volte per le vignette su Maometto, e per questo messo sotto la
protezione della polizia. Non gli è servito, non è stato sufficiente. Nel numero
uscito proprio la scorsa settimana c’è la sua ultima vignetta, profetica e
agghiacciante, ora che si è consumato il massacro. Il titolo dell’illustrazione:
«Ancora nessun attentato in Francia», sotto il pupazzetto che raffigura un
terrorista islamico, con la barba e il mitra sulle spalle, che dice: «Aspettate!
Abbiamo tempo fino alla fine di gennaio per fare gli auguri». Caduti sotto il
fuoco dei terroristi i tre più importanti vignettisti della testata: Cabu,
Tignous e Georges Wolinski, molto famoso anche in Italia, da anni.
Nell’attentato è rimasto ucciso anche l’economista Bernard Maris, azionista
della testata parigina.
Jean Cabut meglio noto come
Cabu , 76
anni, antimilitarista e di spirito anarchico, ha collaborato con tutte le
principali testate francesi come caricaturista e disegnatore di fumetti.
Attualmente disegnava sia per «Charlie Hebdo» che per il suo principale
concorrente, «Le Canard Enchainé». Per «Pilote», una delle principali riviste
francesi di fumetti, aveva creato il personaggio del «Grand Duduche», liceale
maldestro. Era il padre del cantante Mano Solo, morto di malattia nel 2010.
Charb, 47 anni, disegnatore satirico, collaborava anche con il quotidiano del
partito comunista «L’Humanité» e due delle principali riviste francesi di
fumetti, «Fluide Glacial» e «L’Echo des Savanes». Sue le strisce, irriverenti e
al limite del pornografico, del cane Maurice, bisessuale e anarchico, e Patapon,
gatto asessuato e fascista.
Ucciso anche Bernard
Verlhac, detto Tignous , 57 anni. I suoi disegni venivano pubblicati da
«Charlie Hebdo», «Marianne» e «Fluide Glacial».
E poi c’era il più famoso di
tutti, fumettista e vignettista noto, non solo in Francia, ma anche in Europa,
per il suo caratteristico taglio caustico nel rappresentare la quotidianità. È
Georges Wolinski , con «Charlie Hebdo» collaborava da anni. Nato a Tunisi
il 28 giugno del ’34, Wolinski aveva esordito come disegnatore per la rivista
«Hara-Kiri», dalla quale era poi passato a «Action», «Paris-Presse», «Hara-Kiri
Hebdo», «L’Humanité», e infine «Paris-Match». Attualmente era anche capo
redattore di «Charlie Mensuel». Wolinski aveva ottenuto la popolarità con i
fatti del maggio del ’68, attraverso la rivista «Action». La sua cifra
stilistica era costituita dalla capacità di porre l’accento sui personaggi,
dall'ampio uso di doppi sensi, anche sessuali - tanto da farlo conoscere a molti
come l'umorista del sesso - e dal taglio caustico nel rappresentare il cinismo
quotidiano. Il fumettista era anche noto per avere collaborato, negli anni ’70,
con Georges Pichard creando il personaggio di Paulette.
Bernard Maris
era invece un professore d’economia allo Iep di Tolosa e attualmente insegnava
anche all’Istituto di studi europei dell’università Parigi-VIII. Il 68enne era
anche una firma per diversi giornali, come «Le Monde», «Le Figaro Magazine» e
«Le Nouvel Observateur». Del settimanale satirico era stato uno dei fondatori,
con l’11% delle azioni, e fino al 2008 direttore aggiunto. Era uno dei
principali studiosi della globalizzazione «etica e sociale». Un grande
intellettuale francese, tra le sue attività, anche la scrittura, con la
pubblicazione di diverse opere letterarie.
Non tutte le firme del
settimanale satirico sono state messe a tacere. È una carneficina che «ha
decapitato» il settimanale, come succede in «Siria e in Iraq»: così ha reagito
Bernard «Willem» Holtrop, vignettista di «Charlie Hebdo», scampato all’assalto
che ricorda che le vittime «non sono dei colleghi, sono degli amici». E la
carneficina del settimanale parigino ha scatenato una silenziosa, gigantesca
reazione, a livello mondiale. In Francia tantissime persone sono scese in strada
con un cartello: «JeSuisCharlie», «Io sono Charlie», con il chiaro riferimento
alla testata. L'ambasciata americana a Parigi ha anche cambiato la sua icona
Twitter in #JeSuisCharlie, in segno di sostegno alla Francia. «La libertà di
espressione è un diritto umano», ha twittato Amnesty Italia.
Charlie Hebdo, una storia
di satira irriverente.
La testata è nota per le vignette e illustrazioni, ma anche per
gli articoli incentrati su politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo,
islam e giudaismo, scrive “Il Tempo”. Charlie Hebdo è un settimanale satirico di
tradizione libertaria, dal tono irriverente e anticonformista. Il giornale
difende le libertà individuali e ha un orientamento di sinistra, fortemente anti
religioso. Charlie Hebdo è noto per le vignette e illustrazioni, ma anche per
gli articoli incentrati su politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo,
islam e giudaismo. Anche se prende di mira principalmente i politici di destra,
il settimanale non risparmia neanche i partiti di sinistra francesi. Secondo
l'attuale direttore, il disegnatore Stéphane Charbonnier, noto come Charb, il
giornale riflette "tutte le componenti del pluralismo di sinistra e perfino
dell'astensionismo".
Nel 2006
il giornale suscitò polemiche pubblicando una serie di caricature del profeta
Maometto, diffuse inizialmente dal quotidiano danese Jyllands-Posten. Nella
settimana precedente le illustrazioni avevano suscitato proteste in alcuni Paesi
musulmani. Diverse organizzazioni musulmane francesi, tra cui il Consiglio
francese del culto musulmano, chiesero di seguito di mettere al bando il numero
del settimanale contenente altre caricature di Maometto, ma la richiesta non fu
accolta.
Nel 2011
la sede del giornale venne colpita da alcune bombe molotov; l'attacco fu
lanciato prima dell'uscita nelle edicole di un numero con in copertina un'altra
vignetta satirica con Maometto. Il sito web del settimanale fu invece preso di
mira da hacker. La storia di Charlie Hebdo comincia negli anni '60 ed è
strettamente legata a quella del mensile Hara-Kiri, lanciato da Georges Berniere
e François Cavanna, e definito da loro stessi "un giornale stupido e cattivo".
La rivista fu al centro di
diverse polemiche
e fu interdetta dalla magistratura nel 1961 e poi nel 1966. Trasformata
successivamente in settimanale, a novembre del 1970 la rivista suscitò critiche
dopo la morte di Charles de Gaulle, titolando in copertina "Bal tragique à
Colombey - un mort", ossia 'Ballo tragico a Colombey, un mortò, con un
riferimento alla residenza del generale. Di seguito le pubblicazioni di
Hara-Kiri vennero bloccate dal ministero dell'Interno francese, ma i giornalisti
aggirarono il divieto lanciando una nuova pubblicazione, Charlie Hebdo, che deve
il nome al famoso personaggio del fumetto Peanuts. Il settimanale rimase chiuso
tra il 1981 e il 1992 dopo un calo del numero di lettori. Prima di Charb a
guidarlo furono François Cavanna e Philippe Val. La rivista è pubblicata ogni
mercoledì.
Matite satiriche. Satiriche
come le penne di sinistra che alzano le sopracciglia quando si parla di satira
di destra.
Charlie Hebdo, parlano
Staino, Altan, Vauro e Makkox: «La satira non si fa intimidire».
Dopo l'attentato al giornale satirico
francese, che ha causato dodici vittime, parlano alcuni dei più celebri
fumettisti italiani. Che piangono gli amici scomparsi e dicono: "Questi omicidi
devono far crescere la nostra voglia di contrastare l'oscurantismo", scrive
Daniele Castellani Perelli su
“L’Espresso”. Hanno la
voce rotta. Cercano le parole giuste. Promettono che nulla cambierà nel loro
lavoro, ma temono che niente sarà più come prima. Alcuni dei più noti
vignettisti italiani, da Staino a Altan, da Vauro a Makkox, commentano al
telefono con “l'Espresso” la tragedia parigina, l'assalto al giornale satirico
“Charlie Hebdo”.
Il dolore più grande è quello di Sergio
Staino, che
nell'attacco ha perduto un amico, il disegnatore
Georges Wolinski.
«La mia prima reazione è stata di andare a vedere se tra le vittime ci fosse
Georges. Lo reputavo improbabile, visto che non lavora all'interno della
redazione. E invece hanno ammazzato anche lui, significa che sapevano che oggi
era prevista la riunione», racconta
Staino:
«Avevo conosciuto Wolinski all'inizio degli anni Ottanta, quando ero andato a
visitare la redazione di “Charlie Hebdo” a Parigi. Poi era stato più volte mio
ospite, e aveva anche partecipato a un mio film del 1992, “Non chiamarmi Omar”,
con Ornella Muti, ricordo che si era innamorato di Stefania Sandrelli». Staino,
storico disegnatore dell'“Unità”, ha fatto vignette su Hamas e l'Islam politico,
ma mai sulla religione musulmana in sé. Tuttavia ha sempre difeso il diritto
alla libertà di espressione, anche quando, dice, «le vignette erano
artisticamente di scarso valore, come quelle su Maometto, una peggiore
dell'altra, pubblicate in Danimarca dallo“Jyllands Posten”». La cosa che più lo
colpisce è che i terroristi abbiano voluto colpire i più deboli: «Non sono
andati a colpire che ne so la Cia, ma dei vignettisti. È come attaccare la Croce
Rossa, è una cosa da vigliacchi». E ora? Cambierà qualcosa nel mondo della
satira? I vignettisti si autocensureranno? «No, non succederà mai», risponde
Staino: «La nostra molla sono la ricerca della verità, lo sberleffo dei
fondamentalisti, il dubbio, l'antidogmatismo. Questi omicidi accresceranno la
nostra voglia di contrastare l'oscurantismo».
È d'accordo anche Vauro, storica
matita del “Manifesto” prima e di “Servizio pubblico” e “Annozero” poi. «Non
credo che reagiremo con quella forma tremenda di censura che è l'autocensura.
Noi che viviamo di satira siamo, che piaccia o no, degli istintivi. In noi
domina quell'elemento ludico, infantile, anche inopportuno come spesso sono
inopportuni i bambini, un elemento che non si fa intimorire dalle minacce di un
gruppo di intolleranti». Vauro conosceva Wolinski, e dice di essere rimasto
annichilito davanti alla notizia dell'attacco. Lo hanno colpito molto anche
certi inviti che gli sono arrivati sui social network, che gli dicevano «Ora
disegna Maometto se hai le palle». «Io ho disegnato Maometto, e ho anche
“affrescato” i muri dell'ospedale di Emergency a Kabul al tempo
dell'oscurantismo talebano. Non mi farò fermare dai fondamentalisti islamici, ma
non devo neanche dimostrare niente a nessuno».
Anche Francesco Tullio Altan,
storico vignettista di “Espresso” e “Repubblica”, ha perso degli amici oggi. Non
nasconde che ora possa diventare più difficile, per un vignettista, ironizzare
sull'Islam, ma non crede che l'attacco sia da intendersi contro il mondo della
satira: «Come gli attentati alle metropolitane o ai treni, questo non è che un
episodio della grande guerra contro la libertà in generale».
Makkox,
infine. Il disegnatore del “Post” e di “Gazebo” ammette di aver sentito crescere
in sé una rabbia davanti alla notizia. «Quei nomi, quei colleghi di cui a casa
ho i libri...», dice incredulo, per poi confessare il suo tormento interiore:
«Oggi cambia tutto. Questo attacco ci radicalizzerà tutti, spingerà tutti noi a
essere manichei, è come una chiamata alle armi. Il discorso pubblico verrà
sconvolto. Da un lato vorrei dire liberamente che non mi piacciono le vignette
contro Maometto o Gesù, che non le trovo efficaci, che il problema sono l'Isis e
i preti pedofili e non le religioni, però poi penso subito che un'opinione così
non potrò più esprimerla, perché potrei essere accusato di stare dalla parte dei
“nemici”. Dall'altra la rabbia che provo mi spinge a prendere posizione, a non
tirarmi indietro». La satira si farà più cauta? «Sì farà magari meno cauta, si
radicalizzerà, il rischio è che perderemo tutti un po' il senso critico, vincerà
l'estremista che è in noi, mentre proprio ora avremmo bisogno di essere
razionali».
Tutti sono consapevoli dei
tanti rischi che si aprono. Dice Vauro: «Quello che è successo a Parigi,
una vera azione militare, non deve innescare nuove guerre, non dobbiamo
inventare nuovi nemici dove non ce ne sono e generare nuovi conflitti armati».
Guardando all'Italia, Staino aggiunge: «Il pericolo è ora che nella vicenda
inzuppino il pane i fondamentalisti di casa nostra, la destra becera e
intollerante. A destra come a sinistra abbiamo bisogno che le persone più
illuminate guidino il dibattito, e aiutino la parte migliore del mondo musulmano
a farsi sentire».
Vauro Senesi e il
"coccodrillo" per Charlie Hebdo: pioggia di insulti sui social.
La doppia morale di Vauro Senesi. Va in tv con la maglia "Je suis Charlie",
salvo scordarsi le sue feroci critiche alle vignette di "Charb". Su twitter
infatti è scoppiata la bufera dopo il coccodrillo in diretta tv del vignettista
di Santoro a Sevizio Pubblico dedicato alle vittime del massacro di Charlie
Hebdo: "Parliamo ancora di guerra santa, sembra di essere nel medioevo, abbiamo
fatto passi da gigante indietro nel tempo. Siamo in guerra, ma perché facciamo
le guerre. Questi mostri li abbiamo creati noi", afferma Vauro da Santoro. Ma
dimentica quelle sue parole di qualche tempo fa contro le vignette di Charlie
Hebdo: "Questi disegni sono messaggi violenti che provocano reazioni violente".
Implacabile la reazione del web: "Vauro sei un paraculo".
Criticava Charlie, ora lo
piange Tutti contro il coccodrillo Vauro. Il vignettista di Santoro indossa la
maglietta di solidarietà, ma quando i francesi pubblicarono i disegni anti islam
li accusò di provocare "reazioni violente". E il web si scatena: "Che paraculo",
scrive Luigi Mascheroni su “Il Giornale”. Sui social, che non sono la
rappresentazione del mondo, ma ne incorniciano comunque un pezzo, c'è chi
ricorda che le vignette contro i cristiani non hanno mai prodotto vittime, ecco
la differenza tra noi e loro: «Bella la vita Vauro, neh!». C'è chi spegne la tv,
perché non può sopportare «Vauro, Ruotolo e tutti quei quaquaraquà che ora
alzano le matite al cielo, ma fino a ieri invece...». C'è chi non si ricorda,
fino l'altro giorno, vignette di Vauro sull'Islam, e chi ricorda invece che
Vauro attaccò le vignette danesi anti-Maometto perché, disse, «messaggi violenti
provocano reazioni violente». C'è chi ironizza sul fatto che ora «in Italia
aspettiamo la risposta di Vauro, che con sprezzo del pericolo farà una vignetta
molto aggressiva. Su Berlusconi o Renzi». E chi, esagerando come solo Twitter è
capace di esagerare, nel suo micidiale mix di sintesi e cinismo, digrigna la
tastiera: «Vauro con la maglietta "Jesuischarlie", lui, amico dei terroristi
islamisti...». E in effetti, l'altra sera, in una trasmissione come Servizio
Pubblico di Santoro che faticava parecchio, tra distinguo e cautele, tra
buonismo e correctness politica, ad avvicinare i termini «terrorismo» e «Islam»,
faceva impressione (per alcuni pena) vedere Vauro Senesi, in arte Vauro, in
pratica un disegnatore con le sue debolezze e i suoi talenti, come tutti noi,
indossare a favore di telecamera la t-shirt con la scritta Je suis Charlie .
Che, si vedeva, era fuori taglia, e non solo metaforicamente. Perché a Vauro
quella maglietta stava strettissima. Piange i colleghi francesi, ma nega che ci
sia una guerra in corso. Condanna i terroristi, ma non dice mai «terroristi
islamici». Sbuffa: «Parliamo ancora di guerra santa, sembra di essere nel
Medioevo, abbiamo fatto passi da gigante indietro nel tempo», ma dimentica che i
passi li ha fatti la civiltà cristiana, in avanti: e infatti per quanto ritenga
esecrabili le vignette satiriche contro il Papa, Comunione e liberazione non ha
mai organizzato una crociata su Parigi. Un po' troppi «ma», quando ci sono
persone uccise a colpi di Ak47 in nome di Allah. Ieri, sul Corriere della sera ,
in un pezzo nascosto a pagina 15, non richiamato in prima né postato sul sito
del quotidiano, Pierluigi Battista ha firmato un pezzo dal titolo «Vauro e gli
altri che bocciarono quelle vignette "provocatorie"», smascherando l'ipocrisia
di chi, come Vauro appunto o come Ruotolo, oggi piangono gli eroici giornalisti
di Charlie Hebdo , ma ieri li consideravano irresponsabili, dei provocatori. E
Vauro ha subito risposto su Dagospia invocando, per par condicio, la censura
subita per una vecchia vignetta su Berlusconi. Perdendo sia il senso della
misura sia quello del ridicolo. «Siamo in guerra, ma perché facciamo le guerre -
ha detto - Questi mostri li abbiamo creati noi». La colpa, anche se a sparare
sono gli «altri», è sempre nostra. Per il resto, quella che ci stanno disegnando
davanti agli occhi, è una vignetta già vista tante volte. Dentro ci sono molte
matite perfettamente appuntite nell'offendere il sentimento religioso cristiano,
più spuntate nel farlo con i simboli musulmani. Un'unica mina, una doppia
morale. E non fa ridere.
Quell'odio a ritmo di rap
dove "balla" il deputato Pd.
Molti dei jihadisti, tra cui uno di quelli di Parigi, cantavano le rime violente
in voga nelle comunità islamiche, Italia inclusa. In un video compare
l'onorevole Chauki, scrive Paolo Giordano su “Il Giornale”. Ormai non si può
più. Ora che il video del killer parigino Chérif Kouachi in versione rapper ha
fatto il giro del mondo (ma è stato girato nel 2005), è impossibile non
riconoscere il fil rouge che collega tanti jihadisti a questa espressione
musicale. Dopotutto anche il presunto carnefice dell'ostaggio decapitato James
Foley è l'inglese Abdel-Majed Abdel Bary che, prima di sparire, aveva un
microscopico seguito londinese come rapper. E pure qui in Italia le rime
violente vanno di moda, con varie sfumature. Si va da Amir Issa che nel video
Ius Music , (in cui canta «da Palermo a Torino scoppierà un casino»), ha
ospitato un deputato Pd di origini marocchine (Khalid Chauki), ai rapper che
incitano all'odio mortale come Anas El Abboubi, ora ventenne, arrestato a giugno
2013 per «addestramento finalizzato al terrorismo internazionale» però poi
rilasciato dopo pochi giorni: adesso sarebbe ad Aleppo con il nome di Anas
Al-Italy e, come si legge sul suo profilo Facebook, di professione «lavora
presso la Jihad». Quand'era in Italia, lui di origini marocchine ma arrivato
giovanissimo in provincia di Brescia, rappava: «Il martirio mi seduce, voglio
morire a mano armata, tengo il bersaglio sulla Crociata». Hai letto bene. Dopo,
dalla Siria ha annunciato, keffiah al collo e kalashnikov in mano, di aver
abbracciato la sharia con i ribelli siriani. Certo i toni sono diversi, ma
sempre aggressivi. Intollerabilmente. Ci sono rapper ultrafamosi come Busta
Rhymes, Ice Cube, Nas, Everlast o Jay Z che hanno inserito nelle proprie rime
espliciti e tolleranti riferimenti alla fede musulmana. E uno, non proprio
famoso per coerenza come Snoop Dogg, si è convertito all'Islam per tre anni dal
2009 prima di passare al Rastafarianesimo. Rap islamico si può ascoltare pure in
rete e scaricare in free download e, per quanto aggressivo e colorito, rimane
lontano dall'integralismo. Come quello celebrato quattro anni fa a Lignano
Sabbiadoro dai Giovani Musulmani d'Italia con il concorso di «anashid islamiyà»,
ossia canzoni islamiche in arabo. Un altro conto sono le rime che inneggiano
alla lotta armata e mortale. Sono un segno di quanto pericolosamente, e
nell'indifferenza pressoché totale di quasi tutta la politica e l'informazione,
la Jihad abbia fatto propri gli strumenti di comunicazione tipici del mondo
giovanile: il rap è il linguaggio musicale più usato dagli under 30 e i
terroristi lo hanno capito. Dopo una prima e lunga fase di totale chiusura a
forme musicali (ad esempio l'Afghanistan talebano era un paese orfano di ogni
tipo di musica) hanno drammaticamente assorbito i linguaggi giovanili
occidentali per piegarli alla propria propaganda assassina. Ad aprile il rapper
olandese-libanese Hozny ha pubblicato un video che mostrava la macabra
messinscena dell'esecuzione del deputato Geert Wilders. E proprio in quei giorni
il tedesco Deso Dogg (vero nome Denis Mamadou Cuspert) è morto combattendo con i
ribelli dell'Isis in Siria. Follie totali. Ora, anche in questo caso, il rischio
emulazione si dilata. E senza dubbio il rap, stile di protesta nato negli anni
'70 per cantare il bisogno dei neri americani di uscire dai «ghetti»
metropolitani, offre la metrica adatta e soprattutto l'indice di penetrazione
popolare più alto in tutto l'Occidente. Quindi non sarà difficile che in un
futuro immediato saltino fuori altri esempi di integralismo rap. Mutatis
mutandis , il punk o il metal sono stati passioni fugaci di terroristi in epoche
non troppo lontane. Ma il segreto per non trasformare le eccezioni in una regola
è non generalizzare. Oltre che un errore, l'equazione rap = terrorismo sarebbe
un assist imperdonabile alla peggiore delle propagande.
Terrorismo, provate a
mettervi nei panni di un musulmano.
Khalid Chaouki, parlamentare del Pd, parla a cuore aperto dei fatti di Parigi e
delle colpe dell'Islam, scrive Carmelo Abbate su “Panorama”. Khalid Chaouki è
nato a Casablanca, in Marocco. Ha 32 anni, è arrivato in Italia da bambino, è
cresciuto tra Parma e Reggio Emilia. È tra i fondatori dell’associazione
“Giovani musulmani d’Italia”, della quale è diventato presidente, siede nella
consulta per l’islam istituita al ministero dell’Interno, da ultimo è stato
eletto alla Camera dei deputati nelle file del Partito Democratico.
Come vive un musulmano
quello che sta succedendo a Parigi?
«Con
grande tensione, paura e sconcerto. Con la consapevolezza che bisogna tradurre
in azione concreta e positiva le sensazioni che affollano la nostra mente».
Proprio in questo momento
leggiamo che i terroristi sono rimasti uccisi durante le irruzioni delle forze
speciali, ma tra i morti ci sarebbero anche alcuni ostaggi.
«Altri
morti innocenti. Spero almeno sia la fine di un incubo, spero che le prossime
ore siano di silenzio e raccoglimento».
Torniamo a voi musulmani.
«I
fatti di questi giorni impongono una riflessione a tutti noi musulmani, ci
dobbiamo guardare dentro, aprire una riflessione e interrogare sul ruolo che
vogliamo avere nella società del futuro. Una riflessione che deve essere
trasparente, visibile, alla luce del sole».
Cosa c’è dentro il cuore di
un musulmano?
«C’è
grande dispiacere. C’è angoscia, per l’immagine e l’utilizzo che viene fatto
della tua religione. C’è vergogna, nel vedere la tua fede che viene associata
alla morte. C’è un dolore profondo, che non viene percepito dall’esterno».
Basta manifestarlo, urlare
se serve.
«Infatti,
io credo che noi musulmani proprio in queste ore dobbiamo fare un passo avanti,
andare oltre e costruire le basi di quello che sarà il modello di convivenza nel
futuro».
Trasformare questi eventi
tragici in occasione positiva?
«Nella
loro tragicità, i fatti di Parigi ci offrono l’opportunità per toglierci di
dosso il peso che noi musulmani ci portiamo dietro dall’11 settembre. È arrivato
il momento di urlare al mondo la nostra rabbia per il modo in cui viene
sottomessa e manipolata la nostra religione».
La moschea in Italia viene
considerata come una sorta di Rubicone, la linea che non bisogna attraversare,
la bandierina che non bisogna issare sul nostro territorio. Alla luce di quello
che sta succedendo in Francia e nel mondo, non pensa che sia una scelta
controproducente? Non pensa che sarebbe più facile la prevenzione contro i
cosiddetti cani sciolti se ci fossero dei luoghi di aggregazione e preghiera con
regole chiare e accettate da tutti? E con possibilità di controllo maggiore da
parte delle autorità?
«Sarebbe
tutto molto più semplice. Purtroppo l’Italia ha sprecato troppi anni in balia
della propaganda, senza ragionare da paese serio. Il diritto al culto va
regolamentato, e la moschea può diventare una occasione per isolare chi si
nasconde e fa proselitismo dentro gli scantinati».
I fatti a cui assistiamo in
diretta televisiva dalla Francia, lei come li giudica, atti di terrorismo o
guerra?
«Si
tratta di guerra, una guerra asimmetrica che va combattuta con una forte
controffensiva culturale da parte di tutti, con il mondo musulmano che deve
diventare il nostro principale alleato».
Cosa rimprovera al mondo
musulmano?
«Il
tentativo di etichettare questi fatti come la deriva violenta di un piccolo
gruppo criminale. Non è così. La questione è molto più ampia e ci investe nel
profondo. Nel mondo musulmano c’è un problema di reinterpretazione dei testi
sacri alla luce della modernità, va sancito in modo solenne il rapporto pacifico
con l’Occidente. Ci sono nodi teologici irrisolti che poi portano a gesti
criminali».
C’è il pericolo di gesti
inconsulti nei confronti delle comunità musulmane?
«Sta
già accadendo in Svezia e in Francia, sono state lanciate molotov contro
moschee. Serve un senso di unità molto forte, serve lo sforzo di tutti, come sta
avvenendo in Francia, con i musulmani che si stanno riversando sulle strade per
manifestare sgomento, indignazione e condanna».
Lei è oggetto di insulti
sui social network, come li vive, come li sopporta?
«Il
mio impegno civile è sempre stato di frontiera, vengo criticato anche da molti
islamici che mi accusano di essere troppo moderato».
Non ha paura?
«A
volte fa male, a volte fa paura. Ma se accetti una sfera pubblica e ti impegni
per un’Italia migliore, allora devi essere preparato a fare i conti con una
società impaurita dai fomentatori di odio professionisti».
Cosa le fa più male delle
immagini che ci arrivano da Parigi?
«Il
senso di impotenza che sta vivendo un grande paese come la Francia. Il totale
black-out di una città meravigliosa come Parigi, che adoro e che ho visitato con
mia moglie. Le fotografie di una Parigi deserta ci sbattono in faccia il
fallimento di tutti noi».
Charlie Hebdo siamo tutti
noi. La strage nel giornale
parigino è un attacco alla nostra stessa idea di civiltà. Una sfida portata
dall’estremismo fondamentalista che l’occidente deve affrontare e vincere.
Perché in gioco c’è il nostro modello di convivenza, scrive
Gigi Riva su “L’Espresso”.
Hanno sparato e ucciso nella sede del giornale satirico francese “Charlie Hebdo”
ma è come se lo avessero fatto nelle case di noi tutti. Perché quelle pallottole
sono idealmente indirizzate contro uno dei valori su cui si regge la nostra idea
di civiltà, progresso, democrazia. È un pilastro fondativo della modernità
occidentale il considerare che la satira è, deve essere, libera e nessun potere,
fosse anche un potere che fa ascendere la propria fanatica legittimità
direttamente da un dio, si può arrogare il diritto di imbrigliarla. “Charlie
hebdo” ha avuto il coraggio di ribadirlo, nella sua gloriosa e travagliata
storia (irridente anche nei confronti dei regnanti di Francia), davanti alle
minacce per i titoli, gli editoriali e le vignette che hanno avuto come
bersaglio l’Islam e Maometto (l’ultima, pubblicata sul sito pochi minuti prima
dell’assalto, la vedete qua sotto). La vignetta di “Charlie Hebdo” con il
califfo che augura: “e soprattutto la salute”Ma l’estremismo fondamentalista non
tollera lo sberleffo, mette al bando il sorriso. Vuole pervadere di cupezza
censoria e regolare nei dettagli la vita di sudditi da ridurre all’obbedienza.
Tutto il contrario di quanto l’Europa e i suoi cittadini hanno deciso per se
stessi, almeno dai Lumi in poi, da quando la libertà di espressione è diventata
un diritto inalienabile accanto agli altri che definiscono la dignità degli
umani. Che l’attacco a queste conquiste, a questo modo di intendere la
partecipazione alla vita pubblica, avvenga a Parigi, aggiunge una suggestione
simbolica che rende ancor più potente l’atto e chiama a una reazione altrettanto
decisa e coesa. La capitale francese è il luogo dove i valori alla base della
nostra convivenza hanno trovato la culla. Anche quello dove la laicità si è
declinata in quella dottrina dell’assimilazionismo per cui coloro che abitano
nel Paese sono perciò “citoyen de la République”, tutti uguali davanti alla
legge secolare, con l’opportunità di esercitare il culto che preferiscono a
patto che non interferisca coi supremi diritti dello Stato. Un modello di
integrazione che ha coinvolto mezzo milioni di ebrei, cinque milioni di
musulmani e recentemente entrato in sofferenza anche, e soprattutto, a causa di
una crisi economica che ha contrapposto immigrati vecchi e nuovi e francesi
delle classi meno agiate. Mai tuttavia, nemmeno nelle rivolte delle banlieue
datate 2006, era stato messo in discussione l’ordine dei valori. Anzi: i
disperati rivoltosi chiedevano di essere “più francesi”, di avere le stesse
chance degli altri “citoyen”. ma ora che il conflitto si è radicalizzato in
Medioriente, ora che lo Stato Islamico offre una terra, un credo e un
irresistibile richiamo alla violenza nichilista, ecco che alcune frange
esportano la guerra in Europa in un furore iconoclasta che ha l’obiettivo di
radere al suolo, e a casa nostra, ciò che rende l’occidente un originale e
riuscito paradigma di emancipazione. Non siamo ancora a quella catarsi
catastrofista che lo scrittore Michel Houellebecq tratteggia nel suo ultimo
romanzo “Sottomissione”, ma il livello dello scontro col fanatismo islamista si
è alzato con “Charlie Hebdo” e merita che si aprano finalmente gli occhi. Ci si
renda conto della realtà emergenziale e si chiami alla comune difesa di un modo
di vivere a cui non vogliamo rinunciare, gli stessi fratelli islamici europei
non infatuati del Jihad. Per fortuna, la stragrande maggioranza.
1. MOSTRARE O
CENSURARE I DISEGNI DI CHARLIE HEBDO: ORA I MEDIA SI DIVIDONO. Enrico
Franceschini per “la Repubblica”.
Siamo tutti Charlie Hebdo: lo dicono i cartelli della gente nelle strade di
tutta Europa, lo affermano i titoli dei giornali di tutto l’Occidente. Ma non
tutti i giornali occidentali — pur condannando come barbaro l’attacco di Parigi
e difendendo il diritto del settimanale francese di fare satira come vuole su
quello che vuole — hanno ripubblicato le vignette messe sotto accusa dagli
estremisti islamici. Il mondo dei media si è per il momento diviso fra chi non
pubblica nulla o soltanto vignette che non ritraggono Maometto e chi invece ha
pubblicato proprio il materiale che ha fatto infuriare gli islamisti, come la
famosa copertina di Charlie Hebdo in cui il Profeta ammonisce: «Vi farò dare 100
frustate se non morite dal ridere!» Adesso un appello lanciato da Timothy Garton
Ash, docente di relazioni internazionali a Oxford, columnist del Guardian e di
Repubblica, autore di saggi di successo, chiede a tutti i giornali d’Europa di
pubblicare le vignette più “forti” del settimanale francese come gesto
collettivo in difesa della libertà di stampa. Ma le opinioni in materia appaiono
contrastanti. In Gran Bretagna nessun quotidiano ha pubblicato le vignette di
Charlie Hebdo. «Siamo dei codardi», scrive amaramente un columnist del Times.
Viceversa Tony Barber, commentatore del Financial Times, definisce
«editorialmente stupida» la scelta del settimanale parigino di provocare
consapevolmente l’ira dei musulmani e lo giudica «non il miglior campione di
libertà di espressione»: uscito prima sul sito, il suo articolo è stato
ritoccato ieri sera, cancellando questi due severi giudizi, che hanno scatenato
sdegno sui social network, ma li ha ripristinati nella versione cartacea
pubblicata ieri mattina. Non finisce qui. In America il Washington Post afferma:
«Non pubblichiamo mai immagini che possono offendere qualunque religione» e il
New York Times segue la stessa linea. Ma il quotidiano del Watergate deve
incassare le critiche di una delle sue firme di punta, Carl Bernstein, che con
Bob Woodword fece esplodere quello scandalo. In Danimarca alcuni giornali hanno
pubblicato le vignette e altri no. L’ Huffington Post, il Daily Beast, Slate e
altre testate online le hanno pubblicate; la Bbc e la Cnn no. D’altra parte,
come denuncia il blog statunitense Gawker, considerato in patria una sorta di
“tempio” della controinformazione, il Daily Telegraph britannico e il New York
Daily News hanno pensato bene di “pixelare”, quindi rendendole irriconoscibili,
le copertine più controverse contro il Profeta e l’Islam. Stephen Pollard,
direttore del Jewish Chronicle, un giornale britannico, pone il dilemma in
questi termini: «Il mio istinto giornalistico mi dice di pubblicare tutto, ma
che diritto ho di rischiare la vita dei miei redattori?».
2. MA PER L’AMERICA I
DISEGNI SUL PROFETA MANCANO DI RISPETTO. Paolo Mastrolilli per “La Stampa”.
L’attacco terroristico di Parigi sta spaccando i media americani. Non nella
condanna dell’attentato, ovviamente unanime, ma nella opportunità di
ripubblicare le vignette del periodico Charlie Hebdo, che hanno provocato la
furia degli estremisti. I grandi giornali come New York Times, Washington Post,
Wall Street Journal e Usa Today hanno scelto di non farlo. La linea usata dai
loro direttori è abbastanza simile: non pubblichiamo immagini che sono state
pensate con lo scopo dichiarato di offendere la religione e mancarle
di rispetto. Descriverle basta, per compiere il servizio di informazione dovuto
al lettore. Questa posizione per certi versi si riflette nella prudenza che la
stessa Casa Bianca aveva usato nel settembre del 2012, quando la diffusione di
un video giudicato offensivo verso Maometto aveva generato proteste in molti
Paesi del Medio Oriente. Era seguito poi l’assalto al consolato americano di
Bengasi, che però in seguito si è scoperto essere un’operazione premeditata di
un gruppo terroristico. Allora il portavoce del presidente Obama, Jay Carney,
aveva commentato proprio alcune vignette pubblicate da Charlie Hebdo, dicendo
che non metteva in discussione il diritto di stamparle, ma il giudizio della
direzione che aveva deciso di farlo. In altre parole, la libertà di espressione
andava sempre difesa, ma forse si potevano evitare le provocazioni. Più dura
ancora è stata la reazione ieri del gruppo cattolico conservatore Catholic
League. Il suo direttore, Bill Donohue, ha detto che «i musulmani hanno il
diritto di essere arrabbiati». Naturalmente Donohue non giustifica l’attentato,
però aggiunge che «se Stephane Charbonnier, direttore di Charlie Hebdo, fosse
stato meno narcisista, oggi sarebbe ancora vivo. Maometto per me non è sacro, ma
non mi è mai passato per la testa di insultare deliberatamente i musulmani
offendendolo». Questa linea non è stata condivisa da tutti, nelle redazioni dei
giornali americani. La pagina degli editoriali del Washington Post, che nella
tradizione dei media Usa ha una gestione separata e autonoma dalla direzione, ha
pubblicato una vignetta di Charlie Hebdo, e lo stesso ha fatto l’edizione online
del Wall Street Journal. Usa Today invece ha optato per mettere le altre
vignette che hanno condannato l’attacco di Parigi, mentre diversi giornali hanno
stampato foto in cui si vedono i disegni contestati del periodico francese.
L’editorialista del New York Times Ross Douthat ha commentato così: «Se qualcuno
vuole ammazzarti per una cosa che vuoi dire, significa che quella cosa va
detta». Il dibattito dunque è aperto, fra l’opportunità di prendere decisioni
editoriali che non siano apertamente mirate a creare guai, e il dovere di
evitare sempre la censura e difendere la libertà.
3. PLANTU:
“CONTINUEREMO A PRENDERE IN GIRO. CON LE MATITE DENUNCIAMO LE VIOLENZE”. Cesare
Martinetti per “la Stampa”.
E adesso? «Il faut continuer se moquer», dice Plantu, non dobbiamo smettere di
prendere e prendersi in giro con i disegni. Dunque la satira vive, a Parigi, a
cominciare dal grande bureau di Jean Plantu, al settimo piano di Le Monde. Il
suo studio è una foresta popolata dalle sagome dei suoi personaggi, la sua
scrivania un accumulo di bruillon, schizzi, prove, colori. Plantu ci mostra la
vignetta che ha appena concluso per il giornale di oggi: una macchia rossa in
strada, il tricolore a mezz’asta sulla tour Eiffel, la bandiera di Charlie Hebdo
sull’ingresso dell’Eliseo, una Marianna in lacrime, due barbuti che si
allontanano con il kalashnikov sulle spalle e il topolino (l’alter ego del
disegnatore) che li guarda reggendo un cartello: «gros connards», diciamo grandi
bastardi.
Plantu dal 1985
disegna la vignetta sulla prima pagina di Le Monde e dieci anni fa ha creato
«Cartoonist for peace». Che fate?
«Cerchiamo ogni giorno di
dialogare con disegnatori cristiani, ebrei, musulmani, agnostici, atei e
arriviamo talvolta a fare dei ponti con le nostre piccole matite là dove altri
con le loro asce scavano fossati».
Nel vostro programma
c’è l’impegno ad essere rispettosi dei credenti. Ci riuscite sempre?
«Ci sono mille modi di
raccontare le cose, ho passato la notte qui al giornale a ricevere disegni dal
medioriente, dal maghreb di tutte le religioni. C’è l’immagine seria e
rispettosa e ci può essere quella un po’ folle. E noi vogliamo tentare di essere
più forti degli intolleranti, essere impertinenti senza offendere i credenti.
Bisogna continuare la battaglia avendo rispetto per il dolore delle persone che
vivono in Iraq o in Afghanistan e smettere di dire che la guerra è lontana. No è
qui, a casa nostra».
Ma se c’è di mezzo la
religione tutto si complica. Come si superano queste divisioni?
«A noi non interessa sapere se
Gesù Cristo ha camminato sulle acque o cosa ha fatto Maometto. Quello che ci
interessa è: c’è una donna lapidata? Non è un problema di religione ma di
diritti umani, e prendiamo matite e pennarelli per denunciare le violenze. E
capita che ci riusciamo perché l’arte e la creatività sono sempre più forti
dell’intolleranza».
Lei ora si sente un
bersaglio?
«Non lo considero un problema.
Io lavoro molto con le scuole. Un disegno è qualcosa che ognuno vede, se ne
appropria, ci si può esprimere in mille modi, lascio la mia matita a qualcun
altro. Oggi siamo con tutto il cuore con Charlie Hebdo e tutti possono firmare
questo disegno, la mano è anonima».
A Charlie Hebdo
qualcuno aveva passato il segno del rispetto?
«Io penso che gli artisti
abbiano tutti i diritti, di disegnare e fare il ritratto di chiunque. Ciò detto
siamo nel 2015, e bisogna fare attenzione perché laggiù all’angolo della strada
c’è un mascalzone che aspetta soltanto che gli facciamo un regalo per liberare
la sue folle armate di kalashnikov e granate. Abbiamo creato l’associazione
dieci anni fa per battere l’imbecillità dei farabutti».
I quattro di Charlie
erano nell’associazione?
«Solo Tignous».
4. LA LIBERTÀ DEGLI
ALTRI. Francesco Merlo per “la Repubblica”.
Non ci piacciono le vignette anti islamiche di Charlie Hebdo , anche se abbiamo
sempre pensato che fosse suo pieno diritto pubblicarle. Erano coerenti infatti
con la natura canzonatoria e provocatoria di quel giornale, con la sua idea di
satira vasta e disinteressata, con quell’accanimento derisorio portato alle
estreme conseguenze dinanzi al quale, scriveva Italo Calvino «mi faccio
piccolo piccolo». «Perché — aggiungeva — supera la soglia del particolare per
mettere in questione l’intero genere umano, confinando con una concezione
tragica del mondo». E tuttavia non ci piacciono quelle vignette neppure dopo
l’enormità dell’atto terroristico e l’immenso dolore per la morte di 12 persone
libere e innocenti. Appartengono infatti alla grammatica della blasfemia e non a
quella della trasgressione, anche se, sbeffeggiando il profeta Maometto, più che
bestemmia in senso stretto quelle caricature erano empietà aggressiva in una
città, Parigi, dove tantissime jeunes filles musulmane passeggiano per
gli Champs-Élysées con i capelli al vento. A Parigi sono musulmane le
studentesse universitarie, le impiegate, le giornaliste, e sono arabi musulmani
i grandi chirurghi e i piccoli venditori di frutta, le star del pop e i
professori universitari, gli edicolanti e i camerieri dei ristoranti. Tutti
laici come i calciatori eredi di Zidane e come il poliziotto finito con un colpo
di Kalashnikov dal fanatico terrorista, con un accanimento selvaggio che offende
tutti i codici militari e in nome di un Dio killer che svilisce qualsiasi Dio.
Di sicuro al Dio macellaio la stragrande maggioranza dei musulmani francesi non
crede e non crederà mai. Dunque sono un pretesto le vignette blasfeme. Se
Charlie Hebdo non fosse mai esistito i terroristi avrebbero sparato in un bar,
in una stazione del metrò o in un aeroporto. Le vignette sono l’alibi
dell’attacco e del ricatto all’Occidente, più insidioso per noi, spaventati da
una violenza irriducibile dalla quale è difficile difendersi, che per le
frustrazioni nazionaliste, etniche e religiose di quella minoranza di profughi
ribelli e di barbuti arrabbiati e confusi dalla quale provengono i terroristi in
cerca di una scusa per uccidere. Dal punto di vista militare questo nuovo
terrorismo diffuso prova a rilanciare, a partire dalla città più civile
tollerante e laica d’Europa, il famoso scontro di civiltà. Ma la strage nella
sede di un giornale rischia di armare di più i francesi tentati da Marine Le Pen
che i francesi musulmani che, per la verità, non sono tentati né dallo Stato
Islamico né da Al Qaeda. La bestemmia diventa così uno di quei dispositivi
accidentali della storia, come il naso di Cleopatra per esempio. E basta
guardare la felicità dei leghisti italiani e le reazioni scomposte dei fanatici
delle Leghe Sante. I 12 morti di Parigi sono come un richiamo della foresta per
i nostri cristianisti con il Crocifisso tra i denti che papa Francesco aveva
messo a cuccia, un ritorno alla natura per l’estrema destra razzista pronta alla
difesa di una Francia e di un’Europa bianche e cristiane. La paura sui cui
soffiano è quella dall’islamizzazione immaginata nel romanzo Sottomissione da
Houellebecq, preso in giro proprio dalla copertina di Charlie Hebdo: «Le
predizioni del mago Houellebecq: “Nel 2015 perdo i denti... ” (i suoi problemi
odontoiatrici sono noti) e “nel 2022, faccio il Ramadan!”». La verità è che
persino la rabbia delle squadracce di banlieue a Parigi, anche se araba e
violenta, non è governata dagli integralisti islamici. E in fondo questi
terroristi così barbari sono quelli che non ce l’hanno fatta, gli scarti feroci
di un’integrazione che è invece riuscita, non solo in Francia. E sono due volte
disadattati, sia in Francia sia nelle milizie islamiche dove devono sempre
conquistarsi i quarti di nobiltà terrorista sgozzando e massacrando più degli
altri. Ieri a caldo una vignetta di Charlie Hebdo mostrava un energumeno tutto
bardato di nero incappucciato e sudato che entrava in Paradiso mitragliando e
gridando: «dove sono le mie vergini?». Riceveva questa risposta al tempo stesso
canzonatoria e malinconica: «Sono nel paradiso dei vignettisti ». Disadattato
anche là. È già stato scritto che Charlie Hebdo aveva deriso, e certamente
avrebbe continuato a farlo, anche i simboli delle altre religioni. E ricordo
bene le natiche del Papa, il matrimonio omosessuale tra il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo e la masculinità di Shiva, senza risparmiare neppure Buddha, un
dio “parzialmente scremato”. Si rideva forte e facile con Charlie Hebdo, perché
la scurrilità di Maometto, raffigurato prono con le stelline sulle terga, quando
ti arriva sotto gli occhi, è più veloce del pensiero. E certo è ancora libertà
d’espressione la violazione dei codici del rispetto delle religioni. Ma non
avere stampato le bestemmie è stato il nostro codice di libertà di espressione,
coniugata, ancora di più adesso che siamo tutti sotto choc, con il controllo
degli istinti. La laicità e la secolarizzazione comportano infatti anche un
governo dell’invocazione e dell’imprecazione: della preghiera, che non è un
selvaggio rito collettivo, e della bestemmia, soprattutto del Dio altrui. Ma
viviamo in una parte del mondo — ecco la differenza — dove la libertà è la cosa
più importante. Non conta che gli altri la pensino come me: ma che siano liberi
di pensare e di esprimere le loro idee con il solo limite del rispetto delle
leggi. Ecco perché difendiamo la libertà di Charlie di esprimersi secondo la sua
natura e le sue modalità, le sue libere scelte, anche quando non sono le nostre.
Facciamo sapere a tutti gli estremisti religiosi del mondo che mai rinunzieremo
alla critica e alla satira, anche delle religioni, e non accetteremo un ritorno
all’inquisizione e alla punizione fisica delle bestemmie, al medioevo islamico.
Anche se non diventeremo mai, come vorrebbero gli estremisti islamofobi, tutti
sbeffeggiatori di Maometto.
Terrorismo islamico a
Parigi: massacro al giornale Charlie Hebdo.
Due terroristi fanno irruzione
nella redazione di Charlie Hebdo armati di kalashnikov, poi fuggono a Reims. Tra
i dodici morti c'è il direttore Charb. Un poliziotto giustiziato per strada,
scrive Andrea Indini su “Il Giornale”. Armati di kalashnikov due terroristi
hanno assaltato la redazione di
Charlie Hebdo.
Cinque minuti di sangue e quello che è l'attentato più cruento commesso in
Francia dal 1961, ai tempi della guerra di Algeria, fa ripiombare Parigi e
l'intera Europa nell'incubo del
fondamentalismo islamico.
Al grido di "Vendicheremo il Profeta"
due uomini incappucciati e vestiti di nero hanno fatto irruzione nella reception
del settimanale satirico e hanno aperto il fuoco. A terra i cadaveri crivellati
di colpi di dodici persone. Tra questi il direttore Stephane Charbonnier, che
firma le vignette Charb, e altri sette giornalisti. Una raffica di colpi, almeno
una trentina, con i mortali AK47. Dodici morti a terra e i giornalisti in fuga
sui tetti. Un assalto che porta la firma della jihad islamica. La colpa di Charb
e dei disegnatori di
Charlie Hebdo?
Aver pubblicato vignette satiriche su Maometto. Già nel 2011 la redazione fu
distrutta da una molotov. L’attentato, che non provocò vittime, avvenne nel
giorno dell'uscita del numero speciale dedicato alla vittoria elettorale degli
islamisti in Tunisia. Il titolo "Maometto
direttore responsabile di Charia Hebdo" era un gioco di parole sulla
sharia. Anche nell'ultimo numero non è mancata la provocazione: in copertina
campeggia una foto dello scrittore
Michel Houellebecq,
al centro di polemiche per il romanzo
Sottomissione
che racconta l’arrivo al potere in Francia di un presidente islamico. A fare
irruzione è stato un commando armato formato da Said e Cherif Kouachi, due
fratelli franco-algerini di 32 e 34 anni legati alla rete terrorista yemenita e
da poco tornati dalla Siria. Oltre a Charb i due hanno ammazzato otto
giornalisti
(tra questi Jean Cabut detto Cabu, Tignous, Georges Wolinski, Bernard Maris e
Philippe Honoré), il poliziotto Franck D., un ospite della redazione (Michel
Renaud) e il portinaio. Tra gli undici feriti c'è il giornalista Philippe
Lançon. Dopo il blitz sono scappati a bordo di una Seat guidata dal 18enne Hamyd
Mourad. Durante la fuga hanno investito un passante e hanno ingaggiato un
secondo scontro a fuoco con le forze di polizia. Immagini di violenza inaudita
che sono state riprese dai tetti: l'agente Ahmed Merabet è stato
giustiziato con
un colpo alla testa mentre si trovava, inerme, ferito a terra. Solo dopo diverse
ore le teste di cuoio dei reparti Raid sono riuscite a localizzarli a Reims. Il
presidente francese
Francois Hollande
ha parlato di "attentato terroristico di
eccezionale barbarie, un attentato alla nostra libertà". Un attentato che
arriva a stretto giro da altri tre inquietanti attacchi al grido "Allah hu
Akbar". Il 22 dicembre a Nantes, nella Francia nord occidentale, un camion è
stato lanciato sul tradizionale mercatino natalizio ferendo undici persone.
Nemmeno ventiquattr'ore prima a Digione, nel nord est del Paese, un 40enne alla
guida di una Renault Clio aveva travolto la folla mandando all'ospedale 13
persone. Sempre al grido di "Allah
hu Akbar". Vicende troppo
simili e troppo vicine per non metterle in relazione tra loro. A queste va poi
aggiunta una terza, quella di Jouè-lès-Tours dove un convertito all'Islam è
entrato nel commissariato cittadino e ha aggredito tre poliziotti. Una scia di
sangue nel nome di Allah.
Dal direttore Charb al mitico Wolinski, la strage
della satira nella redazione di Charlie Hebdo. Tra le dodici vittime
dell'assalto anche cinque celebri vignettisti: il direttore, il vecchio e
storico creatore di "Paulette", Cabu, Tignous e Honoré, scrive Francesco Fasiolo
su “La Repubblica”.
Un giornale satirico simbolo della libertà di stampa e di espressione. Questo è
diventato Charlie Hebdo nel corso degli anni. E per questo è tragicamente
divenuto anche l'obiettivo simbolo del terrorismo. Dieci collaboratori uccisi in
redazione, tra loro alcuni dei grandi vignettisti famosi ben oltre i confini
francesi. Una storia cominciata nel 1960, quando nacque Hara-Kiri, definito dai
suoi fondatori (tra cui Cabu e Georges Wolinski, tra le vittime dell'attentato)
"un giornale stupido e cattivo", da subito protagonista di innumerevoli
battaglie e censurato un paio di volte dalla magistratura francese. E' nel 1970
che lo stesso gruppo, dopo l'ennesimo scandalo (una copertina che ironizzava
sulla morte di Charles De Gaulle e che costò al giornale il blocco delle
pubblicazioni) diede vita al "Charlie Hebdo", riferimento al celebre Charlie
Brown dei Peanuts. Da allora sono stati attacchi, sarcasmo e ironie contro la
destra, ma anche la gauche, su tutti i fronti e tutti i temi.
Vignette su Maometto.
È però nel 2006 che l'Hebdo diventa noto al pubblico internazionale con la
scelta di ripubblicare le dodici controverse vignette su Maometto del giornale
danese Jyllands-Posten. Immediate arrivarono le proteste di esponenti del mondo
islamico, il giornale fu incriminato per razzismo e l'allora direttore Philippe
Val fu assolto nel 2008 da un tribunale francese. Nel novembre 2011 esce "Charia
Hebdo", il numero speciale dedicato alla vittoria degli islamisti in Tunisia. In
copertina una immagine di Maometto che promette "Cento frustate se non morite
dal ridere". Prima che l'edizione arrivasse nelle edicole, la sede della rivista
viene distrutta da un incendio provocato da un lancio di molotov. Il numero
vende 400.000 copie, il direttore Charb viene minacciato di morte e messo sotto
protezione.
Le vittime.
Charb
era il nome d'arte di Stéphane Charbonnier, 47 anni, alla guida del settimanale
dal maggio 2009. Insieme a lui, nell'attentato sono morti anche altri quattro
vignettisti: Cabu, Tignous, Philippe Honoré e Georges Wolinski. E' proprio
quest'ultimo il nome più noto anche fuori dalla Francia. Controcorrente e
provocatorio
Wolinski,
nato a Tunisi nel 1934, lo è sempre stato. Gli italiani lo hanno conosciuto sin
dagli anni 70, quando leggevano su Linus le sue storie dissacranti. Disegnatore
e sceneggiatore, con Georges Pichard crea il personaggio di Paulette,
inizialmente su Charlie Mensuel e poi protagonista di pubblicazioni autonome. La
protagonista è una giovane ricchissima, che ha almeno due particolarità: è di
sinistra e appare spesso, in pratica sempre, nuda o seminuda. Le sue storie sono
sempre in bilico tra l'erotico e il politico, perché la ragazza, in opposizione
con la sua vantaggiosa situazione economica e sociale, è pienamente calata nel
clima degli anni '70, tra lotte studentesche, manifestazioni contro la guerra in
Vietnam, suggestioni hippy. Se in passato Wolinski è stato al centro di
polemiche, accusato di immoralità o pornografia per le nudità e le tematiche
trattate (tra i suoi libri "Il porcone maschilista" e "Le donne pensano solo a
quello") , a 80 anni era uno dei nomi più importanti del fumetto mondiale. Una
fama che gli è stata riconosciuta nel 2005, con la vittoria del Grand Prix di
Angouleme, in pratica l'equivalente nel mondo dei comics dell'Oscar alla
carriera, e con una grande retrospettiva del 2012 alla Bibliotheque Nationale de
France, dove sono custoditi tutti i suoi archivi. Cabu,
vero nome Jean Cabut, 76 anni, era uno dei pilastri di Charlie Hebdo, sin dalla
fondazione di Hara-Kiri. Il suo nome era rimbalzato sui media di tutto il mondo
quando nel febbraio 2006, in piena polemica per le vignette danesi su Maometto,
disegnò in copertina il Profeta che insultava i fondamentalisti. Tra i suoi
lavori, molto famoso in Francia è "Mon Beauf", serie su un francese medio,
razzista e maschilista. Bernard Verlhac era invece il vero nome di
Tignous,
57 anni, che lavorava anche per Fluide glacial, storicamente uno dei più
importanti magazine francesi di fumetti. Al suo attivo otto libri. Il più
recente, intitolato "5 ans sous Sarkozy" (Cinque anni sotto Sarkozy) è stato
pubblicato nel 2011. Fa venire i brividi oggi l'ultima vignetta di Charb,
pubblicata sull'ultimo numero di Charlie Hebdo, mostrava un terrorista islamico
sotto la scritta: "Ancora nessun attentato in Francia". "Aspettate" diceva
l'uomo armato "Abbiamo ancora tutto gennaio per farvi i nostri auguri".
Il dissacrante Charlie
Hebdo, nato alla sinistra della sinistra,
scrive Anna Maria Merlo su “Il Manifesto”. Il settimanale. Da sempre
indipendenti, dagli industriali e dalla pubblicità. Vignette e reportage
corrosivi. Non solo contro l’islam: il primo bersaglio sono state la chiesa
cattolica e l’estrema destra. Cabu e Wolinski, che sono stati assassinati ieri
assieme al più giovane Charb, nell’attentato che ha fatto 12 vittime nella
redazione del settimanale Charlie Hebdo, sono stati protagonisti fin
dagli anni ’60 dell’avventura, iniziata con Hara-Kiri, della stampa
satirica libertaria francese della seconda metà del XX secolo. All’inizio,
c’erano personalità come Topor, Reiser, lo scrittore François Cavanna, che hanno
l’idea di pubblicare la versione francese di Linus italiano. Nel ’70,
dopo varie censure di cui è vittima Hara-Kiri – l’ultima, a novembre,
dopo la morte di De Gaulle, per un titolo dissacrante – il gruppo fonda
Charlie Hebdo (dal nome di un personaggio di Schultz e con un riferimento
ironico a Charles De Gaulle). Della prima versione di Charlie Hebdo
usciranno, fino all’81, 580 numeri. Un altro numero uscirà nell’82. Nel ’92, la
testata rinasce. Fa effetto oggi, di fronte agli avvenimenti, ricordare che la
società costiuita allora per il rilancio si chiamava Les Etitions
Kalachnikof. Nel ’92 partecipa già Charb, che dal 2009 era diretore della
pubblicazione. Charlie Hebdo ha radici nella sinitra della sinistra, ma
non ha mai avuto una linea editoriale precisa. La sua storia è fatta di
battaglie, di scontri, di abbandoni, di ostracismi, di ritorni. E di molte
polemiche, anche interne alla redazione: nel 2002, un articolo a difesa del
libro La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci, viene subito criticato.
Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 ci sono prese di posizione
conflittuali contro una parte dell’estrema sinistra, accusata di non aver
condannato gli islamisti per antiamericanismo. Philippe Val, che all’inizio
degli anni 2000 diventa direttore della pubblicazione, accusa Tariq Ramadan di
essere un propagandista antisemita. Val nel 2005 difende il «sì» al referendum
sul Trattato costituzionale europeo, altri difendono il «no» – che sarà
vittorioso – sulle pagine del settimanale. Charlie Hebdo non si limita
alla satira, ma pubblica anche reportage sulla società e sulle grandi questioni
dell’attualità mondiale (in particolare, alla fine degli anni ’70, importanti
inchieste sull’estrema destra). Oncle Bernard (l’economista Bernard Maris,
assassinato anch’egli ieri) ha firmato cronache economiche sempre di grande
interesse. La caratteristica di Charlie Hebdo, con le sue vignette
corrosive che molto spesso hanno disturbato, è sempre stata l’indipendenza,
dalle ideologie come dal denaro. «Non vogliamo ricchi industriali come azionisti
– aveva detto Charb nel 2010 – e non vogliamo neppure dipendere dalla
pubblicità. Non prendiamo quindi gli aiuti di Stato che vanno ai giornali
cosiddetti “di deboli introiti pubblicitari”, visto che non abbiamo pubblicità.
L’indipendenza, l’indipendenza totale, ha un prezzo». Charlie Hebdo ha
sempre lottato contro tutti i fanatismi. Il primo bersaglio è stata la chiesa
cattolica, in quanto religione maggioritaria in Francia. Le vignette sono state
sempre corrosive, a volte anche con una certa pesantezza. Il settimanale molte
volte è stato denunciato, dai politici, dai cattolici, di recente dai musulmani.
Charb ha sempre precisato: la critica è sull’«alienazione delle fede», qualunque
essa sia. Nel 2006, Charlie Hebdo pubblica le caricature di Maometto del
giornale danese Jyllands Posten, arricchite da altre vignette firmate dai
disegnatori del settimanale. Il Consiglio francese del culto musulmano chiede la
censura del numero e sporge denuncia. L’allora presidente, Jacques Chirac,
condanna le «provocazioni manifeste». Ne seguirà un processo nel 2007, dove ha
testimoniato, a favore della libertà di stampa, anche François Hollande, non
ancora presidente. La storia delle caricature di Maometto, che sembra
all’origine del massacro di ieri, era già stata la causa di un incendio
criminale di cui era stata vittima la sede di Charlie Hebdo nel novembre
2011. La redazione, allora, era stata ospitata per due mesi da Libération.
Altre caricature di Maometto susciteranno polemiche e denunce nel 2012. La
copertina in edicola di Charlie Hebdo questa settimana prende in giro lo
scrittore Michel Houellebecq, di cui ieri è uscito l’ultimo libro, Soumission,
che racconta dell’elezione di un islamista alla presidenza della Repubblica
francese nel 2022.
L'attentato
che spazza via le certezze della sinistra.
L'attentato
terroristico di Parigi è riuscito là dove le innumerevoli stragi dei cristiani
hanno fallito: ha risvegliato la coscienza della sinistra italiana ed europea
contro l'Islam. Tutto, compreso quello moderato, scrive Roberto Bettinelli su “L’Informatore”.
Il massacro nella redazione del giornale satirico Charles Hebdo è riuscito là
dove le innumerevoli stragi dei cristiani in tutto il mondo hanno fallito: ha
risvegliato l’ottusa coscienza della sinistra italiana ed europea contro
l'Islam. Michele Serra su Repubblica
ha evocato «la terza guerra mondiale» sentenziando che «esiste un fanatismo
islamista terrificante contro il quale l’Islam per primo è chiamato a
mobilitarsi». Fino ad ora nessuno mai nel campo della sinistra, e men che meno
un esponente illustre della sua intellighenzia come l’ex direttore di Cuore, si
era spinto fino a pronunciare una condanna che per la prima volta varca il
confine fra l’Islam moderato e l’Islam dei terroristi. Serra l’ha fatto, e nel
farlo, ha sicuramente interpretato lo stato d’animo di gran parte del popolo
della sinistra che è stato scosso in profondità e con una forza mai provata in
precedenza dalla ferocia di un fondamentalismo che ha preso di mira un valore
intoccabile come la libertà di stampa e di satira. Una reazione inedita che
rivela come per la cultura politica che anima Repubblica esista una gerarchia
delle libertà. E fra queste la libertà di stampa e di satira, uno dei generi
prediletti dalla sinistra, siano da collocare su un gradino più alto della
libertà di religione. La prova che non ci sbagliamo è che in questa
occasione Serra e il giornale più letto e autorevole della sinistra italiana
hanno preso posizione contro tutto l'Islam, anche quello moderato, rompendo con
la lettura ideologica che li separa nettamente e che non è disposta a tollerare
nessuna sovrapposizione. E sono stati costretti a farlo da una macabra beffa che
cade tragicamente a poche settimane dalla risoluzione del parlamento europeo che
ha riconosciuto, per iniziativa del Pse, il diritto alla Palestina di costituire
uno stato autonomo. Un'azione diplomatica che sembrava assicurare la pace ma che
ha contribuito a innescare la risposta dei terroristi che hanno attaccato
il giornale diretto da Stephan Charbonnier, colpevole di aver ripetutamente
pubblicato vignette e fumetti contro Maometto e Al Baghdadi, il leader
dell’Isis. Lo scenario non poteva essere più chiaro. Da un lato l'Europa che,
sulla spinta di un’adesione incondizionata e irresponsabile al dogma del
multiculturalismo, riconosce il diritto palestinese di formare un proprio stato
nonostante la massiccia presenza di formazioni legate ad Al Quaeda nella
striscia di Gaza e in Cisgiordania; dall’altro il terrorismo islamico che
colpisce a morte una delle capitali più importanti dell’Unione Europea, uccide
12 persone tra giornalisti e poliziotti, getta nell’incubo perenne degli
attentati l’intero occidente. Adesso che i ‘lupi solitari’ hanno travolto con la
loro furia omicida un simbolo della libertà di stampa e di satira come Charles
Hebdo, la sinistra insorge e attacca l’Islam, tutto, che dovrebbe ribellarsi e
comportarsi «come fece la sinistra con le Brigate Rosse». Così suggerisce Serra
stabilendo un parallelo fra quello che avrebbe fatto il Pci negli anni di piombo
e quello che dovrebbero fare oggi i mussulmani che non si riconoscono nella
brutalità di Al Quaeda e dell’Isis. Il consiglio di Serra è apprezzabile, ma ha
l’odore fastidioso dell’ipocrisia. A sconfiggere le Brigate Rosse non fu il Pci
ma furono i carabinieri del generale Alberto Dalla Chiesa. L’Italia divenne il
teatro di uno scontro spietato. Vinse lo Stato. E per un solo motivo: fra i due
contendenti fu il più duro e implacabile. Lo stesso deve valere per i terroristi
che ammazzano e muoiono nel nome di Allah. Ci saranno altri attentati e altri
morti. L’alleanza dell’Islam moderato può essere utile ai fini della vittoria
finale. Ma non può bastare. L’Europa e l’occidente, se non vogliono soccombere,
non hanno altra scelta che porre fine alle illusioni di un multicuralismo che è
l'esatto contrario del rispetto delle identità dei popoli. Ma soprattutto devono
accettare di avere di fronte un nemico che vuole la loro fine con tutti i mezzi
disponibili. E fare altrettanto.
Charlie Hebdo, quella
satira “cattiva” che disturbava i perbenisti.
Il giornale francese è stato bersaglio di polemica da parte degli esponenti
musulmani per le sue vignette su Maometto. Venne più volte chiuso e poi
riaperto, scrive Cesare Martinetti su “La
Stampa”. Un simbolo del
giornalismo francese, un giornale nato e cresciuto negli anni 70, che si
autodefiniva con ironia “bete e méchant”, bestiale e cattivo, iconoclasta, un
giornale che disturbava l’opinione pubblica perbenista, capace anche di
ironizzare su Charles De Gaulle il giorno della sua morte e che per questo
chiuso per un po’. Nato dalle ceneri di Hara-Kiri, lanciato da Georges Bernier e
François Cavanna, Charlie Hebdo è un giornale a fumetti satirico che ha fatto
della provocazione la sua cifra costituente. “Journal bete et méchant”, secondo
l’autodefinizione degli autori. Vi hanno lavorato negli anni caricaturisti come
Francis Blanche, Topor, Fred, Reiser, Wolinski, Gébé, Cabu. Più volte chiuso e
poi riaperto in seguito a denunce e a crisi editoriali. Il nome Charlie viene
scelto nel 1969 quando il giornale appare sostanzialmente come versione francese
dell’italiano Linus e come quest’ultimo prendi il nome da un personaggio dei
Peanuts (Charlie Brown). Nel 1992 assume l’attuale identità. Il giornale è
sostanzialmente espressione di una sinistra culturale. Tuttavia vi si trovano le
opinioni e le posizioni più diverse e anche contrapposte. Nel 2002 aveva preso
posizione a favore di Oriana Fallaci quando venne pubblicata in Francia “La
rabbia e l’orgoglio”, il suo pamphlet contro i cedimenti occidentali
all’islamismo. Nel 2006 CB pubblicò le famose vignette di satira su Maometto e i
costumi musulmani che erano uscite sul settimanale danese Jyllands-Posten
provocando manifestazioni violente di protesta in tutto il mondo islamico.
Disegnatori e giornalisti danesi vennero minacciati ripetutamente. Charlie Hebdo
scelse di pubblicare quelle vignette aggiungendone altre francesi per
solidarietà e per marcare una linea di libertà di espressione contro tutte le
intolleranze religiose. La pubblicazione provocò proteste nella comunità
musulmana francese, il Consiglio del culto musulmano chiese che il giornale
venisse sequestrato, lo stesso presidente della Repubblica Jacques Chirac
censurò la scelta di Charlie Hebdo. Da allora il giornale – che pure tratta con
articoli e vignette tutti i temi di società - è stato bersaglio di polemica da
parte degli esponenti musulmani. Da allora un presidio di polizia era stato
istituito davanti alla sede del giornale.
Charlie Hebdo, la storia
della rivista già colpita per le vignette su Maometto.
Il settimanale ha un orientamento libertario, di sinistra e fortemente
anti-religioso. Pubblicato la prima volta nel 1970, scatena subito polemiche
all'indomani dei funerali del generale Charles de Gaulle. Nel 2011 la sede viene
incendiata, scrive F. Q. su “Il Fatto Quotidiano”. Satirico, irriverente e
anticonformista. E’ questo lo spirito di
Charlie Hebdo, il
settimanale francese che questa mattina è stato preso di mira da un commando di
terroristi armati che hanno compiuto una strage nella sede parigina. Il giornale
ha un orientamento libertario, di sinistra e fortemente anti-religioso. E si
pone l’obiettivo di difendere le libertà individuali. La rivista è soprattutto
nota per le sue
vignette
e illustrazioni politicamente scorrette, ma anche per gli articoli incentrati su
politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo, islam e giudaismo. E anche se
prende di mira principalmente i politici di destra, il settimanale non risparmia
i partiti di sinistra francesi. Secondo l’attuale direttore, il disegnatore
Stéphane Charbonnier,
noto come Charb, il giornale riflette “tutte le componenti del pluralismo di
sinistra e perfino dell’astensionismo”. Nel 2006 il giornale suscitò polemiche
pubblicando una serie di caricature del
profeta Maometto,
diffuse inizialmente dal quotidiano danese
Jyllands-Posten e
vendendo 400.000 copie. In Italia le vignette vennero riprese dal ministro delle
Riforme Roberto Calderoli che in un’intervista televisiva indossò una maglietta
con le illustrazioni, un episodio che scatenò forti reazioni popolari nel mondo
arabo, culminate con alcuni morti in Libia. Il numero di Charlie Hedbo incendiò
proteste violente nei Paesi mussulmani. Diverse organizzazioni musulmane
francesi, tra cui il Consiglio francese del culto musulmano, chiesero di seguito
di mettere al bando il numero del settimanale contenente altre caricature di
Maometto, ma la richiesta non fu accolta. A fine 2011, la redazione venne
completamente distrutta da un
incendio doloso
e il sito del giornale venne attaccato dagli hacker dopo un numero speciale
denominato Sharia Hebdo. Attacchi di matrice islamica, secondo gli inquirenti.
Temporaneamente, la redazione si trasferì nei locali del quotidiano
Liberation,
per poi migrare in nuovi locali; l’attacco fu lanciato prima dell’uscita nelle
edicole di un numero con in copertina un’altra vignetta satirica con Maometto.
La storia di Charlie Hebdo comincia negli anni ’60 ed è strettamente legata a
quella del mensile Hara-Kiri, lanciato da
Georges Berniere
e François
Cavanna, e definito da loro
stessi “un giornale stupido e cattivo”. La rivista fu al centro di diverse
polemiche e fu interdetta dalla magistratura nel 1961 e poi nel 1966.
Trasformata successivamente in settimanale, uscì in edicola per la prima volta
nel 1970, ispirato a Charlie Brown. A novembre dello stesso anno la rivista
suscitò critiche dopo la morte di
Charles de Gaulle,
titolando in copertina ‘Bal tragique à Colombey – un mort’, ossia ‘Ballo tragico
a Colombey, un morto’, con un riferimento alla residenza del generale. Di
seguito le pubblicazioni di Hara-Kiri vennero bloccate dal ministero
dell’Interno francese, ma i giornalisti aggirarono il divieto lanciando una
nuova pubblicazione, Charlie Hebdo, che deve il nome al famoso personaggio del
fumetto Peanuts. Il settimanale rimase chiuso tra il 1981 e il 1992 dopo un calo
del numero di lettori. Prima di Charb a guidarlo furono François Cavanna e
Philippe Val. La rivista è pubblicata ogni mercoledì, ha una tiratura media
settimanale di 100.000 copie, con 15.000 abbonati.
Giuliano Ferrara alza i toni
l’8 gennaio 2015 durante «Servizio Pubblico» su La7. Il direttore de Il
Foglio ritiene che la strage di Parigi non sia "terrorismo" ma che faccia
parte di un'ampia strategia voluta dal mondo islamico per «andare contro
l'Occidente cristiano-giudaico». «Questa è una Guerra Santa, se non lo capite
siete dei coglioni!», tuona Ferrara.
Vietato parlare di Islam,
scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. Dopo la strage di Parigi
esiste ancora la libertà di stampa? Si può ancora pubblicare oppure no
un’opinione anche quando questa è politicamente scorretta? Ieri tutti i
quotidiani traboccavano di articoli di fondo inneggianti alla libertà minacciata
dall’assassinio a sangue freddo del direttore e dei principali collaboratori di
Charlie Hebdo. E però gli stessi quotidiani si guardavano bene dal prendere di
petto la questione, preferendo nascondere se non cancellare la parola islam.
Sulla prima pagina del Corriere per trovarla ci si doveva sottoporre a una vera
caccia al tesoro. Il titolo a tutta pagina non parlava di strage islamica o di
terrorismo islamico, ma di «Attacco alla libertà. Di tutti». Ah sì? E da parte
di chi? Per scoprirlo bisognava leggere il sommario su una colonna: «Al grido di
“Allah è grande” tre terroristi assaltano il giornale delle vignette satiriche
su Maometto: 12 vittime». Per capire poi che l’islam c’entra qualcosa, l’occhio
doveva cascare sull’occhiello sfumato (una colonna) che sovrastava l’editoriale
di Ernesto Galli Della Loggia: «Islam, la vera questione». Ecco, la notizia era
lì, nell’occhiello. Solo allora si scopriva che l’islam c’entra qualcosa in
quello che è accaduto a Parigi, perché Galli della Loggia scriveva che esiste un
problema islam, «un insieme di religione, di cultura e storia, riguardante in
totale circa un miliardo e mezzo di esseri umani dove nel complesso (nel
complesso perché vi sono anche le eccezioni e sarebbe da stupidi ignorarle)
vigono regole diverse e perlopiù incompatibili con quelle che vigono in quasi
tutte le parti del mondo». Questo è il punto. Ma il Corriere ha pensato bene di
nasconderlo il più possibile, titolando sull’11 settembre dell’Europa, di cui
peraltro nell’articolo non si fa nemmeno cenno e che comunque sarebbe sbagliato
perché l’Europa ha già avuto i suoi 11 settembre con le bombe nel metrò di
Londra (52 morti) e sui treni alla stazione di Madrid (191 morti).
Vietato illudersi: l'islam è
il nemico, continua Belpietro. "È un nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia
ci odia e ci disprezza con intensità". Sono passati dieci anni da quando Oriana
Fallaci scrisse queste frasi sulla prima pagina del Corriere. La più conosciuta
e stimata giornalista italiana era appena stata denunciata per vilipendio
all’Islam, perché nei suoi libri e nei suoi articoli si era permessa di metterci
in guardia contro il Mostro, così lo chiamava, e di mettere in dubbio la
fandonia dell’Islam buono contro quello cattivo. Oriana si opponeva alla nascita
della moschea di Colle val d’Elsa, sosteneva che il mondo occidentale era in
guerra e doveva battersi, attaccava il multiculturalismo, la teoria
dell’accoglienza indiscriminata, la dottrina cattolica che insegna ad amare il
nemico tuo come te stesso. E per questo, per quel che scriveva, fu considerata
pazza dall’intellighezia progressista mondiale, quasi che l’integralista fosse
lei, lei armata di penna e taccuino e non gli islamici armati di esplosivi,
coltelli e kalashnikov che noi abbiamo invitato nelle nostre case e nelle nostre
città, consentendo loro - in virtù della libera circolazione imposta dal
trattato di Schengen - di viaggiare a loro piacimento, senza controlli e con la
possibilità di organizzare qualsiasi massacro. Oriana è morta da anni, ma le sue
nere profezie si stanno realizzando puntuali come erano state previste. Quel che
è accaduto ieri nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo, una
delle poche testate che anni fa difesero nel silenzio generale il coraggio della
scrittrice toscana, è esattamente ciò che lei aveva immaginato.
Il lungo incubo di Coco: «Ho
aperto quella porta e hanno sparato a tutti». Parla la vignettista che per prima
ha incontrato i due attentatori del «Charlie Hebdo» I due boia incappucciati le
hanno puntato i kalashnikov alla testa, scrive Elisabetta Rosaspina “Il Corriere
della Sera”. «Faccio attenzione quando si tratta di religione. Ci penso due
volte prima di fare un disegno. Ma non mi autocensuro, è fuori questione»
garantiva tre anni fa «Coco» al sito della cittadina di Carquefou (Loira
Atlantica) dove ogni anno, dal 2000, si organizza il festival dei caricaturisti.
Era stata lei, Corinne Rey, giovane disegnatrice, allora non ancora trentenne,
ma già affermata nel mondo della stampa, a disegnare il manifesto dell’happening
del 2011. Un signore dalle grandi fauci che inghiotte il mondo infilzato su uno
stecchino, come fosse un’oliva. È lei, Corinne Rey, la mamma cui mercoledì
mattina, sotto gli uffici di Charlie Hebdo , a Parigi, i due boia incappucciati
hanno puntato i kalashnikov alla testa, ingiungendole di comporre il codice
d’ingresso alla sede della redazione, l’ultimo ostacolo tra i killer e le loro
prede. Gli assassini non l’hanno riconosciuta come una delle firme del
settimanale e, forse, l’hanno risparmiata per questo. O perché, come invece ha
ipotizzato lei, non si sono accorti che scivolava al riparo di una scrivania. Ma
quella carneficina resterà negli occhi della giovane donna per sempre. «Superato
l’ingresso hanno sparato a Wolinski poi a Cabu. Erano seduti uno accanto
all’altro. Tutto è durato cinque minuti, forse anche meno. Una pioggia di
colpi», ha rivissuto poco dopo il suo incubo, parlando al telefono con i
colleghi de «L’Humanité ». Sotto choc, ma anche sotto protezione, come testimone
diretta e ravvicinata di quel bagno di sangue, Coco si è salvata perché era
andata a prendere la figlioletta all’asilo. Come lei, è scampata al massacro
anche un’altra disegnatrice della redazione decimata, Catherine Meurisse,
arrivata in provvidenziale ritardo alla riunione settimanale. Catherine ha fatto
in tempo a incrociare i due uomini mascherati mentre fuggivano dal palazzo e ha
intuito che qualcosa di terribile doveva essere accaduto. Anche se qualche altro
passante si era fermato incuriosito, convinto che si stesse girando un film
d’azione. È salva Coco, anche se ha visto e sentito morire i suoi colleghi e se
non potrà più togliersi dalle orecchie e dalla memoria le urla di soddisfazione
dei carnefici che gridavano i nomi delle loro vittime mentre sparavano, come in
un sordido appello: «Pagherete per aver insultato il Profeta».
Sottomissione
è il romanzo più visionario e insieme realista di Michel Houellebecq, capace di
trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il lettore.
A Parigi, in un indeterminato
ma prossimo futuro, vive François, studioso di Huysmans, che ha scelto di
dedicarsi alla carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo verso
l’insegnamento, la sua vita procede diligente, tranquilla e impermeabile ai
grandi drammi della storia, infiammata solo da fugaci avventure con alcune
studentesse, che hanno sovente la durata di un corso di studi. Ma qualcosa sta
cambiando. La Francia è in piena campagna elettorale, le presidenziali vivono il
loro momento cruciale. I tradizionali equilibri mutano. Nuove forze entrano in
gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno crollare. È un’implosione
improvvisa ma senza scosse, che cresce e si sviluppa come un incubo che travolge
anche François. Sottomissione è il romanzo più visionario e insieme realista di
Michel Houellebecq, capace di trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il
lettore che, come il protagonista, François, vedrà il mondo intorno a sé,
improvvisamente e inesorabilmente, stravolgersi.
La Parigi "sottomessa" di
Houellebecq divide i politici francesi.
Il romanzo
sull'islam fa discutere. Hollande: "Non si deve cedere a paura e angoscia". Le
Pen: "E' fiction ma potrebbe diventare realtà", scrive
Alessandro Gnocchi su “Il
Giornale”. Questa sera Michel Houellebecq si difenderà dalle accuse scatenate
dalle anticipazioni del suo nuovo romanzo Sottomissione (da domani in Francia,
in Italia dal 15 gennaio per Bompiani). Lo farà sul canale televisivo France2,
intervistato da David Pujadas. Ma lo scrittore ha già rivendicato il diritto,
sulla Paris Review , di trattare temi d'attualità, anche scomodi. Respinte le
accuse di razzismo e islamofobia, ha osservato la crisi dei valori
dell'Illuminismo, il rifiuto crescente della modernità, il ritorno delle
religioni, il suicidio dell'Europa e la lotta dei francesi per restare in vita.
Il libro entra in pieno nel dibattito in corso da tempo in Francia sull'identità
nazionale e sul corretto rapporto con l'immigrazione, specie quella di matrice
religiosa musulmana. In Sottomissione , le elezioni presidenziali del 2022 sono
vinte dal candidato del neonato partito musulmano, che batte la destra di Marine
Le Pen grazie all'appoggio sia dei socialisti sia dei repubblicani. Parigi
accetta di buon grado l'islamizzazione morbida propugnata dal nuovo governo. La
Francia, forse l'intera Europa, rinuncia alla libertà avvertita come un inutile
fardello, il retaggio di un passato ormai finito. La sfiduciata cultura
occidentale non può non cedere di fronte alle forti rivendicazioni identitarie
dei musulmani. Il protagonista di Sottomissione , un professore esperto di Joris
Karl Huysmans, accetta senza opporsi l'islamizzazione dell'università, e in
questo segue a suo modo le orme dell'oggetto dei suoi studi. Huysmans, l'autore
di A ritroso , passò infatti dal Naturalismo al Cattolicesimo («lo fece per
ragioni estetiche, restando freddo di fronte alle grandi domande di Pascal»,
precisa Houellebecq nella citata intervista alla Paris Review ). Fantapolitica?
Dipende dai punti di vista. Dopo critici, filosofi e opinionisti, sono
intervenuti i pesi massimi della politica francese. Il presidente della
Repubblica, il socialista François Hollande, ha detto che leggerà Sottomissione
non appena possibile. Nel frattempo osserva che la tentazione di denunciare «la
decadenza, il declino, di esternare pessimismo e dubitare di se stessi» è una
costante di molta letteratura, non solo di questo secolo. «Ciascun autore è
libero di esprimere quello in cui crede. Il mio compito, invece, è invitare i
francesi a non cedere alla paura, all'angoscia». Perché nel Paese ci sono «forze
positive» capaci di porre rimedio alle situazioni incerte e di migliorare le
condizioni generali. Del resto, pochi giorni prima di Natale, Hollande aveva
dichiarato che gli immigrati servono, e il resto è demagogia. Di parere
radicalmente opposto la leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, tra i
personaggi del romanzo stesso: « Sottomissione è un libro interessante. È
fiction ma potrebbe diventare realtà. Il patto pro islam tra socialisti e
repubblicani, in opposizione alla nostro destra, si può già osservare a livello
comunale o regionale».
Houellebecq, l’ultimo
“Charlie Hebdo” dedicato al suo nuovo libro.
Il romanziere sotto scorta ora
piange l’amico morto. Disse: «Non sento una responsabilità particolare per
quello che scrivo. Un romanzo non cambia la storia», scrive Stefano Montefiori
su “Il Corriere della Sera”. Michel Houellebecq è scoppiato in singhiozzi, ieri,
quando ha saputo che tra i morti c’era il suo amico Bernard Maris, economista
alla Banca di Francia ed editorialista a “Charlie Hebdo”. Sul numero della
rivista uscito poche ore prima della strage, Maris conclude con queste parole
quello che sarà l’ultimo articolo della sua vita: «Ancora un romanzo magnifico.
Ancora un colpo da maestro». Si riferisce a “Sottomissione”, il libro di
Houellebecq che negli stessi momenti cominciava finalmente a essere venduto
nelle librerie, dopo settimane di indiscrezioni, distribuzioni illegali su
Internet e polemiche che, come solo in Francia può accadere, passano rapidamente
dalla letteratura alla politica. È stata una giornata spaventosa per tutti.
Michel Houellebecq non ha potuto che viverla in modo ancora più drammatico, per
le persone colpite a lui vicine e perché quella, fino alle 11 e 30 era la «sua»
giornata, quella dell’uscita del libro più atteso dell’anno, da giorni sulle
prime pagine di tutti i giornali. Una giornata preceduta la sera prima da un suo
intervento al tg delle 20 sul canale pubblico France 2, in cui lo scrittore di
tanti romanzi tra analisi della società e profezia aveva risposto con la
consueta flemma alle domande del conduttore David Pujadas. «Non sente di avere
una responsabilità particolare, lei che è uno scrittore così importante e
seguito?», chiedeva Pujadas. «No - aveva risposto Houellebecq -, forse un saggio
può cambiare la storia, non un romanzo». Il giornalista alludeva a una voglia di
provocazione - tante volte negata - di Houellebecq, che in “Sottomissione” mette
in scena il fantasma più angosciante per la società francese di questi giorni:
un Islam trionfante, che ha ragione per vie democratiche di una civiltà
giudaico-cristiana ormai estenuata, spossata dall’Illuminismo e dal fardello di
libertà che pesa su ogni essere umano. Meglio la sottomissione, allora,
suggerisce François, il protagonista del romanzo: delle donne all’uomo (la
poligamia viene incoraggiata, più mogli smettono di lavorare e restano a casa ad
accudire un unico marito), e di tutta la società a Dio. Anzi, ad Allah. Per
questo, Houellebecq è stato accusato di soffiare sul fuoco, di usare la paura
per vendere libri. Ma Houellebecq è uno scrittore, di sicuro il più celebre e
forse il migliore scrittore francese contemporaneo, non un opinionista né
tantomeno un uomo politico. Ha il diritto di descrivere la realtà, e anche di
offrirci la sua idea di quel che la realtà potrà diventare tra qualche anno,
«esagerando e velocizzando», come dice lui stesso. Da quando in autunno si è
saputo che il suo prossimo romanzo avrebbe dipinto questa Francia del 2022 in
mano all’Islam, l’Islam per certi versi rassicurante (donne a parte) del nuovo
presidente della Repubblica Mohammed Ben Abbes, il dibattito culturale - e
politico - francese ha cominciato a incentrarsi su Sottomissione , fino a
esserne completamente monopolizzato. L’azione militare dei terroristi è stata
talmente efficace da essere probabilmente pianificata da mesi, dicono le fonti
di polizia: l’uscita di Sottomissione e l’ultimo numero della rivista non
c’entrano nulla. I piani si sovrappongono perché c’è la coincidenza dell’uscita
nelle librerie, e perché l’ultimo Charlie Hebdo esibisce in copertina una
splendida vignetta firmata Luz, almeno lui per fortuna scampato al massacro, che
dipinge Houellebecq con l’eterna sigaretta e un ridicolo cappello con stelle e
pianeti. Titolo: «Le predizioni del mago Houellebecq», e lo scrittore che dice
«Nel 2015 perdo i denti...» (i suoi problemi odontoiatrici sono noti) e «Nel
2022, faccio il Ramadan!». Nell’ultima pagina di Charlie Hebdo , come sempre,
«le copertine alle quali siete scampati»: e riecco Michel Houellebecq in braccio
a una Marine Le Pen sognante che canta «Sarai il mio Malraux», disegnato da
Cabu, morto nell’attentato; Houellebecq in ginocchio che sniffa una pista di
cocaina stesa per strada e il titolo «Houellebecq convertito all’Islam?»,
disegnato da Coco, alias Corinne Rey, la donna che sotto la minaccia delle armi
ha aperto la porta della redazione ai terroristi; infine, ecco un ritratto poco
avvenente di Houellebecq, lo strillo «Scandalo!» e il titolo «Allah ha creato
Houellebecq a sua immagine!». La firma è di Charb, il direttore, l’uomo che più
di tutti gli assassini volevano uccidere. Michel Houellebecq è ovviamente sotto
la protezione della polizia, come lo sono le redazioni di tutti i giornali e i
locali della casa editrice Flammarion, che ieri sono rimasti chiusi. Nel
romanzo, gli islamici prendono il potere vincendo le elezioni grazie a
un’alleanza con gli esangui partiti di centrosinistra e di centrodestra. Prima
che l’ordine coranico regni sovrano sulla Francia e l’Europa, in base al sogno
di Ben Abbes di rifondare un impero romano con l’Islam al posto del
Cristianesimo, in Sottomissione (uscirà in Italia il 15 gennaio per Bompiani) ci
sono scontri, un timido debutto di guerra civile. E la guerra civile, il caos,
sono evocati nelle dichiarazioni di mesi fa di Éric Zemmour, l’opinionista che
con il bestseller Le suicide français ha generato furiose polemiche su razzismo
e islamofobia, con la sua accusa rivolta ai musulmani di Francia di essere «un
popolo nel popolo».
Negli ultimi giorni i migliori intellettuali
e scrittori francesi, da Michel Onfray a Emmanuel Carrère, si sono
pronunciati sulla polemica Houellebecq. Charlie Hebdo, Michel Houellebecq
sospende la promozione di Sottomissione, scrive Angela Iannone. L'attentato di
matrice terroristica al settimanale satirico francese coincide con la
pubblicazione del romanzo di Michel Houellebecq, "Sottomissione". Michel
Houellebecq ha deciso di
"sospendere la promozione"
del suo libro "Sottomissione"
perché "profondamente turbato dalla morte del suo amico Bernard Maris, ucciso
nell'attacco terrorista al settimanale Charlie Hebdo, nel quale sono state
uccise altre undici persone". Lo ha annunciato il suo agente Francois Samuelson,
secondo quanto riportato dai media francesi. Lo scrittore, che è sotto scorta,
lascerà Parigi, come ha precisato il suo editore Flammarion. L'attentato
terroristico alla redazione di "Charlie Hebdo", il settimanale satirico
attaccato da un commando armato stamattina, coincide con
due pubblicazioni.
La prima è la copertina del settimanale stesso, che aveva proprio oggi come
protagonista
Michel Houellebecq, lo
scrittore francese che nel suo ultimo romanzo
"Sottomissione",
immagina una Francia governata nel 2022 dai Fratelli Musulmani e lancia un
allarme sulla progressiva islamizzazione del Paese. La seconda è proprio la
pubblicazione di "Sottomissione",
che è in uscita oggi nelle librerie francesi. Charlie Hebdo riportava oggi la
caricatura dello scrittore travestito da mago, il cui titolo era
"Le previsioni del mago
Houellebecq" con
lo scrittore francese che dice
"Nel 2015 perdo i miei
denti" e poi
"Nel 2022 faccio il Ramadan".
Sottomissione è un
romanzo fantapolitico
che ipotizza una Francia futura nelle mani dell'integralismo islamico. Un Paese
in cui un leader musulmano impone l'islamizzazione forzata a tutti gli
abitanti. Circa 300 pagine con una tiratura di 150mila copie diffuse
illegalmente già prima della pubblicazione ufficiale, suscitando non poche
polemiche tra l'opinione pubblica francese, che si è divisa commentando il
titolo come "sublime" o "irresponsabile". Intervistato dalla radio France-Inter,
Houellebecq ha minimizzato lo scandalo, ritenendo che non è sia quello il vero
senso del libro e che "la
parte del romanzo che fa paura è piuttosto precedente all'arrivo dei musulmani
al potere. (...) Si può dire che quello è terrificante, questo regime".
"Nel mio libro -continua -
l'Islam non è per nulla radicale, al contrario, è una delle religioni più
pacifiche che si possano immaginare. Non penso che il mio libro dipinga un Islam
minaccioso".
Charlie Hebdo, Houellebecq
e Sottomissione, il libro fatale.
La strage nel giorno dell'uscita di Sottomissione, scrive “L’Ansa”. Gli
assalitori che hanno sparato e ucciso nella sede del settimanale satirico
Charlie Hebdo non hanno scelto un giorno a caso: oggi, 7 gennaio 2015, esce in
Francia l'ultimo libro di Michel Houellebecq,
Sottomissione
(traduzione letterale della parola Islam), che in Italia arriverà il 15 gennaio.
Proprio a questo libro del controverso autore di
Le particelle elementari,
Piattaforma,
La possibilità di
un'isola, il numero di Charlie
Hebdo aveva dedicato un articolo e la copertina con una vignetta che ritrae lo
scrittore vestito da mago e il titolo: Le previsioni del mago Houellebecq; le
profezie dello scrittore sono: Nel 2015 perderò i denti, nel 2022 farò il
ramadan. Perché
Sottomissione proprio di questo
parla: di una Francia governata nel 2022 dai Fratelli Musulmani, che riescono ad
andare al governo grazie ad una (poco) incredibile alleanza con quel resta di
centristi e sinistra alleate al musulmano moderato Mohammed Ben Abbes, leader
di Fraternité musulmane, contro lo strapotere di Marine Le Pen. Non è solo
l'ennesimo allarme di Houellebecq contro la progressiva islamizzazione del
Paese. Come ha scritto Emmanuelle Carriere, Houellebecq ha il merito di essere
l'unico a parlare di un problema che esiste ma che molti intellettuali sembrano
ignorare. Non solo: per Carriere quella di Houllebecq è una posizione
politicamente e sociologicamente ragionevole. L'Occudente si arrende per così
dire dolcemente all'Islam, sfinito da secoli di razionalità e illuminismo
eccessivamente responsabilizzanti. Nell'acceso dibattito intellettuale francese
sul libro e sullo scrittore, non è l'unica recensione positiva incassata da
Houellebecq: un altro intellettuale 'scorretto', Michel Onfray , noto per il suo
trattato di ateologia e per le sue posizioni anti-cristiane e favorevole al
libertinismo, ha parlato di Europa come Continente morto che volontieri si
consegna all'Islam dopo averlo fatto con i mercati. E dunque, per Sottomissione,
di uno scenario assolutamente plausibile. Proprio ieri, Houllebecq aveva parlato
al canale francese France 2 per rivendicare il suo diritto di trattare temi di
attualità e soprattutto di sottolineare la crisi dei valori dell'illuminismo e
della modernità.
"Ecco la mia Francia nelle
mani dell'Islam". Parla lo
scrittore Michel Houellebecq. I musulmani prendono il potere. E opprimono le
donne. Lo scrittore più provocatorio d’Oltralpe qui racconta “Sottomissione” il
suo nuovo romanzo. E dice: «Il Corano è decisamente meglio di quello che
pensavo, di lettura in rilettura. La conclusione più evidente è che i jihadisti
sono cattivi musulmani», scrive
Sylvain Bourmeau su
“L’Espresso”. Michel
Houellebecq, lo scrittore più controverso di Francia, non ama parlare con i
giornalisti. Per il lancio del suo nuovo romanzo, “Sottomissione”, ha dato una
sola intervista al critico Sylvain Bourmeau, che in vent'anni lo ha incontrato
decine di volte e che, malgrado le critiche sincere che gli riserva anche in
questa occasione, si è guadagnato la sua fiducia. “L'Espresso” pubblica in
esclusiva per l'Italia il lungo colloquio che parte dalla trama del nuovo
romanzo, ancora più provocatorio dei precedenti. Il libro è uscito in Francia
proprio nel giorno dell'attentato a Charlie Hebdo (in Italia esce il 15 per
Bompiani). E lo scrittore, che dopo aver subito un processo per islamofobia non
vive più in Francia ma è a Parigi per il lancio del libro, è stato posto sotto
scorta. Al centro di “Sottomissione” c'è una Francia trasformata in uno stato
islamico dopo la vittoria alle presidenziali del leader di un partito
musulmano. Un'ipotesi irrealistica? Non secondo Houellebecq, che ipotizza un
ballottaggio con la leader della destra xenofoba Marine Le Pen. «Per la Le Pen
mi pare del tutto verosimile che arrivi al ballottaggio già alle elezioni del
2017», spiega lo scrittore. «Quanto al partito musulmano, mi sono reso conto che
i musulmani vivono in una situazione del tutto alienata. Sono molto lontani
dalla sinistra e ancor di più dagli ecologisti. E non si vede perché dovrebbero
votare per la destra, che li rifiuta. Quindi l'idea di un partito musulmano mi
sembra plausibile». Il nuovo romanzo sfrutta la paura dell'Islam che serpeggia
per la Francia, ammette Houellebecq. Che però è convinto che «non si può
definire “Sottomissione” una predizione pessimista». Anche perché, dichiara a
sorpresa, «il Corano è decisamente meglio di quello che pensavo, di lettura in
rilettura. La conclusione più evidente è che i jihadisti sono dei cattivi
musulmani. La guerra santa di aggressione non è permessa per principio, e solo
la predicazione è valida. Dunque si può dire che ho cambiato un po’ opinione. È
per questo che non ho l’impressione di essere nella situazione di dover avere
paura. Ho l’impressione che ci si possa mettere d’accordo».
«La civiltà dell’Europa è
sfinita».
Onfray promuove Houellebecq. «È un continente morto, oggi in mano ai mercati.
Domani forse all’islam», scrive Stefano Montefiori su “Il Corriere della Sera”.
Il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione , immagina una Francia del
2022 governata da un presidente musulmano e un nuovo ordine sociale che prevede
poligamia e donne che restano a casa a occuparsi di mariti e figli in omaggio a
una religione - l’islam - che ha trionfato sulla civiltà dell’Illuminismo. Prima
ancora dell’uscita (il 7 gennaio in Francia per Flammarion e il 15 gennaio in
Italia per Bompiani) il libro scatena polemiche e discussioni, tra
riconoscimento del valore letterario e critiche a una presunta voglia di
provocazione. Il «Corriere» ha sollecitato l’opinione di Michel Onfray, uno dei
più noti intellettuali francesi, autore di decine di opere tra le quali il
celebre Trattato di ateologia e una Controstoria della filosofia (Ponte alle
Grazie); un pensatore ateo che ha letto - e amato - il romanzo del momento.
Visto che «Sottomissione» è
un romanzo e non un saggio, è possibile separare il valore letterario dal
contenuto profetico?
«È un esercizio di stile, una
fiction politica ma anche metafisica: un romanzo sull’ignavia delle persone,
degli universitari in particolare. Un romanzo molto anarchico di destra. Un
libro sulla collaborazione, vecchia passione... francese! Come un universitario
specialista di Huysmans può convertirsi all’islam? Ne scopriamo le ragioni poco
alla volta: la promozione sociale in seno all’istituzione riccamente finanziata
dai Paesi arabi, gli stipendi mirabolanti dei convertiti, la possibilità della
poligamia, una ragazza per il sesso, un’altra meno giovane per la cucina, una
terza se si vuole, il tutto continuando a bere alcool... Questo libro è meno un
romanzo sull’islam che un libro sulla collaborazione, la fiacchezza, il cinismo,
l’opportunismo degli uomini...».
La parte più scioccante è
forse il destino riservato alle donne. Qual è la sua opinione? È concepibile
nella nostra società un’evoluzione simile?
«La nostra epoca è
schizofrenica: bracca il minimo peccato contro le donne e, per fare questo,
milita per la femminilizzazione dell’ortografia delle funzioni, la parità nelle
assemblee, la teoria di genere, il colore dei giocattoli nelle bancarelle di
Natale; la nostra epoca prevede che ci si arrabbi se si continua a rifiutare
auteure o professeure (femminili di autore e professore ), ma fa dell’islam una
religione di pace, di tolleranza e di amore, quando invece il Corano è un libro
misogino quanto può esserlo la Bibbia o il Talmud. Se si vuole continuare a
essere misogini con la benedizione dei sostenitori del politicamente corretto,
l’islam alla Houellebecq è la soluzione!».
In una sua prima intervista
alla «Paris Review», Houellebecq decreta la fine dell’Illuminismo e il grande
ritorno della religione (l’islam, ma non solo). In quanto pensatore ateo, qual è
la sua reazione?
«Credo che abbia ragione. I
suoi romanzi colgono quel che fa l’attualità del nostro tempo: il nichilismo
consustanziale alla nostra fine di civiltà, la prospettiva millenarista delle
biotecnologie, l’arte contemporanea fabbricata dai mercati, le previsioni
fantasticate della clonazione, il turismo sessuale di massa, i corpi ridotti a
cose, la loro mercificazione, la tirannia democratica, la sessualità fine a se
stessa, l’obbligo di un corpo performante, il consumismo sessuale, eccetera.
Quindi, utilizzare i progressi incontestabilmente compiuti dall’islam in terra
d’Europa per farne una fiction sull’avvenire della Francia è un buon modo per
pensare a quel che è già».
Houellebecq descrive una
società francese ed europea stanca, affaticata dalla perdita di valori
tradizionali. Cosa pensa? L’Europa è condannata, come dicevano i neocon
americani?
«Houellebecq continua a
dipingere il ritratto di una Francia post-68. E ha ragione di vedervi un
esaurimento, meno in rapporto con il breve termine del Maggio 68 che con il
lungo periodo della civiltà giudaico-cristiana che crolla. Questa civiltà è nata
con la conversione di Costantino all’inizio del IV secolo, il Rinascimento
intacca la sua vitalità, la Rivoluzione francese abolisce la teocrazia, il
Maggio 68 si accontenta di registrarne lo sfinimento. Siamo in questo stato
mentale, fisico, ontologico, storico. Houellebecq è il ritrattista terribile di
questo Basso Impero che è diventata l’Europa dei pieni poteri consegnati ai
mercati. L’Europa è morta, ecco perché i politici vogliono farla!».
La mia impressione,
leggendo il libro, è che si finisca per credere alla profezia. In questo sta
l’abilità di scrittore di Houellebecq? O la sua previsione è davvero plausibile?
«È in effetti uno dei talenti
di questo libro: il racconto è estremamente filosofico perché è estremamente
credibile... Sottomissione rivaleggia con 1984 di Orwell, Fahrenheit 451 di
Bradbury, Il mondo nuovo di Huxley. Per me è il migliore libro di Houellebecq, e
di gran lunga. La sottomissione di cui diamo prova nei confronti di ciò che ci
sottomette è attualmente sbalorditiva. È un altro sintomo del nichilismo nel
quale ci troviamo».
Evocando l’islam,
Houellebecq agita un fantasma molto presente nella Francia di oggi, come
dimostrano i libri di Alain Finkielkraut e Éric Zemmour. È giustificata, questa
preoccupazione dell’identità?
«Ricorrere alla parola
fantasma è già un modo di prendere una posizione ideologica. Esiste una realtà
che non è un fantasma e che coloro che ci governano nascondono: divieto di
statistiche etniche sotto pena di farsi trattare da razzisti ancor prima di
avere detto alcunché su queste cifre, divieto di rendere note le percentuali di
musulmani in carcere sotto pena di farsi trattare da islamofobi al di fuori di
qualsiasi interpretazione di queste famose cifre, eccetera. Non appena si
nasconde qualcosa, si attira l’attenzione su quel che è nascosto: se non esiste
che un fantasma, allora che si diano le cifre, saranno loro a parlare...».
Edward Luttwak: Islam
significa «sottomissione», E questo è il suo vero obiettivo finale.
L'ambiguità vi porta al macello. L'Europa, in particolare, tiene il piede in due
scarpe, scrive di Goffredo Pistelli su
“Italia Oggi”. A Edward Luttwak
il politically correct non fa velo. Questo ebreo americano d'origine rumena,
politologo e esperto di studi strategici, quando viene chiamato a parlare di
terrorismo islamico, non infiocchetta distinguo ma dice quello che pensa. E il
suo pensiero è spesso durissimo. È il caso di questa conversazione che ci ha
concesso a poche ore dalla strage del Charlie Hebdo a Parigi.
Domanda. Mr.
Luttwak questo attentato, nel cuore dell'Europa, è per gli Europei un brutto
risveglio, non trova?
Risposta. Il
punto non è solo di svegliarsi ma di agire.
D. Vale a
dire?
R. Quello che
c'è da fare è chiaro: dovete delegittimare questo trionfalismo musulmano.
D. Ma come,
c'è un attacco terroristico e lei mi parla del trionfalismo? Che c'entra?
R. Centra,
perché il trionfalismo è quello che crea un'atmosfera per cui qualcuno si sente
in diritto di uccidere la gente.
D. Ma a quale
trionfalismo si riferisce?
R. Quello
praticato da persone, ragazze magari, che vanno con il hijab indosso per
dimostrare la loro partecipazione a questa forma estrema di islamismo. Magari
parlano perfettamente l'italiano, sono carine e gentili, dicono «non siamo
affatto sottomesse», ma poi difendono Hamas, con la sua costituzione genocida.
D. Si
riferisce a quel dibattito piuttosto animato che ha avuto in dicembre durante
una puntata di Announo (in cui Luttwak, collegato dagli Usa, si toglieva
l'auricolare quando parlava una giovane esponente musulmana in studio, ndr)?
R. Non mi
riferisco a niente in particolare. Dico che queste persone vendono falsità a
cominciare dall'etimologia stessa di Islam, che vuol dire «sottomissione»,
mentre loro dicono che significhi «amore».
D. Quella
musulmana non è una religione come tutte le altre?
R. No, perché
appunto vuole tutte le altre sottomesse. E in questa sottomissione prevede che
le persone e gli Stati chinino il capo. Il disegno è che lo faccia Roma, Parigi,
Washington.
D. Non c'è
possibilità di discussione, quindi?
R. È inutile
perdersi in chiacchiere con gente come Tariq Ramadani (scrittore e imam
ginevrino di origine egiziana, che piace molto al mondo francofono, ndr), dovete
sfrondare, dovete smettere di legittimarli o vi ritroverete quattro pazzoidi col
kalashinikov in pugno, come questi di Parigi, che magari fino a ieri avevano
fatto il ragioniere, l'architetto, il medico.
D. Sfrondare
come?
R. Smettendo per
esempio di parlare per acronimi: basta dire Isis. Cominciate a chiamarlo Stato
islamico. E a cessare di trattare la religione musulmano come le altre. Capisco,
che sia troppo spinoso, ma dovete ammettere che l'unico scopo di quel credo è
sottomettere gli altri.
D. Nessuno la
fa, secondo lei?
R. Ci sono già
editori e giornalisti che, in Europa, hanno deciso di non occuparsi di questi
cose e stare alla larga da queste vicende. La sottomissione comincia così.
D. E con gli
islamici europei nessun dialogo è possibile allora?
R. L'unico
dialogo è questo: «Riformatevi e diventate un altro tipo di religione». Non
possono venire a dirci che non stanno con Isis perché sono brutti e cattivi, in
quanto tagliatori di teste, e schierarsi con Hamas che, all'articolo 7 della
propria Costituzione, prevede l'uccisione di tutti gli ebrei. Il giornalista,
l'intellettuale e chiunque altro appoggi Hamas non merita di stare nella società
civile, in quanto sostiene un'intenzione genocida proclamata.
D. Ma
l'Europa della politica che cosa dovrebbe fare?
R. Essere meno
ipocrita. Francois Hollande lo è quando avalla l'idea di un Islam moderato. È
una falsa moderazione: l'imam che non perde un congresso sul dialogo
interreligioso, lo trovi poi su YouTube con le prediche in arabo con cui chiama
tutti alla jihad, alla guerra santa. I politici europei smettano di essere
ipocriti perché, così facendo, indeboliscono milioni di post-islamici del
Vecchio Continente.
D. Di chi
parliamo?
R. Di quegli
immigrati, oggi spesso cittadini francesi, tedeschi, belgi, olandesi, che hanno
voltato le spalle alla religione musulmana perché hanno capito che è
irreformabile. Sono quelli che lasciano andare le loro moglie vestite
all'occidentale, che non menano le loro figlie perché si scoprono le braccia.
Vivono in Europa e oggi sono in imbarazzo a causa dell'ipocrisia di tanti vostri
primi ministri.
D. Che cosa
c'è nelle menti di chi ha organizzato l'attentato di Parigi? Le bombe ai treni
in Spagna, nel 2004, spodestarono José Maria Aznar, impedendone la rielezione.
Le raffiche parigine vogliono favorire l'avvento delle destre in Europa?
Vogliono alzare il livello di scontro?
R. Alzare il
livello dello scontro sarebbe sbagliato. Però siete di fronte a una scelta: o
delegittimate l'Islam o delegittimate la democrazia.
Macellai islamici.
Una dichiarazione di guerra all'Europa e alla libertà. Ma noi #nonabbiamopaura,
scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Questa è guerra. Altro che islam
buono e islam cattivo, altro che multiculturalismo come risorsa e porte aperte
all'immigrazione come dovere, altro che «cani sciolti». Hanno fatto strage di
giornalisti nel cuore di Parigi, cioè nel cuore dell'Europa, in nome di Allah.
Qualcuno li ha addestrati, qualcuno li ha istruiti, qualcuno li ha mandati a
sparare agli inermi colleghi del settimanale satirico Charlie Hebdo (la cui
testata oggi è affiancata alla nostra in segno di solidarietà). E siccome loro
hanno urlato, tra una raffica e l'altra, che il mandante è Allah, ecco allora io
dico: per loro Allah è il capo dei terroristi che vogliono sopprimere le
basilari libertà dell'Occidente. Dico che l'immigrazione selvaggia è il
grimaldello per entrare nella nostra storia, nelle nostre città. Dico che non ci
sarà mai possibilità di integrazione, perché come scriveva Oriana Fallaci «non è
vero che la verità sta sempre nel mezzo, a volte sta da una sola parte». E non
ho dubbi che la parte giusta è la nostra, quella di una «civiltà superiore»
(sempre per citare Oriana) che mai si sognerebbe di alzare un dito su Crozza per
le sue imitazioni satiriche di Papa Francesco. Abbiamo un problema di polizia,
di servizi segreti che fanno acqua, ma prima ancora abbiamo un problema politico
e culturale di soggezione (vero presidente Boldrini?) nei confronti dei nostri
carnefici, passati (vedi le scuse per Guantanamo), presenti (le cautele e i
distinguo di oggi) e futuri. Io odio questa gente, così come gli uomini liberi
hanno odiato nazisti e stalinisti. Il problema non è farsi ammazzare, ma farlo
in silenzio. È spalancare le porte di casa senza nulla chiedere in cambio al
nemico che si presenta con la faccia affamata e sofferente del profugo. È
rinunciare a crocefissi, presepi e tradizioni per non offenderli. È inculcare -
anche da parte di eminenti cardinali della Chiesa - nei nostri bambini l'idea
che Gesù e Allah pari sono. È stato rinunciare - e lo dico da laico - a inserire
le «radici cristiane» nella Costituzione europea. È non capire che siamo
sull'orlo di una guerra civile europea tra islamici di passaporto europeo e il
resto d'Europa. Non kamikaze invasati, ma banditi con tecniche brigatiste che
vogliono salvare la loro vita, togliendola agli altri in nome di Allah. Per
ribadire la nostra libertà, oggi ripubblichiamo quelle vignette che sono costate
la vita ai colleghi francesi, senza che una sola di esse violasse le leggi di
quel Paese. A noi i terroristi non hanno mai fatto paura. Ci fanno più paura le
«attenuanti culturali» con cui la nostra magistratura troppo spesso giustifica
le violazioni delle nostre leggi. E il termine «inarrestabile» usato per
arrendersi all'immigrazione selvaggia. Avanti così, qui di «inarrestabile» ci
sarà solo la fine dell'Occidente. E a questo gioco, noi non ci staremo mai. Che
piaccia o no ad Allah.
L'editoriale-shock del
Financial Times: "Stupidi i giornalisti di Charlie Hebdo",
scrive “Libero Quotidiano”. È una voce fuori dal coro, una presa di posizione
durissima e controcorrente mentre tutto il mondo condannava la strage nella
redazione di Charlie Hebdo stringendosi alle famiglie dei morti. E' quella del
quotidiano britannico Financial Times, che in un editoriale sul suo sito online
afferma che i giornalisti e i vignettisti della rivista satirica francese si
sono comportati in modo “stupido”. Il Ft accusa il magazine, che in passato era
stato già colpito per la pubblicazione delle vignette su Maometto, di aver
peccato di “stupidità editoriale” attaccando l’Islam. “Anche se il magazine si
ferma poco prima degli insulti veri e propri, non è comunque il più convincente
campione della libertà di espressione“, si legge ancora. Sui social network gli
altri media offrono giornalisti e solidarietà, ma il giornale della City invece
attacca chi ha con quelle vignette causato la reazione terroristica. “Con questo
non si vogliono minimamente giustificare gli assassini, che devono essere
catturati e giudicati, è solo per dire che sarebbe utile un po’ di buon senso
nelle pubblicazioni che pretendono di sostenere la libertà quando invece
provocando i musulmani sono soltanto stupidi”. L'editoriale si chiede anche
“quale impatto” gli omicidi “avranno sul clima politico, e in particolare le
sorti di Marine Le Pen e il suo estrema destra Fronte Nazionale“.
Altro che moderati. Nel
Corano i precetti dei killer.
La
carneficina della redazione del giornale francese mostra all'Occidente la verità
che ci rifiutiamo di vedere. È il Corano a prescrivere l'omicidio contro gli
"infedeli", scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Ciò che veramente mi
sconvolge è il fatto che, subito dopo la condanna di rito e scontata della
strage nella sede di Charlie Hebdo , la preoccupazione generale di tutti, quasi
tutti, dal presidente americano Obama al presidente della Camera Boldrini, è di
scagionare l'islam sostenendo che l'islam è una religione di pace, che Maometto
non c'entra, che la stragrande maggioranza dei musulmani «moderati» sono
contrari alla violenza e che i terroristi islamici sono una scheggia impazzita
che offende il «vero islam». Eppure se c'è un caso emblematico che ci fa toccare
con mano la contiguità e la consequenzialità sul piano del pensiero e
dell'azione tra i sedicenti musulmani moderati e i terroristi islamici è proprio
questo caso specifico che mette a confronto il divieto assoluto di raffigurare
Maometto, precetto condiviso da tutti i fedeli di Allah, con l'esercizio della
libertà d'espressione che è il fulcro della nostra civiltà occidentale. Questa
strage è la punta dell'iceberg di un contesto saturo di odio per la diffusione
di vignette satiriche nei confronti del profeta dell'islam, alimentato e
condiviso da lunghi anni da tutti i musulmani di Francia. A partire dai
«moderati» della Grande Moschea di Parigi, che rappresenta l'islam istituzionale
ed è il referente del governo francese, e dai militanti «moderati» dell'Uoif
(Unione delle organizzazioni islamiche in Francia) che s'ispirano all'ideologia
dei Fratelli musulmani, che nel 2007 intentarono e persero un processo contro
Charlie Hebdo perché aveva ridiffuso delle vignette su Maometto bollate come
blasfeme pubblicate dal quotidiano danese Jyllands-Posten . Così come altri
terroristi islamici, evidentemente meno professionisti di quelli di ieri,
avevano devastato nel 2011 la sede di Charlie Hebdo con una bottiglia molotov.
Quella di ieri è stata una vera e propria azione di guerra condotta da
terroristi che hanno combattuto e che uccidono spietatamente i nemici di Allah.
Probabilmente si tratta di reduci dalla Siria o dall'Irak, dove si stima che
almeno 600 cittadini francesi si siano uniti ai terroristi dell'Isis, dello
Stato islamico dell'Irak e del Levante. Una realtà che ci obbliga a prendere
atto che il terrorismo islamico nella sua versione più feroce è ormai un
fenomeno endogeno, interno all'Europa, e che i suoi protagonisti sono cittadini
europei musulmani. Così come nel maggio 2013 due terroristi islamici britannici,
di origine nigeriana, decapitarono a Londra il soldato venticinquenne Lee Rigby,
ieri a Parigi abbiamo assistito a un atto di guerra inedito per il contesto
urbano europeo. La Francia, che è il Paese europeo che accoglie il maggior
numero di musulmani è, insieme alla Gran Bretagna, il Paese multiculturalista
per antonomasia, quello più a rischio di attentati terroristici islamici. E non
è un caso. Quanto è accaduto evidenzia il fallimento di un modello di convivenza
che precede il fallimento dell'attività dei servizi di sicurezza. Alla base c'è
l'ideologia del relativismo con cui noi europei ci autoimponiamo di non usare la
ragione per non entrare nel merito dei contenuti delle religioni, perché
aprioristicamente le vogliamo mettere sullo stesso piano attribuendo così a
ebraismo, cristianesimo e islam la stessa valenza, finendo per legittimare
l'islam a prescindere da ciò che prescrive il Corano e da ciò che ha detto e ha
fatto Maometto. Così come c'è l'ideologia parallela del multiculturalismo che ci
ha portato a concedere a ciascuna comunità etnico-confessionale il diritto di
autogovernarsi anche se, ad esempio, la poligamia e l'uccisione dell'apostata in
cui credono indistintamente tutti i musulmani, sono in flagrante contrasto con
il nostro Stato di diritto. Il fallimento dei servizi di sicurezza è anch'esso
legato a un deficit culturale frutto della tesi ideologica secondo cui l'islam è
buono a prescindere mentre i terroristi islamici non sarebbero dei «veri
musulmani», anche se - come si è ripetuto ieri - massacrano invocando «Allah è
grande» e chiarendo «vendicheremo il nostro profeta Maometto». Noi europei
saremo inesorabilmente condannati ad essere sconfitti fintantoché non prenderemo
atto che il terrorista islamico è solo la punta dell'iceberg di un retroterra
che l'ha fatto emergere e che si sostanzia di una filiera che inizia laddove si
pratica il lavaggio di cervello predicando e inculcando l'odio, la violenza e la
morte nei confronti dei nemici dell'islam. La strage di Charlie Hebdo sostanzia
il frutto avvelenato del reato di «islamofobia», il divieto di criticare
l'islam, il Corano e Maometto. Si tratta di un pericolo che conosciamo bene
anche in Italia. Quell'atrocità potremmo viverla anche qui a casa nostra.
Quell'islam moderato che
dietro le quinte finanzia la guerra santa.
Dai
movimenti che in Italia bruciano false bandiere dell'Isis a Turchia e Qatar, che
fingono amicizia con l'Occidente e danno soldi alla jihad, scrive Magdi
Cristiano Allam su “Il Giornale”. Non ho mai avuto dubbi che i musulmani possono
essere delle persone moderate, essendolo stato per 56 anni. Ma non credo affatto
nei militanti del cosiddetto «islam moderato». Quelli che ad esempio lo scorso
21 settembre in Piazza Affari a Milano, usando uno stratagemma e ingannando il
pubblico credulone compresi i giornalisti, diedero alle fiamme non la bandiera
dell'Isis, che reca la scritta «Non vi è altro dio al di fuori di Allah» e
«Maometto è l'inviato di Allah», bensì un drappo nero su cui avevano scritto a
mano in italiano «Isis». Eppure stampa e tv hanno titolato: «I musulmani
moderati bruciano la bandiera dell'Isis»! La verità è semplice: di islam ce n'è
uno solo, Allah è lo stesso per i moderati e per i terroristi, Maometto è il
profeta a cui si rifanno tutti i musulmani indistintamente. Bisogna ammettere
che in fatto di bandiere fasulle i musulmani nostrani eccellono. Quando il 5
gennaio 2009 circa un migliaio di islamici arruolati dall'Ucoii (Unione delle
Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia) occuparono lo spazio antistante
la Basilica di San Petronio a Bologna (che custodisce l'affresco di Giovanni da
Modena con Maometto all'Inferno tra i seminatori di discordie, così come lo
volle Dante), e diedero alle fiamme le bandiere israeliane, la Procura di
Bologna li assolse perché erano da considerarsi «un drappo artigianalmente
predisposto con un simbolo grafico», che deve essere ritenuto «un simulacro» e
«un tentativo di emulazione», ma non la bandiera israeliana ufficiale! In realtà
la contiguità tra i militanti del sedicente «islam moderato» e i terroristi
islamici non si limita alla devozione dei nomi di Allah e di Maometto che fanno
sì che la bandiera dell'Isis non possa essere bruciata, ma abbraccia l'insieme
di un'ideologia che promuove la conversione all'islam, l'instaurazione della
sharia e la riesumazione del Califfato. Il caso eclatante è quello della Turchia
del regime islamico di Erdogan. A partire dal 2005 l'Occidente si è affidato
totalmente alla Turchia nell'illusione che sarebbe riuscito a portare l'«islam
moderato» dalla sua parte nella guerra contro Al Qaida. Assecondando la volontà
di Erdogan, Stati Uniti e Unione Europea legittimarono politicamente i Fratelli
Musulmani che sono riusciti a prendere il potere nei Territori palestinesi con
Hamas, in Tunisia con Ennahda, in Libia e in Egitto, mentre in Siria hanno
scatenato la guerra del terrore contro Assad. Ebbene la verità è che i turchi
sono presenti in massa al vertice e nelle fila delle organizzazioni
terroristiche, 2000 in seno a Jabhat al Nusra, affiliata ad Al Qaeda in Siria, e
3000 in seno all'Isis, forti del sostegno di Erdogan che fornisce loro
assistenza militare, cure mediche e denaro in cambio del petrolio estratto nello
«Stato islamico». Altro caso significativo della contiguità tra l'«islam
moderato» e il terrorismo islamico è quello del Qatar, principale finanziatore
dei Fratelli Musulmani in tutto il mondo e dei gruppi terroristici affini in
Siria, Libia e Tunisia, particolarmente impegnato negli investimenti in Europa
come copertura alla più massiccia campagna di costruzione di moschee. Soltanto
in Italia, a fronte dell'acquisto di alberghi di lusso, il St. Regis e
l'InterContinental a Roma, il Gallia a Milano, il Four Seasons a Firenze e i
resort sulla Costa Smeralda, il Qatar Charity Foundation ha donato 6 milioni di
dollari ai centri islamici in Sicilia, mentre altre decine di milioni di dollari
sono state donate - così come si legge sul suo sito - ai centri islamici a
Saronno, Colle Val d'Elsa, Frosinone, Lecco, Roma, Ferrara, Bergamo, Sesto San
Giovanni, Modena, Città di Castello, Vicenza, Verona, Torino, Mortara, Olbia,
Mirandola, Taranto, Milano, Argenta (Ferrara), Gavardo (Brescia), Quingentole
(Mantova). La verità è che il loro jihad, la guerra santa islamica, si traduce
comunque nella nostra sottomissione: noi «perdiamo la testa» sia quando i
terroristi ci decapitano, sia quando i «moderati» ci condizionano a tal punto da
impedirci di usarla per salvaguardare la nostra civiltà.
Il predicatore radicale
Choudary: "L'islam non crede alla libertà di pensiero".
Dopo l'attacco a
Charlie Hebdo difende
l'idea che ci debbano essere dei limiti. "Le conseguenze sono note a tutti",
scrive Lucio Di Marzo su “Il Giornale”. "L'islam
non è pace, ma piuttosto sottomissione ai comandi del solo Allah. Per questo i
musulmani non credono nell'idea della libertà d'espressione, perché le loro
parole e azioni sono determinate dalla rivelazione divina e non basate sui
desideri della gente". La pensa così
Anjem Choudary,
un predicatore radicale tra i più ascoltati in Europa, intervistato su queste
pagine alcuni mesi fa da Barbara Schiavulli, per un reportage nell'Europa
estremista. Dopo l'attacco contro la redazione del Charlie Hebdo, in cui sono
morte dodici persone, tra le quali giornalisti e il direttore del magazine
satirico, ha riassunto in una lettera pubblicata da
Usa Today
il suo pensiero sui fatti, in netta contraddizione con opinioni molto più
moderate espresse da altri imam e fedeli musulmani. "Persino i non musulmani che
sposano l'idea della libertà di pensiero sono d'accordo sul fatto che comporti
delle responsabilità", scrive Choudary, che ammonisce: "Le potenziali
conseguenze dell'insultare il Messaggero Muhammad sono note a musulmani e non
musulmani". Parole che suonano come un tentativo di giustificare fatti
impossibili da legittimare. "Proprio perché l'onore del Profeta è qualcosa che
tutti i musulmani vogliono difendere, molti prenderanno la legge nelle proprie
mani", aggiunge il predicatore radicale, che ricorre poi a un argomento molto
utilizzato da chi si colloca su posizioni estremiste come le sue. "I governi
occidentali sono contenti di sacrificare libertà e diritti quando complici di
torture e rendition
- scrive - o quando limitano la libertà di movimento ai musulmani, sotto le
mentite spoglie della difesa della sicurezza nazionale". E al governo francese
chiede perché "mettere a rischio i propri cittadini" continuando a provocare il
mondo islamico, come accusa il Charlie
Hebdo di avere fatto. Parole,
quelle del predicatore, che stupiscono fino a un certo punto. Già in passato
aveva lodato gli attentatori dell'11 settembre e al Giornale
aveva detto: "Bin Laden è il nostro eroe. Purtroppo è morto, ma la lotta
continua anche senza di lui".
Chi l'ha visto il servizio
pubblico sulla carneficina dei giornalisti? La figuraccia della Rai,
scrive
Maurizio Caverzan su “Il Giornale”. Il servizio pubblico della Rai? Chi l'ha
visto?. Ma anche L'apprendista stregone e Che Dio ci aiuti . Sono i programmi
trasmessi nella serata della strage terroristica di Parigi, definita da molti
osservatori l'11 settembre dell'Europa. Niente speciali, zero edizioni
straordinarie. Titoli che, riletti oggi, svelano un sapore autocritico verso
quella che è una delle pagine più nere dell'informazione pubblica. Facevi
zapping da un canale all'altro, mercoledì sera, e trovavi un programma di
cronaca nera, un film qualsiasi, su Raiuno addirittura la replica di una
fiction. L'informazione può attendere. E il famigerato approfondimento, totem
dei talk show che sgomitano quotidianamente nei nostri teleschermi, può mettersi
in fila. Senza spingere. Quando invece ci sono dodici morti causati da un atto
terroristico nella redazione di un giornale della capitale francese, tutti
assenti. In vacanza o chissà. Dopo i tg che hanno conquistato ascolti ben al di
sopra della media, lo Speciale TgLa7 di Enrico Mentana è stato un approdo
obbligato come lo zapping sulle reti all news , a cominciare da Rainews24 , la
più solerte fin dal mattino a rendersi conto della gravità dell'accaduto. Su
Mediaset, Retequattro ha aperto una lunga finestra dopo il tg con Mario Giordano
e Paolo Del Debbio, mentre Matrix di Luca Telese è andato in onda in edizione
straordinaria. In Rai solo a notte inoltrata arriverà uno spezzone di Porta a
Porta nel tentativo di tamponare una falla gigantesca. Ma dopo il collegamento
con Di Bella e le dichiarazioni del ministro Alfano, vedere Gigi D'Alessio e
Lina Sastri commuoversi per la scomparsa del povero Pino Daniele aveva un
inevitabile effetto-extraterrestre. Servizio pubblico latitante. Lacunoso.
Ritardatario. Sui social network è un diluvio di proteste, di lamentele contro
un canone - il cui pagamento la Tv pubblica ricorda in questi giorni con
petulanza - purtroppo non corrisposto da servizi all'altezza in un momento
storico come questo. Il ritardo sulla notizia si è accumulato fin dalla tarda
mattinata quando, come ha notato tal Nicolino Berti su Twitter , «solo Raitre in
edizione straordinaria su Parigi, Raiuno deve prima far scolare la pasta alla
Clerici». I telegiornali Rai hanno fior di corrispondenti nella Ville Lumière,
anche uno di lunga esperienza come Antonio Di Bella. Ma quella di mercoledì 7
gennaio, prima giornata post-festività, rimarrà una pagina buia. Il giorno dopo,
la polemica infiamma. Il sindacato dei giornalisti Rai si straccia le vesti
(«Come si può parlare di riforma se poi di fronte a una vicenda di questa
portata, il servizio pubblico non reagisce mettendo in campo almeno su una delle
tre reti uno speciale di prima serata?»). Proteste arrivano da quasi tutte le
forze politiche che hanno deciso di chiedere spiegazioni al dg Luigi Gubitosi.
Riflessi appannati dai troppi dolciumi nelle calze della befana?
Sottovalutazione dell'accaduto? Disabitudine alle dirette su fatti
internazionali? Intoppi o veti burocratici sembrano da escludere. Non risulta,
infatti, che siano state avanzate richieste di modifica dei palinsesti della
prima serata dai vari direttori di rete o di testata ai quali compete la
valutazione degli avvenimenti. Spostare la replica di Che Dio ci aiuti non
sarebbe stato difficile nemmeno per i vertici di Viale Mazzini. Ora, dopo
l'ennesima giornata nera, ci si augura che qualcosa cambi. E che Dio aiuti la
Rai.
Toh, sui giornali i terroristi
non sono più «islamici», scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. I
«terroristi islamici» non esistono. Oggi vengono occultati dai mezzi di
comunicazione di massa con l'eufemismo «jihadisti». Ma quanti italiani sanno che
cosa significhi «jihadisti» o «jihad»? Il motto dei Fratelli musulmani evidenzia
il significato più genuino del jihad : «Allah è il nostro obiettivo. Il Profeta
è il nostro leader. Il Corano è la nostra legge. Il jihad è il nostro sentiero.
Morire lungo il sentiero di Allah è la nostra aspirazione massima». Il divieto
di usare il termine «terrorismo islamico» fu formalizzato nel 2006 (...)(...)
dall'Unione europea. È sconvolgente il fatto che mentre i terroristi islamici
sgozzano, decapitano e massacrano in ottemperanza ai versetti coranici e ai
detti e fatti attribuiti a Maometto, l'Occidente - pur di negare l'evidenza - si
sia spinto fino a «scomunicare» i terroristi islamici. Lo scorso 14 settembre,
dopo la decapitazione dell'ostaggio britannico David Haines, il premier Cameron
ha detto che i terroristi islamici dell'Isis «non sono musulmani ma mostri»,
«dicono di fare questo in nome dell'islam. È assurdo, l'islam è una religione di
pace». Anche il presidente americano Obama, intervenendo all'Assemblea generale
dell'Onu lo scorso 24 settembre, ha scagionato l'islam: «Gli Stati Uniti non
saranno mai in guerra contro l'islam. L'islam insegna la pace». Ma lo sanno
Obama e Cameron che il capo supremo del sedicente «Stato islamico»,
l'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi, oltre ad essere musulmano ha un
dottorato di ricerca in Scienze islamiche? Secondo loro questi tagliatori di
teste se non sono musulmani che cosa sarebbero? Di quale islam parlano? Il
Corano è unico e di Maometto ce n'è solo uno. Il vescovo di Mosul, Emile Nona,
intervistato da l'Avvenire lo scorso 12 agosto, ha detto che l'ideologia dei
terroristi islamici «è la religione islamica stessa: nel Corano ci sono versetti
che dicono di uccidere i cristiani, tutti gli altri infedeli», e che i
terroristi islamici «rappresentano la vera visione dell'islam». Eppure il 23
ottobre, sotto l'egida della presidente della Camera Laura Boldrini, la stampa
cattolica ( L'Avvenire , Famiglia Cristiana e la Fisc), hanno promosso la
campagna «Anche le parole possono uccidere», in cui si denuncia anche l'uso
della parola «terrorista» in rapporto ai musulmani. Sempre la Boldrini aveva
sponsorizzato nel 2007, da portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, con l'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione
nazionale della stampa, la «Carta di Roma», in cui si chiede di sostituire la
parola «clandestino» con «migrante». Ebbene, dopo che nessun mezzo di
comunicazione di massa usa più la parola «clandestino», ci ritroviamo in
un'Italia in cui la clandestinità non solo non è più reato ma in cui risorse
nazionali sono spese per favorire l'auto-invasione. Inevitabilmente accadrà lo
stesso con l'abolizione della parola «terrorista islamico». Già oggi i
terroristi islamici con cittadinanza europea, che rientrano dopo aver ucciso,
sgozzato e decapitato in Siria e Irak, vengono accolti con la disponibilità
riservata al figliol prodigo della parabola evangelica. Consentiamo che nelle
moschee e sui siti Internet si predichi l'odio e la violenza nei nostri
confronti, concependolo come libertà d'espressione fintantoché non si traduce
concretamente nella nostra morte. Di questo passo finiremo per giustificare i
terroristi islamici fino a legittimarli, sottoscrivendo noi stessi il nostro
suicidio e la fine della nostra civiltà.
L'unica paura della
sinistra? Che vincano gli "islamofobi".
Dal Pd agli
intellettuali progressisti il grande timore non è per la diffusione del
radicalismo omicida islamico, ma per la crescita di consensi della destra,
scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. Una minaccia paurosa, un nemico dentro
casa, travestito da anonimo cittadino ma pronto a colpire con la forza cieca
dell'odio: è lui, l'«islamofobo». Sì c'è qualche terrorista islamico armato di
kalashnikov e lanciarazzi che stermina innocenti, ma il vero problema, il vero
pericolo che corrono Francia, Italia ed Europa, adesso, più che l'ascesa degli
islamisti, è l'ascesa dei terribili «islamofobi», che con la scusa degli
sterminii in nome di Allah rischiano di prendere parecchi voti, e questo
l'Occidente non può accettarlo. Bernardo Valli su Repubblica , in un commento a
caldo sui dodici morti di Charlie Hebdo, ha subito ravvisato, con un brivido
lungo la schiena, il vero rischio implicito nell'attentato: «Attizzare
l'islamofobia». Un pericolo da combattere con uno spiegamento di forze speciali,
intelligence, ed editorialisti istruiti per educare il volgo, che sennò si
impressiona e poi vota male. Scende in campo anche Federico Rampini, sempre sul
giornale di De Benedetti, con la domanda che in queste ore attanaglia l'Europa
dopo gli attentati jihadisti e le minacce di nuovi morti: «E adesso Marine Le
Pen all'Eliseo?». Cioè la domanda non è «E adesso come ci difendiamo?» o «Adesso
che fare con il radicalismo islamico», ma «E adesso Marine Le Pen all'Eliseo?».
La sconvolgente conseguenza politica della carneficina, osserva l'esperto di
esteri di Repubblica , è infatti che si rafforzano «i partiti xenofobi in tutta
l'Europa», mentre sarebbe bene si rafforzasse il centrosinistra che piace più a
De Benedetti. Adesso «una vittoria di Marine Le Pen nella corsa all'Eliseo è più
probabile», mentre la Lega Nord e le formazioni «anti-immigrati» in ascesa
ovunque «raccoglieranno più consensi». Ci sarebbe da arrestare i terroristi solo
per il favore fatto a Le Pen e Salvini. Terrorizzato anche Khalid Chaouki,
deputato Pd di origine marocchina, tra i fondatori dei Giovani Musulmani
d'Italia : «Questa tragedia rischia di trasformarsi in un'occasione d'oro per
l'estrema destra francese e italiana e per gli ambienti antislamici - scrive
preoccupato su Il Garantista - Temo che Marine Le Pen non si lascerà sfuggire
l'occasione di cavalcare l'ondata emotiva francese e soffiare sul fuoco
pericoloso dell'islamofobia; perciò è doveroso ribadire con forza che noi siamo
contro il terrorismo di qualsiasi matrice ma anche contro l'islamofobia, che ne
è l'altra faccia». Le feroci cellule islamofobe, fagocitate dai famosi «ambienti
antislamici». Gente pericolosa da cui difendersi. Nessun problema culturale di
integrazione dell'Islam trova invece l'ex ministro (per mancanza di prove,
direbbe Dagospia ) Cécile Kyenge, miracolata da un seggio all'Europarlamento,
che invece ravvede una seria minaccia nei fondamentalisti delle brigate Salvini,
riconoscibili dalle felpe: «L'unico problema culturale lo ha creato chi come
Salvini e la Lega Nord avvelena la società con i suoi proclami di odio e
emargina il diverso, stigmatizzandolo» spiega l'ex ministra di origine
congolese, che poi mette sullo stesso piano l'Isis e la Lega Nord. «Dobbiamo
fermare tutti i moderni califfi fomentatori di odio, inclusi i nuovi
professionisti dell'odio politico» come l'odiato Salvini. Sempre dal Pd è il
giorno di Lia Quartapelle, giovane promessa di partito alla Farnesina e poi
sfumata, che su La7 ha ripetuto la vecchia storia sulle paure sfruttate dagli
estremisti di destra, «che fanno lo stesso gioco dei terroristi», mentre «nessun
terrorismo è di matrice religiosa». Tutti allievi, però, di Laura Boldrini, che
vorrebbe persino epurare il dizionario: «la parola “clandestino” - spiegò -
andrebbe cancellata, è carica di pregiudizio e negatività». Gli islamofobi,
invece, direttamente ai campi di rieducazione.
A Servizio Pubblico l'islam
che sta coi macellai di Parigi: "Fascisti, se la sono cercata".
Gli inviati di Santoro nelle
banlieue francesi danno voce alla rabbia dei musulmani: "Hanno fatto bene ad
ammazzarli, erano razzisti", scrive Sergio Rame su “Il Giornale”. È la storia di
due ragazzi di banlieue sprofondati nell’abisso dell’estremismo
e del terrore. Sono
Cherif
e
Said Kouachi,
i due franco-algerini di 32 e 34 anni, che ieri hanno insanguinato la Francia
nella strage contro Charlie Hebdo. Eppure, il primo era ben noto
all’antiterrorismo di Parigi, condannato nel 2008 per aver partecipato alla
filiera delle Buttes-Chaumont,
cellula islamica
del nord della capitale che tra il 2003 e il 2005 era impegnata nella recluta di
combattenti per al Qaeda in Iraq. Ed è proprio in queste
banlieue
che, ieri sera,
Servizio Pubblico ha portato le
proprie telecamere. Nel salotto di
Michele Santoro
va in scena il volto violento dell'islam.
"Hanno fatto bene ad ammazzarli - tuona un intervistato - erano razzisti".
"Non sono stati gli islamici - fa eco un
altro - è tutta una trappola". La strage alla redazione parigina di
Charlie Hebdo fa da margine. Eppure le dodici persone ammazzate gridano ancora
vendetta. I
jihadisti che le hanno
fatte fuori a colpi di kalashnikov sono ancora a piede libero. E a
Servizio Pubblico
c'è pure chi li giustifica, chi li difende, chi è pronto a stare dalla loro
parte. Dalla parte dei violenti. Per Santoro, invece, è l'occasione buona per
invitare i francesi a non votare il Front National di
Marine Le Pen.
Perché, a conti fatti, l'unica paura della sinistra è che alla fine vincano i
partiti che loro considerano "islamofobi". Dal Partito democratico
all'intellighenzia progrsessista non c'è una voce che grida contro il violento
diffondersi dell'estremismo islamico. Sono tutti concentrati a tuonare contro la
destra che, dall'Italia alla Francia, vede crescere i propri consensi di giorno
in giorno. Eppure gli stessi servizi trasmessi dagli inviati di
Servizio Pubblico
parlano chiaro. Il quartiere di Saint Denis è la fotografia della polveriera su
cui siede l'intera europa. Qui la concentrazione di
immigrati
è altissima. La stragrande maggioranza sono di fede islamica. E sono pronti a
difendere, anche davanti alle telecamere, il massacro alla redazione di
Charlie Hebdo.
"Adesso daranno la colpa a noi - si lamenta un
giovane - è sempre così". "Se è successo
quello che è successo - fa eco un altro - è perché qualche colpa quelli di
Charlie Hebdo ce l'hanno avuta". E ancora:
"Se si offende il Profeta è naturale che
qualcuno si vendichi". Mentre nelle piazze parigine si manifesta al grido
Je suis Charlie,
a Saint Denis di solidarietà per le dodici persone ammazzate non c'è spazio.
Anche a Reims, città dei fratelli Said e Cherif Kouachi, la musica è la stessa.
Nel quartiere di Croix Rouge, dove vivevano i due
terroristi
islamici, sono molti disposti a difenderli: "Li
conoscevo, non sono terroristi". "Non
possono essere stati loro - assicura un altro - è tutto un complotto".
Non eravate americani, ora
non siete Charlie.
Ieri come oggi dichiararsi
tutti paladini della libertà è una menzogna vigliacca. Perché abbiamo rinunciato
da tempo alla certezza di stare dalla parte giusta, scrive Giuseppe De Bellis su
“Il Giornale”. Bugiardi, quelli che dicono o scrivono «Siamo tutti Charlie
Hebdo». Mentono ora, come hanno mentito quasi 14 anni fa, quando scrivevano o
dicevano «siamo tutti americani», all'indomani dell'11 settembre. È una
vigliacca menzogna e qui non si parla del sentirsi oggi paladini della libertà
di stampa e di satira. Qui si parla di molto di più. Dell'Occidente che si mette
sul petto o sull'account dei social network lo slogan per sentirsi parte di
qualcosa alla quale in realtà ha rinunciato da tempo: la certezza di stare dalla
parte giusta. Ci abbiamo rinunciato quando abbiamo accettato che passasse la
filosofia dei «distinguo». Il fanatismo islamico non conosce differenze:
colpisce Stati e persone, militari e civili, cultura e satira. Uccide senza
pietà, come ha fatto a Parigi. E la nostra risposta è il dubbio che in fondo ce
la siamo cercata. O di più: che magari ci sia sotto la complicità o la manina di
chissà quale potere o servizio segreto. La teoria del complotto sulla strage di
Charlie Hebdo adesso appartiene a Beppe Grillo, ma presto penetrerà un pezzetto
alla volta esattamente come è accaduto 14 anni fa per le Torri Gemelle. È uno
dei sintomi della nostra sconfitta preventiva, questo. Aiuta la rimozione, la
presa di distanza dall'evento che sconvolge le nostre coscienze nell'immediato,
ma poi passa via. Il paragone con l'11 settembre sta in questo: è un ricordo
sbiadito, una memoria residua, una rievocazione appannata. Dov'è finito il
«siamo tutti americani» del giorno dopo? Non c'è: è sparito così in fretta da
non lasciare più spazio nemmeno alla retorica. Quattordici anni sono pochi per
ridurre solo a una data il momento che ha cambiato la storia, eppure non c'è un
altro fatto che sia diventato passato con la stessa velocità. Sembra che
l'Occidente abbia un pudore tutto suo ad alimentare la memoria e a piangere i
propri morti: qualcosa che assomiglia alla paura di dare fastidio all'islam e
alla vergogna per essersi sentiti tutti colpiti al cuore. Ricordiamo
ossessivamente il 25 aprile, nonostante molti di noi non fossero neanche nati
quel giorno e invece dimentichiamo l'11 settembre che invece abbiamo vissuto in
diretta. Il secondo sintomo della nostra sconfitta sta nell'incapacità di
accettare che a una guerra sporca si risponde con leggi straordinarie e a volte
anche con qualcosa che sta al confine con la legge. L'hanno fatto tutti i Paesi
occidentali quando hanno battuto il terrorismo domestico. Con il terrore
internazionale no. Di più, abbiamo messo in discussione tutto: l'apertura di
Guantanamo, gli interrogatori ai presunti terroristi, gli arresti dei sospetti.
Abbiamo fatto passare i servizi segreti di tutto il mondo per criminali. Abbiamo
rinunciato di fatto alla guerra in Afghanistan, convinti che i presupposti
fossero sbagliati. Così via alla guerra del drone che ha pulito molte coscienze,
ma in realtà ha fatto molti più morti. Anche la clamorosa campagna di
autocritica sulle torture è stata un errore colossale. Noi processiamo
(soprattutto noi stessi), loro fanno stragi. Allora, che significato ha il
nostro senso di colpa? È una sconfitta doppia, perché rende l'Occidente ancora
più vulnerabile. Qualcuno davvero pensa che se i governi avessero usato o
usassero solo mezzi totalmente leciti la violenza cesserebbe o si ridurrebbe?
No. Anzi, forse è il contrario. L'Occidente darebbe il segnale della sua
debolezza e presterebbe il fianco a un'escalation del fanatismo. I
fondamentalisti attaccano nel centro di una metropoli europea con i kalashnikov
e noi applichiamo leggi ordinarie? Non abbiamo capito. Non capiamo. Non capisce
soprattutto la politica, assente da 14 anni nel dibattito sulla guerra al
terrorismo. Guardate l'imbarazzante reazione dell'Europa ai fatti di Parigi: non
una sola voce comune, né tantomeno una voce forte di condanna o di presa d'atto
che si tratta di una guerra dichiarata sul nostro territorio. L'Europa non
esiste, punto. E più che sull'euro, sulla crisi, sull'austerità, lo dimostra sul
terrorismo. Siamo in balia della nostra apatia e della nostra ideologia
remissiva: la verità è che ci siamo autoconvinti che l'Occidente sia colpevole.
Le immagini di Parigi hanno fatto rimbalzare quelle di Londra 2013, quando due
inglesi di origine nigeriana uccisero sgozzandoli due agenti nell'indifferenza
collettiva. Nessuna reazione. Paura, punto. L'Occidente si protegge chiedendo
scusa. Perché? Ci siamo dimenticati che non siamo noi quelli dalla parte
sbagliata. Ci siamo dimenticati che noi siamo le vittime.
Sull'islam aveva ragione
quella "pazza" di Oriana Fallaci.
L'odio per l'Occidente, il
fallimento dell'integrazione: in queste righe sembra di leggere la cronaca di
oggi, scrive Oriana Fallaci su “Il Giornale”.
Leggete queste righe come fossero un saggio scritto ieri, e avrete una valida
analisi dei fatti di attualità degli ultimi giorni. Ma, com'è ovvio, le righe
che seguono sono state scritte da Oriana Fallaci non in queste ore, ma
all'indomani dell'11 settembre del 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle.
Parole scritte con rabbia e con l'intensità di cui lei era capace, ma anche con
coraggio. Un coraggio che dette fastidio a chi preferiva non intendere le sue
ragioni. Abbiamo deciso di ripubblicare un estratto dei suoi scritti sul
rapporto tra l'Islam e l'Occidente, che si possono leggere in versione integrale
nei libri editi da Rizzoli:
Con "La rabbia e
l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci rompe un silenzio durato dieci anni,
dalla pubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sulla missione occidentale di
pace nella Beirut dilaniata dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle
faide con Israele. Dieci anni in cui la Fallaci sceglie di vivere ritirata nella
sua casa newyorchese, come in esilio, a combattere il cancro. Ma non smette mai
di lavorare al testo narrativo dedicato alla sua famiglia, quello che lei chiama
"il-mio-bambino", pubblicato postumo nel 2008, "Un cappello pieno di ciliege".
L'undici settembre le impone di tornare con furia alla macchina da scrivere per
dar voce a quelle idee che ha sempre coltivato nelle interviste, nei reportage,
nei romanzi, ma che ha poi "imprigionato dentro il cuore e dentro il cervello"
dicendosi "tanto-la-gente-non-vuole-ascoltare". Il risultato è un articolo sul
"Corriere della Sera" del 29 settembre 2001, un sermone lo definisce lei stessa,
accolto con enorme clamore in Italia e all'estero. Esce in forma di libro nella
versione originaria e integrale, preceduto da una prefazione in cui la Fallaci
affronta alle radici la questione del terrorismo islamico e parla di sé, del suo
isolamento, delle sue scelte rigorose e spietate. La risposta è esplosiva, le
polemiche feroci. Mentre i critici si dividono, l'adesione dei lettori, in tutto
il mondo, è unanime di fronte alla passione che anima queste pagine.
"La forza della ragione"
(2004)
voleva essere solo un post-scriptum intitolato "Due anni dopo", cioè una breve
appendice a "La rabbia e l'orgoglio". Ma quando ebbe concluso il lavoro, Oriana
Fallaci si rese conto di aver scritto un altro libro. L'autrice parte stavolta
dalle minacce di morte ricevute per "La rabbia e l'orgoglio" e, identificandosi
in tal Mastro Cecco che a causa di un libro venne bruciato vivo
dall'Inquisizione, si presenta come una Mastra Cecca che, eretica irriducibile e
recidiva, sette secoli dopo fa la stessa fine. Tra il primo e il secondo rogo,
l'analisi di ciò che chiama l'Incendio di Troia, ossia di un'Europa che a suo
giudizio non è più Europa, ma Eurabia, colonia dell'Islam.
Oriana Fallaci
intervista se stessa (2004).
“Scrivere per libertà e disobbedienza”: è il monito che ha sempre guidato
Oriana Fallaci e che ha ispirato anche questo libro, terzo e ultimo volume della
Trilogia iniziata con La Rabbia e l’Orgoglio (2001) e proseguita con La Forza
della Ragione (2004). Completando le sue riflessioni sul declino morale e
intellettuale della nostra civiltà, la grande scrittrice costruisce una lunga
intervista a sé stessa e la arricchisce con uno straordinario Post-Scriptum che
si rifà all’Apocalisse dell’evangelista Giovanni. Con la sua scrittura
magistrale, potente, provocatoria, la Fallaci ci offre un’accorata testimonianza
della sua vita e del suo pensiero: scrive con la consueta schiettezza di
terrorismo islamico e della crisi europea, racconta la sua lotta contro il
cancro, rimarca principi etici da difendere senza compromessi, colpisce con
durissimi fendenti la pavidità della politica e traccia il ritratto senza sconti
di un Occidente rassegnato e indifeso, sempre più prossimo al rischio di andare
in frantumi.
Un atto di giustizia
rileggerli oggi che il quadro è ancora più chiaro e molti, che le davano della
pazza, sono costretti ad ammettere che invece ci aveva visto giusto.
***
Sono anni che come una
Cassandra mi sgolo a gridare «Troia brucia, Troia brucia». Anni che ripeto al
vento la verità sul Mostro e sui complici del Mostro cioè sui collaborazionisti
che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Che come nell'Apocalisse
dell'evangelista Giovanni si gettano ai suoi piedi e si lasciano imprimere il
marchio della vergogna. Incominciai con La Rabbia e l'Orgoglio . Continuai con
La Forza della Ragione . Proseguii con Oriana Fallaci intervista sé stessa e con
L'Apocalisse . I libri, le idee, per cui in Francia mi processarono nel 2002 con
l'accusa di razzismo-religioso e xenofobia. Per cui in Svizzera chiesero al
nostro ministro della Giustizia la mia estradizione in manette. Per cui in
Italia verrò processata con l'accusa di vilipendio all'Islam cioè reato di
opinione. Libri, idee, per cui la Sinistra al Caviale e la Destra al Fois Gras
ed anche il Centro al Prosciutto mi hanno denigrata vilipesa messa alla gogna
insieme a coloro che la pensano come me. Cioè insieme al popolo savio e indifeso
che nei loro salotti viene definito dai radical-chic «plebaglia-di-destra». E
sui giornali che nel migliore dei casi mi opponevano farisaicamente la congiura
del silenzio ora appaiono titoli composti coi miei concetti e le mie parole.
Guerra-all'Occidente, Culto-della-Morte, Suicidio-dell'Europa,
Sveglia-Italia-Sveglia.
Il nemico è in casa. Continua
la fandonia dell'Islam «moderato», la commedia della tolleranza, la bugia
dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo. E con questa, il tentativo di
farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza e che quella
esigua minoranza vive in Paesi lontani. Be', il nemico non è affatto un'esigua
minoranza. E ce l'abbiamo in casa. Ed è un nemico che a colpo d'occhio non
sembra un nemico. Senza la barba, vestito all'occidentale, e secondo i suoi
complici in buona o in malafede
perfettamente-inserito-nel-nostro-sistema-sociale. Cioè col permesso di
soggiorno. Con l'automobile. Con la famiglia. E pazienza se la famiglia è spesso
composta da due o tre mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di
botte, pazienza se non di rado uccide la figlia in blue jeans, pazienza se ogni
tanto suo figlio stupra la quindicenne bolognese che col fidanzato passeggia nel
parco. È un nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia ci odia e ci disprezza
con intensità. Un nemico che in nome dell'umanitarismo e dell'asilo politico
accogliamo a migliaia per volta anche se i Centri di accoglienza straripano,
scoppiano, e non si sa più dove metterlo. Un nemico che in nome della
«necessità» (ma quale necessità, la necessità di riempire le strade coi
venditori ambulanti e gli spacciatori di droga?) invitiamo anche attraverso
l'Olimpo Costituzionale. «Venite, cari, venite. Abbiamo tanto bisogno di voi».
Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in
centri di reclutamento per i terroristi, e che obbedisce ciecamente all'imam. Un
nemico che in virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen
scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia sicché per andare da Londra a
Marsiglia, da Colonia a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento.
Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un
massacro, può avere addosso tutto l'esplosivo che vuole: nessuno lo ferma,
nessuno lo tocca.
Il crocifisso sparirà. Un
nemico che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si
abbandona alle prepotenze ed esige l'alloggio gratuito o semi-gratuito nonché il
voto e la cittadinanza. Tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che
ci impone le proprie regole e i propri costumi. Che bandisce il maiale dalle
mense delle scuole, delle fabbriche, delle prigioni. Che aggredisce la maestra o
la preside perché una scolara bene educata ha gentilmente offerto al compagno di
classe musulmano la frittella di riso al marsala cioè «col liquore».
E-attenta-a-non-ripeter-l'oltraggio. Un nemico che negli asili vuole abolire
anzi abolisce il Presepe e Babbo Natale. Che il crocifisso lo toglie dalle aule
scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce «un
cadaverino ignudo e messo lì per spaventare i bambini musulmani». Un nemico che
in Inghilterra s'imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il
jumbo del volo Parigi-Miami. Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo van Gogh
colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane e che dopo
averlo ucciso gli apre il ventre, ci ficca dentro una lettera con la condanna a
morte della sua migliore amica. Il nemico, infine, per il quale trovi sempre un
magistrato clemente cioè pronto a scarcerarlo. E che i governi eurobei (ndr: non
si tratta d'un errore tipografico, voglio proprio dire eurobei non europei) non
espellono neanche se è clandestino.
Dialogo tra civiltà. Apriti
cielo se chiedi qual è l'altra civiltà, cosa c'è di civile in una civiltà che
non conosce neanche il significato della parola libertà. Che per libertà,
hurryya, intende «emancipazione dalla schiavitù». Che la parola hurryya la coniò
soltanto alla fine dell'Ottocento per poter firmare un trattato commerciale. Che
nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate.
Che dei Diritti dell'Uomo da noi tanto strombazzati e verso i musulmani
scrupolosamente applicati non vuole neanche sentirne parlare. Infatti rifiuta di
sottoscrivere la Carta dei Diritti Umani compilata dall'Onu e la sostituisce con
la Carta dei Diritti Umani compilata dalla Conferenza Araba. Apriti cielo anche
se chiedi che cosa c'è di civile in una civiltà che tratta le donne come le
tratta. L'Islam è il Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è
incompatibile con la Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile
con i Diritti Umani. È incompatibile col concetto di civiltà.
Una strage in Italia? La
strage toccherà davvero anche a noi, la prossima volta toccherà davvero a noi?
Oh, sì. Non ne ho il minimo dubbio. Non l'ho mai avuto. E aggiungo: non ci hanno
ancora attaccato in quanto avevano bisogno della landing-zone, della testa di
ponte, del comodo avamposto che si chiama Italia. Comodo geograficamente perché
è il più vicino al Medio Oriente e all'Africa cioè ai Paesi che forniscono il
grosso della truppa. Comodo strategicamente perché a quella truppa offriamo
buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà. Ma presto si scateneranno.
Molti italiani non ci credono ancora. Si comportano come i bambini per cui la
parola Morte non ha alcun significato. O come gli scriteriati cui la morte
sembra una disgrazia che riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una
disgrazia che li colpirà per ultimi. Peggio: credono che per scansarla basti
fare i furbi cioè leccarle i piedi.
Multiculturalismo, che
panzana. L'Eurabia ha costruito la panzana del pacifismo multiculturalista, ha
sostituito il termine «migliore» col termine «diverso-differente», s'è messa a
blaterare che non esistono civiltà migliori. Non esistono principii e valori
migliori, esistono soltanto diversità e differenze di comportamento. Questo ha
criminalizzato anzi criminalizza chi esprime giudizi, chi indica meriti e
demeriti, chi distingue il Bene dal Male e chiama il Male col proprio nome. Che
l'Europa vive nella paura e che il terrorismo islamico ha un obbiettivo molto
preciso: distruggere l'Occidente ossia cancellare i nostri principii, i nostri
valori, le nostre tradizioni, la nostra civiltà. Ma il mio discorso è caduto nel
vuoto. Perché? Perché nessuno o quasi nessuno l'ha raccolto. Perché anche per
lui i vassalli della Destra stupida e della Sinistra bugiarda, gli intellettuali
e i giornali e le tv insomma i tiranni del politically correct , hanno messo in
atto la Congiura del Silenzio. Hanno fatto di quel tema un tabù.
Conquista demografica.
Nell'Europa soggiogata il tema della fertilità islamica è un tabù che nessuno
osa sfidare. Se ci provi, finisci dritto in tribunale per
razzismo-xenofobia-blasfemia. Ma nessun processo liberticida potrà mai negare
ciò di cui essi stessi si vantano. Ossia il fatto che nell'ultimo mezzo secolo i
musulmani siano cresciuti del 235 per cento (i cristiani solo del 47 per cento).
Che nel 1996 fossero un miliardo e 483 milioni. Nel 2001, un miliardo e 624
milioni. Nel 2002, un miliardo e 657 milioni. Nessun giudice liberticida potrà
mai ignorare i dati, forniti dall'Onu, che ai musulmani attribuiscono un tasso
di crescita oscillante tra il 4,60 e il 6,40 per cento all'anno (i cristiani,
solo 1'1 e 40 per cento). Nessuna legge liberticida potrà mai smentire che
proprio grazie a quella travolgente fertilità negli anni Settanta e Ottanta gli
sciiti abbiano potuto impossessarsi di Beirut, spodestare la maggioranza
cristiano-maronita. Tantomeno potrà negare che nell'Unione Europea i neonati
musulmani siano ogni anno il dieci per cento, che a Bruxelles raggiungano il
trenta per cento, a Marsiglia il sessanta per cento, e che in varie città
italiane la percentuale stia salendo drammaticamente sicché nel 2015 gli attuali
cinquecentomila nipotini di Allah da noi saranno almeno un milione.
Addio Europa, c'è l'Eurabia.
L'Europa non c'è più. C'è l'Eurabia. Che cosa intende per Europa? Una cosiddetta
Unione Europea che nella sua ridicola e truffaldina Costituzione accantona
quindi nega le nostre radici cristiane, la nostra essenza? L'Unione Europea è
solo il club finanziario che dico io. Un club voluto dagli eterni padroni di
questo continente cioè dalla Francia e dalla Germania. È una bugia per tenere in
piedi il fottutissimo euro e sostenere l'antiamericanismo, l'odio per
l'Occidente. È una scusa per pagare stipendi sfacciati ed esenti da tasse agli
europarlamentari che come i funzionari della Commissione Europea se la spassano
a Bruxelles. È un trucco per ficcare il naso nelle nostre tasche e introdurre
cibi geneticamente modificati nel nostro organismo. Sicché oltre a crescere
ignorando il sapore della Verità le nuove generazioni crescono senza conoscere
il sapore del buon nutrimento. E insieme al cancro dell'anima si beccano il
cancro del corpo.
Integrazione impossibile. La
storia delle frittelle al marsala offre uno squarcio significativo sulla
presunta integrazione con cui si cerca di far credere che esiste un Islam ben
distinto dall'Islam del terrorismo. Un Islam mite, progredito, moderato, quindi
pronto a capire la nostra cultura e a rispettare la nostra libertà. Virgilio
infatti ha una sorellina che va alle elementari e una nonna che fa le frittelle
di riso come si usa in Toscana. Cioè con un cucchiaio di marsala dentro
l'impasto. Tempo addietro la sorellina se le portò a scuola, le offrì ai
compagni di classe, e tra i compagni di classe c'è un bambino musulmano. Al
bambino musulmano piacquero in modo particolare, così quel giorno tornò a casa
strillando tutto contento: «Mamma, me le fai anche te le frittelle di riso al
marsala? Le ho mangiate stamani a scuola e...». Apriti cielo. L'indomani il
padre di detto bambino si presentò alla preside col Corano in pugno. Le disse
che aver offerto le frittelle col liquore a suo figlio era stato un oltraggio ad
Allah, e dopo aver preteso le scuse la diffidò dal lasciar portare quell'immondo
cibo a scuola. Cosa per cui Virgilio mi rammenta che negli asili non si erige
più il Presepe, che nelle aule si toglie dal muro il crocifisso, che nelle mense
studentesche s'è abolito il maiale. Poi si pone il fatale interrogativo: «Ma chi
deve integrarsi, noi o loro?».
L'islam moderato non esiste.
Il declino dell'intelligenza è il declino della Ragione. E tutto ciò che oggi
accade in Europa, in Eurabia, ma soprattutto in Italia è declino della Ragione.
Prima d'essere eticamente sbagliato è intellettualmente sbagliato. Contro
Ragione. Illudersi che esista un Islam buono e un Islam cattivo ossia non capire
che esiste un Islam e basta, che tutto l'Islam è uno stagno e che di questo
passo finiamo con l'affogar dentro lo stagno, è contro Ragione. Non difendere il
proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la
propria essenza, è contro Ragione. Accettare passivamente le sciocche o ciniche
menzogne che ci vengono somministrate come l'arsenico nella minestra è contro
Ragione. Assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi per viltà o per pigrizia è contro
Ragione. Morire di sete e di solitudine in un deserto sul quale il Sole di Allah
brilla al posto del Sol dell'Avvenir è contro Ragione.
Ecco cos'è il Corano. Perché
non si può purgare l'impurgabile, censurare l'incensurabile, correggere
l'incorreggibile. Ed anche dopo aver cercato il pelo nell'uovo, paragonato
l'edizione della Rizzoli con quella dell'Ucoii, qualsiasi islamista con un po'
di cervello ti dirà che qualsiasi testo tu scelga la sostanza non cambia. Le
Sure sulla jihad intesa come Guerra Santa rimangono. E così le punizioni
corporali. Così la poligamia, la sottomissione anzi la schiavizzazione della
donna. Così l'odio per l'Occidente, le maledizioni ai cristiani e agli ebrei
cioè ai cani infedeli.
La Parigi della Fallaci
capitale d'Eurabia e dei collaborazionisti.
Nella
Trilogia, molti passi sulla Francia ormai contro-colonizzata dall'immigrazione
musulmana. Colpa (anche) degli intellettuali,, scrive Alessandro Gnocchi su “Il
Giornale”. Secondo Oriana Fallaci, Parigi era la capitale d'Eurabia.
Quest'ultimo termine, introdotto nel dibattito dalla storica Bat Ye'Or (in
Eurabia , Lindau), descrive il futuro del Vecchio Continente dilaniato al suo
interno dallo scontro con l'islam. Alla radice ci sono gli accordi di
cooperazione tra Europa e Paesi arabi firmati negli anni Settanta. L'Europa
avrebbe fornito tecnologia ai Paesi arabi in cambio di greggio e manodopera. Si
teorizzava la necessità di una forte immigrazione, presto diventata accesso
incontrollato, verso le nostre sponde. La massiccia presenza di stranieri in
Europa, secondo la Fallaci, era il cavallo di Troia di una colonizzazione al
contrario. Rileggiamo La Forza della Ragione (Rizzoli, 2004). Per i difensori
dell'Occidente, Parigi è persa. «Non è facile avere coraggio in un Paese dove
esistono più di tremila moschee» e i musulmani sono così numerosi (ben oltre
l'ufficiale dieci per cento della popolazione). In Francia «il razzismo islamico
cioè l'odio per i cani-infedeli regna sovrano e non viene mai processato, mai
punito». Gli imam dichiarano di voler sfruttare la democrazia «per occupare
territorio» e sovvertire le leggi laiche in favore della sharia. L'antisemitismo
è in crescita. I quartieri di troppe città, stravolte dal cambiamento
demografico, hanno perso l'identità francese per acquisire quella magrebina. Di
fronte a queste tesi, l'intellighentia scese compatta in campo per screditare la
Fallaci. La giornalista fu tra i primi, in Europa, a sperimentare strumenti ed
effetti del politicamente corretto. Ripercorriamo questa vicenda esemplare. La
Rabbia e l'Orgoglio (Rizzoli) esce a Parigi nel maggio 2002. Mentre la prima
tiratura di 25 mila copie va esaurita in due settimane, gli intellettuali si
esibiscono sui giornali. Ad aprire la polemica è il settimanale Le Point .
Secondo il filosofo Bernard-Henri Lévy, il libro della Fallaci è paragonabile
alle peggiori opere antisemite come Bagatelle per un massacro di Louis-Ferdinand
Céline: «È un libro razzista. Con meno talento, è un Bagatelle antiarabo».
Stessa linea per Françoise Giroud su Le Nouvel Observateur : «La Fallaci tocca
nel lettore qualcosa di profondo, d'inconfessato, che egli negherà sempre di
aver pensato ma che queste pagine cariche di odio e di disprezzo rischiano di
illuminare brutalmente». Il sociologo Gilles Kepel su Le Monde imputa al libro
di aver sancito la vittoria di Osama bin Laden, trascinando l'Occidente sul
campo della reazione isterica. Una voce fuori dal coro? Charlie Hebdo ammette la
verità di fondo del libro. Ma anche il settimanale satirico, di fronte alla
reazione dei lettori, è costretto a «ritrattare» (in parte). All'inizio di
giugno, la Fallaci risponde sul Corriere della Sera . L'articolo Eppure con la
Francia non sono arrabbiata è accompagnato da brani composti in francese per La
Rabbia e l'Orgoglio e ora tradotti in italiano. In breve: la specie tutta
europea dei «voltagabbana» (o collaborazionisti) trova la sua origine e massima
espressione in Francia fin dal Medioevo. Tra i voltagabbana più abili nello
schierarsi sempre dalla parte vincente, ci sono gli intellettuali. Oggi ha vinto
il politicamente corretto. E quindi... «Queste creature patetiche, inutili,
questi parassiti. Questi falsi sanculotti che vestiti da ideologi, giornalisti,
scrittori, teologi, cardinali, attori, commentatori, puttane à la page, grilli
canterini, giullari usi a leccare i piedi ai Khomeini e ai Pol Pot, dicono solo
ciò che gli viene ordinato di dire. Ciò che gli serve a entrare o restare nel
jet-set pseudointellettuale, a sfruttarne i vantaggi e i privilegi, a guadagnar
soldi». Gli intellettuali hanno rimpiazzato l'ideologia marxista con la «viscida
ipocrisia» che «in nome della Fraternité (sic) predica il pacifismo a oltranza
cioè ripudia perfino la guerra che abbiamo combattuto contro i nazifascismi di
ieri, canta le lodi degli invasori e crucifigge i difensori». La cultura è il
regno delle mode. La moda «o meglio l'inganno che in nome dell'Humanitarisme
(sic) assolve i delinquenti e condanna le vittime, piange sui talebani e sputa
sugli americani, perdona tutto ai palestinesi e nulla agli israeliani». La moda
«o meglio la demagogia che in nome dell'Égalité (sic) rinnega il merito e la
qualità, la competizione e il successo». La moda «o meglio la cretineria che in
nome della Justice (sic) abolisce le parole del vocabolario e chiama gli
spazzini “operatori ecologici”». La moda «o meglio la disonestà, l'immoralità,
che definisce “tradizione locale” e “cultura diversa” l'infibulazione ancora
eseguita in tanti paesi musulmani». La moda di magnificare le conquiste
culturali dell'islam per farlo apparire superiore all'Occidente. E infine la
moda «che permette di stabilire un nuovo terrorismo intellettuale: quello di
sfruttare a proprio piacimento il termine “razzismo”. Non sanno che cosa
significa eppure lo usano lo stesso». Passano dieci giorni. Tre associazioni
francesi denunciano la Fallaci per islamofobia e incitazione al razzismo. Era
accaduto, poco prima, anche a Michel Houellebecq, a causa dei duri giudizi
sull'islam contenuti nel romanzo Piattaforma (Bompiani) e ribaditi in
un'intervista. Il tribunale di Parigi assolve la Fallaci mentre La Rabbia e
l'Orgoglio supera le duecentomila copie. Quanta fatica sprecata per liquidare la
Fallaci. Oriana guardava lontano mentre gli intellettuali non si sono accorti
dei processi storici e delle ideologie di morte che hanno davanti agli occhi.
Magdi come la Fallaci
processati per le loro idee.
La
scrittrice finì alla sbarra in Italia, Francia e Svizzera per i suoi scritti sul
pericolo islamico E anche lei diceva: «Non mi faccio intimidire», scrive “Il
Giornale”. L i chiamava «i miei trofei». E di «trofei», alias processi per reato
d'opinione a causa delle idee sull'islam espresse in libri e articoli, Oriana
Fallaci ne ha subiti diversi nel corso della sua vita, in tutta Europa, dalla
Francia alla Svizzera. E naturalmente pure in Italia, anche se l'ultimo, a
Bergamo, è cominciato a giugno del 2006, due mesi prima che lei morisse, il 15
settembre. Oriana Fallaci come Magdi Cristiano Allam, anzi molto di più. A parte
«l'amicizia complessa», così la definì Allam quando lei morì, che li legava sul
fronte comune della denuncia dei pericoli del fondamentalismo islamico e del suo
radicamento in Europa, c'è anche la persecuzione per via giudiziaria delle
opinioni che li accomuna. Per Allam, oggi, si tratta di un procedimento avviato
dal Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti che lo accusa
di «islamofobia». Per la Fallaci, all'epoca, erano invece veri e propri processi
penali, per vilipendio all'islam, razzismo, xenofobia. La sostanza, però, non
cambia: vietato essere critici nei confronti dei musulmani, pena la gogna, anche
giudiziaria. Si arrabbiava, la Fallaci, per quei quattro processi: due in
Francia, a partire dal 2002 (quello per «razzismo», nel 2003, si chiuse con la
sua assoluzione) e uno in Svizzera, tutti legati a La rabbia e l'orgoglio ; e un
altro in Italia, nel 2006, finito con la sua morte. Li chiamava sì trofei ma li
riteneva profondamente ingiusti. Ecco come lei stessa li raccontava a novembre
del 2005 nel discorso di ringraziamento per il conferimento dell' Annie Taylor
Award , il cui testo è stato pubblicato qualche giorno fa da Libero : «I trofei
che chiamo processi. Si svolgono in ogni Paese nel quale un figlio di Allah o un
traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da
Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France
Eternelle , la Patrie du Laïcisme , la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité
, dove per vilipendio all'islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha
sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France
Libérale, Progressiste , dove tre anni fa gli ebrei francesi della Licra
(associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel
Sharon con la svastica in fronte) si unì ai musulmani francesi del Mrap
(associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush
con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice penale di
chiudermi in galera, confiscare La Rage et l'Orgueil (La rabbia e l'orgoglio, ma
la richiesta fu respinta, ndr ) o venderla con il seguente ammonimento sulla
copertina: “Attenzione! Questo libro può costituire un pericolo per la vostra
salute mentale”. Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweits , la
meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il ministro della Giustizia osò
chiedere al mio ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo,
Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un
giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena
che per vilipendio dell'islam viene impartita nel mio paese». Era furibonda, la
Fallaci, per il processo di Bergamo, legato ad alcune affermazioni contenute in
La forza della ragione . Un processo travagliato, partito dalla denuncia, nel
2004, di Adel Smith, il presidente all'epoca del'Unione dei Musulmani d'Italia
che aveva definito il crocifisso un «cadaverino nudo inventato per spaventare i
bambini musulmani». Il pm aveva chiesto l'archiviazione per la Fallaci, ma il
gip l'aveva rigettata, imponendo l'imputazione coatta. Ecco cosa scriveva la
stessa Fallaci a luglio del 2005, sul Corriere della Sera , nel celebre articolo
dopo gli attentati di Londra «Il nemico che trattiamo da amico» : «Mi ascolti
bene, signor giudice di Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio
all'islam ma che non ha mai incriminato il mio persecutore per vilipendio al
cristianesimo. Nonché per istigazione all'omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi
condanni pure. Mi infligga pure quei tre anni di reclusione che i magistrati
italiani non infliggono nemmeno ai terroristi islamici beccati con l'esplosivo
in cantina. Il suo processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò
ciò che ho scritto nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta
intimidire, non mi faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle
persecuzioni, dalle denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato
bene dal proteggermi, anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi
faccio intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed
esprimere la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve
togliere. Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato
italiano mi ha cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o
come Theo Van Gogh? Glielo chiedo perché il ministro dell'Interno dice che nelle
nostre carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e
suppongo che di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia». Al
processo, iniziato il 9 giugno del 2006, la Fallaci non si presentò per scelta.
Per quel processo ricevette attestati di solidarietà da mezzo mondo, pure
dall'ex presidente polacco Lech Walesa. E quel processo finì nel nulla. Alla
fine lo beffò la morte della giornalista e scrittrice, il 15 settembre del 2006.
La guerra siriana si
combatteva in Italia. Tra il
2011 e il 2012 sono state commesse, tra Milano e Roma, più di venti azioni
violente di chiara matrice jihadista con obiettivo soprattutto i cristiani. A
rivelarlo è un'indagine della polizia e dai magistrati anti-terrorismo, scrive
Paolo Biondani su “L’Espresso”.
Un piccolo spezzone della
guerra civile siriana
si è combattuto in Italia. Ma era ancora troppo presto per capirlo. Tra il 2011
e il 2012 sono state commesse, tra Milano e Roma, più di venti azioni violente
di chiara matrice jihadista: ferimenti, aggressioni, pestaggi, danneggiamenti,
devastazioni, minacce e intimidazioni. Le vittime appartengono alle minoranze
politico-religiose più perseguitate dalle milizie islamiste in Siria: le
violenze in Italia hanno colpito soprattutto cristiani. A rivelarlo è
un'indagine, avviata dalla polizia e dai magistrati anti-terrorismo di Milano,
che viene ricostruita in un articolo del settimanale “l'Espresso”. Da quando è
esplosa la guerra civile in Siria, le forze di polizia di tutti i Paesi
occidentali hanno cominciato a sorvegliare le partenze degli estremisti verso i
fronti di guerra. A Milano la Digos ha messo sotto controllo, in particolare, un
gruppo di siriani residenti da anni tra Milano, Como e Monza: spariti
dall’Italia, sono ricomparsi, mitra in pugno, in una serie di foto e video
pubblicati su Internet tra febbraio e luglio del 2012. Solo a quel punto la
polizia, ricostruendo le loro precedenti attività in Italia, ha scoperto che
quegli stessi jihadisti siriani avevano già colpito, segretamente, anche a casa
nostra. L’unica azione visibile si è svolta nella notte del 10 febbraio 2012 nel
centro di Roma: un plotone di oppositori siriani ha dato l’assalto
all’ambasciata di Damasco, che è stata occupata e devastata. Quel raid di
protesta contro il regime del presidente-dittatore
Bashar El-Assad
è stato organizzato proprio dal gruppo di
estremisti che poi sono partiti per la guerra in Siria. Nei mesi successivi le
indagini della polizia hanno collegato alla stessa cellula jihadista molte altre
azioni violente, mai denunciate per paura. Tra le vittime, due siriani di fede
cristiana, che gestivano un bar a Cologno Monzese. Il loro locale è stato
devastato nell'estate 2011 da un commando di oltre trenta uomini armati di
bastoni e spranghe di ferro. Sulla saracinesca è poi comparsa una scritta in
arabo: «Per tutti i siriani: quelli che sono a favore del presidente devono
stare attenti. In Siria ci penseremo noi. Quelli che ammazzano nel jihad, vivono
con Dio». Nella primavera 2012, dopo altre gravi intimidazioni, i due cristiani
hanno ceduto il bar e si sono trasferiti. Un altro agguato di stampo jihadista
ha colpito due siriani che lavorano regolarmente tra Milano e la Brianza: uno è
cristiano, l’altro della minoranza sciita-alauita, ma i loro amici più cari sono
sunniti. Il 16 luglio 2011 hanno partecipato a una fiaccolata filo-Assad
organizzata da un'associazione di cui fanno parte anche cittadini italiani.
Mentre tornavano a casa in macchina, sono stati circondati e picchiati
ferocemente da almeno 15 sprangatori jihadisti. Le due vittime, sanguinanti a
terra, sono state salvate dall'arrivo dei carabinieri. Il cristiano è stato
ricoverato al San Raffaele con una gamba spappolata e operato più volte. A una
spedizione punitiva è sfuggito anche un religioso legato alla
Fratellanza Musulmana,
il partito allora al potere in Egitto, che aveva messo al bando le sette
jihadiste dalle moschee milanesi. A quel punto l’ala dura dei salafiti siriani
lo ha minacciato di morte: «Sei un traditore.... Ti uccideremo a coltellate...
Ti sgozzeremo come un cane». Dopo mesi di indagini, la
Digos
ha smascherato gli esponenti più violenti del gruppo jihadista milanese. Ma a
quel punto erano già partiti tutti per la guerra. Uno dei più sanguinari è stato
identificato in due video-choc, girati in Siria nel maggio 2012 (e scoperti da
un fotoreporter della Rai): con il mitra a tracolla, si è fatto riprendere con
un plotone di uomini armati, mentre uccidevano con un colpo alla testa sette
prigionieri di guerra, legati e torturati.
IL NATALE COME TRADIZIONE E
CULTURA: GENESI ED EVOLUZIONE.
Da san Nicola a Santa
Claus: la vera storia di Babbo Natale. Come un severo vescovo proveniente
dall'attuale Turchia è diventato il gioviale dispensatore di doni natalizi che
cala dal Polo Nord,
scrive Brian Handwerk su "Nationalgeographic.it" il 24 dicembre
2015. Tutti i bambini lo sanno: Babbo Natale viene dal Polo Nord, è barbuto e
sovrappeso e la notte tra il 24 e il 25 dicembre porta i regali ai piccoli di
tutto il mondo viaggiando su una slitta trainata da renne. Ma la storia di
questo amato personaggio del folklore è lunga e affascinante quasi come la sua
leggenda. Babbo Natale nasce sulle rive del Mediterraneo, si evolve nell’Europa
del Nord e assume la sua forma definitiva (Santa Claus) nel Nuovo Mondo, da dove
poi si ridiffonde quasi in ogni parte del globo. In principio era san Nicola, un
greco nato intorno al 280 d.C. che divenne vescovo di Mira, cittadina romana del
sud dell’Asia Minore, l’attuale Turchia. Nicola si guadagnò la reputazione di
fiero difensore della fede cristiana in anni di persecuzioni e trascorse molti
anni in prigione finché, nel 313, Costantino emanò l’Editto di Milano che
autorizzava il culto. L’iconografia ha tramandato diverse sue immagini, ma
nessuna somiglia troppo all’omone allegro, sovrappeso e dalla barba bianca che
oggi attribuiamo a Babbo Natale. Catherine Wilkinson, un’antropologa forense
della University of Manchester, ha cercato di ricostruirne il vero aspetto
basandosi sui resti umani conservati nella cripta della Basilica di san Nicola
di Bari, dove le presunte reliquie del santo furono portate nel 1087 da un
gruppo di marinai e sacerdoti baresi che era andato fino a Myra per
impadronirsene. Quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, la cripta fu
restaurata, il cranio e le ossa del santo furono accuratamente misurate,
fotografate e radiografate. Wilkinson ha esaminato questi dati alla luce delle
moderne tecniche dell’antropologia forense, aiutandosi con un software di
ricostruzione facciale e aggiungendo dettagli dedotti dalle fattezze delle
popolazioni mediterranee dell’epoca. Il risultato – un uomo anziano, dalla pelle
olivastra, il naso rotto forse nel corso delle persecuzioni, e barba e capelli
grigi – è stato illustrato nel documentario della BBC The Real Face of Santa.
Dopo la morte (avvenuta il 6 di dicembre di un anno imprecisato alla metà del IV
secolo), la figura del santo divenne popolarissima in tutta la cristianità,
grazie anche ai tanti miracoli che gli furono attribuiti. Molte professioni (ad
esempio i marinai), città e intere nazioni lo adottarono e ancora lo venerano
come loro patrono. Ma perché diventò anche protettore dei bambini e mitico
dispensatore di doni? La ragione, spiega Gerry Bowler, storico e autore del
libro Santa Claus: A Biography, sta soprattutto in due leggende che si
diffusero in Europa intorno al 1200. La prima, e più nota, racconta del giovane
vescovo Nicola che salva tre ragazze dalla prostituzione facendo recapitare in
segreto tre sacchi d’oro al padre, che così può salvarsi dai debiti e fornire
una dote alle figlie. Nella seconda, Nicola entra in una locanda il cui
proprietario ha ucciso tre ragazzi, li ha fatti a pezzi e li ha messi sotto
sale, servendone la carne agli ignari avventori. Nicola non si limita a scoprire
il delitto, ma resuscita anche le vittime: “ecco uno dei motivi che lo resero
patrono dei bambini”, commenta Bowler. Resta da spiegare come questo santo
mediterraneo si sia spostato al Polo Nord e sia stato associato al Natale. In
realtà per molti secoli il culto di san Nicola – e la tradizione di fare regali
ai bambini - si continuò a celebrare il 6 dicembre, come avviene tuttora in
diverse zone dell’Italia del Nord e dell'arco alpino, fino in Germania. Col
tempo al santo vennero attribuite alcune caratteristiche tipiche di divinità
pagane preesistenti, come il romano Saturno o il nordico Odino, anch’essi spesso
rappresentati come vecchi dalla barba bianca in grado di volare. San Nicola era
anche incaricato di sorvegliare i bambini perché facessero i buoni e dicessero
le preghiere. Ma la Riforma protestante, a partire dal Cinquecento, abolì il
culto dei santi in gran parte dell’Europa del Nord. “Era un bel problema”,
commenta Bowler. “A chi far portare i doni ai bambini?”. In molti casi, risponde
lo studioso, il compito fu attribuito a Gesù Bambino, e la data spostata dal 6
dicembre a Natale. “Ma il piccolo Gesù non sembra in grado di portare troppi
regali, e soprattutto non può minacciare i bambini cattivi. Così gli fu spesso
affiancato un aiutante più forzuto, in grado anche di mettere paura”. Nacquero
così nel mondo germanico alcune figure a metà tra il folletto e il demone.
Alcune, come i Krampus, servono da aiutanti dello stesso san Nicola; in altre il
ricordo del santo sopravvive nel nome, come Ru-klaus (Nicola il Rozzo),
Aschenklas (Nicola di cenere) o Pelznickel (Nicola il Peloso). Erano loro a
garantire che i bambini facessero i buoni, minacciando punizioni come frustate o
rapimenti. Per quanto possa sembrare strano, anche da questi personaggi nasce la
figura dell’allegro vecchietto in slitta. Gli immigrati nordeuropei portarono
con sé queste leggende quando fondarono le prime colonie nel Nuovo Mondo. Quelli
olandesi, rimasti affezionati a san Nicola, diffusero il suo nome,
"Sinterklaas". Ma nell’America delle origini il Natale era molto diverso da come
lo consideriamo oggi. Nel puritano New England era del tutto snobbato, mentre
altrove era diventato una specie di festa pagana dedicata soprattutto al
massiccio consumo di alcol. “Era così anche in Inghilterra”, spiega Bowler. “E
non c’era nessun magico dispensatore di doni”. Poi, nei primi decenni
dell’Ottocento, diversi poeti e scrittori cominciarono a impegnarsi per
trasformare il Natale in una festa di famiglia, recuperando anche la leggenda di
san Nicola. Già in un libro del 1809, Washington Irving immaginò un Nicola che
passava sui tetti con il suo carro volante portando regali ai bambini buoni; poi
fu la volta di un libretto anonimo in versi, The Children’s Friend, con la prima
vera apparizione di Santa Claus, associato al Natale “ma privato di qualsiasi
caratteristica religiosa, e vestito nelle pellicce tipiche dei buffi portatori
di doni germanici”, spiega Bowler. Questo Santa porta doni ma infligge anche
punizioni ai bambini cattivi, e il suo carro è trainato da una sola renna. Le
renne diventano otto e il carro diventa una slitta nella poesia A Visit From
St. Nicholas, scritta nel 1822 da Clement Clark Moore per i suoi figli ma
diventata subito “virale”. Per molti decenni Santa Claus viene rappresentato con
varie fattezze e con vestiti di varie forme e colori. Solo verso la fine del
secolo, grazie soprattutto alle illustrazioni di Thomas Nast, grande disegnatore
e vignettista politico, si impone la versione “standard": un adulto corpulento,
vestito di rosso con i bordi di pelliccia bianca, che parte dal Polo Nord con la
sua slitta trainata da renne e sta attento a come si comportano i bambini. Una
volta standardizzata (grazie anche alle pubblicità della Coca-Cola, nota del
trad. it) la figura di Santa Claus torna in Europa in una sorta di
migrazione inversa, adottando nomi come Père Noel, Father Christmas o Babbo
Natale e sostituendo un po’ ovunque i vecchi portatori di doni. A diffonderla
sono anche i soldati americani sbarcati durante la Seconda mondiale, e l’allegro
grassone finisce per simboleggiare la generosità degli USA nella ricostruzione
dell’Europa occidentale. Naturalmente, c'è anche chi nel Babbo Natale di origine
yankee vede nient'altro che il simbolo della deriva consumista del Natale. Altri
lo rifiutano o lo snobbano semplicemente in nome della tradizione, come i non
pochi italiani ancora affezionati a santa Lucia, alla Befana o al vecchio,
originale san Nicola.
Greccio, il primo presepe
della storia è italiano.
Per la prima volta, San
Francesco d'Assisi rappresentò la natività di Gesù in una grotta vicino a
Greccio (Rieti), scrive Giuseppe De Lorenzo Venerdì 25/12/2015 su "Il Giornale".
Lo hanno relegato in un angolo. Lo hanno chiuso in un cassetto. Messo sotto
chiave negli armadietti scolastici. Hanno detto essere solo un simbolo
confessionale. Ma il presepe è anche un segno culturale. E’ parte integrante
della tradizione italiana. Tradizione che abbiamo esportato in tutto il mondo.
Il primo presepe della storia, infatti, è stato realizzato in Italia. Per capire
i perché della grotta, del bue e dell'asinello, siamo andati a Greccio, un
piccolo centro in provincia di Rieti (Lazio). Il luogo dove venne rappresentata
per la prima volta la nascita di Gesù. San Francesco d'Assisi arriva a Greccio
nel 1209. Come d'abitudine andò ad abitare in un luogo isolato, da eremita, sul
Monte Lacerone a qualche chilometro dal castello della città. Dopo alcuni anni
di predicazione, la popolazione del luogo comprese la santità di quell’uomo. Il
castellano di Greccio, Giovanni Velita, ne divenne amico sincero, tanto da
chiedergli di avvicinarsi alla città per permettere a tutti di andarlo ad
ascoltare. La leggenda vuole che per scegliere il luogo della nuova dimora, San
Francesco si affidò ad un bambino di quattro anni. Al quale venne fatto lanciare
un tizzone di fuoco, che cadde in una località piena di grotte. Quelle stesse
grotte al cui interno venne rappresentata la natività e che ora ricorrono in
tutti i presepi del mondo. Il desiderio di rievocare la nascita di Gesù viene a
Francesco durante un viaggio in Palestina. Quando nell’autunno del 1223 si reca
a Roma da papa Onorio III, chiede al Santo Padre di poterla realizzare. Ottenuto
il permesso, San Francesco torna in quella Greccio che gli “ricordava Betlemme”
e disse a Giovanni Velita: “Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una
grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un
asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di
Betlemme! Questo è il mio desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con
i miei occhi, la nascita del Divino infante”. E così, il 24 dicembre 1223, viene
messa in scena la nascita di Gesù bambino. C'erano la grotta, il bue e
l'asinello. Nessuno dei presenti prese il ruolo di Giuseppe e Maria, perché
Francesco non voleva si facesse "spettacolo" della nascita di Gesù. Solo
successivamente nei presepi del mondo sono stati aggiunti gli altri personaggi.
Il biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, scrisse che uno dei presenti
vide il bambinello di terracotta prendere vita. Da questi momenti trae origine
il tradizionale presepio, poi tramandato e esportato in tutto il mondo
cristiano. A Greccio, ogni anno, viene messo in scena il ricordo di questo
evento. Non un semplice presepe vivente, ma la rievocazione dei momenti che
hanno spinto San Francesco a realizzare la natività di Gesù. Le tradizioni
rimangono vive solo se le si coltivano. Chiudendole in un cassetto si finisce
per dimenticarle. Un simbolo che dal lontano 1223 viene esposto in tutti i
luoghi d’Italia e d’Europa non può essere abbandonato con la scusa di non
“offendere” le altre religioni. Oppure, ed è ancor più grave, in nome della
laicità dello Stato. Il presepe è un simbolo culturale. E come tale va difeso.
Il Presepe oggi. San
Francesco e la storia di una tradizione natalizia,
scrive “Frati Cappuccini”. Chi ha inventato il Presepe? Perché lo ha fatto? Che
c’entra San Francesco con la storia del presepe? Che significato ha? Perché una
tale tradizione resiste nel tempo? Per conoscere e approfondire la storia del
Presepe e la sua attualità anche nel mondo moderno dell’oggi, ZENIT ha
intervistato Padre Pietro Messa Preside della Scuola Superiore di Studi
Medievali e Francescani della Pontificia Università Antonianum.
Che c’entra San Francesco
con il presepio?
«Nel
1223, esattamente il 29 novembre, papa Onorio III con la bolla Solet annuere
approvò definitivamente la Regola dei frati Minori. Nelle settimane successive
Francesco d'Assisi si avviò verso l'eremo di Greccio dove espresse il suo
desiderio di celebrare in quel luogo il Natale. Ad uno del luogo disse che
voleva vedere con gli "occhi del corpo" come il bambino Gesù, nella sua scelta
di abbassamento, fu adagiato in una mangiatoia. Quindi stabilì che fossero
portati in un luogo stabilito un asino ed un bue - che secondo la tradizione dei
Vangeli apocrifi erano presso il Bambino - e sopra un altare portatile collocato
sulla mangiatoia fu celebrata l'Eucaristia. Per Francesco come gli apostoli
videro con gli occhi del corpo l'umanità di Gesù e credettero con gli occhi
dello spirito alla sua divinità, così ogni giorno mentre vediamo il pane ed il
vino consacrato sull'altare, crediamo alla presenza del Signore in mezzo a noi.
Nella notte di Natale a Greccio non c'erano né statue e neppure raffigurazioni,
ma unicamente una celebrazione eucaristica sopra una mangiatoia, tra il bue e
l'asinello. Solo più tardi tale avvenimento ispirò la rappresentazione della
Natività mediante immagini, ossia il presepio in senso moderno».
Perché lo ha fatto?
«Francesco
era un uomo molto concreto e per lui era molto importante l'Incarnazione, ossia
il fatto che il Signore fosse incontrabile mediante segni e gesti, prima di
tutto i Sacramenti. La celebrazione di Greccio si colloca proprio in questo
contesto».
Come si spiega la
popolarità e la diffusione dei presepi?
«Francesco
morì nel 1226 e nel 1228 fu canonizzato da papa Gregorio IX; fin da quel momento
la sua vicenda fu narrata evidenziandone la novità e, grazie anche all'opera dei
frati Minori, la devozione verso il Santo d'Assisi si diffuse sempre più e in
modo capillare. Di conseguenza anche l'avvenimento del Natale di Greccio fu
conosciuto da molte persone che desiderarono raffigurarlo e replicarlo,
iniziando a rappresentare e diffondere il presepio. In questo modo divenne
patrimonio della cultura e fede popolare».
Che significato ha e perché
la Chiesa invita i fedeli a rappresentare, costruire, tenere presepi in casa e
in luoghi pubblici?
«La
Chiesa ha sempre dato importanza ai segni, soprattutto liturgico sacramentali,
sorvegliando però che non sconfinassero in una sorta di superstizione. Alcuni
gesti furono incentivati perché ritenuti adatti per la diffusione dell'annuncio
evangelico e tra questi si segnala proprio il presepio nella cui semplicità
indirizza tutto alla centralità di Gesù».
Quale rapporto tra il
presepe e l’arte? Perché tanti artisti lo hanno dipinto, scolpito, raccontato,
….?
«Proprio
per la sua plasticità il presepio si presta a rappresentazioni in cui il
particolare può diventare segno della concretezza della quotidianità della vita.
E proprio tali particolari della vita umana - i vestiti dei pastori, le pecore
che brucano l'erba, il fanciullo attaccato alla gonna di mamma, eccetera - sono
stati rappresentati anche come ulteriori indizi del realismo cristiano che
scaturisce proprio dall'Incarnazione».
Cosa pensa della devozione
popolare nei confronti del presepe ancora molto diffusa tra la gente? Va
incoraggiata o limitata?
«Come
san Francesco ogni uomo e donna ha bisogno di segni; alcuni risultano ormai
incomprensibili mentre altri per la loro semplicità e immediatezza hanno ancora
un'efficacia. Tra questi possiamo porre il presepe e quindi ben venga la sua
diffusione».
Il Presepe. La storia,
scrive "Proloco Greccio".
Betlemme e Greccio sono due nomi inseparabili nei ricordi natalizi di ogni anno
poiché, se a Betlemme si operò il mistero della divina incarnazione del
Salvatore del Mondo, a Greccio, per la pietà di San Francesco di Assisi, ebbe
inizio, in forma del tutto nuova, la sua mistica rievocazione. La prima volta
che San Francesco venne a Greccio fu intorno al 1209. In quegli anni la
popolazione di Greccio era esposta a grave flagello: la zona infatti era
infestata da grossi lupi che divoravano anche le persone, ed ogni anno campi e
vigneti erano devastati dalla grandine. “E accadde, per disposizione divina e
grande ai meriti del padre Santo, che da quell'ora cessassero le calamità”. Egli
non abitò nel castello, ma si costruì una povera capanna tra due carpini sul
Monte Lacerone, detto appunto di San Francesco, monte alto 1204 mt., ove sorse
nel 1712 una cappellina Commemorativa. San Francesco da lì si recava, durante la
giornata, a predicare alle popolazioni della campagna. Gli abitanti di Greccio
presero ad amare Francesco e giunsero a tale punto di riconoscenza, per la sua
grande opera di rigenerazione, da implorarlo perché non abbandonasse i loro
luoghi e si trattenesse sempre con loro. Tra coloro che andavano a sentire la
parola del piccolo frate, c'era Giovanni Velita, il castellano di Greccio che
divenne un “innamorato” del Santo. Dal 1217, Giovanni divenne uno dei migliori
amici di Francesco e si prodigò per onorare nel miglior modo possibile quest'
uomo, che già aveva manifestato i segni della santità. E mentre Francesco
dimorava nella misera capanna ebbe le visite di Giovanni Velita, il quale, un
po' grosso di costituzione, un giorno gli chiese di scegliere una dimora più
vicina per confortare lui e il suo popolo con la sua parola. Francesco comprese
la sincerità di tale proposta e l'accettò volentieri dicendo che avrebbe rimesso
la scelta della nuova dimora, non alla sua volontà, ma ad un tizzo lanciato in
aria da un fanciullo. La leggenda o verità non accertata, racconta che trovato
un fanciullo di quattro anni lo si invitò a lanciare il tizzo in aria. Obbedì il
fanciullo: "et el focoso tizzone, si come un dardo dall'arco scoccato, volando
veloce se ne andò ad incendiare una selvaggia selva, sopra da un monticello, il
quale d'appartenenza era del Velita, et tutto questo fece, alla lunghezza de uno
bon miglio et più". Stupiti i Grecciani di tanto miracolo si recarono, con
Francesco e con Giovanni Velita, al luogo ove era caduto il tizzo. Questa
località ripida e scoscesa fu scelta come nuova dimora del Santo. Francesco
amava l'eremo di Greccio, e aveva una predilezione anche per gli abitanti di
quella terra, per la loro povertà e semplicità, perciò si recava spesso a
soggiornare lì, attirato inoltre da una celletta estremamente povera ed isolata
dove il Padre santo amava raccogliersi. A proposito degli uomini di Greccio
soleva dire tutto felice ai frati: " non esiste una grande città dove si sono
convertiti al Signore tante quante ne ha un paese così piccolo." Nell'autunno
del 1223 Francesco si trovava a Roma in attesa dell'approvazione della Regola
definitiva scritta per i suoi frati e presentata al Pontefice Onorio III°. Il 29
Novembre di detto anno ebbe la gioia di avere tra le mani la regola munita di
bolla pontificia. Siamo ormai alle porte dell'inverno e un pensiero assillante
dominava la mente di Francesco: l'avvicinarsi della ricorrenza della nascita del
Redentore. Il poverello di Cristo, nella sua innata semplicità si fece audace, e
durante l'udienza pontificia, concessagli per lo scopo suddetto, umilmente
chiese al Papa la licenza di poter rappresentare la natività. Infatti, dopo il
viaggio in Palestina, Francesco, rimasto molto impressionato da quella visita,
aveva conservato una speciale predilezione per il Natale e questo luogo di
Greccio, come dichiarò lui stesso, gli ricordava emotivamente Betlemme.
Tormentato dal vivo desiderio di dover celebrare quell’anno, nel miglior modo
possibile, la nascita del Redentore, giunto a Fonte Colombo, mandò subito a
chiamare Giovanni Velita, signore di Greccio, e così disse: "Voglio celebrare
teco la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia
ed ivi condurrai un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è
possibile la grotta di Betlemme! Questo è il mio desiderio, perché voglio
vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino infante." Il
cavaliere Velita aveva quindici giorni per preparare quanto Francesco desiderava
e tutto ordinò con la massima cura ed " il giorno della letizia si avvicinò e
giunse il tempo dell'esultanza!". Da più parti, Francesco aveva convocato i
frati e tutti gli abitanti di Greccio. Dai luoghi più vicini e lontani mossero
verso il bosco con torce e ceri luminosi. Giunse infine il Santo di Dio, vide
tutto preparato e ne gode.
Greccio fu così la nuova Betlemme! Con somma pietà e grande devozione
l'uomo di Dio se ne stava davanti al presepio, con gli occhi in lacrime e il
cuore inondato di gioia. Narra Tommaso da Celano: "fu talmente commosso nel
nominare Gesù Cristo, che le sue labbra tremavano, i suoi occhi piangevano e,
per non tradire troppo la sua commozione, ogni volta che doveva nominarlo, lo
chiamava il Fanciullo di Betlemme. Con la lingua si lambiva le labbra, gustando
anche col palato tutta la dolcezza di quella parola e a guisa di pecora che bela
dicendo Betlemme, riempiva la bocca con la voce o meglio con la dolcezza della
commozione". E narrasi ancora come vedesse realmente il bambino sulla
mangiatoia, scuotersi come da un sonno tanto dolce e venirgli ad accarezzare il
volto. Un cavaliere di grande virtù e degno di Fede, il signore " Giovanni da
Greccio" asserì di aver visto quella notte un bellissimo bambinello dormire in
quel presepio ed il Santo Padre Francesco stringerlo al petto con tutte e due le
braccia. La narrazione della visione di questo devoto cavaliere è resa credibile
non solo dalla santità di colui che la vide con i suoi occhi, ma è confermata
anche dai miracoli che ne seguirono: come quello della paglia di quel presepio,
che serviva per sanare in modo prodigioso le malattie degli animali ed ad
allontanare le pestilenze, per la misericordia del Signore. Così ebbe origine il
tradizionale Presepio che si costruisce in tutto il mondo Cristiano, per
ricordare la nascita del redentore.
Il Consumismo natalizio che
ci unisce, dove gli ignoranti vogliono dividerci,
scrive Barbara Di il 25 dicembre 2015 su "Il Giornale". Il Natale a Mauritius è
una splendida festa che tanti dovrebbero vivere prima di sproloquiare di
tolleranza accecati dall’ignoranza. Vedere cattolici, cinesi, indù, tamil,
protestanti, musulmani passeggiare allegramente e scambiarsi gli auguri in
un’atmosfera gioiosa forse gli farebbe capire come le persone siano molto più
intelligenti di loro, che vorrebbero insegnarci a vivere secondo precetti
forzati e innaturali. Tutti con qualcosa di rosso addosso, dai creoli con il
cappello di Babbo Natale, alle indiane con il sari sgargiante fino alle
musulmane con il chador scarlatto che ci prenderebbero per matti se sentissero
Boldrini, presidi, sindaci e compagnia ignorante vietarci di festeggiare o di
farci gli auguri per una presunta offesa nei loro confronti, semmai si
offenderebbero se non ricambiassimo i loro sorridenti Joyeux Noël. Questo
piccolo paradiso nell’Oceano Indiano ha tanto da insegnare al resto del mondo in
tema di tolleranza, che già è una parola sbagliata, peraltro, perché tollero ciò
che in fondo non sopporto. Qui hanno invece imparato la vera convivenza basata
sul rispetto reciproco di popoli tanto diversi quanto uniti dal desiderio di
stare tutti bene in una Nazione che amano. E una delle basi di questo rispetto
ritengo nasca proprio dal fatto che le feste religiose di ciascuno sono
considerate festività nazionali, dalla Pasqua al Cavadee, al Diwali, alla fine
del Ramadan, al Capodanno Cinese, fino appunto alla più amata, il Natale. Tutti
festeggiano, tutti rispettano le usanze altrui, nessuno si sognerebbe di
vietarle perché questa sì che sarebbe una mancanza di rispetto. E d’altro canto,
che il Natale sia diventato una festa così sentita in tutto il mondo lo deve ad
un motivo che è esattamente l’opposto di quanto professa questa specie di
Pa-pauperista: il consumismo. Perché il Natale è la festa dei bambini, della
frenesia dell’attesa di Santa Klaus, della gioia impareggiabile nei loro occhi
quando scartano i regali, di quel puro egoismo interiore psicologico che questa
stupida cultura socialista e politicamente corretta ci permette di esprimere
solo da piccoli, senza farci sentire sbagliati. Siamo esseri umani perché amiamo
il piacere di soddisfare i nostri desideri psicologici e ci distinguiamo dagli
animali, abbiamo creato la civiltà, ci siamo evoluti prorio perché non ci
accontentiamo di appagare solo i bisogni essenziali e materiali. Il Natale, coi
suoi cenoni carichi di prelibatezze per l’olfatto ed il palato, con i regali che
appagano tutti i nostri sensi, è proprio la gioia del donare e del ricevere, che
grazie all’empatia raddoppia il piacere. Quel piacere, quella ricerca della
felicità grazie ai meritati guadagni del proprio lavoro che non a caso è la
bestia nera di qualsiasi regime autoritario, statalista e integralista poco
cambia, perché trasforma i sudditi soggiogabili in cittadini ambiziosi che
lottano, lavorano, producono per essere liberi di soddisfare tutti i propri
desideri senza che nessun governante o sacerdote possa imporglieli o
reprimerglieli. Ecco perché il modo migliore per combattere qualsiasi
fondamentalismo religioso non passa dalla tolleranza vigliacca, ma dal saper
mostrare al mondo quanto sappiamo trarre piacere da tutto ciò che ci circonda e
che ci possiamo permettere grazie al nostro lavoro, dal più effimero al più
lussuoso dei desideri. In fondo, quindi, se il Natale – non importa perché o
grazie a chi, se al Santa Klaus della Coca-Cola o a San Nicola – ormai è tanto
amato da tutti, atei o credenti di ogni religione, è perché non è altro che la
Festa della Libertà. Per questo auguro a tutti un Felice Natale, che vi porti
tutti i piaceri che desiderate.
Ecco perché è sbagliato
cancellare il Natale (anche per gli islamici).
Ripensare al
2015 significa ripensare a un anno in cui il dilagare di una guerra, militare e
ideologica, ha interessato ognuno di noi, scrive Luca Steinmann Venerdì
25/12/2015 su "Il Giornale". Natale, un attimo di pace. Natale, periodo di
riconciliazione. Oggi come ieri, per i fedeli come per i non credenti, questo
momento dell’anno va ad assumere un significato trasversale, che evade la
dimensione meramente religiosa: ogni Natale le famiglie si riuniscono, le
persone si ritrovano in un momento staccato e lontano dalla frenesia quotidiana
e dai problemi che hanno accompagnato i mesi precedenti. Per molti è
un’occasione di riflessione e di confronto con l’anno che si sta per chiudere,
con le scelte che in questo arco di tempo sono state prese o subite e con le
conseguenze che esse hanno avuto sulle proprie persone e sulle proprie storie.
Ripensare al 2015 significa ripensare a un anno in cui il dilagare di una
guerra, militare e ideologica, ha interessato ognuno di noi. Perché nessuno che
viva nella società occidentale può essere immune dal cambiamento che questa sta
subendo a seguito dell’inasprimento di uno scontro che ha visto nelle due stragi
di Parigi, quella di Charlie Hebdo e del Bataclan, i suoi momenti più
emblematici. Uno scontro sanguinoso dichiarato da esponenti di due diversi mondi
che, in nome di due religioni considerate contrapposte, si sono posti come
portavoce della totalità dei propri fedeli e hanno dichiarato di voler esportare
il proprio modello di società e di vita dove esso non è ancora presente. Così,
se da una parte l’Occidente ‘cristiano’ già da tempo bombarda i territori
musulmani in nome del progresso, dall’altra i terroristi dell’Isis hanno portato
la propria guerra in terra europea in nome di Allah. Da una parte come
dall’altra è stato invocato lo stesso messaggio: che si tratta di una guerra tra
religioni, di uno scontro di civiltà tra Islam e Cristianesimo, di una battaglia
tra bene e male. E questo Natale, in quanto festa cristiana, è stato da alcuni
considerato come un momento per inasprire questo scontro. Generando, da una
parte come dall’altra, sentimenti di rabbia, di emozione, di sfiducia, di
diffidenza, di paura per il futuro. Siamo nel pieno di un disordine che non
sembra volersi arrestare. E le guerre che l’Europa in passato ha già vissuto non
si sono mai concluse fino alla vittoria totale di una parte sull’altra.
Interrompendosi però solo in un’occasione: proprio durante il Natale. Nel 1914,
per esempio, i soldati tedeschi e inglesi che si combattevano sul fronte
occidentale durante la Grande Guerra dichiararono un inufficiale cessate il
fuoco, celebrando comuni cerimonie religiose e di sepoltura dei caduti. Solo lo
scorso anno, invece, l’esercito ucraino intento a combattere nella città
Donetsk, si è accordato con i ribelli filo-russi per una breve tregua natalizia.
E’ possibile, dunque, che anche il Natale del 2015 diventi un momento di tregua
anche dello scontro di civiltà? Secondo Niyazi Oktem, professore dell’Università
di Istanbul, non solo è possibile, ma strettamente necessario. Senza mai
dimenticare che la diversità di religione è una delle cause principali dei
conflitti internazionali, spiega, va fatto sapere che l’Islam riconosce come
sacro il Natale e i suoi protagonisti. Esso, infatti, concepisce sia l’Antico
sia il Nuovo Testamento come testi sacri, oltre che tutti i profeti in essi
menzionati. Soprattutto la Vergine Maria e suo figlio godano di una
considerazione del tutto speciale: menzionati in 100 versetti del Corano,
vengono indicati come modelli di retta condotta e di verità. Per questo le
celebrazioni cristiane del Natale sono un momento di pace anche per i musulmani.
E per questo lo sfruttamento del Natale come occasione per attaccare i musulmani
da parte occidentale - e vice versa - è un insulto a entrambe le fedi. Abolire
la celebrazione del Natale, dunque, significa cancellare il più importante punto
d'incontro tra le due religioni. Ridurre o limitare le festività natalizie
significa ridurre anche ciò che gli islamici considerano come sacro nel
Cristianesimo. Trasformare questo Natale in uno strumento di battaglia per
attaccare un’altra fede farebbe altrettanto male. Da una parte come dall’altra.
Così hanno ucciso il
Natale: ecco le tradizioni cancellate.
Dalle scuole alla famiglia, ormai il Natale ha perso il suo vero significato. Un
modo per estirpare le radici della nostra cultura, scrive Giuseppe De Lorenzo
Venerdì 25/12/2015 su "Il Giornale". “La tradizione - diceva Ezra Pound - è una
bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci”. Un filo rosso che
lega la comunità, che unisce le persone intorno ad un sistema di valori.
Affermare che il cristianesimo non ha permeato la vita dell’Occidente è
(lecitamente) sciocco, eppure quel filo rosso è stato tranciato. Di netto. Con
un obiettivo preciso: estirpare le radici cristiane dell’Europa e sostituirle
con multiculturalismo, globalismo, buonismo. Tra tutti i simboli della
cristianità, il Natale è forse il più rappresentativo. Senza rendercene conto,
abbiamo abbandonato (o ci hanno fatto abbandonare) parole, canti, emblemi e
gesti dal significato cristiano. Tanto che a stento le giovani generazioni ne
conservano i ricordi. Proviamo a ripercorrere le tradizioni dimenticate. E gli
attacchi che gli sono stati rivolti. L’enciclopedia Treccani la definisce
come la “festa della Natività di Gesù Cristo”. Sembra scontato, ma non lo è. Per
fare un esempio, il preside della scuola "Iqbal Masih" di Trieste ha
affermato che “il Natale non è solo una festa cristiana”. Non solo. Nella sua
ultima pubblicità, la nota casa di moda svedese "H&M" ha sostituito “Merry
Christmas” con “buone vacanze”. Escludendo così ogni riferimento alla natività
del bambinello. Non c’è probabilmente persona nata nel secolo scorso che non
abbia seguito nella sua giovinezza un calendario d’Avvento. Circa 24 caselle da
aprire una volta al giorno, dall’inizio del "tempo dell’attesa” fino al giorno
di Natale. La tradizione sorge nel Nord Europa e ad inventarlo nei primi anni
del 1900 sarebbe stato Gerhard Lang, proprietario di una stamperia di Monaco. La
sua stampa con 24 caselle non fece altro che istituzionalizzare una pratica
diffusa tra le donne del luogo per rendere più piacevole ai bambini l’attesa
della nascita di Gesù. Spesso al dolcetto veniva allegata anche una frase della
Bibbia. Ebbene: sono poche, ormai, le famiglie che ne posseggono uno. Se poi lo
si cerca al supermercato, è (quasi) impossibile trovarne la versione
“cristiana”. Il più di moda di quest’anno raffigura “Masha e l’Orso”. Che per
quanto sia un cartone apprezzabile, non ha niente a che fare col Natale. E’
forse ridondante parlare del presepe. L’idea di posizionare in una grotta Gesù,
il bue e l’asinello venne a San Francesco d’Assisi nel 1223. Che lo realizzò per
la prima volta a Greccio (Rieti). Prima lo hanno bandito dai luoghi pubblici,
poi dalle scuole e infine lo hanno realizzato in formato gay (due Giuseppe e in
dono i preservativi). Ha creato scalpore il caso dell’asilo di Pietrasanta
(Lucca) che ha deciso di escludere la rappresentazione della natività dalle
aule. Ma non è un caso isolato. Nella stessa scuola è stata fatta un’eccezione
per l’albero di Natale, ammesso tra i banchi. Tra tutti il simboli, infatti,
l’abete addobbato è il meno cristiano. Per questo resiste più degli altri. Per
risalire alle sue origini bisogna guardare ai germani, che ornavano gli alberi
cosmici con i simboli del sole e della luna in onore degli dei. Simbologia poi
riletta alla luce della dottrina cristiana. Oggi, invece, le Poste Italiane lo
cancellano dall’arredo natalizio asserendo a motivazioni di uniformità
aziendale. “Tu scendi dalle stelle” è ormai un canto reazionario. Composto nel
dicembre 1754 a Nola dal napoletano sant'Alfonso Maria de' Liguori, è un cult
delle feste natalizie. Ma quei riferimenti al Re del Cielo, alla grotta e alle
preghiere sono troppo espliciti. Così il preside della scuola di Rozzano ha
deciso di annullare il tradizionale concerto di Natale, trasformandolo in una
più laica Festa d’Inverno. Perché “un concerto a base di canti religiosi”
sarebbe stata “una provocazione pericolosa” dopo gli attentati di Parigi del 13
novembre. Via anche “Adeste fideles”: troppo bigotto. Nel tempo abbiamo detto
addio alla corona d’avvento e alle quattro candele delle domeniche che precedono
il Natale. L’unico a difendersi egregiamente è San Nicola di Myra (o di Bari).
E’ lui il genitore di Babbo Natale. Vescovo del IV secolo, è un santo venerato
sia dai cattolici che dagli ortodossi: viene rappresentato dalla tradizione con
la barba lunga e la mitra in testa. Per i popoli dei Paesi Bassi era lui a
portare i doni. Ora gli è rimasto solo il cappello rosso e una discreta pancia.
Risulta difficile stupirsi allora se all'istituto "Carlo Pisacane" di Roma
sostituiscono il Natale con la festa antirazzismo. Stanno estirpando le nostre
radici, per ripiantarne delle altre. E i preti che fanno? Annullano la Messa
natalizia nell’istituto cattolico di Monza perché è un “atto di fede troppo
forte” per i non credenti. Anche questo, a suo modo, è segno dei tempi che
passano. Portare gli studenti a Messa era del tutto normale, finché qualcuno non
s’è ribellato. E allora prontamente abbiamo messo la testa nella sabbia, per non
infastidire nessuno. Per paura d’essere reazionari.
Più crimini contro la
religione che contro omosex e trans: ma il governo dimentica di tutelare i
cattolici.
L'Osce che i crimini antireligiosi sono cinque volte superiori a quelli contro
gli Lgbt nel 2014. Ma nello stesso anno l'Unar non cita nemmeno le
discriminazioni anticattoliche, scrive Giovanni Masini Venerdì 25/12/2015 su "Il
Giornale". L'Italia non è un Paese per gay. Quante volte ce lo siamo sentiti
ripetere? Il nostro Paese è arretrato, arretratissimo, medievale (come se poi
fosse un insulto). Una macchia nera nell'oceano di luce dell'Europa civile. Non
solo isolati quanto a legislazione, ma pure in balìa di una vera e propria
ondata di omo e transfobia - contro cui ogni anno protestano migliaia di persone
scendendo puntualmente in strada con la bandiera arcobaleno in mano. Eppure,
numeri alla mano, scopriamo che l'emergenza omofobia sembra esistere più negli
slogan delle manifestazioni che nella realtà. Spulciando il rapporto dell'Osce
sui cosiddetti "hate crimes" del 2014, balza subito all'occhio come, su 48 Stati
in gran parte europei, l'Italia registri, nel corso dell'anno passato, "appena"
27 crimini d'odio contro persone Lgbt su quasi seicento casi totali. Il numero
di reati motivati dall'odio religioso, invece, è di oltre cinque volte
superiore: 153. Sebbene si tratti, naturalmente, di un conteggio incompleto
perché mancante di tutti i casi non denunciati, fa riflettere notare come
proprio in Italia - troppo spesso dipinta come la culla del settarismo religioso
fanatico ed omofobo - i crimini legati all'orientamento sessuale siano di gran
lunga meno numerosi di quelli causati dall'odio religioso, razziale o
xenofobico. E a certificarlo sono dati raccolti da un'organizzazione
sovranazionale come l'Osce. Ma non è tutto: c'è una domanda che sorge spontanea:
come mai le strutture statali deputate alla lotta contro le discriminazioni - il
famoso Unar, l'ufficio Anti Discriminazioni razziali, che già dal nome non
dovrebbe occuparsi che di "razze" - profondono sforzi ed energie in
mastodontiche campagne per la lotta a quei crimini contro gli Lgbt che, nei
dati, sono meno frequenti di tanti altri? Nella relazione presentata a Palazzo
Chigi per l'anno 2014, l'Unar dedica ampio spazio alla strategia nazionale per
combattere le discriminazioni contro gli Lgbt, peraltro già nota per
alcuni controversi casi di cronaca relativi all'insegnamento nelle scuole
pubbliche. Nei paragrafi dedicati all'odio per motivi religiosi si citano quasi
di sfuggita solo le "minoranze religiose": buddhisti, musulmani, anglicani...
Sulle discriminazioni verso i cattolici, i cui diritti pure vengono attaccati, a
volte anche
quando si trovano in maggioranza, nemmeno una parola. Una mancanza vistosa,
sottolineata con amarezza, tra gli altri, anche da Mattia Ferrero, delegato per
le attività internazionali dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, che,
parlando conProVita ha notato come "gli hate crimes contro le
maggioranze, ad esempio fondati sull'odio verso la religione cristiana, vengono
sottovalutati. Eppure i crimini motivati dall'odio contro i cristiani,
principalmente gli atti di violenza contro luoghi di culto, rappresentano un
numero molto significativo, comparabile, e qualche volta superiore, a quelli
fondati sull'odio verso altre religioni".
Le feste della "Famiglia":
cocaina, fucili e proiettili per il Natale dei Boss. Organizzano summit, bevono
champagne, celebrano riti di affiliazione. E sparano tantissimo, soprattutto la
notte di Capodanno. Così padrini e picciotti trascorrono le festività,
scrive Giovanni
Tizian il 24 dicembre 2015 su “L’Espresso”. Festeggiamenti in corso nelle case
dei boss. Per loro le feste natalizie sono fitte fitte di impegni. Dalla Sicilia
alla Lombardia, passando da Calabria, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, padrini
e picciotti si danno da fare. Organizzano summit e “mangiate” a base di carne
arrostita, affiliano e conferiscono cariche, stappano costosissime bottiglie di
champagne Kristal e altre di genuino vino di casa. Poi ci sono gli affari, che
non conoscono ferie. Girano tra i commercianti chiedendogli di “mettersi a
posto” con la tangente, potenziano la rete di smercio della cocaina, che durante
le feste, a detta degli stessi mafiosi intercettati, aumentata in maniera
esponenziale. E come ormai è tradizione festeggiano armi in pugno l'arrivo del
nuovo anno. Sparando dai balconi e dai giardini delle loro ville con pistole,
fucili e mitragliatrici. I capi supremi della mafia calabrese, è noto e ormai
accertato nei processi, si riuniscono tra fine agosto e i primi giorni di
settembre a Polsi, nei giorni della festa della madonna, all'ombra del
santuario. Hanno fatto il giro del mondo le riprese effettuate dal Ros dei
carabinieri in cui i boss riuniti conferivano cariche e discutevano del futuro
dell'organizzazione in quel luogo sacro. Ma c'è anche un'altra occasione di
festa e riunione per lo stato maggiore delle 'ndrine. A dicembre, in occasione
delle feste natalizie. È un particolare rivelato dal capo cosca di Siderno,
paesone della Locride. Al figlio che gli chiede se i summit ufficiali del
circolo ufficiali della 'ndrangheta siano due o tre, il leader della famiglia
risponde secco: «Pari», ovvero due. Durante la festa religiosa e nei giorni a
ridosso di Natale. Un periodo buono anche per le promozioni dei giovani
'ndranghetisti. Le cariche e i gradi della gerarchia vengono spesso conferiti
tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Anche le affiliazioni ricorrono spesso in
questi giorni trascorsi tutti in famiglia. Il rito con cui si arruolano nuovi
soldati, con la ormai celebre cerimonia durante la quale viene bruciato il
santino di San Michele Arcangelo, è un momento di festa che si somma all'euforia
di quei giorni. «Quando avrai quell'altra cosa Giovanni», così risponde al
figlio un papà premuroso che lo invita ad avere pazienza: la pistola a
disposizione del clan non può ancora averla perché prima deve essere investito
di una carica più importante. Un evento previsto per le venture festività
natalizie: «Magari per Natale ti diamo l'una e l'altra». Il ragazzo non è
soddisfatto del discorsetto paterno: «Minchia io voglio la mia, però, pà». Che
feste sarebbero senza tutti, ma proprio tutti, i parenti seduti attorno al
tavolo imbandito di specialità locali? Per questo non è un vero Natale o un
perfetto Capodanno, se all'appello manca l'uomo di casa. Così i latitanti
siciliani si fanno in quattro pur di presenziare ai festeggiamenti. Incoscienza?
Certamente, ma anche una dimostrazione di forza. Perché i mafiosi che fuggono
dalla polizia sanno benissimo di avere mille occhi puntati addosso e una minima
distrazione può loro costare cara. Ma in Sicilia i boss ci tengono troppo alle
riunioni di famiglia durante le feste. Gli investigatori lo sanno altrettanto
bene, e per tutto il mese di dicembre stanno molto attenti a tutto ciò che si
muove intorno alle abitazioni dei familiari del fuggitivo. D'altronde molti
latitanti sono caduti proprio su questioni di cuore o di gola. Impossibile
resistere alla pasta al forno fatta da mammà. Per esempio, ai detective che
seguivano un calabrese fuggito in Olanda, è bastato seguire la teglia al ragù
per rintracciarlo nel suo covo ad Amsterdam. In Campania invece la regola fissa
del Natale è chiedere la mazzetta ai commercianti. Una tradizione che si ripete
a Pasqua e ferragosto. I boss non riescono proprio a farne a meno. E invece che
divertirsi e andare in ferie per qualche giorno, molestano e intimidiscono
commercianti e imprenditori. Chiedono somme di denaro o regali, facendo
riferimento all'esistenza di comuni amici, e molto spesso camuffando quella
richiesta con la solidarietà per chi sta in carcere. La formula classica
utilizzata dai baby camorristi, dipendenti a tempo dei camorristi adulti, è «Vi
dovete mettere a posto». Con tanti saluti e sinceri auguri dal clan del rione.
«A Natale e Capodanno il lavoro si fa più sostanzioso a livello di stupefacenti,
perché sotto il periodo delle feste c’è un consumo maggiore...a Natale poi ci
sono le feste e quindi uno aveva bisogno di un po’ di liquidità». Il pentito
racconta ai magistrati della procura di Roma degli affari con la cocaina. La
'ndrangheta gestisce la gran parte della sostanza che arriva nella Capitale.
Durante le feste natalizie i consumi aumentano, quindi anche l'offerta. Lavorano
senza sosta i broker della 'ndrangheta. Lavorano senza sosta pure i narcos dei
clan. Un impegno che ha un fine preciso: ci sono i regali da fare alle mogli,
sempre più esigenti, ai figli, che già a 12 anni chiedono lo scooterone, i
parenti che vogliono gioielli costosissimi. Tutti, insomma, si aspettano un
cadeau importante da l'uomo che, in fondo, gestisce milioni di euro al mese. Una
responsabilità da cui nessun manager della polvere bianca si può sottrarre.
D'altronde è lo stesso pentito che spiega come nelle feste si davano più da fare
perché durante feste c'è bisogno di un po' di più di «liquidità». Ma quale bomba
di Maradona. Ma quali raudi e razzi. Queste bombette è roba per principianti.
Gli uomini d'onore per salutare l'arrivo del nuovo anno imbracciano fucili,
mitragliatrici e pistole. Sono fatti così, è gente semplice, che ama divertirsi
con le cose che ha in casa. In effetti, armi e munizioni non ne mancano di certo
in quelle abitazioni. Quando arriva la mezzanotte, perciò, in molti paesi, anche
del centro nord, si possono percepire senza troppa fatica raffiche e colpi
secchi. Insomma, si trasformano in teatri di guerra. Esagerazioni? Non proprio.
Le intercettazioni lo confermano. Molti di questi tiratori scelti, infatti, dopo
aver bevuto per tutta la sera chiamano amici e parenti per fare gli auguri. In
queste telefonate si lasciano andare. Come se quella notte fosse
intercettazione-free. E così agli inquirenti è capitato di sentire dialoghi di
questo tenore: «Acchiappo quella giusta ... a capodanno, a capodanno acchiappo
quella .. . trrrrrrrr ... trrrrrrrr...quella è bella ... bastarda quella non
s'inceppa», si esaltata un giovanotto di un clan della piana di Gioia Tauro
residente provincia di Como. Anche nella provincia emiliana gli uomini della
'ndrangheta non sono avari di proiettili. Dall'indagine Aemilia emergono i
particolari di un normale veglione di follia. Era il capodanno 2013, a
Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, e nell'abitazione di un imprenditore della
'ndrangheta emiliana era in corso la festa. Pochi minuti dopo la mezzanotte
parte il tradizionale giro di telefonate per gli auguri. In sottofondo gli
investigatori ascoltano in diretta spari con pistole e fucili. «Aspetta, aspetta
un secondo, senti senti...questo è per te fai conto che sono con te», si sentono
alcuni colpi di pistola e successivamente il rumore del caricamento dell'arma.
«Hai sentito?», domanda l'uomo. E il suocero che si trova in Calabria risponde:
«Che sono questi giocattoli, che non li senti che sono bombardini?», fa lo
spaccone. «Te lo faccio vedere di persona il giocattolo che è», ribatte,
ridendo, il marito della figlia. Poi il telefono passa proprio alla donna, che
saluta il padre: «Papà Tonino mi ha fatto sparare due colpi con il fucile, me lo
ha dato tra le mani e mi ha fatto sparare con il fucile» dice entusiasta la
figlia poco più che trentenne. Nel frattempo si sente Tonino dire: «l'ultima
caricata». E subito dopo la ragazza che al padre rivolge un pensiero dolce:
«Dice che la caricata l'ha dedicata a te». Il papà per nulla preoccupato della
situazione risponde con un «altrettanto», lasciando intendere che anche dove si
trova lui, a Cutro, in provincia di Crotone, hanno abbondantemente sparato
quella notte di festa. «Amo con che fucile mi ha fatto sparare a capodanno?»
chiede, infine la ragazza. «Con un Benelli M3», naturalmente. Anche a Napoli si
spara per la felicità. I baby boss di Forcella, poi, sono i più fanatici delle
armi. «Tre caricatori a Capodanno abbiamo sparato, non si ha inceppato una
botta», urla al telefono uno di loro. Ma non sempre questi giochi di fuoco di
fine anno finiscono bene. Proprio a Forcella, in casa dei nuovi Giuliano (il
clan emergente e molto violento che sta terrorizzando la città) era tutto pronto
per il veglione del capodanno 2014. Verso le sette di sera un giovanotto della
famiglia decide di provare la pistola 7,75 in uno dei vicoli vicino
all'abitazione. Qualche istante dopo aver sentito questi dialoghi, al 118 arriva
una richiesta di soccorso per un ferito da arma da fuoco. La prova era finita
malissimo, un cittadino del Bangladesh era stato colpito. Per poco non è stato
ucciso. Come se nulla fosse il ragazzo di casa Giuliano torna a casa. Il
veglione, gli amici, l'insalata di rinforzo, lo champagne, lo attendono. Una
notte di festa, che i mafiosi trasformano in delirio criminale.
IL TERRORISMO ISLAMICO CHE
VIENE DA LONTANO. QUANDO NEW YORK E PARIGI ERAVAMO NOI.
27 DICEMBRE 2015.
Gli attacchi agli aeroporti di Roma e Vienna, 30 anni fa. Breve storia di uno
degli ultimi grandi attacchi terroristici compiuti da organizzazioni palestinesi
in Europa, il 27 dicembre 1985, scrive “Il Post”. Alle 8 e 15 del 27 dicembre
1985, due commando palestinesi formati da sette terroristi attaccarono gli
aeroporti di Roma e Vienna con armi automatiche e granate, in quello che diventò
uno degli ultimi attacchi compiuti dal terrorismo internazionale in Italia e un
punto di svolta nel conflitto israelo-palestinese. I due commando riuscirono a
uccidere 19 persone e a ferirne più di 130 prima di essere uccisi o catturati a
loro volta. I terroristi cominciarono ad agire a Roma, alle otto e un quarto in
punto, quando quattro uomini armati entrarono nella grande sala dell’aeroporto
dove centinaia di persone erano in fila per il check-in della compagnia aerea
israeliana El Al e dell’americana TWA. I quattro uomini spararono sulla folla
con armi automatiche e lanciarono alcune granate. Le guardie di sicurezza
israeliane, alcune in borghese e mischiate tra i passeggeri, risposero al fuoco.
La compagnia aerea israeliana era oggetto di attacchi da anni e oramai in tutti
gli aeroporti del mondo si era dotata di guardie di sicurezza, spesso
ex-militari o poliziotti. La sparatoria durò un minuto. Tre palestinesi furono
uccisi dalle guardie armate, mentre il quarto fu ferito e catturato dalla
polizia italiana. Mentre la sparatoria terminava a Fiumicino, altri tre uomini
iniziarono a sparare contro le persone in coda davanti agli uffici di El Al
nell’aeroporto di Vienna. Tre persone furono uccise da una granata e altre 39
rimasero ferite. I tre assalitori fuggirono in macchina, ma furono inseguiti e
fermata dalla polizia austriaca. Uno di loro rimase ucciso nello scontro a
fuoco, mentre altri due furono catturati. Durante il processo, i terroristi
catturati dissero di appartenere ad Abu Nidal, un’organizzazione palestinese che
nel 1974 si era separato da Fatah, il gruppo guidato da Yasser Arafat e la
principale delle molte fazioni che lottavano per la liberazione della Palestina.
Abu Nidal era uno dei gruppi più cruenti e, nel corso degli anni Ottanta e dei
primi anni Novanta, uccise più di 900 persone in una serie di attentanti ed
assassinii mirati, spesso nei confronti di altri palestinesi. Il doppio attacco
di Fiumicino e Vienna fu il più ambizioso degli attentati che l’organizzazione
provò a compiere in Europa e rappresentò un punto di svolta nella lotta per la
liberazione della Palestina. L’opinione pubblica europea, che fino ad allora
aveva adottato un atteggiamento cauto nei confronti del terrorismo palestinese,
reagì con durezza agli attacchi. Pochi mesi prima, nel novembre del 1985, Arafat
aveva dichiarato in un famoso discorso al Cairo che gli attacchi terroristici
contro obiettivi israeliani all’estero servivano solo a danneggiare la causa
palestinese. La reazione dell’opinione pubblica dopo gli attacchi sembrò in
parte confermare le sue parole e negli anni successivi il terrorismo palestinese
in Europa praticamente sparì. Le indagini successive e le confessioni dei
terroristi catturati indicarono che il regime siriano, guidato da Hafez al
Assad, padre dell’attuale dittatore Bashar, aveva fornito aiuto logistico e
ospitalità agli organizzatori dell’attentato. Gli Stati Uniti all’epoca
accusarono anche il regime libico di Muammar Gheddafi. I servizi segreti
tunisini dimostrarono che la Libia aveva fornito passaporti falsi ad alcuni dei
terroristi, ma giudici e investigatori europei rimasero convinti che l’appoggio
maggiore all’attacco fu fornito dai siriani. L’organizzazione Abu Nidal esiste
ancora oggi, ma la sua forza politica e militare è andata scomparendo.
Assalto a Fiumicino. Il
terrore 30 anni prima di Parigi,
scrive Luca Laviola
su “L’Ansa”, “America Oggi”, ecc. il 21-12-2015.
Doveva finire come l'11 Settembre a New York - ma 16 anni prima -, con un aereo
a schiantarsi su Tel Aviv. Invece fu la seconda strage dell'aeroporto di
Fiumicino, con modalità che ricordano quella di Parigi a novembre. Era il 27
dicembre 1985 - 30 anni fa -: un gruppo di terroristi palestinesi assaltò con
bombe a mano e kalashnikov i banchi della compagnia israeliana El Al e della
statunitense Twa, sparando sulla gente in fila o al bar. Nello scontro a fuoco
con i poliziotti e la sicurezza israeliana morirono 16 persone: 12 passeggeri, 3
terroristi e un addetto israeliano; 80 i feriti. Secondo alcune fonti, avallate
dal giudice Rosario Priore che indagò, il commando doveva prendere un aereo e
farlo precipitare su Israele. Come avrebbero poi fatto nel 2001 i kamikaze di
Osama Bin Laden in America. Ma i terroristi furono scoperti e scatenarono
l'apocalisse in aeroporto. "Sapevamo che nessuno di noi sarebbe uscito vivo", ha
detto anni fa Ibrahim Khaled, l'unico dei quattro a essere catturato. Condannato
a 30 anni, ha collaborato, chiesto perdono e di recente è tornato libero. Il
massacro dell' '85 arrivò 12 anni dopo quello del 17 dicembre 1973, sempre a
Fiumicino e da parte di arabi armati, con 34 vittime e modalità ancora più
cruente: due bombe incendiarie gettate dentro un aereo pieno fermo sulla pista.
A seguito di quella strage Aldo Moro avrebbe stretto un accordo con i gruppi
palestinesi, che si impegnavano a non compiere azioni in Italia a patto di poter
transitare per il Paese con armi ed esplosivi. Ma l'intesa segreta voluta dal
ministro degli Esteri democristiano sarebbe emersa solo molti anni dopo. Il
mandante dell'attentato dell' '85 era Abu Nidal, capo di una fazione palestinese
contraria alla linea più moderata a cui si era deciso il leader
dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Yasser Arafat.
Condannato all'ergastolo in contumacia, Abu Nidal è stato ucciso nel 2002 a
Bagdad. Il commando arrivò a Roma un mese prima, in un periodo in cui stava
saltando il cosiddetto Lodo Moro (lo statista Dc era stato ucciso nel '78), che
aveva risparmiato per 12 anni attentati palestinesi all'Italia. In poche
settimane, un colpo di bazooka sull'ambasciata Usa, una bomba al Cafè de Paris
in via Veneto, un'altra alla compagnia British Airways. Ad ottobre il
dirottamento della nave Achille Lauro e l'uccisione di un passeggero americano
sulla sedia a rotelle, Leon Klinghoffer. E si arriva al 27 dicembre 1985. Sono
le 9.05 quando i quattro, che si trovano vicini ai check-in El Al e Twa, vengono
individuati dalla security israeliana - probabilmente corpi speciali - e scoppia
la sparatoria. Un minuto di terrore, i palestinesi mirano ai passeggeri in fila.
Tra le vittime italiani, statunitensi, messicani, greci e un algerino. Tre
terroristi vengono uccisi. Khaled, 18/enne, viene catturato. In simultanea a
Vienna un altro gruppo attacca l'aeroporto, uccide 3 persone, decine i feriti.
Due fedayn vengono presi, uno muore. L'ammiraglio Fulvio Martini, nell' '85 capo
del Sismi (intelligence militare), ha scritto che dal 10 dicembre si sapeva di
un possibile attentato in Italia. Il 19 i servizi informarono che sarebbe
avvenuto tra il 25 e il 31 dicembre a Fiumicino. Gli israeliani, scrive Martini,
misero tiratori scelti a difesa della postazione El Al. Furono loro i primi a
reagire. Le forze dell'ordine italiane erano impreparate. Nel 1992 i capi della
sicurezza di Fiumicino sono stati assolti. Il 17 dicembre '73 era andata perfino
peggio: un gruppo di terroristi arabi arrivato dalla Spagna in aereo con le armi
nei bagagli a mano gettò bombe al fosforo dentro un Boeing Pan Am sulla pista,
uccidendo 30 persone. Quindi dirottò un aereo su Atene, altri morti prima di
arrendersi in Kuwait. Un massacro quasi dimenticato. Stragi di civili, come
quelle dell'Isis oggi.
Strage di
Fiumicino, parla il fotografo che visse quei momenti in diretta.
Vergati: "Ero lì, la gente stava al bar e un attimo dopo era morta", scrive
Luca Laviola su
“L’Ansa” il 20
dicembre 2015.Il 13
novembre ha ripensato a quella strage avvenuta, trent'anni fa, a poche decine di
metri da lui. "E' una cosa incredibile, a Parigi quelle persone stavano sedute
al bar e un attimo dopo una sventagliata di mitra le ha uccise. Come il 27
dicembre dell'85 a Fiumicino". Elio Vergati aveva 46 anni e faceva il fotografo.
Lo fa ancora oggi che ne ha 76 e vanta un secondo posto al premio Pulitzer e al
World Press Photo. Sempre nella mitica agenzia Telenews che da decenni racconta
quello che accade negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. "Ero nel
nostro ufficio e sentimmo dei botti - racconta -. Si capì subito che erano bombe
a mano e la gente scappava da tutte le parti. Ho preso la macchina fotografica e
ho fatto di corsa i 100, 150 metri di distanza dai check-in dell'El Al e della
Twa. Una sparatoria tremenda, ma sarà durata un minuto, non di più". E' la
strage di Fiumicino: 4 terroristi palestinesi tirano bombe e sparano sulla gente
in fila all'imbarco o al bancone del bar, prima che tre di loro vengano uccisi
dalla sicurezza della compagnia israeliana. "Sono intervenuti subito - ricorda
Vergati -, il quarto terrorista è stato catturato da un poliziotto italiano e ha
rischiato il linciaggio". Una foto del reporter mostra il diciottenne Khaled
Ibrahim portato via da un agente. Una delle tante esclusive scattate quel giorno
da Vergati. "C'erano tanti feriti in terra, sangue, gente che chiedeva aiuto e
si lamentava, una scena pazzesca - racconta -. Mentre scattavo le foto cercavo
di rassicurarli, che i soccorsi sarebbero arrivati. Ma ti senti impotente. I
primi feriti li hanno portati via con i carrelli dei bagagli. Ricordo una donna
con il ginocchio aperto, poi ho saputo che è morta. Tra le vittime una ragazzina
di 12 anni figlia di un giornalista americano". "Gli israeliani erano preparati,
come sempre, loro difendevano i loro voli - dice il fotografo - due agenti
italiani sono arrivati poco dopo. Dell'allarme lanciato dai servizi italiani si
è saputo in seguito". Secondo alcune fonti gli addetti alla sicurezza dell'El Al
- in realtà corpi speciali - avrebbero finito i tre palestinesi con un colpo
alla nuca e poi sarebbero subito partiti per Israele. "Non lo so. Può darsi. Non
li abbiamo più visti", dice Vergati che ricorda però che un palestinese aveva un
foro sulla nuca e un rivolo di sangue. "La cosa più incredibile è che dopo la
strage hanno chiuso l'aeroporto una mezz'ora massimo, poi è stata messa una
paratia per non far vedere quel settore e hanno ripreso a fare biglietti - dice
Vergati -. E la gente si lamentava che perdeva l'aereo". "Eravamo così vicini
alla sparatoria, abbiamo trovato dei proiettili nel vetro dell'ufficio - ricorda
-. La paura non la senti quando fai le foto, ti viene dopo, ti tremano le gambe
e pensi 'ma che so' matto?'". Quella del resto era la seconda strage a cui
Vergati assisteva in diretta al Leonardo Da Vinci. Il 17 dicembre 1973, 12 anni
prima, un commando arabo gettò bombe incendiarie dentro un aereo della Pan Am
fermo sulla pista: 30 morti bruciati. "Anche allora ero in ufficio e sentimmo le
esplosioni - racconta -. Corsi dietro un agente con il mitra e mi piazzai dietro
una colonna a fotografare. I terroristi erano a 40 metri e le pallottole
fischiavano vicine". Vergati scattò la foto di un finanziere morto sulla pista
"che arrivò seconda al Premio Pulitzer". Oggi Elio Vergati è ancora lì, lavora
all'aeroporto di Fiumicino che nei decenni è molto cambiato, ma non è cambiato
il modo in cui lui lavora. Con il suo compagno di lavoro di sempre Nevio
Mazzocco, insieme allo storico direttore Lamberto Magnoni e a un collaudato
gruppo di giornalisti sono conosciuti da tutti e conoscono tutti. Rimangono un
punto di riferimento fondamentale per Fiumicino. Oggi come allora.
27 dicembre 1985, Abu
Nidal attacca in aeroporto: 30 anni fa le stragi di Fiumicino e Vienna.
Alle 9.15 due
assalti simultanei di due gruppi armati palestinesi seminarono il terrore negli
scali di Roma e della capitale austriaca: 17 vittime in Italia, 3 allo
Schwechat, scrive di Antonio
Ferrari su “Il Corriere della Sera” del 27 dicembre 2015. Fu una mattina di
terrore in due aeroporti internazionali, Fiumicino e Vienna, quella del 27
dicembre 1985. Esattamente trent’anni fa, il gruppo che allora era il più
estremista della galassia palestinese, guidato da Sabri el Banna detto Abu
Nidal, decise di compiere con perfetta sincronia due simultanei e sanguinosi
attentati, anche se all’epoca non esistevano il web e i cellulari. Bisognava
fidarsi degli orologi da polso. Abu Nidal, che lo stesso presidente dell’Olp
Yasser Arafat aveva condannato a morte per i suoi crimini, si opponeva a
qualsiasi alito di trattativa, a qualunque cenno di disgelo con gli odiati
israeliani, con gli americani e i loro alleati europei. Alle 9 e 15 minuti,
secondo più o meno, di quel mattino due commando entrarono in azione negli scali
delle due capitali con un unico obiettivo: uccidere il maggior numero possibile
di persone. Quelle assiepate davanti ai banchi per l’imbarco in vista del
Capodanno, o magari al bar per un caffè: famiglie serene, bambini sorridenti con
i giocattoli ricevuti in dono a Natale, immigrati che tornavano a casa. Quattro
terroristi, con i mitra nascosti sotto i giubbotti, presero posizione a
Fiumicino, controllando da una ventina di metri di distanza i banchi della
compagnia di bandiera israeliana El Al, e quelli dell’adiacente compagnia
americana TWA (ndr. Uno degli attentatori, l’unico sopravvissuto, condannato e
incarcerato in Italia, poi si pentì: leggi l’intervista sul Corriere del 2008
sfiorando l’icona blu). Altri tre fecero altrettanto in Austria, nello scalo
Schwechat di Vienna. In pochi attimi, l’inferno, e due stragi: 17 morti a
Fiumicino, compresi gli attentatori, e 3 morti a Vienna. Doveva finire come l’11
Settembre a New York - ma 16 anni prima - con un aereo a schiantarsi su Tel
Aviv. Invece fu la seconda strage dell’aeroporto di Fiumicino, con modalità che
ricordano quella di Parigi a novembre. Era il 27 dicembre 1985 - 30 anni fa -:
un gruppo di terroristi palestinesi assaltò con bombe a mano e kalashnikov i
banchi della compagnia israeliana El Al e della statunitense Twa, sparando sulla
gente in fila o al bar. Nello scontro a fuoco con i poliziotti e la sicurezza
israeliana morirono 17 persone: 12 passeggeri, 3 terroristi e un addetto
israeliano; 80 i feriti. Secondo alcune fonti, avallate dal giudice Rosario
Priore che indagò, il commando doveva prendere un aereo e farlo precipitare su
Israele. Come avrebbero poi fatto nel 2001 i kamikaze di Osama Bin Laden in
America. Ma i terroristi furono scoperti e scatenarono l’apocalisse. Mentre is
spara a Fiumicino, altri complici compiono lo stesso massacro all’aeroporto di
Vienna. ll massacro dell’’85 arrivò 12 anni dopo quello del 17 dicembre 1973,
sempre a Fiumicino e da parte di arabi armati, con 34 vittime e modalità ancora
più cruente: due bombe incendiarie gettate dentro un aereo pieno fermo sulla
pista. A seguito di quella strage Aldo Moro avrebbe stretto un accordo con i
gruppi palestinesi, che si impegnavano a non compiere azioni in Italia a patto
di poter transitare per il Paese con armi ed esplosivi. Ma l’intesa segreta
voluta dal ministro degli Esteri democristiano sarebbe emersa solo molti anni
dopo. Il mandante dell’attentato dell’’85 era Abu Nidal, capo di una fazione
palestinese contraria alla linea più moderata a cui si era deciso il leader
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Yasser Arafat.
Condannato all’ergastolo in contumacia, Abu Nidal è stato ucciso nel 2002 a
Bagdad. Il commando arrivò a Roma un mese prima, in un periodo in cui stava
saltando il cosiddetto Lodo Moro (lo statista Dc era stato ucciso nel ‘78), che
aveva risparmiato per 12 anni attentati palestinesi all’Italia. In poche
settimane, un colpo di bazooka sull’ambasciata Usa, una bomba al Cafè de Paris
in via Veneto, un’altra alla compagnia British Airways. Ad ottobre il
dirottamento della nave Achille Lauro e l’uccisione di un passeggero americano
sulla sedia a rotelle, Leon Klinghoffer (Ansa) E si arriva al 27 dicembre 1985.
Sono le 9.05 quando i quattro, che si trovano vicini ai check-in El Al e Twa,
vengono individuati dalla security israeliana - probabilmente corpi speciali - e
scoppia la sparatoria. Un minuto di terrore, i palestinesi mirano ai passeggeri
in fila. Tra le vittime italiani, statunitensi, messicani, greci e un algerino.
Tre terroristi vengono uccisi. Khaled, 18/enne, viene catturato. In simultanea a
Vienna un altro gruppo attacca l’aeroporto, uccide 3 persone, decine i feriti.
Due fedayn vengono presi, uno muore. L’ammiraglio Fulvio Martini, nell’’85 capo
del Sismi (intelligence militare), ha scritto che dal 10 dicembre si sapeva di
un possibile attentato in Italia. Il 19 i servizi informarono che sarebbe
avvenuto tra il 25 e il 31 dicembre a Fiumicino. Gli israeliani, scrive Martini,
misero tiratori scelti a difesa della postazione El Al. Furono loro i primi a
reagire. Le forze dell’ordine italiane erano impreparate. Nel 1992 i capi della
sicurezza di Fiumicino sono stati assolti. Il 17 dicembre ‘73 era andata perfino
peggio: un gruppo di terroristi arabi arrivato dalla Spagna in aereo con le armi
nei bagagli a mano gettò bombe al fosforo dentro un Boeing Pan Am sulla pista,
uccidendo 30 persone. Quindi dirottò un aereo su Atene, altri morti prima di
arrendersi in Kuwait. Un massacro quasi dimenticato. Stragi di civili, come
quelle dell’Isis oggi. Fu una fine d’anno di orrore e di angoscia. L’attrice
Sandra Milo, che stava per imbarcarsi, si gettò a terra e riuscì a salvarsi. I
giornali raccontarono le storie delle vittime e dei familiari sopravvissuti.
Come si sarebbe scoperto in seguito, la strage di Fiumicino poteva forse essere
scongiurata. Infatti i servizi segreti italiani avevano ricevuto, da un Paese
arabo amico, l’informazione (risultata attendibilissima) che vi sarebbe stato un
attentato nello scalo aereo romano tra il Natale e il San Silvestro di
quell’anno. Fu avvisata anche la sicurezza israeliana, che da sempre controlla e
vigila sulle partenze dei propri aerei, e i tiratori scelti si piazzarono in
posizione strategica. Riuscirono a colpire e a uccidere tre degli attentatori,
limitando il numero delle vittime (ndr. Oltre 50 i feriti, nella foto Ansa, qui
sotto, uno dei passeggeri colpiti davanti al banco delle linee aeree
israeliane). Ma, come affermarono i vertici del Sismi, la nostra intelligence
militare, qualcosa non funzionò. Eppure vi erano tante ragioni per ritenere che
vi fosse un’allerta da codice rosso. Il primo ottobre di quell’anno, gli
israeliani avevano bombardato il quartier generale dell’Olp a Tunisi, dove
vivevano in esilio, dopo la partenza coatta dal Libano, Yasser Arafat e i suoi
fedelissimi. Fu una strage, ma il leader palestinese si salvò grazie a un
provvidenziale avvertimento. Allora, infatti, gli americani avevano imposto un
limite al loro alleato israeliano: che non si uccidessero i leader. Sei giorni
dopo — il 7 ottobre 1985 — era cominciata l’odissea, finita in dramma, della
nave italiana «Achille Lauro», in balia di due estremisti palestinesi del gruppo
di Abu Abbas. Ci fu l’assassinio dell’ebreo americano disabile Leon Klinghofer,
e la vicenda di Sigonella, con il muro contro muro tra i nostri soldati e i
marines, e la decisione del presidente del consiglio Bettino Craxi di sfidare
apertamente il presidente-Usa Ronald Reagan. Alla fine, tutto si ricompose tra i
due alleati. Non certo nel mondo palestinese, dove Arafat stava cercando di
trovare la strada per intavolare una trattativa con il suo storico nemico:
Israele. E’ chiaro che la strage di Fiumicino fu un attacco diretto anche ad
Arafat da parte degli estremisti palestinesi, che avevano trovato rifugio
nell’accogliente Siria di Hafez el Assad, padre di Bashar. A Damasco vi era
persino un pubblico ufficio del gruppo di Abu Nidal, guidato dal suo vice e
portavoce Walid Khaled. Appena arrivato a Damasco, all’inizio di quel gelido
1986, andai subito a cercare Khaled, per chiedergli ragione di quei massacri. Il
giovane guerrigliero, che si vantava delle imprese terroristiche della sua
organizzazione, fu gentile e insieme sprezzante. In realtà, noi italiani in
Siria avevamo nel Paese canali privilegiati. Assad padre aveva stima
incondizionata per il presidente Giulio Andreotti, e il suo ministro degli
esteri Farouk al Shara non mancava mai di ricordare i bei tempi in cui aveva
servito come ambasciatore a Roma. I giornalisti americani che riuscivano ad
ottenere il visto per la Siria faticavano non poco a ottenere interviste e
notizie interessanti dalle fonti locali. Un giorno incontrai la collega Elaine
Sciolino, una delle firme più prestigiose del New York Times. Bravissima, colta,
notevole grinta e grande coraggio. Dopo avermi ricordato l’origine italiana del
suo cognome, mi chiese la cortesia di aiutarla ad incontrare, in mia compagnia,
Walid Khaled. Organizzammo l’intervista, che si concluse in maniera quasi
drammatica. Elaine, sensibilissima, domandò, cercando invano di trattenere le
lacrime: «Ma come potete ammazzare donne, bambini, persone che non vi hanno
fatto nulla. Non ascoltate mai la voce della vostra coscienza?». L’uomo di Abu
Nidal, per nulla turbato, rispose gelidamente: «Per colpire il cuore bisogna
tagliare le vene».
30 anni dalla strage di
Fiumicino: quando il terrorismo palestinese colpì l’Italia,
scrive Simone Cosimelli il 27 dicembre 2015. La storia dell’Italia del
dopoguerra è costituita da un vortice di avvenimenti strazianti e convulsi,
frutto delle spinte politiche e sociali che dagli anni successivi all’Assemblea
Costituente – con le sue speranze e le sue illusioni – culminarono nello
scandalo dell’inchiesta Mani
Pulite del 1992, che di fatto segnò il limite di un epoca (la così
detta Prima
Repubblica) per aprirne una nuova, non meno discutibile. Il ricordo
di quel periodo, carico di circostanze oscure e casi irrisolti, è eredità e
condanna di tutti. Ma non solo vicende interne hanno plasmato il Paese, e spesso
è il tempo ad offrire l’occasione per volgere lo sguardo indietro: esattamente
30 anni fa in due attacchi terroristici di matrice palestinese, uno
all’aeroporto di Fiumicino e l’altro a Vienna,
morirono 16 persone e
oltre 100 rimasero ferite. Il 1985 era stato un anno difficile. Il
dirottamento della nave da crociera italiana
Achille Lauro (con
oltre 500 persone a bordo) da parte di un commando di palestinesi pronti ad un
azione offensiva sulle coste Israeliane, e la conseguente crisi di Sigonella, in
cui l’allora capo del Governo Bettino
Craxi si oppose al Presidente statunitense Ronald Reagan, avevano
intorpidito la situazione internazionale. Craxi andò fino in fondo e non
trattenne l’emissario di Arafat (Presidente dell’OLP) Abu
Abbas, a sua volta leader del gruppo paramilitare FLP (Fronte per la
Liberazione della Palestina) e presunto promotore del tentato attacco, in cui un
cittadino americano invalido, Leon Klinghoffer, perse la vita dopo essere stato
gettato in mare. Abu Abbas lasciò indenne l’Italia, ma fu subito giudicato
colpevole grazie alle prove schiaccianti addotte dalla Cia e condannato
all’ergastolo in contumacia. L’Italia non fece in tempo ad attenuare le tensioni
sorte con gli USA, che, nonostante l’atteggiamento comprensivo mostrato nella
vicenda verso i palestinesi, fu
duramente colpita due mesi più tardi: e questa volta, al Leonardo da
Vinci di Roma, si dovettero contare i morti. Alle nove del mattino del 27
dicembre quattro uomini entrano nell’atrio dell’aeroporto e si posizionano di
fronte ai banchi accettazione delle compagnie aeree El
Al e Twa (l’una
israeliana e l’altra americana). Armati di kalashnikov cominciano a lanciare
bombe a mano e a sparare sulla folla davanti ai banchi del check-in e nel bar
vicino. Gli agenti della sicurezza israeliani e le forze dell’ordine italiane
rispondono al fuoco: in pochi minuti tre attentatori sono uccisi e il quarto è
catturato. L’attentato
nella capitale conta tredici morti e settantasette feriti (tra italiani,
americani, messicani, greci, e un algerino). Contemporaneamente, in Austria, un
commando terroristi mette in atto lo stesso tipo di azione all’aeroporto Schwechat di
Vienna, provocando tre
morti e quaranta feriti. Secondo alcune fonti, avallate dal giudice
Rosario Priore che all’epoca indagava, il piano doveva concludersi con la
requisizione di un aereo da far precipitare, in stile 11
settembre, in una città di Israele. Per l’ammiraglio Fulvio Martini,
al tempo capo del Sismi,
dal 10 dicembre si sapeva di un possibile attentato. I servizi informarono che
sarebbe potuto avvenire tra il 25 e il 31 a Fiumicino. Gli israeliani misero
infatti tiratori scelti a difesa della postazione El
Al: furono loro i primi ad intervenire, mentre
le forze dell’ordine italiane si trovarono sostanzialmente impreparate.
“Sapevamo che nessuno
di noi sarebbe uscito vivo”. Confermò in seguito l’unico degli
attentatori rimasto illeso nello scontro a fuoco, Ibrahim Khaled, condannato poi
a 30 di reclusione e recentemente liberato. Non era la prima volta che si
spargeva sangue sul suolo del Bel Paese: c’era stata nel 1973 la “prima” strage
di Fiumicino (una delle più cruente d’Europa), dove su un Boeing 707 della Pan
Am, diretto a Beirut, furono fatte esplodere due bombe, con un bilancio finale
di 32 vittime, tra cui 4 italiani. Nel 1982, invece, l’attentato alla sinagoga
di Roma sconvolse la comunità ebraica causando 37 feriti e la morte di un
bambino di due anni, Stefano Gaj Taché.
Il mandante dell’85 fu Abu Nidal, capo di una fazione palestinese
contraria alla linea più moderata perseguita da Arafat in quegli anni. Anche lui
– come successo ad Abu Abbas – fu giudicato colpevole in contumacia, e,
riconosciuto coinvolto in circa 90 attentati a livello internazionale, perse la
vita nel 2002 a Bagdad su ordine del dittatore Saddam Hussein, liberatosi di una
presenza “ingombrante”.
Eventi del genere seguono logiche difficile da percorrere ma doverose da
ricostruire: fu l’eccessiva compiacenza, o negligenza, del Governo a permettere
che i palestinesi considerassero l’Italia un porto sicuro da dove far partire, o
verso cui finalizzare, gli attacchi terroristici? Si sarebbero dovuti condannare
con più veemenza certi fatti internazionali di quegli anni (Guerra
del Kippur, Invasione del Libano, massacro di Monaco alle Olimpiadi),
deplorando tanto le azioni palestinesi quanto le continue vessazioni israeliane?
Perché non si combatté concretamente, mettendo da parte la retorica e i
protocolli, l’indigenza e la precarietà politica del Medio Oriente? Se il mondo
si trova ancora nel mezzo di una guerra asimmetrica, qual è quella che
imperversa in Siria e porta avanti lo Stato Islamico, o che ogni giorno rischia
di deflagrare sulla striscia di Gaza e in Cisgiordania, significa
che un tipo di politica ha fallito: la
politica dell’interesse. E con essa, come si è visto, non sono mai
mancati coinvolgimenti diretti, e drammatici, di nazioni distanti sulla carta
geografica dai conflitti mediorientali ma poi duramente colpiti: ieri è toccato
all’Italia, oggi al Mali, alla Tunisia e alla Francia.
E domani?
Tante sono le proposte, troppi gli incontri conclusi con sterili promesse, poco,
invece, è l’impegno profuso senza che il proprio tornaconto prevarichi quello
collettivo. Da quando la mano dell’Occidente ha cercato di cogliere i frutti
(avvelenati) del Medio Oriente, il
terrorismo è stata una costante e si è fatto finta di non capire che
dalle guerre nasce e delle guerre si alimenta. Questi conflitti, sobillati e
finanziati dalle stesse forze che poi si impegnano nel debellarli, arriveranno,
presto o tardi, ad un punto di non ritorno. Quel punto troppe volte sembra
essere un obbiettivo da raggiungere piuttosto che evitare.
Se la storia non insegna, quanto meno invita a riflettere. Soprattutto oggi.
Fiumicino, strage
inevitabile.
Raid del 1985, assolti tutti i responsabili della sicurezza. Assolti dall'
accusa di strage colposa Casagrande Raffaele, ex dirigente dell'aeroporto; D'
Agostino Francesco, responsabile del centro di Polizia; Jovinella Carlo, capo
del commissariato; Carlino Antonio, ispettore generale della polizia di
frontiera. Secondo l'accusa avevano ignorato gli allarmi sul pericolo di
attacchi. La strage all'aeroporto di Fiumicino del 27 dicembre di sette anni fa
non poteva essere evitata. A questa conclusione sono giunti i giudici del
Tribunale che, al termine di una breve camera di consiglio, hanno assolto
"perchè il fatto non costituisce reato" le quattro persone che dovevano
garantire la sicurezza nello scalo. Una sentenza destinata a far discutere, che
costituisce una sorta di caposaldo sul fronte dell'accertamento delle
responsabilità per il funzionamento delle misure anti-attentati. Il processo e'
andato avanti per parecchie udienze. Sul banco degli imputati l'ex dirigente del
"Leonardo da Vinci", Raffaele Casagrande, gli allora responsabili del centro di
polizia e di prevenzione del Dipartimento di sicurezza del ministero
dell'Interno, Francesco D' Agostino, e del commissariato "Polaria", Carlo
Jovinella, e l'ispettore generale con funzioni di coordinamento dei servizi di
polizia della frontiera, Antonio Carlino. Al termine della requisitoria, il
Pubblico ministero Giuseppe Geremia aveva chiesto la condanna di Casagrande a
due anni di carcere e degli altri imputati a un anno e mezzo. La sparatoria tra
terroristi e forze dell'ordine provocò tredici morti e ottanta feriti. La tesi
sostenuta dalle famiglie delle vittime fu che non erano stati tenuti nella
dovuta considerazione i suggerimenti dei servizi segreti: l'avvocato Lepore era
riuscito ad avere un fonogramma della Twa (la compagnia statunitense che venne
presa di mira insieme alla israeliana El Al dal commando palestinese del gruppo
di Abu Nidal) col quale si lanciava un preciso avvertimento ai dipendenti. I
servizi segreti americani avevano saputo che erano stati messi a punto piani per
eseguire attentati terroristici negli aeroporti europei. Non basta. L'avvocato
Lepore aveva appreso che il fonogramma era in possesso del Sismi, il quale lo
aveva ricevuto prima della strage. E l'allora responsabile dei nostri servizi
segreti, Fulvio Martini, sentito come testimone nel corso dell'inchiesta,
confermò anche che nel documento riservato veniva indicato il periodo entro il
quale doveva essere compiuto l'attentato, dal 25 al 31 dicembre del 1985. Da
qui, l'incriminazione e il successivo rinvio a giudizio dei responsabili dei
servizi di sicurezza. Agli imputati venne contestato il reato di strage colposa.
Secondo l'accusa, avevano avuto un comportamento negligente: Casagrande non
attuò accorgimenti per evitare che i terroristi arrivassero ai banchi
dell'accettazione, dove poi avvenne il conflitto a fuoco. Jovinella e Carlino
non diedero un giro di vite ai servizi di sorveglianza, D' Agostino non trasmise
agli organi di polizia circolari con le quali venivano imposte precise
disposizioni di prevenzione. Insomma, il peggio sul fronte della prevenzione. Ma
i giudici hanno sconfessato questa impostazione. Flavio Haver
Pagina 14 (31 marzo 1992) - Corriere della Sera
Uccise 13 persone a
Fiumicino. Esce di cella e fa il
giardiniere.
Mahmoud nell'85 guidò il commando palestinese all'aeroporto.
Portò la guerra a Roma, ha tredici morti sulla coscienza e raccoglie foglie
secche in un prato. Khaled Ibrahim Mahmoud oggi ha 41 anni. Ne aveva 18, il 27
dicembre 1985, quando guidò il commando della strage di Fiumicino. «Ci penso sì,
a quei morti. Ci penso ancora e ci penserò sempre. E penso anche che l'aver
seminato il terrore, come abbiamo fatto noi, non è servito a niente. Non è
servito al mio popolo, non è servito alla pace. Anzi, il contrario...». Il 27
dicembre 1985, all'aeroporto di Fiumicino, il commando di terroristi palestinesi
uccise tredici persone e ne ferì più di 80, sparando contro il banco delle linee
aeree israeliane. Il fuoco della sicurezza in pochi secondi annientò gli
assalitori, tre morirono all'istante, Khaled rimase ferito, unico superstite.
Poi è stato in carcere 23 anni, fino a tre giorni fa. Oggi è un detenuto
semilibero (la sera torna a Rebibbia) e da giovedì ha cominciato a lavorare
all'esterno per una cooperativa sociale: giardinaggio, facchinaggio, pulizie nei
mercati e nei parchi di Roma (come Pino Pelosi, l'assassino di Pier Paolo
Pasolini). La prima cosa che ha chiesto è stato il permesso di acquistare un
telefonino cellulare («Per chiamare mio fratello e i miei genitori ormai
anziani», dice in buon italiano, appreso in questi anni leggendo e guardando in
cella la televisione). Gli altri detenuti che lavorano con lui non conoscono la
sua storia. Khaled, in fondo, preferisce così: «Il dolore che provo — dice — non
potrebbe essere condiviso, sono venuto al mondo durante la guerra, una lunga
scia di sangue e di orrori mi accompagna da sempre, da Sabra e Chatila a
Fiumicino. Ma allora avevo 18 anni, ero completamente indottrinato, non
ragionavo. Il carcere, almeno, mi è servito a questo: a farmi pensare con la mia
testa, a farmi capire tante cose». Lui faceva parte del gruppo di Abu Nidal, il
feroce leader della lotta armata palestinese, mandante del massacro di
Fiumicino, trovato morto in un appartamento di Bagdad nell'agosto 2002 («È stato
ammazzato, ne sono certo», dice oggi Khaled, condannato a 30 anni per la strage
dell'85). Il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, è la
persona che in questi anni l'ha seguito più da vicino: «Di sicuro — dice il
Garante — Khaled ha maturato una critica profonda rispetto al suo passato. In
carcere ha studiato, ha fatto il bibliotecario, è stato un detenuto modello,
perciò ha ottenuto la liberazione anticipata. Il nostro è un sistema premiale,
dunque non c'era motivo perché lui non ottenesse i benefìci previsti dalla
legge. Il primo permesso gli fu accordato un anno fa, lo accompagnai io stesso
ad Ostia, a vedere il mare...». Il giorno che andarono al mare, però, pioveva e
faceva freddo: del resto, dopo 23 anni di carcere, diventa difficile far tornare
i conti. Se n'è andato un pezzo di vita perché tu hai distrutto quella degli
altri e anche andare avanti fa paura. «Il mondo da allora è completamente
cambiato — sospira l'ex terrorista, con i capelli ingrigiti —. È caduto il muro
di Berlino, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più il comunismo. Noi
stavamo coi russi, all'epoca, io stesso ero comunista-stalinista, oggi però sono
in via di guarigione...». L'anno prossimo Khaled finirà di scontare la sua pena,
nel frattempo si è laureato in Scienze politiche con una tesi sui Diritti umani
e, malgrado tutto, sembra avere fiducia nel futuro del Medio Oriente: «Prima o
poi tutti i muri cadono. Ma la pace non s'impone, la pace bisogna volerla».
Fabrizio Caccia
22
novembre 2008 "Il Corriere della Sera".
7 ottobre 1985: dal
sequestro dell’Achille Lauro alla lunga notte di Sigonella,
scrive “Il Corriere della Sera”. Sono da poco passate le 13 del 7 ottobre del
1985, la nave da crociera Achille Lauro della Mediterranean Shipping Company sta
percorrendo la tratta al largo delle coste egiziane, a bordo ci sono 101
passeggeri e 344 membri dell’equipaggio, quando un commando composto da quattro
militanti del Fronte per la Liberazione della Palestina, saliti a bordo a Genova
con dei passaporti falsi, dà inizio a un dirottamento che diventerà un caso
diplomatico internazionale, con conseguenze fatali per il passeggero americano
di origine ebraica Leon Klinghoffer. L’Italia reagisce inviando la sera stessa
60 incursori del reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin alla base
militare di Cipro, pronti all’intervento in quella che verrà chiamata
l’Operazione Margherita. Nella foto di repertorio l’Achille Lauro lascia il
porto di Napoli. I terroristi vengono sorpresi da un componente dell’equipaggio
mentre maneggiano delle armi, ne nasce un conflitto a fuoco, dopo il quale viene
immediatamente inviato un SOS dalla nave che verrà captato in Svezia. Nella foto
i quattro terroristi autori del sequestro, da sinistra: Ibrahim Fatayer
Abdelatif, Youssef Al Molqi, Al Ashker Bassam, Marrouf Al Assadi. I dirottatori
chiedono la liberazione di cinquanta palestinesi detenuti in Israele a Nahariya,
si dichiarano esponenti dell’OLP, e minacciano di far saltare in aria la nave in
caso di mancata risposta alle loro richieste. Il Governo italiano si attiva non
appena ricevuta la notizia del dirottamento: agli Esteri c’è Giulio Andreotti,
forte di buoni contatti con il mondo arabo, alla Difesa c’é Giovanni Spadolini
che convoca immediatamente l’intelligence, mentre alla Presidenza del Consiglio
c’é Bettino Craxi, che spinge per una risoluzione diplomatica della crisi. I
nostri ministri sono in contatto telefonico con il governo egiziano di Hosni
Mubarak, con il leader palestinese Yasser Arafat, che in un comunicato stampa fa
sapere di essere estraneo alla vicenda, e con la Tunisia, allora sede dell’OLP.
Nella foto d’archivio, Andreotti con Arafat. Dopo una frenetica serie di
colloqui internazionali, l’Egitto e Arafat comunicano all’Italia l’invio di
alcuni emissari per gestire la situazione: tra loro Hani El Hassan, braccio
destro del leader dell’OLP, e Abu Abbas, che solo in seguito si rivelerà
coinvolto nell’attentato in qualità di ispiratore e di capo del fronte
terroristico palestinese filosiriano. Nella foto, Abu Abbas. Il Presidente
americano Ronald Reagan si oppone a qualsiasi trattativa con i terroristi,
mentre l’Achille Lauro si dirige verso il porto di Tartus in Siria e chiede un
negoziato mediato dalla Croce Rossa Internazionale. Nella foto, Maxwell Rabb,
all'epoca ambasciatore USA a Roma. Sulla nave intanto la tensione sale
vertiginosamente con i terroristi che minacciano ripetutamente di iniziare a
uccidere i passeggeri, in primis i cittadini americani. Nella foto i familiari
dei marinai dell’Achille Lauro in attesa di notizie. Gli Stati Uniti decidono di
intervenire rompendo le trattative diplomatiche in corso, mentre Bettino Craxi
insiste nel voler evitare un’azione di forza, e nel caso, vuole che sia guidata
da forze armate italiane. Nella foto Giulio Andreotti e Bettino Craxi. La
Achille Lauro abbandona la costa siriana e raggiunge Port Said, mentre le
trattative, non appoggiate dagli americani, riescono a convincere alla resa di
terroristi, grazie alla mediazione di Abu Abbas e alla promessa di fuga
diplomatica verso la Tunisia. Una soluzione che trova l’appoggio del Governo
italiano e che apparentemente sembra portare a un epilogo non drammatico della
vicenda, fino a quando non arriva la notizia dell’uccisione a bordo del
cittadino americano Leon Klinghoffer, nella foto. La situazione si aggrava
tragicamente e la tensione con gli Stati Uniti assume dei contorni molto
preoccupanti anche per lo Stato italiano, che sta vivendo da protagonista
l’intricata vicenda. Dopo la liberazione della nave si decide per l’immediato
trasferimento dei quattro attentatori e dei diplomatici egiziani e palestinesi
in Tunisia, a bordo del boeing 737 delle linee aeree egiziane. Nella foto il
comandate della nave Gerardo De Rosa. Oltreoceano Reagan dispone di intercettare
l’aereo egiziano facendo partire dalla portaerei Saratoga quattro caccia F-14 e
spingendo diplomaticamente affinché gli aeroporti di Tunisia, Grecia e Libano
rifiutassero l’atterraggio. Nella foto Caspar Weinberger, segretario alla difesa
americano, durante la riunione al Pentagono illustra dove i jet US F14 hanno
intercettato l’aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell’Achille Lauro.
Senza possibile luogo d’atterraggio l’aereo egiziano viene così intercettato dai
velivoli americani e costretto ad atterrare alla base statunitense di Sigonella,
in territorio italiano. «Perché in Italia?» chiederà Craxi durante una
telefonata con il consulente CIA Michael Leeden, come racconterà poi Michael K.
Bohn nel suo libro sulla vicenda di Sigonella e dell’Achille Lauro. Nella foto
la nave liberata, i passeggeri e i marinai guardano le strisce di sangue
lasciate dal corpo dell’americano Leon Klinghoffer, ucciso e gettato in mare.
Contrariato dall’improvvisazione degli americani, l’allora presidente del
Consiglio italiano Bettino Craxi rivendica la competenza territoriale,
appellandosi al diritto internazionale e schiera a difesa del velivolo egiziano
uomini dei Carabinieri di stanza all’aeroporto e del comando di Catania. Nella
foto la gioia dei passeggeri dell’Achille Lauro sulla nave liberata. Il
controllore di torre dell’aeroporto militare di Sigonella e il suo assistente,
inizialmente all'oscuro dell'identità dei passeggeri a bordo del boeing
egiziano, saranno decisivi e indispensabili alla gestione dei momenti concitati
sulla pista e alla cattura dei terroristi da parte delle autorità italiane.
Nella foto Edward Casey, dell'ambasciata degli Stati Uniti, sull'’Achille Lauro
con i passeggeri americani. Sulla pista di Sigonella, poco dopo la mezzanotte,
atterrano a luci spente e senza autorizzazione due Lockheed dei Navy Seal, da
cui scendono militari americani armati con l’intento di ottenere il controllo
dell’aereo e soprattutto di prendere in consegna i terroristi e Abu Abbas. Nella
foto la moglie del cittadino americano ucciso, Marilyn Klinghoffer. L’Italia e
gli Stati Uniti vivono ore di tensione fortissima, il cui apice sarà la
telefonata di Reagan a Craxi per chiedere la consegna dei terroristi, ma Craxi
non si muoverà dalle sue posizioni, attestandosi sulla linea che in assenza di
richiesta di estradizione non era consentito a nessuno sottrarre alla giustizia
italiana persone sospettate di reati punibili ai sensi della legge italiana.
Dopo ore interminabili, con l’invio di altri Carabinieri e di mezzi blindati, le
forze armate americane ricevono l’ordine di ritirarsi. Nella foto il presidente
americano Ronald Reagan. Si dirà poi che a vincere questo pericoloso braccio di
ferro fu soprattutto il socialista Bettino Craxi, anche se poi vedrà cadere
proprio su questa vicenda il proprio gabinetto di governo, ma le conseguenze di
questo intricato affaire internazionale non termineranno con l’arresto dei
quattro terroristi. Nella foto il carcere di Siracusa dove sono stati rinchiusi
i terroristi palestinesi. I due dirigenti palestinesi e il diplomatico egiziano
restano a bordo del boeing, che parte alla volta di Ciampino, protetto da un
velivolo del SISMI e quattro caccia italiani F-104S, mentre un caccia americano,
senza autorizzazione e senza aver comunicato il piano di volo, decolla subito
dopo con l’intento di prendere in consegna il boeing con a bordo Abbas,
considerato responsabile del dirottamento. L’aereo riuscirà ad atterrare a
Ciampino, ma in un continuo crescendo di tensione, un secondo jet militare
statunitense fingendo un guasto otterrà di poter atterrare proprio sulla stessa
pista, davanti al boeing egiziano per impedirne la ripartenza. L’ammiraglio
Fulvio Martini, protagonista diretto di tutta la vicenda, intimerà di liberare
la pista, e per altri minuti l’Italia e gli Usa saranno a un passo dallo scontro
armato. Nella foto il boeing 737, atterrato all’aeroporto di Ciampino, con a
bordo i palestinesi. La crisi si sposta dalla pista dell’aeroporto alle stanze
di Governo, dove è in corso un braccio di ferro sulla gestione e l’eventuale
fermo in Italia dei due dirigenti dell’OLP a bordo del boeing egiziano: da un
lato Craxi, Andreotti e Martinazzoli, nella foto, contrari all’arresto dei due
funzionari palestinesi, dall’altro Giovanni Spadolini che chiede una
consultazione collegiale della decisione. Il 12 ottobre Abu Abbas e l’altro
funzionario palestinese ripartono a bordo di uno volo delle linee aeree
jugoslave verso Belgrado, senza che Spadolini sia stato informato. L’intera
vicenda porterà alla caduta del governo Craxi poche settimane dopo e a una
rottura personale tra Craxi e Spadolini, esponenti rispettivamente delle due
correnti filopalestinese e filoamericana. Nella foto la prima pagina del
Corriere della Sera del 17 ottobre 1985 che annuncia le dimissioni del Governo
Craxi. Solo nei giorni successivi verranno raccolte informazioni e
intercettazioni dei servizi segreti israeliani e americani che proveranno con
certezza il coinvolgimento diretto nel dirottamento di Abu Abbas, nella foto,
che sarà condannato all’ergastolo in contumacia. I quattro dirottatori saranno
poi rinchiusi nel carcere di Siracusa, trasferiti a Genova, processati e
condannati dalla magistratura italiana, mentre l’Achille Lauro farà ritorno a
Napoli dopo un breve scalo in Grecia e dopo che un’informativa della CIA sulla
possibile presenza di esplosivo sulla nave su alcune casse, gettate poi in mare
dal comandante. Nella foto Al Ashker Bassam durante il processo. Quanto ai
rapporti Usa-Italia, gli attriti rientreranno qualche tempo dopo con l’invito
dal famoso incipit “Dear Bettino” rivolto da Reagan a Craxi a recarsi negli Usa,
un viaggio già programmato, ma annullato a causa della vicenda Achille Lauro.
Nella foto la vedova di Leon Klinghoffer, ricevuta dal presidente Ronald Reagan.
A proposito di prevenzione.
Un magistrato la arresta l'altro la rimette in libertà. Qual è il pericolo a
piede libero? Scrive Salvatore Tramontano Giovedì 24/12/2015 su "Il Giornale".
Qual è il pericolo a piede libero? Una terrorista con l'obbligo di dimora, ma
con la possibilità di contattare via Internet i suoi compagni di fede e di
terrore, pianificando eventuali azioni di guerriglia e attentati oppure il pm
che voleva marchiare e sbattere in galera un'innocente? Oppure è il gip che ha
scarcerato la donna, che dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 al largo di
Palermo, avrebbe affermato: «Questa è la vendetta divina»? Nulla è come prima.
La guerra invisibile dello Stato islamico sgretola le nostre certezze, i
capisaldi del diritto, fa sponda sulle paure e gioca a scacchi con la fede nella
libertà e il desiderio di sicurezza. La storia della ricercatrice libica di 45
anni, accusata di istigazione a commettere atti di terrorismo, che per il pm è
così pericolosa da essere rinchiusa in carcere mentre per il gip al massimo
merita l'obbligo di dimora, mostra quale sia la nostra realtà: noi non siamo in
grado di capire se questa donna sia davvero una terrorista. Questo caso incarna
tutte le nostre paure e segna le fragilità di questa stagione. Come mai il pm,
convinto che la donna sia pericolosa, non è riuscito a trovare le prove per
tenerla in carcere? Non è stato abbastanza bravo? O la legge non fornisce a chi
indaga gli strumenti adeguati? E il gip è stato troppo fiscale o davvero non
poteva fare altrimenti? Certo che se per aiutare i magistrati a «formarsi»
meglio sul fenomeno jihadista, come ha raccontato alcuni giorni fa Fausto
Biloslavo su questo Giornale, la Scuola superiore della magistratura organizza
un solo corso, allora tutto diventa più difficile. Il motivo spiegato nella
presentazione è chiaro: «Scandita dagli attentati, la disciplina antiterrorismo
costituisce un vero e proprio sottosistema della giustizia penale». Purtroppo la
prestigiosa Scuola offre poco altro sull'argomento. Di terrorismo, infatti, si
parlerà brevemente soltanto nel corso su «Religione-Diritto-Satira». Questo
nonostante al sistema di formazione dei magistrati concorra anche il ministero
della Giustizia. In compenso, però, ha raccontato sempre Biloslavo, viene
ripetuto, dopo il grande successo dello scorso anno, il corso sull'«immagine
della giustizia nell'arte, nel cinema, nella letteratura». La questione è seria
e forse il guaio maggiore è che non siamo pronti ad affrontare una situazione
come questa. Se c'è un punto dove siamo più vulnerabili, questo è il versante
della giustizia: l'Italia, le sue leggi, si confrontano con un nemico nuovo,
diverso perfino dal terrorismo rosso e nero degli anni '70, con integralisti
fanatici che non temono la morte e sono pronti a farsi saltare in aria o sparare
sulla folla come martiri. Come ci si difende da nemici così assoluti e
imprevedibili? Quante garanzie si possono concedere? È il paradosso della
società aperta: fino a che punto si può essere tolleranti con gli intolleranti?
La risposta è che una società aperta non è suicida, non è spalancata. Non può
essere tollerante fino alla morte. È arrivato il momento di difendersi dal
terrore islamico con tutti i mezzi. E servono nuove leggi. Per non morire o
sopravvivere nella paura.
LA DIFFERENZA TRA
RELIGIONI.
Il laicismo è esso stesso una
religione, se al contempo con esso si santifica il comunismo. Ergo. Il comunismo
non è una ideologia, ma per i suoi adepti è una religione, che non promana
dubbi.
Contro il naufragio laico
studiamo le religioni.
Sono stati smentiti coloro che avevano indicato nella
secolarizzazione un processo irreversibile, immaginando che le religioni
sarebbero state confinate per sempre alla sfera privata. Pensare che la
religione sia solo violenza è un modo sbrigativo per ridurre ogni conflitto alla
«guerra del sacro» contro la laicità, scrive
Donatella Di Cesare su
“Il Corriere della Sera” il 29 dicembre
2015. Le polemiche sui presepi o sui crocefissi a scuola, le difficoltà
in cui spesso si scontra chi tenta di affrontare temi religiosi, non solo nelle
aule scolastiche, ma anche in quelle universitarie, spingono a più di una
riflessione. La
presenza dell’Islam (come religione) in Europa ha fatto emergere un fenomeno
diffuso già da qualche anno: il
ritorno delle religioni nella sfera pubblica. Sono stati smentiti coloro che
avevano indicato nella secolarizzazione un processo irreversibile, immaginando
che le religioni sarebbero state confinate per sempre alla sfera privata.
Giustamente Jürgen Habermas parla perciò di «società post-secolari».
Il «ritorno» delle religioni crea molti problemi soprattutto là dove, come in
Francia, la laicità sembrava un valore intramontabile. Di
qui il forte attrito con l’Islam. Mentre Ebraismo e Cristianesimo, rinunciando a
molte prerogative, hanno concordato, già all’inizio della modernità, un patto
con lo Stato, riconoscendone la sovranità, l’Islam comincia solo ora a entrare
nel «patto laico» e nella nazione. L’ingresso dell’Islam nella cittadinanza
europea porta alla luce una difficoltà che riguarda anche le altre religioni.
Così Ebraismo e Cristianesimo hanno dovuto rinunciare alla loro dimensione
politica, senza che questa
rinuncia fosse mai definitiva. Forse perché la separazione tra religione e
politica è una pretesa del laicismo, fittizia quanto irrealizzabile. E se a
essere un problema fosse proprio quella sorta di religione civile dello Stato
che sta tramontando insieme allo Stato-nazione? Certo è che le componenti più
laiche sembrano oggi le più impreparate a comprendere quel che accade nel
complicato processo della globalizzazione.
Pensare che la religione sia solo violenza, che
rappresenti un inutile oscurantismo, è un modo sbrigativo per ridurre ogni
conflitto alla «guerra del sacro» contro la laicità. Come se bastasse
sbarazzarsi delle religioni per trovare un rimedio nel tormentato scenario
contemporaneo. Quel
che appare ormai evidente è che la laicità non è il luogo neutro di un confronto
tra religioni e culture diverse, non
è il terreno di una non meglio precisata «morale universale», né la forma
dell’identità collettiva. Ciò a cui oggi si assiste è proprio il naufragio della
laicità così intesa. Il patto laico, che ha sempre avuto tratti fortemente
nazionali, non funziona nel mondo globalizzato. Ma a ben guardare non ha
funzionato neppure prima, lasciando una difficile eredità.
Giudicate dall’alto della ragione illuministica, le
religioni sono state ridotte a dogmi superflui e dannosi, quasi che non
facessero parte del patrimonio culturale. Gli effetti sono devastanti. Questo
spiega perché il «dialogo interreligioso» è una faccenda di élite. Nelle scuole
e nelle università, sia nel nostro Paese, sia in altre nazioni europee, domina
l’ignoranza. Peraltro
proprio quando oramai in quasi ogni classe ci sono studenti delle tre religioni
e sarebbe auspicabile la mutua conoscenza. Ma
come si può dialogare con la religione degli altri, se si sa poco o nulla della
propria? E se si è portati a credere che, in un caso come nell’altro, si tratta
di oscuri dogmi? Si
moltiplicano allora preconcetti e cliché. Anche
l’ebraismo è oggi più che mai nel mirino. Così si spalancano le porte
all’islamofobia non meno che all’antisemitismo. E così finiscono per avere la
meglio le posizioni fondamentaliste, diffuse purtroppo anche tra i giovani.
Dove non si è stati abituati all’ermeneutica dei testi, alla
riflessione sui concetti religiosi, si resta muti di fronte alla ostentazione di
una pretesa «verità», che dovrebbe invece essere subito decostruita. I
fondamentalismi religiosi tentano infatti di separarsi dalla cultura di
provenienza. Mentre il Corano, come i Vangeli, come la Torà, richiedono
interpretazione.
Isis, curdi e peshmerga,
sciiti e sunniti: il glossario del Medio Oriente.
Quali sono le definizioni delle parole e delle sigle che meglio spiegano i
conflitti religiosi, militari e politici in corso nella regione mediorientale,
scrive “Il Corriere della Sera” il
4 gennaio 2016.
ALAUITI.
O Alawiti, termine coniato dall’amministrazione francese per indicare la setta
musulmana sciita dei Nusairī e la regione da essi abitata, fra Tripoli e
Laodicea, sopra le falde occidentali del gebel Ansāriyya. Staccata dal Libano
nel 1920 ed eretta in amministrazione autonoma con la denominazione di
Territorio degli Alauiti, poi di Stato alawita, nel 1922 la regione entrò a far
parte della Federazione siriana, dalla quale uscì nel 1924 ricostituendosi come
Territorio autonomo degli Alauiti, poi divenuto (1930) Governatorato autonomo di
Laodicea. Prefettura della repubblica siriana dal 1935, di nuovo territorio
autonomo nel 1939, con la definitiva cessazione del mandato francese (1945) è
stata reincorporata nella Siria. Il presidente siriano Bashar al-Assad è
alauita. (Fonte: Treccani).
CALIFFATO.
È stato proclamato il 29 giugno del 2014 da Abu Bakr al-Baghdadi, leader
dell’Isis che si auto definisce Califfo. Viene usato impropriamente come
sinonimo di Isis (vedi sotto alla voce Isis). In passato il califfato è stato
una forma di governo adottato dal primissimo Islam, il giorno stesso della morte
di Maometto e intende rappresentare l’unità politica dei musulmani, ovvero la
Umma. Nel corso di questi secoli, oltre i primi quattro califfi “ortodossi”
(definiti, secondo una traduzione impropria, “ben guidati”) e quelli omayyadi di
Siria e abbasidi di Baghdad e Samarra, altri due califfati si sono affermati:
quello sciita-ismailita fatimide fra il 909 d.C e il 1171, e poi quello omayyade
andaluso, attivo tra il 929 e il 1031.
CURDI.
Popolazione iranica la cui regione storica, il Kurdistan, è attualmente
suddivisa fra Turchia, Iran, Iraq, Siria e Repubblica di Armenia. La consistenza
numerica dei curdi, di difficile valutazione per la mancanza di dati ufficiali
sufficientemente attendibili, si aggira sui 20-30 milioni di persone,
distribuite soprattutto fra la Turchia sud-orientale, il Nord-Ovest dell’Iran e
il Nord-Est dell’Iraq, mentre assai minore è la presenza curda nella fascia più
settentrionale della Siria e nella regione transcaucasica (specialmente in
Armenia). I curdi erano suddivisi in numerose tribù patriarcali, dotate di
un’organizzazione di tipo semifeudale. Elementi di tale assetto tradizionale
sono tuttora presenti. La religione predominante è musulmana di rito sunnita. La
lingua è indoeuropea della famiglia iranica, con tre grandi gruppi dialettali:
l’orientale, il settentrionale e l’occidentale; il lessico è caratterizzato da
numerosi prestiti dal persiano moderno e dall’arabo, questi ultimi quasi sempre
per il tramite del persiano o del turco. (Fonte: Treccani)
ISIS.
L’Isis è lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, spesso abbreviato in Is, ed
è un gruppo terroristico di natura jihadista guidato da Abu Bakr Al Baghdadi. Il
13 ottobre del 2006 venne annunciata la fondazione del Dawlat al Iraq
al-Islamiyah (Stato islamico dell’Iraq, Isi). Il 9 aprile 2013, dopo essersi
espanso in Siria, il gruppo adottò il nome di Stato Islamico dell’Iraq e del
Levante, conosciuto anche come Stato Islamico dell’Iraq e di al-Sham.Il nome
viene abbreviato in Isis o Isil. La s finale nell’acronimo Isis deriva dalla
parola araba Sham (or Shaam), che nel contesto di una jihad globale si riferisce
al Levante o alla Grande Siria. Il 14 maggio del 2014 il Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti ha annunciato la sua decisione di usare Islamic State of Iraq
and the Levant (Isil) come nome principale del gruppo ma a seconda dei paesi e
della traduzione vengono usati acronimi diversi (EI, IS, ecc). L’equivalente
arabo, Al dawla al islamiya fi al Iraq wal Sham, può essere abbreviato in Daesh.
Isis segue un’interpretazione estremamente anti-occidentale dell’Islam, promuove
la violenza religiosa e considera coloro che non concordano con la sua
interpretazione come infedeli e apostati. Allo stesso tempo mira a fondare uno
stato islamista orientato al salafismo (vedi sotto) in Iraq, Siria e altre parti
del levante.
JIHAD.
Questa parola araba significa
esercitare il massimo sforzo. Si riferisce a una delle istituzioni fondamentali
dell’Islam e compare in 23 versi del Corano, il testo sacro per i musulmani.
Anche se si discute molto sulla sua vera interpretazione, negli ultimi decenni,
le scuole coraniche concordano sul fatto che il concetto di Jihad implichi una
battaglia contro i persecutori e gli oppressori. Si distingue dunque tra una
concezione difensiva, come era tradizionalmente intesa, e una invece offensiva
del concetto, propria degli ambienti radicali.
PESHMERGA.
In lingua curda indica un
combattente guerrigliero che intende battersi fino alla morte. Il nome è stato
ugualmente usato per una parte dei combattenti autonomisti e indipendentisti
curdi in Iraq, appartenenti al Partito Democratico del Kurdistan. In
particolare, Peshmerga è il nome ufficiale delle forze armate del Governo
Regionale del Kurdistan nella regione semiautonoma (a tutto agosto 2014) del
Kurdistan iracheno. Queste forze si sono in passato scontrate con i militanti
dell’Unione Patriottica del Kurdistan (ed anche al Partito dei lavoratori del
Kurdistan turco, presente nella parte nord dell’Iraq) e con i guerriglieri
islamisti di Ansar al Islam; sempre nell’agosto 2014, alcuni battaglioni della
milizia peshmerga sono stati integrati nella Guardia Nazionale Irachena, e sono
parte della nuova 2a divisione irachena, di base a Mossul. La storia di questi
combattenti è però molto più antica: i peshmerga sono stati attivi nei vari
sconvolgimenti della storia dell’Iraq dalla sua indipendenza, nella guerra
Iran-Iraq, nella prima e nella seconda guerra del golfo. Durante le guerre del
Golfo hanno cooperato con le forze speciali dell’Alleanza contro Saddam Hussein,
salvando vari piloti e incursori sul loro territorio, e tenendo occupato
l’intero V corpo iracheno nel 2003 a nord, impedendogli di schierarsi contro le
forze alleate a sud. Hanno avuto e hanno proprie forze speciali, al 2014 in
parte amalgamate con l’esercito iracheno. Il termine peshmerga indica anche i
combattenti pathani(pashtun) lungo la frontiera dell’Afghanistan.
SALAFISMO.
È una scuola di pensiero sunnita che prende il nome dal termine arabo salaf
al-salihin (“i pii antenati”) che identifica le prime tre generazioni di
musulmani (VII-VIII secolo) considerati - dai salafiti - dei modelli esemplari
di virtù religiosa. I primi segnali evidenti, e ufficiali, del mutamento
ideologico e strategico del Salafismo, da movimento “riformista” e tollerante a
movimento “fondamentalista”, si possono forse riscontrare in Tunisia, verso gli
anni trenta del XX secolo. In Egitto, la trasformazione del Salafismo avvenne
nello stesso periodo, con l’avvento della cosiddetta “Neo-Salafiyya”.
SCIITI E SUNNITI.
Come ha spiegato Roberto Tottoli sul Corriere della Sera,
la divisione tra sunniti e sciiti risale alla morte del profeta Maometto nel 632
d.C. Per il «partito di Alì», in arabo shi’at ‘Ali, da cui deriva il nome
«sciiti», il legittimo successore di Maometto doveva essere ‘Ali, suo genero. E
dopo di lui dovevano regnare i suoi discendenti con il titolo di imam. Ma la
questione della successione non fu solo politica: per gli sciiti gli imam erano
e sono una guida anche religiosa. Per i sunniti, invece, i primi sovrani,
chiamati «califfi», furono scelti tra i compagni di Maometto, senza alcun ruolo
religioso ma solo con il dovere di garantire l’ideale unità della comunità. Nel
corso dei secoli il sunnismo è stato la via seguita dalla stragrande maggioranza
dei musulmani, mentre lo sciismo si è a sua volta frantumato in svariate sette
circoscritte ad alcune regioni.
SHARIA.
Legge sacra dell’islam, qual è
dedotta dai quattro ‘fondamenti del diritto’: il Corano, la sunna o consuetudine
del Profeta, il consenso della comunità musulmana, e il qiyās o deduzione
analogica. Si distinguono nella s. le norme riguardanti il culto e gli obblighi
rituali da quelle di natura giuridica e politica. Le varie prescrizioni del
diritto musulmano sono suddivise dai Sunniti in ‛ibādāt, le pratiche del culto,
e mu‛amalāt, il modo d’agire verso gli altri. In alcuni Stati islamici la s. può
essere considerata legge civile e penale. (Fonte Treccani).
YAZIDI.
Popolo di origine curda,
costituito da circa 300 mila persone. Il gruppo principale, costituito da 150
mila yazidi, vive in due aree dell’Iraq: i monti del Gebel Singiar (al confine
con la Siria) e i distretti di Badinan (o Shaykhan) e Dohuk (nord-ovest del
Paese). Il nord-ovest dell’Iraq è l’area originaria del popolo yazidi, insieme
all’Anatolia sud-orientale (province di Diyarbakir e Mardin). Sbagliato è
trattare gli yazidi come gruppo entico. La parola va riferita infatti a una
specifica religione, combinazione sincretistica di zoroastrismo, manicheismo,
ebraismo e cristianesimo nestoriano sui quali sono stati successivamente
aggiunti elementi islamici sciiti e sufi. Sono stati perseguitati da Isis, oltre
5 mila donne yazide sono state rapite e ridotte in schiavitù dai jihadisti dopo
la caduta di Sinjar.
La differenza tra sunniti e
sciiti. Di
Giordano Stabile, Ugo Leo e Samuele Pozzato su “La Stampa”.
Le sanguinose guerre in corso
in Siria, Iraq, Yemen e altri Paesi musulmani nascono da due visioni, quella
sunnita e quella sciita, islamiche che si confrontano da 1400 anni. Il punto
cruciale della discordia è su chi sia e che ruolo debba avere il khalifa, il
califfo, cioè il successore di Maometto. Tutto comincia l’imam Hussein,
considerato dagli sciiti vero erede del Profeta ma trucidato nel 680 a Karbala,
in Iraq.
Il profeta e il califfo.
1) Maometto, Muhammad (570-632
dopo Cristo), per i musulmani è il Profeta incaricato da Dio (Allah) di
diffondere la sua Parola, il Corano. Nomina califfo (khalifa, successore) Abu
Bakr, uno dei primi compagni. I sunniti aderiscono a questa linea di
successione.
2) Gli sciiti non riconoscono
come successore Abu Bakr ma Ali, cugino e genero di Maometto.
Origine del nome.
1) Il nome sunnita viene da
sunna, la tradizione dei detti (ahadith) di Maometto.
2) Il nome sciita viene da
Shiat Ali, «Partito di Ali”.
Pilastri del culto.
1) Per i sunniti sono 5: la
testimonianza di fede, al-shahada; la preghiera rituale, al-salah; l’elemosina
canonica, al-zakah; il digiuno durante il Ramadan, sawm; il pellegrinaggio a
Mecca, hajj.
2) Nello sciismo ci sono 10
pilastri: fra gli altri, la tawalla, esprimere l’amore per il bene; tabarra,
esprimere odio per il male.
Atteggiamento nella
preghiera.
1) I sunniti pregano con le
mani congiunte all’altezza del diaframma. Per la Professione di fede si ripete
la formula: «Testimonio che non c’è divinità se non Iddio, e Muhammad è il suo
Profeta». È la frase che vediamo anche sulle bandiere dell’Isis.
2) Alla shahada gli sciiti
aggiungono «e Ali ibn Abi Talib è amico di Dio». Gli sciiti pregano con le mani
in parallelo rispetto al corpo, davanti alle cosce. Finisce pronunciando tre
volte il takbir («Allahu akbar).
Feste.
1) I sunniti celebrano solo
due feste: Eid al-Fitr, che segna la fine del mese di digiuno, e la Eid al-Adha,
festa del sacrificio, alla fine del pellegrinaggio (hajj) alla Mecca.
2) Gli sciiti festeggiano in
particolare l’Ashura, in cui viene ricordato il martirio di Hussayn a Karbala.
Cibi e bevande.
1) Vietata la carne di maiale
e l’alcol.
2) Non ci sono differenze con
il sunnismo.
Velo islamico.
1) L’uso del velo è
obbligatorio in base a due sure del Corano. Ma le versioni più rigide, come
niqab e burqa sono diffuse in Paesi sunniti come l’Afghanistan.
2) In Iran, il più grande
Paese sciita, il velo più usato è lo hijab.
Diffusione.
1) La maggior parte dei
musulmani è sunnita, l’80% del totale.
2) Il 15% dei musulmani è
costituito da sciiti. Lo sciismo è diffuso in Iran (90%), Iraq (55%), Pakistan
(20%), Arabia Saudita (15%), Bahrein (70%), Libano (27%), Yemen (50%), Siria
(15%).
Clero.
1) Fra i sunniti non c’è
clero. L’imam è colui che guida la preghiera.
2) Lo sciismo ha un clero
organizzato, preparato in università specifiche di scienze islamiche.
I motivi per cui Cristiani
e Islamici non adorano lo stesso Dio - l'eresia dell'Onnivolenza divina.
Dio nel Cristianesimo è Trinitario, nell' Islam no. La base unitaria delle
religioni monoteiste (ebraica, mussulmana, cattolica) è la Sacra Bibbia. Fonte
di un Dio tutto da interpretare. Le differenze in loro le scopri nei loro
profeti. Nell’Ebraismo manca; nell’Islam c’è Maometto, profeta di guerra; nel
cristianesimo c’è Gesù Cristo, considerato dai cattolici figlio di Dio e Dio al
contempo. Non si può negare che sia un Dio o un Profeta di pace. Diverso dal Dio
del Vecchio Testamento. "Allah o Gesù, cosa cambia? In fondo è lo stesso Dio!"
Il problema è che non è affatto lo stesso Dio. I motivi sono molteplici ma per
uno studio più approfondito rimando alla splendido documento firmato dall'allora
cardinale Ratzinger dal titolo "Dominus Iesus" dell'anno 2000. Qui mi limiterò a
spiegare quella che secondo la visione islamica è una caratteristica del divino
e che invece per il Credo cattolico e' semplicemente un'eresia dalle conseguenze
inaudite. Intendo parlare brevemente dell'Onnivolenza divina secondo l'Islam.
Secondo gli Islamici Dio è onnivolente, cioè, in parole povere, può comandare
ciò che vuole e ciò che comanda e' bene e va fatto. Dove sta il problema? Il
problema sta in quello che anche Papa Benedetto XVI descrisse nel suo famoso
discorso di Ratisbona (a cui rimando per comprendere meglio il discorso che sto
facendo): non è vero che una cosa e buona perché Dio dice che è buona, ma una
cosa e' buona quindi Dio dice che quella cosa e' buona. Mi spiego meglio: se
domani Allah comandasse di uccidere nel suo nome, anche se l'omicidio è un male,
questo diventa un bene perché Allah dice che in quel caso è un bene. Questa cosa
non è condivisa dal credo cattolico che parla di un Dio onnipotente,
onnisciente, ma non onnivolente. La Chiesa, seguendo il pensiero
platonico-socratico, ha sempre creduto che il bene e il male siano realtà
oggettive, non dipendenti dall'arbitrio umano ne dall'arbitro divino. Il Dio
cristiano indica la strada dei comandamenti come la strada del bene e questa
strada non potrà mai cambiare o essere modificata perché il bene indicato da Dio
non è tale perché Lui lo indica come bene, ma è in se bene e di conseguenza Dio
lo indica, perché desidera che l'uomo segua la via del bene. In questo senso il
pensiero islamico si distanzia in modo determinante dal pensiero cattolico.
Comprendiamo bene perché in quel discorso di Ratisbona il Santo Padre ha
insistito sul fatto che "agire contro la ragione è contrario all'agire di Dio".
Con queste parole riaffermo' proprio questo concetto. Il bene e il male sono
fatti oggettivi, non modificabili secondo l'arbitro umano, ne secondo un
presunto arbitrio divino. Dio ha indicato qual è la via del bene e qual è la via
del male e queste vie non potranno mai cambiare. Le conseguenze di questo sono
facilmente comprensibili: Dio non solo non comanda di uccidere, ma non può
comandare di uccidere perché uccidere è un male in se'. Il dio islamico invece
può anche comandare di uccidere e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Attenzione quando si afferma che il dio islamico e lo stesso Dio dei cristiani,
perché questo non è - per il motivo che ho descritto e per molti altri descritti
nei documenti sopra citati - assolutamente vero. D Cristiano M.G.
«Con la venuta di Gesù Cristo
salvatore, Dio ha voluto che la Chiesa da Lui fondata fosse lo strumento per la
salvezza di tutta l'umanità (cf. At 17,30-31). Questa verità di fede niente
toglie al fatto che la Chiesa consideri le religioni del mondo con sincero
rispetto, ma nel contempo esclude radicalmente quella mentalità indifferentista
«improntata a un relativismo religioso che porta a ritenere che “una religione
vale l'altra”». Se è vero che i seguaci delle altre religioni possono ricevere
la grazia divina, è pure certo che oggettivamente si trovano in una situazione
gravemente deficitaria se paragonata a quella di coloro che, nella Chiesa, hanno
la pienezza dei mezzi salvifici. Tuttavia occorre ricordare « a tutti i figli
della Chiesa che la loro particolare condizione non va ascritta ai loro meriti,
ma ad una speciale grazia di Cristo; se non vi corrispondono col pensiero, con
le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più
severamente giudicati ». Si comprende quindi che, seguendo il mandato del
Signore (cf. Mt 28,19-20) e come esigenza dell'amore a tutti gli uomini, la
Chiesa «annuncia, ed è tenuta ad annunciare, incessantemente Cristo che è “la
via, la verità e la vita” (Gv 14,6), in cui gli uomini trovano la pienezza della
vita religiosa e nel quale Dio ha riconciliato a sé tutte le cose» (Dominus
Iesus n°22).
Il documento a firma del card.
Ratzinger fu approvato da Papa Giovanni Paolo II e da lui fu ordinata la
pubblicazione e la diffusione.
INTELLETTUALI A SCARTAMENTO
RIDOTTO.
Perchè su Matteo Renzi gli
intellettuali italiani stanno zitti? In
prima linea contro il berlusconismo, oggi gli intellettuali tacciono imbarazzati
di fronte al giovane premier. E lasciano il monopolio della critica alla
generazione dei “vecchi”, scrive Marco Damilano il 29 dicembre 2015 su
“L'Espresso”. Parlo all’Italia
riformista. Perché stiamo perdonando a Matteo Renzi quello che non perdonavamo a
Silvio Berlusconi? Che cosa ci sta portando a fermarci?». La voce di Roberto
Saviano su repubblica.it risuonava su smartphone e tablet nel pomeriggio di
venerdì 11 dicembre a Firenze nella grande ex stazione Leopolda che si preparava
ad accogliere il popolo renziano per il raduno annuale. Lo scrittore attaccava
«una struttura politica che ha compiuto l’ennesimo atto autoritario», il
«conflitto di interessi» del ministro Maria Elena Boschi, figlia dell’ex
vice-presidente della Banca Etruria oggetto di un decreto del governo. Un
crescendo che, il giorno dopo, arrivava a definire la Leopolda «un’accolita che
difende i malversatori». Ma esaurita l’indignazione di giornata del cerchio
magico del premier contro le parole dello scrittore, bisogna riprendere il
j’accuse di Saviano che va ben al di là della singola questione, chiama in causa
il diritto di critica, «che non può essere considerato un impiccio», e il
rapporto degli intellettuali con il nuovo principe venuto da Rignano.
Nell’Italia di Matteo Renzi il ruolo di teste pensanti della sinistra sembra
passato dai topi di biblioteca ad attori e teatranti. Scrittori, registi,
sceneggiatori, opinionisti solitamente impegnati. In prima fila nella firma di
appelli e manifesti. Pronti a ingaggiare il corpo a corpo delle idee. Sul palco,
in piazza, sui giornali. Con parole e opere: romanzi, film, canzoni, articoli. E
ora, invece, stretti tra due accuse. Quella di Renzi e dei suoi laudatori,
secondo cui le voci di dissenso sarebbero in blocco «professoroni, gufi,
professionisti della rassegnazione». «Un giorno si parlerà finalmente delle
responsabilità delle élite culturali nella crisi italiana: professori,
editorialisti, opinionisti non sono senza colpe», disse il premier a
“Repubblica” dopo pochi mesi di governo, il 4 agosto 2014. «Siamo gli unici che
vogliono bene all’Italia, contro il disfattismo e il nichilismo, contro chi
sfoga la sua frustrazione nelle polemiche», ha replicato, senza nominarlo, a
Saviano dal palco della Leopolda. E c’è, sul versante opposto, la seconda
accusa, non meno bruciante, quella avanzata dall’autore di “Gomorra”. La
timidezza verso il nuovo potere renziano nell’ambiente culturale «riformista».
Gli intellettuali di sinistra che furono in prima fila negli anni del
berlusconismo. E che ora appaiono svogliati. Ritrosi a schierarsi. Ritirati nei
propri quartieri. Taciturni. In silenzio. Forse imbarazzati, di certo confusi.
Per loro stessa ammissione. «Renzi è di sinistra? Diciamo che, come Margherita
dice in “Mia madre”, anch’io sono confuso in questa fase e preferisco tacere,
piuttosto che dire cose generiche o banali… Sono contento se il governo è di
centrosinistra, facendo però davvero riforme di centrosinistra. Ma ripeto: in
questo periodo sono confuso e preferisco non dire cose a caso». Nanni
Moretti ha interrotto di recente con un’intervista a “Oggi” e poi a “Le
Monde” la sua distanza dalla politica. Per testimoniare, però, che in questa
fase è meglio restare zitti piuttosto che parlare per non dire nulla. Eppure per
decenni Moretti ha portato sul grande schermo la crisi del Pci e della sinistra,
da “Palombella Rossa” a “Aprile”, gli psicodrammi di militanti, dirigenti,
semplici elettori, con le lettere mai spedite ai leader di partito.
L’interpretazione del ministro socialista Botero in “Il portaborse” di Daniele
Luchetti all’inizio degli anni ’90 anticipò Tangentopoli. E poi “Il Caimano”
(2006) su Berlusconi e il conformismo di stampa e televisioni. E soprattutto la
stagione dei girotondi, tra il 2002 e il 2003, quando il regista accettò di
guidare un movimento e finì per assumere la leadership dell’anti-berlusconismo
in un momento di debolezza politica dei partiti di centro-sinistra. Ora è un
altro momento. Di confusione. E perfino, per i cinquantenni-sessantenni coetanei
di Moretti, di un sottile senso di colpa. «A me Renzi sta antipatico, non mi
sento contiguo alla Leopolda, ma mi sono supremamente rotto le scatole di quello
che ha fatto la mia generazione in politica», ha detto la settimana scorsa Michele
Serra in tv a “Otto e mezzo”. In continuità con quanto l’ex direttore di
“Cuore” aveva scritto su “l’Espresso” (11 maggio 2015): «Non esisterebbe Renzi
se non fosse esistita, prima, una lunga stagione di impotenza. Matteo Renzi è il
figlio più rappresentativo della crisi della democrazia italiana e più ancora
della paralisi della società italiana. Chi lo critica ha quasi sempre ragione,
ma alle spalle di quasi ogni critica c’è il sospetto inevitabile della
conservazione. E se Renzi è quello che è, la colpa non è tutta sua». De te
fabula narratur: non è colpa di Matteo, e forse neppure del tutto merito suo, se
con facilità impressionante ha conquistato il potere, scalato la sinistra,
polverizzato i riferimenti culturali del passato, sgretolato il pantheon dei
miti fondativi. Colpa di chi l’ha preceduto, dei dirigenti antichi e
inamovibili, dei padri nobili che in ogni cambiamento hanno avvertito,
sospettosi, l’ombra della fuoriuscita dal patto costituzionale su cui si è
costruita la Repubblica e sono cresciute le culture politiche dei partiti, più
forti e resistenti delle ideologie. Il grande silenzio, come si intitolava il
libro-intervista sugli intellettuali di Alberto Asor Rosa con Simonetta Fiori
(Laterza, 2010), sembra essere la reazione di una certa generazione e di una
certa cultura: quella che ha combattuto da sinistra negli anni Ottanta la
modernizzazione di Bettino Craxi, il rampantismo socialista e poi, naturalmente,
il berlusconismo trionfante. E che ora, dopo tante battaglie e molte sconfitte,
non se la sente più di intrecciare un conflitto anche con il premier
rottamatore. Anche perché, come dice Serra, «Renzi non è come Berlusconi». C’è
chi questo passaggio l’ha fatto con agilità e senza farsi troppi problemi: ad
esempio Francesco
Piccolo, sceneggiatore di Moretti, con “Il desiderio di essere come
tutti” (Einaudi, 2013), vincitore del premio Strega, uscito nei mesi in cui
Renzi dava l’assalto al vertice del Pd e poi a Palazzo Chigi, aveva già ben
rappresentato la felicità di un intellettuale di sinistra pronto a tuffarsi
nella nuova epoca. Sul versante
opposto, quello della critica, si schierano intellettuali di altre
generazioni e di altri filoni culturali, più azionisti che ex Pci. Sono loro i
«famigerati professoroni». Giuristi come Stefano
Rodotà o come Gustavo
Zagrebelsky, ex presidente della Corte costituzionale, che denuncia nel
suo ultimo libro “Moscacieca” (Laterza, 2015) «l’allergia per il pensiero non
allineato» e si spinge a comporre l’elogio del pessimismo contro la «leggera,
fatua, insulsa allegrezza che fluttua qua e là senza alcun costante e maturo
impegno per un’opera degna della parola politica». Professori come Asor
Rosa che attacca «la mutazione genetica» del Pd. E storici come Marco
Revelli: erano in tanti il 3 dicembre a discutere nella sede romana della
casa editrice Laterza il suo ultimo libro “Dentro e contro”, una delle più
compiute requisitorie contro il sistema renziano. Seminario ad alta tensione,
con uno scontro senza ipocrisie tra l’autore e il giurista Sabino Cassese, ex
giudice della Corte costituzionale, difensore delle riforme del governo Renzi.
Perché in questi mondi l’atteggiamento da tenere nei confronti del premier
spacca, divide. Renzi, nelle pagine di Revelli, è descritto come Callicle,
piccolo filosofo ateniese del V secolo a.C., «archetipo di quel disprezzo per la
conoscenza e per i sapienti che ritornerà infinite volte nelle zone grigie della
storia». Un modello di potere post-democratico nell’Europa attraversata dai
populisti: «L’Italia danza sull’abisso, nelle mani di un funambolo che cammina
sulla fune senza rete. E tutti lì sotto, con il naso in aria, a gridare di
accelerare». Tutti chi? Inutile cercare pensatori vecchio stile tra gli
intervenuti all’ultima edizione della Leopolda.
Nelle precedenti kermesse aveva colpito e affascinato la platea lo scrittore Alessandro
Baricco, con la sua narrazione popolata di spazi bianchi da riempire,
pezzi sulla scacchiera da muovere per primi, navi da bruciare alle spalle. Ma
questa volta non si è fatto vedere, né lui né altri artigiani dell’immaginario.
E non si trovano citazione di contemporanei nel discorso finale di Renzi, con
l’eccezione di Paolo
Sorrentino, fresco vincitore degli Efa di Berlino, l’Oscar europeo, il
regista prediletto dal premier. Forse perché almeno gli ultimi due titoli, “La
Grande Bellezza” e “Youth - La giovinezza”, sono involontariamente,
inconsciamente renziani. O forse perché, semplicemente, Sorrentino è un outsider
che vince, come sempre si rappresenta l’ex ragazzo di Rignano. Nell’ultima
edizione è stato lanciato il think tank che avrà il compito di formare la classe
dirigente di domani. A dirigere “Volta” sarà Giuliano
Da Empoli, presidente del Gabinetto Viesseux, già assessore alla Cultura
con Renzi sindaco, ritornato nell’orbita di Matteo dopo qualche dissidio. Il suo
“La prova del potere” (Mondadori, 2015) è il manifesto dei nati tra la fine
degli anni Sessanta e i Settanta del secolo scorso, «vaso di coccio tra due
generazioni di ferro, i nativi dell’ideologia e i nativi della tecnologia», i
quarantenni che traggono da questa debolezza la loro forza: i Sorrentino, i
Renzi e i Saviano, e già, c’è anche lui, l’irregolare scrittore diventato il
nemico del popolo nel raduno dell’ex stazione fiorentina. La generazione Renzi
raccolta da Christian
Rocca, direttore di “IL”, il mensile del “Sole 24-Ore” in “Non si può
tornare indietro” (Marsilio, 2015), in cui si ritrovano toni forse perfino più
renziani dell’originale che ha in odio qualsiasi ideologia, compresa
eventualmente la sua. C’è anche questo, la difficoltà per gli intellettuali di
professione di interloquire con un leader pragmatico, compiutamente post,
impossibile da incasellare in una definizione. Che per di più si agita su un
terreno di gioco, il confine della politica nazionale, con sempre minore
significato. In Francia gli intellettuali litigano e si dividono tra mondialisti
e identitari. In Italia il balcone è vuoto, come nell’ultima scena di “Habemus
papam”. Forse per questo Moretti è confuso. E anche gli altri non stanno tanto
bene.
Abbiamo tanto bisogno di un
Cesare Beccaria.
"L'arte della ricchezza" di Carlo Scognamiglio Pasini svela il lato "economico"
del grande giurista e filosofo, scrive
Vittorio Feltri Martedì
29/12/2015 su “Il Giornale”. Ho letto un libro su Cesare Beccaria (1738-1794) da
cui ho imparato che cosa è Milano, e che cosa potrebbe diventare anche adesso,
se ascoltasse lo spirito illuminista che dorme in qualche posto della sua testa,
forse intorpidito dalle polveri sottili della scemenza. Lo ha scritto Carlo
Scognamiglio Pasini, il quale è uno dei pochi ad avere due cognomi ben spesi, e
lo dimostra anche stavolta. Questo volume, che ha la densità di un testo
accademico e la prosa avvincente di un Bertrand Russell, propone la genialità di
Beccaria immersa nella vita intellettuale e politica e persino pettegola della
Milano del Settecento, a me assolutamente sconosciuta ed invece attualissima, ma
ripropone anche la figura di Scognamiglio che avrebbe molto da dire alla storia
di questa città, questo però lo vedremo dopo. Il libro si intitola L'arte della
ricchezza. Cesare Beccaria economista (Mondadori Università, pagg. 328, euro
22). Beccaria è famoso giustamente come autore di Dei delitti e delle pene. Lo
finì che aveva 26 anni. Era il massimo che si potesse scrivere e pensare sul
tema, ed ha fama mondiale. Sono 85 pagine d'oro. Ed infatti in Italia lo si
cita, ma l'idea illuministica di giustizia che intesse quelle pagine arricchisce
le biblioteche e i convegni ma non la pratica dei tribunali e delle carceri.
Scognamiglio va oltre. Che successe a Beccaria dopo quel capolavoro? A ventisei
anni, Beccaria smise di fare il giurista, e provò a trasferire i principî
illuministici che aveva attinto dai francesi Voltaire ed Helvetius e dagli
inglesi Locke e Hume all'economia e al pensiero sociale. Nessuno cita
alcun'altra opera di lui, salvo che negli ambienti dei dotti. Eppure, ci fa
sapere il professore già presidente del Senato, oltre che giurista, il marchese
Beccaria è considerato uno dei massimi economisti della storia, e non da autori
avvezzi al campanilismo nostrano, ma da luminari come Joseph Schumpeter. Nella
personale classifica di Scognamiglio, che vede ai primi posti appaiati Adam
Smith e John Maynard Keynes, il nonno di Manzoni (tale fu Beccaria) viene subito
dopo. Aveva capito tutto. E cioè, anticipando Smith, aveva compreso che la
ricchezza delle nazioni non sta nel patrimonio che consente rendite anche
cospicue, ma nel lavoro, nella capacità di movimentare i commerci. Insomma:
Beccaria è stato un grande pensatore liberale. Liberale e milanese. Liberale e
lombardo. Aveva capito anche che la questione della «moneta» è essenziale. La
teoria monetaria non è qualcosa di incomprensibile, ma uno strumento per dare
ricchezza e felicità a tutti. Espose le sue teorie in lezioni di economia
politica destinate ai futuri funzionari dello Stato di Milano (un governatorato
all'interno dell'impero austriaco, con circa un milione e trecentomila
abitanti). Le sue tesi, gradite a Vienna, che voleva la prosperità dei popoli
governati nei suoi confini, erano invece piuttosto invise ai patrizi milanesi,
che tenevano molto a caste e corporazioni, di cui erano l'emblema. Dovette
mollare la cattedra, e non poté o non volle pubblicare il libro che raccoglieva
le sue lezioni di docente non ancora trentenne. Uscirono dieci anni dopo la sua
morte, nel 1804. Pare che non amasse le grane, del resto, quando per gioco gli
chiesero cosa avrebbe voluto scrivere sulla sua tomba, compitò in latino: Vitam
minus ambitiose Quam Tranquille vixit (Visse la vita tranquillamente, senza alte
ambizioni). Non è che non fece nulla: scrisse opere filosofiche e di scienza.
Fece il burocrate dell'amministrazione dello Stato, scrisse moltissime
disposizioni, e fece star bene il popolo lombardo. Aveva infatti questa idea del
bene comune come compito dell'attività politica e di governo: «La condotta
migliore è quella che permette di raggiungere la massima felicità per il maggior
numero di persone». Qui non ho nessuna intenzione di esporre le tesi
rivoluzionarie di Beccaria riscoperte da Scognamiglio: le sciuperei. Mi limito a
descrivere l'ambiente dove sono nate. Milano a quel tempo era una fucina di
idee, una culla di vita geniale. I giovinotti dopo studi severi dai barnabiti e
dai gesuiti, magari uscivano piuttosto atei o poco cattolici, ma sapevano
forgiare il progetto di mondi nuovi. Si trovavano a leggere e a commentare le
opere nuove che arrivavano dalle università inglesi o dai circoli parigini. Dei
delitti e delle pene non germinò da studi solitari ma dall'appartenere insieme
all'Accademia dei pugni, dove c'erano i fratelli Verri, capeggiati dal maggiore
di loro e capo della combriccola, Pietro, Luigi Lambertenghi, Giambattista
Biffi, l'Abate Longo. Non disdegnavano le ragazze, talvolta vere e proprie
ninfe, che portavano idee, leggevano e discutevano Shakespeare e Rousseau,
Voltaire e Hume. Beccaria era considerato un genio matematico e poetico, fu
vittima di dileggi come uomo pigro, Verri si dilettò con la di lui moglie,
circolavano pettegolezzi, e formule algebriche. A Parigi questa brigata era
rinomata, Beccaria era conteso da Caterina di Russia che lo voleva come
consulente. Milano è questa cosa qui. E questi intellettuali (da cui nacque il
famoso Caffè) non erano ricamatori di follie o di astrazioni, ma non erano
neanche gli utopisti francesi delle ghigliottine o del comunismo come Marx, che
tante morti hanno causato, ma riformatori, sburocratizzatori, al servizio del
benessere semplice del pragmatismo lombardo. Milano però era un piccolo Stato
per nulla indipendente, l'Italia non esisteva, era frantumata, il laboratorio
milanese non contagiò la penisola. La caratteristica di questa cultura
dell'illuminismo milanese, che Scognamiglio racconta come un'avventura di teste
e di sentimenti, è che teneva insieme scienza e umanesimo. Ciò che è stata poi
la caratteristica anche del Politecnico di Carlo Cattaneo e delle sue idee
federaliste...Dicevo di Scognamiglio. Come Beccaria, è di una grande famiglia
milanese, ha condotto alti studi, ha inventato l'economia industriale in Italia
portandola qui dalla London School of Economics and Political Science. Ha
trasformato la Luiss da piccola università locale a faro europeo. Poi ha avuto
il torto di entrare in politica. Il suo guaio è che sopra di lui non c'era Maria
Teresa d'Austria. La Milano che racconta, quella di Beccaria e Verri, dei
giovani che amavano la matematica e le belle donne, il lavoro e i pensieri
guardando la Madonnina; quella Milano è la sua, in fondo è lui. A suo tempo,
chiamato dopo il disastro di Tassan Din, risanò finanziariamente e politicamente
il Corriere, insediando Piero Ostellino come direttore. Riassunse anche me. Ma
dei danni che ho fatto, nessuno gliene faccia una colpa.
Ma quanto si chiacchiera di
politica nel mondo dello spettacolo.
Nell’Italia di Matteo Renzi il
ruolo di teste pensanti della sinistra sembra passato dai topi di biblioteca ad
attori e teatranti, scrive Angiola Codacci-Pisanelli il 29 dicembre 2015 su
“L’Espresso”. Per un Nanni
Moretti che sceglie il silenzio, ci sono mille personaggi del mondo dello
spettacolo che non perdono occasione per «dire qualcosa di sinistra». Tanto che
nell’Italia di Matteo Renzi il ruolo di teste pensanti della sinistra sembra
passato dai topi di biblioteca ad attori e teatranti appena scesi dal mitico
Carro di Tespi, quello che secondo Orazio segnò la nascita dello spettacolo. «Se
davvero l’Italia sta ripartendo io vorrei sapere dove va», ha detto Valerio
Mastandrea presentando al festival di Torino “La felicità è un sistema
complesso”, dove interpreta un cacciatore di teste che spinge le aziende verso
la chiusura. Una stoccata all’ottimismo di tante dichiarazioni, slogan e hashtag
renziani che non arriva come una sorpresa da parte dell’attore romano, da sempre
in prima linea nel difendere centri sociali o occupazioni in nome della cultura,
dal Teatro Valle al Cinema America. In prima linea contro il berlusconismo, oggi
gli intellettuali tacciono imbarazzati di fronte al giovane premier. E lasciano
il monopolio della critica alla generazione dei “vecchi”. In molte di queste
battaglie lo affianca Elio
Germano, che l’anno scorso ha salutato con il pugno chiuso presentando
“Il giovane favoloso” alla Mostra di Venezia. Quest’anno proprio dal red carpet
veneziano partiva un’iniziativa molto “di sinistra”, la “Marcia degli Scalzi”
che ha coinvolto migliaia di persone e 60 città italiane per solidarietà con i
migranti. Con Mastandrea e Germano, ad appoggiare l’iniziativa c’erano anche
Jasmine Trinca, Ettore
Scola e Marco
Bellocchio. Ma la trasferta veneziana non inganni: lo zoccolo duro
cinematografaro della sinistra critica è radicato a Roma. È partito da qui
l’appello «contro la pratica dell’utero in affitto» che ha fatto tanto scalpore
proprio perché visto come un attacco da sinistra al progetto di legge sulle
unioni civili. Tra i 120 firmatari ci sono Stefania Sandrelli, Giovanni Soldati,
Fabrizio Gifuni, Claudia Gerini, Cristina Comencini, Claudio Amendola, Ricky
Tognazzi, Simona Izzo, Micaela Ramazzotti...La mappa della Roma impegnata nei
mesi scorsi si è allargata: alla Garbatella di Mastandrea e al Pigneto di
Germano si è aggiunta Trastevere con Alessandro
Gassmann. Del resto, a far esplodere il protagonismo degli attori è stata
anche la vicenda Marino. In piena crisi Gassmann, con il suo invito ai romani a
smettere di lamentarsi e rimboccarsi le maniche per ripulire la città, è stato
uno dei primi a spingere per un appoggio concreto e quotidiano a una giunta
impantanata nel tentativo di affrontare i problemi più grandi, dalla
mega-discarica alla corruzione al buco di bilancio. Quando poi la vicenda è
finita con la decisione clamorosa del Pd di trascinare consiglieri propri e
dell’opposizione a firmare dimissioni irrevocabili davanti a un notaio, tra le
voci che si sono alzate quelle degli uomini di spettacolo sono state le prime e
le più forti, se non le sole. Con Nicola
Piovani che scrive a “Repubblica” («Non è sospetto il linciaggio
mediatico subito da Marino?»), Gassmann che rimpiange il sindaco via Twitter
(«Saluto Ignazio Marino nel momento in cui non lo saluta nessuno») e
Sabrina Ferilli che promette: «Se ritira le dimissioni ballo il tango per
una notte intera». Lei che ha presentato anche il suo film “Io & Lei” come una
scossa al governo sul tema dei diritti dei gay: «Certo che è un film politico.
Perché qui abbiamo a che fare con la rivendicazione dei diritti di persone alle
quali non viene riconosciuto il fatto di essere coppia, il matrimonio o la
possibilità di assistere il proprio compagno in ospedale». Non ha niente a che
vedere con Roma, invece, l’impegno diToni
Servillo, che si è speso per i lavoratori di Pomigliano d’Arco. «Non è
assistenza sociale, ma è condivisione e solidarietà», ha spiegato presentando il
reading “Toni Servillo legge Napoli”, del 31 ottobre scorso: l’intero incasso è
andato a un fondo di solidarietà per disoccupati, precari e cassintegrati. Una
presa di posizione “di sinistra” basata sui fatti e non sulle parole. Del resto,
come ha detto Mastandrea proprio all’“Espresso” nell’agosto del 2013, in
un’intervista molto critica sul governo del momento, quello di Enrico Letta:
«Non sono mica un intellettuale: dico le cose che penso e che mi escono
spontanee». Ecco: prima pensare, poi parlare “spontaneamente”, senza calcoli e
retropensieri. La prima cosa forse gli intellettuali di sinistra la sanno fare
ancora, ma è la seconda che proprio non gli viene più.
COSA NON VORREMMO PIU'
VEDERE IN TV.
Cara tv, ecco chi e cosa
non vorremmo più rivedere.
Dalle infinite prodezze di Matteo Salvini nei talk show alle risate tristissime
di "Colorado" e simili. Passando per Balivo, D'Urso e il solito Vespa, senza
dimenticare la litania dei talent all'ennesima edizione. Manuale spiccio di ciò
che è il caso di lasciarsi alle spalle, scrive Riccardo Bocca il 28 dicembre
2015 su “L’Espresso”.
L'immagine è estrema, spiazzante, definitiva. Sconcertante in un certo senso. Al
centro della tele-scena, tornando con il pensiero al 15 novembre, troviamo
madame Barbara D'Urso.
Nel cuore di Parigi due giorni prima è esploso l'inferno. Cellule terroristiche
hanno seminato per la città il cancro del panico e della morte di ragazzi
incolpevoli. L'Europa s'interroga sul suo presente e futuro incerti. Ovunque,
all'estero, prevalgono il cordoglio e l'analisi. Mentre in Italia non sempre è
la lucidità a prevalere; e non, in particolare, sotto i riflettori di Mediaset,
dove la mattatrice dello Speciale-Strage è la titolare in cattedra di “Domenica
Live”. Colei che nel curriculum personale ed emozionale vanta, accanto a una
serie di show evitabili, un'inesauribile collezione di smorfie e super smack al
pubblico. La strada (poco) maestra che le garantisce in automatico empatia e
ascolti. Dunque eccola, l'anchor-trash di casa Berlusconi, che con il piglio
delle occasioni speciali si rivolge così ad Angelino Alfano, capo del Viminale e
ospite in collegamento: «Ciao ministro!». E ancora: «Sai bene, ministro, che nel
Paese c'è grande allerta...». E ancora ancora: «Ho la possibilità di averti in
diretta, spiegaci: dobbiamo avere paura? E cosa farà il governo, per evitare che
abbiamo paura?». Non è stato soltanto il funerale del buongusto e della
professionalità, quel cicaleccio a base di “tu” e confidenza esondante: a
questo, in effetti, già si era abituati. È stato, invece, il crollo dell'ultimo
mattone di un muro: quello che fino a lì aveva diviso il contenitore delle somme
tragedie da quello delle somme farse. Mai il barnum di uno show basato sul
flusso delle Romine e Al Bani, di parenti di Alberto Sordi in conflitto furente
per l'eredità e di altri mille protagonisti del pop nostrano, si era elevato a
interprete di emergenze transnazionali. E dunque ora che è fine dicembre,
ripensando a quella giornata, e apparecchiando il tavolo delle aspettative per
il 2016, l'augurio da porgere ai televedenti è quello che tanta pochezza resti
nel passato, e non torni a palesarsi nei mesi a venire. D'altronde un tempo -
antico, in bianco e nero e da un pezzo svanito nel nulla - si usava a fine anno
scrivere articoli sul meglio della tv in arrivo. Usanza che oggi induce al
sollazzo e alla consapevolezza che la necessità è mutata. Nel senso che la
domanda chiave, adesso, corre in direzione opposta, e consiste nell'interrogarsi
su cosa si spera con tutta l'anima di non rivedere nella stagione entrante.
Quesito, va detto, tutt'altro che elementare. Perché il problema di base non sta
nella singola trasmissione, o nel dettaglio di una certa sera per via di un
certo conduttore. Il vero guaio, invece, consiste nella bugia più scaltra mai
messa in circolazione: cioè che i vertici delle principali televisioni abbiano
fame e smania di produrre programmi di qualità, aggiornando in sincrono il
panorama dell'immaginario pubblico. Un maremoto di retorica dietro al quale
spunta una verità più sincera e triste; che consiste, senza sforzi di fantasia,
nel fatto che l'unico impegno effettivo è quello di restare a galla. A qualsiasi
costo. Con qualunque formula e artificio. Persino spacciando al pianeta Terra il
prossimo ritorno del “Rischiatutto” ad opera di Fabio Fazio, non come un ammicco
strategico al club della nostalgia, ma quale nobile omaggio al grande Mike
Bongiorno. Che buio feroce. Che avvilimento cronico. Siamo qui tutti armati di
pinne, fucile ed occhiali (visto che anche la neve, a questo punto, è utopia)
per tuffarci nel 2016, e nella mente spuntano i tele-momenti che vorremmo
cancellare per sempre. Penso ad esempio, tra i brividi, al cumulo delle ospitate
concesse a Matteo
Salvini e alle sue geofelpe: in apparenza scelta dei talk show per
testimoniare l'ascesa dell'onda destroide, ma in sostanza scorciatoia per
acquisire share. Come quando in video, anche nel 2015, è apparsa in loop
Daniela Santanchè,
e pareva quasi d'udire sottotraccia il gaudio degli autori causa ascolti sicuri.
Per non parlare della serata in cui Corrado
Formigli, maestro di inchieste e reportage sul campo, forse mosso da
invidie per le vette raggiunte dalla "Quinta colonna" deldebbica e "La gabbia"
paragonica, ha scolpito su La7 i limiti di “Piazzapulita” lasciando che il
direttore Mario
Giordano e il filosofante
Massimo Cacciari si scannassero in allegria. «Mai più nel 2016!», è il
coro che tutti dovremmo intonare sotto l'albero, sperando che il bambinello
intanto non si turbi nel presepe accanto. E mai più, anche, sull'altro lato del
video-grottesco, vorrei ridere - anzi in effetti non ridere, ma stranirmi in
preda a rigetto da telecomando - per la sfilata degli show a base di risate a
cottimo. Quelli, per essere affettuosamente chiaro, che hanno avuto come padre e
madre lo “Zelig”
di Canale 5, killer dell'umorismo inteso quale elaborazione creativa, e paladini
invece di uno sghignazzo precox maturato nell'arco di tre minuti di sketch. Show
come “Colorado”,
insomma, di cui nessuna mancanza sentiremmo, e che ancora insistono a occupare
il telespazio italico con la furbesca scusa che «Sai, i giovani... a loro piace
questa roba... e poi fa premio sempre la semplicità». C'è la speranza vera,
concreta, che tutto questo diventi merce da archivio, e non prospettiva cronica
per l'anno e gli anni entranti? Posso chiedere, con la dovuta dolcezza e garbo,
di affidare a Caterina
Balivo la conduzione di un adventure-game sull'Everest (tempo di
lavorazione: dieci, quindici anni minimo) per non rischiare nel 2016 di
ritrovarla su Raidue alla guida di un altro “Monte Bianco”? E soprattutto: c'è
qualcosa che si può fare e scrivere per arginare il presenzialismo di
Bruno Vespa,
anche quest'anno premio Massimo Imbarazzo con la puntata di “Porta a Porta” sul
clan Casamonica,
e la promozione - questa sì, davvero porta a porta e trasmissione a trasmissione
- del suo tradizionale exploit saggistico? Temo che la risposta più onesta sia
composta dal matrimonio tra la lettera “n” e la sorella “o”. Inutile sperare che
il Meglio trionfi, o perlomeno che il Peggio si faccia da parte. Inutile pure
sperare che i mandanti del “Grande Fratello”, mossi da tardivo rimorso, la
smettano di recludere giovani umani nella Casa di Canale 5. Tale e tanta è
l'attenzione ai nuovi standard tecnologici, e ai prossimi equilibri tra le
multi-piattaforme, che ai colossi stanchi della tv generalista è sfuggito un
dettaglio: quello non secondario dei contenuti e di chi dovrebbe realizzarli in
azienda. Flop-format dopo flop-format, “Processo del lunedì” biscardiano dopo
“Processo del lunedì” varialesco, telequiz dopo telequiz, Sanremo
dopo Sanremo, Bonolis dopo Bonolis o Costanzo dopo Costanzo (per il 2015
addirittura in versione duplex: conduttore su Retequattro del salotto omonimo e
direttore artistico per Raiuno di “Domenica in”), l'unico futuro spendibile
resta nelle mani delle migliori serie:
di norma americane, ma anche europee ed italiche (da “Gomorra” a “1992”,
premiando l'impegno Sky). E queste sì che vorrei ancora (ri)vederle nel 2016.
Perché protette dall'ambiguità del falso, per definizione hard business del
ramo, riescono ancora ad azzannare la realtà. Sempre meglio dell'ennesima
edizione delle padelle-glam di “Masterchef”,
in corso con l'aggiunta del barbacuoco Cannavacciuolo, o della progressiva
plastificazione del miracolo (tele)visivo di “X Factor”: lunare, in quanto a
produzione e classe, ma privo del coraggio indispensabile per trasformarsi da
forma a sostanza.
Considerazioni di Riccardo
Bocca saccenti e comuniste?
Arbore: “Il
comunismo è stato un bluff”.
Intervista del 28/12/2015 di Francesco Sala su “Il Giornale”.
Nato a Roma il 16 settembre
73, regista, autore di teatro e tv, consulente artistico per diversi teatri di
produzione. Ha collaborato con il teatro Carcano di Milano, ass. “la terza isola
di Ivrea” fondazione Olivetti, teatro dell'Orologio e Brancaccio di Roma.
Docente di recitazione presso l'accademia La Fonderia delle arti di Roma. Ha
tenuto dei corsi tecnici come docente di istituzioni di regia presso il DAMS
Roma Tre. Copywriter freelance. Ha lavorato in Rai, Mediaset, Sky. Scrive su Il
Giornale Off.
Proprio nel trentennale di “Quelli della Notte” e nel suo
cinquantennale di carriera, celebrato
con una mostra al Macro Testaccio-La Pelanda di Roma, Renzo Arbore si racconta
ai lettori di OFF. Cognome: Arbore. Nome: Giovanni Lorenzo. Disc-jockey, autore,
regista, sceneggiatore, attore, showman, clarinettista. In una parola:
artista. La sua casa romana è una specie di Vittoriale Pop, traboccante di
ninnoli, carillon che suonano, foto epiche con dediche, libri, vinili; è
luminosa e colorata come lui. Abbiamo parlato di tutto: musica, improvvisazione,
televisione, poesia, donne, arte e orto: “Come sono difficili le melanzane,
vanno aiutate a crescere. I pomodori invece danno molte soddisfazioni”. Abbiamo
mantenuto il “lei” istituzionale a fatica.
Chi è un artista?
«Secondo
me l’artista ha un tassello in più dello scienziato, che è già il massimo della
scala. Il vero artista è un signore fuori ordinanza. Ha un vantaggio rispetto
agli altri mestieri: non è razionale. L’artista sfugge alle regole. Fontana fa
uno squarcio sulla tela ed è artista come Modugno che canta Lu pisci spada.
E siccome siamo in un’epoca di rottamazione voglio dire: l’artista è longevo!
Quando sento: “Questo lo rottamiamo, ha fatto il suo corso”, ebbene caro Renzi,
Presidente del Consiglio, nel mondo artistico non esiste la rottamazione. Io ho
imparato dagli artisti più vecchi di me: Roberto Murolo, Louis Armstrong, Totò,
Charlie Parker, Ruggero Orlando. Erano tutti più vecchi di me e sono stati tutti
miei maestri. Ancora oggi io guardo al passato. È un arricchimento spirituale,
di sapienza, saggezza. In arte non esiste vecchiaia. Alcuni sono spenti e vabbè…»
Il principale problema dell’artista è quello di essere accettato.
Da figlio di un medico e di una casalinga, com’è nata a Foggia la sua passione
per la musica?
«Foggia
è la città di Umberto Giordano. C’era una banda e tutto il pubblico, tutta la
gente di Foggia era melomane. I negozi avevano l’altoparlante e si sentiva
musica da tutte le parti. La città di Foggia nel’43 è stata severamente
bombardata. Tutti i muratori che ricostruivano la città, cantavano. Io sentivo
musica da tutte le parti. Mio padre era melomane, mia madre cantava le canzoni
napoletane, mia sorella era soprano. Quando io ho sentito il Jazz ho capito che
era molto più importante della canzonetta. Comprai una tromba, poi l’ho ceduta
in cambio di un clarinetto. Frequentavo un circolo che si chiamava Tre Bis. Ti
puoi immaginare il Tre Bis a Foggia! C’erano gli artisti della mia città. Io ho
sempre pensato: “Voglio fare l’artista, non voglio essere un figlio di papà con
l’Alfa Romeo”. Prima abbiamo fondato il Jazz College e poi la Taverna del Gufo,
un Cabaret dove venivano scritturati Roberto Benigni, Massimo Troisi, Carlo
Verdone, Enrico Montesano, Pippo Franco… io suonavo il clarinetto, facevo
Dixieland».
È vero che è stato il primo a mettere i jeans a Foggia?
«Sì.
Io ero molto appassionato delle mode americane. Sono sempre stato filoamericano.
Ero uno di quei ragazzini che chiedevano le gomme americane ai soldati alleati.
Appena arrivati a Napoli, i jeans, li ho presi e portati a Foggia. Mio padre
diceva: “Cosa sono questi, pantaloni da elettricista? Senza la piega!”»
Suo padre non aveva tutti i torti. Lei canterà poi… Mannaggia
a sti’ blue jeans!
«Le
lotte con i jeans stretti, molto più difficili da sfilare rispetto alle gonne
per le ragazze».
Si ricorda il primo amore?
«E certo.
Non si scorda mai davvero. Mi ha fatto soffrire ed è giusto che sia così. Mi ha
dato un carattere sentimentale, appassionato. Sono le emozioni che ti dà la
vita. Guai a non avere avuto dolori. Sarei un pirla come molti credono che io
sia… (ridiamo)»
Nei testi delle canzoni napoletane ci sono molti amori non
corrisposti. Un suo amore non corrisposto?
«Ci
sono stati amori non corrisposti con donne non famose. I testi delle canzoni
napoletane poi, sono i testi più belli del mondo, più poetici del mondo.
Soltanto in Messico ci sono testi altrettanto poetici. Le canzoni spagnole che
conosciamo, non sono né spagnole, né cubane, sono messicane! Paloma, La
storia di un amor, ecc… quando parlo con dei veri appassionati di canzoni
napoletane, mi commuovo e mi delizio. Non si trovano giovani artisti che amano
ancora la vera canzone napoletana. Chi canta oggi le canzoni napoletane antiche,
d’autore anzi? Chi? Tra i giovani? Il discorso potrebbe riguardare l’intera
canzone italiana. Io amo molto Francesco De Gregori, un vero poeta di ricordi,
di emozioni. Oggi le canzoni le usano i giornalisti. Mi tocca leggere Scalfari
che titola: Fatti più in là! Gaber, Endrigo, testi meravigliosi che
andrebbero studiati a scuola».
È cambiata Napoli? Io sono romanticamente ancorato a De Filippo,
ma c’è ancora la Napoli di Eduardo?
«Napoli
è cambiata, ma c’è ancora la Napoli che dici tu. Di Napoli si parla solo in
senso negativo. C’è la borghesia napoletana che purtroppo è silente. La
borghesia napoletana è ancora un’ottima borghesia: educata, elegante, frequenta
i teatri, però prende le distanze dalla Napoli eduardiana, non ne parla. C’è
stata una generazione -ne ho parlato con Raffaele La Capria – di grandi
borghesi: Rosi, Patroni Griffi… un’altra generazione che si è opposta alla
Napoli laurina, pittoresca, ecco che ha dominato una cultura egemone della
controreazione. Egemonia, a Napoli specialmente, egemonia culturale dei
comunisti!»
Ancora dicono: “Non ci piace o’ presepe!”
«Sì.
Qualcuno ha pure detto che Eduardo era piccolo borghese, ma ti rendi conto? La
Napoli per loro, per essere verace, deve essere quella della merda, della
povertà, della periferia e della suburra. C’è, ma c’è anche Salvatore Di
Giacomo! Ecco di Di Giacomo, questi qui, non ne vogliono sentir parlare».
Parliamo di donne se non le dispiace. Lei ha affinato negli anni,
una tecnica di seduzione?
«A parte
gli amori grandi, di cui non voglio parlare perché mi commuovo, ho avuto dei
grandi intervalli. Naturalmente venivo corteggiato da aspiranti modelle. Quando
non c’era colloquio tra me e una bellissima ragazza fotomodella friulana, il mio
amico Luciano De Crescenzo risolveva parlando lui e sfiniva quella poveretta
friulana che non si interessava alle sue avventure di guerra. Io mi rendevo
conto della noia di dovermi sciroppare i suoi racconti o i miei di repertorio.
De Crescenzo ha dichiarato: “Il sesso? Fatica tanta, piacere
breve, la posizione è ridicola”.
«(risata
contagiosa) È vero. La posizione è ridicola. Con De Crescenzo abbiamo parlato
molto di sesso…»
La nostra testata si chiama OFF. Un racconto Off a riguardo?
«Lo
sai come ci siamo conosciuti con Luciano De Crescenzo? Avevamo una fidanzatina
in comune. Una furbacchiona che manteneva i contatti tra me che stavo a
Sorrento, e lui che stava a Napoli. Il bello è che non lo sapevamo! Lo scoprimmo
dopo e diventammo amici! Cosa vuoi, con l’età si diventa più esigenti. Se c’è un
incoraggiamento da parte loro, va bene… il feeling intellettuale però è
importantissimo. La fotomodella friulana non va al cinema, a teatro, non legge,
sport niente, musica o politica neanche a parlarne. Arrampicarsi per cercare una
conversazione minima è triste. Con la fotomodella poi non c’è neanche la
gastronomia. Non mangiano la parmigiana di melanzane… Io le friulane le adoro,
intendiamoci, la mia bambinaia era friulana. La mia prima canzone era in
friulano, ma la fotomodella no, per favore!»
La canzone Io faccio o’show a chi era dedicata?
«A
una ragazza con cui ho avuto un breve ma succoso amore. E veramente l’ho scritta
in dieci minuti… con questa ragazza, della quale ero innamorato, andai a una
festa di amici, e come succedeva sempre, usciva fuori una chitarra e si cantava
e beveva. Questa ragazza a fine serata fa una sfuriata al mio migliore amico, mi
rimprovera di aver fatto o’ show! La mattina dopo chiamo Claudio Mattone e gli
racconto tutto. Lui mi fa :” Vediamoci subito!” A casa mia in dieci minuti è
uscita Io faccio o’ show! È autentica».
Come ha vissuto Renzo Arbore gli anni della contestazione del
Sessantotto?
«Dolorosamente.
Avevo amici sessantottini. Io non condividevo. Ero stato a Berlino Est. Avevo
visto la differenza. Le chiacchiere sul comunismo non mi convincevano per
niente. Il comunismo è stato un bluff! Raccontavano palle! Gli artisti che
arrivavano in Russia, in Unione Sovietica, raccontavano di repressione, censura.
Io sono sempre partito dalla libertà. Sopra il mio letto c’è un ritratto di
Abramo Lincoln. Confesso di essere a-comunista. Poi nel’68 ho sofferto molto per
le morti di poliziotti e magistrati. Quando ho fatto Speciale per voi c’erano
tutti i ragazzi divisi in categorie ideologiche di sinistra: i Sanbabilini…ecc,
in tribù».
È una domanda che ho fatto anche a Boncompagni: come vedevano i
dirigenti Rai le vostre improvvisazioni?
«Bisognava
dare il copione. Ad Alto gradimento lo abbiamo eliminato! Siamo riusciti
a dire: “Noi il copione non lo possiamo fare!”. I funzionari non volevano, ma
noi facevamo le cassette che poi mandavamo alla Siae».
È nata prima Domenica in o L’Altra domenica?
«Ecco
bravo. È nata prima L’Altra domenica. Domenica In è nata per contrastare
il successo nostro. Hanno visto che c’era una trasmissione che intratteneva il
pubblico, dalle due di pomeriggio alle otto, nella prima edizione io e Barendson
con Sport e Spettacolo. Abbiamo litigato col Tg2 che si mangiava le
nostre cose e abbiamo fatto la trasmissione dalle due alle cinque e mezza».
Come riconosce i suoi fan?
«Dai
capelli! Io per esempio, ti ho individuato subito, persino musicalmente. Vabbè
tu sei un caso raro, perché a quarant’anni ami il Jazz, ma la tua generazione è
dance music».
Io sono vintage.
«E ho
capito, sei anomalo. Ma quello di Bandiera Gialla ha settanta anni! Sono
i D’Agostino quelli che si sono formati con Bandiera Gialla e che erano
giovani. Tra i sostenitori avevo Renato Zero, la Bertè. Poi ci sono quelli di
Alto Gradimento, quelli di DOC come te, quelli di Indietro tutta,
vengono tutti ai miei concerti.»
E i detrattori li hai individuati?
«Alcuni
intellettuali che ritengono che io sia frivolo come i programmi che ho fatto.
C’è un gruppetto di snob che mi identificano soprattutto con Quelli della
notte e Indietro tutta che sono le trasmissioni di maggiore evasione.
Non mi considerano. Qualcuno pensa che il mio amore per la canzone napoletana
sia suggerito da un fatto commerciale, ma si astengono dal parlare in pubblico
male di me, perché io sono “beniamino” e quindi ci rimettono. La mia era una
missione».
Un altro episodio OFF della tua vita che ti commuove?
«Ho
scelto la canzone di Louis Armstrong per il Festival di Sanremo: Mi va di
cantare. E quando Ravera mi portò nel suo camerino e disse: “Questo è il
ragazzo che ha scelto la tua canzone”, Armstrong mi ha messo la mano sul cuore.
Io ancora oggi non ne posso parlare… (Renzo prende un fazzoletto) Poi Totò. Sono
stato una giornata intera sotto la sua casa, il giorno che Totò è morto. Ero con
la mia Cinquecento, ho fatto il giro del palazzo, del quartiere, ma non ho avuto
il coraggio di vederlo, di salire. Il mio cruccio di tutta una vita: non ho
avuto il coraggio di salire per dare l’ultimo saluto a Totò».
E Ruggero Orlando?
«Con
Ruggero eravamo amici. Ha fatto una scena nel mio Pap’occhio. Io ero
timido, dovevo parlare alla radio e lui era il mio idolo di giornalismo
televisivo. Con Ruggero ho superato la timidezza. All’epoca della contestazione,
noi avevamo la passione per l’America e ci parlavamo all’orecchio: “Ruggé, ma tu
hai capito questi che stanno dicendo?”»
Federico Fellini?
«A lui
era piaciuto moltissimo Pap’occhio. Per il secondo film abbiamo litigato.
Poi abbiamo fatto pace. Mi ha scritto una lettera bellissima. La fantasia di
Fellini!»
Nei suoi programmi il telespettatore è invitato a casa sua, alla
sua festa, partecipando attivamente alle vostre goliardate. Non c’è separazione
fra lo schermo e la vita reale. Sembra di stare con voi.
«La
parola goliardia va riletta. C’è la buona e la cattiva. In Quelli della notte
era Jazz, totalmente improvvisata. Aveva la liturgia del jazz. Tema, tonalità,
Pazzaglia: trombone, una jam session».
Un ricordo di Massimo Catalano e le sue massime?
«Ecco
Massimo era un jazzista. Tutte le domeniche veniva a suonare a casa mia e si
divertiva a giocare. Lui suonava con i Flippers, Vianello, Siamo i Vatussi…Spiritoso,
carino, educato. Pensa che dal primo bacio fino alla fine dei suoi giorni, è
stato sempre con la moglie. Sempre insieme. Un tuffo al cuore quando lo rivedo
in televisione. La “catalanata” l’ho suggerita io. Le ovvietà che si dicono
nelle interviste su qualsiasi cosa, elette a sistema. E così nacque la
“catalanata”».
Indietro Tutta.
Io ero pazzo di Miss Nord. Ma chi era la più bella?
«Difficile.
Erano davvero tutte belle. Noi volevamo ragazze della porta accanto.
Naturalmente Maria Grazia Cucinotta giovanissima, bellissima e serissima, era
una delle più belle perché era l’emblema: la ragazza che avresti voluto sposare».
L’invenzione del Cacao Meravigliao! Mi ricordo un cartello da
Castroni (nota caffetteria romana, n.d.r): “Non vendiamo il Cacao Meravigliao!”
«Tutti
torturavano Castroni. Quella fu un’intuizione. Indietro tutta è stata la satira
contro la televisione anni Ottanta/Novanta. Il pericolo era: “La televisione la
fate voi, da dove chiama?”. Lo sponsor che è il dominus attraverso la
pubblicità. Lo sponsor decideva addirittura le ragazze di Fantastico di
Celentano! Metteva bocca sulla qualità dello spettacolo. Allora il Cacao
Meravigliao…»
Uno poi s’è messo a produrlo…
«Abbiamo
vinto la causa contro un libanese che aveva depositato il marchio. Noi l’avevamo
inventato ma non lo depositammo».
Non le chiederò di Mariangela Melato…
«La
ferita è aperta e sanguinante. Prima o poi parlerò di lei. Mariangela è stata la
più grande. Ha fatto sì il cinema, ma ha fatto tutto il Teatro! Le altre grandi
attrici non lo hanno fatto. Basta mettere in fila i titoli».
È ancora Radicale?
«Sono
stato Radicale. Parto da Il Mondo di Mario Pannunzio, Ennio Flaiano,
Nicolò Carandini. Mi leggevo tutti i giornali di partito cercando un’identità: La
Tribuna, La Voce Repubblicana, Mondo Nuovo, La Discussione.
I socialdemocratici mi erano simpatici. Ma io resto kennediano!»
Dove ti piace passare le vacanze, se le fai?
«Da
bambino andavo a Riccione, dalla nonna bolognese. Poi a Pescara, Francavilla,
sul Gargano… adesso mi piace la bellezza di Ischia. Saranno i bagni caldi, i
nove comuni, la cucina napoletana… Ischia!
Convivi con i selfie dei tuoi ammiratori?
«Mammamia!
Una volta un fan di Caserta Sud voleva una foto con me alla toilette. “Come
scusi, al bagno?” “Devo dire a mia moglie che ho fatto pipì con Renzo
Arbore!”. Il pompiere di servizio a teatro che ti abbraccia mentre stai per
entrare in scena e vuole farsi il selfie! Io però non posso rifiutarmi».
Ultima domanda: lo stesso giochino che ho fatto con Gianni
Boncompagni. Arbore presidente assoluto della Tv. Che farebbe?
«Io
non sono come Boncompagni. Gianni dice il peggio della tv ma c’è un piccolo
particolare: non la vede. Io la vedo. Ha bisogno di creatività. Non c’è
creatività. Noi che siamo il Paese del gusto, della fantasia, abbiamo delegato a
format olandesi».
Con chi ti piace scherzare, improvvisare oggi?
«Con
Gegé Telesforo. È un jazzista. Abbiamo un repertorio formidabile. Con Gegé non
riesco a fare una telefonata normale. Proviamo a chiamarlo?»
ANCHE IO ERO OFF, al telefono con RENZO ARBORE, intervista di
Bruno Giurato.
Si ricorda un episodio OFF divertente o imbarazzante dell’inizio
della sua carriera?
«Ne
ho avuti tanti, perché ho una vita fortunatamente lunga. Ricordo quando suonavo
per gli americani, per esempio, a Napoli, per la United States Organization, che
è un’organizzazione fantastica di assistenza ai militari americani. Il mio
pianista non sapeva l’inglese e siccome i nostri ospiti ci chiedevano i pezzi
americani, gli avevo detto: “Devi dire sing the melody, canta la melodia.
Così tu capisci che pezzo è, e lo facciamo. E ci danno anche una mancia in
dollari”. Che poi era un dollaro, non di più. E una volta trovai questo pianista
che si accaniva contro un nero altissimo e continuava a dirgli “Sing the
melody, sing the melody…”, allora andammo a vedere e il nero aveva chiesto
al pianista dov’era la toilette: “Where is the restroom?” e lui gli
diceva: “Sing the melody”! Lì nacque la mia passione per gli Stati Uniti
d’America».
Lei che strumenti suonava?
«Suonavo
un contrabbasso a tre corde, cantavo le canzoni americane e strimpellavo il
clarinetto. Ero alle prime armi col clarinetto, però eravamo un gruppo di
appassionati di jazz, io facevo parte del Circolo Napoletano del Jazz, e quindi
eravamo invitati anche a Bagnoli, alla Nato, a sentire la Fitzgerald, Louis
Armstrong, o David Brubeck. La passione del jazz c’era da quando avevo 14 anni,
ma lì ho consolidato la mia conoscenza. E adesso sono presidente dell’Umbria
Jazz Festival. Devo dirlo: noi sminuiamo sempre le cose belle, invece Umbria
Jazz Festival è probabilmente il più bel jazz festival del mondo. Sono andato a
quasi tutti, e i migliori jazzisti del mondo vengono a Perugia e d’inverno a
Orvieto. La bellezza dell’Umbria, di Perugia, di Orvieto, ma anche delle altre
location, fanno di questo festival il più ambito: tutti vogliono venire ad
appuntarsi la medaglietta per aver suonato all’Umbria Jazz».
Ed è anche un festival che conserva ancora elementi di
sperimentazione e non si è piegato completamente alle logiche del pop…
«Facciamo
pochissimo pop, per catturare il pubblico, ma pop di qualità. Per esempio,
quest’estate verrà Doctor John, il pianista blues. Abbiamo ospitato Tony
Bennett, Gaetano Veloso, che non sono veramente jazz. Però, anche le
enciclopedie del jazz comprendono Frank Sinatra e Tony Bennett e Ben Goldberg,
pure se fanno o hanno fatto canzoni. Erano canzoni talmente di qualità e di
classe che erano molto vicini allo swing e allo spirito del jazz».
Torniamo un attimo al discorso di Napoli. Lei, studente
universitario e appassionato di jazz…
«Lo
scorso giugno andò in onda un programma mio e di Raffaele La Capria, il
grandissimo scrittore, adesso novantenne. Parliamo proprio della sua Napoli – la
Napoli della generazione precedente alla mia, quando a Palazzo Donn’Anna c’erano
Antonio Ghirelli, Franco Rosi e tutti gli altri suoi amici – e della Napoli
successiva, quando c’erano ancora gli americani, e io andai a studiare
Giurisprudenza. Un programma bellissimo, perché è fatto da Fabrizio Corallo, che
è un regista straordinario e ha trovato un sacco di documenti dell’epoca,
meravigliosi».
Lei ha inventato una sorta di sintesi straordinaria: da una parte
c’è, se vogliamo, l’atteggiamento goliardico dello studente universitario,
dall’altra l’improvvisazione, oltre che improvvisazione musicale anche
improvvisazione della parola. La miscela è esplosa alla radio con “Bandiera
Gialla”e “Alto Gradimento”. Si riconosce in questo?
«Devo
essere grato proprio alla musica e alla mia passione per il jazz. Se non avessi
apprezzato subito questa caratteristica del jazz che è l’improvvisazione, che mi
ha affascinato moltissimo, probabilmente io e Boncompagni non saremmo stati i
primi ad adottare il linguaggio parlato e improvvisato alla radio… addirittura
consegnavamo alla SIAE le registrazioni invece che i copioni, perché non
scrivevamo e quindi facevamo prima la trasmissione e poi come documento
consegnavamo le musicassette. Purtroppo molte sono andate perdute. La devo
proprio al jazz, l’improvvisazione, quella caratteristica che poi ho continuato
a perseguire alla televisione… e anche in genere adesso, come stiamo facendo
noi! Lo dico solo per il pubblico di OFF: le conversazioni di “Quelli della
notte” venivano decise esattamente dieci minuti prima della messa in onda.
Questo lo testimoniano tutti i protagonisti, da Marisa Laurito a Nino Frassica.
Perché non ci si preparasse prima e ci si divertisse veramente e autenticamente
a inventare delle stupidaggini».
Però in quel momento potevano nascere anche delle cose un po’
particolari che uscivano fuori dai binari… è vero che all’epoca de “L’altra
domenica” ci furono addirittura dei brigatisti che pensarono di telefonarvi?
«Sì,
l’ho saputo in ritardo. Per la verità, quando per la prima volta io misi il
telefono a disposizione del pubblico – non era mai successo, nemmeno in America,
il “da dove chiama?”, cioè che si potesse chiamare la televisione direttamente
da casa. Lo facevano solo le primissime radio private – quando io con Ugo
Porcelli ci inventammo questa cosa, naturalmente pensai che accanto alle
telefonate dei concorrenti potessero arrivare delle cose di questo tipo.
Domandai ad Andrea Barbato: “Se succede una cosa del genere, mi dici che debbo
fare?” e lui mi rispose: “Lasciali parlare”. Questa era la decisione presa dal
TG2, il programma dipendeva dal TG e dalla rete. Poi ho saputo sia da un
giornale sia personalmente, parlando con una persona dentro, che avevano
approfittato di questo numero 3139 per fare dei programmi, naturalmente non
trovando la linea libera perché fin dalla prima volta che telefonavano migliaia
di persone».
Lei è un grandissimo improvvisatore… ma il suo amico Luciano De
Crescenzo dice “Arbore è un misto tra un genio e un dittatore”. È vero?
«Dittatore
proprio no! È strano che Luciano l’abbia detto, perché lui sa benissimo che il
mio atteggiamento è proprio contrario alla dittatura. Io dico “facciamo così”
con sicurezza, perché per esempio ai personaggi che ho inventato ho dato
personalità, quindi per dare una personalità a Passaglia, che ne aveva una sua,
per dare una personalità a Catalano, o per dare personalità a Marisa Laurito,
che non fosse quella dell’attrice ma quella della cugina, dovevo imporre una
certa linea. Era un insegnamento. In genere, tutto ciò che ho fatto scaturiva da
un mio colloquio amichevole con i protagonisti. Perfino nei film con Roberto
Benigni, io lo caricavo, lo massaggiavo, gli dicevo: “Allora, puoi dire questo,
puoi dire quest’altro… se vuoi”. Proprio era la mancanza di dittatura che li
stimolava, erano suggerimenti, non c’era la paura di doversi ricordare questo o
quell’altro. Mai dire: “Tu devi dire esattamente così”. Se me lo dicono, per
esempio nel cinema, io non lo so fare. E infatti come attore sono abbastanza
cane».
Quindi, libertà di cazzeggio come libertà creativa. Lei ha fatto
nascere tantissimi talenti: Catalano, Gegè, Antonio e Marcella, Bracardi,
Benigni, che abbiamo nominato prima, Frassica, D’Agostino… Per esempio,
D’Agostino si aspettava che poi diventasse arbiter diciamo elegantiarum,
lui direbbe cafonalarum, della società?
«Beh,
diventare arbiter elegantiarum era il suo destino. Lui bazzicava
moltissimo la società, soprattutto i giovani, faceva il dj, quindi sapeva tutto.
Se volevi sapere qual era il locale in – la parola è brutta – del
momento, telefonavi a D’Ago, e lui ti diceva: “Vai lì al Testaccio, c’è questa
cosa” però da quello a diventare un grandissimo spione, nel senso buono perché
Dagospia è la sua rubrica dove suggerisce cose, estrapola articoli e informa lui
stesso, io non mi aspettavo che lo sapesse fare in maniera così… sapiente,
diciamo. Perché lo fa con grande cognizione di causa. Si può abbracciare o meno
qualche sua teoria, però Roberto è certamente molto attento».
A Sanremo nel 2014 ha detto: “Ho conosciuto Antonello Falqui, che
ha fatto la TV classica, ed Enzo Trapani che ha fatto l’altra TV”. E invece
dopo? Il nulla? Lei ha detto che la TV di oggi è una TV paracula: conferma?
«Eh
beh, certo. È una TV asservita completamente all’Auditel. Ho letto il saggio di
MarioVargas Llosa sulla società dello spettacolo: questo premio Nobel sostiene
proprio che alla fine la TV è diventata un’industria, e quindi ha perso le
caratteristiche vagamente artistiche che aveva prima. La televisione, quando
l’abbiamo fatta noi, ma soprattutto quando la faceva Falqui, e anche tanti
registi straordinari dell’epoca, si basava sul fare una cosa bella vagamente
artistica, vagamente vicina al mondo del cinema. Non sarà stata arte
cinematografica, ma certe opere sono rimaste televisivamente legate al mondo
dell’arte. Adesso la definizione “TV d’arte” è riservata solo a qualche canale
un po’ così: ce n’è un po’, diluita nelle reti, ma bisogna proprio andarla a
catturare. Ma questo succede anche in America, non è una cosa solo italiana. E
poi soprattutto per accontentare l’Auditel, che è diventato il dittatore supremo
di quello che succede in televisione per ragioni commerciali giustificatissime,
ma comunque economiche, si fanno anche, come si dice a Roma, le peggio cose.
Il pubblico dovrebbe essere presente alle riunioni di redazione dei programmi,
quando si decide: “chiamiamo questa ragazza perché fa vedere le gambe… chiamiamo
questo perché si arrabbia… chiamiamo questo perché si arrabbia con quello che si
arrabbia… chiamiamo questo perché è il re del gossip…”. Tutto è fatto in
funzione dell’ascolto mattutino del giorno dopo».
Una cosa che però lei è riuscito a fare è stata portare la musica
in TV con un programma poco conosciuto che è durato molto, ed era in una fascia
un po’ particolare, come Doc…
«Sono
molto contento che me lo ricordi, perché Doc è stato un programma fondamentale.
C’è un archivio che ha la Rai, preziosissimo, perché sono 400 puntate in cui
sono venuti tutti, da Miles Davies A Enzo Iannacci. Da Francesco De Gregori nel
pieno della sua creatività a Joe Cocker, o James Brown o Dizzy Gillespie. Pochi
sanno che io, siccome in qualche maniera mi diverto a pensare al futuro, non al
passato, facevo registrare agli artisti, oltre che le cinque performance che poi
andavano in onda dal lunedì al venerdì, anche quaranta minuti in più che
rimanevano nell’archivio della Rai. Quindi ci sono 40 minuti di Miles Davies,
mai visti, mai utilizzati, che stanno lì. Adesso poi forse c’è tutto il problema
dei diritti, ma sarebbe bello magari che qualcuno andasse a scoprire. Quello è
stato un periodo straordinario per la musica: c’era già stata la rivoluzione del
rock, il jazz era diventato fusion, era un periodo di grande creatività. Adesso
diciamo che ci stiamo godendo i postumi di questo periodo».
È da un bel po’ che non va in televisione e non fa più dei
programmi. Si vedrebbe in un programma televisivo? Come se lo immagina? Ci sono
speranze di vederla? E se non ci fossero, cosa le piacerebbe fare?
«Io
adesso ho un canale, renzoarborechannel.tv, che per adesso è un po’ silente e di
repertorio soprattutto mio, anche recente. Cioè, se vado a fare come è successo
una serata ad Alba e a parlare con Fabio Fazio nelle Langhe, io lo registro e
poi lo si vede in questo canale. Così con la mia orchestra, se vado a fare
qualche concerto particolare, oppure un po’ di cazzeggio incontrando Gigi
Proietti. Accanto al repertorio recente e anche antico mio, poi ci sono delle
cose che secondo me il pubblico dovrebbe vedere: credo che la mission di
uno della mia età sia far capire ai ragazzi che accanto a questi epigoni di
Drive-In ci sono i classici che non si possono ignorare. Da Totò, Aldo Fabrizi,
Alberto Sordi, Walter Chiari… le basi. Fortunatamente, c’è la rete che secondo
me è un dono della provvidenza, e rapidamente informa chi vuole essere informato
delle cose che sono fondamentali del passato per poter fare il futuro. Anche
musicale. Io sto dedicandomi, adesso lo farò con maggiore sollecitudine, a
questo renzoarborechannel.tv, poi vedremo se ne scaturirà qualche programma
curioso. Sto esplorando, diciamo. Poi, per la verità, i programmi come quelli di
un tempo sono difficili da farsi perché non ci sono più improvvisatori. È
rimasto Nino Frassica e qualche altro con cui ho già lavorato, ma di nuovi
talenti che improvvisano spericolatamente come facevamo noi non ce ne sono. Io
li cerco, vengono a trovarmi alcuni che vengono ai miei concerti, e io mi
diverto a improvvisare con l’Orchestra Italiana. Chi venisse a vedere un
concerto, capirà che non è solo musica, ma anche cazzeggio con i miei musicisti».
Però qualcuno mi sembra che ci sia, per esempio Zalone è un
ottimo musicista e anche un bravo performer. Lei cosa ne pensa?
«È ottimo,
Checco Zalone, anche lui mi chiese di collaborare, però quando gli chiesi se
improvvisava, lui disse: “Purtroppo no, io scrivo”. È una scuola
rispettabilissima, ma è come dire che un cantante pop come Eros Ramazzotti è un
musicista di jazz. Sono due cose differenti, il cantante pop non sa improvvisare
una canzone che non conosce, il jazzista lo fa. Si ritorna sempre a questa
storia del jazz… Per dirla in soldoni, i jazzisti se tu gli dici di suonare una
canzone napoletana lo fanno subito, Bollani gli dici “fammi Ohi Marì”, lui l’ha
sentita una volta e la fa. Male, in maniera jazzistica, benissimo, però la fa.
Il musicista classico, il musicista che ha studiato, quello che viene dal
conservatorio, no. Se non ha lo spartito non riesce a farla».
Una curiosità, che ne pensa di trasmissioni tipo X-Factor, oppure
The Voice of Italy, le sembrano interessanti?
«Mi
sembrano interessanti perché in qualche maniera vengono fuori dei talenti, e
quindi sono una promozione per artisti in erba. Alcuni diventano grandi, altri
vivono solo una stagione. Però, certamente mi piacerebbe che accanto ai cantanti
– cantanti, cantanti, cantanti – fossero premiati anche musicisti. Talenti di
altro tipo… quindi, perché no? Chitarristi, clarinettisti, pianisti… ma anche di
altre discipline artistiche».
Un po’ di tempo fa, ha detto che Renzi è uno sfrucugliatore,
uno che scombina le carte e la liturgia politica. È questo ancora il giudizio o
l’ha rivisto? Cosa ne pensa?
«Sì,
sta sparigliando, sta scombussolando tutta la situazione insieme con Grillo.
Insieme con tutti, perché mi sembra che la situazione sia proprio questa, ognuno
spariglia».
Ma nessuno costruisce…
«Per
adesso sparigliano, poi si vedrà».
COME TI COSTRUISCO UNA
BUFALA SUL WEB.
Come ti costruisco una
bufala sul web.
Il segreto della viralità dei falsi su internet si annida su Facebook. Perché
qui si tende a fare amicizia con persone simili a noi che fruiscono i nostri
stessi contenuti. Con i like che ne attirano altri succede che alcuni post
palesemente farlocchi finiscano per acquistare un successo sorprendente. Le
bugie diventano verità, i fake soggetti reali. Per un motivo che gli esperti ci
spiegano in modo scientifico, scrive Rosita Rijtano su “la Repubblica”. Per
trovare mondi paralleli non bisogna andare lontano, nessun viaggio
intergalattico: basta accendere il pc, collegarsi alla Rete, e aprire Facebook,
dove coesistono diversi universi destinati a non incontrarsi mai (o quasi) e
popolati da utenti con gli stessi interessi, le stesse paure, la stessa dieta
mediatica. Ed è qui, nella presunta genesi di microcosmi digitali, che - secondo
alcuni studiosi - si nasconderebbe il segreto della viralità delle burle
internettiane. "Le bufale si diffondono tanto, e velocemente, semplicemente
perché sulla rete sociale tendiamo a fare amicizia con persone simili a noi, che
fruiscono i nostri stessi contenuti", spiega Walter Quattrociocchi, informatico,
coordinatore del Laboratory of Computational social science dell'IMT di Lucca.
Un like tira l'altro, insomma: questa sarebbe la formula magica, la chiave che
ci permetterebbe di capire perché alcuni post, anche se palesemente farlocchi,
hanno molto successo sul social network di Mark Zuckerberg. Prevedibile, forse.
Un conto però è la teoria, un altro paio di maniche è la dimostrazione
matematica, scientifica. Quattrociocchi sostiene di averla fatta in un nuovo
studio, dal titolo "Viral Misinformation: The role of Homophily and
Polarization" (tradotto come "Disinformazione virale: il ruolo dell'omofilia e
della polarizzazione", vedi glossario), condotto con altri sette ricercatori,
dislocati in diverse università italiane, e che Repubblica.it ha potuto
visionare in anteprima.
Complottisti vs scienziati.
Bisogna fare un paio di necessarie premesse. Il paper affonda le sue radici in
diversi lavori precedenti. Sempre targati IMT. "Una trilogia del complotto",
l'ha definita Fabio Chiusi su Wired. Dove il team ha, di volta in volta,
vivisezionato le abitudini di milioni di italiani sulla piattaforma di Menlo
Park, in base al modo in cui si informano sul social (se fanno riferimento ai
media classici, o a dei siti scientifici, o a quelli di informazione non
tradizionale), per arrivare a interessanti conclusioni. Non solo, per l'appunto,
che su Facebook "chi si somiglia si piglia". Ma anche che "le varie categorie di
utenti, da noi prese in esame, interagiscono molto poco tra loro", spiega
Quattrociocchi, "e quando lo fanno litigano, si insultano, ognuno resta della
sua idea, poco importa se sia giusta o sbagliata". Non solo: "Appassionati di
scienza e complottisti, cioè quegli internauti che si informano su pagine
definite alternative, dedicano alle diverse news che leggono la stessa quantità
di attenzione, tutto indipendentemente dalla qualità dell'informazione, e
persino dalla sua veridicità, perciò le notizie false hanno la stessa rilevanza
delle notizie vere". Negli ultimi giorni dell'anno è tempo di bilanci anche per
gli scherzi. A ripercorrere le bufale del 2014 è il Washington Post, che grazie
alla classifica delle parole più ricercate su Google, fa un quadro delle notizie
che hanno ingannato milioni di utenti. A guadagnarsi lo scettro è Jasmine
Tridevil, vero nome Alisha Jasmine Hessler. La 21enne della Florida lo scorso
settembre è balzata all'onore delle cronache dopo aver rivelato di aver speso
circa 20 mila euro per sottoporsi a un'operazione chirurgica per l'aggiunta di
un terzo seno, con l'obiettivo di diventare famosa e partecipare a un reality.
In realtà si trattava di una protesi mobile, servita per realizzare l'autoscatto
diventato virale in poco tempo. A tradirla è stata una denuncia di furto fatta
presso il Tampa International Airport, dove tra gli oggetti rubati spuntava
anche un 3 breast prosthesis. La bufala è servita comunque da trampolino e
Alisha ha recentemente registrato la sua prima canzone. Tra le altre bufale
dell'anno anche il video virale della ragazza ubriaca a Los Angeles, esperimento
sociale rivelatosi poi finto; l'uomo che si è salvato dall'attacco di un orso
grazie alla suoneria del telefonino e le immancabili ''morti annunciate'' di
personaggi famosi diffuse sui social network. Ecco alcune delle notizie false
che hanno fatto discutere (e persino ridere) nei mesi scorsi.
Al secondo posto la minaccia
di un hacker a Emma Watson che prometteva di pubblicare sul sito
emmayouarenext.com le foto dell'attrice nuda, presa di mira per il suo accorato
discorso contro le differenze di genere e gli stereotipi sulle donne fatto
davanti alle Nazioni Unite. Il sito 4chan era stato indicato subito come
responsabile delle minacce, ma in realtà la bacheca che aveva diffuso le
immagini osé delle attrici rubate dai loro 'cloud', in questo caso, non aveva
colpa. Le minacce erano in realtà una trovata pubblicitaria dell'agenzia di
marketing virale Rantic che con questa bufala ha generato oltre 48 milioni di
contatti sul web, 7 milioni di condivisioni e "mi piace" su Facebook e 3 milioni
di menzioni su Twitter.
La medaglia di bronzo va al
video girato dalla sconosciuta Stephen Zhang Production chiamato "esperimento
sociale", in cui una ragazza finge di essere ubriaca e si aggira barcollando per
la più famosa strada del quartiere di Hollywood a Los Angeles facendosi
avvicinare da molti ragazzi per dimostrare quali sono le reazioni degli uomini
in una situazione del genere. Il video pubblicato sul web in pochissimo tempo ha
guadagnato milioni di visualizzazioni, scatenando i commenti degli utenti.
Peccato che il regista, tale Stephen Zhang, avesse in realtà allenato gli uomini
a recitare.
La misteriosa bandiera bianca
comparsa la scorsa estate sul ponte di Brooklyn sembrava essere frutto di una
mossa dei ciclisti, in una ipotetica battaglia contro i pedoni. La notizia,
rivelatasi poi falsa, era stata diffusa via Twitter, sull'account BicycleLobby.
In realtà, si trattava di un blitz rivendicato da due artisti tedeschi, intenti
a celebrare il ponte come spazio pubblico.
Nella lista c'è anche
l'incredibile storia di un uomo che si è salvato dall'attacco di un orso in
Russia, grazie alla suoneria telefonica 'Baby' di Justin Bieber impostata sul
cellulare.
La notizia della ''Miracle
Machine'' che può trasformare l'acqua in vino. Il marchingegno in realtà non
esiste, ma si è trattato di un'operazione di lancio per finanziare il progetto
di una ONG che ha come obiettivo quello di portare acqua potabile nei paesi
bisognosi. La bravata ha raggiunto comunque il suo scopo: grazie al video, le
donazioni sono aumentate del 20%.
Passando dall'America alla
Russia, si è rivelato falso anche il video postato su Twitter dalla slittinista
statunitense Kate Hansen che mostrava un lupo grigio senza collare aggirarsi
liberamente nel corridoio del suo hotel, nel parco olimpico dei Giochi di Sochi
(in realtà si trattava di una messinscena, realizzata in uno studio di Los
Angeles).
E di un montaggio video si è
trattato anche nel caso del filmato diffuso su YouTube all'inizio di agosto che
mostrava il presidente russo Vladimir Putin colpito da escrementi di uccello
durante il discorso tenuto in occasione del centenario della Prima guerra
mondiale.
Nella classifica non potevano
poi mancare i sei giorni di buio totale che avrebbe dovuto attraversare la Terra
tra il 16 e il 22 dicembre. Un articolo pubblicato dal sito satirico Huzlers.com
annunciava l'arrivo imminente di una tempesta solare, che avrebbe bloccato il
90% della luce solare con polvere e detriti. La notizia, che tra l'altro citava
come fonte direttamente la Nasa, è diventata virale e a fine ottobre l'agenzia
spaziale americana ha dovuto rilasciare una smentita ufficiale.
Infine, chiudono la classifica
la morte di Betty White e Macaulay Culkin . In realtà entrambi stanno molto
bene: White, che si sta avvicinando il suo 93esimo compleanno, è ancora in tv
con la sitcom "Hot in Cleveland", mentre il protagonista di ''Mamma ho perso
l'aereo'' è in tour con la sua band Pizza Underground.
Negli ultimi giorni dell'anno
è tempo di bilanci anche per gli scherzi. A ripercorrere le bufale del 2014 è il
Washington Post, che grazie alla classifica delle parole più ricercate su
Google, fa un quadro delle notizie che hanno ingannato milioni di utenti. A
guadagnarsi lo scettro è Jasmine Tridevil, vero nome Alisha Jasmine Hessler. La
21enne della Florida lo scorso settembre è balzata all'onore delle cronache dopo
aver rivelato di aver speso circa 20 mila euro per sottoporsi a un'operazione
chirurgica per l'aggiunta di un terzo seno, con l'obiettivo di diventare famosa
e partecipare a un reality.
In realtà si trattava di una
protesi mobile, servita per realizzare l'autoscatto diventato virale in poco
tempo. A tradirla è stata una denuncia di furto fatta presso il Tampa
International Airport, dove tra gli oggetti rubati spuntava anche un 3 breast
prosthesis. La bufala è servita comunque da trampolino e Alisha ha recentemente
registrato la sua prima canzone.
Tra le altre bufale dell'anno
anche il video virale della ragazza ubriaca a Los Angeles, esperimento sociale
rivelatosi poi finto; l'uomo che si è salvato dall'attacco di un orso grazie
alla suoneria del telefonino e le immancabili ''morti annunciate'' di personaggi
famosi diffuse sui social network. Ecco alcune delle notizie false che hanno
fatto discutere (e persino ridere) nei mesi scorsi.
E chi, fra gli utenti, ha più
probabilità di scambiare la bufala, o la satira, per un fatto reale?, è la
successiva domanda quasi obbligatoria. Il ricercatore non ha dubbi: "Osservando
i contenuti a cui è generalmente esposto chi la condivide, troviamo i fan delle
pagine di controinformazione, cioè di notizie difficili da verificare. Esempi:
Lo Sai, Vaccini e Basta o Coscienza Sveglia". Se siamo disposti a fare un passo
in più, in un altro paper che - anche in questo caso - abbiamo avuto in preview,
Quattrociocchi & Co. suggeriscono la fede politica di molti "creduloni"
digitali. "Questa tipologia di utenti scrive il 27,13 per cento dei commenti che
ci sono sulla pagina di Beppe Grillo", chiosa il ricercatore. Insomma, stando ai
lavori del gruppo IMT, seppur con tutti i dubbi che può lasciare un'analisi non
generalizzabile, limitata a un solo Paese e a determinate tipologie di
alimentazione digitale, ci comportiamo così sulla rete sociale più popolare al
mondo. Che conta 1 miliardo e 350 milioni di iscritti. Una bordata per chi
sostiene che internet sia necessariamente il luogo dell'intelligenza collettiva.
Bufale virali: il ruolo di
omofilia e polarizzazione.
Ma come, queste dinamiche relazionali, influiscono sulla diffusione pervasiva
della disinformazione? Ed ecco che si arriva al nuovo studio, un monitoraggio
spalmato nell'arco di 4 anni, e diviso in due fasi. Nella prima gli informatici
hanno analizzato post e like di 73 pagine aperte in Italia sul network firmato
Zuckerberg: 34 scientifiche (Science & Co.), e 39 cospirazioniste (Lo Sai &
Co.). "Così", prosegue Quattrociocchi, "siamo riusciti a inquadrare come si
comportano 1,2 milioni di utenti nostrani (su 25 milioni di utenti attivi al
giorno, secondo i dati che ci ha fornito un portavoce di Facebook ndr), e a
stabilire matematicamente che il numero di "Mi piace" su un determinato post è
direttamente collegato all'omofilia, cioè al numero di amici che consumano lo
stesso tipo di contenuto". In concreto: più il fake è condiviso da persone che
conosciamo, e più aumentano le possibilità di essere contagiati dalla burla a
nostra volta. Mentre nulla contano hub e influencer, anzi: la probabilità di
trovarne uno diminuisce all'aumentare della viralità della news. Per il secondo
step, invece, la lente del team ha zoomato su 4,709 annunci fasulli, messi in
circolazione da due pagine satiriche: "Semplicemente Me" e "Simply Humans".
Bufale, ma considerate vere dai naviganti. Spiega l'informatico: "Sono state
tutte ripubblicate da utenti molto polarizzati, cioè in media con circa l'80 per
cento di like su fonti di informazione complottarda, difficili da controllare.
Trovato uno, trovati tutti. Perché, grazie all'omofilia, possiamo individuare
con esattezza la rete di amicizia di ognuno di loro".
Il problema non è il mezzo:
"Manca una preparazione scientifica".
"Un lavoro impostato su un'interessante mole di dati", commenta David Lazer,
professore alla Northeastern University, e uno dei papà della Computational
social science, la disciplina che propone un approccio computazionale alle
scienze sociali. "Ma non sappiamo niente di ciò che succede al di fuori del
social network preso in esame, cioè di Facebook, come per esempio nelle mailing
list". Lo stesso concetto di disinformazione - secondo Lazer - è troppo vasto
per poter esser ben inquadrato. Aggiunge: "Ciò che è disinformazione per uno,
può essere informazione per qualcun altro. Si tratta, del resto, di un fenomeno
che esiste da sempre. Per cui sarebbe più interessante chiederci: quanto
internet e i social network lo agevolano rispetto ai media tradizionali?".
Trovare una risposta è difficile. Certo, sul web le bufale si diffondono
velocemente. "La disinformazione digitale" è "uno dei principali rischi della
società moderna", ha ammonito il report 2013 del World Economic Forum. E dalla
piattaforma di Menlo Park passa una fetta sempre più consistente delle news che
mastichiamo ogni giorno. Ma è anche vero che, quando e se vogliamo, possiamo
ottenere la news più corretta e completa. Con lo stesso click. Con lo stesso
strumento. Con la stessa velocità. Per Rosaria Conte, scienziata cognitiva e
vice presidente del Consiglio scientifico del Cnr, il problema quindi non è il
mezzo, "ma la mancanza di una preparazione scientifica da parte di chi fornisce,
e fruisce, le notizie". Conclude: "A essere virali non sono tanto le bufale, ma
le informazioni non verificate, e la loro conseguente accettazione acritica, un
atteggiamento da abbandonare". In questo mondo. Come in un altro, parallelo.
"L'informazione è un fenomeno
di contagio sociale", ne è convinto Alessandro Vespignani, fisico, ed esperto di
modelli previsionali delle epidemie. Quarantanove anni, professore di Physics,
Computer Science e Health Science alla Northeastern University, e autore - con
Romualdo Pastor Satorras - del libro "Evolution and structure of the Internet".
Da anni scandaglia la Rete. Con un obiettivo: studiare la diffusione delle
malattie. L'abbiamo contatto su Skype per parlare della cosiddetta viralità
delle notizie. Secondo Vespignani, ci sono delle somiglianze tra le pandemie e
il modo in cui circola una bufala online, ma anche delle notevoli differenze.
Che affondano le loro radici nel contesto sociale in cui viviamo, cioè nella
nostra rete di relazioni quotidiane. Reali e virtuali. "Insomma, si tratta di un
meccanismo molto più complesso", avverte. Perciò è difficile prevedere, e
analizzare, le sue dinamiche. È, quindi, giusto parlare di intelligenza
collettiva quando si parla di Internet? O, forse, sarebbe più appropriata la
definizione di ignoranza collettiva?, lo provochiamo. Replica: "Sono due facce
della stessa medaglia".
Dottor Vespignani, secondo
lei la circolazione sul web delle notizie false può essere equiparata a
un'epidemia?
"Di sicuro tutto ciò che è
informazione è un fenomeno di contagio sociale. Solo che in questo caso a
passare di persona in persona non è un virus, o un patogeno. Ma un concetto, che
si diffonde di testa in testa. Così, nel momento in cui recepisco alcune
informazioni dai mie amici e comincio a ripeterle, è come se fossi stato
infettato. E infettassi gli altri a mia volta. Ci sono, ovviamente, anche delle
grandissime differenze con il mondo biologico. Dove a difenderci dai virus è il
nostro sistema immunitario. Quando parliamo di informazione, invece, il mondo
esterno ha un forte effetto sulle probabilità di contagio. E se la notizia a cui
siamo esposti arriva da un amico, da una persona di cui ci fidiamo, o che ha i
nostri stessi interessi, potrebbe avere un peso maggiore. Insomma, si tratta di
un meccanismo molto più complesso".
È quindi, possibile
prevedere, dove, quanto e quando si diffonderà una cosiddetta bufala?
"Prima di tutto bisogna capire
che cos'è una bufala, o che cos'è la disinformazione. In alcuni casi,
l'interrogativo viene risolto guardando all'informazione in maniera banale. In
altri, la differenza è più sottile. Quindi, comprendere qual è la percezione
del mondo rispetto a una determinata notizia, può risultare complesso. Una
capacità predizionale in questo campo mi sembra che ancora non sia di portata
immediata. Non solo perché dobbiamo risolvere un problema concettuale, stabilire
- appunto - che cosa sia disinformazione e che cosa no. Ma anche perché dobbiamo
avere una dettagliata mappatura di tutto lo spazio sociale in cui la bufala si
diffonde: le persone con cui parlo al telefono, con cui parlo di persona, con
cui interagisco su Facebook e così via. Per tanto tempo è stato del tutto
impossibile, solo di recente sono stati fatti dei grandi passi avanti. Grazie
allo sviluppo di nuove tecnologie, anche pervasive, che monitorano i social
network e non solo".
Secondo alcuni studi, i
social network, e in particolare Facebook, sono un terreno particolarmente
fertile per la circolazione di informazioni fasulle. Qual è la sua opinione?
"Credo che internet sia
un'enorme rete di conoscenza. Un'enorme rete di comunicazione che ha effetti
molto positivi sul nostro modo di vivere, conoscere, e comunicare. Allo stesso
tempo, però, crea un'orizzontalizzazione del sapere. Cioè, mettendo qualsiasi
cosa a disposizione di tutti, fa credere a chiunque di poter masticare ogni
informazione in modo efficace. Purtroppo non è vero. A volte ci vogliono anni di
studi per capire determinate notizie. E discriminare quale sia l'informazione
corretta e quale no. Per fare un paragone: è come se ci trovassimo in un grande
bazar, dove è possibile incappare anche nella cosiddetta sòla. Perché, così come
non tutti siamo esperti di tappeti, allo stesso modo non tutti siamo in grado di
leggere un saggio politico, o un paper scientifico. Io, ad esempio, non mi
sognerei mai di voler pilotare un aereo solo perché ho letto un articolo
sull'argomento".
Intelligenza collettiva o
ignoranza collettiva?
"Purtroppo una è lo specchio
dell'altra. L'intelligenza collettiva esiste. E internet ne è una sua faccia.
Può diventare ignoranza collettiva nel momento in cui la disinformazione si
diffonde sulla Rete. Perciò è importante continuare a stabilire una scala dei
valori. E, in qualche modo, ognuno di noi non deve farsi abbindolare dall'idea
che l'informazione su internet sia automaticamente accessibile e veritiera. Un
po' la lezione che abbiamo già imparato con i media tradizionali, insomma".
Quanto sarebbe, invece,
importante una corretta informazione? Ci sono dei modi per veicolarla meglio e
per evitare di diffondere, a nostra volta, notizie false?
"Una domanda da un milione di
dollari. Saper distinguere l'informazione corretta e veicolarla nel modo giusto
è, ovviamente, la cosa più importante del mondo. Che cosa bisogna fare? Bisogna
diventare più furbi e attenti. I dati, le verifiche: sono importanti. Ma non è
da meno l'onestà intellettuale. Tutti noi abbiamo una particolare visione del
mondo, di cui cerchiamo conferme. E in Rete si può trovare la conferma di
qualsiasi cosa, quindi bisogna stare attenti ai valori reali. Si tratta di una
presa di coscienza necessaria per evitare di aprire un grande conflitto tra
l'età dell'intelligenza collettiva e quella che lei definiva, invece, età
dell'ignoranza collettiva. Quest'ultima può portare a fenomeni catastrofici.
Cambiare grandi vittorie della società e trasformarle in sconfitte. Un fenomeno
che purtroppo si verifica già oggi, quando si parla di scienza: in certi campi
si rischia di tornare indietro di decine di anni".
È il diciassette dicembre 2012
quando su Facebook si diffonde un messaggio: "Ieri il Senato della Repubblica ha
approvato con 257 voti a favore e 165 astenuti il disegno di legge del senatore
Cirenga che prevede la nascita del fondo per i parlamentari in crisi creato in
vista dell'imminente fine legislatura". In che cosa consiste? "Uno stanziamento
di 134 miliardi di euro da destinarsi a tutti i deputati che non troveranno
lavoro nell'anno successivo alla fine del mandato. E questo quando in Italia i
malati di SLA sono costretti a pagarsi da soli le cure". Conclusione: "Rifletti
e fai girare". Segue un'ondata d'indignazione: sono più di trentaseimila le
condivisioni in poche ore. Un putiferio. Con tanto di petizione online per
fermare "questo scempio", come si legge in uno dei 958 commenti al post. Peccato
che l'annuncio sia falso. Per accorgersene basta fare un rapido calcolo, dare
un'occhiata a qualche dettaglio, prestare attenzione alla didascalia della foto.
Il numero dei voti non combacia con i senatori eletti in Parlamento: 422 contro
315. La somma stanziata è superiore al 10 per cento del Pil italiano. Inoltre, a
commento dell'immagine, i naviganti sono persino avvisati: si tratta di
"un'immane boiata", si legge. Ciò non impedisce all'informazione di diventare
virale, e di essere considerata vera, anzi. "Nei giorni successivi c'è stata una
gara tra alcuni blog per riprendere, modificare e ripubblicare la notizia",
racconta Dino Ballerini, la mente che ha architettato lo scherzo. "Secondo una
ricerca, tra post originale e successive repliche, la bufala è stata condivisa
da circa due milioni di persone. Un italiano su trenta". Per la prima volta,
Ballerini confessa a Repubblica.it: "Sono stato io a inventare la notizia".
Tutto durante una pausa pranzo. "Ero stufo di vedere condivise tante
stupidaggini". Così, dopo aver redatto il testo di legge, l'ha messo in
circolazione sulla pagina "Semplicemente Me", una fan page creata grazie
all'incontro virtuale con due troll: Rettiliana Illuminata e Paride Rampicante.
Che non ha alcun intento pedagogico. "Oggi la nostra unica motivazione sociale è
mettere in luce la carenza di senso critico da parte delle persone. Ma è stata
una scoperta che abbiamo fatto successivamente. Lo scopo iniziale era solo
quello di divertirci alle spalle dei creduloni, senza ottenere alcun vantaggio
economico, ovviamente". Ci sono riusciti? "Pensa: qualcuno, ogni tanto, continua
a scrivere sulla bacheca del senatore Cirenga: Vergogna", ride.
False notizie.
Dalle tecnologia alla scienza: tutti i tipi di bufale. La storia delle false
notizie online segue di pari passo la storia di internet. Un sottobosco di
frottole: ha avuto origine con la Rete stessa, e riguarda i campi più disparati.
Dall'ambiente alla medicina. Tra passato e presente. Risale al 1997 la leggenda
secondo cui Bill Gates regala dei soldi a chi fa girare una email relativa a un
test di Microsoft. Mai successo. Il 9 giugno 2014 l'Università di Reading
annuncia che un software sviluppato dai suoi ricercatori ha passato il test di
Alan Turing. La notizia rimbalza su testate nazionali e internazionali. Il
risultato è messo in dubbio il giorno successivo. Qualcuno, come il sito
americano Hoaxes.org, prova a tenere traccia degli inganni "on the net". Paolo
Attivissimo, giornalista, che si auto definisce "cacciatore di bufale", cerca di
mettere ordine. Spiega: "Sicuramente tra le bufale più popolari sul web ci sono
quelle che riguardano la salute: gli appelli per aiutare le persone malate; o
per evitare preoccupanti, quanto inesistenti, malattie. Al secondo posto, metto
la tecnologia. Attenti c'è un virus in quel messaggio di posta elettronica;
attenti al wi-fi, causa il tumore; attenti a quell'applicazione, dietro si
nasconde una banda di pedofili: sono solo alcuni, ma significativi, esempi". A
volte si tratta di piccole sciocchezze. Altre, invece, le informazioni prive di
fondamento hanno una portata più ampia. "Come la paura per le sostanze
cancerogene contenute, secondo alcuni, in determinati alimenti. O per le scie
chimiche, che sono diventate persino oggetto di dibattito politico, in quanto
sarebbero sostanze tossiche rilasciate nell'aria per il controllo delle menti, o
l'avvelenamento della popolazione". Una bufala in volo da almeno 15 anni.
Prosegue Attivissimo: "In realtà, si tratta di fenomeni dovuti alla
condensazione dell'acqua presente nell'atmosfera, e generati dalla combustione
del carburante degli aeroplani. Infine, ci sono gli inviti razzisti. Uno dei più
noti parla dei segni lasciati dai nomadi accanto al citofono per dire se una
casa deve essere ancora derubata, o meno. Si potrebbe obiettare: la soluzione è
semplice, basta indicare che la tua abitazione è già stata svaligiata".
Fake.
In alcuni casi i fake sono cronache dell'assurdo. Con lo scopo di fare
pubblicità a chi li ha creati. Prendete Jasmine Tridevil, la ragazza che avrebbe
pagato 20mila dollari per avere un terzo seno. Il motivo: voleva disgustare gli
uomini, per non avere più appuntamenti con l'altro sesso. Si è scoperto, solo
dopo che la news era finita su vari tabloid americani e non solo, che in passato
la donna era stata accusata di frode. E la storia della chirurgia era un
inganno. In altri, invece, la matrice della bugia è più seria. Durante l'ultima
campagna elettorale statunitense, ad esempio, un movimento chiamato Sandy Hook
Truthers ha cercato in tutti i modi di diffondere tra gli internauti la
convinzione che Barack Obama non è nato alle Hawaii, ma in Kenya. E per questo
motivo era ineleggibile alla Casa Bianca. A poco è servito pubblicare il
certificato di nascita del presidente sul sito della White House. Sulla sua
veridicità, e sui presunti natali africani di Obama, negli Stati Uniti si
dibatte ancora oggi.
Un capitolo a parte meritano
le notizie scientifiche non corrette. Giusto per citarne alcuni temi top: Hiv,
correlazione tra vaccini e autismo, staminali. Ma non sono gli unici. Basti
pensare: il post più condiviso su "Semplicemente Me" riguarda quella che viene
definita "un'evenienza rarissima, i cinesi la chiamano shu tan tzu che
significa anno della gloria e della fortuna". Quale sarebbe? "Quest'anno dopo
5467 anni, ottobre avrà 5 martedì, 5 mercoledì e 5 giovedì". Un fake. Un tipo di
disinformazione, quella sulla scienza, a cui contribuiscono, o hanno
contribuito, anche esponenti politici. Più o meno ingenuamente. Nel 1998, nel
corso dello spettacolo Apocalisse morbida, Beppe Grillo ha definito l'Aids la
più "grande bufala di questo secolo", negando che l'Hiv è un virus trasmissibile
capace di danneggiare il sistema immunitario. Non solo: ha anche sostenuto che
epidemie come poliomielite e difterite sarebbero scomparse anche senza le
campagne di vaccinazioni. "Un'affermazione falsa perché gli agenti patogeni non
scompaiono nel nulla, solo che non riescono a trovare un ospite da infettare",
ha spiegato Giovanni Maga, virologo dell'Istituto di Genetica molecolare del
Cnr, a Wired Italia che ha dedicato un articolo a tutte le fandonie del comico
genovese.
Che cosa spinge al click?
Bufale
diverse, quindi, così come sono diverse le molle che fanno scattare la
condivisione. E nel futuro? Quale sarà la prossima informazione sbagliata in
grado di diventare virale? Risponde Ballerini: "Impossibile programmarle, è
questo il bello. Se ci mettessimo a tavolino per studiare lo scherzo perfetto,
magari poi sarebbero in due a condividerlo. Non possiamo stabilire in anticipo
che cosa tocca realmente nell'intimo le corde di una persona. Si tratta di una
serie di fattori x che non riusciamo a comprendere. Un argomento legato
all'attualità può di certo favorire, ma anche l'ora di pubblicazione è
determinante". Insomma, tanti dubbi, un'unica certezza: "La prossima bufala ci
sarà. Sicuramente".
Bloccare la diffusione delle
bufale sul nascere è difficile. Ma difendersi si può. Anzi: si deve. E internet
offre tutti gli strumenti necessari per farlo, a patto, sia chiaro, che
l'internauta sia disposto a cambiare tutte le sue cattive abitudini. "Il miglior
modo per proteggersi è modificare il proprio comportamento", spiega Paolo
Attivissimo. Lui lo sa bene: da anni gestisce una piattaforma italiana per
controllare la veridicità delle notizie, pubblicate sia online sia sui media
tradizionali. Una caccia quotidiana alla frottola. Così il suo primo
suggerimento è accantonare, in via definitiva, la tendenza comune più deleteria:
"Non ne sono sicuro, non posso controllare. Però, nel dubbio, condivido".
Continua Attivissimo: "Diffondendo la notizia, anche quando non sappiamo se sia
vera o meno, crediamo di fare un favore ai nostri amici. Mentre in realtà
alimentiamo solo la disinformazione. Dobbiamo abituarci a non inoltrare nulla,
se non abbiamo tempo per verificare. Del resto, basta poco: andare su un motore
di ricerca e digitare le parole, o i nomi, che sono contenuti nell'appello; o
rivolgersi a un sito antibufale". Una delle novità più rilevanti in questo campo
è Emergent.info, un lavoro sviluppato per il Tow Center for Digital Journalism
da un giornalista specializzato nella verifica delle fonti: Craig Silverman. Un
progetto ancora in fase sperimentale, ma che ha l'obiettivo di diventare una
sorta di cane da guardia, grazie a una web app che combina il lavoro di un
algoritmo con il fact checking umano. Un sistema capace di monitorare in tempo
quasi reale tutto ciò che è discusso quotidianamente sulla Rete, fino ad
analizzarne la correttezza e la diffusione. Compresa la capacità di tracciare
chi ha smascherato la menzogna e chi, invece, sta solo riportando la notizia
originale. L'obiettivo ultimo, scrivono gli ideatori del progetto, è
"individuare i modi per aiutare la verità a emergere velocemente e a diffondersi
più che in passato". Emergent.info non è il solo, né il primo, sistema che
spinge in questa direzione. Gli strumenti recenti fanno per lo più leva sul
crowdsourcing, cioè combinano le verifiche fatte da più utenti, per stabilire se
l'informazione è falsa oppure vera. Come Rbutr, che funziona grazie a un plugin:
scaricandolo sul browser si mettono a disposizione degli altri internauti tutte
le nostre conoscenze su un determinato argomento. O Civic Links, la piattaforma
della fondazione Ahref, datata 2012. Alcuni hanno messo in piedi un team di
persone specializzate nello scoprire le bugie sul web. Citizen Evidence Lab, ad
esempio, è il sito con cui Amnesty International aiuta giornalisti e no ad
autenticare video su YouTube. E persino Mark Zuckerberg, sul suo social network,
ha avvertito l'esigenza di creare qualcosa per vagliare le news: Facebook
NewsWire, una sorta di agenzia stampa che è stata lanciata lo scorso aprile e
alal quale si è aggiunto recentemente un nuovo strumento di controllo. Sul
fronte portali, uno degli esperimenti più riusciti e antichi d'oltreoceano si
chiama Snopes, un database nato nel lontano 1996 per smontare leggende urbane.
Mentre in Italia la sorveglianza è affidata ad Attivissimo.net, Hoax.it e
Bufale.net, solo per citarne alcuni. Una presenza di cui si sente bisogno in
terra digitale? La risposta arriva dai numeri di Bufale.net: "Contiamo", spiega
Claudio Michelizza, uno dei cofondatori, "tra le 400 e le 500mila visite al
mese, e più di mille articoli". Perché l'estinzione delle bufale è tutt'altro
che vicina.
Un glossario per capire:
A come Agenda setting.
È la teoria sociologica secondo cui i media precisano e
descrivono la realtà su cui formarsi un'opinione. "L'assunto fondamentale
dell'agenda-setting", ha scritto l'accademico Donald Shaw, "è che la
comprensione che la gente ha di larga parte della realtà sociale è mutuata dai
media".
B come bufala o Big Data.
L'etimologia della parola è incerta. Ma la bufala è,
in gergo, un'informazione falsa o inverosimile. Si parla, invece, di Big Data
quando si fa riferimento alla pachidermica mole di dati che generiamo ogni
giorno, soprattutto grazie alle nuove tecnologie: dai computer agli smartphone,
passando per carte di credito ed e-reader.
C come Computational Social
Science o Cospirazionista.
Con l'espressione Computational Social Science si
indica un'emergente disciplina accademica che propone un approccio
computazionale alle scienze sociali. Secondo i suoi promotori, la crescente
capacità di collezionare e analizzare dati potrebbe rivelarci modelli
comportamentali di gruppi e individui. "Con la potenzialità - scrivono i
ricercatori nel primo manifesto dedicato alla materia e pubblicato su Science il
6 febbraio 2009 - di trasformare la comprensione che abbiamo delle nostre vite,
delle nostre organizzazioni e delle nostre società". Il cospirazionista, sia
online che offline, è colui che crede alle cosiddette "teorie del complotto",
cioè quelle che attribuiscono la causa di un evento, o un insieme di eventi, a
un accordo segreto.
D come Data Science e
Debunking.
Data Science è, in generale, la capacità di ricavare
conoscenza dai dati. Una possibilità che diventa via via sempre più ricca,
grazie ai cosiddetti Big Data. Mentre debunking è un neologismo usato per
indicare un individuo che smaschera notizie, informazioni, o affermazioni
fasulle. È stato coniato dallo scrittore William Woodward, il quale scrisse che
bisognava "tirar fuori il falso dalle cose": "take the bunk out of things".
E come Engagement.
Si tratta del numero di like che si possono contare su
un determinato contenuto.
F come Fact checking.
Il fact checking è semplicemente il controllo
dell'informazione che leggiamo online o sui media tradizionali. Internet non è
solo uno straordinario strumento per la diffusione delle bufale, ma anche per la
verifica delle notizie. Sono, infatti, diverse le piattaforme dedicate a questo
scopo. Civic Links; Rbutr; FactCheck.org; Flack Check.org; Attivissimo.net: sono
solo alcuni esempi.
G come Grafo o Grado medio.
Il grafo è una struttura matematica, studiandola è
possibile schematizzare una grande varietà di situazioni e processi: mappe
geografiche, reti di amicizie tra persone, aeroporti e voli. Il grado medio
indica il numero di amici che un generico utente ha su Facebook.
H come Hub.
Nel campo informatico e delle telecomunicazioni l'hub è
un nodo che funziona come un dispositivo di rete per lo smistamento dei dati.
Quando si parla di social network, con il termine hub si intende - invece - una
persona molto centrale nella rete sociale, con un gran numero di amici,
attraverso cui è possibile raggiungere molte altre persone. Nelle reti reali gli
hub sono pochi e hanno moltissimi collegamenti.
I come Influencer o
Intelligenza collettiva.
Lo suggerisce la parola stessa: l'influencer è una
persona "influente", cioè autorevole nel suo campo. Svolge il ruolo di opinion
leader, cioè offre la sua visione su una determinata questione. Un'opinione che
poi viene adottata da molti. Che cos'è l'intelligenza collettiva nel
cyberspazio? Pierre Lévy, filoso francese che studia l'impatto di Internet sulla
società, la definisce così: "In primo luogo", ha dichiarato in un'intervista,
"bisogna riconoscere che l'intelligenza è distribuita dovunque c'è umanità, e
che questa intelligenza, distribuita dappertutto, può essere valorizzata al
massimo mediante le nuove tecniche, soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, se
due persone distanti sanno due cose complementari, per il tramite delle nuove
tecnologie, possono davvero entrare in comunicazione l'una con l'altra,
scambiare il loro sapere, cooperare. Detto in modo assai generale, per grandi
linee, è questa in fondo l'intelligenza collettiva".
L come Lurker.
Il lurker è una sorta di voyeur internettiano. Si
tratta cioè di un utente che partecipa a una comunità digitale (come mailing
list, gruppi, chat), osservando attentamente tutte le attività e tutti i
messaggi, ma senza intervenire mai nelle discussioni, senza postare o interagire
con gli altri. Insomma, senza rendere manifesta la propria presenza. Da qui
deriva anche il verbo lurkare, che può essere tradotto come "osservare da dietro
le quinte".
M come Meme.
Un meme è un fenomeno di internet: un'idea, un'immagine
o un'azione che si propaga attraverso la rete e diventa famosa per un certo
periodo di tempo. Uno degli ultimi esempi? Harlem Shake, una serie di video
comici diventati virali all'inizio del 2013, in cui, con sottofondo la canzone
di Baauer, si susseguono due scene: una statica e tranquilla; più una caotica,
in movimento.
N come Nodo.
Stampanti, modem, computer, fax: in informatica sono
tutti dei nodi, cioè dei dispositivi hardware che sono in grado di comunicare
tra loro, e con tutti gli altri sistemi che fanno parte della stesse rete.
O come Omofilia.
Viene definita omofilia la tendenza (sulle reti sociali
ma non solo) a fare amicizia con le persone che hanno i nostri stessi interessi,
le nostre stesse opinioni, paure, e aspirazioni. E anche la nostra stessa dieta
mediatica.
P come Polarizzazione.
Indica il grado di esposizione di un internauta a
informazioni che non possono essere verificate. È uguale a uno se l'utente è
continuamente esposto a questo tipo di notizie. È invece pari a zero se non lo è
mai. Secondo gli studi di Quattrociocchi & Co., in caso di bufala virale, la
polarizzazione delle persone che la condividono tende a uno.
Q come Quantitativo.
Un approccio matematico e statistico alla comprensione
di fenomeni complessi. Che punta a sfruttare la grande mole di dati a nostra
disposizione.
R come Rinforzo.
Per rinforzo si intende la resistenza di a cambiare
idea, quando si è esposti a una versione dei fatti in contrasto con la nostra
opinione.
S come Social network.
Con il termine social network intendiamo, nel
linguaggio corrente, quelle reti sociali online che ci consentono di interagire
con altri utenti di Internet, in base a determinati, e a volte comuni,
interessi. Esempi sono: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, aNobii,
Pinterest, Google+, o il neonato Ello.
T come Troll.
La parola troll ha spesso un'accezione negativa. In
realtà, troll è sia chi interviene nei dibatti online con affermazioni fuori
luogo, provocanti, e a volte offensive, sia chi vuole semplicemente fare
dell'ironia su chi sulla Rete si prende troppo sul serio. Non sono - quindi -
sempre e necessariamente "cattivi".
V come Virale.
Si usa il termine virale per indicare un'informazione
che si diffonde velocemente. Come un virus o quasi. Alessandro Vespignani,
fisico ed esperto di modelli previsionali, conferma che ci sono delle
somiglianze tra la circolazione in Rete delle notizie e il mondo biologico. Ma
anche delle differenze. Dice: "A difenderci dai virus è il nostro sistema
immunitario. Quando parliamo di informazione, invece, il mondo esterno ha un
forte effetto sulle probabilità di contagio. E se la notizia a cui siamo esposti
arriva da un amico, da una persona di cui ci fidiamo, o che ha i nostri stessi
interessi, potrebbe avere un peso maggiore. Insomma, si tratta di un meccanismo
molto più complesso".
W come World Economic
Forum.
Il World Economic Forum è una fondazione senza fini di
lucro nata nel 1971. Di recente ha sottolineato come la "disinformazione
digitale" sia "uno dei principali rischi della società moderna". Quali sono le
sue potenzialità sulla vita reale? Ad esempio, citano nel report redatto nel
2013, dei tweet falsi hanno avuto la capacità di muovere il mercato finanziario.
Come quando nel giugno del 2012 un falso utente di Twitter, che si spacciava per
il Ministro degli Interni russo Vladimir Kolokoltsev, ha annunciato la morte, o
il ferimento, del presidente siriano Bashar al-Assad. Il prezzo del petrolio è
schizzato alle stelle, fino a che i commercianti si sono resi conto: si trattava
di un falso.
Ingannato da un falso
impeccabile,
commenta Riccardo Stiglianò. Un paio di anni fa avevo dato un annuncio dal blog
del giornale: il mio nome figurava, tra quello di Larry Page e Tim Berners-Lee,
su uno studio scientifico a proposito di istruzione online. Sedere a destra del
padre di Google e a sinistra di quello del web sul frontespizio di A Case for
Reinforcement Learning era un risultato di tutto rispetto per un cronista,
ancorché con qualche infarinatura tecnologica. Peccato che fosse - ovviamente,
vorrei dire, ma il seguito prova che è meglio non dirlo - tutto falso.
L'apparenza dello studio, ancora consultabile, era impeccabile: un abstract, dei
capitoletti in inglese, note a piè di pagina. Vari conoscenti si erano
rallegrati via email. Un mio amico molto intelligente, scaltro e in quel caso
frettoloso mi aveva fatto i complimenti addirittura su Twitter e mi ero sentito
in colpa di averlo involontariamente trascinato in quella trappola goliardica.
Eppure sarebbe bastato leggere sino in fondo il mio breve testo per accorgersi
di un post scriptum che confessava il trucco, ovvero che lo studio era frutto di
SCIgen - An Automatic CS Paper Generator, un generatore automatico creato da
alcuni programmatori del Mit. Così convincente che in un caso sarebbero
addirittura riusciti a farne accettare un paper, altrettanto farlocco, in una
conferenza scientifica dai controlli assai laschi. La quale, dopo la gaffe che
ricorda da vicino l'affaire Sokal, una bufala che nel '96 aveva scosso
l'establishment intellettuale newyorchese, sembra aver chiuso i battenti. Cosa
sto cercando di dire? Che il falso, nell'èra della sua riproducibilità tecnica,
è diventata una commodity. Un prodotto a bassissimo valore aggiunto, da produrre
in serie senza sforzo. Ci sono siti che vi recapitano in Val Brembana
impeccabili patenti del Wisconsin, altri per stamparsi perfette ricevute
illegali o app che ricreano rumori di sottofondo pertinenti al vostro alibi
extra-coniugale ("Cara sono alla stazione" e parte lo sbuffo della locomotiva o
l'annuncio delle partenze imminenti). Per non dire degli spacci di prodotti
fisici contraffatti, dalle borse di Louis Vuitton alle medicine sino alle parti
di ricambio degli aerei (Alibaba, prima di diventare una rispettabile
superpotenza di commercio elettronico, era famoso per questo). C'è un mondo di
contraffazione digitale, fai-da-te o consegnata a destinazione da zelanti
falsari. Negarlo sarebbe folle, ma enfatizzarlo come spesso si tende a fare è
fuorviante. L'argomento implicito di chi lancia questo allarme è: internet è un
posto molto inaffidabile e quindi pericoloso (a differenza del piccolo mondo
antico di mattoni e cemento, lineare e sincero). Ed è un argomento risibile,
perché se è vero che è più facile falsificare è anche vero che è molto più
semplice smascherare i falsi. Con Google e Wikipedia siamo tutti in grado di
diventare formidabili fact checker. In teoria, almeno, perché confrontare,
scriminare, contestare è una fatica. Anzi, a essere più precisi, un lavoro.
Quello che fanno, bene o male, i giornalisti. Il dibattito è vecchio come la
rete, e non è il caso qui di rivangarlo. Dico solo che nei primi anni 90 il
bestsellerista Michael Chricton annunciò l'imminente scomparsa dei giornalisti
in quanto mediasaurus, dinosauri dei media. Non c'era più bisogno di loro perché
tutti potevano andare direttamente alla fonte delle informazioni. Che è vero,
però così facendo non avreste più tempo per fare il vostro di lavoro, quale esso
sia. Pensateci la prossima volta che vi lamentate nel tirare fuori 1 euro o 40 o
il corrispettivo per una copia digitale. La differenza tra un software a
pagamento e uno free, disse una volta (con evidente conflitto di interessi) l'ad
di Microsoft Steve Ballmer, è che nel primo caso a testarlo erano stati i
programmatori, nel secondo le cavie eravamo noi. Lo stesso, più o meno, vale per
le tante informazioni che circolano allo stato brado nel cyberspazio. Vale, per
tutte, la prima raccomandazione delle scuole di giornalismo americane: When
your mother says I love you, double check it (quando tua madre dice che ti
ama, verificalo e controverificalo). Enunciata ben prima di internet e fresca
come non mai. Altrimenti si rischia di credere a tutto, compreso che
all'estensore di queste poche righe manchi solo la peer review prima di essere
pubblicato con tutti gli onori su Science o Nature insieme al Dio dell'algoritmo
e al creatore del world wide web.
FAMILISMO AMORALE. LE
GUERRE PER L'EREDITA' DEGLI ARTISTI.
Anche per Totò, il principe,
ci furono due funerali. Una folla immensa e commossa diede l'ultimo saluto al
grande attore. ''A Roma 30mila e nella sua Napoli 150mila'' dice il cinegiornale
Luce del 24 aprile del 1967, che titolò il servizio: ''Il principe e la
marionetta''.
La morte di Pino Daniele. Due
verità sulle ultime ore. L’ex moglie rilancia: era svenuto, ritardi nei
soccorsi. Amanda: ha deciso lui. Furto nella villa in Maremma. L’autopsia:
confermata l’insufficienza cardiaca, scrive Fulvio Fiano su “Il Corriere della
Sera”. Non poteva essere l’autopsia a dare una risposta alle domande sulla
scomparsa di Pino Daniele, che - come appurato dall’esame effettuato ieri - è
morto per insufficienza cardiaca (e dietro l’asciutta formula ci sono i
vent’anni di gravissimi e ben noti problemi al cuore del cantautore, anche
questi confermati dai medici incaricati dalla procura). Di altro tipo sono i
dubbi rilanciati anche ieri dalla seconda moglie dell’artista, Fabiola
Sciabbarrasi: «Qualcosa è andato storto, Pino stava molto male e la scelta di
portarlo in auto in un ospedale lontano oltre 150 chilometri non me la spiego».
Il dolore delle parole non fa sconti alla rivale in amore e ultima compagna del
bluesman, Amanda Bonini, di avergli quanto meno prestato soccorsi (e consigli)
inadeguati. «Pino era svenuto non avrebbe potuto decidere lui di andare a Roma»,
accusa la prima. «Era lucido, ha detto lui di metterci in auto», replica la
seconda. Una doppia verità che segna una distanza tra le due famiglie marcata
già dalle divisioni sui funerali, replicati a Napoli poche ore dopo Roma. Se
quel viaggio si potesse e dovesse evitare resta una valutazione soggettiva, in
mancanza di una diagnosi medica diretta sul malore. L’unico consulto, che ha
preceduto la chiamata, poi annullata, al 118, c’è stato al telefono con Achille
Gaspardone, che in tutti questi anni lo ha avuto in cura, con successo: «Pino
stava sufficientemente bene - racconta il cardiologo -. Mi ha detto che aveva un
senso di malessere, ma non mi ha trasmesso l’ansia di una situazione grave».
Sintomi analoghi c’erano stati già in passato e in quei casi Daniele aveva
preferito farsi visitare di persona dal medico di fiducia: «Ho parlato sia con
lui che con la compagna - continua Gaspardone - e gli ho consigliato di chiamare
l’ambulanza». Quindi, prosegue lo specialista, «credo abbia chiamato e poi
disdetto perché stava sufficientemente bene, era piuttosto stabile e preferiva
andare in un ambiente dove era conosciuto. Poi tutto è precipitato come può
succedere nei casi di ischemia miocardica». Daniele, 59 anni, è arrivato nella
Capitale dopo oltre un’ora d’auto, quando era già morto. Si sarebbe potuto
salvare con un intervento più tempestivo? «Sarebbe prematuro e senza alcuna
oggettività dirlo adesso», sottolinea Vittorio Fineschi, uno dei medici
incaricati dell’esame (presenti i periti nominati da Fabiola Sciabbarrasi).
L’autopsia è durata tre ore e mezza e darà ulteriori risultati nei prossimi
giorni con gli accertamenti in programma su campioni prelevati. Dopo la folla
dei giorni scorsi, l’artista era solo nella camera mortuaria. Tanti invece gli
amici e parenti di un 21enne ucciso la scorsa notte in una storia di camorra. La
salma del cantante è tornata in serata a Roma, al cimitero di Prima Porta, per
la cremazione. Acquisita all’inchiesta per omicidio colposo (a carico di ignoti)
la documentazione medica pregressa. E al ritorno nella villa in Maremma un’altra
brutta notizia per la famiglia del cantautore. La serratura di una porta
finestra sul retro scardinata ha aperto l’ex podere alla razzia dei ladri.
Rubati contanti e due preziose chitarre. A dare l’allarme, ieri pomeriggio, è
stata Amanda Bonini. La villa, in una zona isolata, con un ampio giardino
attorno e le mura di cinta delimitate da cipressi, non è dotata di
videosorveglianza ma di un sistema d’allarme che però sarebbe stato divelto dai
ladri, entrati nella proprietà dopo aver scavalcato la recinzione. Secondo i
primi accertamenti dei carabinieri di Orbetello il furto sarebbe avvenuto la
sera in cui centinaia di migliaia di persone piangevano l’artista scomparso.
Battisti, Pavarotti, Dalla:
quando la morte finisce in lite.
La decisione sulle esequie e le battaglie per l’eredità. All’origine un incrocio
di affetti privati, scrive Renato Franco su “Il Corriere della Sera”. Quei
nemici di casa. “Parenti serpenti” (Mario Monicelli, 1992), ma anche “Fratelli
coltelli” (Maurizio Ponzi, 1997). La famiglia che da vincolo di solidarietà e
fratellanza si trasforma in groviglio di attriti. La battuta di Kipling («tre
italiani, tre partiti politici») nel momento solenne della morte diventa «tre
parenti, tre opinioni diverse». Se poi i parenti sono pure di più il caos è
esponenziale. Nelle famiglie - larghe o allargate che siano - ognuno vuole dire
la sua quando arriva l’ora di funerali & eredità. Ma basta anche una testa sola,
ma tenace, come quella della vedova di Lucio Battisti a rendere complicati
omaggi e celebrazioni.
Grazia Veronese, vedova
Battisti, negli anni ha sempre cercato di bloccare tutte le manifestazioni di
omaggio al cantautore tanto a Poggio Bustone (Rieti) dove era nato quanto a
Molteno (Lecco) che aveva eletto a buen retiro. Ora sarà la Cassazione a
decidere la legittimità o meno del Festival «Un’avventura, le emozioni» che si è
sempre tenuto a Molteno. Nel frattempo per scoraggiare il pellegrinaggio dei fan
sulla tomba di Battisti, ha deciso che le spoglie avrebbero lasciato il
cimitero. Sono rimaste solo le canzoni.
Non è stata semplice la
gestione dell’eredità Pavarotti. Il tenore morto nel 2007 ci mise del suo,
facendo diversi testamenti. Mentre all’indomani del funerale spuntò un’amica che
accusò la seconda moglie, Nicoletta Mantovani, di isolarlo dalle figlie avute
dal primo matrimonio. Ci fu anche un’inchiesta della procura di Pesaro, a carico
di ignoti, su una presunta circonvenzione di incapace quando Pavarotti prima di
morire ridefinì eredità ed eredi. Alla fine pace fu: Nicoletta Mantovani e le
tre figlie nate dal matrimonio con Adua Veroni hanno raggiunto un accordo per la
divisione dei beni immobili.
Per Lucio Dalla nessun
testamento, cinque eredi e un grande escluso. Gli eredi sono i cinque cugini
(con i figli sono in 10 ad avere voce in capitolo), il grande escluso è quel
Marco Alemanno che ha convissuto con il cantante fino alla sua morte. Quindici
anni insieme, ma per la legge sono nulla.
FAMILISMO AMORALE (E
PATRIMONIALE) - LA GUERRA TRA MADRE E FIGLIO, PER IL TESTAMENTO DI ORIANA
FALLACI, È SOLO L’ULTIMO EPISODIO DI UNA FICTION SGUAIATA CHE VEDE LE COSIDDETTE
‘FAMIGLIE PER BENE’ PRENDERSI A CALCI IN FACCIA PER L’EREDITÀ - E’ ACCADUTO IN
CASA AGNELLI, CON LA FAIDA TRA MARGHERITA E MARELLA CARACCIOLO - TRA IL FIGLIO
ADOTTATO DI RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO - FINIRONO IN TRIBUNALE ANCHE I
QUADRI DELLA COLLEZIONE DI CARMELO BENE E LE VILLE DI PAVAROTTI…
Francesco Persili per "Il
Messaggero".
Dynasty all'italiana. La battaglia sull'eredità di Oriana Fallaci è solo
l'ultima puntata di una saga di contenziosi giudiziari e appetiti patrimoniali
che ha visto dilaniarsi i rapporti all'interno delle grandi famiglie del
capitalismo italiano e ha raccontato di lotte senza esclusioni di veleni per le
grandi fortune di Guttuso, Carmelo Bene, Pavarotti. Più che la storia di
un'eredità contesa, è la fotografia in chiaroscuro della più grande dinastia
italiana, la guerra degli Agnelli che ha opposto la figlia Margherita alla
madre, Marella Caracciolo, al resto della famiglia, e ad alcuni fra i più
importanti avvocati e manager dell'Avvocato. Una disfida sul patrimonio che ha
portato la mamma di John, Lapo e Ginevra Elkann a «sentirsi danneggiata dagli
accordi ereditari con cui sono stati spartiti i beni del padre Gianni» e ad
avviare, prima della pax, una battaglia legale che ha riguardato ville, società,
quadri, proprietà e un presunto «tesoretto» di un miliardo di euro. Un altro
conflitto che sa di maledizione è quello che ha visto protagonisti gli eredi
Formenton e Mondadori sullo sfondo di quella partita di complessi equilibri e
battaglie legali mai finite tra Berlusconi e De Benedetti che passerà alla
storia come guerra di Segrate. Si trasforma in un feuilleton, invece, la contesa
testamentaria sull'eredità di Renato Guttuso, che disvela una lunga controversia
tra la musa del grande pittore siciliano, Marta Marzotto, e il figlio adottivo,
Fabio Carapezza, designato dall'artista di Bagheria, in punto di morte, suo
erede legittimo. La contessa viene accusata dalla magistratura di Varese di aver
realizzato in concorso con lo stampatore, Paolo Paoli, e senza l'autorizzazione
dell'erede legittimo dell'artista, settecento copie di opere che il pittore
siciliano le aveva regalato negli anni del loro grande amore. Marzotto esibisce
la fotocopia di una lettera autografa di Guttuso, datata «Roma 23 settembre
1986» con la quale l'artista la autorizzava a riprodurre le sue opere. La
vicenda si trascina per anni, il giudice della corte di Appello dà ragione a
Marzotto, inizialmente condannata, anche se Fabio Carapezza continua ad essere
il solo titolare dell'eredità Guttuso. Un altro artista, la cui eredità diventa
un caso giudiziario internazionale al punto da coinvolgere la magistratura
italiana, quella francese, e quella del principato di Monaco, è Alberto Burri,
il cui patrimonio viene conteso tra il fratello della vedova, la ballerina e
coreografa americana, Minsa Craig, e la fondazione dedicata al maestro umbro. La
controversia si è chiusa nel 2007 con un accordo che stabilisce che tutte le
opere e i beni del maestro spettano alla Fondazione a lui intitolata mentre ai
parenti di Minsa Craig sarebbe stata destinata la parte di patrimonio che aveva
ereditato da Burri. Tre De Chirico, una tela di Dalì, un dipinto di Kandinskij,
un disegno di Tirinnanzi nel quale Carmelo Bene amava specchiarsi, e altri
oggetti d'arte sono le opere, invece, al centro del contenzioso tra Raffaella
Baracchi, vedova dell'attore e madre della sua unica figlia Salomè, e l'ultima
compagna di Bene, Luisa Viglietti, accusata di furto aggravato e continuato. Se
il Tribunale civile di Roma ha definitivamente affermato che gli unici eredi
dello scrittore Giorgio Bassani sono i figli Paola ed Enrico, rigettando
l'impugnazione del testamento avanzata da Portia Prebys, l'insegnante americana
che è stata la compagna del romanziere negli ultimi vent'anni di vita, l'eredità
di Luciano Pavarotti ha detto della battaglia tra le figlie nate dal matrimonio
con Adua Veroni e l'ultima moglie Nicoletta Mantovani. Il contenzioso si è
risolto con l'assegnazione a Nicoletta degli immobili newyorchesi, mentre alle
figlie restavano la villa di Pesaro, l'appartamento di Montecarlo e alcune
proprietà italiane, oltre a una cospicua somma di denaro. Si è conclusa, invece,
con una transazione la controversia, condotta a colpi di carte bollate,
richieste di prova del Dna e bordate a mezzo stampa, sull'eredità del conte
amateur Carlo Caracciolo, tra gli editori più importanti d'Italia, presidente
del gruppo L'Espresso e fondatore del quotidiano La Repubblica. Carlo Edoardo e
Margherita Revelli, che alla morte dell'editore avevano chiesto il
riconoscimento di paternità per poter partecipare all'eredità, si sono visti
assegnare parte dell'11,72% dell'Espresso, che alla morte di Caracciolo, era
passato a Jacaranda Falck. Un compromesso che fa calare il sipario su una serie
vicissitudini dinastiche ché tanto, poi, come scriveva Tolstoj, «le famiglie
felici si somigliano tutte mentre ogni famiglia infelice è infelice a modo suo».
Specie quando c'è di mezzo l'eredità.
Eredità, da Fallaci a
Pavarotti: i contenziosi sulle grandi fortune, scrive Adnkronos. La guerra tra
le figlie del tenore modenese e Nicoletta Mantovani; Marta Marzotto contro il
figlio adottivo di Renato Guttuso, Fabio Carapezza. Aspra la contesa tra la
vedova di Burri e la fondazione intestata all'artista.
La battaglia legale sull'eredità di Oriana Fallaci, scomparsa nel 2006, è un
ulteriore capitolo che si aggiunge alla storia dei contenziosi giudiziari che si
aprono ogni volta che muore un grande personaggio. Da Pavarotti a Guttuso, da
Burri a Bassani a Carmelo Bene, le guerre tra gli eredi hanno sempre riempito
pagine di cronaca e aule di tribunali. L'ultima in ordine di tempo è quella che
riguarda l'eredità di Luciano Pavarotti. Il tenore modenese è scomparso nel
2007, un anno dopo la Fallaci, ma nel caso di Big Luciano la battaglia si aprì
subito tra le figlie della prima moglie e Nicoletta Mantovani. Nel testamento
depositato dal notaio Luciano Buonanno, uno dei tre in circolazione, il tenore
scriveva che il 50% del suo patrimonio sarebbe stato diviso tra le quattro
figlie, il 25% sarebbe andato alla moglie e il restante 25 avrebbe
rappresentato, invece, la 'disponibile', di cui il testatore poteva fare quello
che riteneva opportuno. Il contenzioso tra Mantovani e le tre figlie del tenore,
nate dal matrimonio con Adua Veroni, si sarebbe risolto un anno dopo con
l'assegnazione a Nicoletta degli immobili newyorchesi, mentre alle figlie
restava la villa di Pesaro, l'ambito appartamento di Montecarlo e alcune
proprietà italiane, oltre a una cospicua somma di denaro liquidata loro da
Nicoletta Mantovani. Un altro contenzioso giudiziario che ha fatto epoca è
quello per l'eredità del grande pittore siciliano Renato Guttuso, scomparso il
18 gennaio 1987. La magistratura ha sempre dato ragione a Fabio Carapezza,
l'allora giovane funzionario del ministero degli Interni che, Guttuso,
gravemente malato e prostrato dall'improvvisa morte della moglie Mimise Dotti,
aveva adottato nell'ottobre 1986 e, sul letto di morte, designato suo erede
legittimo. Fu un'adozione lampo (tutto, dall'istanza alla sentenza, si svolse
nel solo mese d'ottobre al Tribunale di Roma) dichiarata senz'ombre da altri
giudici che hanno rigettato le denunce dei nipoti Dotti. All'epoca dell'adozione
Carapezza aveva 32 anni. Quanto a Marta Marzotto, a lungo sua musa ispiratrice e
amante, non ha mai dimenticato come fu emarginata da Palazzo del Grillo,
casa-studio a Roma del pittore, nei giorni dell'agonia di Guttuso e della sua
improvvisa conversione. Nel febbraio 2006 la Marzotto è stata accusata dalla
magistratura di Varese di aver realizzato in concorso con lo stampatore, Paolo
Paoli, senza l'autorizzazione dell'erede legittimo dell'artista, Fabio Carapezza
Guttuso, 700 copie di opere che il pittore siciliano le aveva regalato negli
anni del loro grande amore. E questo è solo l'ultimo processo della serie. Senza
il consenso dell'erede di Guttuso, Marta Marzotto aveva fatto incollare sul
retro delle opere una sorta di personale autentica. Si trattava della fotocopia
di una lettera autografa di Guttuso, datata 'Roma 23 settembre 1986', con la
quale l'artista autorizzava l'ex contessa a riprodurre le sue opere, in diversi
materiali (carta, ceramica etc.) per lo scopo che lei avrebbe ritenuto
opportuno. Peccato, però che, all'improvviso poche settimane dopo adottò Fabio e
lo nominò suo erede, e che quella lettera non essendo stata autenticata da un
notaio non aveva nessun valore legale. Il 16 aprile 2002 la Cassazione ha,
infatti, confermato le pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano:
Fabio Carapezza Guttuso è il solo titolare dell'eredità Guttuso. Dal civile al
penale: Fabio Carapezza Guttuso ha portato alle sbarre la ex contessa. "Ma
niente di personale, in giro per l'Italia ci sono 40 processi contro chi ha
riprodotto o contraffatto opere di Guttuso", dichiarò. Dopo la morte del
pittore, il figlio adottivo ha fondato gli Archivi Guttuso, cui ha destinato lo
studio di Piazza del Grillo, e ha integrato la collezione del museo di Bagheria.
Ben più intricata la vicenda giudiziaria scatenatasi dopo la morte dell'artista
umbro Alberto Burri, scomparso a Nizza nel 1995, che ha coinvolto le
magistrature italiana, francese e quella del Principato di Monaco. Il
contenzioso si è concluso nel 2007 con un accordo che stabilisce che tutte le
opere e i beni del maestro spettano alla Fondazione a lui intitolata. Il
patrimonio di Minsa Craig, vedova dell'artista, ballerina e coreografa
americana, andrà invece al fratello Cecil e agli altri parenti. Ma la fortuna
lasciata da Burri era stata contesa, in un primo momento, tra la vedova e la
Fondazione dedicata al marito. Nel 2001 la tregua davanti al notaio: alla
fondazione spettevano tutte le opere custodite nell'ex essicatoio del tabacco di
Città di Castello, a palazzo Albizzini e nell'abitazione del maestro, mentre a
Minsa Craig andavano il casale, i terreni, le ville in Francia incluso tutti i
beni che vi erano custoditi e una cospiciua somma di denaro. A riaprire il
contenzioso fu il fratello 85enne di Minsa, quando questa scomparve nel 2003.
L'accordo raggiunto ha quindi rispettato quello precedente tra la fondazione e
la vedova, destinando ai parenti di quest'ultima la parte di patrimonio che
aveva ereditato dall'artista umbro. Risale al 2003, invece, la chiusura della
battaglia giudiziaria per ereditare i beni lasciati dallo scrittore Giorgio
Bassani, scomparso all'età di 84 anni il 13 aprile 2000. La quarta sezione del
Tribunale civile di Roma, a marzo di quattro anni fa, ha definitivamente
affermato che gli unici eredi dell'autore del capolavoro 'Il giardino dei Finzi
Contini' sono Paola ed Enrico Bassani, rigettando l'impugnazione del testamento
avanzata da Portia Prebys, l'insegnante americana che è stata la compagna del
romanziere negli ultimi vent'anni di vita. A promuovere la causa civile era
stata Portia Prebys, che aveva chiesto al Tribunale di diseredare i figli dello
scrittore "per indegnità a succedere al padre". Questa richiesta era l'ennesimo
atto di una battaglia legale tra i figli e la compagna del loro anziano padre.
"Finalmente, ora, questa sentenza, dopo anni di aspra contesa, ha riconosciuto
che i figli del professor Giorgio Bassani sono gli unici eredi, respingendo le
pretese finora avanzate dalla sua ex convivente, e riconoscendo ai figli quel
ruolo morale e affettivo che essi hanno sempre rivendicato con decisione e
fierezza", aveva commentato in quell'occasione l'avvocato Alessandro Mete,
legale di Paola ed Enrico Bassani. In base al testamento del romanziere, aperto
a Roma a metà maggio del 2000 (depositato dal notaio Livio Colizzi presso
l'Ufficio successioni del Tribunale civile di Roma), gli unici eredi sono Enrico
e Paola Bassani, avuti dalla moglie Valeria Sinigallia, con il quale era
separato di fatto. Quel testamento olografo, cioè scritto di pugno, fu steso
dallo scrittore ferrarese il 13 luglio 1997. Questo atto notarile ha annullato
il precedente testamento redatto nel 1991, nel quale era inclusa tra i
beneficiati dall'eredità anche Portia Prebys. Il testamento del 1997 nomina
eredi universali i due figli, i quali sono impegnati espressamente dal padre "a
curare con sensibilità ed amore la pubblicazione e la diffusione delle mie
opere". Prebys aveva chiesto dichiarare nullo questo testamento, ma il Tribunale
civile, nel 2003, ha rigettato l'istanza. Tre De Chirico, una tela di Dalì, un
dipinto di Kandinskij, un disegno di Tirinnanzi nel quale Carmelo Bene amava
specchiarsi, e altri oggetti d'arte. Sono le opere al centro del contenzioso tra
la vedova dell'attore e madre della sua unica figlia Salomè, Raffaella Baracchi,
e l'ultima compagna di Bene, Luisa Viglietti, finito in tribunale con una
denuncia per furto aggravato e continuato fatta dal pm Fabio Santoni ai danni di
Viglietti. E Baracchi si è costituita parte civile. La vedova dell'attore, ex
Miss Italia '83, che fece coppia con Bene, scomparso nel 2002, dal 1988 al 1992,
ha sempre detto di volere tutelare la figlia che oggi ha 19 anni. Moglie e
figlia avevano ottenuto l'eredità, pari a circa 3 milioni di euro, nel 2005,
dopo che il Tribunale ha condannato la Fondazione 'L'Immemoriale di Carmelo
Bene' a rinunciare ai beni che lo stesso attore e regista aveva assegnato alla
Fondazione in due testamenti, redatti il 6 ottobre 2000 e il 21 giugno 2001.
Bene infatti non aveva lasciato nulla alla moglie, mentre alla figlia Salomè
aveva intestato la metà delle quote (l'altra metà come tutto il resto andava
alla Fondazione) della società 'Nostra Signora' che gestisce i diritti d'autore
e l'appartamento di via Aventina a Roma. All'ultima compagna, Luisa Viglietti,
accusata di furto, Bene aveva lasciato il diritto di abitare una parte della
casa rimasta a Salomè. Una vicenda intricata nella quale si innestano anche le
rivendicazioni della sorella del regista, Maria Luisa Bene, che si è rivolta in
Tribunale più volte chiedendo di far luce sulle circostanze della morte del
fratello.
NEOREALISMO E MODA.
Il neorealismo di Dolce e
Gabbana.
«All’Italia del Dopoguerra ha dato un’immagine fortissima. Adesso invece c’è chi
pensa che “troppo italiano” sia volgare. Che errore», scrive Paola Pollo su “Il
Corriere della Sera”. «Siamo stilisti, non costumisti». Domenico Dolce e Stefano
Gabbana mettono subito le cose in chiaro. Non sia mai che qualcuno fraintenda:
tra loro e il cinema, anzi il cinema neorealista, è «solo» amore, passione,
attrazione. Nonché fonte inesauribile di ispirazione. Così se a New York sono i
supporter di «Costumes for Cinema from Tirelli Atelier», esposizione dei capi
della sartoria romana creata per i più famosi film, al MoMi (Museum of Moving
Arts) è solo perché, nella vita, ad un certo punto tutto torna. Ecco cosa.
Inaugurazione, serata, premio (agli stilisti per il «Fashion Award»; a Baz
Luhrman per il «Movie Award») e installazione «Nero Sicilia» (24 look uomo e
donna dall’archivio).
«È che quando ci è stato
chiesto di collaborare a questa iniziativa, per noi è stato come andare a
nozze». Tirelli, cioè il Gattopardo: «Erano i primissimi anni e ci ispiravamo a
quelle immagini. Ma eravamo giovani non sapevamo chi aveva fatto quegli abiti.
Quando lo scoprimmo decidemmo di commissionare a Tirelli l’abito bianco della
Cardinale. Volevamo capire se eravamo sulla strada giusta. E quando arrivò ci
piaceva certo, ma era così rigido e pesante! Ecco la differenza fra lo stilista
e il costumista, ci siamo detti».
Però è anche vero che il
neorealismo ce lo avete nel sangue.
«Di più è il nostro mondo. La
prima musa fu la Magnani, poi la Loren: mediterranee e formose, sempre le stesse
donne».
Possibile che non siete mai
stati tentati dagli abiti di scena?
«Ce l’hanno chiesto ma il
lavoro del costumista è conoscere, veramente, la storia. Noi ne siamo solo
incuriositi. Comunque anche quando lavoriamo con Tornatore e Scorsese per i
nostri film chiariamo subito che agli abiti ci devono pensare loro perché la
moda in quelle immagini non la vogliamo vedere».
Quindi in un film la moda
non dovrebbe mai prendere il sopravvento sul resto?
«Assolutamente no».
Ma ci sono grandi film
imprescindibili dalla moda…
«Come colazione da Tiffany,
certo. Ma adesso non può essere più così».
Al successo di «Sex in the
city» hanno contribuito anche abiti e scarpe.
«E hanno usato anche molti
nostri capi, certo. Ma in quei filoni gli abiti durano cinque minuti, poi via un
altro».
Facile raccontare ora di
voi e il neorealismo, ma quando avete cominciato era a dir poco bizzarro che due
poco più che ventenni guardassero a quel mondo.
«Le nostre prime due
collezioni parlavano di super modernismo e trasformismo: un vestito poteva
diventare tre abiti diversi. Ma fu un insuccesso commerciale: arrivavano i capi
e non sapevano neppure come appenderli alle grucce e ci volevano le istruzioni
per indossarli. Detto questo: il nero e la femminilità c’erano. Poi a Palermo
vedemmo quella locandina con una donna nuda avvolta in uno scialle nero al
balcone di un palazzo barocco! “Questo dobbiamo fare noi”, ci siamo detti. Era
il 1986. Silvana Torregrossa, un’amica, ci disse che il fotografo era Ferdinando
Scianna. E lì nacque tutto. Lo cercammo come pazzi, all’ultimo tentativo lui
rispose, salvo scoprire che quella foto non era sua ma lui era l’uomo giusto».
Stefano Gabbana: «Io poi ero
attratto da quel mondo che non conoscevo. Domenico invece mi diceva che ero
pazzo a parlare di uncinetto e che lui era scappato da quelle cose e che aveva
buttato via tutti i portaombrelli di ceramiche! Io adoravo. Milanese con
genitori veneti, ero sempre stato infatuato dal Sud. Poi comunque mia nonna
vestiva di nero e con il fazzoletto in testa. Quindi era un immagine che
conoscevo». Domenico Dolce: «Al liceo mi ero iscritto ai cineforum e andavo a
vedermi tutti i film dedicati a Visconti. Ricordo che mi era innamorato di Morte
a Venezia. Ma a quell’età non è che sei attratto dall’estetica, non sapevo
neanche che avrei fatto questo lavoro».
I film cult e gli abiti di
conseguenza?
«“La terra trema”, con gli
abiti sdruciti di Tony; “Rocco e i suoi fratelli” e le maglie di Delon,
“Bellissima” con i tailleur e le sottovesti della Magnani, “Ossessione” e le
canotte bianche di Massimo Girotti».
Il neorealismo oggi?
«Giuseppe Tornatore. Ma
viviamo in un’epoca dove tutto è troppo ritoccato e dove ognuno vuole dire la
sua. La presa diretta è impossibile. Il neorealismo rappresentava un Paese, che
era l’Italia nel Dopoguerra, un’immagine fortissima. Adesso addirittura la gente
pensa che il troppo italiano è volgare. Peccato perché non è così La «Grande
bellezza? «Meraviglioso ma tristemente vero. E fa pure un po’ male: tutte quelle
donne rifatte e ansiolitiche. E anche lui che perde il suo tempo in feste quando
potrebbe scrivere. Lo specchio dei tempi: cioè la ciafferia. Ma non ci piace
perché noi siamo romantici e sognatori e vogliamo che le donne siano belle e
reali».
CHE QUALCUNO LA RACCONTI
GIUSTA! LA STORIA NON SIAMO NOI……
Ai posteri l'ardua
sentenza. Così si suol dire. Ma noi siamo capaci di giudicare, specialmente noi
stessi?
Le sentenze di assoluzione
sono una vergogna! Scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Le sentenze sono
di due tipi. Quelle di condanna e quelle di assoluzione. Se sono di condanna
vanno bene, e sanciscono il fatto che il condannato è colpevole. Su tutti i
giornali si dichiara in modo solenne e devoto: le sentenze (di condanna) si
eseguono, non si commentano. E soprattutto non di discutono, non si
criticano, non si protesta contro di loro, non le si dichiara ingiuste. Una
condanna vale la verità. Il secondo tipo di sentenze sono le sentenze di
assoluzione. Queste sentenze sono una vergogna. Per definizione sono una
vergogna. E infatti, in genere, in aula c’è un bel gruppetto di persone che
grida: “vergogna, vergogna”. E se non c’è, il giorno dopo molti giornali
titoleranno così: “Vergogna”. Oppure, in modo più efficace, titoleranno:
“delitto tal dei tali, non lo ha commesso nessuno”. O: “Nessun colpevole”.
Negando la possibilità che qualcuno abbia commesso il delitto ma non sia stato
scoperto, cosa che ogni tanto succede. Le sentenze di condanna, per definizione,
non si discutono. Le sentenze di assoluzione, per definizione, sono una
vergogna. Come mai? Semplice. Il processo penale, da qualche anno, non si
celebra più nelle aule dei tribunali ma molto prima. Quando un Pm emette un
avviso di garanzia, il processo è già svolto, di fatto, e l’avvisato, o
l’indagato, è – di prassi – considerato colpevole del delitto del quale è
accusato. Non c’è bisogno di nessunissima sentenza. Da quel momento si inizia a
eseguire la prima parte della condanna che talvolta è il carcere preventivo, il
quale può durare anche molti anni, altre volte è la gogna realizzata attraverso
giornali e Tv, altre volte è tutte e due le cose. In più c’è spesso la perdita
del lavoro, gigantesche spese per pagare gli avvocati, problemi di salute, di
tenuta nervosa, eccetera. Poi, molti anni dopo, la magistratura giudicante
emette la sentenza, ma è chiaro che la sentenza deve essere di condanna, visto
che l’imputato è colpevole, altrimenti non sarebbe stato indagato. E se invece
la sentenza è di assoluzione, e dunque nega l’evidenza che l’imputato, in quanto
imputato, è colpevole, allora è chiaro che è una sentenza vergognosa. Perché è
una vergogna mandare assolti i colpevoli, per di più dopo che comunque hanno già
scontato (col carcere e con il letame) gran parte della condanna. E i giudici
che mandano assolto un imputato sono corrivi, anzi fetenti. A quel
punto conta poco anche il capo di imputazione. Ieri, per esempio, “Il Fatto” ha
spiegato che l’assoluzione degli scienziati che erano stati messi sotto accusa
(come poteva succedere solo in Corea del Nord) per non aver previsto un
terremoto, equivale alla sentenza di assoluzione degli agenti che erano accusati
di avere ucciso a botte Stefano Cucchi. Naturalmente, in parte, questo è vero:
se non esistono prove della colpevolezza di quegli agenti – lo abbiamo già
scritto – è sacrosanto che siano stati assolti. Perché – a occhio –
l’assoluzione non dovrebbe dipendere dalla gravità della colpa ma dalle prove
raccolte contro l’imputato. Così dicono, almeno, i vecchi libri, polverosissimi,
di diritto. E però per giungere ad accostare il reato di omicidio al reato di
mancata previsione di un terremoto, bisogna metterci un bel po’ di faziosità e
pregiudizio. Credo. Ma forse mi sbaglio, non è faziosità: quelli del ”Fatto”
credono davvero che gli scienziati dovrebbero prevedere i terremoti, e conoscere
gli oroscopi, e indovinare il futuro (almeno il futuro prossimo) e altre cose
così. Anche a Salem (Massachussets) nel seicento, molti credevano che le donne
poco “timorate di Dio” fossero streghe, avessero poteri soprannaturali e fossero
al servizio del diavolo. E dunque, saggiamente, le bruciavano vive, perché
ritenevano che quello fosse l’unico modo per cancellarle per sempre. Ciascuno è
bene che sia fedele ai propri principi. Anche Travaglio. Anche Kim il Sung, o
come diavolo si chiama suo nipote.
Troppa voglia di giustizia
sommaria,
scrive Cesare Martinetti su “La Stampa”. Viviamo sull’orlo
dell’indignazione permanente. «Vergognosa» la sentenza dell’Aquila.
«Sconvolgenti» le assoluzioni dei boss della camorra nel processo Saviano. Non
parliamo di quelle del caso Cucchi. Va da sé che i parenti delle vittime del
terremoto hanno il sacrosanto diritto di chiedere giustizia. È ovvio che ci
sembra incomprensibile una sentenza che condanna l’avvocato che per conto dei
boss ha proferito miserabili minacce contro uno scrittore e assolve i mandanti.
Siamo con il cuore, e non soltanto, accanto alla signora Ilaria che per amore
del fratello morto in carcere e con un vivo sentimento di coraggio civile sta
battendosi per una causa che dev’essere di tutti. Ciò detto, però, c’è qualcosa
che non va in tutte queste indignazioni che si rivolgono contro giudici
legittimi che – salvo prova contraria – hanno pronunciato sentenze legittime in
legge e coscienza. Questo qualcosa è che nel nostro Paese è caduto il
riconoscimento del potere costituito, sia esso politico, scientifico o, come in
questo caso, giudiziario. C’è una domanda di giustizia sommaria. O arriva la
sentenza sull’onda di un’accusa costruita sull’indignazione popolare e
mediatica, rapida e senza appello, o si castigano in modo esemplare gli imputati
del caso anche se ricoprivano nella vicenda un ruolo marginale o subalterno, o è
«Vergogna, vergogna, vergogna». E tutto questo quasi sempre senza aver
analizzato o conosciuto a fondo le prove di accusa e quelle di difesa, collocato
nella giusta valutazione le une e le altre mettendosi nel difficile ruolo del
giudice che deve decidere. Condannare i sismologi per il terremoto dell’Aquila è
certamente molto popolare ed emotivamente compensatorio nei confronti dei
parenti delle vittime. Gli scienziati costituiscono un capro espiatorio ideale e
paradigmatico per quanto caricaturale: che fa un sismologo se non sa nemmeno
prevedere un terremoto? Gli anni di galera fanno un bel titolo sul giornale. Ma
poi? Ha detto il professor Enzo Boschi, prima condannato poi assolto: «Spiegai
che il terremoto era improbabile, ma non si poteva escludere... il linguaggio
della scienza è diverso da quello dei media...». Superata l’emergenza emotiva
che chiedeva la condanna immediata ed esemplare di qualcuno in primo grado, si
va in appello, l’emozione è rarefatta e le cose appaiono un po’ diverse. Si
scopre, come quasi sempre in Italia, che le indagini sono state incomplete (caso
Cucchi) che bisognava risalire alla fonte che non è un’onnipresente Spectre
italica che obnubila, confonde, occulta una verità alla Pasolini nota a tutti:
io so chi è il colpevole, ma non ho le prove... È invece quella frantumazione di
responsabilità che si trasforma in de-responsabilità dove la burocrazia si
incrocia con la politica in un impasto oscuro e impunito. Ed è in questo strato
opaco che sta il vero scandalo, è lì che si costruisce la vera ingiustizia.
Trattasi di una procedura antica, quasi costitutiva del sistema Italia, un Paese
dove alla parola «stragi» si unisce con tragico automatismo l’aggettivo
«impunite» anche quando impunite non sono. C’è dunque un sentimento diffuso di
ingiustizia che giustifica il sospetto e l’indignazione. C’è un sistema
giudiziario dove alle inerzie corporative si sommano anni di leggi, leggine e
circolari costruite apposta per bloccare e rallentare il corso delle indagini e
dei processi. C’è un’insopportabile lentezza delle procedure. In Sud Corea ieri
è stato condannato (a 36 anni di carcere) il comandante del traghetto affondato
in primavera e 300 studenti sono morti. Era accusato di aver abbandonato la
nave. Lo chiamavano lo Schettino di Corea. Da noi il vero Schettino, dopo quasi
tre anni dal disastro è ancora sotto processo, nel frattempo ha fatto una
lezione all’università ed è diventato personaggio da paparazzare per i
rotocalchi, drammatica e patetica maschera della giustizia sospesa: ci dicano se
è innocente o colpevole. Tutto
questo è insopportabile, ma ciò non toglie che quei «vergogna» lanciati contro i
giudici senza nemmeno aver letto i perché di una sentenza siano sbagliati, come
erano sbagliati gli applausi per le condanne e gli arresti facili contro i
nemici politici o il capro espiatorio del momento. I giustizialisti, che prima
invocano le manette per gli altri e poi rifiutano le sentenze su se stessi come
il sindaco di Napoli De Magistris sostenuto dal Tar di turno, producono quella
nebbia in cui ogni «vergogna» si giustifica. Diradare questa nebbia, rendere
trasparenti e riconoscibili le responsabilità politiche e amministrative,
semplificare le procedure, sarebbe la prima riforma necessaria al Paese perché i
cittadini, innocenti, colpevoli e vittime, si riconoscano senza vergogna nel
Paese. E nella sua giustizia.
La storia non siamo più noi:
lettere e risposte su “L’Espresso".
La storia siamo noi, nessuno
si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi,
attenzione, nessuno si senta escluso.
La storia siamo noi, siamo noi
queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così
duro da masticare.
E poi ti dicono “Tutti sono
uguali, tutti rubano alla stessa maniera”.
Ma è solo un modo per
convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
Però la storia non si ferma
davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la
storia dà torto e dà ragione.
La storia siamo noi, siamo noi
che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da
perdere.
E poi la gente, (perchè è la
gente che fa la storia) quando si tratta di scegliere e di andare, te la ritrovi
tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.
Quelli che hanno letto milioni
di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia
dà i brividi, perchè nessuno la può fermare.
La storia siamo noi, siamo noi
padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo.
La storia non ha nascondigli,
la storia non passa la mano.
La storia siamo noi, siamo noi
questo piatto di grano.
Mi scuso per la citazione
integrale del bel testo di Francesco De Gregori, “La storia”, che comunque è
sempre una bella lettura, ma credo, anzi temo, che ormai la storia non siamo più
noi. Quel vento che gonfiava le vele della storia, che proveniva da lontano, che
spalancava i portoni chiusi e che, a torto o a ragione, con i suoi eccessi, le
sue atrocità, ma con le sue conquiste diede origine alla rivoluzione francese
nel 1789, dopo cui il concetto di eguaglianza tra cittadini ha trovato
ospitalità, (pur con tutte le ambiguità ed ipocrisie del caso, specie in Italia,
terra di gattopardi), quel vento ormai non soffia più. La storia ha cambiato
percorso, è sempre più in mano ad un oligopolio di poteri che pur pochi rispetto
al totale della popolazione mondiale decidono per tutti. E qui non si tratta di
tirare in ballo ipotetici complotti di “illuminati”, massoni e/o quant’altro,
pur senza volerli obbligatoriamente escludere, ma semplicemente di prendere atto
che le decisioni di una nazione, economiche e quindi sociali sono oramai
transnazionali in uno scacchiere in cui l’Unione europea, ad esempio, conta due
su dieci (figuriamoci l’Italia da sola quanto conterebbe..). Molti dicono che
questo sia il prezzo da pagare per la pace, ma ai molti io replico che la
cosiddetta pace riguarda nel caso la sola Europa, non investendo in maniera
reale e continuativa nessuno degli altri continenti tranne l’Australia e il Nord
America sino al confine con il Messico. E allora gentili forumnauti, se quanto
sopra esposto è non dico vero ma almeno verosimile e ragionevole, in questa
cultura dell’effimero (nulla a che vedere con quella dello scomparso Renati
Nicolini, che nel suo ambito era cosa seria) e dell’apparenza che proprio qui in
Italia ha preso così piede (ne dubitavate? Io no…), prendiamone atto. I
nostalgici della visione marxiana potranno sostenere che il capitalismo sta
vincendo prendendosi la rivincita sul periodo in cui per un po’ vacillò, i
liberali saranno o afasici o liberisti, destrelli e sinistrelli si ritroveranno
spiazzati perchè entrambi convinti di poter guidare il corso (e gli obiettivi)
della storia, si riscoprono invece al più pedine inutili di un gioco che non
solo li sovrasta ma li ignora. Il mondo nuovo pare non prevederli, le stesse
istanze di cui sono stati portatori si sono riamalgamate tra loro (ironia del
melting pop…) e cercano nuovi modi di rappresentanza. Su tutto pare vigere,
immanente, un precariato stabile che di fatto impedisce ogni tipo di equilibrio
e di futuro sociale che ha già da un pezzo trovato i suoi alfieri e a cui - ecco
il punto - le nuove generazioni sono state educate sino a considerarlo l’unico
futuro possibile. E i pochi gongolano mentre i molti ogni giorno di più
soffrono. Ma non accade nulla, come avvenne invece nel 1789 e per ragioni in
parte simili nel 1917 nella Russia zarista dei servi della gleba. Concludendo
oggi De Gregori la sua “Storia” non potrebbe più scriverla, perchè la storia non
siamo più noi.
La storia dei contemporanei
dopo anni va riscritti dai posteri.
Caso Moro, un mese prima di
via Fani un documento anticipava il rapimento,
scrive Gero Grassi, Vicepresidente Gruppo Pd, Camera dei Deputati, il 6 gennaio
2016 su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. I documenti ci sono da sempre ma o non
sono stati capiti, oppure sono stati accantonati perché capiti troppo bene da
parte di Governo, Magistratura, Servizi e Commissioni precedenti. In base alla
ragione di Stato. L’attuale Commissione Moro ed il presidente Giuseppe Fioroni
invece li hanno letti, riletti ed attenzionati ora, con opportune indagini e
ricostruzioni. Quale è la vicenda? Il documento originale, sotto riprodotto
fedelmente, il 18 febbraio 1978, parte da Beirut, presumibilmente dal Colonnello
Stefano Giovannone. Dice notizia riservatissima. È forse la prima notizia del
rapimento di Aldo Moro perché i terroristi, di cui parla il documento, sono le
Brigate Rosse e la Banda Baider Meinhof tedesca. La “fonte 2000” cita Habbash e
parla di operazione terroristica di notevole portata che salvaguarderebbe
impegni finalizzati ad escludere il nostro Paese da piani terroristici (Lodo
Moro). Attenzione: nella chiusura del documento si dice di «non diramare la
notizia ai Servizi collegati all’OLP» e questa è affermazione straordinariamente
importante perché conferma grandi rapporti tra parte dei nostri Servizi e
l’Organizzazione per la liberazione della Palestina. Lasciamo il documento al
lettore e, per ora, alla sua fantasia. Aggiungiamo che, in una delle lettere
scritte dal carcere delle BR, Moro cita il colonnello Giovannone, deceduto anni
dopo improvvisamente. Così come misteriosamente è “suicidato”, anni dopo, il
capitano dei carabinieri Mario Ferrario, altro protagonista di questa storia.
Analogamente sospetta è la scomparsa, nell’agosto 1980, a Beirut di due giovani
giornalisti italiani, mai più ritrovati: Graziella De Palo ed Italo Toni che
avevano denunciato la copertura, da parte dei nostri Servizi Segreti, della
internazionale e clandestina vendita di armi italiana. Il Maresciallo Oreste
Leonardi, capo scorta di Moro, a fine febbraio 1978, è fortemente preoccupato e
ai suoi superiori evidenzia necessità di maggiore protezione. Moro certamente ha
saputo di questo documento e il 15 marzo 1978, giorno prima dell’eccidio di via
Fani, chiama il Capo della Polizia, non certo per aumentare la scorta al suo
studio, come invece sostengono dopo lo stesso Capo della Polizia e i suoi
collaboratori Sereno Freato e Nicola Rana. Chiama perché sa ed ha paura. A
questo punto va citato, perché potrebbe avere grande connessione, il documento
che il 2 marzo 1978, secondo G71, al secolo il gladiatore Antonino Arconte,
parte dal Ministero della Difesa, a firma dell’Ammiraglio Remo Malusardi, Capo
della X Divisione SB (Gladio), con il quale si invita il Colonnello Giovannone
(G219), Capo dei nostri Servizi Segreti in Medio Oriente, a “prendere contatti
immediati con i Gruppi del terrorismo mediorientale al fine di ottenere
informazioni e collaborazioni per la liberazione di Aldo Moro”. 14 giorni prima
del rapimento. Io non so se la connessione tra i due documenti è certa. Le
indagini verificheranno cosa lo Stato italiano ha fatto per rispondere al
documento proveniente da Beirut. So che la perizia “Gabella” dice vero il
documento Arconte, così come so che a questo documento nessuna presta grande
attenzione e fede. Non so se Arconte dice il vero, ma è verosimile che Arconte
abbia intercettato una notizia successiva al documento Habbash. So per certo che
le armi ai palestinesi le vendevano gli italiani e che i palestinesi le hanno
date anche alle Brigate Rosse. So infine che sulla porta di casa, quella mattina
del 16 marzo 1978, negli occhi di Aldo Moro, mentre Maria Fida gli impediva di
portare insieme il figlio Luca, di due anni e mezzo, c’era la consapevolezza che
qualcosa di grave stava per succedere ed il Maresciallo Leonardi, nella
telefonata alla moglie di qualche minuto prima, aveva lanciato strani e
preoccupanti segnali di immediato pericolo.
“Il consulente di Cossiga
deve essere indagato per concorso nell’omicidio di Aldo Moro”.
La richiesta del pg Luigi Ciampoli contro Steve Pieczenik, l’ex funzionario del
Dipartimento di Stato americano coinvolto nell’unità di crisi durante il
rapimento, scrive Raphaël Zanotti su “La
Stampa”. La richiesta è di quelle shock: il pg Luigi
Ciampoli chiede che la procura generale proceda nei confronti di Steve
Pieczenik, ex funzionario del Dipartimento di Stato americano e superconsulente
di Francesco Cossiga, per concorso nell’omicidio dell’onorevole Aldo Moro
avvenuta in Roma il 9 maggio 1978. Secondo il pg, che ieri è stato sentito dalla
commissione parlamentare istituita sulla vicenda, sarebbero emersi gravi indizi
nei suoi confronti in merito all’istigazione o perlomeno al rafforzamento del
proposito criminale delle Br di uccidere lo statista italiano. Elementi
contenuti nelle oltre cento pagine di richiesta d’archiviazione che il pg ha
consegnato al tribunale per quanto riguarda le rivelazioni dell’ex ispettore di
polizia Enrico Rossi che aveva ipotizzato la presenza di agenti dei Servizi
Segreti a bordo di una moto Honda, in via Fani, la mattina del rapimento. Non è
stato possibile identificare quelle misteriose presenze, ma altri elementi sono
emersi dall’indagine. Elementi che portano a una possibile responsabilità di
Pieczenik. D’altra parte un ruolo centrale nel drammatico sviluppo di quei
giorni se l’era ritagliato lo stesso Pieczenik, psicologo, in un libro
confessione (edito in Italia da Cooper nel 2008 e passato sotto silenzio dal
titolo «Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un protagonista esce
dall’ombra»). Nel libro Pieczenik raccontava: «Ho messo in atto una
manipolazione strategica che ha portato alla morte di Aldo Moro». Il
superconsulente racconta come, all’epoca, sarebbe riuscito a portare i comitati
dell’unità di crisi dalla sua parte sostenendo di essere l’unico ad avere a
cuore la sorte di Aldo Moro visto che era l’unico a non conoscerlo
personalmente. In realtà, rivelava qualche anno fa, l’obiettivo era eliminare
Moro: lo si voleva uccidere, ma a farne le spese sarebbero state le Br. Sempre
secondo Pieczenik l’operazione sarebbe stata condotta facendo crescere la
tensione in modo spasmodico, così da mettere le Br con le spalle al muro e non
lasciare loro alcuna via d’uscita se non uccidendo Moro. «Mi aspettavo che si
rendessero conto del loro errore e che lo liberassero facendo fallire il mio
piano - racconta ancora Pieczenik - Fino alla fine ho avuto paura che lo
liberassero. Per loro sarebbe stata una grande vittoria». Tutti sappiamo come
andò. Pieczenik venne mandato dagli Stati Uniti a Roma come super esperto di
terrorismo. «La sua autoreferenzialità era esasperata e quasi schizofrenica - ha
detto ancora il pg Ciampoli - In un’intervista a Giovanni Minoli su Rai Storia
raccontò che Moro doveva morire perché in questo modo si sarebbero
destabilizzate le Brigate Rosse. Noi abbiamo acquisito il cd di quell’intervista
televisiva e tutto il girato completo e siamo convinti che la sua posizione
meriti un approfondimento da parte della Procura». Nell’intervista televisiva di
Minoli, Pieczenik aveva spiegato anche i motivi della sua azione: «Quando sono
arrivato in Italia c’era una situazione di disordine pubblico: c’erano
manifestazioni e morti in continuazione. Se i comunisti fossero arrivati al
potere e la Democrazia Cristiana avesse perso, si sarebbe verificato un effetto
valanga. Gli italiani non avrebbero più controllato la situazione e gli
americani avevano un preciso interesse in merito alla sicurezza nazionale. Mi
domandai qual era il centro di gravità che al di là di tutto fosse necessario
per stabilizzare l’Italia. A mio giudizio quel centro di gravità si sarebbe
creato sacrificando Aldo Moro». Impossibile risalire all’identità delle due
persone a bordo della Honda, quella mattina in via Fani, segnalati in una
lettera anonima arrivata nel 2010 alla questura di Torino. Non erano sicuramente
Peppo e Peppa (i due agenti dei Servizi il cui coinvolgimento era già stato
escluso dalla polizia). E nemmeno Antonio Fissore, il fotografo piemontese morto
nel 2012 in Toscana che l’anonimo dichiarava essere un agente segreto sotto il
comando del colonnello Camillo Guglielmi dei Servizi. In realtà i magistrati
hanno appurato che quella mattina Fissore era su un volo Levaldigi-Varese con
rientro su Levaldigi alle 17.15. I magistrati hanno anche risentito l’ingegner
Alessandro Marini, l’uomo che quella mattina in via Fani per un miracolo non
venne colpito dai proiettili sparati dall’uomo sul sellino posteriore della
Honda che s’infransero sul parabrezza del suo motorino. La Procura generale ha
appurato che in quei giorni Marini aveva denunciato di aver ricevuto minacce
(senza però saper spiegare quali) e che per questo motivo venne montato nel suo
appartamento un baracchino per intercettare le chiamate in entrata al suo
telefono. Incredibile ma vero, a 36 anni di distanza quel baracchino non era mai
stato smontato e la Procura generale lo ha acquisito. Figura centrale
nell’inchiesta, il colonnello Camillo Guglielmi, in servizio all’ufficio “R”
della VII divisione del Sismi nonché istruttore abba base Gladio di Capo
Marrangiu dove gli agenti venivano addestrati anche alla strategia della
tensione. Il pg Ciampoli ha riferito che nei suoi confronti si potrebbe
ipotizzare un’accusa per concorso nel rapimento di Aldo Moro e nell’omicidio
degli uomini della scorta, ma è impossibile procedere perché il colonnello è nel
frattempo morto. L’unica cosa certa, però, è che quella mattina intorno alle 9
il colonnello si trovava in via Fani senza un motivo ragionevole. Alla Corte
d’assise ha riferito che era lì per caso, perché doveva andare a pranzo con un
collega che viveva nelle vicinanze. Una versione ritenuta «risibile» dal pg
Ciampoli, nonché smentita dallo stesso collega. Il suo ruolo nel rapimento,
dunque, rimane per ora un mistero.
Consulente Usa accusato di
concorso in omicidio nel sequestro di Aldo Moro.
La procura di Roma accusa lo 007 americano Steve Pieczenik: "Deve essere
processato, ci sono gravi indizi circa il suo concorso al delitto di Via Fani",
scrive Ivan Francese su “Il Giornale”. Ci sono importanti novità giudiziarie sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse
nel 1978. ll procuratore generale di Roma Luigi Ciampoli ha chiesto alla procura
di procedere nei confronti dello 007 americano Steve Pieczenik, ex funzionario
del Dipartimento di Stato Usa e superconsulente del Governo italiano, verso cui
vi sarebbero "gravi indizi circa un suo concorso nell'omicidio" dello statista.
Il presunto coinvolgimento di Pieczenik è emerso nel corso della richiesta di
archiviazione che il pg Ciampoli aveva inoltrato ieri al gip del Tribunale
romano per un'altra inchiesta: quella relativa alle rivelazioni dell'ex
poliziotto Enrico Rossi, che aveva insinuato la presenza di uomini dei servizi
segreti al momento del rapimento di Moro. Ciampoli ha quindi ordinato la
trasmissione della richiesta di archiviazione alla procura romana "perché
proceda nei confronti di Steve Pieczenik in ordine al reato di concorso
nell'omicidio di Moro". Pieczenik, all'epoca consulente del Viminale guidato da
Francesco Cossiga, faceva parte del comitato di crisi istituito dal ministero
dell'Interno nel giorno del sequestro dello statista democristiano. Dalla
procura generale di Roma viene evidenziato che a carico di Piezcenik "sono
emersi indizi gravi circa un eventuale concorso nell'omicidio, fatto apparire,
per atti concludenti, integranti ipotesi di istigazione, lo sbocco necessario e
ineludibile, per le Brigate Rosse, dell'operazione militare attuata in
via Fani, il 16 marzo 1978, o, comunque, di rafforzamento del proposito
criminoso, se già maturato dalle stesse Br". Pieczenik ha studiato ad
Harvard e al Mit, è stato psichiatra ed esperto di terrorismo: nel dibattito
storiografico è considerato un personaggio cruciale nella storia dei rapporti
tra Italia ed Usa durante gli anni delicatissimi dell'esplosione del terrorismo.
Nel 2008 pubblicò un libro-intervista in cui rivelò di aver sviluppato un piano
di "manipolazione strategica" che conducesse all'uscita di scena di Moro,
considerata ineludibile nel piano di "stabilizzazione" del nostro Paese.
Decisivo sarebbe stato il suo ruolo nell'impedire un'iniziativa vaticana (Papa
Paolo VI era amico personale di Moro, ndr) per raccogliere denaro da
destinare alla liberazione del presidente Dc: "In quel
momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe
potuto essere rilasciato. Non era per Aldo Moro in quanto uomo: la posta in
gioco erano le Brigate rosse e il processo di destabilizzazione dell'Italia".
L'americano che aiutò
Cossiga: "L'ordine degli Usa non era di far rilasciare Moro ma di stabilizzare
l'Italia".
La testimonianza dello psichiatra americano che nel 1978 arrivò in Italia per
aiutare il ministro dell'Interno Cossiga dopo la strage di via Fani, scrive
Raffaello Binelli su “Il Giornale”. Nelle drammatiche settimane del sequestro
Moro "nessuno era in grado di fare qualcosa, né i politici, né i pubblici
ministeri, né l'antiterrorismo. Tutte le istituzioni erano assenti". Ad
affermarlo, 36 anni dopo, è lo psichiatra statunitense Steve Pieczenik. Già
assistente al sottosegretario di Stato del governo americano e capo dell'Ufficio
per la gestione dei problemi del terrorismo internazionale, Pieczenik nella
primavera del lontano 1978 fu inviato in Italia per assistere il ministro
dell'Interno Francesco Cossiga. Rimasto nell'ombra per molti anni, alla fine di
maggio è stato interrogato dal pm Luca Palamara, che è andato a sentirlo in
Florida. Ne parla oggi Giovanni Bianconi in un articolo sul Corriere della
sera. Fu Cossiga a chiedere l'aiuto del dottor Pieczenik al segretario di
Stato Cyrus Vance: "Ero appena riuscito a negoziare il rilascio di 500
ostaggi americani a Washington in tre diversi palazzi utilizzando tre
ambasciatori arabi". Insomma, si era guadagnato una certa fama e così fu
chiamato in Italia, dove sbarcò una decina di giorni dopo la strage di via Fani.
Lo psichiatra svela quale fosse l'intenzione del suo Paese: "L'ordine non era
di far rilasciare l'ostaggio, ma di aiutarli nelle trattative relative ad Aldo
Moro e stabilizzare l'Italia". Per gli Stati Uniti, dunque, la vita dello
statista della Democrazia cristiana era un particolare secondario. La tesi
americana, maggioritaria (a livello politico) anche in Italia, era questa: "In
una situazione in cui il Paese è totalmente destabilizzato e si sta frantumando,
quando ci sono attentati, procuratori e giudici uccisi, non ci possono essere
trattative con organizzazioni terroristiche... se cedi l'intero sistema cadrà a
pezzi". E il cedimento non ci fu. Anche se costò la vita a Moro. Ma cosa
fece di concreto Pieczenik, oltre a passare le sue giornate nell'ufficio di
Cossiga? "Dovevo valutare che cosa era disponibile in termini di sicurezza,
intelligence, capacità di attività di polizia. E la risposta è stata: niente".
Prosegue mostrando un quadro a dir poco imbarazzante per il nostro Paese: "Ho
chiesto a Cossiga che cosa sapeva delle trattative per gli ostaggi e lui non
sapeva niente...". E poi ancora: "Dovevamo valutare la capacità delle Br
nelle trattative e sviluppare una strategia di non-negoziazione,
non-concessione". Su precisa domanda del pm Palamara (è vero
che lo Stato italiano ha lasciato morire Moro?) il dottor Pieczenik risponde di
no: "L'incompetenza dell'intero sistema ha permesso la morte di Moro. Nessuno
era in grado di fare niente... tutte le istituzioni erano insufficienti e
assenti". E sottolinea che andò via prima dell'omicidio, dopo essersi reso
conto che l'America poteva stare tranquilla: "Cossiga era un uomo
estremamente intelligente che ha capito molto in fretta ciò che doveva fare, ed
è stato in grado di attuarlo... nessuno scambio di terroristi e nessun altro
scambio". Seppe della morte dello statista italiano quando era già in
America. E fece questa constatazione: "Ho pensato che sfortunatamente erano
dei dilettanti e avevano fatto davvero un grande sbaglio. La peggiore cosa che
un terrorista può fare è uccidere il proprio ostaggio. Uccidendo Aldo Moro hanno
vinto la causa sbagliata e creato la loro autodistruzione". Ai microfoni di
Mix24 nel settembre dell'anno scorso Pieczenick aveva svelato altri particolari
interessanti a Giovanni Minoli, parlando chiaramente di una "manipolazione
strategica al fine di stabilizzare la situazione dell'Italia" in quel
periodo. E rivelò persino di aver temuto che Moro venisse alla fine rilasciato.
"A un certo punto - raccontò ancora lo psichiatra a Mix24 - per poter incidere
in una situazione di crisi, sono stato costretto a sminuire la posizione e il
valore dell'ostaggio, a Cossiga ho suggerito di screditare la posta in gioco"
fino a suggerirgli di dire che "quello delle lettere, le ultime soprattutto, non
era il vero Aldo Moro". E infine giocò un ruolo determinante nel bocciare
l'iniziativa del Vaticano di raccogliere una cospicua somma di denaro per pagare
un riscatto. "In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali
attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. Non era per Aldo Moro in
quanto uomo: la posta in gioco erano le Brigate rosse e il processo di
destabilizzazione dell'Italia". Già in un libro del 2008 ("Abbiamo ucciso
Aldo Moro", Cooper edizioni) Pieczenick aveva svelato l'importanza della
manipolazione delle informazioni, nella difficile gestione del sequestro Moro.
Il 18 aprile 1978 fu diramato il falso comunicato del lago della Duchessa (il
luogo dove si sarebbe trovato il corpo di Moro, ndr). Secondo lo psichiatra
americano era un tranello elaborato dai servizi segreti italiani che era stato
"deciso nel comitato di crisi". Il falso comunicato serve a preparare l’opinione
pubblica al peggio. Ma sarebbe servito soprattutto a choccare i brigatisti. Una
mossa che, alla fine dei conti, metteva in conto l’omicidio di Moro. Che poco
dopo sarebbe puntualmente arrivato.
Ho manipolato le Brper far
uccidere Moro.
Dopo 30 anni le rivelazioni del «negoziatore» Usa, scrive “La
Stampa”. «Ho mantenuto il silenzio fino ad
oggi. Ho atteso trent’anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi
rincresce per la morte di Aldo Moro; chiedo perdono alla sua famiglia e sono
dispiaciuto per lui, credo che saremmo andati d’accordo, ma abbiamo dovuto
strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere. Le Br si erano spinte
troppo in là». Chi parla è Steve Pieczenick. Un uomo misterioso, che volò in
Italia nei giorni del sequestro Moro, inviato dall’amministrazione americana ad
«aiutare» gli italiani. Pieczenick non ha mai parlato di quello che fece in quei
giorni. Dice addirittura di essersi impegnato con il governo italiano di allora
a non divulgare mai i segreti di cui è stato a conoscenza. Ed è un fatto che né
la magistratura, né le varie commissioni parlamentari sono mai riuscite a
interrogarlo. Finalmente però l’uomo del silenzio ha parlato con un giornalista,
il francese Emmanuel Amara, che ha scritto un libro («Abbiamo ucciso Aldo Moro»,
Cooper edizioni) sul caso. Le rivelazioni sono sconvolgenti. Pieczenick, che è
uno psichiatra e un esperto di antiterrorismo, avrebbe avuto un ruolo ben più
fondamentale in quei giorni. E che ruolo. «Ho manipolato le Br», dice. E
l’effetto finale di questa manipolazione fu l’omicidio di Moro. Il «negoziatore»
Pieczenick arriva a Roma nel marzo 1978 su mandato dell’amministrazione Carter
per dare una mano a Francesco Cossiga. E’ convinto che l’obiettivo sia quello di
salvare la vita allo statista. Ben presto si rende conto che la situazione è
molto diversa da quanto si pensi a Washington e che l’Italia è un paese in
bilico, a un passo dalla crisi di nervi e dalla destabilizzazione finale. Da
come maltratta l’ambasciatore e il capostazione della Cia si capisce che
Pieczenick è molto più di un consulente. E’ un proconsole inviato alla periferia
dell’impero. «Il capo della sezione locale della Cia non aveva nessuna
informazione supplementare da fornirmi: nessun dossier, nessuno studio o
indagine delle Br... Era incredibile, l’agenzia si era completamente
addormentata. Il colmo era il nostro ambasciatore a Roma, Richard Gardner. Non
era una diplomatico di razza, doveva la sua nomina ad appoggi politici». Cossiga
è molto franco con lui. «Mi fornì un quadro terribile dalla situazione. Temeva
che lo Stato venisse completamente destabilizzato. Mi resi conto che il paese
stava per andare alla deriva». Nella sua stanza all’hotel Excelsior, e in una
saletta del ministero dell’Interno, Pieczenick comincia lo studio
dell’avversario. Scopre che invece sono i terroristi a studiare lui. «Secondo le
fonti di polizia dell’epoca, ventiquattr’ore dopo il mio arrivo mi avevano già
inserito nella lista degli obiettivi da colpire. Fu allora che capii qual era la
forza delle Brigate Rosse. Avevano degli alleati all’interno della macchina
dello Stato». Una sgradevole verità gli viene spiegata in Vaticano. «Alcuni
figli di alti funzionari politici italiani erano in realtà simpatizzanti delle
Brigate Rosse o almeno gravitavano nell’area dell’estrema sinistra
rivoluzionaria. Evidentemente era in questo modo che le Br ottenevano
informazioni importanti». Così gli danno una pistola. «Ogni volta che uscivo in
strada stringevo più che mai la Beretta che avevo in tasca». Comincia una
drammatica partita a scacchi. «Il mio primo obiettivo era guadagnare tempo,
cercare di mantenere in vita Moro il più a lungo possibile, il tempo necessario
a Cossiga per riprendere il controllo dei suoi servizi di sicurezza, calmare i
militari, imporre la fermezza a una classe politica inquieta e ridare un po' di
fiducia all’economia». Ma la strategia di Pieczenick diventa presto qualcosa di
più. E’ il tentativo di portare per mano i brigatisti all’esito che vuole lui.
«Lasciavo che credessero che un’apertura era possibile e alimentavo in loro la
speranza, sempre più forte, che lo Stato, pur mantenendo una posizione di
apparente fermezza, avrebbe comunque negoziato». Alla quarta settimana di
sequestro, però, quando comincia l’ondata delle lettere di Moro più accorate,
tutto cambia. Una brusca gelata. Il 18 aprile, viene diramato il falso
comunicato del lago della Duchessa. Secondo Pieczenick è un tranello elaborato
dai servizi segreti italiani. «Non ho partecipato direttamente alla messa in
atto di questa operazione che avevamo deciso nel comitato di crisi». Il falso
comunicato serve a preparare l’opinione pubblica al peggio. Ma serve soprattutto
a choccare i brigatisti. Una mossa che mette nel conto l’omicidio di Moro. E
dice Pieczenick: il governo italiano sapeva che cosa stava innescando. «Fu
un’iniziativa brutale, certo, una decisione cinica, un colpo a sangue freddo: un
uomo doveva essere freddamente sacrificato per la sopravvivenza di uno Stato. Ma
in questo genere di situazioni bisogna essere razionali e saper valutare in
termini di profitti e perdite». Le Br di Moretti, stordite, infuriate, deluse,
uccidono l’ostaggio. E questo è il freddo commento di Pieczenick: «L’uccisione
di Moro ha impedito che l’economia crollasse; se fosse stato ucciso prima, la
situazione sarebbe stata catastrofica. La ragion di Stato ha prevalso totalmente
sulla vita dell’ostaggio».
“Quel giorno ero in via
Montalcini e arrivò l’ordine di non intervenire”.
L’ex brigadiere della Finanza finito sotto accusa per le clamorose dichiarazioni
sul caso Moro racconta per la prima volta la sua verità: «Con altri militari
presidiavamo il palazzo adiacente la prigione di Moro. Quando tutti finì ci
venne ordinato di dimenticare quello che era successo». Roma, via Caetani, 9
maggio 1978. Il cadavere di Aldo Moro viene fatto ritrovare tra la sede del Pci
e della Dc. Due giorni prima l’ex finanziere novarese assicura che era in
servizio di vigilanza in un palazzo di via Montalcini, scrive Carlo Bologna su
“La Stampa”. Giovanni Ladu, ex brigadiere
della Finanza in pensione da un anno e mezzo, vive a Novara. Il suo nome è
venuto alla ribalta in occasione della pubblicazione del libro dell’ex giudice
Ferdinando Imposimato al quale Ladu si era rivolto anche con un’altra identità,
quella di un fantomatico Oscar Puddu, per rafforzare la tesi del mancato blitz
nel covo delle Brigate Rosse in cui era prigioniero Moro. L’ex magistrato, dopo
la pubblicazione del libro, si è rivolto alla Procura di Roma sollecitando nuove
indagini. C’è voluto poco per scoprire che Ladu e Puddu sono la stessa persona.
Ora l’ex finanziere è indagato per calunnia. Per la prima volta ha deciso di
rilasciare a La Stampa un’intervista sulla sua versione dei fatti.
Respinge l’etichetta di «calunniatore». Giovanni Ladu, ex brigadiere della
Guardia di Finanza, parla per la prima volta accanto ai suoi difensori, gli
avvocati Gianni Correnti e Giorgio Legnazzi. Nel 1978, nei giorni del sequestro
Moro, era un bersagliere di leva. È indagato dalla Procura di Roma perché
sostiene che lo Stato era a conoscenza della prigione dello statista ed ha fatto
un passo indietro due giorni prima che venisse ritrovato nella Renault rossa in
via Caetani. Lui, con altri gruppi pronti al blitz per liberare il leader Dc,
garantisce che il 7 maggio era in via Montalcini. Dall’«alto» arrivò l’ordine
che l’ex giudice Imposimato, nel libro «I 55 giorni che hanno cambiato l’Italia»
traduce in una denuncia-bomba: la liberazione fu impedita da Cossiga e
Andreotti. Imposimato solo a libro stampato si è affidato alla Procura.
Ladu, la sua
è una verità contestata.
«Le e-mail a Imposimato sono
state mandate dal 2012 a maggio di quest’anno però quei fatti del ’78 sono stati
resi noti ai miei superiori, inizialmente a voce al mio comandante Alessandro
Falorni. Dopo le opportune verifiche è stato contattato il giudice che si era
occupato del caso Moro».
Lei ha
iniziato a raccontare questi fatti nel 2008, perché solo allora? Temeva una
rappresaglia?
«Sì, anche perché quando finì
tutto, ci era stato detto di dimenticare quello che era successo».
Ma lei chi
era in quei giorni?
«Avevo 19 anni, l’anno primo
avevo finito il diploma. Ero in servizio di leva obbligatoria ai bersaglieri
della caserma Valbella, ad Avellino».
Vi avevano
preparato a questa missione?
«No. Ci hanno imbarcato su un
pullman “dovete andare a Roma”. Sulle prime ci portano alla caserma dei
carabinieri vicino all’hotel Ergife».
Sapevate che
c’erano altri gruppi pronti a intervenire in quella che sarebbe risultata la
prigione di Moro?
«Inizialmente no. Poi
prendiamo possesso di un appartamento adiacente allo stabile dove, scopriremo
poi, c’era Moro. Eravamo dieci militari, non in divisa. Non avevamo attrezzature
di ascolto (queste attrezzature sono state poi messe in una cascina abbandonata
che era di fronte al palazzo, lì c’era una postazione di controllo già
predisposta prima che arrivassimo. Noi dovevamo solo verificare chi entrava e
usciva, se c’erano persone sospette».
Quando avete
intuito che poteva essere il covo?
«Ci avevano detto che c’era un
noto personaggio in quell’appartamento, messo in condizione di non uscire. Moro
era stato rapito il 16 marzo , in Italia si parlava solo di quello».
E arriva il 7
maggio 1978, con l’ordine di smobilitare senza liberare il «personaggio». In
seguito scoprirete che là dentro c’era proprio il presidente della Dc.
«Certo, leggendo i giornali.
Io mi sono anche strizzato sotto. Rientrato ad Avellino sono stato destinato
subito al reggimento, alla caserma dei bersaglieri di Persano (Salerno)».
I dieci
commilitoni non li ha più sentiti?
«No, non so nemmeno che fine
abbiamo fatto. Nessun contatto».
Dopo
trent’anni, nel 2008, decide di parlare. Perché?
«Ogni anno, in occasione
dell’anniversario dell’uccisione di Moro, venivano riferite falsità».
Non ha mai
cercato di «vendere» la sua verità?
«Assolutamente no, all’epoca
ero ancora in servizio. Non ho avuto, né cerco compensi. Ho fatto i miei
passaggi rivolgendomi ai miei superiori gerarchici, loro hanno poi informato il
procuratore di Novara Francesco Saluzzo al quale ho fornito un memoriale di tre
pagine. Non ho fatto alcun nome, nessun riferimento ai vertici dello Stato. Ho
soltanto indicato i fatti di cui sono a conoscenza. E non sono state ravvisate
ipotesi di calunnia perché nel 2011 questo procedimento è stato archiviato».
Lei, in
questa prima fase, è Giovanni Ladu. Poi nel 2012 si ripresenta con il nome
fittizio di Oscar Puddu. Al punto che Imposimato ci casca, pensa che Ladu e
Puddu siano due persone distinte. Perché questo espediente?
«Volevo che si riaprisse il
caso, per venire a capo di questa vicenda. L’ex giudice faceva delle domande, io
rispondevo. Ci siamo scambiati 84 mail, da privato a privato. Io ero in pensione
dalla Finanza, Imposimato dalla magistratura».
Imposimato,
anche sulla base della sue rivelazioni, arriva a scrivere che «Moro fu vittima
della ferocia delle Br ma anche di un complotto ordito da Andreotti e Cossiga».
«Mai fatti quei nomi, sono
conclusioni di Imposimato. Lui mi chiese se erano al corrente dell’ipotesi di un
blitz e della decisione di fermarlo».
Il figlio di
Cossiga ha definito le sue ricostruzioni da «trattamento sanitario
obbligatorio».
«Non sono matto, né mitomane.
E non ho mai detto che Cossiga ha ordinato quel delitto».
E a chi parla
di depistaggio, cosa risponde?
«Nessuna intenzione di alzare
polveroni o coprire qualcuno, chiedo l’opposto: che si arrivi alla verità. Non
volevo nemmeno tutto questo clamore. Quando ho visto il mio nome nel libro di
Imposimato mi sono pure arrabbiato. Ho fatto tutto questo anche contro il volere
della mia famiglia ma sentivo che dovevo togliermi un peso. Tutti gli altri
hanno seguito l’ordine di dimenticare, io non ci sono riuscito».
L’ex ispettore e i misteri
del caso Moro “Parlerò solo con pm e in Parlamento”.
Enrico Rossi
aveva indagato su una lettera inviata nel 2009 a La Stampa Al centro i due
motociclisti sulle Honda comparsi in via Fani. C’era un torinese? Scrivono
Grazia Longo e Massimo Numa su “La
Stampa”. L’ex ispettore della Digos Enrico
Rossi sa di essere, da poche ore, al centro dell’attenzione. Ha rivelato
all’Ansa alcuni retroscena del caso Moro, in particolare sul ruolo - mai
chiarito - di un motociclista, in sella a una Honda, comparso in via Fani
nell’ora X del rapimento di Aldo Moro e della strage della sua scorta. Deciso a
raccontare la «sua» verità, perchè gli accertamenti che furono svolti in allora
dai suoi colleghi in modo scrupoloso non portarono a nulla. «Tutto è partito -
ha detto Rossi all’Ansa - da una lettera anonima scritta dall’uomo che era sul
sellino posteriore dell’Honda in via Fani quando fu rapito Moro. Diede riscontri
per arrivare all’altro. Dovevano proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano
dal colonnello del Sismi che era lì». Le ricerche dell’ispettore sono nate da
una lettera anonima inviata nell’ottobre 2009 alla redazione de La Stampa.
Questo il testo: «Quando riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei
mesi dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di
quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi
fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio
sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del
colonnello Guglielmi, con me alla guida della moto un altro uomo proveniente
come me da Torino; il nostro compito era quello di proteggere le Br nella loro
azione da disturbi di qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non
sappiate come veramente andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a
parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci
siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontralo ultimamente...Tanto io
posso dire, sta a voi decidere se saperne di più». La polizia avviò così le
prime indagini. In una casa di Cuneo, dove l’uomo ha vissuto con la prima
moglie, vengono trovate due armi regolarmente denunciate: una Beretta e una
Drulov, un’automatica di precisione di fabbricazione cecoslovacca. E le pagine
originali di Repubblica dei giorni del sequestro Moro. Rossi afferma di aver
chiesto di sentire la coppia e di ordinare una perizia sulle armi. Ma non
accadde nulla. Sui dettagli dell’indagine Rossi è pronto a testimoniare. «Ma
solo con la magistratura e nelle commissioni parlamentari. Aspetto di essere
convocato». Che l’Honda blu presente in via Fani il 16 marzo del 1978
rappresenti un mistero è un dato assodato. Tutte da chiarire sono invece le
rivelazioni di Rossi: la procura di Roma, che si sta occupando del caso, non ha
per ora trovato riscontri. L’attività degli inquirenti, comunque, prosegue.
Intanto la memoria ricorre a pochi mesi fa, quando - il 6 novembre scorso - l’ex
brigadiere della Guardia di Finanza Giovanni Ladu è stato indagato per calunnia
dalla procura della capitale proprio perché, secondo la pubblica accusa, aveva
fornito informazioni false sul caso Moro .
La moto Honda di via Fani
Un mistero lungo 36 anni.
Le rivelazioni di un ex poliziotto: “A bordo c’erano due 007”, scrive “La
Stampa”. Per una volta sono tutti d’accordo:
magistrati e Br. La Honda blu presente in via Fani il 16 marzo del 1978 è un
mistero. I capi brigatisti hanno sempre negato che a bordo ci fossero due loro
uomini, ma da quella moto si spararono - sicuramente - gli unici colpi verso un
“civile” presente sulla scena del rapimento, l’ingegner Alessandro Marini, uno
dei testimoni più citati dalla sentenza del primo processo Moro. Mario Moretti e
Valerio Morucci sono stati sempre chiarissimi su quella moto blu di grossa
cilindrata: «Non è certamente roba nostra». L’ingegner Marini si salvò solo
perché cadde di lato quando una raffica partita da un piccolo mitra fu scaricata
contro di lui “ad altezza d’uomo” proprio da uno dei due che viaggiavano sulla
moto. I proiettili frantumarono il parabrezza del suo motorino con il quale
l’ingegnere cercava di “passare” all’incrocio tra via Fani e via Stresa. Marini
fu interrogato alle 10.15 del 16 marzo. Il conducente della moto - disse - era
un giovane di 20-22 anni, molto magro, con il viso lungo e le guance scavate,
che a Marini ricordò «l’immagine dell’attore Edoardo De Filippo». Dietro, sulla
moto blu, un uomo con il passamontagna scuro che esplose colpi di mitra nella
direzione dell’ingegnere perdendo poi il caricatore che cadde dal piccolo mitra
durante la fuga. La sera a casa Marini arrivò la prima telefonata di minacce:
`Devi stare zitto´. Per giorni le intimidazioni continuarono. Si rafforzarono
quando tornò a testimoniare ad aprile e giugno. Poi l’ingegnere capì l’aria, si
trasferì in Svizzera per tre anni e cambiò lavoro. Il caricatore cadde
certamente dalla moto e Marini, dicono le carte, lo fece ritrovare ma questo non
sembra essere stato messo a raffronto con i tre mitra (ritrovati in covi Br) che
spararono in via Fani (ce ne è anche un quarto, mai ritrovato). Di certo da
quella moto si sparò per uccidere Marini, tanto che i brigatisti sono stati
condannati in via definitiva anche per il tentato omicidio dell’ingegnere.
Marini d’altra parte confermò più volte durante i processi il suo racconto e
consegnò il parabrezza trapassato dai proiettili. A terra in via Fani rimasero
quindi anche i proiettili sparati dal piccolo mitra ma le perizie sembrano
tacere su questo particolare. Sarebbe questa l’ottava arma usata in via Fani: 4
mitra, 2 pistole, oltre alla pistola dell’agente Zizzi, che scortava Moro, e
quella in mano all’uomo della Honda: il piccolo mitra. Su chi fossero i due
sulla Honda tante ipotesi finora: due autonomi romani in “cerca di gloria” (ma
perché allora sparare per uccidere?); due uomini della `ndrangheta (ma non si è
andati oltre l’ipotesi); o, come ha ventilato anche il pm romano Antonio Marini
che ha indagato a lungo sulla vicenda, uomini dei servizi segreti o della
malavita. I Br negano ma, ha detto il magistrato, «una spiegazione deve pur
esserci. Io vedo un solo motivo: che si tratti di un argomento inconfessabile».
Uomini della malavita o dei servizi? «Allora tutto si spiegherebbe». Certo che
quella mattina a pochi passi da via Fani c’era, per sua stessa ammissione,
Camillo Guglielmi, indicato alternativamente come addestratore di Gladio o uomo
dei servizi segreti, invitato a pranzo alle 9.15 di mattina da un suo collega. E
Guglielmi è proprio l’uomo dei servizi chiamato in causa nella lettera anonima
che ha dato il via a Torino agli accertamenti sui due uomini a bordo Honda, poi
trasferiti a Roma. A Guglielmi si è addebitata anche la guida di un gruppo
clandestino del Sismi incaricato di “gestire” il rapimento Moro secondo
un’inchiesta che è anche nell’archivio della Commissione stragi, in Parlamento.
Il martire del terrorismo
su cui l'Italia resta spaccata.
C'è chi ha avviato il processo per la sua beatificazione, chi lo considera un
cattocomunista responsabile di molti dei problemi italiani: Aldo Moro rimane uno
dei personaggi più controversi della Prima Repubblica, scrive Livio Caputo su
“Il Giornale”. C'è chi ha avviato il processo per la sua beatificazione, chi lo
considera un cattocomunista responsabile di molti dei problemi italiani. C'è chi
esalta tuttora la sua politica di avvicinamento al Partito Comunista di Enrico
Berlinguer (le famose convergenze parallele), chi è convinto che il suo progetto
di compromesso storico avrebbe addirittura messo in discussione la nostra
appartenenza al blocco occidentale. C'è chi ha parole di elogio per la sua
politica estera filoaraba, chi la critica al punto di averlo ribattezzato
Al-Domor. C'è chi ritiene che con le sue ripetute prese di distanza dagli Stati
Uniti d'America abbia fatto gli interessi dell'Italia, chi lo esecra ancora per
avere concluso il famigerato trattato di Osimo con la Jugoslavia di Tito. A
quasi trentacinque anni dal suo rapimento ed assassinio ad opera delle Brigate
Rosse, Aldo Moro, primo capo di un governo di centro-sinistra e poi per cinque
volte presidente del Consiglio tra il 1963 e il 1976, rimane uno dei personaggi
più controversi della Prima Repubblica. Pugliese di nascita, laureato in legge,
profondamente cattolico, Moro ha fatto parte fin dal principio della corrente
dossettiana di sinistra, critica della politica centrista di Alcide De Gasperi,
ed è rimasto sempre su queste posizioni. Quando fu rapito il 16 marzo del 1978,
era presidente del partito e si apprestava a realizzare il suo obbiettivo di
inserire formalmente il Partito comunista italiano nei meccanismi del potere. I
cinquantacinque giorni della sua prigionia furono i più drammatici degli anni
del terrorismo, spaccando governo, partiti e parlamento in un fronte della
fermezza, contrario a ogni trattativa per la sua liberazione per non dare un
riconoscimento politico alle Brigate Rosse (Giulio Andreotti, Francesco Cossiga,
il Partito Comunista Italiano) e un fronte possibilista disponibile a negoziare
uno scambio di prigionieri coi rapitori (Bettino Craxi, Amintore Fanfani, il
Vaticano). Durante la prigionia scrisse 86 lettere, di cui alcune ferocemente
critiche verso i dirigenti della Democrazia Cristiana («Il mio sangue ricadrà su
di loro»). Ma tutto fu inutile: il 9 maggio il suo corpo crivellato di colpi fu
ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa a pochi metri da piazza del Gesù
a Roma. Per protesta, i familiari rifiutarono i funerali di Stato. Vari aspetti
della vicenda sono ancora circondati dal mistero, dando vita a una pletora di
teorie complottistiche che attribuiscono il suo assassinio alla P2, alla CIA, al
KGB o addirittura ad ambienti democristiani. Inutile dire che nessuna è stata
provata.
Troppi bugiardi sul
memoriale Moro.
La figlia legge il libro di Gotor sugli scritti dalla prigionia
"È il momento per chi ha sempre taciuto di dire la verità", scrive Agnese Moro
su “la Stampa”.
Il nuovo libro dello storico Miguel Gotor, Il memoriale della Repubblica. Gli
scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano
(Einaudi, 2011, 622 pagine, 25 euro) è un lavoro interessante, che ci accompagna
nelle avventurose traversie di quel Memoriale che raccoglie le risposte
che mio padre, Aldo Moro, diede alle Brigate Rosse, durante gli interrogatori ai
quali fu sottoposto nel corso della sua prigionia (16 marzo - 9 maggio 1978).
L'Autore ha fatto un minuzioso lavoro di ricostruzione delle vicende che
interessarono quello scritto: la pubblicazione, nel corso del sequestro, di
alcune pagine riguardanti l'onorevole Paolo Emilio Taviani; il ritrovamento, da
parte degli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nell'ottobre del
1978, nel covo di via Monte Nevoso a Milano, di un testo consistente in
fotocopie di un dattiloscritto; il secondo ritrovamento, nell'ottobre del 1990,
sempre nello stesso covo brigatista, di fotocopie di lettere e di un
manoscritto, il cui contenuto è parzialmente diverso da quello del
dattiloscritto rinvenuto nel '78. Fino ad arrivare alla ragionevole e
documentata ipotesi della esistenza di un manoscritto più ampio di quello del
'90 (identificato dall'Autore come ur-memoriale), fin qui mai ritrovato. Le
tracce di questo testo originario vengono seguite da Gotor attraverso una
raccolta di dichiarazioni di chi quel testo - con ogni probabilità - lo vide e
lo lesse. Testimoni che, nel libro, sono divisi in due gruppi: i morti (il
generale Dalla Chiesa, il giornalista Mino Pecorelli) e i sopravvissuti (i
brigatisti, alcuni giornalisti ad essi in qualche modo contigui, esponenti
dell'area dell'autonomia, Francesco Cossiga). C'è un grande lavorio attorno al
Memoriale: impossessarsene, ritrovarlo, delegittimarlo (assieme al suo autore),
farlo sparire, edulcorarlo. Tutto sembra ruotare attorno alla figura di Giulio
Andreotti, sul quale mio padre avrebbe fatto - è questa l'ipotesi -
dichiarazioni molto compromettenti. La posta in gioco nella gara drammatica per
il recupero e la pubblicazione del manoscritto originale, o, al contrario,
perché ciò non avvenga, riguarda, infatti, la presa del potere in Italia, che si
gioca proprio attorno alla figura di Giulio Andreotti, e degli ambienti
emergenti che a lui fanno riferimento. Si tratta di una destra profonda, ben più
ampia di quella rappresentata come tale in Parlamento, alla quale non sono
estranee la loggia massonica deviata P2, pezzi dei servizi segreti, la
criminalità organizzata, i grandi interessi privati. Una presa di potere che poi
effettivamente avverrà, almeno al livello nazionale, con un cambiamento radicale
della finalità e della qualità della nostra vita democratica. Non si tratta,
purtroppo, di una spy-story, o di uno scritto «a tesi». E' piuttosto la
puntigliosa e precisa ricostruzione di un pezzo importante di storia del nostro
Paese, che Gotor fa passare sotto i nostri occhi senza abbellimenti. E con una
drammaticità non retorica, dal momento che è una storia piena di speranze e di
sangue. Al termine di una lettura che mi ha particolarmente, e ovviamente,
coinvolta, mi pongo tre quesiti. Il primo riguarda il manoscritto completo:
esiste ancora da qualche parte? Sarebbe davvero bellissimo che fosse così,
perché ci aiuterebbe a comprendere meglio quello che avvenne allora. Se qualcuno
ne sapesse qualcosa sarebbe il momento di dirlo. Il secondo quesito riguarda la
consapevolezza o l'inconsapevolezza del mondo politico nel suo insieme rispetto
a quanto stava avvenendo, ovvero alla lotta per il potere combattuta con tenacia
da forze ostili alla democrazia repubblicana, con tutto quello che essa comporta
in termini di sovranità di ogni cittadino, solidarietà e impegno per la
costruzione della giustizia. Quanti sapevano? Chi sapeva in quel 1978? Il terzo
quesito: quanto hanno pesato le vicende che Miguel Gotor descrive nel libro
sulla decisione di non far nulla (come disse papà in una delle sue lettere: «Non
c'è niente da fare quando non si vuole aprire la porta») per salvare Moro? Il
valore di un libro non si vede solo dalle cose alle quali dà una risposta, ma
anche dai quesiti che pone in tutta evidenza, senza che si possa sfuggire loro.
Personalmente sono convinta che sia venuto il tempo di unire le forze per dare
una compiuta ricostruzione e spiegazione di quegli anni difficili. Unire le
forze: gli storici, i protagonisti attivi nella lotta armata, nelle attività
eversive,nella politica, nei Servizi o nell' antiterrorismo, coloro che
custodiscono i documenti e chiunque possa dare un contributo per chiarire le
cose. E noi che abbiamo patito i frutti avvelenati di quella stagione. E' una
strada certamente complessa e dolorosa, ma è necessario percorrerla se vogliamo
avere quella verità che come Paese attendiamo da troppo tempo. E' il prezzo che
dobbiamo pagare se vogliamo rimettere il passato al suo posto, e riprendere, con
mitezza e serenità, il cammino che quegli anni terribili hanno interrotto.
Alla fine la storia dà
lustro ai bistrattati contemporanei.
Il ritratto di Giorgio
Almirante, il "fascista che amava il Parlamento",
scrive Mario Bernardi Guardi su “Libero Quotidiano”. Giorgio Almirante,
ricoverato per ischemia cerebrale nella clinica romana «Villa del Rosario»,
muore il 22 maggio 1988, un mese prima di compiere 74 anni. Accanto a lui la
moglie, Donna Assunta Stramandinoli, che della sua «eredità d’affetti» si farà
colorita custode. Come nota Aldo Grandi (Almirante. Biografia di un fascista,
Sperling & Kupfer, pp. 468, euro 18,90, da oggi in libreria), a scrivere il
“coccodrillo” più schietto e polemico fu Indro Montanelli, che «non fece
piangere nessuno, ma arrossire tanti», tutti quelli che per oltre 40 anni
avevano cercato di emarginare il leader missino. Chissà cosa avrebbe potuto fare
quest’uomo - si chiedeva Indro - se avesse scelto di militare in un partito
antifascista. Ma, fedele com’era alla milizia repubblichina, nemmeno a pensarci!
Tuttavia, nessuno come lui «si adattò alla libertà e seppe adattarvi un partito
nutrito di rimpianti totalitari e di tentazioni eversive». Chissà cosa avrebbe
potuto provocare il terrorismo nero, «se avesse avuto il supporto, anche solo
morale, di un partito organizzato». Invece Almirante lo sconfessò, «prima ancora
che il Pci sconfessasse il terrorismo rosso», frenò sempre le tentazioni
bombarole e golpiste e, convinto che il Msi potesse avere un avvenire solo se si
distaccava dal passato, dette vita alla Destra Nazionale, per costruire un
partito moderno e addestrarlo alle battaglie parlamentari. Infatti al fascista
Almirante piaceva, eccome, quel Parlamento dove poteva cimentarsi al meglio con
la sua «oratoria efficace» e i suoi «interventi puntuali, tempestivi,
brillanti». Onesto e coraggioso, era «uno di quei pochi politici cui si poteva
dare la mano senza paura di sporcarsela». Su questa immagine positiva, Grandi è
d’accordo, tanto che chiude il suo libro proprio con le parole di Indro. Ma il
percorso biografico che traccia non ha nulla a che fare con l’agiografia. Perché
è, piuttosto, un invito a dibattere, con tanto di documenti e testimonianze, su
una figura ricca di luci e ombre. E allora va ricordata prima di tutto la
coerenza del fascista. Non un “mistico” come quel Giani o quel Pallotta venerati
da Montanelli, ma di sicuro un convinto militante. Con la Destra Nazionale
indossò il doppiopetto? Sì, ma non rinnegò mai nulla. Meno che mai Salò. Per
dirne una, nel primo comizio che tenne (Brescia, 29 giugno 1969) dopo esser
tornato alla guida del partito, affermò che i motivi ispiratori della Rsi
dovevano essere «richiamati, attualizzati, proiettati in avanti, per la loro
validità storica e per la loro permanente validità morale». Se fu sempre fedele
alla sua giovinezza in camicia nera, l’Almirante parlamentare e segretario del
Msi prese invece le distanze dalle battaglie antisemite combattute sui giornali
di Telesio Interlandi. Mea culpa, confessava Almirante, aggiungendo che,
comunque, era sempre stato distante dal razzismo biologico di stampo nazista.
Vero? Beh, osserva Grandi, che è andato a rileggersi tutti gli articoli
razzisti, Almirante non inneggiava certo allo sterminio, ma auspicava una forte
mobilitazione politico-culturale contro l’ebraismo. A partire dal mondo del
cinema, formidabile macchina di educazione e propaganda. Insomma Almirante,
parlando dei propri trascorsi, gettava un bel po’ d’acqua sul suo «interventismo
culturale» razzista. Imbarazzi, reticenze e mezze verità che Julius Evola gli
rimproverò. Perché, gli faceva osservare il Barone Nero, prendendo le distanze
da ogni furore persecutorio, non hai rivendicato la legittimità di un «razzismo
dello spirito», volto alla disciplina del carattere, alla formazione interiore e
alla difesa della tradizione culturale “romana” contro ogni meticciato? Mica
facile, però, precisare e distinguere… Va da sé che il lungo viaggio attraverso
l’antifascismo compiuto dal fascista Almirante avrebbe messo a dura prova
chiunque altro non avesse avuto la sua tempra. Anche se non mancano gli errori.
Ad esempio, non è certo lungimirante quando oppone al ’68 come «rivolta
generazionale», potenzialmente al di là della Destra e della Sinistra, un
trucido forcaiolismo piccolo-borghese a presidio del sistema. E poi ci sono un
po’ di misteri non del tutto chiari: il passaggio dall’antiamericanismo e dal
filoarabismo al sostegno, sempre e comunque, a Usa e Israele, le contraddizioni
sulla rivolta di Reggio, il golpe Borghese, i rapporti con la destra radicale,
il filo (in)diretto con le questure, il viavai dei servizi segreti... Eppure,
alla fine e parafrasando Montanelli: ma se non ci fosse stato Almirante?
E poi si ristabilisca la
verità sulle pagine nere della storia italica.
VIA RASELLA Un mistero che
dura da sessant'anni,
scrive Pierangelo Maurizio su “Il Giornale”. E così la Cassazione ha condannato
il Giornale per un articolo di undici anni fa che criticava l'attentato di via
Rasella compiuto dai Gap, il braccio armato del Partito comunista italiano, il
23 marzo '44, e ha confermato che si tratta di un'«azione di guerra». Siccome mi
sono occupato a lungo di quella vicenda - in quel budello di strada che è via
Rasella nel centro storico di Roma ci ho passato i mesi, mentalmente gli anni -
provo a offrire la mia testimonianza. Nel '96 - allora lavoravo al Tempo -
cominciai l'inchiesta. Trovai le foto del corpo di Piero Zuccheretti, un bambino
di 13 anni, fatto a pezzi dall'esplosione della bomba dei Gap. Soprattutto
rintracciai il fratello gemello di Piero. Mi raccontò la tragedia abbattutasi
sulla famiglia e la rabbia per essere stati costretti al silenzio. Riuscii anche
ad avere il certificato di morte di Piero Zuccheretti: risultava morto il 23
marzo '44 «per scoppio di bomba». Se non vado errato, solo a quel punto Rosario
Bentivegna, cioè colui che accese la miccia nel carrettino da spazzino imbottito
di tritolo, e la «letteratura resistenziale» hanno ammesso che a via Rasella
«purtroppo morì un bambino, Piero Zuccheretti». Eppure la famiglia aveva
pubblicato fin dal giorno dopo l'attentato sul Messaggero il necrologio di
Piero. Primo mistero: perché c'è voluto mezzo secolo per ammettere la morte di
un bambino (e dargli un nome)?
Secondo mistero. A via Rasella ho ricostruito l'identità di un altro morto. Si
chiamava Antonio Chiaretti. E qui le cose si complicano. Già, perché Chiaretti
era un partigiano di «Bandiera rossa». Ma la sua memoria, di partigiano caduto
in via Rasella, è stata cancellata. Perché? Come mai? Con lui si trovavano
alcuni compagni di «Bandiera rossa» che finirono alle Ardeatine. Che ci facevano
a via Rasella? Nei loro ricordi gli ultimi sopravvissuti di «Bandiera rossa» che
ho incontrato conservavano l'idea che fossero stati attirati in una trappola. E
adombravano il sospetto che si volesse far ricadere la responsabilità
dell'attentato su quella formazione. Sul giallo di questa presenza a via Rasella
né da Bentivegna né dalla vulgata resistenziale è venuto un aiuto a capire di
più.
Terzo mistero. Quante furono le vittime, esclusi i 32 soldati del battaglione
Bozen, poi diventati 33 e poi oltre 40? La perizia del professor Ascarelli (lo
stesso che eseguì le autopsie sui 335 morti delle Fosse Ardeatine) su quei
poveri resti è sparita. Se ne trovano tracce nella sentenza del processo Kappler
del '48. Parla, senza fare i nomi, di due cadaveri, un adulto e «una bambina» .
Forse si confuse con Piero Zuccheretti? Strano. Oppure le vittime civili furono
più di due. Come la Cassazione possa affermare che «ora nessuno più mette in
discussione che quelle vittime furono soltanto due» è, storicamente,
incomprensibile. La Cassazione fa una descrizione precisa dei componenti del
Battaglione Bozen, come «di uomini pienamente atti alle armi, di età compresa
tra i 26 e i 43 anni». Vero. Ma traccia il ritratto, in un'epoca in cui la
migliore gioventù di 18-20 anni veniva maciullata al fronte, dei perfetti
riservisti. È vero, avevano un moschetto e tre bombe a mano alla cintola. La
Cassazione però dimentica un piccolo particolare. Nel '96 rintracciai un
superstite del «Bozen». Mi raccontò che il Comando tedesco, in ragione dello
status di Roma come «Città aperta», con teutonica ottusità, li faceva marciare
con i moschetti scarichi. Erano montanari altoatesini, che avevano optato per la
cittadinanza tedesca ed erano stati forzatamente arruolati. A Roma stavano
seguendo un corso di addestramento, al termine sarebbero stati impiegati come
piantoni. Certamente non erano destinati a reparti d'assalto o di SS. Via
Rasella non è sempre stata un'«azione di guerra», come ha ora ribadito la Corte
di Cassazione. A cose ancora calde, nel '48 la sentenza del Tribunale militare
di Roma contro il colonnello delle SS Herbert Kappler, condannato all'ergastolo
per le Fosse Ardeatine (non per la rappresaglia ma per i condannati in più che
aggiunse arbitrariamente), definì l'attentato dei Gap un «atto illegittimo»
contrario a tutte le convenzioni internazionali. Tanto che i familiari di tre
poveri ebrei finiti a far numero alle Fosse Ardeatine cercarono di portare in
giudizio non solo gli esecutori dell'attentato ma anche i mandanti tra cui, a
torto, Sandro Pertini. Per motivi incomprensibili, si trovò il modo di
incardinare il processo non al Tribunale militare, non in sede penale, ma in
sede civile. Nel '51 poche settimane prima che ci fosse il verdetto il governo
De Gasperi conferì onorificenze al valor militare agli esecutori materiali di
via Rasella (la medaglia d'argento a Rosario Bentivegna è stata consegnata solo
nell'83 dall'allora Presidente-partigiano Sandro Pertini). Qualche settimana
dopo il Tribunale civile sentenziò, pressoché sulla base di questo assunto: gli
attentatori sono stati appena premiati pubblicamente come eroi, dunque nessun
atto illegittimo può essere addebitato loro. Da qui nasce il mito intoccabile di
via Rasella «azione di guerra». Da allora chiunque abbia osato contestarlo è
stato passibile di querela, con condanna più che probabile. Ne fece le spese
anche il grande Indro Montanelli, per aver violato in un libro la sacralità del
mito; la Rizzoli - a quanto mi è stato detto - fu costretta a mandare al macero
30mila copie. A lungo si è parlato, e ora ci è tornata sopra la Cassazione, dei
manifesti che il Comando tedesco avrebbe affisso invitando gli attentatori a
consegnarsi per evitare la rappresaglia, e di cui nessuno è mai riuscito a
fornire una prova. Tempo perso. Non è questo il problema. Qualche anno dopo in
un'intervista a un settimanale Rosario Bentivegna e la moglie Carla Capponi
dissero che «se anche avessimo voluto consegnarci, il partito ce lo avrebbe
impedito». E questo è il punto. L'ineffabile professor Nicola Tranfaglia,
storico, richiesto di un commento alla nuova sentenza della Cassazione, ha
dichiarato che «alle Fosse Ardeatine vennero uccisi antifascisti, ebrei,
oppositori». Nella più che prevedibile rappresaglia nazista furono sterminati in
prevalenza appartenenti a «Giustizia e libertà», a «Bandiera rossa», ai
partigiani monarchici, tutte e tre formazioni contrapposte al Pci o sue rivali.
Tutti, a cominciare dall'eroico colonnello Montezemolo (zio di Luca), che come
capo del «Fronte militare clandestino» aveva vietato gli attentati a Roma
proprio per evitare rappresaglie, nei mesi e nelle settimane precedenti erano
stati arrestati, il più delle volte sulla base di delazioni provenienti
dall'interno della Resistenza. Nei mesi precedenti l'Unità clandestina, diretta
da Mario Alicata, fece una guerra spietata a quelli di «Bandiera rossa»,
formazione in cui c'erano trozchisti, un anarchico, qualche repubblicano e
soprattutto numerosi ufficiali «democratici» come Aladino Govoni (trucidato alle
Ardeatine), il figlio del poeta Corrado. Il foglio del Pci arrivò a definirli
«emissari di Goebbels» uguagliandoli ai nazisti. Poche settimane prima di via
Rasella avvertì che se qualcosa di grave fosse accaduto a Roma «sappiamo di chi
è la responsabilità». Lo sterminio alle Fosse Ardeatine di «Bandiera rossa» e
delle altre formazioni fu un danno collaterale dell'azione di via Rasella? Un
caso? Antonello Trombadori, uno dei leader del Pci, che aveva capeggiato i
gappisti romani nella prima fase e si trovava nel carcere di Regina Coeli, si
salvò grazie al medico del carcere, il dottor Monaco, che lo dichiarò
«intrasportabile» perché malato. Ma alle Fosse Ardeatine finirono storpi e anche
un ragazzo di 14 anni. Si potrebbe poi parlare - tra le tante ombre di questa
vicenda - del segretario romano del Pci che all'epoca era un informatore
dell'Ovra la polizia politica di Mussolini. Il commando di via Rasella in parte
fu arrestato poche settimane dopo l'attentato (tranne Rosario Bentivegna e Carla
Capponi) e salvato grazie alle complicità della Questura. Si potrebbe discutere
degli intrecci e del potere che, a partire dalla «geometrica potenza» dispiegata
il 23 marzo del '44, i vertici del Partito riuscirono a imporre su una parte dei
servizi segreti ex fascisti. Giorgio Amendola, comandante militare dei Gap a
Roma che fece da supervisore dell'attentato, si è portato dietro per tutta la
vita il cruccio di via Rasella. Rosario Bentivegna continua a tacciare come
«imbecilli e faziosi» quelli che mettono in dubbio la vulgata. Ma io lo
abbraccerei, Bentivegna. Pur di mantenere intoccabile il mito si è assunto le
responsabilità per tutti, compresi storici e pseudo-storici come i giornalisti,
trascinando per decenni il peso di quel carretto carico di centinaia di morti.
Lo abbraccerei, e gli chiederei solo: che cosa pensi veramente, che cosa hai
capito di questa storia? Ma so che è inutile.
Via Rasella, finalmente
qualcuno la racconta giusta.
Dopo Via Rasella, una piece teatrale racconta i fatti con empatia verso gli
esseri umani, scrive Simonetta Sciandivasci su “Il Giornaleoff”. Per andare da
Casalbertone a Termini, a piedi, ci vogliono 50 minuti. Le pallottole non fanno
curve, corrono dritte. Niente whiskey, c’è solo l’amaro fatto in casa. Quelle
che imparano a scrivere a macchina studiano dattilografia. I notai sono ricchi.
Vittorio, protagonista di “Dopo Via Rasella”, si fa prendere da tutto questo
mentre tenta di raccontare a Giacomo (Antonio Pisu) la rappresaglia seguita
all’attentato del GAP in cui rimasero uccisi 33 tedeschi e che costò la vita a
335 italiani. Si fa prendere da visioni e battute. Vuole dire quanto freddo fa,
quanto cammina, com’è il suo lavoro. Non pensiamo mai che alla storia sia
attorcigliata la vita e a quanto essa sia materialista, pratica. Se immaginiamo
Roma, la mattina dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la pensiamo solenne,
piegata. Invece, era solo Roma: fredda, lunga, rumorosa, tutti incazzati.
Compreso Vittorio, ferroviere ed ex alpino, reduce dalla guerra in Grecia, che
si sveglia dicendosi “oggi non vado a lavoro”, ma poi ci va. E passa al
cimitero, perché di parlare con Dio non se la sente, ma con la moglie sì.
Vittorio, nella sua narrazione, fa vincere la vita, che è sempre una distrazione
dal suo senso, dal percorso collettivo su cui il tempo la incunea. Non appena
comincia a capire cosa gli è successo, di essere stato salvato dal
rastrellamento e di essere, quindi, un debitore, Pierpaolo De Mejo, che di “Dopo
Via Rasella” è autore, sceneggiatore e attore, fa calare il sipario. Una scelta
perfetta che rende lo spettacolo, in scena a Roma dal 6 al 30 novembre presso il
Teatro Elettra, quello che il suo autore voleva che fosse: il racconto di una
vicenda umana, i cui protagonisti (con Vittorio e Giacomo c’è una ragazza,
Olivia Cordsen, che ricorda che si sta parlando di guerra, che sono morte
persone ed è importante dire quante e come) hanno un ruolo misericordioso:
prescindere da bene e male, dalle coscienze dei carnefici. Per Adorno, dopo
l’olocausto non sarebbe più stata possibile la poesia. Si ricredette presto,
capendo che proprio da poesia e arte l’umanità sarebbe ripartita. Pierpaolo,
trentenne poderoso, dimostra che il teatro, che è poesia mobilitata, può essere
civile senza essere politico, guardando con gli occhi (non con i manuali) la
storia. Se riuscissimo ad affrontarla senza emotività, l’appropriazione delle
tragedie per corroborare o distruggere ideologie sarebbe impensabile: basterebbe
l’intuito per illuminarci sulla funzionalità degli eventi e riallacciarci
all’empatia verso gli altri esseri umani, anche quelli con le responsabilità
peggiori. Quando ci riusciremo, potremo riflettere su quanto strana sia stata la
scelta dei partigiani, a pochi giorni dalla liberazione di Roma, di attentare
alla vita dei tedeschi, ormai in ritirata.
In questo modo non è
scandaloso rivalutare la statura degli statisti del tempo che fu.
“L’unica lotta alla mafia?
Quella di Mussolini”.
Una passione per i perdenti, gli oscuri, i presunti cattivi. Un interesse per i
lati poco indagati o indagati male di storia, antropologia, geopolitica. Un
certo anti-modernismo di fondo che non è mai diventato mentalità reazionaria. E
la convinzione che le categorie di destra e sinistra siano un’eredità ormai da
dismettere. Questo è Massimo Fini. Di padre toscano e di madre ebrea russa,
brillante ediorialista e inviato per il Giorno e l’Europeo. Compagno di
scorribande di Vittorio Feltri all’Indipendente, ora editorialista de Il
Fatto Quotidiano. Autore di saggi controcorrente. Siamo andati a trovarlo
per una chiacchierata su Nerone, che poi è andata per conto suo. Lo spettacolo
di Edoardo Sylos Labini, in questi giorni al Manzoni di Milano, prende titolo,
argomento, e impostazione proprio da un saggio di Fini: Nerone. Duemila anni
di calunnie (Marsilio, pp 267, Euro 12) “Della piéce mi ha colpito la
drammaturgia, la scrittura. Era molto difficile fare una sceneggiatura di
quest’opera, soprattutto avendo scelto di valorizzare Nerone e Seneca.
Nonostante la modernizzazione degli ambienti siamo all’interno di una storia a
pieno titolo romana” racconta Fini a ilgiornaleoff.it.
Qual è il significato
storico di una figura come Nerone?
«Nerone
è stato un principe rinascimentale calato nella storia romana. Con visioni molto
ampie in tutti i campi, ma nato con troppi secoli di anticipo. Da un punto di
vista politico fa parte di una linea che parte da Catilina, che tenta di
tagliare un po’ le unghie ai “fannulloni” (come li chiama lui) del Senato, e di
dare una dignità alla plebe».
E’ una costante della
storia romana, dalla crisi della Repubblica in poi: chi vuole il comando cerca
di bypassare il Senato e di farsi amica la plebe. Populismo?
«Due
imperatori, Caligola e Nerone si interessarono alla plebe per riequilibrare le
forze. Nerone di più. E infatti fu amatissimo dal popolo che continuò a portare
foori a lungo sulla sua tomba, aspettandone il ritorno. E nei decenni successivi
ci furono ben tre falsi Nerone che si presentarono come la sua reincarnazione.
Come statista Nerone ebbe una visione molto ampia. Volle abolire le imposte
indirette ma senza aumentare quelle dirette attraverso una politica keinesiana
di grandi lavori pubblici. Non aveva grande voglia di fare l’imperatore: Nerone
era un amante delle arti. Ma ebbe il suo peso anche come uomo politico».
Da un certo momento in poi
gli imperatori usano la cultura per realizzare il loro progetto politico.
Augusto fa scrivere l’Eneide, Nerone usa molto gli spettacoli del circo…
«Ma
mentre il tentativo di Augusto è elitario quello di Nerone no: nell’anfiteatro
ci andavano tutti. Augusto era una sorta di proto-democristiano: governava per
l’aristocrazia. Un personaggio abbastanza spregevole, tutto sommato».
Seneca. Viene citato ancora
oggi come saggio universale, mentre sembra di capire che a lei fa abbastanza
orrore. Perché?
«E’
il classico personaggio dalla doppia morale. Faceva prestiti a usura in
proporzioni pazzesche. Una delle guerre che a Nerone tocca fare nasce perché
Seneca richiede ai Britanni il rientro immediato di dieci milioni e mezzo di
sesterzi. E anche come pensatore, Caligola lo definisce “sabbia senza calcina”.
E’ un ottimo divulgatore dello stoicismo. Ma non va al di là di questo».
Questa sua mania per vedere
i lati oscuri dei personaggi positivi, anche nell’attualità. Qualche anno fa
stroncò Emma Bonino, che si era introdotta nei reparti femminili di un ospedale
afghano con un codazzo di uomini.
«Lì
la Bonino era da frustare con le verghe sacre. Bisogna tenere conto della
cultura del paese in cui si entra».
Altre buone fame di cui
diffida?
«Per
esempio quella di Matteo Renzi. Del tutto basata sul virtuale. Non c’è nulla di
concreto che la giustifichi».
Renzi recentemente è andato
da Barack Obama.
«Obama
quando è venuto in Italia l’unica cosa che ha saputo dire era che il Colosseo è
più grande di un campo da baseball. Ma sono due poveretti che non contano più
nulla di fronte a Cina, Russia e altre potenze emergenti mondiali. Comunque
sappiamo com’è la storia…»
E com’è?
«Il
solito tributo all’alleato presunto importante. A proposito, in Italia l’unico
che ha tentato una politica autonoma è stato Andreotti. Ha fatto una politica di
avvicinamento al mondo mediterraneo, anche molto abile e molto coraggiosa. In un
altro paese sarebbe stato un grande statista. Nel nostro è stato a metà un
grande statista e a metà un delinquente. Perché purtroppo in Italia non può non
andare cosi. Il giornale per il quale scrivo insiste sul parallelo
Andreotti-belzebù, i contatti con la mafia…»
E non li aveva?
«Ce
li avevano tutti. Anche l’integerrimo Ugo La Malfa aveva il suo uomo in Sicilia,
Aristide Gunnella, che era un mafioso…»
Bisogna prendere i voti al
Sud…
«Certo.
E poi, è noto che la mafia assume il potere che assume perché gli americani
l’hanno usata come appoggio per lo sbarco in Sicilia. L’unico regime che l’ha
davvero combattuta è stato il fascismo. Un regime forte non può accettare che ci
sia all’interno un altro regime forte. Che poi è il motivo perché Saddam Hussein
detestava Bin Laden, e quest’ultimo in Iraq non c’è mai stato».
E a questo punto parliamo
di geopolitica. Quest’Europa che si preoccupa tanto di osteggiare la Russia,
mentre infuria la guerra dell’Isis, è legata a una contrapposizione da guerra
fredda, ormai vecchia?
«Assolutamente
stupida. Avremmo dovuto prendere le distanze dagli Usa col crollo dell’Urss.
Fino ad allora il legame aveva avuto un senso. Ma come dice Luciana Littizzetto
(a volte i comici dicono meglio) “Ma quand’è che scade il mutuo?”. Oggi sarebbe
molto più ragionevole una vicinanza con la Russia, che ci è più vicina
geograficamente e culturalmente. La Russia è Europa».
Ma perché l’idea del
dialogo con la Russia ce l’ha solo gente di destra, anche estrema, mentre la
sinistra è in blocco filoamericana? Non le sembra un paradosso?
«La
destra (parliamo in generale, banalizzando) ha una concezione individualista, è
più libera in certe cose. La sinistra sconta ancora il materialismo storico, è
collettivista, non riesce a staccarsi dalle sue categorie(tte). E poi chi
governa (al momento la sinistra) pensa solo al qui e ora. E vengono fuori
disastri, come il fatto che gli Usa ci abbiamo trascinati nella guerra in Libia.
Totalmente autolesionista. O nella guerra alla Serbia. Ce la siamo presa con un
paese cristiano ortodosso. Attaccare questi per favorire la componente musulmana
nei Balcani non è stata una cosa intelligente. Ora in Kossovo e in Albania sono
cresciute cellule di radicalismo islamico che ci possono colpire in ogni momento».
Lei si definisce un “onesto
pagano”. Non è certo un cattolico. Le domando: c’è un fondamentalismo laico? Ci
sono i Mullah del laicismo?
«E
come no? L’altro giorno ho pubblicato con gran dispetto del mio direttore una
frase di un leader della rivoluzione francese come Louis Antoine de Sant Just:
“La verità è una sola, può essere ammesso solo il partito che si riconosce in
questa verità. Tutti gli altri devono essere soppressi”. Il gene del
totalitarismo laico c’è già. E oggi si è fatto carne. E sta in questa
convinzione che il mondo occidentale sia migliore e abbia il dovere di imporre i
propri valori agli altri mondi. Lo scontro che c’è adesso in Iraq è lo scontro
tra due totalitarismi, laico e religioso».
E questo fondamentalismo
laico esiste anche in Occidente? Per esempio col controllo del linguaggio,
completamente asservito alla correttezza politica? Non si può più dire “frocio”.
«Non
si può più dire “finocchio”. Sono infinite le cose che non puoi più dire in
Occidente. E’ una cosa orwelliana, è un aspetto del totalitarismo più
complessivo. Questa società di fatto (e credo di poterlo dire) non tollera idee
che siano sovversive. E’ un sistema soft di totalitarismo. Non si può parlare di
cos’è veramente la donna oggi, per esempio».
Ecco, le donne. Lei ha fama
di essere un grande cultore della femmina.
«Della
femmina, non della donna».
Che vuol dire?
«Che
non amo la donna. Amo la femmina. Conosco donne che arrivano a 36 38 anni e si
accorgono che è tardi per avere dei figli, e rimpiangono di non averne avuti. Si
guardi in giro. Non si vedono che cani, e niente bambini. Non esiste più la
parte materna-accuditiva, che è pure importante. E’ anche vero che
contemporaneamente il maschio non fa più il maschio».
E questo dove si vede?
«L’altro
giorno ero al bar. Passa una bella donna, vistosa. Un operaio le fa un fischio.
Lei lo fulmina con lo sguardo. Poi, quando passa davanti a me, dico alla
ragazza: “signora, rimpiangerà il giorno in cui non le faranno più questi
fischi”. La sovrastruttura donna ha molto compromesso la struttura femmina».
Bene. Adesso la frittata
d’Occidente è fatta. Cosa fare? Cosa consiglierebbe a un giovane per non restare
incastrato sotto lo spirito del tempo?
«C’è
chi cerca di scappare. Chi se ne va in una cascina. C’è chi si arruola nei
fondamentalisti. Uno scrittore può cercare di svegliare le coscienze. Ma il
pessimismo non permette di indicare una via d’uscita. Ma non dipende da noi.
Questo mondo, come tutti i mondi totalitari imploderà su se stesso».
L’ITALIA DEGLI IPOCRITI.
GLI INCHINI E LA FEDE CRIMINALE.
L’italiano è stato da sempre
un inchinante ossequioso. Ti liscia il pelo per fottersi l’anima.
Fino a poco tempo fa nessuno
aveva mai parlato di inchini. Poi i giornali, in riferimento alla Concordia,
hanno parlato di "Inchini tollerati". Lo sono stati fino a qualche ora prima
della tragedia sulla Costa Concordia che ha provocato morti e feriti
incagliandosi sulla scogliera davanti al porto dell'Isola del Giglio.
Repubblica.it lo ha documentato: nei registri delle capitanerie di porto che
dovrebbero controllare il traffico marittimo, emerge che la "Costa Concordia" -
così come tutte le altre navi in zona e in navigazione nel Mediterraneo e nei
mari di tutto il mondo - era "seguita" da Ais, un sistema internazionale di
controllo della navigazione marittima che è stato attivato da alcuni anni e reso
obbligatorio da accordi internazionali dopo gli attentati dell'11 settembre (in
funzione anti-terrorismo) e dopo tante tragedie del mare avvenute in tutto il
mondo. Si è scoperto così che quel passaggio così vicino all'isola del Giglio
era un omaggio all'ex comandante della Costa Concordia Mario Palombo ed al
maitre della nave che è dell'isola del Giglio. Si è scoperto anche che per ben
52 volte all'anno quella nave aveva fatto gli "inchini". Inchini che fino al
giorno prima, fino a prova contraria, erano stati tollerati: nessuno fino ad
allora aveva mai chiesto conto e ragione ai comandanti di quelle navi. Nessuno
aveva cercato di capire perché passassero così vicini alla costa dove per legge
è anche vietato (se una piccola imbarcazione sosta a meno di 500 metri dalle
coste, se beccata dalle forze dell'ordine, viene multata perché vietato).
Figuriamoci se a un bestione come la Costa Concordia è consentito "passeggiare"
in mezzo al mare a 150-200 metri dalla costa. Il comandante Schettino, come
confermano le indagini e le conversazioni radio con la capitaneria di porto di
Livorno, ha fatto errori su errori, ma nessuno prima gli ha vietato di
avvicinarsi troppo all'isola del Giglio. Quando si è incagliata era troppo
tardi.
Da un inchino ad un altro.
Dopo il 2 luglio 2014 l’anima italica, ipocrita antimafiosa, emerge dalle
testate di tutti i giornali. I moralisti delle virtù altrui, per coprire meglio
le magagne governative attinenti riforme gattopardesche. Si sa che parlar dei
mondiali non attecchisce più per la male uscita dei pedanti italici. Pedanti
come ostentori di piedi pallonari e non di sapienza. Lo dice uno che sul tema ha
scritto un libro: “Mafiopoli. L’Italia delle mafie”.
Una protesta plateale. Se la
Madonna fa l’inchino ai boss, i carabinieri se ne vanno. Se i fedeli e le
autorità, civili e religiose, si fermano in segno di “rispetto”, davanti alla
casa del mafioso, le forze dell’ordine si allontanano, in segno di protesta. E
ne diventano eroi. Tanto in Italia basta poco per esserlo. È successo il 2
luglio 2014, a Oppido Mamertina, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria,
sede di una sanguinosa faida tra mafiosi: durante trenta secondi di sosta per
simboleggiare, secondo tutti i giornali, l’inchino al boss Giuseppe Mazzagatti,
i militari che scortavano la processione religiosa si sono allontanati. Tutti ne
parlano. Tutti si indignano. Tutti si scandalizzano. Eppure l’inchino nelle
processioni è una tradizione centenaria in tantissime località del sud. Certo è
che se partiamo con la convinzione nordista mediatica che il sud è terra
mafiosa, allora non ci libereremo mai dei luoghi comuni degli ignoranti, che
guardano la pagliuzza negli occhi altrui. Gli inchini delle processioni si fanno
a chi merita rispetto: pubbliche istituzioni e privati cittadini. E’ un fatto
peculiare locale. E non bisogna additare come mafiosi intere comunità (e dico
intere comunità), se osannano i singoli individui e non lo Stato. Specie dove lo
Stato non esiste. E se ha parvenza di stanziamento, esso dà un cattivo esempio.
A volte i giudizi dei tribunali non combaciano con quelle delle comunità, specie
se il reato è per definizione nocumento di un interesse pubblico. Che facciamo?
Fuciliamo tutti coloro che partecipano alle processioni, che osannano chi a noi
non è gradito? A noi pantofolai sdraiati a centinaia di km da quei posti? Siamo
diventati, quindi, giudici e carnefici? Eliminiamo una tradizione centenaria per
non palesare il fallimento dello Stato?
Dare credibilità agli
amministratori locali? Sia mai da parte dei giornali. Il sindaco di Oppido
Mamertina, Domenico Giannetta, ha rilasciato un lungo comunicato per spiegare
l'accaduto «Noi siamo una giovane amministrazione che si è insediata da 40
giorni e non abbiamo nessuna riverenza verso un boss. Se i fatti e le
motivazioni di quella fermata sono quelli ricostruiti finora noi siamo i primi a
condannare e a prendere le distanze», spiega Domenico Giannetta, sindaco di
Oppido Mamertina. «A quanto appreso finora - spiega ancora il sindaco - la
ritualità di girare la madonna verso quella parte di paese risale a più di 30
anni, ma questa - chiarisce Giannetta - non deve essere una giustificazione. Se
la motivazione è, invece, quella emersa condanniamo fermamente. Noi - sottolinea
- siamo un’amministrazione che vuole perseguire la legalità. Ci sentiamo come
Amministrazione Comunale indignati e colpiti nel nostro profilo personale e
istituzionale. Era presente al corteo religioso tutta la Giunta Comunale, il
Presidente del Consiglio Comunale, il Comandante della Polizia Municipale e il
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Oppido. Giunti all'incrocio tra via
Ugo Foscolo e Corso Aspromonte, nel seguire il Corteo religioso tutti i predetti
camminando a piedi svoltavamo a sinistra, circa 30 metri dietro di noi vi erano
i presbiteri e ancora dietro la vara di Maria SS. Delle Grazie. Mentre tutti
procedevamo a passo d'uomo la vara si fermava all'intersezione predetta e veniva
girata in direzione opposta al senso di marcia del Corteo, come da tradizione.
Peraltro, nell'attimo in cui i portatori della vara hanno espletato tale
rotazione, improvvisamente il Comandante della Stazione locale dei Carabinieri
che si trovava alla destra del Sindaco si è distaccato dal Corteo, motivando che
quella gestualità era riferibile ad un segno di riverenza verso la casa di
Mazzagatti. Sentiamo dunque con sobrietà di condannare il gesto se l'obiettivo
era rendere omaggio al boss, perché ogni cittadino deve essere riverente alla
Madonna e non si debba verificare al contrario che per volontà di poche persone
che trasportano in processione l'effigie, venga dissacrata l'onnipotenza divina,
verso cui nessun uomo può osare gesto di sfida. Dal canto nostro
nell'immediatezza del fatto, nel dubbio abbiamo agito secondo un principio di
buon senso e non abbiamo abbandonato il Corteo per non creare disagi a tutta la
popolazione oppidese ed ai migliaia di fedeli che giungono numerosi da diversi
paesi ed evitare il disordine pubblico».
Se non vanno bene, possiamo
cambiare le regole. Bene ha fatto a centinaia di km in quel di Salerno il clero
locale. Meno applausi e più preghiere, affinchè la processione di San Matteo
ritorni ad essere «un corteo orante» e non un teatro o un momento «di interessi
privatistici», scrive “La città di Salerno”. L’arcivescovo Luigi Moretti
annuncia così le nuove “regole” che, in linea con la Cei, caratterizzeranno la
tradizionale celebrazione dedicata al Santo Patrono, invitando tutti - fedeli,
portatori, istituzioni - a recuperare il senso spirituale della manifestazione.
Non sono previste fermate dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza, nè
dinanzi al Comune. Aboliti gli “inchini” delle statue che per nessuna ragione
dovranno fermarsi sulla soglia di bar e ristoranti, visto che «sono i fedeli che
si inchinano ai Santi e non il contrario». Nessuna “ruota” delle statue, fatta
eccezione per tre momenti di sosta all’altezza di corso Vittorio Emanuele, corso
Garibaldi e largo Campo. I militari che sfileranno dovranno essere rigorosamente
non armati e le bande saranno ridotte ad un unica formazione. Le stesse statue
saranno compattate «in un blocco unico per evitare dispersioni». Nei giorni che
precedono la processione saranno organizzate iniziative nelle parrocchie della
zona orientale, «che prima erano tagliate fuori dalla celebrazione». Il corteo
sarà aperto da croci e candelabri, poi le associazioni, con l’apertura anche a
quelle laiche, altra novità di quest’anno. A seguire la banda, le statue, il
clero «su doppia fila», l’arcivescovo che precederà San Matteo e dietro i
Finanzieri, il Gonfalone del Comune e le autorità con il popolo. Durante la
sfilata «si pregherà e verranno letti dei brani del Vangelo». No ai buffet
allestiti per ingraziarsi il politico di turno con brindisi e pizzette. «Quelle,
se i fedeli vorranno, potranno recapitarle a casa dei portatori», ha ironizzato
Moretti. «Ben venga chi vuole offrire un bicchiere d’acqua a chi è impegnato nel
trasporto delle statue, ma il resto no, perchè c’è un momento per fare festa ed
uno per pregare».
In conclusione sembra palese
una cosa. Gli inchini nelle processioni non sono l’apologia della mafia, ma
spesso sono atti senza analisi mediatica dietrologica. Molte volte ci sono per
ingraziarsi, da parte dei potenti, fortune immeritate. Sovente sono un segno di
protesta contro uno Stato opprimente che ha vergognosamente fallito.
L’italiano è stato da sempre
un inchinante ossequioso. Ti liscia il pelo per fottersi l’anima. Si inchina a
tutti, per poi, un momento dopo, tradirlo. D'altronde ognuno di noi non si
inchina a Dio ed ai Santi esclusivamente per richieste di tornaconto personale?
Salute o soldi o carriera?
Ricordatevi che lo sport
italico è solo glorificare gli appalti truccati ed i concorsi pubblici falsati.
PREMIO STREGA ED
AUTOCITAZIONI. LO SCRITTORE NON E’ MAI AUTORE.
Bisogna credere agli editori
che in queste ore, alla vigilia del Premio Strega, ostentano nonchalance? Si
chiede Silvia Truzzi per “Il Fatto Quotidiano”. Naturalmente no: giurano tutti
indifferenza, intanto collezionano telefonate e questuano voti. Il clima è teso,
quest’anno ci si è messa pure Federcosumatori, con una “richiesta di
trasparenza” alla Fondazione Bellonci: “Qualche finalista è stato sorpreso con
le mani nel sacco del ricorso al copia e incolla di passi presi da proprie
precedenti opere. Altri finalisti vantano consorti collaboratrici del direttore
della Fondazione organizzatrice del Premio”. Il riferimento è ad Antonio Scurati
e alla sua, diciamo, “autocitazione” di una scena di sesso che compare pressoché
invariata anche in un precedente libro (che pure era stato in concorso allo
Strega). La seconda allusione invece è alla moglie di Francesco Piccolo, che
fino all’anno scorso collaborava con la Fondazione Bellonci. Se la matematica è
una scienza che porta a conclusioni necessarie, gli editori hanno ben altri
motivi d’inquietudine. I numeri di questo Strega non sono incoraggianti: le
statistiche Nielsen (la società che raccoglie i dati delle vendite senza
includere la grande distribuzione) sul venduto dei titoli in concorso parlano
chiaro. Ed ecco cosa dicono. Si difende Il desiderio di essere come TUTTI di
Francesco Piccolo (Einaudi) che ha venduto 42 mila copie dal novembre 2013 (data
di pubblicazione) a oggi. Bisogna dire che di questo “romanzo della sinistra
italiana” - ancora prima di nascere era già il vincitore annunciato dello Strega
- si è parlato molto sui giornali e Piccolo è stato anche ospite del salotto di
Fabio Fazio. Non che Bompiani abbia lesinato pubblicità a Il padre infedele:
eppure il libro di Antonio Scurati, uscito a ottobre 2013, resta fermo a 8.200
copie, che sono davvero poche per un autore già affermato. Va meglio in casa
Feltrinelli, dove Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, uscito a
gennaio 2014, arriva alle 20 mila copie. La vita in tempo di pace, esordio
letterario di Francesco Pecoraro con Ponte alle grazie – un piccolo caso per le
ottime recensioni ottenute – ha venduto 4.500 copie da ottobre 2013 a fine
giugno 2014. Ultima – ma il dato è poco significativo perché il romanzo è uscito
a metà marzo di quest’anno – Antonella Cilento con Lisario o il piacere infinito
delle donne (Mondadori), ferma a 3.800 copie. Naturalmente tutto questo non è
strano, visto che il mercato editoriale non dà segni di miglioramento: nel 2013
ha registrato un -6,2% a valore e -2,3% a copie nei canali trade (quelli rivolti
al pubblico: librerie, librerie online e grande distribuzione) rispetto al 2012.
Gli italiani hanno acquistato lo scorso anno 99,2 milioni di volumi (2,3 milioni
in meno del 2012) e il 2014 non si è aperto sotto auspici molto migliori, se nei
primi tre mesi sono stati venduti 1,4 milioni di libri in meno rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Lo Strega s’inscrive in una curva discendente
e per questo vincerlo o no è, se possibile, ancora più importante. Non sfugge,
ai sopracitati e irrequieti editori, che quest’anno è cambiato il sistema
elettorale: si può votare – oltre che mettendo personalmente la scheda nell’urna
domani sera – con un account personale da un computer che non può essere
utilizzato per esprimere più d’una preferenza. Per la selezione della cinquina,
su 460 aventi diritto, hanno votato in 403: di questi hanno utilizzato la scheda
digitale in 320. Il sistema è più trasparente , sicuro e anonimo: certo toglie
un’arma dalle mani degli editori, che non sempre si sono limitati alla moral
suasion. È finita l’epoca dei telegrammi, dei voti raccolti dagli uffici stampa
e di tutti i pasticci che tanto hanno contribuito alle numerose leggende del
Ninfeo? Come da copione, anche quest’anno i giurati sono stati inseguiti da
autori e direttori editoriali, ma nel segreto dell’urna digitale non si sa mai
cosa può accadere: lo scopriremo domani al Ninfeo.
Ammaniti, Raimo e Pincio,
che figuracce,
scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”. Vi ricordate tutte
quelle belle discussioni su che cosa sia la letteratura? Rappresentazione del
reale, suo stravolgimento, reinvenzione, altro? E ancora vi ricordate le
appassionate disquisizioni sul ruolo degli scrittori? Beh dimenticatevi tutto
questo. Oggi scrivere vuol dire raccontare di sé, autocitarsi. La hanno
chiamata, nobilitandola, <autofiction finzionale> (Vanni Santoni su “La lettura”
del Corriere) ma con il linguaggio forse un po’ volgare ma veritiero la potremmo
definire “sega d’autore”. In alcuni casi “sega d’autore 2.0”. Partiamo dal 2.0.
Ben due scrittori, Christian Raimo e Tommaso Pincio, stanno infatti per
pubblicare due opere ispirate ai loro status su facebook. Raimo quelli scritti
col personaggio del professore zimbello degli studenti; Pincio quelli che
prendendo per il fondelli il senso comune avevano come incipit “Genti che non
sanno”, che sarà anche il titolo del libro. Visti i like ricevuti, come
sottolinea bene Simonetta Sciandivasci su Il Foglio, hanno deciso che la loro
social produzione meritasse addirittura una consacrazione tipografica. La
presunzione, tornando al dibattito iniziale, è che i loro status non abbiano a
che fare con la realtà pedissequa di cui tutti raccontano, ma siano già opera
letteraria. Invenzione o creazione che sia. Al di là del valore complessivo dei
due libri -aspettiamo con impazienza di sfogliarli pur avendo letto tutti i vari
status e essersi dopo un po’ rotte le scatole della ripetizione
ossessiva - quello che colpisce è proprio questa idea. Cioè la convinzione che
da una parte ci siano persone reali e dall’altra personaggi inventati dal genio
dello scrittore. Niente di più sbagliato. Chi – come Raimo e Pincio – frequenta
il social network sa bene che non è così. Anche il racconto più alla lettera, il
commento più politico, la considerazione più legata al quotidiano costruiscono
avatar di colui e colei che scrive. Questo vale per tutti. In molti poi, non
certo con l’abilità dei nostri scrittori, hanno fatto anche uno sforzo in più.
Quello di costruire consapevolmente una narrazione orientata, pensata, voluta. I
selfie spesso sono questo. Non un semplice autoscatto, ma la volontà di
costruire un immaginario diverso. Il valore di queste narrazioni non è certo
nella loro ricaduta sui mezzi di comunicazione tradizionali. Niente di più
sbagliato. La novità è di per sé in questa narrazione diffusa, molteplice,
spesso accattivante. Davanti a questo cambiamento epocale, che va ancora
studiato e approfondito, lo smarrito possessore della verità narrativa che fa?
Non si scoraggia e cerca di recuperare la posizione se non perduta messa
fortemente in discussione. Scrive un libro che raccoglie i propri status. Non
tanto per il valore in sé quanto per dare un messaggio chiaro: io sono io, voi
non siete… etc etc… Almeno, a discolpa di Pincio e Raimo, bisogna dire che i due
hanno capito che con i social sta avvenendo qualcosa di importante. Hanno però
scelto la strada più facile: pensare che la logica che sottende facebook possa
essere riportata su un libro come se niente fosse. I “sega d’autore” (senza
punto zero) hanno fatto anche di peggio. Hanno saltato il passaggio
dell’attraversata del mare magnum del web e si sono concentrati sulle loro
personali e reali avventure. Sulle loro “Figuracce”, libro edito da Einaudi da
un’idea di Niccolò Ammaniti, a cui hanno collaborato come coautori De Silva,
Giordano, Pascale, Piccolo, Raimo, Stancanelli, Trevi. In questo caso il
Corriere parla di autofiction e ci risparmia il finzionale. La sostanza è però
la stessa. La messa in scena di se stessi, il guardarsi l’ombelico pensando che
ai lettori possa interessare qualcosa. I diversi scrittori parlano delle loro
figuracce legate al lavoro. Probabilmente il libro venderà, vista anche il
battage di cui può contare e i nomi che lo hanno firmato, ma resta la domanda
iniziale. Ma questa roba che cosa è?
Lo scrittore non è mai un
autore. Il
narratore di «Sentire le donne» esplora la distinzione tra cultura alta e
passatempo. Troppi «commissari» e romanzi simili a compitini. Ma l’opera
omologata è già passata, scrive Aldo Busi su “Il Corriere della Sera”. Che
uggiosa stravaganza quella di suddividere le opere letterarie in
autoreferenziali, cioè che parlerebbero autobiograficamente dell’autore che le
scrive, e in altro-da-sé, cioè che parlerebbero della società e del vasto mondo
esterno (?) all’autore! Oltretutto senza avere ancora operato con taglio netto
la separazione tra scrittore e autore, cioè tra letteratura, che il fiasco un
po’ se lo va a cercare, e, si spera, industria, fatturato (il testo alquanto
mediocre di uno scrittore mi coinvolgerà sempre di più del meglio confezionato
libro con commissario incorporato di autore), e senza alcun snobistico
moralismo, giusto a vantaggio di entrambi gli scriventi — per sorvolare sulla
pletora di quanti si descrivono nei blog e nei talk show come «attore e
scrittore», «comico e scrittore», «pittore e scrittore», per arrivare
all’ossimoro per eccellenza, «giornalista e scrittore». Quando uno non sa
scrivere, scrive bene. Io, per scoraggiarla e quindi reprimerla, arriverei a
teorizzare addirittura la sciocchezza tutta accademica di suddividere quanto
pubblicato in opere scritte bene o scritte male — sempre soprassedendo al fatto
che quando uno non sa scrivere, scrive bene, sicché ci sono almeno due modi per
scrivere male convogliati entrambi nell’unico modo buono per tutti di non sapere
affatto scrivere, e di solito chi non ha neppure un pensiero suo fa i compitini
più perfetti e perfettamente in regola con le norme del bello scrivere e
dell’ottimo pensare, altrui. Secondo un comune buon senso ancora del tutto
ideale, l’unico metro di giudizio critico possibile. Chi non ha neppure un
pensiero suo fa i compitini più perfetti da adottare per includere ed escludere
dall’attuale lettura è tra opere di regime e nel regime di autori, pertanto
coccolate dal mercato e dai non lettori, e opere di scrittori che vi si
oppongono, che si oppongono a ogni possibile regime e, non appropriabili subito,
perdurano in ogni regime, invise, poco lette, magari ammirate ma da lontano,
senza mai farle avvicinare troppo perché ancora bruciano l’ipocrisia dell’io e
di ogni relazione civile e politica e sentimentale tra codesti io e non
permettono scampo ai sentimentalismi, ai sessualismi, ai familismi, alle
superstizioni, alle religioni, agli assolutismi — anche tecnologici —, agli
avventismi, alle reincarnazioni, ai migliorismi della scienza e della stessa
economia, in altre parole, all’intrattenimento da qualsivoglia consolazione di
progresso promesso e non mantenuto (soprattutto grazie a quelli che ci hanno
creduto e poi però hanno letto noir per tutta la vita e osano lamentarsi o fare
la voce querula della vittima fintamente, per l’appunto, inconsolabile); le
prime, mere pubblicazioni, prendono solo quanto più possibile c’è da prendere,
cioè da incassare, dal regime, dai suoi luoghi comuni e dai suoi sudditi, e se
ne guardano bene dal cambiare una sola virgola al mondo così com’è, le seconde,
che da mere pubblicazioni attingono nel tempo — e poi caso mai assurgono per
sempre — alla dignità di opere, danno solo e, anche se sono più spiritose e
divertenti, vivono di necessità per autocombustione sacrificale senza averne
l’aria e senza attribuirsi alcun orfismo o sacralità d’accatto: in tutta
semplicità anti-sacerdotale rivoluzionano o almeno aggiornano la condizione di
beota stupidità di ogni regime e dell’umana fatalità che lo legittima e se ne
sostenta (tra alti lamenti d’obbligo, va da sé). Un’opera omologata è un’opera
estinta. La data di scadenza di ogni singola opera — e del suo autore — è
conforme al suo grado di omologazione nel tempo: un’opera omologata è un’opera
estinta; se non la si brucia, è perché non vale lo zolfo di un fiammifero, non
certo perché il pregiudizio buonista vorrebbe che coi libri non si fanno falò:
si aspetta direttamente l’inestinguibile benefattore piromane in tournée dopo
aver fatto tappa alla biblioteca di Alessandria. Da qui il fatto che le opere
preferite al momento di ogni momento sono quelle nate morte, punto.
Nell’impossibilità di prevedere l’omologazione futura o futuribile di un’opera
ora o prima immessa sul mercato, l’unico interrogativo possibile e passabile
della critica, a prescindere dall’immediato successo di vendita e consenso
«critico» dell’opera medesima, è: quanto è nata già morta? Quanto fa da
compiaciuto specchio al morto non lettore che la fa propria, di fatto
lasciandoci ancora un po’ della sua già scarsa vita a disposizione? Si potrebbe
intanto stabilire subito chi è uno scrittore e chi, per quanto di moda, un
becchino. Certo, occorrerebbe però un critico non di regime e non nel regime
perché una domanda simile possa porsi e un simile filtro imporsi. Infatti, a
parte me, che non sono nemmeno un critico, non l’ho mai sentita formulare da
nessuno da che mondo è mondo.
ATTORI E REGISTI: UNA CASTA
DI IDIOTI DI SINISTRA RACCOMANDATI.
«Date un luogo comune a un
fanatico e ne farà un dogma». Così, sommessamente, Roberto Gervaso salmodiava
per esorcizzare la malattia culturale del nostro tempo. Un virus che si è
annidato per decenni in anfratti ben protetti, da dove ciclicamente esce per
«evangelizzare» le nuove leve. Una malattia culturale che ha nella
monopolizzazione della sinistra il suo sintomo più evidente. Quasi un gigantesco
drago contro il quale faticano non poco gli sparuti san Giorgio indipendenti che
tentano di difendere i principi della cultura liberale. Il paradosso è più raro
e costoso di un diamante. Aveva ragione Longanesi a dire che il paradosso è il
lusso delle persone di spirito, mentre la verità è il luogo comune dei mediocri.
Le invettive, i paradossi, la libertà e l'indipendenza di un artista di razza
non possono che scontrarsi con il muro di gomma tirato su da chi ha fatto della
verità culturale prima un monopolio e poi un dogma. Si può parlare di tutto,
beninteso. Però la chiave di lettura dominante su ogni argomento la dettano i
giornali di sinistra, forti di una tradizione che ha origini lontane. E contro
questo monopolio è giusto sempre scendere in guerra e combattere. Tra i luoghi
comuni più odiosi c'è quello che da decenni identifica l'artista di valore come
naturalmente schierato a sinistra. Una sciocchezza che è sempre stata venduta
come oro colato. Mai come oggi, però, questa falsità mostra la sua pietosa
debolezza dal momento che sono in molti a uscire allo scoperto. Insomma siamo
all'outing collettivo di tanti artisti che finalmente possono mostrare tutto
l'orgoglio del loro non essere allineati. Oggi è possibile rivendicare questa
autonomia. Basta smascherare il vizietto del doppiopesismo e del miope
allineamento ai dogmi.
Il cinema a sfondo politico è un genere
cinematografico più italiano ed europeo che americano, che pone al centro del
proprio interesse temi di attualità politica o storici, ma in questo caso con
marcata spendibilità e risonanza nel dibattito politico contemporaneo. Quasi mai
il Cinema politico (chiamato anche Cinema di impegno, politico o civile
indifferentemente) è neutrale e nemmeno vuole esserlo, anzi esplicita con molta
chiarezza la propria tesi, in alcuni casi si può parlare proprio di Cinema a
tesi, la cui finalità è cioè quella di dimostrare una precisa posizione nel modo
più chiaro e comprensibile possibile, con tanto di pericoli (sempre incombenti
in questo caso) di
didascalismo
e semplificazione (vedi in proposito il Cinema del
Realismo socialista
e il Cinema di propaganda in generale). Strettamente collegato con il Cinema
politico è il cosiddetto Cinema militante, in tutto simile al primo,
se non fosse per il suo carattere prevalentemente documentarista, anziché di
finzione, per una accentuata propensione propagandistica e soprattutto per il
fatto che esso si muove al di fuori del circuito commerciale, indirizzandosi
verso canali alternativi legati alle organizzazioni partitiche e politiche che
hanno prodotto o commissionato il singolo film. Il Cinema militante ha
conosciuto il suo periodo di maggior diffusione negli anni a cavallo del 1968,
quando la Sinistra storica e quella extraparlamentare usarono con grande
convinzione questo strumento, mai eccelso dal punto di vista qualitativo, ma a
volte assai efficace nel comunicare idee e concetti spendibili nell'immediata
urgenza politica. Il Cinema politico propriamente detto, invece, privilegia il
film di finzione, spesso giovandosi di grandi
budget
e attori e
registi di fama e senza mai
dimenticare la dimensione spettacolare. Anch'esso ha conosciuto una stagione
felice in coincidenza con gli anni sessanta e settanta, anche se i suoi
antecedenti sono rinvenibili nel movimento del
Neorealismo
e del Realismo
poetico francese.
Politicamente orientato a sinistra (per trovare un Cinema politico
esplicitamente e consapevolmente orientato a destra bisogna rifarsi ai film di
propaganda fascista e nazista degli anni trenta o a certi prodotti statunitensi
ferocemente anticomunisti del periodo maccartista degli anni cinquanta, per non
parlare di tanto Cinema
Bellico,
soprattutto in coincidenza con le guerre mondiali), il Cinema politico ha
offerto il meglio di sé quando ha saputo coniugare la critica sociale e la
polemica politica con una salda e vigorosa struttura narrativa e il peggio
quando è diventato
manierata
ripetizione di stereotipi e facile schematismo.
Il senso del Partito
Democratico per il cinema,
tratto da
un articolo di Alberto
Alfredo Tristano.
Con l’ascesa di Matteo Orfini alla presidenza del Partito Democratico, si
rafforza ulteriormente il senso del Pd per il cinema. E’ lunga la frequentazione
e stretto il rapporto tra molti esponenti della prima formazione politica
italiana e la settima arte. Non c’è solo un ex segretario ormai passato
direttamente dietro la macchina da presa, qual è il caso di Veltroni col
documentario su Berlinguer; c’è anche il neopresidente, archeologo di formazione
e di famiglia cinematografara, col padre Mario regista e produttore delle – tra
le altre cose – simpatiche incursioni sul grande schermo di Luciano De Crescenzo
e Renzo Arbore; c’è Nicola Zingaretti, fratello di Luca “Montalbano”, il più
amato personaggio della recente tv italiana; c’è Bettini, da poche settimane
eurodeputato, che – forse per civetteria – fino a poco tempo fa usava
presentarsi come direttore artistico di Moviemov, festival itinerante del cinema
italiano per capitali dell’Oriente; c’è il ministro Madìa, moglie di Mario
Gianani, che con Lorenzo Mieli, figlio di Paolo, e Saverio Costanzo, figlio di
Maurizio, regge le sorti della Wild Side, arrembante casa di produzione
cine-televisiva che spazia da Bernardo Bertolucci a “In Treatment”; e c’è anche
Renzi, che alla Leopolda schierava Umberto Contarello, sceneggiatore tra l’altro
con Sorrentino della “Grande bellezza”, e affidava il set della kermesse
fiorentina al regista Fausto Brizzi. Certo è pur vero che dall’altra parte c’è
Berlusconi, che col colosso Medusa grazie a Sorrentino s’è portato a casa
l’Oscar, e che i film li ha pagati assai cari, visto che la condanna che sta
scontando deriva proprio dai diritti tv delle pellicole acquistate da Mediaset.
Ma in ogni caso: c’è una egemonia culturale del Pd sul nostro cinema?
Probabilmente no, come forse non ce n’è mai stata una. Nemmeno col Pci. Partito
che certamente sul campo fu molto attivo, anzi protagonista quanto ad
organizzazione, e magnetico quanto a ideologia. Lunga è la lista dei registi
militanti: Scola, Petri, Bertolucci, Pasolini (che in realtà ne fu espulso, ma
rimase sempre legato a quell’idea sentimentale di partito come “Paese pulito in
un Paese sporco”). Egemonia, si diceva, anche se è altrettanto lunga la lista di
coloro che, se fecero dichiarazioni di appartenenza e molti le fecero, si
pronunciarono non in senso comunista. Socialista era Monicelli, e socialisti i
milanesi Lattuada e Comencini, come anche Rosi con discreta tradizione familiare
nella massoneria (che lui però non volle seguire); di Fellini, forse il più
grande di tutti, sempre allergico al dibattito eppure autore di film
profondamente politici, si sanno la vicinanza a Nenni e poi La Malfa, e
l’amicizia con Andreotti, che sboccò anche in un lungo carteggio privato;
convinto saragattiano, più ancora che socialdemocratico, era Germi; Rossellini,
certo, dopo la guerra (aveva debuttato, come molti, sotto il fascismo) fu vicino
alla sinistra ma si appassionò assai più al francescanesimo che alle icone
marxiste e al cinema portò la storia dell’anticomunista De Gasperi (si disse con
finanziamenti dall’area fanfaniana). Certo va ricordato come il neorealismo fu
difeso e crebbe sotto l’egida del Pci, si pensi solo a Visconti e alla difesa di
De Sica e Zavattini sui “panni sporchi” che non piacevano al Divo Giulio: ma per
completezza e senso della verità, va serenamente valutato – insieme con la
creatività e il successo dei registi postbellici – anche il lavoro del giovane
sottosegretario allo Spettacolo di De Gasperi per il rilancio del cinema
italiano, grazie a una legge che richiamò ingentissimi investimenti sulle
produzioni nazionali. Egemonia? Tornando all’oggi, se c’è un senso del Pd per il
cinema, forse non vale il contrario. Si farebbe fatica a trovare una vera
attenzione alla politica in generale da parte dei nostri autori. Se si escludono
la passione di registi come Virzì o Moretti e pochi altri, disposti più
schiettamente di altri a esporsi con giudizi e opinioni, e il rilancio del
cinema politico col superbo “Divo” sorrentiniano (che è sembrato un caso unico e
isolato, a dire il vero), c’è una sostanziale indifferenza di quel mondo verso
il mondo della politica. E questo vale ancor di più per le leve più giovani, che
appaiono sostanzialmente apolitiche. Il che è un po’ preoccupante. Anche perché
la politica domina il dibattito nella comunità nazionale. Forse in un partito
come il Pd, così grande e ambizioso e così anagraficamente ringiovanito nei suoi
vertici, sarebbe opportuno che oltre il senso e l’attenzione e le personali
frequentazioni e le individuali attitudini si sviluppasse un vero e più organico
progetto di politica culturale. Foss’anche anche con una coltivata utopia di una
bella, sana, civilissima egemonia…
“Dal fascismo al Pci il
filo rosso di un’egemonia culturale”.
Intervista a Pierluigi
Battista di Cristiana Vivenzio.
Come si sono legati tra
loro universo culturale, tendenze ideologiche e mondo politico negli ultimi
quarant’anni?
«Ricostruendo
un percorso reale che parte dall’inizio degli anni Sessanta, Pierluigi Battista,
giornalista e saggista, editorialista della Stampa, nel suo ultimo libro “Il
partito degli intellettuali” traccia i contorni del rapporto anomalo che in
Italia ha legato gli intellettuali alla politica. Partendo dalla riflessione su
temi noti ma ancor oggi di scottante interesse, questo libro riapre la strada ad
una serie di problematiche in merito al ruolo svolto dagli uomini della cultura
in Italia e soprattutto richiama ad una riflessione ampia e approfondita sul
ruolo prossimo futuro dell’intellighenzia.»
Il monopolio culturale
della sinistra: una delle tante anomalie della vita politica italiana?
«Non
parlerei di monopolio culturale quanto piuttosto di egemonia. Il termine
monopolio prefigura una sorta di irregimentazione. Del resto, il problema di
un’egemonia culturale in Italia non è di natura quantitativa, non dipende cioè
dal fatto che la maggior parte degli scrittori, degli intellettuali, degli
uomini di teatro, dei registi mostrano un certo tipo di appartenenza politica.
Il merito della sinistra italiana, e del Pci in particolare, è stato quello di
dare il senso di una missione agli intellettuali italiani e al loro ruolo
all’interno della società: infondendo l’idea che la cultura fosse un elemento
essenziale della battaglia politica, che facesse parte integrante dello scontro
per le civiltà. La cultura continuava ad essere vissuta e percepita come
prosecuzione e prolungamento della lotta politica e la percezione generale era
quella per cui fare un film, scrivere un libro, più in generale produrre cultura
conferisse un ruolo meritorio. Poiché alimentava l’assoluta convinzione di
possedere il monopolio di ciò che è giusto.»
Questo tipo di concezione
egemonica della cultura può rintracciarsi anche in altre realtà europee?
«Non
direi che questa sia un’anomalia esclusivamente italiana. La Francia ha
presentato un modello analogo. Ma non è un caso che Italia e Francia abbiano
avuto i partiti comunisti più forti d’Europa.»
Quindi la presenza di un
forte partito comunista, in Italia come in Francia, è stato elemento
determinante nel produrre questo tipo di rapporto tra cultura e politica.
«La
forza dell’egemonia intellettuale di sinistra in Italia non è monocausale. Può
essere rintracciata, naturalmente, in più di un fattore. In primo luogo questo
ruolo dell’intellettuale militante e interventista è proprio di una certa
mitologia già propria della cultura italiana a partire dagli inizi del
Novecento: pensiamo a intellettuali come Papini, Prezzolini, Salvemini. Ma
l’elemento determinante nella costruzione di un rapporto imprescindibile tra
mondo culturale e mondo politico è stato istituito nel periodo fascista. Si è
sempre fatto emergere il lato repressivo del fascismo nei confronti della
cultura. Eppure la cultura è stata l’unico ambito, seppure attraverso
manifestazioni allusive o dissimulate, in cui si poteva, anche in tempo di
regime, dar vita ed espressione alle rivalità ideologiche. Nel passaggio dal
fascismo alla democrazia, ad emergere sono stati gli elementi di affinità, che
hanno costituito la linea di continuità tra l’appartenenza pre (la fascista) e
quella post (rappresentata dal comunismo). Finita la guerra e liquidato il
fascismo gli intellettuali italiani scelsero, liberamente e con entusiasmo, di
trasmigrare a schiere compatte nei luoghi ove era possibile proseguire senza
frustrazioni l’opera di fiancheggiamento politico rodata e perfezionata nel
passato regime.»
Ma esistevano reali
alternative a quella visione monotematica della cultura? E soprattutto le altre
forze politiche italiane erano in grado di esprimere modelli alternativi?
«La
sinistra ha schiantato tutte le appartenenze ideologiche alternative: sia quella
liberal-conservatrice sia quella cattolica. L’ideologia comunista, o
filo-comunista, come quella azionista, si è fatta promotrice del monopolio
dell’etica. Questo ha prodotto un intollerantismo ideologico che ha portato
all’automatica scomunica nei confronti di tutti coloro che manifestavano una
qualsiasi forma di dissenso. Certamente la controparte ha dimostrato un’assoluta
incapacità propositiva. I cattolici troppo attenti probabilmente ad un diverso
modo di concepire la politica, legata al concreto esercizio del potere. I
liberali per una tendenza snobistica ed elitaria nel concepire la cultura. Fatto
sta che la storia è una storia di attacchi violentissimi. Da Sciascia a Fellini,
da Montale a De Felice: tutti questi grandi intellettuali hanno assaggiato il
bastone della scomunica.»
Il Cinema italiano e la
sinistra, scrive Gaither Stewart
su “Onlinejournal.com”.
La storia di Roberto Rossellini è una storia molto italiana, che riguarda
l’Italia nel cambiamento dal periodo fascista, che va oltre la sua esistenza,
fino al 2009. Sebbene l’Europa non sia Europa senza l’Italia, la storia di
Rossellini, nel più stretto senso, è una storia molto italiana; non una storia
europea. Perchè l’Italia, separata dal resto dell’Europa dalle Alpi, è, e forse
lo è sempre stata, qualcosa a parte, ancora oggi considerata dai nord europei un
posto esotico verso cui fuggire. Come è comunemente detto, l’Italia è un posto
meraviglioso da visitare, ma un inferno per viverci. La storia di Roberto
Rossellini ha a che fare con questo paradosso. Leggi Roberto Rossellini e pensa
all’Italia degli ultimi 75 anni. Il regista italiano Roberto Rossellini,
conosciuto al 95% come neo-realista, ebbe molto successo nella sua carriera di
regista. Tuttavia – e qui abbiamo due pezzi d’informazione che potrebbero essere
notizia per gli appassionati del cinema – dopo essere cresciuto in una famiglia
borghese nei pressi della Via Veneto della Dolce Vita a Roma e aver armeggiato
con un cinema insignificante durante il periodo fascista, divenne poi un regista
del cinema italiano della Sinistra. Più tardi nella sua vita, Rossellini ebbe
una visione, una visione lontana anni luce dalla registica europea: negli anni
’70, molto più avanti del suo tempo, si innamorò dell’Oriente e sognava un
ricongiungimento tra Occidente e Islam. Come gli scrittori, anche i registi
creano nel loro lavoro una certa aura di se stessi, mentre, allo stesso tempo,
proiettano un messaggio, un tema, nel migliore dei casi, qualcosa di universale.
Il regista geniale è in qualche misura anche un visionario. Tuttavia, per
diventare un visionario deve prima essere in grado di vedere la vita così com'è,
toccarla, sentirne l'odore, assaporarla, soffrire per essa, e si spera infine,
amarla. Questo è ciò che i registi italiani fecero nell’ Italia del dopoguerra,
durante quel breve periodo di forse cinque anni quando crearono il loro cinema
neo-realista che ha cambiato il mondo del cinema. Il regista geniale, quello
eccezionale, si basa quindi sul fondamento della sua esperienza di vita, e, se è
fortunato, potrebbe vivere momenti di trascendenza nella sua arte e produrre un
capolavoro. In questi miei giorni "rosselliniani", mentre mi addentravo in quel
passato, ho intervistato persone che avevano finito la scuola ed erano entrate
nella vita negli “anni del neo-realismo” dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti
concordano che la vita era più reale allora; nella sua semplicità era piena di
speranze e promesse; tutto era possibile. Paradossalmente, l'atmosfera dei
turbolenti anni ‘70, dopo la rivolta del 1968 e la successiva esplosione del
terrorismo interno, ha creato anche una pittoresca, folkloristica immagine
dell'Italia, che sopravvive solo all'estero, non in Italia. Quelli non erano "i
bei vecchi tempi" per gli italiani. L'Italia che rimane nella mente di molti
non-italiani è morta decine di anni fa. La globalizzazione e il selvaggio
capitalismo mondiale hanno spento i sentimenti di solidarietà che contagiavano
gli anni ‘60 e '70. Se lo stato d'animo in Italia allora sapeva anche di
ribellione e di anarchia, oggi ognuno pensa a se'. Nella misura in cui esiste
ancora, l’ Italia cinematografica di oggi riflette uno stile di vita segnato da
brutta televisione commerciale, pubblicità, e quota audience. Mai l'espressione
italiana "stavamo meglio quando stavamo peggio" (la vita era meglio quando le
cose erano peggiori) è stata più valida. Una volta in Italia c'era un cinema
della Sinistra. Un cinema sulla sinistra. Era un diretto e chiaro appello a
votare per i partiti della sinistra, guidati allora dal Partito Comunista
Italiano, il PCI. Quel cinema di sinistra emerse in uno specifico ambiente
italiano del post-fascismo, su cui è necessaria qualche valutazione per capire
su cosa era improntato il suo cinema. Da un lato, il Maccartismo che soffocò
Hollywood ebbe poco effetto sul cinema italiano. Ma lo sconvolgimento della
gioventù degli anni ‘60, che esplose nel 1968, è stato vivido; la resistenza era
nell'aria. Prima la rivolta, poi il terrorismo esplose contro lo stagnante
sistema politico italiano in gran parte finanziato e controllato dagli Stati
Uniti. A quei tempi, il giornale comunista di Roma, Paese Sera, stampava fino a
sei edizioni al giorno, con rivelazioni e scoop, uno dei quali nel 1980 fu lo
scandalo Iran-Contras. Il cinema di sinistra sosteneva le varie battaglie
sociali e politiche dei partiti della Sinistra. Ogni notte, sale
cinematografiche – di prima visione e molte sale meno costose di seconda e terza
visione nella periferia – erano piene fino al soffitto, alcune con sistemi audio
così cattivi che erano difficilmente comprensibili. I cinema di Roma erano
rumorosi, o troppo caldi o troppo freddi, una nube densa di fumo azzurro che
saliva verso il soffitto, per lo più giovani, e tutti della sinistra politica.
Se arrivavi tardi, eri destinato alle prime file. A nessuno importava. Accendevi
e ti univi alla folla. Tutti fumavano, specialmente al cinema. Specialmente al
cinema della Sinistra. E tutti parlavano dei registi, i quali quasi tutti erano
della Sinistra. Essi rispecchiavano la metà d'Italia che era Sinistra. La storia
d'amore del "cinema di Sinistra" era reciproca e sembrava eterna. Era basata su
convinzioni e impegno. Quando i partiti della Sinistra chiamavano, il cinema era
presente. Allo stesso modo, dalla fine della guerra fino al '70 i partiti di
sinistra appoggiavano il cinema. Era un rapporto d'amore. Il cinema italiano
degli anni '60 e '70 aveva un colore. Era rosso: il cinema di Rossellini,
Visconti, Pasolini, Rosi, Pontecorvo, Montaldo, Antonioni, Comencini, Monicelli,
Damiani, Pirro, Scola, Scarpelli, Bertolucci. I loro film separavano la Sinistra
dalla Destra. Dopo l'euforia, però, il cinema e la Sinistra si separarono. La
vicenda passionale durò fino alla fine degli anni '70, momento in cui i partiti
politici erano diventati centri di potere e superato il loro bisogno di avere
per alleato il cinema. Allo stesso tempo la televisione di Stato era esplosa
sulla scena, diventando uno dei più potenti strumenti di propaganda che il
cinema avesse mai potuto immaginare. La decennale storia d'amore della Sinistra
e del cinema perse il suo ardore, le parti si allontanarono, nella separazione,
se non nel divorzio, lasciando l'industria cinematografica italiana
letteralmente a secco. Così finì il grande cinema italiano che aveva conquistato
il mondo. I registi italiani hanno parlato apertamente della causa del divorzio.
Francesco Rosi: i partiti politici divennero centri di potere. Giuliano
Montaldo: il timore che il nostro cinema denuncia sarebbe stato utilizzato per
giustificare il terrorismo. Furio Scarpelli: la nostra incapacità di fare satira
sulla Sinistra come facciamo con la Destra. Tuttavia, altri come Bernardo
Bertolucci e Gillo Pontecorvo conservavano la fede in un potenziale di
rinnovamento del cinema italiano. Purtroppo, non è mai successo. La
commercializzazione grossolana della vita italiana, l’economicità, la volgarità
e l'imitazione dell’America schiacciarono la maggior parte delle iniziative.
Anche se oggi, di tanto in tanto, un buon film d'arte in qualche modo emerge
dalle paludi, il cinema italiano ha toccato il fondo. Lo scrittore e
instancabile critico cinematografico Alberto Moravia scrisse nell'introduzione
alla sua collezione di 144 recensioni di film dal titolo Alberto Moravia Al
Cinema che il regista o l'autore cinematografico è l'unico elemento che conta
davvero in film di qualità, ossia, in film d'autore. Gli attori recitano solo,
in meglio o in peggio. Buoni film, ha sottolineato, non sono da considerarsi “in
base a chi o cosa interpretano, ma da chi." Il regista esprime se stesso,
affrontando sempre nuovi problemi, sempre in cambiamento. Gli attori e la
fotografia hanno il loro ruolo, ma la regia è l'aspetto centrale. "Il cinema è
anche un prodotto estetico e come tale dovrebbe essere apprezzato anche per le
sue immagini, ma un criterio del genere sarebbe troppo limitato". Il concetto di
film d'autore era diametralmente opposto al sistema hollywoodiano degli Studio,
in cui le compagnie cinematografiche come Paramount, MGM, Warner Brothers, e la
Twentieth Century Fox controllavano tutti gli aspetti della produzione
cinematografica. Grandi aziende controllavano i tipi di film che venivano fatti,
così come i registi e gli attori. Lo star sistem era nato. Fare cinema divenne
grande business. Questa era l'altra faccia della luna del cinema della Sinistra
italiana del periodo neo-realista del cinema artistico impegnato. Un buon
esempio di cinema impegnato è stato Francesco Rosi. Proveniente da una famiglia
benestante della classe media di Napoli, Rosi è entrato nel cinema dopo la
guerra come assistente di Luchino Visconti prima di fare il suo cinema
socialmente molto impegnato, evidenziato da film come Le Mani Sulla Città, 1963,
sulla dilagante speculazione edilizia che devastava le città d'Italia durante il
cosiddetto "miracolo economico". Il film inizia con il crollo catastrofico di un
grattacielo e molti morti, le cui inchieste vengono bloccate da macchinazioni
politiche. Il film di Rosi denuncia il crimine. Nella nuova era della
televisione e dei film spazzatura e di attrici nate in una notte, il figlio di
Roberto Rossellini, Renzo Rossellini Jr. ha detto, a riguardo della fine della
storia del cinema della Sinistra in un colloquio con me negli uffici Gaumont
Italia di Roma nei primi anni 1980: “Niente succede come il successo”. Sapeva di
cosa stava parlando perchè, col cambiamento dei tempi, lui e la Gaumont
Productions fecero i loro compromessi, in cambio di un posto privilegiato nel
cinema europeo. Il Neo-realismo nel cinema emerse dalla falsa coscienza, la
sciocca decenza e l'insistenza sulla forma, sulla finzione e sul trionfo così
prevalenti sotto il Fascismo. Emerse dall’esperienza della guerra, dalla paura
patologica di un'altra guerra, e dalla situazione di stallo ideologico tra Est e
Ovest. Per quanto riguarda l'influenza della Guerra Fredda, Eric Rhode nella sua
La Storia del Cinema-Dalle Origini al 1970, scrive: "La sua (la guerra fredda)
influenza immediata fu che il pubblico cercava qualità di calore, sebbene
simulate. La critica elogiava i film italiani neo-realisti per la loro umanità
spontanea e teneva in poco conto la loro dolcezza spesso artificiosa ". La
scarsità di film americani durante la Seconda Guerra Mondiale permise al cinema
tedesco di monopolizzare il mercato europeo e al cinema italiano di crescere
rapidamente. Quando una valanga di film americani arrivò dopo la guerra, era
evidente che Hollywood non aveva progredito di una virgola. Il cinema europeo,
invece, era ricco di idee. Voleva essere ascoltato nel mondo. Anche se
l'industria cinematografica tedesca fu distrutta, la Francia e soprattutto l’
Italia erano pronte. I nomi di Rossellini e De Sica si diffusero in tutto il
mondo. Allora il Neo-realismo esplose sulla scena. Non più i film degli Studio
di Hollywood, ma i film d'autore di decine di registi che avrebbero cambiato il
mondo del cinema per sempre. Voglio fare marcia indietro per un momento per
chiarire il coinvolgimento degli artisti italiani in generale con il Fascismo,
tra i quali Rossellini era una figura in erba. Conformità compiacente e
opportunismo, credo, sia la peggiore critica che si possa attribuire al
Rossellini di quel periodo; aveva già 36 anni quando il Fascismo italiano
crollò. Conformità e l'opportunismo vanno di pari passo. Sotto il Fascismo, lo
stile era molto importante. L'osservazione e il pensiero critico non erano visti
di buon occhio. Se non si accettavano i valori fascisti della famiglia e del
patriottismo, ci si doveva adattare o scappare all'estero, come Moravia e altri
intellettuali fecero. Come regola, i sistemi autoritari contano su artisti
compromessi per produrre false immagini. L'artista che pratica il compromesso
segue i vincitori. Inevitabilmente l'artista compromesso si colloca nel mezzo;
evita di dire ciò che pensa per paura del suo posto nella società. Gli
intellettuali italiani, fin dai tempi dell'unificazione italiana nella metà del
19° secolo, erano in gran parte obbedienti o silenziosi, come lo erano stati
durante il Fascismo. L'annoiata indifferenza del popolo italiano nel suo insieme
- non solo quella dei suoi intellettuali e artisti - facilitò la nascita e la
ventennale sopravvivenza del Fascismo, la stessa indifferenza politica che
contraddistingue la società italiana e americana di oggi di fronte a forme
moderne dell'estremismo reazionario. Non c'è da meravigliarsi se, dopo la
guerra, la generazione liberale d’Europa, specialmente i suoi creativi artisti,
gravitò verso il Comunismo. Nonostante il Ventennio, i venti anni di Fascismo,
il Socialismo era ancora una parte potente della psiche italiana, come lo era
stato dalla fine del 19° secolo. Comunisti e socialisti guidarono la lotta
partigiana anti- fascista e dopo la guerra, la nuova Repubblica Italiana venne
fondata sul lavoro e sull’anti-fascismo. In seguito a confessione tardiva dello
scrittore Premio Nobel Günther Grass diversi anni fa, il quale era entrato nella
Waffen SS nazista a diciassette anni, alla fine del 1944, i critici italiani
cominciarono a cercare di individuare le date precise, nella metà del secolo
scorso, in cui gli intellettuali italiani erano passati dal fascismo al
comunismo. Molti artisti avevano già confessato che una volta erano fascisti, ma
datavano la loro uscita dal regime all’inizio del 1938, principalmente per
prendere le distanze dalle brutali leggi razziali italiane. La verità è che
alcuni di loro avevano continuato a collaborare con il regime fascista fino alla
fine. In ogni caso, nella fase post-bellica della Seconda Guerra Mondiale, una
maggioranza di scrittori europei e registi erano di sinistra. In Italia, la
maggior parte aderì al Partito Comunista Italiano. Il loro cambiamento di colore
politico era una questione molto soggettiva e non voglio invischiarmi qui in
accuse di chi è colpevole di che cosa. La Hollywood dell'era McCarthy e il
sorprendente numero di voltagabbana suggeriscono cosa sarebbe accaduto agli
intellettuali americani - ciò che è già accaduto a molti – di fronte ad un
fascismo americano. Le nuove leggi già in vigore forniscono una vaga idea di
quello che essi avrebbero affrontato. Dietro la devastazione dell’Europa e la
distruzione fisica e morale dell'Italia che derivavano da una combinazione di
Fascismo e sconfitta militare, il neo-realismo arrivò come un mondo visto
attraverso gli occhi dei bambini, gli occhi di un ladro di biciclette o gli
occhi di un operaio indigente. "Anche se il Fascismo di Mussolini era stato
apparentemente distrutto”, Rhode continua, "la sua influenza persisteva ovunque
nell’Italia del dopoguerra. I migliori film neo-realisti tendevano ad includere
molte delle confusioni e delle esitazioni di questa neonata società: le sue
superstizioni, sia pagane che cristiane, le sue aspirazioni vagamente marxiste e
la sua fame di dipendenza (in parte mitigata dal ruolo post-bellico degli Stati
Uniti in Italia). L'entusiasmo suscitato da questi film in tutto il mondo rivela
in che misura essi incarnavano un’ ideologia che andava oltre di interessi
nazionali italiani ". Ma, vorrei aggiungere, che essi offrivano anche una
risposta ambivalente e insoddisfacente all’ autorità, come fece Fellini più
tardi.
Papa Francesco un pontefice
comunista, pauperista, populista?
«Io dico solo che i comunisti ci hanno derubato la bandiera. La bandiera dei
poveri è cristiana. La povertà è al centro del Vangelo». Lo ha detto il
pontefice in un’intervista al Messaggero il 29 giugno 2014. «I poveri -
dice Papa Francesco - sono al centro del Vangelo. Prendiamo Matteo 25, il
protocollo sul quale noi saremo giudicati: ho avuto fame, ho avuto sete, sono
stato in carcere, ero malato, ignudo. Oppure guardiamo le Beatitudini, altra
bandiera. I comunisti dicono che tutto questo è comunista. Sì, come no, venti
secoli dopo. Allora quando parlando si potrebbe dire loro: ma voi siete
cristiani». Il pontefice ha poi parlato della corruzione e ha spiegato che il
corrotto non ha amici, ma solo complici. «Difficile rimanere onesti in politica,
vieni fagocitato da un fenomeno quasi endemico» ha commentato. «E’ l’ambiente
che facilita la corruzione -ha aggiunto -. Non dico che tutti siano corrotti, ma
penso sia difficile rimanere onesti in politica. Parlo dappertutto, non
dell’Italia. Penso anche ad altri casi. A volte ci sono persone che vorrebbero
fare le cose chiare, ma poi si trovano in difficoltà ed è come se venissero
fagocitate da un fenomeno endemico, a più livelli, trasversale. Non perché sia
la natura della politica, ma perché in un cambio d’epoca le spinte verso una
certa deriva morale sono più forti».
C’eravamo tanto amati.
Perché tra sinistra e popolo sembra tutto finito. Non si riconoscono più, è
rimasta solo una reciproca antipatia, scrive
Ritanna Armeni (di sinistra) su “Il Foglio” di Giuliano Ferrara (di
centro- destra).
Diciamo una verità scomoda: il popolo non ama la sinistra.
Anzi, gli sta abbastanza
antipatica. Del resto neppure la sinistra ama così tanto il popolo e i poveri.
Sia chiaro: per poveri non si intendono i mendicanti, i disperati e col termine
di popolo non ci si riferisce agli operai o ai lavoratori sindacalizzati. Quando
parliamo di popolo pensiamo a quella famiglia che all’Autogrill si ingozza di
panini, parla con un tono di voce insopportabile e non risparmia qualche
scappellotto ai bambini. A quei giovinastri che tengono l’autoradio a tutto
volume e se ne sbattono del fracasso che provocano. Alle donne con la busta
della spesa che sgomitano e smoccolano in autobus. A tutti quelli che vanno al
cinema solo a Natale, forse neppure, e non sanno fare alcuna distinzione fra il
gusto dell’aspirina e quello del tartufo.
Ai tanti che bevono il vino meno costoso del supermercato e non lo trovano così
diverso dal Barolo più raffinato.
Che leggono meno di un libro all’anno – o che non leggono affatto – e si fanno
prestare il giornale dal vicino solo per sfogliare le pagine sportive. “Popolo”
sono le donne che tengono la televisione accesa tutto il giorno, le ragazze che
aspirano al top leopardato, i ragazzi che passano la notte con il telefonino
acceso e due birre, la casalinga che strilla al mercato perché l’hanno fregata
sul peso della verdura. Lo incontriamo questo popolo e ci pare cafone,
maleducato, aggressivo, malvestito. Sgomita e strilla, rubacchia allo stato
quando può, non rispetta le file, si arrangia in tutti i modi, anche non sempre
legittimi, e tira avanti. I poveri poi – si sa – spesso non sono buoni e qualche
volta appaiono anche poco intelligenti. Per questo la sinistra non li sopporta e
cerca di dimenticarli. O meglio, li dimentica fino alle elezioni quando si
accorge che “il popolo” non vota più per lei. Che si è rotto qualcosa, e questo
ha ripercussioni anche sui consensi.
La straordinaria affermazione nei sondaggi di Marine Le Pen, leader del Front
national, a spese dei socialisti francesi e nei luoghi dove erano più forti, ha
fatto gridare all’allarme, com’era prevedibile.
Ma è solo l’ultimo caso dei tanti che si sono susseguiti in questi anni di
spostamento, quasi repentino, dei voti. In Italia la sinistra ha cominciato ad
accusare il colpo negli anni Novanta, quando scoprì all’improvviso che gli
operai del nord, addirittura anche quelli iscritti alla Fiom, il sindacato dei
metalmeccanici della Cgil, votavano Lega. C’era da riflettere e molto, ma non mi
pare che in questi venti anni sia stato fatto. E infatti, alle ultime elezioni
politiche, nuovo sbigottimento. Si predicava il cambiamento ma il primo partito
del voto operaio non è stato il Pd, bensì il Movimento cinque stelle, seguito
dal Pdl (primo fra le casalinghe: anche loro popolo, eccome) mentre al Pd è
andato solo il terzo posto.
I voti fuggiti via sono però solo la conseguenza, una delle conseguenze, di
questa reciproca antipatia, ciò che la rende evidente.
E’ difficile pensare di essere rappresentato da chi ti sta antipatico e che – lo
senti – nutre per te un malcelato disprezzo. I motivi, quelli veri e profondi,
sono altri. In un famoso libro del 2004, più volte aggiornato e tradotto in
francese con il titolo “Perché i poveri votano a destra” (in originale “What’s
the Matter with Kansas?”), ne ha parlato l’americano Thomas Frank, analista e
collaboratore del Monde Diplomatique e di Harper’s Magazine. La sua idea è che
negli ultimi decenni il populismo di sinistra rooseveltiano, egualitario, capace
di conquistare gli animi, si è trasformato in un populismo di destra fondato
sulla paura di tanti di perdere anche quei pochi vantaggi che avevano
conquistato e che appaiono insidiati da altri più poveri di loro. Frank fa
un’analisi del fenomeno negli Stati Uniti dove la distinzione e l’antipatia fra
liberal e popolo sembra netta e la spaccatura è chiara come il sole. L’America
da un pezzo è divisa in due, c’è addirittura chi parla di due Americhe: da una
parte quella “normale” detta anche “profonda”, che ama la famiglia, crede nei
valori della tradizione, omaggia la bandiera a stelle e strisce, dipende dalla
tv e dallo junk food; dall’altra ci sono i progressisti, gli intellettuali che
abitano sulla costa e che con i primi non hanno nulla a che fare perché trovano
che hanno gusti volgari, non leggono, non vanno al cinema e non conoscono buoni
ristoranti. Le due parti si riconoscono anche da lontano e si evitano. Thomas
Frank ha scritto il suo libro dopo aver scoperto che nella contea più povera
degli Stati Uniti Bush aveva ricevuto l’ottanta per cento dei voti. “Come si fa
a votare per un repubblicano quando almeno una volta nella vita si è lavorato
per un padrone?”, gli ha chiesto un amico, ovviamente di sinistra. E lo
scrittore, come molti politici, sociologi, osservatori della sinistra europea ha
spiegato il fenomeno a partire dalla “struttura”: la scomparsa delle grandi
fabbriche, la crisi verticale dei sindacati, la fine delle sicurezze che
derivavano dal lavoro. A tutto questo vanno affiancate le nuove proposte di
sicurezza che la destra ha riproposto con nuovo vigore: quelle fondate sulla
tradizione, sulla difesa di valori ampiamente riconosciuti e sulla lotta contro
coloro che vogliono mettere in crisi l’identità che su questi valori si fonda,
che sostengono, per esempio, l’aborto o il matrimonio gay.
Le analisi sulle modifiche della struttura e le conseguenti modifiche sociali
sono sicuramente importanti,
e si potrebbero aggiungere le considerazioni su
quello che ha rappresentato contemporaneamente la fine del comunismo e della
identità fra partiti comunisti e popolo. Ma rispondono solo in parte alla
domanda di fondo sul perché la sinistra è antipatica ai poveri e perché i poveri
la guardano con sospetto e disprezzo. Si può anche perdere la propria base
sociale tradizionale per molti importanti motivi, economici e legati agli
inevitabili cambiamenti della modernità, e si possono perfino perdere voti ed
essere una minoranza. Ma si può rimanere interessanti, stimabili, stimolanti,
attraenti. E invece questo non è accaduto.
Con una differenza fra i due atteggiamenti antipatizzanti, quello del popolo
verso la sinistra e quello reciproco.
Mentre nei poveri l’antipatia provoca distacco e disprezzo, i progressisti per
difendere la loro identità e la loro stessa ragione sociale, pretendono di
aiutarli e di rappresentarli, di fornire loro le basi di una emancipazione
sociale. Devono, quindi, almeno fingere di amarli. E infatti ci provano, ma non
ci riescono. E non solo in un’America che, si sa, ama dividere con qualche
semplificazione e giudicare rozzamente, ma anche nella più raffinata Europa e
persino in quei paesi culturalmente lontani dall’una e dagli altri. Possiamo
dire, insomma, che la sinistra con le sue élite intellettuali e i suoi gruppi
dirigenti in questi anni è riuscita ad apparire veramente antipatica.
Ci è riuscita perché l’immagine che ha costruito di sé, quella con la quale
viene identificata, è ritenuta imbrogliona, bugiarda, ipocrita.
Forse l’immagine non corrisponde del tutto alla realtà, ma su quella realtà
vince. I progressisti – così si pensa – parlano dei poveri ma vivono da ricchi.
Propongono di abolire il privilegio, ma sono privilegiati. Vogliono essere
vicini al popolo, ma non lo conoscono. Nella società occupano la parte “alta”,
che guarda al “basso” ma non vi entra in contatto. In gran parte, insomma,
offrono di sé un’immagine radical chic. Questo termine e questa accusa
riassumono bene i motivi dell’antipatia per la sinistra. Per radical chic – dice
la Treccani – si intende “ironicamente” il “borghese che, per moda o
convenienza, professa tendenze politiche radicali di sinistra, con atteggiamento
fortemente snobistico e contrario al proprio ceto di appartenenza”.
Definizione giusta, ma
non esaustiva, perché su questa figura si possono dire molte altre cose.
Il radical chic finge di
disprezzare il denaro e il modo in cui la maggior parte della gente se lo
procaccia, ma lo guadagna nello stesso modo. E’ convinto della propria
superiorità culturale e morale, è noiosamente ricercato nei gusti e volutamente
provocatorio nelle affermazioni, ha atteggiamenti fintamente modesti. Un tipo
così non può essere simpatico. Ne parlava lo scrittore Tom Wolfe nel famoso
articolo, poi divenuto libro, apparso nel giugno del 1970 sul New York Magazine.
Si intitolava appunto “Radical chic” e parlava della moda dilagante fra gli
intellettuali newyorchesi, ricchi, ricchissimi e importanti, di ospitare nei
loro salotti i rivoluzionari dell’epoca, dalle Pantere Nere ai pacifisti, agli
hippie di tutti i generi, per mostrare in questo modo il proprio anticonformismo
e la propria non adesione al sistema. Wolfe descrive con eccezionale vivacità e
veridicità i salotti, le cene, gli inviti all’insegna di
“Invita-una-Pantera-Nera-al-Cocktail”. Lo scandalo fu grande: mai prima di
allora il progressismo dei ricchi e dei famosi era stato preso in giro con tanta
ferocia. Dal
libro di Wolfe sono passati oltre quarant’anni e il fenomeno, in parte
modificato, si è esteso.
Non ci sono più i rivoluzionari da invitare a cena nelle grandi case della
Milano bene e neppure chi, come Giangiacomo Feltrinelli, prese tutto così sul
serio da morire su un traliccio dell’alta tensione. Oggi altri sono i tratti
distintivi del radicalismo chic, altri i contenuti che convivono con l’agio
sociale e l’osmosi con il potere. Ma suscitano la stessa antipatia e si
identificano, ahimè sempre di più, con la sinistra. I radical chic sono
diventati antipatici a livello planetario. Non sono certo amati in Francia, dove
sono la cosiddetta “gauche caviar”, né in Germania dove, con disprezzo teutonico
vengono definiti “Toskanafraktion” (pare che i progressisti di quelle parti
amino la Toscana). L’Irlanda benevolmente li addita come “smoked salmon
socialist”, mentre in Svezia sono la “rödvinsvänster”, sinistra del vino rosso,
in quel paese raro e raffinato.
L’elenco potrebbe continuare, ma quel che stupisce è l’esistenza di una
definizione per questa sinistra anche in Brasile che ha la sua “esquerda
festiva”, o in Cile dove i
nostri radical chic li additano come “red set”, e addirittura in Grecia. La
quale, fra tutti i guai di cui soffre, può annoverare la sua canonica “aristerà
tu saloniù”, sinistra da salotto. Per amore di giustizia dobbiamo dire a questo
punto che la sinistra non è formata solo da radical chic. E che la destra,
accusando la sinistra, tutta la sinistra, di radicalismo chic, dà spesso
dimostrazione di volgarità e strumentalismo. Per averne un esempio, basta
ricordare il precursore di questo atteggiamento che oggi è stato ereditato da
parte consistente del centrodestra. Negli anni Settanta, Indro Montanelli
scriveva a Camilla Cederna, che allora indagava sulla strage di piazza Fontana,
parole a dir poco volgari, cavalcando l’accusa che poi gran parte della destra
avrebbe rivolto alla sinistra: “Ti sei innamorata – le scrisse – dei bombaroli,
e questo, conoscendo i tuoi rigorosi e severi costumi, posso accettarlo solo se
alla parola ‘amore’ si dia il suo significato cristiano di fratellanza… Fino a
ieri testimone furtiva o relatrice discreta di trame e tresche salottiere,
arbitra di mode, maestra di sfumature, fustigatrice di vizi armata di cipria e
piumino, ora si direbbe che tu abbia sempre parlato il gergo dei comizi e non
sappia più respirare che l’aria del Circo. Ti capisco. Deve essere inebriante,
per una che lo fu della mondanità, ritrovarsi regina della dinamite e sentirsi
investita del suo alto patronato. Che dopo aver tanto frequentato il mondo delle
contesse, tu abbia optato per quello degli anarchici, o meglio abbia cercato di
miscelarli, facendo anche del povero Pinelli un personaggio della café society,
non mi stupisce: gli anarchici perlomeno odorano d’uomo anche se forse un po’
troppo. Sul tuo perbenismo di signorina di buona famiglia, il loro afrore, il
loro linguaggio, le loro maniere, devono sortire effetti afrodisiaci. Una
droga”. Ma
torniamo all’oggi. Non è dell’antipatia della destra nei confronti della
sinistra di cui ci vogliamo occupare,
né della immagine che da Montanelli a Brunetta
(che, ben conoscendo il popolo, pensa di sputtanare in diretta i giornalisti
televisivi che sono di sinistra con l’accusa di guadagnare troppo) si tende a
dare di questa. Ognuno nella battaglia politica usa gli strumenti, anche
intellettuali, che possiede. Quello di cui la sinistra dovrebbe preoccuparsi è
che questa immagine è diffusamente penetrata nel popolo. E la penalizza non
poco. Sono
proprio tutti antipatici? Pare di sì, ma in modo diverso.
La “gauche caviar” francese, per esempio,
ha una sua antipatia che deriva da una laïcité irrispettosa sia del velo che
della croce. Oggi possiamo dire che gli italiani aggiungono due caratteristiche
specifiche: sono piagnoni e manettari. Fra i nostri radical chic lamentarsi va
di moda, anzi è l’ultima moda. Non che motivi di lagnanza in questo disastrato
paese non ce ne siano, ma questi antipatici – proprio loro – non hanno quasi
nessun motivo di compiangersi. In gran parte occupano posti di lavoro di
prestigio, hanno redditi medio alti, sono egemoni nei luoghi della cultura,
continuano a permettersi quelli che oggi sono i veri privilegi, perfino maggiori
del denaro: una vita che può non essere contaminata dalla volgarità, dalla
grossolanità, dallo stress a cui è sottoposta la gente cosiddetta normale, cioè
il popolo e i poveri. I ristoranti dove il cibo è ricercato, il cinema, le buone
letture, le conoscenze interessanti, le scuole d’élite per i figli, le vacanze,
la grande forza che deriva dalla consapevolezza di vivere al centro e non alla
periferia del mondo.
Ma si sa, oggi i poveri stanno male. La crisi li ha colpiti duramente.
E se nell’America degli anni Settanta, per essere di sinistra, si doveva
invitare a cena un rappresentante dei Black Panter, oggi per dimostrare
solidarietà e unità con il popolo ci si lamenta con lui e più di lui. Si
aggiungono lagnanze del tutto ingiustificate a quelle di chi se la passa male
davvero. In questo modo gli “champagne socialist” (questo è il nome inglese) si
mettono a posto la coscienza: nella crisi tutti soffriamo insieme. Ma non è
così. E il popolo non la beve. Se sentissero i commenti ai loro piagnistei ne
uscirebbero tramortiti. Se osservassero bene gli sguardi di coloro a cui
vorrebbero mostrare solidarietà, tacerebbero immediatamente e cambierebbero
strada. Lamentarsi perché è aumentata l’Imu sulle seconde e sulle terze case, o
sono saliti i prezzi dei ristoranti, di fronte a chi non si permette neppure una
pizza suona irrispettoso, oltre che, naturalmente, ipocrita e antipatico.
E poi il “radikal elegance” (definizione norvegese) nostrano è tendenzialmente
“manettaro”, tende a
pensare che tutti i problemi si possano risolvere con un po’ più di severità e
di carcere. Pensa che la moralità possa essere ristabilita con atti forti di
distinzione, alzando alte le bandiere del giusto, del legittimo, impugnando la
lotta per le regole con veemenza attraverso la continua affermazione delle
manette. Il carcere per i nostri radical chic è una panacea che può curare tutti
i mali, compresi quelli che derivano da culture radicate e purtroppo assai dure
da estirpare. Anche questo è un tentativo goffo e disperato di riconquistare un
rapporto col popolo. Si pensa che questa sia la via più facile: i poveri, si sa,
sono rozzi e anche esasperati, quindi non possono non seguire chi propone
punizioni esemplari, chi addita colpevoli sicuri, chi si mostra deciso nella
condanna della pubblica immoralità. Naturalmente anche questa è un’illusione.
Forse il popolo segue, forse si mostra veemente e arrabbiato, ma continua a non
amarli. Perché non c’è nulla di peggio ai suoi occhi dei moralisti e dei
paladini della legge che poi sono i primi a preferire le vie del compromesso,
della raccomandazione, del sotterfugio.
In questi anni, in quanti scandali si sono trovati politici della sinistra?
In quante cronache di carriere universitarie abbiamo letto di moglie e figli di
baroni rossi che hanno fatto carriera? Il popolo evidentemente – è desolante ma
è così – preferisce i malfattori sinceri, i ricchi che ostentano la loro
ricchezza, gli evasori di grandi fortune che li fanno sentire meno colpevoli
della loro piccola evasione, gli imbroglioni dichiarati. Ma se è così quando e
con quali gesti la sinistra si porrà il problema di spezzare una sua immagine
tanto radicalmente odiata?
I registi italiani? "Tutti
comunisti", ma con "case dappertutto".
A dirlo è Gérard Depardieu in un'intervista a Valerio Cappelli su “Il Corriere
della Sera”. L’attore ha preso la cittadinanza russa, per qualcuno lo ha fatto
per non pagare le tasse esose in Francia. «Non sono andato a Mosca per evadere
le tasse ma perché Putin mi ha dato un passaporto e perché mi piace la
letteratura russa - racconta ora - Non è una questione di soldi, io vengo dalla
terra, sono nato povero, sai che me ne frega dei soldi. Amo più di tutto
l'Italia (dove si mangia bene ovunque e non c'è bisogno di andare nei grandi
ristoranti, bastano le trattorie), e la Russia, dove non conosco nessuno,
specialmente i giornalisti. In Francia dicono che Putin è un dittatore. Io dico
che cerca solo di fare il meglio per il suo Paese. Intanto in Francia hanno
ucciso i piccoli agricoltori, quanto alla cultura ad Avignone protestano... Non
ci sono più festival in Francia, solo bagarre. Bisogna viverci in un Paese prima
di criticarlo, hanno sbagliato indirizzo, che andassero nella Corea del Nord». E
a Ettore Scola, che accusa Depardieu di evasione fiscale, replica: «Abbiamo un
progetto per un film, una bellissima storia di cui non voglio parlare. Prima
Scola non voleva farlo perché lo produceva Berlusconi e ora non so. Non credo
che troveranno i soldi. Amo Ettore Scola anche se mi ha criticato. Io non sono
né di sinistra né di destra, glielo dissi tanto tempo fa a Bertolucci, voi
registi italiani siete tutti comunisti, però avete case dappertutto. Mi rispose
che in Russia è pieno di Mercedes. Io sono un essere vivente, mi piace la vita.
Sono un cittadino del mondo, in Russia sono un viaggiatore e basta».
Il commento di Ginevra Sorrentino su “Il Secolo
D’Italia”. Cosa lega Gérard Depardieu a Carlo Verdone? Oltre al fatto di essere
due attori capaci di utilizzare sia le corde comiche che quelle drammatiche, il
filo di una polemica sempre aperta con la critica integralista. E allora, se
«meglio rosso che Verdone» era lo slogan in voga qualche anno fa, all’epoca
della diatriba tra il regista e attore romano e l’intellighenzia di sinistra,
austera e radical kitsch, oggi l’asse polemico viene spostato dall’istrione
francese proprio sui cineasti di casa nostra che, in un’intervista al
Corriere della sera,
senza troppi giri di parole etichetta così: «I registi italiani? Tutti comunisti
con case ovunque». Sempre pronti, aggiungiamo noi, autori e critici
fondamentalisti militanti, a incentivare con manifesti ideologici e proclami
mediatici esterofilia cinefila e produzioni drammatiche, e, parallelamente, ben
disposti a storcere accademicamente il naso contro la commedia, dai tempi del
neorealismo bollata severamente come genere di serie B. Con buona pace degli
incassi milionari di Checco Zalone e Christian De Sica, veri “re Mida” di
celluloide grazie ai quali – in barba ad austeri dibattiti estetici e forum sul
rigore formale – il cinema può tornare a godere di nuova linfa economica e
spettacolare. Dunque oggi la differenza per il successo la fanno lo spettatore e
i risultati al botteghino: e a quella nutrita schiera di sceneggiatori, registi
e attori – ma anche cantautori e istrioni da palcoscenico – che si sono nei
decenni cullati sugli allori dell’incoronazione mediatica e della continuità
professionale grazie all’arruolamento ideologico nelle fila della sinistra
militante e sponsorizzante, non resta che farsene una ragione. Un’egemonia
culturale e spettacolare, quella democrat, che ha avocato a sé talenti della
settima arte, della canzone d’autore e della letteratura, a cui il brand
progressista ha garantito sempre partecipazioni ai festival del cinema che
contano, agli agoni editoriali più in voga, ai palcoscenici discografici più
blasonati. Oggi, invece, il trend si inverte: e mentre una firma del grande
schermo come Ettore Scola, rivela Depardieu dalle colonne del quotidiano di via
Solferino, avrebbe un progetto nel cassetto – («una bellissima storia di cui non
voglio parlare. Prima Scola – prosegue l’attore – non voleva farlo perché lo
produceva Berlusconi, e ora non so. Non credo che troveranno i soldi») – autori
non schierati a sinistra lavorano. Incassano. Vengono promossi a suon di record
dalle platee e, gioco forza, in qualche modo anche rivalutati dalla critica
costretta a rileggere morfemi e grafemi della sua grammatica giudicante. Chissà,
allora, come sarebbe stata la parabola del successo di attori come Lando
Buzzanca o come Lino Banfi – oggi nobilitati dalla tv e riaccreditati da un
tardivo revisionismo critico – se negli anni Settanta, invece di pagare a suon
di commediole scollacciate e di stroncature lo scotto di una mancata adesione
culturale e politica a sinistra, avessero potuto vedere capacità e fortuna
decretate semplicemente dal pubblico in sala… Ai posteri l’ardua sentenza.
Luca Barbareschi intervistato
al telefono da Gabriele Lazzaro a “Anche io ero off” e pubblicato su “Il
Giornale”: «Sono solo contro una casta di idioti raccomandati».
Luca, mi racconti un
episodio OFF degli inizi della tua carriera?
«Ce
ne sono tanti… quest’anno compio quarant’anni di carriera…»
Uno che però non hai mai
raccontato a nessuno?
«Il
mio vero primo ruolo nell’Enrico V – poi dopo ho lavorato solo in ruoli più
importanti – era suonare il tamburo nascosto in quinta, cioè, fare le rullate
mentre Gabriele Lavia faceva i monologhi. Chiuso in una scatola di legno, a
Verona, a luglio, con un caldo infernale, suonavo questa grancassa per circa
un’ora e mezza pensando di suonare la batteria. Questo è stato il mio debutto
teatrale, a diciotto anni.»
Come si vive a diciotto
anni un’esperienza del genere?
«Mah,
io ero felice! mi sembrava di toccare il cielo con un dito! Era una compagnia
meravigliosa, c’era il Garrani, Lavia… Meschieri e Fo erano i produttori…
Ciò che mi fa tristezza oggi è vedere ragazzi di 18 anni che sono già vecchi.
Sanno già tutto, hanno già capito tutto, sono già depressi. E’ tutto politico…
invece ai miei inizi era poesia pura, arte pura: il teatro, di sera, nella
Piazzetta delle Erbe… Suonavo bene la chitarra e il piano: ero un musicista, più
che altro, per cui intrattenevo gli altri, cercavo gli spazi cercando di fare
simpatia e di fare il mio lavoro: l’entertainer. Ma questo ha messo in moto il
mio futuro: il regista mi aveva preso all’inizio come uno che doveva fare il
caffè, poi sono diventato il suo primo aiuto – lui era il numero due insieme
a Strehler al Piccolo – e due mesi dopo ero a Chicago a fare il primo aiuto
all’Opera Lirica. Le opportunità, se le vivi con entusiasmo, sono bellissime.
Anche perché poi, questo lo vedo adesso, a quasi sessant’anni vuoi circondarti
di persone piene di entusiasmo, di voglia di fare, e di bellezza. No?»
Certo. E quindi questo
stupore è un po’ quello che ti ha accompagnato in questi quarant’anni di
carriera…
«E’
ancora così per me. Se vieni a vedere il mio one man show a Spoleto a giugno,
piangerai e riderai. Ci sono io con una band di cinque elementi, uno è Marco
Zurzolo, un jazzista che ha aperto Umbria Jazz, tra i più bravi musicisti
italiani; io mi diverto con in scena le mie Stratocaster, le Martin, un
pianoforte a coda Steinway, cinque elementi d’orchestra… facciamo di tutto, per
due ore e un quarto. Come se avessi quindici anni.»
Il tuo one man show,
“Cercando segnali d’amore nell’universo”, per la regia di Chiara Noschese lo
vedrò al Teatro Manzoni, perché verrai anche qui a Milano… ti aspettiamo! Nella
tua carriera hai fatto veramente di tutto: teatro, cinema, hai condotto
programmi di successo: alcuni me li ricordo anche molto bene…
«“Il
grande bluff”…»
Come no! E “C’eravamo tanto
amati”. Ma questo tuo essere così tanto eclettico e così professionale in
qualche modo lo devi all’esperienza americana?
«Infatti
io sto sulle palle a tutti i vari Virzì e Servillo… questa gente qui mi odia,
perché loro sono degli snob tremendi… quindi, fanno finta di essere intimisti,
profondi, ma è tutta gente che vive in una casta. Io ho imparato a vivere in
America che qualsiasi cosa fai ti arricchisce: facevo l’aiuto regista, facevo i
servizi per Gerry Minà sulla storia della boxe e contemporaneamente vincevo a
Venezia con il mio film “Summertime”. Poi non c’avevo più una lira di nuovo e
facevo l’aiuto regista per Mario Merola in “Da Corleone a Brooklyn”… In questo
modo mi sono costruito un curriculum che credo non abbia nessuno. Ho una
bellissima azienda, oggi, che ha prodotto più di centotrenta film, ho quotato in
borsa la mia azienda di informatica… e l’ho fatto per curiosità. Quando vedo i
ragazzi demotivati… Io adesso sto facendo un film sulla vita di Pietro Mennea,
per esempio, è la cosa più bella è che lui è stato il più grande campione del
mondo come velocista e poi si è preso tre lauree, si è candidato parlamentare
europeo, è ricordato come uno degli uomini più importanti del Parlamento
Europeo… Perché tutto dipende da noi, alla fine. Da quanto tu credi che la vita
ti possa dare e da quanto sei aperto.»
Proprio parlando di tutte
queste trasformazioni che possono far parte del percorso di una persona, nel
2002 hai diretto “Il trasformista”, che è un film molto arrabbiato verso il
cattivo uso della politica…
«I
miei film verranno apprezzati tra vent’anni. Perché in quel film ho detto tutto
quello che sarebbe successo dieci anni dopo, ma quando l’ho fatto io… poi,
quando l’hanno dato in televisione è andato bene, ma in sala… mi ricordo che
quando ho fatto il primo film, Ardena, tutti i vari ortodossi della sinistra
hanno fatto un picchetto per impedire al Barberini di andare a vedere il film
del fascista Barbareschi. Che imbecillità… il povero Morando Morandini ha anche
scritto da qualche parte: “Barbareschi ha osato fare un film falcata, tempio
degli intellettuali come Amanda Sandrelli”… delle cazzate così neanche uno
sceneggiatore se le può inventare. Adesso l’ha rifatto con “Something good”,
questo film sulle frodi alimentari, l’han tolto dopo un giorno dalle sale! Tu
pensa a Milano Expo il tema è la sicurezza alimentare, ed il mio film che è
venduto in tutto il mondo, girato in Cina sul tema alimentare, niente. Non è
interessante!»
È pazzesco, perché tra
l’altro è stato anche apprezzatissimo da Spielberg…
«Ti
mando le foto: alla prima al festival di Los Angeles, c’erano ad applaudire
Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Hanks, Bono degli U2 con il suo chitarrista The
Edge… c’era tutta Hollywood ma in Italia non se ne è parlato per niente. Basta
vedere i David di Donatello: la più grande porcata fatta in televisione negli
ultimi vent’anni. Dove un’idiota come Ruffini si permette di insultare Sophia
Loren dicendole “bella topa”… Qui c’è una casta di idioti raccomandati, protetti
dalla politica, protetti dalla casta autocelebrativa, che ha ucciso lo
spettacolo italiano. Ci sono anche quelli veri, oggi, nello spettacolo, c’è
gente che fa un patto col pubblico: Brignano fa 130 mila euro a sera. Cioè,
gente vera… Proietti, io, che faccio teatro da quarant’anni,Branciaroli… Poi
però c’è una casta autocelebrata che può anche fare un peto al cinema o in
teatro. Ed è sempre Chanel.»
Una Casta che lavora
moltissimo…
«Io
il David di Donatello non lo vincerò neanche se faccio Ben Hur… io non son stato
neanche invitato.»
Perché Ruffini alla
conduzione? È sempre stato molto istituzionale…
«Perché
non hanno capito che chi deve celebrare la messa non può far le pernacchie. Il
master of ceremony deve essere istituzionale. O sennò è un genio come Billy
Crystal, quando ha presentato una volta gli Academy Awards, che però non si è
permesso di insultare Jack Nicholson. Anche perché Jack Nicholson gli staccava
la testa in diretta… Invece i premi italiani sono finti. I David sono finti, i
Leoni sono finti. Io ho ricevuto una lettera di Alberto Barbera, il direttore
della Mostra del cinema di Venezia, quest’estate … non mi hanno preso perché
non faccio parte della schiera dei suoi amici.»
È una cosa forte, questa…
«Ma
mi ha scritto su carta da bollo protocollata! Allora, siccome sono cretini,
fanno marchette autocelebrativa che infatti hanno ucciso il cinema. Lo
scollamento dell’autocelebrazione critica della casta è totale. Checco Zalone
può piacere o non piacere – a me personalmente piace – e quest’anno ha fatto
settanta milioni. Ma non può non aver vinto un premio! È bravissimo e
spiritosissimo e non puoi non tener conto di quello che esiste, no? Ma ho detto
una vecchia cosa. Tornatore ha fatto un film bellissimo quest’anno e in
televisione l’avrebbero ucciso.»
Tornando a bomba sulla
politica di cui tu hai parlato ne “Il trasformista”, quindi sei stato un po’
profetico… com’è cambiata la politica del 2002 rispetto a quella di oggi? I
politici sono gli stessi…
«La
politica di una volta – ti faccio un’immagine molto semplice – da cinquant’anni
in America ci sono due simboli: l’asinello e l’elefantino. Uno sono i
repubblicani e l’altro i democratici. Dentro quei due piccoli simboli per
cinquant’anni cambiano le facce. In Italia succede l’opposto: le facce son le
stesse, cambiano i simboli. Ulivo, melo… il nome: PD, PDC MDC, CFC…Questa
secondo me è l’immagine di un paese morto. A parte che è morto perché in mano a
mafia, ’ndrangheta e camorra. Al di là della corruzione dei politici, che fanno
schifo, al di là di queste facciate delle Iene da cui mi son preso delle
querele, io le leggi le ho fatte. Tu vai a vedere la legge sulla tax credit, è
mia. Pensi che qualcuno mi abbia ringraziato?»
Penso proprio di no.
«Infatti,
nessuno. La legge sulla pedofilia, l’ho fatta io. Poi l’altro giorno ho fatto un
tweet di sfogo, stupido, da ragazzino, che dimostra la mia età dell’anima…
dicevo che qualsiasi cosa io faccia – perché l’altro giorno c’è stato un
processo in cui ero parte lesa, perché dopo otto anni hanno finalmente
condannato una pazza…»
La skipper?
«La
skipper, sì. Sai cos’ha scritto Repubblica? “Barbareschi dal suo panfilo caccia
una povera lavoratrice del mare”. Capisci che, visto così, la mia responsabilità
va a quel paese. Io, anche se faccio Arancia Meccanica moltiplicato per Otto e
mezzo di Fellini, devo firmarlo con un nome diverso. Perché sono scomodo, perché
voglio essere indipendente, non me ne frega più un cazzo di nessuno di questi
servi che hanno scritto sulla stampa le cose peggiori, anzi non hanno scritto…
La vera tangentopoli dei giornalisti dev’essere ancora scritta!»
Ti fa onore l’aver
trasformato il tuo percorso artistico, la tua fortuna, tutto quello che fa parte
del tuo impero, in forza lavoro, perché hai aperto una società di produzione…
«È
questo, il mio “Summertime”, che ha vinto a Venezia quando non c’erano ancora
questi mentecatti servi dei politici.»
In un certo senso sei un
esempio per i giovani…
«Voi
però dovete ribellarvi! Dovete mandarli a fanculo. Sai perché odio quelli del
Valle? Non perché l’hanno occupato, perché l’occuperei anch’io, ma perché non
hanno fatto un cazzo dentro il Valle. È questa la tragedia: Peter Brook alla
Gare du Nord dentro un garage ha rivoluzionato il teatro mondiale! Noi, nel
nostro piccolo, all’Elfo di Milano… “Sogno di una notte d’estate” fatto
trent’anni fa, è stato in cartellone un anno, ed eravamo degli illustri
sconosciuti! Io, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Maddalena Crippa, Irene Capitani…
oggi siamo tutti conosciuti, ma allora eravamo sconosciuti. Eravamo in un
garage, non è che fossimo al Piccolo. Un anno in cartellone, ottocento persone a
sera. Contro il Piccolo di Strehler, che stava morendo. Non abbiamo mica avuto
bisogno di occupare il Teatro Lirico… Però c’era talento. Eravamo tutti giovani
pieni di talento che hanno fatto delle cose. Qui invece occupano i teatri e non
hanno idee… e questo è il risultato.»
Hai citato il Teatro Valle…
noi abbiamo lanciato anche una petizione…
«Sai
chi sono i peggiori, in malafede? Sono Gifuni, il figlio di Gifuni, il
funzionario di stato. Quell’altro, come si chiama? Che è anche un bravissimo
attore, ricciolino, rosso…»
Elio Germano?
«Elio
Germano. Tutti froci col culo degli altri! Vanno al Valle, fanno i combattenti,
però col cazzo che si fanno arrestare. Hanno distrutto la società di raccolta
per gli attori, questo per colpa anche di un senatore idiota del Pdl… tutti
quelli di adesso hanno distrutto la Repubblica. Perché non appena arriva uno di
sinistra si calano le braghe per essere accettati. Di società di raccolta ce ne
erano tre, adesso più niente.»
Noi fra l’altro siamo
contenti di averti fra le firme di quelli che hanno aderito a questa petizione
per liberare il Teatro Valle perché l’iniziativa che ha lanciato Edoardo Sylos
Labini dalle nostre pagine secondo me è fondamentale…
«È
encomiabile, ha fatto bene. Infatti ho aderito subito, io ci sono anche andato a
litigare da solo.»
Ma sai che non è facile…
«Io
ho chiesto di farmi entrare perché volevo parlare. Ma ormai non c’è più nessuno,
cinquanta precari, gente che non ha mai fatto un provino in vita sua, non c’è
gente dello spettacolo lì.»
Ma ti hanno ascoltato,
quando sei andato a bussare alla loro porta?
«Ma
chi? Non sono attori! Qui c’è il malinteso: gli occupanti del Valle non sono
attori. Non sono registi, non sono scenografi… sono dei precari, c’è gente di
cinquant’anni. Ma sai chi è l’altro deficiente, lì? Ronconi è andato al Valle a
dire “sono con voi”. Ronconi! Ronconi ha devastato il teatro italiano: al
Piccolo non lavora un giovane da vent’anni. Capisci com’è facile il trucco?
Quando c’erano le manifestazioni a Milano, c’era gente che scendeva dalle Rolls
Royce col maggiordomo, che diceva: “Vi passo a prendere dopo, che la mamma vi
manda tutti a Saint Moritz?”, questo era il movimento studentesco a Milano.
Nessuno racconterà mai la verità su questo. I movimenti veri erano Lotta
Comunista, Lotta Continua a Torino. Gli operai, non i fighetti di Milano!»
Però, Luca, non è semplice…
«Posso
dirti? Il signore del Giornale vostro, il signor Sallusti, quando c’è da fare
una battaglia con quelli come me non la fa. Diteglielo pure. Io non sono mica la
Santanché.»
Glielo stai dicendo tu,
perché sarai ascoltato…
«Glielo
dico, glielo dico. Perché son spariti tutti, invece di far coesione fra i
cervelli migliori, vanno a Cannes, si fanno vedere alla Festa dei Ciak…c’è
Servillo a braccetto con Verdone e la Santanché…. Qui è una questione di
competenze, di mettere il meglio, fare scuole di eccellenza, però bisogna
capirle, le cose. Io son contento che ci sia Edoardo, perché ha tanta competenza
e tanta voglia di fare. Io le ho fatte le mie battaglie, da onorevole, per
cinque anni. Litigai con lo stesso Berlusconi con cui ai tempi non ero
d’accordo.»
Ecco, il bello della
battaglia di Edoardo è proprio che è bipartisan, a nome della cultura libera e
al di là del colore politico.
«Ma
non vi caga nessuno. Guarda, io sto a testa alta, perché nelle mie produzioni,
tu le avrai viste, da Olivetti a Walter Chiari, lavorano solo professionisti.
Mai raccomandati. Tu vedrai da Paolo Graziosi a Rocco Papaleo. Però se faccio la
prima di “Something Good” gli attori che ho fatto lavorare credi che
siano venuti? No, perché hanno paura che se vai a una prima di Barbareschi
magari non ti chiama Nanni Moretti. A me di Nanni Moretti non me ne frega un
cazzo, ma neanche a nessuno di questi. Io lavorerei domani con Moretti, se ha
voglia, alla pari però.»
Torniamo alla tua carriera:
tu teatralmente hai sempre fatto delle scelte originali. Hai portato sulla scena
italiana autori come Mamet, Polanski… oggi, secondo te, di quali testi avremmo
ancora bisogno teatralmente?
«Banalmente
di copiare quello che hanno fatto all’estero. Se tu vai a vedere, il teatro è
contemporaneo: solo qui è un’eccezione. Il teatro racconta quello che accade in
questo momento, non quello che accadeva. Poi, i grandi teatri stabili dovrebbero
star fermi e non itinerare. Ma i teatri non me li danno mai, l’unico teatro che
ho diretto per due anni è stato l’Eliseo e hanno tentato di cacciarmi subito,
perché io mi opponevo a questa consorteria degli scambi, di comprare a scatola
chiusa uno spettacolo.»
«Ma infatti la tua
direzione artistica si è conclusa poco dopo…
«Perché
ho detto che avrei fatto una compagnia fissa a Roma, con otto novità all’anno e
fine. Risparmiavo sulle spese per i trasporti e diventava un teatro innovativo.»
Quindi copiamo dall’estero.
Importiamo novità dall’estero…
«Ma
li vedi questi qua del Piccolo? Che non sanno neanche la differenza tra
sceneggiatura, scenografia e coreografia? Gente attaccata alla sedia, al potere,
fanno gli scambi, prendono chi è utile, che è figlio di questo o di quello…»
SI CENSURA, MA NON SI DICE.
Non fu la resistenza a
liberare l'Italia ma solo gli alleati. Gli elementi dominanti della Resistenza,
quelli comunisti, lottavano per l'Unione sovietica. Ecco perché Churchill voleva
puntare non sulla Francia, ma sull'Italia, scrive
Nicholas Farrell su “Il Giornale”. Quando guardo in streaming le facce
nobili dei vecchi uomini inglesi e americani e del Commonwealth che hanno
partecipato all'invasione della Francia nel 1944 e che ora sono tornati alle
spiagge della Normandia per commemorare il 70° anniversario del «Longest Day», e
poi, quando ascolto le loro parole piango - sorridendo. Sono da onorare perché
sono uomini in perfetta sintonia con la regola antica della vita, cioè: per
meritare l'onore, un uomo deve dimostrare prima l'umiltà e poi la virtù. E loro,
questi uomini che ormai hanno compiuto i 90 anni - e tutti i loro compagni
caduti in nome della libertà - ce l'hanno fatta. Poi, però, penso alla
liberazione di Roma dagli stessi anglo-americani, accaduta due giorni prima del
D-Day - il 4 giugno 1944 - e mi incazzo. Per parecchi motivi. In anzitutto, mi
incazzo perché sono inglese ma in Italia si commemora la liberazione d'Italia
ogni 25 aprile come se fosse un lavoro compiuto da partigiani e basta. E mi
sento offeso che a Forlì in Romagna dove abito la strada che porta ad uno dei
due cimiteri degli alleati nella città si chiama Via dei Partigiani. E mi sento
offeso che quando si parla di alleati in discorsi o sui giornali, si fa
riferimento solo agli «americani». In quei due cimiteri di Forlì giacciono i
resti mortali di 1.234 soldati dell'Ottava Armata Britannica. Così tanti morti,
solo a Forlì. Ma vi rendete conto? Non è ora - dopo 70 anni - di affrontare una
semplice verità? Eccola: la Resistenza in Italia era completamente irrilevante
dal punto di vista militare. In ogni caso, nell'estate del 1944 non esisteva una
Resistenza in Italia. Dopo, invece - dall'autunno del 1944 in poi - che cosa di
concreto ha portato questa Resistenza? Peggio. Secondo la storiografia la
Resistenza lottava per la patria, la libertà e la democrazia. Non è vero. I suoi
elementi comunisti (quelli dominanti) lottavano per l'Unione sovietica, la
dittatura e il comunismo. Ecco perché Churchill voleva puntare non sulla
Francia, ma sull'Italia. Voleva a tutti costi fermare le forze comuniste nei
Balcani e in Austria. Roosevelt no, invece, e ha prevalso il Presidente
americano. Perciò, gli alleati, che avevano invaso l'Italia nel 1943, non ebbero
le forze necessarie in Italia per liberarla fino all'aprile 1945. Si dice: solo
grazie alla Ue ci sono stati 70 anni di pace in Europa. Non è vero. C'è stata
pace in Europa solo grazie agli anglo-americani e al piano Marshall. Oggi, la Ue
e la sua moneta unica rappresentano la più grave minaccia alla pace in Europa.
Di questo oscurantismo la tv di Stato ne è molto
responsabile, ma guai a toccarla. Santoro confessa: "Sono un vecchio comunista",
scrive “Libero quotidiano”. Il teletribuno: "Giusto lo sciopero in Rai, ma la tv
pubblica è vecchia e tre tg sono troppi". Lo sciopero Rai? Se lui lavorasse
ancora nella tv pubblica vi aderirebbe, "perchè sono un vecchio comunista e se
il mio sindacato me lo chiede io non faccio il crumiro". Esordisce così,
Michele Santoro,
nell'intervista concessa oggi a Repubblica e nella quale affronta lo spinoso
tema della televisione pubblica, alle prese col taglio da 150 milioni imposto da
Renzi. una mossa che il teletribuno applaude nei fini ma non nei contenuti:
"Tagliare di botto 150 milioni significa imporre tagli lineari, costringere
l'azienda a ridimensionare il prodotto. Ma Renzi, che ha nell'intuito la sua più
grande dote, ha capito che la Rai è l'ultima sopravvissuta del vecchio sistema
politico e i tagli sono un modo per destabilizzare tutto. Nel senso che Grillo
si è messo a difendere lo sciopero passando così come l'alfiere del passato, col
"vecchio" Pd e Forza Italia che hanno fatto alleanza mentre lui li osserva
dall'altra parte. Un capolavoro politico". Santoro ricorda i suoi esordi in
viale Mazzini nel lontano 1987, "quando ero la voce della piazza mentre ora
rischio anch'io di passare per istituzionale perchè la tv generalista, non solo
la Rai, è in crisi profonda per una mancanza di reale concorrenza tra i due
grandi poli che ha abbattuto la qualità di ciò che viene trasmesso. Basti
guardare le fiction: parlano di preti, di carabinieri, di buoni sentimenti. Non
c'è il futuro, non c'è modernità, capacità di innovare". Poi c'è la questione
della "lottizzazione" e dei tre tg nazionali: "Un sistema vecchio, figlio di
quando c'erano le grandi ideologie a contendersi il Paese. Ma oggi non c'è una
domanda di pubblico che giustifiche tre grandi redazioni". Con un occhio al suo
futuro professionale, con voci che ogni anno lo vedono verso un rientro in Rai,
Santoro definisce invece demagogia chiedere che le star del piccolo schermo, da
Vespa a Floris a Fazio si taglino lo stipendio: "Se non hai Maradona, lo stadio
non lo riempi, così senza Celentano non fai audience". E il futuro di viale
Mazzini? "un canale finanziato col canone che faccia tutto quello che il mercato
non fa: niente reality, grande informazione, innovazione. E due canali aperti ai
privati".
Quando Santoro e De Gregorio erano colleghi al
quotidiano comunista. Dopo la parentesi in un gruppo maoista, il teletribuno
lavorò a "La Voce della Campania". E tra i collaboratori c'era il nuovo idolo
della sinistra, scrive “Libero Quotidiano”. Dopo
Massimo Ciancimino,
la sinistra manettara, santoriana e travaglina ha un nuovo totem:
Sergio De Gregorio.
L'ex senatore dell'Idv è il testimone chiave dell'inchiesta napoletana sulla
compravendita di onorevoli, per le toghe orchestrata da
Silvio Berlusconi,
che tra il 2007 e il 2008 avrebbe fatto cadere il governo Prodi. Roba tosta,
insomma, roba in grado di trasformare De Gregorio in superstar della prima
puntata della nuova stagione di
Servizio Pubblico,
la trasmissione di Michele Santoro a cui partecipa
Marco Travaglio
e dalle cui labbra pende tutta la sinistra manettara. Il terzetto si ricompone,
insomma, e con De Gregorio si trasforma in quartetto. In questo quartetto, però,
c'è un legame che affonda le sue radici più in là nel tempo. E' quello tra il
teletribuno Michele e l'ex "traditore" De Gregorio, fino a qualche mese fa
liquidato nel migliore dei casi come "maneggione" e oggi, invece, asso nella
manica nella guerra contro il Cavaliere. Già, perché i due sono ex colleghi.
Entrambi
campani - Santoro classe
1951, De Gregorio 1960 -, il primo giornalista e il secondo, invece, ex
giornalista, avevano iniziato le loro attività da cronisti nel
quotidiano comunista
La voce
della Campania tra la fine
degli anni '70 e gli inizi degli anni '80. Una conoscenza, la loro, nata tra le
scrivanie della redazione di un quotidiano comunista: nessuna sorpresa per
Santoro, un po' di stupore in più, invece, per De Gregorio (ex socialista ed ex
valorista). Che Santoro abbia lavorato a
La Voce della Campania
non è certo un mistero: la sua
parentesi al quotidiano rosso iniziò dopo quella con il periodico
Servire il popolo,
edito dal gruppo maoista Unione Comunisti Italiani in cui militò fino alla sua
chiusura, nel 1975. De Gregorio collaborò con
La voce della Campania
proprio nella seconda metà degli anni
'70: negli anni successivi, dopo l'ingresso in politica,
promosse il ritorno in edicola
della testata. Il nuovo
idolo della sinistra, insomma, il senatore De Gregorio (lo stesso che, ha
denunciato
Maurizio Belpietro, "mi
propose di pagare la Camorra"), consosceva Santoro da anni, dai tempi della
militanza comunista. Una carriera iniziata insieme, quella di Michele e Sergio,
che a distanza di quasi 40 anni si sono ritrovati sul piccolo schermo, a La7,
per spalare fango contro Berlusconi.
La Rai
"censura" il giornalista e le sue scomode verità sulla Sardegna.
La Rai intervista Anthony W. Muroni (direttore dell'Unione Sarda) e dopo decide
per la "censura", non mandando in onda il suo intervento. Poi la retromarcia:
ecco la denuncia. Prima l'hanno chiamato per un'intervista sulla
tragedia della Sardegna
e poi gli hanno riferito che non sarebbe mai andata in onda, con un commento
secco: "Meglio non parlare di queste cose". E lui,
Anthony W. Muroni, direttore
dell'Unione Sarda,
ha denunciato la "censura" della Rai sulla sua pagina Facebook. Nell'intervento
registrato per il Tg2, riferisce lo stesso Muroni, il giornalista aveva invitato
ad interrogarsi sul "perché i ponti crollano, sul perché i cantieri per la messa
in sicurezza dei fiumi si bloccano per anni a causa di contenziosi tra Comuni e
imprese appaltatrici". Ecco la sua denuncia su Facebook: Mezz'ora fa ho
registrato un intervento per il Tg2, nel quale ripetevo i concetti già espressi
a Uno Mattina: serve solidarietà, servono interventi, servono aiuti, serve
combattere l'emergenza, Ma serve anche interrogarsi sul perché i ponti crollano,
sul perché i cantieri per la messa in sicurezza dei fiumi si bloccano per anni a
causa di contenziosi tra Comuni e imprese appaltatrici. Ho detto anche: va bene
la solidarietà del governo e gli stanziamenti, ma forse dovrebbero rendersi
conto che c'è un intero sistema che non funziona. E che in Sardegna, dieci anni
dopo Capoterra, stiamo ancora parlando delle stesse cose. Mi ha appena chiamato
una collega della Rai: l'intervista non verrà mandata in onda: "Meglio non
parlare di queste cose". Tanti saluti.
Poi è arrivata la retromarcia, dopo che la notizia aveva fatto il giro dei
social network.
Come scrive su Twitter lo stesso Muroni, l'intervista, dopo un equivoco, andrà
in onda questa sera: "Mi ha chiamato Rocco Tolfa, vicedirettore Tg2: c'è stato
equivoco. Intervista in onda alle 20.30".
Censura
in Italia.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. L'Italia è ad uno dei livelli più bassi per
quanto concerne la libertà di stampa in Europa. Un'analisi effettuata da Freedom
House classifica l'Italia come "parzialmente libera", uno dei soli due paesi
dell'Europa Occidentale (il secondo è la Turchia), relegandola dietro anche a
diversi paesi comunisti dell'Europa Orientale. A livello mondiale, Reporter
Senza Frontiere classifica l'Italia al 57º posto per la libertà di stampa. La
censura viene applicata tanto sulla televisione quanto sugli altri mezzi di
informazione e di stampa.
Storia della censura in Italia.
Nel periodo che segue il
Congresso di Vienna (1814-1815), in territorio italiano era in atto un incisivo
controllo sulla stampa da parte delle monarchie. Nelle capitali dei vari
staterelli, e nei centri urbani più importanti, in genere usciva solo un foglio
ufficiale della monarchia, generalmente intitolato Gazzetta, che serviva
per la pubblicazione delle leggi e di una cronaca attentamente selezionata.
Oltre a questi tuttavia erano presenti dei periodici letterari e culturali, dove
potevano essere espresse nuove idee. Nel 1816, su iniziativa degli austriaci, a
Milano fu fondato un mensile letterario intitolato Biblioteca Italiana,
in cui vengono invitati a collaborare (non sempre con successo) oltre 400 fra
intellettuali e letterati di tutta Italia. A questa rivista faceva da
contraltare Il Conciliatore, periodico statistico-letterario vicino alle
idee romantiche di Madame de Staël, che continuerà ad uscire fino al 1819,
quando sarà costretto alla chiusura. La situazione del giornalismo italiano
comincia a cambiare con la nascita di numerosi fogli clandestini, stampati dai
nuclei carbonari e dai movimenti rivoluzionari sotterranei, che porteranno ai
moti del 1820-1821. Uno dei giornali più noti di questo periodo è
L'Illuminismo, pubblicato nelle Legazioni pontificie nel 1820, ma abbiamo
anche La Minerva di Napoli e La Sentinella subalpina di Torino.
Nello stesso periodo, anche negli ambienti liberali italiani ci fu un certo
attivismo giornalistico. Risalgono a quegli anni infatti Antologia,
giornale di scienze, lettere e arti, nato a Firenze nel 1821, i genovesi
Corriere mercantile del 1824 e L'Indicatore genovese, cui collaborò
anche il giovane Giuseppe Mazzini. Nel 1847 e nel 1848 furono promulgati gli
editti di Pio IX e di Carlo Alberto, relativi alla libertà di stampa. La prima
legge che introduceva un vero e proprio intervento censorio è quella relativa
alle proiezioni cinematografiche e risale al 1913. Con questa legge si impediva
la rappresentazione di spettacoli osceni o impressionanti o contrari alla
decenza, al decoro, all'ordine pubblico, al prestigio delle istituzioni e delle
autorità. Il successivo regolamento, emanato nel 1914, elencava una lunga serie
di divieti e trasferiva il potere di intervento dalle autorità locali di
pubblica sicurezza al Ministero dell'Interno. Nel 1920 con un Regio Decreto fu
istituita una commissione, che fra le altre cose aveva il compito di visionare
preventivamente il copione del film prima dell'inizio delle riprese. La censura
fascista in Italia, consistente nella forte limitazione della libertà di stampa,
radiodiffusione, assemblea e della semplice libertà di espressione in pubblico,
durante il ventennio (1922-1944), non fu creata dal regime fascista, e non
terminò con la fine di questo.
I principali scopi di questa
attività erano:
Controllo sull'immagine
pubblica del regime.
Controllo costante
dell'opinione pubblica come strumento di misurazione del consenso.
Creazione di archivi nazionali
e locali (schedatura) nei quali ogni cittadino veniva catalogato e
classificato a seconda delle sue idee, le sue abitudini, le sue relazioni
d'amicizia e sessuali, costituendo così di fatto uno stato di polizia.
La censura fascista combatteva
ogni contenuto ideologico alieno al fascismo o disfattista dell'immagine
nazionale. La censura nel settore dei media veniva posta in atto dal
Ministero della Cultura Popolare (Min.Cul.Pop.), che aveva competenza
su tutti i contenuti che potessero apparire in giornali, radio, letteratura,
teatro, cinema, ed in genere qualsiasi altra forma di comunicazione o arte. Nel
1930 fu proibita la distribuzione di libri con contenuti di ideologia marxista o
simili. Questi libri dovevano essere raccolti, presso le biblioteche pubbliche,
in sezioni speciali non aperte al vasto pubblico. Per avere accesso a questi
testi bisognava ottenere una autorizzazione governativa, che veniva concessa
dietro alla manifestazione di validi e chiari propositi scientifici o culturali.
Grandi falò di libri si verificarono sin dal 1938: le opere contenenti temi
sulla cultura ebraica, la massoneria, l'ideologia comunista, vennero rimosse
dagli occulti scaffali di biblioteche e librerie. Per poter evitare i
sequestri e le conseguenze delle ispezioni fatte dalla polizia fascista, molti
bibliotecari nascosero le opere incriminate, ed in effetti in molti casi queste
vennero ritrovate alla fine della guerra. Un episodio recente di censura è stata
la cancellazione di una puntata della trasmissione televisiva Le Iene che
avrebbe dovuto mandare in onda un test sull'uso della droga all'interno del
Parlamento Italiano. Come per tutto il resto dei sistemi di informazione
italiani, l'industria della televisione italiana è considerata, sia da fonti
interne che esterne al paese, ampiamente politicizzata. Riprendendo un sondaggio
effettuato nel dicembre del 2008, solo il 24% degli italiani crede ai programmi
informativi televisivi, in netto svantaggio ad esempio con il dato della Gran
Bretagna che è al 38%, facendo dell'Italia uno degli unici tre paesi esaminati
dove le risorse online informative sono ritenute più affidabili di quelle
televisive. Spesso in Italia i cartoni animati e gli anime vengono
tagliati o modificati per evitare scene di violenza o di sesso. Uno degli esempi
più eclatanti è sicuramente Naruto. L'8 dicembre 2008, la rete televisiva Rai 2
ha diffuso una versione censurata del film I segreti di Brokeback Mountain
nella quale due scene sono state tagliate (la scena dove è rievocata la prima
relazione sessuale tra i due eroi e la scena dove si abbracciano). La censura ha
suscitato le proteste dei telespettatori e delle associazioni omosessuali. Nel
2009 la RAI e Mediaset si sono rifiutate di mandare in onda il trailer
promozionale di Videocracy, un'analisi del potere della televisione e di
come essa influenzi comportamenti e scelte della popolazione italiana, di come
essa sia entrata nella vita quotidiana come principale fonte di informazione per
la quasi totalità delle persone, a causa di motivi, rispettivamente per RAI e
Mediaset, politici e di opportunità. Nel 2010 in concomitanza con le elezioni
regionali, erano stati sospesi i talk show informativi dell'intero panorama
televisivo italiano, su ordinanza dell'Agcom, poi abrogata dal TAR del Lazio con
sentenza del 12 marzo 2010. In realtà poi rimasero sospesi alcuni talk show RAI,
inclusi Porta a Porta, Ballarò e Anno Zero, come
precedentemente sancito dal Consiglio di Amministrazione e poi ribadito dalla
Commissione Vigilanza della RAI, in ottemperanza al previgente ordinamento
Agcom. Nel 2009 la televisione di stato RAI tagliò i fondi per l'assistenza
legale al programma televisivo d'inchiesta giornalistica Report (messo in
onda da Rai 3). Il programma si è sempre interessato di questioni molto
sensibili, esponendo spesso i giornalisti ad azioni legali (esempio fra tutti
l'autorizzazione alla costruzione di edifici che non rispondevano a specifiche
tecniche di resistenza ai terremoti, casi di eccessiva e mala burocrazia, i
lunghi tempi della giustizia italiana, prostituzione, scandali di malasanità,
casi di banchieri falliti che segretamente possedevano dipinti e opere d'arte di
altissimo valore, cattiva gestione dei rifiuti tossici e di diossina, casi di
cancro causati dalle schermature antincendio in amianto (Eternit) e casi di
inquinamento ambientale causati da centrali elettriche a carbone (Taranto). Un
accumulo di cause pendenti contro i giornalisti in assenza di fondi per la loro
gestione potrebbe portare il programma ad una fine. Prima del 2004, nel rapporto
dell'organizzazione americana Freedom House sulla libertà di stampa, l'Italia
era sempre stata considerata "libera". Nel 2004 fu declassata a “Parzialmente
Libera” a causa dei '”'20 anni di fallita amministrazione politica”, la “controversa
Legge Gasparri del 2003” e soprattutto per tutte le “possibilità del
primo ministro di influenzare la RAI (radiotelevisione italiana di stato), uno
dei più lampanti conflitti d'interesse al mondo” (citazione del rapporto).
Lo status del resoconto risalì al grado libero dal 2007 al 2008
durante il Governo Prodi II, per tornare subito a parzialmente libero dal
2009 con il Governo Berlusconi IV. La Freedom House ha notato come l'Italia
costituisca un “valore erratico regionale” e, più precisamente, che “l'attuale
governo ha incrementato i tentativi di interferire con la politica editoriale
della televisione di stato, in particolare per quanto riguarda la copertura
degli scandali che circondano il presidente Silvio Berlusconi”. Il controllo
estensivo di Berlusconi sui media è stato ampiamente criticato sia da analisti
che da organizzazioni per la libertà di stampa, che concordano nel considerare i
media italiani con una limitata libertà di espressione. La Freedom of the
Press 2004 Global Survey, uno studio annuale promosso dall'organizzazione
americana Freedom House, per tali motivi ha più volte declassato l'Italia da
Libera a Parzialmente Libera esplicitamente a causa dell'influenza di
Berlusconi sulla Rai, una valutazione condivisa in tutta l'Europa Occidentale
solo dalla Turchia. Reporter Senza Frontiere afferma che nel 2004 Il
conflitto d'interessi che coinvolge il primo ministro Silvio Berlusconi e il suo
vasto impero mediatico non è stato ancora risolto e continua a minacciare la
democrazia informativa. Nell'aprile del 2004, la Federazione Internazionale
dei Giornalisti si unì a tali critiche, obiettando al passaggio di una legge
respinta da Carlo Azeglio Ciampi nel 2003, che criticanti credono sia disegnata
appositamente per proteggere il controllo al 90% del sistema televisivo italiano
da parte di Silvio Berlusconi. L'influenza di Berlusconi sulla RAI divenne
evidente quando a Sofia, Bulgaria, espresse le sue opinioni sui giornalisti Enzo
Biagi e Michele Santoro, e sul comico e attore Daniele Luttazzi. Berlusconi
disse che “usano la televisione come un mezzo di comunicazione criminale”. Come
risultato i tre persero il loro lavoro. Questa affermazione fu chiamata dai
critici "Editto Bulgaro". La trasmissione televisiva di un programma
satirico chiamato Raiot fu censurata nel novembre del 2003 dopo che la
comica Sabina Guzzanti aveva espressamente criticato l'impero mediatico di
Silvio Berlusconi. Nel 2006, all'uscita del film Il caimano di Nanni Moretti, la
RAI (che essendo televisione di stato utilizza denaro pubblico) acquisisce il
film per un milione e mezzo di euro per 5 passaggi del film sulle reti RAI in
altrettanti anni. Il film, che ricalca in molti punti e situazioni la figura di
Silvio Berlusconi e soprattutto le questioni riguardanti i media e le sue
controversie con la giustizia italiana, non è stato tuttora mai trasmesso. La
questione risulta particolarmente calda durante gli scandali che coinvolgono il
presidente del consiglio Silvio Berlusconi nel 2010 e 2011, facendo risultare il
film di Nanni Moretti particolarmente profetico e accendendo a tal riguardo
l'opinione pubblica. La Mediaset, il gruppo televisivo di Silvio Berlusconi, ha
affermato che esso utilizza gli stessi criteri della televisione pubblica (RAI)
nell'assegnazione di un'appropriata visibilità ai più importanti partiti
movimenti politici (la cosiddetta par condicio) – tale affermazione è
stata più volte confutata. Nel mese di ottobre del 2009, il segretario generale
di Reporter Senza Frontiere Jean-François Julliard dichiarò che Berlusconi è
sul limite per essere aggiunto sulla nostra lista dei Predatori della Libertà di
Stampa, rendendolo così il primo leader europeo della lista. Aggiunse anche
che l'Italia sarebbe probabilmente posizionata all'ultimo posto nell'Unione
Europea per quanto riguardava l'imminente edizione della lista annuale dei paesi
in base alla libertà di stampa. Attualmente la filtrazione internet in Italia
viene applicata a circa 5500 siti sulla base di richieste dell'autorità
giudiziaria, della polizia postale e delle comunicazioni (tramite il Centro
nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia su Internet), dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato. Nell'elenco sono compresi anche siti web che contengono pedopornografia
e ad alcuni siti P2P. Dal febbraio del 2009 il sito internet The Pirate Bay e il
loro indirizzo IP è stato reso inaccessibile dall'Italia, bloccato direttamente
dai Provider e seguendo un verdetto definito dalla Corte di Bergamo, poi
confermato dalla Corte Suprema definendo quest'azione utile per la prevenzione
dell'infrangimento del copyright. Un filtraggio pervasivo viene applicato ai
siti di gioco d'azzardo che non hanno una licenza locale per operare in Italia.
Vari strumenti legali vengono però anche utilizzati per monitorare e censurare
l'accesso ai contenuti internet. Alcuni esempi sono dati dalle applicazioni
della legge Romani, in seguito ai numerosi casi di gruppi Facebook creati contro
il primo ministro Silvio Berlusconi. Una legge anti-terrorismo venne promulgata
nel 2005 dopo gli attacchi terroristici a Madrid e a Londra, con essa il
ministro degli interni Giuseppe Pisanu restrinse l'apertura di nuovi Hotspot
(WLAN), sottoponendo così le entità interessate ad una richiesta di permesso da
aprire presso la Polizia di Stato di competenza e gli utenti di Internet ad
identificazione, presentando un documento d'identità. Ciò inibì l'apertura di
hotspots in tutta l'Italia, con un numero di hotspots inferiore di 5 volte
rispetto alla Francia e con la sostanziale assenza di network wireless
municipali. Nel 2009 solo il 32% degli utenti Internet italiani ha un accesso
Wi-Fi. L'Italia ha inoltre posto una restrizione ai bookmaker stranieri
su internet, dando mandato ad alcuni ISP di deviare il traffico di alcuni host
DNS.
C'era una volta... la censura
Rai, scrive Alesandra Comazzi su “La Stampa”. Avevo scritto per La Stampa un
pezzo sulla puntata di "Da da da" dedicata alla censura Rai. Poi, sapete come
capita nei giornali, il pezzo è saltato, scacciato dalla morte di Amy Winehouse.
Allora eccolo qui sul blog, ci sono cose divertenti. E' «Da da da» una
trasmissione a basso costo ma ad alto contenuto, concentrato in una mezzora, su
Raiuno dopo il Tg. «Da da da» come la vecchia canzone del 1982, gruppo tedesco
Trio. Ideatore è Michele Bovi, capostruttura intrattenimento, la firma è di
Elisabetta Barduagni, ricercatrice e regista Rai. Ogni puntata, un argomento
diverso, qualche sera fa toccava alla censura televisiva Anni '60-'70. Dunque
censura Rai, operando a quei tempi la Rai in regime di monopolio. Intorno al
tema, si costruisce una narrazione fatta di spezzoni d'epoca, ritagli definiti
«tivucinemusicali». Attraverso questi ritagli si racconta la storia del Paese,
dove non si stava meglio quando si stava peggio: ma certo, si stava
diversamente. Tra i censurati d'epoca, antesignani di Morgan, di Daniele
Luttazzi, di Sabina Guzzanti, rivedremo Clem Sacco, Herbert Pagani, i Nomadi,
Giorgio Gaber, tutti bloccati a causa di quelle che evidentemente non erano solo
canzonette. «Clem Sacco - racconta Michele Bovi - si può considerare il nonno di
Elio e le Storie Tese, il suo cavallo di battaglia si intitolava "Baciami la
vena varicosa". Figuriamoci se una cosa così poteva passare, in quegli anni». E
le altre canzoni proibite? «Solo alcuni esempi: Herbert Pagani non potè cantare
"L'albergo a ore", I Nomadi "Dio è morto" e Gaber "Addio Lugano bella", c'erano
problemi con la Svizzera». Insomma, in quegli anni di tv educativa, la censura
era pesante, sul piano politico, ma anche su quello del «buon costume». Gli
zelanti funzionari Rai avevano prepararo un elenco di parole impronunciabili:
non si poteva dire «membro» di un partito; restò memorabile il grottesco giro di
parole sul quale si dovette inerpicare Ugo Zatterin, che conduceva il
telegiornale, per dire che era stata approvata la legge Merlin, e che si
chiudevano le case di tolleranza. Ma dagli stessi problemi censori nascevano
scene sarcastiche e provocatorie, come quelle di Tognazzi e Vianello in «Un,
due, tre». Il loro programma fu sospeso quando si permisero di prendere in giro
il presidente della Repubblica Gronchi. Le ballerine dovevano fare il loro
mestiere con i mutandoni; le gemelle Kessler, che per prime misero in mostra le
gambe, ebbero a ricoprirle con una pesante calzamaglia nera. Ancora adesso
ricordano: «Non si doveva vedere la pelle. E quando facevamo la prova generale,
c'era sempre un funzionario del Vaticano che vigilava. Se qualche scollatura era
troppo profonda, qualche parola troppo spinta, lui segnalava, e gli autori
cambiavano». Un funzionario del Vaticano, addirittura: siete sicure? «Siamo
sicure». L'americana Abbe Lane, moglie del cubano Xavier Cugat, che dirigeva
l'orchestra con il cagnolino in braccio, fu costretta a cucirsi una rosa sul
generoso petto, tanto per coprirlo un po': e a ballare praticamente da ferma.
D'altronde, e «Da da da» si è aperta proprio con Fanfani, il governo aveva
appena approvato la legge sul buon costume, «La dolce vita» era oggetto di
attacchi furibondi («come osa Fellini dissacrare la città del Papa?»), in un
ristorante Scalfaro aveva schiaffeggiato una signora che si era tolto il
giubbino. E poi, in questa tv bacchettona ma nello stesso tempo fervida, ci fu
la cacciata di Dario Fo, avvenuta durante la «Canzonissima» 1962. Ettore
Bernabei era diventato direttore generale Rai nel 1961, con l'appoggio di
Fanfani. Manterrà la carica fino al 1974. Raccontò così il caso Fo: «La mia non
fu censura. C'era lo sciopero nazionale degli edili, una manifestazione in
piazza SS. Apostoli degenerò in scontri violentissimi con la polizia, che aveva
ordini di non infierire, trenta poliziotti finirono all'ospedale. Dario Fo volle
cambiare lo sketch previsto con la solita figura del costruttore col panciotto,
il palazzinaro romano che, quando gli portano la notizia di un suo operaio che
cade da un'impalcatura e muore, se ne infischia e regala un gioiello all'amante.
Io bloccai tutto, sì: troppa tensione in piazza». Aggiunge Bovi: «Un uso del
repertorio dinamico, non parassitario, ci aiuta a raccontare, ben più della
politica, quanto sia cambiato il comune senso del pudore».
Anche la Rai "censura"
Tortora. Se questo è servizio pubblico...Dopo
l'esclusione del docufilm dal Festival del cinema di Roma un'altra bocciatura.
Il Pd attacca viale Mazzini: "Occasione persa", scrive
Emanuela Fontana
su “Il
Giornale”. Il film escluso, condiviso, e ora «scippato». Enzo Tortora, una
ferita italiana di Ambrogio Crespi è stato proiettato in anteprima nazionale
ieri alla Camera dei deputati, ed è questa condivisione, tra parlamentari di
partiti diversi, il riscatto per una pellicola esclusa dal Festival del cinema
di Roma, ma ancora di più per Tortora e per la «malagiustizia», per dirla con le
parole del regista. La polemica, partita proprio dal «no» alla proiezione
all'auditorium dei red carpet, è sempre alta. E questa volta investe in pieno i
concorrenti Rai e Mediaset. Stralci del film sono stati mostrati a Matrix ieri
su Canale 5, e la produzione ha ufficializzato che la prima proiezione integrale
è stata ottenuta proprio da Mediaset, a discapito della Rai. Rai che era la casa
di Tortora e del suo Portobello. Il Pd ha fatto partire un bombardamento contro
i piani alti di viale Mazzini: «Un'occasione persa per la Rai. L'azienda si è
fatta scippare da Mediaset il docufilm». A firmare la dichiarazione i deputati
Michele Anzaldi e Gero Grassi, con il senatore Federico Fornaro. Alla Rai non
sarebbero mancati gli spazi per inserire il docufilm, insistono i parlamentari,
«ma appare evidente che l'azienda ha deciso di regalare il ruolo di servizio
pubblico a Mediaset, perdendo una nuova occasione per fare della buona
informazione». Non si conosce ancora la data della messa in onda del film, ma
regista e produzione hanno precisato che l'interesse non è il lucro: «Questo
film dovrà essere di tutti, proiettato nelle scuole», la precisazione ieri di
Crespi. E a eccezione delle «piccole spese» di produzione, gran parte degli
introiti sarà destinato alla fondazione presieduta dalla compagna di Tortora,
Francesca Scopelliti. Un grazie per la proiezione in Parlamento «va ai radicali
- chiarisce il regista - poco fa mi ha chiamato Pannella in lacrime, dopo aver
visto il film. Se ripenso a quanto ha lottato in quegli anni, per me è il
miglior premio che potessi ricevere». È normale che ieri ci sia stata qualche
garbata reazione al rifiuto della proiezione al festival romano. Tra le
motivazioni della direzione: il film è troppo televisivo e «dura solo cinquanta
minuti, forse non hanno controllato l'orologio», dice Francesca Scopelliti. In
una conferenza stampa che ha preceduto la proiezione, l'ex compagna del
conduttore ha poi invitato le forze politiche a pensare a una «legge Tortora»:
sono ancora troppi i detenuti nelle carceri in attesa di giudizio, è necessaria
una riflessione più approfondita «sulla modifica del codice penale». A 30 anni
dall'arresto, 25 dalla morte, questa storia rimane sempre una «ferita» della
giustizia. Una storia ora contesa dalla televisione, senza pace ma che parla
«anche per coloro che non possono parlare», come ricorda Scopelliti citando una
frase di Tortora. Un film che «non è né berlusconiano né antiberlusconiano»,
chiarisce Crespi. Non è «contro i magistrati», ma contro «la malagiustizia.
Muller (il direttore artistico del Festival, ndr) è stato forse un po' miope
nell'anima».
Censura
Rai, una storia antica,
scrive
Franca Rame su
“Il Fatto Quotidiano”. Ci sono nella vita di ogni uomo o donna, o in
entrambi, uno o due momenti chiave con picchi
a salire e a scendere.
Dario e io ne abbiamo vissuti più di uno e tutti di straordinario valore, anche
perché non si muovevano solo nell’ambito del nostro particolare interesse, ma
coinvolgevano molta altra gente. Quando esplose per esempio lo
scandalo
Canzonissima, non si trattò
solo di un contenzioso fra la televisione e noi, cioè due attori e autori di un
programma di sketch e di canzoni che si ribellavano ad un Ente statale a
proposito di un contratto, ma tirava in ballo la vita e i diritti degli operai,
quella della libertà di informazione oltre che di esprimersi riguardo alla
politica: cioè tirava in ballo addirittura la Costituzione. Inoltre, per la
prima volta attraverso un programma di puro intrattenimento popolare, si
denunciava l’esistenza di due grandi conflitti, nei quali c’erano
morti e feriti ogni giorno.
Si trattava delle morti sul lavoro e della guerra di mafia. Di questi atti
incivili e spesso criminali non se ne parlava mai in televisione e molto
raramente sui quotidiani. Anzi, in televisione nessuno aveva mai trattato di
questa realtà. Tutto era mascherato e seppellito. Il fatto poi che il
vaso delle nefandezze fosse
rovesciato nel programma più seguito non solo in televisione, ma anche
attraverso la totalità dei mezzi d’informazione, fu il detonatore massimo della
bomba e del relativo scandalo. Il caso volle che, nello stesso momento in cui
andava in onda la scena che trattava delle morti bianche, tutti gli operai
d’Italia, in primo luogo i muratori, avessero indetto uno sciopero di alcuni
giorni per protestare contro la mancanza di protezione sul lavoro, cioè la causa
prima dei continui incidenti che causavano ormai una vera e propria strage in
tutti settori. Proibire che quell’atto unico satirico e di forte denuncia fosse
trasmesso, era come
buttare benzina sul fuoco.
Bernabei, direttore
politico e organizzativo dei programmi Rai, scelse per il fuoco, sperando nei
pompieri, quelli politici, soprattutto. Ma la cosa non funzionò e la protesta
divampò coinvolgendo anche quei movimenti sindacali che normalmente accettano
compromessi come certi pesci s’ingoiano l’esca con l’amo. Sempre in
Canzonissima,
mi pare la puntata appresso, ecco che va in scena un dialogo fra una “mugliera”
sicula e un giornalista inviato dal continente. La donna è intenta ad avvolgere
un lungo filo. Forse allude a una delle tre Parche, allegoria della vita e della
morte. Ogni tanto si odono degli spari e qualche botto. Il giornalista chiede di
che si tratti, e la donna risponde che forse, quello sparo, proviene dal fucile
di qualche cacciatore solitario, ma poi si corregge: può darsi che sia anche
quello che
uccide un infame che si piglia la sentenza.
Altro sparo, ed ecco che viene indicato un sindacalista che creava guai; un
botto, ed è il salto in aria della casa di qualcuno che non ha pagato il pizzo e
così via, fra spari e mitragliate si arriva al punto in cui il giornalista
chiede: “Come mai all’istante hanno cessato di far botti?” e la donna risponde:
“Sempre prima dell’ultimo sparo c’è un attimo di silenzio”. “E a chi andrà
l’ultimo botto?” Chiede il cronista. E la donna risponde: “A chillu cchi fa
troppe domande, cioè a te”. Sparo, il cronista cade riverso. Il peso e la forza
di quella
satira sfuggì ai censori.
Era ritenuta troppo enigmatica per preoccuparsene, ma tutti gli spettatori,
soprattutto a cominciare da quelli siciliani, capirono immediatamente che si
trattava di discorsi sulla mafia e sui crimini che nell’isola si susseguivano a
ripetizione (giudici, poliziotti e 70 sindacalisti uccisi in pochi anni). Si
scandalizzarono i politici, a cominciare dai ministri del governo. Perfino i
liberali con il loro segretario in capo, Malagodi, presero una posizione
durissima, insultandoci e ricordandoci che già altri comici avevano sbattuto
tempo addietro la faccia sulle tavole del palcoscenico, per aver esagerato
nell’ironizzare sul potere; ma chi erano questi comici colpiti con tanta
ferocia? Ed ecco che il segretario dei liberali fa il nome di un certo
Mattia Perollo, comico di
Trieste che si prese una fucilata da un fanatico fascista durante una
rappresentazione. Il cardinale arcivescovo di Palermo fece pure un’omelia contro
quello sconcio in grottesco; urlò: “La mafia non esiste, o ad ogni modo non si
tratta di un’organizzazione criminale che voglia sostituirsi allo Stato, ma di
normale delinquenza locale”. Ricevemmo lettere minatorie in gran numero, scritte
addirittura col sangue e biglietti sui quali era disegnata una lupara. Le
minacce arrivarono anche su nostro figlio Jacopo, che aveva sei anni, al punto
che per tutto l’anno scolastico dovemmo vederlo andare a scuola protetto da due
poliziotti. Il direttore in capo della Rai, all’unisono con il dottor
Bernabei,
quando ci rifiutammo, in seguito alle loro censure, di salire sul palcoscenico
per recitare il nulla (giacchè ogni sketch di satira ci era stato cancellato) ci
avvertì: “Voi rischiate molto, più di quanto non crediate. A parte una denuncia
per turbativa dell’ordine pubblico, per la quale rischiate l’arresto immediato,
sappiate che per anni e anni non vi capiterà più di poter calcare le scene della
televisione…” e fu proprio così. Fummo letteralmente
cancellati dallo schermo
televisivo per la bellezza
di sedici anni, il che significa, nel mondo dello spettacolo, essere messi al
bando per una vita. Ci restava solo il teatro, ma le varie piazze gestite da
comuni dalla Dc come Bergamo, Vicenza, Padova, Rovigo, eccetera erano per noi
assolutamente proibite. Ma il nostro gesto aveva mosso una notevole solidarietà
da parte dei nostri colleghi, che avevano capito che bisognava rispondere non a
branco, contro la prepotenza dei gestori culturali di Stato, ma era giocoforza
organizzarsi con la creazione di un autentico sindacato degli attori e dei
tecnici. La sorpresa più straordinaria l’avemmo dal
pubblico
che, come rimontammo sulla scena con un nuovo spettacolo – si trattava di
“/Isabella, tre caravelle e un cacciaballe/” – rispose al nostro apparire con
uno slancio ed entusiasmo sconvolgenti. L’Odeon, teatro nel quale avevamo
debuttato, era stato letteralmente preso d’assalto. Il botteghino dovette aprire
le prenotazioni addirittura con dieci giorni di anticipo. La gente ci fermava
per strada e ognuno ci dimostrava affetto e stima. Per di più la notizia della
nostra vicenda era giunta anche all’estero, per cui ricevemmo visite da cronisti
da tutta Europa, nonché inviti da alcuni teatri di Francia e d’Inghilterra
perché debuttassimo da loro.
Naturalmente la Rai ci fece causa,
ma prevedendo il gesto, riuscimmo a superare in velocità l’ente pubblico e
sporgemmo denuncia contro di loro con grande anticipo. Eravamo nei primi anni
’60, e quello era il tempo in cui esplodeva il grande miracolo economico
dell’Italia… dappertutto crescevano case e palazzi come funghi, la produzione
industriale era in forte rimonta e il grande successo della nostra economia
aveva sorpreso tutti gli altri paesi dell’Europa; anche la coscienza civile e
politica delle classi subalterne si trovava in forte crescita e ognuno era
partecipe del fermento culturale che stava montando in tutti i settori, dal
cinema alla letteratura al teatro. Uno degli argomenti di cui maggiormente si
discuteva riguardava il
ruolo dell’intellettuale nella società.
Naturalmente c’era chi parlava di impegno politico, e in particolare se gli
uomini di pensiero ed arte dovessero schierarsi per una causa o dovessero
rimanere al di fuori d’ogni coinvolgimento, completamente autonomi e
indipendenti da ogni gioco di potere. Fra l’altro c’era chi riprendeva l’antico
tema dell’arte per l’arte alla ricerca della pura bellezza edonistica. Fu
proprio per entrare a piedi giunti nel dibattito che scegliemmo il
tema delle grandi
scoperte, prima fra tutte
quella che culminò con il viaggio di Colombo nelle Americhe. Ci siamo serviti
come testo base del saggio del grande storico spagnolo Salvador De Madariaga e
ci inserimmo come contrappunto dominante la repressione condotta dal Tribunale
dell’Inquisizione in quell’epoca in tutta la penisola iberica. Lo spettacolo si
apriva infatti con una processione d’auto da fè, dove si notava subito la
presenza d’alcuni condannati per eresia, fra i quali in primo piano appariva un
attore capocomico che veniva portato al patibolo poiché ritenuto colpevole
d’aver messo in scena un testo satirico che prendeva spunto dalla spedizione di
Cristoforo Colombo, con relativa strage di selvaggi rei di credere in divinità
estranee alla fede cristiana. Oltretutto nel testo opera presunta di Fernando de
Rojas si trattava della grande diaspora di ebrei che venivano spogliati dei
propri beni allo scopo di rimpinguare le casse dissanguate dello Stato. Il
condannato spera nel sopraggiungere seppur in extremis della grazia concessa dal
re. Quasi a mo’ di beffa gli viene ingiunto di recitare insieme alla sua
compagnia, che finora lo ha seguito in prossimità del patibolo, l’opera che gli
ha causato la condanna, cioè la vita di Cristobal Colon, il tutto direttamente
sul palco del supplizio. Pur di prender tempo l’attore accetta:
il palco delle esecuzioni si trasformerà in palcoscenico
e di volta in volta diventerà nave, con tanto d’alberi e vele, cattedrale e
trono sul quale siederanno il re e la regina contornati dai giudici
dell’Inquisizione. Con questo espediente è logico che tutta la vicenda riceverà
una spinta paradossale straordinaria. Più che di personaggi, quindi,
si tratterà di
maschere: re, ammiragli e
regine appariranno in tutta la loro vis comica deformante. Cristoforo Colombo
verrà interpretato dall’attore condannato, quindi le vite dei due personaggi
saranno costrette a una sintonia quasi metafisica. E così scopriremo se il
grande navigatore è maggiormente interessato alla scienza o agli affari e le
cariche di potere; se dimostra pietà per i selvaggi fatti schiavi o piuttosto ha
interesse a trarne utile nella tratta; e soprattutto capiremo come mai alla fine
dei suoi viaggi, che hanno procurato tanta ricchezza e prestigio alla corte
spagnola, viene da questa condannato alle catene e posto in galera. Dicevamo che
la turnè con quest’opera ci regalò un notevole successo, applausi ma anche
contestazioni da parte di alcuni
scalmanati reazionari,
che male accettavano si svelassero alcune verità troppo aspre per alcuni palati.
Fra l’altro, la commedia satirica era sostenuta da canti carichi di esplicita
ironia; un coro, eseguito da otto uomini d’ordine esaltava l’odio razziale e
l’intolleranza come aspetti del tutto positivi di una società. La prima strofa
diceva: “Ogni tanto fa un certo piacere/ il poter bastonare qualcuno, il poter
legalmente sfogare/ il livor di sentirsi nessuno/ su, urliamo, copriam di
pernacchie/ Questa razza di bestie in ginocchio/ su pestiamoli senza pietà./ Oh
che grande invenzione il nemico/ un nemico che sia disarmato/ ringraziam chi ce
l’ha procurato/ umiliato e per giunta marchiato”. Ognuno può ben capire che si
tratta di versi, ahimè, di una attualità sconcertante. È facile intuire che
questo fosse uno dei momenti dello spettacolo che in qualcuno poteva
maggiormente produrre forte indignazione e rabbia, tant’è che una sera,
all’uscita del teatro Valle di Roma, fummo aggrediti da una squadra di fascisti
che ci tirò addosso ogni lordura. Poi giacchè noi si era reagito, eccoli fuggire
come di regola.
In quegli anni, una compagnia di Barcellona – mi pare si chiamassero i Comedians
– tentò di mettere in scena la satira su Colon. La Spagna era ancora sotto il
regime di Franco. La compagnia riuscì anche ad eseguire la prova generale. Alla
fine della prova
gli attori furono tutti arrestati
e portati in carcere, compreso il suggeritore. Chi
guarda oggi la televisione italiana probabilmente non crederà che solo fino a
una ventina di anni fa le donne vestivano in modo poco vistoso, le ballerine
portavano il calzamaglia per non mettere in mostra le gambe nude e il linguaggio
doveva essere controllatissimo: parole come amante, parto, vizio, verginità,
talamo, alcova, amplesso erano assolutamente vietate. E vietatissime erano
espressioni come "membro del parlamento" o "in seno alla
commissione". Figuriamoci le parolacce!, Scrive Roberto Tartaglione. Negli
ultimi anni le censure collegate al linguaggio, al comportamento, alla morale,
al sesso e all'esibizione del nudo sono praticamente scomparse. Resta invece (e
forse aumenta pericolosamente) la censura (e l'autocensura) collegata alla
politica. Vediamo una rapida carrellata degli episodi censori più famosi dei
cinquant'anni di televisione italiana.
Nel 1954 il varietà "La
piazzetta" viene sospeso: la ballerina Alba Arnova porta un
calzamaglia così aderente che sembra nuda. Scandalo! Il primo caso di censura
"storica" riguarda però la coppia di comici Raimondo Vianello e Ugo
Tognazzi: in una popolare trasmissione dal titolo Un, due, tre,
i due prendono in giro il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
che, durante una serata di gala con il Presidente francese Charles de Gaulle, si
era seduto male su una sedia e era caduto per terra. L'umorismo sullo scivolone
presidenziale non piace al mondo politico di allora e il varietà viene sospeso.
Siamo nel 1959.
Nel 1960 viene
allontanato dalla televisione il presentatore Enzo Tortora: in una sua
trasmissione l'imitatore Alighiero Noschese aveva scherzato su
Amintore Fanfani, potente uomo della Democrazia Cristiana. Tortora rientrerà
in televisione solo dieci anni dopo. Un clamoroso caso di censura riguarda
Dario Fo (premio Nobel per il teatro nel 1997): insieme a Franca Rame, nel
1962, è conduttore e autore dei testi del varietà Canzonissima,
probabilmente la più famosa trasmissione della televisione italiana di tutti gli
Anni Sessanta. Le sue scenette sulla mafia e sulle fabbriche (in particolare
quella che parla di incidenti sul lavoro) non piacciono ai vertici della RAI. I
due sono costretti ad abbandonare la trasmissione. Dario Fo ritornerà in video
soltanto nel 1977 con il suo famoso spettacolo Mistero Buffo: anche
questa volta suscita scandalo e da allora le sue presenze sugli schermi della
televisione sono stati pochissime. Ancora oggi, nonostante il Nobel vinto nel
1997, ha qualche difficoltà a portare in giro le sue opere nei teatri italiani.
Nel 1974 in Italia c'è
il referendum sul divorzio. Durante lo sceneggiato televisivo David
Copperfield viene censurato l'audio di una frase detta da un vecchio
signore alla sua giovane moglie. La frase tagliata è: "Se vuoi ti concedo il
divorzio, non mi oppongo!" Nel 1980 è Roberto Benigni (premio
Oscar per il film La vita è bella del 1998) a incorrere nelle ire dei
vertici Rai: durante un Festival di Sanremo dice scherzosamente e
affettuosamente Woytilaccio, riferito a Papa Woytila, Giovanni Paolo
II. L'espressione, tipicamente toscana e comunque non offensiva, viene però
ritenuta assolutamente irrispettosa.
Nel 1984, durante la
trasmissione musicale Blitz, programma della Rai condotto da
Stella Pende, a Leopoldo Mastelloni scappa una bestemmia. Condannato per
"turpiloquio" viene cacciato dal video e il suo "esilio" dura ancora oggi.Beppe
Grillo viene allontanato dalla televisione nel 1986. Durante un
programma attacca duramente i socialisti (racconta che quando Craxi era
andato in Cina accompagnato da decine di compagni di partito, Claudio Martelli,
il suo vice, gli ha domandato: "Ma se sono tutti socialisti, a chi rubano?").
Tutto questo alcuni anni prima che lo scandalo di "Tangentopoli" mettesse fuori
gioco l'intero partito socialista che poi sparirà dalla geografia politica
italiana. Fatto è che l'attacco di Beppe Grillo provoca la sua espulsione dalla
tv e, ancora oggi, il popolare comico si esibisce quasi esclusivamente nei
teatri senza poter rientrare negli schermi televisivi.
Nello stesso 1986 uno
sketch del trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi provoca quasi un
incidente diplomatico: i tre prendono in giro addirittura l'Ayatholla
Khomeini. L'Iran-air chiude i voli per l'Italia e a Tehran ci sono
seri problemi per l'Ambasciata e per l'Istituto Italiano di Cultura, uno dei
pochissimi centri culturali stranieri ancora aperti nella capitale persiana. In
breve l'incidente si chiude e i tre comici riprenderanno a lavorare per la
televisione senza problemi. Il resto è storia contemporanea: le censure
politiche negli ultimi due anni sono più numerose di tutte quelle degli anni
precedenti.
Nel 2001 il Presidente
del Consiglio italiano Berlusconi dichiara pubblicamente che i giornalisti
Enzo Biagi e Michele Santoro, insieme con il comico Daniele
Luttazzi "fanno una televisione criminale". Immediatamente tutti e tre
vengono allontanati dalla tv e le loro trasmissioni sono sospese.
Il programma satirico
Blob, nel 2002, prevede quattro trasmissioni speciali sul
Presidente del Consiglio: vanno in onda le prime tre puntate e la quarta viene
annullata. Nel 2003 - dopo la prima puntata - viene sospesa la
trasmissione Raiot, di Sabina Guzzanti: la satira contro il
Presidente del Consiglio e il governo di centro-destra è giudicata troppo forte.
Nello stesso anno viene impedito al comico Paolo Rossi di presentare in
televisione un brano teatrale tratto da un discorso di Pericle. Il
pezzo, che è di 2500 anni fa, sembra attaccare troppo direttamente il Presidente
del Consiglio italiano. Questo il pericolosissimo testo:"Qui
ad Atene noi facciamo così. Il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi
per questo è detto democrazia. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici
affari quando attende alle proprie faccende private. Ma in nessun caso si occupa
delle pubbliche faccende per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene
noi facciamo così, ci è stato insegnato a rispettare i magistrati e c'è stato
insegnato a rispettare le leggi, anche quelle leggi non scritte la cui sanzione
risiede soltanto nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso.
La nostra città è aperta ed è per questo che noi non cacciamo mai uno straniero.
Qui ad Atene noi facciamo così" .
Niente nudi, sangue e fasci
Così la censura spegneva i film.
La religione, la politica, il sesso e la violenza: ecco tutte le scene vietate
nel nostro Paese in cento anni di (assurdi) divieti cinematografici, scrive
Cinzia Romani su "Il Giornale”. Finalmente conquistiamo un profilo
internazionale con la divulgazione elettronica del nostro pregiato patrimonio
cinematografico. Qualcosa che il mondo ci invidia e che giaceva sepolto
dall'incuria e la burocrazia. Il film di Totò "Gli onorevoli" (1963) di Corbucci
andò nei cinema dopo che le parole "culo" e "rincoglionito" furono sostituite
con "popò" e "rimbambito". Arriva Cinecensura. 100 anni di revisione
cinematografica italiana (dal 12 disponibile in Rete: cinecensura.com), mostra
online della Cineteca Nazionale e del Ministero dei Beni e le attività
culturali, progettata dagli studiosi di cinema Pier Luigi Raffaelli e Tatti
Sanguineti, che dopo anni di trappismo d'archivio, con la Cineteca di Bologna,
l'Archivio Luce, il Museo del cinema di Torino e l'Archivio centrale di Stato,
hanno messo su piattaforma digitale, a disposizione di tutti, un'esposizione
davvero notevole. Che ha il pregio di appassionare non soltanto i cinefili, ma
anche chi voglia conoscere il secolo trascorso, dal punto di vista del costume e
dei cambiamenti sociali. Così profondi, sotto la lente dell'intrattenimento pop,
che ci s'intenerisce, di fronte alle richieste dei prefetti di provincia, o
degli spettatori più bigotti, tra i pruriginosi Quaranta e Cinquanta, lesti a
invocare revisioni e controlli di frasi, cosce, allusioni. E giù lettere, carte
da bollo di Lire 200, processi e ricorsi, dove Visconti e Pasolini, De Sica e
Bertolucci vagano per tribunali, alla mercè di qualche massaia, pronta a
scandalizzarsi per un particolare, che oggi fa sorridere. Il materiale a
disposizione è sterminato: 300 lungometraggi, 90 cinegiornali o pubblicità, 86
cortometraggi, 28 manifesti censurati, filmati di tagli di 75 film, 15
cinegiornali e videointerviste. Il tutto divido in sale virtuali “a tema”:
sesso, politica religione, violenza. Sesso: se nel 1938 il Trio Lescano cantava
Ma le gambe, nei Cinquanta repressi gli arti inferiori femminili destano
prurigini. Dove sta Zazà (1947) di Giorgio C. Simonelli ottiene il nulla osta, a
patto si eliminino alcune scene. Le donne cristiane del Centro italiano
femminile di Palermo scrivono al ministero degli Interni, sentendosi insultate
dalla pubblicità «ad ogni angolo di strada, raffigurante una ballerina quasi
nuda». La dignità morale del popolo pare vilipesa anche ne La famiglia Passaguai
(1951) di Aldo Fabrizi, con la procace Rita Dover: foto-busta sotto accusa. Un
kafkiano Segretariato della Moralità di Foligno inoltra formale denuncia alla
Procura della Repubblica di Perugia, chiedendo l'immediato ritiro del materiale
raffigurante «una persona in succintissimo e disgustoso atteggiamento,con una
bottiglia in mano e in posizione quanto mai provocante in cabina da bagno». Oggi
che si fa sesso per strada, chi pensa alle cabine? Ma è Ultimo tango a Parigi
(1972) di Bertolucci il film-simbolo della guerra tra censura e libertà
espressiva. Denunciato e condannato “al rogo” per la scena in cui «il
protagonista, utilizzando del burro, possiede contro natura la ragazza». Vani i
tagli per 9,80 metri di pellicola... Certi fatti hanno perso capacità offensiva,
se pensiamo che in Terza liceo (1954) di Luciano Emmer, vietato ai minori di 16
anni, un prof. si stranisce, scoprendo nel libro di un'allieva «Anita nuda con i
baffi»: per la versione tv, via la sequenza. Tacendo di Nino Manfredi, una
condanna penale per essere apparso «in mutande, con i pantaloni in mano» nel
film a episodi Le bambole (1965). Sequestri e denunce aprono la strada al cinema
a luci rosse, nei '60 e '70 affollati di pellicole vietate ai minori. «Scopate e
fellatio entrano così in modo surrettizio», spiega Sanguineti. Politica. C'è
sempre qualcuno che si sente diffamato. Così sparisce Tragica alba a Dongo
(1951) di Vittorio Crucillà, redattore di Omnibus, che mai avrà il nulla osta
per il film. Frutto della collaborazione tra Comune di Dongo, partigiani e
volontari della guerra di Liberazione, il film ritrae Mussolini e Claretta
Petacci, visti di spalle, durante la loro fuga, cattura e fucilazione. Materia
scottante, che per l'onorevole Andreotti «può ingenerare all'estero errati e
dannosi apprezzamenti sul nostro Paese». La diffida della famiglia Mussolini,
verso la casa produttrice, metterà una pietra tombale su quei 1040 metri di
docufilm, che per Crucillà, «umile regista e soggettista», implorante udienza ad
Andreotti, doveva «preparare la rinascita dell'Italia democratica». Ce n'è pure
per Togliatti è ritornato (1948) di Lizzani, stoppato per le immagini d'una
festa dell'Unità al Foro Italico: potevano «determinare perturbamento
dell'ordine pubblico». Peccato che sia una canaglia (1954) di Alessandro
Blasetti è bloccato perché un maresciallo «si esprime con espressioni dialettali
e grottesche»...Religione. Nei Cinquanta, i preti spopolano al cinema. Anche
perché sono 5.900 le sale parrocchiali, dove censura di Stato e revisione
cattolica controllano l'orientamento delle masse. Così non si contano i processi
intentati da associazioni cattoliche. A finire nel tritafilm, Viridiana (1961)
di Buñuel; La dolce vita (1960) di Fellini e Ro.Go.Pa.G (1963), film a episodi,
che suscitò accanimento giudiziario nei confronti dell'episodio La ricotta di
Pasolini: «È sempre un rischio violare il mistero che circonda ogni uomo»,
scriveva la Pontificia Università Gregoriana al produttore, Alfredo Bini.
Adesso, certi misteri non lo sono più.
Censura cinematografica.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La censura cinematografica è il
mezzo attraverso il quale una autorità attua il controllo preventivo di un'opera
cinematografica, autorizzando o negando la sua proiezione in pubblico, o
limitandone la visione ad un pubblico adulto. Lo Stato si è sempre riservato la
possibilità di intervenire sui contenuti di rappresentazioni pubbliche,
offensivi alla morale e al buon costume o pericolosi per l'ordine pubblico,
ancora prima della nascita del cinematografo. Risale tuttavia al 1913 la prima
legge che introduceva un vero e proprio intervento censorio sulle proiezioni,
allo scopo di impedire la rappresentazione di spettacoli osceni o impressionanti
o contrari alla decenza, al decoro, all'ordine pubblico, al prestigio delle
istituzioni e delle autorità. Il successivo regolamento elencava una lunga serie
di divieti e trasferiva il potere di intervento dalle autorità locali di
pubblica sicurezza al Ministero dell'Interno. Questi, dopo il giudizio espresso
da un revisore, rilasciava il nulla osta, eventualmente eliminando alcune parti
della pellicola giudicate non idonee alla proiezione. Era prevista comunque la
possibilità di un secondo grado di giudizio, al quale poteva essere sottoposta
la pellicola se giudicata in primo grado non idonea. Nel 1920 un Regio Decreto
istituì una vera e propria commissione, composta anche da soggetti esterni alle
istituzioni: ne facevano parte, oltre a due funzionari di pubblica sicurezza, un
magistrato, un educatore o un rappresentante di associazioni umanitarie, una
madre di famiglia, un esperto di arte o di letteratura e un pubblicista. Con
questo decreto si prevedeva anche che il copione del film venisse
preventivamente sottoposto alla commissione prima dell'inizio delle riprese. Il
regime fascista confermò le disposizioni precedenti, intuendo fin dall'inizio le
potenzialità del cinema come mezzo di comunicazione e utilizzandolo spesso a
fini di propaganda politica. Il controllo, prima accentrato presso il ministero
dell'Interno, venne in seguito affidato al Ministero della Cultura popolare.
Venne introdotta la possibilità di sottoporre a revisione ogni fase della
realizzazione del film, quindi la possibilità anche di interrompere le riprese,
se necessario, e venne istituito un nulla osta anche per le pellicole destinate
alla proiezione all'estero, nulla osta che poteva essere negato se il film era
ritenuto dannoso per il decoro e il prestigio della nazione o se poteva turbare
i rapporti internazionali. Nel 1926 fu anche introdotta la tutela dei minori,
con un decreto che consentiva il divieto della visione di alcuni film ai minori
di 16 anni. Durante il ventennio, la censura venne "potenziata" sia in senso
preventivo, sia per "istruire" le folle ai valori del regime, tanto che nel 1934
venne istituita una apposita Direzione generale per la cinematografia. Con
l'avvento della repubblica, contrariamente a quanto si pensa, non vennero
introdotte sostanziali modifiche, nonostante l'articolo 21 della Costituzione
consentisse la libertà di stampa e di tutte le forme di espressione. Su
pressioni soprattutto del mondo cattolico, venne anzi aggiunto il comma che
sancisce il divieto degli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. Presso la Presidenza del Consiglio fu istituito
un Ufficio centrale per la cinematografia, al quale confluivano i giudizi
delle commissioni di primo e secondo grado, che in sostanza erano rimaste quelle
del 1923, anche se leggermente variate nella loro composizione. Nel 1949 fu
emanata una legge, presentata dall'allora sottosegretario allo spettacolo Giulio
Andreotti, che doveva sostenere e promuovere la crescita del cinema italiano e
al contempo frenare l'avanzata dei film americani ma anche gli imbarazzanti
"eccessi" del neorealismo. A seguito di questa norma, prima di poter
ricevere finanziamenti pubblici, la sceneggiatura doveva essere approvata da una
commissione statale. Inoltre se si riteneva che un film diffamava l'Italia
poteva essere negata la licenza di esportazione, insomma era nata una sorta di
censura preventiva. Nel 1962 venne approvata una nuova legge sulla Revisione
dei film e dei lavori teatrali, tuttora in vigore: pur apportando alcuni
cambiamenti, essa confermava il mantenimento di un sistema preventivo di censura
e assoggettava al rilascio del nulla osta la proiezione pubblica dei film e la
loro esportazione all'estero. In base a tale legge, il parere sul film viene
dato da un'apposita Commissione di primo grado (e da una di secondo grado per i
ricorsi), mentre il nulla osta è rilasciato dal Ministero del Turismo e dello
Spettacolo. Le Commissioni di censura, definite dalla legge "Commissioni per la
revisione cinematografica", sono otto e fanno capo al Dipartimento dello
Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ogni commissione è
composta da un presidente (di solito un magistrato o un docente di diritto), due
esponenti della categoria (produttori e distributori), due genitori in
rappresentanza delle associazioni per i diritti dei minori, due esperti di
cultura cinematografica, uno psicologo. Ad essi si affianca un esponente delle
associazioni animaliste se nel film compaiono anche animali. Ad ognuna di queste
otto commissioni sono assegnati dei film da visionare. Le commissioni possono
approvare la diffusione del film per tutti o imporre un divieto ai minori. La
casa distributrice dell’opera ha a disposizione 20 giorni per presentare
appello, o per effettuare tagli e modifiche, di solito suggerite dalla
commissione stessa, per rendere la pellicola adatta ad un pubblico di minori.
Una volta accolto l’appello, la commissione visiona nuovamente il film e decide
se confermare il divieto, abbassarlo dai 18 ai 14 anni oppure revocarlo
definitivamente una volta accertata l’eliminazione delle scene suggerite. In
caso di ulteriore rifiuto, è possibile il ricorso al TAR. L'autore o il
produttore del film può chiedere eventualmente di essere ascoltato dalla
commissione, per "difendere" le ragioni del film e per evitare il rifiuto del
nulla osta o il divieto della visione del film ai minori. Il rilascio del nulla
osta condizionato dal divieto ai minori di anni 14 o 18 si ripercuote anche
sullo sfruttamento televisivo del film. Infatti i film ai quali viene negato il
nulla osta e quelli vietati ai minori degli anni 18 non possono essere trasmessi
in televisione, mentre i film vietati ai minori degli anni 14 possono essere
trasmessi solo in determinate fasce orarie, regolate dalla successiva Legge 203
del 1995, per cui la trasmissione di film che contengano immagini di sesso o
di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è
ammessa (...) solo fra le 23 e le 7. Talvolta i distributori e i produttori
anticipano le probabili richieste delle Commissioni, presentando alla revisione
pellicole già ridotte nelle parti che condurrebbero ad un divieto per i minori.
Oggi, vista la soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, le sue
funzioni sono state delegate, dal 1998, al nuovo Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Sempre nel 1998 veniva abrogato l'art. 11, rimuovendo quindi
la censura dalle opere teatrali. A luglio 2007 il disegno di legge Modifiche
alla legge 21 aprile 1962, n.161, in tema di revisione cinematografica, è
stato approvato dal Consiglio dei ministri. Esso cancella la censura preventiva
nei film, ma introduce nuovi paletti per la visione di film e cartoni: i
produttori di programmi, film, cartoni dovranno autocertificare se il loro
prodotto è per tutti, o deve essere vietato ai minori di 18, 14 o 10 anni
(quest'ultimo divieto introdotto appositamente con questa legge), oppure
affidarsi ad un'apposita Commissione di classificazione dei film per la
tutela dei minori istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che esprimerà un parere sulla classificazione. Nel caso la
classificazione autocertificata non sia poi considerata consona, sono previste
sanzioni amministrative fino a 100.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. Oltre
alla censura totale, dagli anni trenta fino agli anni novanta in Italia è stata
in voga un'altra forma di censura, quella dei tagli mirati. In pratica si
usava tagliare le parti di pellicola che non si voleva venissero mostrate,
permettendo tuttavia di mandare in visione il film così mutilato.
La censura ed il cinema.
Una torbida storia di censura,
autori seviziati e pellicole passate al tritacarne. Leggi censorie. Si intende
di seguito presentare una breve carrellata delle normative che hanno interessato
l’industria cinematografica dal 1913 al dopoguerra, per arrivare poi alla
normativa vigente ( Legge
161 del 21 aprile 1962).
20 febbraio 1913 Il
presidente del Consiglio Giolitti dirama ai prefetti una circolare che colpisce
“le rappresentazioni dei famosi atti di sangue, di adulteri, di rapine, di altri
delitti” e i film che “rendono odiosi i rappresentanti della pubblica forza e
simpatici i rei; gli ignobili eccitamenti al sensualismo (…), ed altri film da
cui scaturisce un eccitamento all’odio tra le classi sociali ovvero di offesa al
decoro nazionale”.
Legge 25 giugno 1913,
n. 785 Il primo
provvedimento legislativo registrato
in materia di censura autorizza “il governo del Re ad esercitare la vigilanza
sulla produzione delle pellicole cinematografiche, prodotte all’interno o
importate dall’estero”.
Il regolamento
esecutivo della
legge (Regio
decreto 31 maggio 1914, n. 532)
è di grande importanza, perché introduce quella casistica di argomenti
suscettibili di rientrare nell’ambito della censura che verrà ripresa
fedelmente, adattata e ampliata, non solo nel periodo fascista ma anche in età
repubblicana.
Obiettivo della legge è
vietare al pubblico la visione di: “spettacoli offensivi della morale, del buon
costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini; spettacoli contrari
alla reputazione e al decoro nazionale o all’ordine pubblico, ovvero che possano
turbare i buoni rapporti internazionali; spettacoli offensivi del decoro e del
prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti
della forza pubblica; scene truci, ripugnanti o di crudeltà, anche se a danno di
animali; delitti o suicidi impressionanti e in generale azioni perverse o fatti
che possano essere scuola o incentivo al delitto, ovvero turbare gli animi o
eccitare al male”. La legge accenna anche alla questione della lingua straniera:
“I titoli, i sottotitoli e le scritture (…) debbono essere in corretta lingua
italiana. Possono tuttavia essere espressi anche in lingua straniera, purché
riprodotti fedelmente e correttamente anche in lingua italiana”. La censura sui
film è esercitata dal ministro dell’Interno, cui spetta concedere o negare il
nulla osta “in conformità al giudizio del revisore” (ed eventualmente imporre
una nuova revisione a film già muniti di nulla osta). Sono previsti due gradi di
giudizio per la revisione delle pellicole: in primo grado il revisore è un
funzionario della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza o un commissario
di polizia, in secondo grado una commissione composta dal vice-direttore
generale e da due capi divisione della Direzione Generale della P.S.
Il R.d.
9 ottobre 1919, n. 1953 introduce
il controllo preventivo sul “copione o scenario”: perché una pellicola possa
accedere al procedimento di revisione, prima dell’inizio delle riprese il
soggetto deve essere “in massima riconosciuto rappresentabile” dalla censura.
Nella pratica, tuttavia, il copione viene sempre presentato alla commissione di
primo grado insieme al film finito: il controllo preventivo sarà
applicato con rigore solo a partire dal 1935.
R.d. 22 aprile 1920,
n. 531 (a
firma del ministro dell’Interno F. S. Nitti). Anche la revisione di primo grado
è affidata a una commissione, che non ha più una natura solo repressiva ma si
allarga ad altri soggetti, seppur sempre di nomina ministeriale: oltre a due
funzionari della Pubblica Sicurezza, “un magistrato, una madre di famiglia, un
membro da scegliersi fra educatori e rappresentanti di associazioni umanitarie
che si propongono la protezione morale del popolo e della gioventù, una persona
competente in materia artistica e letteraria e un pubblicista”. Alla casistica
censoria si aggiungono l’offesa al “pudore”, l’offesa al “Regio esercito e alla
Regia armata”, “l’apologia di un fatto che la legge prevede come reato” e “le
operazioni chirurgiche e i fenomeni ipnotici e medianici”.
R.d. 24 settembre
1923, n. 3287. La
composizione delle commissioni di revisione viene trasformata in senso
rigidamente burocratico. Quella di primo grado si riduce a “singoli funzionari
di prima categoria dell’Amministrazione dell’Interno appartenenti alla Direzione
Generale della Pubblica Sicurezza”, ma viene ripristinata un anno dopo (R.d.
18 settembre 1924, n. 1682)
e conta tre membri: un funzionario di polizia, un magistrato e una madre di
famiglia. In quella di secondo grado o di appello, che rimane di sette membri,
l’educatore è sostituito con un professore e la “persona competente in materia
artistica e letteraria” è prima eliminata e poi reintegrata. L’elenco delle
scene da proibire riprende fedelmente quello del 1920 (a sua volta ricalcato su
quello del 1914), con l’aggiunta di una sola frase sulle “scene, fatti e
soggetti” che “incitino all’odio fra le varie classi sociali”, tuttavia già
presente nella circolare del 1913. È stabilita un’apposita revisione per le
pellicole destinate all’esportazione: sono da vietare quelle che possano, tra
l’altro, “ingenerare, all’estero, errati o dannosi apprezzamenti sul nostro
paese”.
Il R.d.
6 novembre 1926, n. 1848 introduce
una prima forma specifica di tutela dei minori: è consentito vietare la visione
dei film ai minori di anni 16, pur senza alcuna indicazione sui motivi del
possibile divieto. Un precedente si ritrova nella l.
10 dicembre 1925, n.
2277, art. 22: “La
commissione a cui spetta di autorizzare gli spettacoli cinematografici deciderà
a quali di essi possano assistere i fanciulli e adolescenti dell’uno e
dell’altro sesso”, che verrà applicata con un divieto ai minori di anni 15.
L. 16 giugno 1927, n.
1121 Tra i parametri
di valutazione di un’opera in sede di censura rientra anche la qualità
artistica: un film può essere vietato quando non presenti “sufficienti requisiti
di dignità artistica così nella trama del soggetto, come nella esecuzione
tecnica”.
R.d. 9 aprile 1928, L.
24 giugno 1929, L. 18 giugno 1931 Aumenta
progressivamente la politicizzazione delle commissioni di revisione. Sia in
quelle di primo che di secondo grado, entrano rappresentanti del Partito
Nazionale Fascista e dei ministeri dell’Educazione Nazionale, delle
Corporazioni, delle Colonie e della Guerra (gli ultimi due competenti solo per
copioni e pellicole di carattere “militare o coloniale”). La presenza di
rappresentanti dell’Istituto Nazionale LUCE e dell’Ente nazionale per la
cinematografia, introdotta nel 1929, dura solo due anni: la legge più
restrittiva del ’31 riduce di nuovo il numero dei censori abolendo anche le
persone “competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica”
nominate dal Ministero dell’Educazione.
Il R.d.
28 settembre 1934, n. 1506 trasferisce
la responsabilità amministrativa della censura, non solo cinematografica, dal
Ministero dell’Interno al nuovo Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la
Propaganda (trasformato un anno dopo in Ministero, rinominato nel 1937 Ministero
della Cultura Popolare). Come sezione del Sottosegretariato nasce anche la
Direzione generale della cinematografia, che riunisce le competenze sul cinema
prima suddivise fra i vari ministeri ed è affidata a Luigi Freddi, protagonista
indiscusso della politica cinematografica italiana e convinto sostenitore del
rafforzamento del ruolo della censura, che d’ora in poi non si limiterà a
compiti di mero controllo ma sarà anche attiva, “ispiratrice”, propositiva. Tra
le competenze della Direzione generale c’è infatti quella di esaminare e
revisionare i soggetti dei film di produzione nazionale: comincia l’applicazione
rigorosa del principio della censura preventiva, già formulato nel 1919.
La l.
10 gennaio 1935, n. 65,
conversione del decreto precedente,uniforma la composizione delle commissioni di
primo grado e di appello fissando per entrambe a cinque il numero di membri: tre
in rappresentanza dei ministeri dell’Interno, delle Corporazioni e della Guerra,
uno del Partito Nazionale Fascista e uno dei GUF (Gruppi Universitari Fascisti),
designato dal segretario del partito. Il processo di assoggettamento al potere
politico è completo: gli ultimi ad essere esclusi sono il magistrato e la madre
di famiglia. La presidenza spetta per legge a un funzionario del
Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda nelle commissioni di primo
grado, direttamente al Sottosegretario o per delega al Direttore generale della
cinematografia in quelle di appello.
L. 29 maggio 1939, n.
926 A
seguito della conquista dell’Etiopia, si aggiunge in entrambe le commissioni di
controllo un rappresentante del Ministero dell’Africa Italiana, per stabilire
“quali delle pellicole, sia nazionali che estere, possono essere destinate alla
proiezione nell’Africa Italiana”.
Il R.d.
30 novembre 1939 ufficializza
la censura preventiva: “Chiunque intenda produrre una pellicola cinematografica
destinata alla rappresentazione nel Regno o all’esportazione, dovrà ottenere,
prima di iniziarne la lavorazione, il nulla osta del Ministero della Cultura
Popolare. Sono esenti dal nulla osta (…) le pellicole di attualità e i documenti
eseguiti dall’Istituto Nazionale LUCE”.
L. 16 maggio 1947, n.
379 L’Assemblea
costituente affida il controllo preventivo sui film al nuovo Ufficio centrale
per la cinematografia, costituito presso la Presidenza del Consiglio, previo
parere delle Commissioni di primo e secondo grado, nuovamente mutate nella loro
composizione. Si elimina l’obbligo della revisione dei copioni, ma per il resto
sono confermate tutte le disposizioni contenute nella legge del 1923, compresa
la casistica delle scene da proibire.
L’art.
21, comma VI, della Costituzione recita:
“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
La l.
29 dicembre 1949, n. 958 non
apporta nessuna innovazione in materia. La necessità di un aggiornamento della
disciplina si realizzerà solo con la legge 161/1962, che in ogni caso,
nonostante le novità, manterrà il sistema della censura preventiva.
(fonti: italiataglia.it e P. Caretti,
Diritto pubblico dell’informazione, Bologna,
Il Mulino, 1994).
Andreotti e il cinema, dalla
censura di Stato al maligno "Il Divo", scrive “Notizie Tiscali”. Quando la
televisione non c'era ancora, e i politici non litigavano per la presidenza
della commissione di Vigilanza Rai, un sottosegretario di appena una trentina
d'anni vigilava sul cinema italiano, allora ritenuto un potente mezzo di
formazione delle coscienze dei cittadini. Tra il luglio del 1951 e il luglio del
1953, Giulio Andreotti, nel settimo e ottavo governo De Gasperi, aveva il
delicato compito di occuparsi di tutto il settore dello spettacolo. Luci e ombre
caratterizzano l'operato di quel suo primo incarico governativo. L'allora
sottosegretario, per dirne una, aveva obbligato le produzioni americane a
versare nelle casse dello Stato italiano una percentuale degli utili del
botteghino. La tassa su Hollywood serviva per finanziare il cinema tricolore, e
qui cominciavano i guai. Per accedere ai contributi, bisognava passare
attraverso il giudizio di commissioni e burocrati di nomina governativa: e così
succedeva che la saga di Peppone e Don Camillo ricevesse dieci volte di più di
un film di Vittorio De Sica. Il fatto è che, al giovane sottosegretario, il
neorealismo proprio non piaceva, perché insisteva troppo sugli aspetti tragici
dell'Italia del dopoguerra. Secondo la vulgata, Andreotti avrebbe espresso il
suo astio nei confronti dei neorealisti con la celebre battuta (sempre smentita)
"i panni sporchi si lavano in famiglia". Se l'autenticità della frase è dubbia,
viene però dalla penna di Andreotti un articolo per "Il Popolo" contro "Umberto
D.", un film di Vittorio De Sica che racconta la storia di un pensionato ridotto
alla miseria: "Se nel mondo si sarà indotti, erroneamente, a ritenere che quella
di Umberto D. é l'Italia della metà del XX secolo - scriveva Andreotti - De Sica
avrà reso un pessimo servigio alla patria, che è la patria di don Bosco, di
Forlanini e di una progredita legislazione". Il film di De Sica, come ha
denunciato recentemente il figlio Manuel, ancora oggi non può essere trasmesso
in Tv in prima serata, perché fu bollato dalla commissione censura (della quale
Andreotti faceva parte) come "disfattista". Dietro la posizione di Andreotti
c'era l'insofferenza del Vaticano per la lontananza della cinematografia
italiana dai valori della tradizione cattolica. "La verità - scrisse Andreotti a
monsignor Montini, il futuro Paolo VI - è che la gran parte dei registi, dei
produttori e dei soggettisti non proviene dalle nostre file né condivide con noi
le essenziali convinzioni religiose". Lo stesso Andreotti, nei suoi diari,
racconta che papa Pio XII gli telefonava per protestare contro questa o quella
scena scabrosa vista in un film. Una volta Papa Pacelli lo chiamò perché in una
copertina della Settimana Incom Illustrata si vedeva un'attrice che, scendendo
dalla macchina, mostrava le gambe un po' sopra le ginocchia. Il Vaticano non
transigeva e Andreotti non risparmiava energie per raddrizzare le storture.
Largamente sua era la normativa contro l'oscenità e "tutto ciò che può turbare
l'adolescenza" (ma anche un certo numero di esponenti della sinistra, tra i
quali Pietro Ingrao, votarono a favore). Anni dopo, quando la sua stella era
all'apogeo, Andreotti accettò di interpretare sé stesso nel film di Alberto
Sordi "Il tassinaro". A bordo del taxi di Sordi, tra le strade di una Roma dei
primi anni '80, Andreotti chiacchierava con il conducente di calcio e politica,
probabilmente convinto che la Dc avrebbe governato l'Italia per altri 50 anni.
Passati altri 20 e più anni, con la prescrizione al processo per mafia alle
spalle, Andreotti si è ritrovato protagonista di un film che lo presentava come
il simbolo del "lato oscuro" della politica italiana. Di fronte a "Il Divo" di
Paolo Sorrentino, il flemmatico Andreotti è sbottato: "E' cattivo, é maligno, è
una mascalzonata", disse il giorno della prima. Poi però tornò a essere
andreottiano: "Ho esagerato, le mascalzonate sono ben altre. Questa la
cancello".
BERLINGUERISMO. I MITI
DELLA SINISTRA.
Enrico Berlinguer, l'ultimo
leader.
Enrico Berlinguer nacque a Sassari il 25 maggio del 1922 figlio di Mario
Berlinguer, un avvocato repubblicano, antifascista e vicino alla massoneria,
come molti intellettuali laici dell'epoca, discendente da una nobile famiglia
catalana stabilitasi in Sardegna all'epoca della dominazione aragonese, e di
Maria Loriga. La famiglia portava i titoli nobiliari di Cavaliere, Nobile, con
trattamento di Don e di Donna per concessione il 29 marzo 1777 a Giovanni e
Angelo Ignazio da Vittorio Amedeo III Re di Sardegna. Nel dopoguerra, Mario
Berlinguer fu parlamentare socialista. Enrico crebbe quindi in un ambiente
culturalmente assai evoluto (il nonno, suo omonimo, era stato il fondatore del
giornale La Nuova Sardegna, e aveva avuto contatti con Garibaldi e
Mazzini) ed ebbe occasione di profittare di relazioni familiari e politiche che
influenzarono notevolmente la sua ideologia e la carriera politica successiva.
Era parente di Francesco Cossiga (le rispettive madri erano cugine tra loro) –
che fu presidente della Repubblica – ed entrambi erano parenti di Antonio Segni,
anch'egli Capo di Stato. Condotti gli studi liceali classici presso il Liceo
Azuni di Sassari, nel 1943 Berlinguer si iscrisse al Partito Comunista Italiano
e ne organizzò la sezione sassarese, svolgendo un'intensa attività di
propaganda. Nel gennaio del 1944 la fame spinse la popolazione a saccheggiare i
forni della città e Berlinguer fu accusato di esserne stato uno degli
istigatori. Fu quindi arrestato e trattenuto in carcere per tre mesi, dopo i
quali fu prosciolto dalle accuse e liberato.
Berlinguerismo: un misto di
filosofia da oratorio e di marxismo in caricatura,
scrive Ishmael su “Italia Oggi”.
2014. Sono passati trent'anni dalla morte d'Enrico Berlinguer, quasi altrettanti
dalla caduta del Muro di Berlino, ma l'ideologia berlingueriana, un misto di
filosofia da oratorio e di marxismo in caricatura, continua a pesare sulla
sinistra italiana come un incubo: la «diversità», la «questione morale», il
«nuovo modello di sviluppo» e soprattutto l'incapacità «di pensare la democrazia
nella sua realtà politica, affrancandosi dal mito comunista e togliattiano della
democrazia progressiva», come scrive Claudia Mancina — ex comunista, deputata
diesse negli anni novanta — nel suo nuovo libro, Berlinguer in questione
(Laterza 2014, pp. 136, 12,00 euro, ebook 7,99 euro). Come tutti i leader del
comunismo italiano, anche Berlinguer, l'ultimo dei grandi segretari generali,
partecipava di due nature: la fedeltà al «campo socialista» e l'istinto politico
di conservazione, che gli faceva preferire l'ovest all'est, la Nato all'Armata
rossa, la democrazia parlamentare alla democrazia popolare. Ma «agli occhi dei
comunisti», scrive sempre Mancina, «la democrazia vera non è quella formale ma
quella sostanziale», una democrazia «che consiste nella mobilitazione delle
masse, nel potere dei lavoratori nel luogo di lavoro, dei sindacati sulla
politica economica, o perfino degli studenti nell'università o dei genitori
nella scuola». Berlinguer, ai suoi tempi, stabilì con accenti pasoliniani che
«l'Italia non avrebbe seguito le banali strade delle democrazie occidentali,
nelle quali c'è alternanza di governo e a volte vince la destra, altre la
sinistra. Troppo poco per questo paese così speciale, il paese del più grande
partito comunista d'Occidente! A noi toccava invece superare il capitalismo e
portare a maturazione piena la democrazia, cioè realizzare la mitica democrazia
sostanziale». Caduto il Muro di Berlino, passata Tangentopoli, con Berlusconi
sugli altari, «i postcomunisti non hanno fatto che oscillare tra ipotesi di
riforma elettorale e costituzionale e difesa acritica della costituzione, fino
alla favola della costituzione più bella del mondo». Quanto all'eredità
berlingueriana, invece di restare patrimonio dei solo ex e post e vetero
comunisti, è diventata patrimonio collettivo, come i mezzi di produzione
socializzati della favola marxista. «Per la sua deriva moralistica»,
l'intervista sulla questione morale di Berlinguer «è oggi un testo sacro per gli
antipolitici». È grazie a Berlinguer e al suo marxismo bacchettone che «ancora
oggi si pensa che l'intransigenza sia una politica».
Le grandi firme di ieri e
di oggi per raccontare il segretario del Pci.
"L'Espresso" ha scelto di celebrarlo, a trent'anni dalla morte con un libro
impostato su un doppio registro: una riflessione attuale e la riproposizione
degli articoli a lui dedicati negli anni della sua segreteria, dal 1972 al 1984,
scrive Loredana Bartoletti su “L’Espresso”. Berlinguer come se fosse appena
successo. A trent'anni dalla morte, l'ultimo grande leader del Partito comunista
è tornato di attualità sulla ribalta politica. Evocato dai palchi dei comizi
elettorali per solleticare consensi in suo nome, celebrato con film,
documentari, libri e ricordi vari. Certo c'è un anniversario importante -
trent'anni appunto da quell'11 giugno 1984 - ma c'è anche l'omaggio, il
rispetto e quasi la nostalgia per un politico che appare diverso dal panorama
cui ci siamo abituati, quasi un alieno nella sua severità di tratto e di
comportamento e in più un contemporaneo per quelle parole d'ordine, come la
questione morale, che a decenni di distanza non hanno ancora trovato una
risposta. Il ricordo di un politico diventato icona può però tendere a
idealizzare, a semplificare, a minimizzare le difficoltà e gli ostacoli che quel
leader e il suo progetto hanno dovuto affrontare. Anche per questo "l'Espresso"
ha scelto di celebrare Berlinguer con un libro impostato su un doppio registro:
una riflessione attuale e la riproposizione degli articoli dedicati al capo di
Botteghe Oscure proprio negli anni della sua segreteria, dal 1972 al 1984. Nel
volume si alternano così le grandi firme del nostro settimanale, quelle di oggi
e quelle di ieri. I bilanci e i giudizi su Berlinguer che la distanza di tempo
consente di tracciare con maggiore lucidità e le cronache dirette del suo agire
politico, dove emergono i tormenti di Botteghe Oscure, i "processi" che il
leader subì da parte dei suoi, il lungo scontro con Bettino Craxi, i colpi
inferti dal terrorismo, il tormentato rapporto con l'Urss... Insomma la
complessità dell'azione di un grande leader. Ma la lettura di quegli articoli di
decenni fa consente anche di riflettere sul modo di fare informazione politica
di allora. In parte diversa, più stretta al succedersi degli eventi che non ai
retroscena, e in parte anticipatrice di modelli poi ampiamente copiati: curiosa,
irriverente, capace di disegnare legami e collegamenti inediti. Molto
"Espresso", se è consentito dirlo. Il libro "Berlinguer", che sarà dal 6 giugno
nelle edicole, è aperto da un’introduzione del direttore dell’”Espresso”, Bruno
Manfellotto che riflette sul "politico perbene", poi una intervista di Denise
Pardo a Eugenio Scalfari, in cui il grande giornalista ripercorre la carriere
politica di Berlinguer, commenta gli eventi di quegli anni ma racconta anche il
rapporto personale che ebbe con il leader di Botteghe Oscure. Questione morale,
compromesso storico ed eredità politica: Eugenio Scalfari parla del segretario
del Pci. L'intervista di Denise Pardo. Poi Chiara Valentini ricostruisce gli
anni giovanili di Berlinguer, dal primo arresto in Sardegna all’incontro con
Togliatti fino alla scalata al vertice del partito. Quindi Paolo Franchi
analizza la strategia del compromesso storico mentre Marco Damilano firma un
intervento sull’eredità politica di Berlinguer. L’ampia sezione centrale del
libro è poi dedicata agli articoli di ieri, con una carrellata di grandi pezzi
e grandi firme tra cui Livio Zanetti, Nello Ajello, Eugenio Scalfari, Giorgio
Bocca, Gianni Corbi, Paolo Mieli, Lucio Colletti, Ernesto Galli della Loggia,
Giampaolo Pansa. A chiudere una sezione “pop”, con le copertine che il
settimanale ha dedicata a Berlinguer e una trentina di straordinarie tavole di
Pericoli e Pirella, tutte con il leader politico come protagonista, più un quiz
divertito e divertente su Berlinguer, apparso nel 1972 sull’”Espresso colore”.
San Berlinguer martire e
apostolo.
È in atto la
costruzione di un Mito, l'invenzione di un Grande. Serve a nobilitare il
comunismo passato. A deprecare il presente renziano, scrive Marcello Veneziani
su “Il Giornale”. San Berlinguer, il Terzo Santo. Dopo i film, i libri, gli
inserti, ora un largo Berlinguer al centro di Roma e la canonizzazione
proclamata da Napolitano in un libro-intervista, Quando c'era Berlinguer,
curato da Veltroni. È in atto la costruzione di un Mito, l'invenzione di un
Grande. A cosa serve? A nobilitare il comunismo passato. A deprecare il presente
renziano. A rianimare un partito spaesato. A cercare nel vintage un titolo di
nobiltà. A rifarsi le labbra col silicone moralista. A lanciare qualcuno per il
Quirinale. Berlinguer non aveva la statura di Togliatti e, quanto a svolte, fu
più ardito Occhetto, seppur col favore dei muri crollati. Berlinguer era
modesto, per lunghi anni allineato anche ai più sordidi eventi, mestamente
comunista, non lasciò tracce importanti, si oppose alla socialdemocrazia e la
storia gli dette torto, considerò il Partito come l'Assoluto. Fu una persona
onesta, per bene, ma basta la sua decorosa mediocrità per farne un santo con
relativa agiografia? In realtà, tramite la copiosa apologetica su di lui, si
vuol celebrare il popolo di sinistra. Berlinguer è un pretesto narrativo per
santificare gli eredi. L'industria del santino che abbina il leader del Pci a
Papa Francesco (Scalfari dixit) è all'opera. Rischiamo un pantheon di fuffa, tra
finti eroi e finti geni, finti grand'uomini e palloni gonfiati, sfornati dalla
Ditta Tarocco che produce falsi d'autore. Il P.C. oggi si traduce con
Politically Correct. Finite le sciagurate illusioni, la sinistra passò
all'illusionismo.
La beatificazione di
Berlinguer sempre fedele a Stalin,
scrive Mario Cervi su “Il Giornale”. Un supplemento di 100 pagine dell'Unità,
convegni e dibattiti, o fervidi elogi del mondo politico, gli applausi dei
grillini: per i trent'anni dalla morte di Enrico Berlinguer il ricordo prende i
connotati della venerazione se non della santificazione laica. Omaggi più che
meritati se si riferiscono all'uomo. Che fu onesto, intelligente, riservato in
un mondo di ciarlatani, gran lavoratore. Per dirlo in sintesi una persona per
bene. Il culto per lui di chi ha nostalgia dal Partito (...) (...) comunista
italiano e alimenta ancora speranze in fulgide sorti progressive della sinistra
è non solo giustificato ma doveroso. Perché riguarda chi fu comunista
nell'essenza e in tutte le implicazioni del termine. E lo restò sfidando i fatti
e le e delusioni con la tenacia indomabile dei credenti. Gian Carlo Pajetta
disse, con il sarcasmo d'obbligo, che «si iscrisse giovanissimo alla direzione
del Pci». Lasciando con questo intendere che il ragazzo di buona famiglia
borghese fosse stato agevolato nello scalare la Nomenklatura delle Botteghe
Oscure. Un raccomandato. In effetti l'ascesa di Berlinguer ai vertici comunisti
ebbe l'avallo di Palmiro Togliatti che ai compagni altolocati indirizzò un
biglietto così concepito: «Questo è il compagno Berlinguer che viene dalla
Sardegna. Utilizzatelo nella vostra organizzazione». In verità, pur con
l'iniziale e potente spinta di Ercoli, la successione di Togliatti e di Longo
gli spettava di diritto: per le sue qualità e per la sua ortodossia ideologica.
Alla valanga di articoli di questi giorni ne aggiungo uno mio. Con l'ambizione
di non voler offendere una memoria, ma anche di non aggiungermi ai gloria
imperversanti. Il primo incarico di gran rilievo del ragazzo sardo fu la guida
della Federazione giovanile comunista italiana. Il che gli dava accesso ai sommi
uffici, compreso quello del sommo tra i sommi, il Migliore. Al rispetto delle
gerarchie ci teneva molto. Gli era stato assegnato un segretario particolare,
Mario Pirani, (ora editorialista di Repubblica), e s'era accorto che Pirani
sfogliava prima di lui la mazzetta dei quotidiani. «Dice con piglio da dirigente
- cito dalla biografia di Chiara Valentini - che il primo a sfogliarli vuole
essere lui». Non era incline all'ironia e nemmeno alle confidenze. Aveva da poco
compiuto i 24 anni - attingo di nuovo al saggio citato - quando andò per la
prima volta in Unione Sovietica con una delegazione di giovani partigiani.
Rimase estasiato. Ripeteva in ogni discorso che «la gioventù sovietica felice
canta nelle piazze la sua canzone preferita, Com'è bello vivere nel Paese dei
Soviet». Ammirava sconfinatamente Stalin che ebbe la fortuna - almeno lui la
ritenne tale - di incontrare. Togliatti era il Maestro: da lui aveva mutuato il
vezzo d'indirizzare bigliettini in inchiostro verde ai collaboratori. Alla fine
del viaggio russo fece firmare dalla delegazione un documento unitario che
esaltava le conquiste e le libertà dello stalinismo. Al ritorno a Roma ci fu chi
ebbe l'audacia di chiedergli qualcosa sulle donne russe, su come si vestivano,
su come si truccavano. La risposta può essere collocata nella casistica del
fanatismo quasi delirante. «Nel Paese del socialismo le donne non hanno bisogno
di nessun orpello per attrarre gli uomini. In Urss non ci sono donne. Ci sono
compagne sovietiche». Sciocchezze d'un ventenne, si dirà. Invece quel ventenne
non era per niente sciocco, era un apparatchik inflessibile che nella sostanza
rimase tale fino all'ultimo, quando un malore lo uccise e Sandro Pertini
presidente della Repubblica, tanto si agitò da dare l'impressione che
protagonista del funerale fosse lui. Ebbe anche nell'abbigliamento e nel
linguaggio tratti da asceta. In un suo volumetto Dietro la vetrina a Botteghe
oscure, il vecchio militante Fidia Gambetti, messo a dirigere la biblioteca di
Rinascita a Roma, così scrisse: «Da Bologna ritorna vincitore Berlinguer, unico
e naturale successore di Togliatti e di Longo. Con il suo aspetto sofferente di
sempre, più piegato che mai sotto gli sfuggenti colli del soprabito e della
giacca. Se dovessi dare un giudizio non potrei che rispondere non lo conosco.
Non ha mai messo piede in libreria. Il primo a comparire è il grande sconfitto,
Napolitano, sereno e signore come sempre». Ho indugiato su questi aspetti
marginali della vita di Berlinguer non per sminuirlo ma per collocarlo sul podio
che gli spetta e che a mio avviso è quello d'un conformista preparato e anche
illuminato, non quello degli innovatori. Fu preso a rimorchio dai cambiamenti,
talvolta rassegnandosi a malincuore. Anche gli strappi che gli sono valsi inni
d'ammirazione erano tutto sommato prudenti e inevitabili. Non si rese mai conto
del baratro verso il quale il comunismo si stava avviando, o se si rese conto lo
tenne per sé. Ha scritto Alfredo Reichlin nell'inserto dell'Unità: «È vero, noi
non fummo liberaldemocratici. Non avevamo letto i libri dei politologi americani
e a Botteghe Oscure del modello Westminster non si parlava». Concesso. Ma la
straordinaria vittoria del capitalismo sul comunismo che già era nell'aria non
derivava dalla genialità dei politologi, derivava dal disastro di un'utopia
tirannica. Berlinguer non sarebbe stato un tiranno. Probabilmente dei tiranni in
cui aveva fiducia sarebbe stato vittima. Dopo averli osannati. A Berlinguer
viene accreditato l'aver posto la «questione morale». Credo fosse sincero nel
metterla sul tappeto. Credo anche che con la sua condotta privata si sia
dimostrato degno della battaglia contro la corruzione. Non lo fu come massimo
dirigente del Pci foraggiato e mantenuto dall'Urss. Personalmente accredito a
Enrico Berlinguer, senza distinguo, la scelta della fermezza dopo il sequestro
di Aldo Moro e la strage della sua scorta. La scelta arrivò dopo un lungo
flirtare del Pci con le frange eversive della sinistra. Ma fu una scelta decisa.
Molti anche oggi spiegano che il negoziato con i terroristi assassini sarebbe
stato la via migliore per salvare la vita del leader democristiano. Io ritengo
che una trattativa svolta ignorando il sacrificio di cinque servitori dello
Stato sarebbe stata ignobile.
Berlinguer, anatomia di una
sconfitta.
Il libro di Claudia Mancina analizza la criticamente l'attività del leader di
Botteghe Oscure, scrive “Europa Quotidiano”. Claudia Mancina ha vissuto
dall’interno i travagli del Pci e cerca in questo veloce ma denso volumetto (Berlinguer
in questione, edito da Laterza, 2014) di sviluppare un bilancio critico
molto argomentato della leadership di Enrico Berlinguer. Ne esce fuori un
ritratto molto simile, quasi identico, a quello delle memorie sull’Italia
dell’ex-ambasciatore francese Gilles Martinet, inviato a Roma nel 1981.
Berlinguer appare «più umano, più autentico, più comunicativo» di Palmiro
Togliatti, al punto che ciò «lo rese accetto anche a chi non avrebbe mai votato
comunista», essendo peraltro alla guida di un partito che dopo il dissenso sulla
Cecoslovacchia aveva espanso i suoi consensi nei ceti medi urbani, specie
giovanili. Eppure, se quelle erano le premesse personali, il bilancio
strettamente politico è quello di una sconfitta: al di là delle diverse
strategie (dal compromesso storico alla regressione neo-identitaria successiva)
Berlinguer elude l’unica possibile opzione, quella della trasformazione
esplicita in una moderna forza inserita nel socialismo europeo, ossia dentro
l’orizzonte dell’economia di mercato. Volendo mantenere un riferimento
rivoluzionario (anche se i contenuti con cui esso si identifica si modificano,
dall’ammirazione per l’Urss si passa a una sorta di diversità etica, di ripulsa
morale per la società dei consumi lontana dall’apertura modernizzante del
marxismo) ma al contempo anche delineare una prospettiva credibile di accesso al
governo, la soluzione consiste nell’idea di farsi legittimare da un sistema di
alleanze. Come, nonostante le differenze e gli accenti, la elude la prospettiva
“comunista e riformista” rivendicata ancora qualche mese fa da Emanuele Macaluso
nel suo ultimo libro, in alternativa all’opposta ricostruzione di Enrico
Morando. In questo senso è la storia politica del Pci, come sostengono Mancina e
Morando, ad essere tramontata come tale nel segno della sconfitta, al di là
delle energie che essa ha liberato dopo quella sconfitta. Da qui il rapido
declino che si manifesta subito dopo la sua scomparsa, che lascia in eredità il
referendum sulla scala mobile, voluto non per ragioni di contenuto ma per
difendere il potere di veto del proprio partito. Un’impostazione che si riflette
sulle questioni elettorali e istituzionali dove paradossalmente un partito di
sinistra, che dovrebbe essere in astratto preoccupato di garantire forza ai
governi per riequilibrare le disuguaglianze sociali, finisce per difendere a
lungo regole iper-garantistiche varate nel periodo della frattura verticale
della Guerra fredda. Anche il Pci, insieme alle forze di maggioranza,
contribuisce quindi attivamente all’esito catastrofico del primo sistema di
partiti, che nel suo insieme, come nota Pietro Scoppola richiamato da Mancina,
non riesce a uscire da quella sorta di grande coalizione anomala che era la
solidarietà nazionale per giungere ad una fisiologica democrazia dell’alternanza
europea, come avrebbe voluto Aldo Moro. Alla fine Mancina ci propone un
paradosso: la personalità politica che più ha insistito per una continuità
ideale con alcuni aspetti di Berlinguer, Walter Veltroni, è quella che si è più
battuta per una trasformazione post-ideologica, per un nuovo centrosinistra a
vocazione maggioritaria che non avesse bisogno di protesi centriste; viceversa
la persona più critica con Berlinguer in nome di una visione realistica della
politica, D’Alema, rivendicando orgogliosamente la continuità con la storia del
Pci ha poi sempre voluto alleati centristi per accedere al governo. Alla fine,
però, la mutazione molto netta del centrosinistra è arrivata, dando ragione alla
frase di Aldo Moro che Mancina premette: «Perché qualcosa cambi, dobbiamo
cambiare anche noi».
QUANDO IL CAPO ERA QUASI
SACRO. Nel
dicembre del 1977, all'indomani di una grande manifestazione di metalmeccanici,
sulla prima pagina di Repubblica Giorgio Forattini disegnò il Segretario, o
meglio il Segretario Generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer
che adagiato in vestaglia su una poltrona sorbiva una tazza di tè incurante
delle grida che gli giungevano dalla finestra di casa sua, scrive Filippo
Ceccarelli su “Il Corriere della Sera”. Si trattava appunto di una vignetta.
Senonché il giorno dopo lo storico ufficiale del Pci Paolo Spriano scrisse a
Repubblica una sdegnatissima lettera chiedendo conto ai responsabili del
misfatto: «Ma avete idea della vita di sacrificio, di passione rivoluzionaria,
di tensione politica e morale di un dirigente comunista come Berlinguer?».
Contro la caricatura prese posizione anche Trombadori e persino Fortebraccio,
mentre Pajetta decretò che non faceva ridere. Nel rispondere a tutti, Eugenio
Scalfari osservò che per i compagni Berlinguer era considerato «poco meno che
l'Immacolata Concezione». Il richiamo dogmatico e dottrinario aiuta a
comprendere in che modo quella carica fosse allora vissuta nel partito.
Nell'immaginario comunista la figura del segretario non solo era per sua natura
sottratta alla competizione, ma specialmente e letteralmente incarnava la
Razionalità della Storia. Anche per questo un'atmosfera mistico-magico già
aleggiava intorno a Togliatti, la cui guardia del corpo Armandino pretendeva che
mangiasse ogni giorno un piatto di cervello perché doveva «pensare a tutti noi»;
così come il suo medico personale, Spallone, si preoccupava anchea livello
organizzativo della vita sessuale del Migliore per evitare «che la tensione
affettiva, se contrastata, impedisse alla mente di Togliatti di ragionare con la
lucidità che gli era propria e ai suoi nervi di essere meno saldi del
consentito». E tuttavia con lo scorrere del tempo quest'aura al tempo stesso
corporeae sacrale, venne meno e nel 1986 l'inserto satirico dell' Unità, Tango,
raffigurò il povero Natta, allora in carica che ballava nudo al suono della
fisarmonica di Craxi. Quest'ultimo ne fu piuttosto impressionato. Nessuno a via
del Corso si sarebbe mai spinto a tale dileggio. Rispetto alla separatezza che
persino nelle dislocazioni logistiche informava l'intangibile solitudine dei
capi alle Botteghe Oscure, il vertice del Psi era da sempre più libero,
provvisorio, litigioso e sgangherato. Il "Vecchio", cioè Nenni, era persona
amabile e tollerante; e la guerra permanente fra Mancini e De Martino aveva
finito per insediare una specie di rispettosa alternanza con tanto di
stratificazioni. Craxi al contrario instaurò un cesarismo piuttosto prepotente,
forse necessario alla guerra di corsa, ma di certo basato sulla paura e sul
conformismo. Rimase segretario anche a Palazzo Chigi, lasciando che nel partito
crescessero ambizioni e appetiti, cacicchi e ladroni. Del resto anche La Malfa
senjor, Saragat, Malagodi e Almirante ebbero personalità così forti da oscurare
sia avversari che re travicelli di Pri, Psdi, Plio Msi. Caso tutto diverso
quello dei segretari della Dc. Qui occorrevano indispensabili requisiti, il
primo dei quali era il favore delle gerarchie ecclesiastiche; il secondo
imponeva una situazione coniugale regolare e il terzo una teorica
indisponibilità al comando (« Domine non sum dignus ») temperata da spirito di
servizio. Eletto primus inter pares, e tuttavia investito del maggior potere
possibile, il segretario dc era in realtà in quel posto come garante del
governo, delle alleanze, delle oligarchie, delle corporazioni, dei gruppi
collaterali, dei territori, delle correnti, della tribù. Per cui ogni tanto
veniva fatto secco ma non per sempre, un po' come succede nel Pd - ma con molta
più fantasia e perizia.
SIAMO TUTTI PUTTANE.
E Gesù sposò Maddalena: non
è Dan Brown, ma un codice del 570 d.C.
Scritto in siriaco su pergamena sarà presentato domani alla British Library,
scrive Vittorio Sabadin su “La
Stampa”. Un altro tassello fortifica la ancora
traballante tesi che Maria Maddalena fosse la moglie di Gesù e la madre dei suoi
figli. Un libro scritto nel 570 in siriaco su pergamena, e ora custodito alla
British Library, racconta una storia diversa da quella dei quattro Vangeli
canonici, molto più vicina - come si è affrettata a ironizzare la Chiesa
d’Inghilterra - al Codice da Vinci di Dan Brown. Ma il numero di antichi
documenti che conferma questa tesi continua a crescere, e decine di seri
studiosi vi si stanno dedicando senza pregiudizi. Domani la stessa British
Library terrà una conferenza stampa, e si conosceranno altri dettagli. Il libro
proviene da un monastero egizio ed era stato acquistato nel 1847 dal British
Museum. Probabilmente si tratta di una traduzione dall’aramaico di un testo più
antico. Redatto in 29 capitoli, racconta la storia di Joseph, un giovane molto
noto all’epoca, conosciuto dall’imperatore Tiberio e dal faraone d’Egitto (forse
Natakamani), che lo considerava figlio di Dio. A 20 anni Joseph va in sposo ad
Aseneth, che gli dà due figli: Manasseh ed Ephraim. Simcha Jacobovici,
giornalista investigativo israeliano che scrive anche sul New York Times,
e Barrie Wilson, professore di ricerche religiose a Toronto, hanno studiato per
sei anni il manoscritto e raccolto le loro deduzioni nel libro The Lost
Gospel, il vangelo perduto. In una delle prime pagine dell’antico testo il
misterioso autore avverte che tutto quello che segue è scritto in un codice che
va interpretato. I riferimenti cristiani contenuti nelle pagine sarebbero però
così tanti che non è necessario essere Robert Langdon per capire che i nomi di
Joseph e Aseneth nascondono quelli di Gesù e Maria Maddalena. Nel testo si narra
che alla donna, dopo la morte del marito, viene somministrata l’eucarestia, «il
pane e il calice della vita». Gli unici quattro Vangeli autorizzati dalla Chiesa
dopo le riforme di Costantino non raccontano nulla della vita di Gesù tra la sua
infanzia e l’età matura, un periodo nel quale, per un «rabbi», sarebbe stato
obbligatorio sposarsi. Ma la storia di Joseph e Aseneth sarebbe raccontata anche
in altri manoscritti, sopravvissuti alla sistematica distruzione dei Vangeli
apocrifi solo grazie al fatto che celavano la vera identità dei due sposi. Anche
il testo della British Library non sembra però sfuggito alla censura: alcune
pagine sono state vistosamente strappate via. Due anni fa la docente di Harvard
Karen L. King aveva annunciato la scoperta di un frammento di papiro in copto di
uno di questi testi perduti, nel quale si legge: «E Gesù disse loro: mia
moglie…». Ma secondo Jacobovici e Wilson basta anche solo scorrere i Vangeli di
Marco, Luca, Matteo e Giovanni per convincersi che Maddalena aveva un ruolo di
primissimo piano accanto a Gesù. Assiste alla crocifissione, alla sepoltura e
alla scoperta della tomba vuota. Lava il corpo del Cristo, cosa consentita solo
alle mogli o ad altri uomini, ed è la prima persona alla quale Gesù si rivolge
dopo la resurrezione. Il sentimento popolare, soprattutto in Francia, non ha
avuto bisogno di aspettare Dan Brown per venerare Maria di Magdala come la
seconda donna più importante del Cristianesimo dopo la Vergine Maria, nonostante
papa Gregorio Magno l’avesse bollata nel 590 come una prostituta, commettendo un
vistoso errore - forse meditato e voluto - di interpretazione dei testi
canonici. Per secoli è stata ritratta dai grandi maestri, da Tiziano a
Caravaggio a Canova, come una penitente afflitta dai suoi peccati: che sia stata
o no la moglie di Gesù, era un destino che non meritava.
Maria Maddalena.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Maria Maddalena o di Magdala
è stata, secondo il Nuovo Testamento, una donna discepola di Gesù; è venerata
come santa dalla Chiesa cattolica, che celebra la sua festa il 22 luglio. La sua
figura viene descritta sia nel Nuovo Testamento che nei Vangeli apocrifi, ma non
è citata in altre fonti. Il nome Maddalena deriva da Magdala, una piccola
cittadina sulla sponda occidentale del Lago di Tiberiade, detto anche di
Genezaret. Le narrazioni evangeliche ne delineano la figura attraverso pochi
versi, facendoci constatare quanto ella fosse una delle più importanti e devote
discepole di Gesù. Fu tra le poche a poter assistere alla crocifissione e,
secondo alcuni vangeli, divenne la prima testimone oculare dell'avvenuta
resurrezione. Maria Maddalena è menzionata nel Vangelo secondo Luca (8:2-3) come
una delle donne che «assistevano Gesù con i loro beni». Secondo tale vangelo,
esse erano spinte dalla gratitudine: proprio da Maria di Magdala «erano usciti
sette demòni». Costoro finanziavano personalmente la missione itinerante del
Maestro. Secondo la tradizione, era una della tre Marie che accompagnarono Gesù
anche nel suo ultimo viaggio a Gerusalemme (Matteo 27:55; Marco 15:40-41; Luca
23:55-56), dove furono testimoni della crocifissione. Maria rimase presente
anche alla morte e alla deposizione di Gesù nella tomba ad opera di Giuseppe di
Arimatea. «Stavano
presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di
Cleofa e Maria di Màgdala.» (Giovanni
19,25) Fu ancora lei, di primo mattino
nel primo giorno della settimana, assieme a Salomè e Maria la madre di Giacomo
il Minore, (Matteo 28:1 e Marco 16:1-2, oltre che nell'apocrifo Vangelo di
Pietro 12), ad andare al sepolcro, portando unguenti per ungere la salma. Le
donne trovarono il sepolcro vuoto ed ebbero una "visione di angeli" che
annunciavano la risurrezione di Gesù (Mt 28:5). «Nel
giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino,
quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro...
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e
anche ciò che le aveva detto.» (Giovanni
20,1;20,18) Maria Maddalena, divenuta
così prima testimone della resurrezione, corse a raccontare quanto accaduto a
Pietro e agli altri apostoli, (Giovanni 20:1-2), guadagnandosi l'appellativo di
"apostolo agli apostoli". Ritornata immediatamente al sepolcro, si soffermò
piangendo davanti alla porta della tomba. Qui il "Signore risorto" le apparve,
ma in un primo momento non lo riconobbe. Solo quando venne chiamata per nome fu
consapevole di trovarsi davanti Gesù Cristo in persona, e la sua risposta fu nel
grido di gioia e devozione, "Rabbunì", cioè "maestro buono". Avrebbe voluto
trattenerlo, ma Egli glielo proibì e le disse: «Non
mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre mio; ma va' dai miei
fratelli e dì loro: Sto ascendendo al Padre mio e al Padre vostro, al Mio Dio e
al vostro Dio» (Giovanni 20:17).
Identificazione di Maria
Maddalena con la peccatrice penitente.
La figura di Maria di Magdala è stata identificata per lungo tempo con altre
figure di donna presenti nei vangeli: alcune tradizioni accostano la figura di
Maria Maddalena a Maria di Betania, la sorella di Marta e del risorto Lazzaro
(Lc 10:38-42 e Gv 11:1-45) e alla peccatrice che unge i piedi a Gesù a casa di
Simone il Fariseo, probabilmente a Nain, in Galilea:
«Ed, ecco, una donna in città, che era una
peccatrice, quando lei seppe che Gesù sedeva nella casa dei Farisei, portò una
scatola di unguento, e si levò in piedi ai suoi piedi dietro lui piangendo, e
iniziò a lavare i suoi piedi, e li pulì con i capelli della sua testa, e baciò i
suoi piedi, e li unse con l'unguento.» (Luca
7:36-50) L'accostamento avviene poiché
entrambe le donne (per intendersi, Maria di Betania e la peccatrice) lavano i
piedi al Cristo e gli ungono il capo con il profumo, nel caso di Maria di
Betania, il fatto avviene a casa di Simone il lebbroso, a Betania, in Giudea (Gv
12:1-11 - Mt 26:6-13) e l'episodio della peccatrice avviene in casa di uno di
cui si dice che era un Fariseo di nome Simone. L'ipotesi che si tratti di due
distinte figure è sostenuta dai seguenti particolari: l'unzione dei piedi di
Maria appare verso la fine della vita pubblica di Gesù, quella della peccatrice
non è specificato; Non è assolutamente assodato che Maria di Betania e Maria
Maddalena siano la stessa persona. A sostegno dell'ipotesi che si tratti invece
della stessa figura si può invece ricordare che: nel caso di Maria, Gesù è il
festeggiato di una cena in casa di Simone il lebbroso, nel caso della peccatrice
Gesù è in casa di uno che si chiama Simone; è molto improbabile che per due
volte in due luoghi differenti Gesù sia stato unto con una quantità di olio di
nardo avente esattamente lo stesso valore (Mc 14:5 e Gv 12:5) e che per due
volte questo abbia dato luogo alle stesse pesanti critiche da parte dei
presenti. In altri casi gli evangelisti sono in disaccordo su tempi e luoghi di
eventi (es. i due racconti della natività in Matteo e Luca, le differenze nel
giorno della crocifissione tra Giovanni e i sinottici e altri ancora). Più di
una volta il Nuovo Testamento mostra imbarazzo e reticenza nei confronti delle
persone che hanno stretti legami con Gesù (es. l'improvvisa menzione della
leadership di Giacomo, "il fratello del Signore" (Ga 1:19), negli Atti (At
12:17, At 15:13), non preceduta da alcuna spiegazione o introduzione pur essendo
essa ampiamente attestata dai più importanti scrittori cristiani antichi,
Origene, Eusebio, San Girolamo, Pseudo-Clemente e anche da non cristiani come
Giuseppe Flavio. Il comprensibile imbarazzo degli evangelisti di fronte agli
elementi che indichino l'accoglimento da parte di Gesù delle aspettative di
regalità terrena su di lui appuntate dalla popolazione ebrea. L'unzione è, in
tal senso, il più caratteristico di essi. Se anche il senso teologico dei due
episodi è diverso in Giovanni rispetto ai sinottici, si deve ricordare che
l'autore del quarto Vangelo mostra non di rado la tendenza a subordinare il
racconto degli eventi a esigenze teologiche. Nel situare, p.es., a differenza
dei sinottici, la morte di Gesù al momento del sacrificio pasquale, Giovanni
tende ad asserire l'identificazione tra Gesù e la vittima del sacrificio.
Ancora, nel fornire il particolare, unico rispetto ai sinottici, della ferita al
costato da cui esce sangue e acqua, Giovanni allude alla natura kosher della
vittima. In entrambi i casi le implicazioni teologiche dei particolari sono così
evidenti da non poter essere ignorate nell'analisi delle discordanze tra
Giovanni e i sinottici. Maria viene inoltre scambiata per l'adultera salvata da
Gesù dalla lapidazione (come raccontato nella Pericope Adulterae) in Gv
8:1-11. In questo caso non ci viene tramandato nemmeno il nome della donna e
l'identificazione probabilmente avviene solo per analogia con il caso
precedente. L'accostamento tra Maria Maddalena e l'adultera redenta risale in
realtà al 591, quando il papa Gregorio Magno, basandosi su alcune tradizioni
orientali, in un suo sermone identificò le due figure. L'identificazione di
Maria Maddalena con Maria di Betania o con la peccatrice è stata infine
esplicitamente ridiscussa dalla Chiesa cattolica nel 1969 (dopo il Concilio
Vaticano II). Tuttavia, era comune nell'esegesi medievale, e per antichissima
tradizione anche oggi, tanto che la figura della Maddalena peccatrice fu
inserita accanto a quella del Buon Ladrone nella sequenza del Dies irae
(utilizzata nella liturgia cattolica tradizionale dei defunti): «Qui Mariam
absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti.» A seguito della
revisione post-conciliare il testo della sequenza è stato ritoccato ma non è
stato ritoccato nella cosiddetta: Messa in latino, che ancora lo mostra integro:
«Peccatricem qui solvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti.» La
stessa identificazione è rifiutata dai protestanti. Invece, nel cosiddetto
Vangelo di Maria Valtorta, di poco anteriore al Concilio Vaticano II, la figura
di Maria Maddalena è chiaramente identificata con quella di Maria di Betania e
la peccatrice pentita. A causa di queste sovrapposizioni tra le varie figure dei
Vangeli, Maria Maddalena divenne un simbolo di pentimento e divenne patrona di
varie istituzioni che si occupavano della gioventù femminile, come l'Ordine di
Santa Maria Maddalena o le congregazioni delle maddalene di Lubań e Torino. Il
suo nome fu anche usato per le Case Magdalene in Irlanda, conventi che
ospitavano ragazze inviate dalle famiglie o dagli orfanotrofi: l'ultima case
Magdalena in Irlanda è stata chiusa nel 1996. Tuttavia l'identificazione di
Maria Maddalena con la prostituta rimane ancora viva nella tradizione popolare.
Come già accennato, ad esempio, in vari film che narrano di Gesù, Maria
Maddalena viene effettivamente identificata con una prostituta, come in Mel
Gibson, La passione di Cristo e nel film ispirato al romanzo di Nikos
Kazantzakis L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese.
Le lucciole a Roma? Le
hanno portate i papi.
Al tempo del Papa re a Roma c'era una quantità impressionante di
prostitute, scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale”. È curiosa l'idea che
Ignazio Marino si è fatto di Roma e del suo compito di sindaco. Nessuno dei
problemi veri che vive Roma lo sfiora realmente: in compenso si occupa
d'incalzare governo e Parlamento sui gay e le prostitute. Incurante della
Cassazione, dei prefetti e delle leggi, il sindaco de Roma insiste a occuparsi
della sfera sessual-affettiva dei romani anziché di quella civica e urbana. E
lottizza la città destinando alcune aree a sorbirsi i rom, con relativo aumento
di furti, e altre a subire il racket di prostitute. È un modo generoso di
mandare una città a puttane. L'idea ha spaccato l'opinione pubblica e ha diviso
al loro interno sinistra e destra. In tema di puttane però, lasciate che io
spezzi una lancia in favore del sindaco marziano: il modello di riferimento per
la zona a luci rosse non è Amburgo, Amsterdam o Bangkok, ma è la Roma dei Papi.
Al tempo del Papa re c'era infatti a Roma una quantità impressionante di
prostitute, c'erano accorsati lupanari e strade apposite (una ha ancora il nome
di un tempo, via delle zoccolette). Perché la prostituzione era considerata dai
cattolici di mondo una valvola di sfogo per l'esuberanza maschile (cardinali
inclusi) e per salvaguardare la durata dei matrimoni. Mejo 'na mignotta che
n'amante diceva la morale papalina - bollata come cazzolicesimo, da licet, è
permesso - e discendeva nientemeno che da S. Agostino e S. Tommaso. Insomma del
quartiere a luci rosse o Mignottown possono lamentarsi tutti, a partire dai
residenti, meno i preti e santa romanesca chiesa.
Storie di puttane: 10 libri
che parlano del mestiere più antico del mondo, scrive Valeria Merlini
su “Panorama”. Una vera e buona puttana non ama che il piacere (Anonimo, La
Cauchoise, ou Mémoires d'une courtisane célèbre, 1784). La letteratura è colma
di storie in cui le protagoniste sono “signore del piacere”. Per scelta,
per fatalità o per sventura. Moderne, lontane dal nostro presente, incastonate
in pezzi di storia ormai trascorsa. La parola “prostituzione” deriva dal
latino "pro statuere" che significa mettere in mostra, esporre;
nell'uso comune ha preso il significato di prestazione sessuale a scopo di
lucro. È senza dubbio un mestiere praticato da migliaia di anni: una volta
erano le cortigiane, ma anche le favorite, quindi semplici puttane, ora le
escort, tutte a praticare quello meglio conosciuto come il mestiere più antico
del mondo. Da Messalina a Veronica Franco, da Emma Hamilton alla Bella Otero.
Senza andare così lontano nel tempo, qui di seguito troviamo una selezione dei
migliori romanzi recenti le cui protagoniste raccontano la loro storia composta
sempre e comunque da una clientela quanto mai varia (ed avariata).
Puttana di Nelly Arcan
Gremese, 2014 – (192 pagine).
Nella camera del grande edificio di Montréal in cui svolge la sua professione,
una prostituta aspetta tra un cliente e l’altro. L’attesa si nutre di ricordi e
i ricordi danno voce all’incalzante, impudica confessione con cui Cynthia – è il
suo nome da puttana – si racconta ai lettori. Nella scrittura disperata, con
lunghi periodi inframmezzati da virgole come sospiri, come gemiti di un coito,
la giovane Nelly Arcan, morta suicida nel 2009, riversa tutto il suo disgusto,
tutto lo squallore che la circonda, tutta la sua inquietudine per un’esistenza
lasciata trascorrere mentre la morte aspetta dietro l’angolo.
La favorita di Leda
Melluso
Piemme, 2014 – (378 pagine).
1580. Isabella, che tutti chiamano "la Castigliana", non avrebbe mai lasciato la
Spagna per trasferirsi a Palermo se non per amore. Peccato che l’uomo che le
aveva promesso amore eterno si è poi rifugiato in un matrimonio di convenienza.
Fu così che Isabella, rimasta sola e senza possibilità di sostentarsi, imboccò
l’unica via possibile: divenne una cortigiana. Da cortigiana a concubina per
fuggire al Tribunale dell’Inquisizione il passo fu breve.
Storia di una puttana di
Adele Carrion
Lite editions, 2013.
Kris è una donna
contemporanea. È molto bella, giovane e disinibita. Ama il sesso e non ha nessun
pudore. Per questo e per amore dei soldi ha deciso di fare la prostituta. Vende
il suo corpo a clienti di alto livello e non si tira mai indietro anche di
fronte a richieste poco convenzionali. Nella sua vita così ben organizzata
qualcosa però s'incrinerà e la costringerà a fare i conti con effetti
collaterali non prevedibili.
Sette diavoli di Marco
Archetti
Giunti, 2013 – (192 pagine).
Egle Petrillo ha dodici anni,
perde i genitori durante la guerra e uno zio sconosciuto prende lei e il
fratello che ha difficoltà di apprendimento con sé trascinando entrambi in
un’altra città. Per lei, finita la seconda guerra mondiale, comincia la guerra
personale. Fuggirà da quella casa, verrà inseguita, fuggirà ancora. Il vicolo la
ingoierà e diventerà una prostituta, sarà allora Sette diavoli per tutti. Ma a
quel punto ci saranno ancora molti conti da regolare. Il romanzo racconta la sua
vendetta, la sua sfida mettendo Dio sotto accusa, il suo riscatto.
Selvaggia di Leonardo
Belmonte
Arduino Sacco editore, 2013 – (340 pagine).
Primi anni del 1900. Un’epoca fatta di fatica, sudore, pane sazio di dolore,
femmine silenziose, uomini senza onore, con altrettanti maschi, in attesa
dell’onore. Un’epoca che dava poco spazio all’essere di donna, cui era
consentito solo dare mute risposte a doloranti domande. Risposte silenziose, con
un altrettanto cenno à capo basso, solo questo era concesso loro, alle decisioni
prese, dell’essere maschile che imponeva lo zittire. Per la donna, assai penosa
e dolorante era partorire una figlia femmina considerata senza alcun valore, sé
non quello restante di un villan allargar di cosce.
Quasi mai di Daniel Sada
Del
Vecchio, 2013 – (448 pagine).
La Seconda Guerra Mondiale è appena finita e Demetrio Sordo, un giovane agronomo
di inconsistenti ambizioni è preso da una novità: il sesso a pagamento nei
bordelli. Proprio in uno di questi, sviluppa una passione per Mireya: è lei
l’unica prostituta che desidera, e per averla ogni giorno pagherà una tariffa
extra e sarà costretto a chiedere un aumento di stipendio. In breve la sua vita
sembra esaurirsi in questa relazione fisica. Fino a quando…
Due vite in vetrina di
Martine & Louise Fokkens
Vallardi, 2013 – (208 pagine).
Martine e Louise Fokkens sono sorelle gemelle. Oggi hanno settant'anni, e per
cinquanta si sono messe in vetrina nel Red Light District di Amsterdam.
Abbandonata ogni illusione di una vita romantica, le due gemelle rifiutano di
essere delle vittime e tengono sempre ben saldo in mano il timone della loro
vita. Sono donne forti e, grazie a una notevole dose di ironia, riescono a
vivere il mestiere più antico del mondo proprio così, come un mestiere come un
altro. Dopo 355.000 clienti (stimati), oggi Martine e Louise, protagoniste anche
del film- documentario “Meet the Fokkens”, non si prostituiscono più: colpa
dell'artrite.
Come l’acqua sul fiore
di loto di Hwang Sok-yong
Einaudi, 2013 – (384 pagine).
Lianhua, Fiore di Loto, è il nuovo nome di Shim Chong. A quindici anni, la
giovane viene venduta dal padre a un ricco mercante cinese e inizia la sua
carriera di concubina. Da cortigiana a geisha, da tenutaria di bordello, a
moglie di un potente occidentale, la storia di un apprendistato erotico, e
umano, in un paese ricco di contraddizioni.
Confessioni di una baby
prostituta di Veronica Q
Newton Compton, 2013 –
(pagine).
Veronica ha un passato scabroso. A soli quattordici anni, sconvolgendo
all’improvviso la sua sobria esistenza, entra a far parte di un mondo estremo,
fatto di sesso sfrenato, fiumi di alcol e montagne di droga. In brevissimo
tempo, ribalta completamente tutte le regole che aveva seguito fino a quel
momento. Quelle che dovrebbe rispettare ogni brava bambina cresciuta in una
famiglia dell’alta borghesia romana. Ma Veronica è stanca di essere una brava
bambina, e la sua famiglia, forse, non è poi così perfetta.
Trilocale di plastica di
Petra Hůlová
Baldini & Castoldi, 2013 – (192 pagine).
Una prostituta trentenne esercita il suo mestiere con ferrea disciplina
e finanche un pizzico d’orgoglio, lavorando alacremente alla propria
crescita professionale per tenersi stretta la sua fetta di mercato. In questo
ramo però si fa presto a invecchiare e allora diventa fondamentale «non puzzare
e tenere d’occhio il peso». Teatro delle sue gesta è un trilocale in plastica
– «quello che probabilmente qualcuno chiamerebbe bordello è per me un nido umano
di calore pieno di angolini ricchi di sorprese nascoste» – e il catalogo è
vario: triangoli, incontri a due o di gruppo o ancora numeri acrobatici
che richiedono appositi attrezzi e travestimenti adeguati.
S. Valentino, l'esperimento
sociale: rose alle prostitute.
"C'è chi si ricorda dell'amore solo a San Valentino. E chi l'amore è costretto a
farlo tutto l'anno, contro la sua volontà". Per questo Io Ti Maledico,
specializzato in video virali, ha deciso di portare una rosa alle prostitute nel
giorno della festa degli innamorati. Tra le ragazze in strada, stupite, spunta
però un "protettore" che si scaglia contro il giovane protagonista del filmato
(Maurizio Valente). L'uomo lo minaccia: "O fai sesso o te ne vai". E alla fine
trascina via la prostituta.
Sono puttana e me ne vanto,
scrive Laglasnost su “Al di Là del Buco”.
Mi hanno chiamata puttana. Perché gli ho sorriso
quando mi diceva che avevo un bel culo, gli ho detto si senza aspettare troppo
tempo, mi sono fatta toccare ovunque senza particolari impedimenti, gliel’ho
preso in mano senza guanti sterilizzati da chirurgo e poi l’ho perfino messo in
bocca e non ci eravamo ancora neppure presentati. Mi hanno chiamata troia perché
mi è piaciuto, ed eravamo in un piccolo sgabuzzino ricavato dentro il pub, mi
sono liberata di mutande, reggiseno, gli ho sbottonato il pantalone e mi
sembrava gli piacesse, era felice, lui godeva e devo dire che godevo anch’io. Mi
hanno chiamata sporca perché non ho tenuto a precisare i dettagli della mia
intimità, gli ho solo detto “tiè,
mettiti ‘sto preservativo”
e poi ho sollevato l’anca e l’ho spinto dentro senza indugiare. E se ne avevo
voglia non ho capito perché mai avrei dovuto rifiutare. L’unica cosa della quale
avrei potuto lamentarmi era il fatto che è venuto troppo presto, era eccitato,
c’era da capirlo, allora mi sono toccata e lui mi ha dato una mano, anzi la
lingua, per fare arrivare pure me. Ma come, non lo fermi? Non gli dici niente?
Non vuoi neppure avere un abbraccio, una parola dolce, qualcosa che possa dare
l’illusione di un interesse differente? E dico no, non me ne frega niente. Mi è
piaciuto. Dovessi mai incontrarlo un’altra volta può anche ricapitare. Se gli
sta bene. Se mi sta bene. Ma al momento dirsi ciao e grazie dopo il sesso e
continuare a trascorrere la serata come prima mi sembra la migliore cosa. Mi
hanno chiamata troia perché secondo la mia amica mi sarei comportata come un
maschio. E ho chiesto “un
maschio gode quando scopa? e perché mai non posso farlo anch’io?“.
Mi hanno chiamata puttana perché mi è piaciuto quello che non avrebbe mai dovuto
piacermi. Anzi mi eccita, ancora, solo ripensarci. Perché sono fatta di carne e
di libido e non c’è alcuna morale che possa convincermi del fatto che mi sono
sbagliata. Mi hanno chiamata sporca perché avrei dovuto, come minimo, sperare
che lui mi chiamasse il giorno dopo, a me che non gli ho neppure dato il numero
di telefono, avrei dovuto sospirare, innamorarmi, immaginare di mettere su casa
e fare mille figli con uno con il quale mi è solo piaciuto scopare. Mi hanno
chiamata stronza quando è sembrato che per difendermi dalle accuse ho dato delle
bacchettone e moraliste alle mie conoscenti, quelle che mi hanno vista entrare
con quel tale dentro lo stanzino e poi mi hanno aspettata fuori. Una mi ha detto
“ero
preoccupata… pensavo ti stesse stuprando…“.
Mi hanno chiamata troia perché avessi detto si trattava di uno stupro forse
sarebbe stato meglio, avrei evitato di essere processata perché manco
dell’aspirazione alla santità. E mi chiedevo se esiste regola che imponga alle
donne di sentirsi violate se non rispettano le convenzioni sociali. Io mi
ricordo ancora quelle mani strette, i colpi serrati, il caldo, l’odore, lo
rifarei senza problemi, perché certe volte l’intesa scatta in un momento e di
lui non so cosa mi ha colpito, forse la voce, forse. Ma se dopo il sesso non
proclamo di essere una martire profondamente innamorata, se ben distinguo la
chimica dal sentimento, allora sono un maschio, che per chi è un po’ specista
diventa essere un “animale”, nel senso becero e deteriore di quel termine. Io
troia, io puttana, io animale, io sporca. Perché in fondo c’è una mentalità che
ci vuole un po’ così: stuprate, sofferenti e infelici o se felicemente scopanti
dunque stigmatizzate. Al massimo sposate figlianti, senza eccessiva eccitazione
per gli appuntamenti a letto. Ho fatto sesso consensuale con un tale che non me
l’ha chiesta, io non gliel’ho chiesto, mi è piaciuto e poi non ci siamo mai più
visti. Per la mia amica sono ancora quella che avrebbe avuto un trauma da
piccola ché altrimenti sarei lì a fare la sentimentale con qualcuno. Mi ha
triturato le ovaie con il mio presunto senso di solitudine, ché noi femmine
saremmo diverse, che non è possibile che possa piacerci una cosa così, che per
sentirsi realizzate per davvero le “donne”, e l’ha detta proprio così declamando
teorie al plurale, avrebbero bisogno di sicurezza, stabilità, casa, famiglia,
figli. Le ho detto “stai
serena… a te forse non sarebbe piaciuto ma a me invece si“.
Lo posso dire che se lei trombasse di più e avesse meno moralismi attaccati
sulla pelle forse starebbe meglio e farebbe stare meglio pure me?
Perché vado a puttane, scrive Massimiliano
Maccaus, per la rubrica Cattivi propositi in Facci un salto. Non è che accada
solo per solitudine, e non è neanche roba da sfigati. Perché come in tutte le
cose, anche nel sesso, entrano in gioco mille e mille variabili e generalizzare,
o semplificare, mortifica ogni senso critico.
Si va a puttane
la prima volta per provare, per vedere come si fa, come riesca. Molti ragazzi
s’iniziano così al rapporto sessuale, e non sono tutti brutti o sgorbi, o
timidi, od obesi. Molti sono ragazzi normali, sì come te; sì, proprio come
il tuo ragazzo. Proprio
come tuo
marito.
Tuo padre.
Tuo nonno, che
fa incetta di pillole blu. Non chiederglielo, difficilmente te lo racconterà.
Molti ragazzi s’iniziano così al rapporto sessuale, e non sono tutti brutti o
sgorbi (…) Molti sono ragazzi normali, sì come te; sì, proprio come il tuo
ragazzo. Proprio come tuo marito. Tuo padre. Tuo nonno. Perché il sesso è amore
ma non solo, e dall’amore non è che possa separarsi, nella mente dell’uomo, ma è
da esso
distinto per propria
natura. Un comparto stagno lo divide, e ad unirlo ai sentimenti non resta che
l’immaginazione. La realtà è diversa. Perché nell’incontro con una prostituta
mille cose possono essere eccitanti. Anche la stessa idea di piacergli, o di
non piacergli
affatto. Sì, perché non
dimentichiamolo, il sesso è anche esercizio del
potere,
territorio consacrato ai muscoli e al sudore, alle prese animalesche, alle
forzature, persino talvolta ai feticismi, alle perversioni, alla
violenza.
Che vale anche per le donne, a ruoli inversi, e spesso piace anche a chi la
subisce. I marciapiedi delle metropoli ne son pieni, vedete? E che se ne vuol
dedurre? E’ la
domanda che genera l’offerta.
Lezione zero di macroeconomia. Non si scappa. Se non avessero clienti,
semplicemente ce ne sarebbero poche, e costerebbero di meno. E i padri i mariti
e i fidanzati che bazzicano gli stessi marciapiedi, di giorno e di notte, tutti
i giorni e tutte le notti, a caccia di mercanzia sono centinaia. Tra loro si
conoscono pure, e si riconoscono a distanza. Impiegati comunali, politici,
medici e vari professionisti. Carabinieri e vigili urbani. Senza distinzioni. Io
tra quelli. Quanto
vuoi? Di dove sei? Lo sai che sei carina? Cosa fai? E
che volete che faccia. Si inizia sempre così, come fosse un’intervista. Poi si
va. In auto, in hotel. Bocca
e figa. Due botte e via. E
la si pianti di dire che mettere in affitto il corpo mortifica la dignità delle
donne. La
prostituta esalta in sé l’esser donna,
è la quintessenza della femmilità. Fa del piacere uno stile di vita, e sa
donarsi come ogni donna dovrebbe saper fare. Il mestiere più antico del mondo è
anche il più
gratificante, e spesso pure
il più
remunerativo. Guadagnare e
godere.
Quale indegnità, quale umiliazione. Che poi
non è vero che i papponi le
trattano male. Sono datori
di lavoro come gli altri, e devo ancora capire perché non è punibile chi sfrutta
gli operai che costruiscono i palazzi a mani nude, e senza protezioni, mentre a
mandar donne a farsi qualche sana scopata, con ogni precauzione del caso, si
rischia la galera. Il mestiere più antico del mondo è anche il più gratificante,
e pure il più remunerativo. Guadagnare e godere.
A loro piace, ve lo dico
io, e anche i
gemiti spesso non son
finti, che trovarsi un bell’uomo per mezz’ora fra le gambe spesso fa la
differenza. Per questo
vado a puttane quando
posso, quando ne ho voglia, e quando le finanze lo consentono: io me la godo e a
loro, sfruttate o meno, in fondo piace, perché sono donne, e
alle donne piace l’uomo.
Inoltre ho l’intima certezza, so, che in ogni contatto umano può esserci della
magia, anche se è fatto nudo e crudo, anche e specie in questi casi, dove non
c’è spazio per i misteri, dove la schiettezza e la sincerità sono padrone.
Mentirai al tuo
avvocato, ma non alla tua puttana.
Perché l’intimità che può ricavarsi da un incontro tra sconosciuti va oltre e al
di là d’ogni immaginazione. E poi vuoi mettere il piacere di provarne quante se
ne vuole? Bionde, rosse, more, nordafricane, esteuropee, sudamericane. Un giro
al luna park
alla scoperta del pianeta donna, al prezzo d’un biglietto. Le prendi in
affitto,
e fai quello che vuoi, e dei suoi mal di testa non t’importerà un fico secco;
come all’autonoleggio, solo che alla fine non devi rifare il pieno. Così la
patonza
gira. E poi ognuno per la sua strada. Questo è l’importante. Difatti non le pago
perché vengano con me,
ma per andarsene subito dopo.
Perché non ti assillino di richieste, perché non ti telefonino, perché non
abbiano altra pretesa che quei trenta, cinquanta o cento bigliettoni. Due botte
e via, poi ognuno per la sua strada. A casa c’è mia moglie che m’aspetta, avrà
già messo tavola.
Prostituzione senza
moralismi bigotti (chi sono le sex workers),
scrive “Stato Quotidiano”. A fine dello scorso gennaio 2012, la rivista
telematica
LucidaMente
è andata on line con una decina di
articoli aventi come tema centrale e comune denominatore l’“eros senza amore” e,
in particolare, la prostituzione (ad esempio: Dal Brasile senza passione…;
Quelle ragazze coi pupazzi di peluche; I fantasmi della strada; Escort, emblema
del degrado sociale; La prostituzione? Va rifiutata dalle stesse donne; Le
“Escort 25” cantate da Immanuel Casto; …Fino alla
“cybersexual addiction”;
Il “sexting” contagia anche gli italiani. Minorenni compresi).
Le modalità della trattazione
del tema. Intenzionale e
ponderata era stata la scelta da un lato di non usare la parola “sesso” o
“sessualità”, così come, d’altro canto, quella di non parlare di erotismo
tout court,
che sarebbe stato automaticamente collegato all’amore di coppia (miticamente
inteso come “naturale” o “normale” dalla società attuale). Del resto, anche
l’uso di termini come “trasgressivo” avrebbe fatto intendere che esistono regole
“normali” e “trasgressioni” di tali “normalità”. Per un laico avrebbe
significato porre dei paletti di intolleranza e di pregiudizio.
Ancora, altra scelta “laica” è
stata quella di lasciare ai redattori e ai collaboratori della rivista libertà
di esprimere qualsiasi
punto di vista, senza alcuna posizione precostituita. Insomma, tematica comune,
opinioni libere.
Le reazioni dei lettori.
Innanzi tutto, diciamo che il numero speciale della rivista ha battuto ogni
proprio precedente record di contatti e di articoli letti. Nella decina di
giorni nei quali gli articoli sono stati on line si sono avute circa diecimila
visualizzazioni da parte degli internauti. Molti i commenti, a favore e a
sfavore dei contenuti degli articoli (ad esempio: Anche voi moralisti sul
sesso?).
Relativamente numerose anche le richieste di essere cancellati dalla mail list
della newsletter (un 50% di utenti uomini e un 50% di utenti donne).
Prima
considerazione: la tematica
affrontata interessa sempre molto. Seconda considerazione: ancora forte è la
reazione irrazionale da parte di molti verso tali temi (la peste emozionale di
cui parlava Wilhelm Reich?). Invece, l’unica modalità per trattare il tema della
prostituzione è quella aperta, problematica, pragmatica. Insomma, laica.
Chi sono le prostitute.
Pertanto, partiamo dai dati ufficiali (relativi all’Italia). Secondo l’ultima
indagine commissionata dalla
Commissione Affari sociali della Camera,
le prostitute – ma sarebbe meglio usare il termine anglosassone
sex workers
– operanti del nostro Paese sarebbero dalle 50.000 alle 70.000, di cui circa
25.000 immigrate. La massima concentrazione a Milano e Torino. Il 65% delle
prostitute lavora in strada, il 29,1% in albergo, le rimanenti in casa. Il 94,2%
delle prostitute sono donne, il 5% transessuali e lo 0,8% travestiti. Duemila
sarebbero minorenni e più o meno lo stesso numero quelle ridotte in schiavitù
e/o costrette a prostituirsi. Crolla, quindi, la leggenda volutamente divulgata
da parte cattolica secondo la quale “quasi tutte le prostitute lo fanno perché
costrette con violenza”. Secondo l’indagine citata, invece, sarebbero solo il
4-5% le prostitute che preferirebbero uscire da tale “mestiere”.
Anche per le ricerche condotte da Parsec, Censis, Università di Trento,
Fondazione Cesar, la
percentuale di chi preferirebbe lavorare in altro ambito è molto bassa e si
aggira intorno al 10%. Il perché è facile da intuire: è una professione molto
redditizia, non più rischiosa di altre, meno umiliante e frustrante che fare la
commessa o la badante o la operaia. Poi, in tempi di crisi economica e
disoccupazione, non si può andare tanto per il sottile.
Le tipologie delle sex workers.
Impossibile tracciare un quadro univoco delle prostitute operanti in Italia. La
molla: essenzialmente economica. Per nazionalità: italiane e rumene, ma anche
brasiliane, cinesi, nigeriane, area ex Urss… Per età: giovani, ma anche
quarantenni e oltre. Titolo di studio: dall’analfabetismo delle africane alle
lauree delle russe.
Prezzi: da poche decine di euro a migliaia di euro per una notte
o un weekend, con una media
di 50 euro a prestazione. Tipologie fisiche: bellissime e meno belle, alte e
piccoline, vistose e insignificanti, raffinate e volgari. Tipologie
psicologiche: sbrigative, brusche, frettolose, dolci, cordiali, umane,
amichevoli, affettuose (e a volte si arriva al matrimonio col cliente). Servizi
sessuali: dal coito in pochi secondi a cena e notte trascorse insieme,
dall’erotismo spicciolo al sadomaso con dotazioni varie, dal rapporto genitale
freddo a quello affettuoso e attento. Come viene vissuto il proprio mestiere:
con vergogna, sensi di colpa, normalità, “professionalità”, ironia, giocosità,
sfrontatezza.
Nel complesso, un mondo variegato, sfaccettato, inclassificabile.
Chi sono i
clienti. E i clienti?
Verrebbe da dire “tutti gli italiani” (anche se non troverete mai alcuno che lo
ammetterà: in Italia nessuno “va a puttane”). Infatti, secondo uno studio
commissionato nel 2007 dal Dipartimento Pari opportunità, risulta che i
connazionali che hanno regolari frequentazioni con prostitute, sebbene con
motivazioni, cadenze e modalità diversificate, sono 9 milioni! Se escludiamo
donne, bambini, anziani, asessuati e qualche altra categoria, siamo quasi al
100% dei maschi italiani. Anche in questo caso, infinito lo sperpero delle
tipologie. Per
classe sociale, istruzione, cultura, gusti, età, tendenze, credi ideologici e
religiosi. Ci sono quelli
che vanno a prostitute perché “brutti”, perché hanno in testa fantasie
“ridicole”, “sconvenienti”, inaccettabili da una donna “perbene”, perché
vogliono stare con più donne contemporaneamente, perché vogliono “evadere”
qualche volta al mese, perché sono anziani, perché la loro moglie non piace più,
perché ne hanno abbastanza di donne oppressive e soffocanti, perché sono preti,
perché non vogliono “perdere” tempo, perché è più “economico”, perché desiderano
il corpo di una donna giovane e bella, perché si innamorano di una prostituta.
Lo stereotipo “femminista” del maschio che vuole “umiliare” una donna non
esiste, se non in rari casi psicopatologici. Davvero, di fronte alla “origine
del mondo” (come chiamava la vagina nel suo dipinto Gustave Courbet), gli uomini
son tutti uguali, fragili, in ginocchio.
Considerazioni generali.
Diamo per scontato che in un mondo migliore non dovrebbero esistere prostitute e
clienti. Tuttavia, se guardiamo in faccia alla realtà, tale ipotetico “mondo
migliore”, anche per questo ambito, parrebbe assomigliare più a Utopia che a una
realtà possibile, in quanto dovrebbe esistere un pianeta di esseri tutti belli,
tutti perfetti, tutti sessualmente “normali”, tutti che si innamorano del
partner giusto, che ricambia a sua volta allo stesso modo… E, a questo punto,
siamo arrivati più a una distopia nazistoide che a un’utopia…
Più concretamente, crediamo
che la prostituzione sia una fondamentale valvola di sfogo
psicologica e sociale per quei clienti
che avrebbero davvero grosse difficoltà a realizzare in qualche modo una propria
vita sessuale (anziani, “brutti”, disabili, “fantasiosi”, “diversi”, ecc.). Se
le prostitute non sono eroine, visto che sono in genere ben pagate, un qualche
merito pur ce l’hanno. Permettono a molti una sessualità che, altrimenti,
sarebbe loro negata.
L’imbarazzo della politica italiana.
Se la prostituzione è “quella piaga che la società ha reso tale”, l’adagio si
attaglia perfettamente al Belpaese bigotto e intollerante e ai suoi politici
vili e meschini. Nessuno dovrebbe passare la notte per strada, magari durante un
gelido inverno. Ma la maggioranza dei nostri politici si gira dall’altra parte.
Innanzi tutto, il centro cattolico, teocratico e filovaticano, per il quale la
prostituzione è un “problema morale”. Per la destra, dopo il modello
berlusconiano, tanto tutte le donne sono a pagamento.
E la sinistra? Anche lì imbarazzo, prima di tutto per non perdere i voti di una
popolazione che vorrebbe
addirittura aumentare le pene per i reati connessi alla droga, come se non
avessimo già le prigioni intasate di poveracci! E, poi, la realtà cozza con la
visione puritana “progressista” e/o fanaticamente femminista, per non parlare
del “politicamente corretto”: la nostra – si sa – è una sinistra perbenista e
borghese, lontana dai problemi sociali.
Così resta in vigore la legge
Merlin che, nell’impianto e persino nel lessico (“meretricio”,
“lenocinio”, “libertinaggio”!), resta legata un’Italia che non c’è più. Una
legge che lascia ampi margini di discrezionalità, per non dire di arbitrio, a
forze dell’ordine e magistrati. Ad esempio, il “reato” di “favoreggiamento della
prostituzione” – che non esiste altrove –, a causa del quale, chiunque
accompagni in auto una prostituta può essere sottoposto a un pesante
procedimento penale. E, così, c’è scappato qualche suicidio di cliente
“svergognato”.
Pragmatismo e spirito laico.
Eppure, se, una volta tanto, si guardasse all’esperienza degli altri Paesi, si
potrebbero regolarizzare le sex workers operanti in Italia. Come per le droghe,
se le prostitute fossero disciplinate dallo Stato, si darebbe un colpo mortale
alle mafie e agli sfruttatori.
E si potrebbero far pagare le
tasse su un giro di miliardi all’anno, con grande beneficio per l’erario.
La politica del pragmatismo, della razionalità, della “riduzione del danno”,
piuttosto che la ricerca di un’utopia sociale – sia essa cattolica che
“progressista – resta lontana, fuori dall’orizzonte politico. Meglio l’inferno
in Terra. Tutti devono soffrire. In questo come negli altri casi: l’aborto va
praticato dalle donne nella vergogna, gli uomini sono costretti a consumare
squallidi rapporti sessuali in auto o in sporche camerette, gli omosessuali
possono essere scherniti o peggio, gli immigrati sfruttati, i malati terminali,
se non hanno la possibilità di recarsi all’estero, devono urlare di dolore. Un
Paese ipocrita e vigliacco, che perseguita chi è debole. Una nazione
insensibile, sotto la maschera del pietismo e della morale cattolicista.
Alba Parietti: "Per la
sinistra sono sempre stata la puttana con cui girare la notte".
La showgirl, in un'intervista per "Il Fatto Quotidiano", ha raccontato senza
peli sulla lingua il suo rapporto con la politica e quando, nel 1992, rifiutò 9
miliardi offerti da Berlusconi, scrive “Today”.
E' un fiume in piena Alba Parietti
quando racconta della sua vita, tra privato e carriera. 53 anni di aneddoti che
la showgirl torinese ha ricordato in un'intervista per "Il Fatto Quotidiano".
Da sempre simpatizzante di sinistra,
la Parietti con gli anni ha avuto modo di guardare da vicino e toccare con mano
la politica italiana: "Da un certo mondo sono stata sempre percepita e guardata
come la puttana che porti in giro di notte e di giorno sei costretto a
nascondere - ha spiegato - Negli anni ho capito quanto fossero snob e bigotti i
presunti rappresentanti della sinistra italiana. Non è bastato neanche che
rinunciassi ai nove miliardi che mi offriva Berlusconi. Non è cambiato niente.
La verità è che non mi hanno perdonato di aver scaldato gli istinti più bassi
degli intellettuali. Quelli perdevano la testa e i censori con la puzza sotto il
naso insorgevano. Oggi Berlusconi e la sinistra governano insieme".
E proprio su quei 9 miliardi rifiutati torna a parlare subito dopo con un po' di
amaro in bocca: "Con Silvio
Berlusconi fui molto antipatica. Un peccato. Lui, al contrario, da allora e
negli anni a venire, con me fu simpaticissimo. Si prestò al tour della villa e
nel castello incantato, al momento del dunque, fu generoso. A Mediaset però non
andai. Dissi no, grazie. Adriano Galliani, presente all'incontro, era attonito.
Non voleva credere che avessi dato un calcio alla fortuna".
Oggi, forse, col senno di poi, Alba Parietti di quel "no" si è pentita,
anche se la fortuna, lavorativamente parlando, in quel periodo è sempre stata
dalla sua parte.
ALLARMI SIAM BIGOTTI! – C’ERA
UNA VOLTA GIÒ STAJANO, “IL BORGHESE”, PINGITORE E NINO STRANO, OVVERO LA DESTRA
LIBERTINA – INVECE ADESSO ABBIAMO GASPARRI CHE ATTACCA SUL “SESSO CONSENZIENTE”
E LA RUSSA CHE INSULTA “UN CULATTONE”
I due episodi di Gasparri e La
Russa, scrive Pietrangelo Buttafuoco su "Il Fatto Quotidiano", “confermano il
contrappasso rispetto a ciò che fu la destra italiana, ricettacolo di libertini,
dandy e maliarde (vulgo: puttane)”. Quando Almirante fece il baciamano al trans
Stajano…Da je suis Charlie a je suis Ignazì il passo è breve. Se passa – come
nella vignetta di Charlie Hebdo – l’idea di Padre, Figlio e Spirito Santo uniti
in transustanziazione sodomitica, un omosessuale, oltretutto lanciato in
un’intemerata all’incontro sulla famiglia, può mettere in conto di incontrare la
santa teppa. Un filmato diffuso in rete mostra Ignazio La Russa al convegno
sulla famiglia tradizionale organizzato dalla Regione Lombardia mentre,
sull’onda di un chivalà, insulta il suddetto contestatore. Il dettaglio tutto
sublime sta nel fatto che l’oltraggio, ripreso in video, viaggia sul labiale.
Non si sente il roco ruggito. L’urto della maschia gioventù risulta
cristallizzato nella moviola – cu lat to ne! – e l’incidente precipita nell’aita
dell’ideologicamente corretto. Più che la blasfemia poté il sessismo, si dirà,
ma la vicenda di La Russa suona dada rispetto allo sbrego di Maurizio Gasparri
che, su twitter, incurante di ogni cautela istituzionale insulta le due rapite
immaginandole consenzientI – dunque, due puttane – nel sollazzare i propri
rapitori. Il popolo della rete, al netto delle vampe contro Gasparri, ha
reclamato una propria fetta di je suis Maurizì solo che gli estremi di un lapsus
più che rivelatore, nei due episodi, confermano il contrappasso rispetto a ciò
che fu la destra italiana, ricettacolo di libertini, dandy e maliarde (vulgo:
puttane). In principio fu Giò Stajano, buonanima. Fu il primo travestito
d’Italia, quindi il primo transessuale, deciso – negli anni della sua vecchiaia
– a entrare in convento e così completare il quadretto di brava ragazza devota
ai principi di Dio, Patria e Famiglia. Nipote di Achille Starace, segretario del
partito fascista, Stajano si presentava alle prime all’Opera, a Roma, annunciata
da un codazzo di paparazzi vogliosi di raggranellare scoop per poi far sbucare
su Lo Specchio (il settimanale del gossip, diretto da Nelson Page) delle
foto-notizie con didascalie tipo: “L’onorevole Andreotti in compagnia
dell’invertito Giò”. Ebbene, una sera, a Caracalla, era il 1971, Giò tese un
agguato a Giorgio Almirante. Il leader del Msi, galante, spiazzando tutti, la
salutò con un perfetto baciamano. Per poi dirle: “Mi saluti la mamma”. In
principio fu Stajano ma, nel frattempo, a destra, tutto quell’arroventarsi
d’eros trovava il modo di esercitarsi anche nella sequenza sexy de Il Borghese –
un settimanale che occupa un importante posto nella storia del giornalismo,
fondato da Leo Longanesi – negli anni della direzione di Mario Tedeschi e Gianna
Preda inserisce nella fascicolazione foto di nudi espliciti lasciando cadere,
già negli anni ’50 del secolo scorso, le pecette della censura solitamente
appiccicate su curve e seni procaci. Saranno i primi nudi a far capolino nei
tinelli dell’Italia tutta Dio, Patria e Famiglia. Primi destinatari, i lettori
della destra monarchica, missina e cattolica. Ninni Pingitore, futuro inventore
del Bagaglino, il cabaret libertario della destra anarchica (una scena, quella,
che il berlusconismo spegnerà per sempre), ancora una volta alzava il tiro
esplorando i pruriti del costume italico da caporedattore del mensile Playmen. E
fu al cinema, con Gualtiero Jacopetti, che la destra portò sul grande schermo
più di un’inaudita crudezza e un’indiscussa novità di linguaggio. Con “Mondo
Cane”, con “Africa Addio”, le pellicole di Jacopetti, attese dal pubblico
sull’onda dello scandalo ma sempre eseguite – il regista non licenziava copione
che non fosse letto da Indro Montanelli, il suo unico riferimento – con la
maestria di chi il gusto se l’era formato alla scuola della disobbedienza. La
stessa di Mario Castellacci, autore della canzone di rabbia e di popolo “Le
donne non ci vogliono più bene (perché portiamo la camicia nera)”. Un
contrappasso, dunque, e La Russa e Gasparri non dimenticano di sicuro la
carovana degna di Pedro Almodovar, tutta di coloratissimi trans, al seguito di
Nino Strano. Esteta, mecenate delle arti (educato all’arte da Franco Zeffirelli)
già senatore di Catania – prima del Msi, poi An – Strano, spiritoso come
nessuno, è stato sempre in prima fila a cavar diritti dall’eccentrica estetica
del fascismo etneo. Libertino, libertario e dandy in ogni contesto. Perfino
quando si avventurò in una scenataccia – i lettori la ricorderanno, quando
inghiottì la mortadella in Senato, alla caduta del Governo Prodi – trovandosi
poi nel gorgo di una chiassosa contestazione, Strano sentì qualcuno gridargli
qualcosa. A Fabio Granata, che era vicino a lui, chiese: “Che cosa mi stanno
dicendo, Pinocchio?”. Granata lo rassicurò: “No, Nino, no. Non dicono Pinocchio,
ti stanno dicendo fi-noc-chi-o”. Perfetta, la risposta di Strano: “Pinocchio
proprio, no. Bugiardo non lo sono mai stato!”. Più che Collodi poté
l’ortofrutto. E fu tutto un coro: Je suis Ninò.
1. ALLA FACCIA DEI BIGOTTI,
SEMPRE PIÙ ITALIANE VANNO A PROSTITUIRSI IN SVIZZERA - 2. TRA I CANTONI, LA
PROSTITUZIONE È UN’ATTIVITÀ ECONOMICA TUTELATA DALLA COSTITUZIONE FEDERALE: CHI
VUOLE “BATTERE” DEVE REGISTRARE ALLA POLIZIA LA SUA PRESENZA SUL TERRITORIO,
DOPODICHÉ OTTIENE UN PERMESSO DI CINQUE ANNI - 3. IN TICINO SI CONTANO 600
PROSTITUTE E, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, BOOM DI ITALIANE - 4. TRA LORO DIVERSE
FRONTALIERE: OGNI GIORNO VANNO, FANNO VENIRE E VENGONO - 5. LA LEGA NORD,
ARCHIVIATA LA PADANIA LIBERA VUOLE LA PATATA LIBERA: RACCOLTA FIRME PER UN
REFERENDUM PER ABOLIRE LA LEGGE MERLIN E TORNARE ALLE CASE CHIUSE - 6. IL
GESTORE DI UN “MOTEL PER ADULTI” IN SVIZZERA: “MOLTI DEI BEN PENSANTI CONTRO CUI
MI SONO SCONTRATO IN PUBBLICO POI LI HO RITROVATI NEL MIO CLUB” -
1 - REGOLE, TASSE E
SICUREZZA. IL POLITICO TICINESE: «COSÌ SI EVITA IL MERCATO NERO»
di
Gp.r. per il "Corriere della
Sera". Abolizione
(parziale) della legge Merlin e, di fatto, via libera alle case chiuse. È questo
l'obiettivo della campagna referendaria promossa dalla Lega Nord. Al di là della
scelta di lanciare il tema nel periodo elettorale, il percorso individuato non è
soltanto quello dei banchetti per la raccolta delle firme dei cittadini, ma -
soprattutto - quello istituzionale. La settimana scorsa, infatti, il Consiglio
regionale della Lombardia ha approvato (con un solo voto di margine) la proposta
di referendum presentata dal gruppo del Carroccio. Oltre alle storiche, aspre
divergenze culturali sul tema della prostituzione, al Pirellone il dibattito
politico è stato aspro e lacerante anche all'interno della stessa maggioranza di
centrodestra. Gli alfaniani del Nuovo centrodestra, infatti, sono rimasti
inamovibili nel dire no al referendum, e in aula il testo è passato per un
soffio grazie al voto del Movimento 5 Stelle. Adesso, perché la richiesta di
consultazione popolare sia valida, la Costituzione prevede che venga condivisa
da almeno altri quattro Consigli regionali. E, puntuale, la Lega stessa ha già
avviato lo stesso iter anche in Veneto, dove giovedì scorso la commissione
Sanità ha dato il primo via libera.
2 - IN SVIZZERA, DOVE
PROSTITUIRSI È LEGALE QUELLE ITALIANE FRONTALIERE DEL SESSO
di
Chiara Maffioletti per il
"Corriere della Sera".
Il parcheggio non è pieno. Sulle auto - tutte dignitose ma nessuna di grossa
cilindrata - sistemate a lisca di pesce si riflette il sole di una calda mattina
di primavera. Il silenzio anonimo di tutte le anonime zone industriali di
provincia è rotto solamente dal rumore di una segheria che lavora, poco lontano.
Un posto qualunque. Che però è in Svizzera. E così, da dietro il separé di
plastica da stabilimento balneare a poco prezzo che nasconde i ballatoi della
palazzina affacciata sul parcheggio, appare una ragazza. Dondola su tacchi
altissimi e indossa un abitino blu che le sta un po' stretto. La testa è bassa:
guarda il cellulare. Non può parlare, è di fretta: «Mi stanno aspettando in
camera», si scusa. «Ma - aggiunge - al bar ci sono altre ragazze». Il bar è
quello del Motel Castione e le ragazze sono tante, almeno trenta. Sono sedute al
bancone o ai tavoli e quando si apre la porta, tutte si voltano a guardare. In
Svizzera la prostituzione è legale e anche locali come il Motel Castione lo
sono. Lo ribadisce il titolare che però preferisce restare anonimo visto che la
legge non basta a cancellare «i pregiudizi. Prima c'erano 33 ritrovi simili in
Ticino ma sono stati quasi tutti chiusi», spiega. Questo perché non si può più
mascherare una casa d'appuntamenti con un bar: «È cambiata la norma: siamo
diventati "luogo di incontro per adulti". Chi entra da noi paga l'ingresso e
riceve in omaggio una consumazione». Dieci franchi, meno di dieci euro. Tra i
clienti non notturni, soprattutto anziani. Parlano con le ragazze, sorridono.
Ogni tanto qualcuno viene preso per mano da una di loro e si allontana lungo il
corridoio che porta alle camere. Per il gestore il guadagno, oltre agli ingressi
(in media 200 giornalieri), è l'affitto delle stanze alle prostitute: «Al giorno
sono 120 franchi. E forniamo ogni volta biancheria fresca». Le camere sono sì
pulite ma sembrano quelle di un hotel a due stelle. «Per renderla più calda ho
attaccato sul lampadario un velo rosso», racconta Gina. Ha 29 anni, ha iniziato
a prostituirsi quando ne aveva 23 e viene dalla Romania. «Da noi gli stipendi
sono di 200 euro al mese. Ho una bambina e credo sia giusto se mi sacrifico io
perché non lo faccia mai lei». Il peso più grande è non averla cresciuta: «Ma
quando penso che va a scuola ed è vestita bene e apre il frigo e lo trova pieno,
allora so che sto facendo la cosa giusta». Nella sua famiglia nessuno sa che
lavoro faccia Gina. La sua idea, come di molte altre, è fare tanti soldi in
pochi anni. In media una prostituta chiede 100 franchi per mezz'ora e ne
guadagna attorno ai 5, 6 mila al mese. Gina si è comprata un appartamento. «Ci
sono storie a lieto fine - racconta un cliente, 42 anni, svizzero che di
professione fa il giornalista -. Questi posti vengono raccontati sempre sotto
una cattiva luce ma qui ho conosciuto molte brave ragazze, che aiutano le
famiglie. Mi spiace che così tanta gente le giudichi male». A Castione in
effetti i clienti del bocciodromo (dopo il motel, il secondo locale più vivo di
questo minuscolo centro) scuotono la testa: «Ma davvero c'è gente anche a
quest'ora? Sono anziani? Ma anziani come noi?». Una coppia di marito e moglie
classe 1929 ascolta attenta. Lei indignata. Lui sbuffa. Ma alla fine chiede
sospettoso: «Ma anche della mia età? Io ho 85 anni eh». «La prostituzione in
Svizzera è un'attività economica tutelata dalla Costituzione federale»,
scandisce Norman Gobbi, ministro ticinese con delega alla prostituzione.
«L'obiettivo è evitare la prostituzione di strada e la clandestinità. Chi vuole
prostituirsi deve registrare la sua presenza sul territorio alla polizia,
dopodiché ottiene un permesso di cinque anni. In Ticino al momento si stimano
600 prostitute». Ma non proprio tutte pagano le tasse. La maggior parte fa la
spola con il Paese d'origine: lavora in Svizzera per un paio di mesi poi torna a
casa, per rientrare di nuovo a distanza di qualche tempo. Una strategia semplice
per evadere. Ulisse Albertalli, titolare del Bar Oceano - 70 camere vista
autostrada - si definisce «un pioniere del settore». È orgoglioso delle
battaglie fatte per ottenere «la licenza di bordello ufficiale. Le ragazze sono
libere. Io offro le camere, i servizi alberghieri e la sicurezza (che garantisce
però anche una sezione specifica della polizia)». Tutto per 165 franchi al
giorno e due giorni di preavviso prima di liberare la camera: «Le ragazze girano
per tutta la Svizzera e si fermano poche settimane. I clienti preferiscono il
ricambio: spesso una moglie l'hanno già a casa». Albertalli gestisce il locale
con i figli «a testa alta. E molti dei ben pensanti contro cui mi sono scontrato
in pubblico poi li ho ritrovati nel mio club». Vanessa ascolta seduta su un
divanetto. Ha 30 anni, anche lei è romena e a Bucarest ha aperto un salone di
bellezza con i soldi fatti qui. Da piccola voleva fare la sarta. È molto bella
ma il trucco marcato la fa sembrare più grande. Eppure nella sua stanza ci sono
decine di peluche tra cui un orsacchiotto gigante. «Ai miei ho detto che lavoro
nella hall di un hotel», confessa. Perché non lo fa davvero? «Così guadagno
molto di più e molto più velocemente». Una formula che vale per tante. Sempre
più italiane conferma Marco, titolare del sito incontriticino.ch . Il suo è un
portale di annunci per chi esercita puntando sull'altra faccia del «modello
svizzero»: la prostituzione da appartamento. «La percentuale delle italiane che
si iscrivono sta salendo moltissimo negli ultimi tre anni. Prima si contavano
sulle dita di una mano. Ora ce ne sono almeno 25, diverse frontaliere. In
Svizzera italiana è dove danno i permessi più facilmente e dove poi sono più
bigotti. Al di là del Gottardo è l'opposto: ci sono quartieri a luci rosse ma
non c'è il moralismo che esiste qui, dove chi lavora in casa spesso lo fa di
nascosto per evitare guai con i condomini». Come fa anche una ragazza svizzera:
«Nel mio appartamento faccio la massaggiatrice: decido io se proseguire con il
rapporto o no». Non ama il suo lavoro, ma si sente tutelata. «Pago le tasse e
sono in regola. Ma non lavorerei mai in un club: è vero che le ragazze possono
scegliere con chi andare ma se devono pagare un fisso al giorno per me è
comunque sfruttamento della prostituzione. Se non ci sono clienti sono costrette
a svendersi». La crisi non aiuta: «Le ragazze fanno sempre di più per sempre
meno. E molte sono italiane». Come la giovane donna seduta sugli sgabelli del
Pompeii, locale a pochi passi dal confine, a Chiasso, che conferma il teorema
secondo cui più ti avvicini all'Italia e più si fa spessa l'aria di omertà. La
ragazza è di Palermo ma si è trasferita vicino alla dogana e ha un permesso come
frontaliera. Sta aspettando i primi clienti ma non ha voglia di parlare. Una
cosa però le sfugge, mentre si sistema distratta la scollatura: questo mestiere
in Italia? No, non lo farebbe mai.
Basta con l’ipocrisia:
prostituzione legale,
scrive Francesco Maria del Vigo su “Il Giornale”. Prostitute, troie, puttane,
mignotte, passeggiatrici, peripatetiche, meretrici, squillo, sgualdrine, battone
chiamatele come vi pare, ma fatele lavorare. In pace. E nella legalità. Da
alcuni giorni la Lega di Matteo Salvini (accompagnato dal trans Efe Bal) ha
iniziato a raccogliere firme per abolire la legge Merlin, la legge del 1958 che
abolì le case chiuse e di fatto rese illegale la prostituzione. Finalmente una
battaglia di buon senso e di civiltà. Che in un Paese in cui tutto va a puttane
i cittadini non possano farlo liberamente, sembra un paradosso. L’argomento da
anni viene sfiorato da molte forze politiche. Riaprire i bordelli significa
regolamentare, tassare e controllare la prostituzione, Ma significa anche fare i
conti con un velo di ipocrisia che non vuole essere squarciato e con una realtà
che molti fingono di non vedere. Eppure basterebbe soffermarsi sulla parola,
sulla nostra lingua e sui modi di dire, mai casuali, che genera. Non servono
approfondite conoscenze sociologiche o storiche: se si chiama “il mestiere più
vecchio del mondo” un motivo ci sarà? Infatti le leggi restrittive e punitive
non hanno avuto alcun risultato, se non quello di portare sulla strada migliaia
di schiave del sesso e gettarle in mano alla criminalità. Il commercio di esseri
umani che vive ai margini delle nostre città è uno spettacolo indegno di un
Paese civile. Molto più civile riaprire le case chiuse e prendere atto di
un’abitudine millenaria. Vogliamo dare un giudizio morale? Vogliamo crocifiggere
il puttaniere? Ma per favore, smettiamola con questa ipocrisia. Anche perché, in
alcune zone d’ombra della legalità, il commercio sessuale vive e prospera senza
alcun controllo. Per esempio in molti di quei centri massaggi che come funghi
sono sbucati ovunque nelle nostre città. Mentre tutti fanno finta di non vedere.
Nel momento in cui, liberamente, una donna e o un uomo decidono di mettere in
vendita il loro corpo, non c’è nulla di male. E lo Stato non può impedirglielo.
Chi va a puttane non è un criminale, al massimo uno sfigato. Ma non merita di
finire dietro le sbarre. Ancor meno chi, per scelta o necessità, mette in
vendita il proprio corpo. C’è tutta una letteratura sull’esperienza “iniziatica”
nei bordelli. Il Cioran adolescente si rifugiava nelle case chiuse per sfuggire
all’angoscia della morte. Drieu La Rochelle si spinge più in là e teorizza che
il bordello sia l’unico “posto dove l’umanità si zittisce e offre un commercio
gentile”. Ma il legame tra gli artisti e il sesso a pagamento è un filo rosso
che si srotola lungo gli anni: da Flaubert a Mario Soldati, passando per Kafka e
Zola fino ad arrivare al recente appello dei 343 “intellettuali maiali” francesi
che sono scesi sul marciapiede per salvare le lucciole. Sono solo l’escrescenza
di un massa invisibile che continua a crescere: secondo le stime dell’Università
di Bologna gli italiani che si rifugiano nel commercio del sesso sono 2,5
milioni. Ma parlarne è un tabù. Perché siamo rinsecchiti da un moralismo
strabico e da un bacchettonismo a targhe alterne, come se ognuno di noi, almeno
una volta nella vita, non si fosse prostituito moralmente, intellettualmente o
anche professionalmente. Insomma, sradicare la prostituzione è impossibile,
regolamentarla doveroso. Per non uscire dalla metafora: maiali e lucciole hanno
diritto di “cittadinanza” anche da noi, brava Lega!
Puttane e trans: lontane
dagli occhi, lontane dal cuore,
scrive
Daniela Minerva
a il vaso di Pandora su “L’Espresso”.
Il sindaco di Roma vuole un quartiere a luci rosse. Non resta che sperare che
non si sia accorto di quanto propongono i suoi assessori. Quoque tu... Ignazio
Marino è un uomo perbene. È un medico straordinario. È un intellettuale di
prim'ordine. Ha una tempra invidiabile, una rettitudine esemplare, una lucidità
di pensiero rara. Ed è un uomo buono, sensibile, delicato. Mi chiedo come è
possibile che sia caduto anche lui nella trappola del “quartiere a luci rosse”.
Passi per qualche sgangherato assessore leghista immerso nelle nebbie (fisiche e
mentali); passi per l'ineffabile Ombretta Colli, incaricata dalla destra di
curare le pari opportunità a Milano; passi anche per i misogeni di mezz'Italia
che vanno cercando le “pubbliche mogli” (dell'immortale De André) ma ci tengono
a farlo al calduccio e invocano la revoca della legge Merlin. Ma Marino, no. Non
doveva pugnalarci al cuore. Riassumo: la giunta capitolina, fregandosene del
ruolo di Roma capitale dell'umanesimo cristiano, ha deciso di spostare tutte le
mignotte e i femminielli della città (e sono tanti) all'EUR (1). Ha deciso poi
che chi viene beccato a farseli fuori dalla cinta del geniale quartiere voluto
da Giuseppe Bottai - che sarà anche periferico ma è una delle meraviglie del
mondo - paga 500 euro di multa (2). Ha deciso di mettere per strada qualche
camper con dei non ben specificati “operatori sociali”, e che Dio ci scampi da
qualche altra storiaccia di gente che prende soldi per occuparsi dei disagiati e
poi se li beve a champagne e mignotte, appunto (3).
1. Sul bisogno di
“regolamentare” la prostituzione e seppellire la legge Merlin ne abbiamo sentite
di tutti i colori. Sostanzialmente si tratta di levare dalle strade chi vende il
proprio corpo, per non offendere il pubblico buon costume. Un intento di tal
genere è pensabile solo se si crede alla fola che la prostituzione sia un
mestiere come un altro. E credere questo è il più infame dei propositi. Donne e
trans sono sulla strada perché non possono fare altro; perché oppressi dalla
povertà, dallo stigma, dal dolore; perché trascinati in schiavitù da delinquenti
che le forze dell'ordine non riescono (o non ci mettono molta energia) a
cacciare in galera e buttare la chiave. Non c'è niente di più umiliante per una
donna che pensare anche solo per un attimo che ci sia là fuori una ragazza
costretta con la forza o dal bisogno a vendersi. Non posso immaginare la
condizione di un trans, ma sento che non è molto diverso. Il cuore si spezza a
immaginare le sequenze di quei milioni di stupri perpetrati all'ombra di questa
bugia scandalosa: no, la prostituzione non è un mestiere. È un cancro del nostro
mondo sessista e crudele. Che a Roma sia legale è un pensiero impensabile.
2. Marino e i suoi hanno
scelto l'Eur. E nello specifico le stradone attorno al Palazzo della Civiltà del
lavoro (che è bellissimo e tiene tra le sue volte la voglia di modernità di un
secolo intero). A parte il simbolico sberleffo (civiltà e lavoro non sono
termini che si applicano a quanto vi accadrebbe), resta che il principio
ispiratore dell'intento è il raffinato “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.
Perché l'Eur è lontano dai Palazzi del potere politico, dal Vaticano e dalle
residenze dei pregati e inutilmente pagati assessori capitolini. Ma sì, va:
buttiamoci le nigeriane, le\i brasiliani, le rumene e i loro pulciosi clienti
dal colletto bianco. Stuprino a go go, di sera in sera. Tanto la gente per bene
non li vede. Io dall'Eur sono lontanissima, ma li vedo, minuto dopo minuto. E
spero che i lettori de “l'Espresso” facciano altrettanto, e di minuto in minuto
dichiarino la loro guerra morale a chi permette quella vergogna. Di solito, mi
sento rispondere: ma comunque la prostituzione c'è. Non puoi evitarla, è
embedded nel nostro modo di vivere. Tanto vale che le si dia una regolata.
Rispondo: a. Il fatto che c'è è doloroso, come molti altri eventi del nostro
mondo. E proprio per questo dobbiamo vedere. dobbiamo sapere, dobbiamo
vergognarcene. Per alimentare la cultura del rifiuto, per educare i nostri figli
e sperare in un mondo migliore. O no?
b. regolamentare non vol dire
emarginare. La filosofia del “lontano dal...” fa schifo. Ripensiamo alla legge
Merlin, se volete. Anche se io penso che sia stata un'ottima e opportuna legge.
Ma è vero che il 1958 è lontano (molto: io nascevo in quell'anno); che le cose
hanno preso una piega che la senatrice che costrinse De Gasperi a guardare nelle
mutande dei democristiani non avrebbe mai potuto immaginare. Dobbiamo comunque
tutelare la salute delle schiave.... È drammatico ma bisogna pensarci. Certo è
che se cominciasse a toglierle dalla strada e a mette in galera gli schiavisti
saremmo a buon punto.
3. Quei geni del Campidoglio
pensano di stanziare qualche migliaia di euro al mese per mettere nelle strade
dell'Eur (che diventeranno, si badi bene, a divieto di sosta!) dei camper con
degli operatori sociali che vigilino sul benessere delle ragazze. È pazzesco. E
non vale neanche la pena di commentarlo. In conclusione: forse ci penserà il
Vaticano a far cambiare idea a Marino. Dove non può la ragione, può il potere.
Ma questa idea pazzesca è un vulnus per me insanabile. È un punto di non
ritorno. Roma, la città più bella del mondo, cuore della cristianità,
dell'umanesimo, del calore magnifico di sole e intelligenza, non poteva
sprofondare più in basso.
Torniamo sul brutto
affare delle luci rosse all'EUR. Il Questore di Roma taglia corto: non si può
fare. La Cei, nemmeno a parlarne. E il Sindaco? Annaspa, continua
Daniela Minerva.
Dell'idea balzana venuta a qualche balzano assessore capitolino di barricare le
mignoitte in un lager di periferia abbiamo detto. Ora, il day after. Che si
sinora su tre fatti essenziali:le parole di Marino a rai News 24: «bisogna
proteggere la famiglia con i suoi valori, dare la possibilità alle persone di
poter usufruire di un parco, di una strada senza trovarsi a dover dare
spiegazioni ai propri figli» (1), un capolavoro di “lontano dagli occhi, lontano
dal cuore” che avrebbe dovuto convincere la Cei, la quale, però, non si è fatta
convincere e ha detto: non se ne parla neanche (2). A chiudere la partita è il
prefetto Giuseppe Pecoraro: «Tutta questa storia è una boutade, non ci sono
riferimenti normativi. Anzi, una legge c'è: si chiama Merlin. Fare ciò che
vorrebbe fare Marino senza un intervento del Governo o del Parlamento è un
reato: è favoreggiamento della prostituzione». Cominciamo dalle parole di Marino
che vuole proteggere i figli delle persone perbene. Mi metto nei suoi panni: lo
spettacolo nelle strade di Roma è davvero osceno. Non farò la santarellina a far
finta di non sapere che trans e povere ragazze se ne stanno seminudi, e nudi,
per strada a offrire la loro tragica merce. E non farò finta di ignorare che
questo stravolge la naturale entrata dei bambini e dei giovani nell'amore e nel
sesso. E allora? Signor Sindaco, non sarebbe meglio evitare questo scempio con
un migliore uso delle risorse e dei (discutibili) talenti che si sono prodigati
in questa scemata? Non ci sono scorciatoie: l'unico modo per evitare gli
spettacolini notturni e non che disturbano le famiglie per bene è recuperare le
ragazze, dare loro un'accoglienza, un tetto, un permesso di soggiorno, un
lavoro. Convincerle così a denunciare e mettere, conseguentemente in galera chi
le opprime. Utopia? Forse, ma fare diversamente è barbarie. Chiunque (e molti mi
hanno scritto sul blog e sulla mia mail privata) pensi che si deve
“regolamentare” la prostituzione ha tutte le ragioni per cercare una soluzione,
ma deve rendersi conto che questa soluzione non può, per nessuna comprensibile
ragione, rendere moralmente accettabile che avvenga un commercio del corpo delle
donne, che si accetti un orizzonte violato dei sentimenti che trasforma il sesso
in violenza e sopraffazione. La Conferenza episcopale italiana, com'era ovvio,
ha tuonato. Non che mi stanno simpatici i vescovi misogini e riottosi a
qualunque modernizzazione del rapporto tra i generi ( persino all'idea di genere
tout court), ma il loro pronunciamento è benvenuto. Perché Marino li starà ad
ascoltare. Il prefetto dice, giustamente, che mettere le mignotte all'EUR e
proteggerle significa violare la Merlin. Bravo Pecoraro. Ma a violare la Merlin
oggi sono in molti. Mi piacerebbe che Pecoraro se ne occupasse. Infine: finirà
tutto a tarallucci e vino. È inevitabile. Le ragazze continueranno a passeggiare
seminude per le strade della capitale. I clienti continueranno a violentarle
convinti che si tratti del più antico mestiere del mondo; e che l'uomo è
incontenibile sessualmente quindi deve “sfogarsi”. I romani più giovani, come i
coetanei di tutte le città italiane, vedranno sfilare quel commercio diventando
sempre più insensibili a quanto esso rappresenta per il degrado delle nostre
vite. Così è stato centinaia di volte: chiacchiere, chiacchiere e nulla accade.
A Roma, come altrove, si è consumata una buffonata buona solo a portare qualche
oscuro burocrate capitolino o di quartiere sui giornali e in Tv. E io spero
tanto che il sindaco non ne sapesse niente e sia stato tratto in una trappola da
qualche imbecille in giunta.
Il tema spacca, continua
Daniela Minerva.
Lo vediamo, nel nostro piccolo anche dalle reazioni dei lettori de L'Espresso.
Chi continua a interrogarsi su una soluzione possibile e sostenibile al fatto
ineluttabile che le prostitute ci sono, e continua a rimuovere la causa di
questo dato di fatto chiedendo tutela e sicurezza per quelle ragazze che
tutelate non sono a prescindere. E chi pone la questione di coscienza di uno
sfruttamento tanto antico quanto infame. Ovvio che non c'é soluzione.
Ma....Leggo troppo spesso quando si parla di prostituzione e revisione della
legge Merlin la parola "ipocrisia". Come se chi non vuole saperne di accettarne
l'ineluttabilità sia un povero struzzo anche un po' sciocco. Le puttane ci sono
e i clienti pure: é il mercato, bellezza, e tu non ci puoi fare niente. Forse é
così, ma solo se continuate a guardarvi l'ombelico. Perché è il nocciolo stesso
della prostituzione che le persone di buona volontá devono provare a enucleare
per un attimo: ci sono uomini che palpano, strusciano, penetrano e umiliano
ragazze schifate, quando non rese schiave. Cosa c'é di ipocrita a non volere che
accada? Esiste una assoluta coincidenza tra violenza sulle donne e consumo
sessuale di strada (macchina, appartamento, bordello...). I ruoli sono gli
stessi, i presupposti sono gli stessi (l'impulso maschile é irrefrenabile, la
femmina é sempre ricettiva sessualmente, male non le fa anzi...). Leggiamo i
racconti delle donne violate, delle bambine schiave dell'Isis, persino di quei
galantuomini dei turchi che vogliono sposare le adolescenti così non imparano la
dignitá di genere come fanno le loro sorelle maggiori. Leggiamo e ci indigniamo,
si indignano anche quelli che, invece, parlano di ipocrisia se speriamo in un
mondo senza servitù sessuale. Sono questi per lo più uomini, di buona volontá
anche, ma privi della sensazione del corpo femminile che trema di fronte
all'immagine di uno stupro, anche a pagamento. E sono donne, lontane dal corpo,
private dello sguardo di genere. O forse solo gente per bene, ma distratta dal
rincorrere la propria illuministica visione del mondo. Presi dal rimirarsi
l'ombelico.
Il quartiere a luci rosse
nasconde solo l'ipocrisia.
Il sesso a pagamento in zone ad hoc emargina prostitute e clienti
senza abolire il vizio. E costringe i poveri a pagare la doppiezza dei ricchi,
scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. L'argomento è scatologico, ma di moda.
E, come tutte le mode, va e viene a seconda dei periodi: la prostituzione. Che
ora è di attualità perché Ignazio Marino, il sindaco di Roma dalla bella Panda
rossa, ha proposto col solito insuccesso l'inaugurazione di un quartiere a luci
del colore identico a quello della sua famosa utilitaria. L'idea non è nuova
eppure fa discutere quasi che fosse inedita. Quando un politico o un
amministratore è in crisi di consensi, e desidera farsi notare, raschia il fondo
del barile da cui estrae le conigliette. E avanti col dibattito. Delimitare una
zona riservata ai commerci carnali serve solo a emarginare le puttane e i loro
clienti, non certo ad abolire il triste fenomeno degli incontri a pagamento.
Poiché siamo tutti abbastanza ipocriti da non voler ammettere che tale fenomeno
sia inestirpabile, ci accontentiamo di non averlo sotto gli occhi o sotto casa.
Senonché, se si toglie dal centro città l'ignobile attività del meretricio e la
si trasferisce in periferia, si ottiene un risultato scarsamente democratico:
non si disturba più la vista ai signori che abitano in condomini di lusso e si
offende quella dei poveri cristi costretti ad alloggiare in edifici popolari o
fuori mano. Spostando il problema da un luogo all'altro non lo si risolve.
Questo lo capisce chiunque, tranne Marino. Al quale vorremmo ricordare che negli
anni Cinquanta la senatrice Lina Merlin riuscì, dopo battaglie asperrime, ad
abolire le case chiuse, altrimenti dette casini, dove le signorine esercitavano
la loro arte (si fa per dire) in ambienti riservati, controllate dal punto di
vista sanitario e disciplinate sotto quello tariffario. Gli avventori,
chiamiamoli così, entravano, pagavano, facevano e nessuno si scandalizzava.
L'iniziativa della parlamentare aveva due finalità: abolire lo sfruttamento di
Stato delle mignotte ed evitare che queste fossero schedate e immesse in un
elenco infame a disposizione delle questure. Intento condivisibile. Tuttavia non
si può dire che lo sbaraccamento delle «ville del piacere» sia coinciso con
l'annientamento della prostituzione che, in mancanza di un sito deputato, ha
continuato a svolgersi per strada - incrementandosi - e in appartamenti. Da
alcuni lustri a questa parte, il cosiddetto «mestiere» non è più esclusivamente
femminile; anzi, i maschi che battono ormai sono più numerosi delle colleghe. È
l'evoluzione della specie. Nell'Occidente sono stati esperiti vari tentativi per
eliminare le puttane e i puttani, ma si è scoperta solamente l'acqua calda:
anche in questo settore è la domanda che stimola l'offerta. Quindi, per azzerare
la categoria di chi dà, sarebbe indispensabile azzerare contestualmente quella
di chi chiede. Impossibile. Perché gli uomini hanno spesso le fregole e, non
essendo selettivi o non potendo esserlo per motivi temperamentali o estetici, le
placano ingaggiando lì per lì una professionista. I costumi mutano nel tempo, ma
l'istinto animalesco di certuni (molti) resiste nei secoli dei secoli. Amen. È
velleitario pensare anche solo di ridurre gli affari relativi al sesso
mercenario. Bisogna rassegnarsi a convivere con puttane e puttanieri, che sono i
foruncoli dell'umanità: ne curi tre o quattro e te ne spuntano altrettanti. Non
esiste una terapia definitiva. Guarisci una pustola sul collo? Se ne forma una
su un gluteo. Indignarsi è superfluo. Delocalizzare le trattative fra
utilizzatori e utilizzate non comporta alcun vantaggio reale: significa
scaricare un fastidio da un angolo all'altro, magari penalizzando la popolazione
meno abbiente. Non sarebbe - non è - un'operazione degna di un progressista.
Vero, sindaco Marino? Le conviene calmarsi. Invece che delle zoccole, si occupi
dei ladri e dei mafiosi che infestano il Palazzo: non danno via la roba loro, ma
prendono la nostra. È peggio.
"Solo un pasticcio. Serve il
coraggio di aprire le "case". L'onorevole Daniela Santanchè critica il quartiere
a luci rosse di Roma. Per lei è necessario un approccio più liberale volto a
permettere la riapertura delle "case di tolleranza", scrive Manila Alfano su “Il
Giornale”. E se fosse la solita trita e ritrita mezza misura all'italiana? È
questo il dubbio di Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, sull'idea di
dedicare una zona a luci rosse che partirà ad aprile a Roma nella zona dell'Eur.
«È La classica soluzione del
voglio ma non posso. Ma perché? Possibile che in Italia non si riesca mai ad
affrontare un problema in modo radicale?».
Quindi favorevole o
contraria?
«Assolutamente contraria.
Questo progetto - a parte che lo vedo ancora molto molto nebuloso - mi sembra
piuttosto un bordello a cielo aperto. Che bella trovata. Ma così si crea una
zona di serie B, cioè la via delle prostitute che stazionano lì a tutte le ore.
Ma che senso ha?».
L'idea è quella di
monitorarle.
«Ma no. Qui siamo davanti solo
alla più classica delle scelte italiane: quelle senza coraggio. È evidente che i
politici romani hanno capito che c'è un'emergenza, che è un problema da
affrontare ma non hanno trovato niente di meglio che recintarle. Più che un
progetto vedo un pasticcio, un paio di strade dove ci sarà una concentrazione di
prostitute a tutte le ore».
Dicono che ci saranno
controlli...
«Si, ma è solo un trasloco di
vie che di certo non piacerà alla gente che abita in zona. Giorno e notte a
subirsi uno spettacolo del genere, senza pensare al valore delle loro case che
scenderà in picchiata».
E allora lei cosa
propone?
«Da sempre io sono per
l'apertura di case chiuse. Non è difficile. In Europa è così. In Germania, in
Svizzera le case chiuse sono gestite in modo esemplare. Perché invece da noi il
problema deve sempre essere rimandato? O peggio ancora raffazzonato?».
Forse perché c'è chi
spera che prima o poi la prostituzione finisca...
«Ma per piacere! È il mestiere
più antico del mondo e per di più oggi coinvolge ragazze sempre più giovani,
finite nel racket, sfruttate, abusate. Questo non è certo sintomo di un Paese
civile».
SIAMO TUTTI PUTTANE.
Pro porno e pro prostituzione:
ecco il femminismo di Annalisa Chirico in "Siamo tutti puttane", scrive “Libero
Quotidiano”. "Siamo tutti puttane". Un titolo spiazzante quello che
Annalisa Chirico, giornalista e compagna di Chicco Testa, politico di
sinistra e dirigente industriale italiano, ha deciso di dare al suo ultimo
libro. Ma già se si legge il sotto titolo ci si potrebbe fare un idea del
concetto che sta alla base della lettura: "Contro la dittatura del
politicamente corretto". Un libro che ha come bersaglio i perbenisti di
sinistra e le femministe alla "Se non ora quando". La Chirico rivendica il
sacrosanto diritto di farsi strada nella vita come ognuno può e vuole, e quindi,
anche diventando una puttana. Un femminismo pro sesso, pro porno e pro
prostituzione, sia per le donne sia per i maschi. Un dibattito a suo avviso che
"ha diviso il Paese tra un popolo di sinistra moralmente irreprensibile e uno di
destra, gaglioffo e sciocco". L'ispirazione dal processo Ruby - In un'intervista
a Formiche.net del 7 maggio, la stessa giornalista alla domanda "È
Berlusconi ad averla ispirata?", non risponde esplicitamente, ma il riferimento
è chiaro. "Ho seguito da cronista il processo Ruby - afferma Chirico - dove nel
tribunale di Milano, non di Riad o della Kabul talebana, trentatré ragazze sono
state vivisezionate nella loro vita privata in qualità di semplici testimoni,
senza alcun capo di imputazione a loro carico. Quando una democrazia smette di
distinguere tra peccato e reato, si getta al macero l'abc della civiltà
giuridica". Dunque nulla di male.
Tutto per apparire -
Le famose "Olgettine", da Via Olgettina, le ragazze indagate dalla Procura di
Milano per il caso Ruby, non hanno, a suo parere, la colpa di aver "conosciuto
Silvio Berlusconi, il tycoon d'Italia, il capo di un impero mediatico, il
presidente del Consiglio italiano". Un'occasione ghiotta di farsi notare e farsi
apprezzare, per entrare nel mondo dell'apparire, della tv e dell'estetica da
vendere. "E' stato un pornoprocesso, un rito a elevato tasso moraleggiante,
oltre che erotico".
La donna può decidere come
utilizzare il proprio corpo -
Poi dal porno si passa all'erotico e a quelle foto di Paola Bacchiddu, il capo
comunicazione della lista L’Altra Europa con Tsipras, che qualche giorno
fa ha pubblicato una foto in bikini suscitando clamore. "Mi è sembrata la
trovata goliardica di una ragazza intraprendente. In Italia ne sono nate le
solite polemiche perché va di moda l’idea boldriniana che il corpo vada nascosto
in un sudario di pietra. Per cui i concorsi di bellezza che si fanno in tutto il
mondo da noi andrebbero proibiti. La donna invece è un soggetto che decide come
usare il proprio corpo, sono le pseudofemministe a rappresentarla come un
oggetto". Poi attacca Barbara Spinelli, candida la paladina delle donne e della
guerra contro la mercificazione del loro corpo per Tsipras. "E' un esemplare del
livello di oscurantismo che caratterizza il femminismo nel nostro Paese. Sono le
donne che strumentalizzano le altre donne. La campagna talebanfemminista 'Se non
ora quando' aveva l’unico obiettivo politico di colpire l’allora presidente
Berlusconi, ci ha fatto credere che il suo indomito fallo fosse il principale
assillo delle donne italiane". Infine la frecciatina a Renzi incalzata dalla
giornalista di Formiche.net che gli chiede se la convince "il femminismo
alla Renzi": "Non esiste un femminismo alla Renzi - ha risposto la Chirico - ma
una strategia comunicativa renziana. il premier ha capito che la sinistra del
presunto primato morale era perdente. Perciò si è abilmente smarcato dalla linea
dei suoi predecessori. E li ha rottamati".
"Siamo tutti puttane" di
Annalisa Chirico è la risposta al fanatismo del "se non ora quando",
scrive Dimitri Buffa su “Clandestino Web”. - “Siamo innanzitutto puttane, in
senso figurato, perché cerchiamo tutti, ciascuno come può, di districarci nel
complicato universo dell’esistente, vogliamo arrabattarci, sgomitiamo per
conquistare il nostro posto nel mondo”. La “summa philosphica”
dell’Annalisa Chirico pensiero, da brava giornalista, l’interessata la mette nel
primissimo capitolo introduttivo del proprio libro “Siamo tutti puttane”, da
poco uscito per i Grilli di Marsilio editore anche in e-book. E nelle prime
parole articolate in concetto. Non si tratta quindi tanto di una semplice difesa
d’ufficio o di fiducia del mestiere più antico del mondo, che la Chirico da
buona radicale comunque svolge, quanto di una presa d’atto dell’impazzimento di
un intero paese, quello italiano, dove, complice e alibi il contraccolpo di
venti anni di berlusconismo nel bene e nel male, la sinistra ha dismesso i panni
del progressismo sessuale e si è incartata in una sorta di talebanismo di
ritorno. In perfetta malafede intellettuale e ideologica, peraltro. Il libro in
questione, ben scritto e ancora meglio documentato, ricorda una per una tutte le
conquiste degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, dal divorzio all’aborto
passando per il travagliato brevetto della pillola anti concezionale, ed è
l’ideale risposta all’isterico e ideologico (e disonesto intellettualmente)
movimento coagulatosi intorno alla piazza di quelle mezze esaltate del “se non
ora quando”. I riferimenti e le punzecchiature contro le vetero-femministe e le
discepole vestali di oggi in seno ai vari movimenti tipo 5 stelle e dintorni,
compresi i popoli viola et similaria, fatti da Annalisa Chirico (che cita
Plutarco e Marcuse, Madonna e Cleopatra, Pasolini e tutti i mostri sacri
dell’immaginario catto-comunista di ieri e di oggi con la stessa nonchalance e
la stessa precisione) sono tutti alle conquiste del passato rinnegate nel
presente. Secondo la logica del fine che giustifica i mezzi. Il fine era fare
fuori mediaticamente e politicamente Berlusconi come adescatore di minorenni e
sfruttatore seriale di prostituzione minorile, il mezzo era il neo moralismo
para talebano di quelle che negli anni ’60 andavano in piazza a dire che
“l’utero è mio e me lo gestisco io”. Ovviamente dietro un fenomeno politico,
pensato dai maschi della sinistra estremista e forcaiola e fatto interpretare
alle femmine del branco, c’è anche un completo “misunderstanding” dell’afflato
libertario della cosiddetta rivoluzione sessuale. Giustamente la Chirico parla
di una sorta di classismo verso le veline e le “olgettine” che vengono dipinte
come “puttane” e come “dementi” solo perché la danno all’uomo ricco e non al
dirigente Rai o al direttore di un grande quotidiano o al filosofo di grido.
Entrambe le tipologie, la puttana oca e quella intellettuale o pseudo tale hanno
invece pari dignità secondo il Chirico pensiero. Avendo il comune fine di
valorizzare il proprio corpo per promuoversi socialmente, cosa che la Chirico
ritiene non solo giusta ma anche necessaria. Però le prime non hanno diritto di
cittadinanza nei salotti buoni della sinistra e della borghesia e le seconde
invece sì. Per non parlare della prostituzione, anche al maschile, del proprio
cervello che forse è ben più squallida di quella animale del sesso. Insomma non
si sa se è peggio adulare un imbecille o andarci a letto. Il pamphlet di
Annalisa Chirico farà sicuramente “incazzare” tante portavoce del nulla che
hanno visto esaurire la loro carica propulsiva di utili idiote dopo la condanna
di Berlusconi in primo grado per prostituzione minorile. Reato commesso, se mai
è stato commesso, con una “ragazzina” che dimostrava molto più dei propri anni
cui nessuno in un dato contesto avrebbe chiesto i documenti prima di scoparci. E
“ictu oculi” non si poteva considerare una povera creatura corrotta da un orco
cattivo. Sarebbe come venire arrestati per avere fatto a botte, prendendocele di
santa ragione, allo stadio con un cristo alto uno e novanta, tatuato e violento,
tipo Genny ‘a carogna, salvo venire a sapere che, dopo averti fatto a pezzi, ti
denuncia per sovrappiù in quanto “minorenne”. Anche questa eccessiva iper
protettività verso i minori senza giudicare caso per caso è purtroppo una delle
trovate legislativo ideologiche del centro destra che per la legge del
contrappasso sono state applicate nella maniera più plateale proprio contro chi
si era battuto per trasformare in legge simili obbrobri. Da Cosimo Mele
all’episodio che recentemente ha coinvolto il marito di Alessandra Mussolini la
storia recente è tutta una grottesca antologia di questa aneddottica da
contrappasso dantesco. Ma questo non significa che siano gli intellettuali, e le
vetero femministe di cui sopra, autorizzati, oggi, a mettere in mostra la
massima disonestà intellettuale possibile nel deprecare le abitudini sessuali e
lo stile di vita di un ex cumenda della politica e della tv. Intendiamoci: nel
libro della Chirico il caso di Berlusconi è citato al massimo un paio di
volte. E sarebbe stato ipocrita da parte sua, giornalista di “Panorama”, se non
lo avesse fatto. Ma la citazione, come quelle da Plutarco, da Shakespeare e da
Francis Bacon, è finalizzata ad esorcizzare il candore che lei definisce
“apollineo” di quelle che in tv si battono il petto contro la mercificazione del
corpo femminile dopo essere state in gioventù convinte baldracche. Oltre alle
Lidia Ravera e alla presidente della Camera Laura Boldrini, gli esempi negativi
di donne di sinistra che trattano le cosiddette olgettine come dementi oltre che
come prostitute, il discorso si allarga a quei maschi compagni di partito da
considerare i mandanti di questo neo puritanesimo di sinistra. Coloro che adesso
utilizzano il moralismo di ritorno, sospetto anche un po’ di acidità da
menopausa, delle femministe di ieri per farne un’arma di battaglia politica. Sia
come sia, il libro di Annalisa Chirico non va raccontato o recensito, ma
semplicemente letto. Perché è esattamente il genere di libro che ognuno di noi
avrebbe voluto scrivere e fare materializzare in pochi minuti nelle proprie mani
oltre che nella propria mente ogni qual volta ha preso la parola ad “Annozero”
negli ultimi quattro anni una come Giulia Innocenzi, cinica interprete e
sobillatrice dell’invidia, anche “del pene”, di tante ragazze di sinistra che
non sopportavano (o fingevano di non sopportare) la narrazione della vita
sessuale dei potenti, specie se di centro destra. Nella fiera dell’ipocrisia che
abbiamo dovuto sorbirci negli ultimi tre o quattro anni dal caso Noemi in poi,
queste rare perle di saggezza e di analisi storico filosofica sono sempre le
benvenute. Dopo avere dovuto sopportare il fatto che l’ex attrice di teatro
Veronica Lario fosse eretta a monumento nazionale vivente, insieme alla sua
mentore Maria Latella, del politically correct made in piazza Indipendenza (oggi
in largo Fochetti) questa soddisfazione ci era proprio dovuta.
“Siamo tutti puttane”,
Chirico: nel mio libro smaschero un’Italia ostaggio del moralismo, scrive
Monica Gasbarri su “Clandestino Web” – “Siamo tutti puttane”, edito da Marsilio,
e nelle librerie dal 7 maggio, è un pamphlet che si scaglia contro l’ipocrisia e
contro il perbenismo imperanti nel nostro paese e parte da un assunto che, in
tempi di “politically correct”, farà storcere il naso a quanti ancora si
aggrappano all’immagine edulcorata della natura umana: l’interesse personale è
democratico. Titolo d’effetto, spirito caustico e provocatorio, il libro
racchiude al suo interno un’anima politica e una più pop come racconta l’autrice
a Data24News. “Non è certo il memoire di una prostituta a fine carriera”
ci spiega Annalisa Chirico, giovanissima giornalista di Panorama, “è un libro
sul sacrosanto diritto di farsi strada nella vita come meglio si può, nei limiti
del lecito ovviamente. Se non ci trovassimo in un paese perbenista come il
nostro non ci sarebbe bisogno del mio libro per ribadire quello che dovrebbe
suonare persino scontato: ognuno ha diritto di mettersi in gioco e di
valorizzare le doti che ha. Ma l’Italia è afflitta da un moralismo asfissiante”.
Di chi è la colpa?
«Una
grossa colpa va imputata, in questi ultimi venti anni, alla sinistra che ha
spostato lo scontro dal terreno della politica a quello della morale. Di fronte
alla “variabile imprevista”, Berlusconi, la sinistra si e’ illusa di potersi
affermare non per quello che faceva ma per quello che pensava di essere:
moralmente superiore».
Le responsabilità sono tutte a
sinistra?
«La
sinistra ci ha raccontato una storia che non si reggeva in piedi, in realtà il
primato morale della sinistra non esiste. La destra non ha mai vantato un
primato morale. Berlusconi ha anzi esibito e ostentato il suo essere un uomo
come tutti gli uomini, entrando così in empatia con l’elettore. Berlusconi non
si è mai proposto come Grande Pedagogo, la sinistra sì. Pensi a D’Alema che ci
ha raccontato per anni che la sinistra rappresentava “la parte migliore del
Paese”. Nel libro intitolo un capitolo al “bunga bunga di Pasolini”, con giovani
persino “più minorenni” della minorenne anagrafica Ruby. Mi soffermo sulle
sregolatezze sessuali di un’altra icona gauchiste come J F Kennedy. Il fronte
cosiddetto progressista è passato dagli slogan sessantottini a favore della
liberazione sessuale all’ipocrisia dei giorni nostri, ai bigottismi bindiani e
ai diktat boldriniani. Per cui l’ardore e la sfrontatezza di alcune giovani
ragazze (che cercano di farsi strada nella vita e che non commettono reati, ma
hanno l’unica colpa di frequentare un uomo potente) diventano il perno di una
campagna mediatica che è tutta politica. Le donne sono ridotte a strumento,
pretesto, vittima sacrificale. Il bersaglio vero è Berlusconi».
Il suo è un saggio
rigorosamente politico.
«Io
incarno il mio libro che non può non essere politico. Esalto figure come
Cleopatra e Madonna, donne fatali che non subiscono ma dominano il desiderio
sessuale maschile. Per le femministe americane degli anni ’80 Madonna è una
traditrice del genere femminile perché sbaraglia il femminismo mainstream che
considera i maschi un nemico».
Ecco introdotto dunque un tema
centrale, quello del femminismo. Quanto spazio ha nel suo testo?
«Io
sono un’appassionata del genere, anche per motivi accademici. Sono cultrice di
studi di genere alla Luiss. Nel libro metto a confronto femminismi diversi,
italiani e stranieri. Dalle seguaci di Diotima alle libertarie americane meno
conosciute in Italia».
In quale si riconosce di più?
«Nel
femminismo della seconda ondata, quello delle grandi battaglie sui diritti
civili, per questioni concreti, per guadagnare maggiori spazi di autonomia.
Oggi, invece, il femminismo è corporativo, avviluppato su se stesso, tutto
concentrato in una battaglia intellettualistica, quasi metafisica. E’ un
femminismo antimodernista».
Non condivide, dunque, le idee
delle italiane di “Se non ora quando”…
«Il
movimento “Se non ora quando” ha delle basi filosofiche assolutamente fragili e
ha strumentalizzato la battaglia delle donne per fini politici. Come se
l’assillo principale delle donne italiane fosse l’ “indomito fallo del premier”.
Invece le battaglie da portare avanti sono ben altre: i tetti di cristallo nel
mondo del lavoro, la salute riproduttiva, la fecondazione assistita, l’accesso
alla contraccezione, tematiche di cui si parla troppo poco in Italia».
Certo che, con un titolo del
genere, il suo libro è destinato a generare polemiche…
«Ben
vengano. La polemica è un esercizio retorico ed intellettuale finissimo. Non è
da tutti. Nel libro rivendico il diritto di ciascuno a “darla” per interesse e
convenienza, ma parlo anche di prostituzione in senso stretto. spiego per
esempio come funziona in Austria e in Germania, dove il sesso a pagamento è
regolato e i sex worker pagano le tasse come ogni altro lavoratore. In Italia
invece le prostitute e i prostituti non possono perché non é riconosciuta loro
alcuna dignità professionale».
Da giornalista quanto è
difficile rompere questo tabù del politicamente corretto?
«L’Italia
è afflitta dal moralismo e dal conformismo imperante. E’ difficile prendere
posizioni contrarie a quello che è il pensiero dominante. in questo devo dire
che hanno un grande ruolo i mezzi di comunicazione, ma anche la classe
dirigente, non solo politica. C’è un completo appiattimento. Io non ho
difficoltà a definirmi una puttana, tra le puttane e i puttani d’Italia. Cerco
di coltivare le relazioni personali che possono essermi utili: l’interesse
personale è democratico e muove il mondo».
Tornando all’attualità, cosa
pensa della polemica delle ultime ore sulla Bacchiddu? Una questione che sembra
calzare a pennello con i temi del suo libro…
«Si
tratta delle solite polemiche italiane sul nulla. Quella della candidata di
Tsipras è una trovata efficace sul piano della comunicazione. Il sesso e la
seduzione del corpo femminile fanno parte della natura. Il corpo è parte di me
non meno delle mie doti intellettuali, e questo vale per tutti. Quindi brava la
Bacchiddu, della quale altrimenti non sapremmo nemmeno il nome. Giocare con il
proprio corpo non è disdicevole. Evviva chi osa. Siamo in Italia, non a Riad.
Teniamolo a mente».
“Siamo tutti puttane”,
Chirico: nel mio libro smaschero un’Italia ostaggio del moralismo.
‘Siamo tutti puttane’ non è un coito interrotto. La Rai è l’alcova del
puttanizio, scrive Annalisa Chirico su “Panorama”. Se Michele Emiliano è in
grado di spiegare il ‘Siamo tutti puttane’ alle femministe imbestialite, vuol
dire che di questo libro c’era un gran bisogno. Dovevate vederlo lo scorso
sabato a Lecce, il sindaco di Bari, quasi estasiato, spiegava e declinava il
messaggio profondo del ‘Siamo tutti puttane’. Ne tesseva l’elogio e l’imponenza,
‘non sono stato abbastanza puttana’, ha ammesso senza celare un filo di
rammarico. E va bene che gli economisti austriaci non vanno di moda in Italia, e
va bene che il panegirico dello scambio e del compromesso non va di moda in
tempi di guerra grillin-guerreggiata. E va bene il ‘negoziare mai’, e va bene
che il titolo è un’efficace provocazione, e va bene che ‘puttane’ è una parola
che non si confà alle educande ben insediate nel circolo elitario
dell’intellighenzia all’amatriciana. Va bene tutto. Ma davvero qualcuno può
pensare che il ‘Siamo tutti puttane’ equivalga ad un coito interrotto? In molte
hanno replicato con altisonanti ed elaborati ‘Io non l’ho mai data a nessuno.
Puttana sarai tu’ o ancora ‘Facci sapere a chi l’hai data ché gliela diamo pure
noi’. Fantastico. Mi perdonerete se di costoro non mi occuperò, per il bene loro
prima che per il mio. Non compilerò alcuna lista, anche perché sarebbe lunga
assai e alle stesse eleganti signore potrebbe appalesarsi una bruciante verità:
se nessuno te l’ha mai chiesta, un motivo c’è. Passiamo invece alle critiche da
prendere sul serio, quelle che meritano. E’ vero, finora ‘Siamo tutti puttane’ è
stato trattato con i guanti dalla stampa di centrodestra, da Panorama (la
testata per cui lavoro) al Giornale a Libero, il Foglio ha dedicato un’intera
pagina, Alessandra Di Pietro ne ha scritto su La Stampa Top News (come del libro
che ‘onora le battaglie femministe negli ultimi due secoli’). Si sono
moltiplicate le interviste sui siti d’informazione online, gli inviti a
presentarlo di qua e di là (farò del mio meglio). Dagospia lo ha esaltato come
solo Dago può. Seguiranno ulteriori recensioni, e mi auguro che le voci
dissonanti afferrino la penna più acuminata per sfornare argomenti su argomenti
contrari alle mie tesi. Del resto, quando abbiamo programmato il lancio de
libro, ho richiesto per prima cosa alla casa editrice Marsilio che una copia
venisse spedita a ciascuna delle talebanfemministe citate nel mio libro. Le
Concite, le Spinelli, le Comencini, tutte. Per la prima presentazione del libro
a Lecce ho invitato la presidente della Camera Laura Boldrini che dopo qualche
giorno di meditazione ha declinato l’invito. Dunque l’autrice di ‘Siamo tutti
puttane’ non si sottrae al confronto. Lo agogna. Sul blog di IoDonna ho letto il
post di Marina Terragni. Lei non è citata nel mio libro. Le critiche sono mosse
in via preventiva, ossia pregiudiziale, dacché la stessa ammette candidamente di
non aver letto il saggio. Spero che almeno dopo la pubblicazione del post
Terragni si sia decisa a leggerlo. Ad ogni modo a lei qualche risposta desidero
darla. Io non dico che per riuscire nella vita devi darla a qualcuno. Anche
perché sono così brava che per scrivere una simile minchiata mi sarei fatta
bastare 3 pagine, non 286. E’ questa una banalizzazione che non fa onore a chi
se la intesta. Io dico che, se nel gioco a dadi con la sorte tu scegli di
scambiare qualcosa di te con l’altro, hai il sacrosanto diritto di farlo.
Avviene ad ogni latitudine, è sempre accaduto e sempe accadrà. Si chiama
libertà. E Terragni, che è donna di mondo, lo sa bene. A questo punto si possono
muovere due obiezioni. La prima riguarda la prostituzione fisica, che ci
infastidisce e ci indigna assai più di quella intellettuale, verso la quale
siamo sorprendentemente benevolenti. La seconda, più insinuante, riguarda il
merito. Qui la questione è semplice. In ambito privato, se uno assume un
incapace, maschio o femmina, solo per meriti extraprofessionali, quel datore di
lavoro se ne assume la responsabilità e il costo. Nel pubblico invece esistono
meccanismi di selezione basati sul merito e sulla competizione tra le persone.
Ma se il sistema scelto consente l’arbitrio della selezione, è inevitabile che
si aprirà la gara a chi offre di più, chi con le cosce, chi con le mazzette, chi
con la forza. Criminalizzare colui o colei che ‘c’ha provato’ significa guardare
il dito e non la luna. Significa cercare il capro espiatorio per non cambiare
nulla. Così hanno agito le talebanfemministe quando hanno puntato il dito contro
le Minetti di turno, contro le vergini del Drago, contro le sfrontate che
accettano inviti galanti, come se il problema fosse un batter di ciglia. Io
difendo il batter di ciglia. Piuttosto, basta con questa idea che se sei un po’
gnocca devi essere per forza scema. La gradevolezza fisica si accompagna spesso
alle rinomate doti intellettuali. Non esiste una secca alternativa, per fortuna.
Pensate ai giornalisti televisivi, di solito non sono dei cessi. Qualche
eccezione, a dire il vero, c’è, ma ai piani alti della Rai, che è il luogo del
puttanizio per antonomasia. Quando sei in sella da un numero imprecisato di
decenni e vai in video a dispetto di ogni legge di gravità, vuol dire che hai
puttaneggiato ad arte prima, costruendo relazioni e simmetrie che ti hanno
permesso di fare quel che fai. E sai farlo meravigliosamente, sia chiaro, perché
anche il merito abbisogna di puttanizio.
LE DONNE IMMIGRATE PER I
GIORNALISTI? MEGLIO SCHIAVE CHE PUTTANE.
Processo alla stampa. Un nuovo
capitolo riempie il saggio “MEDIOPOLI. DISINFORMAZIONE. CENSURA ED OMERTA’”. Il
libro di Antonio Giangrande.
La cronaca è fatta di
paradossi. Noi avulsi dalla realtà, manipolati dalla tv e dai giornali, non ce
ne accorgiamo. I paradossi sono la mia fonte di ispirazione e di questo voglio
rendere conto.
In Italia dove tutto è
meretricio, qualche ipocrita fa finta di scandalizzarsi sull’esercizio della
professione più antica del mondo. L’unica dove non si ha bisogno di abilitazione
con esame di Stato per render tutti uniformi. In quell’ambito la differenza
paga.
Si parla di sfruttamento della
prostituzione per chi, spesso, anziché favorire, aiuta le prostitute a dare quel
che dagli albori del tempo le donne danno: amore. Si tace invece della riduzione
in schiavitù delle badanti immigrate rinchiuse in molte case italiane. Case che,
più che focolare domestico, sono un vero e proprio inferno ad uso e consumo di
familiari indegni che abbandonano all’ingrato destino degli immigrati i loro
cari incapaci di intendere, volere od agire.
Di questo come di tante altre
manchevolezze dei media petulanti e permalosi si parla nel saggio “Mediopoli.
Disinformazione. Censura ed omertà”.
E’ da venti anni che studio il sistema Italia, a carattere locale
come a livello nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi,
raccolti in una collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo",
letti in tutto il mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media
nazionali. Pennivendoli venduti all’economia ed alla politica. Book ed E-Book
che si possono trovare su Amazon.it.
Un esempio.
Una domenica
mattina di luglio, dopo una gara podistica a Galatone in provincia di Lecce, nel
ritorno in auto lungo la strada Avetrana-Nardò insieme a mio figlio ed un altro
amico intravediamo sedute sotto il solleone su quelle sedie in plastica sul
ciglio della strada due figure familiari: le nostre vicine di casa. Non ci
abbiamo mai parlato, se non quando alla consuetudinaria passeggiata serale di
uno dei miei cani una di loro disse: che bello è un chow chow! Ciò me li rese
simpatiche, perché chi ama gli animali sono miei amici.
Poi poverette sono diventate
oggetto di cronaca. I loro nomi non c’erano. Ma sapevo trattarsi di loro.
“I
carabinieri di Avetrana hanno denunciato un 31enne incensurato poiché sorpreso
mentre prelevava due giovani rumene dal loro domicilio di Avetrana per condurle
a bordo della sua autovettura, nella vicina località balneare di Torre Lapillo
del comune di Porto Cesareo (Le), dove le donne esercitavano la prostituzione -
scrivevano il 22 agosto 2014 “La Voce di Manduria” e “Manduria Oggi” - I
militari, che da diversi giorni monitoravano gli spostamenti dell’uomo, ieri
mattina, dopo aver pedinato a bordo di auto civetta, lungo tutto l’itinerario
che dal comune di Avetrana conduce alla località balneare salentina, decidevano
di intervenire bloccando l’autovettura con a bordo le due giovani ragazze ed il
loro presunto protettore, proprio nel punto in cui le donne quotidianamente
esercitavano il meretricio. Accompagnati in caserma, le rumene di 22 anni sono
state solo identificare mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà
alla Procura della Repubblica di Taranto, con l’accusa di favoreggiamento della
prostituzione. Lo stesso è stato inoltre destinatario del foglio di via
obbligatorio dal comune di Avetrana per la durata di tre anni.”
Tutto a caratteri cubitali,
come se fosse scoppiato il mondo. E’ normale che succeda questo in una Italia
bigotta e ipocrita, se addirittura i tassisti sono condannati per aver
accompagnato le lucciole sul loro posto di lavoro e ciò diventa notizia da
pubblicare. Le stesse ragazze erano state oggetto di cronaca anche
precedentemente con un altro accompagnatore.
“Ai domiciliari un 50enne di
Gallipoli per favoreggiamento della prostituzione. Le prostitute, che vivono ad
Avetrana, venivano accompagnati lungo la strada per Nardò,” scriveva ancora il
18 luglio 2014 “Manduria Oggi”.
“Accompagnava le prostitute
sulla Nardò-Avetrana in cambio di denaro. Ai domiciliari 50enne gallipolino”,
scriveva il 17 luglio 2014 il “Paese Nuovo”.
“I militari della Stazione di
Nardò hanno oggi tratto in arresto, in flagranza di reato, MEGA Giuseppe, 50enne
di Gallipoli, per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Nell’ambito
dei controlli alle ragazze che prestano attività di meretricio lungo la
provinciale che collega Nardò ad Avetrana, i Carabinieri di Nardò, alcune
settimane orsono, avevano notato degli strani movimenti di una Opel Corsa di
colore grigio. Pensando potesse trattarsi non di un cliente ma di uno
sfruttatore o comunque di un soggetto che favorisse la prostituzione, i militari
hanno iniziato una serie di servizi di osservazione che hanno permesso di
appurare che il MEGA, con la propria autovettura, accompagnava sul luogo del
meretricio diverse ragazze, perlopiù di etnia bulgara e rumena. I servizi svolti
dai militari di Nardò hanno permesso di appurare che quotidianamente il MEGA,
partendo da Gallipoli, si recava in Avetrana, dove le prostitute vivevano e ne
accompagnava alcune presso la provinciale Nardò – Avetrana, lasciandole lì a
svolgere il loro “lavoro” non prima però di aver offerto loro la colazione in un
bar situato lungo la strada. Per cui, avendo cristallizzato questa situazione di
palese favoreggiamento dell’attività di prostituzione, nella mattinata odierna i
militari di Nardò, dopo aver seguito il MEGA dalla sua abitazione e averlo visto
prendere le due prostitute, lo hanno fermato nell’atto di lasciarle lungo la
strada e lo hanno portato in caserma assieme alle due ragazze risultate essere
di nazionalità rumena. Queste ultime hanno confermato di svolgere l’attività di
prostituzione e di pagare il MEGA per i “passaggi” che offre loro. Viste le
risultanze investigative, il MEGA è stato tratto in arresto per favoreggiamento
della prostituzione e, su disposizione del P.M. di turno, dott. Massimiliano
CARDUCCI, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione”.
Come si evince dal tono e
dalla esposizione dei fatti, trattasi palesemente di una velina dei carabinieri,
riportata pari pari e ristampata dai giornali. Non ci meravigliamo del fatto che
in Italia i giornalisti scodinzolino ai magistrati ed alle forze dell’ordine. E’
un do ut des, sennò come fanno i cronisti ad avere le veline o le notizie
riservate e segrete.
Fatto sta che le povere
ragazze appiedate, (senza auto e/o patente) proprio affianco al dr Antonio
Giangrande dovevano abitare? Parafrasi prestata da “Zio Michele” in relazione al
ritrovamento del telefonino: (proprio lo zio lo doveva trovare….). Antonio
Giangrande personaggio noto ai naviganti web perché non si fa mai “i cazzi
suoi”. E proprio a me medesimo chiedo con domanda retorica: perché in Italia i
solerti informatori delegati non fanno menzione dei proprietari delle abitazioni
affittate alle meretrici? Anche lì si trae vantaggio. I soldi dell’affitto non
sono frutto delle marchette? Silenzio anche sui vegliardi, beati fruitori delle
grazie delle fanciulle, così come il coinvolgimento degli autisti degli autobus
di linea usati dalle ragazze quando i gentili accompagnatori non sono
disponibili.
Un fatto è certo: le ragazze
all’istante sono state sbattute fuori di casa dal padrone intimorito.
Che fossero prostitute non si
poteva intuire, tenuto conto che il disinibito abbigliamento era identico a
quello portato dalle loro italiche coetanee. Lo stesso disinibito uso del sesso
è identico a quello delle loro italiche coetanee. Forse anche più riservato
rispetto all’uso che molte italiane ne fanno. Le cronache spesso parlano di
spudorate kermesse sessuali in spiaggia o nelle piazze o vie di paesi o città.
Ma questo non fa scandalo. Come non fa scandalo il meretricio esercitato dalle
nostre casalinghe in tempo di crisi. Si sa, lo fanno in casa loro e nessuno li
può cacciare, nè si fanno accompagnare. Oltre tutto il loro mestiere era usato
dalle ragazze rumene per mangiare, a differenza di altre angeliche creature che
quel mestiere lo usano per far carriere nelle più disparate professioni. In modo
innocente è la giustifica per gli ipocriti. Giusto per saltar la fila dei
meritevoli, come si fa alla posta. E magari le furbe arrampicatrici sociali sono
poi quelle che decidono chi è puttana e chi no!
Questa mia dissertazione non è
l’apologia del reato della prostituzione, ma è l’intento di dimostrare
sociologicamente come la stampa tratta alcuni atteggiamenti illegali in modo
diseguale, ignorandoli, e di fatto facendoli passare per regolari.
Quando il diavolo ci mette la
coda. Fatto sta che dirimpettai a casa non ne ho. C’è la scuola elementare. Ma
dall’altro lato della mia abitazione c’è un vecchio che non ci sta più con la
testa. Lo dimostrano le aggressioni gratuite a me ed alla mia famiglia ogni
volta che metto fuori il naso dalla mia porta e le querele senza esito che ne
sono conseguite. Però ad Avetrana il TSO è riservato solo per “Zio Michele
Misseri”, sia mai che venga creduto sulla innocenza di Cosima e Sabrina. Dicevo.
Queste aggressioni sono situazione che hanno generato una forte situazione di
stalking che limita i nostri movimenti. Bene. Il signore in questione (dico
quello, ma intendo la maggior parte dei nostri genitori ormai inutili alla
bisogna tanto da non meritare più la nostra amorevole assistenza) ha da sempre
delle badanti rumene, che bontà loro cercano quanto prima di scappare. Delle
badanti immigrate nessuno mai ne parla, né tanto meno le forze dell’ordine hanno
operato le opportune verifiche, nonostante siano intervenuti per le mie chiamate
ed abbiano verificato che quel vecchietto le poverette le menava, così come
spesso tentava degli approcci sessuali.
Rumene anche loro, come le
meretrici. Ma poverette non sono puttane e di loro nessuno ne parla. In tutta
Italia queste schiave del terzo millennio sono pagate 500 o 600 euro al mese a
nero e per 24 ore continuative, tenuto conto del fatto che sono badanti di gente
incapace di intendere, volere od agire. Sono 17 euro al giorno. 70 centesimi di
euro all’ora. Altro che caporalato. A queste condizioni non mi meraviglio nel
vedere loro rovistare nei bidoni dell’immondizia. A dormire, poi, non se ne
parla, in quanto il signore, di giorno dorme e di notte si lamenta ad alta voce,
per mantenere sveglia la badante e tutto il vicinato. Il paradosso è che il
signore e la sua famiglia sono comunisti sfegatati da sempre, pronti, a loro
dire, nel difendere i diritti del proletariato ed ad espropriare la proprietà
altrui. Inoltre non amano gli animali. Ed è tutto dire.
Le badanti, purtroppo non sono
puttane, ma semplici schiave del terzo millennio, e quindi non meritevoli di
attenzione mediatica.
Delle schiave nelle italiche
case nessuno ne parla. Perché gli ipocriti italiani son fatti così. Invece dalle
alle meretrici. Zoccole sì, ma persone libere e dispensatrici di benessere. Se
poi puttane non lo sono affatto, le donne lo diventano con l’attacco mediatico e
gossipparo.
LA PALUDE DEGLI SCRITTORI.
LE VESTI STRACCIATE E LA LAVATA IN PUBBLICO DEI PANNI SPORCHI DEGLI (A LORO
DIRE) INTELLETTUALI.
Mettete in scena una commedia
inesistente in cui editori mafiosi manovrano addirittura centinaia di voti
popolari, o autori con famiglie numerosissime e stuoli di schiavi o clientes……
Campiello, una cinquina
contestata.
Un esito che non è piaciuto per niente al figlio Vittorio, che in serata ha
sparato ad alzo zero come suo solito: «Sono indignato - ha detto - ma non perché
hanno escluso mio padre, ma perché hanno perso l’occasione di far parlare di un
premio che di suo è morto, e di fare un omaggio a uno dei fondatori, Gian
Antonio Cibotto: cosa c’era di meglio che premiare un esordiente ultranovantenne
piuttosto che il solito trentenne (in realtà Valenti di anni ne ha 50, ndr)? E
cosa di meglio che fare un omaggio a Cibotto, dando spazio a un suo amico, che
parla come lui del Po e della vita che gli scorre intorno? Così rinnegano le
loro origini, sono degli incapaci. E tutto per far passare due libri Einaudi,
una prova della loro mafiosità».
Campiello, tutti contro Sgarbi
per la polemica sul libro del padre, scrive “Il Gazzettino”. Il Campiello
riparte il giorno dopo da Vittorio Sgarbi. Dalla sua nuova entrata a gamba tesa
sulle scelte di una giuria che ha deciso di lasciare fuori dalla cinquina finale
il libro del padre esordiente a 93 anni. Riassumendo il pensiero del critico: il
Campiello è un premio morto, ci sono mafiosità, persone incapaci, giurati a cui
piacciono cose schifose eccetera. Ovviamente promettendo un bombardamento di
strali futuri, già iniziato in tv. I destinatari di tali, simpatiche attenzioni
cercano di non scendere in battaglia, limitandosi molto signorilmente a
rispedire al mittente le tante illazioni, ribadendo come il Campiello sia un
premio vivo, libero e del tutto autonomo nelle scelte, da parte di una giuria,
che come quasi tutte le giurie, non ha trovato accordo unanime, ma ha scelto in
piena serenità. Insomma: non c’è assolutamente voglia di infuocare la polemica,
lasciando il profilo della risposta nella più ordinata ed elegante spiegazione.
Riccardo Calimani, componente della Giuria dei letterati, spiega subito le
scelte sue e dei compagni d’avventura: «Il libro del papà di Sgarbi è un buon
libro, che è stato apprezzato e ben discusso da tutti noi. Quindi le sue
reazioni sono assolutamente fuori regola, logica e assolutamente sbagliate e del
tutto inaccettabili. La violenza verbale, poi, è deprecabile. Dire poi che il
Campiello è morto non ha senso. Il Campiello è un premio vivissimo,
assolutamente libero e lo dimostra proprio perché la presidente Monica
Guerritore si è dichiarata non contenta dell’esito finale, questo a
dimostrazione che non eravamo tutti d’accordo, come capita spesso nelle giurie,
ma il verdetto finale ci ha lasciati del tutto sereni». Anche Piero Luxardo,
presidente del Comitato di gestione, non accetta la "morte" del Campiello:
«Morto? Le polemiche semmai dimostrano esattamente il contrario. Le
manifestazioni di Sgarbi sono nelle loro consuete tinte diciamo estroverse, che
fanno parte del personaggio. Pazienza, non saprei che altro dire, se non che il
Campiello è un premio libero, trasparente, non condizionabile. Essendo la seduta
pubblica, durante la quale tutti sanno chi e come ha votato, è chiaro che è
impossibile parlare di risultato predeterminato. Ma comunque non voglio
commentare certe frasi vivaci, sopra le righe. Noi non abbiamo nessun manuale
Cencelli da soddisfare. Anche sulle opere prime abbiamo dibattuto in modo
articolato, e siccome il Campiello passa spesso per un premio a tematica
industriale, diventa paradossale che la scelta sia caduta su un romanzo che
parla di intossicazione per amianto di un operaio». Infine lo scrittore Mauro
Corona, uno dei cinque finalisti, che conferma la richiesta di Sgarbi a cedere
il posto al padre: «Vittorio mi ha telefonato per questo. Ma le giurie sono come
le sentenze dei tribunali: non si discutono. Mi ha chiesto un gesto eclatante,
ma al di là di dire di no, non credo sia nemmeno contemplato dal regolamento. E
poi non credo che suo padre sarebbe orgoglioso di approdare in questo modo in
finale. Posso solo dire che il libro del papà è proprio un gran bel libro. A me
non interessa sapere se qualcuno crede che il premio Campiello sia morto. Io
ringrazio solo la giuria che ha avuto lungimiranza e coraggio a mettermi nella
cinquina».
Passano Mari, Corona, Fontana,
la Garavini e Falco. Fuori Sgarbi senior. La Guerritore voleva «un’altra
cordata». E la stroncatura di Cordelli su «la Lettura» si fa sentire, scrive
Marisa Fumagalli su “Il Corriere della Sera”. Non s’era mai visto al Campiello
un presidente di Giuria esprimere con tanta schiettezza la delusione per il
risultato della Cinquina che «non è la mia». E neppure era mai accaduto che, nel
corso della seduta pubblica per la selezione dei finalisti, lo stesso presidente
leggesse nell’aula Magna del Bo un brano di un’opera in gara. Con dizione
perfetta, certo. Ed anche con quella dose di teatralità che si addice a un
attore. Anzi, a un’attrice. Parliamo di Monica Guerritore, presidente della 52°
edizione del Premio fondato dagli industriali del Veneto, che occupa da tempo
una solida posizione di prestigio nel panorama letterario italiano. «La nostra
cordata non ce l’ha fatta», ha detto chiaro e tondo, la Guerritore, in chiusura
di votazione, alludendo evidentemente ad alcuni colleghi della Giuria (composta
da 10 membri lei compresa), allineati nelle valutazioni dei libri in concorso.
Vero è che, rispetto all’anno passato, la gara per entrare nella rosa dei 5, in
marcia verso la vittoria che sarà decisa dalla Giuria Popolare dei 300, è stata
piuttosto movimentata. Sei giri di tavolo per trovare la quadra della Cinquina,
così definita: Roderick Duddle di Michele Mari (Einaudi, 8 voti), La voce degli
uomini freddi di Mauro Corona (Mondadori, 6), Morte di un uomo felice di Giorgio
Fontana (Sellerio, 6), entrati nella rosa alla prima votazione. Le vite di monsù
Desiderio di Fausta Garavini (Bompiani, 6), alla seconda; La gemella H di
Giorgio Falco (Einaudi, 5), alla sesta. Quest’ultimo ha dovuto giocarsela fino
all’ultimo con Giuseppe Sgarbi, ultranovantenne, «padre d’arte» di Vittorio ed
Elisabetta. «Il riscatto di un uomo delicato, sensibile, elegante, nei confronti
di due figli e una moglie ingombranti», chiosava con ironia il giurato Philippe
Daverio. Ma Lungo l’argine del tempo (Skira) ha dovuto cedere il passo a La
gemella H. Con i voti di Silvio Ramat, Luigi Matt, Nicoletta Maraschio, Paola
Italia. Poi, si è aggiunto Riccardo Calimani. Mentre Ermanno Paccagnini,
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Salvatore Silvano Nigro, agli ultimi giri,
sono andati a zig zag. «La rosa ideale spesso comprende più di 5 libri — osserva
Paccagnini —. In dirittura d’arrivo si deve stringere, e qualche voto viene dato
più per contrastare che per favorire». Nella cinquina caldeggiata dal
presidente, infine, avrebbe figurato soltanto uno dei favoriti: Michele Mari. (E
neppure al primo posto, al terzo). Ma quanto è oggettivo il valore di un libro?
Ad ogni edizione del Campiello, assieme alle tendenze di stagione, ai filoni
letterari, affiora nel dibattito anche il tema dei criteri di valutazione delle
opere. Quest’anno, si segnala una polemica divampata fuori dal Premio ma che in
qualche misura lo riguarda da vicino. Al centro c’è lo scrittore entrato in
cinquina Giorgio Falco, indicato tra gli esempi di mediocrità narrativa da
Franco Cordelli, in un articolo pubblicato la scorsa domenica su «la Lettura»,
supplemento culturale del «Corriere della Sera». Il critico stronca l’autore de
La gemella H, per poi lanciare un attacco alla «palude» letteraria dove si
annidano gruppi che perseguono «la sopravvivenza editoriale». E altro ancora. La
riflessione di Cordelli non è passata inosservata. Consensi e dissensi si
rincorrono sul web e sulle pagine culturali dei quotidiani. In attesa della
sfida finale al Gran Teatro La Fenice di Venezia (13 settembre), il Premio di
Confindustria Veneto ha già un vincitore. Si tratta del Campiello Opera Prima
2014, attribuito dalla Giuria a La fabbrica del panico di Stefano Valenti
(Feltrinelli). «Racconta una storia familiare che diventa corale di fronte alla
malattia e alla morte per amianto», si legge nella motivazione. A narrarla,
muovendosi tra i ricordi, è il figlio quarantenne che sente la necessità e il
dovere di stringere un rapporto più ravvicinato col padre, sceso a Milano dalla
Valtellina per morire in fabbrica. «Per questo riconoscimento, il competitor di
Valenti era Giuseppe Sgarbi», rivela Monica Guerritore.
La palude degli scrittori.
Che cosa ci lascia la produzione editoriale degli ultimi vent’anni?
Sguardo su autori o «tribù» che si sono formate, forse in modo inconsapevole,
scrive Franco Cordelli su “Il Corriere della Sera”. Le «sagome sudate»... Quando
sono arrivato a queste due parole ho avuto un moto di rabbia, di sicuro
eccessivo. Ma si sa che per un sintagma si può perdere la testa — in un doppio
senso. Le «sagome sudate», che per me non vuol dire niente, compare in un
romanzo di Giorgio Falco: La gemella H. Compare nella prima pagina. Poi
invitando me stesso alla calma ho messo da parte La gemella H e ho preso il
libro precedente di Falco, L’ubicazione del bene, che avevo conservato ma non
letto. Di questo sono arrivato fino in fondo. «L’aria accucciata».Ne cito due
frasi: «Le pale del ventilatore girano lente, sembrano acchiapparsi a vicenda,
al prossimo giro, spiate dall’aria accucciata». Sappiamo bene che si possono
usare metafore in mille modi, che si possono avere visioni, che si può
stravolgere fino a essere considerati veggenti. Ma se si può accettare che le
pale sembrino acchiapparsi, chi ha mai visto l’aria accucciata? L’altra frase,
ancora da L’ubicazione del bene, dice: «L’aria (sempre l’aria! ma è molte pagine
avanti, in un altro racconto) arriva dal basso, noi siamo a disagio nel restare
fermi, disabituati a quell’ariosità gratuita, così andiamo verso uno dei
cannocchiali che, come molte altre cose, per avere senso ha bisogno dell’energia
di una moneta». Come non pensare che per scrivere «l’energia di una moneta» di
fantasia bisogna averne molta? Qualunque cosa sia, una simile espressione,
metafora o che altro, non è un bello scrivere. Al più (ovvero al meno) è un modo
di scrivere che ha il merito di mostrare l’intenzionalità, la volontà d’essere
originali, il mettersi in posa. Sfiguramento proprio del conflitto bellico. Alla
lettura di Falco ero arrivato sull’onda di una stampa a lui molto favorevole,
nell’ambito di una circoscrizione che per comodità diremo d’«avanguardia». Ed
ecco poi (dopo l’avvenuta lettura) proprio su La gemella H un articolo di
Giorgio Vasta, il cui primo libro non avevo finito di leggere per motivi
analoghi a quelli di Falco. Anche dell’articolo di Vasta do due esempi di prosa
che a qualcuno è parsa letteratura pura e a me pura farneticazione. Prima frase:
«Si ha la sensazione che Falco sia dominato da una duplice ossessione: da un
lato dal bisogno di ricomporre per via letteraria una genesi del contemporaneo,
vale a dire quella cosa che chiamiamo presente; dall’altro dal desiderio di
rendere conto nella lingua (e dove, se no? né posso trattenermi dall’osservare
che contemporaneo e presente sono la medesima cosa) — rendere conto nella lingua
di ogni microfenomeno umanamente percepibile — gli infrasuoni, l’ultravioletto,
le più minuscole increspature dell’esistente». La seconda frase di Vasta dice:
«Il transito dalla guerra alla pace permette un’ulteriore consapevolezza: la
messa in torsione dell’etica (questo, della frase che qui ripeto, è il picco),
il suo sfiguramento proprio del conflitto bellico, non è qualcosa che termina
con la fine della guerra ma prosegue in forme più attenuate e diluite,
socialmente compatibili». A me sembra incredibile che questi due scrittori
possano essere esaltati. Eppure così è. Riconoscimento di una tribù. Li
ritroviamo in una tanto ricca quanto tendenziosa antologia di Andrea
Cortellessa, La terra della prosa, dedicata agli scrittori che hanno esordito
dopo il 1999. Ed è a questo punto che m’è sembrato di uscire da un lungo sonno,
quello in cui, e io con essa, è caduta la letteratura italiana contemporanea:
non più un campo di forze, una scacchiera su cui sia possibile — come era fino
alla soglia degli anni Novanta — scorgere e valutare linee di tendenza, gesti
peculiari, prese di posizione esplicitamente e implicitamente teoriche e
soprattutto opere di qualità, impugnate con argomenti critici riconoscibili e
validi, se non per tutti almeno per i più. Invero la letteratura italiana degli
ultimi vent’anni (a cominciare dal declino della critica, impoverita ancor più
di romanzo e poesia) non è che una palude, in cui il bello e il brutto sono
detti e sostenuti secondo un percorso prestabilito: pubblicazione (ma pubblicano
tutti), recensione, premio. Non c’è altro. Oppure c’è, a guardare bene, meno
distrattamente, il riconoscimento di una tribù: una adesione prodiga di stilemi
iperbolici. Sì, la faccenda è uguale per tutti, o quasi tutti; la plausibilità
del valore è minima o nulla; la palude nasconde gruppi che non si riconoscono
come tali, che neppure sanno di esserlo, e in cui ognuno per conto proprio
persegue lo stesso fine — vale a dire (prima ancora del successo) la
sopravvivenza editoriale, o presso l’editore per il quale si pubblica, o dello
stesso editore, insidiato a sua volta da sempre nuovi editori — almeno quanto
costoro sono insidiati da sempre nuovi scrittori. Non è questione di «buoni» o
«cattivi». Questo grafico, il grafico che qui presento, è un tentativo di
guardare dentro la palude — più o meno dove non si vede niente, o poco, o in
modo confuso. Ovviamente ciò che vedo e trascrivo è frutto della mia percezione,
del mio sguardo. Ma non è la mia opinione intorno al buono o al cattivo. Parlo
solo di ciò che tra un anno potrebbe essere diversissimo ma che in questo
preciso momento balza agli occhi, ossia di ciò che viene valutato criticamente
ad un certo livello, di qualità, o appunto di intrinseca necessità perfino
personale. Parlo non già d’una totalità, ma d’una parte — appunto la meglio
visibile. Voglio chiarire: parlo di ciò che viene percepito (che credo venga
percepito in questo momento come culturalmente significativo — almeno un poco);
e di come chi viene percepito percepisce se stesso e gli altri, i lontani e i
meno lontani, vale a dire gli appartenenti alla stessa tribù. Ne consegue che i
cento scrittori non nominati non lo sono per la medesima ragione, perché poco o
troppo percepiti. Essi appaiono culturalmente irrilevanti (almeno
nell’immediato: la maggior parte dei poeti, che ha rinunciato a dire qualcosa in
più, rispetto ai propri versi) o già acquisiti in una sfera di vera o presunta
eccellenza o quanto meno dignità (culturale e, naturalmente, artistica). In
quanto ai settanta nominati. Il numero è una mera casualità o, se si vuole, una
mezza necessità. Le categorie, o caselle, o tribù, o famiglie. Sono qui ridotte
allo schema parlamentare perché esso resta, benché a vanvera, eloquente.
Eloquente, come? Non posso che semplificare, ridurre, stravolgere. A sinistra
(novisti) troviamo un che di simile a una casta di incerta memoria politica,
erede di una tradizione di stile e rigore e i cui esponenti, per quanto sempre
in prima linea, faticano a ritrovare l’antico vigore; esterna a questa, una
sparuta e ideologicamente incoerente raccolta di nomi di irriducibili guardiani
dell’hic et nunc (dissidenti); a destra, quanti mostrano un’orgogliosa
indifferenza per il tempo che passa e sono spesso riconosciuti in quanto sempre
reattivi a ciò che viene di sinistra presunto (conservatori); l’estrema destra,
di matrice dannunziano-pasoliniana, si caratterizza per un’aggressività verbale
e una vistosa muscolarità (vitalisti); a fare da ago della bilancia, il
centro-moderato, una forza ad alta vocazione istituzionale pronta ad assumere
sulle proprie spalle il ruolo che la società culturale gli riconosce (moderati);
ai margini il gruppo misto — simile al suo analogo parlamentare — composto da
minoranze, transfughi e orfani; assisi nel distacco della loro indiscussa
celebrità, i senatori a vita guardano con relativa attenzione a quanto gli
accade intorno. Da questi settanta nomi ne estraggo due per diminuire i
possibili equivoci. Walter Siti compare tra i novisti né in ragione della forma
dei suoi romanzi né in ragione dei loro contenuti, ma perché pur essendo egli un
uomo fondamentalmente di destra («resistere non serve a niente») fu oggetto di
ammirazione presso lettori che si considerano di sinistra, o meglio cultori del
nuovo, avanguardisti, sperimentali ecc. Giorgio Ficara — il cui Riviera è
considerato un contributo innovativo, nella riconosciuta crisi e insopportazione
del romanzo, a questo genere da lui stesso ritenuto obsoleto (ma per me Riviera,
comunque eccellente, è un libro di viaggio) — Ficara compare tra i conservatori
per ragioni che ritengo del tutto casuali, per avere egli quegli amici, quei
sostenitori, le altre dieci persone nominate nel suo schema: che sono quelle a
lui più vicine, o dal punto di vista del gusto o nella vita di tutti i giorni.
Cordelli, penna rossa ma
distratta. La critica colpisce «giovani avanguardie» dotate di un pensiero
solido, eppure assolve scrittori più famosi che usano una lingua desueta e
lontana dal presente, replica Gilda Policastro su “Il Corriere della
Sera”. A leggere lo sfogo di Franco Cordelli uscito domenica su «la Lettura»,
che senza scandalo possiamo definire idiosincratico, vien da chiedergli
immediatamente dov’era, negli ultimi (a dir poco) dieci-quindici anni, mentre
anche da noi s’inveravano le profezie di Schiffrin e gli allarmi di un’editoria
soccombente alla necessità di trarre profitto non solo o non più dal fatturato
complessivo ma da ogni singolo titolo stampato, col sacrificio programmatico
dell’opera costata al suo autore, diceva Leopardi, «anni di fatica e grandissimo
lavoro» e destinata in partenza agli altrimenti famigerati venticinque lettori o
ancor meno. Dov’era mentre gli editori diventavano imprenditori e gli editor
venivano assunti di preferenza tra ragazzetti non laureati, che dei libri
pretendevano innanzitutto una sinossi, aspettandosi (o esigendo) poi che lo
stile si adeguasse per contratto alle trame seriali come sceneggiati da prima
serata di Raiuno, e normalizzando qualunque violazione (l’iperbato, questo
sconosciuto) linguistica, stilistica, strutturale. Dov’era quando l’aggettivo
«rastremato» veniva da uno di codesti pischelli espunto da una copertina (di ciò
ha esperienza diretta chi scrive) perché «non esiste in italiano», salvo
inserirci di suo pugno un errore marchiano di concordatio (un’endiadi in una
bandella vorrebbe il verbo al plurale: vaglielo a spiegare); e dov’era quando
gli editori si ostinavano a selezionare gli autori e i libri dei rispettivi
autori in base alle vendite del libro precedente, quando gli anticipi milionari
si riservavano agli autori televisivi e agli altri non restava che elemosinare e
ringraziare in ginocchio per il compenso corrisposto a rate e appena appena
superiore alla pessimistica previsione di vendita dei librai. Tutto questo,
secondo Franco Cordelli, è ininfluente, non riconfigura il perimetro del campo
letterario, non lo determina, non lo condiziona, non gli cambia i connotati?
Mentre negli ultimi dieci-quindici anni si è distratto per sua stessa
ammissione, Cordelli oggidì non trova di meglio, per rientrare nel dibattito sul
romanzo contemporaneo, che impugnare la penna rossa e emendare gli aggettivi
impropri di Falco e Vasta, i due scrittori più apprezzati della generazione
cosiddetta TQ. Quelli che riescono, malgrado la loro raffinatezza stilistica e
complessità concettuale, a farsi pubblicare in sedi come Stile Libero (il cui
editor sarà uno di quei ragazzetti di cui dicevamo: e infatti non edita, e giù
errori, incongruenze, ridondanze) e Laterza, a scrivere su «Repubblica», a farsi
recensire e premiare. Se con merito o senza, non lo deciderà l’epiteto «sudato»
(leopardiano anch’esso, tra l’altro), con buona pace del Nostro, il quale non ha
mai avuto simpatia per le avanguardie, e che oggi, come quelle al tempo, non ha
simpatia per il romanzo egemone, specie se generazionale (con qualche sparuta
eccezione: lo stilista Bajani, i cui romanzi scorrono piacevolmente e però dopo
un giorno o due si dimenticano come una bella bevuta d’acqua fresca dopo una
passeggiata in collina). Ma come si fa a liquidare l’opera di un autore
stralciandone un sintagma? Si potrebbe ripetere lo stesso esercizio con tutti i
libri, classici compresi e nessuno escluso. È come quando vai dal medico con le
analisi fatte di fresco e gli sottolinei il valore per te ansiogeno del
colesterolo o della glicemia improvvisamente aumentata. Non è serio se si
allarma a sua volta, se diagnostica una malattia terminale. È serio se ti chiede
di ripetere le analisi, perché è il trend a determinare la patologia, non il
caso isolato. E il benessere del corpo non si misura dal singolo organo
eventualmente in sofferenza, ma dall’insieme. Giorgio Falco e Giorgio Vasta, con
buona pace di Cordelli, sono due tra i migliori scrittori emersi nei famigerati
Anni Zero per consapevolezza del mondo (non solo letterario) e padronanza della
scrittura, ma soprattutto perché la loro scrittura non è un orpello né un
fumogeno bensì l’impalcatura di un pensiero solido (o, piuttosto, è il pensiero
a costituire l’impalcatura di una facciata più o meno riuscita a seconda dello
specifico libro e della singola pagina), portatore di significati.
Appropriandoci del metodo Cordelli, prendiamo ad esempio Antonio Scurati (che
nella tabellina annessa al pezzo – o viceversa? - si merita un posto d’onore
chissà perché tra i vitalisti, accanto ai consentanei Genna e Di Consoli e ai
diametralmente opposti Nove e Moresco): come esordisce sulla pagina la
protagonista del suo ultimo romanzo (candidato a tutti i principali premi
letterari, anche quelli che hanno nella giuria professoroni e cattedratici)?
«Giulia ha erotto in un pianto convulso» (sic!). E poco più avanti scopriamo
ammantate di un’«indubbiamente indubbia bellezza» le rivali della medesima
Giulia. Ahi: dov’era l’editor quando questi specimina di vitalismo andavano in
stampa? E Cordelli e la sua penna rossa, ubi erant. Ma la vera colpa di Scurati
non è nemmeno quella sua lingua desueta e improbabile come il patetico rewind di
una nonna che si ostini a parlare di Carosello al nipotino che gioca coi
Pokemon, è piuttosto l’incapacità di rappresentare un mondo, il mondo come lo
vede lui, persino, e di pretendere a ogni nuovo libro di sciorinarci ore rotundo
le sue trite consapevolezze sociologiche, incastonate in una qualche letale
tramina raffazzonata. Perché Cordelli non si accanisce piuttosto su Scurati?
Trova che sia più opportuno che il romanzo contemporaneo si occupi di padri
fedifraghi e morbosità cronachistiche assortite che di terrorismo e olocausto?
Risponderebbe che non gl’importa di cosa, ma di come. Dunque avevano ragione i
deprecati neoavanguardisti, ma anche Nanni Moretti: chi parla male pensa male,
le parole sono importanti. E sono tanto più importanti le parole di un critico
monumentale come Cordelli, soprattutto quando consacrano o escludono, più che
mai in una tabellina che si preoccupa di mappare il contemporaneo seguendo i
percorsi canonici dell’appartenenza all’antico o della propensione al nuovo.
Giglioli, Mazzoni, Cortellessa, Laura Pugno e Valeria Parrella però qui vanno a
braccetto, tutti insieme, scrittori e critici e certi scrittori con certi
critici. Ubi sunt (tra i novisti cosiddetti), a dire solo di alcuni (e di
alcune: esistono anche le donne-critico, Cordelli!) Cecilia Bello Minciacchi,
Daniela Brogi, Clotilde Bertoni, che recensiscono con una competenza e
profondità che non ha decisamente nulla da invidiare ai colleghi (maschi)
laureati da Cordelli, poesia, romanzo, cinema contemporanei? Perché se nella
palude ammette di non orientarsi, non fa allora come in Dante, dove «quei c’ha
mala luce» può volgere lo sguardo solo verso ciò che è lontano rinunciando, per
dichiarata «vanità d’intelletto», a ciò che «s’appressa?» Riviera. No, dico:
Riviera. Ma chi potrebbe parlarne, tra i critici a me coetanei (e non solo: il
problema non è di rottamazione ma di ampiezza di sguardo), in una disamina del
romanzo contemporaneo da affossare aut salvare? E chi salverebbe, tra i critici
del romanzo contemporaneo, i pur volenterosi Andrea Caterini e Stefano Gallerani
a scapito di Paolo Giovannetti, Pierluigi Pellini e Gianluigi Simonetti
(marchiati forse dall’aborrita provenienza accademica, ma certamente con
maggiori e migliori titoli all’attivo dei nominati), chi potrebbe mai dire,
avendo letto (e riletto: che il grande romanzo è quello che vuoi e puoi
rileggere a distanza di anni) Scuola di nudo e Troppi paradisi,
che Siti è un reazionario? Cos’è più reazionario, mirare alla pagina levigata (e
nei fatti indolore) o alla sostanza marcia e brutta delle cose, ostentare un
italiano da romanzo ottocentesco in traduzione o «sapere bene come scrivere
male»? Cordelli, l’Armani di Ponte Milvio, si contamini con altri mondi e altre
forme (altro che il vitalismo all’amatriciana tirato in ballo) come ha fatto
Siti, e se non ne ha il coraggio (letterario, intendiamo), che almeno si lasci
contaminare dalle parole, trascurando, nelle sue faziose, raffinate, elitiste
pagelline, le sapienti tessere lessicali, la callida iunctura, l’agudeza. Per
quello ci sono i classici di sempre, da Orazio a Marino a D’Annunzio a Landolfi,
fino a Manganelli. Che poi l’italiano (letterario) è proprio come la salute:
ognuno se ne allestisce una versione e visione conveniente e ci si adatta, anche
coi peggiori guasti. Perché sono quelli, insegnano i foucaultiani, a rendere al
corpo come meccanismo la sua unicità. A questo bisogna guardare, quando si
emette la diagnosi: anche perché i sani sono nella vita normale (che Cordelli si
picca di privilegiare stigmatizzando l’aggettivazione incongrua dei deprecati
«due Giorgi») molto spesso dei noiosissimi ipocondriaci, non trovate?
In Italia, la vera «palude»
risiede nello scarso sostegno alla cultura. Pochi fondi per gli scrittori,
mancanza di una politica che vada a nutrire quella «società culturale» che
potrebbe risollevare anche l’economia, replica Raffaella Silvestri su “Il
Corriere della Sera”. «Che cosa ci lascia la produzione editoriale degli ultimi
vent’anni?»: domenica scorsa, leggendo l’articolo di Franco Cordelli su «la
Lettura», ho cercato di farmi la stessa domanda, pur partendo da presupposti
diversi. Avevo provato per la prima volta a fare il punto della situazione
editoriale italiana per un pubblico straniero, sul «New York Times»; così
domenica ho cominciato, in un certo senso, una riflessione a ritroso: dal
raccontare com’è casa mia a un estraneo, provo ora a osservarla come se la
vedessi per la prima volta dall’interno (del resto, da pochissimo tempo la
visito dall’interno e ancora non ne distinguo le stanze con chiarezza). Dov’è il
sostegno agli esordienti? Mi sembra, intanto, che la produzione editoriale degli
ultimi vent’anni sia fortemente e tristemente segnata da due elementi: in primo
luogo una mancanza di fondi dedicati ai programmi culturali, agli scrittori
esordienti soprattutto. Questo lascia interamente alle case editrici il compito
di leggere, scoprire, «allevare» la nuova generazione di scrittori, quelli che
segneranno la produzione editoriale dei prossimi vent’anni. In un’industria in
contrazione, che perde il 7% di anno in anno, e che di conseguenza dispone
risorse più limitate di un tempo, questo mi sembra un compito titanico, che
meriterebbe il supporto di istituzioni equivalenti, ad esempio, al francese
Centre National du Livre. Dall’altra parte, poi, c’è l’anomalia legata ai pochi
riconoscimenti dati alle voci femminili italiane. Voci che esistono, producono
narrativa di qualità, eppure vengono citate meno dei loro colleghi uomini,
eppure raramente vincono premi veramente prestigiosi (l’ultimo Strega più di
dieci anni fa: sintomo forse che, come nella società in generale, anche nella
società letteraria la situazione di gender non vede miglioramenti). Se
questi due punti poco hanno a che fare con le categorie della palude, molto
hanno a che fare invece con la produzione che troviamo in libreria, molto
c’entrano, anche, con il numero esiguo di scrittori chiamati, in modo secondo me
condivisibile, «moderati»: scrittori di cui ci sarebbe invece un forte bisogno,
proprio per la loro caratteristica di «assumere sulle proprie spalle il ruolo
che la società culturale gli riconosce». La società culturale. La società
culturale è la parte della società che ogni intellettuale dovrebbe provare a
estendere, in un’Italia in cui il 57% della popolazione non ha toccato un libro
nell’ultimo anno. La società culturale, per come la intendo io, è quella che
legge i giornali, compra i libri, sa decifrare un testo complesso (il 70% degli
italiani oggi, secondo l’OCSE, non è in grado di farlo). Storicamente, la
società culturale italiana rappresenta una piccolissima parte della popolazione.
Ci sono varie ragioni per cui questa è la verità oggi: la nascita tardiva di una
classe media, la televisione che non ha contribuito a crearla (né, del resto,
sarebbe stato suo compito farlo). Ragioni storiche che tendono tutte alla
situazione odierna: una polarizzazione della cultura, più che una frammentazione
precisa. Da una parte la letteratura cosiddetta alta, dall’altra parte quella
cosiddetta di consumo, una distinzione più triste di quella della palude,
eppure, forse, più vicina alla percezione del fruitore medio di cultura
italiana. Si tratta di una percezione che ha bisogno di essere infranta,
cambiata, sostituita con una diversa, più democratica. Perché se, come sosteneva
Spinazzola, ogni libro risponde a un bisogno del pubblico, esiste una reale
necessità di mediazione non giudicante e non prevenuta fra questo bisogno e
l’offerta, così ampia, di letteratura contemporanea.
Giù le mani dalla critica di
Cordelli. Il suo è un clamoroso atto di libertà. La polemica nata significa che
molti scrittori di oggi hanno una straordinaria opinione di se stessi, e che
null’altro si aspettano – dalla critica e dalla vita – che l’applauso, replica
Andrea Di Consoli su “Il Corriere della Sera”. Si potrebbe dire — e non
insisterò su questo, perché sarebbe una scorciatoia un po’ ribalda – che la
debolezza dell’avanguardia letteraria italiana a partire dal Gruppo 63 sia stata
la robustezza teorica e la fragilità delle opere letterarie corrispondenti. E
non insisterò su quest’aspetto per tanti motivi, anzitutto perché ogni critico
onesto dovrebbe sforzarsi di essere anche almeno un po’ uno storico, e perciò un
intellettuale rispettoso e magari indulgente, soprattutto nei confronti della
commovente fragilità di ciascun scrittore, comunque la pensi o la si pensi. Le
accuse al «gruppo sperimentale». Eppure mi rendo conto che facile non è, questa
massima tolleranza che mette a dura prova le certezze del nostro io, cioè del
nostro gusto, perché forte è la tentazione di agire per impulsi umorali, oppure
per settarismi, fanatismi. Dico questo perché molto mi hanno sorpreso le
insofferenze, le stizze rancorose e gli anatemi rivolti a Franco Cordelli, reo
di aver scritto un articolo su «la Lettura» dello scorso 25 maggio al quale era
annesso uno schema di scrittori classificati secondo macro-categorie abbastanza
generiche, com’è inevitabile per simili sistemazioni giornalistiche. Al di là
degli insulti, figli di una società che molte ambizioni sollecita e troppe
frustrazioni procura, il nodo critico rilevante, anche a livello di cronaca
letteraria, è il divorzio di Cordelli con la letteratura e critica «novista». In
sostanza, Cordelli ha sconfessato in un articolo – che evidentemente, vista
l’impetuosità delle reazioni, covava da tempo – autori del «gruppo sperimentale»
come Giorgio Falco, del quale Cordelli stigmatizza «la volontà di essere
originali, il mettersi in posa». Può una teoria letteraria così reboante
accontentarsi? Personalmente non ho letto Falco, e dunque nulla posso dire sulla
sua opera, ma è evidente che la dura sortita di Cordelli è figlia di un
ripensamento che ha il sapore di un’abiura o, più correttamente, di una
ritrovata libertà; oppure, a un livello più malizioso, dell’eterno ritorno della
questione che ponevo in apertura di articolo, ovvero se davvero una così
reboante teoria letteraria possa poi accontentarsi di partorire opere che
sembrerebbero non all’altezza delle premesse teoriche con le quali si
presentano. Nulla, ripeto, posso dire su Falco; ma qualcosa posso dire intorno
all’equivoco – sul quale pure intervenni in passato in polemica con Cordelli –
che si è determinato in sede critica soprattutto a partire dalla pubblicazione
del romanzo Il Duca di Mantova (ricordo per inciso che non solo questo
romanzo, ma anche Il poeta postumo del 1978, furono opere di cosiddetta
autofiction, e davvero non si capisce come altri più attardati si siano visti
riconoscere il merito di aver inaugurato questo genere in Italia) che
rappresentò dal mio punto di vista il vertice più alto dell’adesione da parte di
Cordelli – mi si perdoni la semplificazione – alla «scrittura nova», spesso
sollecitata e quasi modulata dal Andrea Cortellessa, notevole critico letterario
afflitto, purtroppo, dal morbo del settarismo. Cordelli è stato qualcosa in meno
e qualcosa in più di questa prospettiva. Parve, a quell’altezza, che tutta
l’opera narrativa e critica di Cordelli fosse nata da una costola un po’ eretica
del Gruppo 63. Io sapevo, al contrario, che le cose non stavano in questo modo,
anche perché non potevo dimenticare opere romanzesche quali Guerre lontane
e Un inchino a terra, che nulla avevano da spartire, pur ribadendo la
natura non conciliata della sua idea di romanzo, con chi auspicava e auspica una
letteratura resistenziale, sabotatrice, arma primaria per lottare alla radice
(linguisticamente) «il sistema», che poi è semplicemente la vita, cioè la
realtà. Cordelli è sempre stato qualcosa in meno e qualcosa in più di questa
prospettiva. Non mi sfuggì per esempio in anni antecedenti a Il Duca di
Mantova la sua adesione a scrittori quali Carlo Levi, Ennio Flaiano, Oreste
del Buono, Giancarlo Fusco, Sandro De Feo; scrittori, cioè, di «terza strada»,
sintesi e dunque avanzamento del conflitto – spesso puramente estetico-retorico
– tra Avanguardia e Tradizione. Nessuno quanto Cordelli ha criticato tutte le
avanguardie del teatro. E voglio ripeterlo a beneficio di quanti non lo sanno o
fingono di dimenticarlo: nessuno come e quanto Cordelli ha raccontato e
criticato tutte le avanguardie possibili del teatro d’avanguardia italiano,
almeno dalla fine degli anni ’60 in poi – e la stessa cosa, a ben pensarci, vale
per la letteratura, non soltanto italiana. Dunque Cordelli è uno scrittore
d’avanguardia? La risposta è no, e questo non significa affatto che egli sia
scrittore della tradizione, oppure del romanzo conciliato, compiaciuto della
propria meccanica armonia. Cordelli è, appunto, in una «terza strada», in
un’oscillazione estremamente complessa, spiazzante, nutrita, sempre consapevole
della dannosità di «valori» o nevrosi quali il settarismo, l’odio programmatico
per la realtà, il sentimento di superiorità di chi pensa di poter dividere il
mondo in dannati e salvati o, ancora peggio, in happy few soddisfatti di
possedere i segreti della cabala stilistica, che poi spesso si risolve in un
banale esibizionismo lessicale (ché il lessico, purtroppo, non è lo stile). Ora
io non entrerò nella polemica sulle collocazioni degli scrittori in quella o in
quell’altra macro-categoria. Io stesso, che sono stato collocato tra i
«vitalisti di destra», avrei molto da ridire, ma non già in chiarezza, ma dal
punto di vista del dubbio, perché, a ben pensarci, mi sarei trovato assai bene
anche nel «gruppo misto», tra i «conservatori», oppure tra i «dissidenti».
Guardiamo con ammirazione a un gesto dolorosamente giocoso. Ma me ne sto con
ironia nel casellario dove Cordelli mi ha voluto mettere, e mai mi sognerei
d’insultarlo – come ha fatto un giovanotto assai arrogante e presuntuoso, fermo
al suo primo libretto – per il solo fatto di non avermi messo altrove (dove poi,
tra i «novisti», i «senatori», i «moderati»?). Non scherziamo, per favore.
Piuttosto guardiamo con ammirazione a un gesto dolorosamente giocoso che ha
fatto arrabbiare tutti, e che ha azzerato in un colpo solo ogni tentativo di
assimilare Cordelli a un «gruppo». Perché il suo, di fatto, è stato un clamoroso
(e, se si vuole, spavaldo) atto di libertà. Libertà, per esempio, di poter dire
che il libro di Alessio Torino è un bel romanzo senza affidargli ruoli
palingenetici o resistenziali, visto che troppo subordinata alle logiche della
politica peggiore appare il parlar bene di libri magari belli (come quello di
Falco) usandoli come clave per liquidare il mondo intero, in maggioranza venduto
al capitalismo, linguisticamente corrotto e stilisticamente miserabile. E mi
chiedo: è possibile parlar bene di un libro senza usarlo per fini politici,
ovvero di potere, di cordata? Giù le mani, perciò, da Cordelli, dalla sua
complessità. È possibile evitare la costituzione di gruppi o gruppuscoli, spesso
«usati» come scudi umani per portare avanti lotte che null’altro sono se non
lotte politico-ideologiche, oppure, perché nasconderlo?, lotte di egemonia
personale? Giù le mani, perciò, da Cordelli, dalla sua complessità, dalla sua
sofferta sintesi tra Avanguardia e Tradizione, tra sguardo freddo e lirismo; e,
soprattutto, rispetto per uno scrittore che è tra i pochi ad avere un posto
sicuro nella nostra storia letteraria post-68. Aggiungo infine a beneficio di
qualche livoroso in servizio permanente che questo non è un articolo in difesa
di Cordelli (troppe volte ho polemizzato con lui per meritarmi questo sospetto).
È, molto più semplicemente, un articolo che vorrebbe richiamare, me per primo,
al dovere civile della tolleranza rispettosa, dell’autoironia e della
leggerezza. Perché gettare fango su uno scrittore che ha deciso di prendere le
distanze da un’assimilazione critica non riuscita e che ha voluto esprimere,
avendone l’autorevolezza, una schematizzazione della letteratura odierna che gli
sembra più viva e presente? E perché non concordare con lui che troppi tra
coloro che gettano fango solo perché «esclusi» o «mal collocati» nulla hanno
letto non soltanto dello stesso Cordelli ma anche – e faccio dei nomi a caso –
di Vassalli, Celati, Montefoschi o La Capria? Perché conta soltanto l’egemonia
del e nel presente, ovvero il successo, fosse anche l’anti-successo degli
scrittori dell’Avanguardia di oggi – spessi «usati», ripeto, in funzione
politico-ideologica? Una società letteraria matura e non frustrata avrebbe
accolto l’articolo e lo schema di cui stiamo parlando discutendoli nel merito,
oppure accettandoli con un sorriso o uno sfottò. È successo invece il finimondo,
in pubblico e in privato. Probabilmente questo significa che molti scrittori di
oggi hanno una straordinaria opinione di se stessi, e che null’altro si
aspettano – dalla critica e dalla vita – che il monumento, l’applauso, il
complimento assoluto, sperticato, superlativo.
La «palude» è letteraria e
politica. Ma la cultura ha bisogno di conflitto. Le contrapposizioni estetiche
di un tempo hanno lasciato il posto a una sorta di amicizia/inimicizia, una
condizione di non belligeranza, in cui tutti puntano ad assicurarsi una
dignitosa carriera di scriventi (pubblicazione-recensione-premio), replica
Gabriele Pedullà su “Il Corriere della Sera”. Le metafore sono importanti. Lo ha
ricordato Andrea Cortellessa, rimproverando a Franco Cordelli di aver associato
l’immagine della palude al concetto di mappa: le paludi, proprio perché
instabili, non possono essere cartografate. Cortellessa ha rivendicato invece il
lavoro di quanti – a cominciare dalla sua antologia La terra della prosa
– hanno cercato di mettere un po’ di ordine nelle patrie lettere con i soli
strumenti adeguati per un simile compito improbo: leggendo, ragionando,
assumendosi la responsabilità di scegliere. Proprio grazie a questo lavoro un
primo atlante ora c’è. Come tutti i lettori dell’articolo di Cordelli anche io
sono stato colpito da questa immagine, che a molti degli inclusi e degli esclusi
è apparsa un insulto gratuito al proprio lavoro. A me l’immagine della palude
non dispiace. La palude non allude solo alla instabilità dei confini (in questo
caso del canone degli esordienti dal 1999 in poi), ma suggerisce inevitabilmente
un luogo sgradevole e ben poco ospitale. Sono anzi sicuro che se Cordelli avesse
formulato la medesima idea adoperando una similitudine più gentile, per esempio
se avesse parlato di «brodo primordiale» della letteratura del XXI secolo (la
soluzione di acqua e molecole carboniose da cui sono nate le prime molecole
organiche), nessuno si sarebbe offeso. Salvo, ovviamente, gli assenti. A me
invece l’immagine della palude non dispiace affatto. E non per le ragioni di
Paolo Sortino, che ha rivendicato la formula di Cordelli per descrivere il corpo
a corpo dello scrittore nella melma della lingua e si è paragonato a «una carpa
gravida di batteri». Credo, semplicemente, che la metafora di Cordelli non sia
geografica (come pensa Cortellessa), né biologica (come ritiene Sortino), ma più
verosimilmente politica. Palude come massa informe, interessata a sopravvivere.
La Palude, non necessariamente con la lettera maiuscola, è il soprannome che al
tempo della Rivoluzione francese avevano ricevuto i membri della Convenzione
nazionale non schierati né a sinistra, con la Montagna, né a destra, con i
Girondini: i quattrocento parlamentari pronti a fornire indifferentemente il
proprio sostegno agli uni e agli altri, appoggiando prima il Terrore giacobino e
poi la controrivoluzione del Termidoro. Una massa informe, interessata
soprattutto alla propria sopravvivenza politica e composta di cinici gregari,
insuperabili nel fiutare il vento con il necessario anticipo per riposizionarsi.
Anni fa, sfogliando per una vecchia rivista patinata degli anni Ottanta, mi
capitò di imbattermi per caso in un durissimo attacco di Cordelli ai propri
coetanei (Daniele Del Giudice, Andrea De Carlo, Antonio Tabucchi, Elisabetta
Rasy…), accusati di essersi fatti complici di un grande Termidoro letterario.
Evidentemente, a trent’anni di distanza, Cordelli non ha mutato atteggiamento
verso il presente, né campo metaforico. Palude è l’Italia (letteraria e non
solo) emersa dal tramonto degli ideali degli anni Settanta. «Partito dei
flemmatici» era l’altro soprannome della Palude. E proprio perché l’intervento
di Cordelli vuole essere eminentemente politico, è inutile rimproverargli – come
da tanti è stato fatto in questi giorni – di non aver scritto un articolo di
critica letteraria. Che cosa è dunque che Cordelli non ama nella letteratura,
anzi nei letterati, d’oggi? Oltre alle similitudini di Falco e alla prosa di
Vasta, esattamente la condizione liquida della cultura italiana, dove le
contrapposizioni estetiche di un tempo hanno lasciato il posto a una sorta di
amicizia/inimicizia, che non è nell’una né l’altra ma piuttosto una condizione
di non belligeranza, in cui tutti puntano anzitutto ad assicurarsi una dignitosa
carriera di scriventi (pubblicazione-recensione-premio) attenendosi al motto di
«non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te». Per tradurre in
termini sociologici la diagnosi di Cordelli, i gruppi in lotta per il controllo
della società letteraria che hanno caratterizzato il Novecento avrebbero
lasciato il campo a una incerta federazione di comunità, interessate a sostenere
i propri campioni negoziando di volta in volta con le altre onori e
riconoscimenti piuttosto che attraverso un conflitto aperto. «Partito dei
flemmatici» era l’altro soprannome della Palude, e Cordelli avrebbe potuto usare
anche questa formula. Per un uomo della sua generazione (venticinque anni nel
1968, non dimentichiamolo), il piccolo cabotaggio di oggi è il peccato capitale.
Costringere gli scrittori a prendere posizione. E la classificazione affidata
alle pagine de «la Lettura» è anche un modo per costringere i diretti
interessati a prendere partito (una volta tanto) e a pronunciarsi. Anche se,
sino a questo momento, si direbbe che il principale effetto ottenuto
dall’articolo di Cordelli sia stato invece quello di compattare i giovani
scrittori contro di lui, in un nuovo, paradossale, slancio unanimistico. Come
volevasi dimostrare. Non tutto convince nelle famiglie di Cordelli, ma su un
punto è impossibile dargli torto: la Palude, la vocazione alla Palude, è la
grande tendenza del nostro tempo. Da membro onorario della tribù dei «novisti»,
i più politicamente battaglieri, non posso evidentemente che essere d’accordo
con lui (chi sono i «novisti»? Ecco la descrizione feroce di Cordelli: «una
casta di incerta memoria politica, erede di una tradizione di stile e rigore e i
cui esponenti, per quanto sempre in prima linea, faticano a ritrovare l’antico
vigore»). Invece, la cultura italiana avrebbe disperatamente bisogno di più
conflitto – e non sulla base di banali risentimenti personali, ma perché capace
di dividersi di nuovo su grandi opzioni letterarie, stilistiche, politiche. Il
conflitto può far male. Ma il conflitto è anche l’unico strumento che abbiamo
per dare un senso alla nostra attività intellettuale oltre il giustificabile ma
assai limitato obiettivo di sbarcare il lunario. Se tutto va altrettanto bene,
allora la letteratura nel suo complesso non ha più alcun valore. E se non siamo
disposti ad accapigliarci (meglio, certo, se educatamente) per una rima o per
una metafora, allora tanto meglio cercarci un altro lavoro. Personalmente,
ritengo che la letteratura italiana più recente sia in uno stato di salute assai
migliore di quello che suggerisce Cordelli, ma lui stesso, occorre riconoscere,
nelle sue recensioni ha spesso dato prova di grande curiosità e apertura. Quello
che soffre, e non da ora, è il sistema letterario nel suo complesso, dove tra
l’inimicizia personale e l’acquiescenza interessata è scomparso lo spazio per il
dissenso e la discussione critica. La smodata, irragionevole passione dei
trenta-quarantenni per Pasolini e le sue intemperanze appare da questo punto di
vista una sorta di compensazione simbolica per l’eccessiva prudenza degli
stessi. Un anno e mezzo fa, con la richiesta di 50 mila euro da parte del
senatore PD e giallista Gianrico Carofiglio al poeta Vincenzo Ostuni (che lo
aveva definitivo «scribacchino»), un altro confine è stato superato: da questo
momento, con un precedente tanto illustre, ogni italico scrivente potrà prendere
seriamente in considerazione l’ipotesi di citare in giudizio il critico o
collega che non gli ha riservato gli elogi che riteneva di meritare. Non tutto è
ancora compromesso. In quell’occasione, per fortuna, attorno a Ostuni si venne a
condensare una ampia rete di solidarietà (Cordelli compreso): e non in nome di
una sin troppo scontata e generica libertà di espressione, ma di una idea di
cultura sottratta agli avvocati e in cui il conflitto possa farsi ancora lievito
delle idee come è stato nel Novecento. Non tutto, dunque, è ancora compromesso.
È dello stesso problema, credo, che parla Cordelli nel suo articolo. Perché
oggi, al tempo della Grande Palude, il conflitto è visto male (e si paga) anche
quando non viene sanzionato in un tribunale della Repubblica. Sarà sufficiente
un unico esempio. Il «novista» Cortellessa, autore dell’antologia da cui è sorta
la polemica, è il maggiore giovane critico italiano (in un paese nel quale si è
giovani critici sino a cinquant’anni e giovani poeti fino a quando non si entra
nei «Meridiani», per chi ci entra), non solo perché Cortellessa è un interprete
formidabile e un lettore onnivoro; il «novista» Cortellessa è il maggiore
giovane critico italiano perché ormai, volenti o nolenti, è alle sue scelte che
tutti gli altri devono rifarsi: che sia per prendere posizione a favore o
contro. Troppo conflittuale, troppo libero. Basta infatti sfogliare
distrattamente Terra della prosa o gli interventi sulla poesia raccolti
ne La fisica del senso per rendersi conto come nessuno, nella nostra
generazione, abbia prodotto una ricognizione altrettanto approfondita e
appassionata sulla letteratura contemporanea: una ricognizione che non può
essere ignorata anche da quanti manifestano il proprio disaccordo. Sono in
molti, ormai, a riconoscergli questo merito. Eppure che, io sappia, nessun
quotidiano di questo paese ospita regolarmente le recensioni di Cortellessa: il
quale dopo una deludente collaborazione con «La Stampa» è dovuto emigrare sul
web, dove adesso scrive anzitutto su «doppiozero». Troppo conflittuale, troppo
libero, in definitiva troppo innamorato della letteratura, questo Cortellessa.
Perché Palude e Consenso sono rispettivamente il nome e il cognome della
malattia che, emarginando alcune delle voci più libere e offrendo a tutti una
bella lezione di conformismo, rischia di uccidere il nostro sistema delle
lettere. Torniamo in Montagna? L’invito, con «antico vigore», non è rivolto solo
ai «novisti».
Non prendetevela con Cordelli.
Fa una proposta, non impone leggi. Lo schema cordelliano è un’istantanea, i cui
valori possono quindi cambiare nel tempo. Un’occasione per giocare con
l’immaginario delle poetiche. Senza rabbie inutili, replica Alessandro Beretta
su “Il Corriere della Sera”. Mi sono piaciuti Giorgio Falco, Giorgio Vasta e,
anche per la sua parzialità, l’antologia curata da Andrea Cortellessa – nella
sua prima edizione per Ponte Sisto – dedicata ai narratori italiani degli anni
Zero: ne ho scritto bene, in diverse sedi, di tutti e tre. Logica vorrebbe che
non sia d’accordo con Franco Cordelli. Peccato si stia parlando di gusto e
critica, materie ben diverse dalla rigidità di altre discipline. Sulla palude,
poco da aggiungere: viviamo in un paese insano. Quindi, mi è piaciuto anche
l’articolo di Cordelli, e l’ho letto e riletto fino a viverlo come un racconto
da camera dedicato alla letteratura italiana contemporanea. Se non condivido i
suoi giudizi sui tre nominati in apertura, ciò non toglie che trovo interessante
l’immagine che finisce per dominarlo: un parlamento che sorge in mezzo a una
palude. Sulla palude, c’è poco da aggiungere: viviamo in un paese insano– siamo
arrivati allo 0,6 del Pil investito in cultura, siamo gli ultimi in Europa – ed
è normale che il clima non sia dei più accoglienti, anche nei tentativi di
modificarlo. Davanti al Parlamento di Cordelli, invece, la sindrome delle
figurine è scattata immediata: chi c’è, chi non c’è, «celo, manca», quello è
amico suo, quell’altro non poteva non metterlo… Così via. Lo schema cordelliano
è una proposta. Tutti quelli che si occupano di libri ci sono cascati – e lo
stesso procedimento, chiaramente, avviene anche con l’aggiornata antologia
curata da Andrea Cortellessa La terra della prosa, uscito per i tipi de
L’orma, che include 30 autori emersi dopo il 2000. Questo tipo di gioco,
inevitabilmente, vale per ogni classificazione – antologica o schematica che sia
– e in quasi ogni campo. Mi stupisco, allora, per la violenza di certe reazioni:
quel sonno da cui si sveglia Cordelli nel suo articolo, ha generato un po’ di
mostri con reazioni di ogni genere online e offline. Lo schema cordelliano è una
proposta, non una legge, ed è un’istantanea, i cui valori possono quindi
cambiare nel tempo. Lo prendo più come un’occasione per giocare con
l’immaginario delle poetiche, che come una gabbia, e ciascuno può chiedersi dove
gli piacerebbe sedere in Parlamento - ammesso che vi siano nuove elezioni – o
domandarsi perché un autore sta vicino a un altro. Un’anarchia strategica, altro
che un parlamento. Andrebbe forse allestita, di fianco, un’altra Camera dove far
sedere anche editori, agenti, editor, una bella sauna per gli esordienti e un
planetario per i poeti, anche se, chiaramente, costruire in palude non è poi
così facile e bonificarla sarebbe un bene per tutti. Allora, guardo la mia
libreria di autori italiani e mi chiedo: «Li devo spostare?». Devo ricollocare i
libri secondo i settanta suggerimenti di Cordelli? No, li lascio come stanno,
divisi un po’ per città – Milano versus Roma – e regioni, talvolta per
generazioni, ogni tanto per tema o per collana, qua e là secondo un accenno
d’ordine warburghiano. Un’anarchia strategica, altro che un parlamento, e
preferisco lasciarla così, con una certa libertà di letture.
La silenziosa «casta» degli
scrittori. Dove tutti sponsorizzano gli amici. L’articolo di Cordelli ha fatto
venire allo scoperto le conventicole alla base della letteratura italiana di
oggi. Ecco perché, nelle risposte, prevale la frustrazione, conclude
Paolo Di Paolo su “Il Corriere della Sera”. Se l’articolo di Franco Cordelli,
da cui tutto è partito, era spiazzante e perciò anche divertente, la gran parte
delle reazioni non lo sono state: lamentose, lugubri, contorte. O peggio ancora:
opache. Viene il sospetto, a leggere certe repliche in rete e alcuni degli
interventi ospitati da Corriere.it, che alle categorie istituite da Cordelli ne
mancasse ancora una: quella degli «involuti». Nel senso che si ingarbugliano,
fanno pasticci con le parole, usano l’italiano senza disinvoltura, forse perché
non lo amano fino in fondo, e lui, l’italiano, gli si rivolta giustamente
contro. E dove sono, tra i senatori, Arbasino, Maraini o Debenedetti? Partiamo
dal presupposto che si tratta di una polemica per «addetti ai lavori», come si
diceva un tempo: ebbene, se posso considerarmi tale, io non ho capito oltre metà
dei ragionamenti opposti a quello di Cordelli. In fondo, molto in fondo magari,
la sostanza era però quella più biliosa e indicibile: la frustrazione. La spinta
istintiva e umanissima, da esclusi, a puntare i piedi. Tradotta più o meno in
questi termini: «lasciando da parte che Cordelli non mi ha inserito, vorrei
sapere perché non ha inserito nemmeno x e y, che peraltro sono amici miei
stimatissimi». Ma così il gioco non finisce più. Io stesso avrei obiezioni:
perché, al di là del suo valore, c’è Giordano, se Cordelli dice di aver escluso
i «troppo percepiti»? E dove sono, tra i senatori, Arbasino, Maraini o
Debenedetti? E Mazzucco, vitalista moderata? Celati non dovrebbe passare nel
gruppo misto? E il dissidente Maggiani, autore di un pamphlet definivo e
violentissimo sulla generazione dei cinquanta-sessantenni? Comunque. Solo un
premiuzzo può tirarci un po’ su di morale. Un «ispettore del commercio librario»
nella Parigi del 1750 aveva registrato in città, attivi, 359 scrittori, tra cui
Diderot e Rousseau. Oggi, anno 2014, sulla sola piattaforma di self-publishing
ilmiolibro.it gli scrittori attivi sono oltre 20mila. Il punto è questo: la
macro-categoria che include tutte le altre proposte da Cordelli è quella che va
sotto l’aggettivo «frustrati». Lo siamo, inclusi o no, praticamente tutti.
Frustrati perché siamo troppi, perché il cosiddetto mercato non si allarga ma
resta lo stesso o si contrae. Frustrati perché le recensioni non escono e
comunque non servono, i libri passano in libreria per un mese e scompaiono.
Frustrati perché – ci diciamo – l’editore non si impegna. Frustrati perché lo
cambiamo e, nonostante questo, le cose non cambiano. Frustrati perché sentiamo
che il nostro romanzetto non riesce a farsi largo, e che solo un premiuzzo può
tirarci un po’ su di morale, o l’alleanza di qualche simpatico amico a cui
ricambieremo il favore. Nessuno ammetterà che funziona così per tutti (salvo
quei cinque o sei baciati dal vero successo commerciale), e proprio perché non
lo ammetterà nessuno, è vero. Un autore su ilmiolibro.it sponsorizza un suo
compagno. Navighiamo tutti a vista, sempre meno convinti, sempre meno «puri»,
sempre più affannati e stanchi e in alcuni casi cattivi, risentiti. E tutti,
praticamente tutti, caro Cordelli, «poco percepiti». È la tribù a salvarci: qui
Cordelli ha ragione. Fino a trent’anni fa c’era l’unica grande tribù della
letteratura, riconosciuta da una élite, certo, ma più solida e dai contorni più
definiti. E lì convivevano (si fa per dire) i diversi: Calvino e Moravia,
Bassani e Morante. Si guardavano a vicenda, dialogavano, si tenevano d’occhio,
ma erano soli. Maestosamente soli. Nella palude letteraria in cui siamo
condannati a stagnare, ci si tiene d’occhio solo fra amici. Su Facebook se ne ha
la triste certezza: ci si sponsorizza a vicenda, ma solo in una ristrettissima
cerchia. Un autore pubblicato su ilmiolibro.it sponsorizza un suo compagno di
strada pubblicato su ilmiolibro.it, Cortellessa mette nell’antologia i suoi
amici, quell’altro posta la recensione appena pubblicata allo straordinario
esordio del suo ex compagno di scuola. Siamo patetici, ma meglio far finta che
non sia così. E così avanziamo, nell’illusione che il mondo sia quello che
vorremmo che fosse, una ghenga composta di zie, di mamme, dei compagni di
merende; ci facciamo forza così, salvo poi puntare il dito sulle cricche altrui.
Le conventicole contro cui, in un film di Virzì, puntava il dito un Castellitto
professore frustratissimo. Siamo patetici, ma meglio far finta che non sia così.
Allora se Cordelli ha un merito è che lui – a differenza di tutti i suoi
detrattori – prova a leggere quanto più può, a mappare, a capire, è curioso,
anche crudelmente curioso come pochi altri, di tutto, di tutti, degli scrittori
di Roma, d’Italia, del mondo, e ingaggia una sfida titanica contro il
molteplice, l’universale, pur sapendo che è votata al fallimento. Così, ogni
tanto, per fare ordine e per provocare anche sé stesso, sul tovagliolo in un bar
o su una pagina della Lettura, prova a tirare giù una mappa. Gli altri, il 90%,
continuano a leggersi solo tra vicini, tra complici, hanno già deciso da sempre
chi leggere e chi no, hanno già deciso da sempre chi è bravo e chi no, e fanno
tanta, tanta tenerezza perché sono come quel famoso cavaliere ariostesco. «Il
cavalier del colpo non accorto / andava combattendo ed era morto». Esistono un
po’ perché e finché hanno accanto la ghenga. Chi si guarda intorno, chi guarda
oltre casa sua, magari non supera la frustrazione, magari si sente più solo, ma
almeno resta vivo. Paolo Di Paolo.
EDITORIA E CENSURA. SARAH
SCAZZI ED I CASI DI CRONACA NERA. QUELLO CHE NON SI DEVE DIRE.
Editoria e censura. Sarah
Scazzi ed i casi di cronaca nera. Quello che non si deve dire. Quando gli autori
scomodi sono censurati ed emarginati. Il caso che ha sconvolto l'Italia e ha
cambiato per sempre la cronaca nera in due libri-dossier precisi e dettagliati
che fanno la storia, non la cronaca, perché fanno parlare i testimoni del loro
tempo. “Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana. Il resoconto di un avetranese.” E
“Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana. Il resoconto di un avetranese. La
Condanna e l’Appello”. Sono i libri che Antonio Giangrande ha scritto in
riferimento al caso nazionale. In questi libri l’avetranese Giangrande
ripercorre da testimone privilegiato in prima persona tutte le tappe del caso:
gli interrogatori, lo studio degli incartamenti, le analisi delle tracce sul
luogo del delitto, i ragionamenti per entrare nella dinamica del delitto. Da
giurista e da sociologo storico inserisce la vicenda in un sistema giudiziario e
mediatico che ha trattato vicende similari e che non lasciano spazio ad alcuna
certezza. Di Sarah Scazzi si continuerà a parlare a lungo. La vicenda, tra le
più controverse nella cronaca recente del nostro Paese, è stata costantemente
seguita, commentata e interpretata, anche a sproposito. Antonio Giangrande in
questi libri compie un viaggio meticoloso e preciso all'interno delle prove e
delle contraddizioni sia del caso giuridico, che dei suoi controversi
protagonisti. Antonio Giangrande è un punto di riferimento, è il destinatario
della tua prima telefonata per capire cosa sia successo. Le sue analisi sono
sempre schiette, appassionate, cristalline. Mai scontate o banali. Puoi anche
non essere d'accordo, ma dal confronto ne esci più sapiente. Antonio Giangrande,
noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla
rovescia, per una scelta di libertà si pone al di fuori del circuito editoriale.
Questo è un dazio che egli paga in termini di visibilità. Ogni kermesse,
manifestazione, mostra o premio a carattere culturale è in mano agli editori.
Premi e vincitori li scelgono loro, non il lettore. I giornali e le tv dipendono
dagli editori e per forza di cose sono costretti a promuovere gli autori della
casa. Il web è uno strumento per far conoscere gli autori sconosciuti. Antonio
Giangrande usa proprio il web per raccontarsi. «Sono orgoglioso di essere
diverso. In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi
diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io,
in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo
sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo
sottosopra. Che cazzo di vita è? Faccio mia l’aforisma di Bertolt Brecht. “Ci
sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci
sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono
più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci
sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili.”
Rappresentare con verità storica, anche scomoda, ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!» Continua Antonio Giangrande «E’ comodo
definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.
In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto
di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. Faccio ancora mia un
altro aforisma di Bertolt Brecht “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Si è mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per far sapere quello che non si sa? E questo al di là della
convinzione di sapere già tutto dalle proprie fonti? – conclude Giangrande – Si
provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Si scoprirà cosa
succede veramente in un territorio o in riferimento ad una professione. Cose che
nessuno dirà mai. Non si troveranno le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o
i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Si troverà
quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Si può anche non leggere questi libri, frutto di anni di
ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non si potrà più
dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.» “L’Italia del
Trucco, l’Italia che Siamo”. Collana editoriale di decine di saggi autoprodotta
da Antonio Giangrande su Amazon, Create Space, Lulu, Google Libri ecc. Libri da
leggere anche a costo zero. Se invece volete dargli una mano, regalate un libro
di Antonio Giangrande. Scoprirete tutto quello che non si osa dire.
LA SOTTOCULTURA IDIOTA
DELL'ANTIFASCISMO MILITANTE. L'OSTRACISMO ARTISTICO A DANNO DEI MUSSOLINI.
Quando ad un artista è
vietato chiamarsi Mussolini,
scrive Gabriele Lazzaro su “Il Giornale”. La gogna mediatica a cui è
sottoposta in questi giorni Alessandra Mussolini rivela l’immagine di un paese
in crisi culturale prima che economica. La tanto strombazzata crisi non è solo
ciò che ci costringe a fare e rifare i conti durante il mese, è anche quel misto
di pigrizia e di maramaldàggine nel prendersela con una donna per la famiglia a
cui appartiene. Un’ostilità che la Mussolini ha sempre combattuto in maniera
orgogliosa, come quando disse no alla proposta indecente di varcare le porte del
Parlamento come “Alessandra Floriani”, e anche, in alcuni casi, con una certa
autoironia, come quando si definì “portatrice sana di cognome”. Ma facciamo un
passo indietro nella storia di Alessandra, una storia che l’ha vista ostacolata
a priori in un’infinità di occasioni. Ha frequentato l’università in anni di
antifascismo militante, ed è stata costretta dalle contestazioni a poter
scegliere solo la facoltà di medicina. Le è stato detto: “E tu con quel cognome
vorresti fare filosofia morale?” Si è presenta per sostenere un esame al
cospetto di un professore che le chiese “Mussolini Mussolini?”. “Sì, Mussolini
Mussolini”. E il libretto in un attimo gettato a terra con disprezzo. “Alzati, e
va’ a raccoglierlo”. L’Italia che siamo, l’Italia che vogliamo è quella che fa
dipendere la cultura solo da uno stato di famiglia? Gli Italiani che sostengono
la decadenza e l’impoverimento ideale della Roma della “grande bellezza” sono
gli stessi che twittano continuamente attacchi contro la Mussolini? Prima
dell’ascesa politica la nipote del Duce ha rivelato un talento artistico
confermato anche da Eduardo De Filippo. Ma la sua filmografia è breve,
brevissima, ancora una volta per motivi dipendenti da quel cognome così tanto
scomodo. Dino Risi la volle incontrare per proporle il ruolo della figlia di
Sophia nel remake televisivo della “Ciociara”. Ma in realtà fu solo un’occasione
per umiliarla, ancora una volta, proponendole di cambiare il nome in Alessandra
Zero. Perché “prima di dimenticare questi occhi dovranno passare sette
generazioni”. Gli attacchi di questi giorni rivelano che non si aspettava altro
che un suo cedimento per fare rivivere lo stesso ostracismo di cui è stato
vittima anche il padre Romano, grandissimo jazzista eppure così poco
considerato. Così poco invitato nelle trasmissioni televisive. Per l’ovvio
impedimento del cognome. Ma perché non essere apprezzati, stimati, semplicemente
per quello che si è? Perché voler vedere in quel “Mussolini” posto dopo il nome
la negazione di tutto? È vergognoso. Così come, di fronte alla vicenda
matrimoniale di Alessandra, vergognosa è stata la reazione di Vladimir Luxuria.
Una reazione non giustificata neppure da quel “meglio fascista che frocio”,
sicuramente infelice ma smentito dalle tante occasioni in cui Alessandra ha
dimostrato di battersi per i diritti individuali. Sfatando quel mito che la
vuole a tutti i costi omofoba. Luxuria è solo l’ultima di una lunga fila di
intellettuali e gente comune, la cui “passione civile” si sveglia solo in
presenza di un capro espiatorio. Che responsabilità ha la Mussolini nelle
vicende del marito? Ovviamente nessuna. Ovviamente è una delle parti lese. Ma
ecco il paradosso: “quel” cognome l’ha resa semplicemente una donna sola,
costretta a difendersi contro tutto e tutti.
SESSO E CIVILTA’. IL COMUNE
SENSO DEL PUDORE: QUANTO E’ COMUNE E QUANTO E’ IMPOSTO?
Ci sono testimonianze di peni eretti bene
auguranti nelle grotte paleolitiche di Lascaux, nei postriboli pompeiani fino a
giungere ai graffiti che deturpano le città moderne. Un tempo si facevano
persino delle processioni al dio Priapo chiamate falloforie (portatori di
fallo). Gli artisti di
Lascaux
hanno creato un mondo sotterraneo
e sconvolto
Picasso,
lasciandoci con i misteri della loro vita e del perché hanno questa “Cappella
Sistina” della preistoria,
scrive Raffaele Bonadies. Nel 1940, all’uscita da una grotta in Francia, Pablo
Picasso, non noto per la modestia, si lasciò quasi cogliere dallo sconforto:
«Non abbiamo inventato niente» disse. Aveva appena visto l’opera dei nostri
antenati, Homo
sapiens di 17.300 anni fa, che
crearono a Lascaux quella che è stata definita la “Cappella Sistina della
preistoria”,
un capolavoro di
pittura rupestre.
Scoperto proprio nel 1940 da quattro ragazzi (col loro cane Robot) in Dordogna,
in Francia, la grotta è un labirinto di circa 235 metri di lunghezza, in lieve
pendenza. Suddivisa convenzionalmente in 7 sale, dalla
Sala dei Tori
alla Navata al
Pozzo, contiene circa 2.000
figure che possono essere classificate in tre gruppi: animali, figure umane e
segni astratti. Nei primi, la parte del leone la fanno i cavalli (364) e i cervi
maschi (90), anche se i veri capolavori sono le figure degli uri, i buoi
selvatici che popolavano le foreste europee. Come per altre grotte in Francia e
Spagna, come
Chauvet o
Altamura,
non sono chiare le ragioni che hanno spinto gli uomini a ritrarre gli animali
sulle pareti della grotta. Secondo alcuni studiosi alla base di tutto c’è la
religione, e le visioni degli sciamani, grazie alle quali erano in grado di
ritrarre animali visti tempo prima. Erano allucinazioni indotte da danze che
portavano in uno stato di
trance o da
sostanze psicotrope. Poiché le specie dipinte erano le più potenti e pericolose
della fauna della zona (uri, cavalli e bisonti), forse i dipinti servivano a
esorcizzare il pericolo che si correva cacciando questi animali, o addirittura a
insegnare ai giovani le migliori tecniche di caccia a queste prede. Ci sono in
compenso molti segni astratti, punti o figure geometriche, che alcuni studiosi
ritengono rappresentino costellazioni visibili dalla zona, come il
Toro,
le Pleiadi,
e il Triangolo
estivo – tre stelle molto
brillanti che da giugno a ottobre si vedono dopo il tramonto. Lo scrittore
francese
Georges Bataille
considerava Lascaux il momento della nascita dell’arte, e di conseguenza
dell’essere umano vero e proprio.
Non sappiamo con certezza le cause che hanno
favorito, soprattutto nell’Europa Occidentale, in Francia ed in Spagna, la
realizzazione di opere che ci lasciano stupiti e che ci inducono a riflettere
sulle capacità organizzative dei nostri avi, scrive Maria Antonia Ferrante. Le
opere grandiose sono sempre il risultato di un’organizzazione collettiva dove
ogni componente del gruppo svolge un ruolo. Capacità mentali progredite,
affinamento del pensiero, maggiore ricchezza del linguaggio e della
comunicazione, nuove fonti di approvvigionamento delle materie necessarie
all’esecuzione dei dipinti e delle incisioni e presenza degli spazi favorevoli
alla messa in opera, contribuiscono a dare spazio alla fantasia. Sono gli
abitanti delle zone franco–cantabriche che in questo periodo hanno lasciato il
segno indelebile del loro avanzamento nel processo evolutivo espresso nelle
stupefacienti pitture parietali in grotta. La grotta di Lascaux, affrescata
18.000 anni fa, si trova in Dordogna, Francia. Si accede con facilità alla prima
sala dell’antro, detta La Rotonda. Qui, si impongono alla vista dipinti di
animali giganteschi; gli uri misurano 5 metri di lunghezza. Dopo la sequenza
degli animali mastodontici: uri, cavalli e cervi, appare il cosiddetto unicorno
con il corpo segnato da cerchi; animale fantastico non definibile. Nelle
successive parti della grotta continua la sfilata delle immagini degli stessi
animali: di cervi e stambecchi e di una grandissima quantità di incisioni che
sembrerebbero messe a caso perché si mescolano con i profili delle figure degli
animali precedenti, in un groviglio di difficile lettura. Su di una parete dello
spazio detto il pozzo, appare il dipinto di una figura umana; un uomo disteso
con il fallo in erezione; sembra ferito. Vicino gli sta l’immagine di un
bisonte, anch’esso probabilmente ferito. Sembra una scena di caccia conclusasi
male par l’uomo e per l’animale. Per la realizzazione di questo grande affresco
della grotta, chiamata giustamente Cappella Sistina del Paleolitico, sicuramente
è stata necessaria la collaborazione di parecchi individui. Immagino che Eva
abbia dato una mano alla messa in opera dei dipinti di Lascaux. Eva, forse, ha
preparato i colori: l’ocra, il carbone, il manganese, i grassi e le materie
collanti. E’ stata anche lei nella grotta reggendo le torce, portando le assi di
legno per preparare le impalcature e soprattutto per provvedere
all’alimentazione degli artisti impegnati per ore ed ore in uno spazio
ristretto, oscuro e poco ospitale. Il progetto dell’affresco, probabilmente, è
il risultato di un lavoro collaborativo. Di questa opera il gruppo che l’ha
eseguita ne ha parlato prima di metterla in opera, disegnandola mentalmente e
riconoscendone le finalità. Quale? Archeologi, critici dell’arte, antropologi,
etnologi e psicologi si sono cimentati per penetrare nell’intima struttura delle
opere parietali paleolitiche. Leroi-Gourhan ha dedicato un interesse particolare
ai dipinti di Lascaux. Di essi dice
“Le
figure di Lascaux non si dispongono in pannelli di insieme, ma lungo un
itinerario, legata l’una all’altra da un tema di cui ci sfugge il senso, ma il
cui coinvolgimento si ripete un piano dopo l’altro fino alle figure di
rinoceronti situate nel punto più profondo. Le figure possono prolungarsi per
due e più chilometri con un’unica versione del tema; figura per figura, a
intervalli di parecchie centinaia di metri. Si tratta di una vera e propria
cosmografia? Il mito, qui, qualunque sia il substrato, si dispone in maniera
lineare e ripetitiva” (Leroi-Gourhan, A., 1977).
La gogna del moralismo di
Stato. Parliamo di Vilfredo Pareto e il suo "Il mito
virtuista e la letteratura immorale".
Mentre attendeva nell'"eremo" di Céligny alla sua opera più ponderosa e
sistematica, il Trattato di sociologia generale, Pareto metteva mano al
"trattatello" Le mythe vertuïste et la littérature immorale (Paris 1911),
che fu tradotto con notevoli integrazioni e pubblicato in Italia nel 1914.
Questa succosa e incalzante analisi condensa in modo esemplare l'anima
profondamente liberale e libertaria di Pareto, e mette a nudo le tante ipocrisie
che si nascondono dietro ogni moralismo proibizionista che, oggi come un secolo
fa - in nome di una presunta igiene fisica e morale collettiva -, pretende di
vietare irrinunciabili diritti personali dell'individuo. «Si può leggerlo in due
modi, Il mito virtuista. Si può prenderlo come l'opera letteraria di un uomo
singolare: logico e passionale, preciso e fantasioso, ironico e caustico,
coltissimo di storia e attento alla cronaca. Senza curarsi troppo di
dimostrazioni e tassonomie, gustarsi esempi e citazioni, senza voler cogliere
l'architettura complessiva, seguirlo su per le scale ripide della sua
indignazione e nei saloni sontuosi della sua cultura. È il suo procedimento
[...] Oppure si può leggere il libro come l'applicazione ad un fatto particolare
dei costrutti logici, "residui" e "derivazioni", su si basa il suo opus magnum,
una sorta di intermezzo in quel ventennale impegno.»
Torna il libreria il
trattatello liberale e libertario di Pareto,
scrive “Il Piffero”. Un libro
che nel mettere a nudo le ipocrisie dell’epoca, denuncia i rischi che si
nascondono dietro ogni moralismo proibizionista che, oggi come un secolo fa,
pretende di vietare irrinunciabili diritti personali dell'individuo. È una
iattura il trionfo del conformismo moralista. Anzi, quando i moralisti assurgono
a maître à penser di un’epoca la dittatura è dietro l’angolo, per quanto soft e
mistificata da buonismo possa essere. E mentre si diffonde questa potente arma
di distrazione di massa le classi dirigenti dimenticano i veri problemi del
Paese. Ci hanno provato in tanti, soprattutto nella stagione del berlusconismo
declinate, a dare una lettura assolutoria delle macerie contemporanee al
libretto che Vilfredo Pareto scrisse nell’eremo di Célignymentre si accingeva a
dare l’ultima versione alla sua opera più ponderosa e sistematica, il
Trattato di sociologia generale. Ora di questo trattatello, pubblicato in
Francia nel 1911 (Le mythe vertuïste et la littérature immorale) e
tradotto con notevoli integrazioni in Italia nel 1914, è uscita una riedizione
per iniziativa di Franco Debenedetti e dell’editore Liberilibri. Con il termine
«virtuismo» Pareto intende sviluppare una critica verso i censori moderni, che
si ergono a paladini della morale pubblica a detrimento delle più elementari
espressioni della libertà individuale. Per alcuni può essere definito
«libertario», un intellettuale consapevole della trasformazione dei valori
morali, e della loro opinabilità alla stregua della religione e della politica.
Un antiproibizionista ante litteram, in particolare contro le limitazioni
legislative alla letteratura cosiddetta immorale di cui fu portavoce il
presidente del Consiglio dell’epoca Luigi Luzzatti. Sulla scia di questo
principio Pareto dà alle stampe il volume, che fu dettato dalla curiosità per i
fatti contemporanei e dall’interesse che egli mostrava per la cronaca nera e
giudiziaria. Anzi si può affermare che il libro nacque dall’attenzione che
Pareto rivolse al romanzo Quelle signore (1904) e al processo che il suo
autore Umberto Notari (1878-1950) subì per oltraggio al pudore nel 1906 e nel
1911. Le due sentenze si ritrovano nell’edizione del 1914 e sono riportate in
quella del 1966, insieme alla Circolare Luzzatti sulle pubblicazioni
pornografiche: «Qui riproduciamo la sentenza di uno di questi processi in cui si
vedrà incriminata la riproduzione di ”due brani tolti una dalla Bibbia e uno dal
Dialogo delle prostitute di Luciano”».
Il mito virtuista e la
letteratura immorale.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Scritto polemico del sociologo Vilfredo
Pareto sul fenomeno del virtuismo. Durante gli anni della stesura del
Trattata di sociologia (1916) imperversavano in Europa rigidi atteggiamenti
in difesa della virtù, della pulizia morale e del pudore e si moltiplicavano
manifestazioni di intolleranza verso l'oscenità, o presunta tale. Questa ondata
di moralismo venne promossa da alcuni associazioni che condannavano
indistintamente il mondo pagano, le dottrine antisociali ed i concetti
naturalistici, frammisti ad oscenità, della Grecia e di Roma antica. Pareto
decise di intervenire sull'argomento ed invitando il governo Italiano a non
perdere tempo "a pensare alle foglie di fico", quanto a preoccuparsi di
denunciare i gravi problemi dell'Italia del tempo: miseria, corruzione,
analfabetismo, il dominio della mafia e della camorra, le non sopite mire
espansionistiche dell'Austria. Il termine "virtuista", un neologismo coniato da
Pareto, sta ad indicare una persona ipocrita e bigotta, che ha dichiarato guerra
alla letteratura immorale, criminale sessuale. Raccolti in associazioni, i
virtuisti chiedono allo stato misure censorie sempre più restrittive,
giustificandole con il pretesto dell'utilità sociale, della preservazione
della pace sociale, della tutela dell'interesse dei fanciulli e
con la motivazione dell'utilità della castità. Pareto rileva che il vero
fine inseguito dai virtuisti è quello di imporre la loro dottrina e fa notare
come l'aumento delle misure restrittive vada di pari passo con l'aumento di
sentimenti anarchici e che "le leggi senza costumi non valgono niente". Inoltre,
secondo Pareto, "non è un dovere dello stato quello di allontanare ogni
tentazione dall'individuo". Di seguito, Pareto critica sia la famiglia "modern
Style", incapace di dare una vera educazione ai propri figli ("l'educazione
dei figli si fa coll'azione cumulativa di mille cose da nulla, e non con alcune
proibizioni annunciate con gran fracasso") e di seguito delle Istituzioni
scolastiche ("l'anarchia nell'educazione dei giovani è una causa dell'aumento
della criminalità giovanile"). In conclusione, Pareto aggiunge che la forza
che permette ad un popolo di elevarsi al di sopra degli altri non è dato
dall'ascetismo, dalle rinunce e dalla mediocrità, ma nei sentimenti profondi e
attivi che si manifestano con un ideale, una religione, un mito, una fede.
"Nella vita dei popoli, niente è tanto più reale e pratico quanto l'ideale.
[...] Il contenuto logico dell'ideale poco importa. Ciò che importa molto di più
è lo stato psichico che rivela, di cui è sintomo".
La pubblica moralità? È
questione di buon gusto,
scrive Cesare Cavalleri su “Avvenire. Vilfredo Pareto (1848-1923), oltre
che economista e sociologo, è anche un ottimo scrittore, il che non guasta.
Appartiene alla schiera degli economisti "marginalisti" il cui capostipite è
Léon Walras, al quale Pareto succedette nella cattedra di economia
dell'Università di Losanna, nel 1894. Sia Pareto, sia Walras provenivano da
studi d'ingegneria. Pareto fu nominato senatore da Mussolini, ma, morendo nel
1923, non fece in tempo a vedere la piega che il fascismo avrebbe preso. Nel
1910 Pareto pubblicò Il mito virtuista e la letteratura immorale, che
Liberilibri (Macerata 2011, pp. 216, euro 18) oggi sottrae all'oblio,
riproponendo con poche correzioni l'antica traduzione del "giovane" Nicola
Trevisonno (a p. 49 è rimasto un "dai scultori"). Con neologismo paretiano, i
"virtuisti" sono i bigotti intolleranti e spesso ipocriti che pretendono di
imporre per legge la morale, soprattutto e quasi esclusivamente in materia di
"oscenità". Non che Pareto sia favorevole all'oscenità e al libertinaggio, ma ha
buon gioco nel dimostrare l'inafferrabilità di una definizione giuridica
dell'ipotetico reato, e si diverte fin troppo ad antologizzare le "oscenità" di
taluni passi della classicità greca e latina, che neppure l'Index
post-tridentino aveva proscritto. L'invito di Pareto, oltre a proclamare la
libertà di opinione a meno che non vengano violate le regole dell'ordine
pubblico, è a non scambiare gli effetti con le cause. Se la famiglia e la scuola
vengono meno ai loro compiti educativi, non è proibendo il commercio di
cartoline licenziose che la moralità sarà salva: «È il buon gusto, la buona
educazione che possono decidere in questa materia complicata, delicata e
variabile, e non i Tribunali»; «La vera sicurezza voi l'avrete, anzitutto, se
saprete ispirare a vostra figlia il disgusto dell'oscenità, poi se vi darete la
pena di sorvegliarla». Insomma, contrariamente a quanto affermava la circolare
del 16 gennaio 1910 emanata dal ministro dell'Interno Luzzatti, ripetutamente
ridicolizzata nel libro, non è lo Stato «il più alto tutore della pubblica
moralità». E sia lode agli antichi romani, che sapevano distinguere «tre cose
molto differenti: il virtuismo, la temperanza, la dignità. I romani ignoravano
la prima, tenevano in grande considerazione la seconda, ed in maggiore la
terza». Le considerazioni paretiane non hanno solo un interesse storico o di
curiosità: come ben scrive Franco Debenedetti nell'introduzione, oggigiorno il
"virtuismo" si è metamorfizzato nel "politicamente corretto": «"Lotta continua"
non guida più cortei, invece di università e fabbriche occupa le scrivanie dei
direttori di giornali e Tv. Per quelli che non sprofondarono nel mondo coatto
della lotta armata, è l'istituzionalizzazione delle "conquiste": le libertà
diventano diritti, codificati in leggi, dettagliati in regolamenti, garantiti da
magistrati, sorvegliati da autorità. E, se non basta, affermativamente imposti
in "quote". Al potere, di cui si denunciava l'oppressione, ora si chiede di
esercitare la protezione». E ancora: il "virtuismo" dell'epoca di Pareto
«chiedeva al potere di dare la caccia all'immorale, per mantenerlo "fuori dalla
scena" e impedire che si mostrasse in pubblico: il nuovo virtuismo va alla
caccia dell'immorale all'interno del potere stesso, per renderlo visibile al
pubblico. Così si compie l'evoluzione dall'esibizionismo al voyeurismo: quello
sbraitava e gesticolava dal balcone del palazzo; questo sbircia e origlia nel
corridoio del palazzo, nella stanza dell'albergo, nel salone della villa».
L'allusione a fatti e persone dei giorni nostri è volutamente trasparente.
Troismo e nuovismo.
Diagnosi sociale dedicata a Gustave Thibon, scrive Pietro Ferrari su “I Due
Punti”.
Preferisco una società più sobria nella dimensione pubblica (meno tette e culi
sui media), ma meno sessuofobica in quella privata (meno guardoni nelle camere
da letto altrui), più libera dal sesso che tormentata dal testosterone.
Preferisco una società in cui i giornalisti, prima di bandire purghe contro la
mercificazione del sesso, controllassero se nei loro giornali non vi siano
all’ultima pagina le “inserzioni pubblicitarie” di prosperose donne dell’est
“pronte a tutto” per “inviti piccanti”. Ogni riferimento ad eventuali rilievi di
favoreggiamento della prostituzione è puramente voluto. Questa è la società
della Legge Merlin, intreccio folle tra libertinaggio sfrenato e puritanesimo
ipocrita, in cui prostituirsi è lecito o addirittura legittimo, ma andare a
prostitute è riprovevole, in cui la donna è libera di guadagnare col suo corpo
ma è immorale chi la fa guadagnare. Prostituirsi sarebbe un lavoro come un altro
ma essere fruitori di quel “lavoro” sarebbe ripugnante. Laicità bigotta.
Moralisti amorali da una parte contro ipocriti immorali dall’altra, uniti nella
condanna per lo Stato Etico e l’Autorità Morale della Chiesa, ma bisognosi di
usare la morale contro l’avversario. La morale esiste davvero? Ed è valida per
tutti e sempre? Vi è una Istituzione legittimata ad interpretare e a proporre
questa morale? Come si concilia tutto ciò col pluralismo culturale e la libertà
occidentale negli Stati “laici”? Oppure non esiste La morale ed ognuno si fa la
propria? La Morale o è una cosa seria o semplicemente non è; o è una legge o è
una balla; o discrimina i comportamenti o si riduce a farsa. Basta coi difensori
della famiglia (soprattutto nella dimensione “allargata”: due mogli e
quattordici concubine), permissivi per sé ed intolleranti con l’altro. Basta coi
farisei arrabbiati col prete che non dà la comunione ai concubini, ma pronti a
scagliarsi contro il concubinaggio se il concubino ti fotte alle elezioni.
Bunga-bunga no, Gay-Pride sì; Nicòle Minetti no, Vladimir Luxuria sì; donne
oggetto no, libertà sessuale sì; Mara Carfagna da “gnocca senza testa” a (dopo
la polemica nel PdL) “libera, forte e di grande stile”; la morale non si fa agli
altri, la si vive in proprio conformandosi ad essa. Il "filosofo contadino"
Gustave Thibon preferiva le peggiori realtà ai falsi ideali, intuendo come il
reale sia contrario non tanto allo ideale, quanto alla menzogna. I popoli
resistono alle tirannìe senza perdere equilibrio, ma davanti alle demagogìe si
corrompono profondamente e per questo le élites dovrebbero essere delle nuove e
vere aristocrazie (I "migliori" in quanto tali distinti, ma non separati dal
popolo), che sappiano imporre a se stesse e indurre nel popolo un clima
rigoroso, non la “vita facile” o le illusioni. Oggi non abbiamo niente di
simile. Le società si ammalano a partire dalla testa e quindi guariscono a
cominciare dalla testa, se è vero quello che sosteneva San Tommaso D'Aquino (il
Santo tra i Dottori e il Dottore tra i Santi) che il Sovrano deve diffondere la
Virtù. L’austerità però non ha nulla a che vedere con l’ipocrita seriosità, ma è
diretta a risollevare ogni lembo della società dalla dissoluzione; Essa è “amore
severo”, non “asettica solidarietà”, Essa è prova di auctoritas, non più
complice interessata. Essa non è mai “argomento” contro l’avversario se prima
non è autenticamente vissuta e proposta come stile di vita e visione del mondo.
Vita individuale e vita sociale seguono medesime regole di sviluppo. La vita non
è mai novità, ma rinnovamento: quanta bolsa retorica dei politicanti sul
“nuovo”, sul “futuro”, sui “giovani”, quando in realtà sono sempre gli stessi,
loro, affatto nuovi o giovani, più capaci di conservare i cognomi sugli scranni
che i nomi dei partiti, involucri artificiali. Questo proliferare di Fondazioni
che si ispirano al Futuro ("FareFuturo", "ItaliaFutura") esprimono in realtà
l'esigenza di non volersi cimentare con la penosità del presente da governare.
Allora viva i rivoluzionari? Sì, ma i veri rivoluzionari sono coloro che
fecondano come fa la tempesta dopo la folgore, coloro che irrigano con
l’entusiasmo la vera tradizione spezzando rami secchi e idoli imbalsamati, non
coloro che distruggono: “Le primavere sono tenere, fragili e disarmate. Tutto
ciò che nasce è prodigiosamente vulnerabile: i germogli d’aprile, gli uccelli
del cielo nel loro nido. Così è delle primavere della storia umana: più le cose
che nascono tra le nazioni sono grandi e pure, più sono indifese …. è normale
che tutta una categoria di spiriti confonda promessa e miraggio …. Costoro si
dicono ‘realisti’ ma sono soffocatori della primavera. L’utopìa si insinua nelle
anime imitando i dolci colori dell’aurora e i teneri gesti d’aprile, ma non si
tratta qui di una vera primavera: le utopìe sono febbri derivate dalla decadenza
e che affrettano la decadenza. Che Dio ci conceda la grazia di saper discernere,
nella ressa delle idee, ciò che è primavera da ciò che è menzogna e di
combattere le utopìe senza soffocare le rinascite”. Per attestare la giovinezza,
non sempre è attendibile il certificato anagrafico.
Il femminicidio è un dramma
troppo serio perché si apra una discussione moralistica sull'uso del corpo delle
donne nelle pubblicità,
scrive Aurelio Mancuso su "L'huffingtonpost.it". Il rischio, dietro l'angolo, è
che ancora una volta si dividano le donne per bene e per male, un errore
politico e culturale così praticato in questi anni da tante associazioni
femminili e femministe che non ha stoppato alcun omicidio di odio nei confronti
delle donne. Si dice che solo nel nostro Paese vi sia un uso così sfrontato e
inqualificabile del corpo delle donne nelle pubblicità, e questo può esser vero,
ma da qui bisogna partire? Il possesso machista che si risolve contro
l'autodeterminazione delle donne, dilaga nel nostro Paese, per oggettive tare
culturali che non possono esser affrontate solo da un lato, ovvero dalla
censura, dalla moralizzazione dei costumi, dalla sottrazione dei corpi svestiti
o lascivi per fini commerciali. Perché l'altro lato è proprio il moralismo
ipocrita, la madonizzazione delle donne che persiste a causa di visioni
ecclesiali cattoliche ed ecclesiali laiche, prima fra tutte quella della
sinistra istituzionale. Quando non si avrà più paura del sesso, della sua
veicolazione come elemento essenziale della vita, dell'identità delle persone,
dei generi, degli orientamenti sessuali, allora un pezzo importante della
sessuofobia che porta alla castrazione sociale, nei rapporti intimi, nella
rappresentazione e gestione dei poteri, sarà spazzato via. E di pubblicità non
dovremo più discutere, perché il "mercato" riterrà non remunerativo ostentare
corpi femminili. Parliamo di educazione sessuale obbligatoria nei programmi
scolastici (meglio l'educazione alla salute e alla consapevolezza di se), di
narrazione pubblica che permetta la demitizzazione della sessualità,
imprigionata ancora dall'immagine classica dell'impurità del corpo, di elemento
esterno alla volontà razionale, di promozione scientifica delle differenze dei
generi e degli orientamenti. Insomma, fare un discorso unilaterale, comodo e
anche rassicurante, che tende a eliminare i conflitti, ci riporta indietro, non
aiuta l'individuazione concreta anche di strumenti di prevenzione e di tutela. E
in ultimo si continua a girare intorno alla questione centrale: la violenza
contro le donne è un problema degli uomini, in quanto tali, così come sono oggi
pervenuti dopo i millenari vaneggiamenti antropologici sulla superiorità
intellettuale e fisica. Lo scatenamento della strage delle donne, ha dentro un
elemento di vittoria evidente: i maschi sono finalmente entrati in crisi,
l'autonomia delle donne li fa agire come i loro antenati, perché sono i ruoli
che stanno crollando. È necessario punire i reati, attrezzare di strumenti veri
i centri donna, la polizia, ma anche oltre, aprire una discussione sulla
necessità di come rieducare gli uomini, perché il femminicidio è la
manifestazione violenta di una patologia sociale e culturale diffusa: il
machismo.
L'ipocrisia e la doppia
morale sessuale.
Sorelle, partiamo da quando da piccole ci viene insegnato che il sesso è un
peccato, scrive Chiara di Notte - Città Invisibile. E’ un fatto culturale. Anche
nelle situazioni di maggiore “apertura” mentale, ai bambini e alle bambine viene
fatto capire, inizialmente dalla famiglia, poi dalla scuola e soprattutto per
mezzo della religione, un concetto fondamentale: la separazione netta fra i due
generi, ognuno dei quali ben distinto e con la propria sessualità, determinata
secondo dei parametri ben definiti. Il maschio, che dovrà fare cose da
“maschio”, viene perciò educato ad avere gusti e comportamenti secondo “canoni”
maschili, mentre la femmina, essendo colei che poi dovrà adeguarsi a lui, viene
educata ad avere comportamenti e gusti confacenti a quelli maschili. Il tutto
secondo una logica per la quale ogni discrepanza fra il “modello” prestabilito e
quella che sarà poi la personalità del bambino e della bambina in età adulta,
verrà etichettata come “anomalia”, se non addirittura come perversione oppure
patologia. Fin da bambini i maschi sono dunque abituati a giocare con giocattoli
“da maschi”: soldatini, trenini, automobiline, armi giocattolo. Mentre alle
femmine vengono riservate bambole con i loro vestitini, pentoline, stoviglie,
casette da arredare e tutto l’armamentario necessario per essere in futuro ben
inquadrate nel loro ruolo di brave madri e donnine di casa oltrechè di amanti
devote e con una decisa tendenza eterosessuale. In questo tipo di educazione
viene del tutto esclusa la possibilità che la persona, da adulta, possa poi
avere gusti ed aspirazioni completamente opposti. Se oggi ricordo alcuni episodi
di quando ero bambina, comprendo l’enorme “violenza” psicologica che talvolta i
genitori possono operare ai danni dei loro figli, pur amandoli. Di questi
episodi ne ricordo in particolare uno. Mia madre, che non voleva che giocassi
con i soldatini che rappresentavano il mio divertimento preferito, ma che
secondo lei non erano adatti ad una bambina, mi regalò un bambolotto. Era un
bambolotto di plastica di quelli che, inclinandoli, parlavano. Per me, quel
bambolotto è sempre stato un’angoscia. Forse per la fissità dello sguardo oppure
per l’immobilità della bocca che, quando lo inclinavo, emetteva quella voce
meccanica che mi terrorizzava, io quel bambolotto proprio non lo volevo.
Preferivo i miei soldatini. Ma siccome Mamma me lo imponeva ogni momento, un
giorno che ne abbi l’occasione lo infilai in una tinozza piena d’acqua e lo
“affogai” fino a quando quel suo mugolio fastidioso e innaturale non divenne
prima un gracchiare e poi si spense. Tutte voi sapete, presumo, quel che accadde
dopo. Mamma ve lo avrà sicuramente raccontato. E’ uno dei suoi argomenti
preferiti. Ricordo infatti come si arrabbiò per quel mio gesto e tuttora,
nonostante i bambini io li ami più di me stessa, ancora non smette di ricordarmi
quell’episodio facendomi quasi vergognare. Ma cosa significava tutto ciò in
termini di personalità che poi avrei sviluppato da adulta? Preludeva forse a
istinti infanticidi? Scarso senso materno? Latente omosessualità? O più
semplicemente era il modo che avevo di ribellarmi ad un ruolo nel quale, fin da
piccola, non mi sentivo felice in quanto costretta? Quel ruolo, appunto, di chi
accetta passivamente la propria condizione di femmina imposta dall’alto e non
invece come conseguenza di una libera scelta? Anche se allora non lo potevo
ancora capire, oggi mi è evidente come dentro di me, già a quell’età, tutto
lottasse per uscire fuori dal guscio nel quale mi si voleva rinchiusa. Comunque,
questo è solo un esempio di cosa significhi indottrinamento ai ruoli e di
conseguenza, insegnare ai bambini a considerare “buone” certe cose e “cattive”
altre secondo il loro genere di appartenenza. Poi ci sono cose considerate
cattive per entrambi i generi. Una di queste è il sesso. Il sesso è cattivo. Il
sesso è male. Il sesso è vietato. Il sesso è immorale. E qualcuno, a causa
dell’indottrinamento ricevuto, potrebbe anche aggiungere che il sesso è
schifoso. Questo è il modo in cui la stragrande maggioranza dei bambini, ancora
nel nostro cosiddetto ventunesimo secolo vengono educati. E so che, quando dico
maggioranza, non sto rischiando di generalizzare. Ma non solo il sesso è un
peccato, se poi si mette di mezzo anche la religione, diventa addirittura il
“peccato originale”, quindi il più grande, il più cattivo di tutti, almeno per
chi crede a ciò che è stato scritto nei libri sacri delle tre religioni
monoteiste. Non ha importanza se il sesso è l’atto attraverso quale il genere
umano ha potuto esistere. Non ha importanza se è col sesso che si accresce
l’amore fra due persone. Non ha importanza se è quell’impulso primario che guida
ogni essere umano verso il piacere e la felicità. La morale impone di
considerarlo il fondamento di ogni vizio. Forse c’è chi ha ancora bisogno di
credere che Dio avrebbe inventato un altro modo meno scandaloso per l'uomo e la
donna di procreare e se non si fosse messa di mezzo quella maliziosa di Eva, con
la sua curiosità, la sua inguaribile voglia di sapere, la sua incosciente
aspirazione a vivere la vita provando ogni esperienza, forse quest’altro modo
meno vergognoso esisterebbe. Ma le cose, come sappiamo, sono andate come sono
andate. E chi è la principale responsabile di quel terribile errore divino? Chi
è che rappresenta la fonte di ogni tentazione che conduce l’uomo alla
perdizione? Chi? La donna, naturalmente! E l’uomo in tutto questo è solo una
povera vittima. Vittima della vergogna legata al sesso. Vittima per il solo
fatto di sentirne il desiderio. E se il sesso è cattivo, è male, è proibito, è
immorale, è schifoso, lo è molto di più se a desiderarlo è la donna. Questo ci
porta direttamente al tema: l'ipocrisia e la doppia morale sessuale. Inutile
dire che in un breve discorso non si possono affrontare tutte le cause e i
sintomi dell’ipocrisia e della doppia morale sessuale. Ma tenterò di definire
almeno tre dei fenomeni principali che tutto ciò produce.
1 - Il primo fenomeno è il
persistere della misoginia, nel considerare le donne come immature,
irresponsabili, non in grado di fare scelte sessuali e di vita indipendenti.
Viola ha commesso il “grande reato” di essere rimasta incinta quando è stata
violentata da suo fratello, ed è stata scacciata di casa perchè ha rifiutato di
abortire. E’ stata abbandonata e per sopravvivere ha dovuto prostituirsi anche
durante il periodo di gestazione. Ora è madre di una bellissima bambina sana e
intelligente, ma cosa ne è stato di suo fratello? Ha subito forse qualche
castigo per ciò che ha fatto? No. L’unico castigo lo ha subito lei e se non
avesse trovato aiuto, chissà dove sarebbero adesso lei e la sua bambina. E’
questo che accade: se una donna osa opporsi ad un sistema ipocrita e maschilista
semplicemente rifiutando di interrompere una gravidanza, come ha fatto Viola,
deve subirne le conseguenze. Ma se un uomo violenta la sorella ed è protetto
dalla famiglia, non subisce alcun castigo. Il problema è forse limitato alle
zone rurali della Moldavia dalle quali Viola proviene? Dovremmo augurarcelo, ma
tutte noi sappiamo che non è così. Se si parla della storia recente dell’Est
Europa e dei Balcani, la violenza sessuale contro le donne è un fatto
ineludibile che si è manifestato a diversi livelli e in varie forme. Sono state
le donne a vivere drammatici episodi di violenza durante i conflitti che hanno
sconvolto i Balcani negli anni novanta. Oltre allo stupro, usato come vero e
proprio strumento di offensiva interetnica, vi sono state innumerevoli
situazioni di sopruso e di sopraffazione. I casi di stupro e di violenza sono
stati decine di migliaia e raramente i colpevoli, tutti uomini, sono stati
condannati. Come dimostra che a sedici anni dalla fine della guerra in Bosnia
Erzegovina, i responsabili degli stupri continuano a sottrarsi alle indagini e
alla giustizia. Alcuni occupano addirittura posizioni di potere e molti vivono
nelle stesse comunità delle loro vittime. Sono pochi in definitiva i colpevoli
che sono stati assicurati alla giustizia attraverso i tribunali internazionali e
nazionali. Amnesty International stima che anche oggi, nella sola area dei
Balcani, ben 15.000 donne o ragazze o bambine subiscano ogni anno abusi sessuali
di vario genere, molti dei quali da membri maschi della propria famiglia. Abusi
che poi restano impuniti. Ma dicendoli così, sono solo dati statistici, freddi
numeri che non riescono a dare la misura di questo orribile fenomeno, e noi
tutte sappiamo quanto non sia accurata questa cifra, come la stragrande
maggioranza dei casi non vengano denunciati per vergogna, passando quindi sotto
silenzio. Di quelle che subiscono violenza sessuale, infatti, non si parla e
spesso le vittime sono circondate da un’aura di qualcosa che sa di sporco,
intoccabile, che è meglio non provocare, non sentire, non udire.
2 – Il secondo fenomeno è la
celebrazione della verginità femminile. Soprattutto laddove l’influsso religioso
sta tornando ad essere molto forte, ci si attende che le donne si mantengano
vergini fino a quando si sposano. Per me, che sono cresciuta sotto il comunismo
e che ho vissuto gli anni della mia emancipazione in una grande città, in piena
indipendenza e libertà, tutto ciò pare una barzelletta di cattivo gusto. Però,
purtroppo, non lo è. Questa nuova ondata di “moralismo” e di “sottovalutazione
della donna” sta prendendo di nuovo vigore da quando il sistema comunista è
caduto e la religione si è di nuovo incuneata nella vita delle persone
sostituendosi all’antica “dottrina” di partito, soprattutto in quei luoghi
lontani dalle grandi città, nelle zone rurali e più povere. Allora, dove porterà
tutto questo? Alla ricostruzione dell'imene? All'utilizzo dell’imene
artificiale? Le donne accetteranno questa umiliazione prestandosi a questa
immonda pratica talvolta costrette proprio dalle loro stesse madri al fine di
rifabbricare la menzogna? Oppure come fece una bambina tanti anni fa con un
bambolotto, affogheranno l’ipocrisia nella tinozza della propria dignità?
3 - Il terzo fenomeno, ma non
il meno importante, è la discriminazione di quelle donne che sono capaci di
gestire liberamente la loro sessualità e che vengono immancabilmente
ostracizzate per il loro stile di vita definito, nella migliore delle ipotesi,
come scandaloso o audace. La donna, perciò, tranne rare eccezioni, deve
accontentarsi di essere la destinataria dei desideri del maschio. Soggetto
dunque passivo e non attivo della sessualità perchè a lei non dato esprimere ma,
piuttosto, di essere espressa. E’ per questo motivo che quelle che sono così
coraggiose da ribellarsi andando contro alle regole, che trasgrediscono nello
stesso identico modo che è concesso al maschio che per gli stessi comportamenti
viene considerato normale, devono sapere che nella società dell’ipocrisia e
della doppia morale sessuale saranno immancabilmente etichettate nel peggiore
dei modi e che avranno sempre l’indice puntato contro.
Io credo che sia giunto il
momento di non essere soddisfatte solo di lamentarci, ma che tutte quante per
andare avanti dobbiamo fare qualcosa al riguardo: innanzitutto essere
consapevoli di noi stesse e della grande forza che ci ha dato la Natura, e poi
assumerci la nostra responsabilità. E qual è la responsabilità di noi donne in
tutto questo? Qual è la nostra responsabilità nei confronti di questa ipocrisia
sessuale che, fin da bambine, c’impedisce di fare delle libere scelte? Si
tratta, almeno a mio avviso, di rifiutare il lavaggio del cervello che da secoli
ci stanno facendo coloro che vogliono tenerci a bada, e che utilizzano il sesso
come un elemento di controllo su di noi. E’ renderci conto che c’è qualcosa di
sbagliato negli insegnamenti che ci sono stati inculcati. E’ credere che una
vita sessuale sana, libera e non condizionata dai giudizi altrui è un nostro
diritto. Una vita sessuale senza gli ostacoli posti dall’ignoranza,
dall'educazione patriarcale, dal sessismo, dai tabù e dagli stupidi divieti. Si
tratta dunque di educare le nostre figlie e i nostri figli in un modo diverso
che porti le generazioni future ad un maggiore rispetto e comprensione del
proprio corpo e della sessualità.
Per riassumere:
- il sesso non è male. Il
male è solo nella doppia morale misogina che penalizza le donne;
- il sesso non fa schifo. Quel
che fa schifo sono gli inutili valori basati sul sessismo;
- il sesso non è immorale.
Immorale è la spaventosa ipocrisia che dilaga ogni giorno di più.
Nudo artistico o
pornografia?
Si chiede Antonio Lo Torto.
Anche se la fotografia non è antica come altre forme di espressione artistica,
nondimeno molte sue forme vengono legittimamente considerate arte. Ciò non
significa che tutte le “buone immagini” siano automaticamente artistiche (ma
questo, a nostro avviso, vale anche per molti quadri e sculture…). Pertanto non
tutte le fotografie si eleveranno alla dignità di seri nudi artistici soltanto
perché mostrano donne o uomini privi di abiti. Basta consultare un qualsiasi
vocabolario per rendersi conto che il termine “nudo” può essere infatti sia un
aggettivo (che indica la condizione di chi non è coperto da vesti, cioè la
nudità), sia un sostantivo (la rappresentazione artistica di un soggetto nudo).
Il primo ha sicuramente una connotazione oggettiva, quasi “clinica”, mentre il
secondo suggerisce un’interpretazione che attiene al campo dell’arte. Per un
fotografo questa è una distinzione fondamentale, infatti possiamo affermare che
l’immagine di un corpo nudo diventa un nudo, nel senso artistico, solo quando
tale corpo viene messo in posa, illuminato, modellato e descritto non a fini
documentativi, clinici o informativi che dir si voglia, bensì per scopi estetici
ed interpretativi. Ma non basta. Esiste un sottile confine tra “bello e brutto”,
tra “morale e immorale”. Soprattutto quando si parla di fotografia di nudo. Il
fotografo e il pubblico delle sue immagini devono poter stabilire se una data
fotografia sia definibile un’opera d’arte o una rappresentazione oscena. Il
confine tra i due i campi è quasi impossibile da fissare, sia esteticamente, sia
legalmente (Potter Steward, giudice della Suprema Corte di Giustizia USA, ha
affermato: “Io non so esattamente cosa sia la pornografia, né so esattamente
come descriverla; però quando la vedo, la riconosco!”). In linea di principio,
ritengo che un’immagine sia da definirsi pornografica quando offenda il buon
gusto di chi la osserva, non solo per la presenza dell’erotismo, ma soprattutto
per quella sensazione di degrado della femminilità in generale e della donna
ritratta in particolare che risulta inevitabile da una sua lettura. Quando
un’immagine “sfrutti”, piuttosto che esaltare, le qualità erotiche e umane di un
soggetto ci troviamo di fronte ad un lampante esempio di fotografia
pornografica. Sebbene la pornografia sia spesso associata alla rappresentazione
visiva della figura umana, una fotografia di nudo realizzata con onestà,
sensibilità ed integrità è non soltanto una delle forme di espressione artistica
più impegnative e difficili da creare, ma arriva a situarsi quasi agli antipodi
del concetto di osceno. Un nudo magistrale può rappresentare uno dei massimi
doni offerti al soggetto ritratto, un qualcosa che con la pornografia non ha
assolutamente nulla a che fare…
ARTE O PORNOGRAFIA?
Arte o pornografia? Nel
dubbio Facebook censura.
Nuovo caso di nudo artistico bloccato dai software del social netowrk: «L'étud
de nu» di Guillot online con i seni coperti, scrive Elmar Burchia su “Il
Corriere della Sera”. Cos’è pornografia, cos’è arte? La domanda pare
retorica, ai più. Non per Facebook. Ancora una volta il colosso di Zuckerberg
non riesce a distinguere tra i due concetti. Un nudo femminile della celebre
fotografa francese Laure Albin Guillot (1879-1962), pubblicato sul profilo del
museo parigino Jeu de Paume per illustrare la mostra dedicata all'artista, è
stato censurato e il profilo è stato temporaneamente bloccato. Certo va detto:
per il museo parigino che ospita la mostra della pioniera dell'uso moderno della
fotografia, Laure Albin Guillot, si tratta di un’enorme pubblicità. Ma a che
prezzo? La pagina Facebook del Jeu de Paume è stata bloccata venerdì per 24 ore
a causa del nudo femminile degli anni ‘40 postato sul profilo. I responsabili
del museo, specializzato in fotografia contemporanea e video artistici, si sono
affrettati a denunciare la vicenda parlando di «censura» da parte del colosso di
Menlo Park: «Non distinguere tra un’opera d’arte e un’immagine pornografica è
discutibile e soprattutto pericoloso». Laure Albin Guillot, che nel corso della
sua vita si è dedicata a vari generi come il ritratto, il nudo, il paesaggio, la
natura morta e il reportage, è stata anche una delle prime fotografe a lavorare
in forma professionale per la stampa, l'edizione di libri, le illustrazioni e la
pubblicità. Ciò nonostante, «L'étude du nu», questa l’opera finita nel mirino,
infrange gli standard della comunità del social network. La foto in bianco e
nero mostra una donna distesa e solo in parte nuda; le parti intime sono infatti
coperte da un panno bianco. Nelle ultime ore il museo ha pubblicato la
controversa foto su Facebook con una barra nera a coprire il seno e l’avviso che
l'immagine è stata bloccata a causa di una violazione delle linee guida del
social network (immagini di nudo non sono infatti ammesse su Facebook). Dopo i
«numerosi messaggi di sostegno», la direttrice del museo, Marta Gili, ha
annunciato che rifiuterà «ogni forma di censura». «La società non ha il diritto
di fare una cosa simile con un’opera d’arte». Un portavoce di Facebook in
Francia ha ammesso in una dichiarazione scritta che «a volte risulta difficile»
riuscire a «distinguere tra arte e pornografia». Eppure non è la prima volta (e
non sarà nemmeno l’ultima), che Facebook o meglio, i software automatici
impiegati dal colosso californiano, censura alcuni dei profili a causa di
fotografie ritenute lesive delle linee guida. L’estate scorsa, il social network
rimosse l'immagine in cibachrome di Ema (nudo su una scala) del pittore tedesco
Gerhard Richter dalla pagina del centro Pompidou di Parigi. Anche in quel caso,
il motivo fu la nudità del soggetto. A seguito delle proteste, gli
amministratori del sito si scusarono: avevano confuso il dipinto per una foto.
Altro caso recente: a fine novembre scambiò un gomito - non proprio innocente,
perché l'immagine venne creata apposta - per un seno femminile scoperto.
Insomma, il social di Zuckerberg & Co. non va sul sottile, ma è fiero delle sue
rigide politiche sulla pornografia. Con pene che vanno dalla semplice
cancellazione, alla sospensione a tempo fino alla cancellazione del profilo per
i recidivi.
Pinterest apre alle foto di
nudo, gli artisti esultano,
scrive “Il Messaggero”. Pinterest apre al nudo: la piattaforma digitale dedicata
alla condivisione di fotografie, video ed immagini sta per dare ufficialmente
luce verde alla pubblicazione di immagini senza veli proprio mentre Facebook e
altri social network premono sul freno della diffusione di messaggi
potenzialmente offensivi, violenti o sessisti. Una inversione a 'U' o quanto
meno a 90 gradi decisa in seguito alle pressioni di artisti e fotografi. Finora
l'etichetta di Pinterest per consentire l'affissione di foto sulla bacheca
digitale era chiara: «Niente nudo, nudo parziale o pornografia». Ma «Pinterest è
nata per consentire di esprimere le proprie passioni e la gente è appassionata
dell'arte e l'arte include anche nudi», ha fatto sapere la società fondata nel
2010 da Ben Silbermann, Paul Sciarra e Evan Sharp al Financial Times rivelando
l'intenzione di «far posto a queste richieste». Via libera dunque alla Venere di
Milo e al Davide di Michelangelo mentre ieri Facebook si è impegnato a rivedere
e migliorare la sua policy di moderazione online dopo che numerose aziende
avevano ritirato la pubblicità per protestare contro il fatto che le loro
inserzioni erano affisse accanto a messaggi violenti o misogini come quelli di
gruppi che in apparenza avallavano femminicidi e stupri. Gli approcci divergenti
- nota Il Financial Times - mostrano come i social network debbano fare un
complicato gioco di equilibrio tra gli interessi dei loro utenti, la necessità
di controllare e moderare quanto viene postato online e la pressione degli
inserzionisti: Facebook guadagnerà 6,6 miliardi di dollari nel 2013, di cui 5,6
dalla pubblicità, secondo stime di eMarketer e la stessa Sheryl Sandberg, chief
operating officer del colosso californiano, ha ammesso che «esiste tensione
reale» tra quanto vogliono gli inserzionisti e la libera espressione. L'impegno
di Facebook a far pulizia rendendo più severe le sue regole ha indotto alcune
aziende, come la casa automobilistica giapponese Nissan, a tornare sul social
network. Non così Nationwide, la maggiore società immobiliare del Regno Unito
che ha annunciato di aver sospeso a tempo indeterminato gli spot fino a che non
verranno definite «regole severe e chiare per impedire che il suo brand venga
accostato a contenuti indecenti».
L'Onu e la guerra fredda
del sesso.
Si sorvola su regimi sanguinari e genocidi e ci si occupa del mancato
riconoscimento delle coppie omosessuali, scrive
Marcello Veneziani su “Il
Giornale”. Ma non vi pare di stare un po' esagerando con la questione
omosessuale elevata a priorità planetaria? L'Onu, che meglio sarebbe
ribattezzare Omu visto che non si occupa di nazioni ma di omosex, censura Stati
e religioni sul mancato riconoscimento delle coppie omosessuali, sorvolando su
banali incidenti come regimi dispotici e sanguinari, genocidi su base etnica o
religiosa e pena di morte a gogo in grandi Paesi come la Cina. L'Omu arriva a
censurare un'istituzione bimillenaria come la Chiesa sulla questione omo e
sull'aborto, con la pretesa ideologica e invasiva di dettare pure alla fede i
suoi canoni paranoically correct. La retorica organizzazione umanitaria,
inefficace quando si tratta di risolvere le questioni legate ai diritti
elementari della vita umana e della persona violata o di tutelare i cristiani
massacrati nel mondo, getta benzina sul fuoco della Guerra fredda che si è
riaperta tra Usa e Russia per le Olimpiadi invernali. Stavolta gli States hanno
schierato non missili e testate nucleari ma lesbiche e omosessuali nel nome
dell'omolatria violata. Lascio da parte il merito della questione, che peraltro
riguarda, non dimentichiamolo, una piccola minoranza all'interno della minoranza
omosessuale. Ma trovo assurdo che le questioni internazionali, i rapporti tra
Stati, le sanzioni, le rotture diplomatiche e le censure, vengano regolati
sempre e solo da questa ideologia trans e biofoba, onnipervasiva. Per far questo
non c'è bisogno dell'Onu, Ban Ki-moon e Obama, bastano le Pussy Riot.
I Sex toys valgono 15
miliardi. All’Italia resta solo il porno,
scrive
Wall & Street, ossia Massimo
Restelli e Gian Maria De Francesco, su “Il Giornale”.
Di
Lady Gaga vi
abbiamo già parlato in merito alla sua popolarità su Facebook, inferiore a
quella della
Coca Cola
(a proposito su
Twitter è
stata di recente stracciata da
Katy Perry
che ha sfondato il tetto dei 50 milioni di follower). Oggi ve la proponiamo in
una «luce» diversa pubblicando la foto di un gadget a lei ispirato. Si tratta di
una torcia che in inglese si dice
flashlight. Ma
poiché l’oggetto si chiama
fleshlight e il
riferimento è a
flesh (carne), l’utilizzo che
se ne può fare è diverso. Per non perderci nei giri di parole vi diremo che si
tratta di un gadget per praticare l’autoerotismo, un
sex toy.
Come rivelato da un’indagine promossa da My Secret Case, una piattaforma
Internet specializzata nel commercio di questo tipo di articoli, nei Paesi
industrializzati il 95% degli uomini e l’89% delle donne ammette di praticare
l’autoerotismo. È una percentuale molto elevata che induce anche a porsi un
altro tipo di domande. Ma noi non ci occupiamo di sociologia. Sono le donne,
però, a essere più intraprendenti. Negli Usa il 60% di esse fa uso di giocattoli
erotici, il 49% in Inghilterra e il 45% in Germania. In Italia solo il 28% delle
donne ha fatto un acquisto «speciale». È anche una questione di mentalità,
evidentemente.
Le stime che circolano in Rete indicano
che i sex toys producono un giro d’affari pari a 15
miliardi di dollari, un
business che cresce del 30% all’anno. si tratta, però, di un vantaggio,
soprattutto, per la Cina che produce oltre l’80% dei dispositivi. Nel Paese
asiatico – dove la pornografia è illegale – negli ultimi vent’anni sono spuntati
come funghi oltre 200mila sexy shop. Secondo i dati del Guangzhou
Sexpo del 2012, l’industria
del sesso fattura oltre due miliardi di dollari all’anno. Alibaba,
l’eBay cinese, sulla sua piattaforma dà spazio a oltre 2.500 aziende che vendono
sex toys. Il Rapporto Coop «Consumi & distribuzione» ha rivelato che quest’anno
il nostro Paese dovrebbe registrare uno sconfortante -6,1 per cento negli
acquisti del comparto
non food. Per il
settore del sexual entertainment (che va dal Viagra ai sex toys), la crescita
sarà straordinaria: +6,4 per cento. La classifica Loveville pubblicata
da Durex su dati Nielsen vede Bologna come città con maggiore propensione
all’acquisto: 546mila euro in due mesi di monitoraggio. Seguono Firenze e
Verona. Circostanza confermata anche dai dati di My Secret Case: il 45% degli
acquirenti risiede infatti nel Nord Est. A seguire il Centro, mentre Nord Ovest
e Sud spendono meno. L’importo medio degli ordini è di tutto rispetto: 90 euro.
Per il sesso non si bada a spese. P.S.: Wall & Street sono cattolici. Dopo la
pubblicazione di questo post correranno subito in Chiesa a confessarsi…
Sesso insegnato ai bimbi
dell'asilo: polemica e referendum in Svizzera.
In diverse scuole del Cantone di Basilea i bambini ricevono un'educazione
sessuale che a molti appare troppo precoce. Tra poco sul tema si terrà un
referendum, scrive
Luisa De Montis su “Il Giornale”. Insegnare il piacere sessuale ai bambini di
quattro anni non sarà un po' troppo presto? Eppure avviene dal 2011, in decine
di scuole elementari del Cantone di Basilea, in Svizzera. Nelle "sex-box"
distribuite ai bimbi dai 4 ai 6 anni c'è tutto il necessario per spiegare
l'anatomia del corpo umano e, soprattutto, come nascono i bambini. Con tanto di
video esplicativi, pupazzi, peni e vagine finte. Crescendo, ma di poco (tra i 6
e i 10 anni) ai bimbi vengono spiegati temi come la masturbazione,
l'orientamento sessuale, i preservativi, le mestruazioni e l'eiaculazione.
Salendo fino ai 13 e i 15 anni si affrontano, invece, altre tematiche sessuali.
Si tratta di un percorso sperimentale di educazione sessuale, che dovrebbe
diventare obbligatorio dal prossimo anno scolastico estendersi alla Svizzera
tedesca, a quella francofona e al Canton Ticino. Con questo scopo: "Fornire ai
giovani le conoscenze essenziali, le capacità, le competenze e i valori di cui
hanno bisogno per conoscere la loro sessualità, provando piacere fisico,
psichico ed emozionale". L'iniziativa ha fatto arrabbiare alcuni genitori, che
si sono mobilitati promuovendo un referendum (che si terrà nei prossimi mesi)
contro l'insegnamento troppo precoce del sesso, a partire dagli asili. Il
referendum (che in tre anni ha raccolto 100mila firme) chiede di abolire
l’educazione sessuale nelle scuole a bambini fino ai 9 anni di età, di renderla
opzionale fino a 12 anni e obbligatoria per i più grandi, ma a una condizione:
che sia tenuta da insegnanti di biologia che si concentrino sulla riproduzione
senza andare a toccare gli "aspetti sociali della sessualità".
Sesso coi minori? Perché no, è "accettabile",
scrive “Libero Quotidiano”. Almeno così
la penserebbe
oltre un italiano su tre, il
38% per la
precisione. E' quanto emerge da
un'indagine Ipsos per
Save the Children.
Il 28% degli adulti ha tra i propri contatti degli adolescenti che non conosce
personalmente, mentre l'81% pensa che le interazioni sessuali tra adulti ed
adolescenti siano diffuse e trovino
terreno fertile su internet.
Inoltre un italiano su dieci attribuisce la "colpa" dell'iniziativa di contatto
proprio agli adolescenti.
Le cifre - Secondo il 48%
degli intervistati i ragazzi di oggi sono più disinvolti degli adulti nel loro
approccio, nonché (per il 61%)
sessualmente più precoci.
Per il 36%, però, sono impreparati a gestire una relazione matura. C'è anche un
1% che sostiene che un rapporto sessuale con un adulto
può essere formativo
per il minore. Comunque per il 51%
del campione gli adulti che fanno sesso con gli adolescenti sono o
"irresponsabili" o "emotivamente immaturi".
Il campione - L'indagine è
stata effettuata a gennaio su un campione di 1.001 adulti tra i 25 e i 65 anni
in occasione del
Safer Internet Day 2014,
la giornata dedicata dalla Commissione Europea alla sensibilizzazione dei più
giovani a un corretto e consapevole uso della rete. Tra i dati interessanti,
anche quello che rivela che tra
gli over45,
il 37% del campione usa la rete (soprattutto i social network)per colmare il
vuoto affettivo e conoscere persone disponibili a fare amicizia o ad
intrattenere un rapporto amoroso.
L'incontro sessuale tra un
minore e un adulto è ritenuto "accettabile" da quasi un pugliese su due (47%),
sempre (21%) o ad alcune condizioni,
scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. E’ quanto emerge da una ricerca nazionale
Ipsos per Save the Children su "Le interazioni sessuali adulti-minori a partire
da Internet", in occasione del Safer Internet Day 2014, la giornata dedicata
dalla Commissione europea alla sensibilizzazione dei più giovani ad un uso
corretto e consapevole della rete. Dalla ricerca emerge che più della metà dei
pugliesi si affaccia alla rete per colmare un importante vuoto relazionale e
affettivo della vita reale: il 58% dei pugliesi afferma di utilizzare il web –
soprattutto i social network – per conoscere persone disponibili a fare amicizia
o ad intrattenere un rapporto di affetto o amore. Il 29% degli adulti pugliesi
ha tra i propri contatti adolescenti che non conosce personalmente. La
stragrande maggioranza (90%) pensa che le interazioni sessuali tra adulti e
adolescenti siano diffuse e trovino in Internet il principale strumento per
iniziare e sviluppare la relazione, che può sfociare nell’incontro fisico,
mentre uno su 10 attribuisce la responsabilità dell’iniziativa di contatto
esclusivamente agli adolescenti.
Il dato pugliese supera le
percentuali nazionali -
L'incontro sessuale tra un minore e un adulto è infatti ritenuto "accettabile"
da oltre un italiano su tre (38%). Il 28% degli adulti italiani ha tra i propri
contatti adolescenti che non conosce personalmente e l’81% pensa che le
interazioni sessuali tra adulti e adolescenti siano diffuse e trovino il loro
'input' su Internet. Un italiano su dieci attribuisce la responsabilità
dell’iniziativa di contatto agli adolescenti. Dalla ricerca emerge inoltre che
il 58% degli intervistati, dato più alto a livello nazionale, attribuisce agli
adulti la responsabilità dell’iniziativa di contatto nell’interazione con un
adolescente, ma secondo il 38% anche gli adolescenti hanno una parte attiva
nell’iniziativa del contatto (per il 28% condividono questa responsabilità con
gli adulti, mentre per un pugliese su 10 sono i ragazzi i principali
responsabili). Il 32% degli adulti pugliesi considera infatti i ragazzi più
disinvolti nell’approccio con loro, e sessualmente più precoci (50%), ma
comunque impreparati nel gestire una relazione sessuale con una persona matura
(40%). Di contro, per due intervistati su 100 la relazione sessuale con un
adulto potrebbe addirittura essere formativa per il minore. La consapevolezza e
la parziale accettazione delle relazioni di natura sessuale tra adulti e minori,
tuttavia, non esclude il giudizio sugli adulti che intraprendono relazioni di
natura sessuale con adolescenti, ritenuti irresponsabili dal 60% degli
intervistati o emotivamente immaturi (27%).
Il portale web delle fantasie
pedofile,
dove anonimi autori si scambiano
racconti di stupri e violenze su bambini, scrive “Libero Quotidiano”.
Tutte opere di fantasia, assicurano i responsabili del sito, ma l'associazione
per la lotta alla pedofilia
Meter,
che ha segnalato
il web site alla Polizia Postale della Sicilia Orientale,
non ce la vede giusta: troppo cruenti e verosimili i contenuti, come troppo duri
sono i commenti. "Non chiediamo alla magistratura solo la chiusura del portale -
si legge in una nota diramata dall'associazione -, ma anche di aprire
un'indagine
per istigazione alla pedofilia
e alla sua pratica". Gli
autori, anche italiani, "sono specializzati nelle storie in cui si insegna come
stuprare i bambini - si legge nel testo -. Del resto, per loro,
raccontare è meglio che
stuprarli realmente". Sul
sito non vi sono immagini o video dal contenuto pedopornografico, ma solo testi
della cui natura prettamente narrativa
don Fortunato Di Noto,
presidente di Meter, nutre dei dubbi: "Ma come si fa a dire che sono solo idee,
immaginazione? - chiede -. Così fanno i negazionisti del razzismo, del nazismo,
dei lager e dei campi di concentramento quando dicono che la soluzione finale
era solo una idea. Pedofili scrittori che narrano stupri di bambini e le
presentano come 'fantasie' che non fanno del male a nessuno - conclude -: ma i
commenti sono tutto fuorché fantasie. Sono parole che mascherano una realtà
drammatica e spesso taciuta, la realtà dell'abuso".
Che siano solo opinioni
interessate da parte di un prete presidente di una associazione. Anche perchè è
troppo facile parlare di pedofilia se poi....
Lui 60 anni e lei 11: per
la Cassazione è amore. Annullata condanna a dipendente Comune Catanzaro.
La decisione della Suprema Corte farà sicuramente discutere. I due erano stati
sorpresi in flagranza in una villetta del catanzarese e l'uomo era stato
condannato in processo a cinque anni per violenza sessuale su una minore. Ora la
decisione di rivedere tutto riconoscendo l'attenuante della relazione
sentimentale, scrive Stefania Papaleo su “Il Quotidiano della Calabria. Lui 60
anni e lei 11 anni. Lui impiegato presso i Servizi sociali del Comune di
Catanzaro, lei bimba di famiglia disagiata. La mamma l'aveva affidata alle sue
cure. E lui l'aveva presa tra le sue braccia. Ma quando i poliziotti avevano
fatto irruzione in quella villetta in riva al mare, le sue braccia la tenevano
stretta sotto le lenzuola del lettone. Entrambi nudi. Ma anche innamorati,
scrivono oggi i giudici della Corte di Cassazione, che, tra le righe di una
sentenza che non mancherà di far discutere, individuano un'attenuante
nell'accondiscendenza della vittima a consumare rapporti sessuali con
l'imputato. Così, annullata con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di
reclusione per ben due volte inflitti a Pietro Lamberti, rispediscono gli atti
alla Corte di appello di Catanzaro e ordinano un nuovo processo. Che ripartirà
proprio da lì. Da quella villetta trasformata nell'alcova di un amore proibito.
Fatto di telefonate quotidiane e incontri a tutte le ore. «Ma tu mi ami», le
chiedeva romanticamente la minorenne. E lui, tentava invano di fermarla, per poi
lasciarsi andare a commenti a sfondo erotico. Fino a quando il timore di una
gravidanza lo avrebbe fatto desistere. E la paura si era sostituita al
corteggiamento. Così come emerge da alcune delle centinaia di intercettazioni
raccolte dai poliziotti. Lei gli faceva uno squillo quando si trovava da sola in
casa e lui la richiamava dal cellulare, fatta eccezione per il week end. «Non
chiamarmi sabato e domenica perché sono con la famiglia», la avvertiva. E lei
ubbidiva. Così come avrebbe fatto quella mattina di sole del 22 giugno di tre
anni fa, nel momento di indossare la gonna per poterlo “incontrare” in macchina,
perché ritornare nella casa di Roccelletta sarebbe stato troppo rischioso, le
avrebbe fatto notare il “suo uomo”, che da qualche tempo si sentiva addosso gli
occhi della madre della undicenne, tanto da raccomandare continuamente a
quest'ultima di non aprire bocca con nessuno e di non raccontare della casa di
Roccelletta, «perché questo è un segreto che ci dobbiamo portare fino alla
tomba». Ma il segreto alla fine fu scoperto. E Lamberto era caduto dritto nella
rete dei poliziotti che, dopo avere intercettato l'incontro, lo avevano seguito
e colto in flagranza.
Detto questo possono apparire
bigotte puritane e moraliste certe prese di posizione.
Cassazione, assolto un
60enne: fece sesso con una bimba di 11 anni,
scrive
Simona Bertuzzi su “Libero Quotidiano”.La
Cassazione salva l'uomo: "Era una vera storia d'amore". Lei era in affidamento.
Ma se per un giudice della Cassazione un uomo di sessant’anni che si porta a
letto una bambina di 11 è amore, solo amore, e una condanna a 5 anni per
violenza va annullata e rimandata in Appello perché l’attenuante della relazione
sentimentale non è stata presa in considerazione, a noi che resta? La notizia
l’ha raccontata con dovizia di particolari Il Quotidiano di Calabria. A
Catanzaro una mamma in difficoltà affida la sua bimba di 11 anni ai servizi
sociali del comune. Le dicono: siete una famiglia disagiata signora, lasci fare
a noi. E lei, la mamma disagiata, decide di fidarsi. Prende la sua bimbetta
adolescente, coi suoi 11 anni di giochi, codini e Winxs e la porta negli uffici
dei servizi sociali. «In fondo alla scala a destra, signora...» dove c’è
quell’impiegato così gentile, con quell’aria da medicone di paese. Da quel
giorno tra l’impiegato per bene e la ragazzina in difficoltà comincia una
storia allucinante, fatta di corteggiamenti, letterine, messaggi. Poi le gite al
mare nella villa di famiglia che resta vuota durante l’inverno, e infine il
sesso. Come una coppia di amanti qualunque, come il più banale e il più visto
dei rapporti clandestini. Il giorno dell’arresto il sessantenne viene trovato a
letto nudo con la bimba, nella sua casa estiva. La piccola è svestita anche lei
e lo abbraccia. La polizia che ha fatto irruzione nella casa non ha dubbi.
Finisce come deve finire: l’arresto e poi la condanna a 5 anni di carcere per
violenza sessuale. Fino a quando un solerte avvocato non fa notare che la
ragazzina era consenziente quando faceva sesso con l’impiegato comunale e dunque
non è stata considerata l’attenuante della relazione sentimentale. Di lì il
ribaltamento della sentenza. Amore dicono i giudici. Non pedofilia come siamo
abituati a considerare e giudicare qualunque rapporto con un minore. E a
sostegno della tesi si portano le centinaia di intercettazioni fatte dalla
polizia. Dalle quali emerge che l’undicenne lo assillava quotidianamente con la
domanda che fanno tutte le amanti: «Mi ami?. E lui all’inizio tentava di
fermarla perché temeva un gravidanza indesiderata, ma poi sai com’è, uno alla
fine cede e si lascia andare. Sempre le intercettazioni dicono che lei lo
chiamasse in continuazione quando era sola in casa, e lui le rispondesse dal
cellulare, imbarazzato e durissimo: «Non cercarmi il sabato e la domenica, lo
sai che sono in famiglia». Anche quella mattina del 22 giugno di tre anni fa
andò più o meno così. Lei indossava la gonnellina bella per «incontrarlo» in
macchina, perché tornare nella casa di Roccelletta sarebbe stato rischioso. E
lui fu più duro del solito: «Mi sento addosso gli occhi di tua madre, non devi
aprire bocca con nessuno e non devi raccontare della casa di Roccelletta perché
questo è un segreto che dobbiamo portarci nella tomba». Amore dicono i giudici.
Anzi no scusate: una relazione sentimentale. No. Non è vero. Avvocati, giudici,
fino all’ultimo praticante di tribunale avranno fatto ogni cosa a norma di legge
in questa orribile vicenda. Ogni cavillo sarà stato considerato, ogni telefonata
sarà stata risentita fino all’inverosimile, fino alla nausea. Ma noi no. Noi che
siamo solo gli spettatori inermi dell’orrore, le mamme e i papà che tremano ogni
volta che nostra figlia adolescente chatta su facebook o ha lo sguardo assente e
un po’ smarrito a tavola, noi non possiamo leggere, girare il capo, e fare finta
che sia tutto ok. Che non sia violenza. Che davvero sia possibile un rapporto
d’amore tra un 60enne e una bimba di 11 anni. Anche se lei scriveva sms. Anche
sei lei diceva «mi ami», metteva il vestito «degli incontri in macchina» e
aspettava che mamma uscisse a comprare il pane per rifugiarsi nella sua
cameretta e fare una telefonata al suo amore. Anche se lui, forse, pensava
davvero di amare quella bimba. Qualcuno dirà che al giorno d’oggi le undicenni
sembrano giovani donne fatte e finite, che vestono come le grandi e ammiccano
come loro. Era dovere di quell’uomo vedere l’orrore di quello che stava
facendo. Sentire la puzza di violenza e perversione e fuggire lontano,
preservando se stesso e la bambina dal più aberrante dei finali. E invece no:
lui, che faceva l’impiegato per i servizi sociali e avrebbe dovuto strappare la
ragazzina al disagio, sussurrava al telefono dalla sua poltroncina calda di
marito e impiegato irreprensibile: «Non chiamarmi a casa...». E già te lo vedi
il sabato fare la spesa, vedere gli amici e raccontare alla moglie indaffarata
in cucina le ultime dal Comune come se nulla fosse. Diceva talvolta alla bimba:
mi sento addosso gli occhi di tua mamma. Ma ve lo immaginate cosa deve aver
provato quella mamma a sentirsi dire che l’uomo che doveva aiutare la sua
bambina aveva abusato di lei? Che lei stessa aveva consegnato la figlia
all’orco? Anzi, l’aveva raccomandata? Pensavano fosse amore i giudici. Invece
era violenza e schifo e orrore.
GLI ORGASMI NELLA
STORIA DEL CINEMA.
Billy Crystal, tutta la
verità sull'orgasmo di Meg Ryan.
Da Orson Wells alla celebre scena del finto amplesso in "Harry ti presento
Sally": in un libro tutti e 65 gli anni dell'attore, scrive
Francesco Borgonovo su “Libero
Quotidiano”.. E’ il
1975. Un giovane comico di nome
Billy Crystal
è stato ingaggiato per apparire al Tonight Show di Johnny Carson. E’ la sua
prima volta nel tempio della comicità americana. In un angolo, seduto su una
sedia, c’è Orson Welles – ospite fisso del programma - che sta ripassando le sue
battute. “All’Università di New York”, ricorda Crystal, “Scorsese ci aveva
parlato molto di Welles e del suo straordinario lavoro di attore e regista (…) e
ora che me lo ritrovavo davanti avevo una certa soggezione”. Billy, preso
dall’entusiasmo, gli si avvicina. “Mi scusi, signor Welles. Sono Billy Crystal,
lavoro anche io nello show e volevo dirle che ho studiato i suoi…”. Welles lo
interrompe bruscamente: “…film, e lei è un innovatore e un grande regista e bla
bla bla. Sto lavorando, va’ a farti fottere”. Questo episodio, assieme ad altri
altrettanto divertenti, è contenuto nell’autobiografia che Crystal ha scritto
appena compiuti i sessantacinque anni, appena pubblicata in Italia da Sperling (Dove
sono stato, dove sto andando e dove diavolo ho lasciato le chiavi?,
pp. 308, euro 18). Si tratta di un memoir esilarante, che al racconto della
carriera del grande comico americano unisce le sue riflessioni
sull’invecchiamento, sul sesso, sull’amore (è sposato con Janice dal 1970, caso
più unico che raro a Hollywood) e su mille aspetti della vita. Un altro episodio
divertente è il dietro le quinte di Harry ti presento Sally, il celebre film di
Rob Reiner del 1989. E’ la mattina in cui Meg Ryan si appresta a entrare nella
storia del cinema registrando la scena dell’orgasmo al ristorante. “A un tavolo
vicino era seduta Estelle, la magnifica madre di Rob. Era lei la signora che
dice: ‘Quello che ha preso la signorina’. Cominciammo a provare, e Meg sembrava
un po’ insicura. Il primo orgasmo fu così così; in quello successivo sembrava
fossimo sposati da dieci anni. Forse era un po’ nervosa perché doveva
condividere il suo orgasmo con tanta gente. Rob, un po’ spazientito, la invitò a
fargli posto al tavolo perché potesse mostrarle cosa voleva da lei. Così mi
ritrovai seduto di fronte quest’omone barbuto e sudaticcio pronto a eccitarsi.
(…) Dopodiché Rob si esibì in un orgasmo da fare invidia a King Kong. ‘Sì, Sì,
Sì’ urlava, sferrando certi pugni sul tavolo che i sottaceti volavano e
l’insalata di cavolo fluttuava a mezz’aria. Una volta terminato, gli artisti di
contorno applaudirono e Rob mi prese da parte. ‘Ho commesso un errore’, mi
confidò. ‘Non avrei dovuto farlo’. ‘Meg non se la prenderà. Non credo tu l’abbia
messa in imbarazzo’, lo rassicurai. ‘Ma no, cos’hai capito?’, replicò. ‘Ho
appena avuto un orgasmo davanti a mia madre’”. Il meglio di sé, come
prevedibile, Crystal lo offre nei monologhi da stand up comedian. Prendiamo i
brani sul sesso. “Poi c’è quella pubblicità del Cialis dove dicono che se lo
prendi vai avanti per trentasei ore. Puoi fare sesso in qualsiasi momento,
nell’arco di quelle trentasei ore. Ma così è troppo stressante per me. Viviamo
in una società frenetica: vogliamo tutto subito, abbiamo internet e messaggi
istantanei, quindi vogliamo sesso istantaneo di certo non un Cialis che fa
effetto per trentasei ore. Trentasei ore è più della durata totale della mia
vita sessuale! E poi il Cialis non va bene per noi ebrei. ‘Irving, prendi questa
pasticca, funziona per trentasei ore’. E Irving: ‘Trentasei ore in un anno,
giusto? Posso riscattare quelle che non uso? Posso scambiarle con quel servizio
di piatti?’”. O ancora: “Ho sempre pensato che il segreto per avere una vita
sessuale soddisfacente fosse la varietà. E’ per questo che Dio mi ha dato due
mani”. A un certo punto, Crystal immagina di origliare la conversazione di una
coppia. Lui e Lei avevano venticinque anni nel 1973 e nel 2013 ne hanno compiuti
sessantacinque. “1973. Lui: Guardati, sei bellissima. Lei: Oh, ma dai! 2013.
Lui: Mai viste due tette così! Lei: Smettila di guadarti allo specchio e vieni a
letto.” “1973. Lui: Perché tieni gli occhi aperti? Lei: Perché mi piace
guardarti mentre facciamo l’amore. 2013. Lui: Cosa stai guardando? Lei: Le
tende, non si intonano con la parete”. “1973. Lei: Cavolo, sarà almeno venti
centimetri! Lui: Aspetta di vedermi eccitato! 2013. Lei: Accidenti, è così duro.
Lui: Il dottore ha detto che è benigno”. Infine, una piccola dichiarazione
d’amore per la sua città. “A Los Angeles gli inseguimenti fanno più ascolti di
CSI. Sono i reality originali. C’è quest’auto che va contromano in autostrada,
poi a centoquaranta in un centro abitato, dove si schianta contro una
recinzione. Al che il tizio al volante scende dalla macchina e si mette a
correre attraverso i cortili delle case saltando le staccionate, mentre la
troupe sull’elicottero lo inquadra dall’alto con un riflettore puntato su di
lui. Personalmente, credo che sia una delle migliori performance di Lindsay
Lohan”.
IL PORNO IN RETE.
Chi ha paura del porno in rete?
Si chiede Emmanuele Jannini
su “Panorama”. Il mantra ripetuto e rilanciato dai media è sempre lo stesso,
acritico e pedissequo: attenzione alla pornografia e al cybersex! Internet
pullula di pericoli per la salute sessuale e sociale di giovani e adulti. Ed
ecco che arriva “l’esperto” dichiarante
coram populo
che il sesso on line genera mostri, perversioni (per gli addetti: parafilie) e
subito dopo se ne alza un altro che cerca i riflettori ribattendo: no; produce
invece astenia sessuale, desiderio sessuale ipoattivo, inibizione. Ma su una
cosa sono entrambi d’accordo: l’inventarsi a tavolino due numeri spacciati per
“ricerche” (che naturalmente non verranno mai pubblicate su un vero giornale
scientifico) sulla pornoaddiction, giusto per guadagnarsi quei 15 minuti di
celebrità mediatica che a nessuno si negano. Qualche mese fa il
Journal of Sexual Medicine
mi ha chiesto di valutare la letteratura scientifica su questo argomento. Mi è
parso che ben pochi siano riusciti a sfuggire alla tentazione di un
atteggiamento giudicante, più teso a cogliere i rischi che non i possibili
benefici dell’espressione della sessualità on line. Così è stato per
Robert Weiss,
che si guadagna da vivere “curando” i sexual addicted nel suo Sexual Recovery
Institute, denunciando che il 12% dei siti internet sono porno (avrei detto di
più), il 25% delle parole googlate è correlato al sesso (68 milioni al giorno),
il 35% dei download è porno, 40 milioni di americani sono pornofili, il 70% dei
giovani visita un sito porno almeno una volta al mese (1/3 sarebbero donne) e il
giorno preferito per il cybersex sarebbe la domenica e le feste comandate.
Racconta questi numeri come rappresentazione dell’abisso di perdizione su cui ci
sporgiamo ad ogni click, ma a
Robert Weiss non
viene in mente che il pianeta non è, si direbbe, popolato da zombi iper- o
ipo-sessuali contagiati dal morbo internettiano. Nonostante la diffusione di
internet, la gente non si accoppia selvaggiamente sulla metropolitana e la
pressione demografica anziché calare è in continuo, drammatico aumento (ho
appena finito di leggere l’ultimo
Dan Brown: ne è
valsa la pena anche per riflettere su quest’ultimo – infernale – aspetto). La
stessa orrenda piaga dei delitti sessuali si colloca molto più facilmente
nell’aerea dell’ignoranza e della repressione sessuale che in quella della
licenza, come il paradigma vittoriano di
Jack-the-Ripper
ha insegnato e la cronaca conferma di continuo. In effetti, quando si cerca una
verifica empirica, galileiana, scientifica dei pericoli della pornografia e
della rete, le paure artatamente evocate da chi è interessato a suscitarle
sembrano venir meno. Il collega
Gert Martin Hald
dell’Università di Copenaghen ha scoperto che la pornografia è solo uno dei
fattori, e non il più determinante, che si può correlare a comportamenti
devianti o a rischio. Come sempre, non è il mezzo a creare il pericolo, come non
è il chianti a creare l’alcolismo. Né i sempre esistiti terrorizzati dai tempora
e dai mores riusciranno a conculcare la scopofilia (che non sta per, come
sembrerebbe ai non grecisti, la passione per la copula, ma quella di chi ama
guardare chi copula). Che il voyeurismo sia evidentemente innato nella nostra
specie lo dimostra la lettura del godibilissimo
The Prehistory of Sex: Four
million years of human sexual culture
di Timothy Taylor (Fourth Estate, Londra, 1996): appena l’uomo primitivo ha
imparato a graffitare le sue caverne le ha riempite di immagini sessuali.
D’altra parte il nostro cugino macaco è disposto a “pagare” con la sua riserva
di frutta la visione (noi diremmo:
pay per view)
di fotografie dei genitali delle femmine top rank (noi diremmo:
dive).
L’ha elegantemente dimostrato Robert Deaner del Dipartimento di Neurobiologia
della Duke University, North Carolina. Purtroppo sembra che nella nostra specie
sia anche innato l’istinto censorio che si direbbe talvolta si alimenti di
invidia. Censurando e lacerandosi le vesti, pochi si accorgono del vero pericolo
della pornografia: il modello di accoppiamento è rudimentale, violento,
maschilista, performante, ginnico, irreale, sostanzialmente costruito sulle
grossolane proiezioni maschili. Tuttavia la stragrandissima maggioranza degli
utilizzatori, anche abituali, ne trae piacere senza cercare di imitarne le
imprese sintetiche e artefatte, esattamente come succede a uno spettatore delle
olimpiadi che si diverte e partecipa, ma poi non si sente frustrato per non
nuotare come le medaglia d’oro dei 100 metri rana né prende a cazzotti o passa a
fil di spada il suo prossimo appena spento il monitor. Tutto rimane nell’ambito
(sano) della fantasia. Ignoranti e ingenui possono invece pensare che non sia
adeguato/a chi non abbia le dimensioni di Rocco Siffredi, chi non duri come la
leggenda metropolitana disse di Sting e chi non sia una disponibilissima
sacerdotessa del sesso come l’indimenticata Moana Pozzi. E poi ci sono i
perversi, quelli veri: la pornografia spasmodicamente cercata non è la causa
della loro malattia, che ha radici ben più remote; semmai ne è la conseguenza.
Un sintomo, quindi. E un amplificatore del tratto psicopatologico che trova cure
sia psicoterapeutiche sia farmacologiche. C’è un solo antidoto per questi, che
sono i veri seppur rarissimi rischi del porno internettiano: la conoscenza (nam
et ipsa scientia potestas est,
diceva Bacone e ho suggerito queste parole quando si è trattato di trovare un
motto per il mio Dipartimento universitario all’Università dell’Aquila) e
l’aperta discussione. Come faccio con voi in questo blog che apre lo spazio –
ovviamente internet – di
Sex Cathedra.
Professore
Emmanuele A. Jannini –
Coordinatore del Corso di Laurea Indirizzo Psicologia della Devianza e
Sessuologia – Università degli Studi dell’Aquila e di Sex Cathedra.
È fashion o porno?
Scopriamo il trucco...scrive Melissa Panarello su “L’Unità”. “Fashion or
Porn?” è il nome di un quiz che in questi giorni sta girando su Facebook. La
ragazza nella foto è seminuda e bella, ci sono le parole porn e game che già di
per sé costituiscono ottimi motivi per aprire la pagina e giocare a quello che
si rivela essere
il quiz d’intelligenza più
difficile del decennio.
Vengono proposti particolari di quaranta foto ed è da quei particolari che
bisogna indovinare se si tratta di un’immagine pubblicitaria o di una scattata
su un set porno. I creatori del test non hanno minimamente pensato di aiutare i
fannulloni che decidono di giocare, così capire se si tratta di una foto porno o
fashion risulta praticamente impossibile (a meno che, come me, non vi arrendete
e giocate tutto il giorno così da conoscere ormai ogni foto). La discriminante,
ovviamente, sono i genitali. Dove ci sono genitali ben esposti e “in azione”, si
tratta di porno. Il resto è arte. Un’altra differenza la traccia lo sguardo:
dove ci sono occhi languidi oppure divertiti, si tratta di porno. Se sono vuoti,
senza espressione, sono occhi prestati alla moda. Anche le piante finte possono
aiutare: nei set porno, per qualche misteriosa ragione, usano sempre ficus
benjaminus di plastica. Quello che stupisce è quello che in realtà già sappiamo
tutti, ovvero che il confine fra pornografia ed erotismo è sempre più sfocato,
che l’erotismo è morto negli anni 80, quando lo spietato Patrick Bateman spiava
gli
hard bodies
dal suo divanetto nel privé oppure quando in Italia Umberto Smaila sorrideva
beato fra le ballerine di “Colpo Grosso”. Il mercato ha semplicemente capito che
la pornografia frutta molti più utili dell’erotismo, dopotutto l’etimologia del
nome è molto chiara: il verbo
pernemi
(da cui porne,
meretrice) significa appunto vendere. Se vuoi vendere, dunque, devi usare lo
stesso linguaggio della pornografia, ma con un’eccezione: salvare i genitali.
Seguita quest’unica, semplice regola, puoi fare quel che vuoi: chiedere alla
modella o all’attrice di mimare un orgasmo per vendere un pacchetto di
fazzoletti, alludere a un ménage-à-trois per sponsorizzare una concessionaria di
auto usate, far calpestare un uomo da un tacco 12 per mostrare l’ultima,
strepitosa collezione primavera/estate. La pubblicità e il mercato devono tutto
alla pornografia. La pornografia, al contrario, non ha debiti con nessuno. Lei è
quel che è: sfrontata, volgare e sincera. Mentre tutti gli altri linguaggi
strizzano l’occhio, la pornografia ha la capacità di guardarti con tutti gli
occhi aperti, anche un po’ infantili. E’ questo che la rende irresistibile,
tanto invidiata e imitata. Roman Polański dice che mentre l’erotismo usa solo
una piuma, la pornografia usa il pollo intero. Le pubblicità proposte nel gioco,
che sono le stesse che vediamo tutti i giorni, ovunque, usano un’ala o un petto
di pollo. Questo significa che presto arriveremo tutti a mangiare il pollo
intero? Che si abbandoneranno le allusioni e diventerà tutto pornografia? Non
credo. Il mercato, oltre che di sesso, ha bisogno di nutrirsi di mistero. Se non
alimenti il mistero anche i messaggi sessuali perdono potenza, non hanno più
valore. La coscia di pollo, dunque, è il limbo cui siamo approdati e su cui
rimarremo per molto, molto tempo. Sono fermamente convinta che associare il
corpo al sesso non sia di per sé umiliante né tanto meno scandaloso. È anzi
separandoli che si creano sempre più fratture, crisi identitarie, sessuofobia.
Il corpo è anche sesso e il sesso, immagino/spero/credo, non è umiliante per
nessuno. L’uso che il mercato fa del corpo e del sesso non toglie senso e
bellezza ai corpi e ai desideri sessuali: se una società ha una coscienza
sessuale definita, se non ha paura delle sessualità in tutte le sue forme, se
non ha paura del corpo e delle infinite possibilità in esso racchiuse, come può
un cartellone sull’A1 minacciare l’identità sessuale o denigrarla? Ogni cosa è
spettacolo e lo spettacolo, per sua natura, si ciba di e vomita menzogna.
Scoperto il trucco, siamo tutti liberi.
Nymphomaniac di Lars Von
Trier: "Un film ripugnante da amare".
Il chiacchierato lungometraggio che promette sesso esplicito ha debuttato in
Danimarca. E spuntano le prime recensioni. Controverse, scrive Simona Santoni
su “Panorama”. Il giorno di Natale Nymphomaniac, il nuovo lavoro
di Lars Von Trier che promette sesso esplicito a profusione, ha debuttato in
Danimarca. E intanto cominciano a comparire le prime recensioni. Il film
racconta la storia erotica di una donna che si è autodiagnosticata ninfomane,
interpretata da Charlotte Gainsbourg. Dopo un certo vuoto distributivo, il
lungometraggio finalmente ha trovato distribuzione in Italia grazie all'audace
Good Films di Ginevra Elkann. La pellicola è diventata oggetto di attenzione
ancor prima dell'inizio delle riprese perché il controverso e innovativo
cineasta ha annunciato che si tratta di un porno con scene di sesso vero
interpretate da attori hollywoodiani come Gainsbourg, Uma Thurman, Shia LaBeouf,
Willem Defoe e Christian Slater. Secondo alcune fonti in realtà Lars Von Trier
non ha detto tutta la verità: per le scene più hot, infatti, professionisti
dell'hard avrebbero "prestato" i loro organi genitali ai divi. Panorama.it ha
già pubblicato i teaser trailer scandalo (uno è stato rimosso da YouTube per i
suoi contenuti ritenuti inappropriati), il trailer ufficiale e i character
poster che rappresentano l'orgasmo. In attesa di poter vedere l'ultima
provocazione del controverso regista danese anche da noi, ci affidiamo alle
parole dei colleghi stranieri. "Nymphomaniac di Lars von Trier randella
il corpo e intenerisce l'anima. È sconcertante, assurdo e assolutamente
affascinante", scrive Xan Brooks sul Guardian. "Un film sul sesso che è
volutamente poco sexy e una lunga storia loquace (due volumi, quattro ore) che
in gran parte parla a se stessa. Quelle figure nude in movimento sono solo una
distrazione". E ancora: "Personalmente l'ho trovato un'esperienza livida e
faticosa ma il film è rimasto con me. È così carico di calci piazzati, così
screziato di idee ossessive e voli arditi della fantasia che raggiunge una sorta
di trascendenza. Nymphomaniac mi infastidisce, mi ripugna e penso che
potrei amarlo. Si tratta di un rapporto violento; ho bisogno di vederlo ancora".
Secondo Peter Debruge di Variety l'enfant terrible del cinema
internazionale - ormai non più enfant ma sempre terrible -
"consegna un denso lavoro progettato per scioccare, provocare e infine
illuminare un pubblico che considera fin troppo pudico". Tra tanti riferimenti
all'arte, alla musica, alla religione e alla letteratura, "in questa versione di
Nymphomaniac l'unica eccitazione nell'intenzione di Von Trier è di tipo
intellettuale, rendendo questa immagine filosoficamente rigorosa più adatta ai
cinefili che alla folla impermeabile". Il film infatti è pensato per essere
proiettato in due versioni; quella "corta" e soft è di quattro ore ed è quella
attualmente uscita nelle sale danesi, divisa in due parti. La versione più lunga
e hard è della durata di 5 ore e mezza e anche questa è divisa in due parti. Di
questa versione, il volume 1 avrà la sua prima mondiale al Festival di
Berlino. Todd McCarthy su Hollywood Reporter ci rivela che in fin dei
conti Nynphomaniac è molto meno hard "di quanto molti potrebbero aver
immaginato o sperato. Eppure non è mai noioso". Nymphomaniac è uno dei
rari film di Von Trier a non aver debuttato al Festival di Cannes, da cui il
regista venne cacciato nel 2011 per alcune dichiarazioni sconcertanti sul
nazismo. In Italia arriverà a marzo nelle due versioni (sarà distribuito così
anche negli Usa da Magnolia Picture).
Von Trier sbarca a Berlino
con «Nymphomaniac» e sdogana il sesso esplicito.
Nelle sale aumento le pellicole osé. E tornano alla memoria Kubrick e
Bertolucci, scrive Dina Disa su “Il Tempo”. Con l’avvento di Internet il
mercato dei film porno è praticamente finito, distrutto dai video relity online
e dall’amatoriale. Ora il sesso esplicito è territorio del cinema d’autore. Sono
passati i tempi in cui Bertolucci faceva scandalo con «Ultimo tango a Parigi» o
quando Malle raccontava i suoi adolescenti perversi e la Bellucci si prestava ad
una scena di sodomizzazione per ben 9 minuti diretta da un talentuoso Gaspar Noè
in «Irreversible». La tendenza sta diventando quasi un obbligo anche per le star
più affermate che si esibiscono in scene lesbo o full frontal d’autore. Da
«Shame» di Steve McQueen, con un glorioso Michael Fassbender, che ha suscitato
entusiasmo presso critica e pubblico, anche per le immagini in cui appariva nudo
in fullscreen al lesbo movie «La vie d’Adele». La fantasia di Kubrick in «Eyes
Wide Shut» non si può certo paragonare al trasgressivo «Shortbus», esplicito sì,
ma poco raffinato e ossessionato dal contorsionismo. Nonostante due precedenti
eccellenti come la fellatio metafisica di «Batalla en el cielo» del messicano
Reygadas e la fellatio americana di «The Brown Bunny», di Vincent Gallo (2003),
la ribalta porno d’autore parte soprattutto Oltralpe. Ne sanno qualcosa gli
amatori di «Baise-moi» di Coralie Trinh Thi, interpretato da veri attori hard
core che con disinvoltura offrono le proprie performance alla cinepresa. Mentre
il nostro pornoattore Rocco Siffredi è apparso in «Romance» di Catherine
Breillat. A parte «Caligola» di Brass, l’erotismo di Bertolucci e l’altro grande
cult, «Impero dei sensi» di Oshima, il film d’autore con scene hard in Francia
ha tradizione più solida. Ora tocca al danese Lars Von Trier scandalizzare, e
per giunta la platea raffinata di un festival intellettuale come la Berlinale
(6-16 febbraio), con il suo «Nymphomaniac». Ad interpretarlo ancora lei, la sua
musa di sempre, Charlotte Gainsbourg, nei panni di una ninfomane raccolta
insaguinata per strada da un professsore (Stellan Skasgard) al quale racconterà
le sue estreme esperienze sessuali.
Nel cast anche
Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem
Dafoe, Jens Albinus e Connie Nielsen.
Tra genitali finti, sesso vero
con attori porno usati come controfigure, membri maschili di ogni genere e
colore che riempiono il grande schermo, la versione integrale (di oltre 5 ore)
sarà proposta alla Berlinale mentre l’altra sarà distribuita a marzo in Italia
da Good Films. Il film è di grande livello artistico: certo, può non piacere o
irritare, ma è impossibile che non colpista lo spettatore, preso per mano verso
i lidi più estremi della sessualità. Certe scene di masochismo, per la
Gainsbourg, «sono state umilianti», soprattutto quando si è lasciata frustare a
sangue legata su un divano. Mentre il cerebrale professore trovava paralleli
avventati tra le avventure erotiche della sua eroina e le realtà culturali, come
la successione numerica di Fibonacci (paragonata alle infinite posizioni assunte
dalla Gainsbourg) o la differenza tra sessualità libera e quella sadomaso,
rapportate alla Chiesa d’Oriente e a quella più punitiva d’Occidente.
L’escalation della protagonista ripercorre i déjà vu di Anais Nin, Henry Miller
e del Marchese de Sade. Diverse le presenze italiane alla Berlinale (compresa
Valeria Golino in giuria), ma nessun film in concorso: nella sezione Generation
«Matilde», cortometraggio di Vito Palmieri e «Il sud è niente» di Fabio Mollo;
nella sezione Forum «Materia oscura» documentario di Parenti e D’Anolfi (girato
nel poligono del Salto di Quirra in Sardegna dove gli eserciti hanno testato per
anni le nuove armi con danno all’ambiente); nella Kulinarischen Kino saranno
presenti «Couscous Island», documentario di Amato e Scarafia, oltre a «Green
Porno Season Two» di Isabella Rossellini e Jody Shapiro, «Slow Food Story» di
Stefano Sardo e «Cavalieri della laguna 1» di Bencini. Nella sezione panorama
sono infine attesi «Felice chi è diverso» di Amelio, «In grazia di Dio» di
Winspeare e «La migliore offerta» di Tornatore. Tra le anteprime internazionali,
oltre a «Nymphomaniac», anche «Monuments Men» di George Clooney, «Grand Budapes
Hotel» di Anderson e poi, Resnais, Linklater e Bouchared.
Tira più un video hot di un
carro di libri!!
Questa è l’opinione di Francesco Maria del Vigo su “Il Giornale”. Per fare il
verso ad un antico detto: tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Tira
più un video hot di un carro di libri? Il celebre adagio si può tradurre in
un’agile regoletta sull’informazione on line. Ma solo a un’occhiata frettolosa e
quanto mai accigliata. Il dibattito sulla “leggerezza” dell’informazione on line
è un tema di discussione caro non solo agli addetti ai lavori. E c’è sempre chi,
bacchetta moralizzatrice alla mano, intona dolorosi lamenti per la depravazione
dei lettori (ma sono gli stessi che amano aggiungere una E all’inizio della
parola) italiani che si riversano sopra contenuti soft porn. Prefiche di una
verginità mai avuta. Seni esibiti in un autoscatto, perizomi che fanno capolino
da pantaloni adamitici, capezzoli che sbucano sornioni da vestiti troppo
scollati. Il basso si mescola inevitabilmente con l’alto nel cocktail
dell’informazione. Alle volte se ne ricava un beverone indigeribile, altre un
cicerone dalle piacevoli allucinazioni. È internet, bellezza. Al bando gli
snobismi, suvvia. Non c’è niente di male. Chi dice che dietro una natica non
possa nascondersi un contenuto culturale? In quale sacro testo sta scritto che
lo sguardo che scivola giù per una profonda scollatura non finisca poi a leggere
una poesia, per dire? Facciamo un esempio casalingo. Su queste pagine è stata
pubblicata una pirotecnica intervista a Tinto Brass. Maestro dell’eros e
dell’approccio carnale alla vita. Uno che, per intenderci, è stato escluso dal
Festival di Venezia fino all’anno scorso, perché mostrava troppi centimetri di
ignuda epidermide. Al microfono di Sylos Labini ha raccontato che “il culo è lo
specchio dell’anima” e ha ricordato – ai pochi che non conoscono la sua opera –
che con i suoi film procura “emozioni e non soltanto erezioni e lubrificazioni”.
Ci sono voluti trent’anni perché il Lido ospitasse una retrospettiva sul regista
(e non poteva che essere una retrospettiva una rassegna antologica del regista
veneziano). Dopo aver sventolato la censura e sfoderato il cipiglio del
bacchettonismo arriva, trent’anni dopo, la celebrazione. Per non parlare della
ormai mitologica – e citatissima – intervista a Rocco Siffredi. Estrema,
esagerata e più siffrediana che mai. Un colloquio senza filtri che è rimbalzato
sulle pagine di decine di quotidiani. Non nascondiamoci dietro a un seno: i
contenuti leggeri fanno clic e spesso sono interessanti, si fanno leggere e
portano lettori. Lettori che poi si guardano attorno, perché a pochi pixel dallo
scontornato di una coscia può apparire la recensione di un libro o la critica
acuminata di uno spettacolo teatrale. Ed è subito contaminazione. Niente di
nuovo sotto il cielo grigio della cultura italiana, un cielo pesante come il
piombo, claustrofobico. Spesso le idee più scomode e urticanti trovano spazio
tra le cosce della provocazione. Non per caso su Playmen, negli anni sessanta,
sbarcarono intellettuali del calibro di Gian Carlo Fusco e Luciano Bianciardi e
trovò spazio, persino, il pensiero osè di Julius Evola. Ieri come oggi la
cultura libera non ha paura di percorrere le autostrade della comunicazione per
entrare nelle zone traffico limitato del pensiero. E alla fine il bacchettone
non si rende conto che è più volgare chi mangia una banana nascondendosi dietro
a una mano – nel nome di chissà quale pudore – di una fellatio.
LA PORNOGRAFIA.
Pornografia.
Universo del Corpo
(2000),
scrive di Piero Benassi su “Treccani”.
Pornografia.
Il termine pornografia (che deriva, mediante il francese pornographie, dal greco
πόρνη, "prostituta", e γραθία, "scritto") sta a indicare la trattazione oppure
la rappresentazione, attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli
ecc., di soggetti o immagini osceni, effettuata allo scopo precipuo di stimolare
eroticamente il lettore o lo spettatore. sommario: 1.
Relatività del concetto . 2. Diffusione attuale. 3. Pornolalia. 4.
Interpretazioni.
1.
Relatività del concetto.
La pornografia può essere considerata un'esibizione di organi o di atti sessuali
finalizzata a provocare eccitazione. Come ogni altra espressione umana, essa
risente fortemente della cultura del luogo e dei tempi in cui viene realizzata.
Nel Palazzo del Tè di Mantova, edificato per le relazioni proibite dei Gonzaga,
o in alcuni degli affreschi di Pompei sono raffigurate scene erotiche che
nessuno interpreta come pornografiche, così come nessuno è eccitato dalla coppia
a letto rappresentata nel Palazzo del Podestà di San Gimignano o di fronte ai
nudi di Tiziano. Infatti, occorre distinguere fra il nudo proprio dell'arte
erotica e il corpo nudo della pornografia. Inoltre, dai tempi dei Gonzaga o di
Tiziano, è mutata la cultura e con essa la sensibilità. Nel Giudizio Universale
della Cappella Sistina Michelangelo ha dipinto molti corpi nudi, in quanto nel
Rinascimento il nudo non era considerato pornografico, come invece lo fu
all'epoca della Controriforma quando, infatti, si ritenne opportuno coprire le
figure michelangiolesche. I libri cinesi d'ammaestramento pedagogico per
istruire alla sessualità una buona moglie sono invece considerati pornografici
per l'Occidente. In Africa i missionari hanno costretto a vestirsi gli indigeni,
che, invece, consideravano il nudo del tutto privo di significati erotici.
L'effetto che un seno scoperto aveva fino a qualche anno fa attualmente ha perso
gran parte del suo significato, se non è accompagnato da messaggi o stimolazioni
più incisive, in quanto sono cambiati gli stimoli all'erotismo e di conseguenza
i significati ritenuti pornografici, anche perché le nuove tecnologie mediatiche
hanno determinato un rivolgimento nei gusti e nelle aspettative dei fruitori di
tali messaggi. Sono tutti esempi di come il fenomeno pornografico risulti
condizionato da una serie di fattori ben individuabili e siano diverse le
valutazioni interpretative circa quello che viene considerato pornografico o
meno. Il binomio pornografia-tabu, sostenuto da correlazioni teoriche, concetti
psicodinamici e dimostrazioni storiche, inquadra i limiti del lecito rispetto a
quello che i tabu rifiutano. Tra le variazioni culturali della pornografia, si
possono distinguere quella erotica, che stimola l'uso 'normale' della
sessualità, da una pornografia che invece si riferisce a pratiche
sadomasochistiche, omosessuali, incestuose che giungono fino al feticismo, al
travestitismo e al transessualismo (Andreoli 1989).
2.
Diffusione attuale.
Negli ultimi anni del 20° secolo i dati sul consumo dei prodotti pornografici
hanno segnalato un costante aumento. Rispetto ai tradizionali prodotti stampati,
hanno avuto crescente successo le videocassette che permettono l'uso privato dei
film e quindi una maggiore utilizzazione rispetto ai cinema 'a luci rosse'. Meno
diffusi in Italia, ma molto altrove, sono i pornoshops, i quali offrono oggetti
utilizzabili per un rapporto pornografico attivo che oltrepassa la semplice
percezione visiva. Un'altra innovazione è rappresentata dall'erotismo telefonico
che offre il godimento di una relazione variabile a seconda delle
caratteristiche richieste, impiegando mezzi vocali e verbali fortemente
evocativi. Nell'attuale società si è diffusa, inoltre, l'offerta multimediale di
varia sessualità via Internet, che in questo campo si pone in alternativa
all'esperienza dei rapporti umani diretti e pare rispondere al carattere
'intellettuale' della sessualità contemporanea, caratterizzata da una
sofisticata elaborazione immaginativa. Per la sua perfezione tecnica, l'erotismo
multimediale sembra consentire stimolazioni istintive finora racchiuse
nell'immaginario privato, ma che oggi possono tradursi in corpose immagini
ricche di sensorialità, sostitutive o anticipatorie degli eventi reali. Questo
erotismo, che può facilmente sfociare nel pornografico, diventa sempre più un
voyeurismo trasgressivo, a uso del singolo, ma anche di coppia e di gruppo; in
alcuni casi utilizzato in luogo della pratica sessuale, è un fenomeno di
parasessualità ascrivibile a difettoso sviluppo della personalità, oppure può
rappresentare un sostituto di sessualità turbata dalla paura di contagio di
malattie veneree, soprattutto dell'AIDS. In una dimensione tribale o comunitaria
la raffigurazione di soggetti erotici o di atti sessuali assume prevalentemente
un significato rituale e finalità estetiche; nella società di massa,
contraddistinta da tendenze e aspettative anche molto differenziate, il realismo
o il simbolismo erotico vengono contaminati dalla trivialità e dall'insistenza
compiacente su perversioni sessuali, pratiche sadomasochistiche, voyeurismi ecc.
Nelle librerie è in notevole aumento la manualistica erotica; superate le
pubblicazioni dei rituali sessuali induisti-buddhisti, di moda fino a pochi anni
fa, i testi attuali esplorano le frontiere di un erotismo più carnale,
suggeriscono aspetti sempre più ludici, consigliano l'utilizzo di nuovi
afrodisiaci e di farmaci contro l'impotenza o per potenziare le capacità
sessuali e sollecitano un uso di nuove tecnologie al servizio del piacere
sessuale. Nel cinema, il genere pornografico, presente sin dai primordi, è in
pieno sviluppo; non mancano le pellicole dove la pornografia è usata come
elemento drammatico, ma in genere gli spunti narrativi si perdono in mediocrità
ripetitive, non ci sono veri drammi, ma nemmeno sogni o realistiche redenzioni:
in questo mondo persiste un insistente squallore nel quale ogni mistero perde i
propri connotati, in quanto ogni aspetto di affettività, emotività e potere
oscilla in un ventaglio di espressioni sessuali dai confini sempre più incerti.
Sono numerosi gli esempi di inserimenti pornografici nell'ambito della
quotidianità, dal moderno design di oggetti di uso comune a tutte le
riproduzioni, le illustrazioni e i richiami, anche di stile pubblicitario. In
campo letterario, si devono distinguere le opere alle quali lo spunto o la
partecipazione di un erotismo ragionevolmente introdotto ed equilibrato
assicurano un interesse e uno stimolo alla lettura, dal pornografico letterario
vero e proprio, in cui gli autori ricorrono alla ripetizione e all'esagerazione,
a situazioni esasperate, con avventure erotiche in luoghi favolistici nel corso
di viaggi immaginari ecc., e che ha un tono sempre teso e drammatico, descrive
esperienze eccezionali, è privo di senso dell'humour, della contemplazione, del
distacco e della logica, si sviluppa in situazioni di allarme o di angoscia
nelle quali le valenze sadomasochistiche, distruttive e autopunitive sono
reiterate per stimolare immaginazioni e pulsioni istintive inabituali. La
letteratura, il cinema e i mass media abbinano spesso l'erotismo incontrollato
con la violenza, l'aggressività, gli impulsi, cioè aggiungono ingredienti idonei
ad amalgamare aspetti dell'istintività che cercano soddisfazione sia tramite
l'eros sia attraverso manifestazioni distruttive. Si realizza, dunque, una
specie di connubio fra i due estremi, erotismo e senso di morte, in cui affetti,
sentimenti, emozioni, passioni possono esplodere in forme drammatiche. Questo
amalgama di pulsionalità istintiva può essere catalizzato dalla droga e dal
connubio fra sesso e violenza. L'effetto droga rispecchia la ricerca, presente
nella letteratura a carattere erotico-osceno ma anche in alcuni aspetti della
realtà quotidiana, di piaceri assoluti e immediati, di evasioni e di fantasie
liberatorie, e mette in gioco l'erotismo, più fantasticato che reale, ma anche
il rischio della vita, in un sempre possibile abbinamento con la pornografia,
alla ricerca di potenziamenti reciproci. Tuttavia sia la pornografia sia la
droga stimolano la realizzazione di soddisfazioni istintuali che smorzano le
funzioni del razionale, della conoscenza della realtà e della morale, per cui la
contemplazione, la fantasia, il piacere, gli istinti tendono a sostituire
l'azione, l'attività lavorativa e creativa, il dinamismo operativo. L'associarsi
di queste due esperienze può suscitare fenomeni di depersonalizzazione, sia del
proprio corpo sia della realtà esterna, può sottrarre alla latenza tendenze
oppure impulsi sessuali prima controllati o ignorati, può infine provocare
sentimenti di diffidenza, di ostilità, di odio, con possibili reazioni auto ed
eteroaggressive.
3.
Pornolalia.
La pornolalia è ormai utilizzata a tutte le età e da tutti i ceti sociali. Tale
forma di linguaggio ha infatti enormemente dilatato i propri confini,
contestualmente al graduale ridursi degli eufemismi, dei tabu terminologici,
delle metafore. L'uso e l'abuso delle parole a contenuto erotico, sessuale e
genitale, si possono prospettare come una vera e propria mentalizzazione
dell'istinto che si realizza a livello verbale per dare un rinforzo e un
potenziamento di significato nel rapporto comunicativo. Pornolalia si può
definire come l'espressione di un'aggressività verbale, che in passato era
essenzialmente maschile, ma che ora si è sviluppata molto anche nel linguaggio
femminile, quasi come mezzo di autoaffermazione e rivendicazione della parità
dei due sessi. Anche il bambino prova un gran piacere nel dire le parolacce: pur
se ne ignora il significato, ne coglie al volo l'effetto dirompente e
dissacratorio e le reazioni che provocano attorno a lui; l'impulso più immediato
è, quindi, a ripeterle (Vegetti Finzi-Battistin 1994). Inoltre, il linguaggio
osceno è molto vicino al corpo e alle sue funzioni, evoca impressioni tattili,
olfattive, uditive, adatte a esprimere le pulsioni infantili, specie anali e
genitali, ed è composto di parole che infrangono argomenti tabu, diversi tra
loro, ma ugualmente intoccabili: il sacro, il sesso e gli escrementi.
Nell'adolescenza, che riattualizza le trasgressioni e le dissacrazioni,
specialmente se realizzate insieme al gruppo sociale, la pornolalia fa parte del
linguaggio di gruppo, rappresenta forza, coesione e convalida l'identità verbale
e comportamentale. Vanno poi considerati i fattori ambientali e sociali che
ritardano lo sviluppo verso la maturità della personalità e che quindi
mantengono a lungo comportamenti ed espressioni anche pornolaliche che si
continuano mediante un condizionamento automatizzato.
4.
Interpretazioni.
La letteratura psicoanalitica sui principi costitutivi del perverso sessuale ha
evidenziato, in particolare, che l'erotizzazione è una delle cure primitive
della paura: quando una forma di angoscia infantile riprende vigore nella vita
adulta, uno dei molti modi per fronteggiare questa crisi è il rafforzamento dei
sistemi di erotizzazione primitiva, cioè di una sorgente originaria delle più
svariate perversioni. Le angosce più profonde possono rappresentare il nucleo
propulsore delle più varie patologie sessuali che, in fase di esasperazione, si
abbinano spesso a fatti violenti, quali espressione concreta d'impulsi che
esplodono e si scaricano tramite forme di aggressività; la criminalità a sfondo
sessuale ha spesso questa patogenesi. Inoltre, nella nostra società si vanno
palesando nuove tecniche erotiche in cui oscenità e violenza, insieme, sono più
accentuate che nel passato. In questo scenario, la pornografia rappresenta un
aspetto di dissoluzione della sessualità che si inserisce in una costellazione
di crisi profonda dei valori, di negazione violenta e anche spietata del pudore,
inteso come struttura portante della storia interiore dell'individuo. Il pudore
del singolo non va confuso con il cosiddetto comune senso del pudore, che spesso
è chiamato in causa proprio per circoscrivere il fenomeno pornografico. In ogni
caso, il pudore può essere ricondotto alla delimitazione dei confini tra il
lecito e il proibito, mentre alla pornografia vanno riconosciuti una componente
ossessiva, in quanto comportamento ritualizzato fondato su un desiderio
irrealizzato, e un suo affondare nei fantasmi più o meno perversi,
universalmente presenti nell'inconscio individuale. Analizzando gli aspetti
psicologici e antropofenomenologici del pudore, questo può essere inteso come
barriera di protezione nei confronti dei valori affettivi che connotano la vita
individuale nei suoi vari modi di manifestarsi (De Vincentiis-Callieri 1974);
l'eros pubblicizzato dimostrerebbe che gli impulsi sessuali si sono scissi da
quelli affettivi. Rispetto al pudore, l'analisi antropofenomenologica valuta una
serie di condizioni necessarie al suo costituirsi: il corpo, l'altro o gli
altri, il guardare e l'essere guardati. La genesi del pudore è relazionale, di
spazialità, di distanza, di stimoli sensitivo-sensoriali, ed è espressione
esistenziale ambigua perché può essere autentica o inautentica a seconda della
sua fungibilità nel mondo dei rapporti interpersonali. L'incontro, il rapporto,
la mondanità possono, dunque, oscillare in un'estensione ubiquitaria,
dall'ossessionante pudicizia alla più sfrenata pornografia: in questo modo
oggettuale (pudico od osceno) l'orizzonte esistenziale risulta povero o comunque
costellato di oggetti anodini, senza rapporti dinamici, senza storia e quindi
senza valori da offrire o da rappresentare. Oltre a ciò, sono noti gli aspetti
psicopatologici nell'ambito sia del pudore sia dell'eros pornografico, con una
serie di fenomeni che tendono in molti casi a unificarsi nella loro patologia
(v. oltre). E. Borgna (1989), richiamando i fondamenti etici dell'esistenza
umana, osserva che i valori hanno una costituzione eidetica autonoma e assoluta,
che non può essere infranta senza rompere quell'ideale gerarchia in cui la
dignità della persona ha un'importanza assoluta; il fenomeno della condotta
pornografica s'inserisce nella costellazione della profonda crisi dei valori. La
persona, con il suo corpo, viene reificata e parcellizzata dalle pulsioni della
libido narcisistica che mantiene la cecità, il mutismo e l'anonimato di un
oggetto strumentalizzato dalla cultura di massa. Anche dal punto di vista
giuridico la pornografia si pone nel quadro dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume, e in particolare contro il pudore (art. 529 c.p.
riguardante la definizione legale dell'osceno, in riferimento agli atti e agli
oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore). Questa norma è
formalmente esplicativa, in quanto individua il significato del termine osceno
in riferimento all'effetto o al risultato sociale dei comportamenti e degli
oggetti così qualificati, ammettendo anche la possibilità di un osceno non
offensivo per il comune sentimento del pudore, di cui peraltro manca una
specifica definizione, rinviata a un'interpretazione giurisprudenziale
forzatamente aperta o elastica. In riferimento alla qualità dell'attuale vivere
sociale, alla salute mentale e alle possibili manifestazioni di violenza
collegabili a fenomeni pornografici, si può affermare che la pornografia
riguarda una violenza suggestiva che permea tutta la società consumistica e
cerca d'imporre al consumatore, soprattutto a quello poco in grado di difendersi
dalla pressione dei mass media, beni di nessuna utilità materiale, ivi compresa
una sessualità degradata. La pornografia può, quindi, nascere anche dalla
frustrazione di non riuscire a ottenere i beni consumistici, come fenomeno
sostitutivo e come risposta dell'individuo a un ambiente denso di stimoli
egoistici. Gli pseudovalori della società consumistica costituiscono la premessa
logica a un uso della pornografia come riferimento a modelli comportamentali
molto attuali e sempre più valorizzati e pubblicizzati. Secondo alcuni, il
comportamento sessuale illustrato dalla pornografia facilita reazioni che
portano alla violenza, che può giungere fino alla criminalità sessuale
(Ferracuti-Solivetti 1976). Sono tuttora numerosi i dati da verificare: in
particolare se la criminalità sessuale possa essere collegata a un maggiore o a
un più precoce consumo di pornografia, oppure se abbiano più importanza i
fattori endogeni, riducendo quindi il ruolo della pornografia a fattore sociale
capace di scatenare determinate reazioni solamente in individui diversi dagli
altri per certi tratti di personalità. Questi dati non risultano ancora del
tutto conosciuti, ma resta acquisito che i contenuti violenti dei materiali
pornografici potenziano, nella loro combinazione, le valenze istintive
pulsionali, e sono tali da contribuire al diffondersi di specifici comportamenti
criminali. Altre indagini, come pure differenti orientamenti ideologici,
sostengono che la pornografia, quale mezzo idoneo a liberare, a catalizzare
oppure a metabolizzare tensioni o impulsi sessuali altrimenti irrisolvibili,
possa produrre effetti catartici tali da contribuire alla risoluzione di
problemi sessuali e da lenire problemi e angosce esistenziali con conseguente
riduzione di forme di aggressività. Nel DSM-IV (Diagnostic and statistical
manual of mental disorders), dell'American psychiatric association (1994), oltre
alle più svariate disfunzioni sessuali, anche i disturbi d'identità in genere e
in particolare tutte le perversioni sessuali (v. perversione)
‒
feticismo, 'frotteurismo', zoofilia, pedofilia, esibizionismo, voyeurismo,
sadismo, masochismo, trasvestitismo
‒ sono elencati e
descritti come casi clinici di disturbi psichici. È possibile che alcune di
queste patologie trovino in qualche fenomeno di oscenità sessuale un compenso o
un sollievo terapeuticamente valido. D'altra parte, è certo che le
sollecitazioni provocate da perversioni pornografiche, eventualmente associate a
violenza, a carico di soggetti già vulnerabili nei loro comportamenti sessuali,
possono rappresentare fattori patogeni per la salute mentale, a maggior ragione
se si tratta di soggetti con immaturità caratteriale, con difetti di sviluppo
intellettivo o con disturbi o tratti abnormi della personalità.
La pornografia, o la logica
culturale del nostro tempo,
pubblicato da Gianluigi Simonetti e scritto da
Emiliano Morreale su “Le
Parole e le cose”.
Le immagini di sesso esplicito, per lungo tempo vendute e consumate in maniera
più o meno sotterranea e illegale, nel corso del decennio hanno invaso gli
schermi domestici. Dal 1988 al 2005 i titoli a luci rosse negli Usa sono passati
da circa 1200 a più di 13.500 l’anno (la Hollywood “ufficiale” ne produce circa
400). Secondo i dati più attendibili, nel 2006 erano attivi almeno 4 milioni di
siti porno: il 12% di tutta la distribuzione online (oggi saranno molti di più,
visto che ne nascono circa 270 al giorno). Una parola su quattro inserita nei
motori di ricerca, e un download su tre, sono di carattere pornografico. La vera
mutazione però è qualitativa, e non riguarda i singoli prodotti, ma la struttura
del sistema. Il cinema, la televisione, la moda hanno un “doppio” osceno
sotterraneo e rimosso, che sempre più viene a galla al tempo di Internet. Questo
mondo è interrogato dagli studiosi di rado, e con comprensibile imbarazzo. In
America i cosiddetti porn studies sono nati all’inizio degli anni Novanta, da
una costola della teoria femminista e dei
cultural studies.
Da qualche tempo, questo filone di studi è giunto anche in Italia, ad opera di
una generazione di studiose e studiosi non a caso trenta-quarantenni, che in un
mondo così sono cresciuti. Da un paio d’anni a Gorizia si tengono convegni
internazionali sul tema (con titoli tipo “Economies, Politics, Discoursivities
of Contemporary Pornographic Audiovisual”) ed è appena uscito un ponderoso
volume intitolato
Il porno espanso. Dal cinema ai nuovi media
(a cura di Enrico Biasin, Giovanna Maina, Federico Zecca, Mimesis). Il libro
offre i dati che abbiamo citato e ricapitola anche la vita clandestina della
pornografia nel secolo scorso: dalla fase dei filmini mostrati nei bordelli o
spediti per posta, all’ esplosione con titoli come
Mona, the Virgin Nymph
(1970) e Gola
profonda (1972). Così il porno
diventa un genere tra i generi, mutuando dal
mainstream
hollywoodiano un modo di fruizione (la sala), una forma narrativa (il
lungometraggio di finzione) e uno standard tecnologico (il 35mm). Negli anni
Ottanta, quando le sale (anche a luci rosse) cominceranno a chiudere, l’avvento
del video moltiplicherà la produzione. Del resto, i contenuti per adulti guidano
da sempre lo sviluppo dei media. Trent’ anni fa, il Vhs si affermò anche perché
Sony, che sosteneva il formato Betamax, sosteneva una netta politica anti-porno.
I dvd sono stati spinti dai “pornomani” perché rendevano più comodo trovare in
modo rapido momenti specifici del film. E fondamentale è stato questo segmento
di pubblico per avviare la tv via cavo, i servizi telefonici a pagamento o la
banda larga. Oggi siamo davanti a un passo ulteriore, che non riguarda i singoli
prodotti o mezzi di comunicazione. È quella che nel libro citato viene chiamata
“pornificazione del
mainstream“, una
“invasione hardcore
della cultura popolare”. La stessa che ha incuriosito scrittori come Martin
Amis, David Foster Wallace, Chuck Palahniuk, che le hanno dedicato reportage e
libri. Il porno espanso analizza il ruolo dell’ immaginario
fetish
nella creazione del divismo musicale, da Madonna a Lady GaGa; il porno “emerso”
diventa glamour,
alludendo fino a un certo punto a un universo osceno. L’ arrivo in Italia dei
canali satellitari produce combinazioni di generi, nei quali anche l’
hard
ha la sua parte: reality show, pseudo-inchieste, serie (ultima la francese
Xanadu,
una specie di
Dallas sui magnati del porno),
o inopinati talkshow (esiste una specie di versione inglese di
Forum,
con un giudice che dirime questioni sessuali tra partner). Potremmo dire che i
due poli ideali dell’ “immaginazione pornografica” attuale sono la declinazione
glamour
e il suo opposto, la verosimiglianza bruta: il filmato domestico e amatoriale
(il cosiddetto gonzo), autentico o più spesso finto, che presuppone, notano gli
autori del libro, “una sorta di sovrapposizione semantica che assimila il
concetto di reale a quello di privato”. Insomma il massimo del realismo, e la
cosa più eccitante, è ciò che viola (o finge di violare) la privacy. Il consumo
di pornografia domestico, immediato,
prêt-à-voyeur
potremmo dire, cambia. Si tratta forse della forma perfetta di consumismo:
“Perseguire il piacere è uno dei principali modi di edificare la nostra
soggettività in forme autorizzate”, sostiene il teorico inglese Mark Fisher. Il
web 2.0 stimola nuove forme di voyeurismo, e anche di esibizionismo, e non solo
in quelle forme che sono state definite IPorn (l’ esibizione erotica sul web).
Ad esempio, di recente è sembrata rassicurante le notizia che il numero di
utenti dei social network abbia superato quello dei consumatori di
webpornografia: “Facebook batte il porno”. Ma tra i due consumi, nota uno degli
autori di Il porno
espanso, c’è una certa
congruenza, dovuta alla natura vertiginosamente promiscua di queste piattaforme,
che costituiscono “una innovativa forma di autoerotismo del sé”. La pornografia,
insomma, non è oggi questione di contenuti: è quasi la logica culturale dei
media; è il modo in cui funzionano le immagini, in cui noi
spettatori/consumatori guardiamo e ci facciamo guardare.
Osceno e comune senso del
pudore: Antropologia della pornografia
di D. Stanzani e V. Stendardo
su “Diritto”. La società attuale può essere considerata il luogo simbolico in
cui avviene la continua esposizione delle merci; l'individuo si presenta
ambiguo, ambivalente, contaminato, gioca con se stesso attraverso continue
metamorfosi, sospeso tra marginalità e centralità, appartenenza e atomizzazione,
produttività e parassitismo, consenso e conflitto, principi inappellabili del
mondo tecnologico e labilissime e dolorose contingenze della vita quotidiana. Da
qui, da questa identità fragile e polimorfa, le trasgressioni, le
insubordinazioni, le perversioni, diventano mine per i codici simbolici
esistenti e per la cultura dominante. Un aspetto inquietante di questa
dimensione immaginaria dell'individuo che convive con le regole e le norme della
società tutta è rappresentato da quanto di più illusorio e mercificante possa
esserci: la pornografia. Tentare di definire la pornografia non è semplice in
quanto essa chiama in causa tutta una serie di elementi che sono riconducibili a
coordinate psicologiche, sociologiche e culturali. Etimologicamente parlando, il
termine deriva dal greco "pornè" (prostituta) e "graphos" (scrittura), starebbe
quindi ad indicare tutto ciò che viene scritto intorno all'attività della
prostituta. Tuttavia, questa definizione non è esaustiva del fenomeno che
riguarda ben più ampi settori che sono andati modificandosi nel tempo, sia per
la produzione che per i mezzi di comunicazioni. Secondo il vocabolario della
lingua italiana Zingarelli, pornografia starebbe ad indicare la "descrizione e
rappresentazione di cose oscene", ed il termine osceno si intende in
relazione al concetto del comune senso del pudore. Nell'ambito del diritto, la
pornografia è trattata in modi diversi e da diversi punti di vista, quello che
noi abbiamo però voluto privilegiare riguarda due articoli del Codice Penale:
l'art. 528 che individua chi crea la pornografia in colui che: "fabbrica,
introduce sul territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette
in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi
specie allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente"; e l'art. 529 in cui si afferma che: "Agli effetti della
legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune
sentimento, offendono il pudore (c.p. 725, 726). Non si considera oscena
l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di
studio, sia offerto in vendita o comunque procurato a persona minore di anni
diciotto'. Dunque osceno e comune senso del pudore sono elementi
contrapposti, che esistono proprio in virtù della loro contrapposizione. Il
pudore, sentimento di vergogna, di disagio, di repulsione è tipico
dell'individuo quando questi, contro la sua volontà, si trovi di fronte a
manifestazioni sessuali di altri o quando sia egli stesso oggetto di sguardi
durante gli approcci sessuali. Il pudore diventa senso comune nel momento in
cui la società umana di appartenenza condivide la stessa sensibilità nei
confronti della sessualità. L'osceno sarebbe quindi l'offesa al pudore. Ma di
osceno si parla già nell'articolo 527 del c.p. allorché si afferma: "Chiunque
in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (c.p. 529)
è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p. 726). Se il fatto
avviene per colpa (c.p. 43) la pena è della multa da £ 60.000 a £ 600.000".
La grande difficoltà nel definire il comune senso del pudore risiede nel
tracciare un limen tra offesa alla morale pubblica e libertà individuale.
Gli articoli 528 e 529 del Codice Penale convivono e confliggono con l'articolo
21 della Costituzione Italiana che afferma: "Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione". Questo era già implicito nell'articolo 2 della
Costituzione Italiana che sancisce i diritti inalienabili di ogni singolo
individuo: "La Repubblica sancisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale". Ma la difficile gestione giuridica dell'osceno e del comune
senso del pudore in realtà è la risultante di una difficile gestione culturale
di questi. Inoltre non possiamo non tenere conto dell'ampio capitolo riguardante
la prostituzione minorile. E' importante sottolineare come sia il concetto di
osceno che quello di comune senso del pudore non solo si modificano nel corso
del tempo all'interno di una data società, ma cambiano anche da società a
società. La comprensione di questi concetti rimanda alla considerazione del
corpo e della sessualità. "Il corpo è un universo simbolico immediatamente
disponibile e sperimentabile da parte dell'individuo. La capacità del corpo di
produrre significazione è legata al suo essere centro di ogni produzione
immaginifica dell'uomo, centro del desiderio e delle pulsioni, più o meno
controllate dall'educazione e dalla cultura" (M.Combi, 1998). Il corpo è quindi
segnato, disegnato, gestito e mostrato dalla cultura di appartenenza. In molte
società non occidentali il corpo non rappresenta la finitezza anatomica, altra
rispetto al mondo contingente, ma "è il centro di quell'irradiazione simbolica
per cui il mondo naturale e sociale si modella sulle possibilità del corpo, e il
corpo si orienta nel mondo tramite quella rete di simboli con cui distribuisce
lo spazio, il tempo e l'ordine del senso. Mai quindi il corpo nella sua isolata
singolarità, ma sempre un corpo comunitario per non dire cosmico,
dove avviene la circolazione dei simboli e dove ogni singolo corpo trova, non
tanto la sua identità, quanto il suo luogo" (U. Galimberti, 1980). Il corpo
naturale inserito in un fitto intreccio di simboli diventa corpo culturale, con
delle norme di riferimento e le deviazioni da tali norme con le conseguenti
punizioni. La cultura di riferimento gestisce la vita dei corpi ed ogni loro
aspetto e funzionalità, anche il discorso strettamente legato alla sessualità.
Questa è stata definita da B. Malinowski un bisogno primario (bisogno di base):
"Termine che indica il comportamento delle condizioni nell'organismo umano e nel
sistema culturale in rapporto all'ambiente, necessarie alla sopravvivenza degli
individui e del gruppo sociale" (U. Fabietti, 2001). I bisogni primari vengono
soddisfatti attraverso risposte culturali per cui la sessualità è regolamentata,
ad esempio, dall'insieme di norme che definiscono i sistemi di parentela e il
matrimonio. Chiaramente questi cambiano a seconda delle culture. La sessualità è
diversamente interpretata ed utilizzata. Presso i Basuto (popolazione
africana che occupa l'area vicino il fiume Zambesi) è usanza che la nuova moglie
abbia rapporti sessuali con il fratello più giovane del marito. Se poi il
coniuge muore, il fratello del defunto si trasferisce nella capanna della
cognata. I Basuto poi praticano l'ospitalità sessuale e permettono
l'unione dei loro amici fraterni con la propria moglie. Per i Dagari
dell'Alto Volta, invece, le donne sposate possono avere rapporti extraconiugali
con molti amanti a patto però che questi si sottopongano ad una specie di lavoro
forzato per il marito della donna infedele. Presso gli Agni in Costa
d'Avorio durante la festa in onore degli spiriti, le donne dopo essersi
purificate nelle acque del fiume si uniscono con gli uomini e dedicando il
momento più bello dell'amplesso agli spiriti che proteggono la loro fecondità.
Tutto il villaggio partecipa a questo rito in cui l'uomo diventa oggetto
passivo, subisce il rapporto voluto in quell'occasione, soltanto dalle donne che
lo dedicano appunto agli spiriti. Ancora in alcune culture la sessualità è
utilizzata per definire le identità sociali e gli status all'interno della
comunità, e per rafforzare legami, definire alleanze e rapporti sociali non è
inusuale "prestare" le proprie mogli ad altri. Nella cultura occidentale il
corpo e la sessualità sono vissuti in maniera completamente diversa. Il corpo,
involucro finito dell'individuo è rappresentazione, specchio simbolico della
perfezione divina. Per proteggerlo è necessario un rigido controllo sociale e
culturale anche nelle sue funzioni più naturali come la sessualità. Questo
perché il corpo materia definita dell'individuo non vada a contrapporsi
all'aspetto spirituale di questo. E' necessario convivere e non contrapporsi,
perché questo determinerebbe confusione e commistione tra il bene e il male. Le
norme che regolamentano la gestione del corpo sono rigide, il corpo occidentale
infatti è un corpo chiuso all'esterno, un corpo coperto totalmente, che non può
essere mostrato. La nudità è associata al peccato, Adamo si rende conto di
essere nudo solo dopo aver peccato e allora si copre. Dalla perfezione, dopo la
caduta nel caos, si passa con dolore alla veste. Quindi l'indumento diventa
simbolicamente norma culturale che gestisce i rapporti tra il bene e il male,
che segna il confine tra natura e cultura. E' chiaro che da una tal rigida
considerazione non può non derivare un'idea dell'osceno estremamente ampia.
Ovviamente la sessualità ha risentito moltissimo di questa concezione per cui
si è sviluppata nel corso del tempo in special modo in Italia una duplice
esperienza sessuale: quella legata alla vita familiare strettamente correlata
alla procreazione e la vita nei luoghi di piacere. Il primo concetto
rispecchiava la cultura religiosa, per cui il sesso al di fuori del matrimonio
era condannato, associato al male e alla caducità dell'anima (è superfluo poi
sottolineare come questa cultura condannasse i rapporti sessuali fra individui
dello stesso sesso); l'altra esperienza era invece legata alle necessità della
vita degli individui. Se quindi parlare della sessualità è difficile, lo è
ancora di più per quanto riguarda la pornografia considerata come l'industria
della dominazione sessuale (R. Poulin). La pornografia è un fenomeno
moderno strettamente legato agli sviluppi della tecnologia, nello specifico
della fotografia, del cinema e della videoregistrazione ed è solo in tempi
recenti che si definisce il confine tra ciò che può essere considerato erotico e
ciò che si può considerare pornografico. "L'erotismo, questo sì intrinseco ad
ogni fatto amoroso, trova alimento all'interno della fantasia,
dell'immaginazione, non è direttamente funzionale al fatto sessuale come tale,
ma in qualche modo lo richiama per percorsi metaforici. E i segni dell'erotismo
non sono tali perché veicolati da immagini sessuali, ma, anzi, proprio perché in
apparenza lontani dal mondo del sesso e ad esso raccordabili solo, appunto,
grazie alla fantasia ed all'immaginazione del singolo individuo" (A. Sobrero,
1992). Quindi l'erotismo è un fatto meramente individuale e nel momento in cui
diviene collettivo per non tradire la sua nobile origine (infatti il termine
erotismo deriva dal greco Eros, amore), deve essere riscattato da una
interpretazione non mercificante. E' infatti il divenire merce che fa del sesso
o dell'erotico pornografia. Le pubblicazioni di innumerevoli riviste, le
infinite offerte di homevideo, i tantissimi pornoshop, internet come ultima
frontiera, per non parlare degli spettacoli itineranti e le fiere, non hanno
nulla a che vedere con la tradizione del romanzo, se vogliamo pornografico,
della fine del Settecento o con le pubblicazioni più o meno clandestine del XIX
secolo. La pornografia non coglie le sottili e conturbanti sfumature
dell'erotismo e quindi per molti aspetti è la negazione di questo: mortifica
l'aspetto immaginifico, proibisce il senso della scoperta, esaurisce la passione
che c'è nell'unicità di ogni atto sessuale. "L'universo pornografico è utopico,
privo di spazialità, di temporalità, di relazioni e di emozioni, pieno però
all'infinito di gesti sessuali che non possono cessare perché, altrimenti,
ristabilirebbero una scansione temporale. "Non vi è quindi reale azione, ma solo
una rappresentazione asimbolica di desideri, di agiti, nei quali, di
conseguenza, ogni personaggio resta lo stesso, prima e dopo l'evento , e,
naturalmente, con essi, il fruitore cui fanno da specchio illusorio" (R. Dalle
Luche). Oggi la pornografia crea sicuramente meno scandalo, i costumi del nostro
paese sono cambiati, tanto che ad esempio, in televisione, anche in fasce orarie
accessibili anche ai bambini, spesso sono ospiti di talk show, note pornodive.
Si parla continuamente di sesso e lo si rappresenta in continuazione, in video
le danze sono sempre più conturbanti ed esplicite (ovviamente opportunamente
corredate di costumi inesistenti), si fanno programmi ad hoc per soddisfare quel
senso di voyeurismo e pruderie propri dell'animo umano, le pubblicità sfruttano
o tentano di farlo le nuove tendenze sessuali; note drag queen conducono
programmi di costume; si cerca di creare ovunque ambiguità, doppi sensi, per non
parlare di internet: ogni portale ha la sua piccola icona sessuale. Quindi a
questo punto c'è da domandarsi: dove è l'osceno' E dov'è il comune senso del
pudore' La pornografia paradossalmente è un fenomeno di massa (è l'enorme
profitto economico lo sta a testimoniare. L'industria pornografica si è adeguata
più velocemente al cambiamento di costume (esasperandolo per molti versi) di
quanto non abbiamo fatto altre forme di comunicazione, determinato anche da una
conquista e una riscoperta della sessualità da parte delle donne, che sono
diventate esse stesse fruitrici di materiale pornografico. La pornografia
veicola dei messaggi che sono distorti, ma non nel senso che parla (e agisce) di
sesso ( e il sesso come tale è associato al peccato, al diabolico), ma per le
forme che usa e gli strumenti che utilizza: nello specifico i corpi, corpi
umani. Se ci si ferma per un istante ad osservare i corpi pornografici, vediamo
che, come afferma R. Poulin : "Questi si trasformano per enfatizzare i propri
attributi sessuali, i seni femminili ad esempio diventano enormi e duri, sono
riempiti di silicone per occupare lo spazio. I corpi sono modificati al fine di
soddisfare un'idea di ciò che i corpi dovrebbero essere, sono corpi
definitivamente votati alla sessualità". La sessualità vissuta dalla pornografia
è irreale, la sublimazione degli organi genitali, la promiscuità dello
sguardo, l'ossessione per il dettaglio fisico vogliono rendere l'idea di una
realtà che non esiste. L'immagine infatti non è una rappresentazione della
sessualità ma una proiezione della fantasia che paradossalmente però è povera di
contenuti. I film pornografici ad esempio hanno sempre la stessa struttura,
ovviamente la trama è inesistente perché non serve, non c'è un'azione in
crescendo che si sviluppa lungo l'arco di due ore, ma azioni immediate, piatte,
meramente meccaniche che si ripetono all'infinito, per soddisfare all'infinito
le fantasie (e le voglie) dello spettatore. "La pornografia è un lavoro di
rappresentazione genitalizzata della sessualità" (R. Poulin, 1999). Più che un
continuum di azioni, si tratta di una serie di scene che si chiudono con la
consumazione dell'amplesso. Nei film classici ad esempio, ciò che conta è
l'eccitazione e il soddisfacimento del maschio che si realizza, creando
l'illusione che questa sia la verità riscontrabile nella vita reale, nella
continua offerta consapevole da parte delle donne del loro corpo: un corpo
quindi sempre pronto (anche quando è fintamente riluttante), sempre in pose
suggestive ed estremamente provocanti. Banale sottolineare come il corpo
femminile venga strumentalizzato e mercificato, ma paradossalmente la virilità
maschile non può essere esercitata e provata se non attraverso questi corpi. La
presunta superiorità maschile passa inevitabilmente per la presunta inferiorità
femminile e quindi per la sottomissione della donna. La pornografia è una
galassia in continua espansione, soddisfa tutti i generi "tutte le categorie,
come tutte le merci fabbricate per un mercato segmentato" (R. Poulin, 1999), per
questo è difficile anche costruire un identikit del pornoconsumatore tipo.
Nell'immaginario benpensante collettivo, il pornoconsumatore è un individuo
ambiguo, lascivo, che vive ai margini della società e della realtà, un individuo
di cui già l'aspetto esteriore tradisce la deviata moralità. Ma non è così.
Moltissimi sono i fruitori, di tutte l'età, estrazione sociale, grado di cultura
e status, e come abbiamo già sottolineato, molte sono anche le donne. Inoltre
grazie al repentino sviluppo delle tecnologie, si sono aperti nuovi canali, il
già citato internet, che è un mondo parallelo un cui è possibile eludere le
sorveglianze e creare dei contatti con i fruitori della stessa merce. Se fino a
qualche anno fa le pellicole hard venivano proiettate nei cinema di paese,
progressivamente con l'avvento e la diffusione dei videoregistratori si è
passati alla visione casalinga dei film. In molte videoteche erano e sono
tuttora presenti spazi, magari un po' nascosti, appunto per non offendere il
comune senso del pudore degli avventori, interamente dedicate alla pornografia.
In tempi recentissimi abbiamo internet e la possibilità di cliccare e quindi
ingrandire quel particolare anatomico che più sollecita. Oltre che la
compravendita di qualsiasi tipo di merce. Anche qui la Legge cerca di
intervenire, il delitto rientra infatti nell'art. 528 del c.p. e c'è anche la
Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 2000, relativa alla
lotta contro la pornografia infantile su Internet. A volte in ambienti medici si
è anche parlato della possibilità della dipendenza dalla pornografia, ma il DSM
IV, Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorder, ossia il
manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali, più accreditato nel settore
psichiatrico, non annovera la pornografia tra le parafilie cioè tra i
disturbi dell'eccitazione sessuale, come invece la pedofilia. Ma ben sappiamo
quanta pedofilia ci sia nella pornografia. Di pedofilia infatti, si parla già
quando in pornografia vengono utilizzate adolescenti o giovani poco più che
bambine. In questo caso si ha oltre lo sfruttamento anche la riduzione in
schiavitù, e poi c'è tutta la produzione che riguarda i bambini. In Italia è
stata varata la legge n.269 del 3 agosto 1998 che reca Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. L'articolo n.3
di tale legge, 600 ter, afferma: " Chiunque sfrutta minori degli anni
diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione dai sei ai dodici anni e con la multa da
lire cinquanta milioni a cinquecento milioni". Come possiamo vedere quindi
la pornografia è un fenomeno molto complesso e tentacolare. Ogni suo aspetto,
anche quello più nascosto è quasi sempre la facciata di una realtà molto
dolorosa e spesso crudele. Viaggiando in questa dimensione ci si rende conto
come tutto sia un gioco di scatole cinesi, ogni cosa è strettamente correlata
alle altre eppure ognuna di esse vive di vita propria. E' come un immenso
organismo formato da tante particelle che assume forme sempre diverse e sempre
uguali, perché una, fedele a se stessa è la sua natura: la dominazione. La
pornografia è la dominazione del corpo sul corpo, dell'individuo sull'individuo,
del potente sul debole. Vince la produzione industriale, la mercificazione delle
illusioni dei consumatori che trovano piacere nell'osservare corpi smembrati e
ricomposti per solleticare e appagare i loro desideri più reconditi, ma che si
basano per la maggior parte delle volte sulle vite spezzate di tanti essere
umani inermi.
Pornografia online, le
censure Paese per Paese. Dalla
Cina all'Iran, i blocchi dei governi contro l'hard 2.0. In Islanda è allo studio
una nuova legge, scrive di Guido Mariani
su “Lettera 43.”La
pornografia online è nel mirino del governo islandese.
Paese che vai porno che trovi. Il governo dell’Islanda sta lavorando a un
disegno di legge che limiti l’accesso alla pornografia su internet. Non si
tratta di una vera e propria censura, ma di un sistema, tutto da studiare, in
grado di tutelare i minorenni dalla visione di immagini o video hard.
L’iniziativa è partita dal ministro dell’interno Ogmundur Jonasson e, secondo le
dichiarazioni ufficiali, non vuole essere una crociata anti-sesso, bensì contro
la violenza. La legge, se approvata, renderebbe l’Islanda il primo Paese
occidentale a varare una legislazione di questo tipo. Mentre in altri Stati come
Cina e Corea del Sud, le misure repressive sono all'ordine del giorno.
Il governo cinese dà una ricompensa ai cittadini che segnalano siti
pornografici. In Cina, per
esempio, il governo ha installato un sistema in grado di rilevare tutti i
contenuti ritenuti non adeguati. E la pornografia viene trattata alla stregua
del dissenso politico. Inoltre Pechino può contare su una serie di ostacoli
tecnici che vanno dal blocco degli indirizzi Ip sino ai filtri legati a parole e
immagini, che formano quella che è stata definita «la grande muraglia
informatica cinese». Periodicamente, poi, le autorità diffondono notizie di
arresti di persone che riescono ad aggirare i blocchi e a diffondere materiale
proibito o di «cittadini esemplari» che fanno da delatori. Lo scorso marzo, 2
mila internauti hanno ricevuto un premio in denaro per aver segnalato alle
autorità attività online legate alla pornografia. La repressione è altrettanto
rigida nella democratica Corea del Sud dove, dal 2009, tutti i siti ritenuti
osceni vengono bloccati. Nel settembre 2012, in seguito a una serie di reati a
sfondo sessuale, è stata varata un’ulteriore stretta. La polizia ha denunciato
più di 400 persone per possesso e distribuzione di materiale hard-core. A Seul
si sta inoltre valutando l’obbligo di imporre ai gestori di servizi online
l’installazione di software anti-porno. In molti però si interrogano
sull’efficacia di questi provvedimenti: un’indagine ministeriale ha appurato che
il 55% dei maschi che frequentano gli istituti medi e superiori visiona comunque
materiale proibito sul computer o sul cellulare, e le percentuali sono in
crescita. Sempre in Oriente, i Paesi a maggioranza islamica come Malaysia e
Indonesia proibiscono per legge la pornografia, ma nonostante proclami e
iniziative mediatiche, la Rete gode di sostanziale libertà. Il ministero della
Cultura, dell’informazione e della comunicazione di Kuala Lumpur ha rinunciato
nel 2009 a un piano che prevedeva l'inserimento di un filtro ai siti, ribadendo
però il divieto alla diffusione di materiale osceno. La situazione è simile in
Indonesia, dove la legge mette al bando il porno, e dove nel 2012 è stata
istituita dal presidente Susilo Bambang Yudhoyono una task-force contro la
pornografia online. Ma dopo una retata che ha portato alla chiusura di decine di
siti, l’iniziativa è stata accusata solo di essere solo «fumo negli occhi»,
visto che non ha, di fatto, ridotto il fenomeno. Molto più seria invece la
situazione in Iran dove la censura è onnipresente e la moralità pubblica è
vigilata dalle milizie volontarie dei bassidjis, i gendarmi
dell’Ayatollah che fungono anche da guardiani del buoncostume. Il principale
obiettivo della politica repressiva è il dissenso politico e religioso. Seguono
i contenuti web a sfondo sessuale. Si sta valutando di creare una Rete internet
halal
(lecita) e il ministero dell’Informazione ha predisposto l’installazione di
telecamere negli internet cafè. Restrizioni esistono tuttavia anche in Paesi
democratici. In India, la patria del Kamasutra, l’Information Technology Act ha
dichiarato illegale la pornografia online. Ma il fenomeno nei fatti è raramente
represso. Nel 2009 il pubblico indiano ha sperimentato la prima vera
infatuazione di massa per una pornodiva. Il suo nome era Savita Bhabhi e il suo
sito era diventato un fenomeno, prima di attirare l’attenzione ed essere
censurato dal governo. Savita Bhabhi, una sorta di casalinga disperata in salsa
hindi, era però solo un fumetto. Un’eroina cartoon che sul web si lanciava in
avventure così scabrose da scandalizzare i moralisti, ma in grado di ammaliare
un pubblico ormai sempre più permissivo nei confronti delle rappresentazioni
esplicite del sesso. Ora è la volta dell'Islanda che potrebbe aprire a un più
stretto controllo sul materiale pornografico nel resto d'Europa. Proposte di
legge simili, infatti, sono già state valutate in Gran Bretagna. Per gli
islandesi si tratta di difendere le fasce più deboli della popolazione.
«Dobbiamo avere il coraggio di discutere sulla pornografia più violenta», ha
dichiarato il ministro degli interni Jonasson. «Siamo tutti d’accordo che abbia
un effetto dannoso sulle persone giovani e può avere un chiaro effetto
sull’incidenza dei crimini».
LE FOIBE E LA CULTURA ROSSO
SANGUE DELLA SINISTRA COMUNISTA.
Foibe: il giorno del
ricordo.
L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del Giorno del
Ricordo nel 2007, userà queste parole: «Va ricordato l’imperdonabile orrore
contro l’umanità costituito dalle foibe e va ricordata la “congiura del
silenzio”, la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante
dell’oblio. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità
dell’aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e
cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze
internazionali».
Foibe, la verità dopo tanto
silenzio,
scrive Aldo Quadrani su “Viterbo Post”. Il Circolo Reale riportò alla luce la
tragedia nel 1997. Gabbianelli la ricordò. Il 10 febbraio, l’Italia celebrerà il
giorno del ricordo una ricorrenza civile nazionale istituita con legge del 30
marzo 2004 per non dimenticare le migliaia di Italiani trucidati dall’odio
comunista, gettati nelle cavità carsiche, chiamate foibe. Nella nostra città, ma
anche in gran parte d’Italia, di questo dramma non se ne ebbe notizia per tanti
anni, grazie anche alla connivenza di una certa politica. Dobbiamo arrivare al 6
novembre 1997 quando il Circolo Reale della Tuscia in un pubblico convegno portò
alla ribalta questo doloroso evento ed in quella occasione emerse la proposta di
dedicare un pubblico sito a questi martiri. Ma si dovette attendere sino al 1999
e precisamente il 16 ottobre, giorno in cui venne intitolata la piazza esterna a
Porta Faul ai “Martiri delle Foibe Istriane” grazie alla determinazione
dell’allora sindaco Giancarlo Gabbianelli e dell’ allora assessore Antonio
Fracassini. Chi era presente forse ancora ricorda la toccante e bellissima
cerimonia con tante testimonianze di profughi e parenti di infoibati. Ma anche
Viterbo dette il suo contributo di sangue come scoprì, a seguito di indagini,
l’allora consigliere comunale Maurizio Federici: il ventenne Carlo Celestini
conobbe la tremenda fine della sua vita in un Foiba e a lui fu dedicato il cippo
che a tutt’oggi si erge nella piazza. Purtroppo i viterbesi, anche della
provincia, che perirono in siffatte condizioni furono molti, come accertarono in
seguito lo stesso Federici coadiuvato da Silvano Olmi. Con la nascita della
festività nazionale c’è ora un Comitato denominato “10 febbraio” che
magistralmente porta avanti annualmente il ricordo dei nostri martiri.
Quest’anno la commemorazione avverrà con due giorni d’anticipo, domenica 8
febbraio alle ore 11,30 presso il Piazzale Martiri delle Foibe Istriane, per dar
modo ai nostri Cittadini di poter partecipare e ricordare chi morì per la sola
colpa di essere Italiano.
E allora le foibe?
Si chiede Adriano Scianca su “Il Primato
Nazionale”. È capitato una volta a chi scrive
di telefonare, per ragioni professionali, a una delle tre maggiori università
romane a ridosso della Giornata del Ricordo in onore delle vittime delle foibe e
dell’esodo giuliano dalmata. Alla domanda su quali iniziative avesse preso
l’ateneo per ottemperare agli obblighi di legge che prevedono pubbliche
iniziative in occasione del 10 febbraio, il funzionario dell’università,
sensibilmente imbarazzato, si affrettò a precisare: “Guardi, noi abbiamo anche
un dipartimento di studi ebraici”. Al che fu chiaro che il passacarte di turno
confondeva la Giornata del ricordo (10 febbraio) con il Giorno della Memoria (27
gennaio) e che evidentemente no, la sua università non aveva organizzato alcuna
iniziativa per ricordare i connazionali trucidati nelle cavità carsiche.
Volendo, l’aneddoto evidenzia anche una stortura nel rapportarsi alla stessa
commemorazione del 27 gennaio (che c’entra il fatto di ricordare l’Olocausto con
il fatto di avere un dipartimento di studi ebraici?), ma non infieriamo
ulteriormente. A quanto pare, il ricordo è una cosa più complicata di quanto
qualcuno immaginasse. Non basta istituire una giornata ad hoc per riattivare una
memoria interrotta, se non si va a lavorare sulle ragioni di quella
interruzione. Certo, magari la Rai domani sera trasmetterà “Il cuore nel pozzo”,
la melensa fiction cerchiobottista in cui non si parla di comunisti e in cui gli
esuli cantano “O sole mio”, tipico canto del confine orientale. Ma il ricordo
vero è un’altra cosa e la classe intellettual-mediatica italiana si guarda bene
dall’accostarvisi, in quanto erede spirituale di chi infoibò, torturò, stuprò,
cacciò i nostri connazionali, di chi non li fece sbarcare nelle stazioni a cui
approdavano dopo l’esodo, di chi gettava il latte destinato ai neonati affamati
in terra, con gesto di scherno e sadismo, di chi ha imposto che per anni sulle
foibe cadesse un velo di vergognoso silenzio. E dopo aver lasciato per anni il
ricordo in mano a un pugno di patrioti solitari, che hanno tenuto viva la
memoria per anni in mezzo all’indifferenza complice, oggi si denunciano quei
pochi perché strumentalizzerebbero la storia. Non scordiamo, del resto, che poco
tempo fa una mediocre personalità dello spettacolo, paracadutata per meriti
familiari in prima serata, poteva lanciare il tormentone “E allora le foibe?”
(cosa semplicemente inconcepibile in relazione a ogni altra grande tragedia del
Novecento) come a sottolineare che chi ha a cuore il martirio delle terre del
confine orientale è forse troppo invadente, insistente, petulante, dovrebbe
darsi una calmata. Come se di foibe si parlasse in continuazione, come se
l’argomento avesse ormai stancato, fosse un fatto assodato, come se non se ne
potesse più. E forse, per alcuni, è così. Perché le foibe ricordano la loro
eterna colpa e quindi quel nome è per loro insopportabile. Un motivo in più per
continuare a pronunciarlo: e allora le foibe?
Il 10 febbraio, data della
ratifica dei trattati di pace del 1947, si ricordano gli eccidi in Istria e
Venezia-Giulia.
10 febbraio 2015. A 70 anni dai massacri del 1945, scrive Edoardo
Frittoli su “Panorama”. La serie di eccidi noti come i massacri delle foibe
possono essere divisi in due distinti periodi: gli "infoibamenti" del
settembre-ottobre 1943 e le stragi del 1945, che in alcuni casi si protrassero
fino al 1947. Non si conosce esattamente ad oggi il numero esatto delle vittime.
La storiografia attuale comprende una forbice stimata tra i 5000 e i 12.000
morti. Al di là degli approcci ideologizzati dalla letteratura del dopoguerra e
del silenzio sotto il quale passarono gli anni della Guerra Fredda e della
Jugoslavia "non allineata" di Tito, sembrano essere all'origine dei massacri una
serie di gravi concause, alcune risalenti a decenni antecedenti i fatti. Le
popolazioni della Venezia-Giulia, dell'Istria e della Dalmazia a cavallo tra il
secolo XIX e il XX erano caratterizzate dalla dualità etnico-linguistica
italiana e slava. Quest'ultima, originariamente rurale, si trovava in una
posizione socio culturale più bassa rispetto agli italiani, che costituivano una
sorta di borghesia urbanizzata. Tra la fine dell'800 e la Grande Guerra i
movimenti nazionalisti slavi, specie in Dalmazia, furono apertamente sostenuti
dall'Impero Asburgico in funzione anti-italiana. La vittoria del 1918 portò
all'occupazione di tutta la Venezia Giulia, dell'Istria e dalla Dalmazia.
Quest'ultima fu alla fine negata all'Italia dalla "Dottrina Wilson", e
Roma ottenne solo Zara e alcune isole. Da questa situazione tra gli irredentisti
italiani nacque il mito della "vittoria mutilata", ripresa totalmente dal
fascismo che si affacciava al potere. Dopo il 1922 inizia il processo di
"fascistizzazione" attraverso la proibizione dell'uso delle lingue slave,
l'esclusione dalle cariche pubbliche dei cittadini di origine non-italiana e la
conseguente attribuzione a soli cittadini italiani dell'istruzione pubblica. Con
l'aggressione italo-tedesca del 1941 la geografia di Slovenia, Croazia e
Dalmazia fu riscritta. L'Italia procedette all'annessione di Lubiana e gran
parte dell'attuale Slovenia. La Croazia passò sotto il regime filofascista di
Ante Pavelic. Gli eventi bellici fecero poi precipitare la situazione. Nel 1943
i partigiani jugoslavi erano impegnati nella lotta contro i tedeschi e gli
italiani quando arrivò l'8 settembre e il conseguente sbandamento del Regio
esercito. Proprio a seguito dell'armistizio si colloca la prima ondata di
assassinii legati alle foibe. Nei mesi precedenti, la lotta antipartigiana
condotta dagli italiani e dagli alleati tedeschi aveva portato ad alcuni gravi
episodi di repressione, sfociati in veri e propri massacri tra la popolazione
civile. In Croazia Ante Pavelic, alleato dell'Asse, perseguì violentemente i
partigiani, gli ebrei e gli zingari. Parecchi prigionieri sloveni erano stati
portati nel campo di concentramento di Gonars, in Friuli. Così come i partigiani
jugoslavi furono internati da Pavelic nel campo di concentramento di Jasenovac.
All'indomani del' 8 settembre parte del territorio istriano era caduto in mano
ai partigiani jugoslavi, i quali compilarono liste di presunti collaborazionisti
del regime fascista, che comprendevano frequentemente nomi estranei alle
istituzioni nazifascisteo all'esercito. Spesso si trattava di civili italiani
ritenuti "in vista" dalla popolazione slava. Gli arrestati, condotti a
Pisino, furono fucilati e infoibati. Altri massacrati nelle miniere della zona.
Si trattava di circa 600 persone, trascinate e gettate nelle foibe spesso ancora
vive, legate tra loro da un filo di ferro collegato a pesanti massi. Nel
dicembre 1943 i tedeschi riprendono l'Istria, nell'offensiva che porterà i
territori della Venezia-Giulia, Istria e Dalmazia a costituire la cosiddetta
zona d'Operazioni del Litorale Adriatico (OZAK) di fatto annessa al Terzo Reich.
Qui cominciarono ad operare a fianco dei tedeschi i reparti italiani della RSI
(Guardia Nazionale Repubblicana, il reggimento Alpini "Tagliamento", reparti
delle Brigate Nere) che si macchiarono di ulteriori tragici episodi di
repressione. Ad appesantire il bilancio contribuirono i bombardamenti alleati
della zona costiera e l'avanzata dei titini che tra l'autunno del 1944 e la
primavera del 1945 riconquistarono la Venezia-Giulia puntando rapidamente su
Trieste. L'arrivo degli uomini di Tito segnò la fine anche per gli italiani che
avevano fiancheggiato gli jugoslavi nella lotta contro fascisti e nazisti. La
polizia segreta di Tito, l'OZNA, comprese negli elenchi dei nemici dello stato
comunista di Jugoslavia anche molti elementi facenti parte del CLN. La furia
vendicatrice degli uomini di Tito si riversò anche su elementi del clero locale
che non si erano macchiati di collaborazionismo. Nella primavera del 1945 furono
sterminati nelle foibe migliaia di persone, non solo italiane, non solo membri
delle milizie fasciste del Litorale Adriatico. Anche gruppi di Sloveni che si
opponevano alla futura Jugoslavia comunista, anche membri di formazioni
politiche "non allineate" quali gli Autonomisti istriani, i cui vertici
furono barbaramente assassinati. Neppure i membri della Resistenza italiani di
ritorno dai campi di concentramento furono risparmiati. Alla tragedia si
aggiunse tragedia in quanto i titini, vicini alla vittoria finale, parevano non
limitarsi all'acquisizione territoriale della Venezia-Giulia. Essi ritenevano
che la vittoria militare coincidesse con quella della rivoluzione sociale
comunista. La classe borghese in quelle zone era tradizionalmente identificata
con la popolazione italiana tout court , al di là delle appartenenze
politiche. Nei mesi del caos che precedettero la fine della guerra molte furono
anche le morti dovute a rappresaglie locali, vendette personali o questioni
legate a beni e proprietà. Particolarmente cruenta fu la situazione di Trieste e
Gorizia all'arrivo dei titini. Oltre alla eliminazione fisica e
all'occultamento nelle foibe del Carso, molti furono gli italiani e in genere
gli oppositori di Tito ad essere internati nel terribile lager di Borovnica, nel
quale i prigionieri furono massacrati dopo orribili torture fisiche. Sembrava in
sostanza che la rappresaglia in quelle zone non si sarebbe arrestata con la fine
della guerra, ma che sarebbe proseguita al fine di garantire il nuovo stato
jugoslavo contro ogni tipo di opposizione. Cosa che in Italia non si verificò in
quanto la Resistenza non si identificherà mai, come in Iugoslavia, con una nuova
realtà nazionale (La Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia) in
continuità con il movimento resistenziale. Il massacro di migliaia di vite umane
nella profondità delle foibe fu messo a tacere praticamente subito. L'inizio
della Guerra Fredda vide le mire del maresciallo Tito ridimensionate con la
costituzione del TLT di Trieste (zona libera). Nel 1948 poi avviene lo strappo
tra Belgrado e Mosca. Sia il PCI che il governo ritennero prudente non riaprire
la questione delle foibe. Il governo e le istituzioni per evitare di affrontare
la questione dei crimini di guerra compiuti dagli italiani in un contesto
internazionale molto teso. Così come ambiguo rimarrà l'atteggiamento dei
comunisti italiani tra il 1945 e il 1948. Questi avevano avvallato l'ingresso
dei titini nella Venezia Giulia, acconsentito a tutte le rivendicazioni
territoriali jugoslave dal 1945 in avanti. Fino al 1948, anno della rottura tra
Stalin e Tito e alla ratifica dei trattati di pace a Parigi il 10 febbraio 1947.
Poi il grande silenzio internazionale ha coperto per decenni le imboccature
delle depressioni carsiche e il loro contenuto di morte.
La tragedia delle Foibe: 60
anni di silenzio.
Per 60 anni il dramma delle foibe è rimasto ignoto ai più, e secondo lo storico
Gianni Oliva il silenzio è da ricondurre a tre motivi principali. Scopriamoli
insieme, scrive Nicolamaria Coppola su “Quotidiano Giovani”. È stato un tabù per
decenni: non una riga sui libri di scuola, nessuna pubblicazione storica nel
grande circuito editoriale, niente commemorazioni ufficiali. Per 60 anni il
dramma delle foibe è rimasto ignoto ai più, e secondo lo storico Gianni Oliva il
silenzio è da ricondurre a tre motivi principali: innanzitutto la necessità,
subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, del blocco occidentale di
stabilire rapporti meno tesi con la Jugoslavia in funzione antisovietica; cause
politiche dal momento che il PCI non aveva interesse a evidenziare le proprie
contraddizioni sulla vicenda e le proprie subordinazioni alla volontà del
comunismo internazionale; un silenzio da parte dello Stato Italiano che voleva
sorpassare tutto il capitolo della sconfitta nella guerra da poco conclusasi.
Solo in quest'ultimo decennio il dramma delle foibe è tornato alla ribalta, e
nonostante le polemiche ideologiche si è cominciato a fare luce sulla tragedia.
Dal 2005 si commemorano, nella “Giornata del Ricordo” il 10 febbraio, le vittime
dei massacri delle foibe, ma sono ancora pochi gli Italiani che sanno
effettivamente di cosa si tratti e cosa abbiano rappresentato per la generazione
del dopoguerra. Secondo un sondaggio commissionato dall'Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, solo il 43% dei nostri connazionali sa cosa siano le
foibe e ancora più bassa è la percezione sul significato dell'Esodo
giuliano-dalmata (22%). Il 46% dei giovani ha una cognizione abbastanza chiara
della tragedia, ma i dubbi e le incertezze sono ancora tanti. Le foibe sono
delle cavità naturali con ingresso a strapiombo presenti sul Carso, la zona
montuosa compresa tra Trieste, la Slovenia, l'Istria e la Dalmazia, usate per
occultare i cadaveri di un numero non preciso di persone. Alla fine della
Seconda Guerra Mondiale i partigiani comunisti di Tito gettarono- infoibarono -
in queste profonde voragini migliaia di persone, alcune dopo averle fucilate,
altre ancora vive, colpevoli o di essere italiane o di essere contrarie al
regime comunista. La prima ondata di violenza esplose subito dopo la firma
dell’armistizio dell’8 settembre 1943 tra l'Italia guidata dal Generale Badoglio
e le truppe anglo-americane: in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si
vendicarono contro i fascisti e gli italiani non comunisti. Li consideravano
“nemici del popolo”, accusandoli sia di non essere comunisti e, quindi, ostili a
Tito, sia, soprattutto, di aver contribuito, allorquando il regime fascista
impose in tutto il Venezia Giulia una violenta politica di snazionalizzazione,
all'eliminazione delle minoranze serbe, croate e jugoslave in quella regione. Le
vittime dei titini venivano condotte, dopo atroci sevizie, nei pressi della
foiba: qui gli aguzzini, non paghi dei maltrattamenti già inflitti, bloccavano i
polsi e i piedi tramite filo di ferro ad ogni singola persona con l’ausilio di
pinze e, successivamente, legavano gli uni agli altri sempre tramite il di
ferro. I massacratori si divertivano, nella maggior parte dei casi, a sparare al
primo malcapitato del gruppo che ruzzolava rovinosamente nella foiba spingendo
con sé gli altri. La violenza aumentò nella primavera del 1945, quando la
Jugoslavia occupò Trieste, Gorizia e l’Istria. Le truppe del Maresciallo Tito,
al grido di «Epurare subito», «Punire con severità tutti i fomentatori dello
sciovinismo e dell’odio nazionale», si scatenarono di nuovo contro gli italiani,
e a cadere dentro le foibe furono fascisti, cattolici, liberaldemocratici,
socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani e bambini. L'ondata di violenza non
risparmiò neppure le popolazioni slovene contrarie al progetto politico
comunista jugoslavo, le quali, oltre che infoibate, vennero deportate nelle
carceri e nei campi di prigionia, tra i quali va ricordato quello di Borovnica.
Questa carneficina, che testimonia l’odio politico-ideologico e la pulizia
etnica voluta da Tito per eliminare dalla futura Jugoslavia i non comunisti,
finì il 9 giugno 1945, quando Tito e il generale Alexander tracciarono la linea
di demarcazione Morgan che prevedeva due zone di occupazione, la A e la B, dei
territori goriziano e triestino, confermate dal “Memorandum di Londra” del 1954.
È la linea che ancora oggi definisce il confine orientale dell’Italia. La
persecuzione degli Italiani, però, durò almeno fino al 1947, soprattutto nella
parte dell'Istria più vicina al confine e sottoposta all'amministrazione
provvisoria jugoslava. Secondo lo storico Enzo Collotti, parlare delle foibe
significa «chiamare in causa il complesso di situazioni cumulatesi nell'arco di
un ventennio con l'esasperazione di violenza e di lacerazioni politiche,
militari e sociali concentratesi, in particolare, nei cinque anni della fase più
acuta della Seconda Guerra mondiale. È qui che nascono le radici dell'odio,
delle foibe, dell'esodo dall'Istria». Le foibe sono state il prodotto di odi
diversi: etnico, nazionale e ideologico. «Furono la risoluzione brutale di un
tentativo rivoluzionario di annessione territoriale», ha sintetizzato lo storico
triestino Roberto Spazzali. «Chi non ci stava, veniva eliminato».
IL SILENZIO SULLE FOIBE: UN
GENOCIDIO CELATO DA OMBRE, scrive Giuseppe Papalia su “Secolo Trentino”. Foibe.
Probabilmente a molti questa parola direbbe ancora poco se l’argomento non fosse
stato portato alla ribalta dell’opinione pubblica, istituendo una giornata della
memoria, meritata quanto agognata e ancora oggi criticata e strumentalizzata
dalle diverse fazioni politiche che ne recriminano l’accaduto. Il 10 febbraio di
ogni anno, infatti, si ricorda questo terribile genocidio ancora impresso nella
mente di molti, di quell’Italia del dopoguerra travolta dalla miseria e dalla
fame. Di quel paese coinvolto in una crisi identitaria radicale, non solo
politica ma quasi metafisica. In cui la guerra e la persecuzione erano solo i
sintomi di una guerra ormai ultima, la prova, che negli anni a venire avrebbe
gettato una luce cruda su quanto accaduto. Quella luce che in molti oggi
sembrano non voler riesumare, nonostante i corpi riesumati in quelle fosse
furono circa 11000, comprese le vittime recuperate e quelle stimate, più i morti
nei campi di concentramento jugoslavi. Una riflessione scaturisce in merito a
quella storia vissuta eppure dimenticata dai più, impressa tuttavia nelle menti
delle generazioni che l’hanno vissuta sulla loro pelle l’8 settembre del 1943,
quando i territori istriani, giuliani e dalmati, dapprima sotto l’influenza
tedesca, venivano in seguito occupati dai partigiani comunisti di Tito. Titini
che, comunemente ai partigiani comunisti italiani, non solo nutrivano il
progetto di avanzare in un paese ormai stremato e inerme (segnato dalla caduta
del fascismo) recriminandone la conquista territoriale, ma addirittura
rivelarono ben presto quell’odio etnico che li animava. L’intenzione di
“de-italianizzare” i territori occupati con metodi terribili fu presto svelata.
Metodi che nulla avevano da invidiare a quelli nazisti adottati nei confronti di
popoli innocenti e che nulla centravano con i fatti accaduti nell’Europa della
grande guerra e dei crimini di guerra. Così, occorre oggi ricordare, che
Italiani senza particolare distinzione di sesso, età o fazioni politiche, erano
prelevati e poi eliminati con l’unica colpa forse, di non aver partecipato
attivamente a piani espansionistici di Tito, che costrinse ben 350000 persone a
fuggire dalle loro terre e altre 11000, a essere uccise con modalità di una
ferocia inaudita. Nella sola foiba di Basovizza, furono rinvenuti 2000 cadaveri.
Nonostante in molti abbiano portato il tema alla considerazione dell’opinione
pubblica, sorge spontanea una riflessione. Possibile che solo ora, dopo
settantanni di macabra storia celata e quasi dimenticata, se non addirittura
strumentalizzata a piacere dalle diverse fazioni politiche, possiamo ritenerci
soddisfatti dell’istituzione di una giornata della memoria e (addirittura)
dell’uscita di un film sull’avvenimento di tale fatto? E pensare che la
cinematografia e tutte le varie ricorrenze istituite ad hoc, non si sono fatte
aspettare più di tanto per quel che concerne la Shoah. Per quale motivo? Che le
foibe fossero meno importanti? O probabilmente perché nonostante tutto, ancora
oggi, le foibe non sono ancora entrate nella cosiddetta “memoria condivisa” di
un popolo (quello italiano) che ne fu vittima oltre che carnefice? Come scrisse
il grande giornalista Indro Montanelli, “sicuramente il silenzio sulle foibe
oggi si spiega facilmente, considerando che la storiografia italiana del
dopoguerra era di sinistra, la quale apparteneva certamente al comunismo slavo e
di cui era succube e ne curava gli interessi. Di questo quindi non si poteva
parlare poiché della morte di tante persone ne risentiva la coscienza. Ammesso
che ce ne fosse una, in nome di una resistenza che altro non era che una guerra
civile tra italiani stessi.” Forse occorrerà domandarsi cosa, al cospetto dei
quei tragici avvenimenti, viene oggi ricordato nell’immaginario collettivo
comune. Di quel macabro periodo in cui tutto pareva che fosse quasi un nodo, che
prima o poi sarebbe certo venuto al pettine.
Foibe: anche decine e decine di sacerdoti furono
torturati e uccisi, scrive “Imola Oggi”. Cinquanta sacerdoti tra le vittime
delle foibe. Il racconto di Piero Tarticchio, parente di un sacerdote martire di
quel periodo. La storia delle foibe è legata al trattato di pace firmato a
Parigi il 10 Febbraio 1947, che impose all’Italia la cessione alla Jugoslavia di
Zara – in Dalmazia –, dell’Istria con Fiume e di gran parte della Venezia
Giulia, con Trieste costituita territorio libero tornato poi all’Italia alla
fine del 1954.
Dal 1947 al 1954 le truppe jugoslave di Tito, in collaborazione con i comunisti
italiani, commisero un’opera di vera e propria pulizia etnica mettendo in atto
gesti di inaudita ferocia.
Sono 350.000 gli Italiani che abbandonarono l’Istria, Fiume e la Dalmazia, e più
di 20.000 le persone che, prima di essere gettate nelle foibe (cavità carsiche
profonde fino a 200 metri), subirono ogni sorta di tortura. Intere famiglie
italiane vennero massacrate, molti venivano legati con filo spinato a cadaveri e
gettati nelle voragini vivi,
decine e decine di sacerdoti furono torturati e uccisi. Nella sola foiba di
Basovizza sono stati ritrovati quattrocento metri cubi di cadaveri.
Per decenni questa barbarie è stata nascosta, tanto che l’agenzia di stampa
“Astro 9 colonne”, nel fare un conteggio dei lanci di agenzia pubblicati dal
dopoguerra ad oggi sul tema delle foibe, ha scoperto che fino al 1990 erano
stati poco più di 30. Negli anni Novanta l’attenzione per il tema è aumentata:
oltre 100 fino al 1995, l’anno successivo i lanci sono stati ben 155. Negli anni
recenti ogni anno ce ne sono stati addirittura più di 200. Dopo anni di silenzio
la vicenda è arrivata in Parlamento, e con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 è
stato istituito il ”Giorno del Ricordo”, per conservare la memoria della
tragedia delle foibe. Calcolare esattamente il numero delle vittime è difficile,
ma sono stati almeno 50 i sacerdoti uccisi dalle truppe comuniste di Tito.
Interpellato da ZENIT, Piero Tarticchio, che all’epoca dei fatti aveva sette
anni, ha ricordato la tanta gente che partecipò al funerale del suo parente don
Angelo Tarticchio, parroco di Villa di Rovino e attivo nell’opera caritativa di
assistenza ai poveri, ucciso il 19 settembre del 1943 e sepolto il 4 novembre.
Il sacerdote venne preso di notte dai partigiani jugoslavi, insultato e
incarcerato nel castello dei Montecuccoli a Pisino d’Istria. Dopo averlo
torturato, lo trascinarono presso Baksoti (Lindaro), dove assieme a 43
prigionieri legati con filo spinato venne ucciso con una raffica di
mitragliatrice e gettato in una cava di bauxite. Tarticchio ha raccontato a
ZENIT che il 31 ottobre, quando venne riesumato il cadavere, si vide che in
segno di scherno gli assassini avevano messo una corona di filo spinato in testa
a don Angelo. Don Tarticchio viene oggi ricordato come il primo martire delle
foibe. Un’altra delle vittime fu don Francesco Bonifacio, un sacerdote istriano
che per la sua bontà e generosità veniva chiamato in seminario “el santin”.
Cappellano a Volla Gardossi, presso Buie, don Bonifacio era noto per la sua
opera di carità e zelo evangelico. La persecuzione contro la fede delle truppe
comuniste era tale che non poté sfuggire al martirio. La sera dell’11 settembre
1946 venne preso da alcune “guardie popolari”, che lo portarono nel bosco. Da
allora di Don Bonifacio non si è saputo più nulla; neanche i resti del suo
cadavere sono mai stati trovati. Il fratello, che lo cercò immediatamente, venne
incarcerato con l’accusa di raccontare storie false. Per anni la vicenda è
rimasta sconosciuta, finché un regista teatrale è riuscito a contattare una
delle “guardie popolari” che avevano preso don Bonifacio. Questi raccontò che il
sacerdote era stato caricato su un’auto, picchiato, spogliato, colpito con un
sasso sul viso e finito con due coltellate prima di essere gettato in una foiba.
Per don Francesco Bonifacio il 26 maggio 1997 è stata introdotta la causa di
beatificazione, per essere stato ucciso “in odium fidei”. In “odium fidei” fu
ucciso il 24 agosto del 1947 anche don Miroslav Buselic, parroco di Mompaderno e
vicedirettore del seminario di Pisino. A causa della guerra in molte parrocchie
della sua zona non era stato possibile amministrare la cresima, così don
Miroslav accompagnò monsignor Jacob Ukmar per amministrare le cresime in 24
chiese diverse. I comunisti, però, avevano proibito l’amministrazione. Alla
chiesa parrocchiale di Antignana i comunisti impedirono l’ingresso a monsignor
Ukmae e don Miroslav. Nella chiesa parrocchiale di Pinguente una massa di
facinorosi impedì la cresima per 250 ragazzi, lanciando uova marce e pomodori,
tra insulti e bestemmie. Il 24 agosto nella chiesa di Lanischie, che i comunisti
chiamavano “il Vaticano” per la fedeltà alla chiesa dei parrocchiani, monsignor
Ukmar e don Milo riuscirono a cresimare 237 ragazzi. Alla fine della liturgia i
due sacerdoti si chiusero in canonica insieme al parroco, ma i comunisti fecero
irruzione, sgozzarono don Miroslav e picchiarono credendolo morto monsignor
Ukmar, mentre don Stjepan Cek, il parroco, riuscì a nascondersi. Alcuni
testimoni hanno raccontato che prima di essere sgozzato don Miloslav avrebbe
detto “Perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Al funerale i comunisti
non permisero ai treni pieni di gente di fermarsi, nemmeno nelle stazioni
vicine. Al processo i giudici accusarono monsignor Ukmar e il parroco di aver
provocato gli incidenti, così il monsignore, dopo aver trascorso un mese in
ospedale per le percosse ricevute, venne condannato ad un mese di prigione. Il
parroco fu invece condannato a sei anni di lavori forzati. Su don Milo, il
tribunale del popolo sostenne che non era provato che “fosse stato veramente
ucciso”. Poteva essersi “suicidato a scopo intimidatorio”. Le prove erano però
così evidenti che l’assassino venne condannato a cinque mesi di prigione per
“troppo zelo nella contestazione”. Nel 1956, in pieno regime comunista la
diocesi avviò segretamente il processo di beatificazione di don Miloslav
Buselic, ed è diffusa ancora oggi la fama di santità di don Miro tra i cattolici
d’Istria.
Crimini titini: cinquanta i
sacerdoti infoibati, da Bonifacio a Bulesic,
scrive Antonio Pannullo su “Il Secolo d’Italia”. È stato solo con la legge del
2004 che ha istituito
il Giorno del Ricordo in
memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, per iniziativa
del deputato triestino
Roberto Menia,
che la maggioranza degli italiani ha saputo cosa successe alla frontiera
nordorientale negli anni Quaranta. Ventimila gli italiani uccisi, infoibati,
oltre 350mila le popolazioni che dovettero forzosamente abbandonare
l’Istria e la Dalmazia
spinti dalla furia dei partigiani comunisti di
Tito.
Fu un genocidio in piena regola, che ha rispettato tutti i canoni: prima lo
sterminio indiscriminato delle popolazioni residenti in un determinato
territorio, tanto da costringere i superstiti ad abbandonarlo, poi l’occupazione
di quel territorio e la confisca – meglio: il ladrocinio – delle terre e delle
case ai proprietari legittimi. Ferite queste, insieme con gli assassinii di
massa, che non sono mai state rimarginate. Tra gli infoibati, ossia le persone
gettate, spesso vive, nelle depressioni carsiche chiamate foibe, ci furono
persino sacerdoti. E anche questo è stato appreso recentemente, poiché per
decenni su quella vicenda calò una pesantissima cortina di silenzio con la
complicità del debole governo democristiano che non voleva dispiacere alla
Jugoslavia ma
che soprattutto non voleva rinunciare all’apertura a sinistra, che poi realizzò.
Sembra che i sacerdoti assassinati in questo modo siano stati non meno di
cinquanta, alcuni dei quali a tutt’oggi sconosciuti e alcuni dei quali di cui
non è mai stato trovato il corpo. Come accadde per
don Francesco Bonifacio,
torturato e assassinato dai titini, che è stato proclamato beato il 4 ottobre
2008 nella chiesa di San Giusto a Trieste da
Benedetto XVI.
62 anni dopo i fatti. Francesco Bonifacio era nato nel 1912 a Pirano, oggi in
Slovenia, e per la sua bontà era stato soprannominato
el santin.
Nel 1946 era cappellano a
Villa Gardossi,
un grosso comune agricolo nell’entroterra, e fu lì che fu sorpreso da quattro
“guardie popolari”, nome dietro cui si nascondevano i feroci assassini titini, i
quali lo derisero, poi picchiarono selvaggiamente,lo lapidarono, lo spogliarono
e lo finirono a coltellate prima di gettarlo in una foiba, detta di Martines,
che non lo ha mai più restituito. Il fratello, che lo cercò immediatamente
avendo saputo che cosa fosse successo, venne incarcerato con l’accusa di
raccontare storie. Molti anni dovettero passare prima che si facesse luce sulla
vicenda. Vennero fuori i testimoni che raccontarono le atrocità di quelle ultime
ore. Ma la cortina di silenzio era già scesa, di lui non si parlò più per anni.
Nel 1957 il vescovo di Trieste, Santin, avviò la causa di beatificazione, ma la
pratica restò ferma per 40 anni, a riprova del fatto che sulla foibe doveva
calare il silenzio per sempre. Solo Benedetto XVI, recentemente, ha avuto il
coraggio di dichiarare Bonifacio ucciso in odio alla Fede. A Bonifacio si è
aggiunto, nel settembre del 2013, il nome di
Miro Bulesic,
assassinato dai partigiani rossi nell’agosto del 1947 nell’Istria
settentrionale. Bulesic è stato beatificato nell’Arena
di Pola nel corso di una
commovente cerimonia, nel corso della quale si è appreso che nelle diocesi
croate negli anni Quaranta furono trucidati ben 434 sacerdoti, tra secolari e
regolari, più altri 24 morti per le torture e le sevizie in carcere. Quel 24
agosto 1947, nel corso delle cresime nella chiesa di Lanisce, esponenti
comunisti irruppero nell’edificio di culto, distrussero tutto, misero a ferro e
fuoco la chiesa stessa e bastonarono selvaggiamente don Miro, gettandolo contro
il muro e alla fine sgozzandolo con un coltello. Il responsabile, individuato,
fu poi assolto. Ma la mattanza dei religiosi era cominciata molto prima: nel
settembre 1943 i partigiani jugoslavi di notte sequestrarono don Angelo
Tarticchio, parroco di Villa di Rovino, e lo gettarono nelle carceri del
castello di Montecuccoli a Pisino d’Istria. Dopo qualche giorno venne portato
Lindaro insieme con altre 43 persone, legate insieme col filo spinato, e colpito
da raffiche di mitra e gettato in una cava di bauxite. Quando don Angelo fu
riesumato si vide che gli assassini gli avevano messo sulla testa una corona di
spine fatta di filo spinato. Tra i sacerdoti uccisi e infoibati vanno ricordati
anche don
Alojzij Obit del Collio,
che scomparve nel gennaio del 1944, don
Lado Piscanc
e don Ludvik
Sluga di Circhina,
assassinato insieme con altri 13 loro parrocchiano nel febbraio dello stesso
anno, don Anton
Pisk di Tolmino, scomparso
e poi verosimilmente infoibati ad ottobre 1944, don
Filip Tercelj
di Aidussina, sequestrato dalla polizia segreta jugoslava nel gennaio 1946 e
successivamente scomparso, don
Izidor Zavadlav
di Vertoiba, arrestato e fucilato il 15 settembre 1946, e molti altri rimasti
ancora senza nome.
“Rosso Istria”, a rischio il film sulle
foibe?, scrive Marco Minnucci su “Il Giornale”. Rosso Istria, il dramma del
confine orientale del dopo guerra
è il titolo del lungometraggio del regista Antonello Belluco, presentato a fine
gennaio a palazzo Moroni, Padova. Il film sarà prodotto da Venice Film ed
Eriador Film, sostenuti dalla Regione Veneto, con il suo fondo del cinema e
dell’audiovisivo, con la collaborazione del Comune di Padova, della Treviso Film
Commission e dell’ANVG (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia).
Il capoluogo veneto sarà il teatro delle riprese che punteranno
l’obiettivo sul 1943 anno in
cui, per le popolazioni
civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate,
si consuma la tragedia per
mano dei partigiani di Tito
spinti da una furia anti-italiana. Che
il lungometraggio metta in risalto la figura di Norma Cossetto, giovane
studentessa istriana, barbaramente violentata e uccisa nel 1943
dai partigiani titini, è già scritto nel titolo, infatti era proprio
Istria Rossa
(il rosso è relativo alla terra ricca di bauxite dell’Istria) il titolo della
tesi di laurea che Norma Cossetto stava preparando nell’estate del 1943 con il
suo relatore, il geografo Arrigo Lorenzi. La Cossetto girava in bicicletta per i
paesi dell’Istria, visitando luoghi, biblioteche, chiese, alla ricerca di
archivi che le consentissero di sviluppare la sua tesi di laurea, che purtroppo
non vedrà mai la luce perchè la studentessa verrà massacrata per la sola colpa
di essere italiana. Non
è un tema nuovo per Belluco, figlio di esuli, che già a novembre dello scorso
anno era uscito con il film
Il segreto di Italia,
sulla strage compiuta dai partigiani nel 1945 a Codevigo;
un film che non aveva mancato di suscitare aspre polemiche, che videro in prima
fila l’ANPI di Padova. Chissà se anche in questa “opera seconda” Belluco
inciamperà in quelle operazioni di boicottaggio che hanno rallentato e impedito
la distribuzione del film nelle sale cinematografiche?
Questa volta Belluco non sarà solo, poiché a dargli manforte ci sarà la
collaborazione del cantautore Simone Cristicchi,
anche lui presente alla conferenza padovana; l’autore di “Magazzino 18” sarà il
compositore delle musiche che accompagneranno “Rosso Istria”. Quella tra Belluco
e Cristicchi è una solidarietà artistica che, prima di sfociare in questa
collaborazione, era già stata esternata dal cantautore romano sulla sua pagina
Facebook con un post in cui sottolineava le similitudini tra l’ostruzionismo che
aveva colpito il suo “Magazzino 18” e il “Segreto di Italia” e concludeva con
questo messaggio d’ incoraggiamento: “Per fortuna, esiste una forma di
promozione che nessuno può censurare. Si chiama “passaparola”. E allora…in bocca
al lupo Antonello, e coraggio!” Non
resta che augurarci che questa volta si faccia silenzio in sala ma, soprattutto,
che ci sia una sala.
“Io, minacciato per il mio spettacolo sulle
Foibe”, scrive in un a intervista a Simone Cristicchi “Il Giornale”.
In questi ultimi anni
stai raccogliendo il testimone di Giorgio Gaber, porti in tournée in tutta
Italia i tuoi spettacoli di teatro-canzone. In questi giorni sei in scena con
“Magazzino 18″, uno spettacolo sulla tragedia delle Foibe che è al centro di
polemiche secondo me vergognose. Che cos’è il Magazzino 18 e che cosa ti ha
spinto a raccontare questa pagina tragica della storia d’Italia?
«Magazzino 18 è un luogo
realmente esistente che si trova nel Porto Vecchio di Trieste, un hangar dove
venivano messe le merci delle navi in transito; in questo magazzino n. 18 si
trovano invece le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati, che
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale furono costretti ad abbandonare le
loro terre. Sono oggetti di vita quotidiana – letti, armadi, cassapanche, foto,
ritratti – che ci raccontano una tragedia cancellata per tanti anni dalla storia
e dalla memoria, io la chiamo “una pagina strappata dai libri di storia”. Ogni
oggetto racconta la storia di una famiglia, di un vissuto, di un tessuto sociale
strappato e mai più ricomposto. Con questo spettacolo ho cercato di ricomporre
la loro storia dimenticata e di raccontarla a chi, come me fino a pochi anni fa,
non ne era assolutamente a conoscenza».
È una pagina nascosta
per 50 anni dai libri di storia, una cosa vergognosa. Come ti spieghi questo
dividere ancora i morti in ‘morti di serie A’ e ‘morti di serie B? È vero che
hai ricevuto delle minacce perché metti in scena uno spettacolo sulle Foibe?
«Lo spettacolo in realtà non è
soltanto sulle Foibe, che sono un piccolo capitolo di una storia più complicata.
Le persone che mi hanno criticato sono di estrema destra e di estrema sinistra,
nessuno si è sottratto alla lapidazione di chi cerca di fare giustizia, di dare
voce a chi non l’ha avuta per tanti anni; tutte queste critiche sono arrivate da
persone che non hanno nemmeno avuto il buon gusto di vedere lo spettacolo,
quindi mi scivolano addosso».
Non capisco perché ti
attacchino sia da destra che da sinistra…
«Da sinistra perché è uno
spettacolo “da fascisti”, da destra perché probabilmente avrei dovuto essere più
incisivo in alcuni particolari di questa storia, quando invece il mio spettacolo
vuole tendere a una pacificazione tra le parti e forse invece alcuni esponenti
dell’estrema destra non cercano il dialogo. Ancora oggi, a distanza di tanti
anni, non accettano alcune cose e cercano sempre lo scontro. Non ho scritto
questo spettacolo con Ian Bernas per creare ulteriori scontri e offese a questa
gente».
La tua è sempre stata
una musica di denuncia, ho sempre i brividi quando ascolto “Ti regalerò una
rosa”. Tornando a un tema che hai affrontato anche in un tuo spettacolo, chi
sono oggi i veri pazzi della nostra società?
«Probabilmente i veri pazzi
sono i sognatori, quelli che credono che oggi si possa rifare una nuova Italia e
cambiare un po’ il mondo, con una partecipazione attiva alla vita politica e
sociale. I veri pazzi sono quelli che continuano a sognare e che non si lasciano
soffocare da tutto quello che sta accadendo in questo momento».
Che cosa pensi della
protesta dei Forconi, che proprio in queste ore stanno paralizzando molte piazze
per protestare contro la linea del Governo?
«Non ho seguito bene la
questione perché in questo momento sono in tournée in Croazia, posso dire che a
volte sono delle valvole di sfogo difficili da gestire, ma che ci si deve
aspettare… quando le persone sono soffocate a un certo punto esplodono in
qualche modo. La mia paura è che questo tipo di manifestazioni possano portare a
delle violenze, e quando c’è la violenza si passa sempre dalla parte del torto».
Tu sei sempre rimasto
OFF, anche dopo il successo hai sempre imposto una tua linea artistica e
autorale precisa fregandotene del mercato ufficiale, sei perfettamente in linea
con il nostro magazine. Che consiglio ti senti di dare ai giovani artisti che
cominciano questa carriera e che ci leggono su ilgiornaleOFF?
«Il consiglio che posso dare è
quello di coltivare una curiosità per il mondo senza avere delle ideologie
preconcette, di affidarsi all’istinto perché molto spesso ci guida verso mete a
cui non avremmo mai pensato, come è successo a me: sono passato dal fumetto alla
canzone, poi dalla canzone al teatro e alla scrittura, il 4 febbraio uscirà
anche il libro di “Magazzino 18″, con tutti i racconti che ho raccolto in questi
anni. Bisogna mantenere le antenne puntate e presentarsi al grande pubblico con
una maturità quasi già acquisita, non arrivare da debuttanti e sentirsi però
debuttanti sempre, per tutto il proprio percorso».
Vite negate, massacri,
falsità. Anche la verità fu infoibata. Oggi la "Giornata del ricordo" per
celebrare gli italiani cacciati e uccisi da Tito dopo la guerra. Una tragedia
che nella gerarchia del dolore sta sempre dietro le vittime delle dittature
fasciste, scrive Stefano Zecchi su “Il Giornale”. Cos'era accaduto sulle coste
orientali italiane dell'Adriatico dopo la guerra? Niente di rilevante, avrebbero
voluto rispondere chi governava l'Italia e chi da sinistra faceva l'opposizione.
Soltanto un nuovo confine segnato con un tratto di penna sulla carta geografica
dell'Europa. Vite negate. Amori, amicizie, speranze sconvolte, sentimenti
calpestati, che per pudore, in silenzio, lontano da occhi inquisitori, l'esule
arrivato dall'Istria, dalla Dalmazia, da Fiume chiudeva nel dolore, forse
sperando che questo dignitoso comportamento lo aiutasse ad essere accolto da chi
non ne gradiva la presenza. Si chiudeva così il cerchio dell'oblio, e una
pesante coltre di omertà si distendeva sopra le sconvenienti ragioni degli
sconfitti. La Storia non apre le porte agli ospiti che non ha invitato. Sceglie
i protagonisti e i comprimari, anche se gli esclusi si sono dati tanto da fare.
Esuli, allora, con la nostalgia del ritorno, con il dolore dell'assenza. L'esule
dei Paesi comunisti non è mai stato troppo gradito; le sue scelte giudicate con
sospetto. Nella gerarchia morale della sofferenza, egli rientra stentatamente,
sì e no, agli ultimi posti, molto indietro rispetto agli esiliati delle
dittature fasciste e dei sanguinari regimi latino-americani. In una intervista a
Panorama del 21 luglio 1991, Milovan Gilas dichiarava tra l'altro: «Nel 1946, io
e Edward Kardelij andammo in Istria a organizzare la propaganda anti italiana
... bisognava indurre gli italiani ad andare via con pressioni di ogni tipo.
Così fu fatto». Gilas era il braccio destro di Tito, l'intellettuale del partito
comunista jugoslavo; Kardelij era il teorico della «via jugoslava al comunismo»,
punto di riferimento dell'organizzazione della propaganda anti italiana. Dunque,
due protagonisti di primissimo piano del partito comunista jugoslavo impegnati a
cacciare con «pressioni di ogni tipo» gli italiani dalle loro case, dal loro
lavoro, dalle loro terre. Tra le pressioni di ogni tipo ci furono il terrore e
il massacro: una pulizia etnica. A migliaia gli italiani, senza nessun processo,
senza nessuna accusa, se non quella di essere italiani, venivano prelevati di
notte, fatti salire sui camion e infoibati o annegati. Non si saprà mai quanti
furono ammazzati. A decine di migliaia: una stima approssimativa è stata fatta
sulla base del peso dei cadaveri che venivano recuperati dalle foibe; nulla si
sa degli annegati. E poi gli esuli: oltre 350mila, che lasciarono tutto, pur di
rimanere italiani e vivi. Accolti in Italia con disprezzo, perché solo dei
ladri, assassini, malfattori fascisti potevano decidere di abbandonare il
paradiso comunista jugoslavo. Ricordo bene quando a Venezia arrivavano le
motonavi con i profughi: appena scesi sulla riva, erano accolti con insulti,
sputi, minacce dai nostri comunisti, radunati per l'accoglienza. Il treno che
doveva trasportare gli esuli giù verso le Marche e le Puglie, dai ferrovieri
comunisti non fu lasciato sostare alla stazione di Bologna per fare rifornimento
d'acqua e di latte da dare ai bambini. Alla gente che abitava l'oriente
Adriatico, fu negato dal nostro governo il plebiscito che avrebbe dimostrato
come in quelle terre la stragrande maggioranza della popolazione fosse italiana.
Prudente, De Gasperi pensava che l'esito del plebiscito avrebbe turbato gli
equilibri internazionali e interni col PCI. A quel tempo, Togliatti aveva fatto
affiggere questo manifesto a sua firma: «Lavoratori di Trieste, il vostro dovere
è accogliere le truppe di Tito come liberatrici e collaborare con esse nel modo
più stretto». Per esempio, sostenendo, come voleva il Migliore, che il confine
italiano fosse sull'Isonzo, lasciando a Tito Trieste e la Venezia Giulia. I
liberatori comunisti non potevano essere degli assassini: e così, sotto lo
sguardo ipocrita dell'Italia repubblicana, con la vergognosa collaborazione
degli storici comunisti, disposti a scrivere nei loro libri il falso, quella
tragedia sparisce, non è mai accaduta. Ma il cammino trionfale della Storia dei
vincitori si distrae e la verità incomincia ad affiorare. Non si dice con
ottimismo che il tempo è galantuomo? Stavolta sembra di sì. Il 10 febbraio
(giorno della firma a Parigi nel 1947 del trattato di pace) viene istituita nel
marzo 2004 la «Giornata del ricordo», per celebrare la memoria dei trucidati
nelle foibe e di coloro che patirono l'esilio dalle terre istriane, dalmate,
giuliane. Ci sono voluti sessant'anni per incominciare a restituire un po' di
verità alla Storia: adesso sarebbe un bel gesto che il nuovo Presidente della
Repubblica onorasse questa verità ritrovata, recandosi al mausoleo sulla foiba
di Basovizza per chiedere scusa alle migliaia di italiani dimenticati, offesi,
umiliati, massacrati soltanto perché volevano rimanere italiani.
I partigiani ora ammettono
la vergogna di esodo e foibe.
Il coordinatore dell'Anpi veneto riconosce che molti perseguitati italiani non
erano fascisti ma oppositori del nuovo regime comunista e illiberale, scrive
Fausto Biloslavo su “Il Giornale”. Si scusa con gli esuli in fuga dall'Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia per l'accoglienza in patria con sputi e minacce dei
comunisti italiani. Ammette gli errori della facile equazione profugo istriano
uguale fascista e della simpatia per i partigiani jugoslavi che non fece vedere
il vero volto dittatoriale di Tito. Riconosce all'esodo la dignità politica
della ricerca di libertà. Maurizio Angelini, coordinatore dell'Associazione
nazionale partigiani in Veneto, lo ha detto a chiare lettere venerdì a Padova,
almeno per metà del suo intervento. Il resto riguarda le solite e note colpe del
fascismo reo di aver provocato l'odio delle foibe. L'incontro pubblico è stato
organizzato dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia con l'Anpi, che solo da
poco sta rompendo il ghiaccio nel mondo degli esuli. Molti, da una parte e
dall'altra, bollano il dialogo come «vergognoso». Angelini ha esordito nella
sala del comune di Padova, di fronte a un pubblico di esuli, ammettendo che da
parte dei partigiani «vi è stata per lunghissimi anni una forte simpatia per il
movimento partigiano jugoslavo». Tutto veniva giustificato dalla lotta
antifascista, compresa «l'eliminazione violenta di alcune centinaia di persone
in Istria - le cosiddette foibe istriane del settembre 1943; l'uccisione di
parecchie migliaia di persone nella primavera del 1945 - alcune giustiziate
sommariamente e precipitate nelle foibe, soprattutto nel Carso triestino, altre
- la maggioranza - morte di stenti e/o di morte violenta in alcuni campi di
concentramento jugoslavi soprattutto della Slovenia». Angelini ammette, parlando
dei veri disegni di Tito, che «abbiamo colpevolmente ignorato la natura
autoritaria e illiberale della società che si intendeva edificare; abbiamo
colpevolmente accettato l'equazione anticomunismo = fascismo e ascritto solo
alla categoria della resa dei conti contro il fascismo ogni forma di violenza
perpetrata contro chiunque si opponeva all'annessione di Trieste, di Fiume e
dell'Istria alla Jugoslavia». Parole forti, forse le prime così nette per un
erede dei partigiani, poco propensi al mea culpa. «Noi antifascisti di sinistra
- sottolinea Angelini - non abbiamo per anni riconosciuto che fra le motivazioni
dell'esodo di massa delle popolazioni di lingua italiana nelle aree istriane e
giuliane ci fosse anche il rifiuto fondato di un regime illiberale, autoritario,
di controlli polizieschi sulle opinioni religiose e politiche spinti alle
prevaricazioni e alle persecuzioni». Il rappresentante dei partigiani ammette
gli errori e sostiene che va fatto di più: «Dobbiamo riconoscere dignità
politica all'esodo per quella componente di ricerca di libertà che in esso è
stata indubbiamente presente». Gli esuli hanno sempre denunciato, a lungo
inascoltati, la vergognosa accoglienza in Italia da parte di comunisti e
partigiani con sputi e minacce. Per il coordinatore veneto dell'Anpi «questi
ricordi a noi di sinistra fanno male: ma gli episodi ci sono stati e, per quello
che ci compete, dobbiamo chiedere scusa per quella viltà e per quella
volgarità». Fra il pubblico c'è anche «una mula di Parenzo» di 102 anni, che non
voleva mancare. Il titolo dell'incontro non lascia dubbi: «Ci chiamavano
fascisti, ci chiamavano comunisti, siamo italiani e crediamo nella
Costituzione». Italia Giacca, presidente locale dell'Anvgd, l'ha fortemente
voluto e aggiunge: «Ci guardavamo in cagnesco, poi abbiamo parlato e adesso ci
stringiamo la mano». Adriana Ivanov, esule da Zara quando aveva un anno,
sottolinea che gli opposti nazionalismi sono stati aizzati prima del fascismo,
ai tempi dell'impero asburgico. Mario Grassi, vicepresidente dell'Anvgd, ricorda
le foibe, ma nessuno osa parlare di pulizia etnica. Sergio Basilisco, esule da
Pola iscritto all'Anpi, sembra colto dalla sindrome di Stoccolma quando si
dilunga su una citazione di Boris Pahor, scrittore ultra nazionalista sloveno
poco amato dagli esuli e sulle vessazioni vere o presunte subite dagli slavi.
Con un comunicato inviato al Giornale, Renzo de' Vidovich, storico esponente
degli esuli dalmati, esprime «perplessità di fronte alle prove di dialogo con
l'Anpi» che farebbero parte di «un tentativo del Pd di Piero Fassino di inserire
i partigiani nel Giorno del ricordo dell'esodo». L'ex generale, Luciano Mania,
esule fiumano, è il primo fra il pubblico di Padova a intervenire. E ricorda
come «solo due anni fa a un convegno dell'Anpi sono stato insultato per un
quarto d'ora perché avevo osato proporre l'intitolazione di una piazza a Norma
Cossetto», una martire delle foibe. In sala tutti sembrano apprezzare «il
disgelo» con i partigiani, ma la strada da percorrere è ancora lunga e
insidiosa.
«QUEL SILENZIO ASSORDANTE
SULLE FOIBE». Il comunismo e il terrore, l'intervento del Nuovo Psi di Qualiano
su “Interenapoli”. Qual è il vero motivo di sessanta anni di silenzio sulle
foibe? Chi ci ha guadagnato da questo silenzio? Quante carriere, politiche,
universitarie, sono state costruite da questi assordanti silenzi? L’accesso agli
archivi di Mosca, un tempo segreti, ha consentito la stesura di un bilancio
delle vittime del comunismo spaventoso, addirittura quattro volte superiore a
quello delle vittime del nazismo: il più colossale caso di carneficina politica
della storia. A tutt’oggi c’è ancora chi ritiene improponibile un accostamento
dei due regimi rifacendosi alla differente ispirazione iniziale: mentre il
nazismo fu una dottrina dell’odio e i suoi crimini,pertanto prevedibili e legati
alla sua stessa essenza, il comunismo è spesso considerato una dottrina di
liberazione, di amore per l’umanità e i suoi delitti considerati a mo’ di
errori, incidenti, deviazioni. Tale argomentazione è a dir poco artificiosa in
quanto prevedeva in entrambi i casi lo sradicamento di una parte della società.
L’utopia di una società senza classi e l’illusione di una razza pura esigevano
l’eliminazione di individui che si riteneva,ostacolassero la realizzazione del
progetto. Per questo il richiamo all’umanità del comunismo è servito spesso a
dare una legittimazione superiore all’uso del “terrore”. Il principio umanitario
della politica consiste nel non considerare nessun uomo superiore moralmente ad
un altro. Il nazismo è considerato il regime più criminale del secolo, mentre il
comunismo in virtù dell’alleanza dello stalinismo con le principali democrazie
mondiali ne ha ricavato spesso un credito morale che non ha mai cessato di
sfruttare: l’antifascismo. In virtù di questo valore i crimini comunisti sono
diventati un indiscutibile strumento di legittimazione. Contrapporre la
democrazia al fascismo permise al sistema comunista di presentarsi come
“democratico” in quanto antifascista. In tale contesto si inserisce la
complicità del comunismo italiano che in Italia ha peccato di gravi menzogne e
di una palese incapacità di attuare un vero processo revisionistico. La volontà
di palesare una superiorità morale del “comunista” rispetto agli altri non
comunisti ha portato all’atteggiamento del PDS durante il periodo di
tangentopoli che ha comportato la eliminazione di una intera classe dirigente
nazionale. Il cinismo comunista fu accompagnato, insieme alla liquidazione a
all’infoibamento di una intera classe dirigente ad un trasformismo mal celato
complice un uso parziale della Giustizia che certamente non esaminò con eguale
severità i finanziamenti illeciti di ogni partito, compresi i finanziamenti
moscoviti all’ex partito comunista. La ragione del fallimento del tentativo
degli “ex” comunisti di usurpare il socialismo liberale e la politica di Craxi
risiede proprio nella incapacità di ripensare alla propria storia, ripudiando
gli errori commessi e scavando fino infondo la tragedia e i crimini del
comunismo. E’per questo che la riabilitazione della figura di Bettino Craxi non
può venire da Fassino e dal DS. L’Europa dei totalitarismi e dell’uomo
moralmente superiore all’altro uomo, perché politicamente diversi deve restare
dietro di noi ma non può essere né dimenticata, ne sottaciuta perché non
dobbiamo e non possiamo dimenticare. Il ricordo di ciò che copre di vergogna
l’essere umano può impedire di ripercorrere la stessa strada dell’odio. La
nostra gioventù è figlia di quei mali e deve diventare testimone dei valori
della democrazia e della tolleranza. La tendenza al regime trova sviluppo dove
c’è ignoranza e laddove non vengono insegnati i valori di una vita libera.
Mafia, camorra e terrorismo dovrebbero essere sperati da anni, mentre a Scampia
e in tutta la provincia di Napoli si muore e si uccide tutti i giorni e la
corruzione riesce a trovare ampi spazi anche nelle istituzioni Il pluralismo
culturale è stato il protagonista dello sviluppo politico, sociale ed economico
del nostro paese e dell’intera Europa. “Le vittime della violenza non hanno
colore politico”, è ciò che spesso si ascolta da chi forse cerca un alibi
dimenticando che proprio l’odio politico ha provocato quelle vittime.
Non lasciatevi ingannare dal
titolo, Il revisionista, in uscita da Rizzoli (pagine 474), scrive Rino Messina
su “Il Corriere della Sera”. Questo non è l'ennesimo libro di Giampaolo Pansa
sulla guerra civile italiana. È l'autobiografia di un giornalista che, quando si
svolgeva la mattanza raccontata nel Sangue dei vinti, aveva dieci anni. E che è
cresciuto a Casale Monferrato, zona di Resistenza, in una famiglia operaia,
assorbendo i racconti sulla guerra e l'amore per la cultura: «I miei sapevano
che l'unica possibile emancipazione era studiare e non mi facevano mai mancare
libri, penne, quaderni». In uno dei brani più commoventi il padre Ernesto
confida a suo figlio, da poco entrato alla «Stampa» di Torino: «Ora che scrivi
per i giornaloni anche i signori mi salutano». Come fa un libro che contiene
queste storie private a non essere definito un'autobiografia? Eppure Giampaolo
Pansa nella prefazione dice d'essersi limitato a tracciare il suo percorso di
Revisionista. Successi, ma anche attacchi e insulti, a cominciare da quando nel
2002 pubblicò I figli dell'Aquila e soprattutto nel 2003 quando firmò Il sangue
dei vinti, un saggio vicino al traguardo del milione di copie. «Il vero motivo
per cui l'ho scritto - confida Pansa - è ringraziare le persone che mi hanno
apprezzato perché avevo dato loro voce. L'Italia degli sconfitti che prima del
Sangue dei vinti non avevano diritto di partecipare al discorso pubblico. A loro
ho voluto raccontare il mio percorso di giornalista che ha avuto la fortuna di
incontrare tanti maestri. Tra i giornalisti che non appartengono alla sua
cerchia, io credo di essere quello che meglio capisce Silvio Berlusconi. E sa
perché? Perché sono nato nel 1935, un anno prima di lui, e capisco le paure e le
angosce di un settantenne, ma ne condivido anche l'entusiasmo e il percorso
generazionale». Il revisionista non è un libro provocatorio, a tesi, né il
racconto di una sola parte italiana. È la storia di un percorso e degli incontri
che hanno segnato un uomo. La Gianna, la prima fidanzatina di Giampaolo, la
prima con cui abbia fatto l'amore. Ricevendone una lezione straordinaria. Gianna
era una di quelle ragazze che erano state rapate a zero dopo il 25 aprile: suo
padre era un fascista ucciso per vendetta e a lei era toccata quell'umiliazione.
Poi Luigi Firpo, il geniale professore alla facoltà di Scienze politiche,
Alessandro Galante Garrone e Guido Quazza, i due storici che seguirono la tesi
di laurea di Pansa, Guerra partigiana tra Genova e il Po, un malloppo di circa
mille pagine che conteneva documenti e testimonianze di prima mano e che sarebbe
uscito nel 1967 da Laterza. Guido Quazza usava tenere una scheda sui suoi
laureandi. Sulla tesi di Pansa scrisse: «Importante lavoro per la vastità della
ricerca... È sempre presente il principio dell'audiatur et altera pars». Siamo
nel 1959 e questo è un riconoscimento straordinario: ascoltare sempre l'altra
voce. La lezione di Gianna era un seme che cresceva. Quella tesi avrebbe vinto
uno dei due premi Luigi Einaudi: sarebbe stato il salvacondotto per entrare
subito nel mondo del giornalismo, alla «Stampa» diretta da Giulio De Benedetti.
Da «ciuffettino», così era soprannominato il rigoroso direttore del quotidiano
torinese, a «barbapapà» Eugenio Scalfari, Il revisionista di Pansa è anche una
galleria di direttori e colleghi, ritratti impietosi e affettuosi, in cui la
critica non fa mai velo alla gratitudine. Leggete per esempio questo omaggio a
Giorgio Bocca, diventato in questi anni l'arcinemico di Pansa in difesa di una
Resistenza che ha sentito tradita dal suo più giovane collega: «Giorgio era il
primo dei miei maestri indiretti. I giornalisti che leggevo con la matita in
mano per prendere appunti e imparare come si doveva scrivere un buon articolo.
Avevo recensito con entusiasmo un libro che raccoglieva i suoi reportage
italiani. Lui mi aveva ringraziato con un biglietto e io ero andato di corsa a
Milano per conoscerlo». Nel 1964, auspice Bocca, era arrivata la chiamata al
«Giorno» diretto da Italo Pietra, partigiano e uomo di fiducia di Enrico Mattei.
Nella stanza delle riunioni ogni mattina il direttore entrava rivolgendo, tra
l'ironico e il minaccioso, questa domanda ai colleghi: chi di voi ha bruciato la
mia casa sul monte Penice nel rastrellamento dell'agosto 1944? Perché il gruppo
dirigente del «Giorno» era formato per metà da giornalisti che avevano fatto la
Resistenza e per metà da saloini che avevano combattuto dall'altra parte, chi
nella X Mas, chi nelle Brigate Nere, chi nella Guardia repubblicana. Anche in
questo episodio è evidente che «il revisionismo» è il filo conduttore del
racconto, ma il genere letterario è quello dell'autobiografia, sull'esempio
fortunato del Provinciale di Giorgio Bocca. Trovi lo stesso stupore, la stessa
potenza narrativa, tratti simili di sensualità, entusiasmo, stupore della
scoperta. A volte di delusione e di stizza. Sentimenti evidenti nel capitolo «Il
libertino» dedicato a Eugenio Scalfari, di cui riconosce la tenacia geniale del
fondatore di imprese, ma al quale non risparmia pagine amare e impietose. «Via
via - scrive Pansa - diventò la statua di se stesso. Con la barba di un biancore
marmoreo... Quando morì Rocca (che con Pansa era stato vicedirettore della
"Repubblica") nella cerimonia al cimitero del Verano, andai a stringere la mano
a Eugenio. Ma lui se ne restò seduto e sembrò non riconoscermi». Pansa ne rimase
stupito e addolorato: attribuisce questo atteggiamento all'uscita dei suoi
lavori revisionisti, non apprezzati dal fondatore di «Repubblica». Nel libro c'è
anche spazio per ritratti di politici, da Giorgio Almirante a Enrico Berlinguer,
e soprattutto un invito al revisionismo, a raccontare le verità scomode, anche
sugli anni di piombo, la stagione sanguinosa degli anni Settanta che continua a
esalare veleni, come dimostrano le scritte contro Luigi Calabresi comparse in
questi giorni a Torino. Giampaolo Pansa, che oggi collabora al «Riformista» ma
soprattutto scrive libri, a 73 anni è felice della sua vita e continua a dirsi
fortunato. Tuttavia ha qualche rimorso: «Non aver fatto abbastanza per difendere
Calabresi come avrei dovuto». E qualche delusione: «Non aver mai ricevuto
l'invito da una scuola di giornalismo, dove insegnano perfetti sconosciuti. Ma
forse le scuole sono in mano alla sinistra e non invitano uno come me bollato a
destra. Ma io avrei qualcosa da dire ai giovani: per esempio che il mestiere di
giornalista non si impara, ma si ruba, e che il talento serve a ben poco senza
l'umiltà e lo spirito di sacrificio».
Giampaolo Pansa, il
revisionista impenitente, scrive
Gabriele Testi su “Storia in
Rete”. Il
revisionista che non si pente. Anzi. L’autore che più di ogni altro ha attaccato
in Italia miti storiografici del Novecento e l’Accademia, sta per tornare con un
libro destinato a rinverdire le polemiche scatenate da «Il Sangue dei Vinti». Le
tesi di Pansa? «Il PCI di Togliatti voleva l’Italia satellite dell’Urss»; «la
politica di oggi non è interessata a fare i conti con la Storia»; «I miei
critici? Scappano…»; «Le celebrazioni? Non mi piacciono mai»; «Il miglior leader
italiano? De Gasperi»; «Gli italiani? Non hanno futuro se continuano così…».
Forse perché non vogliono avere un passato? C’è sempre una prima volta, anche
per Giampaolo Pansa. Quella del giornalista piemontese al Festival
Internazionale della Storia di Gorizia, dunque allo stesso tempo su un terreno e
in un territorio particolarmente delicato per ogni forma di rivisitazione e di
analisi storiografica, non è passata inosservata. Anzi. La dialettica con un
pubblico tanto attento quanto sensibile alle vicende degli italiani vissuti (e
morti) oltre il Muro, in particolare comunisti di fede stalinista fuggiti in
Jugoslavia e diventati
«nemici
del popolo»,
e lo scontro verbale con il moderatore Marco Cimmino non saranno dimenticati
facilmente dalle parti di Gorizia. L’occasione si è comunque rivelata perfetta
per una chiacchierata con un autore che, in polemica con gli accademici italiani
e i «gendarmi
della memoria»
non arretra di un metro sul piano del confronto scientifico su quei temi, il
tutto alla vigilia del compleanno che il primo ottobre gli farà oltrepassare la
soglia dei tre quarti di secolo e della pubblicazione di un ultimo lavoro che lo
riporterà in autunno nei panni a lui del revisionista. È lui stesso a
raccontarlo a «Storia
in Rete»
in un’intervista esclusiva in cui si mescolano Resistenza e Risorgimento,
eredità del PCI, meriti e demeriti democristiani, una visione organica della
nostra società e le differenze esistenti fra i giovani di oggi e quelli le cui
scelte avvennero con la Guerra.
Considerato il
soggetto dei suoi ultimi due libri, considera ormai chiusa la parentesi dedicata
alla Guerra Civile italiana?
«No, tant’è vero che in
novembre uscirà con la Rizzoli un mio nuovo libro sulla Guerra Civile. Il titolo
è: “I vinti non dimenticano”. Non è soltanto il seguito del “Sangue dei vinti” e
dei miei libri revisionisti successivi. Insieme a vicende che coprono territori
assenti nelle mie ricerche precedenti, come la Toscana e la Venezia Giulia, c’è
una riflessione più generale, e contro corrente, sul carattere della Resistenza
italiana. Dominata dalla presenza di un unico partito organizzato, il PCI di
Palmiro Togliatti, Luigi Longo e Pietro Secchia. Che aveva un traguardo preciso:
conquistare il potere e fare dell’Italia un Paese satellite dell’URSS».
È rimasto fuori
qualcosa – un’osservazione, una storia, un nome – che le piacerebbe aggiungere o
correggere?
«Non ho niente da correggere
per i miei lavori precedenti. E voglio dirvi che, a fronte di sette libri ricchi
di date, di nomi, di vicende spesso ricostruite per la prima volta, non ho mai
ricevuto una lettera di rettifica, dico una! E non sono mai stato citato in
tribunale, con qualche causa penale o civile. Persino i miei detrattori più
accaniti, tutti di sinistra, non sono mai riusciti a prendermi in castagna. Mi
hanno lapidato con le parole per aver osato scrivere quello che loro non
scrivevano. Però non sono stati in grado di fare altro».
E a proposito di
«aggiungere»?
«Come voi sapete meglio di me,
nella ricerca storica esistono sempre campi da esplorare e vicende da rievocare.
In Italia questa regola vale ancora di più a proposito della Guerra Civile fra
il 1943 e il 1948. Parlo del ’48 perché considero l’anno della vittoria
democristiana nelle elezioni del 18 aprile la conclusione vera della nostra
guerra interna. I campi da esplorare sono molti, anche perché della guerra tra
fascisti della RSI e antifascisti non vuole più occuparsene nessuno. I
cosiddetti “intellettuali di sinistra” hanno smesso di scriverne perché si sono
resi conto che il loro modo di raccontare quella guerra non regge più, alla
prova dei fatti e dei documenti. Nello stesso tempo, le tante sinistre italiane
non hanno il coraggio di ammettere quella che ho chiamato nel titolo di un mio
libro “La grande bugia”. Se lo facessero, perderebbe molti elettori, ossia
quella parte di opinione pubblica educata a una vulgata propagandistica della
Resistenza. Sul versante di destra constato la stessa reticenza. Un tempo
esisteva il MSI, in grado di dar voce agli sconfitti. Oggi i reduci di
quell’esperienza, parlo soprattutto del gruppo nato attorno a Gianfranco Fini,
si guardano bene dal rievocare il tempo della Repubblica Sociale Italiana.
Infine, il Popolo della Libertà ha ben altre gatte da pelare. E a Silvio
Berlusconi della Guerra Civile non importa nulla. Di fatto, sono rimasto quasi
solo sulla piazza. Questo mi rallegra come autore, però mi deprime come
cittadino. Sono ancora uno di quelli che non dimenticano una verità vecchia
quanto il mondo: il passato ha sempre qualcosa da insegnare al presente e anche
al futuro».
Che cosa risponde a
chi nega valore ai suoi libri perché «poco scientifici»? È davvero soltanto una
questione di note a margine?
«Mi metto a ridere! Rido e me
ne infischio, perché la considero un’accusa grottesca. Questa è l’ultima trincea
dei pochi “giapponesi” che si ostinano a difendere una storiografia che fa acqua
da tutte le parti. A proposito delle note a piè di pagina, ricordo che tutte le
mie fonti sono sempre indicate all’interno del testo, per rispetto verso il
lettore e per non disturbarlo nella lettura del racconto. Per quanto riguarda i
cattedratici di storia contemporanea, il mio giudizio su di loro è quasi sempre
negativo. Ci sono troppi docenti inzuppati, come biscotti secchi e cattivi da
mangiare, nell’ideologia comunista. Il Comunismo è morto in gran parte del
mondo, ma non all’interno delle nostre università. L’accademia che ho conosciuto
nella seconda metà degli anni Cinquanta era molto diversa…».
Com’è un libro di
storia «scientifico»? Perché non si toglie lo sfizio e glielo fa? Oppure bisogna
necessariamente scriverlo da una cattedra universitaria?
«Se per libro scientifico si
intende una ricerca storica fondata su fonti controllate e che racconta fatti
veri o comunque il più possibile vicini alla verità, questo è ciò che ho sempre
fatto. Anche il libro che uscirà a novembre, se vogliamo usare una parola
pomposa che non mi appartiene, è a suo modo un’opera scientifica. Lo è perché
l’ho pensato a lungo, ci ho lavorato molto e sono pronto ad affrontare ogni
contraddittorio. Ormai la storiografia accademica “rossa” non vuole fare
contraddittori con i cani sciolti come me perché ha paura di essere messa sotto.
Si nascondono, fanno come le lumache. Mia nonna diceva: “lumaca, lumachina,
torna nella tua casina”. Non si fa così: si tengano le loro cattedre sempre più
inutili, cerchino di insegnare qualcosa a studenti altrettanto svogliati.
Dopodiché quello che posso fare per loro è pagare le mie tasse fino all’ultima
lira, come ho sempre fatto. In fondo, io sono tra i finanziatori della ricerca
storica universitaria».
A proposito di
revisionismo: come giudica quello sul Risorgimento (quello neo-borbonico, ma
anche la nostalgia cripto-leghista che ha in mente il Regno Lombardo-Veneto
austriaco)?
«Quando ero studente diedi
anche un esame di storia del Risorgimento. Non mi ricordo più con chi. Mi
appassionava, però confesso di non avere un interesse per quel periodo storico.
Mi rendo conto, com’è accaduto per tutte le fasi cruciali, che bisognerebbe
andare a vedere anche lì se la storia ci viene raccontata nel modo giusto. Io
non santifico nessuno, non mi piace. Non l’ho mai fatto nel mio lavoro di
giornalista politico, per cui mi è difficile trovare qualcuno che mi entusiasmi
anche tra i leader partitici. E credo che anche sul Risorgimento ci sia molto da
rivedere o revisionare. Ma se un partito come la Lega Nord si mette di mezzo e
pretende di riscrivere la storia, io me ne ritraggo inorridito…».
Ci fu anche allora,
indubbiamente, una guerra civile che prese il nome di
«brigantaggio».
Ha mai pensato di occuparsene?
«Sul brigantaggio ho letto
parecchio, recentemente anche un romanzo bellissimo che racconta di un episodio
in Calabria o Campania, adesso non ricordo, della lotta contro i piemontesi.
Ritengo che questo fenomeno fosse una forma di resistenza delle classi dirigenti
del Mezzogiorno nei confronti dei Savoia per quella che era un’occupazione
militare. Lo Stato unitario è certamente nato sul sangue di entrambe le parti,
perché non è che i piemontesi siano andati con la mano leggera al sud, e lo dico
parlando da piemontese. Del resto, le guerre sono sempre state fatte in queste
modo: le vincono non soltanto coloro che hanno la strategia più intelligente, ma
anche chi non usa il guanto di velluto. Basti vedere come sono stati i
bombardamenti alleati in Italia durante la Seconda guerra mondiale, un altro
argomento che gli storici dell’antifascismo e della Resistenza non hanno granché
affrontato e che io credo di avere chiarito bene nel prossimo libro, per di più
alla mia maniera. Ormai ho imparato che i conflitti bellici sono mattatoi
pazzeschi. Ricordo che da bambino vidi passare sulla mia testa, a Casale
Monferrato, le “fortezze volanti” americane che andavano a bombardare la
Germania. In un primo tempo a scaricare esplosivo sui tedeschi erano gli aerei
inglesi del cosiddetto Bomber Command, guidati da questo Harris [sir Arthur
Travers Harris, maresciallo dell’aria della RAF, 1892-1984, soprannominato
“Bomber Harris” NdR] che anche dai suoi era stato battezzato “Il macellaio” [per
la leggerezza con cui mandava a morire i suoi equipaggi NdR]. Anch’io avrei
potuto essere un bambino bombardato in Italia, ma grazie a Dio non abitavo
vicino ai due ponti sul Po che attraversavano la mia città. Queste sono le
guerre. È chiaro che se poi, una volta che sono finite, ci si mettono di mezzo i
faziosi che pretendono di raccontarle alla loro maniera, secondo gli interessi
di una parte politica, allora non ci si capisce più nulla…».
Come si esce dalle
divisioni del passato? Ancora oggi l’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, tessera dei giovani: queste cose hanno senso per lei?
«No, e io sono stato uno dei
primi a raccontarlo in qualche mio articolo e anche in un libro. Una sera mi
trovavo a Modena, dove mi ero recato a presentare uno dei miei lavori
revisionisti, e mi accorsi che sui quotidiani locali c’erano delle pagine
pubblicitarie a colori, dunque costose, e delle locandine in cui si invitavano i
ragazzi a iscriversi all’ANPI. Tutto questo non ha senso o, meglio, lo ha se si
pensa che l’Associazione è oggi un partito politico, minuscolo e molto
estremista. Secondo me tutto ciò non ha senso, però se vogliamo capire il
fenomeno bisogna dire che l’ANPI è uno strumento nelle mani della Sinistra
radicale o, diciamolo meglio, affinché non si offendano, una sua componente: è
chiaro che se dovesse fare affidamento soltanto sugli ex partigiani, anche su
quelli delle classi più giovani del ’25, ’26 e ’27, oggi i soci sarebbero tutti
ultraottantenni. Hanno bisogno di forze fresche e hanno trasformato
un’organizzazione di reduci, assolutamente legittima, in un club quasi di
partito. Siamo in una situazione di sfacelo delle due grandi famiglie politiche,
prima è toccato al centrosinistra e ora sta accadendo per una specie di nemesi
al centrodestra, e possiamo immaginarci quanto poco conti l’ANPI in questo
scenario. Quando l’Italia diventerà ingovernabile e nessuno sarà in grado di
gestirla, ci renderemo conto di come certi leader politici non possano fare
nulla».
Come spessore dei
personaggi, chi vince tra la Prima e la Seconda Repubblica? E, fra i grandi
statisti del passato, chi ci servirebbe oggi?
«È una bella domanda, che però
richiede una risposta complicata. Come ho scritto nella prefazione de “I cari
estinti”, tanto per citare un mio libro che sta avendo un grande successo, sono
un nostalgico della Prima Repubblica. Non ricordo chi lo abbia detto, se Woody
Allen o Enzo Biagi, personaggi agli antipodi fra di loro, ma “il passato ha
sempre il culo più rosa”. Io sono fatalmente portato a ritenere che i capi
partito della Prima Repubblica avessero uno spessore più profondo, diverso,
migliore di quelli di oggi, anche se in quel periodo furono commessi degli
errori pazzeschi. Prima che quella classe politica si inabissasse per sempre e
la baracca finisse nel rogo di Tangentopoli – non tutta naturalmente, perché il
PCI fu graziato dalla magistratura inquirente – negli ultimi quattro-cinque anni
si accumulò un debito pubblico folle, che è la palla al piede che ci impedisce
di correre e, soprattutto, diventa una lama d’acciaio affilata che incombe sulle
nostre teste. Non ho mai votato la DC, anche perché sono sempre stato un ragazzo
di sinistra, ma ho una certa nostalgia della “Balena Bianca”. Il grande merito
della Democrazia Cristiana fu di vincere le elezioni del 18 aprile, perché se
nel 1948 avesse prevalso il Fronte Popolare, non so che sorte avrebbe potuto
avere questo Paese. Secondo me ci sarebbe stata un’altra guerra civile, se non
altro per il possesso del nord Italia, anche se poi la storia non si fa con i
“se”. Per fortuna, lì si impose Alcide De Gasperi in prima persona. Ero molto
giovane, ma quello è un leader al quale ho visto fare grandi cose nei rapporti
con gli elettori. Ma pure i leader dell’opposizione a vederli da vicino erano
cosa altra da adesso. Anche di Enrico Berlinguer, che era una specie di “santo
in terra”, mi resi subito conto di che pasta fosse da un punto di vista
politico, più che umano. Quando lo intervistai per il “Corriere della Sera”,
alla vigilia delle elezioni politiche del 1976, mi disse che si sentiva molto
più al sicuro sotto l’ombrello della NATO che non “protetto” dal Patto di
Varsavia. Queste risposte eterodosse sull’Alleanza Atlantica e il PCI non le
pubblicò “l’Unità”, censurando di fatto il segretario del Partito, perché
avevano suscitato i malumori dell’ambasciata dell’URSS a Roma. Però gli stessi
concetti mi furono ribaditi dal leader comunista, senza battere ciglio, anche in
televisione durante una tribuna elettorale. Evidentemente, tutto ciò non doveva
finire su ”L’Unità”, che era letta come il Vangelo dai militanti comunisti,
mentre in tivù si poteva dire qualsiasi cosa».
Secondo lei chi è
stato il più grande? E perché?
«Io direi che oggi ci
servirebbe un uomo molto pratico ed energico come Amintore Fanfani, che ha
curato i nostri interessi sotto molti aspetti, oppure un temporizzatore
tranquillizzante come Mariano Rumor. Con tutto il rispetto per la sua figura e
la fine che ha fatto, non so invece se ci occorrerebbe un Aldo Moro. A sinistra
ci vorrebbe un tipo come Craxi, diciamoci la verità: Bettino aveva un grande
orgoglio di partito, ma non pendenze storiche che sarebbero state sconvenienti
da mostrare come accadeva a molti leader del PCI. In conclusione, ci servirebbe
un leader democratico e liberale in grado di imporsi con autorità e
autorevolezza per mettere fine a questa guerra civile di parole di cui in Italia
non ci rendiamo troppo conto e che diventa sempre più violenta. Il più grande di
tutti resta comunque De Gasperi, un uomo affascinante, brillante e capace: se
non sbaglio fece sette governi, si ritirò a metà dell’ottavo per il venir meno
della fiducia e fu per undici mesi segretario della DC prima di morire nel 1954.
È stato il politico che ha concesso a me e a voi, in un giorno d’estate del
2010, di procedere in quest’intervista senza paura di dire come la pensiamo».
Come giudica, anche da
piemontese, il modo con cui l’Italia si appresta a «festeggiare» i primi
centocinquant’anni di vita nel 2011 e le dimenticanze su Cavour in questo 2010?
«Vi dirò una cosa: io sono
contrario alle celebrazioni, anche le più oneste. Non servono a nulla, se non a
far girare un po’ di consulenze, a far lavorare qualche storico, vero o presunto
che sia, gli architetti, qualche grafico e chi si occupa di opere pubbliche per
tirar su mostre, ripristinare un museo e via dicendo. Non me ne importa nulla e
non sono affatto d’accordo. Chi vuole approfondire la storia del Risorgimento,
trova già tutto: basta che vada in una buona libreria e si faccia consigliare da
qualche bravo insegnante, magari di liceo, che spesso è anche più competente di
tanti docenti universitari…».
Che popolo sono gli
italiani? È giusto dire che dimenticano tante cose belle e si accapigliano a
distanza di secoli sempre sulle stesse cose?
«Io ho un’idea abbastanza
precisa di come siamo: un popolo in declino, che non è all’altezza delle nazioni
con le quali dovremmo confrontarci. L’Italia è un Paese di “serie B”, che presto
scenderà in “serie C”, con una squadra di calcio che non combina più nulla da un
sacco di anni. La gente è sfiduciata e non vuole più saperne della politica,
anche per come è la politica oggi. I giovani sono in preda ai “fancazzismi” più
esasperati e affollano le università per lauree assurde, vere e proprie
anticamere della disoccupazione. A un sacco di ragazzi se chiedi che cosa
vogliono fare da grandi, non sanno risponderti, perché non vogliono nulla.
Questo è un Paese per vecchi che diventano sempre più vecchi e io mi metto in
cima alla lista, perché a ottobre di anni ne avrò settantacinque. Quand’ero
giovane l’Italia era un contesto più generoso e che osava, baciato da miracoli
economici successivi, in cui il figlio di un operaio del telegrafo e di una
piccola modista, allevato da una nonna analfabeta come Giampaolo Pansa, poteva
andare all’università, laurearsi e fare il giornalista, che era la cosa che
avrebbe sempre voluto fare. Adesso l’Italia è un deserto di speranze, ma anche i
giovani non si accontentano mai. Oggi se ho bisogno di un idraulico, di un
falegname o di un elettricista, o trovo dei signori ultracinquantenni, o mi
affido a giovani molto bravi che quasi sempre sono extracomunitari. Vallo a
spiegare ai ragazzi italiani che gli studi universitari non garantiscono più
nulla…».
Da quanto detto non si può
che arrivare al negazionismo sulle foibe.
Al Magazzino 18 sembrava di
stare ad Auschwitz.
Parla il coautore dello spettacolo teatrale. Bernas: "Revisionismo? Questo tema
era stato occultato dalla storia ufficiale", scrive Gabriele Antonucci su “Il
Tempo”. «La storia non deve essere di nessuno, ma la verità deve essere di
tutti». Così il giornalista e scrittore Jan Bernas, esperto di geopolitica e di
storia, ha spiegato l’urgenza artistica della genesi di «Magazzino 18»,
spettacolo scritto insieme a Simone Cristicchi. Un’idea accarezzata per
vent’anni dal regista Antonio Calenda, che ha trovato finalmente compimento
grazie ai fortunati incontri con Cristicchi e con Bernas, contattato dal
cantante dopo aver letto il suo libro «Ci chiamavano fascisti. Eravamo
italiani». Lo spettacolo, dopo il trionfale debutto a Trieste, ha ricevuto
grandi consensi in tutta Italia per l’equilibrio del testo, la sensibilità di
Cristicchi e la regia emozionante di Calenda. «Magazzino 18» diventerà un libro,
che uscirà a febbraio per Mondadori, corredato dalle foto realizzate dall'autore
all’interno del silos dove sono ancora accatastati i beni lasciati dagli esuli
italiani in fuga. Per Bernas entrare al Magazzino 18 «è stata un’esperienza
incredibile, mi ha ricordato l’atmosfera del campo di concentramento di
Auschwitz. Prima di tutto è necessario un permesso speciale per entrare. Una
volta dentro, sono rimasto colpito da un salone enorme, pieno di sedie
accatastate una sopra l’altra. Dietro ognuna è riportato il nome e il cognome
del proprietario. Una stanza è piena di giocattoli, un’altra di libri, registri
e perfino di lettere d’amore. Fa venire i brividi». Quanto alle polemiche sullo
spettacolo, l’autore se le aspettava, «ma non così forti, violente e
preconcette. Le critiche più odiose sono quelle che sono arrivate prima che lo
spettacolo andasse in scena o, dopo il debutto, da chi non l’aveva neanche
visto. In "Magazzino 18" non diamo colpe, è semplicemente un atto di educazione
alla memoria». Per Jan la parola foiba non è soltanto un tabù, ma «una
semplificazione simbolica di una vicenda molto più complessa e articolata. Le
foibe, in realtà, sono la punta dell’iceberg, visto che in quel periodo tanti
italiani sono morti di crepacuore, chi a seguito dell’internamento, chi morto
dentro, rimanendo a Pola o a Fiume». Sono state numerose le difficoltà nello
scrivere un testo che affrontava una materia così delicata. «»È stato più duro
che scrivere un libro. Quando devi raccontare sopra un palcoscenico avvenimenti
così poco conosciuti non puoi dare nulla per scontato, né dal punto di vista
storico né da quello drammaturgico. Devi condensare una vicenda complessa in
meno di due ore». Sulle accuse di revisionismo, lo scrittore mostra di avere
idee chiare: «Se per revisionismo intendiamo che per la prima volta in Italia
viene rappresentato a teatro un argomento così occultato, allora lo è. Se con
quel termine indichiamo una mistificazione storica a favore di una sola parte,
non lo è certamente. È stato difficile realizzare uno spettacolo equilibrato:
sarebbe stato molto più facile scrivere un testo di parte». Bernas si è
accostato all’esodo degli italiani dalla Jugoslavia fin da giovanissimo. «Quando
ero al liceo già mi interessavo di storia. Un giorno chiesi alla mia insegnante:
"Come mai sono partiti tutti quegli italiani dall'Istria?" "Perché erano tutti
fascisti". Non mi sono accontentato di quella secca risposta e ho iniziato una
ricerca di molti anni che mi ha condotto a visitare quei luoghi, a conoscere e a
intervistare decine di esuli». Grandi emozioni gli ha riservato la prima dello
spettacolo a Trieste, dove era stata allarmata perfino la Digos per il rischio
di scontri tra opposte fazioni politiche: «Quella sera c’era una tensione molto
forte, ma l’applauso di un quarto d’ora con il pubblico in piedi, gli anziani
esuli in lacrime che ci hanno abbracciato, l’inno nazionale cantato alla fine da
tutta la sala sono stati i migliori regali che io, Cristicchi e Calenda
potessimo ricevere».
Ma quanto tempo deve ancora
passare perché il dramma dell’esilio giuliano-dalmata e la tragedia delle foibe
diventino memoria per tutti? Si chiede Federico Guiglia su “Il Tempo”. Memoria è
quel luogo del nostro animo dove il ricordo dell’orribile pagina di storia, che
si è scritta sul confine nord-orientale italiano soprattutto dal ’43 al ’47, può
ancora ferire gli anziani testimoni, commuovere i giovani che non conoscevano,
far riflettere un’intera nazione chiamata a custodire per sempre un capitolo di
sé per troppi anni rimosso. Ed è incredibile che a Simone Cristicchi, artista di
valore di una generazione del tutto estranea alla vicenda, venga oggi scagliato
l’anatema di «propaganda anti-partigiana» per lo spettacolo profondo e delicato,
esattamente com’è lui, dedicato all’esodo di trecentocinquantamila connazionali.
Come ormai si sa o si dovrebbe sapere, essi furono costretti ad abbandonare la
terra in cui erano nati o cresciuti per evitare, nel migliore dei casi, di
perdere la loro identità italiana. Anzi, italianissima, tipica della gente di
confine, lontana da Roma e perciò amante di un amore travolgente verso la
nazione italiana. Nel peggiore dei casi, gli esuli fuggivano per evitare la fine
orrenda dei ventimila infoibati, uccisi o torturati dai partigiani comunisti di
Tito con la sola «colpa» d’essere italiani. Senza dimenticare l’esproprio dei
loro beni, che spesso erano il frutto di sacrifici che si tramandavano di padre
in figlio, perché in Istria, Fiume e Dalmazia si parlava italiano dalla notte
dei tempi. Dunque, è stata un’epopea triste. È stata una fuga per la vita di
chi, da quel giorno, da quell’ultimo imbarco verso la madre-patria, avrebbe
perduto tutto, fuorché la dignità. La dignità di raccontare quel che era
successo, ma senza piangersi addosso. La dignità di ricominciare daccapo in
Italia o all’estero, perché una parte notevole degli esiliati è partita due
volte: la prima dalla propria terra verso la propria patria. La seconda dalla
patria verso il mondo. L’Australia, il Canada, l’America, sempre portandosi nel
cuore quel dramma silenzioso e quasi inconfessabile, tanto tremendo era stato.
Portandoselo, il lutto collettivo, con straordinaria civiltà. È un esodo che non
ha prodotto alcun atto di violenza per reazione o per vendetta, a differenza di
altri esodi sradicati ed espulsi in tante parti dell’universo. Di più. Questi
nostri fratelli mai hanno mostrato né fatto valere rancore nei confronti di chi
li aveva cacciati da casa loro. Chiedevano e chiedono solo «giustizia». Le loro
lacrime mai hanno riempito gli studi televisivi, a cui per anni i sopravvissuti
e le loro famiglie si sono sottratti con discrezione. Anche nel dolore essi
hanno dato prova di un’italianità esemplare: gente che non protestava, che non
dava la colpa agli altri dei propri e terribili guai subìti, che non s’inventava
partiti per lucrare voti sulla sofferenza. Solamente e nient’altro che un
grande, infinito rispetto, dunque, possiamo noi oggi restituire ai vivi e ai
morti, chiedendo scusa d’essere arrivati così tardi a «comprendere» e a
«condividere» la vicenda. È quel che ha fatto Simone Cristicchi con lo
spettacolo «Magazzino 18», andando a spulciare, per poi narrare, le cose senza
nome e senza numeri, ma da oggi con nuova anima, abbandonate dagli esiliati in
quel disperato magazzino di Trieste. Cristicchi ha dato voce e senso a una
storia che è rimasta muta per decenni. L’artista, che non ha ancora trentasette
anni, ha potuto e saputo più degli storici paludati, perfino, che poco o niente
hanno voluto ricordare di quell’esodo alla frontiera, voltando per anni la testa
e la penna dall’altra parte. Il giovane Cristicchi ha potuto e saputo più dei
politici navigati, mondo al quale non appartiene. E si vede, e si sente: libero
artista in libero Stato. Un mondo, quello politico, che ha scoperto l’esilio e
le foibe solo in tarda Repubblica quando, con legge del 2004, fu proclamato
«giorno del ricordo» il 10 febbraio, anniversario del Trattato di Pace che
staccò dall’Italia quei territori italiani. Da allora l’esilio e le foibe sono
tornati nella nostra storia nazionale. E ogni volta la cerimonia al Quirinale
rende omaggio alla memoria dei vinti e innocenti troppo a lungo dimenticati. Il
tesoro della memoria. Perciò la polemica che si è scatenata contro Cristicchi e
riportata dal «Tempo», con chi sollecita la cacciata dell’artista dall’Anpi reo
non si capisce di che cosa, non è né giusta né sbagliata: è semplicemente
incomprensibile. La verità non può far male, neanche settant’anni dopo. Neanche
quand’è raccontata con forza e dolcezza per non dimenticare.
Che le foibe siano state un
tabù per decenni, lo sanno tutti. Non una riga sui libri scolastici, nessun
volume storico diffuso nel grande circuito editoriale, zero commemorazioni
ufficiali. Achille Occhetto, l'ex leader comunista, in un'intervista al Tempo,
ammette candidamente di aver scoperto gli eccidi con cinquant'anni di ritardo. È
vittima della sua stessa disinformazione? Scrive Riccardo Pelliccetti su “Il
Giornale”. Quei massacri di migliaia di italiani a fine guerra sui confini
orientali sono stati nascosti e negati talmente a lungo da apparire quasi una
leggenda. Forse per questo Achille Occhetto, ex segretario del Pci, che con il
suo partito ha contribuito a far credere che non esistessero, afferma
candidamente in un’intervista: “Io stesso ho appreso del dramma delle foibe solo
dopo la svolta della Bolognina. Prima non ne ero mai venuto a conoscenza”.
D’altronde è stato l’ultimo leader dei comunisti italiani, maestri nella
propaganda e nel distorcere la verità. E perciò può essere rimasto vittima della
sua stessa disinformazione se ha scoperto un pezzo di storia solo nel 1989.
Oppure continua a mentire come hanno fatto i suoi compagni per quasi mezzo
secolo, raccontando che gli esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia non erano
semplici italiani in fuga dalle stragi comuniste ma fascisti che scappavano per
i loro misfatti. Un messaggio che aveva già fatto presa nel 1947. C’è un
episodio indimenticabile. Il 16 febbraio, un piroscafo parte da Pola con
migliaia di connazionali che, dopo essere sbarcati ad Ancona, sono stipati come
bestie su un treno merci diretto a La Spezia. Quel treno, il 18 febbraio, arriva
alla stazione di Bologna, dove è prevista una sosta per distribuire pasti caldi
agli esuli. Ma ad attendere i disperati c’è una folla con bandiere rosse (toh, i
compagni di Occhetto?) che prende a sassate il convoglio, mentre dai microfoni è
diramato l’avviso “se i profughi si fermano, lo sciopero bloccherà la
stazione”. Il treno è costretto a ripartire. Questo il clima. La propaganda
comunista e la mistificazione della realtà, come sappiamo, hanno influenzato non
poco la cultura italiana del secondo Novecento. Ma è stato impossibile
seppellire la memoria: troppi profughi, troppi testimoni e quella destra che
alimenta i ricordi. E poi c’è Trieste, che Occhetto conosce bene, città decorata
con la medaglia d’oro al valore militare dal capo dello Stato, nella cui
motivazione c’è scritto “…subiva con fierezza il martirio delle stragi e delle
foibe, non rinunciando a manifestare attivamente il suo attaccamento alla
Patria…”. Tutti sapevano delle foibe, anche se era scomodo e sconveniente
parlarne. Per questo motivo facciamo fatica a credere che il prode Achille
l’abbia saputo così tardi. Fosse stato per il Pci, probabilmente non se ne
sarebbe mai parlato, ma per fortuna è stato sconfitto dalla storia. E al grande
libro dei fatti è stata aggiunta quella pagina strappata.
Pianse Achille Occhetto il
giorno in cui, con la “svolta della Bolognina”, seppellì il Partito comunista
italiano dando vita al Pds, scrive Luca Rocca su “Il Tempo”. Può sembrare
incredibile, ma è lo stesso Occhetto quello che oggi si commuove per lo
spettacolo teatrale “Magazzino 18” con il quale Simone Cristicchi ha messo in
scena le foibe e l’esodo istriano, giuliano e dalmata. Quei drammi che proprio
la sinistra italiana, per molti decenni, non ha voluto vedere per non dover fare
i conti con sé stessa e perché ottenebrata dall’ideologia, adesso inteneriscono
colui che pose la prima pietra per la costruzione della sinistra postcomunista.
Occhetto, come giudica lo
spettacolo di Cristicchi?
«Davvero molto bello.
Trasmette un grande pathos per via di vicende drammatiche nelle quali i torti e
le ragioni non stanno tutti da una parte. Si è lontani da una visione manichea.
Anche se da un punto di vista della vicenda storica, infatti, nel grande
capitolo del ’900, tra fascismo e antifascismo le colpe stanno dalla parte del
primo, occorre dire, e nello spettacolo di Cristicchi ne ho trovato traccia, che
lo stalinismo ha “macchiato” le idealità dello stesso antifascismo».
Dunque Cristicchi, nel
raccontarci che gli esuli non erano fascisti ma italiani che fuggivano da una
dittatura, ha usato un metro di giudizio oggettivo?
«Non c’è dubbio. Cristicchi ci
dice che, al di là delle affermazioni ideologiche con le quali si combattono
delle battaglie politiche, ci furono anche molti antifascisti che si
ingannarono, perché non capirono fino a che punto si stava vivendo il dramma di
un popolo e non uno scontro fra nostalgici del fascismo e non, come invece una
certa propaganda cerca di far vedere».
C’è chi a Cristicchi
vorrebbe togliere la tessera onoraria dell’Anpi.
«Un’iniziativa totalmente
sbagliata. Il pezzo teatrale di Cristicchi inquadra tutta la vicenda nel torto
storico fondamentale del fascismo. L’autore ci dice, fin dall’inizio, che se non
ci fosse stato quel tipo di guerra e soprattutto quel tipo di odio
nazionalistico che aveva suscitato le reazione dell’altra parte, probabilmente
non si sarebbe arrivati a quel punto. Poi, naturalmente, mette in evidenza come
anche la sinistra allora non capì fino in fondo quel dramma umano. Non fummo
messi nelle condizioni di vedere che cosa realmente accadeva, di capire il reale
dramma che si nascondeva oltre i pretesti ideologici».
“Magazzino 18” ha provocato
uno “strappo” fra quanti sostengono che il negazionismo è da respingere sia a
“destra” che a “sinistra”, e quanti continuano a ritenere che il male del
fascismo non è uguale a quello, spesso definito “presunto”, compiuto ai danni
degli esuli. Foibe comprese.
«Non si può negare la
drammatica realtà delle foibe. Forse ci furono degli antifascisti jugoslavi
onesti che rimasero impigliati in quelle vicende, si possono fare delle analisi
articolate quanto si vuole, ma il dato di fatto è indubbio».
Per decenni questo capitolo
della nostra storia è rimasto sconosciuto.
«Io stesso ho appreso del
dramma delle foibe solo dopo la “svolta della Bolognina”. Prima non ne ero mai
venuto a conoscenza».
Com’è stato possibile?
«Di fronte a una storia del
‘900 segnata dai gradi delitti e dalla conculcazione delle libertà da parte del
nazifascismo, probabilmente si è cercato di non vedere, e di non ricercare,
qualche cosa che poteva addolorarci. Il fatto che quella ricerca venisse poi
svolta dalla parte fascista, ha provocato una reazione di tipo ideologico
dall’altra parte. Il merito dello spettacolo di Cristicchi, ecco perché mi
stupisco di certe posizioni, è che ha portato una vicenda drammatica e umana
lontano dal furore degli opposti ideologismi, per ricollocarla nella sua
drammatica realtà storica».
Lei ha pianto il giorno in
cui, con la “svolta della Bolognina”, sancì la fine del Pci, ora si commuove
assistendo alla messa in scena dell’esodo istriano. Se lo sarebbe mai
immaginato?
«Ogni fatto umano, raccontato
nella sua tensione reale, è destinato a commuovere. Non penso sia una commozione
che fuoriesca da quell’orizzonte morale e ideale per cui mi sono commosso
leggendo il Diario di Anna Frank o le Lettere dei condannati a morte della
Resistenza. Ho ritrovato, sotto un segno diverso, lo stesso dramma pagato da
innocenti».
La «guerra civile
culturale» in Italia non è mai finita,
scrive Luca Rocca su “Il Tempo”. Se intorno a un cantante che mette in scena la
«verità storica» sull’esodo istriano, giuliano e dalmata che «condannò» migliaia
di italiani alla fame, alla sete e alla morte, si produce ancora uno «squarcio
storico», allora siamo ancora lontani da una «storia condivisa». Con «Magazzino
18» andato in scena a Trieste, Simone Cristicchi racconta la verità stabilita
dai documenti storici. La verità di italiani, non di fascisti, in fuga dalle
«speciali purghe» titine e in cerca dell’agognata libertà. Una verità che a
quanto pare può essere raccontata solo dopo una preventiva revisione del
«copione» da parte dei «depositari» della verità. E se da una parte la onlus Cnj
ha annunciato di aver raccolto qualche centinaio di firme di aderenti all’Anpi
per chiedere che a Cristicchi venga ritirata la tessera onoraria
dell’associazione dei partigiani, dall’altra c’è chi, fra i rappresentanti dei
partigiani, nello spettacolo storico-teatrale di Cristicchi vede una ventata di
verità. È il caso di Elena Improta, vicepresidente Anpi Roma, a cui abbiamo
chiesto un commento sulla vicenda.
La vicenda Cristicchi ha
riaperto una ferita che in realtà non si era mai chiusa. Che posizione ha l’Anpi
sulla polemica innescata da «Magazzino 18»?
«Le posizioni
nell’associazione non sono univoche. Mi sono informata, ho letto tutto e poi ho
parlato con persone che hanno visto lo spettacolo di Cristicchi. Si tratta di
iscritti al Partito democratico, persone che hanno avuto parenti deportati ad
Auschwitz. Gente, insomma, vicina alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.
Ebbene, tutti mi hanno riferito che in quello spettacolo non hanno trovato
assolutamente nulla di sconvolgente e che si tratta di una polemica
assolutamente ideologica. Cristicchi ha solo voluto evidenziare che vanno
condannate tutte le forme di violenza che hanno segnato la nostra storia. Non ci
possiamo più nascondere».
Qualcuno, come la onlus
Cnj, vorrebbe addirittura togliere la tessera onoraria dell’Anpi al cantante per
aver ricordato le foibe e il destino di quegli esuli.
«Quelle associazioni e quegli
esponenti territoriali dell’Anpi che hanno sottoscritto l’appello contro
Cristicchi per il ritiro della tessera perché nel suo spettacolo ha ricordato le
foibe, mi sembrano fuori dal mondo. Non c’è nulla di sconvolgente in quelle
dichiarazioni. Ricordare quello che furono le foibe non è uno scandalo e nulla
toglie al valore della Resistenza e alla lotta partigiana. Se memoria
dev’essere, si ricordi tutto. È arrivato il momento di riconoscere che chi
scappava da Tito non era fascista, ma cercava la libertà come la cercavano i
nostri partigiani. Mi chiedo se chi ha rilasciato certe dichiarazioni abbia
realmente visto lo spettacolo di Cristicchi. Il "negazionismo" va condannato a
360 gradi, anche quello sulle foibe».
C’è chi nell’Anpi ha una
posizione molto rigida e si accoda alla richiesta di Cnj.
«Le opinioni di chi persegue
rigidamente i valori dell’Anpi sono univoche nel senso che ricordano solo la
violenza fascista, riconoscono e condannano solo quella, non quella delle foibe.
Sto parlando della parte "conservatrice" che fa riferimento o che è vicina ai
Comunisti italiani e a Rifondazione comunista. Sbagliano e lo ripeto. Ricordare
le foibe non vuol dire negare la Resistenza o la lotta partigiana».
Accanto a Elena Improta c’è
Mario Bottazzi, ex combattente partigiano ora nel comitato provinciale dell’Anpi
romana. Va oltre, Bottazzi, e si chiede perché non si debbano ammettere
nell’Anpi anche persone legate alla destra più moderna e antifascista. Sul «caso
Cristicchi» abbiamo sentito anche Carlo Smuraglia, presidente nazionale
dell’Anpi che si chiede: «Chi, come e quando ha deciso di dare la tessera ad
honorem a Cristicchi? In ogni caso l’Anpi toglie le tessere solo in casi
eccezionali, solo in presenza di gravissimi fatti di indegnità». Sottolinea, il
presidente dell’Anpi, che «si occuperà della cosa, lo farà la sezione locale,
per verificare di che spettacolo parliamo e di questa tessera ad honorem. Sarà
una verifica seria e non improvvisata». E poi prosegue: «In genere sono per
rispettare le manifestazioni d’arte, prenderle per quelle che sono e poi
discutere. Certe cose non si affrontano a picconate, vanno rispettate. Se poi
uno fa uno spettacolo per negare l’esistenza delle camere a gas, allora ci si
arrabbia. Se invece affronta qualcosa che è ancora oggetto di discussione, è
diverso». Infine Smuraglia ammette che su quegli esuli italiani in fuga da una
dittatura perché in cerca della libertà e non in quanto fascisti, «è arrivato il
momento di discutere seriamente, di affrontare l’argomento nelle sedi
opportune».
Cristicchi: "Canterò e
reciterò le foibe. E già mi insultano".
Il cantautore porta a teatro il dramma giuliano-dalmata: "A 50 anni di distanza
è ancora un argomento scomodo", scrive Francesco Cramer su “Il Giornale”.
Perché questo tema?
«Per emozionare e illuminare
delle storie rimaste al buio».
Di cui pure lei sapeva
poco?
«Pochissimo. A scuola il
dramma degli esuli istriani e dalmati non viene raccontato».
Eppure lei ha fatto studi
umanistici.
«Liceo classico a Roma. Ma,
come molti, da ragazzino davanti alla targa "Quartiere giuliano-dalmata" mi
chiedevo chi fosse il signor Giuliano Dalmata».
Un capitolo di storia che
dovuto studiare da solo?
«Sì. Ringrazio la mia
curiosità e la mia sete di sapere».
Quando è nata l'idea dello
spettacolo?
«Un anno fa, in una libreria
di Bologna, mi ha colpito un libro di Jan Bernas: "Ci chiamavano fascisti,
eravamo italiani". L'ho divorato».
Poi?
«Ho contattato l'autore su
facebook: "Dobbiamo parlarci...". Siamo diventati amici e abbiamo cominciato ad
approfondire la cosa».
Da lì è partita l'idea di
raccontare a teatro le storie narrate nel libro?
«Sì. Poi ho chiesto di poter
visitare il Magazzino 18 di Trieste, inaccessibile al pubblico. Lì ho varcato la
porta della tragedia».
Il Magazzino 18: l'immenso
deposito di cose mai ritirate dagli esuli istriani.
«Impressionante la tristezza
di quel luogo. C'è di tutto: quaderni di scuola, posate, bicchieri, armadi e
sedie; montagne di sedie».
Da qui il titolo dello
spettacolo: Magazzino 18. Cosa vedremo a teatro?
«Le vicende umane di una
pagina nera e dimenticata, attraverso il personaggio principale: un archivista
del ministero degli Interni inviato al magazzino a mettere ordine».
E attraverso gli oggetti
emergeranno le storie vere?
«Sì, in sei o sette brani con
altrettante canzoni. Tutti episodi drammatici e commoventi».
Ci anticipi qualcosa.
«Ci sarà la storia della
tragedia dei comunisti di Monfalcone, partiti per la Jugoslavia per costruire il
"Sol dell'avvenire". Solo che dopo il loro arrivo Tito ruppe con Stalin e venne
accusato di deviazionismo. Per i comunisti di Monfalcone non ci fu scampo:
furono considerati nemici e molti finirono nel gulalg di Goli Otok-Isola calva».
Una faida tra compagni.
«Certo. Un sopravvissuto
racconta: "Sono stato utilizzato come utile idiota della storia e ho contribuito
a far andar via i miei connazionali. Solo dopo ho capito"».
Lei sa che raccontare
queste vicende è politicamente scorretto?
«Lo so bene. Su twitter e
facebook sono arrivati i primi insulti. Qualcuno mi ha pure dato del traditore».
Traditore? E perché?
«Perché il mio spettacolo "Li
romani in Russia", dove racconto il dramma dei soldati italiani inviati dal Duce
sul fronte sovietico, mi ha affibbiato la patente di uomo di sinistra».
Invece?
«Invece a me interessa
raccontare cose accadute. La verità è che siamo un Paese ancora intossicato
dall'ideologia; che tanti danni ha fatto nel passato. Tra cui strappare alcune
pagine di storia del nostro popolo».
Che lei vuole riattaccare.
«Certo. La mia vuole essere
un'opera di educazione alla memoria. Per non dimenticare. Mai».
Cristicchi: «Io e la mia
compagnia siamo stati insultati».
Il cantante parla dalla sua pagina Facebook e risponde a chi contesta il suo
spettacolo «Magazzino 18», scrive Carlo Antini su “Il Tempo”. Simone Cristicchi
prende la parola in prima persona. E lo fa dalla sua pagina Facebook. Il
cantautore romano risponde a chi lo contesta. A chi contesta il suo spettacolo
«Magazzino 18» (che dovrebbe andare in onda in seconda serata il 10 febbraio su
Rai1) perché colpevole di essere antipartigiano. Cristicchi è un artista
coraggioso e non si fa intimorire dalle minacce. Neppure da chi ha chiesto la
sua espulsione dall’Associazione Nazionale Partigiani. «La tessera mi è stata
donata dall’Anpi stessa nel 2010 come attestato di riconoscenza per lo
spettacolo con il Coro dei Minatori di Santa Fiora - ha scritto Cristicchi sul
suo Facebook - A quanto mi risulta, qualche mese fa la richiesta è già pervenuta
all’Anpi, che ha risposto "No" al ritiro della tessera. Ora un’oceanica folla
(un centinaio di firmatari) ci sta riprovando, con la benedizione del CNJ, che
continua a violare leggi sulla privacy pubblicando mie corrispondenze private
sul loro sito». Ma Cristicchi denuncia anche veri e propri episodi di violenza e
intimidazione subìti negli ultimi mesi. «Senza pensare al fatto che io e la mia
compagnia abbiamo subìto insulti e una sospetta ruota squarciata durante il tour
in Istria - conferma il musicista - Bel modo di esporre le proprie idee!
Complimentoni». Alla lunga prende il sopravvento la rabbia e la voglia di
mettere in luce le contraddizioni del movimento. «Detto questo, se da una parte
è deludente constatare cotanta presunzione, sono quasi contento che stiano
uscendo allo scoperto questi atteggiamenti, le loro critiche campate in aria e
la valanga di menzogne sul mio spettacolo. Così mostrano il loro vero volto, in
fondo non così diverso dagli estremisti di destra che loro si vantano di
"combattere". Si. Indossando le magliette "I love foiba". Da antifascista, sono
schifato da tutto ciò. La tessera gliela rispedisco io! In posta prioritaria.
Altrimenti, senza tante chiacchiere, si facciano loro uno spettacolo con la loro
"sacrosanta" verità. In fondo, ma molto in fondo, siamo un paese democratico,
no?»
Cristicchi racconta le
foibe "Ora mi danno del fascista".
Il cantautore porta in scena un musical sugli orrori dei comunisti titini e
l'esodo degli italiani dalmati. "Sfido l'estrema sinistra: venite a vedermi",
scrive
di Simone Paliaga su “Libero
Quotidiano”.
«"Chi è Giuliano Dalmata?" si
chiede in una battuta del musical, confondendo due aggettivi per un nome e
cognome, il funzionario inviato da Roma a catalogare il materiale dei profughi
italiani provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia. Probabilmente questi sono gli
stessi pensieri che balzano alla mente quando a Roma ci si imbatte nel Villaggio
giuliano dalmata», ci racconta Simone Cristicchi. In questi giorni che la parola
negazionismo rimbalza ovunque il cantante si trova a Trieste per inaugurare il
Salone del libro dell’Adriatico Orientale Bancarella (17-22 ottobre con oltre
cento incontri) e per togliere il velo a una storia negata e dimenticata da
anni. Si tratta di un altro negazionismo di cui pochi si ricordano: l’esodo di
300 mila italiani dalle terre italiane di Istria e Dalmazia alla fine della
Seconda guerra mondiale a causa dell’occupazione jugoslava e con il beneplacito
inglese. Per riportarlo al centro dell’attenzione al Politeama Rossetti di
Trieste il 22 ottobre, con repliche fino al 27, verrà presentato in anteprima
nazionale lo spettacolo di Simone Cristicchi e Jan Bernas Magazzino 18, per la
regia di Antonio Calenda.
Cristicchi, prima che
le venisse in mente di scrivere il musical sapeva di questo episodio storico?
«Vagamente. È un argomento che
non si studia a scuola. L’ho conosciuto attraverso un libro che ho trovato a
Bologna. Si tratta di “Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani” (Mursia) di Jan
Bernas che poi è diventato il coautore del musical. Tra quelle pagine ho
trovato testimonianze di coloro che hanno vissuto l’esodo, il controesodo di
molti monfalconesi poi andati in Jugoslavia e finiti a Goli Otok… Questi fatti
nessuno li conosce».
Che cosa è il
Magazzino 18?
«Mi trovavo a Trieste per fare
delle ricerca sulla Seconda Guerra mondiale e ho sentito dell’esistenza di un
deposito dove si trovano accatastate le masserizie degli esuli, il Magazzino 18.
Dopo un po’ di traversie sono riuscito a visitarlo. E mi è sembrato di rivedere
Ellis Island, l’isola dove gli emigrati italiani venivano tenuti in una sorta di
quarantena prima di poter sbarcare negli Stati Uniti».
Perché ha pensato di
ricavare uno spettacolo dalle vicende dell’esodo?
«Perché è una storia che
merita di essere raccontata. Non è stato un lavoro di poco conto. Tra ricerche e
scrittura mi ci è voluto un anno di fatiche. Prima ho cominciato a lavorare al
testo e poi ne sono uscite anche le canzoni… Si tratta di un musical civile con
una scenografia imponente, un coro, un’orchestra. Un lavoro che senza l’aiuto
del teatro stabile non avrei potuto realizzare».
Cosa ha provato quando
è entrato per la prima volta nel Magazzino 18?
«Avevo l’impressione di
trovarmi in un luogo quasi sacro… era ricolmo degli oggetti degli italiani che
erano stati costretti a lasciare le loro terre in Istria e Dalmazia. Mobili,
poltrone, attaccapanni, tutto insieme. I numeri della tombola si trovavano a
fianco di un cuscino. Su ogni sedia era appiccicato il nome del proprietario…
era come se questi oggetti parlassero. Avevo l’impressione si essere immerso in
una atmosfera fiabesca. In questo magazzino era finito il contenuto di un’intera
città. È per questo che ho deciso di ambientare il musical dentro quelle pareti,
dentro quel Magazzino».
La canzone che lo racconta
ha scatenato una valanga di polemiche…
«Quando l’ho pubblicata sono
rimasto colpito dalla quantità di critiche dell’estrema sinistra che mi sono
piombate addosso. Se prima per i temi che toccavo mi consideravano di sinistra a
un tratto sono diventato un fascista. Io invece sono un artista, voglio
raccontare storie. Non mi interessano questi giochi politici. Mi sento libero di
occuparmi delle storie che voglio. Più mi attaccano e più io mi incaponisco.
Sfido queste persone che mi accusano. Spero vengano a teatro e si ricredano. Nel
testo non c’è niente di revanscista. È equilibrato e intende raccontare un pezzo
dimenticato della nostra storia di italiani».
Chi ha
strumentalizzato questa vicenda penalizzandone la diffusione?
«La strumentalizzazione
politica è stata fatta dall’estrema destra come dall’estrema sinistra. Negli
anni Settanta gli uni lo hanno impiegato come mezzo di propaganda mentre a
sinistra provavano a giustificarlo. Ma il giustificazionismo è pericoloso. Si
può finire con avallare qualsiasi cosa».
Cosa ha provato la
gente non ideologizzata… quella che non sta né da una parte né dall’altra?
«Una reazione di vergogna. Un
po’ quella che ho provato io quando ne sono venuto a conoscenza per la prima
volta. Ci si chiede come sia possibile che questa tragedia sia stata rimossa
dalla nostra attenzione, che se ne trovino scarse tracce anche nei manuali
scolastici…».
Ha intenzione di
continuare in questo filone artistico?
«Certo. È un linguaggio ideale
per raccontare la nostra storia. Il teatro civile attira un pubblico di
intellettuali mentre la musica è più coinvolgente. Dai bambini agli anziani,
tutti possono godere dello spettacolo e imparare qualcosa sulla storia italiana.
E se dovesse funzionare questo spettacolo potrei anche continuare, magari
occupandomi del Risorgimento».
DI FRONTE A TUTTO QUESTO
TROVIAMO UNA TV SPAZZATURA CHE CENSURA E DISINFORMA.
Quanto buonismo nelle
nostre fiction.
Alcune serie tv americane, così come i drammi storici inglesi di Shakespeare,
celebrano il potere. Ma almeno sono fatte bene e vengono ricordate. Da noi,
invece, si vedono acritiche agiografie di santi e padri della patria, scrive
Roberto Saviano su “L’Espresso”. La propaganda filogovernativa è sempre esistita
e ha sempre utilizzato i mezzi più popolari, quelli più seguiti dal pubblico,
quelli che spesso la critica di settore per snobismo o per acritico entusiasmo
non ha saputo interpretare, se non a distanza di anni, talvolta decenni, altre
addirittura a distanza di secoli. Questa riflessione parte da un articolo molto
interessante pubblicato su Jacobin (un magazine “of the American left”) tradotto
in Italia da Internazionale. “La fiction al potere” è l’argomento della
riflessione e davvero credo valga la pena provare a comprendere come tutto ciò
che sia di massa diventi immediatamente strumento utile per i governi,
soprattutto nei momenti di transizione, di momentanea crisi o quando c’è
necessità di giustificare azioni che agli occhi degli elettori potrebbero
risultare incomprensibili. L'articolo si concentra su due serie televisive
statunitensi: “24” e “Homeland”. La prima è stata prodotta dal 2001 al 2010 e
riflette “lo stile cowboy dell’amministrazione Bush”; la seconda, a partire dal
2010, - i creatori delle due serie sono gli stessi - è, invece, un prodotto
dell’era Obama. Osservare queste due serie è utile perché mostra quanto sia
determinante l’influenza delle agenzie governative statunitensi sui prodotti
culturali, che dal 2001 in poi si concentrano sostanzialmente su questioni
legate alla sicurezza nazionale. Ma come spesso accade l’osmosi è perfetta: se
da un lato le piccole concessioni da parte degli autori portano alla possibilità
di poter accedere a location altrimenti inaccessibili, dall’altro il riuscire a
inventare nuovi scenari inediti per attentati e pericoli imminenti, mette in
guardia gli apparati di sicurezza cui troppo spesso manca la fantasia per poter
prevedere il futuro. Incredibile: le fiction che suggeriscono ai governi dove
cercare il pericolo e come eventualmente neutralizzarlo. Ma la propaganda oggi
ha il sapore del complotto, solo del complotto, e quando diventa palese, tutto
il resto finisce per perdere spessore. Questo mio non è un invito ad apprezzare
la capacità che i governi hanno di piegare i prodotti culturali ai loro scopi -
vale la pena sottolinearlo -, ma piuttosto all’osservazione critica anche dei
prodotti culturali che ci piacciono cercando di comprendere se attirano la
nostra attenzione per loro qualità intrinseche o per la capacità che hanno di
intercettare lo Zeitgeist o il consenso dei governi. Insomma, non tutto ciò che
ci piace è “buono” o eticamente corretto. Non deve per questo smettere di
piacerci, ma spingerci a riflettere e a trovare gli strumenti per godere di un
prodotto sapendo che è legato al contesto in cui nasce. A questo punto cerchiamo
di recuperare, nella nostra memoria, altri lavori che sono stati propaganda ma
che il tempo ha trasformato, senza sbagliare, in opere d’arte, in capisaldi
della cultura mondiale. I drammi storici di Shakespeare sono forse l’esempio
massimo di come si sia potuto celebrare il potere dei Tudor senza blandirlo e
senza servilismo. I suoi ritratti dei Plantageneti - re, regine e nobili che
hanno governato e rovinato l’Inghilterra - sono talmente potenti che ormai è
difficilissimo distinguere la realtà dal mito. E quando, a settembre 2012 sotto
un parcheggio a Leicester, sono stati ritrovati i resti di Riccardo III, il più
terribile tra i re d’Inghilterra, ci si domandava se lo studio delle ossa non
avrebbe per caso rivelato le stesse spaventose sembianze che Shakespeare aveva
descritto nell’omonimo dramma, ovvero quelle di un uomo deforme, quelle di “un
ragno gobbo”. Che gli Shakespeare di oggi siano i creatori delle serie tv farà
sorridere, ma se pensiamo alla diffusione e alla popolarità del teatro in epoca
elisabettiana a Londra, il paragone, per quanto incredibile, potrebbe anche
essere calzante. E non è detto che nella miriade di produzioni non ce ne sia
qualcuna che verrà ricordata a distanza di secoli, magari riadattata,
attualizzata. Mi sorge invece il dubbio che nulla resterà delle tante acritiche
agiografie di santi e padri della patria diffuse in Italia a mezzo fiction negli
ultimi anni. Ritratti buonisti, senza chiaroscuri e sfumature - che dovrebbero
costituire il senso di ogni narrazione - immortalmente liquidati dalla geniale
caricatura di “Padre Frediani” che gli amanti di Boris, ricorderanno. Con amaro
piacere.
Dopo l'articolo di Roberto
Saviano: " Quanto buonismo nelle nostre fiction ", l'attore Beppe Fiorello ha
replicato inviando questo messaggio su Twitter. Pubblichiamo qui la sua
opinione.
Capisco la critica e le osservazioni sulla fiction italiana, ma come ho detto
altre volte non accetto generalizzazioni. Personalmente ho raccontato storie
importanti e talvolta scomode. Il manifesto allegato nel tweet precedente
riguarda un tv Movie di circa sette anni fa. Raccontò la storia (insabbiata per
vent'anni) di Graziella Campagna. Tutti sapevano nessuno parlava e proprio per
questo la fiction venne censurata dall'allora Ministro della giustizia che
disse: "Questa fiction turba la serenità dei magistrati". Assurdo.
Il tweet di Beppe
Fiorello: Quella censura
però non venne denunciata da nessuno. Soltanto io, il regista, la stessa Rai e
De Cataldo (che non c'entrava nulla con il progetto) lottammo affinché quella
scomoda verità andasse in onda. Furono oltre sette milioni i telespettatori che
poterono constatare quanto accadde alle spalle di una famiglia che non c'entrava
nulla con il sistema Mafia e perse atrocemente una figlia di diciassette anni.
Come questa, ho anche raccontato L'Uomo Sbagliato, la vera storia di Daniele
Baroni, dieci anni di carcere per un errore giudiziario. E senza risparmiare chi
commise l'errore. Anche qui si sapeva ma non si parlava. Solo per dire che la
Fiction italiana ha delle eccellenze, e mi piacerebbe però far notare che in
America oltre alle due serie citate nell'articolo (24
e Homeland), ce ne sono
(in maggioranza) di totale buonismo, violenza e inutilità sociale. Difendo il
mio mestiere perché lo faccio con passione e verità, ma non nascondo che la
nostra fiction ha realmente bisogno di trovare una strada nuova. Io ci sto
lavorando.
Dal governo pioggia di
milioni al cinema "rosso",
scrive
di Franco Bechis su “Libero
Quotidiano”. Ce l’ha
fatta
Walter Veltroni,
che al suo esordio da regista cinematografico ha strappato il prezioso
riconoscimento di «opera di interesse culturale» per il docufilm
Quando c’era Berlinguer
prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa del commissario
Montalbano). Non ce l’ha fatta invece
Sabina Guzzanti,
con la sua
Trattativa che purtroppo per
lei non pizzica solo Silvio Berlusconi, ma pure Giorgio Napolitano. La
sottocommissione del ministero dei Beni culturali guidato da
Massimo Bray
non le ha concesso il riconoscimento culturale, che Veltroni è riuscito a
strappare per il rotto della cuffia (17° sui 18 ammessi). Meglio di Veltroni è
riuscito un altro esordiente che fa riferimento alla medesima area
politico-culturale:
Ascanio Celestini,
che ha ottenuto anche 150 mila euro per produrre il suo
Viva la sposa.
Poco prima di Natale il ministero dei Beni culturali ha sfornato una bella
pioggia di contributi diretti e indiretti attraverso i riconoscimenti che
faranno incassare abbondanti agevolazioni fiscali (l’interesse culturale a
questo serve). Fra i fortunati che hanno conquistato anche la dichiarazione di
eccellenza che il ministero rilascia ai film di essai c’è pure
La mafia uccide d’estate
di Pierfrancesco Diliberto, in arte
Pif,
la iena nota anche per essere il compagno di Giulia Innocenzi, da anni spalla
televisiva di Michele Santoro. Il giudizio di eccellenza concesso all’opera
prima di Pif consente infatti di ottenere vantaggi fiscali diretti e indiretti e
anche un premio in denaro alle sale che lo trasmettono, calibrato sulla
lunghezza del periodo in cui esso rimane in programmazione. È un attestato che
nell’ultimo anno e mezzo è stato concesso a grandissimi registi internazionali,
come Roman
Polanski (Venere
in Pelliccia),
Quentin Tarantino
(Django),
Ang Lee
(Vita di P),
Steven
Spielberg (Lincoln),
Martin Scorsese
(Hugo Cabret)
e fra gli italiani
Paolo Sorrentino
(La grande bellezza),
Marco
Bellocchio (Bella
addormentata) e
Giuseppe Tornatore
(La migliore
offerta). Nella doppia delibera
di finanziamento della sottocommissione a dicembre ci sono per altro quasi tutti
gli habituè della cassa del ministero. Ottiene un milione di euro
Matteo Garrone
per Il racconto dei
racconti, trasposizione
cinematografica de
Lo conto de li cunti.
Novecentomila euro a
Ozpetek per
il suo Allacciate
le cinture, ottocentomila euro
a testa per firme sicure del cinema italiano come
Ermanno Olmi
(Cumm’è bella ‘a
muntagna stanotte) e i fratelli
Paolo e
Vittorio Taviani (Meraviglioso
Boccaccio). Ha ottenuto 300
mila euro anche
Carlo Verdone
(solo per la distribuzione) per il suo
Sotto una buona stella,
e centomila di più ne ha strappati
Michele Placido
con La scelta.
Non mancano
Francesca Archibugi (Il
nome del figlio), che ottiene
500 mila euro, né
Marco Bellocchio
(La Prigione di
Bobbio) e
Cristina Comencini
(Latin lover)
che hanno incassato 400 mila euro di contributi pubblici. Fra i nomi noti
strappa 350 mila euro
Abel Ferrara
per un film su Pasolini, stessa somma ottenuta dal regista più amato dalla Lega,
Renzo
Martinelli con il suo
The missing paper. Hanno
invece chiesto e ottenuto al posto dei contributi il riconoscimento di film di
interesse culturale sia
Nanni Moretti
per il suo prossimo
Margherita che
Carlo Vanzina
per Sapore di te,
appena uscito nelle sale e perfino
Enrico Vanzina
per Un matrimonio
da favola. È proprio un bello
scherzo fatto da Bray, quello di mettere appaiati sullo stesso altissimo piano
il cinema di Moretti e quello dei Vanzina. Il riconoscimento di interesse
culturale è stato ottenuto a dicembre anche da
Giovanni Veronesi
(Una donna per
amico) e da
Paolo Genovese
(Tutta colpa di
Freud). Bocciati perché è stato
ritenuto assai scarso il valore del soggetto e della sceneggiatura sia la
Guzzanti, che ha ottenuto 28 punti nella valutazione finale, ben al di sotto del
minimo di 36 utili ad essere presi in considerazione per finanziamenti e
riconoscimenti, e anche
Asia Argento
(figlia del maestro dell’horror Dario), che ha proposto il suo
Incompresa. Non è stato appunto
compreso dalla sottocommissione ministeriale di Bray, che comunque ha assegnato
a soggetto e sceneggiatura il punteggio di 34, a un soffio dalla sufficienza, e
ben superiore a quello ottenuto dall’altra silurata eccellente. Grazie a questa
piccola rivoluzione nelle classifiche tradizionali dei beniamini del ministero,
qualche maldipancia a sinistra verrà certamente vissuto. Può diventare un caso
politico quella sliding door grazie a cui è entrato Veltroni ed è uscita di
scena la comica più amata dall’ala militante. Può attutire il colpo l’occhio di
riguardo mostrato per Pif, ma non toglierà il sospetto su una bocciatura che
sembra avere una fisionomia più politica e istituzionale che stilistica.
La notizia è che Film commission della regione
Toscana è riuscita a elargire decine di migliaia di euro per finanziare il
filmino di due indagati in diverse inchieste giudiziarie, scrive
Giacomo Amadori su “Libero
Quotidiano”. Il
consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, quando apprende la
vicenda, scuote la testa: «Pensi che la Regione Toscana per mettere a posto i
conti ha chiesto ai suoi cittadini di pagare, oltre al ticket, una gabella di 10
euro, con la scusa della digitalizzazione, per tac, radiografie e altri esami
diagnostici anche se i pazienti sono poveri o malati terminali». La nostra
storia riguarda Paolo Oliverio, commercialista quarantasettenne con la passione
per gli affari con i padri Camilliani e gli 007, arrestato a novembre per
sequestro di persona nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio. Oliverio dal
gennaio 2013 è socio della Poyel produzioni, con capitale sociale di 100 mila
euro, azienda trasferita a Napoli a ottobre e infine messa in liquidazione nel
dicembre 2013, un mese dopo l’arresto di Oliverio. Nonostante la breve
esistenza, la Poyel ha fatto in tempo, si apprende da Internet, a produrre il
film «Giallo toscano», un thriller girato a Buonconvento (Siena), realizzato
insieme con l’Accademia dei risorti, società di produzione cinematografica con
sede proprio nel piccolo comune senese. Grazie al trailer si scopre pure che il
film è stato realizzato con il contributo della Regione toscana e della Toscana
film commission. Che ha versato, secondo i produttori, 30 mila euro. La trama è
semplice: una mattina di giugno due tartufai in cerca di tuberi trovano il
cadavere di una giovane archeologa. Inizia a questo punto la caccia
all’assassino. Al film ha contribuito con la propria partecipazione gran parte
della popolazione del paese. L’idea è stata del presidente dell’accademia,
Lorenzo Borgogni, per quasi vent’anni influente portavoce di Finmeccanica,
originario di Siena e residente a Buonconvento. La figlia Benedetta ha fatto
l’aiutoregista. Anche Borgogni, come Oliverio, ha avuto le sue traversie
giudiziarie: indagato nel 2011 nell’inchiesta su Finmeccanica, ha patteggiato
una pena di tre mesi di reclusione per finanziamento illecito ai partiti e resta
sotto processo per altri reati; attualmente è coinvolto anche nell’indagine
sulle presunte mazzette pagate per la fornitura degli autobus di Roma Capitale.
Tutto questo non ha impedito alla Regione Toscana di finanziare il progetto. «Ma
il film di Buonconvento con Oliverio non c’entra nulla» puntualizza Borgogni con
Libero. «È stato realizzato nel 2012 e la Poyel è nata nel 2013». Eppure nei
titoli c’è scritto che è stato prodotto dalla Poyel: «In realtà l’abbiamo
inserito in quel catalogo per vedere se si poteva domandare qualche contributo
con questa nuova società. I soldi dalla Toscana film commission li abbiamo
ottenuti come Accademia dei risorti, di cui sono presidente: 25-30 mila euro in
tutto». La toppa sembra peggiore del buco: il pluriindagato Borgogni ottiene
denaro pubblico per un’opera sul suo paese e poi con una società affidata a
Oliverio e che millanta di aver prodotto un film non suo prova a ottenere altri
finanziamenti. Ma come approda il fiscalista alla Poyel? «L’abbiamo fondata io e
il mio amico Alfonso Gallo: lui ci ha messo dentro suo fratello e io Oliverio»
risponde Borgogni. In effetti alla camera di commercio si apprende che soci al
50 per cento della Poyel sono la General holding company spa dei Gallo e Reb
venture srl, in cui sono soci Borgogni e Oliverio, che possiede il 5 per cento
delle quote. I due sono insieme anche nella System plus srl. «Nei giorni scorsi,
dopo aver letto le notizie sulle presunte attività illecite di Oliverio abbiamo
fatto dei controlli e scoperto numerose operazioni sospette e non autorizzate da
Borgogni sui conti delle due società» avverte l’avvocato Stefano Bortone,
difensore dell’imprenditore. «Per questo abbiamo presentato denuncia contro
Oliverio per appropriazione indebita». L’ennesimo colpo di scena nella vicenda
giudiziaria del fiscalista romano. Eppure i due erano diventati amici, dopo
essersi incontrati per la prima volta tre anni fa: «L’ho conosciuto nel
settembre 2010 quando ero ancora in Finmeccanica e cercavo un commercialista. Me
lo presentò come professionista dello studio Lupi, un compaesano, un ex
giocatore della nazionale di calcio che lo conosceva dai tempi di Milano»
ricorda Borgogni. Dopo poco i due si persero di vista. Per poi rincontrarsi
qualche mese più tardi: «Quando uscii da Finmeccanica Oliverio mi propose di
realizzare un’attività immobiliare perché era in contatto con questa fondazione
dei Camilliani che aveva molti appartamenti da valorizzare. Per questo abbiamo
fondato la Reb venture, io ci ho messo i soldi, lui faceva l’amministratore.
Successivamente mi ha detto che erano stati fatti dei compromessi per delle
vendite, ma io non so come sia andata a finire». I due condividevano anche un
ufficio a Roma, in via Gregoriana: «Ma io ci sono entrato una sola volta, poco
prima che arrestassero Oliverio» aggiunge l’ex portavoce di Finmeccanica.
Borgogni frequentava pure la casa del commercialista in piazza di Spagna: «Uno
splendido appartamento all’angolo con via del Babuino. Ricordo che una sera a
cena c’era pure padre Renato Salvatore (superiore generale dei Camilliani,
arrestato insieme con Oliverio per l’accusa di sequestro di persona ndr); il
commercialista nove volte su dieci parlava dei Camilliani, delle loro proprietà
a Casoria, Palermo, Messina, mi chiedeva se avessi dei manager. Gliene trovai
uno che lui, però, non ricontattò mai, perché cambiava continuamente idea. Il
personaggio era strano, io me ne accorsi dopo un po’: per esempio non si
presentava agli appuntamenti, trovando le scuse più assurde». Come quando
Borgogni gli fece acquistare una casa a Montalcino del valore di 700 mila euro:
«Io gli fissavo gli appuntamenti con l’architetto, con l’ingegnere per la
ristrutturazione e lui a volte non si presentava nemmeno». Con i commensali,
Oliverio parlava anche del suo amore per le auto: «Girava in Mini, in Range
Rover, ma aveva una grande passione per i rally. Ultimamente aveva fatto una
gara a San Marino, dove aveva rotto la macchina». Forse quella Lancia Delta che
gli investigatori sguinzagliati alle sue costole nel 2012 hanno imbottito di
microspie e che Oliverio aveva acquistato di seconda mano, pagandola 9.400 euro.
Il commercialista non aveva rapporti solo con i preti, ma anche con diversi
appartenenti alla Guardia di finanza e ai servizi segreti. «Lui mi parlava di
Giorgio Piccirillo (dal 2008 al 2012 direttore dei servizi segreti interni,
l’Aisi ndr) e citava pure Paolo Poletti (ex numero 2 dell’Aisi ndr)» ricorda
Borgogni. Due nomi già emersi nelle indagini. Ma ci sarebbero molti altri
personaggi influenti nell’agenda di Oliverio. Uno dei collaboratori del
fiscalista, arrestato con lui a novembre, davanti al gip ha dichiarato: «Io mi
fidavo di Oliverio perché quando gli squillava il telefono io vedevo nomi noti.
Vantava amicizie con A. B., ma più semplicemente con personaggi di alto rango
istituzionale, con il presidente di Finmeccanica, con Lorenzo Borgogni. (…) Mi
faceva vedere le telefonate forse per aumentare il suo credito nei miei
confronti, io ancora non so chi sia questa persona». Un dubbio che perplime pure
gli inquirenti.
Chi taglia i fondi spesi
male non è nemico della cultura.
Repubblica
invoca la protezione del cinema italiano come avviene in Francia: ma così
sarebbero finanziate solo le pellicole della solita matrice ideologica, scrive
Renato Brunetta su “Il
Giornale”. Sono tornati con i loro costumi damascati, la parrucca
incipriata, la lingua forbita. Invocano l'intangibilità di un privilegio sacro:
il cinema non si tocca! Così sabato Francesco Merlo su Repubblica ha stabilito
che esiste un tempio intangibile ai comuni cittadini che, poveretti, sono
costretti a fare i conti con il mercato globale. Gli imprenditori del tessile, e
gli artigiani del mobile si arrangino. Non pretendano di dar lezioni ai
sacerdoti del Sancta Sanctorum, il quale va preservato da mani immonde e venali:
è la cultura, figlioli! Essa va difesa dai barbari americani e asiatici, da
Hollywood e da Bollywood. La cultura, certo, va difesa. Senza cultura non esiste
neanche l'uomo come tale. Il fatto è che bisogna pur stabilire che cos'è la
cultura, e chi tra i suoi protagonisti meriti una tutela eccezionale. Ciò che è
insopportabile è l'ipse dixit. È insopportabile e niente affatto democratico che
Francesco Merlo ed altri pretendano di trasferire in Italia la legislazione
francese sul cinema, e vogliano sigillare questo privilegio nella legislazione
europea. Diciamolo: è l'eterna pretesa del carrozzone dello spettacolo e dei
suoi tenutari di erigersi da se stessi a sovrani del mondo. Lo conosciamo quel
vagone di primissima classe. Era dipinto di nero sotto il fascismo, si
ritinteggiò di rosso e si lamenta sempre perché vorrebbe più rifornimenti e più
riverenze al passaggio. Cambiano i regimi, ma non la rendita di chi vi si è
accomodato con il biglietto pagato dalla gente comune. Ragioniamo da persone
civili. Non è in discussione se finanziare la cultura: si tratta di stabilire
cosa e come. I principi sono fissati dall'articolo 9 della Costituzione, che
recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione». L'attribuzione del compito di tradurre questi principi in scelte
operative, e la fissazione della forma e dei modi di svolgimento di questo
compito, come è accaduto per diverse altre previsioni costituzionali, ha subìto
varie mutazioni. Alcune felici, altre meno. Un po' di storia. Solo nel 1975
(governo Moro-La Malfa) fu istituito un ministero con compiti specifici, il
ministero per i Beni culturali e ambientali, per volontà di Giovanni Spadolini,
cui fu affidato. Nel 1998 nacque il ministero per i Beni e le attività
culturali. Il passaggio della cura dello spettacolo da un ministero con finalità
economico-industriali importanti (sport, turismo, spettacolo) a un ministero che
doveva promuovere attività culturali non fu certamente casuale e costituì la
premessa per le successive confusioni ideologiche. È bene ripartire dalla prima
domanda: perché le arti e la cultura devono essere sussidiate? E ancora, assieme
alle arti e alla cultura deve anche essere sussidiato lo spettacolo? Quando lo
spettacolo - quello dal vivo e quello cinematografico - diventa cultura? L'arte
e la cultura sono sussidiate in tutto il mondo. Per quanto riguarda lo
spettacolo, in Italia gli aiuti statali sono anteriori all'istituzione, negli
anni Ottanta, del Fus (Fondo unico per lo spettacolo). Per quanto riguarda il
cinema, è utile oggi ricordare che nel 1963 fu introdotta una norma che
subordinava l'erogazione del sussidio al divieto di realizzare opere in lingua
inglese. La smentita venne da chi più se ne intendeva. Dino De Laurentiis ha più
volte dichiarato che la decisione di trasferire la sua attività negli Stati
Uniti fu causata da quella innovazione normativa. A questo punto s'impone un po'
di sana teoria economica. Data la distribuzione esistente del reddito, i mercati
competitivi soddisfano in modo ottimale, nella gran parte delle circostanze, le
preferenze dei consumatori. In base a ciò ci sono due argomenti principali, e un
terzo che li rafforza, per giustificare i sussidi pubblici. Il primo argomento
ha a che fare con l'efficienza allocativa dei mercati. In presenza di certe
imperfezioni che generano un'esternalità (negativa o positiva), una qualche
forma di «fallimento di mercato» conduce a un'allocazione delle risorse non
ottimale, che è l'oggetto dell'intervento pubblico correttivo. Un secondo tema
ha a che fare con l'equità della distribuzione del reddito. La tesi può essere
usata a sostegno di un intervento pubblico se si dimostra che la distribuzione
ineguale del reddito rende l'arte e la cultura inaccessibili ai poveri. Il terzo
argomento ha a che fare con il concetto di bene meritorio. I beni meritori sono
quei beni che la società ha deciso, per qualche motivo, che sia desiderabile
fornire in quantità maggiori di quelle che i consumatori acquisterebbero ai
prezzi di mercato (senza sussidio). Per i beni artistici e culturali si può
argomentare che l'ignoranza delle arti priva molte persone di esperienze da cui
trarrebbero grande giovamento. In conclusione, il sussidio pubblico è
giustificato essenzialmente dal fallimento del mercato nel produrre la quantità
socialmente ottimale di arte e cultura. Ecco perché il finanziamento delle
attività culturali pone non pochi problemi. Si può, infatti, decidere di
sussidiare l'industria cinematografica semplicemente per proteggere gli occupati
di quel settore giudicato per qualche motivo un settore sensibile, così come si
può decidere di effettuare investimenti infrastrutturali utili al settore o
sostenere scuole di formazione. Il cinema italiano sarà competitivo solo con
produttori che rischiano in proprio, non con produttori che si limitano ad
amministrare l'obolo pubblico. Il che vale in generale. Concludendo, aver
mescolato «ministerialmente» la cultura e lo spettacolo ha complicato e confuso
le cose. Ha prodotto una grande e ignobile mistificazione: ogni volta che si
chiede di tagliare il denaro speso male (e cioè di fare più efficienza,
produttività, mercato, trasparenza, qualità e merito) c'è subito qualcuno
(interessato) che ti taccia d'essere un becero nemico della cultura. Oggi la
protezione del cinema italiano, applicando la legge francese e «repubblichina»
alla Francesco Merlo, porterebbe all'aumento dei biglietti dei cinema per le
opere non europee. Con il risultato che chi non ha i gusti raffinati di
Francesco Merlo, che si imbeve di Godard e squisitezze sublimi, si vedrebbe
costretto per risparmiare a entrare nelle sale dove si cimenterebbe con qualche
sicuramente interessante opera prima o seconda di allievi selezionati dai kapò
del cinema italiano, tutti di una certa matrice ideologica... Vogliamo essere
liberi di essere noi stessi, senza essere educati dai Merlo incipriati. Come
diceva Pirandello, «gente volgare, noialtri...».
A proposito di stampa,
sinistra e finanziamento pubblico,
scrive Jacopo Venier, direttore di Libera.Tv. Solidarietà al Manifesto e a
Liberazione ma...In questi giorni in tantissime redazioni di giornali politici e
cooperativi si vivono ore drammatiche. Il quotidiano Terra è stato il primo a
cadere, poi è venuto il turno di Liberazione ed ora è il Manifesto a dover
piegarsi alla liquidazione coatta. Anche l’Unità è in pericolo mentre a Nuova
Ecologia non si pagano gli stipendi. Decine di altre testate sono sull’orlo del
baratro. E’ questa la conseguenza del taglio drastico dei finanziamenti
all’editoria deciso dal Governo Berlusconi e confermato da Monti. Con la scusa
di riordinare il settore, tagliando le “testate finte” che servono solo per
ottenere il finanziamento pubblico, si sta producendo una moria di “testate
vere” che fanno informazione spesso scomoda. Ovviamente la prima risposta
necessaria è la piena solidarietà con queste testate, con i professionisti che
le realizzano, con la loro battaglia per difendere, non solo il loro lavoro, ma
un pezzo del pluralismo e quindi della democrazia. Ieri la direttrice del
Manifesto, in un drammatico video-editoriale, si è appellata ancora una volta ai
propri lettori perché comprino il giornale in edicola ed ha dichiarato che
questa lotta per la sopravvivenza è lotta politica. Sono perfettamente d’accordo
con lei MA vorrei aggiungere alcune considerazioni di fondo. Perché siamo
arrivati a questo punto? La crisi dell’editoria di sinistra non è solo
finanziaria ma, come in qualche modo ammette Norma Rangeri, prima di tutto
politica. Esistono giornali come Il Fatto che sono nati proprio quando altri
entravano definitivamente in crisi. Le testate, in un sistema funzionante,
dovrebbero nascere e morire non perchè ricevono o meno finanziamenti ma se sono
capaci di rispondere ad un bisogno dei lettori, degli ascoltatori, dei
telespettatori, di coloro che si informano sul web. Invece nessuno affronta
questa crisi politica delle testate della sinistra quasi che sia un eresia dire
che come i partiti anche il giornalismo di sinistra ha perso nel tempo la sua
“connessione sentimentale” con il proprio popolo. Se servono appelli drammatici
per far partire sottoscrizioni, vendite ed abbonamenti il problema invece esiste
ed è grave. Parliamone. Parliamo anche poi del fatto che esistono anche
centinaia di esperienze editoriali, di redazioni formali ed informali, di luoghi
e di professionalità dove si produce informazione di qualità senza alcun
finanziamento pubblico. Questo è un punto delicato. Da anni infatti,
giustamente, le testate che rientravano nel quadro del finanziamento pubblico ci
chiedono di unirci a loro nel pretendere che lo Stato contribuisca al pluralismo
finanziandole. E’ una battaglia giusta MA solo se vediamo che forse il
finanziamento non è una soluzione ma parte del problema. Nell’immediato è
evidente che è necessario rifinanziare queste testate per impedire che
spariscano di colpo esperienze importantissime, storiche, di valore culturale
oltre che politico. Però è possibile che i giornali e le testate della sinistra
possano vivere solo con i soldi dello Stato? Vivere di finanziamento pubblico
significa essere impiccati ai governi e, nel tempo, assumere comportamenti non
sempre compatibili con la propria missione. Questo vale sia per i giornali che
per i partiti. Dice la direttrice del Manifesto che ora come non mai i suoi
lettori devono comprare il giornale. Ha ragione. Sono i lettori la forza di una
testata e questa deve rapportarsi e misurarsi con il loro numero. Tutte le
testate hanno bisogno del sostegno dei loro lettori. Ma quelle che non hanno un
finanziamento pubblico, nè possono sperare di averlo, hanno bisogno dei loro
lettori più delle altre. I lettori ed il loro numero non sono una variabile
indipendente, un dettaglio. Se una testata parla a tremila persone questo è il
suo peso. Lo dico perchè non sempre è chiaro se i giornali sono stati fatti per
i lettori, per i giornalisti che li fanno, o per chi procurava o potrà
eventualmente in futuro assicurare il finanziamento. Lo dico perchè al netto
della storia, della influenza, della presenza nelle rassegne stampa e nelle
mazzette non sempre la diffusione delle testate e dei loro contenuti è quella
che la storia ci consegna soprattutto nell’epoca di internet. Le imprese
editoriali, anche quelle di sinistra, devono avere anche una loro sostenibilità
economica. Il direttore di Liberazione Dino Greco, in una intervista che gli ho
fatto per Libera.tv, diceva che le vendite e le sottoscrizioni, pur generose,
non riusciranno mai a sostenere il giornale. Beh questo è un problema, un
problema serio che non trova risposta dal finanziamento pubblico. Se un giornale
non può vivere di vita propria è sempre esposto al rischio di doversi piegare
per sopravvivere. A Greco rispondo che in Italia esiste un mercato immenso per
la stampa di sinistra. Ci sono oltre tre milioni di persone che si considerano
di sinistra a cui vendere i nostri prodotti. Dobbiamo interrogarci su come farlo
e soprattutto su quali prodotti queste persone possano essere interessate a
comprare. Questo è molto, molto chiaro a chi deve far quadrare un bilancio senza
contare che sulle proprie risorse. Noi (testate e giornalisti) dobbiamo cambiare
e cambiare molto. Al contempo dobbiamo mandare al “nostro popolo” un messaggio
chiaro. Se la sinistra vuole la sua stampa deve sapere che se la deve pagare. Un
tempo questo era a tutti chiarissimo. Nessuno avrebbe pensato che De Gasperi
finanziasse la stampa comunista. Ed allora si facevano le feste dell’Unità, gli
abbonamenti, le distribuzioni e la raccolta pubblicitaria casa per casa,
negoziante per negoziante. Reperire soldi per la stampa era il cuore della
militanza politica. Non sarà che anche a causa del finanziamento pubblico questa
pratica, che chiariva la natura intrensicamente partigiana della professione
giornalistica, è andata perduta sostituita dalla passiva attesa dei soldi dello
Stato o dalla ricerca del sostengo di “imprenditori democratici” che poi sempre
imprenditori sono? Se non si impara da questa crisi non si imparerà mai. Per
ricominciare serve un patto per l’informazione libera e critica dove tutti,
piccoli e presunti grandi, possano stare sullo stesso piano. Bisogna che tutti
partano dal presupposto che la morte dell’altro non è uno spazio che si apre ma
una opportunità che si chiude. Bisogna che finiscano le gelosie di testata ed
anche un modo burocratico e corporativo di sentirsi giornalisti anche durante le
crisi aziendali. Per ricostruire l’informazione di sinistra serve innanzitutto
un bagno di realismo e di umiltà che consenta di costruire progetti sostenibili
anche economicamente, adeguati ad una comunicazione moderna dove, ad esempio, la
carta, pur rimanendo importante, non è più il centro. Prima di tutto però serve
una scelta politica chiara che dimostri nei fatti la natura “critica” di questa
informazione, la sua impermeabilità agli interessi economici dominanti, la sua
avversità ad ogni burocrazia politica o sindacale anche quando questa controlla
“i cordoni della borsa”. Fare informazione è battaglia quotidiana. Si può fare.
Lo spazio c’è ed il futuro anche. Basta vederlo e basta volerlo.
WIKIPEDIA DEI ROSSI E
L’EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA.
Quel manipolo di "rossi"
che soffoca Wikipedia.
Chi propone voci storiche contrarie alla vulgata di sinistra è sbattuto fuori
senza troppe cerimonie: alla faccia della conclamata neutralità, scrive
Luca Gallesi su “Il Giornale”. Catalogare il mondo e metterlo a disposizione
dell'umanità, ecco il sogno che Diderot e gli Illuministi volevano realizzare
con l'Encyclopédie, un progetto che avrebbe messo in seria discussione il sapere
e le autorità tradizionali. Quasi tre secoli dopo, sono le Enciclopedie a
capitolare di fronte ad una nuova sfida, altrettanto ambiziosa e ancora più
rivoluzionaria, che affida la catalogazione e la diffusione della conoscenza non
più a una ristretta élite di dotti intellettuali, ma a una vasta massa di
volonterosi dilettanti. Stiamo ovviamente parlando di Wikipedia, l'enciclopedia
virtuale in cui si è imbattuto chiunque abbia un minimo di familiarità con
Internet. Più simile alla Biblioteca di Babele immaginata da Borges che alla
Enciclopedia Treccani elaborata da Gentile, Wikipedia è una delle poche realtà
efficienti e gratuite che da oltre un decennio sono un saldo punto di
riferimento nel caotico mare magnum della Rete, che ha inghiottito corazzate che
sembravano inaffondabili come Second Life o Myspace e progetti simili come
l'enciclopedia multimediale della Microsoft Encarta o quella lanciata da Google
chiamata Knol e totalmente dimenticata. Concepita nel 2001 da Jimmy Wales, un
utopista smanettone appassionato di Ayn Rand, e da uno scettico dottorando in
filosofia all'Università dell'Ohio, Larry Sanger, Wikipedia prende il nome da un
termine hawaiano, wiki, che significa veloce; sin dall'inizio si offre come
piattaforma di contenuti prodotti e curati da chiunque ne avesse accettato le
regole fondamentali, conosciute come i Cinque Pilastri: niente ricerche
originali, punto di vista neutrale, verificabilità delle fonti, e due
comandamenti che riecheggiano quelli di Steve Jobs: be bold, ovvero «sii
audace», e «ignora tutte le regole». In questo caso, la differenza sta nel fine,
che non è, come per Apple, il profitto mascherato da raffinatezza, ma la
catalogazione e la diffusione di tutto lo scibile umano senza scopo di lucro. Il
successo è immediato, e supera ogni rosea previsione: aperta a tutti e con la
neutralità dell'informazione come requisito fondante, Wikipedia si diffonde a
macchia d'olio, diventando la prima enciclopedia al mondo per mole di
informazioni e lettori, mentre progetti di ben altre ambizioni e solidità
innalzano bandiera bianca, come l'Encyclopedia Britannica, che nel 2012 ha
rinunciato alla versione cartacea, o la nostra Treccani, che ha addirittura
abdicato al suo ruolo guida, rimandando i suoi lettori online ad alcune voci di
Wikipedia. Oggi, la libera enciclopedia del web è pubblicata in 285 lingue,
comprese quelle morte come il latino, o artificiali come l'esperanto e il
klingoniano, noto solo agli aficionados di Star Trek. La sola versione in lingua
inglese, se stampata, oggi occuperebbe 2000 volumi come quelli di
un'enciclopedia classica, con un indice superiore ai quattro milioni di voci,
quasi tutte attendibili, grazie al lavoro costante dei collaboratori e degli
amministratori, volontari eletti dalla comunità e preposti al controllo delle
singole voci. Alla storia di questo progetto è dedicato un brillante saggio:
Wikipedia, di Emanuele Mastrangelo ed Enrico Petrucci, edito da Bietti (pagg.
394, euro 16). Oltre a descrivere accuratamente la storia di Wikipedia, il libro
getta qualche ombra sugli amministratori della versione in italiano, che, invece
di essere gelosi custodi della neutralità del sapere, sono zelanti vestali del
politicamente corretto. Come ha provato sulla propria pelle uno degli autori,
chi non si conforma alla vulgata resistenziale, anche se è un ricercatore
laborioso e affidabile, viene inesorabilmente espulso dalla comunità dei
collaboratori italiani. Un piccolo ma agguerrito manipolo di amministratori fa
catenaccio contro le forze oscure della reazione in agguato, vigilando contro la
pubblicazione di versioni che possano anche lontanamente mettere in dubbio
l'egemonia culturale della sinistra, vedi le voci sull'Attentato di via Rasella
(derubricato a Fatti di via Rasella), per non parlare della Guerra civile in
Italia 1943-45, realtà inconcepibile per chi conosce soltanto la gloriosa
ribellione del popolo italiano contro la sanguinaria tirannide. I gendarmi della
memoria agiscono come la psicopolizia descritta da Orwell in 1984, impegnata a
riscrivere la storia; ma i nostalgici degli Anni Settanta, che, per fortuna,
sopravvivono quasi solo su Internet, non sono gli unici colpevoli, dato che
sarebbe facile impegnarsi a contrastarli con successo, come dimostrano i due
autori. Purtroppo, anche in Rete, come sui grandi giornali e nelle televisioni
nazionali, la cultura, se non è allineata, non interessa quasi a nessuno: è
talmente noiosa.
Come taroccare una voce di
Wikipedia.
Uno degli amministratori italiani racconta come aggirare le regole dell’opera
collettiva più influente del pianeta Minare la credibilità dei lemmi sgraditi e
pilotare il voto democratico che decide i contenuti? Si può fare così...continua
Alessandro
Gnocchi su “Il Giornale”. Wikipedia è l’enciclopedia più utilizzata al mondo (60
milioni di accessi al giorno al sito). Multilingue, on line e gratuita è nata il
15 gennaio 2001. Si basa sul principio che il contenuto, libero, è generato sul
web dagli utenti stessi. Jimmy Wales, uno dei fondatori, la descrive «come uno
sforzo per creare e distribuire un’enciclopedia libera della più alta qualità
possibile ad ogni singola persona sul pianeta nella sua propria lingua». Grazie
a Internet. I colossi di carta, già in difficoltà, sono andati in tilt.
Semplicemente non c’è competizione: qui non si spende un centesimo ed è tutto a
portata di clic. La versione italiana accoglie oltre 670 mila voci, quella in
lingua inglese raggiunge i 3 milioni. Le gerarchie sono ridotte al minimo, per
non dire inesistenti. Chiunque può contribuire a creare o modificare una voce.
La certezza che, nonostante tutto, ciò non arrechi danno all’accuratezza
dell’insieme poggia su una doppia convinzione: il sapere collettivo è superiore
a quello individuale; la quantità, superata una certa soglia di informazioni, si
trasforma automaticamente in qualità. Molto si è discusso di questi e altri
aspetti per così dire «ideologici». Meno noti invece sono i meccanismi che
regolano il funzionamento di Wikipedia. Ancora meno note sono le persone che
oliano l’ingranaggio e mantengono operativa la macchina. Qualche notizia
preliminare. Come abbiamo detto, chiunque può scrivere una voce di Wikipedia. Il
contributo deve rispettare alcune caratteristiche, che vanno dalla neutralità al
corredo di una documentazione sufficiente ad attestarne la credibilità, se non
la veridicità. Una voce ritenuta insufficiente per qualsivoglia motivo può
essere proposta per la cancellazione. Se nessuno protesta, dopo sette giorni, la
voce scompare. Altrimenti segue dibattito in rete, al termine del quale si vota.
Il quorum è di almeno 10 partecipanti. Per procedere all’eliminazione, è
necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei partecipanti. Come
vedremo, centrale è la figura dell’amministratore al quale tocca il compito di
«sorvegliare» le voci, segnalare lacune, dirimere le questioni. Per diventare
amministratore non è richiesto alcun requisito particolare. È necessario solo
candidarsi ed essere votati dagli utenti (il quorum è variabile e dipende dal
numero dei votanti alle precedenti elezioni, la maggioranza richiesta per
farcela è di 4/5). Un amministratore può decadere in due casi: se latita troppo
a lungo oppure se gli utenti lo ritengono inadattato alla funzione e lo
«abbattono» con la solita votazione. La versione italiana dell’enciclopedia
dispone di 102 amministratori. Solo sei sono donne. La maggioranza ha tra i 18 e
i 35 anni circa, benché ci siano alcuni ultracinquantenni. (Amministratori a
parte, il decano di Wikipedia.it ha 87 anni, si chiama Antonio Angelo Caria e ha
raccontato la guerra nelle pagine dell’enciclopedia:
wikipedia.org/wiki/utente:Caria Antonio Angelo/Racconti). Sembra il paradiso
della democrazia ma è davvero così? L’enciclopedia è imparziale? È possibile
taroccare una voce? Le votazioni sono trasparenti? Le «sentenze» di vita o di
morte si possono influenzare? Ci dà una mano a rispondere uno degli
amministratori italiani, dal quale siamo stati contattati e del quale
rispettiamo la richiesta di rimanere anonimo. Lo chiameremo, per comodità,
«Admin». Il primo punto, nonostante le apparenze, è forse il meno interessante.
No, l’enciclopedia non è imparziale. Ma quale opera dell’ingegno (individuale o
collettivo) è realmente imparziale? Forse nessuna. Per rendersene conto basta
fare una rapidissima verifica su voci politicamente sensibili ma non troppo
legate all’attualità e quindi non frequentatissime. Difficile «sbarellare» nella
voce dedicata a Silvio Berlusconi, presumibilmente molto letta e quindi
sottoposta a continua verifica. Facile invece «sbarellare» nelle voci riservate,
ad esempio, al liberalismo, al libero mercato, al neoliberismo, a economisti
come Milton Friedman e così via. Qui emerge subito, neanche troppo camuffata,
l’avversione al capitalismo così radicata nel nostro Paese. Comunismo e dintorni
godono di un altro trattamento. «Se si dà un’occhiata ai profili degli
amministratori in carica - spiega Admin - si noterà una seria maggioranza di
sinistra con molte punte di “laicità” che sfocia spesso e volentieri
nell’anticlericalismo». E ancora: «Quando venne eletto un candidato
dichiaratamente cattolico, ci fu una pioggia di osservazioni sulla sua fede. Non
è l’unico esempio di candidato rifiutato perché cattolico». In un caso la
motivazione del voto negativo era questa: «Dichiara (il candidato, ndr) nella
pagina utente di adorare uno Stato straniero che io invece respingo come nemico
e invasore». Lo Stato nemico, ovviamente, è il Vaticano. «Notare che l’autore di
questo commento è una delle figure di punta dell’UAAR (Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti, ndr), attivo in Wikipedia nella propaganda
dell’anticlericalismo. L’UAAR per lungo tempo ha avuto molti utenti naturalmente
impegnati a estirpare voci cattoliche o a modificare in senso anticlericale voci
storiche sulla Chiesa». Forse è troppo dire che l’enciclopedia è schierata a
sinistra: «La maggior parte degli utenti registrati è di sinistra ma per fortuna
la nascita di quella porcata nota come ita.anarchopedia.org ha tolto un sacco di
gente di torno. Pochi sono gli utenti palesemente schierati con Berlusconi o con
il centrodestra, e purtroppo spesso sono dei perfetti imbecilli, talvolta
buttati fuori perché utilizzatori di tecniche degne del peggior “troll”». Per i
non addetti ai lavori: il “troll” nelle comunità digitali è un tizio che
interviene a sproposito e con insulti. Il suo scopo è fomentare l’inimicizia e
alla lunga rendere infrequentabile un sito. Al di là di questo, dice Admin, «il
problema è che per ottenere di inserire o togliere un pezzo controverso
all’interno di una voce, serve il consenso. Ed essendo molti utenti di sinistra,
domina una certa vulgata». Comunque l’argomento di maggior dibattito sembra
essere un altro: «Essendo italiani, gran parte delle discussioni verte sul
calcio. Alcuni utenti insistono a inserire i curricula di calciatori che hanno
giocato anche solo cinque minuti di Serie A. In politica credo sia inutile fare
un elenco. Ai tempi degli insulti della Guzzanti si è aperta la sagra
dell’aggiungere/togliere i riferimenti a Mara Carfagna. Più di recente si è
discusso molto del caso Marrazzo. La voce su Noemi Letizia è stata cancellata ma
i dipietristi di wiki hanno ottenuto che le discussioni sul caso rimanessero
registrate. La religione è un altro argomento scottante, anzi il cattolicesimo
dal momento che delle altre religioni pochissimi si occupano. Sempre calda la
voce su Pio XII e l’Olocausto». Nessuno come s’è detto ha un reale potere di
veto o di censura. «Ufficialmente no, o almeno non è codificato da alcuna parte.
In teoria funziona così: se uno trova una voce che non funziona può apporre
delle stringhe di testo che spiegano la natura del problema. Ad esempio: non si
capisce dove stia l’enciclopedicità; va aiutata, voce troppo smilza e quasi
incomprensibile; va controllata, dati o altro non tornano; non ci sono fonti di
supporto a quanto scritto. Poi c’è questa stringa: è di parte e quindi va
riequilibrata. E qui iniziano i guai. Trovo molto divertente la stringa che
introduce la voce “persecuzione dell’omosessualità in URSS”. Si legge: “La voce
contiene una serie di informazioni sulla persecuzione degli omosessuali in URSS
senza avere nemmeno una fonte a sostegno dei concetti espressi; inoltre i
comunisti vengono mostrati come crudeli omofobi”. Poveri cari, questi comunisti.
Ma se si va a vedere la pagina utente di chi ha messo la stringa che mina la
credibilità della voce, si scopre che si dichiara ateo, anticlericale e...
comunista». Già ma poi la democraticità della votazione ripara ogni torto e
riporta l’equilibrio... «Le regole sono facilmente aggirabili. Non si può fare
“campagna elettorale”, nessuno può andare a chiedere a un altro utente di
aiutarlo a salvare o bocciare una voce. È espressamente vietato. Peccato
esistano le mail, i blog, i forum, le chat. Di fatto alterare quorum e consenso
è facilissimo. Compito dell’amministratore è cassare i voti ottenuti in questo
modo. Il problema è chiaro: se i membri dell’UAAR, o viceversa i cattolici, si
mobilitassero e facessero gruppo per eliminare le voci che non piacciono loro,
addio equilibrio ed enciclopedicità. Qualche tempo fa si aprì la votazione per
cancellare la voce No Berlusconi Day, sbilanciata e affetta da “recentismo”,
cioè troppo schiacciata sull’attualità per essere enciclopedica. Grazie al tam
tam via Facebook ci fu un’impennata di votanti, tutti sfavorevoli alla
cancellazione. Alcuni tornavano su Wikipedia dopo mesi di assenza. Altri si
registrarono appositamente (e i loro voti furono cassati)». Complessivamente,
dal quadro disegnato da Admin appare chiaro che la verità storica non si può
decidere per alzata di mano. Wikipedia non si divide per comunità nazionali ma
linguistiche. «A Wikipedia.it collaborano anche vari utenti svizzeri del Canton
Ticino. Uno dei problemi di Wikipedia.es, quella di lingua spagnola, è che gli
utenti vivono su sponde diverse dell’Atlantico, si esprimono in modo diverso e
hanno mentalità diverse. Nessuno gestisce ufficialmente i rapporti tra le varie
comunità, che spesso seguono principi diversi: quella di lingua inglese è di
manica larga e accetta voci di ogni tipo, per questo ne ha tre milioni, quella
di lingua tedesca è rigorosa. Esistono però le varie Wikimedia, associazioni no
profit che hanno il compito di promuovere la cultura libera e i progetti gestiti
dalla Wikimedia Foundation. Progetti sui quali non hanno alcun controllo.
Wikimedia è divisa su base nazionale. Comunque non esistono vertici né assoluti
né relativi». L’ultima curiosità: qualcuno guadagna attraverso Wikimedia o
Wikipedia? «Ufficialmente non è possibile. Ci sono pettegolezzi relativi alla
organizzazione di alcuni eventi o convegni ma sono chiacchiere non documentate.
Il bilancio delle varie Wikimedia comunque è pubblicato in rete. Nel caso della
Wikipedia vera e propria, credo sia difficilissimo guadagnare qualcosa, e non ne
ho mai avuto notizia».
L’egemonia culturale della
Sinistra,
scrive Luciano Atticciati. Il nostro Paese è vissuto per decenni sotto la
cosiddetta egemonia culturale della Sinistra, una specie di lunghissimo
dopoguerra che ha portato gli uomini di cultura ad assumere posizioni e
atteggiamenti anomali e forzati per dimostrare la validità di certe questioni
decisamente insostenibili. Per costoro il fascismo era stato molto peggiore del
comunismo, nonostante che tutto facesse pensare che il regime totalitario creato
da Mussolini non fosse così coercitivo come quello dell’Unione Sovietica o della
Cina Popolare, i crimini contro l’umanità commessi dai regimi comunisti erano
ben poca cosa rispetto a quelli commessi dai nazisti, le atrocità commesse dagli
Jugoslavi verso il nostro popolo erano decisamente un argomento tabù, così come
l’idea che gli uomini della Resistenza avessero commesso degli eccessi.
Ovviamente per costoro la classe borghese costituiva qualcosa di spregevole, e
aveva gestito il nostro Paese nel peggiore dei modi, il futuro apparteneva ad
altre ideologie che avrebbero stabilito un mondo nuovo, decisamente superiore al
presente o al recente passato ritenuto di scarso valore. L’egemonia culturale
della Sinistra aveva naturalmente il sostegno degli intellettuali, ma trovava un
altrettanto forte sostegno nelle istituzioni, che nei loro proclami ricordavano
costantemente le nefandezze della Destra. Sebbene il partito di maggioranza, la
Democrazia Cristiana esercitasse il suo potere di governo, nel campo culturale
brillava per la sua assenza, o peggio per il suo stato di sudditanza nei
confronti dell’agguerrita opposizione comunista. A rileggere oggi certi discorsi
c’è da rimanere inorriditi, ma a quei tempi tutto era permesso, e nessuno poteva
opporsi ai profeti del mondo migliore. I dibattiti culturali sui mass-media
avvenivano rigorosamente fra esponenti di Sinistra, le librerie ospitavano solo
libri di Sinistra, le poche voci dissonanti venivano messe a tacere con giudizi
pesanti. Due casi sono degni di nota, quello di Montanelli, isolato come un
infetto di un terribile morbo, e Renzo De Felice, lo storico che aveva azzardato
a parlare del fascismo come fenomeno dei ceti medi e teso alla mobilitazione
delle masse. I suoi denigratori coniarono addirittura un termine estremamente
infelice per indicare le sue posizioni, «revisionista». I revisionisti erano in
precedenza definiti i comunisti non allineati, considerati eretici dai marxisti
ortodossi. Gli attacchi contro uno dei maggiori storici italiani da parte di
intellettuali e politici furono estremamente pesanti. L’antifascismo dominante
non permetteva che si potesse esprimere il minimo giudizio anche vagamente non
accusatorio nei confronti di quel regime. Il mondo comunista aveva soppresso
qualsiasi forma di libertà e aveva sottratto ai ceti operai di cui si
considerava formalmente protettore, gran parte dei loro diritti. Non ci voleva
molto a comprendere che il blocco dei Paesi comunisti produceva una eccezionale
quantità di armamenti ma teneva la popolazione ad un livello di vita da Terzo
Mondo. Nonostante ciò giovani entusiasti ed intellettuali proclamavano che la
gente sotto quei regimi disponeva di un benessere, forse diverso dal nostro, ma
comunque di una situazione felice. Fino al 1956, cioè fino a quando Kruscev non
rivelò i crimini commessi da Stalin, gran parte della cultura marxista
proclamava che i gulag non esistevano (vedi anche il caso Kravcenko), che erano
una semplice invenzione della propaganda capitalista. Nel periodo successivo si
parlò allora di «contraddizioni del mondo comunista», come dire che il terrore
di massa era un semplice accidente storico, un limitato e inevitabile male che
non pregiudicava la grandezza di quei regimi. Tutto il mondo doveva comunque
essere grato all’Unione Sovietica per aver sconfitto, a prezzo di enormi
sacrifici, il nazismo, ovviamente si taceva sul «Patto Molotov-Ribbentrop»,
sulla duplice aggressione alla Polonia, e sull’eccidio di Katyn. Negli anni
Cinquanta sorse infine un ambiguo movimento pacifista, i Partigiani della Pace,
che nonostante tutte le guerre e le minacce che provenivano dall’Unione
Sovietica riteneva il pacifismo coniugabile con il comunismo. Anche personaggi
di spicco del mondo europeo ne fecero parte. Non molto tempo dopo si scoprirono
i legami dei vertici dell’organizzazione con il blocco sovietico. Uno spazio
particolare nella cultura degli anni Sessanta fu dato alla questione Vietnam,
vittima non si sa su quali basi di un’aggressione americana. La principale
battaglia combattuta in quell’infelice Paese, avvenne nel ’68 a Khe San fra
unità regolari nord-vietnamite che erano penetrate nel territorio sud-vietnamita
e avevano circondato una base americana, eppure la Sinistra continuava a
ripetere che principali protagonisti di quel conflitto erano i Vietcong, cioè
comunisti locali insofferenti al regime alleato dell’odiato Paese capitalista.
Analogamente si taceva sul fatto che fosse stato Kennedy, uomo della Sinistra,
ad iniziare l’impegno americano a difesa del governo sud-vietnamita. Quando dopo
il 1975 si scoprì la durezza e la crudeltà del comportamento dei regimi
comunisti di quell’area geografica, la questione venne messa presto a tacere.
Nello stesso periodo molti vedevano nel comunismo cinese, una forma di autentico
comunismo «popolare» contrapposto a quello «burocratico» sovietico. I milioni di
morti che avevano accompagnato quella triste rivoluzione, ammesso che potesse
avere senso parlare di rivoluzione parlando del regime cinese, costituivano un
normale inconveniente tipico di qualsiasi fenomeno storico. Le due questioni si
inquadravano all’interno della cosiddetta guerra fredda. Le origini della guerra
fredda apparivano decisamente confuse, forse era stato il discorso sulla
«cortina di ferro» di Churchill (1946) a scatenarla, o forse «l’accerchiamento
capitalista», anche se il mondo comunista appariva un po’ troppo vasto per
essere considerato accerchiato. L’umanità si trovava a vivere una guerra in cui
era scivolata senza sapere nemmeno il motivo, e il muro di Berlino suo simbolo,
era sorto a causa di «reciproche incomprensioni», non dall’attività deliberata
di un regime totalitario. Coronamento di tali discorsi era naturalmente
l’antiamericanismo, il governo degli Stati Uniti controllava non si sa come, né
in che modo le nostre scelte politiche. Se le Sinistre non riuscivano a
conquistare il potere nel nostro Paese, ciò era dovuto non al fatto che i ceti
medi preferissero altre forme di governo, e che una parte della stessa Sinistra,
socialdemocratici e repubblicani avessero scelto il sistema di valori
occidentale, ma a invisibili condizionamenti operati nelle forme più
incomprensibili. Forse non ci voleva molto a comprendere le assurdità e le
palesi falsità di quella cultura, bastava leggere le opere di uno storico come
Luigi Salvatorelli sul Novecento, o quelle di Gaetano Salvemini che aveva messo
in luce come nell’affermarsi del fascismo avessero pesato le violenze scatenate
nel ’19 dall’estrema Sinistra. Anche gli storici fecero la loro parte di
confusioni, molti storici di area comunista limitavano lo studio della storia
all’esposizione di enunciazioni programmatiche, senza mai arrivare ai
comportamenti reali dei governi e delle forze politiche. Un testo ritenuto
importante di Enzo Collotti sulla storia della Germania (1968) considerava
irrilevante l’assorbimento forzato del partito socialista da parte di quello
comunista nella DDR, i Tedeschi sostanzialmente avevano accolto liberamente quel
tipo di regime. Lo storico comunista forse più autorevole, Gastone Manacorda,
ammetteva esplicitamente le esigenze della politica nello studio storiografico.
Sembrava che il mondo dovesse vivere a tempo indeterminato in quella forma di
forzatura mentale, ma la storia («l’astuzia della ragione» avrebbe detto Hegel)
alla fine operava. A metà degli anni Ottanta il comunismo implodeva non a causa
di un attacco militare, o di un oscuro complotto, ma per l’azione di quei popoli
che lo vivevano. Il mondo di bugie aveva una falla, e da qui al crollo il passo
non era lontano. Alla fine anche gli uomini di cultura di Sinistra più avveduti
(tra i quali Giampaolo Pansa) hanno dovuto ammetterlo, i teoremi non stavano in
piedi, erano costruzioni fondate sul nulla. Oggi la storiografia marxista è
quasi inesistente, solo irriducibili dogmatici ci vengono a proporre le loro
tesi un po’ trite, uno di questi è Toni Negri, convinto che il nemico
capitalista trami nell’oscurità, alla stessa maniera con cui i nazisti si
convincevano dell’esistenza del complotto giudaico-massonico. Dietrologi e
complottisti sparano ancora le loro ultime cartucce, e se i fatti storici
smentiscono tesi gloriose, per costoro si può ricorrere sempre a fatti non
dimostrati né dimostrabili. Se il mondo della cultura oggi ha messo da parte la
cappa soffocante dell’egemonia culturale della Sinistra, tuttavia in quella
parte della società più portata a credere acriticamente nei grandi illuminati
che nelle proprie capacità di discernimento, ancora continua a resistere un modo
di pensare decisamente impossibile da comprendere. Le persone che in un certo
senso desiderano ingannarsi non sono assolutamente scomparse.
Non se ne può
più dell’egemonia culturale della sinistra, ma Berlusconi in 20 anni cos’ha
fatto?,
Scrive Mattia Feltri su “Tempi”. La superiorità antropologica della sinistra,
rappresentata dalla Repubblica delle Idee, ci ha stufato ma la destra non è
riuscita ad offrire un’alternativa. Con una spettacolare doppietta, giorni fa il
Foglio di Giuliano Ferrara ha introdotto la questione. Da principio Andrea
Marcenaro, nella sua rubrica quotidiana, immaginando quella catasta
d’intelligenza riunita a Firenze dalla Repubblica delle Idee – naturalmente con
la “i” maiuscola – e diciamo Alessandro Baricco, Umberto Eco, Roberto Saviano,
Gustavo Zagrebelsky eccetera, eccetera, col formidabile peso della cultura non
meno che enciclopedica: tutti a convegno per dire “Berlusconi merda”. Due
mattine dopo, nella pagina della posta, il direttore spendeva una trentina di
righe nell’esprimere il fastidio e la noia mortale per la dottrina dell’ovvio,
del bello e del buono, incontrovertibile come l’espressione “la mafia è
cattiva”, un piccolo manicheismo calzante a tutte le taglie, un bell’alibi per
dirsi l’Italia migliore, e però – concludeva Ferrara – questa è la Repubblica
delle Idee «ma se cominciassimo a imparare qualcosa, da come si sta a tavola a
come si legge un buon libro, quello no?». Qui ognuno deve fare i conti con la
libreria che ha in casa e le macchie di sugo che ha sulla camicia, ma se si
pensa a una colpa collettiva, quella ascrivibile alla destra italiana – a
qualsiasi destra imposta dal bipolarismo, post-missina, socialista
anticomunista, liberale, democristiana, puramente reduce del pentapartito o
leghista – è una colpa totale e senza perdono. Si sono spesi vent’anni, quelli
trascorsi dall’appoggio di Silvio Berlusconi alla candidatura di Gianfranco Fini
per il Campidoglio (autunno 1993), a contrastare colpo su colpo la cultura
progressista nei suoi numerosi ed eterogenei sacerdoti, da Alberto Asor Rosa a
Roberto Benigni, da Paolo Flores d’Arcais a Corrado Guzzanti, da Barbara
Spinelli a Nanni Moretti. L’Italia descritta dall’utopismo pop di Walter
Veltroni o dal moralismo univoco di Michele Santoro, dal femminismo saccente di
Natalia Aspesi o dal giustizialismo rancoroso di Marco Travaglio, è l’Italia che
sulla pelle di destra faceva spuntare foruncoli. C’era e c’è un’allergia esibita
per la superiorità antropologica che la sinistra si è autoattribuita e per la
quale si concede un vitalizio di autoassoluzione. Bene, tutto questo è normale,
è condivisibile. Orrore per il manicheismo, per l’antipolitica consolatoria, per
la mitologia della società civile, per il pacifismo ipocrita, per l’antifascismo
eterno e bolso che marchia di filofascimo chiunque non lo abbracci, per il totem
della Costituzione, per il puritanesimo febbrile. Orrore per la classificazione
sprezzante dell’avversario, che deve giusto scegliersi la casella: mafioso?
Tangentaro? Stragista? Razzista? Servo? Ladro? Però.
Qualcosa oltre l’antitesi?
Però, oltre all’antitesi, la destra che cosa ha proposto? Oltre all’antitesi
automatica, immediata, di istintivo riflesso, qual è l’Italia alternativa che si
è immaginato e si è cercato di costruire? Berlusconi, i suoi ormai dispersi
alleati, i suoi precari luogotenenti, le sue televisioni, le sue case editrici,
quale tipo di paese hanno delineato in questi vent’anni? E, evitiamo equivoci,
non si sta dicendo il progetto di Italia anche abbastanza preciso venuto fuori
da settanta o ottantamila comizi. Quell’Italia lì, di cui Berlusconi parlò da
Arcore con la calza sulla telecamera, quella della meritocrazia, della sana
competizione, dello Stato leggero, antiburocratica, del riequilibrio dei poteri
incrinato da Mani pulite, della riduzione fiscale, anticorporativa, federalista,
ecco, quell’Italia è rimasta nelle promesse e nei sogni. Morì nel medesimo
istante in cui, vinte le elezioni del 1994, al ministero dell’Economia andò
Giulio Tremonti, prelevato dal Patto Segni, e non il liberale Antonio Martino
parcheggiato agli Esteri. Traduzione: morì di parto. Si sta dicendo, in venti
anni di cui la metà trascorsi al governo del paese, quale altra Italia è venuta
fuori? In che cosa è cambiata? Nel conflitto permanente col centrosinistra, il
centrodestra quale visione ha opposto, fuori dal recinto del palco? Quale è
l’assetto istituzionale a cui si è lavorato per rendere il paese aggiornato alla
Seconda repubblica, all’Europa, alla velocità d’esecuzione imposta ai governi?
Come sono cambiati i rapporti di forza fra esecutivo e legislativo? E
Berlusconi, affranto dalla macchinosità con cui si arriva all’approvazione delle
leggi, infine annacquate, quali contromisure ha studiato per accelerare e
affilare la pratica? Se la soluzione impercorribile è ottenere il 51 per cento
nelle urne, quale disegno diverso ha tratteggiato? Come è stata rimodellata la
Costituzione per esempio davanti alla mutata legge elettorale, col referendum
per il maggioritario del 1993, e alla mutata prassi? È entrata nella Carta
quella correzione minima secondo cui il premier, come è stato di fatto, viene
eletto direttamente dal popolo e, caduto lui, si torna a votare? Quale struttura
economica si è fatta avanti? Non certo la rivoluzione, ma il riformismo liberale
come si è concretizzato? Come si sono combattute le corporazioni? Come si sono
affrontati i privilegi di casta? Come si sono liberalizzate le professioni? Come
si sono snellite le procedure ministeriali, quelle del credito, quelle della
tassazione? Come si è allentata la pressione fiscale? In quale modo si è
pensato, se non di contrastare ferocemente l’evasione fiscale, di riconquistare
gli evasori alla causa della contribuzione? Come si è ripensata la pubblica
amministrazione nel suo complesso, compresa la riduzione dello sterminato
personale e l’aumento della produttività? Quali sono stati i provvedimenti
strutturali di sostegno all’impresa tanta cara al leader dei conservatori? Come
si è inciso sul cuneo fiscale? Come si è agevolato l’export? Che cosa si aveva
in testa e come lo si è tradotto nei fatti?
Potere politico e giudiziario.
Come si è messo mano alla giustizia? Dopo la notte in cui la Costituzione venne
modificata con la cancellazione dell’immunità parlamentare, che cosa si è fatto
per irrobustire il potere politico indebolito davanti al potere giudiziario? È
arrivata la separazione delle carriere? È stato equiparato il ruolo del
magistrato dell’accusa e quello dell’avvocato della difesa? Dopo i problemi
emersi con Mani pulite, la questione della carcerazione preventiva come è stata
affrontata? E quella dell’affollamento delle carceri? L’inappellabilità per i
pm? Qual è stato il sistema di giustizia a cui si è lavorato per offrire una
proposta più appetibile di quella propagata da Antonio Di Pietro, Giancarlo
Caselli, il Fatto quotidiano? Quali studiosi hanno delineato un sistema che
andasse oltre le decine di leggi ad personam buttate lì ogni volta che un
processo ad personam intentato al sire di Arcore necessitasse di una
contromisura? Oggi, rispetto al 1993 e al 1994, su quali ipotesi stiamo
ragionando? Qual è la Rai voluta dal centrodestra? Qual è la tv pubblica che
Berlusconi intende offrirci? Deve avere ancora tre reti? Deve avere ancora reti
di riferimento di un partito o di quell’altro, in base a chi sta al comando e
chi all’opposizione? Deve continuare a essere lo specchio di Mediaset – e
viceversa – con una rete finto paludata (Rai1 e Canale 5), una rete finto
giovane (Rai2 e Italia1), una rete di vera militanza (Rai3 e Retequattro)? Come
si è pensato di elevare il concetto di servizio pubblico? Che tipo di palinsesti
si ritiene di promuovere per uscire dalla retorica tanto detestata? Che cosa
dovrebbe raccontare la Rai per superare gli schemi così esecrati del talk show
alla Giovanni Floris e dell’intrattenimento alla Dario Vergassola? Se davvero
quello è l’orrore, la cultura dirimpettaia di centrodestra quali giornalisti o
comici ha individuato? Chi si è incaricato di raccontare il mondo da un altro
punto di vista, e non in forma belligerante, ma dialettica? Quale mondo della
cultura è nato in vent’anni attorno all’esperienza politica di Berlusconi? Il
Sanremo di Tony Renis? Le canzoni di Van de Sfroos? Le fiction di Renzo
Martinelli? Come si sono aiutati i registi che intendevano emergere senza
sposare una causa ideologica o di schieramento? E i giovani musicisti? Come si è
pensato di liberare energie creative per evitare che restassero prigioniere
dell’industria della propaganda di sinistra? Come si è adeguata la politica
editoriale? Si sono organizzati festival o premi aperti alle voci non scontate?
In sintesi, quali rimedi sono stati adottati all’egemonia culturale di sinistra,
che non fosse una reiterata e sguaiata denuncia, o qualche vaga contrapposizione
muscolare e dunque sterile? Il modello eccellente della sanità lombarda, come è
stato portato nel resto d’Italia? Quale studio ha ricondotto il welfare fuori
dall’assistenzialismo? Quale modello di città si è fatto avanti? Quale
architettura? Quale urbanistica? Quale politica energetica? Quale tipo di scuola
(a parte gli sforzi di Mariastella Gelmini)? Come sono stati introdotti inglese
e informatica alle elementari? Come si è affrontato il baronaggio nelle
università? E come l’università di destra si è messa alle calcagna
dell’università anglosassone? Quale politologia si è sviluppata? Quale
storiografia? Quale informazione? Insomma, l’Italia che usciva dal pantano
finale della Prima repubblica, e che era l’Italia diversa da quella difesa dai
postcomunisti e dai loro alleati, che Italia era? E che Italia è? Dov’è?
Bene, allora cari italiani:
TUTTI DENTRO, CAZZO!!
SIAM TUTTI FIGLI DI
FASCISTI. I VOLTAGABBANA E L’INTELLETTUALE COLLETTIVO.
Il mito sinistro
dell'intellettuale collettivo. Da Gramsci passando per il Sessantotto ha
prevalso sempre il pensiero organico. Che ha incantato il ceto medio, scrive
Marcello Veneziani su “Il Giornale”. Ma cos'è poi questa famigerata egemonia
culturale? Quando è nata, come è cresciuta, come si manifesta oggi? Dopo la
denuncia del filosofo cattolico Giovanni Reale sulla dittatura culturale
marxista in Italia poi mutata in laicismo illuministico, e il «Cucù» che vi
dedicai, ho ricevuto varie lettere che chiedono di precisare meglio il tema. In
che consiste questa becera egemonia? Per cominciare, il modello ideologico
dell'egemonia culturale viene tracciato da Gramsci con la sua idea del Partito
come Intellettuale Collettivo che conquista la società tramite la conquista
della cultura. Il modello pratico si nutre invece di due esperienze: quella
sovietica, da Lenin a Trotzskj, da Zdanov a Lukács, vale a dire il ministro
della cultura di Stalin e il filosofo ministro nell'Ungheria comunista. E quella
fascista, con l'organizzazione della cultura e degli intellettuali di Gentile e
di Bottai, che è l'unico precedente italiano, anzi occidentale di egemonia
culturale (ma fu ricca di eresie, varietà e dissonanze). La storia dell'egemonia
culturale marxista e laicista in Italia va divisa in due fasi. La prima risale a
Togliatti che nell'immediato dopoguerra nel nome del gramscismo va alla
conquista della cultura, avvalendosi degli intellettuali organici militanti e di
case editrici vicine: da Alicata a Einaudi, per intenderci, per non parlare
della stampa. È un'egemonia non ancora pervasiva, punta alla cultura medio-alta
e regge sulla riconversione di molti «redenti» dal fascismo. Contro questa
egemonia si abbatterà la definizione, altrettanto nefasta, di «culturame» da
parte del ministro democristiano Scelba. La seconda egemonia nasce sull'onda del
Sessantotto e il Pci diventa poi il principale referente ma anche in parte il
bersaglio dell'estremismo rosso. Il distacco dall'Unione Sovietica viene
motivato, pure all'interno del Pci, col tentativo d'intercettare quell'area
radicale, giovanile e marxista che non contestava l'Urss nel nome della libertà,
ma nel nome della Cina di Mao, di Che Guevara, di Ho Chi Minh, e altri miti
esotici e rivoluzionari. Perfino Berlinguer, quando accenna a dissentire dal
Patto di Varsavia, parte da lì. Dopo il '68 vanno in cattedra nugoli di giovani
fino a ieri contestatori, poi assistenti e presto neobaroni. La saldatura tra le
due sinistre avviene con la nascita, da una costola de l'Espresso, de La
Repubblica che raccoglie le sinistre sparse e concorre alla «secolarizzazione»
del Pci nel progetto di un partito radicale di massa. Con La Repubblica e i suoi
affluenti ha un ruolo decisivo nella nuova egemonia la sinistra televisiva,
cresciuta in Raitre. Sul piano culturale Gramsci viene fuso con Gobetti e Bobbio
diventa il nuovo papa laico dell'egemonia. Negli anni di piombo convivono
l'egemonia gramsciana con l'egemonia radical che ne prende il posto, a cui
contribuiscono i reduci del '68, dal manifesto a Lotta Continua. Se prima era il
Partito a guidare le danze, ora è l'Intellettuale Collettivo a dare la linea
alla sinistra e a guidarla sul piano dell'egemonia culturale. L'egemonia, sia
gramsciana che radical, ha due caratteristiche da sottolineare. Non tocca, se
non di riflesso, gli apici della cultura italiana, ma si salda nei ceti medi
della cultura, nel personale docente, fino a conquistare buona parte
dell'Università e della scuola, dei premi letterari, della stampa e
dell'editoria, oltre che del cinema e del teatro, dell'arte e della musica.
Nulla di paragonabile, per intenderci, con l'egemonia nel segno di Gentile e
d'Annunzio, Pirandello e Marinetti, Marconi e Piacentini, per restare agli
italiani. In secondo luogo tocca di striscio la cultura di massa, che è più
plasmata dai nuovi mezzi di ricreazione popolare, a partire dalla Rai
democristiana, Bernabei e l'intrattenimento nazionalpopolare, lo sport e la
musica leggera, e poi la tv commerciale e berlusconiana. Dunque un'egemonia
dell'organizzazione culturale, dei poteri culturali, dei quadri intermedi, senza
vertici d'eccellenza e senza adesione popolare. Ma i riflessi della sua
influenza s'infiltrano a macchia d'olio su temi civili e di costume fino a
creare un nuovo canone di remore e tabù. L'egemonia culturale fagocita la
cultura affine, asserve quella opportunista e terzista, demonizza o delegittima
le culture avverse, di tipo cattolico, conservatore, tradizionale o nazionale.
Innalza cordoni sanitari per isolare i non allineati, squalifica le culture di
destra, bollate ieri come aristocratiche e antidemocratiche, oggi come populiste
e razziste-sessiste; da alcuni anni preferisce fingere che non esistano,
decretando la morte civile dei suoi autori. Qui converrà distinguere nel
trattamento tra gli imperdonabili e i tollerati. Sono imperdonabili coloro che
sono considerati legati a principi tradizionali e a una visione spirituale della
vita, chi nutre un giudizio diverso sul fascismo, sul comunismo o sul
berlusconismo, sulla religione e sulla famiglia, o chi non condivide il nuovo
catechismo fondato sull'omolatria e sul permissivismo intollerante con chi non
si allinea. Sono invece tollerati i neognostici che coltivano spiritualismi
esoterici, fuori dal mondo e dal tempo, tipo Adelphi; si può arrivare a Guénon
ma non a Evola, a Quinzio ma non a Sciacca, a Zolla ma non a Del Noce. Poi i
dandy, che lasciano figurare i loro estremismi come stravaganze individuali o
pose letterarie o puro vintage, che non contestano i valori dominanti e gli
stili di vita; o infine, i fautori della destra impossibile che detestano ogni
destra vivente e reale nel nome di quella che non c'è (genere montanelliani
dell'ultim'ora). Sopravvive all'egemonia chi intrattiene buone relazioni coi
suoi funzionari o si affilia ai clan ammessi o sottomessi. Particolare è il
trattamento per i fuorusciti dalla Casa Madre dell'egemonia, gli ex-compagni
migrati sulle sponde avverse: sono prima trattati con particolare disprezzo come
traditori, cinici e venduti, ma alla fine sono accettati come interlocutori per
via del pédigrée, di antichi rapporti e comuni circuiti di provenienza o
pulsioni sinistre talvolta riaffioranti in loro. L'egemonia culturale fa male
alla cultura, è inutile dirlo, ne danneggia non solo la libertà ma anche la
qualità, la dignità e la varietà. Ma alla cultura nuoce pure la noncuranza, il
disprezzo, la sottovalutazione, assai diffusi nell'alveo sociale e politico
cattolico, moderato, liberale o di destra. Alla fine chi non è allineato
all'egemonia si trova tra due fuochi, anzi tra il fuoco degli intolleranti e il
gelo degli indifferenti. E si destreggia per non finire bruciato o ibernato.
Quegli intellettuali che,
vicini al fascismo, si trasformarono subito in fiancheggiatori del PCI, il
quale, su suggerimento togliattiano, cercava di applicare i princìpi
dell'egemonismo gramsciano. Ma nei limiti dell'intelligenza comunista su
descritta. Infatti, tale operazione si limitò ad intercettare prima gli
intellettuali reduci dai littoriali, poi quelli reduci dalle trincee, infine i
reduci dalla prigionia e dalle file socialrepubblicane. Tale reclutamento
all'italiana portò ad un'egemonia di facciata, molto esteriore e falsa, che gli
italiani percepivano facilmente, ed al primo stormir di vento, qual foglie
precocemente ingiallite, tutti (scrittori, cineasti, artisti, consulenti,
mediatori, critici) s'involarono nell'azzurro cielo del conformismo atlantico.
Già alla vigilia della Prima
guerra mondiale la reputazione degli italiani non era delle migliori. Tutti
erano convinti che nella Grande Guerra avremmo cambiato di nuovo bandiera, cosa
poi puntualmente avvenuta. E questa nostra attitudine a "correre in soccorso dei
vincitori", come disse Flaiano, si manifesta con desolante regolarità da oltre
un secolo. Le migliaia di camicie nere indossate solo dopo il successo della
marcia su Roma. I fascisti diventati antifascisti nell'arco di una notte (25
luglio 1943). Il brusco voltafaccia di Casa Savoia, prima alleata e poi nemica
dei tedeschi nel corso dello stesso conflitto. I partigiani dell'ultima ora. Gli
intellettuali passati, dopo il 25 aprile 1945, dalla corte di Bottai a quella di
Togliatti. Il viavai tra le porte girevoli delle correnti democristiane. La
corsa in massa alle sezioni del Pci nel momento del "sorpasso" sulla Dc (1976).
Craxi che, divenuto segretario del Psi, fu idolatrato come una divinità egizia e
alla fine mollato in un nanosecondo. Berlusconi che, trasformatosi da "ragazzo
coccodè" a eminente statista (1994), fu corteggiatissimo da ex supponenti
rivali. Dirigenti d'azienda e giornalisti Rai che, dopo l'affermazione
elettorale di Alleanza nazionale (1996), scoprirono di essere di destra, salvo
poi dire, quando il leader cadde in disgrazia: "Fini chi?". Fino a Renzi,
snobbato da tutti dopo la sconfitta subita da Bersani alle primarie del 2012 e
oggi inseguito da uno stuolo di zelanti e insospettabili ammiratori.
Ed ecco il naturale sbocco
letterario con Bruno Vespa: "Italiani voltagabbana". Fino all'autunno del 2013
Matteo Renzi era solo, attaccato più all'interno che all'esterno del suo
partito. Nel giro di pochi mesi, molti dei suoi avversari hanno voltato gabbana,
sono diventati renziani, e alcuni fanno parte della squadra di governo. Dopo la
clamorosa vittoria del Pd alle elezioni europee del maggio 2014, un folto gruppo
della classe dirigente del paese si è messo a disposizione del giovane
presidente del Consiglio, sperando di conquistare un ruolo di primo piano. «Ma
visto che da noi non cambiava niente, l'ondata di renzismo è improvvisamente
cessata» racconta il premier nel lungo colloquio accordato a Bruno Vespa per
...Fino all'autunno del 2013 Matteo Renzi era solo, attaccato più all'interno
che all'esterno del suo partito, è scritto nella recensione del libro della
Mondadori. Nel giro di pochi mesi, molti dei suoi avversari hanno voltato
gabbana, sono diventati renziani, e alcuni fanno parte della squadra di governo.
Dopo la clamorosa vittoria del Pd alle elezioni europee del maggio 2014, un
folto gruppo della classe dirigente del paese si è messo a disposizione del
giovane presidente del Consiglio, sperando di conquistare un ruolo di primo
piano. «Ma visto che da noi non cambiava niente, l'ondata di renzismo è
improvvisamente cessata» racconta il premier nel lungo colloquio accordato a
Bruno Vespa per questo libro. I voltagabbana sono una costante della storia
nazionale. Dal Risorgimento, quando venivamo accusati di vincere le guerre con i
soldati degli altri, alla prima guerra mondiale, di cui ricorre il centenario,
quando in nome del «sacro egoismo» a un certo punto ci trovammo a combattere a
fianco delle due fazioni opposte, per scegliere infine quella vincente,
rivolgendo le armi anche contro i tedeschi, nostri alleati da trent'anni.
Mussolini, che voltò gabbana come interventista prima della Grande Guerra, si
alleò con Hitler nella seconda anche perché gli era rimasto il complesso del
«tradimento» del 1915. Alla caduta del fascismo, i voltagabbana furono milioni,
e Vespa narra con divertito stupore la storia di prestigiosi intellettuali e
artisti diventati all'improvviso antifascisti dopo aver orgogliosamente
inneggiato al Duce fino al 25 luglio. E sulla pagina vergognosa dell'8 settembre
1943 è ancora aperto il dibattito se gli italiani abbiano tradito i tedeschi o –
secondo una versione più recente – se siano stati i tedeschi a tradire gli
italiani. Nella Prima Repubblica i politici cambiavano spesso corrente (specie
nella Dc) piuttosto che partito, ma i tradimenti più clamorosi furono senza
dubbio quelli di molti dirigenti socialisti nei confronti di Craxi. Tuttavia, il
trionfo dei voltagabbana si è avuto nella Seconda Repubblica e all'alba della
Terza, quella che stiamo vivendo con la riforma costituzionale. Centinaia di
parlamentari hanno cambiato casacca con sconcertante disinvoltura e diversi
governi sono nati e caduti con il contributo decisivo dei «senza vergogna».
Berlusconi e Prodi ne sono stati le vittime principali. Dopo essere stato via
via abbandonato da Bossi, Fini e Casini, in queste pagine il Cavaliere accusa
severamente Alfano, che si difende dall'accusa di «parricidio» e parla, semmai,
di «figlicidio». A sua volta, il Senatùr è stato abbandonato da chi lo adorava e
Beppe Grillo ha già avuto le sue molte delusioni. Nel libro, naturalmente, ampio
spazio viene dedicato a Matteo Renzi, ai retroscena della sua ascesa al potere e
al governo, e ai tanti che lo detestavano e ora lo amano. E ampio spazio viene
dedicato alle donne: quelle che Renzi ha portato al governo, o a incarichi di
grande potere, e a Francesca Pascale, che per la prima volta racconta nei
dettagli la sua storia d'amore con il Cavaliere. In Italiani voltagabbana, Bruno
Vespa dipinge con il consueto stile incalzante un affresco del costume
nazionale, rileggendo la storia e la cronaca sotto un'angolazione umanissima,
anche se assai poco lusinghiera.
Bruno Vespa ha
cominciato a 16 anni il lavoro di giornalista e a 24 si è classificato al
primo posto nel concorso che lo ha portato alla Rai. Dal 1990 al 1993 ha diretto
il Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione «Porta a porta» è il programma di politica,
attualità e costume più seguito. Per la prima volta nella storia, vi è
intervenuto un papa, Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta. Tra i
premi più prestigiosi, ha vinto il Bancarella (2004), per due volte il
Saint-Vincent per la televisione (1979 e 2000) e nel 2011 quello alla carriera;
nello stesso anno ha vinto l’Estense per il giornalismo. Fra i più recenti
volumi pubblicati da Mondadori ricordiamo: Storia d’Italia da Mussolini a
Berlusconi, Vincitori e vinti, L’Italia spezzata, L’amore e il potere, Viaggio
in un’Italia diversa, Donne di cuori, Il cuore e la spada, Questo amore, Il
Palazzo e la piazza e Sale, zucchero e caffè.
Opportunisti, paurosi,
voltagabbana: italiani, non siete cambiati, scrive Fertilio Dario su “Il
Corriere della Sera”. Dopo le rivelazioni dei colloqui telefonici tra il luglio
e il settembre '43, gli storici si interrogano sull'oggi. Italiani, povera
gente? Di certo opportunisti, paurosi, trasformisti. Persino patetici, nello
sforzo di rimuovere la catastrofe del regime. Infantili, con l'illusione assurda
di invitare a uno stesso tavolo nazisti e alleati. Gattopardeschi, e sicuri che
dopo l'arresto di Mussolini tutto dovesse cambiare per poter restare come prima.
Disinformati, al punto da immaginare che gli angloamericani (in accordo con la
propaganda ufficiale) sarebbero stati "inchiodati sul bagnasciuga della
Sicilia". Equilibristi, in omaggio alla celebre arte di arrangiarsi. Così almeno
appare la nostra classe politica e intellettuale, stando alle intercettazioni
telefoniche registrate dal Servizio d'informazione militare fra il 25 luglio e
l'8 settembre del '43. Ieri le ha pubblicate il Corriere, con il commento di
Renzo De Felice, e oggi l'interrogativo è al vaglio degli storici: possibile che
in quegli anni gli italiani fossero proprio così? Che tutti, o quasi, si
ostinassero a vivere in un mondo di favole littorie e slogan mascelluti quando
già la situazione era precipitata? Possibile, certo, secondo Giorgio Spini.
Anzi, addirittura scontato. "Già alla fine degli anni Quaranta, afferma,
Federico Chabod mi chiese di analizzare autobiografie e memoriali dei generali
italiani nei giorni della sconfitta. Ne venne fuori che nessuno aveva capito
nulla, nè aveva avuto sentore del 25 aprile, eccetto il generale Cadorna per via
dei suoi contatti con il Partito d'azione e La Malfa". Perciò le rivelazioni di
oggi, secondo Spini, "sono soltanto la conferma del lavoro di allora: il deserto
mentale e l'imbecillità della classe dirigente. Qui non c'entravano destra o
sinistra. Il fatto era che la selezione dei gruppi dirigenti nell'Italia
fascista, militari compresi, era stata realizzata alla rovescia, promuovendo i
più stupidi. Le conversazioni telefoniche, le sciocchezze che venivano prese sul
serio confermano come questi importanti generali e dirigenti di regime fossero
veramente poveri diavoli". C'era allora una colpa collettiva? "Non la addosserei
agli italiani: fra loro ce n'erano anche alcuni tutt' altro che scioccherelli,
come De Gasperi. Il problema stava nella selezione negativa del regime, che dopo
tutto era rimasto fedele alla ideologia del manganello". Un simile stato di
minorità mentale, secondo il politologo Dino Cofrancesco, è testimoniato dall'
atteggiamento collettivo nei confronti della guerra. "Proprio come i sudditi di
due o tre secoli prima, i dirigenti concepivano il conflitto in corso come
"limitato" e reversibile, parte di un destino che restava al di sopra di loro, e
sul quale soltanto il capo supremo poteva intervenire. A differenza dei
cittadini di uno Stato democratico, avevano accolto la conquista dell'Abissinia
come un miracolo compiuto da un altro, ora si illudevano che un altro li avrebbe
cavati d'impaccio. Come dire: abbiamo avuto una mano sfortunata alla roulette,
dunque raccogliamo le fiches e torniamocene a casa. Il fascismo, che pure per
molti aspetti aveva modernizzato il Paese, li aveva educati a dipendere da
qualcun altro, ne aveva fatto soltanto dei sudditi. Oggi a nessuno sfugge che le
democrazie, più restie delle dittature a intraprendere le guerre, sono poi
inesorabili nel condurle a termine. Invece nessuno aveva detto agli italiani
d'allora che le guerre contemporanee si combattono in un altro modo, sono
conflitti totali nei quali tutti i cittadini vengono coinvolti più o meno allo
stesso modo, sopportandone fino in fondo le conseguenze". Anche Paolo Alatri, di
fronte alle rivelazioni sull'impreparazione psicologica degli italiani e alla
disinformazione di cui erano vittime, è molto colpito. "Tutti si muovevano in
una specie di gelatina - afferma - in cui trovavano accoglienza le possibilità e
le ipotesi più inimmaginabili. C' era chi fantasticava su possibili alleanze con
i russi, chi prevedeva un abbraccio con gli inglesi, chi avrebbe voluto
volentieri gli uni e gli altri alla sua tavola. Incredibile, poi, la generale
sottovalutazione del ruolo dei tedeschi, come se mettersi d'accordo con loro
fosse stato facile quanto bere un bicchier d'acqua. E che dire poi degli
americani? Nei discorsi collettivi parevano scomparsi, inghiottiti o rimossi
dalla coscienza". Come si era potuto arrivare a simili autoinganni? "La radice
del fenomeno va cercata nella politica di grande potenza: l'Italia si fingeva un
Paese guerriero e attrezzato per tutte le evenienze, senza averne nemmeno le
basi. Non c'è da stupirsi se fra i suoi esponenti o simpatizzanti più in vista
non ne esistesse uno solo con una prospettiva realistica. Basti pensare al
progetto di "Roma città aperta". Oppure a quel senatore Felici, nazionalista
monarchico e per molti anni procuratore di D'Annunzio nei suoi rapporti col
fascismo, convinto che la penetrazione degli Alleati in Italia non sarebbe mai
potuta riuscire". Ma siamo poi tanto mutati, cinquant'anni dopo? Viene da
dubitarne, se diamo retta ad Arturo Colombo, pronto a riscontrare nei discorsi
dell'Italietta 1943 molte affinità con la cultura poi affermatasi nel
dopoguerra. Ecco Spataro, destinato a diventare un leader della Dc, ragionare
sulla necessità di creare un centro politico capace di "logorare" gli avversari.
Ecco la costante paura del comunismo, un autentico spauracchio collettivo, che
lascia in ombra qualsiasi volontà costruttiva di mettere in piedi un sistema
politico liberaldemocratico. Ecco Missiroli, convinto che il vecchio non debba
morire, e deciso a ritornare immediatamente a galla. Ed ecco infine il sacro
slogan "Credere, obbedire, combattere" riadattato alle necessità del momento.
Credere? A niente e nessuno. Obbedire? Ai vincitori. Combattere? Sì, ma per
salvare la pelle.
Italiani, popolo di poeti,
eroi e voltagabbana, scrive “L’Unità”. Che ne è oggi dell’impegno degli
intellettuali italiani? E, prima ancora, esistono ancora veri intellettuali in
Italia? Se ne è discusso all’Università di Bordeaux. Il più noto studioso di
letterature comparate italiano, Remo Ceserani, ha svolto una relazione sulla
figura, tutta italica, del voltagabbana. Una tipologia di personaggio oggi molto
presente nel nostro Paese, tra i politici, ma anche tra gli uomini di cultura.
Tra gli esempi riportati da Ceserani, a un uditorio francese piuttosto
sconcertato, il «responsabile» Domenico Scilipoti (passato dalla sera alla
mattina da Antonio Di Pietro a Silvio Berlusconi), l’ex presidente del Senato e
tutt’ora senatore Pdl Marcello Pera (da giovane simpatizzante radicale, oggi
vicino alle posizioni del cattolicesimo più reazionario), i giornalisti Paolo
Guzzanti (prima socialista, poi berlusconiano, poi antiberlusconiano - fu lui a
coniare il termine «mignottocrazia», che Ceserani ha faticato un po’ a tradurre
in francese - prima di tornare nuovanente a sostenere il Cavaliere) e Giampaolo
Pansa (prima a sinistra, ora artefice, da destra, di un acceso revisionismo
storiografico sulla Resistenza), i politici Claudio Velardi (prima consulente di
Massimo D’Alema, poi di Renata Polverini) e Daniele Capezzone (prima radicale
ora portavoce del Pdl). E, ancora, Giuliano Ferrara, Vittorio Sgarbi, Daniela
Santanché, Tiziana Maiolo. Insomma, cambiare casacca per opportunismo e
tornaconto personale, anche se ammantandosi di nobili motivazioni, sembra essere
diventata una moda radicata e diffusa a tutti i livelli.
Professor Ceserani, come
mai ha deciso di partire da Scilipoti per questa sua carrellata di voltagabbana?
«Perché Scilipoti è la
caricatura del voltagabbana, è un voltagabbana all’ennesima potenza, quindi
diventa quasi la parodia di una maschera della commedia dell’arte italiana. Il
suo caso è talmente estremo da apparire quasi surreale. Ma sono ancora più
paradossali i tentativi di giustificare i propri comportamenti che offre a chi
gliene chieda spiegazione: un’autentica arrampicata sugli specchi, senza alcun
vero argomento».
Che cosa la colpisce
maggiormente nella sua vicenda?
«L’assenza della benché minima
motivazione ideologica o anche solo ideale. Scilipoti è passato dal populismo di
sinistra (Di Pietro) al populismo di destra (Berlusconi) senza battere ciglio,
anzi, senza forse neanche accorgersi del triplo salto carpiato che ha compiuto.
Il voltagabbana classico dà una giustificazione al proprio mutamento di
posizioni. Qui siamo nella commedia dell’assurdo. Scilipoti è un personaggio
pirandelliano: uno, nessuno e centomila».
Perché secondo lei il
«voltagabbanismo» è un vizio tipicamente italiano?
«La radice storica di questo
malcostume sta nel trasformismo parlamentare che ha connotato, sin dall’inizio
della vita unitaria della nazione, la prassi politica. Nei primi decenni della
vita parlamentare tale pratica trovava giustificazione nell’assenza di
differenze ideologiche sostanziali tra destra e sinistra. Poi questa tendenza si
è protratta nel tempo fino ai nostri giorni, seppure in un contesto radicalmente
mutato. Non a caso i voltagabbana sono frequenti oggi, quando sono venute meno
le grandi ideologie del ’900. Si tratta, insomma, di un sintomo tutto
postmoderno, tipico di una società liquida come la nostra. Ma, va ribadito, di
un sintomo assolutamente negativo, del sintomo, cioè, di un’autentica patologia
del tessuto civile prima ancora che di quello politico».
In diversi personaggi tra
quelli che ha nominato (da Pera a Capezzone) c’è, all’inizio della loro
carriera, una militanza o quanto meno una simpatia per il Partito radicale. Come
spiega questa costante?
«Perché Marco Pannella è stato
davvero una nave scuola, ha insegnato a tutti loro tecniche di lotta politica
alternative a quelle dei partiti tradizionali. Ad esempio Capezzone ha portato
le proprie conoscenze nel campo della comunicazione al servizio di tutt’altra
causa. Così l’esperienza radicale è stata spesso la scuola contemporanea del
trasformismo».
Ma non è lecito cambiare
idea?
«Certo, e nella storia della
cultura occidentale le grandi conversioni hanno dato origine a grandi
narrazioni: da San Paolo a Sant’Agostino fino ad Alessandro Manzoni, nella
conversione classica c’è sempre qualcosa di nobile, di ideale. Ma qui non
compare nulla di tutto questo. Non c’è la dimensione alta, tragica, ma solo
quella bassa, farsesca».
I politici che mutano
bandiera, però, rivendicano la legittimità del loro comportamento richiamando
l’articolo 67 della Costituzione: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la
nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»...
«Sì, ed è sacrosanto che i
padri costituenti abbiano voluto questa frase. Ma va chiarita una cosa:
quell’articolo della nostra Carta fondamentale è stato scritto per garantire la
libertà di coscienza dei parlamentari di fronte alle grandi problematiche
etiche. Le giustificazioni di chi cambia schieramento parlamentare snaturano il
senso della legge».
Ma prima ancora di
Scilipoti, forse bisognerebbe parlare di Berlusconi…
«Ma no, perché in questo
Berlusconi è un modello inarrivabile, è un fuori classe, non sono possibili
paragoni. Baciare la mano a Gheddafi e poi sganciargli le bombe sulla testa,
essere un giorno per l’Unità d’Italia e il giorno dopo per un federalismo
spinto, essere per il libero mercato e insieme favorire precisi gruppi di
interesse economico, sostenere le posizioni morali della Chiesa cattolica e
insieme diffondere tramite le tv commerciali di famiglia una visione
assolutamente materialistica ed edonistica della vita, per non parlare dei
modelli di comportamento offerti dalla sua vita privata… In Berlusconi c’è tutto
e il contrario di tutto, da sempre. Per questo non può essere un volta gabbana.
Perché non ha ideali, ma solo istinti: gli istinti più bassi del capitalismo».
Già, la solita sinistra. Vede
la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei suoi occhi.
 Da
“Italiani Voltagabbana” di Bruno Vespa.
Neri con riserva. Da Dario Fo ad Eugenio Scalfari: nel libro di Bruno
Vespa, tutti gli intellettuali di sinistra che furono fascisti, scrive “Libero
Quotidiano”. La storia del nostro Paese è ricca di retroscena e di aneddoti
destinati a fare scalpore: tra queste storie, diverse vengono svelate o
ricordate da Bruno Vespa nel suo nuovo libro, Italiani volta gabbana.
Dalla prima guerra mondiale alla Terza Repubblica, sempre sul carro del
vincitore, in uscita oggi, giovedì 6 novembre (edizione Mondadori). Nel
terzo capitolo di questo volume, Vespa parla di diversi intellettuali che
si dichiararono antifascisti alla caduta del regime di Benito Mussolini, ma che
prima stavano dalla parte del Duce: tra di loro ci sono nomi altisonanti, come
Giuseppe Ungaretti o Dario Fo, o altri comunque ben noti, come
Indro Montanelli o Enzo Biagi. Tutto nasce dalla rivista Primato,
diretta da Giuseppe Bottai: il politico fascista più illuminato sul piano
culturale, ma anche il più feroce sostenitore delle leggi razziali. La rivista
nacque nel 1940 e chiuse il 25 luglio 1943, e furono tantissimi intellettuali a
collaborare per questo giornale. "Fascista in eterno": si definì così Ungaretti
durante il regime. Il poeta notò che "tutti gli italiani amano e venerano il
loro Duce come un fratello maggiore", e firmava appelli per sostenere
Mussolini, salvo poi rinnegarlo dopo il 25 luglio 1943, quando firmò
documenti contrari ai precedenti, tanto da meritarsi una grande accoglienza a
Mosca da parte di Nikita Kruscev. Stessa parabola per Norberto Bobbio,
che da studente si era iscritto al Guf (l'organismo universitario
fascista) e aveva mantenuto la tessera del partito, indispensabile per
insegnare. Il filosofo e senatore a vita, cercò raccomandazioni per poter
evitare problemi che gli derivavano da frequentazioni "non sempre ortodosse", e
il padre Luigi fu costretto a rivolgersi allo stesso Mussolini. Bobbio ottenne
la cattedra, mentre nel dopoguerra diventò un emblema della sinistra
riformista: il 12 giugno 1999, a Pietrangelo Buttafuoco del quotidiano
Il Foglio, il filosofo ammise: "Il fascismo l'abbiamo rimosso perché ce ne
vergognavamo. Io che ho vissuto la gioventù fascista mi vergognavo di
fronte a me stesso, a chi era stato in prigione e a chi non era sopravvissuto".
Indro Montanelli non ha mai nascosto di essere stato fascista: "Non
chiedo scusa a nessuno", ribadiva sul Corriere della Sera. Stesso
discorso per Enzo Biagi, che nel dopoguerra ha sempre mantenuto
gratitudine per Bottai. Eugenio Scalfari, dopo il 1945, parlò di
"quaranta milioni di fascisti che scoprirono di essere antifascisti", senza
celare mai le proprie ferme convinzioni giovanili: anche lui, fino alla sua
caduta, sostenne il fascismo e la sua economia corporativa. Più difficile è
stato negare la propria fede fascista, da parte di Dario Fo, che a 18
anni si arruolò nel battaglione Azzurro di Tradate (contraerea) e poi tra i
paracadutisti del battaglione Mazzarini della Repubblica Sociale Italiana.
Nel 1977 Il Nord, piccolo giornale di Borgomanero, raccontò quei
trascorsi della vita di Fo: l'attore querelò subito Il Nord, e al
processo disse che l'arruolamento era stato soltanto "un metodo di lotta
partigiana". Le testimonianze, invece, lo inchiodarono: la sentenza del
tribunale di Varese, datata 7 marzo 1980, stabilì che "è perfettamente legittimo
definire Dario Fo repubblichino e rastrellatore di partigiani". Dario Fo non
fece ricorso.
Da
“Italiani Voltagabbana” di Bruno Vespa.
Neri con riserva. Da Dario Fo ad Eugenio Scalfari: nel libro di Bruno
Vespa, tutti gli intellettuali di sinistra che furono fascisti, scrive “Libero
Quotidiano”. La storia del nostro Paese è ricca di retroscena e di aneddoti
destinati a fare scalpore: tra queste storie, diverse vengono svelate o
ricordate da Bruno Vespa nel suo nuovo libro, Italiani volta gabbana.
Dalla prima guerra mondiale alla Terza Repubblica, sempre sul carro del
vincitore, in uscita oggi, giovedì 6 novembre (edizione Mondadori). Nel
terzo capitolo di questo volume, Vespa parla di diversi intellettuali che
si dichiararono antifascisti alla caduta del regime di Benito Mussolini, ma che
prima stavano dalla parte del Duce: tra di loro ci sono nomi altisonanti, come
Giuseppe Ungaretti o Dario Fo, o altri comunque ben noti, come
Indro Montanelli o Enzo Biagi. Tutto nasce dalla rivista Primato,
diretta da Giuseppe Bottai: il politico fascista più illuminato sul piano
culturale, ma anche il più feroce sostenitore delle leggi razziali. La rivista
nacque nel 1940 e chiuse il 25 luglio 1943, e furono tantissimi intellettuali a
collaborare per questo giornale. "Fascista in eterno": si definì così Ungaretti
durante il regime. Il poeta notò che "tutti gli italiani amano e venerano il
loro Duce come un fratello maggiore", e firmava appelli per sostenere
Mussolini, salvo poi rinnegarlo dopo il 25 luglio 1943, quando firmò
documenti contrari ai precedenti, tanto da meritarsi una grande accoglienza a
Mosca da parte di Nikita Kruscev. Stessa parabola per Norberto Bobbio,
che da studente si era iscritto al Guf (l'organismo universitario
fascista) e aveva mantenuto la tessera del partito, indispensabile per
insegnare. Il filosofo e senatore a vita, cercò raccomandazioni per poter
evitare problemi che gli derivavano da frequentazioni "non sempre ortodosse", e
il padre Luigi fu costretto a rivolgersi allo stesso Mussolini. Bobbio ottenne
la cattedra, mentre nel dopoguerra diventò un emblema della sinistra
riformista: il 12 giugno 1999, a Pietrangelo Buttafuoco del quotidiano
Il Foglio, il filosofo ammise: "Il fascismo l'abbiamo rimosso perché ce ne
vergognavamo. Io che ho vissuto la gioventù fascista mi vergognavo di
fronte a me stesso, a chi era stato in prigione e a chi non era sopravvissuto".
Indro Montanelli non ha mai nascosto di essere stato fascista: "Non
chiedo scusa a nessuno", ribadiva sul Corriere della Sera. Stesso
discorso per Enzo Biagi, che nel dopoguerra ha sempre mantenuto
gratitudine per Bottai. Eugenio Scalfari, dopo il 1945, parlò di
"quaranta milioni di fascisti che scoprirono di essere antifascisti", senza
celare mai le proprie ferme convinzioni giovanili: anche lui, fino alla sua
caduta, sostenne il fascismo e la sua economia corporativa. Più difficile è
stato negare la propria fede fascista, da parte di Dario Fo, che a 18
anni si arruolò nel battaglione Azzurro di Tradate (contraerea) e poi tra i
paracadutisti del battaglione Mazzarini della Repubblica Sociale Italiana.
Nel 1977 Il Nord, piccolo giornale di Borgomanero, raccontò quei
trascorsi della vita di Fo: l'attore querelò subito Il Nord, e al
processo disse che l'arruolamento era stato soltanto "un metodo di lotta
partigiana". Le testimonianze, invece, lo inchiodarono: la sentenza del
tribunale di Varese, datata 7 marzo 1980, stabilì che "è perfettamente legittimo
definire Dario Fo repubblichino e rastrellatore di partigiani". Dario Fo non
fece ricorso.
Il numero dei voltagabbana tra
gli intellettuali alla caduta del regime fu clamoroso, scrive Bruno Vespa su "Il
Giornale". Giuseppe Bottai era il politico più illuminato del fascismo sul piano
culturale, ma anche il più feroce sostenitore delle leggi razziali. Ebbene, la
sua rivista «Primato» fu pubblicata dal 1940 (quando le leggi razziali avevano
già consumato i peggiori misfatti) e chiuse solo con la caduta del regime il 25
luglio 1943. In quegli anni, Bottai poté contare sulla fervida collaborazione
del meglio della cultura italiana: Giorgio Vecchietti (condirettore), Nicola
Abbagnano, Mario Alicata, Corrado Alvaro, Cesare Angelini, Giulio Carlo Argan,
Riccardo Bacchelli, Piero Bargellini, Arrigo Benedetti, Carlo Betocchi, Romano
Bilenchi, Walter Binni, Alessandro Bonsanti, Vitaliano Brancati, Dino Buzzati,
Enzo Carli, Emilio Cecchi, Luigi Chiarini, Giovanni Comisso, Gianfranco Contini,
Galvano Della Volpe, Giuseppe Dessì, Enrico Emanuelli, Enrico Falqui, Francesco
Flora, Carlo Emilio Gadda, Alfonso Gatto, Mario Luzi, Bruno Migliorini, Paolo
Monelli, Eugenio Montale, Carlo Muscetta, Piermaria Pasinetti, Cesare Pavese,
Giaime Pintor, Vasco Pratolini, Salvatore Quasimodo, Vittorio G. Rossi, Luigi
Russo, Luigi Salvatorelli, Sergio Solmi, Ugo Spirito, Bonaventura Tecchi,
Giovanni Titta Rosa, Giuseppe Ungaretti, Nino Valeri, Manara Valgimigli, Giorgio
Vigolo, Cesare Zavattini. Musicisti come Luigi Dallapiccola e Gianandrea
Gavazzeni. Artisti come Amerigo Bartoli, Domenico Cantatore, Pericle Fazzini,
Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Mafai, Camillo Pellizzi, Aligi Sassu, Orfeo
Tamburi.
GIUSEPPE UNGARETTI.
Una crisi di
coscienza colse Giuseppe Ungaretti. Il poeta notò durante il regime che «tutti
gli italiani amano e venerano il loro Duce come un fratello maggiore» e si
definì «fascista in eterno», firmando documenti e appelli per sostenere il
fascismo. Salvo firmarne di uguali e contrari alla fine della guerra come
alfiere dell'antifascismo, tanto da meritare una grande accoglienza a Mosca da
parte di Nikita Kruscev.
NORBERTO BOBBIO.
Norberto Bobbio da studente si era iscritto al Guf, l'organismo universitario
fascista, e poi aveva mantenuto la tessera del partito, indispensabile per
insegnare. Colpito per frequentazioni non sempre ortodosse da una lieve sanzione
che avrebbe potuto comprometterne la carriera, Bobbio cercò ovunque
raccomandazioni per emendarsi. Suo padre Luigi si rivolse al Duce, lo zio al
quadrumviro De Bono, lo stesso giovane docente a Bottai («con devota fascistica
osservanza»). Fu interessato anche Giovanni Gentile, che intervenne con successo
presso Mussolini. Alla fine, Norberto ebbe la cattedra tanto desiderata. Nel
dopoguerra, Bobbio diventò un maître à penser della sinistra riformista
italiana. Ma il tarlo del passato lo consumò fino a una clamorosa intervista
liberatoria rilasciata il 12 novembre 1999 a Pietrangelo Buttafuoco per Il
Foglio: «Noi il fascismo l'abbiamo rimosso perché ce ne ver-go-gna-va-mo. Ce ne
ver-go-gna-va-mo. Io che ho vissuto la “gioventù fascista” tra gli antifascisti
mi vergognavo prima di tutto di fronte al me stesso di dopo, e poi davanti a chi
faceva otto anni di prigione, mi vergognavo di fronte a quelli che diversamente
da me non se l'erano cavata».
INDRO MONTANELLI.
Montanelli non ha
fatto mai mistero di essere stato fascista. (Fu, anzi, un fascista entusiasta).
«Sono stato fascista, come tutte le persone della mia generazione», ammise nella
sua “Stanza” sul Corriere della Sera nel 1996. «Non perdo occasione per
ricordarlo, ma neanche di ripetere che non chiedo scusa a nessuno». Anche nella
più sfacciata adulazione del Duce, Montanelli scriveva pezzi di bravura come
questo del 1936: «Quando Mussolini ti guarda, non puoi che essere nudo dinanzi a
Lui. Ma anche Lui sta, nudo, dinanzi a noi. Il Suo volto e il Suo torso di
bronzo sono ribelli ai panneggi e alle bardature. Ansiosi e sofferenti, noi
stessi glieli strappiamo di dosso, mirando solo alla inimitabile essenzialità di
questo Uomo, che è un vibrare e pulsare formidabilmente umani. Dobbiamo amarlo
ma non desiderare di essere le favorite di un harem».
GIORGIO BOCCA.
«Quando cominciò il
nostro antifascismo? Difficile dirlo...». Dev'essere cominciato tardi, quello di
Giorgio Bocca, se è vero quanto egli stesso scrive nel racconto «La sberla… e la
bestia» pubblicato l'8 gennaio 1943 su La provincia granda, foglio d'ordini
settimanale della federazione fascista di Cuneo. Il 5 gennaio Bocca aveva
incontrato in treno sulla linea Cuneo-Torino l'industriale Paolo Berardi, il
quale diceva ad alcuni reduci dalla Russia e dalla Francia che la guerra era
ormai perduta. Bocca ascoltò, poi gli diede un ceffone e lo denunciò alla
polizia per disfattismo. Due anni prima, sullo stesso settimanale, il giovane
giornalista aveva scritto un lungo articolo su I protocolli dei Savi di Sion,
che si sarebbero rivelati poi (ma lui, ovviamente, non lo sapeva) il falso più
clamoroso della propaganda antisemita. Le prime righe dell'articolo recitano:
«Sono i Protocolli dei Savi di Sion un documento dell'Internazionale ebraica
contenente i piani attraverso cui il popolo Ebreo intende giungere al dominio
del mondo...». E le ultime: «Sarà chiara a tutti, anche se ormai i non convinti
sono pochi, la necessità ineluttabile di questa guerra, intesa come una
ribellione dell'Europa ariana al tentativo ebraico di porla in stato di
schiavitù».
DARIO FO.
Dario Fo si arruolò a 18 anni come volontario prima nel battaglione Azzurro di
Tradate (contraerea) e poi tra i paracadutisti del battaglione Mazzarini della
Repubblica sociale italiana. Il 9 giugno 1977, quando Fo era ormai da anni
celebre per il suo lavoro teatrale Mistero buffo, un piccolo giornale di
Borgomanero (Novara), Il Nord, pubblicò una lettera di Angelo Fornara che ne
raccontava i trascorsi repubblichini. Fo sporse querela con ampia facoltà di
prova, ma il processo non ebbe l'esito da lui sperato. Secondo quanto riferì Il
Giorno (8 febbraio 1978), l'attore disse in aula che il suo «arruolamento era
una questione di metodi di lotta partigiana» per coprire l'azione antifascista
della sua famiglia. Ma le testimonianze furono implacabili. Il suo istruttore
tra i parà, Carlo Maria Milani, mise a verbale: «L'allievo paracadutista Dario
Fo era con me durante un rastrellamento nella Val Cannobina per la conquista
dell'Ossola, il suo compito era di armiere porta bombe». E l'ex comandante
partigiano Giacinto Lazzarini lo inchiodò: «Se Dario Fo si arruolò nei
paracadutisti repubblichini per consiglio di un capo partigiano, perché non l'ha
detto subito, all'indomani della Liberazione? Perché tenere celato per tanti
anni un episodio che va a suo merito?». Una testimone, Ercolina Milanesi, lo
ricorda «tronfio come un gallo per la divisa che portava e ci tacciò di pavidi
per non esserci arruolati come lui. L'avremmo fatto, ma avevamo quindici
anni...». L'11 marzo 1978, mentre il processo contro gli accusatori di Fo era in
pieno svolgimento, Luciano Garibaldi pubblicò sul settimanale Gente una foto
dell'attore in divisa della Repubblica sociale (altissimo, magrissimo come è
sempre stato) e un suo disegno dove appaiono alcuni camerati con le anime dei
partigiani uccisi che escono dalle canne dei mitra («Sono apocrife e aggiunte da
altri», si difenderà). Il 7 marzo 1980 il tribunale di Varese stabilì che «è
perfettamente legittimo definire Dario Fo repubblichino e rastrellatore di
partigiani». Il futuro premio Nobel non ricorse in appello e la sentenza divenne
definitiva.
VITTORIO GORRESIO.
Vittorio Gorresio, una delle firme più brillanti della sinistra riformista del
dopoguerra, scriveva cose impegnative sulla gioventù hitleriana: «Così pregano
gli ariani piccoli, ora che, dissipato il fumo del rogo ove furon arsi i
venticinquemila volumi infetti di semitismo, l'atmosfera tedesca è più limpida e
chiara». E nel 1936 sulla Stampa, il giornale di cui sarebbe diventato negli
anni Sessanta la prima firma politica, confessava: «Ringrazio Dio perché ci ha
fatto nascere italiani ed è con gli occhi lucidi che si sente nell'animo la
gratitudine del Duce».
EUGENIO SCALFARI.
Nonostante la giovane età, Scalfari era riuscito a far pubblicare alcuni scritti
di Calvino su Roma fascista, era diventato amico di Bottai, che chiamava «il mio
Peppino», e fino alla caduta del fascismo sostenne con convinzione l'economia
corporativa. Ma va ascritto a suo merito di aver sempre parlato nel dopoguerra
di «quaranta milioni di fascisti che scoprirono di essere antifascisti», non
nascondendo mai le sue ferme convinzioni giovanili.
ENZO BIAGI.
Montanelli collaborò a Primato come Enzo Biagi, che nel dopoguerra non ha negato
i suoi trascorsi (scrisse anche per la rivista fascista bolognese Architrave) e
la gratitudine per Bottai. Ma i suoi avversari, spulciando negli archivi, hanno
scovato altri episodi. Secondo il racconto di Nazario Sauro Onofri in I giornali
bolognesi nel ventennio fascista, nel 1941 Biagi, allora ventunenne, recensì il
film Süss l'ebreo, formidabile strumento della propaganda antisemita di Himmler,
sul foglio della federazione fascista bolognese L'assalto, scrivendo che il
pubblico «era trascinato verso l'entusiasmo» e «molta gente apprende che cosa è
l'ebraismo e ne capisce i moventi della battaglia che lo combatte». (Biagi era
in buona compagnia, perché sullo stesso giornale, fortemente antisemita, si
scatenava anche il giovanissimo Giovanni Spadolini, mentre una lusinghiera
recensione allo stesso film fu firmata dal regista Carlo Lizzani). Biagi restò
al Resto del Carlino, controllato dai fascisti e ormai anche dai nazisti, fino
alla tarda primavera del 1944, ricevendo - come tutta la redazione - generosi
sussidi economici dal ministero della Cultura popolare (il Minculpop). Dieci
mesi dopo entrava a Bologna con le truppe americane.
Pansa: ogni italiano è
figlio di un fascista.
Per oltre vent'anni nessuno si oppose al regime del Duce. Solo la conduttrice de
"Le invasioni barbariche" sembra ignorarlo, scrive Giampaolo Pansa su “Libero
Quotidiano”. Mi ha fatto tenerezza la signora Daria Bignardi nel corpo a corpo
con un deputato grillino, Alessandro Di Battista. Era in diretta su La7 per le
sue Invasioni barbariche e tentava di mettere in difficoltà il grillino sul
padre fascista. Deliziosa ingenuità quella di madamin Bignardi. Risultava chiaro
che nessuno le aveva spiegato che per vent’anni, dal 1922 al 1943, tutti gli
italiani sono stati fascisti, hanno adorato Benito Mussolini, gli hanno obbedito
e si sono fatti accoppare per lui. Fino alla notte del 25 luglio, quando un
gruppo di gerarchi, e non un’insurrezione popolare, mandò a gambe all’aria il
Duce. Nel mio piccolo, sono stato anch’io un fascista, essendo venuto al mondo
il 1° ottobre 1935, in pieno regime mussoliniano. Il giorno successivo alla mia
nascita, la sera del 2 ottobre, dal balcone di palazzo Venezia il Duce annunciò
all’Italia di aver dichiarato guerra all’Etiopia. Per volere di Benito, il
discorso venne trasmesso in tutto il Paese, nelle piazze dove milioni di persone
stavano in religiosa attesa del suo verbo. Tra i tantissimi raccolti nella
piazza principale della nostra città, doveva esserci anche mio padre Ernesto,
operaio delle Poste con la mansione di guardafili del telegrafo. E in quanto
dipendente statale precettato per l’adunata in onore dell’attacco al maledetto
Negus, al secolo Hailè Selassiè. Però mio padre in piazza del Cavallo non ci
andò. Gli era appena nato un figlio, il primo, e questo evento gli sembrava un
motivo più che valido per restare accanto alla moglie, mia madre Giovanna. Devo
ricordare che in quel tempo le donne partorivano in casa con l’assistenza di una
levatrice, ossia di un’ostetrica. Così aveva fatto Giovanna, urlando un paio
d’ore poiché ero grosso e lungo. E non volevo saperne di uscire dalla sua
pancia. Il giorno successivo, era il 3 ottobre, due della Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale si presentarono in casa nostra e chiesero a Ernesto
perché mai non fosse andato anche lui in piazza ad ascoltare il Duce. Mio padre
spiegò che gli era appena nato un figlio. «Maschio o femmina? », domandarono i
militi. «Maschio», rispose Ernesto. E i militi, una coppia di bonaccioni in
divisa e camicia nera, si congratularono: «Ottimo! Anche lui diventerà un
soldato della Patria fascista». Mio padre gli offrì un bicchiere di Barbera che
bevvero alla salute di mia madre e dell’inconsapevole sottoscritto, addormentato
nella culla. E l’ispezione finì lì. A vestire la divisa di soldato del Duce non
feci in tempo perché il regime cadde molto prima. In compenso, il 1° ottobre
1941, giorno del mio sesto compleanno, divenni un Figlio della lupa. Era il
gradino iniziale della scala inventata per la gioventù del regime. A sette anni,
in seconda elementare, si restava sempre Figli della Lupa. A otto si diventava
Balilla. Si chiamava Balilla anche il giornaletto che leggevo, una specie di
concorrente del Corrierino dei piccoli. Lì avevo imparato chi erano i nemici
dell’Italia. Re Giorgetto d’Inghilterra. Il ministro Ciurcillone. Rusveltaccio
Trottapiano, presidente americano, che ubbidisce alla signora, la terribile
Eleonora. Ma i più pericolosi erano i russi che si ammazzavano tra di loro. Il
terribile Stalino, l’Orco rosso del Cremlino, dice urlando come un pazzo alle
guardie del palazzo: i compagni qui segnati siano tutti fucilati! Nell’estate
del 1943, conclusa la seconda elementare, i miei genitori decisero di mandarmi
alla colonia montana delle Regie Poste di Alessandria. Era un luogo triste,
nascosto fra alture basse vicine a Biella, dove pioveva sempre. Le giornate si
aprivano con l’alza bandiera e le preghiera del Balilla, recitata a turno da uno
dei ragazzini: «Signore, benedici il Duce nostro nella grande fatica che Egli
compie. E poiché l’hai donato all’Italia, fallo vivere a lungo per la Patria e
fa’ che tutti siano degni di lui...». Ogni mattina, dopo il caffelatte,
cominciava l’ora di dottrina fascista. Ed era l’unica vera attrazione della
giornata. Il merito andava all’insegnante: una ragazzona maestosa, un trionfo di
capelli rossi e un seno stupefacente, figlia del capostazione della nostra
città. Era una cliente della modisteria di mia madre e aveva fatto impazzire il
panettiere del negozio accanto. Quando andavo a comprare il pane, il fornaio mi
domandava: «Le hai viste quelle tette? Darei mille lire per poterle pastrugnare!
». Ma la maggiorata dai capelli rossi non badava alle occhiate dei maschi, tanto
meno alle nostre di ragazzini troppo arditi. E per tenerci a bada, escogitava
ogni giorno una preghiera per il Duce. A me ne toccò una che recitava: «Gioventù
italiana di tutte le scuole, prega che la Patria non manchi al suo radioso
avvenire. Chiedi a Iddio che il ventesimo secolo veda Roma centro della civiltà
latina, dominatrice del Mediterraneo, faro di luce per le genti del mondo». Un
mese dopo, era la fine del luglio 1943, tutto sembrò sparire con la caduta del
Duce. In piazza si videro molte manifestazioni di giubilo, ma la maggior parte
della gente se ne restò a casa. La guerra iniziata nel 1940, e i tanti ragazzi
morti su troppi fronti, stavano allontanando dal fascismo un numero sempre più
grande di italiani. Ma nessuno aveva il coraggio di riconoscere di essere stato
un fascista senza pentimento. E di aver sostenuto con entusiasmo un regime che
adesso ci aveva portato al disastro. Il nostro fascismo esistenziale lo si
constatò sino in fondo in due momenti terribili che confermarono la natura
crudele della dittatura di Mussolini. Il primo, nel 1938, fu il varo delle leggi
razziali contro gli ebrei. Il secondo l’inizio delle deportazioni nei campi di
sterminio nazisti di migliaia di israeliti, quando l’Italia del centro e del
nord stava sotto la Repubblica sociale, un regime sostenuto dai tedeschi. Mi
rammento bene quel che accadde in quei momenti. Per il motivo che non accadde
nulla. Nella mia piccola città, gli ebrei perseguitati e poi uccisi nelle camere
a gas li conoscevamo tutti. Erano nostri vicini di casa, insegnanti nelle nostre
scuole, medici che ci avevano curato, clienti della modisteria di mia madre. Ma
nessuno aprì bocca. Pochi li compatirono. Pochissimi gli offrirono un aiuto.
Quando ci ripenso oggi, mi rendo conto di una verità terribile. Pure in casa
mia, dove ogni sera si discuteva di tutto, della guerra, del fascismo, di
Mussolini e dei suoi gerarchi, della Repubblica sociale e dei tedeschi, nessuno
disse anche una sola parola sulla fine di persone identiche a noi. E mi domando
se, insieme al nostro fascismo mentale, dentro il cuore di ciascuno non si
celasse il mostro dell’indifferenza disumana, della cattiveria, della ferocia.
Per tutto questo mi sembra grottesco che nell’Italia del 2014 qualcuno chieda a
qualcun altro: tuo padre era fascista, tuo nonno portava la camicia nera? La
verità è che tutti eravamo fascisti o ci comportavamo come se lo fossimo. Oggi
la mia speranza è che lo sfacelo della nostra classe politica non metta in pista
qualche nuovo signore autoritario che ci obblighi a innalzare la bandiera voluta
da lui. Il colore non importa. Però mi domando quanti accetterebbero di
sventolarla. E temo che anche stavolta non sarebbero pochi.
Prima di “Bella ciao” la
canzone più nota era “Eia eia alalà”. La cantavano gli italiani sbarcati in
Albania per spezzare le reni alla Grecia. Poi i Figli della Lupa e i piccoli
Balilla. “La verità è che tutti eravamo fascisti o ci comportavamo come se lo
fossimo” scrive Giampaolo Pansa che quell’Italia l’ha vissuta e poi l’ha
raccontata per demolire soprattutto la mitizzazione arbitraria della guerra
civile. Perché l’Italia è stata una nazione in grandissima parte attratta dal
Fascismo, tutti gli italiani sono stati fascisti, hanno adorato Mussolini e gli
hanno obbedito, almeno fino alla notte del 25 luglio 1943 quando un gruppo di
gerarchi, e non un’insurrezione popolare, mandò a gambe all’aria il Duce.
Nell'Italia del Duemila può presentarsi l'avventura autoritaria di un nuovo
Benito Mussolini? Anche oggi siamo un paese strozzato da una crisi pesante, con
una casta di partiti imbelli e un possibile conflitto tra ceti diversi. Sono
queste assonanze con gli anni Venti del Novecento che hanno spinto Giampaolo
Pansa a scrivere "Eia eia alalà", un antico grido di vittoria riesumato dallo
squadrismo fascista. Il racconto inizia con la lotta di classe esplosa tra il
1919 e il 1922, guidata dai socialisti e sconfitta dall'inevitabile reazione
della borghesia. Il nero nacque dal rosso: l'estremismo violento delle sinistre
non poteva che sfociare nella marcia su Roma di Mussolini, il primo passo di una
dittatura ventennale. La ricostruzione di Pansa ruota attorno a un personaggio
esemplare anche se immaginario: Edoardo Magni, un agrario padrone di una tenuta
tra il Monferrato e la Lomellina. Coraggioso ufficiale nella Prima guerra
mondiale, finanziatore delle squadre in camicia nera, all'inizio convinto della
necessità di una rivoluzione fascista ma via via sempre più disincantato. Sino a
diventare un sostenitore del leader squadrista dissidente Cesare Forni, ritenuto
da Mussolini un nemico da sopprimere. Magni è il protagonista di un dramma a
metà tra il romanzo e la rievocazione storica, gremito delle tante figure che
attorniano il Duce, una nomenclatura potente descritta con realismo. In Eia eia
alalà Pansa accompagna il protagonista nello scorrere degli anni e nella
sfiducia crescente verso il regime. Abbiamo di fronte un ricco signore alle
prese con tante incertezze e molti amori: Marietta, Rosa, Anna, Elvira e infine
Marianna. Sarà questa giovane donna ebrea incontrata nel ghetto di Casale a
fargli scoprire lo sterminio degli israeliti della città, con un viaggio
tormentato che alla fine la condurrà a una decisione inaspettata. Grazie alle
ricerche di Marianna, Magni conosce una dopo l’altra le storie degli ebrei
uccisi ad Auschwitz. Nell’indifferenza gelida dei tanti che si voltavano
dall’altra parte e fingevano di non vedere. Eia eia alalà è anche l’affresco di
un’Italia che assomiglia non poco a quella di oggi: distratta, egoista e forse
pronta ad accettare nuove tragedie.
.. Pansa: "Vi racconto
l'Italia in cui tutti, o quasi, gridavano Eia Eia Alalà". Nel suo nuovo libro
Giampaolo Pansa autore del «Sangue dei vinti» ricostruisce l'ascesa del fascismo
e il consenso di massa al regime. Che molti dimenticano..., scrive Matteo Sacchi
su “Il Giornale”. Si chiama Eia Eia Alalà ed è in libreria da oggi. Se non
bastasse il titolo (a caratteri cubitali rossi in stile molto littorio), ci
pensa il sottotitolo a spiegare che cosa si può trovare in questo volume
(Rizzoli, pagg. 378, euro 19,90) a firma Giampaolo Pansa: Controstoria del
fascismo. Pansa infatti, usando l'artificio del romanzo - «a me il lettore piace
acchiapparlo per la coda, non annoiarlo a colpi di saggio» - mette i puntini
sulle «i» della storia italiana della prima metà del '900 per spiegare che cosa
sia stato e come sia nato il Ventennio mussoliniano. Il suo espediente narrativo
è partire dalla sua terra e raccontare attraverso le vicissitudini del
possidente terriero Edoardo Magni (personaggio di fantasia, ma nel libro ce ne
sono molti realmente esistiti) come l'Italia sia diventata, convintamente,
fascista. E lo sia rimasta a lungo. Non c'è bisogno di dire, viste le scomode
verità venute a galla con i suoi precedenti libri (a partire da Il sangue dei
vinti ) e il tema, che la polemica è garantita. E che qualche gendarme della
memoria, per usare un'espressione dello stesso Pansa, avrà qualcosa da dire.
Dunque, Eia Eia Alalà.
L'urlo di una generazione?
«Non sai quante volte l'ho
sentito gridare quando ero bambino ed ero un Figlio della Lupa. Ho anche una
foto in cui, piccolissimo, facevo il saluto romano, davanti al monumento ai
Caduti. Non ho fatto in tempo a diventare balilla, però. Il regime è caduto
prima. E per quanto in casa dei gerarchi sentissi dire peste e corna. Il
sottofondo della vita degli italiani era quello lì».
Per questo l'hai scelto
come titolo?
«In parte, volevo anche un
titolo che cantasse. Che rendesse l'idea di quello che a lungo il regime è stato
per gli italiani. L'avventura del fascismo è stata legata all'idea di vincere,
di migliorare il Paese. Rende l'idea di quella giovanile goliardia che affascinò
molti. Un fascino che iniziò a incrinarsi solo con le orribili leggi razziali e
crollò definitivamente solo con gli orrori della guerra».
Non molti hanno voglia di
ricordare che il fascismo ebbe davvero una presa collettiva. Tu invece questo lo
racconti nel dettaglio...
«Ho voluto fare un racconto
senza il coltello tra i denti. Che cosa rimprovero io a storici, anche molto più
bravi di me che di solito scrivono su Mussolini? Ma di avere una partecipazione
troppo calda, schierata. Io, anche grazie all'invenzione di un personaggio come
Magni, invece ho cercato di fare un racconto neutrale. Per chi c'era è
un'ovvietà che il fascismo ebbe un consenso di massa. Tutti erano fascisti
tranne una minoranza infima. Gli antifascisti erano una scheggia microscopica
rispetto a milioni di italiani. Gli italiani ieri come oggi volevano solo un po'
di ordine... E Mussolini glielo diede. Ai più bastò».
Tu attribuisci molte
responsabilità ai socialisti che favorirono involontariamente il successo del
fascismo, regalandogli il potere... A qualcuno verrà un colpo!
«La guerra perpetua tra rossi
e neri creava sgomento. Gli scioperi nelle città, ma soprattutto nelle campagne
crearono il caos... Si minacciò la rivoluzione senza essere capaci di farla
davvero. Si diede l'avvio alle violenze senza calcolare quali sarebbero state le
reazioni. E per di più, esattamente come la sinistra attuale, i socialisti erano
perpetuamente divisi. Pochi capirono quanto fosse grave la situazione. Tra
questi Pietro Nenni, il quale a proposito della scissione comunista del 1921
scrisse: "A Livorno è cominciata la tragedia del proletariato italiano"».
Però qualche responsabilità
la ebbe anche la borghesia italiana, o no?
«Noi non avevamo la tradizione
liberale di altri Paesi. Ed eravamo in una situazione economica terribile che a
tratti mi ricorda quella di oggi. C'erano dei partiti-casta in cui la gente non
si riconosceva e lo scontro tra ceti (o classi) era alle porte... Il nero è nato
dal rosso, la paura ha fatto allineare gli italiani come vagoni ferroviari
dietro a Mussolini. Non per obbligo, nonostante le violenze degli squadristi.
Sono stati conquistati dalla grande calma dopo la marcia su Roma. L'italiano dei
piccoli centri, delle professioni borghesi, voleva soltanto vivere tranquillo.
Avuta la garanzia di una vita normale e dello stipendio a fine mese, di chi
fosse a palazzo Chigi o a palazzo Venezia gli importava poco».
Qualunquismo?
«L'Italia continuava a essere
soprattutto un Paese agricolo. Lo sciopero agrario del 1920 rischiò di
paralizzare la campagna. Le leghe rosse impedendo la mungitura, nel libro lo
racconto, minacciarono di far morire le mucche... Da lì nacque un fascismo
virulento e tutto particolare che poi si prese la rivincita. Il fascismo è stato
il ritratto di gruppo degli italiani. C'era dentro di tutto. C'erano molte forze
vitali e diverse. Poi il criterio dell'obbedienza cieca, pronta e assoluta che
tanto propagandava Starace fece sì che nel cerchio di persone più vicine al Duce
si andasse verso una triste selezione al ribasso».
In Eia Eia Alalà descrivi
la parabola triste di molti fascisti «diversi».
«La scollatura tra italiani e
regime iniziò con le leggi razziali, non prima. Lì inizio il male assoluto, la
vergogna. Una delle figure più tragiche del libro è Aldo Finzi. Di origine
ebraica, aviatore, fascista della prima ora, poi messo ai margini e fucilato
alle Fosse Ardeatine. Poi è arrivata la guerra e la rimozione di massa».
Ma davvero vedi così tante
assonanze tra l'oggi e l'avvento del fascismo?
«È possibile non vederle?
L'unica variante è il terrorismo internazionale. Ed è una variante
peggiorativa».
“All’epoca dell’Italia che
gridava eia eia alalà, Giampaolo Pansa era un bambino” scrive Federico Guiglia
del Messaggero.
«Ma quel grido lo sentivo di
continuo», ricorda il giornalista e scrittore. Ha appena pubblicato un libro che
proprio quelle parole riporta in copertina: Eia eia alalà, controstoria del
fascismo, Rizzoli editore. Un racconto sul passato per dire del presente:
guardate che cos’è successo, e può ancora succedere, lui dice. «Quando il
fascismo è caduto, io avevo sette anni e mezzo ed ero figlio della Lupa a Casale
Monferrato», riprende il filo del discorso. «Ho pure una foto scattata da mio
padre davanti al monumento ai Caduti della prima guerra mondiale, in cui
apparivo vestito in quel modo un po’ ridicolo con fasce bianche e camicia nera e
facevo il saluto romano. Insieme con la canzone «Giovinezza, giovinezza,
primavera di bellezza», eia eia alalà era un po’ il “jingle” del fascismo». «Il
nero nacque dal rosso» è la riflessione-chiave dei personaggi del libro
(dall’immaginario possidente terriero Edoardo Magni al vero edicolante di Pansa
citato in prefazione).
Ma socialisti e fascisti
erano nemici irriducibili: come fa a imputare ai primi la nascita dei secondi?
«Guardiamo le date. Nel 1915
per noi comincia la prima guerra mondiale, che finisce nel novembre del 1918. I
soldati tornano a casa e la grande maggioranza di loro erano poveracci e
contadini. S’assiste all’espansione politica e sindacale della sinistra di
allora. C’era il Partito socialista. C’erano le leghe operaie e contadine che
nell’Italia della pianura padana si svilupparono molto. Dopo la prima vittoria
elettorale del Partito socialista, comincia quello che Pietro Nenni chiamò il
biennio rosso. Non soltanto una serie di scissioni a sinistra, ma soprattutto
questi matti delle leghe che annunciavano l’arrivo del bolscevismo e della
rivoluzione. Dicevano che l’Italia doveva fare come Lenin. Violenze dappertutto,
in particolare nelle campagne. Basta ricordare il grande sciopero agrario del
1920, quando le leghe rosse, per piegare i proprietari agricoli, ordinarono ai
braccianti e ai mungitori di lasciar morire le vacche per non essere munte».
Sta dicendo che, per paura
del rosso, gli italiani diventano neri?
«A ogni azione corrisponde una
reazione. È quello che non hanno capito le sinistre, la frazione che nel 1921
fondò a Livorno il Partito comunista, i massimalisti. L’hanno capito un po’ i
socialisti riformisti e l’hanno scritto sul loro giornale, La Giustizia. Non è
che il fascismo è un mostro che nasce per caso. È un mostro che viene creato dai
suoi avversari, che fanno di tutto per spaventare la borghesia».
La sindrome per l’uomo solo
al comando ha colpito una volta sola o può colpire ancora il sentimento, le
paure, il conformismo di tanti italiani?
«La sindrome la vediamo anche
oggi. Quando un presidente del Consiglio invece di rivolgersi al Parlamento si
rivolge alla gente e vuole essere solo a decidere, il rischio c’è sempre. È
proprio uno dei motivi per cui ho scritto il libro. Com’era l’Italia del
1920/21? Stremata dal punto di vista economico dopo una guerra mondiale
pazzesca. Aveva una classe politica, oggi diremmo una casta, screditata,
ritenuta imbelle e corrotta. E poi c’erano i conflitti sociali. Ci sono affinità
con l’Italia di oggi? Temo di sì. E poi gli italiani sono gente che ama essere
comandata da un signore solo. Questo non è il Paese dalla tradizione democratica
inglese o americana».
Fin dai tempi della storia
narrata nei libri di Montanelli, gli storici non amano i giornalisti che si
cimentano sul loro terreno. Avendo lei mescolato romanzo e storia non teme di
avallare il loro pregiudizio?
«Non me ne frega nulla del
pregiudizio. Bisogna avere una patente speciale per scrivere di storia come per
guidare la Ferrari? Io ho profonda disistima per la classe accademica degli
storici italiani, che è egemonizzata dai postcomunisti. Quando nel 2003 ho
pubblicato Il Sangue dei vinti, che ha venduto più di un milione di copie, sono
stato bombardato da tutte le parti. Ma io li conosco. Sono stato uno studente
diligente, facendo una tesi di laurea – poi pubblicata da Laterza – sulla guerra
partigiana. Arrivato a settantanove anni, Pansa ha soltanto uno di cui
preoccuparsi: il Padreterno. Non ho ancora capito quanto tempo mi lascerà per
scrivere e rompere le scatole al prossimo. Ma non ce l’ho con tutti i
professori. Ho un grandissimo rispetto per Renzo De Felice, di cui sono stato
allievo indiretto avendo letto tutti i suoi libri. E non solo lui».
De Felice fu il primo a
parlare di “anni del consenso” per il fascismo, almeno fino alle vergognose
leggi razziali del 1938.
«Il consenso c’era, non l’ha
inventato De Felice. Non è vero che Mussolini è arrivato e ha ammanettato
milioni di italiani. Gli italiani sono stati quasi tutti fascisti. Tranne una
minoranza infima di comunisti, cattolici, socialisti repubblicani, anarchici che
stavano in galera o costretti a espatriare. Poi c’era chi si iscriveva al fascio
perché obbligato, perché gli conveniva, per quieto vivere. Se oggi spuntasse un
altro Mussolini, avremmo un po’ di manifestazioni in piazza, ma la maggioranza
degli italiani gli andrebbe dietro. L’attualità del mio libro è proprio questa:
guardate un po’ che cosa è successo, come la storia drammatica degli ebrei
deportati nella primavera del ’44 che racconto. E la gelida indifferenza di
tanti che si giravano dall’altra parte».
"A 10 anni dal "Sangue dei
vinti" lotto ancora con le bugie rosse". Il giornalista che per primo ha
raccontato gli orrori della guerra civile ha scritto una nuova prefazione al suo
"classico". E ci racconta perché, scrive Matteo Sacchi su “Il Giornale”. Dieci
anni fa un grosso sasso, quasi un meteorite, precipitò da grande altezza nel
piccolo stagno della storiografia italiana. Uno stagno dove a gracidare erano,
chi meglio chi peggio, più o meno sempre gli stessi, e da un bel po'. A
lanciarlo un «non professionista», in senso accademico, della Storia: il
giornalista Giampaolo Pansa. Con il suo Il sangue dei vinti (Sperling&Kupfer)
riproponeva il tema delle uccisioni sommarie praticate dai partigiani durante la
guerra civile, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. E non solo. Metteva per
la prima volta in luce i virulenti strascichi di quello scontro. Le
numerosissime esecuzioni sommarie proseguite sino al 1948. Soprattutto in quello
che era conosciuto come il «Triangolo della morte» che aveva per vertici
Castelfranco Emilia, Piumazzo e Mazzolino. E spesso a morire non erano solo i
fascisti, ma chiunque venisse visto come d'ostacolo a una futura rivoluzione
comunista.
Il libro, come è noto, fu subito aggredito dai "guardiani della memoria"
partigiana. Spesso senza nemmeno una lettura sommaria, a prescindere. Oggi a
dieci anni di distanza, seppure molto a fatica, la percezione sul tema è
cambiata. Ecco perché a questa nuova edizione (Sperling&Kupfer, pagg. 382 euro
11,90) Giampaolo Pansa ha aggiunto una nuova prefazione in cui si leva qualche
sassolino dalla scarpa: «"Arrendetevi siete circondati!". Urla così Beppe
Grillo... Il suo grido di battaglia mi sembra adatto a descrivere una situazione
molto diversa. Anche gli avversari dei miei libri sulla guerra civile sono nei
guai. Hanno scelto di farsi circondare da se stessi, rifiutando qualsiasi
revisionismo sull'Italia tra in 1943 e il 1945. E dovrebbero arrendersi alla
sconfitta». Ne abbiamo parlato con lui.
Ma a dieci anni dal Sangue
dei vinti che sensazione ha provato a tornare su quelle pagine?
«Io ho scritto moltissimi
libri e di norma non li rileggo mai dopo che ho licenziato le seconde bozze...
Ho fatto così anche col Sangue dei vinti: l'ho tenuto lì come fosse il libro di
un altro. Rileggendolo ora, quando l'editore mi ha chiesto di ripubblicarlo mi
sono reso conto davvero di quanto sia gonfio di sangue, di esseri umani citati
per nome e per cognome, di morti terribili. È per questo che ho accettato la
ripubblicazione, penso possa avere un senso per i giovani, per chi aveva dieci
anni quando è uscito la prima volta e ora ne ha venti... Credo possa raccontare
molto anche a questa Italia di oggi cosa sia stato quel conflitto civile che è
durato sino al '48. Perché io sono convinto che la guerra intestina sia finita
con il 18 aprile del 1948 quando De Gasperi, vincendo le elezioni, mise il Paese
su un binario di tranquillità».
All'uscita il libro provocò
il finimondo. Se lo aspettava?
«No, si fece molto più
"rumore" di quanto all'epoca potessi prevedere. Forse in un certo senso perché
il mio libro dimostrava che era errato il principio secondo cui la Storia la
fanno soltanto i vincitori. Quella dei vincitori è una storia bugiarda. Solo che
questo era inaccettabile per molti, e in parte è inaccettabile ancora oggi.
C'era e c'è chi pensa che i fascisti avessero un solo dovere: quello di stare
zitti, senza nemmeno poter ricordare i propri morti. Ma soprattutto non
scrivere. Ma io non volevo una storia di parte, a me interessavano i fatti,
raccontare che l'Italia rischiò di diventare l'Ungheria del Mediterraneo».
E Lei arrivava da
sinistra...
«Sì, io non mi chiamavo
Giorgio Pisanò. Io di Pisanò ho sempre avuto grandissima stima: è stato un
pioniere in questi studi. Ma Giorgio veniva delegittimato perché veniva dal
mondo del fascismo... era chiaramente un intellettuale di destra».
Alla fine Il sangue dei
vinti è diventato un ciclo. Lei è rimasto a lungo in questo filone.
«Il ciclo è iniziato per
essere precisi col libro precedente, I figli dell'Aquila, e poi è proseguito con
altri titoli come Sconosciuto 1945, La grande bugia, I gendarmi della memoria. E
se io sarò ricordato per qualcosa credo che lo sarò proprio per il ciclo del
Sangue dei vinti. Me ne accorgo perché le persone mi fermano per ringraziarmi...
Certo se vado in una zona dove dominano i centri sociali è l'opposto. Io dovuto
smettere di andare a parlare in pubblico. Per fortuna i libri buoni si fanno
strada da soli...».
Ecco, allora partendo dal
tuo titolo parliamo anche dei “gendarmi della memoria”. Nell'introduzione cita
Sergio Luzzatto, che con Lei era stato molto duro, e ora a causa del suo
Partigia è finito sotto il tiro incrociato di altri gendarmi...
«Già quando presentai I figli
dell'Aquila a Genova Luzzatto mi sottopose a un assalto verbale non
indifferente... Ora lui ha scritto Partigia. Io l'ho letto e per me non racconta
una storia diversa da molte altre... Certo per uno come lui significa
rimangiarsi un atteggiamento che prima non ha mai voluto cambiare. Mi ha dato
anche atto di aver scritto i miei libri con rispetto della verità... Ovviamente,
però, appena si è messo fuori dal giro dei "gendarmi della memoria", non
gliel'hanno perdonata. Infatti cosa è accaduto? Sebbene in modo più soft di come
fecero con me, gli sono andati tutti addosso. Ho letto le cose velenose scritte
da Gad Lerner, che credo non abbia neppure aperto il saggio. Lo ha demolito
senza pietà. Anche con Il sangue dei vinti iniziarono il fuoco di sbarramento
sette-otto giorni prima di avere il libro a disposizione. Ne cito due per tutti:
Giorgio Bocca e Sandro Curzi... Ma non è elegante far polemica con chi non c'è
più. Qualcuno arrivò a dire che avevo scritto Il sangue dei vinti per compiacere
Berlusconi che mi avrebbe poi ricompensato con la direzione del Corriere della
Sera... Cose deliranti. Provocate da code di paglia chilometriche. Eppure i
gendarmi sanno bene che queste cose sono accadute. Io ho ricevuto in dieci anni
20mila lettere che provano quei fatti».
Faccio l'avvocato del
diavolo. Non hai mai pensato che le sue inchieste siano state sfruttate, a
destra, anche politicamente?
«C'è una destra fatta di
persone che hanno subìto per decenni il silenzio. Sono contentissimo di averli
aiutati. Ma la destra politica non aveva molti mezzi culturali per sostenere
queste battaglie. Già nella Prima Repubblica si diceva che la Dc pensava agli
affari, mentre il Pci ai mezzi di propaganda culturale. Le cose non sono
cambiate di molto. Io non sono mai stato invitato da Fabio Fazio, e sappiamo
quanto questo possa contare per un libro. Ma in fondo questo è niente. Contiamo
quante cattedre di Storia contemporanea sono affidate a docenti di sinistra...
Ed è una materia fondamentale».
Quanti anni ci vorranno per
arrivare a un giudizio equanime su questo periodo?
«Prima o poi succederà. La
Storia è una talpa che scava, prima o poi esce fuori. La verità emergerà,
ammesso che si abbia ancora interesse a cercarla».
La nostra storia. Illusi e
disillusi dal fascismo nel nuovo libro di Giampaolo Pansa, scrive Dino Messina
su “Il Corriere della Sera”. Fascismo «autobiografia della nazione», come
sostenne Piero Gobetti, oppure parentesi della storia italiana, come scrisse
Benedetto Croce? Dopo aver letto il nuovo libro di Giampaolo Pansa “Eia eia
alalà”, edito da Rizzoli (pagine 376, euro 19,90), abbiamo rafforzato la
convinzione che avesse ragione Gobetti. Attraverso il punto di vista di un
personaggio di invenzione, Edoardo Magni, proprietario terriero tra il
Monferrato e la Lomellina, Pansa racconta in forma di romanzo, in pagine ricche
di fatti reali, di colpi di scena (e anche di sensualità), il dramma di un
popolo all’indomani del primo conflitto mondiale. Un Paese, soprattutto al Nord,
dilaniato dallo scontro tra le potenti organizzazioni sindacali, un Partito
socialista massimalista, e una classe borghese timorosa che l’Italia potesse
fare la fine della Russia bolscevica. In questa vicenda, come sa chi ha nozioni
di storia (l’autore cita i classici di Renzo De Felice e di Emilio Gentile),
ebbero un ruolo fondamentale i reduci della Grande guerra, gli ufficiali che
avevano combattuto per più di tre anni e che si trovarono spaesati nella nuova
Italia. Reduce è il protagonista immaginario del romanzo, così come lo erano
tanti personaggi storici realmente vissuti. A cominciare da Cesare Forni,
tenente d’artiglieria tra i primi ad aderire ai Fasci di combattimento,
protagonista della reazione agraria, a capo dei manipoli che misero a ferro e
fuoco Milano con gli assalti alla sede dell’«Avanti!» e a Palazzo Marino. Un ras
locale che presto si mise in contrasto con il regime, al punto da subire
un’aggressione davanti alla stazione di Milano dagli stessi sgherri di Mussolini
(Amerigo Dumini, in primis) che sequestrarono e uccisero Giacomo Matteotti nel
giugno 1924. Due terzi del libro di Pansa sono dedicati agli albori e
all’avvento del fascismo, prima che diventasse regime. È la storia di
un’illusione e di una rapida disillusione, almeno per i protagonisti messi a
fuoco da un grande giornalista che si è saputo reinventare come scrittore, sia
di libri importanti di storia (checché ne abbia scritto qualche accademico con
la puzza al naso) come “Il sangue dei vinti”, in cui ha messo in luce il lato
oscuro della Resistenza, sia di romanzi come questo. La forza di “Eia eia alalà”
sta anche in una narrazione della storia del fascismo, o meglio della sua
«controstoria», come recita il sottotitolo, da un punto di vista locale, quello
delle terre attorno a Casale Monferrato dove Pansa è nato nel 1935 e a cui ha
dedicato pagine importanti. Scontri sociali e intrighi politici sono raccontati
in maniera del tutto originale: voce narrante, si diceva, è il latifondista
Magni, finanziatore di Forni e sempre impegnato in avventure amorose. Le sue
emancipate e spregiudicate amanti hanno il ruolo di fargli aprire gli occhi
sulla reale natura del regime. Attorno al protagonista si muovono figure
realmente vissute come il quadrumviro Cesare Maria Vecchi o i conti Cesare e
Giulia Carminati. Uno dei quadretti più spassosi è l’incontro galante fra
l’avvenente contessa Giulia e un Mussolini assetato di sesso. Il Duce viene
ritratto nei momenti privati, ma anche nelle stanze del potere, circondato da
carrieristi e affaristi di cui ha bisogno e che non lo contrastano quasi mai,
anche nelle scelte più sciagurate. L’atto conclusivo dell’affresco disegnato da
Pansa riguarda le leggi razziali. Davanti alla persecuzione degli ebrei,
all’indifferenza degli italiani per la sorte di quei ragazzi che non potevano
più frequentare le scuole, dei professori che non potevano più insegnare, dei
professionisti cacciati dai loro studi, la disillusione del protagonista diventa
totale. Edoardo, un fascista in buona fede, un pavido che non ha mai saputo
reagire alle nefandezze del regime, assomiglia ai milioni di italiani che, anche
per quieto vivere, applaudirono il Duce e che dopo vent’anni si accorsero del
disastro.
Pansa: «Partiti in crisi,
sembra l’Italia prima del fascismo», scrive Antonella Filippi su “Il Giornale di
Sicilia”. Non serve neppure scavare troppo: le analogie tra l'Italia di oggi e
quella del primo dopoguerra, tra il 1919 e il 1922, vengono a galla con
facilità. Estrema. Crisi economica, partiti inaffidabili come la casta di
governanti litigiosi e inconcludenti, conflitti sociali. Deve essere un paese
infrangibile il nostro, capace di resistere a tutto, se ancora, dopo quasi
cent'anni, annaspa ma resiste. Nel suo ultimo libro Giampaolo Pansa, racconta
quell'Italia cercando questa, contraddice teoremi, avanza ipotesi, ci consegna
certezze. Sarà per questo che il suo “Eia Eia Alalà” (ed. Rizzoli), antico grido
di vittoria adottato dallo squadrismo fascista, è già un best-seller. Una
“controstoria del fascismo” nascosta in un romanzo. Pansa: «A un mese
dall'uscita, delle 70 mila copie stampate è già stato venduto il 30%. Per
aggirare la noia del saggio, ho usato l'escamotage del romanzo e ho cercato di
rendere attraente la storia: Edoardo Magni è un personaggio di fantasia, un
possidente terriero, prima sostenitore della rivoluzione fascista ma a poco a
poco sempre più disincantato, fino a supportare il dissidente squadrista Cesare
Forni che, invece, è realmente esistito. Tante incertezze quelle di Magni,
accanto a una sfilza di amor che si chiamano Marietta, Rosa, Anna, Elvira. E
Marianna: è lei ad aprirgli gli occhi sulle deportazioni degli ebrei ad
Auschwitz». Questo paese e i suoi abitanti resistono a tutto, impermeabili a
governi e crisi… «L'Italia è stata in grandissima parte attratta dal fascismo:
tutti eravamo fascisti o ci comportavamo come se lo fossimo. Tutti hanno adorato
Mussolini e gli hanno obbedito, almeno fino alla notte del 25 luglio 1943. Dopo
la marcia su Roma, Mussolini aveva un potere assoluto: il 99% degli italiani era
fascista, sbaglia chi sostiene che l'Italia non voleva la dittatura. Il Duce ha
commesso errori imperdonabili, avallando le leggi razziali, alleandosi con
Hitler ed entrando in guerra: se non lo avesse fatto sarebbe morto nel suo
letto, e non a gambe per aria, accanto alla Petacci. Come il generale Franco che
tenne la Spagna fuori dalla guerra».
Lei viene accusato di
revisionismo…
«E ne sono felice, anzi vorrei
esserlo ancora di più. L'accusa viene da vecchi accademici di sinistra, a fronte
di un dato incontestabile: in una guerra civile ci sono due antagonisti, uno
nero e uno rosso, e i caduti si trovano da entrambe le parti, non solo da quella
rossa. Il mio libro “Il sangue dei vinti” ha venduto un milione di copie, e
ancora la gente mi fa i complimenti per quello sguardo differente sulla guerra e
i suoi morti. Essere un revisionista per me è un vanto: la storia non si può
tenere sottovetro, vengono fuori nuovi archivi, si chiariscono dei misteri,
emergono personaggi ritenuti secondari».
Cosa ha in comune l'Italia
odierna con quella che preparò la dittatura?
«Il nostro era un paese
povero, fatto di un'economia agraria. L'Italia di allora, come quella di oggi,
era stremata da una crisi economica forte, scoppiata subito dopo la fine di una
guerra durata tre anni, che aveva fatto un gran numero di vittime e che aveva
cambiato profondamente la società italiana. Allora, come oggi, il sistema dei
partiti era screditato. Ed era esploso quello che ora è latente, cioè il
conflitto tra ceti. Queste simmetrie mi hanno colpito».
Quella sua convinzione che
«il nero nasce dal rosso» è la risposta alla domanda: chi, dopo il mattatoio
delle trincee, ha fatto nascere il fascismo?
«Dimostro che il padre del
fascismo è il sinistrismo parolaio, quello degli slogan, quello violento che non
poteva non sfociare nella marcia su Roma di Mussolini, primo atto verso una
dittatura lunga vent'anni. Lo sciopero agrario del 1920 paralizzò le campagne.
Esercitando uno strapotere dispotico, le leghe rosse arrivarono a impedire la
mungitura, a timbrare le mani dei bovari, minacciando di far morire le mucche.
Esplose l'odio di classe: concime che farà spuntare la pianta dello squadrismo.
La sinistra si è uccisa da sola, non potevano non aspettarsi una reazione della
borghesia agraria».
La nostra è una democrazia
debole.
«Si sta costruendo una
situazione istituzionale anomala, con un partito unico, senza opposizione: così
la democrazia va in tilt. La democrazia, come la giustizia, si regge se i due
piatti della bilancia sono in equilibrio o si alternano. Renzi egemonizza,
procede a colpi di annunci, promesse mai realizzate, spese per cui non ci sono i
fondi. L'Italia è ammalata, è come una persona che rischia una grave crisi,
anche se non è esattamente in coma».
Potrebbe allora
ri-presentarsi l'avventura autoritaria di un nuovo Benito Mussolini?
«Il rischio non è immediato ma
c'è: con gli errori che sta commettendo, la sinistra potrebbe rendersi complice
della nascita di una nuova dittatura».
L'innamoramento di
Berlusconi per Renzi cosa nasconde?
«Servirebbe uno psicanalista
per capirci qualcosa. Berlusconi ha la sua veneranda età: io ho solo un anno più
di lui ma non ho la pretesa di dirigere un partito, preferisco stare a casa,
scrivere, leggere, guardare il calcio in tv. Berlusconi ha un partito che mia
nonna Caterina definirebbe “ai piedi di Cristo”, cioè spappolato, in grande
difficoltà: se pensa che Renzi possa essere il suo figlioccio, sbaglia di
grosso. Lui ha 78 anni, il premier 39, c'è un abisso di energie, forze. E Renzi
se ne frega, cerca di utilizzare Berlusconi come stampella. L'unico punto
misterioso è il rapporto di entrambi con Denis Verdini, da dove derivi a Verdini
tutto questo potere, non è mai stato scandagliato, raccontato. Per capire se si
muove per Berlusconi, come credo possibile, o per Renzi, come qualcuno
sospetta».
Vivere è anche conservare i
propri ricordi: lei ne mette tanti nel libro…
«Io sono stato un orgoglioso
figlio della Lupa e, solo per pochi mesi, non sono riuscito a diventare un
balilla, come succedeva in terza elementare. In questo libro c'è molto della
zona in cui ho vissuto, quella padana, tra Piemonte e Lombardia, ci sono i
racconti delle donne che avevo accanto. Mia madre aveva un negozio, una
modisteria, sulla via principale di Casale, guadagnava più di mio padre che era
un capo operaio delle Poste. Io facevo i compiti in negozio e ascoltavo le
chiacchiere con le clienti pettegole: quei discorsi mi tornano sempre alla
memoria quando scrivo un libro. Ricordo i ponti bombardati di Casale e la mamma
che, per alleggerire la tensione, diceva: “Oggi non si può morire perché
dobbiamo mangiare le frittelle”. I bombardamenti sono stati a lungo tra i miei
incubi».
Tasselli di verità: piccoli
spiragli di luce sugli ultimi giorni di Mussolini. Da Pisanò a Pansa, i
tentativi di raccontare la storia senza pregiudizi: ma la nebbia è ancora fitta,
scrive Emma Moriconi su “Il Giornale d’Italia”. Ci sono vicende della storia che
restano, seppure dopo molto tempo, avvolte dal mistero. Una nebbia fitta che
sembra non si possa riuscire a dipanare in nessun modo. Poi, qualche volta,
affiora qua e là qualche momento di luce: ma si tratta di piccoli varchi
nell’oscurità. La verità, la luce piena, forse non arriverà mai. Nel corso di
questi lunghi mesi abbiamo tentato di eviscerare molti aspetti delle vicende
patrie che non hanno, nel tempo, trovato la giusta collocazione o che, quando
sono stati chiariti ed è riuscita ad emergere la verità, si è cercato di
inscatolare a dovere affinché non avessero la giusta risonanza. L’editoria, sia
scolastica che non, viaggia a compartimenti stagni: è quasi impossibile reperire
certi testi, per esempio. Ce ne accorgiamo quando andiamo alla loro ricerca e ci
rendiamo conto che spesso si deve sapere con una certa sicurezza cosa si sta
cercando, e nemmeno così è facile trovarli. In compenso, gli scaffali sono pieni
di altra roba, quella si che è facile da reperire …Per sollevare un po’ di
polverone sui temi scottanti della nostra storia è dovuto arrivare Giampaolo
Pansa: il suo egregio lavoro di ricomposizione delle sorti di questo popolo è
diventato in breve un varco nel muro del silenzio e della menzogna. Lo ha potuto
fare, lui, che nasce di sinistra. Si, perché prima di lui c’è stato un altro
giornalista-scrittore che ne ha dette e ne ha scritte di ogni sorta, ma i suoi
volumi sono un po’ più difficili da trovare e da diffondere: si chiamava Giorgio
Pisanò, ma era un fascista. E, siccome quando a scrivere è un fascista, si può
serenamente far finta di nulla, quasi come se non esistesse, se a scrivere è
invece uno che nasce e cresce a sinistra e ad un certo punto della sua vita
decide di aprire la sua mente e di guardare oltre gli steccati imposti da
decenni di demagogia, quello diventa il “nemico” da colpire, il bersaglio
perfetto. Pansa non se ne cura, naturalmente, e continua nel suo lavoro di
analisi di un’epoca la cui immagine storica esce distorta rispetto alla realtà:
il suo recente “Eja Eja Alalà” sarà presto oggetto di un approfondimento su
queste pagine. Raccontare la storia, insomma, “da fascista” è difficile, perché
c’è questa tendenza diffusa ad ignorare questo tipo di voce, anche quando
vengono raccontate verità eclatanti. Quando invece a parlare di “verità
nascoste” sono personaggi appartenenti alla “sinistra”, essi vengono attaccati,
additati, apostrofati in ogni modo, ma di certo sulle loro parole non cala il
silenzio: di questi si deve per forza parlare, e meno male. La scorsa estate il
quotidiano Il Giornale ha pubblicato una serie di articoli a firma di Roberto
Festorazzi che fanno il punto su alcune novità emerse da documenti e
testimonianze recenti: il tema è, ancora una volta, gli ultimi giorni di
Mussolini e la sorte delle carte che il Duce portava con sé. Anche su questo
spicchio di storia aleggia un alone di mistero, e la ragione è del tutto
evidente: tutto ciò che poteva chiarire certi aspetti, e che poteva in qualche
modo “riabilitare” la figura di Mussolini e del Fascismo andava fatto sparire.
Abbiamo parlato a lungo (e ancora non abbastanza, però) della morte del Duce,
delle ore che precedettero quell’evento, di chi orbitava intorno a lui in quei
giorni e dei tanti stravolgimenti operati contro la verità di quelle ore. Un
argomento sul quale torneremo a tempo debito, facendo un passo alla volta nel
tentativo di ricostruire quegli strani meccanismi che andarono ad incastrarsi in
quei giorni di primavera del 1945. Eppure le due vicende – la morte di Mussolini
e le borse scomparse – sono indissolubilmente legate. Questa premessa è
necessaria per il lavoro che ci attende nei prossimi giorni, durante i quali
riepilogheremo ai nostri lettori le informazioni di cui Festorazzi è venuto in
possesso. Incontreremo, nel piccolo speciale che seguirà, una serie di
personaggi che, a vario titolo, sono stati attori di quel dramma: parleremo del
famoso carteggio Mussolini – Churchill, dei documenti relativi alla famiglia
Savoia, di misteriosi “viaggi” e di carte scomparse. Si tratta di un piccolo
tassello che va a comporre l’intricato puzzle di quei giorni, un mosaico che,
però, probabilmente resterà incompiuto.
CIAK. SI TRUFFA E SI
FLOPPA. IL CINEMA IN ITALIA.
Alla faccia della cultura.
Come ti finanzio gli amici per purghe televisive.
I FINANZIAMENTI AL CINEMA:
PRIVILEGI E SPRECHI.
Tempo fa, recensendo il film di Marco Risi
"L’ultimo capodanno", ho scoperto che era stato
sovvenzionato dallo stato per
€ 1.354.666 e che al
botteghino aveva incassato
€ 96.567, scrive Capannelle
su Davinotti. Ohibò, mi sono detto, come facciamo a dare così tanti soldi ad un
regista peraltro noto per fare un flop simile? Ero convinto si trattasse di un
caso isolato ma ero solo alla punta dell’ iceberg!
I NUMERI PARLANO DA
SOLI
Basta guardare le cifre complessive per rendersi
conto degli sprechi che nel corso degli anni hanno caratterizzato l’utilizzo dei
finanziamenti pubblici. Negli anni
dal 1994 al 2006,
lo stato ha speso
817 milioni €
destinati a
544 film, per un importo
medio di 1.524.000 € a film.
- Dei 544 film finanziati, ben
155 (il 28%) non sono mai
usciti in sala.
- Di quelli usciti l’incasso
medio è stato 378.000 €, gli spettatori medi circa 70.000
- Soltanto 25 film dei 544
finanziati sono riusciti a recuperare in toto i soldi ricevuti
- Hanno ricevuto fondi 61 case
di produzione e 390 registi
Considerando il primo dato si può dire che almeno
una volta ogni quattro (e anche l’annata 2007 lo conferma)
viene finanziato un lavoro che
nessuno vedrà.
Spesso vengono costituite delle imprese già destinate al fallimento con l’unico
scopo di far lavorare un gruppo di persone e di fornitori amici e magari trovare
posto per un paio di ragazzotte amiche dell’onorevole. Tutto fattibile a cuor
leggero tanto buona parte delle perdite se le accolla lo stato. E intanto mi
sono costruito una solida rete di persone che mi devono un favore.
I beneficiari sono registi
sconosciuti e bisognosi di affermarsi? Noooo. Tra i beneficiari troviamo anche:
- Michelangelo
Antonioni,
€ 3.160.716 nel 1997 per un film mai uscito
-
Bellocchio,
finanziato 4 volte tra 1995 e 2003, con risultati al botteghino non
disprezzabili
- I
fratelli Taviani
con 3 sovvenzioni
- La
Wertmuller
4 volte, di cui una senza uscire e un’altra con un ritorno di € 6.625 a fronte
degli 3.718.500 ottenuti per
Peperoni ripieni e
pesci in faccia.
-
Pupi Avati
beneficiario 5 volte con risultati altalenanti: dal 162% de Il testimone
dello sposo al misero 13% di
Festival; ma il tragico è
che ottenne ben 3 finanziamenti in soli due anni (1996-97) e che riusci a far
accedere ai finanziamenti anche la figlia
Mariantonia
per l’indimenticabile
Per non dimenticarti
(finanziato € 1.588.000, incasso 21.808)
-
Barbareschi
con 2 bei flop che hanno incassato il 3 e 4% del finanziamento: Ardena e
Il trasformista.
UN CONTESTO DIFFICILE
PER CHI "NON HA GLI AGGANCI".
Non è facile fare cinema al di fuori dello
star-system americano, è risaputo. In
Italia, la concorrenza
della televisione, i gusti troppo esterofili e poco sofisticati del pubblico, la
stagionalità del consumo non aiutano al botteghino. La crisi delle sale è
compensata in parte da pay-tv e home video ma c’è anche tanta pirateria (ehm...
meglio soprassedere). Che il
quadro generale,
a prescindere dal discorso sovvenzioni, sia poco allegro lo dicono anche i
numeri: ogni anno escono in media 400 nuovi film, di cui circa 100 sono
italiani; di questi 100 solo 20 sono redditizi: metà sono i classici
“cinepanettoni”, metà sono opere di vario genere. Attenzione però a non
enfatizzare questi aspetti (comuni del resto a tutti i paesi europei) per
costruirsi un
comodo alibi e non vedere
che in fondo esiste anche un grosso
deficit professionale
a molti livelli del sistema cinema e un
deficit di trasparenza.
Esiste infatti in Italia una cerchia chiusa che comprende sia i
personaggi più illustri
(registi, sceneggiatori, attori)
che quelle
maestranze che lavorano
dietro le quinte: elettricisti, falegnami, disegnatori, tecnici del suono etc.
che, pur avendo un bagaglio professionale di primo ordine, ormai non lo
utilizzano più in modo completo proprio perché non viene loro richiesto. Fanno
parte di questa casta anche coloro che dovrebbero valutarla tramite recensioni e
pareri: molti
critici sono
particolarmente benevoli verso i registi loro affini come background culturale e
verso certi attori che all’estero faticherebbero a varcare la soglia di uno
studio. Il cortocircuito è particolarmente dannoso - e limitante verso i nuovi
autori - nella gestione dei finanziamenti statali, considerati alla stessa
stregua di tanti altri
fondi pubblici:
non secondo fattori di
meritocrazia
culturale e professionale ma in base a
conoscenze e amicizie.
IL SISTEMA DI
SOVVENZIONI STATALI.
La maggior parte dei film italiani vengono
finanziati, in misura variabile, da enti pubblici.
Ogni anno
vengono erogati circa
80 milioni di euro
del
FUS
(Fondo Unico per lo
Spettacolo, istituito nel
1985). Si tratta di soldi del contribuente utilizzati per dare sostegno a opere,
cineasti, scuole di cinema, centri sperimentali, sale cinematografiche. Una
somma non alta né bassa, certamente non paragonabile alla
Francia
che ha deciso di considerare il cinema una
risorsa strategica
per la propria identità culturale e mette a disposizione fondi 8 volte superiori
ai nostri grazie a tasse su biglietti del cinema (10%), tv commerciali (5,5% del
fatturato) e dvd (2%). Sanno spenderli meglio di noi? Non lo so, ma se li danno
a film come Asterix e Obelix o se magari finanziano anche un documentario
su Cesare Battisti,
stiamo freschi. Fino al 2004 i finanziamenti venivano erogati con
criteri
abbastanza
discrezionali (un merito
artistico che potevi attribuire in base a mille considerazioni) ma finivano
comunque nelle tasche dei “soliti noti” e soprattutto senza alcun vincolo sul
ritorno dell’operazione: se il film per cui avevi chiesto un contributo non era
uscito nelle sale o aveva ottenuto scarsi risultati questo non importava a
nessuno, potevi comunque continuare a chiedere e utilizzare i soldi pubblici
come se nulla fosse. A fine 2004 la
legge Urbani ha riformato il
sistema ma ha corretto ben poco. Ha introdotto
criteri di selezione più
rigidi e basati su un
punteggio ma ha così favorito i “soliti noti” che vantano le dimensioni e il
curriculum per rimanere in prima fila nel magna magna generale. Ha
ridotto il contributo
dall’80% al 50% del costo totale dell’opera (eh sì, prima potevi farti
finanziare quasi tutto senza dovere nulla in cambio, bell’esempio di
responsabilizzazione!) ma da bravi italiani abbiamo semplicemente gonfiato i
costi per ricevere più soldi. Ha introdotto la norma del
“Product placement”
(pubblicità palese e non occulta dei marchi) per permettere di raccogliere
qualche elemosina supplementare. Almeno è stata eliminata una ricorrente
ipocrisia già presente in molti programmi e fiction tv (vogliamo parlare delle
vetture Mazda
che Totti
riforniva di carburante in un programma tv e che compaiono in pianta stabile
nella serie
Distretto di polizia?). Per
finanziare le
opere prime sono rimasti
pochi soldi e la vita di chi si affaccia su questo mondo senza le dovute
conoscenze è rimasta ardua. Qualche coraggioso si è esposto (ad esempio tale
Mascagni
col suo manifesto
Davide contro Golia)
per chiedere che fossero
posti dei limiti all’ingordigia della casta.
Ad esempio:
- minor peso attribuito al
curriculum per consentire maggior ricambio
- introdurre un
tetto massimo
al numero di concessioni di soldi pubblici
- non si può chiedere un
nuovo finanziamento prima di 2
anni dall’uscita del film precedentemente finanziato:
per evitare che ci siano autori che ottengono soldi ogni anno.
- commissioni dove siedano
rappresentanti di diverse tendenze e fasce d’età; dove non possano trovar posto
persone legate da conflitti d’interesse
Non mi risulta che il suo
appello sia stato ascoltato.
A completamento del discorso, aggiungo che la
legge prevede anche
premi commisurati ai risultati
di botteghino:
cinepanettoni vari che hanno sbancato nelle sale ricevono pure una percentuale,
variabile secondo scaglioni, su quanto hanno venduto. Ad esempio, il
pieraccioniano Ti amo in tutte le lingue del mondo si è beccato un bel
premio di € 1.485.600. Il totale dei premi erogati nel 2007 è stato di
19.638.887euro. Mica pochi, su un totale di 79.434.180 di sovvenzioni!
Ciak! paga lo Stato.
Il programma racconta e documenta con taglio giornalistico gli aspetti meno
noti dell’industria cinematografica. L’inchiesta di
Sky Cinema prova a
rispondere a queste e ad altre domande attraverso contributi e interviste
inedite. Come vengono utilizzati i soldi che lo Stato dà al cinema? Ci sono
ancora i finanziamenti a film che nemmeno escono? O c’è un più oculato sistema
per dare incentivi? E a chi? Fuori dai red carpet, dalle anteprime, dalle
interviste in batteria, un mondo di addetti ai lavori, istituzioni, aziende,
enti, ruota intorno al business del cinema, tra investimenti privati e
finanziamenti pubblici che spesso generano polemiche e controversie.
Film soft core, catastrofiche pellicole horror e
soprattutto pellicole che nessuno ha mai visto, perché non sono mai nemmeno
uscite in sala, scrive Barbara Tarricone. Sono i risultati dell’uso scellerato
della prima legge di finanziamento pubblico al cinema, quella del 1965. Meglio
conosciuta per avere prodotto gioielli come “Mutande
Pazze”, di Roberto
D’Agostino. Errori del passato, rimediati dalla nuova legge cinema del 2004?
Sono riposti meglio i sempre più esigui fondi che lo stato destina alla cultura
(e al cinema)? Negli ultimi anni sono stati finanziati grandi registi e autori:
da Marco Bellocchio, 900.000 euro per "Bella
Addormentata” a Paolo
Sorrentino che ha portato a Cannes “La
Grande Bellezza” con una
produzione aiutata da 1.100.000 euro dello stato, a Paolo Virzi sul set in
questi giorni con "Il
Capitale Umano" che dal
Ministero ha preso 700.000 euro. Tra le liste dei film che per lo stato sono di
interesse culturale e che quindi meritano di essere aiutati e pagati dai nostri
soldi abbiamo trovato anche mega commedie e blockbuster. Qualche nome? “Genitori
e Figli” di Giovanni Veronesi
con 1.100.000 euro, la saga goliardica “Amici
miei come tutto ebbe inizio” di
Neri Parenti, con 400.000 euro, 650.000 euro a “Posti
in Piedi in paradiso” di Carlo
Verdone. E addirittura 1.000.000 euro a “Ex”
di Fausto Brizzi. Ma lo Stato non doveva “aiutare a produrre e a diffondere
opere difficili e di qualità”? Così non sembra, se guardiamo i film che, anche
senza ricevere finanziamento, hanno richiesto e ottenuto il bollino di interesse
culturale dal ministero. Un bollino che non è solo un’onorificenza ma garantisce
un maggiore premio statale sugli incassi, sgravi fiscali per il distributore e
premi agli esercenti. Cioè altri soldi pubblici. Tra i film che per lo stato
sono a interesse culturale ci sono “Benvenuti
al Sud” e il sequel “Benvenuti
al Nord” “Immaturi”,
“Femmine contro
maschi”, “Baciato
dalla fortuna”, i mega comici
Aldo Giovanni e Giacomo con “La
Banda dei Babbi Natale”,
Ficarra e Picone con “La
Matassa”, il fenomeno
televisivo Giovanni Vernia con “Ti
stimo fratello!”. E persino i
Vanzina con il loro road trip “Mai
Stati Uniti”!
Per scoprire perché Sky Cine
News parla con registi, produttori, addetti ai lavori e si è avventurato
all’interno della sezione Cinema del Ministero dei Beni delle Attività
Culturali. Appuntamento su Sky Cinema 1 il 18 giugno 2013 alle ore 22.50
Ciak, si floppa. Tanto paga
lo Stato.
I fondi pubblici finanziano soprattutto commediole e registi noti. Come rivela
un documentario di Sky, scrive Matteo Sacchi su “Il Giornale”. Si parla
tanto di fondi alla cultura, e in particolare al cinema. Il dibattito assume
subito toni alti ed ispirati. Si discute della necessità di preservare una
«diversità» italiana, quella che ad esempio Francesco Merlo su Repubblica loda
come «eccezione culturale». Il tema è tutt'altro che semplice e l'impegno a
tutela della cultura è sancito dalla Carta costituzionale. Tuttavia al di là
delle disquisizioni dotte e filosofiche sul tema - o anche della complessità del
mercato degli audiovisivi - si potrebbe anche fare qualche riflessione più terra
terra su dove sono andati a finire i finanziamenti erogati sin qui. In questo
senso aiuta anche una trasmissioncina breve breve che andrà in onda il 18 giugno
2013 stasera su Sky Cinema 1HD e intitolata Ciak!Paga lo stato! (alle 22,50 sul
canale 301 della piattaforma Sky). Ecco qualche numero e qualche titolo di
quelli che verranno presi in considerazione. Il ministero ha erogato fondi per
titoli di cui è difficile mettere in dubbio il valore culturale. Un esempio tra
i tanti Bella addormentata di Marco Bellocchio (900mila euro) o La grande
bellezza di Paolo Sorrentino (1 milione e 100mila euro). Diventa meno facile
spiegarsi come mai si possa trovare culturalmente imprescindibile un
finanziamento di un 1 milione di euro a Ex di Fausto Brizzi del 2009. O forse ad
aver preso un abbaglio nel giudicare la commedia è stato il noto critico
cinematografico Morandini nel suo dizionario del cinema: assegna al film una
stelletta su 5, a causa della «banalità trionfante», la «volgarità a tutti i
livelli» e l'«esterofilia turistica modaiola». E la lista è lunga. Genitori e
figli di Giovanni Veronesi (1 milione e centomila euro); Amici miei come tutto
ebbe inizio di Neri Parenti (400mila euro per un film che è stato un tremendo
flop e secondo alcuni una vera e propria offesa agli originali di Monicelli)...
Quando non si tratta di finanziamenti diretti il ministero sembra aver elargito
con particolare generosità anche il «bollino» di interesse culturale. Non si
tratta infatti semplicemente di una onorificenza: comporta sgravi fiscali per il
distributore, un maggior premio statale sugli incassi e premi agli esercenti che
proiettano la pellicola. Nell'elenco ci sono: Benvenuti al sud e Benvenuti al
nord, Immaturi, Femmine contro maschi, Baciato dalla fortuna, La banda dei babbi
natali di Aldo Giovanni e Giacomo, La matassa di Ficarra e Picone e anche il
road movie all'americana dei fratelli Vanzina Mai Stati Uniti!. Questo, va
detto, è il risultato della nuova legge del 2004 che ha tentato di emendare gli
sperperi addirittura incredibili causati dalla precedente legge del 4 novembre
1965, quella che aveva consentito di finanziare film come Mutande pazze o La
bella dalla pelle nera. Dal 2004 non solo si è tentato di dare una stretta ai
cordoni della borsa ma persino di introdurre dei criteri oggettivi di
valutazione. Oltre alle commissioni del ministero (che contano ancora per il 70%
sulla decisione) ora a fare la differenza è il curriculum del regista e del
cast. Ben vengano i criteri oggettivi ma, secondo alcuni, il risultato è che si
vedono sempre le stesse facce, quelle di quegli attori che portano punti. Non
proprio un modo di favorire le novità (culturali). Come spiega in Ciak!Paga lo
stato! lo sceneggiatore Michele Pellegrini: «Non si può dare un punteggio
elevato, con tutto il rispetto, a Valerio Mastandrea, perché Valerio fa già un
sacco di film...». Ecco spiegato anche come il Mibac possa stanziare 400mila
euro per un pornochic massacrato da pubblico e critica come E la chiamavano
estate. Basta la presenza di Isabella Ferrari. Vi sembra una situazione
surreale? Non abbiamo ancora parlato di quei film che prendono i finanziamenti e
poi nelle sale non escono. Una volta il fenomeno era endemico e mandava in fumo
cifre enormi. Dal 2004 si è cercato di mettere una pezza. Eppure dei 28
lungometraggi dei registi considerati «esperti» dalle commissioni del Mibac
finanziati nel 2011 solo 16 sino a ora sono arrivati nelle sale. Resta da capire
come andrà a finire per i 23 milioni di euro erogati nel 2012 a 79 pellicole.
Speriamo meglio... Ah, ovviamente anche se un film va in sala e fa flop lo Stato
va in perdita secca. Per fare un esempio: La scoperta dell'alba di Susanna
Nicchiarelli è stato finanziato con 550mila euro, ne ha incassati 50mila. E se
un film va bene? C'è un complicato sistema premiale per cui lo Stato spesso non
rientra lo stesso.
CULTURA, INFORMAZIONE E
SOCIETA’. A PROPOSITO DI WIKIPEDIA. L’ENCICLOPEDIA CENSORIA.
Wikipedia,
secondo la presentazione
contenuta sulla sua home page web, è un'enciclopedia online, collaborativa e
gratuita. Disponibile in 280 lingue, Wikipedia affronta sia gli argomenti tipici
delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in almanacchi, dizionari
geografici e pubblicazioni specialistiche. Wikipedia, a suo dire, è liberamente
modificabile: chiunque può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove.
Ogni contenuto è pubblicato sotto licenza Creative Commons CC BY-SA e può
pertanto essere copiato e riutilizzato adottando la medesima licenza. La
comunità di Wikipedia in lingua italiana è composta da 771.190 utenti
registrati, dei quali 8.511 hanno contribuito con almeno una modifica
nell'ultimo mese e 105 hanno un ruolo di servizio. Gli utenti costituiscono una
comunità collaborativa, in cui tutti i membri, grazie anche ai progetti tematici
e ai rispettivi luoghi di discussione, coordinano i propri sforzi nella
redazione delle voci. Quello che non si dice di Wikipedia, però, è che, pur
lagnandosi essa stessa del pericolo della censura, i suoi utenti con ruolo di
servizio svolgono proprio un’attività censoria. Non tutti i contenuti inseriti,
nuovi o di rettifica, sono pubblicati sulla cosiddetta enciclopedia libera.
Wikipedia ha una serie di regole e di linee guida per la pubblicazione, ma poi
ti accorgi che sono puri accorgimenti per censurare contenuti e personaggi non
aggradi all’utente di turno con mansioni di servizio. Censura dovuta ad
ignoranza o mala fede. Un esempio: provate a cercare Antonio Giangrande, o i
suoi 40 libri, o Associazione Contro Tutte le Mafie. Non troverete nessuna
pagina a loro dedicata, e si potrebbe capire non reputandoli degni di
attenzione, ma non troverete anche alcun riferimento a contenuti attinenti ed
esistenti ed inclusi in altre pagine. Per esempio, alla voce mafia tra le
associazioni antimafia non vi è l’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Addirittura hanno tolto il riferimento bibliografico al libro con il titolo
“Sarah Scazzi, il delitto di Avetrana.
Il resoconto di un
Avetranese”, scritto da Antonio Giangrande ed inserito alla pagina “Il Delitto
di Avetrana”. Ognuno, comunque, può verificare da sé con i propri contenuti.
Alla fine ti accorgi che, mancando alcune opere, fatti, personaggi o contenuti
nuovi o di rettifica, proprio perché vi è impedimento al loro inserimento,
Wikipedia proprio un’enciclopedia libera non è.
Ma tutto ciò è avvalorato da
quanto scrive su “Il Giornale” Alessandro Gnocchi.
Wikipedia come
Mao: fa censura per cercare di riscrivere la storia.
La popolare
enciclopedia on line cancella gli interventi degli utenti che non si attengono
alla "linea politica".
«L’egemonia culturale è un concetto che descrive il dominio
culturale di un gruppo o di una classe che “sia in grado di imporre ad altri
gruppi, attraverso pratiche quotidiane e credenze condivise, i propri punti di
vista fino alla loro interiorizzazione, creando i presupposti per un complesso
sistema di controllo”». La definizione, con ampia citazione di Gramsci, è
prelevata da Wikipedia, l’enciclopedia on line ormai egemone nel fornire
informazioni a navigatori, studenti, giornalisti e perfino studiosi. Nel mondo
di Wikipedia le gerarchie sono quasi inesistenti. Chiunque può contribuire a
creare o modificare una voce. La garanzia dell’accuratezza poggia su una doppia
convinzione: il sapere collettivo è superiore a quello individuale; la quantità,
superata una certa soglia di informazioni, si trasforma in qualità. Molto
discutibile, e non solo in linea di principio. Infatti in Wikipedia esiste un
problema di manipolazione del consenso, in altre parole è attivo un «sistema di
controllo» simil-gramsciano (in sedicesimo, si intende). Le posizioni faziose
passano quindi per neutrali, e il collaboratore che obietta può andare incontro
a sanzioni che vanno dalla sospensione alla radiazione. Di recente, ad esempio,
è stato espulso Emanuele Mastrangelo, caporedattore di Storiainrete.com, sito
specialistico, e autore di alcuni studi sul fascismo. La pena «all’utente
problematico» è stata comminata, dopo processo non troppo regolare, per un
«reato» d’opinione gravissimo: aver affermato che in Italia la fine della
Seconda guerra mondiale assunse anche il carattere di una «guerra civile».
Opinione, quest’ultima,
largamente maggioritaria tra gli storici di ogni orientamento, salvo forse
quelli che hanno ancora il mitragliatore del nonno sepolto in giardino. «Guerra
civile», per Wikipedia.it, non merita neppure una voce a sé: l’espressione è
citata di passaggio all’interno di «Resistenza». Stesso trattamento è riservato
alle forze armate che rifiutarono di aderire alla Rsi, facendosi deportare dai
tedeschi: un accenno e via. Quanto alle «esecuzioni post conflitto» operate dai
partigiani, si sfiora il giustificazionismo. Il paragrafo è preceduto da una
imparzialissima (si fa per dire) dichiarazione di Ermanno Gorrieri, sociologo
attivo nella Resistenza: «I fascisti non hanno titolo per fare le vittime». E
accompagnato da una precisazione imparzialissima (si fa per dire) di Luciano
Lama: «Nessuno vuole giustificare i delitti del dopoguerra. Prima di giudicare
però si deve sapere cosa accadde davvero. Una guerra qualunque può forse finire
con il “cessate il fuoco”. Quella no». Ecco, questo si può dire, è super partes
al contrario di «guerra civile», definizione «non enciclopedica» solo per caso
usata da una tonnellata o due di studiosi e scrittori di sinistra da Pavone a
Pansa. Di conseguenza, dopo qualche giorno di discussione on line, arriva la
sentenza: «A un utente che è stato bloccato sei mesi e non ha ancora compreso
che la comunità non tollera atteggiamenti di questo tipo, è il momento di dire
basta. Con tanto dispiacere, ci mancherebbe, né ho “corda e sapone pronta da
lunga pezza”». In effetti l’impiccagione sarebbe stato troppo anche per un
revisionista come Mastrangelo. «Pertanto - prosegue il giudice - procedo a
bloccare per un periodo infinito l’utente». Al di là di questo caso personale,
sono parecchie le voci contestate per una certa parzialità. Da quella sulla
malga di Porzûs (dove nel febbraio 1945 i partigiani comunisti massacrarono
quelli cattolici dell’Osoppo) a quella sull’attentato di via Rasella, che i
wikipediani preferiscono chiamare «attacco», piena di lacune, a esempio sulle
polemiche scatenate dall’azione gappista anche all’interno del Pci e degli altri
partiti del Comitato di Liberazione a Roma. Oggetto di accese discussioni anche
Cefalonia, Pio XII, l’Olocausto, la religione cattolica in generale. Anche in
voci meno calde come quelle inerenti il liberalismo, il libero mercato, il
neoliberismo emerge nettamente una visione assai orientata contro il
capitalismo. Nella voce dedicata all’economista Milton Friedman si legge
addirittura un giudizio morale: «Pur ricordando che né Milton Friedman né José
Piñera sono stati coinvolti con le torture ed i crimini commessi dal governo
Pinochet, la loro correità morale non viene per questo diminuita di fronte alla
gravità dei crimini commessi contro l’umanità». Non si direbbe una valutazione
«enciclopedica». Il sapere «democratico» di Wikipedia sembra un aggiornamento
digitale del maoismo.
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED
EDITORI.
Tutto in famiglia. Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera” ha titolato così il
suo pezzo: La grande famiglia dei dipendenti SIAE, 4 su 10 legati da parentela.
Per far sentire i propri dipendenti come in famiglia la Siae non ha rivali:
pensa anche al bucato. Chi va in missione può far lavare e stirare camicie e
mutande a spese dell'azienda. Dieci euro e 91 centesimi vale la speciale
«indennità lavanderia» quotidiana che scatta in busta paga dopo il quarto giorno
passato fuori sede. Quanti lo ritengono un privilegio anacronistico non sanno
che la Società degli autori ed editori è anche tecnicamente un gruppo familiare.
Al 42 per cento. Nel senso che ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato
(il 42 per cento del totale, appunto) vantano legami di famiglia o di
conoscenza. Ci sono figli, nipoti, mariti e mogli di dipendenti ed ex
dipendenti. Ma anche congiunti di mandatari (cioè gli esattori dei diritti) di
sindacalisti e perfino di soci. E poi rampolli di compositori e parolieri,
perfino delle guardie incaricate della vigilanza nella sede centrale. La lista è
sterminata, con intrecci che attraversano ogni categoria. Dei 559 entrati alla
Siae durante gli anni per chiamata diretta, ben 268 sono parenti. Idem 57 dei
128 reclutati tramite il collocamento obbligatorio. E 55 dei 154 che hanno
superato le selezioni speciali. Ma perfino 147 dei 416 assunti per concorso
hanno rapporti di parentela. I nomi dicono poco o nulla. Ciò che importa è che
in questo clan familiare gigantesco finora tutto sia filato liscio, senza
bisogno di mettere nulla per iscritto. Ecco spiegato perché alla Siae non esiste
nemmeno un contratto di lavoro vero e proprio. I rapporti fra l'azienda e i
dipendenti, come hanno toccato con mano il commissario Gian Luigi Rondi, i suoi
due vice Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino, nonché i loro
collaboratori, sono regolati da micro accordi che hanno determinato condizioni
senza alcun paragone in realtà aziendali di questo Paese. Cominciando dallo
stipendio: 64 mila euro in media per i dipendenti e 158 mila per i dirigenti.
Con un sistema di automatismi che fa lievitare le buste paga a ritmi biennali
fra il 7,5 e l'8,5 per cento. Per non parlare della giungla dei benefit che
prevede, oltre alla già citata indennità per il bucato, quella che in Siae viene
chiamata in modo stravagante «indennità di penna». Altro non è che una somma
mensile, da un minimo di 53 a un massimo di 159 euro, riconosciuta a tutto il
personale per il passaggio dalla «penna» al computer. C'è poi il «premio di
operosità», la gratifica per l'Epifania, tre giorni di franchigia per malattia
senza obbligo di certificato medico, 36 giorni di ferie... Le conseguenze? Sono
nelle cifre delle perdite operative accusate dalla Siae negli ultimi anni: 21,4
milioni nel 2006, 34,6 nel 2007, 20,1 nel 2008, 20,9 nel 2009, 27,2 nel 2010.
Cifre cui dà il suo piccolo contributo anche il costo del contenzioso. Perché si
litiga anche nelle migliori famiglie. Nonostante condizioni di favore che non
hanno eguali nel panorama degli enti pubblici o parapubblici, negli ultimi
cinque anni i dipendenti della Siae hanno attivato 189 cause di lavoro. Con un
costo medio per l'azienda di un milione 469 mila euro l'anno. Insomma, un bagno
di sangue. Del quale ancora non si vede la fine. I commissari hanno tagliato 2,8
milioni di spese generali e un milione e mezzo di costi della dirigenza,
sperando poi di risparmiarne altri 3 rivedendo gli accordi con i mandatari: un
groviglio di 605 agenzie disseminate irrazionalmente sul territorio con
dimensioni medie ridicole, se si pensa che il ricavo medio di ciascuna è di 128
mila euro l'anno. Ma il vero problema è quello del personale, perché finora
tutti tentativi di normalizzare la situazione applicando un qualsiasi contratto
di lavoro sono miseramente naufragati nella melma di uno stato d'agitazione
proclamato dai sindacati interni. La questione fa il paio con la vicenda del
Fondo pensioni, istituito nel 1951, che deve provvedere al pagamento degli
assegni di quiescenza del personale ed è una delle cause principali del dissesto
che ha portato un anno fa al commissariamento. Ha un patrimonio interamente
investito in immobili, con un valore di mercato di 205 milioni. Ma che non rende
praticamente nulla. Tanto che finora, per riuscire a pagare le pensioni, la Siae
ha dovuto mettere costantemente mano al portafoglio, aggravando non poco il
proprio conto economico. Basta dire che il Fondo ha assorbito 130 milioni di
contributi aziendali, con la previsione di ingoiarne altri 60 nei prossimi dieci
anni. Nel tentativo di rimetterlo in sesto, e anche in conseguenza delle nuove
regole sugli investimenti degli enti previdenziali, sono stati istituiti due
fondi immobiliari. Il che ha scombinato i piani di vendita di alcuni stabili di
proprietà della Siae a condizioni favorevolissime: minimo anticipo e dilazioni
di pagamento quarantennali. Parliamo degli immobili a destinazione residenziale
occupati fra l'altro dai dipendenti della Società degli autori ed editori. Che
hanno una caratteristica comune: su 37 affittuari, 34 sono sindacalisti. Fra di
loro figura anche il contabile dello stesso Fondo pensioni. Si tratta di Roberto
Belli, responsabile della Slc-Cgil nonché fratello di una dipendente attualmente
in servizio e di una ex dipendente Siae (rispettivamente Antonella e Patrizia
Belli), destinatario di una recentissima e sorprendente contestazione
disciplinare. Il 13 giugno la direzione generale gli ha spedito una lettera dove
si dice che una verifica condotta dalla Ria&partners, la società di revisione
del bilancio del Fondo, ha fatto saltare fuori alcuni bonifici per un totale di
30 mila euro che insieme ad alcuni assegni e versamenti, c'è scritto, «non
risultano autorizzati e non trovano riscontro nelle registrazioni contabili».
Denaro, dicono i documenti bancari, trasferito dal conto Bancoposta del Fondo
stesso ai conti correnti bancari personali di Belli e della sua compagna.
Inevitabile, adesso, la richiesta di spiegazioni convincenti.
Un sito web
di promozione turistica dell’Italia.
Serve un sito
internet all’altezza dell’Italia, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere
della Sera”. Antonio Giangrande: il sito web c’è
www.telewebitalia.eu
, oltretutto senza oneri per lo Stato, ma tutti lo ignorano.
Secondo il
giornalista del Corriere cinque mesi abbondanti non sono bastati alla
squadra del ministro del Turismo, Piero Gnudi, per rimuovere certe macerie del
sito «italia.it», il portale da tempo immemorabile messo in cantiere prima dal
governo Berlusconi, poi dal governo Prodi (memorabile lo spot in
english-romanesco di Francesco Rutelli di invito agli stranieri: «Pliz, vizit
Italy»), poi ancora dal nuovo governo Berlusconi e da Michela Vittoria
Brambilla. La quale, dopo avere cambiato il logo scelto dal predecessore perché
le pareva un errore la forma della «t» di Italia (titolo del Giornale : «La
Brambilla cancella il "cetriolo" di Rutelli») aveva portato a compimento il
faticosissimo cammino del sito web, costato ai vari governi nel complesso
l'enormità di 35.451.355 euro, con alcune scelte contestate. Basti ricordare la
home page della versione cinese dove spiccavano le foto prese col copia-incolla
dal sito cinese dell'Emilia Romagna con il risultato che pareva che non solo la
capitale fosse Bologna (con tanto di mappa con le freccette e di panoramica
della città) ma che l'intero nostro Paese fosse riassumibile così: parmigiano,
prosciutto, Ferrari e Ducati. Una «svista» che, dopo le pubbliche denunce, è
stata rimossa. «Per favore - dice Stella - vista l'importanza di Internet per il
turismo (il solo sito TripAdvisor ha 35 milioni di recensioni e 29 milioni di
visitatori al mese ) potremmo una buona volta metterci una pezza?»
«Basterebbe –
risponde Antonio Giangrande, autore della collana editoriale “L’Italia del
Trucco, l’Italia che siamo” con 40 libri all’attivo, e presidente di Tele Web
Italia – non essere altamente autoreferenziali e prestare maggiore attenzione a
ciò che vi è sul web e che non sia a se stessi o al sistema di potere
riconducibile. Essere slegati dal sistema editoriale od istituzionale, con oneri
per lo Stato, non vuol dire non produrre prodotti di alta qualità. Il nostro
portale turistico ha ampi consensi e visite da tutto il mondo. In Italia per
essere credibile e pubblicizzato devi per forza allattare dalle mammelle
statali».
PARLIAMO DI PRODOTTI
EDITORIALI E LORO DISTRIBUZIONE.
Lo facciamo attraverso
un’inchiesta di Bernardo Iovene, in collaborazione con Antonella Cignarale
pubblicata su “Il Corriere della Sera”. Internet, freepress e sempre
meno tempo da dedicare alla lettura sono sicuramente fattori che stanno da tempo
mettendo in crisi la filiera editoriale, in primo luogo le edicole. Secondo il
Sinagi, Sindacato Nazionale Giornalai, negli ultimi 5 anni hanno chiuso circa
10mila edicole. Il problema più grosso è legato ai meccanismi di diffusione e
tentata vendita dei prodotti editoriali. In media ogni settimana si muovono
tonnellate di pubblicazioni, dai quotidiani ai mensili, dalle riviste di settore
ai fumetti che dall'editore vengono inviati ai distributori e da questi smistati
e consegnati alle edicole ogni notte. Un movimento che produce un'ingente
quantità di denaro, gran parte sotto forma di anticipazione: l'editore riceve un
anticipo sulla probabile vendita del distributore che, a sua volta, consegna e
chiede il pagamento agli edicolanti entro una settimana. L'edicola riceve e paga
anticipatamente la merce, se vende, recupera i soldi subito, altrimenti li vedrà
solo dopo un mese, al momento della resa della pubblicazione. Questo meccanismo
vale per i quotidiani, i settimanali e i mensili. Il resto delle pubblicazioni,
come i bimestrali o i supplementi vanno in conto deposito, nessuna
anticipazione, ma pagamento solo del reale venduto. Il meccanismo non sempre
funziona, anzi rischia di collassare su sé stesso. Il distributore locale ha di
fatto il monopolio della fornitura alle edicole della provincia e può fare il
bello o il cattivo tempo. Il segretario nazionale del Sinagi, Giuseppe Marchica,
dichiara che molti distributori chiedono il pagamento anticipato di
pubblicazioni che, secondo l'accordo nazionale, devono essere pagati solo se
realmente venduti. Inoltre gli edicolanti denunciano l'eccedenza di prodotti
spesso invendibili: a fronte di un venduto pari ad 8 copie ne vengono consegnate
20, tutte con pagamento anticipato. Altri lamentano di essere l'unica categoria
commerciale che finanzia le campagne pubblicitarie agli editori, infatti le
riviste in offerta a metà prezzo costituiscono per gli edicolanti una perdita
del 50% del guadagno, mentre gli editori recuperano con la pubblicità. «Ma la
sofferenza della categoria degli edicolanti dipende anche dal rapporto di lavoro
con il rispettivo distributore locale» afferma il segretario nazionale del
Sinagi. «In diverse zone d'Italia molti distributori chiedono arbitrariamente ai
rivenditori una percentuale per coprire le spese di trasporto e consegna merce.
Un ricatto rivolto ai piccoli punti vendita, localizzati per lo più nelle
frazioni e che svolgono un servizio di utilità sociale, spesso con un basso
livello di guadagno». Secondo l'accordo nazionale i distributori devono
assicurare il servizio di consegna franco punto vendita e i costi richiesti per
il trasporto sono illegittimi. Nel 1994 si è cercato un equilibrio per risolvere
questi casi all'interno della filiera, gli edicolanti hanno rinunciato al 1% del
proprio agio per coprire il costo del trasporto su tutto il territorio
nazionale. Una sentenza del tribunale di Tivoli ha rafforzato la validità di
tale accordo, chiedendo il risarcimento danni a favore di un rivenditore che per
5 anni aveva pagato una quota al proprio distributore locale per la consegna
delle pubblicazioni. Secondo l'art. 39 sulle liberalizzazioni gli edicolanti
possono effettuare la resa immediata dei prodotti editoriali in eccesso, ma la
diatriba tra i diversi soggetti della filiera non si ferma. Se per i punti
vendita l'anticipazione finanziaria della merce costituisce un esborso
settimanale eccessivo, per gli editori rappresenta la base per pubblicare. Oggi
il meccanismo “tu anticipi, io stampo e diffondo” rischia di saltare. Tra il 50
e il 60% dei prodotti editoriali pagati anticipatamente rimangono invenduti e
rimandati al mittente, una parte va al macero, un’altra viene riciclata,
un’altra viene ristampata con copertine ex novo. Una perdita di soldi che pesa
anche sul distributore che, oltre al lavoro di trasporto e consegna, si occupa
anche della resa dell'invenduto delle edicole e della spedizione al mittente. E
così le tonnellate che arrivano ogni notte nelle edicole ripassano per il
distributore per ritornare indietro all'editore. Le edicole devono garantire gli
anticipi con fidejussioni bancarie che devono coprire 4 settimane di fornitura;
un esborso che per molte edicole è più alto del guadagno e infatti stanno
chiudendo bottega. Secondo Stefano Micheli, direttore di Ndm (Network Diffusione
Media), con l’art.39 del decreto sulle liberalizzazioni, che dà la possibilità
di resa immediata da parte delle edicole: «I distributori vengono messi in
ginocchio e la piccola editoria rischia di sparire dal mercato». L'accordo
nazionale è ormai sorpassato, la liberalizzazione è attuata e la licenza di
edicola ha già perso valore commerciale. L'attuale sistema ha dimostrato,
secondo tutti i soggetti, il suo fallimento.
La Casta
degli editori: la censura occulta.
“L’editoria è la casta più importante. Gli editori sono i veri censori e i
manipolatori della coscienza civile. Il sistema prima riconosce la libertà di
manifestare il proprio pensiero e poi ne impedisce l’esercizio”
Questo dice il dr Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie.
La libertà di
manifestazione del pensiero è una delle principali libertà e diritto
fondamentale dell’era moderna. Tanto più se è mirata allo sviluppo
socio-economico-culturale della comunità. Questa libertà è riconosciuta da tutte
le moderne costituzioni. Ad essa è dedicato l’art. 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948, come l'art. 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848. L'art. 21 della
Costituzione italiana stabilisce che: Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
Tale libertà è,
tra le altre, considerata come corollario dell'articolo 13 della stessa
Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l'inviolabilità della
libertà personale, tanto fisica quanto psichica.
L'interpretazione dell'art. 21 dà vita a dei principi: Il diritto di critica e
di cronaca, oltre alla libertà di informare e la
libertà di essere informati.
Il pensiero per
essere manifestato ha bisogno di formarsi come merce accessibile a tutti, quindi
essere pubblicato e distribuito.
Ciò avviene in
proprio o con l’editore.
La produzione in
proprio con distribuzione porta a porta, è un’ipotesi fallimentare. L’opera non
essendo sostenuta dalle istituzioni e non pubblicizzata dai media, non è
acquistata da una moltitudine di utenti finali.
La produzione
tramite un editore può avvenire, in modo improprio con la compartecipazione alle
spese, ovvero senza oneri per l’autore. Naturalmente l’editore vaglia, corregge
e censura le bozze dell’opera, oltre che valutarne la commerciabilità. Spesso
non è importante l’opera, ma che l’autore sia un personaggio noto alle cronache,
o che sia seguito dal pubblico, per usufruire dei benefici di visibilità. Spesso
si privilegiano argomenti fatui e non di approfondimento e di denuncia, perché
la società contemporanea sente l’esigenza di estraniarsi dalla realtà
quotidiana.
L’editore,
acquisendo i diritti dell’opera, la distribuisce e la vende, riconoscendo una
minima parte dei proventi all’autore, per di più dopo molto tempo.
Paradosso:
l’impedimento alla libertà di manifestare il pensiero è posto proprio dal
sistema che ne prevede l’esistenza.
L’autore
autoprodotto non ha benefici, né sovvenzionamenti, né visibilità.
L’editoria,
quindi un’attività economica privata, ha finanziamenti pubblici e pubblicitari,
benefici postali, regime speciale IVA, sostegno dei media e delle istituzioni.
A questo punto,
per manifestare liberamente il proprio pensiero, si è costretti a rivolgersi ad
apparati: che conformano l’opera alle proprie aspettative; che sono omologati,
in quanto foraggiati dalla politica e dall’economia ed intimoriti dalla
magistratura; che hanno distribuzione esclusiva e rapporti promozionali poco
trasparenti. A riguardo è impossibile essere invitati o premiati a
manifestazioni culturali, se non si è tutorati da qualche editore, pur avendo
scritto un capolavoro. Spesso gli editori sono proprietari di testate
d’informazione o di emittenti radiotelevisive, quindi si parla dell’opera o
dell’autore solo se si fa parte dell’enturage.
Inoltre per
poter pubblicare un articolo d’informazione si è costretti a far parte di
un’altra casta: quella dei giornalisti.
C’è da dire che
non tutti gli editori sono parigrado. C’è prevaricazione dei più forti a danno
dei più deboli. Alcuni di loro, operanti nel campo radiotelevisivo, sono vittime
di tentativi di acquisizione illegale delle frequenze assegnatele, con mancanza
di tutela reale.
Quale è il
trucco ?!
Ogni emittente
ha una frequenza su cui è autorizzata a trasmettere con un'antenna di una certa
potenza, per non disturbare le trasmissioni delle emittenti viciniori. Alcune di
loro, tra cui alcuni grandi network nazionali, pensano bene di centuplicare
illegalmente la loro potenza, irradiando il loro segnale di molto oltre a quello
per cui sono autorizzati. In questo modo disturbano o oscurano le trasmissioni
altrui, impedendo a questi l'acquisizione del mercato pubblicitario, fonte di
sostentamento, che leso, porta al fallimento dell'impresa.
Il Ministero,
informato dalla parte interessata, comunica la data dell'ispezione alla
controparte, che ha il tempo di ripristinare la legalità, per poi ripetere
l'abuso ad ispezione finita. Tempi e costi dell'operazione tecnica sono
ammortizzabili da chi si avvantaggia illegalmente dell'acquisizione
pubblicitaria indebita. Mal che vada, comunque, la parte colta in fragrante,
deve sorbire solo una piccola multa.
Esemplare è il
caso di Radio Padania. Il ministero dello Sviluppo economico zittisce la voce di
Radio Padania Libera nel Salento. In una nota del 24 gennaio 2011 fatta
pervenire in copia al Comune di Alessano, i competenti organi ministeriali
scrivono che l’impianto dell’emittente leghista «non si intende autorizzato».
Radio Padania dal 17 dicembre 2010 ha trasmesso nel Capo di Leuca da una
postazione situata proprio ad Alessano e dotata di un sistema radiante collegato
a un impianto da due kilowatt di potenza. Il segnale viaggia sui 105.600 MHZ in
modulazione di frequenza e disturba quello dell’emittente salentina Radio Nice
del gruppo leccese Mixer Media dell’editore Paolo Pagliaro, che trasmette su
identico canale da Parabita. La radio lumbard ha i contenuti dei palinsesti
carichi di risentimenti contro i meridionali espressi a chiara voce dai
radioascoltatori padani, cui si lascia microfono libero. Ma la nota del
ministero dello Sviluppo economico che sospende le trasmissioni di Radio Padania
non risolve l’anomalia di mercato delle frequenze. Infatti il vero problema
consiste nel fatto che Radio Padania gode del triplice privilegio di
acquisire le frequenze in deroga, di avere un contributo annuale da parte del
governo, di diventare proprietaria della frequenza trascorsi novanta giorni. La
vera anomalia è proprio questa: in un momento in cui il mercato delle frequenze
è bloccato, Radio Padania può, trascorsi novanta giorni, permutare le proprie
frequenze ottenute in deroga con altre frequenze di radio commerciali. Occorre
modificare questo privilegio concesso dalla finanziaria Bossi-Berlusconi del
2001. L’emittente della Lega Nord, in quanto comunitaria dovrebbe rendere un
servizio, ma l’unica cosa che fa è quella di riempire di insulti i meridionali,
senza che mai nessuno abbia denunciato il suo direttore per diffamazione a mezzo
stampa.
Qualcuno spera
che le opportunità tecnologiche, social network o blog, superino la censura
mediatica. Poveri illusi. Non basta una piattaforma d’elite, chiusa ed
autoreferenziale, con tecnologie non accessibili alla massa, oltretutto soggetta
a sequestro ed ad oscuramento giudiziario.
Nulla, oggi, per
arrivare a tutti, può soppiantare un buon articolo, un buon libro, una buona
canzone, un buon film, o una buona trasmissione radiotelevisiva.
In conclusione.
Con questo sistema si può ben dire che il libero pensiero, pur lecito e
meritevole di attenzione, è tale solo quando è chiuso in una mente destinata
all’oblio, altrimenti deve essere per forza conformato al sistema: quindi non
più libero.
PARLIAMO DI
SCRITTORI E PREMI LETTERARI.
Scrittopoli e premiopoli.
Inchiesta di Stefania Parmeggiani su "La Repubblica".
Ogni anno in
Italia si celebrano circa milleottocento concorsi letterari. Li alimentano circa
quattro milioni di aspiranti romanzieri, poeti, saggisti. Ma dietro gli Strega,
i Campiello, I Bagutta, e dietro il centinaio di piccoli premi promossi da enti
locali e associazioni culturali, prospera una selva di gare improbabili e
costose per i concorrenti. Cinque premi al giorno per un affare da 10 milioni di
euro. Spuntano come funghi da Nord a Sud. Ogni anno nascono 90 concorsi
letterari, tanto che oggi se ne contano almeno 1800. Ecco le cifre dei concorsi
in grado di di spostare milioni di euro.
I PREMI
1800 premi
letterari ogni anno
5 al giorno
90 nuovi ogni
anno
500 quelli
dedicati alla poesia
100 quelli
giudicati interessati da una indagine dell'Istituto per il libro.
IL BUSINNESS
1 milione di
euro, il giro di affari delle spese di segreteria e delle tasse d'iscrizione tra
5 e 50 euro la quota richiesta a ogni partecipante
10 milioni di
euro, i contributi pubblici
DATI EDITORIA
E LETTORI
3,4 miliardi di
euro, il fatturato complessivo delle oltre settemila case editrici italiane
25 milioni, i
lettori di almeno un libro in un anno in Italia
60 mila i titoli
che ogni anno vengono pubblicati in Italia.
L'Italia è il
Paese che ha più premi letterari. Una stima affidabile parla di milleottocento
concorsi. Ma se quelli celebri si contano sulle dita delle mani, e se quelli
"piccoli ma dignitosi" sono un centinaio, gli altri prosperano sull'esercito di
aspiranti scrittori disposti a finanziarli con spese di segreteria, tasse di
lettura, autopubblicazioni.
Ecco come. Oggi
è una giornata importante per l’editoria italiana: si assegnano cinque premi
letterari. Uno per la poesia e un altro per i racconti brevi. Poi c’è quello per
i romanzi inediti, quello per i saggi, e il prestigioso Viareggio, ottantadue
anni sulle spalle e un futuro minato dalle polemiche. Anche domani è una
giornata importante: in cartellone ci sono altri cinque premi, tra cui il
Capalbio. E così dopodomani e dopodomani ancora. Perché ogni anno in Italia si
svolgono ben 1800 concorsi letterari, un numero arrotondato per difetto che
sembrerebbe rendere giustizia a un popolo di poeti, scrittori e romanzieri.
Eppure, ascoltando chi ha passato anni a inviare opere a misteriose giurie, si
scopre una realtà diversa, tutt’altro che limpida. Lontano dai riflettori dei
premi che contano, dallo Strega al Campiello, dal Bagutta al Calvino, lontano
dai concorsi poco qualificati, ma tutto sommato innocui, emerge una girandola di
gare improbabili, sfornate in serie da professionisti e minuscole case editrici,
un mondo dove i sogni di carta si pagano a caro prezzo e dove, tra tasse
d’iscrizione, spese di segreteria e contributi pubblici, il giro d’affari supera
i dieci milioni di euro.
Chi sono i
protagonisti di questa premiopoli tutta italiana? Qual è il vantaggio per gli
scrittori e quale quello per gli organizzatori? Perché gli esordienti, riuniti
in gruppi di guerriglia editoriale, puntano il dito contro il mercato? E perché
a volte, a dispetto della logica, si collezionano riconoscimenti che sono carta
straccia?
L’industria dei
premi letterari. L’Italia è il paese al mondo con più premi letterari. Lo era
già nel ‘99 quando Giuliano Vigini, esperto del mercato del libro, decise di
farli censire. "Ne catalogammo 1200, scoprendo che crescevano al ritmo di una
novantina l’anno. Anche tenendo conto di quelli che muoiono nel giro di poche
edizioni oggi saranno 1800, forse duemila". Nella lista troviamo concorsi
illustri come lo Strega, vinto 24 volte dalla Mondadori, 12 dalla Rizzoli e 11
dall’Einaudi. Prestigiosi come il Campiello, il Bancarella, il Bagutta e il
Viareggio, che dopo avere attraversato il Novecento con alterne fortune e avere
incassato il rifiuto di Moravia nel ’50 e quello di Calvino nel ’68 ("Non mi
sento di continuare ad avallare con il mio consenso istituzioni ormai svuotate
di significato"), rischia lo sdoppiamento per una lite tra gli storici
organizzatori e il Comune. Fino a qualche anno fa c’era anche il Grinzane, oggi
rinato grazie alla fondazione Bottari Lattes, ma al tempo trascinato nella
polvere dal suo fondatore, il professore universitario Giuliano Soria. Sotto
processo, è accusato di avere trasferito denaro dalle casse del premio alle sue
personali, distraendo fondi per oltre un milione e mezzo di euro e di avere
trasformato uno degli appuntamenti letterari più attesi dell’anno in una
mangiatoia a beneficio di molti, lui in testa. "Poi ci sono concorsi nati per
emulazione — continua Vigini — e i premi organizzati per animare la vita
culturale di una provincia, per ricordare un autore del posto o per invitare
alla lettura". Ognuno ha una propria dignità e una ragione di esistere, ma anche
sommandoli tutti non arriviamo a quota 1800. L’Istituto per il libro, in una
indagine promossa qualche anno fa, ne selezionava un centinaio come prestigiosi
e interessanti. E gli altri 1700? L'industria letteraria fattura quasi tre
miliardi e mezzo di euro l'anno, le case editrici sono più di settemila.
Aspiranti scrittori e poeti bussano a queste porte inutilmente, poi cercano la
scorciatoia dei premi a pagamento.
Mimetizzato nel
sottobosco dei micro premi si nasconde il mondo dello "scrivi, paga e vinci" in
cui si aggirano ogni anno gli aspiranti scrittori, i protagonisti di quella che
Umberto Eco quarant’anni fa chiamava "la quarta dimensione". Professionisti in
cerca di un riscatto, giovani con ambizioni letterarie, insospettabili vicini di
casa disposti a pagare pur di pubblicare libri destinati all’invisibilità. Sono
un esercito sommerso che fa a pugni con i dati sulla lettura: solo il 46,8%
della popolazione sopra i sei anni nel 2010 ha letto un libro. Nonostante la
percentuale sia in leggera crescita, appena il 15,1% si può definire un lettore
abituale con un romanzo al mese sul comodino. Non sembra molto diffuso l’amore
per la letteratura, eppure chi scrive non conosce crisi. In prima linea i poeti
(circa 500 i concorsi a loro dedicati), subito dopo gli autori per ragazzi, poi
i romanzieri e i saggisti. Si aggirano nervosi ai margini di una industria che
fattura quasi tre miliardi e mezzo di euro l’anno. Bussano alle porte delle
oltre settemila case editrici con un unico chiodo fisso: come mostrare al mondo
di avere talento. Da qui ai concorsi letterari il passo è breve e alla portata
di tutti, bastano pochi euro. Paola Campanile, poetessa il cui talento è stato
riconosciuto dopo lunghi anni di gavetta da un intellettuale come Antonio Porta
e da un editore come Marsilio, ha vissuto nel sottobosco dei premi letterari per
circa un decennio. Scriveva, pagava le spese di segreteria o la tassa di
lettura, vinceva. E ricominciava da capo: "Ho accumulato un baule di pergamene,
targhe, medaglie, statuine. Che piacere è stato buttare tutto, liberarmi di
quell’inutile testimonianza". Inutile ed esasperante visto che dopo le sue prime
partecipazioni, ha iniziato a essere contattata per concorsi di cui ignorava
l’esistenza. "Ho avuto l’impressione che esistesse una specie di indirizzario,
che alcuni organizzatori si scambiassero i nomi dei partecipanti".
La tassa di
iscrizione. Se i nominativi degli esordienti valgono tanto da essere schedati in
un computer, qual è il guadagno? Miriam Bendìa, autrice di un libro che qualche
anno fa fece clamore — "Editori a perdere" (Stampa Alternativa) — individua due
livelli: "Il primo è quello rappresentato dalle tasse di lettura o dalle spese
di segreteria. Le cifre richieste non sono altissime, variano da 5 a 50 euro e
l’incasso dipende dal numero di concorrenti". Spulciando i siti specializzati
nella promozione dei concorsi si nota come più del 70% dei micro premi preveda
un contributo economico. Calcolando una media di 10 euro e ipotizzando 100
partecipanti a concorso (ma non mancano le eccezioni con migliaia di iscritti)
si può stimare un volume di affari superiore al milione di euro. Cifra
ragguardevole, ma insufficiente a descrivere il vero businness. "Che è legato
all’editoria a pagamento. Chi partecipa a un concorso - continua Bendìa - spesso
riceve una lettera, in cui gli si comunica che la sua opera, pur non essendo
stata premiata, merita di essere pubblicata, ovviamente a pagamento". Tra le
testimonianze raccolte nel forum di “Libri Puliti”, campagna lanciata da Stampa
Alternativa dopo la pubblicazione di "Editori a perdere", diverse segnalazioni
hanno acceso i riflettori sul premio “L’autore”, indetto da Firenze libri.
Alcuni dei contratti proposti ai partecipanti prevedevano un contributo per gli
autori fino a cinquemila euro. Qualcosa di simile succede con il principale
editore a pagamento d’Italia, Albatros-Il filo, anche se in questo caso non si
parla di concorso, ma di selezione. Tutto legale, ovviamente. E, infatti, sul
loro sito Internet scrivono: "I contratti da noi proposti possono prevedere sia
un anticipo sui diritti a vantaggio dell’autore, sia l’obbligo di acquisto di un
quantitativo minimo di copie da parte dell’autore". Gli aspiranti scrittori
riuniti nel sito "Writer’s Dream" hanno fatto la prova del nove: un fritto misto
di cento pagine, un copia e incolla volutamente sconclusionato di Wikipedia,
blog, articoli di giornale... Risultato? Una lettera in cui li si elogiava per
l’interessante opera e si proponeva loro la pubblicazione, a pagamento
ovviamente. I sognatori si sono presi una rivincita: nel 2010 al salone del
libro di Torino hanno sventolato contratto e manoscritto sotto il naso della
direttrice editoriale. Immancabilmente il tutto è finito su You Tube. E non era
neanche la prima volta, visto che un esperimento simile era stato già raccontato
dalla giornalista Silvia Ognibene nel suo "Esordienti da spennare" (Terre di
Mezzo), libro-inchiesta sull’editoria corsara.
Vanity press e vanity prize.
Il motore di questo mercato
sommerso è l'ambizione degli autori di veder pubblicato il proprio nome su una
rivista o sulla copertina di un libro. I più avvertiti si sono organizzati e
frequentano siti di auto-difesa come "Il rifugio degli esordienti". Moltissimi i
concorsi patrocinati da comuni, province e regioni, organizzati dalle pro loco
come il premio della montagna Valle Spluga in Lombardia, o da istituti religiosi
come nel caso del premio Madonna dell’Arco organizzato da una parrocchia di
Castellamare di Stabia. Ci sono poi i derby poetici, le competizioni in
estemporanea e decine di altre fantasiose varianti come quelle organizzate
dall’Accademia Francesco Petrarca di Capranica (Vt).
(«I 10 euro di iscrizione sono devoluti alla
Croce Rossa Italiana e che non vi è alcuna speculazione da parte mia e
dell’Accademia». In questo caso la dr.ssa Pasqualina Genovese D’Orazio,
direttore e fondatore dell’Accademia Francesco Petrarca, lo tiene a precisare al
dr Antonio Giangrande, presidente della “Associazione
Contro Tutte le Mafie”
www.controtuttelemafie.it,
e scrittore-editore dissidente che proprio sul tema ha scritto e pubblicato
“CULTUROPOLI" e "IGNORANTOPOLI". Libri facenti parte della collana editoriale
“L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata sui propri siti web, su
Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo. Uno tra i 40 libri scritti dallo stesso
autore e pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. Opere che i media si
astengono a dare la dovuta visibilità e le rassegne culturali ad ignorare).
Un mondo in continua
moltiplicazione che spesso si avvale di sostegni pubblici: si va da poche
centinaia di euro alle centinaia di migliaia. Ad esempio prima che scoppiasse il
caso Grinzane, il premio incassava dalla Regione Piemonte, dalle fondazioni
bancarie e da altri enti, quasi 5 milioni di euro. Se calcoliamo una media di
5.500 euro di contributi a premio e li moltiplichiamo per il numero di concorsi
sfioriamo i dieci milioni di euro di soldi pubblici. Ma sono veramente gli
aspiranti poeti o scrittori a beneficiare di un simile flusso di denaro?
Leggendo “Il rifugio degli esordienti”, un sito che da quattordici anni
raccoglie le testimonianze degli autori, la risposta è un secco no. Aperto da un
ingegnere con la passione per la scrittura, Maurizio J. Bruno, autore del
thriller "Ralf" e del romanzo di fantascienza "Eden", è diventato un punto di
riferimento per i 17mila aspiranti scrittori che ogni mese lo frequentano.
"Visto che sempre più spesso incontravamo autori finiti nelle reti dell’editoria
a pagamento, con un passato infarcito di premi e un garage pieno di libri
invenduti, io e gli altri autori del rifugio abbiamo dato vita a "Danae",
un’associazione che si occupa di promozione, distribuzione e vendita di opere
realizzate da altri". Peccato che la metà dei libri candidati a questa forma di
autopromozione non superi la selezione del comitato di lettura, "sia per colpa
dell’editore, sia per demerito dell’autore". Infatti, tra gli aspiranti poeti e
narratori non manca chi animato dalla passione per la scrittura, dimentica
quella per la lettura. Gli americani la chiamano vanity press, la vanità
dell’autore che si ritiene appagato nel vedere il suo nome stampato su una
rivista o sulla copertina di un libro. In Italia si accompagna alla vanity
prize e l’effetto combinato delle due debolezze umane rappresenta un mercato
inesauribile. Accade così che sempre più spesso facciano la loro comparsa
associazioni culturali e accademie attivissime nel sottobosco dei micro premi.
C’è la salernitana “Gli occhi di Argo” che organizza diversi concorsi, tra cui
“L’almanacco dei cicli celesti” (50 euro per la pubblicazione) e un calendario
delle pin-up da comporre grazie a inedite poesie sul nudo femminile (chi viene
selezionato s’impegna all’acquisto di 10 copie versando 80 euro per il
collettivo o 150 per il monografico). Decisamente prolifica la "Hermes Academy"
di Taranto. Il direttore creativo e fondatore dell’accademia chiede ai
partecipanti di pagare 10 euro di spese di segreteria per svariati premi: “Anima
di Latta”, “Funambolo del cielo”, “Rette parallele”, “La freccia di Cupido”, “la
vigilia della vita”, “(In) fine il mondo” e “La mensa dei sogni”. Altre
associazioni legano la poesia al turismo: è il caso degli "Amici dell’Umbria"
che ne organizzano una dozzina "nell’intento — si legge sul sito — di riproporre
il messaggio d’amore e di pace degli uomini più illustri della nostra terra". E
non serve neanche vincere, basta cercare uno dei tanti concorsi in cui
l’importante è partecipare. Ad esempio in Ciociaria il bando della quinta
edizione del premio di poesia “Giorgio Belli” riserva premi in denaro ai primi
classificati, ma pubblica in una antologia tutte le liriche inviate. A parziale
copertura delle spese gli organizzatori chiedono un contributo di dieci euro.
Stesso discorso in Toscana con il premio il “Forte 2011” dedicato a poesie e
racconti. Il bando de “La nuova rosa editrice” spiega: "Di tutti i lavori
partecipanti ad ogni sezione, verrà scelta una poesia-sintesi di ogni autore che
sarà pubblicata su un’antologia". Il contributo spese è di 25 euro, ma nel caso
si voglia acquistare l’opera servono altri quindici euro.
Mercato in
cortocircuito. Il desiderio di scrivere, di ottenere successo letterario è tale
da autoalimentare il business. E' così che trova spazio il gioco sporco di
premiopoli. Va ricordata la battuta di Montale quando vinse il Nobel: "Nella
vita trionfano gli imbecilli. Lo sono anche io?" "L’editoria a pagamento non è
editoria, così come i premi che garantiscono la pubblicazione a spese
dell’autore non sono veri premi letterari". E’ lapidario Marco Polillo,
presidente dell’Associazione italiana editori. E le sue parole la dicono lunga
sul peso che le case editrici assegnano ai curricula infarciti di riconoscimenti
degli esordienti: solo carta straccia. L’opinione è condivisa anche da piccoli
editori che cercano di fare il loro lavoro seriamente, anche se stretti in un
imbuto: da una parte i giganti dell’editoria che si dividono il 93% del
fatturato, dall’altra chi si è ricavato un mercato sulla pelle (e sulle
aspirazioni) degli esordienti. Aldo Moscatelli della casa editrice “I sognatori”
ha dedicato al meccanismo dei concorsi un capitolo del pamphlet “Le invio un
manoscritto, attendo contratto”, pubblicato su Internet e in un anno scaricato
già 1800 volte. "I premi lasciano quasi sempre l’amaro in bocca. Quelli più
prestigiosi non sono accessibili ai piccoli editori, gli altri, nel migliore dei
casi, tendono a premiare gli autori già famosi per via del ritorno d’immagine.
Spesso, l’inappellabile giudizio della giuria, risulta del tutto
incomprensibile". Il desiderio di scrivere è tale da autoalimentare il mercato.
E così si crea un corto circuito tra domanda e offerta. Ed è questo il rischio
vero che corre chi ha sogni di carta, il gioco sporco di premiopoli. "Gli
esordienti devono interrompere la catena, rifiutarsi di partecipare a questo
tipo di concorsi, evitare di pubblicare a pagamento", dice Mirian Bendìa. "Non
devono preoccuparsi di vincere un premio o di trovare un editore, ma cercare una
persona che li sappia indirizzare, correggere e stimolare", conclude la poetessa
Paola Campanile. O forse, per non dare eccessiva importanza ai riconoscimenti
letterari ed evitare le trappole di premiopoli, basterebbe ricordare come
Montale reagì quando per telefono gli comunicarono che aveva vinto il Nobel. Lo
scrisse Giulio Nascimbeni, che insieme a Gaspare Barbiellini Amidei, quel giorno
era presente. "Dovrei dire cose solenni immagino. Mi viene invece un dubbio:
nella vita trionfano gli imbecilli. Lo sono anche io?".
Strega,
Campiello & Co. gli storici e gli emergenti. Il più antico è il premio Bagutta,
nato nel 1926. I nuovi e i 'micro' ne contano almeno cinque. Tra tasse di
partecipazione, coppe e diplomi, ecco come funzionano:
GLI STORICI
Bagutta.
E' il più antico premio italiano, nato a Milano nella trattoria della famiglia
Pepori l'11 novembre 1926. Sono ammessi i libri, senza distinzione di generi,
segnalati da almeno due membri di una giuria composta da sedici persone. Premio:
12.500 euro.
Bancarella.
Promosso dall'Unione librai pontremolesi fin dal '52 per libri di narrativa e
saggistica. Giuria: 200 librai. Premio: distribuzione gratuita dei volumi, opera
di divulgazione e la statuetta del "San Giovanni di Dio".
Calvino.
Nato a Torino poco dopo la morte di Italo Calvino, è il più importante concorso
per esordienti. Ai partecipanti è richiesta una tassa d'iscrizione di 60 euro.
Premio: 1500 euro per l'opera vincitrice. Spesso i finalisti trovano un editore.
Campiello.
Istituito nel '62 dagli industriali del Veneto, è assegnato a opere di narrativa
italiana segnalate da una giuria di letterati. Le cinque opere finaliste
ricevono un premio di 10mila euro. Una giuria di trecento lettori assegna il
premio finale di 10mila euro.
Strega.
Nato nel '47, è organizzato dalla Fondazione Bellonci. I 400 "Amici della
domenica" scelgono i finalisti del Premio, scegliendo fra i libri di narrativa
ammessi (ognuno deve avere l'appoggio di 2 giurati) e successivamente il
vincitore. Premio: 5mila euro.
I NUOVI
Bottari
Lattes Grinzane.
E' nato nel 2010 dalle ceneri del Grinzane Cavour. Coinvolge sette giurie
scolastiche che scelgono i vincitori, italiani o stranieri, nella rosa
selezionata da un comitato tecnico. Premi da 2.500 a 10mila euro.
Città di
Tropea.
Nato nel 2007 per promuovere la lettura in Calabria, è organizzato
dall'Accademia degli Affaticati di Tropea. Ha una giuria di 450 persone tra cui
i 409 sindaci della regione. Premio: 5mila euro ai tre finalisti, più 5mila euro
al vincitore.
Mario
Luzi.
Nato a Roma nel 2005 in memoria del poeta e senatore toscano, è dedicato alla
poesia edita ed inedita. Si è dotato del manifesto "premio etico" per garantire
la trasparenza. Sei sezioni, per iscriversi tassa da 16 euro. Montepremi: 25mila
euro.
Pieve.
L'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Santo Stefano, in provincia di
Arezzo, organizza dal 1985 un concorso riservato ai diari dei nonni, alle
lettere d'emigrazione, ai taccuini dalle trincee di guerra. Premio:1000 euro e
pubblicazione.
Racconti
dal carcere.
Nato nel 2010 è un premio dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza,
patrocinato dalla Siae e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I
racconti finalisti vengono pubblicati insieme alle interviste ai loro autori.
Rivolto a tutti i detenuti.
I MICROPREMI
Almanacco
dei cicli celesti.
Organizzato dall'associazione "Gli Occhi di Argo" ad Agropoli, nel Cilento.
Dedicato a poesie, novelle, festività, curiosità, ricette, notizie mediche,
astrologia... Premio: otto copie dell'almanacco che il vincitore deve acquistare
al prezzo di 50 euro.
Biancospino
Organizzato dall'associazione Amici dell'Umbria a Gualdo Tadino. Per
l'iscrizione tassa di 15 euro per una poesia, 25 per due, 30 per tre
componimenti, per libro edito, racconto, saggio e silloge. Premi: coppe,
medaglie e prodotti tipici.
Estemporanea in Viterbo.
Organizzato dall'Accademia Francesco Petrarca di Capranica è dedicato alla
declamazione a voce alta delle poesie. Per iscriversi tassa di 10 euro. E'
previsto un pranzo sociale al prezzo di 15 euro per i concorrenti, 20 per gli
accompagnatori.
Funambolo
del cielo.
Organizzato a Taranto dall'Hermes Academy, riservato a poesie, racconti e
drammaturgie, brani musicali, fotografie e cortometraggi. Soggetto, il
funambolismo. Per iscriversi tassa di10 euro. Premi: targhe e diplomi.
Il Forte.
Organizzato dalla Nuova Rosa Editrice a Forte dei Marmi, si rivolge a poeti e
autori di racconti. Per iscriversi tassa di 25 euro. Un'opera per ogni autore
viene pubblicata in un'antologia, che può essere prenotata al momento
dell'iscrizione pagando altri 15 euro.
LA TRUFFA DELLE CLASSIFICHE
DEI LIBRI.
Perché i libri di racconti
non finiscono in classifica?
raccónto s.
m. [der. di raccontare] treccani.it/vocabolario/racconto/. – 1. Relazione,
esposizione di fatti o discorsi, spec. se fatta a voce o senza particolare cura,
oppure se relativa ad avvenimenti privati (si distingue perciò
da narrazione come raccontare da narrare, ed è diverso anche da resoconto, che è
più ufficiale e tecnico): il r. delle tue vicende familiari mi ha colpito; mi
fece il r. particolareggiato del suo viaggio; l’attività stessa del
raccontare: cominciare, terminare un r.; commuoversi nel r. delle proprie
disgrazie; nel calore del r.; a un certo punto del racconto. Con riferimento al
contenuto: r. storico, leggendario, favoloso, verosimile, inverosimile; al
modo: r. prolisso, stringato, brillante, freddo, monotono. 2. Componimento
letterario di carattere narrativo, quasi sempre d’invenzione, più breve e meno
complesso del romanzo (in quanto dedicato in genere a una sola vicenda e
destinato a una lettura ininterrotta) e distinto dalla fiaba perché tende a
presentare i fatti come realmente avvenuti (per questi suoi caratteri si
identifica sostanzialmente con la novella): un volume di
racconti; r. popolari, per l’infanzia; r. lungo, breve, ben
costruito, slegato. 3. Nel linguaggio della critica letter. (spec. nella critica
formalistica), è sinon. di intreccio, contrapposto alla fabula, ed è pertanto
usato per ogni opera narrativa in versi o in prosa. Dim. raccontino;
spreg. raccontùccio; pegg. raccontàccio (tutti con riferimento per lo più a
racconti scritti).
Racconto.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il racconto è una narrazione in prosa di
contenuto fantastico o realistico, di maggiore ampiezza rispetto alla novella e
di minore estensione rispetto al romanzo. Chi si esprime nella dimensione del
racconto normalmente ne compone una serie, e il suo mondo interiore si
estrinseca in una costellazione di racconti: ciascun testo, per quanto in sé
concluso (a differenza dei capitoli di un romanzo è portatore di una storia
completa), va visto in collegamento unitario con gli altri appartenenti alla
stessa raccolta. Se riferito ad una specifica persona, il racconto - di formato
più o meno esteso - diventa biografico. Se il racconto è scritto in riferimento
a sé stessi, si è davanti ad un racconto autobiografico.
Da distinguere da Romanzo.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il romanzo è
un genere della narrativa scritto in prosa. Origini e caratteristiche fondanti
del romanzo sono argomento di dibattito tra gli studiosi. Certamente si può
affermare che una premessa fondamentale del romanzo moderno è da individuare
nella prima produzione in lingua d'oïl (XI secolo): le narrazioni in versi di
questa tradizione, sia che recuperassero temi greco-romani sia che
rielaborassero temi cavallereschi (cicli bretone e carolingio), venivano
indicate già allora con il termine roman. Il principale carattere di novità
rispetto alle tradizioni narrative immediatamente precedenti (e al genere
epico in particolare, con le sue imprese militari collettive) è il modo diverso
di porsi in rapporto col Tempo. Fa parte dell'arte moderna (nominata
contemporanea alla nascita del Romanzo) e necessariamente deve contenere quel
modo di narrare nuovo e di contrasto con l'arte del passato. La Teoria
dell'Estetica di Theodor Adorno si sofferma sull'incompiutezza dell'opera, cioè
il suo essere sempre in formazione: mentre gli altri generi epici tendono a
fermare il Tempo partendo da un inizio e arrivando a una fine, il Romanzo non ha
termine, non mette il punto. Altre caratteristiche stilistiche come il
progressivo focalizzarsi dell'attenzione sul singolo individuo o su piccoli
gruppi di cavalieri, immersi in vicende che hanno un misto di storico e di
"meraviglioso". L'"esperienza assoluta" del cavaliere, irretito nella
sua aventure (termine che in francese antico indicava inizialmente solo il
destino o il caso e che finisce per indicare il complesso delle peripezie e il
perfezionamento etico di chi le attraversa), sviluppa negli scrittori l'esigenza
di una narrazione meno ingessata, "capace di rappresentare un mondo complesso e
variamente articolata". Il romanzo è dunque costruito da una struttura della
storia più o meno complessa e da una varietà di personaggi più o meno ampia.
Questa profonda articolazione ha dato vita a numerosi sottogeneri: si passa
dal genere storico al fantastico, dal giallo al romanzo epistolare.
Da distinguere da Novella.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La novella è una narrazione in prosa breve
e semplice (di modesto respiro), generalmente più breve di un racconto (secondo
molti critici, la distinzione tra le due modalità narrative è labile o nulla),
nella quale c'è un'unica vicenda semplice e in sé conclusa, colta nei suoi
momenti essenziali, i cui personaggi si possono facilmente ritrovare nella vita
quotidiana. Essa nasce, non si sa con precisione dove e quando, nel contesto
della letteratura orale. La novella non è un genere letterario indipendente,
poiché è inglobata all'interno di altri generi. Tracce di novella sono presenti
nelle letterature dell'antico Egitto e della Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi).
Il genere è presente nelle letterature orientali in particolare in quella
indiana dove vi sono varie raccolte, tra cui la celebre Pañcatantra.
In India nasce anche la struttura delle novelle precedute da una cornice
narrativa, struttura che poi avrà diffusione anche in Occidente con
il Decameron. La novella ebbe scarsa autonomia nelle letterature greca e latina.
Si ricordano gli arguti e burleschi Racconti sibaritici e la Fabula Milesia.
Nella letteratura orientale celeberrima è la raccolta Le mille e una notte. Alla
base della struttura che la novella assumerà poi nel Medioevo troviamo
l'exemplum, un genere che si potrebbe definire una forma semplice di novella ma
che possiamo descrivere anche come a metà strada tra la fiaba e la parabola.
Anche l'exemplum è inglobato in altri generi, come la vita dei Santi perché era
usato molto spesso dai predicatori con finalità educative e morali. I
predicatori se ne servivano allora per ricondurre sulla giusta strada coloro che
avevano commesso qualche peccato. Nel Medioevo il fabliau è un altro antecedente
della novella. La novella sorge più tardi, in età medievale, nell'ambito di
culture molto diverse tra loro. Ancora assente in Francia e in Germania, la
novella era un genere praticato in Spagna dove risentiva della novellistica
arabo-orientale, come attestano Furberie e perfidie delle donne (1253), una
versione del Libro de' sette savi scritta da Fadrique di Castiglia, fratello del
re Alfonso X il Saggio; il Libro degli esempi del conte Lucanor e di
Patronio (1335) di Juan Manuel e le novelle in versi del Libro del buon
amor(1330-1343) di Juan Ruiz. In Inghilterra la novella si sviluppò a partire
dai Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer (secolo XIV).
Il genere letterario del
racconto ha le sue radici nel primo costituirsi dei gruppi umani: nasce dal
bisogno di comunicare proprio dell’uomo ed ha una millenaria tradizione orale
che arriva fino all’epoca contemporanea.
(Stefano Turicchia - Beatrice Volpi, 5S2)
Liceogalvani.it/lavori-multimediali/maniera/narrativo/racconto. Oggi il racconto
comprende generi molto diversi fra di loro: il realistico, il racconto d’azione,
il giallo ed il nero, lo psicologico e l’umoristico,
il fantascientifico, il fantastico; a volte alcuni di questi generi si fondono,
formando tipi di racconti del tutto nuovi. "Racconto" una parola di origine
novecentesca, nei secoli precedenti si preferiva invece chiamarlo "novella". I
critici ritengono che la tradizione del racconto abbia avuto origine in India e
che sia diffusa in Occidente a partire dal XII secolo, quando si intensificarono
gli scambi economici e culturali fra l’Oriente e l’Europa medievale. Anche nella
letteratura classica greca e latina si trovano esempi di racconti, che
costituiscono digressioni all’interno di altre opere, soprattutto di genere
storico; solo nel Medioevo il racconto si afferma come genere letterario
autonomo, partendo dalla Francia, mentre in Italia si sviluppa fra il XIII ed il
XIV secolo, con scrittori come Boccaccio. In questo tipo di narrazione le
vicende si articolano secondo relazioni di causa-effetto ed arrivano ad una
conclusione, non sempre positiva per il protagonista, che appare necessaria. Il
racconto si presenta come una forma chiusa, che non ammette aggiunte o varianti;
i personaggi sono realisticamente individuati e inseriti in un contesto
descritto con precisione, spesso con riferimenti a situazioni storiche concrete.
Nel racconto non troviamo più gli eroi del mito o i personaggi simbolo della
fiaba, ma protagonisti che condividono con il lettore caratteri ed esperienze
della natura umana. Tra questi generi letterari ed il racconto c’ una differenza
fondamentale: mito e fiaba sono in larga misura predeterminanti, perciò il
narratore è obbligato a muoversi entro gli schemi fissi stabiliti dalla
tradizione. Sono inoltre destinati a perdere contatto con la realtà, mentre il
racconto specie in talune sue tipologie, non estraneo al contesto storico, anzi
ne vuole essere espressione e manifestazione: rappresenta la realtà in tutti i
suoi contraddittori aspetti, al contrario del mito e della favola, che si
propongono scopi educativi. Il racconto si differenzia anche rispetto al
romanzo, che un testo molto più lungo, che cerca di dare una visione complessiva
del mondo, mentre il racconto affronta aspetti limitativi e circoscritti,
frammenti di realtà, senza la pretesa di offrire di essa un’interpretazione
generale. Il racconto quindi una narrazione breve, in prosa, con personaggi
umani, contenuti verosimili e generalmente non storici, per lo più senza
finalità morali o conclusioni moraleggianti.
Le raccolte di storie
scontano il pregiudizio di non vendere.
Per questo i librai non le
espongono, i premi le escludono e nelle top ten non riescono a entrare. Sarebbe
il caso di allargare gli orizzonti, scrive Rossella Milone il 6 aprile 2018 su
"L'Espresso". Alla domanda: «Quando vede un bel libro in classifica, come
reagisce?», Giorgio Manganelli rispose: «La cosa mi insospettisce molto. Ci deve
essere qualcosa che non va». Come anche ribadito su queste pagine da Wlodek
Goldkorn, la classifica dei libri non è un luogo indegno a prescindere, in cui
se ci finisci, allora significa che sei uno scrittore con la esse minuscola. Ci
sono bei libri che in classifica pure riescono a comparire, ma - ci viene in
soccorso Manganelli - è una specie di eccezione. Il problema a cui si riferisce
Manganelli, e il nodo cruciale su cui ragionare, ha a che fare non tanto con le
presenze, visibili, lampanti, ben evidenziate dal numero in grassetto; quanto
con le assenze. Di quei libri che pur essendo belli e ben scritti, restano
invisibili alla maggior parte delle persone. Questo vuoto, almeno nella
narrativa, è il vero cruccio delle classifiche: una distrazione fatale per quei
libri che pur possedendo un’importante qualità letteraria non sono lì, a
svettare. Vengono sottratti, scippati agli occhi di chi rimane all’oscuro di
tantissima buona letteratura che sprofonda in libreria. La visibilità, in questo
nostro tempo di sovraesposizioni e di eccedenze, è la sola possibilità che ha il
libro di vendere (anche se, spesso, il passaparola pure fa miracoli); e quindi,
cosa accade a quei libri che, invece, per definizione, o per uno strano e
contorto pregiudizio editoriale, restano impercettibili? A quei libri che
scompaiono, cioè, nelle vetrine delle librerie, sugli scaffali, sugli espositori
ammiccanti delle grandi catene libraie, nei premi letterari, nei festival, nei
dibattiti, sui giornali, negli inserti, in televisione? Restano invisibili, e in
questa invisibilità si coagula tutta la fatica del loro esistere. C’è una
categoria specifica di libri, tra tante altre (e penso alla poesia), che subisce
questa specie di ghettizzazione, conseguenza di un meccanismo complesso che
attraversa tutta la filiera editoriale in cui si dipana la vita di un libro.
Questi libri sono le raccolte di racconti. Fatta eccezione per le antologie di
racconti in cui vengono raccolti, miratamente, le storie di Natale degli autori
più disparati con l’avvicinarsi delle feste natalizie; oppure altre in cui i
racconti vengono riesumati per affrontare un tema (le storie che parlano di
madri in occasione della festa della mamma, o quelli per la festa della donna, o
i gialli sotto l’ombrellone…); fatta eccezione anche per le raccolte di racconti
di autori stranieri con un nome, però, ben radicato nella percezione collettiva,
i libri di racconti nostrani (ma anche una miriade di stranieri) scompaiono
dalla considerazione del pubblico ampio, e quindi dalle classifiche. Se una cosa
sparisce dal nostro campo percettivo è come se perdesse la sua possibilità di
esistenza in vita. O, quanto meno, fa molta più fatica a sopravvivere nel
tritacarne delle nuove uscite.
I libri di racconti subiscono
un radicato preconcetto secondo cui le raccolte non vendono. E se non vendono,
allora si fa fatica a investirci molto, a produrre una buona campagna
pubblicitaria, a spenderci energie per la promozione ad ampio raggio. E, a
questo punto, si crea un cortocircuito malefico: se il lettore non trova i libri
di racconti in libreria, nei festival, nei premi, nei dibattiti, nelle
recensioni, sarà molto difficile che si creino le condizioni perché quel libro
riesca a scalare le classifiche. Creando, così, le premesse per una più profonda
oscurità, perché se quei libri non compaiono in classifica, allora i lettori non
sapranno che i libri di racconti esistono. Peggio, si creerà qualcosa di più
losco e pericoloso: si perderanno le condizioni per cui i lettori potrebbero
affezionarsi ai racconti, si perderà l’occasione di fornire loro una mappatura
di lettura specifica per questa forma letteraria, disabituandoli e diseducandoli
alla lettura di racconti tout court. La classifica è il luogo in cui il libro è
messo sotto il riflettore: al primo posto c’è l’étoile, poi i secondi ballerini,
e via via tutto il coro. La classifica è il modo più semplice, veloce,
sovraesposto, appagante e rassicurante che il lettore ha per venire a conoscenza
di qualcosa, di cui, altrimenti, resterebbe all’oscuro. Vedere un libro di
racconti in classifica sarebbe come veder ballare sul palco una prima ballerina
bendata, sui trampoli, con le mani legate; dovrebbe ballare in condizioni
difficili, quasi impossibili: sarebbe, cioè, rischiosissimo porla lì, con un
pubblico che la osserva piena di scetticismi. Ma la ballerina brava ballerebbe
comunque, perché è una ballerina. E un bel libro di racconti saprebbe raccontare
comunque, perché sarebbe, semplicemente, un libro come un altro. Negli ultimi
tempi, sono sorte molte realtà che si occupano di racconti, sviscerando la forma
breve da varie prospettive, proponendo riflessioni, recensioni e nuove proposte.
In una recente intervista a Daniele Di Gennaro di minimum fax, che molto ha
fatto per il racconto come forma letteraria, l’editore ha detto: «Se si
facessero i conti solo con il contenuto e con la scrittura, con il prodotto
culturale e non con il prodotto, nel triste senso del nastro industriale, questo
pregiudizio (i racconti non vendono, ndr) che è un errore per definizione, si
dissolverebbe come il più sottile dei gas». Vale a dire, che in Italia si
pubblicano tantissime raccolte di racconti, sia di autori italiani che di
stranieri, dal contenuto letterario forte e credibile, in alcuni casi connotati
da una qualità letteraria preziosa sia per il nostro patrimonio letterario, che
per quello individuale di ciascun lettore. Per dirne una su tante: nel maggio
del 2017 Racconti Edizioni ha pubblicato una delle raccolte più belle della
stagione, di un’autrice poco conosciuta che, però, è una delle più grandi
narratrici di racconti, una maestra, come dichiarò Alice Munro, premio Nobel per
la letteratura del 2013, scrittrice di racconti anche lei. “Una coltre di verde”
è il titolo di questa raccolta, di Eudora Welty, che, ovviamente, non è mai
finita in classifica. Perché? Per una serie svariata di motivi. I più semplici:
perché l’ha proposta, coraggiosamente, una piccola casa editrice con limitate
forze economiche; perché quello dell’autrice non è un nome conosciuto ai più;
perché la qualità letteraria fa un poco paura; perché è un libro di racconti. Lo
stesso Giorgio Manganelli, i cui racconti hanno fatto risplendere la letteratura
italiana, e che ancora oggi ispirano i più bravi scrittori (non solo di
racconti), dovette veder scritto come sottotitolo a Centuria, un libro di
narrazioni brevi fondamentale nel nostro patrimonio narrativo: “cento piccoli
romanzi fiume”, per spaventare meno il lettore e invogliarlo a comprare il
libro. Come diceva la giornalista Grazia Cherchi, molto spesso i servizi per i
lettori, come le classifiche, sono non-servizi, qualcosa che finisce per
trattarli come non-lettori. Saggiamente, la Cherchi suggeriva di inserire nelle
pagine culturali dei giornali, insieme alle classifiche canoniche, anche le
classifiche dei libri che meriterebbero di essere venduti meglio e che passano
sotto silenzio. Aggiungerei io, con l’obbligo, etico o anche contrattuale, di
inserire almeno uno, se non tre, o quattro, libri di racconti.
Aboliamo le classifiche dei
libri.
Sanciscono il successo di un volume o di un autore rispetto a un altro, ma
confondono qualità con quantità. E fotografano gusti senza dirci niente della
letteratura. Ecco perché dovremmo farne a meno per il bene di tutti, scrive
Wlodek Goldkorn il 28 marzo 2018 su "L'Espresso". Domanda: come mai, sui
giornali, quando si parla della moda non vengono pubblicate le classifiche dei
capi d’abbigliamento più venduti? Eppure sarebbe interessante sapere come
vestiamo, dove acquistiamo le nostre giacche, gonne, camicie, calze, quali
marchi compriamo. E ancora, perché, quando si parla di cibo, un argomento
frequentatissimo dai media, non si dedicano pagine e pagine alle classifiche
della popolarità delle catene di ristorazione o delle singole trattorie, ma si
opta invece per riportare il giudizio di qualità degli esperti culinari?
Insomma, quando parliamo del cosa ci metteremo addosso la prossima stagione e
che cosa mangeremo, quando porteremo a cena il nostro o la nostra partner, il
discorso si fa sulla qualità, mai o raramente sulla quantità. E così sappiamo
che il tal stilista ha imposto il linguaggio nuovo, interpretando attraverso i
vestiti, lo spirito del tempo (guerra, pace, gioia, nostalgia e via
esemplificando). Lo stesso discorso vale per i grandi chef, premiati con un
certo numero di stelle in base alla loro capacità di raccontare attraverso il
cibo (il cibo è idioma) alcune caratteristiche dell’avvenire.
Quanti libri si devono vendere
per finire in top ten? E quali trucchi o strategie usano gli editori? Viaggio in
un meccanismo sconosciuto ai non addetti ai lavori ma che condiziona il mercato.
E allora, un’ulteriore domanda: perché invece, quando si parla dei libri è così
importante informare i lettori su quali sono i volumi più venduti? E che cosa ci
dicono le classifiche dei libri, specie (più che altrove) in Italia? A scanso di
equivoci, una persona che voglia farsi aiutare dai giornali nella scelta dei
libri da acquistare ha a disposizione, quasi sempre, una serie di recensioni. Ma
allora, perché le recensioni dei libri, a differenze delle recensioni dei
ristoranti e delle sfilate, non bastano? Perché appunto le classifiche?
Cominciamo dall’inizio. Fu la
rivista newyorkese “The Bookman” a inaugurare, nel 1895, la rubrica “Libri nuovi
in ordine di vendita”. E anche se qualche esperto spiega quanto l’idea fosse
nata, sempre negli stessi anni nei circoli editoriali di Londra, è negli States
che sapere quanto venda un libro fosse stato allora fondamentale. Siamo a una
trentina di anni dalla Guerra civile, in un Paese che sta assorbendo masse di
immigrati dall’Europa, costruisce città e edifici giganteschi; e dove si sta
forgiando una nuova identità, basata sulla prevalenza dell’esperienza concreta,
con il mito del self made man, l’uomo che diventa ricco e di successo grazie al
proprio ingegno e non per via dei natali o dell’istruzione. Ricchezza e successo
sono sinonimi. Dire quanto vendevano certi libri era una specie di moto di
stampo populista e democratico; era l’emancipazione dall’accademico sapere dei
professori universitari, interessati più ai classici del Vecchio Continente che
all’esperienza del Mondo Nuovo. Le classifiche erano portatrici di un messaggio:
vogliamo la velocità, la soddisfazione immediata; specie di anticipazione del
futurismo. Senza perifrasi: oggi, le classifiche ci parlano ancora e sempre
della soddisfazione immediata e della velocità dei consumi, ma non ci dicono più
niente sulla letteratura. Peggio, ci inducono a scambiare il consumo e gli
indizi di stampo sociologico, per indagine e giudizio letterari. Quanto sopra,
non è un’affermazione per cui chi vende bene non è un bravo scrittore mentre chi
non vende è un genio incompreso. Si può vendere benissimo e avere il posto
assicurato nella storia della letteratura (è il caso di Philip Roth), si può
essere un bestsellerista e grande scrittore (Stephen King). Il punto è un altro:
è il tempo. Non il tempo di lettura, ma la durata del libro nel tempo.
Guardiamo le classifiche di
questo ultimo periodo. I libri (stiamo parlando della narrativa) sono spesso ben
scritti. E di cosa parlano? Delle bambine, che è bene che siano ribelli, delle
malattie curate e fatali e quindi del dolore di chi ha attraversato il male o di
chi deve confrontarsi con la perdita della persona amata; e anche libri che sono
derivazione diretta del mondo on line delle adolescenti YouTuber. In parole
povere: leggendo le classifiche si ha la percezione precisa dei temi e dei
protagonisti della società italiana, oggi. La classifica ci parla della
prevalenza delle donne, del linguaggio trasversale degli adolescenti e
dell’enorme interesse in tutto ciò che riguarda i tumori. Quanti di questi libri
resteranno? Quanti (anche tra quelli scritti bene; ed è pure giusto condividere
angosce ed esperienze) verranno letti fra dieci, vent’anni? Non è una domanda
oziosa. La letteratura, ripetiamo, vive nel tempo, altrimenti è morta nel
momento in cui il libro viene dato alle stampe. La letteratura è sedimentazione,
lentezza, riflessione. I libri non ci rendono migliori (talvolta possono
renderci più cattivi), ma ci rendono consapevoli: di noi stessi, del Bene e del
Male, dei nostri sentimenti reconditi; ecco perché la letteratura ridotta a un
bene di consumo immediato non è più letteratura. E non dimentichiamo che le
classifiche sono costruite su un campione di libri venduti in alcune librerie,
nell’arco di una settimana, e quindi non fanno altro che suggerire: chi vende
bene, velocemente e risponde al bisogno immediato, è un grande scrittore. Ha già
raccontato su questo settimanale Marcello Fois quanto gli autori più venduti di
prima della guerra siano stati Pitigrilli e Guido Da Verona. Del primo si
ricorda oggi l’opera di delazione per conto dell’Ovra; del secondo niente,
mentre tutti i liceali studiano Italo Svevo che vendeva pochissimo.
E allora, aboliamo le
classifiche? Forse sarebbe un atto salutare. Specie in un Paese dove la
confusione indotta dal sistema editoriale tra quantità, politica e qualità è
molto più marcata che altrove. Un esempio per tutti: solo in Italia il premio
più importante, lo Strega, è quasi sempre conferito in base alle manovre di
politica editoriale e non alla qualità intrinseca dei libri (il che non esclude
che talvolta vinca un buon libro e che quest’anno ci siano in lizza alcuni
ottimi libri) e la stessa pletorica composizione della giuria favorisce la
politica a scapito dei meriti letterari. Infine. Viviamo in un tempo di
catastrofe, tra populismi, razzismi e il tutto e subito. Chi ancora pensa al
futuro dovrà compiere la traversata del deserto, ma senza la guida di Mosè e di
Dio. Occorre attrezzarsi. Occorre tornare alle cose essenziali, alle parole
prime, all’indispensabile.
Come funzionano davvero le
classifiche dei libri.
Quanti libri si devono vendere per finire in top ten? E quali trucchi o
strategie usano gli editori? Viaggio in un meccanismo sconosciuto ai non addetti
ai lavori ma che condiziona il mercato, scrive Caterina Bonvicini il 28 marzo
2018 su "L'Espresso". Le classifiche? Ambite o demonizzate. Autori che le
controllano ossessivamente o che le ignorano sprezzanti. Editori sensibili,
sempre. Ma quanto sappiamo di quel mondo? Poco, in realtà. È un universo più
complesso di quel che sembra. E più sfuggente. «Le classifiche di oggi pesano il
40 per cento in meno di cinque anni fa. Perché i best seller vendono meno e il
catalogo vende di più», spiega Stefano Mauri, presidente e amministratore
delegato del gruppo Gems. «È una conseguenza dello sviluppo dell’e-com che rende
tutto disponibile. Siamo davanti a una mutazione genetica: il consumatore che
prima sceglieva fra 5000 titoli, oggi sceglie fra un milione. Si è dimezzata la
vendita nei supermercati, che facevano il 50 per cento su un best seller e
adesso fanno il 25 per cento. Ma è stata compensata dalla vendita on line. I
primi 10 titoli dell’anno vendono il 40 per cento in meno, i primi 100 il 30 per
cento in meno, i primi 1000 il 10 per cento in meno. Però tutti gli altri
vendono un pochino di più». Tendiamo a pensare alle classifiche così come ci
vengono proposte dai giornali (Robinson e La Lettura si affidano a Gfk e
Tuttolibri a Nielsen). Quindi a concentrarci solo sui primi 20. Invece, gli
editori si servono di uno strumento più profondo, più serio di qualunque
spasmodico desiderio e di ogni demonizzazione, cioè di uno strumento asettico,
professionale. Tanto che spesso rizzano le antenne studiando le posizioni medie
o basse, che noi nemmeno vediamo. «Un indicatore molto interessante è quello che
succede in mezzo, non in cima», dice Carlo Carabba, responsabile editoriale
della narrativa italiana Mondadori. «Se un esordiente, su cui non c’è stato
strepito, vende 200 o 250 copie a settimana, mi dico: però, che bella tenuta nel
tempo». E Paolo Repetti, direttore Einaudi Stile Libero, racconta: «Le
classifiche sono uno strumento utile soprattutto nelle parti basse. Io vado
sempre a vedere fra il tremillesimo e il cinquemillesimo posto. Quando abbiamo
preso De Giovanni era pubblicato da Fandango e io trovavo due o tre libri suoi
nelle parti basse, ma sempre, tutte le settimane. Facevano 50 copie al mese però
lui era fisso lì. Era come se la brace fosse un po’ accesa. Aveva una
potenzialità di vendita inespressa». «Dopo il ventesimo posto sembra aprirsi un
vuoto, che non aiuta a rendere conto di quello che si muove al di là della
magica soglia», conferma Piergiorgio Nicolazzini, agente letterario (Pnla), «al
lettore manca uno sguardo più completo e articolato, ne ricava un’impressione
parziale, estremizzata, che alimenta il circolo vizioso del vende ciò che già
vende e dà l’impressione che il mondo editoriale si concentri sulle punte più
significative. La vera forza di una classifica invece è quella di alimentare una
lettura trasversale e disincantata. Cioè scoprire linee di tendenza,
potenzialità, far dialogare novità e catalogo, valorizzare autori che navigano
sotto la magica soglia ma di sorprendente continuità, o altri di piccolo ma
costante rendimento su cui investire». Marco Vigevani, agente letterario (The
Italian Literary Agency), fa l’esempio di una sua autrice: «Un libro può vendere
molto nel tempo e non entrare mai in classifica. Mariapia Veladiano, con “Lei”
ha venduto 20.000 copie senza mai comparire. Se la classifica è molto alta,
intorno a 900 o 1000 copie a settimana, certi romanzi non appaiono».
Perché troviamo sempre gli
stessi nomi nelle top? Perché i librai tendono a ordinare lo stesso numero di
copie vendute del libro precedente. Quindi gli autori da classifica
continueranno a tornarci, raramente capita il contrario. Nessun editore cerca
più di inondare il mercato. È una strategia vecchia, che oggi porta solo alla
rovina. Adesso si fanno solo tirature vicine alle prenotazioni. Di solito
meccaniche, ripetitive. «La cosa veramente complicata, specie nel mercato di
oggi che è abbastanza conservativo, è immettere nuovi autori nelle classifiche»,
dice Carabba. «Quindi bisogna pensare in un altro modo. Io non credo in
un’editoria del tutto e subito, del numerone, in cui conta il venduto dei primi
due mesi, se no remi in barca. È un modello che non si può più sostenere.
Bisogna tornare a un modello di maggior valorizzazione del medio e lungo
periodo. Non parlo di mesi, ma di anni. Siamo in una fase storica in cui i
venduti sono molto calati. E non tutti i libri devono essere giudicati solo dal
risultato commerciale. Su alcuni c’è un obiettivo soprattutto commerciale e, se
non si raggiunge, il risultato è insoddisfacente. Su altri invece ci si
concentra di più sulla comunicazione, sulla valorizzazione dell’autore. Se poi
non si raggiungono abbastanza lettori, pazienza. Imposti le basi per farlo con
il romanzo successivo. Io credo all’idea di percorso. Se uno segue un autore,
deve farlo con un’idea prospettica». Lo stesso pensa Nicolazzini: «Le
classifiche sono una risorsa a disposizione dei professionisti dell’editoria per
rafforzare una visione, soprattutto a medio e lungo termine, senza la quale non
si può interpretare né gestire quell’inestricabile rapporto fra qualità e
quantità che è insito nel mercato e nella natura stessa dei libri e di chi li
scrive».
Come si fa a mandare un libro
nella top ten? «Ahahah», risponde Mauri. E Repetti rilancia con una battuta:
«Quando chiesero a Somerset Maugham le leggi per scrivere un best seller,
rispose: Ci sono tre regole fondamentali. Peccato che io non sappia quali sono».
Antonio Franchini, direttore editoriale Giunti Bompiani, parla di «una preghiera
laica dell’editore. Se avessimo la formula…». Beatrice Masini, direttore di
divisione Bompiani, ricorda i casi di Kent Haruf o di Annie Ernaux, il miracolo
di un piccolo editore indipendente come NN: «Chiamando a raccolta i lettori
forti si riesce a scansare un meccanismo che per sua natura sembra dominato dai
grandi gruppi. È molto bello il rovesciamento». Quindi smettiamola di mitizzare
il potere degli editori. Se fosse in vendita una formula matematica (o magica),
sicuramente la pagherebbero più di qualsiasi loro autore. Invece tutti si
trovano di fronte a una realtà complicata, per certi aspetti troppo conservativa
e per altri in continuo mutamento. Ma se nessuno ha la formula per fare entrare
un libro nella top ten e le classifiche sono uno strumento più sottile di quel
che si pensa, naturalmente esistono delle strategie ben precise per lanciare un
libro. La pubblicità sui giornali, a detta di tutti, ormai conta poco. Le cifre?
Si va da 4.000 euro per una pagina su un supplemento di cultura agli 8.000 per
un’uscita in prima di un quotidiano nazionale. Ben più di quanto ricevono tanti
autori per un romanzo, magari costato anni di fatica. E se un libro viene pagato
caro, cioè più di 50.000 euro, la preoccupazione diventa recuperare l’anticipo
(per un anticipo di 50.000 euro serve vendere 30.000 copie, per esempio).
Dunque perché investire tanto
per un paginone sui giornali? Per fare piacere agli autori, ti rispondono.
Funziona come segnale al mondo culturale e ai librai (questo autore per noi è
importante: vi invitiamo al nostro matrimonio R.S.V.P.). Sembra che sia più
utile per i libri letterari che non per quelli commerciali, perché il pubblico
che legge i supplementi culturali è medio-alto, e il resto così non si
raggiunge. «In certi casi è meglio tappezzare gli autobus o gli spazi
metropolitani con una pubblicità davvero massiccia», dice Vigevani. «Servono
idee nuove», aggiunge Mauri. «Quando Mondadori ha fatto la prima pubblicità in
tivù, ha funzionato. Non si usava. Ma quando hanno ripetuto l’idea, non hanno
avuto gli stessi risultati». E poi, siamo nell’era dei social. Dice Repetti:
«Siamo nel regno del politeismo assoluto, non c’è più un solo dio che governa il
mercato. Come le firme autorevoli sui giornali di una volta. In America hanno
spostato l’investimento pubblicitario al 70 per cento sull’on line e al 30 per
cento sul cartaceo. In Italia questa cosa non c’è ancora. Al massimo si può
sponsorizzare un post di un autore già molto seguito, come Michela Murgia, ma
costa molto». Nel caso dei romanzi di genere, dicono, aiuta coinvolgere i
blogger del settore. Ci sono poi dei piccoli accorgimenti che possono fare la
differenza. «Può contare anche il giorno di uscita», spiega Vigevani. «Perché la
classifica per gli editori esce di giovedì, anche se viene pubblicata la
domenica. Se fai uscire un libro di mercoledì, hai un solo giorno di
rilevamento. Se lo fai uscire di venerdì, per la settimana dopo, hai un
vantaggio». Un lettore innocente e sprovveduto può affidarsi alle vetrine delle
librerie di catena. Non sa che quegli spazi vengono comprati. Come quelli
all’ingresso o alle casse. Si pagano anche gli espositori. Ogni posizione ha un
prezzo, e anche molto alto. Si chiama attività di marketing punto vendita. Può
costare fra i 7.000 e i 15.000 euro, un investimento oneroso, che però ha un suo
ritorno, più efficace della pubblicità. Ma si può fare solo all’inizio, per una
quindicina di giorni, mica si possono spendere cifre così per tutto l’anno. Uno
può pensare che se pubblichi da Feltrinelli è facile riempire le Feltrinelli con
la tua copertina. Come le Mondadori con un libro Mondadori. Invece no. È più
complicato. Feltrinelli editori è una società diversa da Feltrinelli librerie.
Le Mondadori sono in franchising. Più in generale, le grandi catene guadagnano
grazie alla concorrenza, gli altri editori sono clienti importanti. Quindi un
po’ di riguardo per il proprio gruppo c’è, ma non troppo: bisogna mantenere il
giusto equilibrio, per fare tornare i conti. In poche parole: affittare spazi
serve eccome per fare entrare chi si vuole in classifica. È ovvio che un lettore
compri più facilmente un libro che vede piuttosto che uno subito messo a
scaffale. Ma questa spesa si può sostenere solo per pochi autori, dal potenziale
commerciale alto. Quelli che hanno sempre venduto poco, che hanno dei
«pregressi» come si dice (la fedina pedale di uno scrittore, quasi sempre
sporca), di solito ricevono un anticipo più basso dell’affitto di uno spazio in
libreria, e i conti sono presto fatti. Esistono però dei modi per alzare le
prenotazioni, se un editore ti sostiene. Un autore che vende poco non è
necessariamente spacciato. «Il libraio tende a pensare che un libro replicherà
il risultato commerciale del precedente e a prenotare lo stesso numero di
copie», spiega Carabba. «Ovviamente si può ricredere. Per questo si fanno le
“copie librai”». Si può mandare una staffetta del libro, cioè le bozze non
corrette, il primo capitolo, un folder promozionale. «L’importante è creare un
rapporto di fiducia. Il risultato commerciale non deve diventare un’ossessione.
E bisogna superare l’idea che qualità e quantità siano contrapposte». «In ognuno
di noi c’è un lettore letterario, una donna, un pensionato, un appassionato di
romanzi storici, una casalinga», dice Franchini, «in ognuno di noi ci sono
lettori diversi in grado di entusiasmarsi per libri che si comportano in modo
diverso». L’imprevedibilità appartiene soprattutto al long seller, e Repetti
cita il caso Agassi: «Siamo partiti con una prima tiratura di 11.000 copie, ne
abbiamo vendute 700.000. Naturalmente non era programmato».
UN RISCOSSORE
MUSICALE ALLA PORTA
Il Balzello dei
Balzelli, specie se doppio, anzi triplo o addirittura quadruplo. Oppressi, pur
non guardando “le purghe di Stato”. Si dice TV di Stato, quindi TV pubblica al
servizio del cittadino, invece è un baraccone mangia soldi in mano ai partiti
politici ed alla loro claque. Foriera di censura ed omertà non offre qualità, ma
straguadagni a giornalisti e dirigenti politicizzati ed immeritata visibilità a
personaggi senza arte ne parte. Come tutte le cose italiane l’abbonamento RAI è
regolato ancora dalla normativa del tanto bistrattato periodo fascista. Alla
sinistra in Tv questo non gli fa schifo.
Gli Abbonamenti
Ordinari riguardano la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di
uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive.
(art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938
n. 246 e modificazioni successive).
Gli Abbonamenti
Speciali riguardano la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare
nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o
indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc..
In
effetti la normativa, che si rifà a un Regio decreto del 1938 prevede che
‘apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive’
debbano pagare il canone che, per le aziende, è appunto speciale.
L'obbligo è
stato istituito di fatto con l'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, con la seguente disposizione: "Chiunque detenga uno o più
apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al
pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde
elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di
linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere
la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente"; il canone
"speciale" di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n.
458, sostituendo il secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 23
ottobre 1925, n. 1917 con questa disposizione: "Qualora le radioaudizioni siano
effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di
fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a
scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale
contratto di abbonamento con la società concessionaria". Tale norma introduce in
modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l'applicazione del
canone speciale e del canone ordinario. Corrisponde al vero che esiste l'obbligo
di pagamento se si detiene in ufficio, studio o negozio un apparecchio
televisivo (adatto alla ricezione delle trasmissioni). Tuttavia è importante
evidenziare che il tutto non si applica nel caso di monitor non dotati di
sintetizzatore di frequenza. Anche se in apparenza le pagine della Rai paiono
dare la sensazione che si tratti di una disposizione riferita solo agli
alberghi, bar, ed esercizi simili. Sottolineamo che l'obbligo c'è ANCHE PER
UFFICI, NEGOZI, STUDI, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto. Bisogna
evidenziare che l'obbligo vale esclusivamente nel caso si tratti di un
televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di
sintetizzatore), perché si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste
obbligo per i monitor "puri" che non sono in grado di decodificare il segnale
trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori)
che si limitano a leggere il segnale del nastro. Del pari è giusto sottolineare
il fatto che se non c'è apparecchio televisivo (ricordiamo che la RAI
semplicemente "ci prova"), ovviamente non si deve pagare, e non si può essere
obbligati a compiere alcuna azione in merito. Vale a dire non opererebbe il
principio della presuntività; tuttavia potrebbe esserci una verifica di
ispettori della Rai, che comunque per legge non possono procedere ad ispezioni
personali, né reali né sulle persone, nè sui luoghi di lavoro in quanto la legge
non prevede in capo ai medesimi un siffatto potere di agire che andrebbe, se
posto in essere, denunciato immediatamente all'autorità giudiziaria perché
integranti fattispecie di reati ben precisi. La Rai ha inviato un’ingiunzione di
pagamento a 5 milioni di imprese chiedendo il pagamento del canone su qualsiasi
apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo: personal computer,
videofonini, videoregistratori, iPad e sistemi di videosorveglianza.
Finora, la
giurisprudenza non sembra lasciare molte vie d’uscita.
Nel 2007, con sentenza del 20 novembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che
«il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione
nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente,
da un lato, e l’ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo,
dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non
commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo». Ancora
più stringente la posizione della Corte costituzionale del 1988: «Se in un primo
tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla
fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta,
facendo leva sulla previsione legislativa dell’articolo. 15, secondo comma,
della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la
detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti
dall’estero (sentenza n. 535 del 1988)».
Per
l’ADUC il
computer è
soggetto al pagamento del canone Rai? L’annosa questione è stata oggetto di suoi
quesiti alla Rai, interpelli all’Agenzia delle Entrate e di interrogazioni
parlamentari al ministero delle Comunicazioni (ora Sviluppo economico), ma mai è
stata fornita una risposta in tal senso. La Rai ha infatti risposto di non
sapere se il pc era soggetto al canone e che si avrebbe dovuto chiederlo
all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, deputata alla riscossione di questa
tassa, ha risposto di non saper rispondere e di aver girato il quesito al
Ministero delle Comunicazioni. Ad oggi non risulta che il Ministero abbia preso
decisioni in merito. Nonostante ciò, la Rai sta comunque sollecitando le aziende
e i professionisti a pagare il canone anche per i “computer collegati in rete
(digital signage e similari)”.
E poi pagare per
cosa?
Nel caos della prima
serata del "Festival di Sanremo 2012" qualcuno della Rai, tra l'incredibile
blocco del sistema di voto e il sermone di Adriano Celentano si è dimenticato di
far trasmettere pubblicità per 650 mila euro.
Chi è questo qualcuno? Forse riuscirà a scoprirlo, dopo "accurate e prolungate
indagini", il "commissario" Marano "inviato prontamente sul posto" per
"riportare l'ordine" al "Teatro Ariston". Nell'attesa, comunque, una cortese
richiesta: poiché la Rai continua a buttare via in mille modi i suoi soldi,
smetta almeno di assillare gli "abbonati per forza", cento volte al giorno, con
la sua richiesta di versare il rinnovo del canone. I boiardi di Stato stanno
bene attenti a costringere gli utenti a mantenerli con balzelli odiosi nella non
curanza dei pseudo rappresentanti dei cittadini sganasciati in Parlamento.
Non
dimentichiamoci una cosa e per chi non lo sapesse la diciamo ora. Di non solo
Rai è vittima “rapinata” il povero imprenditore che ha una tv o una radio. Già.
Per questo c’è un altro balzello: la SIAE. Società italiana Autori ed Editori.
Be’, sì un tributo a chi crea arte e la pubblica e la distribuisce bisogna
riconoscerlo. Si ma non è finita. A questi si aggiunge un altro mungitore alla
vacca collettiva. Ecco a voi
UN RISCOSSORE
MUSICALE ALLA PORTA.
Il dr. Antonio
Giangrande, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ed autore del
libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo”, denuncia l’ennesima anomalia
italiana. “Non tutti sanno – dice il presidente – che, in tema di
intrattenimento musicale, le direttive dell’Unione Europea e la legge sul
diritto d’autore (vedi gli articoli 72, 73 e 73 bis, Legge n. 633/1941)
riconoscono e tutelano sia i diritti degli autori, che compongono i brani
(gestiti dalla Società Italiana Autori ed Editori), sia i diritti dei
discografici, che realizzano le registrazioni musicali (gestiti in maggior parte
dalla Società Consortile Fonografici). Il consorzio SCF è oggi composto da case
discografiche major e indipendenti ed attualmente tutela i diritti discografici
di oltre 280 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio discografico
nazionale e internazionale pubblicato in Italia. Ciò significa, che per sentire
un brano musicale registrato, in qualunque modo e forma, è necessario
riconoscere anche un compenso al SCF, diritto autonomo rispetto a quanto dovuto
alla SIAE.
Ciò, per
entrambi, avviene comunemente nei seguenti contesti:
 trasmissioni radiofoniche e televisive;
trasmissioni radiofoniche e televisive;
 trasmissioni via satellite;
trasmissioni via satellite;
 attività che utilizzano musica a scopo di lucro (es. discoteche, sfilate di
moda, corsi di fitness);
attività che utilizzano musica a scopo di lucro (es. discoteche, sfilate di
moda, corsi di fitness);
 attività per le quali la musica in diffusione di sottofondo costituisce un
elemento di valore aggiunto al business (es. bar, ristoranti, alberghi, esercizi
commerciali, studi od esercizi professionali, oratori parrocchiali, circoli
privati, feste patronali, ecc).
attività per le quali la musica in diffusione di sottofondo costituisce un
elemento di valore aggiunto al business (es. bar, ristoranti, alberghi, esercizi
commerciali, studi od esercizi professionali, oratori parrocchiali, circoli
privati, feste patronali, ecc).
Il compenso è
dovuto anche nel caso in cui la diffusione dell’opera avvenga senza fine di
lucro (in auto o in casa). Ai sensi della legge sul diritto d’autore, non pagare
i diritti alla SIAE o alla SCF comporta l’applicazione della sanzione penale,
oltre che amministrativa. Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
00626/2007 resa l'8 giugno 2007 dalla terza sezione penale, la diffusione di
musica registrata senza aver versato i diritti connessi alle imprese
discografiche per la riproduzione dei brani musicali, in questo caso
rappresentate da SCF, Società Consortile Fonografici, viola la legge sul diritto
d’autore e assume rilevanza penale. Solo che il Conna, ente rappresentativo
degli interessi di molte emittenti radiotelevisive, disconosce tale sentenza
rilevando che l'articolo 180 della legge 633 del 22 aprile del 1941 dice che
l'attività di intermediario è riservata in via esclusiva alla Siae e al punto 3
aggiunge che essa curerà la "ripartizione dei proventi medesimi fra gli aventi
diritto". Un brutto colpo per i cittadini italiani, che dell’intrattenimento
musicale fanno il loro stile di vita, salvo far finta di niente, fino a quando
non si presenta qualcuno alla porta, che ce lo ricordi.”
SIAE: LA STORIA.
Gian Antonio
Stella su “Il
Corriere della Sera”
racconta di denunce, contro-denunce, avvocati, veleni, dossier... Alla Siae, da
mesi, è in corso una guerra termonucleare. Di qua i nuovi vertici «mandati a
mettere ordine» appoggiati da un pezzo del mondo politico. Di là i sindacati
interni e un altro pezzo della politica. In palio, una società ridotta a un
carrozzone sgangherato e traballante sotto i debiti.
In quali
condizioni la Società italiana autori editori sia entrata nel terzo millennio lo
dice l'Istituto Bruno Leoni: «Il monopolio legale risulta anacronistico, oltre
che lesivo della concorrenza». «La conservazione del regime di esclusiva
impedisce la creazione di soluzioni più efficienti di tutela e gestione dei
diritti d'autore». Le omologhe società inglesi pur chiedendo percentuali minori,
«riescono a distribuire agli iscritti una quota più elevata». Insomma, la Siae è
una macchina che per anni ha alimentato soprattutto se stessa.
Per colpa di
chi? Della società, denunciano i sindacati citando gestioni scellerate, stipendi
da favola, piccoli e grandi lussi auto-concessi dai vertici. Della società e dei
suoi vecchi vertici senz'altro, concorda la nuova dirigenza commissariale, ma
anche dei sindacati che avrebbero profittato per spartirsi la torta. Ed ecco che
di qua l'anziano commissario Gian Luigi Rondi, i suoi vice Domenico Luca
Scordino e Mario Stella Richter e il direttore generale Gaetano Blandini
(bollati come «le badanti del novantunenne, mai visto») sono accusati di avere
«svenduto» il 28 dicembre scorso una serie di immobili di Siae e del Fondo
Pensioni per un prezzo nettamente inferiore alla valutazione (260 milioni invece
di 463 milioni) a due società, la Aida e la Norma. Di là quelli che rispondono
di avere fatto «confluire gli immobili nei due fondi» proprio per «custodire il
patrimonio» e sottrarlo agli abusi del passato dato che «Aida e Norma sono al
100% del Fondo Pensioni e di Siae». Quindi resta tutto in casa. Di qua la
direzione viene denunciata da Cgil e Cisl, le quali chiedono ai giudici la
revoca «della disdetta indiscriminata di tutti gli accordi sindacali» e la
condanna «ad astenersi dall'attuare controlli e/o ingerenze sull'utilizzo dei
permessi sindacali». Di là i vertici sventolano il verdetto che dà ragione alla
società sancendo «l'infondatezza della doglianza in esame» e condannando Cgil e
Cisl a pagare le spese processuali. E accusano a loro volta i sindacati di voler
difendere un sistema indifendibile. Dove i dipendenti costano mediamente 64.200
euro (no, dice la controparte negando tutto: 41.700) cioè il doppio rispetto a
quello (36.425) della pubblica amministrazione. Costo che contando anche la paga
media dei dirigenti (157.700) schizzerebbe addirittura a 69.200. Per salire nel
2014, coi contratti vigenti, a 82.300. Troppi, accusa Blandini, che si è
tagliato lo stipendio di 130 mila euro, per un'azienda in agonia che nel 2010 ha
speso 127 euro ogni 100 incassati e quest'anno prevede comunque di andare sotto
del 16%. Ma Fabio Scurpa, Cgil, contesta anche questo: «A parte il fatto che i
soldi per i dirigenti li hanno trovati, la Siae è sana: dicono che è in rosso
per massacrare chi ci lavora».
Non basta.
Mentre i sindacati dicono di non fidarsi «di un amico della Cricca», dato che
l'allora direttore ai Beni culturali del settore «Cinema» finanziò in quella
veste un film con Lorenzo Balducci, (intercettazione imbarazzante: «Senti oggi
abbiamo approvato... Sono stati bravi, si sono spicciati...»), escono tabelline
fitte di nomi di dipendenti con accanto il marchietto: «figlia di», «nipote di»,
«fratello di», «cognata di», «genero di»... Assunti («Scurpa compreso») per
chiamata diretta. Magari con la benedizione del babbo o della mamma
sindacalista. Per non dire del patrimonio immobiliare affittato a canoni assai
convenienti a volte neppure pagati per mesi. Al punto che la Siae, nella
denuncia penale contro l'ex direttore del Fondo Pensioni, Eugenio Truffa Giachet
e altri 12 dirigenti, scrive che il ricco portafoglio di immobili (il quale
violando il tetto del 20% fissato per legge costituiva il 98% del «tesoro») non
solo non rendeva, ma danneggiava le casse: 2.368.768 di affitti incassati,
3.325.175 di manutenzione. Tesi respinta ancora dalla Cgil: «Vanno presi i
bilanci pluriennali e lì i conti sono diversi. Giocano sui numeri per
comportarsi come Torquemada». La stessa svendita di case offerte ai dipendenti
(tra i primi proprio il direttore Truffa Giachet e sua figlia) in cambio di un
anticipo talora di 500 euro e rate modeste da pagarsi in 40 comodi anni al 2%
d'interessi era secondo Fabio Scurpa una buona idea: «Non è che i tassi, in quel
momento, fossero molto più alti». Dunque sbaglia la Siae a contestare tutto?
«Non è vero che non aveva garanzie d'essere pagata per 40 anni da un ottantenne:
c'era l'ipoteca, se nessuno avesse poi pagato, tornava in possesso
dell'immobile».
Non mancano
nello scontro frontale alcuni episodi, diciamo così, curiosi. Come la denuncia
di due sindacalisti, marito e moglie, che stando a una lettera del direttore
generale da molti anni risultavano «sistematicamente in permesso dalle ore 7.45
alle ore 10.00 /10.30». Sveglia mattutina: riunione sindacale. Caffè: riunione
sindacale. Cornetto: riunione sindacale. Mai che Angelo D. e sua moglie Anna
Rita avessero un solo giorno di normalità casalinga per lavarsi i denti, farsi
una doccia, preparare un cappuccino alla figlia... Subito riunioni su riunioni.
Tutti i giorni. Dalle sette e mezzo di mattina. O almeno così risultava in
ufficio, dove si affacciavano a metà mattinata: «Scusate, eravamo in riunione».
Agli atti,
ovviamente contestati, c'è la lettera della UilPa, che commissaria il sindacato
interno contestando ai due «di avere danneggiato il prestigio
dell'organizzazione attraverso l'utilizzo dei permessi sindacali in contrasto
con gli indirizzi stabiliti...» A quel punto ecco le provvidenziali
testimonianze di alcuni colleghi: quei permessi usati poco dopo l'alba «venivano
notoriamente fruiti dagli stessi per lo svolgimento del mandato sindacale presso
la propria privata abitazione». Nuova richiesta di chiarimenti e nuova risposta
UilPa: «Non è nostro uso autorizzare la fruizione di permessi sindacali presso
abitazioni private». E via così...
Il destino
personale dei coniugi, ovvio, non ci interessa. I giudici diranno chi ha
ragione. La storia, però, la dice lunga sui rapporti a lungo dominanti
nell'ente. Dove si sono via via sedimentati dettagli contrattuali a volte
«eccentrici». Tipo la cosiddetta «indennità di penna», concessa a quanti,
deposti penna d'oca, calamaio e tampone assorbente, accettarono d'entrare nel XX
secolo usando il computer. Per non dire del contributo di solidarietà nato per
soccorrere artisti in difficoltà ma diventato, al di là della legge, una specie
di pensioncina distribuita a pioggia. Perfino a chi incassa ogni anno diritti
d'autore milionari e su questi paga peraltro una quota astronomica rispetto alla
«pensioncina» che riceveva.
Nelle audizioni
e nella relazione al Parlamento c'è di tutto. La facoltà di mettersi in
malattia senza certificato medico fino al terzo giorno («Che c'entra? Siamo
disponibilissimi a cambiarlo, ma senza criteri punitivi», dice la Cgil) col
risultato che qualcuno, come abbiamo raccontato, è arrivato a marcare visita «in
franchigia» 87 giorni in un anno. Le trasferte degli «accertatori musicali» che
se sforano la mezzanotte sono formalmente contate su due giorni... Il turno
«serale» che comincia alle 13.45...
Insomma, un
pasticciaccio. Sul quale è bene che, al di là delle ragioni e dei torti che
animano il micidiale scontro attuale, venga fatta in fretta chiarezza. E
pulizia. Un paese poeti, santi, navigatori e artisti merita qualcosa di meglio.
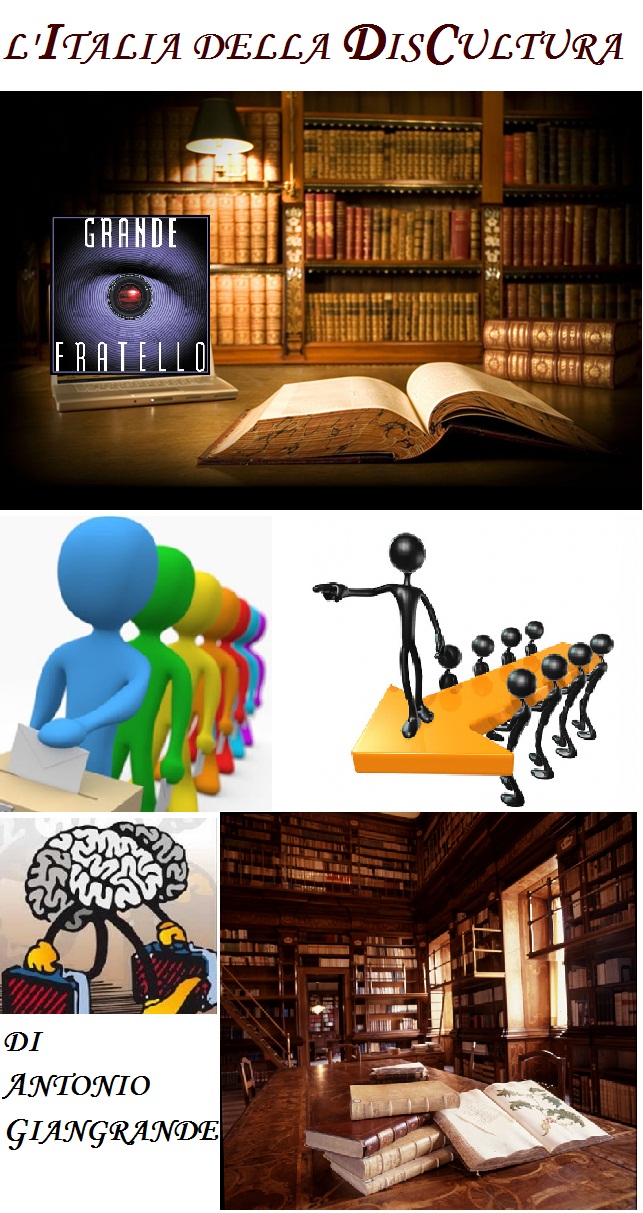



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: