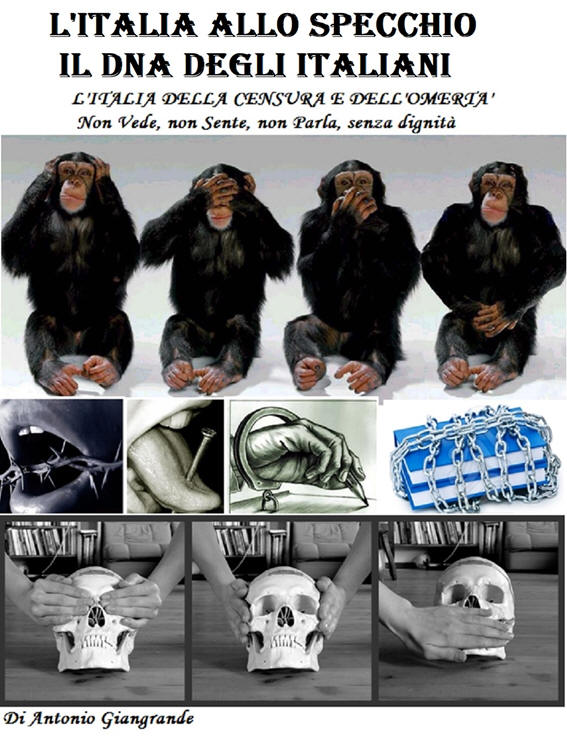Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
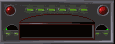
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
L’ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
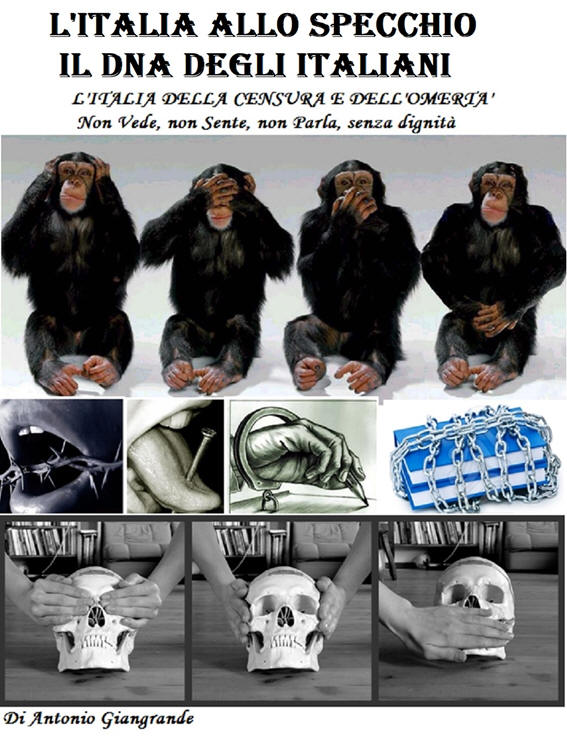
ANNO 2023
L’ACCOGLIENZA
SECONDA
PARTE
L’ATTACCO
TREDICESIMO MESE
UN ANNO DI
AGGRESSIONE
DI ANTONIO
GIANGRANDE
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO
DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale,
pluritematico e pluriterritoriale, riferito al 2023, consequenziale a quello del
2022. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati
ed approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
SANITA’: ROBA NOSTRA.
UN’INCHIESTA DA NON FARE. I MARCUCCI.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
AUSPICI, RICORDI ED ANNIVERSARI.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
L’ACCOGLIENZA
INDICE PRIMA
PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
GLI EUROPEI
Confini e Frontiere.
Quei
razzisti come gli italiani.
Quei razzisti come i serbi.
Quei
razzisti come i greci.
Quei
razzisti come gli austriaci.
Quei
razzisti come i croati.
Quei
razzisti come i kosovari.
Quei
razzisti come gli spagnoli.
Quei
razzisti come i francesi.
Quei
razzisti come gli svizzeri.
Quei
razzisti come i tedeschi.
Quei
razzisti come gli olandesi.
Quei
razzisti come i danesi.
Quei
razzisti come i finlandesi.
Quei
razzisti come gli svedesi.
Quei
razzisti come i norvegesi.
Quei
razzisti come gli inglesi.
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
GLI AFRO-ASIATICI
Quei
razzisti come i zambiani.
Quei
razzisti come i zimbabwesi.
Quei
razzisti come i ghanesi.
Quei
razzisti come i gabonesi.
Quei
razzisti come i marocchini.
Quei
razzisti come i tunisini.
Quei
razzisti come gli egiziani.
Quei
razzisti come i siriani.
Quei
razzisti come i libanesi.
Quei
razzisti come i giordani.
Quei
razzisti come gli israeliani.
Quei
razzisti come i turchi.
Quei
razzisti come gli iraniani.
Quei
razzisti come gli
yemeniti.
Quei
razzisti come gli afghani.
Quei
razzisti come i pakistani.
Quei
razzisti come gli indiani.
Quei razzisti come i thailandesi.
Quei
razzisti come gli indonesiani.
Quei
razzisti come i birmani.
Quei razzisti come i bielorussi.
Quei
razzisti come i russi.
Quei
razzisti come i kazaki.
Quei
razzisti come i nord coreani.
Quei
razzisti come i cinesi.
Quei
razzisti come i giapponesi.
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
GLI OCEAN-AMERICANI
Quei razzisti come
gli statunitensi.
Quei
razzisti come i salvadoregni.
Quei
razzisti come i messicani.
Quei
razzisti come i cubani.
Quei
razzisti come i colombiani.
Quei
razzisti come i brasiliani.
Quei
razzisti come i boliviani.
Quei
razzisti come i peruviani.
Quei
razzisti come i canadesi.
Quei
razzisti come i
neozelandesi.
INDICE SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. UNDICESIMO MESE
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. DODICESIMO MESE
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. TREDICESIMO
MESE. UN ANNO DI AGGRESSIONE
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. QUATTORDICESIMO
MESE
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. QUINDICESIMO
MESE
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Guerra
Calda.
L’ATTACCO. SEDICESIMO MESE
INDICE TERZA
PARTE
SOLITI PROFUGHI E FOIBE. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Il Giorno del Ricordo.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI. (Ho
scritto un saggio dedicato)
I
Migranti.
I
Rimpatri.
Gli affari dei Buonisti.
Quelli che…porti aperti.
Quelli che…porti chiusi.
Cosa succede in Libia.
Cosa succede in Africa.
Gli ostaggi liberati a spese nostre.
Il Caso dei
Marò & C.
Sommario
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato).
La Guerra Calda. Un Anno di
Aggressione. L’Attacco: Tredicesimo mese.
I Pacifondai.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 24 febbraio.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 25 febbraio.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 26 febbraio.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 27 febbraio.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 28 febbraio.
Guerra Ucraina -
Russia, le news dell'1 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 2 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 3 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 4 marzo.
Guerra Ucraina
- Russia, le news del 5 marzo.
Guerra Ucraina
- Russia, le news del 6 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 7 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news dell’8 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 9 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 10 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news dell’11 marzo.
Guerra Ucraina
- Russia, le news del 12 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 13 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 14 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 15 marzo.
Guerra Ucraina
- Russia, le news del 16 marzo.
Guerra Ucraina
- Russia, le news del 17 marzo.
Putin da
arrestare. Criminale di Guerra.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 18 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 19 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 20 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 21 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 22 marzo.
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 23 marzo.
Proiettili
all’uranio.
La pace di Xi sul
tavolo di Putin.
Iraq. Le Guerre
artefatte.
ANNO 2023
L’ACCOGLIENZA
SECONDA
PARTE
L’ATTACCO
TREDICESIMO
MESE
UN ANNO DI
AGGRESSIONE
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
(Ho scritto un saggio dedicato)
Antonio Giangrande:
La guerra ed i contemporanei.
Noi, ieri, abbiamo
studiato la storia. Oggi la viviamo.
Per questo non
bisogna guardare gli eventi bellici periodici con gli occhi di piccoli menti, ma
annotare gli eventi per poterli raccontare in modo imparziale ai posteri.
Di personaggi come
Putin è subissata la storia e solo loro sono ricordati.
La malvagia
ambizione è insita negli esseri normali e di questo bisogna prenderne atto.
Antonio Giangrande:
Solo gli imbecilli non cambiano idea.
Questo è il mio post
di un anno fa.
Antonio Giangrande:
ho scritto il libro work in progress sulla guerra Ucraina-Russia
Il pericolo del
pensiero unico omologato e conformato.
La vittima, dico
vittima, ha sempre ragione?
Cosa noi proviamo,
guardando un film, nel vedere un criminale omicida braccato dalla polizia che si
para dietro una vittima indifesa, usandola come scudo umano, e minacciata con
un'arma a mo di ritorsione? Credo che molti di noi provino odio profondo.
E che dire di chi fa
crollare i ponti prima che la gente possa fuggire dalle città?
Come considerare i
carri armati ucraini nascosti tra i palazzi delle loro città? E come considerare
i resistenti tra i civili?
Non la resa in una
lotta impari, ma si pretende l'aiuto diretto delle nazioni occidentali,
nonostante si preveda il loro coinvolgimento in una guerra totale con la morte
di gente estranea al conflitto in corso. Quella gente sono i nostri figli o noi
stessi.
Non la resa, ma la
pretesa accoglienza di profughi ucraini, negata, però da loro stessi, ad afgani,
siriani, ecc. ecc.
Quando qualcuno al
mare, nonostante l'avviso che è pericoloso fare il bagno, chiede aiuto perchè
sta affogando, tu altruista ti tuffi senza analizzare le conseguenze. Quando ti
trovi al suo cospetto, la reazione dell'affogando è salvarsi a tutti i costi,
aggrappandosi a te, tanto da attentare alla tua sicurezza pur di stare a galla.
I media palesemente
anti Putin che per propaganda ci inondano di immagini di bambini profughi e
ripetutamente ci raccontano di bambini morti e che inneggiano alla resistenza
degli occupati, ci vogliono far entrare in una guerra fratricida e nazionalista
non nostra?
Più che filo ucraino
sono filo italiano, senza dimenticare, però, che, nelle guerre, solo per la
povera gente tutto si perde e nulla si guadagna.
Oggi dopo un anno
penso che Putin dica bene: Non è una guerra.
Nella guerra, come
in una rissa, ci sono due bulli che combattono, magari per motivi futili.
Bambini morti di
qua, bambini morti di là.
In Ucraina vi è solo
la vile aggressione di bulli (Putin e tutti i russi che lo appoggiano).
Quindi di vile
aggressione si tratta. Appunto: "Operazione speciale".
E vedere solo
bambini ucraini morire e nessun bambino russo, esclude ogni giustificazione.
A questo punto i
russi e i pacifondai filoputiniani taccino. Questo è il momento, per i
contemporanei, di sostenere l'evoluzione della specie umana nella giusta
direzione, impedendo, per i vili ed egoistici interessi personali,
l'involuzione.
Le culture nel mondo
sono diverse, non migliori. Ma la violenza sul più debole va fermata a tutti i
costi e con tutti i mezzi. Noi siamo niente rispetto all'evoluzione della nostra
specie: dei nostri figli...
Come cambia la prospettiva.
I russi aggrediscono l’Ucraina
con crimini contro l’umanità. Il Regno Unito appoggia l’Ucraina e gli ucraini
filo-occidentali si chiamano resistenti.
I tedeschi aggrediscono
l’Italia con crimini contro l’umanità. Il Regno Unito appoggia l’Italia e gli
italiani comunisti si chiamano partigiani.
I piemontesi Savoia con a capo
Vittorio Emanuele II aggrediscono il Regno delle Due Sicilie di Francesco II. Il
Regno Unito appoggia i piemontesi ed i meridionali resistenti dalla storiografia
saranno chiamati: Briganti.
Un secolo di minacce. Per
l’Europa dell’Est la cortina di ferro non è mai caduta, si è soltanto spostata.
Micol Flammini su Linkiesta il 14 marzo 2023.
L’invasione russa dell’Ucraina
ricalca il copione di quella nazista della Polonia, ma gli alleati hanno
imparato gli errori di allora e non hanno abbandonato il Paese aggredito. Per
Varsavia (e in futuro Kyjiv) l’ingresso nella Nato e nell’Ue è la rassicurazione
di non essere mai più soli di fronte alle mire russe
Da qualsiasi parte si guardi
la storia dell’Europa, la Polonia è sempre presente, ed è stata costantemente
un centro di sofferenza e di indomabile resistenza. […] Per capire la guerra di
Vladimir Putin contro l’Ucraina, è il caso di guardare con attenzione a quello
che è accaduto in Polonia nel 1939: è un copione con altri personaggi, ma che
si ripete, e se l’attacco congiunto di Hitler e Stalin contro Varsavia ricorda
quello, iniziato il 24 febbraio 2022, di Mosca contro Kiev è perché le cose in
comune non sono poche.
La campagna di Hitler contro
la Polonia era iniziata rivendicando la protezione dei cittadini tedeschi
rimasti, dopo la Prima guerra mondiale, sotto le autorità polacche, soprattutto
di quanti vivevano a Danzica, città libera ma sotto la giurisdizione del
ministero degli Esteri di Varsavia.
L’invasione del paese fu
preceduta da una delle prime operazioni false flag della storia, un’espressione
(falsa bandiera) che indica atti di sabotaggio e macchinazioni per far ricadere
su altri la responsabilità del casus belli, divenuta molto nota proprio con la
guerra della Russia all’Ucraina, quando si pensava che Mosca stesse cercando di
creare un pretesto per invadere Kiev.
I nazisti studiarono a lungo
l’operazione false flag da mettere in atto per attaccare la Polonia. Alcuni
tedeschi vestiti con uniformi polacche assaltarono la stazione radio di Gleiwitz
allora in Germania, oggi Gliwice in Polonia, uccisero alcune guardie di
frontiera e dai microfoni dell’impianto diffusero un messaggio alle minoranze
polacche, incitandole a prendere le armi contro i tedeschi. Il giorno dopo, 1°
settembre, il più potente e moderno esercito dell’Europa dell’epoca entrò in
Polonia, con il proposito di portare a termine una guerra lampo.
In due giorni distrusse
l’aviazione polacca, e l’esercito di Varsavia che si era ammassato alla
frontiera reagì con il suo fiore all’occhiello: la cavalleria. Questo episodio
di grande eroismo, pur venato di mitologia, aiuta a capire quanto i polacchi
fossero determinati a rischiare il tutto per tutto pur di salvaguardare
l’indipendenza appena conquistata. Se poi si siano lanciati con la cavalleria
contro i mezzi corazzati nazisti perché effettivamente fossero convinti di avere
qualche chance o perché, pur di non perdere la libertà, erano pronti a farsi
massacrare, questo non si saprà mai. Fatto sta che questo episodio rimane tra i
più memorabili della guerra.
La Polonia inoltre era
aggredita da tutti i lati: mentre i tedeschi divoravano l’ovest del paese,
annettendo e occupando, i sovietici avevano iniziato la loro avanzata da est
adducendo come pretesto la protezione delle minoranze ucraine e bielorusse
maltrattate dal governo polacco allo sbando.
Quando Putin ha attaccato
l’Ucraina, ha usato una motivazione simile: salvare le minoranze russe, vittime
delle violenze del governo di Kiev. I polacchi di allora, però, erano stati
abbandonati dai propri alleati, che non avevano ascoltato le richieste di aiuto
di Varsavia e avevano sottovalutato la pericolosità e la determinazione del
regime nazista. Un errore che non è stato commesso nei confronti degli ucraini.
[…]
La Polonia è sempre stata
certa di essere la frontiera dell’Europa, dell’atlantismo e anche della
cristianità, e il fatto che la storia entri anche nelle campagne elettorali, sia
materia di dibattito e l’attuale partito al governo, il PiS, la manipoli contro
gli avversari indica quanto per i polacchi sia importante.
L’ingresso prima nella NATO e
poi nell’Unione europea ha rappresentato per Varsavia la rassicurazione che non
sarebbe più stata sola di fronte alla minaccia russa e di essere entrata a far
parte del mondo al di là della cortina di ferro, che per i paesi dell’Est
europeo non è mai caduta, si è soltanto spostata.
Da “La cortina di vetro” di
Micol Flammini, 228 pagine, 14,50 euro.
Dagospia il 13 marzo 2023.
Estratto da “La Cortina di Vetro”, di Micòl Flammini (ed. Mondadori - Strade
Blu), in libreria da martedì 14 marzo 2023
Se l'Unione europea si
dissolvesse oggi sotto i colpi delle ossessioni centrifughe e delle
rivendicazioni nazionalistiche, ne uscirebbero ventisette Stati che dovrebbero
reinventare il loro sistema monetario, gli accordi commerciali, i rapporti alle
frontiere e che dovrebbero anche gestire le spinte centrifughe interne di
movimenti indipendentisti, piccoli terremoti nazionali capaci di far scoppiare
dissapori, recriminazioni e persino conflitti.
[...]
Il nome completo dell'Unione
Sovietica era Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, e la sua
composizione era complessa.
C'erano quindici repubbliche
principali che godevano di un loro grado di autogestione accordato dal potere
centrale e si identificavano come Repubbliche socialiste sovietiche: Lituania,
Lettonia, Estonia, Bielorussia, Ucraina, Russia, Moldavia, Georgia, Armenia,
Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan.
Al loro interno si
distinguevano le repubbliche socialiste sovietiche autonome e
le oblast' autonome, suddivisioni amministrative, sottorepubbliche, che,
contrariamente alle repubbliche socialiste sovietiche, non avevano il diritto di
uscire dall'URSS e non avevano un partito comunista locale.
[...] quando l'Unione
Sovietica cadde, [...] ottennero l'indipendenza soltanto le quindici repubbliche
socialiste sovietiche, aprendo la strada ad anni di rivendicazioni e conflitti.
Nel ridisegnare i confini
nazionali, non si era tenuto conto delle specificità delle oblast' e delle
repubbliche autonome, che erano meno grandi delle nazioni principali, ma
conservavano un ricco patrimonio di specificità culturali, linguistiche e anche
religiose [...].
Queste terre miste, e sovente
di confine, erano disposte a sentirsi sovietiche, ma consideravano inaccettabile
essere risucchiate da altre identità statali.
La fine dell'URSS aveva
dissolto i legami, ricordato le diversità e aperto a una stagione di conflitti
in cui spesso la nostalgia per i tempi andati, per il mondo perduto, ha creato
l'illusione che fosse meglio essere russi che georgiani, o armeni, o moldavi.
Sono nati frammenti di Russia,
aspiranti nazioni che si considerano legate a Mosca e che hanno spesso offerto
al Cremlino il pretesto per rosicchiare parti di territorio altrui e far sentire
che la sua dominazione non è mai finita.
Se si scava nella storia, c'è
sempre un peccato originale e l'inizio dei conflitti di oggi [...] risale a un
periodo costruito in fretta e chiuso di corsa, senza guardarsi troppo indietro.
Quando l'URSS è collassata,
in tanti speravano che le linee interne a quel gigantesco territorio, che viste
da Mosca sembravano squarci, ferite per infierire sul sogno sovietico ormai
sepolto, sarebbero state tracciate tenendo conto delle diversità territoriali.
Non si ebbe il tempo, né in
alcuni casi la voglia di considerare dei distinguo e si ritenne più comodo e
veloce ridisegnare lo spazio postsovietico seguendo le linee di confine delle
repubbliche socialiste sovietiche, che conservavano un sistema di istituzioni
parastatali dalle quali sarebbe stato più semplice ripartire.
[…] Era come se nel corpo in
ricostituzione dell'Unione Sovietica fossero rimaste qua e là schegge di Russia,
pronte a dichiarare guerra pur di determinare o un ritorno al passato o una
nuova divisione territoriale.
E il Cremlino ha sempre
accolto con favore l'opportunità di poter tornare su un territorio che non ha
mai smesso di considerare suo e di approfittare di conflitti che gli hanno
sempre permesso di insidiare la nuova unità dei suoi vecchi alleati.
Il tempo immobile della
Transnistria
Le prime avvisaglie di questi
conflitti si ebbero nel 1991 ai confini dell'Europa, in quella che era stata la
Repubblica socialista sovietica moldava e che, come altre, aveva approfittato
del colpo di Stato contro Michail Gorbacëv per dichiarare l'indipendenza. Le fu
accordata con dei confini che non tutti i cittadini condivisero, ma che
corrispondevano pedissequamente a quelli stabiliti all'ingresso del paese
nell'Unione Sovietica.
La Moldavia si trovava sui
territori che Molotov e Ribbentrop si erano divisi e su cui poi si consumò la
rottura tra Mosca e Berlino. Era considerata una terra di confine, posta tra la
Romania e l'Ucraina, la sua parte più orientale aveva fatto parte della
Repubblica socialista dell'Ucraina con il nome di Repubblica socialista autonoma
moldava, quella più occidentale era stata annessa alla Romania per volere dello
stesso Parlamento moldavo e fu in seguito occupata da Stalin, poi di nuovo dalla
Romania alleata dei nazisti.
Infine, al termine della
seconda guerra mondiale, tornò a far parte dell'Unione Sovietica, che ne
ridisegnò i confini, decretò la nascita della Repubblica socialista sovietica
moldava e assegnò alla nuova regione anche una parte della Repubblica socialista
autonoma di Moldavia, che fino ai primi anni Quaranta era stata legata
all'Ucraina, e che poi tormenterà la storia del paese con il nome di
Transnistria.
Per tutta la sua permanenza
nell'URSS, il paese si ritrovò con due anime e altrettante lingue, ma quella più
a est, la Transnistria, che aveva come città principale Tiraspol, non sentiva la
necessità di aprire un conflitto con i vicini dell'Ovest, con i quali
condivideva l'appartenenza alla Repubblica socialista di Moldavia. Dopotutto,
quello che contava era essere sovietici.
In Transnistria si sapeva che
ogni decisione arrivava da Mosca, inclusi i nomi dei segretari del Partito
comunista locale impegnato in una politica di intensa russificazione: Leonid
Breznev, ucraino di origine, fece pratica in Moldavia per anni prima di
diventare il leader del Partito comunista dell'Unione Sovietica. Le due parti
della repubblica erano molto diverse anche dal punto di vista economico: a est
erano state concentrate le industrie, che invogliarono altri cittadini sovietici
a trasferirvisi, mentre l'ovest era rimasto agricolo e completamente dipendente
dall'est per le forniture di energia.
Nel 1987 si fece largo sulla
scena politica della Moldavia un comunista fervente e sovietico modello, finito
in Transnistria per lavoro. Igor' Smirnov era figlio di un politico e di una
giornalista, suo padre era stato arrestato per corruzione e liberato dopo la
morte di Stalin, ma neppure la detenzione in Siberia aveva fiaccato la sua fede
nel partito, né quella della sua famiglia.
Igor' era cresciuto tra la
Russia e l'Ucraina, aveva collaborato alla costruzione della centrale
idroelettrica di Nova Kachovka, nella regione ucraina di Cherson e, alla fine
degli anni Ottanta venne mandato a lavorare in Transnistria, proprio mentre la
Moldavia cercava di tagliare i rapporti con l'Unione Sovietica e la lingua
russa, e di unirsi alla vicina Romania. Un sovietico entusiasta come Smirnov non
soltanto non poteva accettare, ma non poteva neppure capire come si potessero
desiderare dei cambiamenti tanto radicali, delle fughe così brusche dall'URSS.
Non era un politico e dunque
si impegnò nell'organizzazione di scioperi che coinvolsero alcune industrie
della parte transnistriana per più di un mese, ma che non sortirono alcun
effetto. Decise allora di tentare la strada politica per far sopravvivere quel
mondo che per lui era anche un'intensa storia di famiglia tracciata dal padre.
Smirnov partecipò allora alle elezioni moldave, ma la determinazione della parte
occidentale della repubblica era forte, le spinte nazionaliste anche e la furia
indipendentista era pronta a farsi violenta.
Così, incapace di influenzare
la politica della nazione che stava per nascere, decise di organizzare nel 1990
un referendum sulla secessione dalla Moldavia e di proclamare la nascita della
nuova Repubblica socialista sovietica moldava di Pridnestrovie.
L'Unione Sovietica reggeva
ancora, ma si sentivano le scosse, le spinte indipendentiste, e Smirnov cercò il
riconoscimento di Mosca. Non si aspettava che il referendum sarebbe stato invece
biasimato, e il Cremlino non soltanto non riconobbe la neonata repubblica, ma
Gorbacëv, convinto che le cose potessero risolversi in altro modo e che l'Unione
Sovietica potesse ancora salvarsi, non interpretò il gesto come una
manifestazione di lealtà estrema, ma come un pericoloso sgarbo tra popoli
fratelli.
In realtà non c'era nulla da
recuperare e l'anno dopo, nei giorni del golpe contro il segretario del Partito
comunista dell'URSS, la Moldavia si proclamò Stato indipendente con capitale
Chisinau. La parte occidentale del paese voleva liberarsi al più presto di ogni
retaggio sovietico, tuttavia sapeva che la Transnistria rimaneva il fulcro
prezioso dell'economia nazionale e lasciarla andare era impossibile; quindi,
quando dichiarò la nascita della nuova nazione, lo fece prendendo in
considerazione i confini di tutta la vecchia Repubblica socialista sovietica,
sicché la Transnistria dichiarò a sua volta l'indipendenza dalla Moldavia.
Il primo conflitto
postsovietico alle porte dell'Europa scoppiò dopo che la richiesta di Chisinäu
di ritirare la XIV Armata di Mosca di stanza in Transnistria non ottenne alcun
risultato. La Moldavia prese ad armare un proprio esercito con l'aiuto della
Romania, ma si trovò a combattere contro truppe meglio armate e più organizzate,
costituite dagli abitanti della Transnistria e da volontari russi e ucraini,
forti anche del sostegno della XIV Armata.
Gli scontri iniziarono il 1°
marzo 1992, durarono fino a luglio e si risolsero con un accordo di cessate il
fuoco firmato da Boris El'cin, che era diventato presidente della Federazione
russa, e dal presidente moldavo Mircea Snegur. Venne decisa la creazione di una
forza di peacekeeping per il mantenimento del cessate il fuoco e la gestione fu
affidata a Mosca.
La presenza della XIV Armata
venne ridotta a 1500 uomini e a tutti gli effetti la Transnistria si considera
ancora uno Stato a sé con capitale a Tiraspol, indissolubilmente legato alla
Russia. Tiraspol e Chisinãu di fatto sono ancora in guerra e la Transnistria è
un parco giochi della nostalgia, scollegato da tutto, anche da Mosca.
Difficile trovare altrove un
senso tanto vivo di appartenenza a un mondo che non c'è più, un panorama di
edifici brutalisti e statue sovietiche lasciati a farsi consumare dal tempo, non
per incuria ma per mancanza di mezzi di manutenzione: sebbene la regione fosse
più industrializzata della parte occidentale della Moldavia e sia ancora fonte
di energia per tutta la repubblica, ha rapporti commerciali soltanto con la
Russia e il suo vivere isolata dal resto del mondo non ne aiuta lo sviluppo
economico.
È un non-Stato che utilizza il
rublo, ha carri armati dell'Armata Rossa disseminati con orgoglio sul proprio
territorio, mantiene nella bandiera la falce e il martello, e vanta nella sua
capitale una Casa dei soviet ben tenuta e una statua di Lenin fiera e impettita:
qui l'Unione Sovietica esiste ancora. Mosca ha sviluppato un rapporto speciale
con la striscia di terra incastonata tra Ucraina e Moldavia, dove ci sono ancora
le truppe russe e soprattutto il grande deposito di Cobasna, che contiene circa
20.000 tonnellate di armi della XIV Armata.
Le contraddizioni in questa
regione della nostalgia sono molte: neppure Mosca riconosce la Transnistria, ma
ha rapporti con le sue istituzioni. Il deposito e i soldati russi si trovano
ufficialmente sul territorio moldavo, che tuttavia chiede lo smantellamento del
primo e il ritiro dei secondi e percepisce l'enclave separatista come una
minaccia alla sua esistenza, soprattutto dallo scoppio della guerra della Russia
contro l'Ucraina.
La Transnistria è stata per
Mosca la prima delle schegge rimaste incastrate nel territorio postsovietico ed
è proprio da Tiraspol che il Cremlino ha imparato a utilizzare e fomentare le
spinte separatiste per influenzare la politica di paesi che non ha mai smesso di
considerare suoi. Tra questi Stati, la Moldavia è il più fragile.
Assieme all'Ucraina ha
ottenuto lo status di paese candidato all'Unione europea, rimane dipendente da
Mosca a livello energetico, ha un conflitto non risolto sul suo territorio, una
politica traballante costantemente esposta alle ingerenze della Russia, ed è
talmente vicina all'Ucraina e talmente interconnessa da essere il paese
confinante che più subisce gli effetti della guerra: spesso si ritrova al buio
insieme a Kiev a causa dei bombardamenti russi contro la rete elettrica ucraina,
che rifornisce anche la Moldavia, proprio come quando c'era l'URSS.
Antonio Giangrande:
L’OCCIDENTE MOLLICCIO E DEPRAVATO.
Il mondo è diviso in
due parti. I cattivi ed i buoni.
Dipende da quale
parte lo si guardi. Ogni parte si arroga il diritto di stare dalla parte giusta.
Noi occidentali,
sotto giogo culturale, politico ed economico statunitense, giudichiamo tutti gli
altri come regimi religiosi fondamentalisti, ovvero regimi autoritari e
dispotici.
Gli altri ci
considerano pericolosi perché portatori di pseudo democrazie, governate dalla
dittatura delle minoranze, e infette dalle tre C: Capitalismo; Caos,
Criminalità.
A ciò si aggiunge
l’ateismo dilagante e, cosa fondamentale, il culto del singolo individuo e della
sua personalità, o della frammentazione dei singoli Stati servi della loro
politica economica.
In mano a legioni di
imbecilli, diceva Umberto Eco, guidate dal gradimento di un clik.
Noi vediamo la
pagliuzza negli occhi altrui, ignorando la trave nei nostri occhi.
Da noi i casi di
censura sono sempre più frequenti. A definirne la pericolosità è la natura
ideologica, quasi religiosa, attraversata da una spinta revisionista della
propria storia e delle proprie origini. Dunque è la censura a essere figlia del
politicamente corretto e non l’inverso. La retorica del politicamente corretto
divide la realtà, la storia, gli individui tra bene e male, tra luce e oscurità,
e queste opposizioni pretendono adesioni unanimi, omologazione, conformismo.
Queste radicalizzazioni non concepiscono alcun relativismo, anzi, presentano
evidenze che non possono essere negate. Ideologizzazione e sessualizzazione
dell’insegnamento ai minori, fin dalle elementari, sono due problemi enormi.
Tendono ad ostentare ed imporre le posizioni di infime minoranze, fino a farle
sembrare maggioritarie.
Agli occhi delle
altre culture sembriamo essere governati dal femminismo e dagli LGBTI.
La “cancel culture”,
la “woke revolution” e poi sempre il “politically correct” sono termini inglesi
che stanno entrando prepotentemente nel lessico italiano.
Secondo la maggior
parte degli opinionisti di sinistra non esiste nulla di tutto ciò: sono solo
paranoie.
Sono invece tre
aspetti di una rivoluzione culturale in corso.
La definizione la
traiamo da un articolo di Stefano Magni su Inside Over.
La “woke revolution”
prende il nome dallo slang afro-americano. Woke vuol dire letteralmente “in
allerta”.
Nelle università più
costose anglosassoni sono gli studenti (molto spesso bianchi) e gli
intellettuali che sentono il dovere di restare “in allerta” per scovare ogni
traccia di razzismo nel discorso pubblico. Un gesto, una parola, un tono di
voce, possono sembrare innocui, ma, secondo gli woke, sono minacce velate o
segni di un razzismo residuo.
Il politically
correct è il codice che definisce ciò che per un woke è corretto o scorretto. E
il razzismo contro cui lottano non è solo quello contro i neri, ma anche contro
tutti coloro che sono visti come gli oppressi di ieri e di oggi: omosessuali,
donne, difetto estetico (obesità, nanismo, handicap) immigrati, membri di
minoranze etniche e religiose, transgender, animali (difesi da umani, in questo
caso). Ma le categorie si estendono di continuo e in modi e tempi difficilmente
prevedibili, secondo le mode del momento.
La cancel culture è
il modo in cui gli woke esercitano la giustizia. Ed è un eufemismo per definire
la nuova forma di linciaggio online: il colpevole viene bandito, dopo una
campagna di odio in rete, nelle università e in pubblica piazza, dopo il
boicottaggio, il ritiro di ogni invito e infine anche il licenziamento. Se
l’ingiustizia è un simbolo, come una statua, si chiede la sua rimozione. Se è un
film, si chiede la sua cancellazione. Se è un testo, non deve essere più
venduto. E così di seguito, fino al reset del passato.
Secondo Bari Weiss,
il mostro woke è cresciuto per mancanza di coraggio di chi avrebbe dovuto
opporsi: è un atteggiamento infantile a cui gli adulti, i responsabili, gli
insegnanti, non hanno mai risposto con un “no”. Ma nessuno, neppure Bari Weiss o
Greg Lukianoff, riesce a individuare la radice di questa rivoluzione culturale.
Se tutto ciò vi
ricorda il marxismo leninismo applicato in Urss e in Cina, ma anche nei
movimenti più violenti del nostro Sessantotto, forse avete ragione. La nuova
sinistra non è molto distante dalla vecchia logica della lotta di classe. E se
il fenomeno è cresciuto è perché negli Usa, che non sono mai stati comunisti, il
marxismo è sempre più di moda nelle università, spesso filtrato attraverso lo
studio di Gramsci, il filosofo italiano più influente nella cultura americana da
vent’anni a questa parte.
In conclusione
bisogna dire che il mondo è contro di noi occidentali perché ai loro occhi ci
siamo comunistizzati, ossia siamo molli, effeminati e depravati. E questo stile
di vita non vogliono che infetti il loro modo d'essere.
Naturalmente,
nessuno dei due mondi scende a compromessi.
Entrambi tendono
all'ostentazione ed all'imposizione dei loro difetti.
Gli scontri
tra Oriente e Occidente. Ernst Jünger e il "nodo" dell'incontro-scontro tra
Oriente e Occidente.
La sfida
archetipica segna tutta la storia della civiltà: sempre in bilico, mai risolta.
Marino Freschi su Il Giornale l’11 Gennaio 2023
Erano passati
quattordici anni, non molti, eppure era tutta un'altra storia. Nel 1939 usciva
Sulle scogliere di marmo il romanzo simbolico di Ernst Jünger, uno dei racconti
più intensi della letteratura del primo Novecento, un puro capolavoro. Nel 1953
lo scrittore pubblica un saggio inquietante e nel medesimo tempo un classico: Il
nodo di Gordio, che suscitò una vivace discussione intellettuale. In mezzo
c'erano state la guerra, la catastrofe tedesca, la vergogna tedesca, la
sconfitta di tutta l'Europa, con i russi a Berlino, pronti ad avanzare ancora:
la bandiera rossa sventolava sprezzante sulle rovine del Reichstag «millenario».
A pochi metri il bunker sotterraneo con il corpo carbonizzato del Führer. Ernst
Jünger era stato coinvolto nell'attentato fallito a Hitler del 20 luglio del
1944. Il suo nome venne depennato dalla lista dei condannati a morte dallo
stesso Führer. Lo scrittore dovette immediatamente abbandonare Parigi, sparire
in un villaggio tedesco. Con l'arrivo degli alleati fu sottoposto alle aspre
pratiche di denazificazione, consistenti per lui nel divieto di pubblicare, che
venne ritirato nel 1953. Nello stesso anno usciva un saggio sorprendentemente
affine di A. Toynbeee: The world and the West; si era pronti a riaprire una
grande discussione sulle rovine dell'Occidente.
La Germania di
Jünger era un campo di macerie materiali e ancor più morali e spirituale, il
figlio morto in combattimento sulle Alpi Apuane, vittima forse di fuoco amico in
quanto dissidente del regime. Malgrado tanto dolore, il saggio Il nodo di Gordio
è perfetto come un bassorilievo greco di travolgente bellezza stilistica e
densità intellettuale: si avverte già dall'incipit la mano dell'artista e del
pensatore. «Oriente e Occidente: negli avvenimenti mondiali questo incontro non
è soltanto di primaria importanza, ma rivendica un'importanza tutta particolare.
Fornisce il filo conduttore della storia, l'inclinazione dell'asse rispetto
all'orbita solare. Balenando sin dagli albori, i suoi motivi si dipanano fino ai
nostri giorni. Con tensione sempre rinnovata i popoli salgono sull'antico
palcoscenico e recitano l'antico copione. Il nostro sguardo si fissa soprattutto
sul fulgore delle armi che domina la scena».
La visione è
nitida e riconosce gli antichi attori: i Sarmati, i Persiani, i Tartari, le
masse enormi dei popoli dell'Asia, e dall'altro parte i valorosi spartani,
greci, romani, crociati e templari: Oriente e Occidente. A leggere oggi quelle
pagine di settant'anni fa il pensiero riconosce le tracce visibili della storia
negli attacchi notturni dei nuovi Sarmati sugli operosi villaggi della Vodolia,
della Galizia fino alle «rive del Dnipro, Muro di Berlino che spezza l'Ucraina»
(titolo del quotidiano La Repubblica), mentre Massimo Cacciari apre il primo
numero dell'anno de La Stampa con un articolo in sorprendente consonanza con
l'intuizione storico-mitica di Jünger: «L'Occidente che non riesce a sciogliere
i nodi di Gordio», ma con una curvatura irenica che non è certo la prospettiva
di Jünger, la cui forte impressione mitica fa riapparire gli archetipi dello
scontro epocale tra due civiltà, tra due antropologie, tra due etnologie.
Riaffiora, in Jünger, la grande tradizione culturale tedesca, quella che con
Nietzsche aveva fondato l'antinomia cultural-spirituale tra apollineo e
dionisiaco che con Thomas Mann e Oswald Spengler si era precisata nel contrasto
fondante tra Kultur e Zivilisation, tra spirito e democrazia. Le radici
intellettuali di Jünger risalivano al monumentale Matriarcato di J. J. Bachhofen
del 1861 in cui il regno, oscuro delle madri è contrapposto al dorico, apollineo
sorgere degli Dei luminosi dell'Olimpo, già intuito dai Veda. Il sigillo
oriente-occidente era stato affrontato, dalla prospettiva tradizionale, da Réne
Guénon nel 1924 in un saggio d'immensa risonanza. In realtà il contrasto era
apparente: l'Occidente evocato dal pensatore tradizionalista francese era privo
del fulgore olimpio scolpito da Jünger nel suo saggio, cui rispose nel 1955 Carl
Schmitt, replica che a appare in appendice a Il nodo di Gordio jüngeriano. Oggi
il libro è ripubblicato da Adelphi insieme a un utilissimo aggiornamento
sull'intera discussione a cura di Giovanni Gurisatti (che ha anche tradotto con
Alessandro Stavru i saggi dei due maestri tedeschi).
Con Il nodo di
Gordio Jünger torna alla classica grandezza stilistica delle Scogliere di marmo:
nel saggio il mondo confuso barbarico, oscuro, «asiatico» del Forestaro - il
principe del caos del romanzo - incarna il polo dell'Oriente, quello di una
umanità senza la luce della coscienza, a cui la civiltà d'Occidente è pervenuta
con immensi sforzi, ché la storia nulla regala: «Per dimostrare che lo spirito
libero domina il mondo si paga il prezzo più alto. Questa è la prova che
dev'essere superata nel sacrificio. Con essa bisogna mostrare che il libero
governo è superiore ai dispotismi, che i liberi combattenti pesano più delle
masse e che le loro armi sono meglio congegnate e di più lunga gittata. Si
arriva così ai momenti di svolta, nei quali gli spiriti si gettano nella
mischia. Eserciti immensi vengono affrontati, incalzati nelle valli, nelle
sacche, nelle gole, ricacciati nei mari o negli stretti. I superstiti fuggono, i
loro capi si danno la morte in foreste e deserti». Lo scontro diventa epocale,
tra i valori della luce e le forze ctonie dell'oscurità, tra la cultura della
forma contro l'amorfo. Il sacrificio di Leonida segna non solo un evento
bellico, ma un'illuminazione, l'epifania di un nuovo splendore della coscienza:
in questo contesto la lotta si sublima in un evento grandioso, epocale:
«Adoperata in questo modo la spada è spirituale; è lo strumento di una decisione
libera e risolutiva».
A leggere oggi
questo saggio insieme con la risposta di Schmitt - si viene travolti dalla
lucente bellezza di ogni classica memoria, ma anche dalla sua travolgente
attualità. Pare ma è così! - che l'Occidente sia chiamato a difendere, ancora
una volta, la sua identità storica, la sua libertà, sulle mugghianti rive del
Dnipro nella reiterazione dell'epocale scontro tra civiltà. Tutto è ancora in
bilico, nulla è ancora perduto se l'Occidente saprà elevare al sole i propri
vessilli di libertà, ritrovare i valori della propria cultura, e tagliare con
decisione l'eterno nodo di Gordio: nell'intramontabile mito «compare un
principio spirituale in grado di disporre in modo nuovo e più pregnante del
tempo e dello spazio».
"Il Nodo di
Gordio", Junger e Schmitt raccontano il rapporto tra Occidente e Oriente.
Jünger e
Schmitt scrivono un saggio attuale sul rapporto tra Occidente e Oriente,
fermandosi più volte sulla sfida tra "democrazia" e "autoritarismo" evocata dal
presidente Usa Joe Biden. "Per la storiografia occidentale l'atto di arbitrio è
inconciliabile con la dignità del monarca". Roberto Vivaldelli su Il Giornale il
28 Febbraio 2023
Tabella dei
contenuti
Lo storico Franco
Cardini racconta Il Nodo di Gordio
Il rapporto tra
Occidente e Oriente
Il Nodo di Gordio,
proprio come il nodo che stringeva il giogo al timone del carro consacrato da
Gordio a Zeus nel suo tempio, e che Alessandro Magno nel 334 a. C. troncò con un
colpo netto di spada, ottenendo così il dominio dell’Asia e del mondo, così come
predicava un'antica profezia. Ma Il Nodo di Gordio è anche un'opera monumentale
di Ernst Jünger, pubblicata per la prima volta nel 1953, dopo la Seconda guerra
mondiale e in piena Guerra Fredda, a cui due anni dopo replicava con uno scritto
altrettanto intenso l'amico Carl Schmitt. È un'opera che riflette sulla natura
del rapporto-scontro fra Oriente e Occidente.
"Questo incontro",
scrive Ernst Jünger in apertura del suo Nodo di Gordio, non soltanto occupa una
posizione di primo piano fra gli avvenimenti mondiali, ma "rivendica di per sé
un’importanza capitale. Fornisce il filo conduttore della Storia". Un incontro,
tuttavia, che nella storia si è spesso trasformato in scontro: "Con tensione
sempre rinnovata i popoli salgono sull’antico palcoscenico e recitano l’antico
copione. Il nostro sguardo si fissa soprattutto sul fulgore delle armi che
domina la scena".
Lo storico Franco
Cardini racconta Il Nodo di Gordio
"Il Nodo di Gordio"
è stato recentemente ripubblicato dalla Piccola Biblioteca Adelphi con gli
scritti originali di Jünger e Schmitt, in un'edizione curata da Giovanni
Gurisatti. Saggio fondamentale che è stato raccontato e sviscerato nei suoi
punti focali - in occasione di una serata svoltasi lo scorso 28 gennaio al
Teatro di Pergine Valsugana (Tn) e organizzata dall'omonimo think-tank - dallo
storico Franco Cardini. "La spada è un elemento risolutivo, anche nel suo uso
militare. Si usa la spada per stabilire chi vince e chi perde. La spada di Artù
dall'incudine, dalla pietra, o dall'albero in cui è infitta, secondo le varianti
della leggenda arturiana, è uno strumento che indica il modo in cui l'ordine
mondiale sarà ristabilito. Chi estrae la spada è un eletto a ristabilire
l'ordine in uno stato di disordine. Il Nodo di Gordio è esattamente la stessa
cosa. È un nodo fra due apici di una corda che serve ad aggogiare due bui o due
tori ad un aratro, ma il nodo è così intricato che non si può sciogliere".
Alessandro, ha
spiegato, "fa una scelta: risolve, non sciogliendo il nodo con pazienza, ma con
un taglio netto della spada, ottenendo un risultato, ma a un prezzo. Perché una
sezione della corda viene rovinata da questo gesto". Così si ritrova, ha
continuato Cardini durante la serata organizzata dal think-tank Il Nodo di
Gordio, "sospeso tra l'Oriente e l'Occidente, fra l'Europa e l'Asia".
Alessandro, ha sottolineato lo storico incalzato da Daniele Lazzeri e Andrea
Marcigliano, "non è considerato un greco dai greci. È considerato un greco dai
persiani, e risolve il problema del loro rapporto con un taglio netto e dando
avvio a un sistema di governo nuovo".
Il rapporto tra
Occidente e Oriente
L'attualità dei due
saggi di Jünger e Schmitt sul rapporto fra Occidente e Oriente, sulla sfida tra
"democrazia" e "autoritarismo" più volte evocata - con una buona dose di
retorica - dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è impressionante. Per la
storiografia occidentale, scrive Jünger, l'atto di arbitrio è "inconciliabile
con la dignità del monarca", e getta come un'ombra sul carattere di quei pochi
cui viene attribuito il titolo di "grande". E ancora: il filosofo tedesco
sottolinea come in Oriente l'atto di arbitrio "non pregiudica la grandezza di un
principe", ma ne è piuttosto la conferma.
In Oriente è del
"tutto nella norma che durante un banchetto Alessandro uccida Clito", che gli
aveva salvato la vita. La sentenza del principe "ha valore sia che derivi da una
ponderata riflessione", sia che provenga da una vampata di collera. Nel pensiero
occidentale e nella relativa storiografia l'atto di arbitrio, soprattutto quando
si manifesta in modo brutale, osserva Jünger, "viene considerato una macchia".
Anche quando mira al bene, alla giustizia, "come nella lotta contro il drago,
getta un'ombra sull'impresa".
A tal proposito,
scrive Carl Schmitt commentando l'opera dell'amico, quando si parla di "Nodo di
Gordio" ci si immagina perlopiù un groviglio confuso. Il gesto di Alessandro
Magno sarebbe stato quello di sciogliere il groviglio, e in modo semplice -
pericolosamente semplice - decisionistico: "con un colpo di spada". Ma il libro
di Jünger, come spiega bene Schmitt, non rappresenta una condanna del mondo
orientale e un'esaltazione occidentalistica: "In realtà -osserva -il libro di
Jünger non fa che parlare di polarità e transizione. La sua conclusione non è un
aut-aut, ma un et-et, un incontro reciproco, un bussare alla porta, uno scambio
e un equilibrio, un ritorno nell'eterno nel tempo e un accenno alle recondite
risposte che spettano all'Oriente". Perché senza aver letto questo libro
fondamentale, difficilmente si può comprendere il complesso rapporto tra Oriente
e Occidente. Scritto 70 anni fa, questo saggio si presenta oggi come un
classico: senza tempo.
Putin contro
l'Europa. Una guerra cominciata tanti anni fa.
Paolo Guzzanti su
Panorama il 20 Febbraio 2023
Ecco cosa scriveva
nel 2007 sui rapporti, già allora tesi, con il capo del Cremlino
Da Panorama del 13
settembre 2007 La guerra fredda è tornata. Tutto è cominciato il 23 novembre
dello scorso anno quando l'Atomic weapons establishment, il laboratorio militare
nucleare di Aldermaston nel Berkshire, certificò che un cittadino britannico,
Edwin Redwald Carter, era stato colpito e ucciso su suolo britannico dal primo
attacco nucleare della storia lanciato da una potenza straniera. L'arma era un
isotopo radioattivo, il polonio 210, introdotto violando la sovranità del Regno
Unito. L'identità originale di mister Carter è quella dell'ex esule e colonnello
russo Alexander Valterovich Litvinenko, colpito in una stanza d'albergo a Londra
e morto tre ore prima che l'Awe scoprisse che la causa del decesso era una
minuscola bomba atomica che può essere prodotta soltanto da laboratori militari
per usi militari. La guerra fredda è cominciata nel momento in cui il presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin ha risposto all'insistente richiesta di
estradizione della Procura della Corona britannica per il cittadino russo (ed ex
ufficiale del Kgb) Andrei Lugovoy accusato di aver assassinato Litvinenko,
facendo alzare in volo i bombardieri Tupolev con testate nucleari che non
volavano dal 1992. Poco prima aveva fatto mettere sotto il tiro dei suoi missili
alcune città europee e aveva avuto uno scontro aspro con il primo ministro Tony
Blair pochi giorni prima che questi lasciasse il suo ufficio: Blair, che aveva
sempre parlato di Putin come di un «caro e insostituibile amico», era stato
sferzante. Il segretario di Stato americano Condoleezza Rice l'aveva seguito
portandosi dietro il presidente francese Nicolas Sarkozy e il Portogallo. Il
nuovo primo ministro britannico Gordon Brown non ha esitato a far levare i
caccia per contrastare i bombardieri russi. Tutto ciò accade oggi, nel 2007.
Vladimir Bukovsky, il celebre esule russo che fu liberato dopo uno scambio con
il segretario comunista cileno Luis Corvalan, ha commentato dicendo: «Due
sciocchezze sono state credute in Occidente: che la guerra fredda fosse finita e
che l'Occidente l'avesse vinta».
Le bugie di Putin
prima della guerra nella docu-serie Bbc.
Il Corriere della
Sera il 22 febbraio 2023.
Per chi non vuole
parlare a vanvera dell’invasione russa dell’Ucraina (e scandalizzarsi per le
parole che Zelensky ha rivolto a nostri uomini politici), consiglio vivamente di
seguire Putin contro l’Occidente, la docu-serie che la Bbc ha dedicato ai
tragici eventi dell’«operazione militare speciale» (History Channel, 411 di
Sky).
Putin è uno spietato
dittatore, un mentitore seriale, ma molti leader occidentali, da Hillary Clinton
a Donald Trump, da Emmanuel Macron ad Angela Merkel hanno faticato a capire (o
non hanno voluto capire) cosa stesse succedendo. A partire dal ruolo ambiguo di
Viktor Yanukovich, ex presidente dell’Ucraina, il documentario in tre puntate di
Norma Percy ricostruisce sia i colpi di mano di Putin sia i retroscena delle
tattiche fallimentari dell’Occidente. Tra rivelazioni, aneddoti, scene
raccapriccianti, filmati d’archivio e lunghe interviste, la serie tratteggia lo
scenario del conflitto. Nel primo episodio, per esempio, si ricorda l’invasione
russa del 2014 in Crimea e nella regione orientale del Donbass. Quando decine di
soldati russi vennero catturati sul territorio, con cartellini identificativi e
ordini ufficiali, Putin raccontò che i soldati erano in vacanza o che si erano
smarriti lungo il confine.
L’Occidente restò in
silenzio. Grandi assenti la Merkel e Obama. Cameron e Hollande appaiono distanti
e incapaci di trattare. Barroso racconta di aver ascoltato a bocca aperta Putin
che gli diceva che l’Ucraina era una creazione della Cia e della Commissione
europea. Quando Putin sta per scatenare l’invasione e Boris Johnson tenta di
dissuaderlo, la risposta dello zar russo è: «Boris, non voglio farti del male,
ma con un missile ci vorrebbe solo un minuto». Non è un’inchiesta a senso unico:
secondo uno stile giornalistico che noi non sempre pratichiamo (o «niputini» di
Santoro o Report), ogni affermazione è documentata, ogni descrizione ha un
riscontro.
Il monito
(inascoltato) di Bush a Obama: "Occhio alla Russia".
Francesca Salvatore
il 23 Febbraio 2023 su Inside Over.
Quando alla Casa
Bianca un inquilino si appresta a lasciare, per fare posto ad un altro
democraticamente eletto, il vecchio padrone di casa è solito lasciargli
dei memo. Una sorta di guide for dummies nella quale dispensare consigli sebbene
non si tratti di documenti di alto rango. Tuttavia, questi appunti del
presidente uscente sono ritenuti abbastanza sensibili da venire secretati in
attesa di essere, a tempo debito, declassificati.
Quattordici anni fa
toccava a George W. Bush Jr. lasciare i suoi appunti al successore Barack H.
Obama: l’11 settembre, l’Iraq, l’Afghanistan, tutto era già accaduto. In
quaranta note riservate del Consiglio di sicurezza nazionale, Bush segnava il
passaggio fra due amministrazioni molto differenti ma comunque legate a doppio
filo alla war on terror. Per la prima volta, quei promemoria sono stati ora
declassificati, offrendo una vista su come il mondo appariva agli occhi di Bush
dopo otto anni durissimi.
I memo di Bush per
Obama
Una serie di frasi
lapidarie che suonano quasi profetiche: "L’India è un amico. Il Pakistan no. Non
fidarti della Corea del Nord o dell’Iran, ma parlare è comunque meglio che non
farlo. Attenzione alla Russia; brama il territorio della sua vicina Ucraina. Fai
attenzione a non essere intrappolato da guerre terrestri intrattabili in Medio
Oriente e Asia centrale. E oh sì, la costruzione della nazione è decisamente più
difficile di quanto sembri.". A rileggerlo oggi, quel monito risuona sinistro.
Nel gennaio 2009,
dopo l’insediamento, con le truppe statunitensi ancora in combattimento in due
guerre, Osama bin Laden ancora latitante, una crisi finanziaria in atto e varie
altre minacce alla sicurezza americana incombenti, per Obama si profilava un
inizio di mandato difficile. Iraq e Afghanistan riempiono, infatti, righe e
righe di queste memorie, ma nonostante ciò Bush raccontava al successore quanto
all’epoca la politica estera americana sperasse ancora in relazioni costruttive
con Russia e Cina. Il promemoria sulla Cina sollecitava un ampio impegno
personale tra i leader, attribuendo alle interazioni di Bush con le sue
controparti cinesi la creazione di "una riserva di buona volontà" tra le due
potenze. Il promemoria sulla Russia concludeva, invece, che la "strategia della
diplomazia personale" di Bush aveva avuto un successo iniziale, ma riconoscendo
che i legami si erano inaspriti, soprattutto dopo l’invasione russa della
Georgia nel 2008.
Si trattava, dunque,
di un promemoria sulle future ambizioni espansionistiche di Mosca. Bush, nei
suoi appunti, dichiarava, ancora: "I tentativi della Russia di sfidare
l’integrità territoriale dell’Ucraina, in particolare in Crimea, che è per il
59% etnicamente russa e ospita la flotta del Mar Nero della Marina russa, deve
essere impedita". Il memo aggiungeva che "la Russia sfrutterà la dipendenza
dell’Europa dall’energia russa" e utilizzerà mezzi politici "per creare cunei
tra gli Stati Uniti e l’Europa". Ipse dixit.
Obama e Mosca: dal
"reset" al blitz in Crimea
Se c’è un’immagine
che più di altre racconta la postura americana nei confronti di Mosca in questa
fase è quella di Obama e Dmitry Medvedev che discutono davanti a due cheesbruger
in quel del Ray’s Hell Burger ad Arlington nel 2010. Nei primi mesi del suo
primo mandato, Obama aveva promosso un reset con Mosca destinato a sanare le
acredini legate al caso Georgia, con l’obiettivo di assicurarsi l’aiuto di Mosca
su questioni chiave per Washington. Questo produsse dei primi successi: il New
Start, ormai ridotto in cenere, e una maggiore cooperazione su Iran e
Afghanistan.
I progressi
rallentarono nel 2011 sul dossier Libia, e nel 2012, il ritorno di Vladimir
Putin alla presidenza russa fece presagire un rapporto meno cooperativo, ma
sottostimando le ambizioni della Difesa russa. Gli anni delle elezioni, in
genere, non hanno mai generato tempi favorevoli per i progressi nelle relazioni
Usa-Russia. Nella primavera del 2012, la campagna per le elezioni presidenziali
negli Stati Uniti era in pieno svolgimento. Toccò a Mitt Romney fare la
Cassandra: il governatore, che si era assicurato i voti necessari per la nomina
repubblicana, citò la Russia come la minaccia geopolitica numero uno per il
Stati Uniti. Obama
criticò duramente il commento ma saltò a piè pari la Russia nella sua campagna
elettorale e la questione del controllo degli armamenti venne trattata come un
tabù. In agosto la Russia aderì al WTO e i funzionari russi riconobbero
pubblicamente il sostegno di Washington come la chiave per realizzare l’adesione
dopo tanti anni di attesa. Il dossier siriano, unitamente alla chiusura di Mosca
sulle attività dell’Usaid in Russia, diedero il la ad un nuovo allontanamento
tra le due superpotenze.
L’amministrazione
Obama sembrò arrendersi difronte alle secche in cui navigava questo rapporto nel
corso del 2013, fino a toccare il minimo storico del 2014, con l’annessione
russa della Crimea e l’inizio del caos in Donbass. Un precedente inquietante per
il diritto internazionale e per la tenuta democratica dell’Europa, forse
sottovalutato, ritenendo che la pretesa sulla Crimea e sul Donbass fossero
limitate a quell’area e che non nascondessero l’intento di arrivare a Kiev. Al
di là delle dovute rappresaglie diplomatiche e delle sanzioni, Washington optò
per una strategia trina, cercando di sostenere l’Ucraina, rassicurando gli
alleati della Nato e conducendo una revisione della propria politica estera
Gli errori di Obama
"Leading from
behind" era stato uno dei refrain di Obama. Una politica molto ripiegata sul
programma domestico e grandi progetti come la riforma sanitaria o i diritti
civili, tanto da far pensare ad una probabile rinuncia al ruolo di poliziotto
del mondo. Questo apre un interrogativo ulteriore: glissare sul 2014 fu errore
di valutazione o fu, scientemente, una strategia di disimpegno? Era chiaro già
da allora che l’Europa avrebbe pagato il prezzo più alto se Putin non si fosse
fermato alla Crimea. Del resto, l’amministrazione Obama chiudeva i suoi otto
anni con i compiti a casa tutto sommato ben fatti: una fittissima agenda
interna, due guerre portate a termine, la cattura di Bin Laden, la tempesta
della crisi affrontata. Lo spiegò bene Michael Cohen della Century
foundation nel bel mezzo della crisi in Crimea: "Quel che c’è di sbagliato in
queste analisi è il focus delle critiche. Il cuore del problema non è tanto come
Obama deve rispondere ai russi ma perché".
Nella teoria tutto
fila, nella pratica un po’ meno. Quasi dieci anni dopo, un presidente americano,
tra l’altro ex vicepresidente dello stesso Obama, è fra le macerie di Kiev. Al
di là dell’iconografia e degli usi privati del gesto, è il segno più tangibile
di un’America che è continuamente tentata dall’isolazionismo, ma che alla fine
isolazionista non può e non riesce ad essere. Alla luce di questo, seppur la
scelta di Obama fu isolazionista, fu comunque poco lungimirante: nel 2014 le
bizze putiniane era già chiare. E in un mondo dominato dall’effetto farfalla era
presumibile che una crisi nel granaio d’Europa avrebbe avuto conseguenze
economiche, energetiche, geopolitiche spaventose, oltre che umanitarie. E per
quanto Washington potesse desiderare di ripiegarsi su se stessa, era già chiaro
che quelle conseguenze avrebbero colpito anche gli Stati Uniti. Fu una
strategia, non un errore di valutazione, ma una strategia molto, molto miope.
FRANCESCA SALVATORE
Lorenzo
Cremonesi, diario dalla guerra ucraina. In coda tra i carri armati, quel primo
viaggio da Leopoli a Kiev.
Lorenzo Cremonesi su
Il Corriere della Sera il 22 Febbraio 2023.
Pubblichiamo alcuni
estratti dal libro di Lorenzo Cremonesi «Guerra infinita» che a un anno
dall’invasione sarà disponibile gratis per abbonati nell’app Corriere Online
nella sezione ebook
Di seguito alcuni
estratti dal libro di Lorenzo Cremonesi «Guerra infinita» (Solferino, 2022) che
sarà disponibile gratis per gli abbonati del Corriere della Sera nell’app
Corriere Online nella sezione ebook. Su Corriere.it e nell’app Digital
Edition nella sezione «Guide e ebook» fino al primo maggio.
Leopoli, 25 febbraio
Nella notte ho
camminato per quattro ore con lo zaino in spalla e la sacca del computer a
tracolla per superare le decine di migliaia di profughi che intasavano la strada
che da Leopoli porta verso Medyka. Sapevo che stavano cominciando a scappare, ma
non pensavo fossero già così numerosi. Bastano pochi minuti tra la folla per
immergersi nell’atmosfera dell’emergenza: è gente che fugge, tutti sono stanchi,
spaventati, nelle borse lo stretto necessario. Sono quasi tutti donne e bambini:
le autorità ucraine impongono che gli uomini tra i diciotto e i sessant’anni
restino a combattere. Mi vengono in mente gli scritti di Simone Weil, che nel
1940 osservava sgomenta i parigini in fuga di fronte all’avanzata della
Wehrmacht e descriveva in pagine cariche di compassione quanto velocemente un
essere umano possa trasformarsi in un relitto alla deriva. Solo poche ore fa
questa gente stava tranquilla nelle proprie case, dava per scontato il cibo nel
frigorifero, il calorifero tiepido, la luce elettrica, l’acqua corrente; ora è
già una schiera di profughi indifesi, alla mercé del caso, affamati, sporchi,
tremanti di freddo; le mamme non sanno dove lavare i figli, dalle poche toilette
nelle baracche della frontiera, ormai impraticabili, esce un olezzo
insopportabile.
Leopoli, 27 febbraio
Provo a prendere il
treno per Kiev, ma nella stazione di Leopoli il caos regna sovrano. Gli orari
sui tabelloni sono sbagliati, i ritardi sono di giornate intere, nevica fitto e
il traffico è rallentato, sotto le pensiline migliaia di disperati intirizziti.
Mentre cerco di capire quando potrò partire ricevo un messaggio da Fatima, una
poliziotta afghana incontrata lo scorso settembre all’aeroporto di Herat. Mi
chiede aiuto, vorrebbe emigrare in Italia con i due figli piccoli, il marito è
morto anni fa. Il suo messaggio mi conduce a tracciare un confronto tra queste
due crisi. Gli afghani non sono stati capaci di difendersi: il loro fallimento è
anche quello dei nostri programmi di addestramento delle loro truppe e adesso
stanno collettivamente pagando il prezzo terribile della sconfitta militare
contro i talebani. Al contrario, gli ucraini si stanno difendendo con un
coraggio e una determinazione che lasciano sorpresi; la loro resistenza sta già
creando un nuovo senso identitario nazionale, sarà complicato assoggettarli.
Incontro i loro volontari ai centri di reclutamento in città. «Voglio uccidere i
nemici che hanno invaso il nostro Paese: devono morire, questi ladri della
nostra terra. Non cerco rifugi o aiuti umanitari, dateci piuttosto fucili,
missili e munizioni. Lo so che il mio discorso sembra lontano anni luce se
ascoltato da Roma o Milano. Ma io credo che in alcuni casi valga la pena di
combattere e magari rischiare di morire, ma soprattutto di uccidere per la
libertà e la democrazia» mi dice uno di loro, Roman Babiy, che è poco meno che
trentenne e per dieci anni ha studiato a Salerno. Mi incanta la sua
determinazione, specie per il fatto che Roman è uno di noi. Non ha mai fatto il
servizio militare, non ha mai imbracciato un fucile, non c’è in lui nulla che
richiami i fanatici jihadisti siriani o la violenza tribale delle milizie
libiche. Lui e i suoi amici pianificavano di venire a sciare in Italia, parlano
inglese perfettamente, sono connessi col mondo, sono europei. Eppure, sono
pronti a battersi. Gli ucraini stanno già elaborando il mito dei caduti, c’è una
disposizione alla morte in battaglia che noi non ricordiamo.
Kiev, 28 febbraio
Alla fine, sono
arrivato in auto nella capitale. Mi ci ha portato per duecentocinquanta euro
Maga Nahsibzade, musulmano trentaduenne del Nagorno Karabach. Ci viene con la
sua giovane fidanzata, chiaramente non sa nulla di ciò che ci aspetta sulla
strada e io meno di lui. Partendo alle 10 di mattina da Leopoli — troppo tardi,
ma lo scopriremo a nostre spese — sostiene che in sei ore percorreremo i
seicento chilometri per Kiev: ce ne vorranno più del doppio. All’inizio il
viaggio scorre bene, brilla il sole nell’aria limpida, soltanto i posti di
blocco ci rallentano un poco, troviamo benzina e persino alimentari ben forniti
alle stazioni di servizio. Ma a circa cento chilometri dall’arrivo la situazione
si complica. «I russi stanno attaccando per chiudere l’assedio su Kiev, sparano
sull’autostrada, dovete prendere le vie secondarie» ci spiegano i soldati. Sul
lato della careggiata sono ben visibili alcune auto colpite dai cecchini russi.
Si sta facendo sera e noi dobbiamo seguire una lunga serie di straducole
secondarie che toccano piccoli villaggi agricoli, fattorie isolate, attraversano
campi coltivati e macchie di bosco. Ogni pochi minuti i volontari armati
controllano i documenti ai posti di blocco, puntano i fucili, appaiono
nervosi. Alle 7 di sera siamo nel centro della battaglia. Poche decine di metri
sopra le nostre teste vedo sfrecciare i colpi traccianti, i globi arancioni di
tre forti esplosioni illuminano la campagna a meno di mezzo chilometro dalla
nostra auto. Vorrei fermarmi per la notte al riparo di una casa isolata. Maga
invece insiste per proseguire, la sua fidanzata piange spaventata, lui vorrebbe
arrivare al più presto da alcuni amici che abitano vicino a piazza Maidan.
«Evita di stare vicino ai mezzi militari: potrebbero venire attaccati dai droni
russi» mi limito a consigliare. Ma poco dopo siamo irrimediabilmente
imbottigliati nel mezzo di un lungo convoglio di carri armati. È una situazione
assurdamente pericolosa, restiamo fermi almeno un’ora, le carreggiate bloccate
da un groviglio di bus, mezzi militari con camion al seguito stipati di
munizioni e benzina, auto private cariche di civili spaventati, ma anche giovani
volontari accorsi per difendere il fronte della capitale e che saranno la nostra
fortuna: la città infatti è paralizzata dal coprifuoco, ma loro hanno il
permesso di entrare e noi li seguiamo, come fossimo parte della colonna, sino al
centro.
Kiev, 5 marzo
Vedo continuamente
monumenti e memorie della «Grande guerra patriottica» contro il nazismo. Nella
zona delle officine della Antonov è esposto un T-34, il carro armato diventato
il simbolo della vittoria sovietica contro gli eserciti di Hitler. In queste
pianure otto decadi fa vennero combattute gigantesche battaglie tra mezzi
corazzati. Persino all’entrata del villaggio di Irpin, dove i russi cercano di
sfondare per raggiungere rapidamente le arterie a quattro corsie che conducono
nel centro a Maidan, si trova un monumento con i nomi dei caduti locali nei
ranghi dell’Armata Rossa. Proprio qui di fronte, una mattina fredda e umida, ci
muoiono una mamma con i due figli. Nella gabbietta dei cagnolini, rimasta sul
selciato con gli animali morti, avevano nascosto il denaro e i gioielli di
famiglia. Alla stazione ferroviaria, che da Kiev smista le ondate di profughi in
fuga verso occidente, ritrovo le memorie dei libri che sin da ragazzino ho letto
sulla Seconda guerra mondiale nell’Est europeo, dove i treni erano onnipresenti.
Locomotive avvolte nel vapore che corrono nella notte tagliando i campi
innevati, vagoni carichi di vite precarie: i treni portavano i soldati al fronte
ed evacuavano i feriti, sui treni partivano i deportati per i campi di
concentramento, solo i treni garantivano una certa libertà di movimento. In una
delle stazioni del metrò, cento metri sottoterra, incontro Raissa Stephana, che
ha ben oltre ottant’anni e non nasconde la nostalgia di quando era chiamata «la
più bella artista di Kiev», cantava e recitava nei teatri d’opera di tutta
l’Urss e si esibì anche al Bolshoi: «Ma adesso sono diventati criminali, mi
sento tradita dai russi che ci sparano contro. Ma forse non è colpa loro, Putin
li ha come stregati, li ha ubriacati di guerra!» dice mostrando una sua foto in
scena, risalente alla metà degli anni Sessanta.
Kiev, 24 marzo
È trascorso un mese
dall’inizio della guerra e non so come finirà. Ma è certo che questa prima fase
l’hanno vinta gli ucraini. Sono riusciti a bloccare l’offensiva russa, a ora
soltanto la città di Kherson è caduta e anche qui la popolazione rimasta scende
in strada a protestare. Persino Mariupol, la città martire dove tutti parlavano
russo e che Putin considerava sua ancora prima di sparare il primo colpo,
continua a resistere. Queste ultime note sono scritte di fretta, la cronaca
della guerra cambia di ora in ora. Sospetto che i movimenti nazionalisti ucraini
alzeranno la testa, l’eroismo della resistenza alimenterà i loro miti e
potrebbero limitare lo spazio di compromesso nei negoziati con Putin. C’è tra
loro chi adesso vorrebbe sfruttare il momento propizio per liberare la Crimea e
l’intero Donbass. Putin con le spalle al muro però potrebbe ricorrere alle armi
non convenzionali e trasformare l’intero conflitto in un braccio di ferro con la
Nato. Si ripete una vecchia storia, le guerre spesso generano altri conflitti,
chi le comincia s’illude di chiuderle presto, ma è una chimera pericolosa. Tra
poco partirò per Kharkiv per cercare di vedere come l’hanno ridotta quattro
settimane di bombardamenti. Ancora troverò macerie, molte più che non a Kiev:
case sventrate, immondizia, rottami di auto, testimonianze di esistenze
spezzate. Al contrario delle popolazioni di molte aree del Medio Oriente, ho
scoperto che pochi ucraini si sono attrezzati con i generatori per fare fronte
all’emergenza. Forse dovranno pensarci, alla lunga, ma intanto bivaccano nel
freddo delle rovine: quando li vedo uscire dalle zone bombardate indossano
strati di vestiti sporchi, raccontano di essere rimasti intere giornate nel buio
delle cantine e dei rifugi di fortuna dopo che le batterie delle lampade si
erano esaurite.
Kharkiv, 1° aprile
Sopravvissuti e
profughi che si cercano, famiglie divise, bambini e anziani rimasti soli:
giungono notizie drammatiche dai luoghi attorno a Kiev appena abbandonati dai
russi. Ancora si parla di violenze sessuali compiute dai soldati invasori, fosse
comuni, civili assassinati senza alcun motivo, girano immagini di corpi
abbandonati per la strada. Ci sono aree urbane devastate con scene molto simili
allo scempio di Mariupol. I russi minimizzano e puntano il dito contro le
«falsità» della propaganda di Kiev. Gli ucraini accusano direttamente Putin di
crimini di guerra. Sui social compaiono appelli di persone che fanno nomi,
vogliono sapere dei loro cari, lanciano richieste di aiuti sulla rete per
trovarli. A me ricordano un poco il racconto di mia nonna sulle origini del
«Bollettino della Comunità ebraica di Milano», fondato nel 1945 sostanzialmente
per raccogliere le liste di nomi degli scampati dall’Olocausto che arrivavano in
Italia da tutta Europa e cercavano di capire se i loro familiari fossero ancora
vivi, e come trovarli. Nei conflitti ci sono sempre profughi che si cercano.
Ucraina, un anno
di guerra: il video tributo di Zelensky.
Dal blitz fallito
alla perdita di Kherson: 12 mesi di errori di Putin di Lorenzo Cremonesi,
inviato a Kiev, su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Quella che doveva
essere un’operazione di pochi giorni si trasforma in un disastro già nelle prime
ore della guerra. Gli ucraini resistono, contrattaccano e oggi hanno
riconquistato molti territori. Ora la sfida decisiva è nel Donbass.
La sconfitta
dell’esercito russo si consuma subito, già il 24 febbraio 2022, nelle primissime
ore della guerra. Attacca a sorpresa, ha dalla sua il vantaggio di poter dettare
la tempistica e il luogo dove colpire, ma incredibilmente fallisce. E quando gli
storici nel futuro racconteranno dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina non
potranno che caratterizzare la battaglia di Hostomel come il momento cruciale in
cui Vladimir Putin e il suo stato maggiore si lasciano sfuggire la supremazia
dell’iniziativa, costretti da quel momento a riadattare continuamente i piani le
strategie a quelli dei comandi di Kiev. Compiono il primo passo, ma poi sono
obbligati a rincorrere. Volevano tutto e subito, ma si erano clamorosamente
sbagliati sulla volontà di resistenza ucraina, sull’atteggiamento occidentale,
sulle loro armi vetuste e sul loro esercito alla prova dei fatti inadeguato. Gli
ucraini si rivelano maestri nelle nuove tecnologie, nell’utilizzo agile dei
droni, nel monitoraggio delle comunicazioni nemiche, le loro piccole formazioni
veloci agiscono in modo autonomo e disorientano le molto più numerose e lente
unità russe.Mariupol, soldati russi nascosti dietro un mezzo militare per non
essere colpiti dalla resistenza ucraina
Il sacrificio umano
Si stimano già 350
mila morti
Quello stesso Putin,
che sino a pochi giorni prima del 24 febbraio minimizzava parlando di
«esercitazioni» di una piccola parte delle sue truppe lungo i confini
meridionali sino alla Bielorussia e accusava gli americani di essere
«guerrafondai» perché dall’inizio dell’autunno precedente denunciavano che la
Russia stava preparando una vera guerra in grande stile, si ritrova a dover
combattere con modalità che non aveva seriamente previsto. Così oggi, un anno
dopo, le sue truppe stanno dissanguandosi nella cittadina di Bakhmut — un
obbiettivo secondario, minuscolo rispetto alle aspirazioni iniziali, dove gli
ucraini hanno già comunque costruito altre due linee di difesa fuori dalla zona
urbana in caso di ritirata — e dichiareranno vittoria ai quattro venti se
dovessero prenderla con la speranza di occupare poi tutto il Donbass, pur
sapendo che il conflitto resta del tutto aperto. Difficile prevedere cosa
avverrà nel 2023, si stimano a circa 200.000 le perdite militari russe, tra
morti feriti e dispersi sino ad ora. Quelle ucraine sarebbero circa la metà, cui
si sommano circa 50.000 civili. Certamente gli aiuti militari occidentali
saranno fondamentali per aiutare un Paese di circa 40 milioni di abitanti contro
un nemico che ne conta quasi 4 volte di più, possiede un territorio immenso ed
ormai si dimostra disposto ad impiegare tutte le sue risorse pur di prevalere.
I calcoli sbagliati
Alle 8 è disfatta
russa all’aeroporto
Il giudizio è in
ogni caso netto: il 2022 rivela al mondo la pochezza delle capacità militari
russe, espone gli errori grossolani della loro intelligence, incluso quello
imperdonabile della sottovalutazione dell’avversario, e invece mostra il
pericolo e l’aggressività delle aspirazioni imperiali di Putin e del suo
entourage, che ricorrono persino alla minaccia atomica pur di tentare di
rilanciare quell’immagine aurea di superpotenza che vorrebbe nostalgicamente
riesumare i defunti fasti dell’Unione Sovietica trionfante contro l’esercito
tedesco nel 1945.
Alle 5,30 inizia
l’invasione, due ore e mezza dopo una trentina di elicotteri Mi-8s arrivano nel
cielo dell’aeroporto di Hostomel, a nord di Kiev, una quarantina di chilometri
da Maidan e dai palazzi presidenziali. Gli ucraini li stanno attendendo ed è un
massacro. Ce lo mostreranno un mese dopo, ridotto a un gigantesco campo di
ferraglia annerita dal fumo e sommerso dai rottami di velivoli mischiati agli
scheletri dei blindati. Tra loro anche i resti dei giganteschi Antonov, i cargo
più grandi del mondo. «Li aspettavamo. L’intelligence americana ci aveva
avvisato, poi siamo stati noi armati di missili terra aria statunitensi Javelin
e britannici Nlaw ad annientare i paracadutisti russi. Il peggio per loro è
stato quando siamo riusciti ad abbattere tre Iliuscin-76 con a bordo il meglio
delle teste di cuoio, circa 600. In un pugno di minuti Putin si è visto
annientare il fior fiore del suo corpo d’invasione», raccontava quei giorni un
colonnello dell’antiaerea.
Cambio di strategia
Da blitz a guerra
patriottica
Doveva essere un
blitz velocissimo mirato a uccidere o catturare Volodymir Zelensky e i suoi
fedelissimi entro due o tre giorni, quindi occupare i gangli vitali dello Stato
nella capitale e infine prendere il Paese intero. Da quel momento sarà però una
cosa del tutto diversa: uno sforzo bellico di logoramento prolungato che
contempla l’impegno dell’intera comunità nazionale, anche se per mesi a Mosca si
continua a ribadire la formula farsa dell’«operazione speciale». L’imbroglio
sarà evidente a dicembre, quando il ricorso da parte di Putin alla retorica
della «grande guerra patriottica» serve per mascherare lo stravolgimento delle
dinamiche e degli obbiettivi del combattimento: si è passati dal Blitzkrieg per
«affrancare gli ucraini dal tallone dei nazifascisti» alla mobilitazione
generale contro «l’aggressione della Nato».
Nelle prossime
settimane potrebbero venire reclutati circa 2 milioni di russi, oltre dieci
volte il numero dei soldati mobilitati un anno fa. Già a ottobre il sistematico
bombardamento russo contro le infrastrutture civili, le centrali elettriche, le
stazioni di pompaggio del sistema idrico mirava a fiaccare la volontà di
resistenza della popolazione. Quegli stessi ucraini che prima dovevano essere
«liberati dai fratelli russi» vanno adesso collettivamente puniti, fatti
soffrire in massa. Magie della propaganda negli Stati totalitari: nella
narrativa di Mosca gli aggressori diventano aggrediti, l’attacco preventivo come
difesa. Si comprende così quanto anche gli sviluppi più recenti siano la
conseguenza diretta di quel «piano B» messo in piedi dal Cremlino dopo i primi
insuccessi sul campo e che però non era stato davvero seriamente preparato. Un
gigantesco convoglio composto da migliaia di mezzi di ogni tipo con a bordo
oltre 60.000 soldati entra in Ucraina dalla Bielorussia a fine febbraio, occupa
e supera la centrale nucleare di Chernobyl e mira direttamente sulla capitale.
Kiev si trincera, in città s’impone il coprifuoco notturno nel terrore delle
cellule di filorussi che si dice siano pronti a compiere attentati e assassini
mirati per creare il caos. Il governo distribuisce fucili e munizioni, ovunque
vengono costruite trincee e barricate, sui balconi s’impilano le bottiglie
molotov.Un soldato ucraino della 14a Brigata meccanizzata Roman il Grande
attende la prossima missione di fuoco, è il luglio 2022 nel distretto di
Donetsk, Ucraina (Foto Scott Olson/Getty Images)
Resistenza e
reazione
Kiev si difende,
orrore a Bucha
Ma a questo punto
avviene l’inaspettato: mentre tutti i maggiori esperti e commentatori
internazionali danno per scontata la vittoria russa entro breve, gli ucraini
resistono e contrattaccano. «Non voglio un taxi per scappare, resto qui,
combatto e muoio se necessario, piuttosto dateci armi», replica Zelensky a Joe
Biden, il quale vorrebbe mandare un commando in elicottero per portarlo in salvo
all’estero. Poi la propaganda Usa e di Kiev inizia a parlare di «difficoltà»
russe. Ovviamente noi giornalisti non vi crediamo: com’è possibile che i russi
non ce la facciano?
Eppure, sono i
racconti delle decine di migliaia di sfollati da Hostomel, Bucha, Irpin e dagli
altri centri urbani invasi in fuga verso Kiev che nella loro spontanea
immediatezza aiutano a far comprendere. Che fanno i soldati russi quando entrano
nelle vostre case? Chiediamo. «Si fiondano in cucina, aprono il frigorifero,
svaligiano le dispense e mangiano o rubano. Sono affamati, le loro razioni K
sono scadute. Poi prendono vestiti e coperte, indossano ancora le uniformi
estive, non resistono ai meno quindici delle notti invernali. Li abbiamo visti
fermare le auto diesel nelle strade per pompare il carburante dai serbatoi, i
loro tank sono a secco», rispondono. Si delinea così il quadro di un esercito
che non era affatto pronto ad affrontare ciò che incontra. Dopo la prima
sorpresa, la resistenza ucraina entra in azione. Tra i russi è il panico.
Avevano spiegato loro che sarebbero stati accolti «con pane e sale», come recita
l’antica formula di benvenuto contadina locale, ma adesso dalle case gli sparano
contro, cresce la resistenza partigiana. A metà marzo reagiscono: a Bucha si
consuma l’orrore con torture, fucilazioni, spari contro chiunque giunga a tiro.
Più tardi, troveremo centinaia di auto crivellate dai proiettili cariche di
bagagli, vestiti, giocattoli e con i sedili imbrattati di sangue.
Mire su Odessa,
Mariupol capitola
A inizio aprile i
russi abbandonano la regione di Kiev. La prima fase della guerra — quella
decisiva dove Putin voleva tutto per poi andare a minacciare la Moldavia
annettendosi la Transnistria filorussa e rilanciare il peso di Mosca sulle
regioni europee perse dopo il crollo del Muro di Berlino — può considerarsi
terminata. Gli ucraini hanno combattuto praticamente da soli, garantiti dal
lavoro capillare e massiccio dei loro volontari, forti dell’esperienza maturata
sin dai tempi dell’invasione russa nel 2014 della Crimea e della nascita delle
cosiddette repubbliche autonome di Lugansk e Donetsk nel Donbass. Anche allora i
soldati di Mosca combattevano in prima linea e furono elementi determinanti per
garantire il successo delle milizie locali filorusse: dalla battaglia per il
capoluogo del Donetsk a quella per Debaltsevo, nove anni fa senza gli effettivi
russi il neonato esercito ucraino avrebbe senza dubbio prevalso.
Intanto, però, i
comandi del Cremlino hanno attaccato su più fronti. Nel nord-est minacciano
Kharkiv, prendono Izium, occupano tutto il sud sino a Kherson, a ovest del fiume
Dnipro, sfiorano il capoluogo di Zaporizhzhia dopo essersi impadroniti della
stazione nucleare. Putin vuole a tutti i costi Odessa per impedire l’accesso
ucraino al Mar Nero e strangolare l’export del grano, oltreché mettere in
ginocchio l’economia nemica. La capitolazione di Mariupol il 20 maggio, con la
resa dei suoi 2.500 difensori incluso il meglio del battaglione volontario Azov,
segna uno dei punti più difficili per l’Ucraina. Kiev si difende imputando ai
soldati russi crimini orrendi: violenze sessuali a ripetizione, bambini
torturati in massa, deportazioni forzate. Ma non serve esagerare, se non a
indebolire le accuse ucraine, gli orrori russi sono già abbastanza gravi. A fine
mese Zelensky decide di licenziare Lyudmila Denisova, la responsabile della
commissione parlamentare incaricata di documentare le violazioni dei diritti
umani, che mente ed enfatizza i dati, trasformando le atrocità nemiche in vana
propaganda.
Il contrattacco
Le armi Nato fanno
la differenza
La situazione cambia
ancora tra giugno e luglio, quando l’arrivo delle armi occidentali (assieme alle
truppe ucraine addestrate al loro utilizzo), specie i lanciarazzi americani
Himars, i droni e le artiglierie in dotazione tra i Paesi Nato, aiuta a fare
fronte contro le migliaia di cannoni e Katiusce che a questo punto Mosca sta
impiegando ovunque in modo massiccio. Anche lo spazio aereo resta conteso: Mosca
spara i missili, ma la sua aviazione evita di volare nei cieli avversari. Poche
decine di armi Nato mutano le sorti dello scontro, la superiorità tecnologica
occidentale è palese.
Le difficoltà di
Mosca si evidenziano dalla frequenza con cui Putin sostituisce i generali al
comando delle operazioni: tre capi di Stato maggiore si avvicendano in meno di
un anno, l’intera catena di comando ne risente e ciò favorisce la crescita
d’importanza della Wagner, la compagnia di contractor privati che oggi è forte
particolarmente nella zona di Bakhmut. Il suo proprietario, l’oligarca Yevgeny
Prigozhin, può aspirare ad un ruolo di maggior influenza militare e politica al
Cremlino. La censura sulla stampa russa zittisce gli oppositori alla guerra,
però fatica a far tacere le voci dei «falchi», che non nascondono il crescente
malcontento nell’esercito specie contro i metodi brutali utilizzati dalla Wagner
per reclutare i corpi d’assalto tra i criminali comuni nelle prigioni. Tra
luglio e agosto guadagnano punti occupando Severodonetsk e Lysychansk.
L’Ucraina si
riprende Kherson
Per gli ucraini i
risultati arrivano invece tra settembre e novembre. L’abile capo di Stato
maggiore, Valerii Zaluzhniyi, aveva fatto credere di volere cercare di
riprendere il mammellone di Kherson nel sud, ma ai primi di settembre lancia le
sue truppe nell’est, verso Izium e il Donbass settentrionale. I russi sono colti
di sorpresa e abbandonano il territorio lasciando sul campo immense scorte di
armi e munizioni. Quindi è davvero la volta di Kherson, che viene liberata l’11
novembre sino al Dnipro. Se inizialmente i russi erano riusciti a impadronirsi
di circa il 30 per cento del territorio ucraino, a fine anno sono scesi sotto il
20. Ma la guerra continua. La Russia sta preparando una nuova offensiva in vista
della primavera.
Ci sarà
l’escalation del conflitto? Andrea
Marinelli e Guido Olimpio su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Dodici mesi dopo
siamo daccapo alla casella uno. Mosca minaccia di usare il suo arsenale non
convenzionale per sbloccare lo stallo, Kiev conta sui nuovi carri armati e aerei
dell’Occidente. Ma nel coordinare l’assistenza è cruciale il fattore tempo
L’Ucraina non è
crollata «in due settimane», come in molti avevano predetto attribuendo agli
invasori capacità che non avevano. Un anno dopo sta ancora combattendo: ha
tenuto ed è riuscita a riprendersi città e territori. Con coraggio,
determinazione e capacità, uniti al formidabile aiuto occidentale. Sono
componenti inscindibili: puoi avere tutte le armi del mondo, ma devi saperle
usare. La resistenza lo ha fatto, lasciando però sul terreno molti soldati e
tanti civili ghermiti nelle loro case da raid brutali, indiscriminati quanto
deliberati.
I russi si sono
illusi, convinti di andare a caccia di una preda facile e dimessa, accecati
dalla loro presunzione, rallentati da difetti storici negli apparati. Hanno
pagato un prezzo spaventoso: in termini di perdite hanno avuto il loro Vietnam —
in vent’anni gli americani ebbero 58 mila morti e oltre 300 mila feriti —
nell’arco di appena dodici mesi. Non esistono numeri esatti, ma sarebbero 100
mila tra morti e feriti, persino il doppio secondo stime inverificabili. Il
comune denominatore è il massacro, reso ancora più grave da tattiche
dispendiose, quasi suicide, da primo conflitto mondiale. Il sacrificio di
mercenari e regolari non ha indotto Vladimir Putin a fermare la macchina. Non
può farlo e non vuole farlo, anzi è pronto a rilanciare per arrivare alla
conquista completa delle quattro province annesse tramite «referendum»: Donetsk,
Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.
Un anno dopo siamo
di nuovo alla casella uno. Gli occupanti riusciranno a raggiungere le mete
indicate dal Cremlino? Kiev potrà incassare un’altra spallata e cercare di
ripartire alla riconquista? Zelensky non ha mai smesso di rammentare che la
Crimea deve tornare sotto la bandiera nazionale, a patto di disporre dei mezzi
necessari. Ma, insieme allo scenario convenzionale fatto di corazzati, cannoni,
blindati, bombardamenti persino trincee, c’è quello nucleare. Mosca — è la tesi
— potrebbe affidarsi al suo arsenale non convenzionale per spezzare uno stallo e
costringere l’avversario a piegarsi alle sue condizioni. Magari facendo detonare
un’atomica tattica in mare, in una zona deserta oppure contro un target
specifico. Scenari considerati da esperti con valutazioni diverse. In guerra non
si può mai escludere nulla: il segretario dell’Onu Antonio Guterres ha di
recente espresso tutto il suo allarme.
Al tempo stesso è
chiaro che la propaganda russa allude a questa ipotesi per tre ragioni:
dimostrare di essere pronta a tutto; rinforzare l’idea all’interno di una sfida
all’Armageddon, dove la posta non è Odessa o Mariupol ma l’essenza stessa della
nazione; spaventare ancora di più quella parte di opinione pubblica europea che
ritiene sia pericoloso o inutile appoggiare la lotta degli ucraini. Questa
visione pessimista è respinta da chi ritiene sia troppo rischioso anche per il
neo-zar affidarsi alla Bomba, piccola o grande. Intraprenderebbe un sentiero
sconosciuto, pieno di incognite, con possibili risposte.
Emorragia arrestata
L’analisi di un
domani che speriamo non accada è connessa agli sviluppi più vicini sul
terreno. In autunno-inverno gli occupanti sono riusciti a stabilizzare i fronti,
arrestando l’emorragia dopo le sconfitte a Kharkiv e Kherson. Il generale
Surovikin, poi scivolato nel ruolo di vice, ha costruito linee di difesa, ha
arretrato truppe e ha realizzato un dispositivo di contenimento grazie anche
alla mobilitazione. Lo Stato Maggiore ha a disposizione un contingente di
220-250 mila militari in Ucraina, più altri 150 mila nelle basi in Russia. Sono
tanti e sufficienti per la difesa, ha notato l’esperto Michael Kofman: almeno
fino alla prima settimana di febbraio, infatti, l’esercito di Zelensky ha perso
l’iniziativa e non aveva più la supremazia numerica. Sono però pochi per spinte
massicce e coordinate, non è detto che una nuova chiamata di reclute possa
bastare.
Restano poi gli
interrogativi sulla qualità. Sono infinite le storie sul materiale scadente, i
mezzi non adeguati tirati fuori da caserme lontane, il trattamento brutale dei
plotoni, gli ex detenuti della Wagner trasformati in carne da macello e morti a
migliaia.
I racconti
rispecchiano una parte della realtà, risentono della propaganda e possono
portare a sottovalutare gli aggiustamenti adottati dai generali. Nessuno nega
l’esistenza di problemi nella logistica russa ma forse non sono sempre così
disastrosi e sono stati corretti aggiornando tattiche, spostando più lontano
depositi di munizioni e snodi in modo che non siano esposti agli Himars. La
produzione bellica tiene il passo, trova rimedi e mette a disposizione degli
occupanti altri mezzi. Le munizioni sono consumate a ritmi incredibili ma ne
arrivano di nuove, anche dagli alleati. Evidente è il supporto dell’Iran con i
droni Shahed, meno chiaro quello della Corea del Nord, segreto quello della
Cina.
Non solo i morti
La prova di quale
sia l’analisi giusta l’avremo solo attraverso i fatti. Vale per gli aggressori
come per i «difensori», impegnati in una lotta dispendiosa. Si calcolano le
vittime, ma non va dimenticato l’impatto su quanti sono chiusi in camminamenti e
bunker mentre attorno cadono centinaia di proiettili, potenti o meno, in grado
di limitare i movimenti basilari, come rifornirsi d’acqua. Ci sono i tiri dei
pezzi da 155 millimetri, le salve dei razzi termobarici e le raffiche dei
Terminator russi, gli strike precisi degli Himars americani, i colpi dei
mortai, i «mille tagli» inflitti da piccoli droni civili riconvertiti all’uso
bellico che sganciano ordigni ridotti ma letali, versione rustica rispetto ai
droni-kamikaze che uccidono, con le telecamere a filmare fino al momento
dell’impatto. La morte in diretta..
Gli arsenali sono in
espansione. I paesi Nato hanno promesso a Zelensky alcune centinaia di carri
armati Abrams statunitensi, Amx francesi, Challenger 2 britannici, Leopard 1 e 2
tedeschi forniti insieme a partner europei, i blindati Marder, Bradley e
Stryker. Sono solo alcuni dei mezzi che gonfiano la Babele degli
equipaggiamenti, con le conseguenti difficoltà di gestione e training: ci
vorranno mesi per vederli tutti sul campo, ma sono importanti perché gli ucraini
sanno di poter rimpiazzare le perdite con nuovi mezzi. Magari arriveranno i
razzi con un raggio d’azione da 300 chilometri, per ora sono state garantite le
bombe che raggiungono un target a 150 chilometri.
È il braccio che
deve incalzare gli occupanti in profondità. Le fabbriche vanno a pieno ritmo,
doppio e triplo turno per alimentare la filiera e creare scorte, una
mobilitazione senza precedenti. Gli alleati stanno addestrando migliaia di
ucraini, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, con la partecipazione di
canadesi, australiani, baltici. Da Mosca replicano mettendo «taglie» sui
corazzati, annunciando l’invio di robot anti-tank, ipotizzando il battesimo di
fuoco per il carro Armata T14, tanto decantato ma rallentato da guai tecnici. In
estate potrebbe esserci un nuovo grande duello di tank: per essere efficaci
vanno usati in modo integrato con altre componenti delle forze armate, ed è ciò
che gli ucraini stanno imparando con i corsi all’Ovest.
Assumere impegni ora
Adesso, accompagnato
da tante cautele, c’è un nuovo passo, con la probabile fornitura di caccia a
Kiev: si ipotizzano F16 europei/americani, Mirage 2000C francesi, Typhoon
britannici. Se gli alleati hanno rallentato su questo dossier è perché c’è
sempre il timore dell’escalation, con reazioni ancora più devastanti del
Cremlino. Ma dall’altra parte — ribadiscono gli strateghi — serve assumere degli
impegni ora perché Putin gioca sul fattore tempo, su una possibile stanchezza
occidentale, sul logoramento progressivo del nemico al fronte e nelle aree
urbane con le infrastrutture devastate. L’Occidente, sorprendendo anche il
neo-zar, ha risposto con grande generosità, tuttavia ha faticato a coordinare
l’assistenza all’Ucraina per evitare doppioni, ridurre la dispersione di risorse
(manutenzione, pezzi di ricambio, riparazioni, modelli), creare una filiera che
non solo eviti la sconfitta degli aggrediti, ma che dia loro anche i mezzi per
prevalere.
In prima linea.
Lorenzo Cremonesi su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Ore 5,30 del 24
febbraio
L’«operazione
speciale» è subito un fallimento. Poi stragi e propaganda. E l’Ucraina ribalta
le sorti
Per mesi, prima
dell’invasione, la Russia ha ammassato truppe e mezzi lungo i confini
dell’Ucraina, smentendo tuttavia di voler attaccare il Paese. Nonostante gli
avvertimenti americani, Putin ha sempre sostenuto che si trattasse di
esercitazioni
24-2-2022All’alba
del 24 febbraio le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina via terra, mare e
cielo
I soldati inviati
dal Cremlino hanno varcato i confini nelle aree di Chernihiv, a nord, vicino
alla frontiera con la Bielorussia, di Kharkiv, a est, e di Lugansk, nel Donbass.
Le truppe di Mosca sono anche sbarcate da sud via mare a Odessa e Mariupol.
Esplosioni sono state registrate nella capitale Kiev e in numerose altre città,
da Kharkiv a Mariupol
Al terzo giorno di
guerra, nonostante si pensasse a un’operazione lampo, le truppe russe non sono
ancora riuscite a prendere il controllo delle principali città ucraine: a Kiev e
in molte altre città piovono missili, si combatte a Kharkiv e Mariupol, ma
l’avanzata dei soldati di Putin è stata rallentata dagli ucraini e, soprattutto,
da problemi logistici
Si tenta una
trattativa tra le parti, prima in Bielorussia e poi in Turchia, ma non si
raggiunge nessun accordo. Il 9 marzo una bomba russa colpisce l’ospedale
pediatrico di Mariupol
24-4-2022All’inizio
del mese, mentre gli Usa danno l’ok ai primi invii di armi, vengono scoperti i
massacri di civili a Bucha e in altre città vicine. Il 14 aprile l’incrociatore
Moskva viene affondato nel mar Nero
24-6-2022Il fronte
più caldo da settimane è quello del Donbass: per giorni si combatte sulle sponde
del Siverskyi Donets, nel Lugansk. Severo-donetsk e Lysychansk cadono in mano
russa
24-9-2022Inizia la
controffensiva ucraina a Est e a Sud: viene riconquistata Kharkiv e buona parte
del Lugansk. Si svolgono referendum in quattro regioni occupate, dopo la
mobilitazione decisa da Putin. Il 27 settembre esplodono i tubi del gasdotto
Nord Stream, nel mar Baltico
24-12-2022Il 21
dicembre, dopo 300 giorni di guerra, il presidente ucraino Zelensky esce per la
prima volta dal Paese e compie un viaggio lampo a Washington per chiedere più
sostegno, ovvero più armi
Le mafie hanno
approfittato della guerra?
Marta Serafini su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Droga, esseri umani,
affari: viaggio nelle nuove rotte della criminalità dopo il 24 febbraio 2022
«Metti le mani bene
in vista sul cofano». E’ il 24 agosto 2022, mancano due giorni alla festa
dell’indipendenza ucraina, quando sulla Khreshchatyk, la strada principale di
Kiev, viene arrestato “Yurk”, famoso narcotrafficante ucraino. E’ a bordo della
sua Porsche blu. Appresso, nascosti in un doppio fondo dell’auto, ha 20 chili di
cocaina. «Abbiamo dato un altro giro di vite. Almeno che la guerra serva a
qualcosa, lo cercavamo da tempo». Sorride il sergente Roda della pattuglia di
polizia che ha effettuato l’arresto mentre stringe le manette intorno ai polsi
del sospettato. Prima del 24 febbraio, l’Ucraina era uno dei più grandi centri
di passaggio dell’eroina afgana delle droghe sintetiche e della marijuana. E non
solo. Soprattutto da Kiev e Odessa passava anche il contrabbando di armi verso
l’Europa. «Ma ora tutto sta cambiando», spiega Roda prima di far salire in auto
il sospettato.
Seduto in un bar del
centro, Oleksiy Bobrovnikov, giornalista investigativo ucraino ordina un altro
espresso. Prima di incontrarci abbiamo parlato su una chat protetta. Dopo che ha
realizzato un’inchiesta sul traffico di droga tra Russia e l’Est dell’Ucraina ha
dovuto lasciare il Paese per 5 anni e una sua fonte è stata uccisa. «Con
l’invasione russa è come se un terremoto avesse colpito la criminalità
organizzata: rotte, attività, rapporti con la Russia, in poche settimane c’è
stata una rivoluzione», sostiene. Prende fiato. «Come si dice in Ucraina, tutte
le strade portano a Kiev, non a Roma. Se stai seguendo la pista del denaro e le
rotte del contrabbando dall’ovest e dal sud dell’Ucraina, è nella capitale che
finirai» Come spesso succede, è nella capitale che confluiscono i soldi dei
traffici illeciti. È qui che si trovano i politici, la polizia, i servizi
segreti e i centri militari. Ognuno di questi centri controlla la propria quota
di torta di contrabbando. «Ad esempio, le esportazioni sono solitamente
controllate dalla comunità dell’intelligence, ovvero la Sbu (l’intelligence
interna, ndr) e il Gur (l’intelligence militare, ndr). Questi includono droghe,
legname e armi», spiega ancora. Ora grazie al coprifuoco, introdotto dopo il 24
febbraio, quasi ogni notte gli spacciatori vengono arrestati con ingenti
quantità di droga, in particolare droghe sintetiche. Il loro valore varia da
mille fino a due milioni di euro. «Ma questo non significa che non ci siano
nuovi giocatori, semplicemente è in atto un ricambio».Con l’invasione russa è
come se un terremoto avesse colpito la criminalità organizzata: rotte, attività,
rapporti con la Russia, in poche settimane c’è stata una rivoluzione
Secondo le agenzie
governative europee e mondiali, come EMMCDA e UNODC, è troppo presto per
stabilire l’impatto che la guerra sta avendo sul traffico di droga. Ma i segnali
in realtà ci sono. «Da quando è iniziata la guerra a Kiev non si trovano più
facilmente marijuana o droghe leggere», spiega Boris, seduto in un bar della
capitale. Boris è uno studente e vive con i suoi amici alla periferia della
città e sa bene come i prezzi degli stupefacenti possano variare. Per capire
meglio cosa sta succedendo bisogna andare nella capitale per eccellenza della
malavita ucraina, Odessa. Porto più grande dell’Ucraina e del Mar Nero,
inevitabile che la città sia stata Regina anche del contrabbando di droga,
merci, armi, persone. E’ infatti via acqua che fino al 2021 – secondo quanto
conferma UNODC – transitava parte dell’eroina in arrivo dall’Afghanistan e
diretta a Ovest.
«Odessa era uno spin
off della rotta balcanica», si legge nell’ultimo report dell’agenzia. A causa
però del blocco del Mar Nero provocato dalla Russia all’inizio della guerra, il
suo ruolo come principale hub del traffico di droga e di armi in Europa è
notevolmente diminuito. «Le rotte sono state modificate e potrebbero essere
passate alla Moldova e alla Romania», conferma un agente dell’antidroga della
città che chiede di restare anonimo. «Tuttavia, con le rotte commerciali del
grano ora riaperte, Odessa cercherà sicuramente di tornare al suo status di
Regina dei traffici». Troppa posta in gioco in termini di denaro per l’Ucraina.
Ma anche per la Turchia da sempre snodo centrale del commercio di eroina
afghana. «Se Ankara è infatti una dei più accesi e convinti sostenitori del
ripristino del commercio attraverso i porti ucraini del Mar Nero, il grano
probabilmente non è l’unico bene che è interessato a trasportare, vendere e
acquistare», spiega ancora l’agente.«Odessa era uno spin off della rotta
balcanica»
Ad aver guadagnato
terreno nel campo dei traffici in seguito all’invasione russa è sicuramente
Leopoli. Capitale dell’Ovest, da qui transita la maggior parte degli aiuti
umanitari e militari. Sono già numerosi i casi di furto e rivendita di giubbotti
antiproiettile e beni a duplice uso - come i droni. Da Leopoli, queste merci
viaggiano nell’est e nel sud del Paese, di solito attraverso Kiev. Tra le
persone coinvolte, il “re del contrabbando” Ilya Pavlyuk - un uomo d’affari
considerato il leader di un gruppo separato di 15-20 deputati del partito
presidenziale “Servant of the People” nella Verkhovna Rada, la camera alta del
Parlamento ucraina. Un gruppo che vota spesso nell’interesse del più grande
oligarca ucraino Rinat Akhmetov, proprietario tra gli altri della principale
compagnia elettrica del Paese e presidente dello Shaktar Donetsk, una delle più
importanti squadre di calcio ucraine.
Ma l’affare più
grande di Leopoli, al momento, è il traffico di esseri umani, compresi uomini in
fuga nel tentativo di evitare il servizio militare. Si stima che per uscire sia
dal confine con la Polonia che con la Moldavia in media i trafficanti richiedano
tra i 5.000 e gli 8 mila euro. Cifre che però sono aumentate da quando la
polizia ucraina ha arrestato in giugno un gruppo di uomini che gestiva questa
rete di smuggling. Le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite,
avvertono anche di una nuova minaccia per le donne e i bambini che lasciano
l’Ucraina a rischio di diventare vittime della tratta sessuale in Europa in
Medio Oriente. «Ma ancora non ci sono informazioni specifiche sulla
partecipazione della criminalità organizzata in Ucraina a questo ulteriore
traffico», si legge ancora nei report. Un altro capitolo che presto purtroppo
verrà scritto.
Armi: il vero
ruolo dell’Italia.
Francesco Verderami
su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
A ogni decreto del
governo, parte un carico: un pezzo resta top secret. «Facciamo più di quanto
appare», dicono i ministri Guerini e Crosetto
È stato calcolato
che le forniture militari valgono oltre un miliardo.
E c’è una parte
molto preziosa per gli ucraini: il sostegno al sistema satellitare che dà
informazioni sui movimenti delle truppe russe
A ogni decreto, per
sei volte, un generale segue il carico che parte da Pisa.
Può essere chiamato
il Postino. È il capo della logistica.
Ha esperienza in
Kosovo, Bosnia, Afghanistan.
Il suo nome è
Francesco Paolo Figliuolo: era il commissario del Covid
Da un anno il
Postino svolge il suo lavoro senza mai andare nei luoghi di consegna, anche se
quei luoghi li conosce alla perfezione. Segue il tragitto del materiale
dall’aeroporto militare di Pisa fino alla base Nato in Polonia. Da lì alla
frontiera con l’Ucraina. E ancora oltre il confine, nelle zone di guerra
convenute per gli scambi. Finché la missione non è completata.
Dal Comando
operativo del Vertice Interforze, il Postino ha suonato finora sei volte agli
uomini di Volodymyr Zelensky per dotarli delle armi necessarie a contrastare
l’invasore russo. Non prima di aver completato il rito che compie da vent’anni:
l’esame delle dotazioni, le prove per verificare il loro funzionamento, il
carico nelle stive dei B737 Cargo. Ha già operato così in Bosnia, in Kosovo, in
Afghanistan. Non è un mestiere facile: a volte ci sono momenti critici che
restano «top secret». È il lavoro del generale Francesco Paolo Figliuolo,
responsabile per la Logistica, alle dirette dipendenze del Capo di Stato
maggiore della Difesa.
Dal giorno in cui
Vladimir Putin invase l’Ucraina e Mario Draghi disse in Parlamento che «l’Italia
non può voltarsi dall’altra parte», i viaggi verso Kiev si sono susseguiti senza
sosta, assecondando per quanto possibile le richieste di chi combatte per la
libertà. E non solo per la propria Patria. Così il Postino — su mandato del
premier — si è incaricato di consegnare agli ucraini il materiale più disparato:
dalle stufe da campo che non rilasciano fumo, all’equipaggiamento per attacchi
chimici batteriologici e nucleari; dai giubbotti anti-proiettile ai generatori
di energia; dalle tende da campo ai pasti in scatola. Viene garantita anche
l’assistenza sanitaria, con una centrale da remoto del soccorso sanitario che
s’impegna al trasporto dei feriti per tutte le discipline di emergenza medica:
al momento sono quasi 200 i posti letto occupati negli ospedali italiani da
«bisognosi di cure».
E poi c’è il resto
della posta, che è coperto dal «segreto di Stato»: munizioni di vario calibro,
mitragliatrici pesanti, mezzi da trasporto e da combattimento, fino ai sistemi
d’arma più sofisticati- È stato calcolato che in dodici mesi le forniture
militari offerte a Kiev hanno superato il valore del miliardo di euro. È vero
che l’impegno di Washington e Londra è stato di gran lunga maggiore, ma c’è un
motivo se Zelensky è grato per lo sforzo di Roma. «Perché facciamo più di quanto
appare», hanno spiegato in più occasioni Lorenzo Guerini e Guido Crosetto, che
si sono succeduti al ministero della Difesa.
L’occhio dall’alto
Dall’inizio del
conflitto l’Italia offre alle Forze armate ucraine un contributo tanto
importante quanto discreto sul campo da combattimento. Un sistema
satellitare che agisce da una base nel Lazio combina informazioni aeree e di
intelligence, fornendo elementi sulla dislocazione delle truppe russe e sui
movimenti dei loro mezzi. E dopo un esame dei dati, trasmette le coordinate
utili a Kiev per neutralizzarli. Ogni giorno, ad ogni ora, lo Stato maggiore di
Zelensky elabora o modifica i piani militari grazie allo sguardo vigile che
anche l’Italia mette a sua disposizione.
«Facciamo e faremo
ciò che è giusto per il popolo ucraino», ha sottolineato Giorgia Meloni dal
giorno in cui è entrata a palazzo Chigi. La linea di continuità tra l’esecutivo
delle larghe intese e il governo di centro-destra è insomma assicurata. E lo
sforzo che l’Italia sta compiendo è valso il rispetto degli alleati occidentali.
Sul suolo nazionale giungono i reparti scelti di Kiev per i corsi di
addestramento, così come accade negli altri Paesi della Nato. Ognuno mette a
disposizione un «catalogo», come programmi di specializzazione. Gli ucraini
scorrono la lista e scelgono i corsi in base ai sistemi d’arma che dovranno poi
adoperare: sono strumenti sofisticati e non basta apprenderne il funzionamento,
è necessario acquisire dimestichezza e rapidità nell’uso. Gli istruttori
italiani fanno la loro parte e l’insegnamento è molto apprezzato. Ecco cosa vuol
dire che Roma «fa più di quanto appare».
Il Postino intanto
smista il materiale. Ad ogni decreto del governo spedisce munizioni di vario
calibro, mitragliatrici leggere Mg, mortai da 120 millimetri, mezzi da trasporto
e da combattimento, missili terra-aria. L’Esercito sta dando fondo al suo
arsenale: ha donato vecchi blindati Lince ma anche moderni obici semoventi Mlrs
e Pzh2000, esemplari di FH-70 da 155 millimetri, batterie di Aspide e di Astrid,
lanciarazzi Milan, Stinger portatili per la contraerea, elicotteri da trasporto.
Da ultimo, in sinergia con la Francia, ha disposto l’invio del sistema di difesa
Samp-T dotato di una ventina di missili. L’Ucraina ne ha bisogno per difendersi
dagli attacchi di Putin, soprattutto per proteggere le città e i target civili —
dagli ospedali alle centrali elettriche — che non vengono risparmiati dal regime
sanguinario di Mosca.
Un sistema
satellitare che agisce da una base nel Lazio combina informazioni aeree e di
intelligence
Dopo un esame dei
dati, trasmette le coordinate utili a Kiev per neutralizzare le truppe russe
Ogni giorno, ad ogni
ora, lo Stato maggiore di Zelensky elabora o modifica i piani militari grazie ai
dati che l’Italia mette a sua disposizione
Strategia di
logoramento
La nuova offensiva a
Est dimostra — secondo autorevoli fonti della Difesa — che «il fattore tempo non
spaventa i russi», anzi che «questa è la vera sfida portata all’Occidente: loro
vogliono capire quanto siamo disposti a resistere a fianco dell’Ucraina in un
conflitto di attrito». È una guerra di logoramento, che mette alla prova i Paesi
europei alleati di Kiev e stravolge le loro teorie militari. Nessuno prevedeva
di ripiombare nel Novecento e tutti avevano aggiornato i loro modelli per
rispondere a crisi brevi e circoscritte, con piccoli reparti scelti e altamente
tecnologicizzati. Lo scenario odierno, il ritorno alle battaglie di trincea,
impone di rivedere i piani a fronte di risorse limitate.Un esemplare del sistema
missilistico di difesa Samp-T
Le scorte sono
ridotte e il governo italiano — al pari degli altri nel Vecchio Continente —
cerca una soluzione rapida, per evitare il rischio di non avere più armi da
consegnare agli ucraini, siccome una «riserva» va sempre mantenuta per difendere
il suolo nazionale. L’Aeronautica e la Marina militare dispongono di velivoli e
navi all’avanguardia, al contrario delle dotazioni dell’Esercito, praticamente
privo di carri armati. È una questione che è stata affrontata ai più alti
livelli dello Stato maggiore, ce n’è traccia nelle riunioni del Consiglio
supremo di Difesa. E anche in quelle dell’Unione Europea.
Appena iniziata
l’invasione dell’Ucraina, Bruxelles aveva preso ad utilizzare il fondo Epf, lo
strumento finanziario con cui vengono compensati i Paesi che forniscono armi a
Kiev: dopo un anno il fondo, dotato di sette miliardi fuori bilancio, è quasi a
secco e andrà rifinanziato. L’all-in di Putin nasce dalla convinzione che prima
o poi l’Occidente desisterà. L’invio dei tank a Zelensky da parte degli
americani e dei tedeschi fa capire che non sarà così«E l’Italia continuerà a
fianco degli alleati», assicura Crosetto. Raccontano che al dicastero della
Difesa giungano con cadenza regolare richieste di assistenza da parte degli
ucraini, «a volte per aumentare le dotazioni e a volte per cambiare la scelta
gli armamenti». Ogni volta il ministro dispone e il Postino si attiva.
Va così da quel
tragico 24 febbraio del 2022, e andrà così a lungo visto che «al momento non c’è
nessun indicatore di pace». Lo si capisce anche dalle attività di aereo-policy
delle pattuglie italiane, impegnate nelle zone di confine Nato in prossimità con
l’Ucraina. In questo periodo si sono accentuati gli «scramble», cioè le
intercettazioni a difesa dello spazio aereo di velivoli russi, che mirano così a
saggiare i tempi di reazione delle squadriglie dell’Alleanza Atlantica: fianco a
fianco, con le ali a pochi metri di distanza l’una dall’altra, sono divisi da
una linea immaginaria che segna il limite tra una postura aggressiva e un
ingaggio vero e proprio. Con tutto quello che potrebbe provocare uno
sconfinamento. Sono storie quotidiane descritte nei report riservati a
disposizione solo dei comandi militari. Sono la prova di un conflitto senza
immagini ma non per questo meno drammatico dei bombardamenti trasmessi in
diretta tv. È la faccia nascosta della guerra in cui l’Italia è coinvolta anche
se non formalmente. Ma gli aiuti all’Ucraina decisi con il sostegno del
Parlamento testimoniano quale sia la realtà delle cose e quanto sia alta la
posta. In gioco ci sono la democrazia e la libertà: valori inalienabili. È in
nome di questi valori che il governo ha appena firmato il sesto decreto. Nemmeno
il tempo di avvisare il Postino, che è squillato di nuovo il telefono del
ministro della Difesa. Da Kiev hanno chiesto di approntare un altro decreto...Il
ministro della Difesa Guido Crosetto a un vertice Nato a Bruxelles il 14
febbraio (Afp)
(ANSA il 24 marzo
2023) - L'Onu ha accusato le forze ucraine e quelle russe di aver eseguito
decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante l'invasione russa
dell'Ucraina.
"Siamo
profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra
russi e di persone fuori combattimento" e per quella di "15 prigionieri di
guerra ucraini", ha affermato Matilda Bogner, capo della missione di
monitoraggio dei diritti umani.
Secondo Bogner,
l'Onu ha documentato queste esecuzioni di russi da parte delle forze armate
ucraine, "spesso" effettuate "immediatamente dopo la cattura sul campo di
battaglia".
Il presidente
russo Putin può essere processato per il conflitto in Ucraina? Marilisa
Palumbo su il Corriere della Sera il 21 febbraio 2023
Cresce il consenso
internazionale per un tribunale speciale che giudichi il crimine di aggressione
da parte del presidente russo. Philippe Sands, il giurista che un anno fa lanciò
l’idea, spiega come potrebbe essere messa in piedi questa corte ad hoc
«A quasi un anno di
distanza, la domanda non è più se ci sarà un tribunale speciale per il crimine
di aggressione commesso da Putin. La questione è solo come sarà». Il 28 febbraio
2022 Philippe Sands, professore di diritto internazionale all’University College
di Londra, scrisse un intervento sul Financial Times per promuovere l’idea che
alle indagini sui crimini di guerra della Corte penale internazionale si
affiancasse un organo ad hoc per giudicare l’atto di aggressione, definito dalla
carta dell’Onu come «l’invasione o l’attacco da parte delle Forze armate di uno
Stato sul territorio di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare»: il
«crimine internazionale supremo», quello dal quale scaturiscono tutti gli altri.
E anche quello più semplice da attribuire a chi le guerre le decide, in questo
caso Putin, che invece sarebbe più difficile da processare per crimini di
guerra: bisognerebbe in quel caso provare che il singolo soldato o l’unità che
ha commesso le atrocità — pensiamo a Bucha — ne abbia ricevuto l’ordine
direttamente dal Cremlino.
I grandi aderiscono
Ad aprile, quando il
Corriere lo intervistò, Sands raccontò dei primi passi di una campagna che non
immaginava sarebbe arrivata così lontano. I primi a contattarlo furono l’ex
premier britannico Gordon Brown e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro
Kuleba. «Con Brown — racconta oggi Sands — formammo una mini coalizione, dai
Baltici alla Polonia. Ma ci serviva che si esponesse un Paese più grande. Lo ha
fatto la Francia. Poi la Germania, poi il Regno Unito, ora anche gli Usa».
La prudenza italiana
A inizio febbraio,
durante una conferenza stampa congiunta con Zelensky, la presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione all’Aia di
un centro internazionale per le indagini sul crimine di aggressione in Ucraina,
che raccoglierà prove per un potenziale futuro processo. L’Olanda si è detta
pronta a ospitare il nuovo tribunale. Quanto all’Italia, il ministro degli
Esteri Antonio Tajani ha detto di recente che Roma «non è contraria alla
proposta di un tribunale ad hoc, ma comunque c’è già l’Aia. Vedremo quello che
accadrà».
Le resistenze
La Corte penale
internazionale (Cpi), subito coinvolta nell’indagine sui crimini di guerra in
Ucraina, non può però perseguire l’atto di aggressione, a meno che non vi sia
deferita dal Consiglio di sicurezza, bloccato dal veto russo. E l’emendamento di
Kampala, che nel 2010 aggiunse il crimine di aggressione al Trattato di Roma
istitutivo della Corte, è stato ratificato solo da 44 dei 123 Paesi dello
Statuto. Nonostante questo Karim Khan, attuale procuratore della Corte, è stato
duro sulla creazione di un tribunale ad hoc, sostenendo che delegittimerebbe la
Cpi e le sottrarrebbe risorse.
Il doppio standard
Anche Emma Bonino,
che fu tra le protagoniste della stesura del Trattato e della campagna
forsennata per la ratifica – «Ci dicevano che era impossibile, che non ce
l’avremmo mai fatta», ricorda – si innervosisce a sentire parlare di un
tribunale ad hoc, e non solo per ragioni personali. «Modifichiamo piuttosto lo
statuto della Corte penale internazionale», dice, e solleva un’obiezione
condivisa da molti: «Allora lo sforzo fu quello di stabilire una corte che non
avesse una venatura ultra politica perché decisa dal Consiglio di sicurezza, ora
perché tornare indietro?». Il timore è insomma quello di un tribunale troppo
«eurocentrico», con gli Stati Uniti che la appoggiano mentre non hanno mai
ratificato la Corte penale internazionale.
Putin e la guerra
esistenziale dalla quale dipende il destino dell’intera Russia: il significato
del discorso dello zar
«Condivido questa
preoccupazione – ammette Sands – ma serve anche realismo, la consapevolezza di
non avere sostegno da parte del “Sud globale”, dall’Africa, dall’Asia, dal Sud
America. E allora cosa si fa? Nulla? Sono sempre dell’idea che il meglio sia
nemico del bene, ma non è che non veda l’elefante nella stanza». Quell’elefante
si chiama Iraq, la cui invasione da parte della coalizione guidata dagli Usa,
senza l’avallo delle Nazioni Unite, si avvicina al ventennale. «Quella in Iraq è
stata una guerra palesemente illegale. E capisco che irriti i miei amici in
Africa e Sudamerica il doppio standard di Gran Bretagna e Stati Uniti che fanno
dichiarazioni sull’illegalità di altre guerre. Quindi Emma ha ragione, ma non
c’è via di uscita, questa è la situazione che abbiamo davanti».
I valori di
Norimberga
Ma quali sono le
opzioni concrete sul tavolo per la costruzione di un tribunale ad hoc? «La prima
è un tribunale internazionale a tutti gli effetti, creato con un trattato tra
l’Ucraina e le Nazioni Unite o l’Ucraina e l’Unione Europea, da un lato, e
dall’altro, quello che viene chiamato un tribunale ibrido o tribunale
internazionalizzato, creato cioè attraverso l’internazionalizzazione del sistema
giuridico ucraino. La seconda è l’opzione più semplice, ma la mia preferenza va
a un vero tribunale internazionale». Un accordo con il consiglio di sicurezza
dell’Onu è impossibile a causa del veto russo, allora, spiega Sands, «si può
provare passando attraverso l’assemblea generale, ma anche lì non è detto che ci
sia il sostegno necessario». L’accordo solo con l’Unione europea (secondo il
modello del Kosovo), o con un gruppo di Stati individuali, faciliterebbe il
percorso ma aumenterebbe i problemi di legittimità del tribunale. «Anche solo
una iniziativa europea però — fa notare Sands — sarebbe un modo per segnalare il
sostegno ai valori del 1945 e di Norimberga: non c’è più stato un tribunale per
il crimine di aggressione da allora». Anche quella fu una corte dei vincitori,
ma grazie alla qualità del suo lavoro contribuì alla costituzione di un
meccanismo per la responsabilità penale internazionale.
La domanda è semmai
come si può, senza un regime change a Mosca, processare Putin. «La common law
del diritto britannico (e anche la Corte penale internazionale, ndr) non prevede
processi in absentia, al contrario di molti ordinamenti in Europa, e io
personalmente sarei sfavorevole», dice Sands, che però non ritiene questo un
motivo per arrendersi: «Queste cose richiedono tempo. Quando il tribunale per la
Jugoslavia fu creato nessuno pensava che avrebbero messo le mani su Milosevic,
ma alla fine successe, e quando i leader dell’Europa occupata si riunirono a
Londra nel gennaio 1942 nessuno pensava che i nazisti sarebbero davvero stati
portati alla sbarra». Sands si riferisce alla dichiarazione di Saint James, alla
quale lavorò anche Hersch Lauterpacht, giurista di Leopoli la cui storia
(assieme a quella del conterraneo Raphael Lemkin) il professore racconta nel
suo La strada verso Est (Guanda).
Il nodo
dell’immunità
C’è poi un altro
nodo, quello dell’immunità dei capi di Stato. «Quando si parla dei cosiddetti
crimini internazionali, i crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio, non
c’è immunità per i capi di Stato, per l’aggressione non è chiaro. Ma c’è una
norma di diritto internazionale consuetudinario secondo la quale questa immunità
non esiste», spiega una fonte che ha lavorato dentro diverse corte
internazionali.
L’incriminazione
Una cosa è certa:
intanto la sola incriminazione costituirebbe un duro colpo per lo zar e il suo
cerchio magico. Nel giro di meno di un anno, ha scritto Gordon Brown i pubblici
ministeri di questo tribunale «potrebbero procedere a incriminazioni in
contumacia. Ciò garantirebbe la fine della capacità dei funzionari russi di
viaggiare all’estero senza temere l’arresto, riducendo probabilmente la cerchia
di sicofanti di Putin. Potrebbe anche creare un incentivo per i consiglieri più
stretti di Putin ad abbandonarlo».
Violenze, che
cosa sappiamo degli stupri? Giusi
Fasano su il Corriere della Sera il 13 febbraio 2023
Con il passare dei
mesi, nei luoghi liberati dall’occupazione dell’armata russa si moltiplicano le
testimonianze. E il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino
denuncia abusi su bambini rapiti per video pedofili
Dalla chat via
whatsapp si capisce che è un bambino piccolo. «Viene da un orfanotrofio
dell’Ucraina e non ha parenti», scrive uno degli interlocutori. «Hanno ordinato
una serie di video con lui», aggiunge. L’età è sconosciuta ma ci sono indizi in
alcuni messaggi: dovrebbe «cominciare la scuola fra poco», oppure: «Non è il
primo, stiamo coinvolgendo dei piccoli per questo tipo di lavori».
«Questo tipo di
lavori», cioè abusi sessuali secondo Dmytro Lubinets, difensore civico e
commissario per i diritti umani del parlamento ucraino.
È stato lui a
rendere pubblici nei giorni scorsi questi dettagli, estratti da una
conversazione - via whatsapp, appunto - fra due russi. Non ha voluto rivelare
come l’ha ottenuta ma si è rivolto alla polizia e alla procura perché
prendessero «misure appropriate per trovare e punire i colpevoli». E ha scritto
un post per dire di aver appreso «dai canali di Telegram che i russi rapiscono
bambini ucraini per realizzare video di sesso con loro». Di più. Ha parlato di
prezzi spiegando che per quei video c’è chi «arriva ad offrire 250 mila rubli»,
più di 3200 euro. Impossibile descrivere quel che ha provato, dice. E conclude:
«La Federazione Russa rapisce, uccide, deporta e violenta insidiosamente i
nostri bambini. Com’è possibile nel mondo di oggi?!».
Tutto questo (che si
spera sia argomento d’inchiesta) è soltanto il più recente dei capitoli scritti
sul tema della violenza sessuale nell’Ucraina in guerra. Ma di stupri - e più
precisamente di stupri come arma di guerra - si è cominciato a parlare già un
mese dopo l’inizio del conflitto. A fine marzo, con la ritirata russa dalla
regione di Kiev e dopo il massacro di Bucha, le associazioni umanitarie hanno
cominciato a raccogliere testimonianze su quel che i soldati russi si erano
lasciati alle spalle. Testimonianze rare, perché è già difficile a prescindere
da tutto, ma se sei in guerra e sei sopravvissuta a uno stupro è molto più
probabile che il primo desiderio sia fuggire dalle bombe e da tutto il resto
piuttosto che correre a denunciare quel che ti hanno fatto.
La narrazione di una
violenza, a te stessa e agli altri, ha bisogno del suo tempo. E infatti con il
passare dei mesi sempre più donne hanno deciso di uscire dal silenzio; hanno
descritto non soldati ma bande di violentatori, assalti sessuali e violenze
assortite, spesso di fronte ai mariti poi uccisi o ai bambini.
I dati ufficiali più
recenti disponibili sul binomio guerra- violenza sessuale vengono dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani: a inizio dicembre del
2022 aveva documentato 86 casi di abusi sessuali di vario genere, in grandissima
parte commesse da uomini dell’armata russa. Sempre a fine 2022 le forze
dell’ordine ucraine avevano elementi sufficienti per indagare su altri 43 casi.
Numeri parziali, che
riguardano soltanto le storie arrivate all’apertura formale di un fascicolo. Le
segnalazioni sarebbero però molte di più e le vittime - secondo la Commissione
d’inchiesta internazionale indipendente sull’Ucraina - hanno fra 4 agli 80 anni.
Dieci mesi dopo
l’inizio del conflitto il procuratore generale di Kiev, Andriy Kostin, ha
parlato di un «drastico aumento» degli stupri come arma di guerra e ne ha fatto
cenno di recente anche la stessa first lady, Olena Zelenska: serve una «risposta
globale» contro questi crimini, ha detto. Il mondo dovrebbe raccogliere il suo
appello, in nome delle donne e dei bambini che portano addosso le ferite,
visibili e non, di una violenza.
Putin può cadere?
E la Russia può sgretolarsi?
Paolo Valentino su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
La possibilità di
una storica sconfitta per il Cremlino, lascia aperti molti scenari, anche quello
dello sgretolamento della nazione. Giocano a sfavore la mancanza di
un’alternativa allo zar e le tensioni con le etnie che stanno dando «carne da
cannone» al conflitto
Nel lanciare un anno
fa la sua sciagurata «Operazione Speciale» contro l’Ucraina, Vladimir Putin ha
sostanzialmente commesso tre cruciali errori di valutazione: si è illuso sulla
forza militare della Russia, ha sottovalutato la determinazione e la capacità di
resistenza del popolo ucraino, non ha previsto l’unità e la tenuta
dell’Occidente nel sostenere Kiev e imporre sanzioni contundenti contro Mosca.
Dodici mesi dopo,
nessuno degli obiettivi che lo Zar si era prefissato è stato raggiunto. Anzi,
dopo i primi successi, pagati a caro prezzo in termini di vite umane e risorse
militari, la Russia ha subito perdite devastanti, è stata costretta a ritirarsi
da buona parte del territorio guadagnato nei primi mesi di guerra e si è vista
costretta in una guerra di logoramento, il cui esito rimane aperto perfino a una
sconfitta definitiva.
Il potere dello Zar
appare ancora saldo. Putin ha rafforzato la verticale del potere, completato la
trasformazione totalitaria e neostalinista del sistema russo, intensificato la
repressione, chiuso il Paese al mondo esterno come ai tempi dell’Urss e avviato
la riconversione verso un’economia di guerra autarchica, dove l’intera società è
subordinata ai bisogni del complesso militare. Di più, la distribuzione del
potere all’interno del Cremlino è tale da escludere alcuna alternativa valida a
Putin. Priva di una linea di successione o di un delfino designato, concepita in
modo da incoraggiare il conflitto tra le diverse cricche, è stato lui stesso a
volerla così, nel segno di una logica imperiale in tutto e per tutto tranne che
nel titolo formale.
Eppure, il destino
di Putin non è scritto nel marmo. L’incerto finale della partita ucraina, con la
possibilità di una storica sconfitta per il Cremlino, lascia infatti aperti
molti scenari, alcuni dei quali considerati estremi ma non per questo
impossibili o relegabili nel novero delle pure speculazioni. Non solo. Perché il
futuro personale dello Zar si intreccia in modo indissolubile a quello della
Russia in quanto Stato, che lui ha costruito a propria immagine. Domandarsi
quindi se Putin possa cadere e se la Federazione Russa sia a rischio di
collasso, non è soltanto un esercizio intellettuale o arbitrario.La Russia
frammentata metterebbe a rischio la sicurezza globale per le armi nucleari
sparse in tutto il territorio
A renderlo
plausibile è in primo luogo la Storia, che non si ripete, ma spesso fa rima. E
quella della Russia è costellata di sconfitte in guerra che hanno condotto a
un’implosione del regime: successe nel 1598 al Regno di Moscovia dopo la
sconfitta contro la Svezia nella Prima Guerra del Nord. Successe di nuovo nel
1917 quando il tracollo delle forze russe nella I Guerra Mondiale innescò la
Rivoluzione bolscevica, la guerra civile e la fine del secolare impero zarista.
E più di recente, successe nel 1991, con il collasso dell’Unione Sovietica
seguito alla sconfitta nella Guerra Fredda. E se poi non vogliamo limitarci
soltanto alla Russia, è utile ricordare che nel 1918, altri tre grandi imperi —
Ottomano, Austro-Ungarico e Reich guglielmino tedesco — non sopravvissero alla
sconfitta militare.
Ma nel caso della
Russia, a renderne dubbia la sopravvivenza nel caso di una sconfitta in Ucraina
ci sono altre due buone ragioni. La prima è la stessa che oggi rende saldo il
potere di Putin, cioè la mancanza di alternative: se Putin uscisse di scena, in
seguito a una congiura di palazzo o magari con un colpo a sorpresa sotto la sua
regia alla vigilia delle elezioni del 2024 cercando di guidare la propria
successione, è infatti più probabile che si scateni una feroce lotta di potere
tra gli ultranazionalisti che vogliono continuare lo sforzo di guerra e
distruggere l’attuale gerarchia e la fazione autoritaria, disposta a finire la
guerra pur di salvare il regime e i propri privilegi. Come sempre nelle vicende
russe, un fattore importante in questa equazione è l’incerta salute dello Zar,
che ne mina il culto della personalità e l’immagine macho, ormai un lontano
ricordo. Un Putin indebolito dalla malattia potrebbe essere costretto a cedere
lo scettro.
La seconda ragione
sono le tensioni etniche, che la guerra in Ucraina ha esacerbato. Sono state
finora le minoranze povere cecene, daghestane, ingusce e così via a pagare il
più alto tributo di sangue delle perdite militari di Mosca. Anche la
mobilitazione di 300 mila nuovi coscritti è stata fatta lungo linee etniche, per
tenere il più possibile fuori i giovani di Mosca e San Pietroburgo dove la
guerra deve rimanere un fenomeno astratto e lontano. Detto altrimenti, le etnie
non russe sono state usate come carne da cannone. E questo ha fatto crescere in
periferia risentimento e rabbia verso il centro, creando un potenziale esplosivo
di rivolte ed eventuali secessioni.
Lo scenario di un
collasso innescato dalle tensioni etniche evoca quello che portò alla
dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando furono le proclamazioni
d’indipendenza delle varie Repubbliche (i Baltici, l’Ucraina, la Bielorussia,
l’Asia centrale sovietica) a mostrare nudo il potere moscovita e condannare
Gorbaciov all’impotenza. In questo caso, il centro di gravità potrebbe essere il
Caucaso del Nord. In Cecenia, il sanguinario Ramzan Khadyrov potrebbe
approfittare dell’uscita di scena di Putin, che finora ha sostenuto, per
rilanciare la battaglia per una totale indipendenza da Mosca, dopo quelle
represse nel sangue del 1994-96 e del 1999-2009. Intanto è già in piena
fibrillazione il Daghestan, dove le manifestazioni contro la campagna di
mobilitazione del Cremlino hanno prodotto scontri violenti con la polizia. Altri
candidati potenziali alla secessione sono Tatarstan, Inguscezia e Bashkortostan,
che potrebbero cercare di avvicinarsi a Turchia e Kazakhstan. Nell’estremo
oriente della Federazione, potrebbero seguire Sakhalin, Primorskiy , Khabarovsk,
Kamchatka e Jacuzia, grandi depositi di petrolio, gas naturale, diamanti e oro.
Nelle attuali
condizioni, una sconfitta in Ucraina potrebbe fare da detonatore. Non è scontato
naturalmente. Un osservatore autorevole come l’ex premier svedese Carl Bildt
ritiene improbabile lo scenario di una dissoluzione ed è convinto che «le élite
russe stiano già discretamente sondando le possibilità offerte dal dopo-Putin».
Per Bildt il collasso della Russia non è negli obiettivi dell’Occidente, che
tuttavia dovrebbe lavorare e cercare modi «per creare condizioni e incentivi che
facciano emergere e prevalere forze più democratiche».
Ma se così non
fosse? Se invece l’implosione della Federazione russa prendesse rapidamente il
volo, in che modo avverrebbe? Sarebbe relativamente pacifica, come successe nel
caso dell’Unione Sovietica? Ovvero sarebbe destabilizzante e violenta, compreso
il rischio di una guerra civile?
Henry Kissinger è
convinto di questa seconda ipotesi: «La dissoluzione della Russia o la
distruzione della sua capacità di fare politica strategica ne trasformerebbe il
territorio, che si estende per 11 fusi orari, in uno spazio contestato», dice
l’ex segretario di Stato americano. Gruppi russi potrebbero dar vita a una lotta
violenta e senza esclusione di colpi, mentre potenze esterne potrebbero usare la
forza per raggiungere i propri obiettivi: «Tutti questi pericoli — continua
Kissinger — sarebbero amplificati dalla presenza di migliaia di armi nucleari».
Ecco perché il vecchio statista, profeta della Realpolitik, consiglia
all’Occidente come migliore linea d’azione di «non rendere impotente la Russia
attraverso la guerra» e invece di «includerla in un processo di pace», i cui
dettagli e la cui applicabilità al momento rimangono però ancora nebulosi. Ancor
più pessimista è la storica Marlene Laruelle, direttrice dell’Istituto per gli
studi europei, eurasiatici e russi della George Washington University, secondo
la quale un collasso della Russia «produrrebbe diverse guerre civili, con
piccoli staterelli in guerra fra di loro per i confini e le risorse economiche»
e un centro moscovita che «reagirebbe con violenza a ogni secessione».
Anche senza scenari
così estremi, una Russia frammentata metterebbe però a rischio la sicurezza
regionale e globale. Poiché, a differenza di quanto avvenne nel 1991 con l’Urss,
quando tre dei quattro nuovi Stati che possedevano armi nucleari (Bielorussia,
Kazakhstan e in modo più riluttante Ucraina) accettarono di cederle alla Russia
e metterle in sicurezza grazie all’aiuto degli americani, oggi anche una
secessione localizzata creerebbe una o più entità statali pronte a rivendicare
il diritto di tenersi le armi nucleari presenti sul loro territorio.
L’ipotesi più
realistica e verosimile è comunque la sopravvivenza del regime. Con o senza
Putin, probabilmente sarà ancora una Russia autoritaria, repressiva,
militarizzata e chiusa verso l’esterno. Il corollario è che, quando arriverà, la
fine della guerra in Ucraina assomiglierebbe tanto a quella della Guerra di
Corea: un armistizio senza pace, con l’Ucraina che grazie agli aiuti per la
ricostruzione potrebbe seguire lo stesso percorso della Corea del Sud,
integrandosi nella comunità occidentale via l’adesione all’Ue e alla Nato.
Mentre la Russia diventerebbe una gigantesca Corea del Nord, armi nucleari,
economia decrepita e pochi amici nel mondo, di fatto un protettorato cinese. Ma
anche in questo scenario, il Cremlino dovrebbe misurarsi con problemi drammatici
ed eccezionali: il ritorno a casa delle truppe, le tensioni etniche, la
ricostruzione economica in condizioni di autarchia e di introiti ridotti dalle
esportazioni di materie prime, non ultima l’ennesima umiliazione agli occhi del
mondo. Ci vorranno decenni, ammesso che ci riesca, perché la Russia appaia di
nuovo un Paese quasi normale. Nel frattempo, la sua stessa esistenza rimarrà
ancora precaria.
Biden promosso
sul campo?
Massimo Gaggi su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Il confronto con
Putin e la difesa dell’Ucraina sono il suo chiodo fisso sin dall’annessione
della Crimea nel 2014. Ora il presidente Usa dimostra di saper tenere la barra
dritta nel sostegno militare ed economico, nel rapporto con l’Europa, nel
contrastare i trumpiani
Un impegno
quotidiano, continuo. Decisioni angosciose da prendere cercando di astrarsi
dalle feroci battaglie della politica interna Usa. Rischi da calcolare e
ricalcolare di continuo. E, di continuo, anche sfilacciature dell’Alleanza
atlantica da ricucire. Questo è stato, per Joe Biden, un anno di guerra
combattuta nel cuore dell’Europa ma con un sostegno politico, militare ed
economico ricaduto in gran parte sulle spalle degli Stati Uniti. I conservatori
della Heritage Foundation che lo accusano di aver fatto troppo, pur riconoscendo
che l’Ucraina va aiutata almeno militarmente, sostengono che è ora di frenare
perché al contribuente americano il conflitto ucraino sta costando quasi cento
miliardi di dollari divisi, in parti quasi uguali, tra forniture di armi e aiuti
economici.
Per il presidente
Usa, quello con Putin è uno scontro micidiale, con conseguenze potenzialmente
devastanti che vanno ben oltre i confini ucraini, ma è anche una sfida che
esalta le doti politiche di un leader che, nella sua carriera cinquantennale, ha
sempre messo le relazioni internazionali in cima alla sua agenda. E proprio il
confronto con Putin e la difesa dell’indipendenza dell’Ucraina sono stati il suo
chiodo fisso, almeno dal 2014. Quando Mosca decise l’annessione della Crimea e
lanciò l’offensiva nel Donbass, Biden chiese a Barack Obama, del quale allora
era il vice, di far «pagare cara ai russi col sangue e col denaro»
quell’invasione.
Quando salvò il
salvabile
L’allora presidente
scelse di non intervenire in modo muscolare e mandò Biden a Kiev per salvare il
salvabile: riorganizzare il governo ucraino e ripulirlo dalla corruzione
dilagante. Costretto a essere l’interprete di una strategia prudente, da allora
Biden divenne, comunque, il paladino dell’Ucraina dove, racconta nelle sue
memorie, è stato otto volte «per cercare di impedire a Putin di divorare
l’intero Paese». A Kiev, oltre a un governo inefficiente e corrotto, trovò anche
un esercito con appena 8mila soldati pronti a combattere. Cominciò allora — non
alla vigilia dell’invasione del 24 febbraio 2022 — la sua battaglia per la
difesa di un Paese che considerava essenziale per contenere le ambizioni
imperiali del dittatore del Cremlino. Una battaglia per la libertà e la
democrazia che, costringendolo a entrare nei meandri della politica ucraina, lo
ha poi esposto agli attacchi politici di Trump, soprattutto per via degli affari
che suo figlio Hunter ha gestito in quel Paese.
Il film del
conflitto è, ormai, nella nostra memoria: l’intelligence americana che
intercetta con largo anticipo i preparativi russi dell’invasione, la scelta di
Biden di violare l’abituale segretezza dello spionaggio per mostrare a tutti
quello che sta avvenendo e ammonire Putin. Poi l’attacco e i servizi segreti
che, dopo l’iniziale successo, sbagliano le previsioni: i russi non riescono ad
arrivare a Kiev e Zelensky non fugge per creare un governo in esilio. L’Ucraina
resiste e contrattacca, grazie al sostegno militare degli Usa e della Nato che
Biden mobilita subito.
L’esercito ucraino
resiste ed evita l’accerchiamento, nonostante la sua inferiorità numerica e di
armamenti, anche grazie ad anni di riorganizzazione, rinnovamento tecnologico e
addestramento condotto con l’aiuto Usa. Poi inizia l’invio di un flusso
crescente di armi: prima i razzi anticarro coi quali piccole pattuglie
distruggono i tank russi. Insieme a 850 lanciatori dei Javelin e a 1500 razzi
Tow, arrivano 1600 Stinger, usati anche per abbattere elicotteri e droni. Poi,
quando l’offensiva viene bloccata e inizia una guerra di logoramento, di
trincea, arrivano i pezzi di artiglieria pesante: gli Howitzer da 155 mm e gli
Himars coi loro proiettili «intelligenti».
Un processo
complicato, laborioso, nel quale Biden deve mostrare polso fermo con gli
alleati, sollecitando quelli troppo prudenti e frenando chi, come la Polonia,
vorrebbe interventi più muscolari che rischiano di scatenare una reazione
sproporzionata della Russia: pur sempre una potenza nucleare con un arsenale
sterminato. È un gioco di equilibri complesso nel quale Biden cerca di spingere
Putin a ritirarsi dall’Ucraina, non solo con le armi ma anche con sanzioni
economiche stringenti che dovrebbero mettere alle corde l’economia russa. Al
tempo stesso, è chiamato a sostenere gli alleati europei, alle prese anche loro
con grossi problemi economici, prima per la moltiplicazione del prezzo del gas,
poi per l’interruzione delle forniture di quello russo.
Tutto molto faticoso
anche qui: con la tecnologia del fracking gli Usa hanno raggiunto l’indipendenza
energetica e potrebbero esportare molto gas, ma le promesse fatte a suo tempo da
Obama agli alleati sono rimaste tali. Una cosa sono gli interessi geopolitici,
altra cosa i vincoli di mercato: estrarre, liquefare, trasportare per nave e
rigassificare costa molto e nessuno ha pensato di agevolare questi processi fino
a quando non è partito l’attacco russo. Con Putin convinto di poter ricattare
l’Europa chiudendo i rubinetti dei suoi gasdotti.
Mesi di negoziati
difficili, momenti di crisi tra gli alleati, ma Biden tiene duro e alza il tono
dello scontro col Cremlino a livelli che lasciano attoniti molti: a marzo, un
mese dopo l’inizio dell’invasione, va a Bruxelles, sede dell’Unione europea e
della Nato, e in Polonia, per mostrare con la sua presenza fisica l’impegno a
sostenere fino in fondo l’Ucraina. E in un discorso arriva a dire che Putin non
può più restare alla guida della Russia. Fa scalpore, anche perché gli Usa
affermano di non puntare a un regime change.Stretta di mano tra Biden e il
presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro a margine del vertice del G20 di
Bali, il 14 novembre 2022 (Foto SAUL LOEB / AFP)
Biden ha esagerato,
trascinato dalla sua veemenza. Ma non fa marcia indietro: sa che con Putin il
problema non è quello di moderare i toni ma, semmai, di non superare certe linee
rosse sul campo di battaglia. Per questo evita di fornire a Zelensky missili a
lungo raggio e aerei da caccia coi quali potrebbe portare i suoi attacchi in
profondità nel territorio russo. Ma con Putin va giù duro: lo definisce un
killer e torna a raccontare che in un incontro faccia a faccia di molti anni
prima disse al presidente russo: «Ti guardo negli occhi e penso che non hai
un’anima». Biden sostiene che il leader del Cremlino rispose: «Vedo che ci
capiamo». I due si capiscono davvero: sono tutti e due figli della Guerra
Fredda.
Mese dopo mese, lo
scontro è diventato guerra di logoramento con Mosca che, dopo sconfitte e
umiliazioni, ha riorganizzato le sue forze e prepara nuovi attacchi, mentre i
dati del Pil russo indicano che le sanzioni sono state meno efficaci del
previsto: molti Paesi continuano a commerciare col gigante euroasiatico mentre
la Cina, se non ha dato armi a Putin, gli ha comunque fornito tecnologie civili
e a uso militare molto avanzate.
A questa maggiore
complessità del quadro internazionale si aggiungono le difficoltà interne di
Biden. Storicamente, i repubblicani Usa hanno perseguito il contenimento della
Russia ancor più dei democratici. Ma con Donald Trump, ammiratore di Putin
quando era alla Casa Bianca, molte cose sono cambiate. A dicembre Biden ha fatto
inserire un maxipacchetto di aiuti all’Ucraina da 46 miliardi di dollari
nell’ultimo provvedimento omnibus della legislatura a maggioranza democratica:
temeva che la Camera a guida repubblicana che si è insediata a gennaio freni sul
sostegno a Zelensky. E i trumpiani, in effetti, hanno già cominciato a proporre
di rivedere la materia, chiedendo agli europei di fare di più.
Qualche settimana fa
un quotidiano svizzero ha scritto che il capo della Cia, William Burns, avrebbe
fatto di recente un viaggio segreto a Mosca per sondare la disponibilità del
Cremlino a una fine delle ostilità in cambio della cessione alla Russia di un
quinto del territorio ucraino. Tutto smentito seccamente, tanto dal governo di
Washington quanto dai russi. Ma la rapidità con la quale questa voce si è
diffusa dà l’idea dello stallo di ogni ricerca di soluzioni diplomatiche, mentre
Mosca prepara la controffensiva, con Putin convinto che il fattore tempo sia
dalla sua parte: le democrazie europee alla lunga faranno fatica ad assorbire le
difficoltà economiche e il malumore popolare per i problemi creati da un
conflitto scoppiato nel mezzo del Vecchio continente.
L’arma
dell’esperienza
In queste acque
tempestose Biden cerca di tenere la barra dritta: da un lato continua a dare un
sostegno militare tarato sull’evoluzione del conflitto, anche a costo di mettere
a tacere il Pentagono, contrario all’invio dei tank M1 Abrams, quando si rende
conto che questo è l’unico modo per convincere il cancelliere tedesco, Olaf
Scholz, a inviare in Ucraina i suoi Leopard 2. Dall’altro, il vecchio leader
democratico cerca di proiettare anche fuori dall’America quell’immagine di adult
in the room che, in politica interna, gli serve per marcare la distanza tra la
sua competenza e prudenza e il movimentismo della destra radicale: un presidente
«stagionato» ma che conosce bene i suoi avversari e sa come tenere testa a un
Putin comunque in grande difficoltà da quando è fallita la strategia della
guerra-lampo e un Xi Jinping che ha gestito in modo disastroso la pandemia e ora
deve affrontare il malessere di cittadini che, infuriati per i lunghi e ferrei
lockdown, stanno scoprendo con costernazione che l’era della crescita economica
continua forse è finita.
Zelensky è ancora
un eroe senza macchia?
Francesco Battistini su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Prima della guerra
era precipitato nei sondaggi del suo Paese, oggi è un imperatore del popolo col
94% dei consensi. Ma l’ostinazione contro qualsiasi compromesso e l’attivismo
mediatico creano ora anche imbarazzi nel mondo che lo sostiene
Etiopia, qualche
mese fa. Scava che ti scava, il paleontologo americano William Ausich trova
finalmente il fossile marino che cercava da una vita: una rarissima stella
piumata del Giurassico Superiore, un invertebrato di 150 milioni d’anni fa. Lo
raccoglie, lo pulisce, lo fotografa, lo studia. E alla fine annuncia al mondo:
si chiamerà Ausichicrinites Zelensky. Come il presidente ucraino. Perché questa
specie di stella marina, spuntata nel deserto del Tigrai, è famosa per la sua
capacità di perdere un braccio e di rigenerarlo dal nulla. E perché Zelensky,
spiega, è proprio così: ostinato nel riprendersi le terre perdute, col «coraggio
di difendere un’Ucraina libera».
A Star is Born. Da
«Ballando con le Stelle» a stella fissa nel De Bello Ucraino. Da Servitore del
Popolo a eroe pop. Presidente venuto dal cabaret, protagonista della tragedia.
Quando Vladimir Putin l’invase, sicuro d’eliminarlo, il sesto capo dell’Ucraina
indipendente era ormai precipitato nei sondaggi e aveva contro due terzi degli
elettori: deludente nella lotta alla corruzione e nei negoziati sul Donbass,
inconcludente nelle promesse di legalizzare la cannabis e la prostituzione e
l’aborto gratuito e il gioco d’azzardo, costretto a rimpastare i ministri,
snobbato dai media, sporcato dal Trump dell’Ukrainagate, persino diffamato per
via di qualche vizio privato… «Sei un incapace irresponsabile», l’attaccava
l’oppositore Petro Poroshenko. «Suona il pianoforte, ché ti vien meglio», lo
irrideva l’ex premier Yulia Tymoshenko. Poi, ecco quella notte. Che notte:
«Ricordo d’essermi svegliata con rumori strani all’esterno — racconta la moglie
Olena — e ho visto che Volodymyr non era accanto a me. Sono andata nell’altra
stanza ed era già vestito, senza cravatta. L’ultima volta che l’ho visto in
abiti civili. Gli ho chiesto: che succede? E lui: è iniziata».
Un anno di guerra
dopo, Volodymyr Oleksandrovyc Zelensky detto «Ze» è un imperatore del popolo al
94 per cento dei consensi. «Un leader spirituale», l’esalta il fidato
consigliere Oleksandr Kornienko. «Uno dei più grandi leader mondiali», lo
decanta il fedelissimo Andrij Ermak. «È diventato un soldato e siamo tutti con
lui», ha cambiato idea Poroshenko. «Siamo un solo popolo e un solo cuore», gli
promette adesso la Tymoshenko. Pure all’estero, non solo a Sanremo, è tutt’un
grazie dei fiori e un festival degli onori: il premio John Kennedy per il
coraggio, la Pergamena della libertà a Filadelfia, la medaglia d’oro Ronald
Reagan a Washington, la spilla Churchill a Londra, la targa dell’Ordine del Leon
Bianco a Praga, la coccarda dell’Ordine di Viestur a Riga, la catena dell’Ordine
di Vytautas il Grande a Vilnius, il cordone dell’Ordine dell’Aquila Bianca a
Varsavia, l’onorificenza Dubcek per la speranza a Bratislava… A una conferenza
stampa, una giornalista si commuove e gli chiede d’abbracciarlo. In ogni
Parlamento sfodera la sua retorica prêt-à-porter — che si parli del Muro al
Bundestag, della Shoah alla Knesset, di Pearl Harbor al Congresso, di Churchill
a Westminster — e scatena ovazioni minimo di tre minuti. Lui, che è figlio d’un
ingegnere cibernetico, ha inventato la guerra online: le centraliniste di Kiev
messe a chiamare le mamme russe («lo sa che suo figlio è qui al fronte?»), i
video per i red carpet di Cannes e di Venezia, l’infowar su TikTok che rende
inutili la Cnn e tutte le Amanpour del mondo. Hashtag la victoria siempre. Col
suo autentico kit di magliette militari, i suoi confidenziali selfie dal bunker,
la sua (insta)grammatica social, Zelensky ha mummificato di colpo le roboanti
parate, le algide posture, gli slogan ingessati di Putin. Secondo Time e
il Financial Times, è lui l’uomo dell’anno. Per il Times of Israel, ha in poppa
il vento trionfale dell’Elohìm biblico. Per The Hill, è un eroe globale. E
se Deutsche Welle lo proclama «praticamente un santo», Der Spiegel lo chiama
«eroe in divenire». «La più grande guida dei nostri tempi», dice lo scacchista
russo Garri Kasparov. Lo scrittore Jonathan Safran Foer ne esalta
«l’irraggiungibile lealtà», l’attore Sean Penn «il coraggio, la dignità, l’amore
che emana», Erri De Luca lo paragona al Leonida delle Termopili che oscurò il re
dei Persiani… Ze vanta innumerevoli tentativi d’imitazione, segno che piace; una
dozzina di tentativi d’omicidio, segno che fa paura; milioni di meme, segno che
divide.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con “lo spirito dell’Ucraina”
nominato persona dell’anno di Time per il 2022 (Foto ANSA/TIME)
Heroyam Slava! È
vera gloria, naturalmente. Da comico che recitava nei panni d’un finto
presidente, a presidente un po’ per caso che impersona un presidente vero: «Uso
ciò che lo spettatore ama in un attore, questo sentimento di umanità. È molto
facile da fare, perché io rimango me stesso». Salvator Mundi, si racconta uno e
trino: è nato attore con la vocazione per entrare in tv, è cresciuto politico
con la fissa d’entrare nella Nato, è resuscitato comandante con l’obbligo
d’entrare nella Terza guerra mondiale. La mutazione definitiva, alla boa dei 45
anni: il primo Ze ancora vagiva nei suoi studi di Kvartal 95 declamando che «la
politica è uguale al cattivo cinema, i politici recitano troppo e io li osservo
come può osservarli un produttore televisivo»; il secondo Ze cresceva viaggiando
tra Bruxelles e Washington e avvertendo che «se non possiamo stare nella Nato,
non chiedeteci d’essere neutrali»; il terzo Ze, quello divinizzato d’oggi, è
rinato il 24 Febbraio con la storica risposta agli americani che gli proponevano
la fuga da Kiev («ho bisogno d’armi, non d’un passaggio»).
Un tempo doppiava la
vocina dell’orsetto Paddington, ora si ritrova a far la voce grossa con l’Orso
russo. È il piccolo Chaplin che si fa beffa del Grande Dittatore. Che abbraccia
il mappamondo, sogna un’Europa aperta all’EUkraine e una Mosca sigillata per
sempre. Su questa russofobia peserà il fatto che da bambino sia vissuto per un
po’ nella Mongolia iper-comunista. Conterà che i suoi amici oligarchi, qualcuno
anche un po’ corrotto, gli abbiano fatto assaggiare le delizie del mercato
occidentale. C’entrerà che pure lui tenga qualche conto off-shore alle Virgin
Islands e belle proprietà fra la Georgia e la Versilia. O magari dipenderà tutto
da dov’è nato: la ferrosa e cosacca Kryvyj Rih bombardata ogni settimana da
Putin, la culla dell’anarchismo contadino di Nestor Machno e del machnovismo
rivoluzionario che già sfidava Lenin e i bolscevichi. «Gli ucraini non sono una
minaccia per la Russia — spiega lo storico Timothy Snyder —, ma la loro
democrazia, sì. Zelensky è giovane, democratico, coraggioso, ebreo, russofono.
Non solo smentisce la propaganda di Putin, che vuole i russofoni e gli ebrei
perseguitati in Ucraina: mostra come potrebbe essere un nuovo presidente, se in
Russia ci fossero libere elezioni». Da attore, Ze non ha mai smesso di recitare
in russo. Da presidente, non ha mai smesso di parlare ai russi. E di tutti i
video, forse il più duro ed efficace l’ha messo su Telegram lo scorso settembre,
200esimo giorno di guerra, nel mezzo della controffensiva e della battaglia per
sbloccare il grano a Odessa: «Pensate ancora che siamo “un unico popolo”? — ha
guardato fisso in camera —. Allora non capite proprio nulla. Davvero non capite
chi siamo? Che cosa difendiamo? Di che cosa si tratta, per noi? Leggetelo sulle
mie labbra. Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi?
Senza di voi. Senz’acqua o senza di voi? Senza di voi. Senza cibo o senza di
voi? Senza di voi. Perché per noi il freddo, la fame, il buio e la sete non sono
tanto terribili e mortali quanto la vostra “amicizia e fratellanza”. Ma la
Storia rimetterà tutto al suo posto. Avremo gas, luce, acqua e cibo. E tutto
questo, lo otterremo senza di voi».
Li ha fregati tutti,
Ze. L’eroe senza macchia — l’hanno capito presto Biden e Draghi, i cinesi e
Kissinger — aveva pure il suo bel caratterino. Un giullare che piano piano s’era
fatto re, armato fino ai denti, e noi senza troppa fantasia a definirlo ancora
il Beppe Grillo di Kiev. O-ne-stà, o-ne-stà? Macché: altolà, chi va là! Un
grillo poco parlante, va detto: quando il pericolo s’ammassava ai confini e Joe
Biden gli mostrava la luna dell’invasione imminente, sleepy Zelensky guardava
solo il dito e temeva soprattutto «l’allarmismo che fa fuggire gli investitori
stranieri». Un grillo fin troppo loquace per i pacifisti, che oramai non ce la
fanno più a sentirlo esigere armi e soltanto armi; per Papa Francesco,
gl’indiani o i sudamericani del Mercosur che vorrebbero allunare su una tregua
qualsiasi, ma vengono regolarmente additati come disfattisti: caro mondo libero,
ma quale pace, «il tango si balla in due», datemi casomai più Himars e più
Gripen, altri F-16 e nuovi Leopard, perché adesso tocca a noi e poi toccherà a
voi, perché stiamo difendendo la civiltà di tutti, si vis petroleum para
bellum… Diranno gli storici se sia stato il bavaglio troppo stretto che ha messo
alle tv filorusse, ad aizzare l’Orso Putin. O la de-russificazione troppo severa
che ha imposto al Paese, accelerandola un anno prima dell’invasione. E saranno i
futuri mesi di guerra, i prossimi anni di legge marziale a mostrarci quanta
democrazia possano ancora permettersi l’Ucraina e il populista Volodymyr, mentre
vengono azzannati con tanta ferocia. «Nella vita ho fatto di tutto per farvi
ridere», aveva promesso quattro anni fa insediandosi a Palazzo Marinskij, «ora
farò di tutto perché non piangiate». Non ci è riuscito. Di lacrime s’è riempito
il Dnepr, ma non è colpa sua.Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante
una conferenza stampa congiunta con il Segretario Generale delle Nazioni Unite
dopo i colloqui a Kiev il 28 aprile 2022 (Foto Sergei SUPINSKY /AFP)
«Come le more
selvatiche»: in Ucraina, tra dolore e resistenza.
testo e foto di
Paolo Giordano su il Corriere della Sera il 24 febbraio 2023
Il viaggio di Paolo
Giordano nei luoghi del dolore e della resistenza ucraina. In uno scenario di
devastazioni emergono, attraverso una serie di incontri, la consapevolezza e la
determinazione di un popolo nel cacciare l’invasore russo. Il titolo di questo
racconto è tratto dai versi di un soldato - poeta: conserva la speranza di
libertà nei momenti più bui
Il viaggio inizia
dalla fine: dalla chiesa di san Pietro e Paolo, a Leopoli, dove ogni mattina
vengono celebrati i funerali dei militari ucraini. Ieri erano tre, oggi due:
Bogdan, di quarant’anni, e Ivan, di quarantaquattro. Mentre aspettiamo i feretri
al fondo della scalinata, la neve caduta nella notte gocciola dai cornicioni. Da
un anno la morte dei soldati sfila nella città più lontana dal fronte,
impregnandone la vita quotidiana. I numeri delle perdite fra le forze ucraine
sono secretati, ma considerando che Leopoli è solo una delle decine di città
dove la morte arriva a getto continuo, è facile estrapolare che parliamo di
decine, più probabilmente centinaia di soldati morti ogni giorno. Ciascuna morte
contribuisce a solidificare un senso di appartenenza che prima del 24 febbraio
2022 era ancora in lenta formazione. Una nazione si costruisce esattamente così,
sulla massa invisibile dei propri martiri.
La consuetudine è
ormai tale che tutti, militari e civili, sanno come comportarsi: fuori dalla
chiesa, dentro e poi di nuovo fuori, nella piazza del municipio dove viene
suonata «Taps». Dalla piazza, una fila di autobus raggiunge infine il cimitero
Lychavik. Mentre si svolgono le sepolture, Kateryna e io ci allontaniamo un po’.
Camminiamo fra le lapidi del Campo di Marte. Leggo le date di nascita: anni
ottanta e novanta per la maggior parte, ma si arriva fino al 2003. Nascoste
sotto una corona di fiori, sulla lapide di un soldato ventenne, ci sono una
bottiglia di whisky e una di coca cola.
Ho conosciuto
Kateryna prima di tutto questo, a un festival di scrittori, ma nell’ultimo anno
lei è diventata qualcosa di diverso: una scrittrice attivista, una scrittrice
esperta di droni da combattimento e shrapnel. E per me, più specificamente, una
scrittrice fixer.
A Natale ha chiesto
ai suoi due figli grandi di esprimere un desiderio. Le hanno risposto: Il
desiderio è ovvio. Con un po’ di timore Kateryna si è spinta oltre: Ma è che
l’Ucraina vinca o anche che i russi muoiano? Entrambi, hanno detto loro
freddamente. Mi è dispiaciuto sentirlo, confessa adesso, ma almeno sono stati
sinceri. Quanto al più piccolo, che fa ancora la scuola materna, un giorno l’ha
trovato che litigava con un compagno sul fatto che il muro di lego che avevano
costruito fosse più utile per tenere lontani i russi o i bielorussi. In questo
momento i bielorussi preoccupano perfino più della nuova mobilitazione in
Russia. Se si aprisse quel fronte l’esercito ucraino sarebbe costretto a
disperdere le energie, gli scontri arriverebbero vicino a qui, e ancora una
volta addosso a Kiev.Il cimitero Lychavik a Leopoli (Foto P. Giordano)In questo
momento i bielorussi preoccupano perfino più della nuova mobilitazione in
Russia. Se si aprisse quel fronte gli scontri arriverebbero ancora addosso a
Kiev
Per il momento,
però, dalla Bielorussia si limitano a decollare i cacciabombardieri. Sorvolano
il territorio ucraino, minacciando quel tanto che basta, poi tornano indietro.
Solo ieri è successo quattro volte: per quattro volte le sirene hanno riempito
lugubri l’aria di Leopoli. La maggior parte delle persone, inclusi noi, ha
continuato a comportarsi come se non. Ma, attraverso la recinzione di una
scuola, ho visto un gruppo di bambini con sindrome di Down entrare composti, uno
dopo l’altro, in cantina. Una di loro rifiutava di muoversi, se ne stava
attaccata al muro con le orecchie coperte, paralizzata.
Al cimitero Kateryna
si china a pulire una fotografia dalle gocce. Lui è Doc, dice, stasera Artur te
ne parlerà di certo. Infatti. Ecco quello che Artur – che in questi giorni si
trova a Leopoli del tutto casualmente, perché a inizio gennaio si è congelato
l’alluce del piede in trincea – mi racconterà:
All’inizio dell’anno
scorso, a ventun anni, Artur studiava giornalismo ed era appena stato assunto
nell’ufficio stampa di una casa editrice, dopo mesi di stage sottopagati. Nel
tempo restante scriveva poesie, con intenzioni serie. La notte dell’invasione su
larga scala, il 24 febbraio, non riusciva a prendere sonno. Ha pregato a lungo.
Durante il giorno aveva fatto volontariato in una parrocchia, ma pregando ha
capito che il volontariato non sarebbe stato sufficiente per lui. Così, all’alba
del 25, senza alcuna esperienza militare, si è messo in coda per arruolarsi
nelle Forze di Difesa Territoriali. A marzo si addestrava con altri neofiti come
lui, usando dei fucili finti, di legno; ad agosto era in Donetsk a scavare
trincee, e a ottobre ha perso il suo primo commilitone: Doc.Vita a Kharkiv che
dopo ogni attacco cerca di ripristinare velocemente la normalità. Artur accusa i
sintomi di un trauma: dolore alla testa, nausea, tinnito. Ma il dottore, Doc, è
appena morto, insieme ad altri due.
Bisogna
immaginare un campo rettangolare, vuoto e piatto, profondo circa un chilometro.
Lungo tutto il perimetro ci sono delle «posadka», strisce sottili di foresta,
tre filari di alberi o poco più. Artur e Cola occupano una buca a un’estremità
del campo. Hanno l’ordine di minare il lato adiacente per rallentare l’avanzata
dei russi che sono trincerati dalla parte opposta, ma sono bloccati dai colpi di
un carro armato che spara ferocemente sulla loro posizione, senza sosta. Per via
delle vibrazioni fortissime Artur accusa i sintomi di un trauma: dolore alla
testa, nausea, tinnito. Perciò, quando finalmente il carro armato cambia linea
di tiro, Artur e Cola ne approfittano per spostarsi nella trincea centrale.
Trovano il
comandante impegnato a stabilizzare dei feriti. Artur sta sempre peggio, gli
urla che ha bisogno del dottore, di Doc, urla perché è praticamente
assordato. Ma Doc è appena morto, insieme ad altri due. Aveva cinquantadue anni
e per loro, quasi tutti ventenni, era una figura paterna.
Il carro armato
adesso spara al centro, di nuovo su di loro. Finalmente arriva una squadra dal
villaggio, ma sono solo in due. Artur e Cola, alla fine, portano via Doc da
soli. Quando l’abbiamo sollevato, mi dice, ho sentito il peso dell’amore che
aveva per noi, l’ho sentito fisicamente. Poi aggiunge: Era pieno di schegge.
Nei primi otto mesi
di guerra Artur non aveva scritto un solo verso, sembrava non esserci più spazio
per cose del genere nella sua vita. Ma quella sera, con la testa rintronata dai
colpi di carro armato e il morale al minimo, ha buttato giù una poesia intera,
che inizia così: «Prima del confine / salva questo Amore / che cresce
dappertutto / come le more selvatiche».
L’ultimo giorno a
Leopoli, Kateryna e io facciamo scorte. In un negozio di attrezzatura da
montagna compriamo decine di pasti liofilizzati: chili con carne, cous cous con
pollo, zuppa di funghi, borsch. Questi vanno benissimo, mi spiega, perché
l’acqua calda può essere versata direttamente nella confezione, in trincea è
molto più pratico. Diciamo sempre «trincee», ma l’immagine non è così precisa:
si tratta nella maggior parte dei casi di buche circolari scavate nella terra.A
Kramatorsk davanti a una finestra in frantumi (Foto P. Giordano)Quindi cosa ne
pensi, mi chiede Kateryna? Non ne penso niente, rispondo. Un po’ è davvero così
Raggiungiamo Sashko,
suo marito, che ha già caricato la macchina con il resto degli aiuti per i
soldati: sacchi a pelo, calze termiche, un generatore di corrente che da solo
occupa metà bagagliaio; giubbotti antiproiettili ed elmetti per noi. Faremo una
sola tappa intermedia, per dormire, dalle parti di Vinnitsa, prima di
raggiungere Dnipro domani.
Perché proprio
Dnipro? Perché il 15 gennaio un missile Kh-22 ha centrato un palazzo
residenziale. Il bilancio al momento è di 46 morti, 75 feriti e una trentina di
dispersi: la strage di civili più rilevante dell’ultimo periodo. Ho
l’impressione che, dopo un anno, i luoghi in cui si sono svolti i passaggi
cruciali della guerra si siano incollati fra loro, confondendosi, cancellandosi
parzialmente l’un l’altro. Venendo qui sentivo la necessità di distendere questa
geografia rappresa.
Ma adesso che ci
sono, davanti al condominio bombardato, ai mucchi di cemento e mobili, alle
cucine e le camere da letto tagliate a metà, la mia intenzione mi appare
astratta. Quindi cosa ne pensi, mi chiede Kateryna? Vuole accertarsi che io
comprenda la gravità di quello che ho davanti e per la prima volta il suo
incalzare m’infastidisce. Non ne penso niente, rispondo. Un po’ è davvero così.
Il palazzo non rimanda a nulla se non al proprio sfacelo, all’inutilità
deprimente della propria distruzione. Dopo averlo fotografato da più
angolazioni, mi chiedo che cosa aggiunga contemplarlo da vicino a quello che
sapevo già (e invece no, ma lo capirò solo più avanti, verso la fine del
viaggio: vedere gli edifici e le case in rovina, vederli uno dopo l’altro in una
processione tristissima, richiamare di ognuno la dinamica dell’attacco, i morti
e i feriti, è un esercizio necessario, una forma di assorbimento diversa,
cutanea, della guerra).
Ci rimettiamo in
macchina. Altre quattro ore di strada. Parliamo dell’eventualità che Putin muoia
o che venga ucciso, di come per noi questo significherebbe la fine immediata
della guerra e di come per loro, per gli ucraini, la nostra sia una fantasia
ridicola: la guerra in corso è un processo storico più grande di Putin, andrebbe
avanti anche senza di lui.Il Donbass produce da solo il numero inconoscibile di
cadaveri che ogni giono vengono distribuiti nel paese o che spesso rimangono lì,
nei campi
Dalla nebbia si
stagliano le sagome scure dei primi «terykon», i cumuli di terra scura estratta
dalle miniere. Alcuni solo molto alti, come colline, e striati così di neve non
sono privi di una loro tetra bellezza. Segnalano che ormai siamo entrati nella
regione di Donetsk, in Donbass, come preferiamo dire noi, sebbene non sia del
tutto appropriato. Qui è dove la guerra non è mai cessata, da nove anni. Qui è
dove il fronte è tornato dopo la ritirata dei russi dall’area di Kiev,
concedendoci l’illusione che la fase attuale della guerra sia più «normale», più
sopportabile. Non è così. Il Donbass produce da solo il numero inconoscibile di
cadaveri che ogni giorno vengono distribuiti nel paese, o che spesso rimangono
lì, nei campi. Qui è dove le ambiguità culturali e linguistiche sono
difficilissime da comprendere ed è proprio qui, infatti, che vengono generate le
interpretazioni più scivolose, velatamente apologetiche dell’aggressione russa.
Per ricostruire gli
ultimi dieci anni dei territori occupati (o forse per evitare di farlo) scelgo
di affidarmi a una vicenda singola. Una piccola storia di diaspora famigliare,
per nulla rara da queste parti, che potrebbe intitolarsi: «Tre donne di
Lugansk».
La protagonista,
Nastya, è nata in Russia, suo padre era nell’esercito lì, ha combattuto in
Cecenia ed è morto in circostanze mai chiarite, nel 2000, quando lei aveva sei
anni. Dopo la sua morte la madre di Nastya, una giornalista, ha deciso di
portare lei e la figlia maggiore Katya in Ucraina, a Lugansk, dove vivevano i
nonni. Nastya e Katya sono cresciute in Donbass, frequentando una scuola in cui
s’imparava anche l’ucraino e partecipando insieme, da adolescenti, a qualche
blanda manifestazione pro Ucraina, tutto sommato tollerata dai separatisti.
Nella primavera di quell’anno madre e figlie sono andate a Kiev per festeggiare
il ventesimo compleanno di Nastya, ma da quella gita è tornata a Lugansk solo la
madre, perché nel frattempo c’erano stati i fatti di Maidan e la tensione nel
paese era altissima.
Luglio 2014: tutto
accelera all’improvviso. Lugansk viene occupata. La madre di Nastya smette di
lavorare, tanto è inutile, nei territori non ci sono più le condizioni minime
per fare giornalismo, e in effetti nemmeno le condizioni minime per
sopravvivere: manca l’elettricità e non ci sono generatori, per di più in
un’estate caldissima. Ma lei non può andarsene a causa dei genitori. Le
telefonate verso l’Ucraina sono pericolose, così scrive alle figlie degli sms
stringati, di notte, solo per comunicare che è viva.
Nastya e Katya, nel
frattempo, si sono spostate ancora più a ovest, a Leopoli. Hanno pochi soldi,
sono disorientate, ma non è il caso di lamentarsi: a Lugansk va molto peggio.
Finalmente il marito di Katya trova lavoro, in Crimea. Ed è lì, in Crimea, che
Nastya li ha visti per l’ultima volta, nel 2016, dopo un viaggio
complicatissimo.La statua oltraggiata e crivellata di colpi del poeta Taras
Shevchenko (Foto P. Giordano)E così Nastya è a Leopoli, dove ormai parla solo
ucraino, la sorella Katya in Argentina, a sostenere la guerra di Putin, la madre
in mezzo, nella regione di Lugansk occupata e contesa.
A questo punto del
racconto Nastya scoppia a piangere. Suppongo che sia perché non ha più potuto
incontrare la sorella, ma aspetto che sia lei a dirmelo. Quando si è calmata un
po’, pur senza smettere il pianto, prosegue:
Dalla Crimea, Katya
e il marito si sono di nuovo trasferiti, a San Pietroburgo stavolta, per via di
un’offerta migliore. E lo scorso novembre, dopo che Putin ha ordinato la
mobilitazione, sono scappati da San Pietroburgo in Argentina. Ma lei e la
sorella non si sono più parlate comunque, nemmeno ora che potevano. L’ultimo
messaggio di Katya risale al febbraio scorso e dice più o meno così: «Non
preoccuparti Nastya, l’Ucraina verrà divisa a metà, questa è una guerra fra la
Russia e l’Occidente, voi avete solo la sfortuna di trovarvi in mezzo». Voi. Voi
ucraini. Qualcosa le è successo, dice Nastya, negli anni in Crimea e a San
Pietroburgo.
E così, la
situazione attuale è la seguente: Nastya a Leopoli, dove ormai parla solo
ucraino, la sorella maggiore Katya in Argentina a sostenere la guerra di Putin,
la madre in mezzo, nella regione di Lugansk occupata e contesa. Quasi una
rappresentazione grafica del conflitto. Eppure, il 24 febbraio scorso, Nastya si
è sentita più fortunata di altri, perché era preparata: aveva già vissuto un
risveglio simile, aveva già perso la sua vita una volta, la sua vita di Lugansk.
Passiamo la
notte nei pressi di Dmytrivka, nella fattoria di Victoria e Bogdan. «Fattoria»
dà forse l’idea di qualcosa di più sontuoso di com’è, ma Victoria e Bogdan
possiedono quaranta ettari dove coltivano di tutto, in particolare frumento e
mais. Li hanno raccolti e venduti anche l’estate scorsa, quando molti
agricoltori erano costretti dai russi a lasciar marcire i raccolti, o a vederli
bruciare.La mattina del 24 febbraio, quando un’amica le ha detto dell’invasione,
Victoria si è rifiutata di crederci. Poi si è trovata a implorare la mucca di
non partorire prima che la guerra fosse finita
Victoria ha
preparato per noi dei «varenyky», la versione ucraina dei ravioli. Ce li offre
insieme a una vodka casalinga, il cui colore rossiccio viene dalla macerazione
dei gherigli di noci. All’inizio dell’anno scorso Victoria e Bogdan avevano
comprato la seconda mucca, incinta, ed erano al settimo cielo. Tanto che la
mattina del 24 febbraio, quando un’amica le ha detto dell’invasione, Victoria si
è rifiutata di crederci. Poi si è trovata a implorare la mucca di non partorire
prima che la guerra fosse finita. Ma c’è voluto più del previsto.
Quando sono arrivati
i primi soldati ucraini, Victoria li ha aspettati lungo la strada con i suoi
«varenyky». Erano tutti giovani, dice, tutti belli. Da quel giorno non ha più
smesso, anzi ha trasformato quel gesto emotivo dell’inizio in un’attività
strutturata, che coinvolge donne del paese di tutte le età. Preparano fino a
mille «varenyky» al giorno, li congelano e quando passa un convoglio si fanno
trovare all’ora stabilita lungo la strada, con le razioni pronte per i soldati.
Assistono come
possono anche i feriti in ospedale, ne arrivano in abbondanza. Non è sempre
facile. Il giorno del bombardamento di Sviatohirsk, Victoria era accanto a una
donna ferita, si stava preoccupando di procurarle dei vestiti, quando è entrato
il figlio adolescente, illeso e in preda all’esaltazione: un amico al telefono
gli aveva appena detto che, finalmente, al paese i russi avrebbero ammazzato
tutti quei «khokhly», un termine dispregiativo fra i più comuni che i russi
riservano agli ucraini. Victoria era scioccata ma è rimasta imperturbabile.
A un certo punto
della cena riceve una telefonata, discute a lungo, e quando le chiedo di
riassumere a proposito di cosa mi mostra la foto di un attrezzo di plastica:
serve ad agganciare le granate ai droni. C’è una trattativa in corso: una
fornitura di «varenyky» in cambio di quei pezzi di plastica, che qualcuno in
città potrebbe produrre con una stampante 3D.
A letto la vicinanza
del fronte mi procura una tensione del tutto particolare. La notte precedente
Kramatorsk è stata bombardata, ne hanno parlato anche i media internazionali, ma
è stata bombardata a lungo anche Pokrovsk, molto più piccola e di cui non ha
parlato nessuno. Mi trovo a pensare a come la casa di Victoria e Bogdan potrebbe
essere rasa al suolo in un istante dai missili che piovono di continuo sulla
regione.
Il sonno dura
comunque poco. Ripartiamo appena c’è luce. A Kramatorsk è difficile trovare una
finestra che non sia sigillata. Il bombardamento della stazione, il 22 aprile,
ha ucciso sessanta civili e ne ha feriti più di un centinaio. Due giorni fa,
invece, un Iskander ha colpito un complesso residenziale con un esito meno
eclatante, quattro morti e otto feriti. A differenza del Kh-200 che ha sventrato
il palazzo di Dnipro, gli Iskander sono missili di precisione, i russi devono
aver inserito male le coordinate. Nel condominio di fronte a quello distrutto,
una ragazza è in piedi su un davanzale. Stacca le tende dalla finestra in
frantumi, poi raccoglie i detriti con una piccola scopa di saggina. Quando si
accorge che la fotografo mi fa ciao, mestamente, con la mano.Una chiesa
crivellata di colpi a Irpin (Foto P. Giordano)
Consegniamo il
generatore di corrente ad Andryi, un operatore di droni, poi ci lasciamo alle
spalle anche Kramatorsk. Sashko ci avvisa che da qui in avanti è meglio tenere
le cinture slacciate. I checkpoint s’intensificano, a fine giornata ne avremo
attraversati almeno una ventina.
Arriviamo nei pressi
di Chasiv Yar. La cittadina successiva sulla mappa è Bakhmut, da settimane
l’epicentro della guerra. Nel momento in cui scrivo non è ancora caduta ma è
quasi accerchiata, ormai sembra questione di giorni. Ancora dopo c’è Soledar,
già presa dai russi. Da quella direzione mi sembra emanare un’energia oscura, ma
so che è solo suggestione. I colpi di artiglieria, in compenso, sono autentici e
continui. La neve delle ultime ore assorbe tutti i suoni tranne quelli. Si
susseguono a un ritmo regolare, per nulla frenetico, quasi sonnolento invece,
come se dovessero durare all’infinito.
Roman si trova qui
per questo, per l’artiglieria. Mi porta a visitare il «suo» lanciarazzi
mimetizzato tra i rami. Un modello vecchio, di fabbricazione sovietica, scomodo
e anche poco protetto, ma si vede che Roman si è affezionato. D’altra parte,
nelle prime tre settimane di invasione ha vissuto nell’abitacolo, giorno e
notte, insieme ad altri due. Dormivano appiccicati sull’unico sedile. Il
problema è che le munizioni per quel tipo di lanciarazzi scarseggiano. Stanno
aspettando quelli nuovi che gli alleati hanno promesso, ma chissà quando
arriveranno. Aiutandosi con i gesti delle mani, Roman mi spiega che
nell’intervallo temporale che va fra la promessa dei mezzi militari e il loro
arrivo lì, lui e gli altri come lui muoiono in quantità. Morire, aggiunge con un
sorriso, è comunque meglio di essere fatto prigioniero. Il trattamento riservato
dai russi agli artiglieri è noto, perché il novanta percento delle loro perdite
è causa loro.
Ha fatto preparare
un pranzo per noi nel cortile accanto. Per lo meno adesso non dormono più nel
lanciarazzi. Occupano case di fortuna, spostandosi all’incirca ogni due
settimane per evitare che la posizione venga individuata precisamente. Mangiamo
in piedi, mentre Roman mi racconta del lavoro come insegnante che faceva prima
del 24 febbraio, e dei foreign fighter che sono stati lì per un periodo: avevano
fatto sia l’Afghanistan che l’Iraq, ma hanno detto che il peggio l’hanno visto
in Donbass.
Scattiamo delle foto
insieme e quando stiamo per andarcene capisco che Roman vorrebbe trattenerci.
Dopo undici mesi di questa vita, interrotti solo da quattro giorni di licenza,
ha voglia di un’interazione umana diversa. Ma noi abbiamo appuntamento con un
soldato di fanteria, a Sloviansk. Fanteria? dice lui. Quelli della fanteria li
riconosci dallo sguardo.
Capisco cosa voleva
dire appena stringo la mano a Taras. Ha quarant’anni, la mia età, ed esattamente
quello sguardo. Prima del 24 febbraio Taras lavorava in una compagnia
internazionale, viaggiava, infatti parla inglese. Nel 2012 era stato trasferito
a Mosca. Il livello di propaganda antiucraina incontrata lì lo aveva sconvolto,
ed era prima della guerra in Donbass, prima della rivoluzione di Maidan, prima
di tutto. La tv parlava in continuazione dei nazisti ucraini, al punto che dopo
un po’ aveva iniziato ad avere dei dubbi perfino lui. Quando in metropolitana si
rivolgeva in ucraino ai suoi bambini, l’insofferenza dei russi era evidente.
Stavano già preparando questa guerra, mi dice ora. Mi dice: Non è una questione
di russi buoni o cattivi, è che la loro mente è stata avvelenata troppo a
lungo.La pulizia delle strade di Kharkiv dopo un bombardamento (Foto P.
Giordano)Nel 2012 Taras era stato trasferito a Mosca. Il livello di propaganda
antiucraina incontrata lì lo aveva sconvolto. La tv parlava in continuazione dei
nazisti ucraini. Quando in metropolitana si rivolgeva in ucraino ai suoi
bambini, l’insofferenza dei russi era evidente. Stavano già preparando questa
guerra, mi dice ora.
Taras non aveva
alcuna attrazione per le armi o l’esercito. Aveva schivato il servizio militare
e con tre figli minorenni avrebbe potuto continuare a farlo anche dopo
l’invasione su larga scala. Invece la mattina del 24 febbraio era in fila per
arruolarsi. Da allora è stato sempre al fronte. Ha ucciso e visto morire i suoi
più di quanto una mente solida possa reggere, ed è ancora abbastanza cosciente
per riconoscerlo.
Mi racconta di prima
mano quello che tutti abbiamo appreso con un po’ di incredulità dai media: delle
ondate di soldati russi mandati avanti a farsi trucidare, solo per guadagnare
una posizione. Un costo umano al metro lineare che ha precedenti solo nelle
battaglie più sanguinarie della storia. Sono stanco di ucciderli, dice Taras con
voce spenta. Mi sento almeno dieci anni in più di quando sono partito.
Due giorni fa hanno
perso molti dei loro. Non hanno potuto recuperare i corpi perché i russi hanno
minato l’area e i cadaveri stessi. Enuncia tutto questo senza traccia di
esaltazione bellica o rabbia, solo con grande stanchezza e con un senso cupo di
inevitabilità.Ecco un uomo che faceva le sue cose normali nella sua vita
normale, e che da un anno vede morire e uccide e dorme dentro buche di fango e
ormai ha accettato per intero anche la propria morte. Quando finiamo di parlare
non so come congedarmi da lui, non so cosa dire. Ma lui non si aspetta nulla da
me. Con il passare dei giorni sarà il suo sguardo terminale a ingombrarmi la
mente più di ogni altra immagine incamerata qui.
Lungo la strada per
Izyum è tutto distrutto. Carcasse di auto e carri armati bruciati, case senza il
tetto, muri crivellati. Ogni centinaio di metri un cartello indica la presenza
di mine e di tanto in tanto compare una Z nera disegnata con lo spray, a
sfregio. Chilometri e chilometri così. Dopo un po’ che sfila, il paesaggio di
devastazione risulta monotono. Mi rifugio nel telefono, la connessione funziona
a tratti. Su Telegram vengono lanciate campagne di raccolta fondi per l’acquisto
di droni. Su Twitter è in tendenza l’hashtag #Wagner.
Il primo aprile
2022 Izyum è stata occupata ufficialmente dai russi, dopo un mese di battaglia
fra le sponde del fiume. Le notizie da quel segmento decisivo di fronte erano
poche, frammentarie e paurose. Ma dopo l’occupazione russa era piombato sulla
cittadina un buio assoluto, durato per tutta l’estate, fino alla controffensiva
di settembre. Yurii è stato fra i primi soldati ucraini a entrare nella Izyum
liberata: mi ha detto di aver trovato così tante armi e munizioni abbandonate
dai russi da dover scegliere quali prendere e quali lasciare.
Superiamo la parte
ancora incredibilmente abitata. Imbocchiamo una strada laterale coperta di neve
e parcheggiamo l’auto ai margini di un bosco. Frequentare i boschi è vietato,
nonostante la neve intonsa sia così invitante, ma Kateryna mi garantisce che
questo è sminato.
Le fosse comuni di
Izyum hanno fatto meno scalpore di quelle di Bucha, ma solo perché sono arrivate
dopo. Proprio come a Bucha, anche qui sono stati i superstiti a indicare la zona
delle fosse, l’unica dove i russi permettevano di sotterrare i cadaveri, alla
svelta, avvolti al massimo in una coperta. Ne sono stati riesumati centinaia. Li
hanno portati via per identificarli, perciò quello che troviamo adesso nel bosco
di pini è una distesa di buche rettangolari vuote, squarci scuri nella neve a
perdita d’occhio, ognuno con all’interno una croce di legno numerata. È sera, la
luce è appena sufficiente a scattare qualche foto, ma nessuna che renda l’idea
dell’estensione del cimitero. Tornati in macchina scrivo solo: «Controllare se a
Izyum si sta davvero diffondendo la tubercolosi». I miei appunti si fanno sempre
più scarni, stanno sparendo del tutto i commenti. Ormai mi limito a segnare le
informazioni nude.
Arrivare a Kharkiv,
dopo, sembra impossibile. Troviamo la strada sbarrata all’improvviso, senza un
avvertimento, ne prendiamo una laterale e la percorriamo fino a quando capiamo
dalla neve e dai detriti che non è affatto una buona idea. Impieghiamo un quarto
d’ora solo per fare inversione, perché entrambi i lati potrebbero essere minati.
Sto per avere una
crisi di nervi. Ci troviamo intrappolati fra tre checkpoint che ci rimandano uno
all’altro, finché riusciamo a trovare la deviazione. Quando entriamo a Kharkiv,
circa due ore dopo, non manca molto al coprifuoco. La città è al buio, tanto per
cambiare. I monoliti sovietici sfilano uno dopo l’altro, neri, ne intuisco
comunque la maestosità. Kharkiv aveva quasi un milione e mezzo di abitanti prima
del 24 febbraio, ma si stima che nelle prime settimane l’abbiano lasciata in
circa ottocentomila. Qualcuno sarà tornato nel frattempo, ma non abbastanza
perché la città non appaia vuota.
Per un soffio
riusciamo a comprare del cibo da asporto e recuperiamo le chiavi di un
appartamento. Tanya, che ha trovato questa sistemazione per noi, ci raccomanda
di non farci spaventare troppo dalle sirene, sono molto forti e potrebbero
partire da un momento all’altro: le nove di sera e le quattro del mattino sono
gli orari prediletti dai russi per bombardare.
Come aveva previsto,
la sirena suona due volte nel corso della notte, ma io vengo a saperlo solo al
mattino perché ho abbondato con i sonniferi. Le esplosioni in città alle otto e
mezzo, invece, le sento benissimo: due, ravvicinate tra loro e vicine a qui. Un
suono che vibra sulle basse frequenze, non solo dello spettro acustico, ma anche
– mi viene da pensare lì per lì – dell’anima.
Sashko e io finiamo
di preparare il caffè istantaneo, poi ci mettiamo in corridoio con Kateryna, ad
aspettare. Sembra il punto più sicuro della casa. Proprio quando serviva, la
sirena non è partita. Ecco un altro inconveniente del trovarsi così vicino al
confine: spesso le bombe arrivano prima dell’allarme. Sulla mappa delle allerte
la regione di Kharkiv è rossa, ma in pochi minuti si accende tutto l’est
dell’Ucraina. Per ingannare il tempo scorro le mail: il «New York Times» ha
deciso di interrompere la newsletter sulla guerra, perché è già andata più
avanti di ogni previsione, e soprattutto non se ne intravede la fine. È
arrivato, insomma, il momento di trattarla come qualcosa di normale. E così, noi
abbiamo quasi esaurito le scorte di attenzione, l’Ucraina sta esaurendo le
munizioni per i lanciarazzi, ma la Russia non ha esaurito le riserve di missili
da lanciare e gli uomini da inviare al fronte, né la volontà di farlo.Ecco una
differenza sostanziale, dalla quale non dovremmo mai prescindere: l’Ucraina
appartiene a quella parte di mondo che vuole mostrarsi, dall’inizio ripete
venite a vedere, venite a Mariupol, venite a Bakhmut, venite a Kherson, venite a
Bucha. I regimi illiberali, come la Russia, devono mantenere il proprio segreto
al di sopra di tutto e di chiunque
I Kh-200 hanno
colpito un’università e l’edificio residenziale alle sue spalle. Quando
arriviamo sul posto le attività di ripristino sono già in corso. Personale
specializzato e civili portano via macerie, spazzano, trasportano pentoloni di
zuppa. L’università si trova in una zona centrale, ricca della città: a un
isolato, per dire, c’è un negozio di Bang & Olufsen. Per fortuna è domenica, e
il bilancio finale sarà di solo cinque feriti. Fra le persone che affollano la
scena, intanto, non colgo neppure una manifestazione di rabbia o scoramento,
solo un’operosità fuori dal comune, tanto che dopo un po’ mi sento d’intralcio.
Ci rimettiamo in
macchina. Fuori città passiamo accanto a un lago ghiacciato, punteggiato di
figure che pattinano, giocano, pescano, ma io diffido di quello scorcio
rapidissimo di idillio invernale, come se fosse stata la mia immaginazione a
fabbricarlo.
A Kiev, nella stanza
d’albergo funzionale, accogliente e pulita, mi precipitano addosso le
settantadue ore precedenti. Mi precipita addosso, soprattutto, la gratitudine
delle persone che ho incontrato, la gratitudine di Roman e Taras e degli altri
militari al fronte per il solo fatto che io fossi arrivato lì: un paradosso.
Ecco una differenza sostanziale, dalla quale non dovremmo mai prescindere:
l’Ucraina appartiene a quella parte di mondo che vuole mostrarsi, dall’inizio
ripete venite a vedere, venite a Mariupol, venite a Bakhmut, venite a Kherson,
venite a Bucha. I regimi illiberali, come la Russia, devono mantenere il proprio
segreto al di sopra di tutto e di chiunque.
La mattina seguente
Tanya ci scrive che sulla strada bombardata di Kharkiv è già stato steso
l’asfalto nuovo. Decido di restare aggrappato al suo messaggio, alla possibilità
di riparazione che trasmette. La ricostruzione in Ucraina sta avvenendo davvero,
in modo sparso e disomogeneo, ma sta avvenendo. Il ristorante dove pranziamo,
«Otamansha», appare intatto, sebbene i russi avessero portato via tutto:
computer, stoviglie, pentole, mobili, televisori, le scorte di cibo, perfino il
sale. Ora la guerra non sembra nemmeno passata.
Il ponte saltato di
Irpin, da cui a marzo è avvenuta un’evacuazione disperata, è ancora nello stesso
stato, ma una compagnia turca ne sta completando uno nuovo accanto. L’intenzione
è di ripristinare al più presto il collegamento, lasciando il ponte distrutto
come memoriale. Non tutti sono d’accordo, non tutti vogliono avere davanti agli
occhi, per sempre, l’inverno del 2022. Tutta l’area a ovest di Kiev si trova su
questo crinale fra la conservazione dell’orrore e il ripristino accelerato,
qualcosa rischia di andare perduto nel processo, qualcosa andrà di certo
perduto. Ma i fabbricati nuovi sono anche una prefigurazione di come potrebbero
tornare a essere, prima o poi, i villaggi a est che ho attraversato ieri.
Nonostante gli
sforzi, la collezione di palazzi semidistrutti, carbonizzati, è interminabile,
mi dà la nausea. Borodyanka ha il primato di devastazione. Nel primo complesso
residenziale bombardato, che si erge nei suoi nove piani come un dente marcio e
per qualche ragione sembra già un manufatto antichissimo, i russi hanno impedito
di soccorrere i superstiti. Chi c’era, dice di averli sentiti chiamare da sotto
le macerie per giorni.
La furia dei russi è
evidente, abnorme, irrazionale: hanno distrutto anche per il puro gusto di
farlo, sparando dai carri armati, incendiando. E tuttavia, nel loro procedere
esisteva anche un’intenzione lucida. La si percepisce nell’accanimento specifico
contro la casa della cultura di Irpin, con la sua facciata celeste e i fregi e
le colonne istoriate – almeno un tempo. Ora il tetto è in pezzi, il palcoscenico
denudato, ci sono buchi di proiettili ovunque. Gli ucraini inseguono da mesi il
riconoscimento dell’invasione russa come genocidio, si tratta di un
riconoscimento difficile da ottenere a livello internazionale, ma è indubbio,
venendo qui, che i russi hanno un intento specifico di cancellazione della loro
cultura. Altrimenti perché sparare in testa alla statua del poeta Taras
Shevchenko? Perché, se non come simbolo dell’esecuzione sommaria di tutta la
cultura ucraina? Esiste un nome specifico per questo tipo di crimine?
La categoria
dell’oppressione coloniale non ci va a genio per interpretare la storia
dell’Ucraina, né tantomeno questa guerra, perché ci mette automaticamente in una
posizione morale più scomoda, eppure, con ogni probabilità, è proprio quella da
usare.
Anche la sera che
lascio Kiev non c’è corrente. Il viaggio sul treno notturno fino a Przemysl, la
prima cittadina polacca, dura nove ore, ma ci fanno restare a bordo per altre
tre. Un intoppo di frontiera forse. Io fantastico che possa trattarsi del mio
vicino, che avrà vent’anni e con la legge marziale non potrebbe varcare il
confine. Ha mostrato alle militari di frontiera un plico di documenti bollati.
Loro vanno avanti e indietro, forse poco persuase, senza che lui mostri segni di
insofferenza.
In men che non si
dica sono a Cracovia. Ho davanti molte ore vuote prima del volo. Kateryna mi
chiede come va il viaggio proprio mentre sto cercando di negoziare con il senso
di colpa per l’essermene andato – un senso di colpa che so riconoscere come
infondato e che tuttavia persiste. Le rispondo che è tutto okay. Silenzio i
gruppi Telegram degli allarmi aerei, ma senza cancellarli. È ancora mattina,
cerco un posto per la colazione. Il compito mi distoglie dal pensiero dei luoghi
e delle persone. Mi concedo tutto il tempo di indugiare. Ne ho quanto voglio, di
tempo, qui: qui dove il tempo ancora esiste, qui dove tutto è ancora libero.
Come le more
selvatiche di Paolo Giordano
Ucraina, un anno di
guerra
Progetto di Barbara
Stefanelli
A cura di Alessandro
Cannavò, Mario Garofalo, Mara Gergolet
Progetto
grafico Giovanni Angeli
Hanno
collaborato: Francesca Basso, Francesco Battistini, Lorenzo Cremonesi, Andrea
Ducci, Giusi Fasano, Samuele Finetti, Federico Fubini, Massimo Gaggi, Marco
Imarisio, Andrea Marinelli, Viviana Mazza, Maria Serena Natale, Andrea Nicastro,
Guido Olimpio, Marilisa Palumbo, Greta Privitera, Federico Rampini, Simone
Sabattini, Giuseppe Sarcina, Marta Serafini, Barbara Stefanelli, Paolo
Valentino, Francesco Verderami, Edoardo Vigna, Paolo Valentino
E con un racconto di
Paolo Giordano
Sviluppo: Fabio
Mascheroni, Stefano D'Angelo, Infografici Corsera, Grafici Online
Cura delle
immagini: Antonella Gesualdo, Michele Lovison, Giovanni Angeli
Milano, febbraio
2023
Stasera Italia,
Federico Rampini sull’economia italiana: basta piagnistei.
Libero Quotidiano il
10 marzo 2023
La guerra tra Russia
e Ucraina ha avuto forti ripercussioni sull'economia europea. Ma non così forti
come, spesso, ci raccontiamo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera
Italia in onda il 10 marzo su Rete4. In collegamento c'era Federico Rampini che
ha sottolineato le performance positive della nostra economia nel 2022.
"Il vizio italiano
del piagnisteo è una cosa insopportabile - ha detto Federico Rampini a Barbara
Palombelli - Sembra che la guerra la stiamo facendo noi. Non c'è stata nemmeno
una mini recessione. Nel 2022, l'anno in cui le sanzioni economiche dovevano
rovinare l'economia italiana, ha visto un boom con un +20% del Made in Italy nel
mondo. Anche perché basta fare un po' di conti di aritmetica, l'economia russa è
microscopica. vale 1/14 dell'economia degli Stati Uniti e non è neanche tra le
prime dieci al mondo. Quindi ci voleva davvero tanta immaginazione per pensare
che perdere il mercato russo sarebbe stata una catastrofe per noi".
Estratto
dell’articolo di Federico Rampini per corriere.it il 23 Febbraio 2023.
Perché tante
previsioni sulla guerra in Ucraina si sono rivelate clamorosamente errate negli
ultimi dodici mesi? Ripercorrere le «profezie mai avverate» è utile, in questo
tragico anniversario dell’invasione. […] Provo a elencare, per capitoli, le
principali smentite che la realtà ha inflitto ai nostri pregiudizi.
1) Vittoria facile
e veloce per Putin.
Questa era
l’opinione più diffusa un anno fa. Era una delle ragioni per cui molti leader
occidentali erano pronti a concedere di tutto e di più alla Russia: a cominciare
da una neutralità ucraina che la consegnava al destino di Stato-satellite di
Mosca. Da che cosa nasceva questa previsione, spazzata via dalla resistenza
ucraina?
Da una
sopravvalutazione delle forze armate russe, legata ad alcuni exploit (Cecenia,
Georgia, Siria) studiati poco e male. Da una sottovalutazione del nazionalismo
ucraino: in molti hanno creduto alla propaganda di Putin secondo cui l’Ucraina
non fu mai stata una vera nazione bensì soltanto una costola della Russia. E
quindi avrebbe dovuto accogliere a braccia aperte l’armata di Putin, almeno in
alcune regioni. […]
2) Apocalisse
energetica.
Un anno fa, e per
mesi dopo l’inizio dell’invasione, molti descrivevano un’Europa sull’orlo di una
terrificante penuria energetica, condannata a un inverno di gelo e stenti. I
rialzi delle tariffe energetiche ci sono stati, hanno picchiato duro sui bilanci
di famiglie e imprese, ma quella crisi è stata più breve e assai meno tragica
del previsto.
L’inverno
abbastanza mite è stato un fattore, ma non il più importante. I paesi europei
hanno dimostrato flessibilità nel diversificare le proprie fonti, andando a
cercare energia altrove. Il sistema delle imprese ha reagito accelerando i
risparmi energetici e l’innovazione. Le fasce sociali più deboli sono state
aiutate grazie ai bilanci pubblici. Perché tante previsioni allarmiste e
catastrofiste? Perché tendiamo a sottovalutare la ricchezza dei nostri stessi
paesi. […]
3) Apocalisse
alimentare.
Idem come sopra. A
un certo punto del 2022 sembrava che ci fosse la carestia alle porte
dell’Italia. Il solito riflesso apocalittico – e forse filorusso – descriveva la
produzione di cereali russi come indispensabile a tal punto, che il mondo intero
stava scivolando verso la fame. Ma la Russia non aveva interesse a cessare le
sue vendite di cereali. E nella misura in cui queste si sono ridotte perché la
guerra ha ostacolato la logistica, il mondo annovera tante altre superpotenze
agricole in grado di compensare (tra i maggiori produttori figurano Stati Uniti,
Canada, Argentina, Brasile, Australia, perfino la sorprendente India).
[…]
4) Le sanzioni
costringeranno la Russia a sedersi al tavolo di negoziato.
È dai tempi di
Mussolini in Etiopia che le sanzioni internazionali falliscono. L’Italia
fascista non cambiò politica estera perché era sottoposta a un regime
sanzionatorio. Lo stesso dicasi per Cuba, Corea del Nord, Iran. Tutti questi
paesi hanno trovato anche dei sistemi per aggirare almeno in parte l’embargo,
figurarsi se la Russia non si era preparata per fare lo stesso. […] Peraltro il
regime di sanzioni contro la Russia oggi vede schierato tutto l’Occidente
insieme con alleati importanti come Giappone, Corea del Sud. Ma gran parte del
mondo, inclusa una potenza filo-occidentale come l’India, il Golfo Persico,
l’Africa e l’America latina, non partecipa al nostro regime di sanzioni. […]
5) La guerra finirà
con la mediazione cinese.
Xi Jinping sta con
Putin a tutti gli effetti. Lo aiuta in modo sostanziale aumentando i propri
rapporti commerciali, da cui lucra anche vantaggi: compra gas e petrolio a
prezzi scontati. La Cina vende anche tecnologie “duali” che i russi usano sul
terreno militare: droni e semiconduttori.
Secondo gli Stati
Uniti Xi starebbe valutando la possibilità di fornire apertamente armi vere e
proprie, pur di risparmiare una umiliante sconfitta all’alleato Putin. La Cina
nel lungo termine colonizzerà la Russia. Anche se questa guerra le ha procurato
delusioni e costi, vede la sua utilità in termini di “distrazione” dell’America
dall’Estremo Oriente.
6) Putin userà
l’arma nucleare.
L’ha minacciata più
volte, ma è una minaccia credibile? Fra le contro-indicazioni, gli esperti
americani indicano il fatto che le armi nucleari tattiche usate in un campo di
battaglia dove le forze sono ravvicinate, possono seminare morte e distruzione
anche tra i soldati russi. Alla mercè dei venti, la radioattività può ritornare
sul territorio russo. […]
7) Putin sta per
sparire: golpe o malattia terminale.
Altra profezia che
circola periodicamente, e altrettanto regolarmente viene dimenticata. Lo abbiamo
visto tutti godersi un bagno di folla nel mega-comizio di due giorni fa a Mosca.
Non sembrava un uomo malato, né assediato dagli oppositori. Gli unici attacchi
visibili contro di lui all’interno della Russia, vengono da falchi della destra
nazionalista come il capo della Divisione Wagner.
Il fatto che lui li
tolleri lascia aperta una supposizione: che sia lui stesso a voler far credere
all’Occidente che una sua caduta sarebbe seguita da un regime ancora più
aggressivo. In ogni caso dietro questa profezia (morte o golpe) c’è anche la
convinzione, o la speranza, che Putin sia l’unico vero problema. […]
Ucraina, un anno
di guerra vista dal Donbass.
L’Espresso il 23
febbraio 2023.
Il mondo non è più
lo stesso da quando i carri armati russi hanno oltrepassato il confine ucraino.
La guerra in Europa è tornata, così come le antiche rivalità che per decenni
hanno governato le relazioni internazionali dalla fine del II conflitto mondiale
alla caduta del Muro di Berlino. Sono tornate le trincee, i campi minati e le
sirene antiaeree a scandire le ore dei civili che hanno scelto di non lasciare
le proprie case. Quelle stesse case che da mesi sono vuote, ridotte (nel
migliore dei casi) a poco più di un magazzino dove avventurarsi per recuperare
qualcosa da portare negli scantinati dove si è costretti a vivere. Al buio,
senza né riscaldamenti né acqua corrente, i boati dell’artiglieria in entrata e
in uscita scandiscono le ore e riportano la vita quotidiana a una condizione di
mera sopravvivenza. Intanto al fronte decine di migliaia di soldati sono morti.
La terra di Mariupol, Kherson, Kharkiv e ora Bakhmut si è trasformata in un
cimitero a cielo aperto dove i due eserciti si sono massacrati per mesi. Il
tutto in nome delle mire espansionistiche del governo di Vladimir Putin che
continua ad accusare l’Occidente di voler annichilire la Russia mentre minaccia
di usare il suo arsenale atomico. Sul campo lo stato maggiore russo prepara una
nuova massiccia offensiva per tentare di spezzare la resistenza delle forze
armate ucraine e conquistare almeno tutto il territorio del Donetsk. Ma le forze
armate ucraine continuano a resistere, sperano in nuove forniture di armi da
parte degli alleati e, dicono i generali, si preparano alla controffensiva. A un
anno dal 24 febbraio 2022, la pace resta un miraggio. (di Sabato Angeri)
Ucraina, un anno
di guerra: dall’invasione al rischio di conflitto nucleare.
Il Tempo il 23
febbraio 2023
È passato un anno
dal lancio dell'operazione militare speciale con cui il presidente russo
Vladimir Putin annunciava di voler "smilitarizzare e denazificare" l’Ucraina. Un
obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si
è trasformato in una lunga guerra di posizione.
Dodici mesi che
hanno sconvolto gli equilibri della geopolitica mondiale e causato centinaia di
migliaia di morti, militari e civili. L'Ucraina ha avuto fin da subito
l'appoggio della Nato e dell'Occidente, trainato dal presidente americano Joe
Biden, che alla vigilia del 24 febbraio si è recato in visita a sorpresa a Kiev
per ribadire il sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Proprio il
leader di Kiev, fino a un anno fa noto principalmente per il suo passato da
attore comico prima di scendere in politica, è diventato 'l'uomo dell'anno' e
simbolo della resistenza. La guerra ha nuovamente scavato un solco fra la Russia
e l'Occidente, riecheggiando i tempi della Guerra fredda e le minacce sull'uso
delle armi nucleari, mentre la prospettiva di un tavolo negoziale sembra ancora
lontana. Di seguito le principali tappe di un anno di conflitto.
FEBBRAIO
LA RUSSIA INVADE
L'UCRAINA - Il 24 febbraio del 2022, prima dell'alba, il presidente russo
Vladimir Putin annuncia di aver deciso di lanciare una “operazione militare
speciale” con l’obiettivo di “smilitarizzare e denazificare l’Ucraina” in
risposta a una richiesta di assistenza dalle autorità delle autoproclamate
repubbliche di Donetsk e Luhansk, minacciando i Paesi che fossero intervenuti di
“conseguenze mai viste prima”. Due ore dopo le truppe russe entrano nel
territorio ucraino e raid aerei e missilistici colpiscono tutto il Paese,
inclusa la capitale Kiev. Gli attacchi missilistici balistici e da crociera
nelle prime 24 ore del conflitto sono 160 e 75 le incursioni aeree. Il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, risponde promulgando la legge marziale,
interrompendo i rapporti diplomatici con la Russia e annunciando la
mobilitazione generale. I russi puntano ad accerchiare la capitale Kiev, ma la
loro avanzata viene rallentata dalla strenua resistenza delle forze armate
ucraine.
MARZO
IL PATRIARCA RUSSO
KIRILL AL FIANCO DI PUTIN – Il 6 marzo il patriarca della Chiesa ortodossa russa
Kirill si schiera la fianco di Vladimir Putin giudicando l’appoggio
all’invasione come un “test di fedeltà al Signore”.
BOMBARDATO TEATRO DI
MARIUPOL USATO COME RIFUGIO - Il 16 marzo un attacco aereo russo colpisce il
teatro di Mariupol, che era usato come rifugio. Secondo un'indagine condotta da
Associated Press, sono circa 600 le persone rimaste uccise, e non 300 come si
riteneva in un primo momento.
"Qualcuno peggiore
di Putin?". Ipotesi smembramento Russia, cosa sa Mikhelidze
ZELENSKY INTERVIENE
AL PARLAMENTO ITALIANO – Il 22 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
interviene al Parlamento italiano. 'Genova come Mariupol. L’Italia congeli i
beni dei russi e chiuda porti”, il suo appello.
MUORE SUL CAMPO DI
BATTAGLIA ITALIANO EDY ONGARO – Il 30 marzo muore nel Donbass il combattente
italiano Edy Ongaro. Originario del Veneto, combatteva a fianco delle forze
filorusse con il nome di battaglia di ‘Bozambo’. Aveva 46 anni.
APRILE
UCRAINA RIPRENDE
REGIONE KIEV E SCOPRE GLI ORRORI DI BUCHA - Man mano che i russi si ritirano
dalla regione di Kiev, emergono gli orrori. Ne diventa simbolo Bucha, sobborgo
di Kiev, le cui immagini scatenano indignazione internazionale e appelli a
indagini per crimini di guerra.
AFFONDA NEL MAR NERO
INCROCIATORE MOSKVA – L’incrociatore Moskva, uno dei fiori dell’occhiello della
marina russa, affonda nel Mar Nero. I militari ucraini rivendicano l’atto
dicendo che la nave è stata colpita con missili da crociera antinave, mentre
Mosca parla semplicemente di un incendio.
MAGGIO
PARATA PER GIORNO
DELLA VITTORIA A MOSCA – Il 9 maggio, in occasione della parata per la vittoria
dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, il presidente russo Vladimir Putin
tiene un lungo discorso sulla Piazza Rossa. “Combattete per la sicurezza della
patria, combattete per la nostra gente nel Donbass”, dice ai soldati, e attacca
l’Occidente che “preparava l’invasione” e la Nato che “non ci ha ascoltati sulle
garanzie di sicurezza”.
INFURIA LA BATTAGLIA
NEL DONBASS, TRUPPE RUSSE AVANZANO – Battaglie sempre più cruenti nel Donbass.
La città ‘martire’ diventa Severodonetsk, presa d’assalto dai russi e poi
occupata nel mese successivo. Le truppe di Mosca prendono anche il controllo di
Lyman e Lysychansk.
GIUGNO
DRAGHI-SCHOLZ-MACRON
A KIEV – Il 16 giugno l’allora presidente del Consiglio italiano Mario Draghi,
il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si
recano in Ucraina. I tre leader, che viaggiano insieme in treno nella notte,
portano un messaggio unitario nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel
sanzionare la Russia e nell'aiutare Kiev. Prima della capitale, i tre si recano
in visita a Irpin.
CONSIGLIO UE CONCEDE
A UCRAINA STATUS CANDIDATO – Il 23 giugno il Consiglio Ue accoglie la proposta
della Commissione di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina.
Fabbri rivela il
vero piano di Putin: resa dell'Occidente o terrore nucleare
LUGLIO
ACCORDO SUL GRANO
- Il 22 luglio a Istanbul viene firmato un accordo sul grano che impegna Ucraina
e Russia, per consentire alle navi di grano di lasciare i porti ucraini del Mar
Nero. La firma dell'intesa, raggiunta con la mediazione dell'Onu, avviene alla
presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del segretario generale
delle Nazioni unite Antonio Guterres.
AGOSTO
UCCISA IN ATTENTATO
DARYA DUGINA, FIGLIA DELL'IDEOLOGO DI PUTIN – Il 20 agosto Darya Dugina, figlia
di Alexander Dugin, filosofo di estrema destra molto vicino a Vladimir Putin,
rimane uccisa in un attentato.
La 29enne
giornalista e analista politica è vittima dell'esplosione della Toyota Land
Cruiser della quale era alla guida. Si ritiene che il padre fosse il bersaglio
dell’attacco, sarebbe infatti dovuto tornare nella capitale russa a bordo della
Toyota guidata dalla figlia, ma all'ultimo momento aveva deciso di cambiare
vettura.
L’AIEA VISITA LA
CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZIA - Il 31 agosto, a seguito dell'intensificarsi
degli scontri per il controllo dell'area, una spedizione internazionale
dell'Aiea guidata dal presidente dell'agenzia Rafael Grossi raggiunge la
centrale nucleare di Zaporizhzhia con lo scopo di valutarne le condizioni e
prevenire incidenti. Un gruppo di tecnici resta alla centrale come presidio.
SETTEMBRE
UCRAINI LANCIANO
CONTROFFENSIVA NELLA REGIONE DI KHARKIV – Il 7 settembre le truppe ucraine
lanciano una controffensiva a sorpresa nella regione di Kharkiv riprendendo il
controllo, fra le altre, delle città di Izyum e Kupiansk, importanti siti
logistici delle forze armate russe. A fine mese i soldati di Kiev liberano anche
Lyman nel Donbass, conquistata dai russi nel corso della primavera.
UCCISO ITALIANO
GIORGIO GALLI, COMBATTEVA CON FORZE UCRAINE – Il 20 settembre viene
ufficializzata la morte del secondo italiano nel corso del conflitto fra Russia
e Ucraina. Si tratta del 27enne italo-olandese Giorgio Galli, combatteva con la
Legione internazionale di difesa dell’Ucraina.
PUTIN ANNUNCIA
MOBILTAZIONE PARZIALE – Il 21 settembre il presidente russo Vladimir Putin
annuncia la mobilitazione parziale. Lo stesso giorno il ministro della Difesa,
Serghei Shoigu, ordina il richiamo alle armi di 300mila riservisti.
SABOTAGGIO GASDOTTO
NORD STREAM - Il 27 settembre vengono scoperte tre falle sottomarine nelle
condotte Nord Stream e Nord Stream 2.
L'ipotesi prevalente
che inizia a farsi strada è che si sia trattato di un atto deliberato,
finalizzato al sabotaggio. Inizialmente, Germania, Danimarca e Svezia mettono le
basi per un'investigazione congiunta, che però non si materializza a causa del
rifiuto svedese.
Le autorità
giudiziarie svedesi confermano ufficialmente che il danno subito dai gasdotti
Nord Stream e Nord Stream 2 sia stato dovuto a un atto di 'grave sabotaggio
causato da una grande quantità di tritolo, quantificabile in centinaia di
chili”.
PUTIN ANNETTE 4
REGIONI UCRAINE - Il 30 settembre il presidente russo Vladimir Putin, in una
cerimonia al Cremlino, firma l'annessione unilaterale delle regioni ucraine di
Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, a seguito di 'referendum'
sull'adesione alla Russia orchestrati da Mosca nelle regioni stesse. Dopo i
“referendum farsa” e “l'annessione illegale”, l'Ue adotta un nuovo pacchetto di
sanzioni.
OTTOBRE
ATTACCO A PONTE
KERCH IN CRIMEA - L'8 ottobre un'esplosione avviene sul ponte di Kerch in
Crimea, il più lungo d'Europa e rotta chiave per le forniture delle forze russe
in Ucraina, provocando il crollo in mare di parte di una sezione e il
danneggiamento della linea ferroviaria.
MUORE FOREIGN
FIGHTER ITALIANO ELIA PUTZOLU – La terza vittima italiana nel conflitto fra
Russia e Ucraina è Elia Putzolu. Il 28enne viveva da tempo in Russia, a Rostov,
e si era arruolato con le milizie filorusse del Donbass.
NOVEMBRE
MISSILE CADE IN
TERRITORIO POLONIA, 2 MORTI - Il 15 novembre un missile colpisce il territorio
della Polonia nel villaggio di Przewodow, vicino al confine con l'Ucraina,
causando la morte di due persone. L'incidente avviene durante un attacco alle
città ucraine e agli impianti energetici da parte della Russia. Si tratta del
primo incidente del genere all'interno del territorio della Nato. Il mondo
intero trema per qualche ora, poi, dopo le prime valutazioni, viene appurato che
si trattava di un missile di difesa aerea delle forze ucraine lanciato per
difendersi da quelli russi.
IL G20 DI BALI
CONDANNA GUERRA IN UCRAINA NONOSTANTE DIVISIONI.
ZELENSKY PROPONE
PIANO DI PACE – A Bali, in Indonesia, si tiene il G20. Nella dichiarazione
finale la “maggior parte” dei membri condanna con forza la guerra in Ucraina,
nonostante la vicinana di diversi Paesi a Mosca, sottolineando come il conflitto
stia causando immense sofferenze umane e aggravando le fragilità esistenti
nell'economia globale. In occasione del vertice il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky interviene da remoto proponendo un piano di pace in dieci punti.
DICEMBRE
RUSSIA LIBERA LA
STAR DEL BASKET USA GRINER IN CAMBIO DEL RILASCIO DEL 'MERCANTE DI MORTE' VIKTOR
BOUT – L’8 dicembre Russia e Usa effettuano uno scambio di prigionieri di alto
livello: la cestista statunitense Brittney Griner in cambio del trafficante
d'armi russo Viktor Bout.
Griner era stata
arrestata all'aeroporto di Mosca pochi giorni prima dell'invasione russa
dell'Ucraina, dopo essere stata fermata con l'accusa di detenzione di cartucce
per sigarette elettroniche contenenti cannabis. Bout invece è uno dei più noti
‘mercanti di morte’ internazionali. A lui è ispirato il film di Hollywood 'Lord
of war' con Nicolas Cage.
ZELENSKY ALLA CASA
BIANCA DA BIDEN – Il 21 dicembre visita a sorpresa di Volodymyr Zelensky a
Washington. Mantenuto segreto fino all'ultimo, il viaggio del presidente
ucraino, il primo fuori dal Paese dall'inizio della guerra, ottiene un
importante risultato: la conferma del sostegno americano alla resistenza
ucraina, con l'annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,8 miliardi
di dollari, comprendente anche la prima batteria di missili Patriot.
GENNAIO
MISSILE RUSSO
COLPISCE PALAZZO A DNIPRO, 45 MORTI – Il 14 gennaio un missile russo colpisce un
palazzo nel centro di Dnipro. Il bilancio è di 45 morti, fra cui sei bambini, il
più piccolo di 11 mesi.
MUORE IN ELICOTTERO
MINISTRO INTERNO KIEV – Il 18 gennaio muore il ministro degli Interni ucraino
Denys Monastyrskyi. L’uomo era a bordo di un elicottero che si schianta vicino a
un asilo a Brovary, nella regione di Kiev. La destinazione finale del viaggio
era la zona più calda del conflitto. Tra le vittime anche il suo vice Yevhen
Yenin e il segretario di Stato del ministero degli Affari interni. Il bilancio
complessivo dell’incidente è di 18 morti, fra loro anche tre bambini.
USA E GERMANIA
UFFICIALIZZANO INVIO A KIEV DI CARRI ARMATI ABRAMS E LEOPARD – Il 25 gennaio il
presidente americano, Joe Biden, ufficializza l’invio a Kiev di 31 carri armati
Abrams.
Contestualmente,
dopo aver a lungo tentennato, il cancelliere Olaf Scholz fa altrettanto per 14
tank tedeschi Leopard.
SIGNIFICATIVO
RIMPASTO NEL GOVERNO UCRAINO E FRA I GOVERNATORI REGIONALI – Su indicazione del
presidente Zelensky avviene un significativo rimpasto nel governo ucraino, in
seguito ad accuse di corruzione verso alcuni funzionari. Saltano, fra gli altri,
quattro viceministri, cinque governatori regionali e il vice capo della
segreteria del presidente, Kyrylo Tymoshenko.
FEBBRAIO
L’ASSEDIO DI
BAKHMUT – Sede di feroci combattimenti da mesi, la città di Bakhmut, nel
Donbass, è il nuovo epicentro del conflitto fra forze russe, con i mercenari
della compagnia Wagner, e ucraine. Si combatte casa per casa per questo centro,
snodo cruciale per le linee di rifornimento da una parte e dall’altra.
ACCORDO
ITALIA-FRANCIA PER INVIO SISTEMA DIFESA AEREA SAMP-T ALL’UCRAINA – Roma e Parigi
annunciano l’accordo per l’invio del sistema di difesa aerea italo-francese
Samp-T all’Ucraina.
URSULA VON DER LEYEN
E DELEGAZIONE COMMISSIONE UE A KIEV – La presidente della Commissione Ue, Ursula
Von der Leyen, e una delegazione di commissari, fra cui anche l’italiano Paolo
Gentiloni, si reca in visita a Kiev. “L’Ue sostiene l’Ucraina più fermamente che
mai”, dichiara Von der Leyen.
ZELENSKY A LONDRA,
PARIGI E BRUXELLES – L’8 febbraio, a sorpresa, il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky va in visita a Londra, dove incontra re Carlo e il premier Rishi Sunak.
Poi pronuncia un discorso davanti al parlamento dove chiede l’invio di aerei da
combattimento per difendere la libertà dell’Ucraina. Successivamente Zelensky
viene invitato a Parigi per un incontro con Emmanuel Macron e il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, che scatena l’irritazione italiana. Il 9 febbraio il leader
di Kiev arriva a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo e a una seduta
straordinaria della plenaria del Parlamento europeo. “La pace sarà possibile
solo quando vinceremo”, dichiara.
A MONACO DI BAVIERA
LA CONFERENZA SULLA SICUREZZA, CINA PREANNUNCIA UN PIANO DI PACE – Alla
Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera la Cina afferma che la guerra in
Ucraina “deve finire” e che presto Pechino proporrà una sua iniziativa per
superare la crisi. Gli Usa accusano la Russia di crimini di guerra.
JOE BIDEN A SORPRESA
A KIEV - Il 20 febbraio Joe Biden si reca a sorpresa a Kiev, in una visita
storica e senza precedenti. 'Un anno dopo l'Ucraina resiste, la democrazia
resiste', le parole pronunciate dal presidente americano a fianco di Volodymyr
Zelensky. Biden attacca poi frontalmente Vladimir Putin, che 'pensava di poterci
sconfiggere, ma sta fallendo'. Il presidente Usa annuncia un altro mezzo
miliardo di dollari di nuovi aiuti a Kiev.
PUTIN PARLA AD
ASSEMBLEA RUSSA E ANNUNCIA SOSPENSIONE TRATTATO START - A 24 ore dalla visita di
Joe Biden a Kiev, il presidente russo Vladimir Putin prende la parola davanti
all'Assemblea federale e annuncia la sospensione della partecipazione della
Russia al trattato Start per la riduzione degli arsenali nucleari. Il leader del
Cremlino continua ad attaccare l'Occidente e l'Ucraina, considerati i 'veri
responsabili' della guerra in corso, e conferma la 'prosecuzione dell'operazione
militare speciale'. Biden interviene da Varsavia rimarcando il sostegno Usa e
occidentale a Kiev.
GIORGIA MELONI IN
VISITA A KIEV - Il 21 febbraio Giorgia Meloni arriva in visita a Kiev per
ribadire 'il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa',
l'Italia 'non intende tentennare e non lo farà'. Meloni annuncia inoltre di
voler lavorare a una conferenza sulla ricostruzione da tenersi in aprile. Nel
corso della conferenza stampa congiunta, il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky attacca Silvio Berlusconi per averlo criticato: 'Credo che la sua casa
non sia mai stata bombardata dai missili e non gli siano mai arrivati i carri
armati in giardino'.
La guerra in
Ucraina e l’occasione mancata dell’autonomia strategica europea.
Marco Carnelos
il 24 Febbraio 2023 su Inside Over.
Questo articolo è la
traduzione italiana di un articolo apparso sul ventesimo numero del magazine
inglese di Inside Over, “The Perfect Storm”, dedicato alle conseguenze di un
anno di guerra in Ucraina. Il magazine intero è leggibile a questo link,
l’articolo in inglese è invece disponibile qui.
L’invasione russa
dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 verrà ricordata tra gli eventi cardine del XXI
secolo.
Ad oggi non vi è un
aspetto delle relazioni internazionali o dell’economia globale che non sia stato
toccato da questo conflitto e dalle reazioni che ha provocato. Appena tre
decenni dopo la caduta del muro di Berlino, si prospetta una Guerra Fredda 2.0,
con un riallineamento geopolitico globale che avrà impatto su commercio, filiere
e reti finanziarie in tutto il mondo.
Il celebre
antropologo e storico francese Emmanuel Todd sostiene addirittura che sia
cominciata la Terza Guerra Mondiale, aggiungendo che le leadership coinvolte
mostrano una preoccupante “vertigine nichilista”.
A Mosca il conflitto
viene percepito come una questione esistenziale per la Russia; tuttavia, vi
sono segnali che potrebbe trattarsi di una questione esistenziale anche per le
democrazie occidentali. Il Segretario Generale della NATO ha
persino affermato che il vero rischio non sia un’escalation, ma una vittoria
della Russia.
Chiunque sarà a
prevalere otterrà un ruolo maggiore nel dettare le regole del futuro ordine
mondiale, e in particolare se quest’ultimo continuerà ad essere sotto
l’esclusiva leadership statunitense o se si sposterà verso un vero e proprio
sistema multipolare.
In seguito a questo
conflitto, nulla potrà più essere come prima; ma per le relazioni
transatlantiche, l’invasione russa dell’Ucraina è stata una vera panacea.
Nel 2019, l’allora
Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di ritirare gli Stati
Uniti dalla NATO se i suoi altri membri non avessero incrementato la propria
spesa militare. Fece seguito il Presidente francese Emmanuel Macron, il
quale sostenne che “Stiamo assistendo alla morte cerebrale della NATO” e
che “L’alleato degli Stati Uniti sta voltando le spalle a questioni
strategiche”.
Nell’estate del 2021
poi, Stati Uniti e NATO si ritirarono rovinosamente dall’Afghanistan.
L’umiliante fuga da Kabul suscitò seri dubbi sull’Alleanza e fomentò forti
tensioni a livello transatlantico.
Oggi la situazione è
cambiata radicalmente, e per questo dovremmo tutti ringraziare la decisione
sconsiderata di Vladimir Putin. Se si dovesse pensare ad un modo per celebrare
la rinascita delle relazioni transatlantiche, non ci sarebbe niente di meglio di
un busto del leader russo collocato in maniera provocatoria all’interno del
salone del Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles, con sotto la scritta
“L’uomo che ha salvato l’Alleanza Atlantica”.
Oggi la NATO e
l’Unione Europea stanno fronteggiando la Russia in Ucraina in maniera coesa,
fornendo enorme sostegno economico e militare, e anche attraverso le sanzioni
più dure mai imposte alla Russia. Quest’ultime includono l’interruzione di tutte
le forniture di petrolio e gas in Europa, il congelamento di circa 350 miliardi
di dollari in fondi russi depositati presso banche occidentali, ed il
significativo aumento della spesa militare dei Paesi europei, con la Germania
che ha annunciato un aumento senza precedenti di 100 miliardi di euro. Se
l’espansione orientale della NATO verso l’Ucraina si è momentaneamente
arrestata, quella verso nord sembra proseguire senza intoppi, con gli imminenti
ingressi da parte della Finlandia e, se la Turchia acconsentirà, della Svezia.
La coraggiosa visita
del Presidente Biden a Kiev il 20 febbraio è stata il momento più iconico di
questa sequenza di successi.
Non si dovrebbe
sorvolare su come la guerra abbia suscitato reazioni che vanno ben oltre il
continente europeo e l’alleanza transatlantica.
Lo scorso maggio,
l’Alleanza Atlantica lanciò il suo nuovo Strategic Concept dichiarando che “La
Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli
Alleati, alla pace e alla stabilità dell’area euro-atlantica… [e alle] regole
dell’ordine internazionale”.
Anche la Cina è
stata inclusa nel Concept per la prima volta, rimarcando come “[le sue]
ambizioni
dichiarate e
politiche coercitive sfidano i nostri interessi, la nostra sicurezza ed i nostri
valori. […] Tentano di sovvertire le regole dell’ordine internazionale. […] Il
rafforzamento della collaborazione strategica tra la Repubblica Popolare Cinese
e la Federazione Russa […] mira ad erodere l’ordine internazionale”.
Un’evoluzione
politica radicale: se la Russia era il principale fornitore energetico
dell’Europa, la Cina è ancora il più grande partner commerciale dell’Unione
Europea, nonché degli Stati Uniti.
Da allora, sia la
NATO che l’Unione Europea hanno adottato non solo la posizione degli Stati Uniti
verso la Russia, ma anche le loro crescenti preoccupazioni nei confronti della
Cina. È tutto costruito sulla narrativa dell’Amministrazione Biden che
ha incorniciato l’attuale momento geopolitico come il punto di flesso per un
epico confronto tra regimi democratici ed autocratici.
Per fronteggiare le
autocrazie di Russia e Cina, la rinnovata collaborazione transatlantica è anche
pronta a digerire una maggiore e pericolosa coordinazione tra Mosca e Pechino,
come non accadeva dal culmine della Guerra Fredda negli anni ’50 e ’60. Sembra
che la NATO e l’Unione Europea stiano abbandonando la globalizzazione per come
l’abbiamo conosciuta negli ultimi trent’anni. Le filiere tradizionali compresa
quella energetica stanno cambiando o venendo riconsiderate, le rotte commerciali
reindirizzate, ed espressioni
come near-shoring, re-shoring e de-coupling vengono ora utilizzate di frequente
nel gergo economico e commerciale.
Sebbene sia l’esito
che il costo finale di questo cambiamento geopolitico siano ancora incerti, non
c’è dubbio sul fatto che l’Europa abbia già pagato il prezzo più caro.
La diversificazione
di forniture energetiche da quella russa sta presentando conti salati per i
consumatori europei e per la competitività delle loro economie. Le sanzioni ai
danni della Russia, insieme a quelle che incombono sulla Cina, rischiano di
mettere tutte le filiere sotto forte pressione e di interrompere una relazione
commerciale sinora così tanto proficua. In mezzo alle conseguenze involontarie
di questo cambiamento politico rientrano anche l’aumento dell’inflazione e
quello dei tassi di interesse, che potrebbero entrambi cambiare radicalmente gli
schemi economici degli ultimi quattro decenni.
Il Chip Act,
adottato dall’Amministrazione Biden lo scorso ottobre per fermare la vendita di
semiconduttori alla Cina, potrebbe suscitare una considerevole guerra
tecnologica, che in qualche modo potrebbe a sua volta rallentare l’attuale corso
della Quarta Rivoluzione Industriale, senza menzionare le crescenti tensioni con
Taiwan.
Il cosiddetto IRA
(Inflation Reduction Act), recentemente adottato da Washington per spronare la
transizione ecologica, sta creando forti tensioni commerciali con l’Unione
Europea.
Sfortunatamente,
nonostante tutte le previsioni occidentali, le sanzioni non hanno ancora messo
la Russia in ginocchio. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2024 si
prevede addirittura una crescita dell’economia russa del 2,1%, maggiore rispetto
a quella di Germania e Regno Unito.
Inoltre, le sanzioni
contro Mosca sono state adottate solo dalle democrazie occidentali e da pochi
altri Paesi asiatici che la pensano allo stesso modo.
Al consolidamento
dell’alleanza transatlantica non è dunque corrisposto un consolidamento della
leadership mondiale da parte del cosiddetto Global West. La convinzione di
vecchia data delle democrazie occidentali che il mondo ruoti intorno ad esse è
stata messa in discussione, ed un mondo diverso sta prendendo forma. Sebbene in
maniera indistinta, è il cosiddetto Global Rest a sembrare in ascesa,
sviluppando una propria coscienza geopolitica. Un crescente numero di economie
emergenti si stanno estraniando da narrative, visioni e politiche occidentali,
nonché dai sistemi finanziari globali strettamente legati all’Occidente; la
de-globalizzazione è imminente, e anche la de-dollarizzazione.
Una lunga lista di
Paesi — soprattutto tradizionalmente alleati al Global West — non sta più
mostrando lo stesso affetto per quell’ordine mondiale a matrice statunitense che
dal 1945 ha determinato le politiche globali. Algeria, Argentina, Egitto,
Indonesia, Nigeria, Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, giusto per
citarne alcuni, percepiscono tale ordine come fazioso, talvolta ipocrita, e
spesso caratterizzato da due pesi e due misure, con regole che sembrano
formalmente valide per tutti tranne che per una cerchia ristretta di Paesi
occidentali. Queste economie emergenti si stanno mettendo in fila per entrare a
far parte del Global Rest, dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica),
il vero alter ego globale del G7.
Non c’è dubbio che
la Russia sia stata efficacemente isolata dal Global West, e nemmeno che
l’alleanza transatlantica si sia vigorosamente rafforzata; tuttavia, ci sono
anche sconfortanti segnali di come il Global West appaia sempre più isolato dal
Global Rest. Per prevalere sulle autocrazie occorre conquistare i cuore e le
menti di tutto il mondo, non solo degli elettori in Occidente.
Malgrado la meritata
condanna e punizione della Russia, il conflitto avrebbe potuto essere sfruttato
meglio dall’Unione Europea come una chance unica per dare contenuto alla propria
autonomia strategica ampiamente sostenuta, spingendo di più per delle soluzioni
negoziate mantenendo al tempo stesso il supporto all’Ucraina.
L’Unione Europea ha
invece optato per essere il junior partner degli Stati Uniti ed un’istituzione
di traino nell’area di Polonia e Baltico. È sconcertante quanto persino il Regno
Unito, che ha recentemente abbandonato l’Unione Europea, a Bruxelles sembri
godere rispetto a prima di un’influenza politica maggiore.
Le relazioni
transatlantiche si sono rafforzate con discreto successo; un risultato
fondamentale, considerata l’incertezza del futuro che si prospetta.
Forse si sarebbero
potute rafforzare in una maniera migliore.
Se il prezzo che
l’Europa ha pagato ne varrà la pena lo scopriremo soltanto negli anni a venire.
Dossier: Un anno
di guerra in Ucraina.
Mauro Indelicato il
20 Febbraio 2023 su Inside Over.
Tutte le fasi della
guerra in Ucraina
INDICE DOSSIER
Tutte le fasi
della guerra in Ucraina
Cosa succede a
est? La guerra nel Donbass
Dall'occupazione
alla riconquista: cosa succede a Kherson
Linee rosse e
ipotesi di riconquista. La Crimea al centro della guerra
Ecco dove si
decide la guerra in Ucraina
Il populismo di
guerra di Zelensky
Com'è cambiata la
corte di Putin dall'inizio della guerra
Corruzione,
purghe e dimissioni: le lotte per il potere in Ucraina
Il volto della
guerra: cosa ci ha insegnato
La guerra dei
droni nei cieli dell'Ucraina
Missili, tank e
jet: così la guerra è diventata un banco di prova per le armi
Eserciti di
Russia e Ucraina a confronto: cosa ha insegnato la guerra
L'industria
bellica globale dopo la guerra in Ucraina
Le spie
anglosassoni al servizio di Kiev
Tutti gli errori
e i problemi dell'esercito russo nella guerra in Ucraina
Dalla maskirovka
all'impegno del Wagner: un anno di strategie russe in Ucraina
Un anno di guerra
in Ucraina: ecco cosa non abbiamo capito
Sabotaggi dietro
le linee nemiche. Così Kiev colpisce la Russia
La guerra in
Ucraina e la nuova logica dei blocchi
La guerra in
Ucraina: rischi e opportunità per la Cina
Turchia, Israele
e Vaticano: a che punto è la mediazione tra Russia e Ucraina
La guerra e lo
smarrimento Ue: così la Nato si è “ripresa” l’Europa
La guerra in
Ucraina e la partita italiana nella Nato
Un anno di
guerra: chi ha davvero aiutato l'Ucraina in Italia
Le armi
dell'Italia a Kiev: cosa abbiamo inviato
La partita
energetica a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina
Con l’Ucraina ma
divisa sugli armamenti a Kiev: il paradosso della sinistra in Italia
La guerra
in Ucraina inizia il 24 febbraio 2022. Le operazioni militari vengono avviate
dalla Russia subito dopo un discorso, trasmesso alla Tv di Stato poco prima
dell’alba, pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin. È il secondo
importante discorso tenuto in quei giorni. Il primo, trasmesso la sera del 21
febbraio, viene visto come vero preambolo del conflitto per via della
comunicazione della scelta di riconoscere le due repubbliche separatiste
filorusse di Donetsk e Lugansk.
Il discorso del 21
febbraio 2022
Le due entità cioè
sorte nel 2014, a seguito dell’arrivo a Kiev di un governo filo occidentale dopo
la rivolta di Euromaidan. I separatisti controllano porzioni della regione nota
con il nome di Donbass, lì dove la maggior parte della popolazione viene
segnalata come russofona. I disordini del 2014 sono parzialmente frenati
dagli accordi di Minsk, siglati tra il 2014 e il 2015. Con quel documento, Mosca
e Kiev si impegnano nel far rispettare il cessate il fuoco e a lavorare per la
creazione di un’Ucraina federale, dove il Donbass è destinato ad avere maggiore
autonomia. Con il riconoscimento delle due repubbliche, la Russia rompe la linea
tracciata dagli accordi di Minsk. E tre giorni dopo, rispondendo a formali
richieste di aiuto da parte di Donetsk e Lugansk, inizia l’operazione militare
contro l’Ucraina.
Ore 5:51 del 24
febbraio: Mosca annuncia l’avvio dell’operazione militare
Il 23 febbraio, nel
cuore della tarda serata, arriva la richiesta ufficiale, da parte delle
repubbliche di Donetsk e Lugansk, di aiuto alla Russia. I due governi
riconosciuti dal Cremlino, in stato di emergenza già dal 17 febbraio, dichiarano
di temere un attacco ucraino. Si inizia a capire a livello internazionale che il
conto alla rovescia prima dell’attacco russo è prossimo allo zero.
Sono le ore 3:51 del
24 febbraio in Italia, le 5:51 a Mosca, quando Vladimir Putin ricompare in tv.
Lo scenario è lo stesso del discorso del 21 febbraio, per molti la televisione
russa sta solo trasmettendo un altro stralcio del video registrato pochi giorni
prima. Uno stralcio però destinato a cambiare la storia. Putin infatti annuncia
ufficialmente di aver iniziato un’operazione militare in Ucraina, volta a
preservare la sicurezza della popolazione russofona del Donbass.
Il discorso del 24
febbraio
Ma negli obiettivi
si spinge anche oltre: il presidente russo parla anche di demilitarizzazione e
soprattutto “denazificazione” dell’Ucraina. Ammonendo l’occidente di non
intromettersi, pena “una risposta ancora mai vista nella storia”. Mentre Putin è
in onda, a Kiev si sentono le prime esplosioni. La città non comprende subito di
essere in guerra: fino alla prima mattinata del 24 febbraio il traffico è ancora
intenso, gli uffici sono aperti. Il suono delle sirene antiaeree riporta tutti
alla realtà. Il conflitto è appena iniziato.
Le prime operazioni
via terra
Le prime immagini
che arrivano dall’Ucraina mostrano soprattutto dei bombardamenti. Vengono
attuati a Kiev, a Kharkiv, a Odessa, a Mariupol, persino a Leopoli, principale
città della parte occidentale del Paese, lontana geograficamente e non solo dal
Donbass. Video ufficiali russi, ma anche video amatoriali ucraini mostrano le
esplosioni e le deflagrazioni provocate dai raid. Anche i giornalisti presenti
in Ucraina annotano i continui allarmi aerei e la presenza di mezzi russi sui
cieli del Paese.
Ma dopo le prime
luci dell’alba si capisce subito che l’operazione russa non è solo aerea. Il
ministero della Difesa ucraino denuncia l’ingresso di truppe russe dal confine
con la Bielorussia, dalle frontiere orientali e dalla Crimea. Un attacco a tutto
tondo quindi da nord, da est e da sud. Si parla anche di un possibile sbarco
anfibio a Odessa e Mariupol, ma la notizia viene smentita.
Le forze russe ai
confini dell’Ucraina prima dell’attacco (Gennaio 2022)
La prima vera
operazione militare segnalata è quella di Gostomel, lì dove sorge il principale
aeroporto a nord di Kiev. I russi inviano qui paracadutisti, l’obiettivo sembra
essere quello di conquistare subito lo scalo e farne una base per i soldati
entrati dalla Bielorussia e proiettati verso la capitale ucraina. A metà
mattinata l’aeroporto viene dato per conquistato dalle forze di Mosca. In realtà
ne nasce una cruenta battaglia dall’esito incerto: per giorni le due parti
rivendicano il controllo della zona. Ad ogni modo, i russi sembrano sorpresi
dalla reazione ucraina a Gostomel. Ai parà russi non riesce infatti l’effetto
sorpresa, mesi dopo viene rivelato da alcun fonti di intelligence che gli Usa, a
conoscenza dei piani di Mosca, avvisano il governo ucraino dell’operazione
attorno lo scalo.
Contestualmente, a
poco più di 100 km di distanza verso nord, i russi entrati dalla Bielorussia
marciano verso Kiev. Nella serata del 24 febbraio viene conquistata l’ex
centrale nucleare di Chernobyl, aprendo così la strada verso l’area a nord della
capitale ucraina.
Da est invece i
russi premono subito su Kharkiv. La seconda città del Paese ha al suo interno
un’importante presenza di popolazione russofona. Mosca spera di fare leva su
questo per avere dalla propria parte i cittadini. I soldati inviati dal Cremlino
non puntano solo su Kharkiv, ma anche sulle ampie zone di campagna dell’oblast
di Lugansk, considerato dall’omonima repubblica separatista come parte
integrante del proprio territorio.
L’altra direttrice
di attacco segnalata il 24 febbraio è quella meridionale. Le truppe di Mosca
entrano dalla Crimea, penisola annessa nel 2014 subito dopo la rivolta di Piazza
Maidan. Si dirigono verso nord conquistando subito Nova Kakhova e spingendo a
est verso Melitopol e Mariupol e a ovest verso Kherson. Qui l’avanzata russa è
più lineare e importante che altrove. Il 3 marzo la bandiera russa sventola già
su Kherson, primo capoluogo di regione conquistato dalle forze di Putin.
L’assedio di Kiev e
i tentativi di prendere Kharkiv
Anche se il fronte
più importante, sotto il profilo politico, sembra quello del Donbass, in realtà
i russi provano da subito ad arrivare nella capitale ucraina. L’obiettivo, mai
ammesso ufficialmente dal Cremlino, è mozzare la testa allo Stato ucraino. E
quindi mettere i piedi a Kiev e porre fine all’esperienza politica del governo
guidato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo, a partire dal
24 febbraio, si presenta costantemente in video su Telegram e sui social con una
maglietta che ricorda l’uniforme militare. Zelensky chiarisce di non voler
lasciare Kiev e di continuare a guidare il governo e le istituzioni ucraine
assieme ai suoi fedelissimi.
La capitale viene
bersagliata dai raid, soprattutto in periferia. Via terra, avanzano le truppe
entrate dalla Bielorussia e dal nord, tramite le regioni di Sumy e Chernihiv. I
militari di Mosca provano una manovra a tenaglia: dal lato nord occidentale si
prova ad avanzare dal quadrante di Gostomel, Bucha e Irpin, mentre dal lato nord
orientale l’obiettivo è avanzare da Sumy e prendere Brovary.
Nel primo caso, i
russi non riescono a raggiungere il centro di Irpin, ultima località prima dei
confini amministrativi della città di Kiev. Nel secondo, le truppe inviate da
Putin hanno difficoltà nella gestione delle retrovie per via del mancato pieno
controllo del territorio, caratterizzato da foreste che appaiono terreno fertile
per le imboscate ucraine. È in questo settore che i russi subiscono le prime
importanti perdite della guerra.
Occorre poi
considerare anche la reazione popolare. Nonostante una popolarità calante per
Zelensky prima del conflitto, l’attacco russo determina l’appoggio
incondizionato della popolazione all’esercito e alle istituzioni ucraine. A Kiev
vengono organizzate barricate in attesa dell’arrivo dei russi, il parlamento
autorizza l’applicazione della legge marziale con conseguente inizio della
mobilitazione. In molti si arruolano e vengono creati anche gruppi di difesa
territoriale.
Emblematica la
situazione a Kharkiv. La presenza di una grande comunità russofona non coincide
con l’appoggio della popolazione all’operazione militare russa. Il 27 febbraio
le truppe di Mosca sono alle porte della seconda città ucraina, ma vengono
respinte dopo una feroce battaglia in periferia. Nessuno tra i cittadini dà
manforte ai soldati del Cremlino, non c’è alcun appoggio popolare verso le
truppe avversarie. Kharkiv rimane in mano a Kiev e viene costantemente
bombardata anche in centro. Circostanza che amplifica il sostegno dei cittadini
ai soldati ucraini. E che crea forse per la prima volta una forte
identificazione della città con la causa ucraina.
Le truppe russe
avanzano però a sud di Kharkiv. Tra febbraio e aprile vengono prese alcune
località strategiche, considerate come via di accesso al Donbass. Tra queste
figurano Kupyansk, Izyum e Lyman.
Mappa di Alberto
Bellotto
30 marzo: Mosca
annuncia il ritiro dall’area di Kiev
Dopo un mese di
guerra, la situazione sul campo vede le truppe russe avanzare soprattutto a sud.
La presa di Kherson e dell’area compresa tra la Crimea e il fiume Dnepr,
permette a Mosca di dilagare verso Melitopol e Berdiansk. In questo modo
l’intera costa del Mar d’Azov è in mano russa e i soldati iniziano ad assediare
Mariupol. Ossia uno dei principali obiettivi militari e politici, essendo la
città inclusa all’interno dell’oblast di Donetsk e rivendicata dai separatisti.
A Kiev invece i
russi vanno incontro a un pesante stallo. Le vie di comunicazione tra il confine
ucraino e l’area della capitale sono di difficile controllo: saltano i
rifornimenti, vengono uccisi diversi importanti generali, oltre che a numerosi
soldati. Molti di questi, come ricostruito inseguito con il ritrovamento dei
documenti, sono giovanissimi.
Nel frattempo, anche
con la mediazione della Turchia, si apre un canale di dialogo. Il 30 marzo due
delegazioni russe e ucraine si incontrano a Istanbul, alla presenza del
presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Proprio quel giorno Mosca annuncia un
riposizionamento dei soldati. Alle proprie truppe viene dato l’ordine di
lasciare l’area a nord di Kiev, comprese le proprie postazioni nelle regioni di
Chernihiv e Sumy. Se il Cremlino parla di riposizionamento, l’Ucraina invece usa
il termine ritiro e parla di prima vittoria contro il nemico.
Tra la fine di marzo
e i primi giorni di aprile, i soldati russi rientrano nelle postazioni in
Bielorussia e in territorio russo. Gostomel, Bucha, Irpin, Brovary, Borodyanka,
Chernobyl, vengono evacuate e ritornano nel pieno possesso delle forze ucraine.
Kiev denuncia massacri e fosse comuni, soprattutto nella località di Bucha.
Zelensky accusa la Russia, alcune inchieste giornalistiche curate anche dal New
York Times parlano di uccisioni contro civili effettuate da alcuni battaglioni
provenienti dall’oriente russo. Mosca smentisce e parla di mera propaganda
ucraina.
La città di Kiev
intanto ad aprile riesce a tornare lentamente alla normalità. Molte barricate
vengono tolte, molti cittadini rientrano a casa ed escono dai rifugi di fortuna.
La presenza della guerra però è resa palese dai continui allarmi aerei che
scuotono la metropoli.
Gli occhi si
spostano su Mariupol
Nel secondo mese di
guerra tutte le attenzioni sono su Mariupol. La città costituisce il principale
porto ucraino sul Mar d’Azov ed è uno degli obiettivi principali della campagna
avviata dai russi. Già nel 2014 il suo territorio è passato di mano più volte
tra Kiev e i separatisti, fino alla definitiva riconquista da parte ucraina.
Anche per questo Mosca punta molto sulla presa della città.
Mariupol risulta
circondata già dai primi giorni del conflitto e questo grazie alla rapida
avanzata delle truppe russe sul fronte meridionale. Inoltre, separatisti e
regolari russi riescono tra febbraio e marzo ad avanzare da est stringendo i
soldati ucraini in una morsa. Tra le forze di Kiev, figurano i combattenti
del Battaglione Azov. Si tratta di uno dei gruppi nazionalisti più noti nel
Paese, attivo già dal 2014 e formato da movimenti che spesso non hanno nascosto
simboli neonazisti. Mosca, così come anche alcune organizzazioni internazionali,
accusano il gruppo di azioni criminali compiute a danno dei separatisti nel
2014.
Il Battaglione ha
sede proprio a Mariupol e anche se dal 24 febbraio i comandanti iniziano a
inviare propri membri in altre regioni dell’Ucraina, è in questa città che Azov
mantiene il più solido radicamento territoriale. L’impressione quindi è che
all’interno della città ci si prepari a una cruenta resa dei conti.
La Russia, oltre ai
propri soldati regolari e ai separatisti, schiera a Mariupol anche i
combattenti ceceni inviati dal presidente ceceno Ramzan Kadyrov. Presenti anche
a Kiev, dopo l'abbandono delle aree attorno alla capitale i ceceni vengono
dirottati sulle sponde del Mar d'Azov. La loro esperienza nei combattimenti
urbani da subito appare decisiva.
La vera battaglia ha
inizio il 18 marzo, quando i russi conquistano l'aeroporto. Ma già da prima
Mariupol capisce di essere destinata al ruolo di vera martire del conflitto. I
bombardamenti sono infatti incessanti e il 12 marzo un raid colpisce
il teatro dell'opera, uno dei simboli della città e in quel momento rifugio per
tante famiglie scappate da casa. La situazione umanitarie scivola velocemente
verso il collasso. Manca l'acqua, manca la luce, il cibo arriva a singhiozzo. Si
prova a far evacuare i civili, ma i corridoi umanitari concordati tra Kiev e
Mosca spesso falliscono con accuse reciproche da entrambe le parti.
È in questo
terribile contesto che dalla seconda metà di marzo e fino all'intero mese di
aprile va avanti la battaglia urbana. I russi avanzano quartiere per quartiere e
isolato per i solato. I ceceni conquistano ogni singolo palazzo delle zone
nevralgiche, a volte anche entrando negli edifici con grandi scale di legno.
Tanto è vero che viene coniato il termine di “battaglia medievale” di Mariupol.
La svolta arriva il
21 aprile. Quel giorno Putin e il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, si
incontrano al Cremlino con il titolare del dicastero che annuncia al presidente
la conquista della città. Manca però soltanto una zona: è quella
delle acciaierie Azovstal. Di proprietà dell'oligarca ucraino Rinat Akhmetov,
l'impianto prima della guerra era il più grande nel suo genere in Europa. Al suo
interno si trincerano gli ultimi combattenti del Battaglione Azov decisi a non
arrendersi. Putin dispone l'accerchiamento dell'acciaieria e la sospensione dei
combattimenti. Una situazione destinata ad andare avanti per un mese.
Dopo molteplici
trattative, mediate dalle Nazioni Unite e soprattutto dalla Turchia, si decide
per l'evacuazione dei membri di Azov all'interno dell'acciaieria. Le loro
condizioni sono al limite, molti sono feriti e ustionati, senza cure e senza
cibo da giorni. Mosca parla di resa, Kiev di azione volta a limitare i danni. Il
22 maggio l'evacuazione viene completata: i combattenti ucraini vengono portati
nel territorio di Donetsk in attesa di processi o di scambi di prigionieri.
Mariupol viene considerata definitivamente conquistata dai russi.
Dalla conquista di
Mariupol alla presa di Severodonetsk e Lysychansk
La presa della città
sul Mar d'Azov è un punto importante per Mosca. Il prezzo pagato è però salato:
sono morti migliaia di combattenti, la città è in rovina e soltanto il 10% degli
edifici è agibile. Ad ogni modo, nei piani del Cremlino c'è adesso l'avanzata in
altre parti del Donbass. A partire dalla città di Severodonetsk e della
“gemella” vicina Lysychansk.
Severodonetsk, in
particolare, rappresenta l'obiettivo politico più importante. Con la caduta di
gran parte dell'oblast di Lugansk in mano ai separatisti nel 2014, è qui che
Kiev ha spostato il capoluogo regionale. È quindi una delle città più
strategiche del Donbass in mano all'Ucraina.
L'avanzata verso
Severodonetsk ha luogo tra fine febbraio e aprile. I 30 km che separano la città
dalla linea di contatto con i separatisti vengono lentamente conquistati dai
russi, i quali avanzano sia da Lugansk che dai propri confini. A fine aprile
viene conquistata la città di Rubizne, vera porta di accesso verso
Severodonetsk. La caduta di questa località, segna l'inizio della prima fase di
assedio del capoluogo provvisorio dell'oblast di Lugansk.
Tuttavia con le
proprie truppe ancora impegnate a Mariupol, Mosca decide di rinviare l'assalto
finale. A dare manforte ai soldati del Cremlino, ci sono sia i separatisti che
ancora una volta anche i ceceni. Così come vengono segnalati mercenari della
Wagner, l'agenzia di contractors di Evgenij Prigozin. Per gli ucraini, oltre ai
soldati regolari, ci sono membri del Battaglione Donbass e alcuni combattenti
stranieri.
Nove giorni dopo la
definitiva caduta di Mariupol, inizia la battaglia urbana per la presa di
Severodonetsk. Ad annunciarlo è lo stesso governatore ucraino di Lugansk, Sergy
Hayday. I combattimenti vanno avanti per l'intero mese di giugno, ma già entro
la prima decade si intuisce che la battaglia volge nettamente a favore dei
russi. Oltre che per Severodonetsk, si combatte anche per la vicina Lysychansk,
strategica in quanto situata su una collina da cui si può avere il controllo del
fuoco delle zone limitrofe.
Il 20 giugno i russi
annunciano la presa del centro di Severodonetsk, alcuni combattenti ucraini sono
rifugiati e assediati all'interno dello stabilimento chimico Azot. Da Kiev il 24
giugno arriva l'ordine agli ultimi soldati ucraini rimasti di indietreggiare ed
evitare ulteriori perdite. Severodonetsk cade quindi definitivamente nelle mani
di Mosca, sorte toccata il 2 luglio successivo a Lysychasnk.
Lo stallo estivo
A quel punto Mosca
sembra nelle possibilità di attaccare gli ultimi due grandi obiettivi del
Donbass: Kramatorsk e Slovjansk. Si tratta delle ultime due grandi città della
regione in mano a Kiev. L'avanzata da Izyum e Lyman da nord e da Severodonetsk
da est, pone i russi nella possibilità di oltrepassare il fiume Siversky Donetsk
e proiettarsi verso le due località.
Tuttavia l'avanzata
russa si arresta. Le forze russe e filorusse sembrano voler in questa fase
consolidare le proprie conquiste a est e rinforzare le proprie linee di
rifornimento. Si parla più volte di una possibile offensiva su Odessa, città
pesantemente bombardata già da febbraio ma mai raggiunta né via mare e né via
terra. L'offensiva di Mosca si arresta infatti poco più a ovest di Kherson e non
riesce a sfondare a Mykolaiv.
Anzi, gli ucraini
più volte durante l'estate parlano di un possibile contrattacco in questo
settore. Il governo di Kiev più volte annuncia di essere pronto a passare da
un'azione meramente offensiva a una offensiva. I raid su Kherson e l'arrivo di
truppe nella zona sembrano confermare questa intenzione. Per tutta l'estate
tuttavia non avvengono importanti cambiamenti sul fronte.
Il primo vero
contrattacco ucraino
Con l'arrivo di
settembre tuttavia, Kiev prova una manovra a sorpresa nell'est del Paese e non a
Kherson. Le informazioni ricevute dai servizi segreti occidentali, così come
gli aiuti militari di molti Paesi della Nato, permettono all'Ucraina di
pianificare un'azione nell'area a sud di Kharkiv. Tra il 7 e l'8 settembre i
militari ucraini si muovono in direzione di Balakleya, prendendo il centro della
cittadina. Da qui poi, i soldati si spingono sempre più verso est riconquistando
Kupiansk e costringendo i russi a ripiegare a est del fiume Oskil.
Il contrattacco ha
successo: Kiev è a conoscenza delle scarne difese russe nell'area e l'effetto
sorpresa riesce pienamente nel suo intento. Gli ucraini avanzano così anche
verso Izyum e Lyman, città riconquistate nel giro di pochi giorni.
Contestualmente, le truppe di Kiev si muovono anche attorno Kharkiv,
allontanando definitivamente i russi dalla seconda città del Paese. In 5 giorni,
gli ucraini riprendono l'intero oblast di Kharkiv e allontano i russi da
Slovjansk e Kramatorsk. Per Mosca una disfatta che costringe, da qui a poche
settimane, il presidente Putin ad annunciare una mobilitazione parziale.
Gli ucraini
riprendono Kherson
I piani per
l'attacco su Kherson non vengono però accantonati. Sfruttando l'inerzia del
momento e l'inferiorità numerica dei russi nella regione, il 4 ottobre i soldati
di Kiev sfondano il fronte a nord del capoluogo e, in particolare, nella parte a
ovest del Dnepr. I russi preparano una lenta e ordinata ritirata, con gli
ucraini che avanzano verso Kherson per tutto il mese di ottobre.
Non si hanno grandi
combattimenti in questo settore, proprio perché Mosca opta per un ritiro sapendo
di non poter difendere a lungo il capoluogo dell'oblast. Una provincia, è bene
ricordare, da alcune settimane considerata dalla Russia annessa al proprio
territorio assieme a quelle di Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk. Il 12 novembre,
le truppe ucraine entrano così nel centro di Kherson, riprendendo ufficialmente
la città.
I bombardamenti
russi sulle centrali elettriche
La risposta russa
alla controffensiva ucraina arriva con dei massicci bombardamenti su tutto il
Paese. Il principale dei quali è del 10 ottobre, quando tutte le province
dell'Ucraina sono bersagliate da un continuo lancio di missili che va avanti per
diverse ore. La stessa Kiev viene colpita con dei raid più intensi della prima
parte di guerra. Il bombardamento in questione appare come una risposta al
sabotaggio che l'8 ottobre porta al parziale danneggiamento del viadotto sullo
stretto di Kerch, ossia la principale infrastruttura di collegamento tra la
Crimea e la Russia continentale.
I danni sono
ingenti, soprattutto perché a essere prese di mira sono le centrali elettriche.
Si calcola che più della metà delle infrastrutture energetiche ucraine risulta
seriamente o parzialmente danneggiata. Nei giorni seguenti vanno avanti altri
bombardamenti, sempre contro le centrali elettriche. Il governo di Kiev viene
quindi costretto a razionare la distribuzione di energia elettrica e a ricorre a
frequenti blackout. Per diverse settimane, nella capitale e nelle città
principali l'energia viene erogata solo per due o tre ore al giorno.
L'Ucraina affronta
così l'inverno al buio e con pochi riscaldamenti. La strategia dei raid contro
le centrali si attenua solo con l'avvento del nuovo anno. I tecnici ucraini
provano a riparare quanto possibile, ma la logistica civile risulta al momento
ben lontana da livelli normali.
La battaglia di
Bakhmut
Nel 2023 per il
momento l'unico fronte dove si combatte in modo intenso è quello di Bakhmut,
nell'est del Paese. La città dell'oblast di Donetsk non è lontana da Kramatorsk.
Una sua conquista permetterebbe di avanzare nel cuore dell'ultima parte del
Donbass rimasta in mano a Kiev.
Per provare a
smuovere la situazione, i russi hanno premuto sull'acceleratore nel quadrante di
Soledar, cittadina conquistata a metà gennaio. Qui a entrare in azione sono
soprattutto i contractors della Wagnar. La battaglia è ancora in corso e sta
causando un numero elevato di vittime. Un inferno capace di travolgere tanto gli
ucraini quanto i russi. MAURO INDELICATO
Cosa succede a
est? La guerra nel Donbass.
Paolo Mauri il 20
Febbraio 2023 su Inside Over.
L’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia cominciata il 24 febbraio 2022 che ha aperto
il conflitto ancora in atto ha visto tra i vari obiettivi delle operazioni
terrestri una regione di confine che da tempo è percorsa da instabilità e
scontri armati: il Donbass.
In quella regione
orientale dell’Ucraina il conflitto non è cominciato la notte di quel giorno di
febbraio, bensì nell’ormai lontano 2014. Un conflitto che ha provocato, secondo
le stime dell’Onu, quasi 15 mila morti su entrambi i fronti e che è stato
determinato dal fallito tentativo di effettuare un “colpo di mano” sul modello
di quello avvenuto in Crimea più o meno nello stesso arco temporale di
quell’anno.
Le manovre di Mosca
prima della guerra
Se infatti la
tattica russa per annettere alla Federazione la penisola crimeana – sede di
un’importante base navale della Flotta del Mar Nero – impiegando gli strumenti
dell’Hybrid Warfare è stata un pieno successo, così non è avvenuto per il
Donbass (nella fattispecie nelle regioni di Donetsk e Luhansk) per via della
rapida reazione dell’esercito ucraino, che non si è fatto cogliere alla
sprovvista come accaduto in Crimea.
I moti popolari
filorussi, eterodiretti da Mosca, hanno fornito il pretesto ai separatisti
armati sostenuti dalla Russia per occupare gli edifici del governo ucraino in
tutto il Donbass, dichiarando la nascita delle Repubbliche popolari di Donetsk e
Luhansk (Dpr e Lpr) e innescando quindi la reazione delle forze governative
ucraine. La Russia ha sostenuto segretamente i separatisti con truppe e armi
pesanti, ammettendo solo in seguito di aver inviato “consiglieri militari”.
Dopo un anno di
combattimenti, il conflitto si è trasformato in una guerra di trincea diventando
a tutti gli effetti uno dei tanti “conflitti congelati” dell’intorno russo
nonostante i tentativi di pacificazione tramite mediazione internazionale (gli
accordi di Minsk I e II).
Il Donbass dopo il
24 febbraio 2022
Questo breve
riassunto di 8 anni di combattimenti nel Donbass serve per individuare
il leitmotiv delle operazioni belliche russe in quella regione da febbraio del
2022: un lento, sanguinoso, avanzamento spesso dagli esiti alterni, determinato
proprio dal fatto che in quell’area si combatte dal 2014, quindi i due
belligeranti – soprattutto gli ucraini – hanno avuto anni per trincerarsi in
modo efficace.
È risultata infatti
evidente la tattica dell’esercito di Kiev per resistere all’avanzata russa:
una difesa in profondità che ha sfruttato la conoscenza del terreno, la sua
stessa morfologia, l’impiego di tattiche di guerriglia (tanto che si è potuto
parlare nei primi mesi di guerra di conflitto “semi-simmetrico”) rese efficaci
soprattutto dalla fornitura di armamenti occidentali, come gli Atgm (Anti Tank
Guided Missiles).
Più in generale,
questi fattori sono validi per spiegare la capacità di resistenza ucraina in
tutti i fronti del conflitto, senza dimenticare la possibilità per gli ucraini
di avvalersi delle informazioni dell’intelligence
occidentale (soprattutto statunitense e britannica), che ha rappresentato forse
la chiave dell’efficacia del contrasto all’invasione russa.
Le 3 fasi del
conflitto
A un anno
dall’inizio del conflitto, è possibile individuare 3 macrofasi delle operazioni
belliche: la prima, da febbraio sino ad agosto, in cui l’iniziativa è stata
saldamente nelle mani russe nonostante il ritiro dalle regioni di Kiev e
Chernihiv; la seconda, durata da agosto sino a fine settembre, in cui abbiamo
assistito all’esito positivo di due controffensive ucraine, una su Kharkiv (ma
che probabilmente è stata il felice e inatteso esito di un’ampia manovra di
alleggerimento), e una su Kherson; infine la terza, da ottobre sino a oggi, in
cui si è stabilita fondamentalmente una guerra di posizione caratterizzata però
da piccole avanzate russe lungo quasi tutto il fronte.
La rotta russa nella
regione di Kharkiv ha interessato marginalmente anche il Donbass settentrionale,
coi russi che si sono ritirati su linee più sicure e meglio difendibili a nord
di Lyman. Proprio questa parte del fronte è quella che nel momento in cui
scriviamo vede i combattimenti più cruenti, con gli ucraini che sono solo stati
capaci, nelle prime settimane di gennaio, di effettuare un attacco di
alleggerimento verso Kreminna, ma che non ha portato alla liberazione della
cittadina.
Questa zona è stata
al centro di aspri combattimenti nel corso dei mesi passati, soprattutto nella
prima macrofase del conflitto: gli attacchi principali russi, benché non
condotti in forze, si erano concentrati nell’area di Izyum, Rubizhe, Popasna e
Lyman dove le truppe russe avevano conquistato Kreminna. Proprio Lyman e Izyum
formano la base di un triangolo, che ha il vertice a Kramatorsk, che
risulta essenziale per sigillare il Donbass, che comunque è stato conquistato
per la maggior parte con l’oblast di Luhansk occupato al 97% dopo che è stato
eliminato il “saliente di Severodonetsk”.
Sulla strada per
Kramatorsk c’è la città di Sloviansk, la cui difesa è quindi strategica, e prima
di essa troviamo proprio Lyman, che recentemente risulta essere proprio uno
degli obiettivi dell’avanzata russa. Se ci spostiamo leggermente verso sud, i
combattimenti, dopo la caduta di Soledar, si sono concentrati sulla più
grande Bakhmut (o Artemovsk), che però, come già detto, non ha un importante
peso strategico nel quadro del conflitto in Donbass in quanto le linee vitali
linee di comunicazione nord-sud ucraine possono passare per Kramatorsk anche
qualora la città dovesse cadere in mani russe.
Una guerra lenta ma
d’attrito
Nell’area della
città di Donetsk il fronte è rimasto sostanzialmente invariato lungo tutto il
corso della guerra: qui infatti gli ucraini risultano essere trincerati meglio
e, in questa fase del conflitto, la morfologia del terreno e la scarsa copertura
boschiva permettono all’artiglieria a razzo di Kiev (dotata di moderne armi
occidentali come gli M-270 e soprattutto gli M-142), di colpire efficacemente le
truppe e i mezzi russi. In ogni caso anche in questa parte del fronte, in
particolare a sud di Donetsk, nell’area della cittadina di Vuhledar, i russi
stanno lentamente avanzando probabilmente per cercare di ammorbidire le difese
ucraine nel capoluogo dell’oblast‘.
In linea generale,
come già detto, tutto il fronte è in lento movimento coi russi che guadagnano
terreno non senza dispendio di risorse, ma in un confronto di attrito, in questo
momento, sono gli ucraini a trovarsi più in difficoltà non potendo ancora
contare su rifornimenti di armi pesanti come i carri armati.
Vale la pena
ricordare che il ritiro russo da Kherson su linee stabilite lungo la sponda
orientale del fiume Dnepr ha permesso a Mosca di alleggerire la pressione sulle
sue forze, in modo da poterle ricostituire con le riserve recentemente
mobilitate, e avere una barriera naturale difficilmente attraversabile senza
perdite ingenti da parte degli ucraini.
Da tenere sotto
osservazione è anche il settore del fronte da Zaporizhzhia a Donetsk, dove si
stanno sviluppando piccoli attacchi simultanei russi: questa parte del meridione
ucraino è infatti vitale per la Russia, in quanto attraverso di essa passano
le linee di comunicazione e rifornimento verso la Crimea. PAOLO MAURI
Dall’occupazione
alla riconquista: cosa succede a Kherson.
Federico Giuliani il
20 Febbraio 2023 su Inside Over.
L’11 novembre 2022
l’esercito di Kiev è rientrato a Kherson per la prima volta dall’inizio della
cosiddetta operazione militare speciale russa. Da quando, cioè, l’intero,
omonimo, oblast’ meridionale ucraino era finito sotto il controllo di Mosca.
Le forze del
Cremlino avevano appena proclamato la città, situata nel sud dell’Ucraina,
capitale amministrativa della regione, facendo seguito all’annessione
unilaterale di Zaporizhzhia, Lugansk, Donetsk e Kherson. Dopo
un’occupazione andata avanti otto mesi, la Federazione russa ha invece
annunciato di aver completato il ritiro da Kherson dei suoi uomini.
Il centro urbano,
che prima dello scoppio della guerra contava poco meno di 300 mila abitanti, ha
continuato a esser colpito da ingenti quantità di bombe e missili (80, ad
esempio, nelle 24 ore intercorse tra il 2 e il 3 gennaio 2023).
La decisione russa
di ritirarsi in posizioni difensive sulla riva sinistra del fiume Dnipro è stata
guidata da una solida logica militare, visto che il controllo della città poteva
essere mantenuto solo a fronte di un carissimo prezzo da pagare in termini di
truppe e materiale bellico. Se da un punto di vista operativo, dunque, il ritiro
dovrebbe aver aiutato i russi a stabilizzare le loro posizioni difensive durante
l’inverno, strategicamente parlando ha avuto la stessa valenza di una sconfitta.
Ovviamente
l’allontanamento del Cremlino da Kherson non è figlio del caso o della fortuna.
Dall’estate, infatti, gli ucraini hanno alzato la pressione, lanciando
addirittura una controffensiva alla fine di agosto. Gli uomini di Volodymyr
Zelensky sapevano di non essere in grado di prendere d’assalto la città, eppure
gli attacchi sferrati sui ponti, sul Dnipro, hanno limitato considerevolmente le
capacità nemiche di rifornire le loro truppe con attrezzature pesanti. Allo
stesso tempo, il fiume ha protetto le forze di Kiev dalla replica militare
russa.
In definitiva,
questa favorevole geometria del campo di battaglia ha consentito all’Ucraina di
creare una zona d’azione all’interno della quale la sua artiglieria riusciva ad
infliggere pesanti perdite alle unità più motivate e competenti della Russia.
La ritirata russa è
un’enorme battuta d’arresto per il sogno di Mosca di impadronirsi del porto di
Odessa e isolare l’Ucraina dal Mar Nero.
Dalla conquista
russa alla riconquista ucraina
Kherson è stata
conquistata poco dopo lo scoppio della guerra, avvenuto il 24 febbraio 2022. È
stata l’unica capitale provinciale ucraina a cadere sotto il controllo di
Mosca. Unità dell’esercito, con supporto aereo, sono entrate nella regione dal
territorio della Crimea e, quasi senza resistenza, sono avanzate di 100
chilometri a nord e nord-ovest.
Nella notte tra il
28 febbraio e il 1 marzo, i russi hanno circondato la città, oltre ad aver
occupato i villaggi circostanti e l’aeroporto di Cornobaivka. Il 3 marzo hanno
fatto il loro ingresso in città incontrando poca resistenza. Il 4 marzo Kherson
è passata sotto il controllo russo. Ci sarebbe rimasta, come detto, fino al
novembre 2022.
Procedendo con
ordine, il Cremlino ha annesso unilateralmente l’intero oblast di Kherson e
altre tre regioni alla fine di settembre, dichiarando che sarebbero rimaste
russe per sempre. Le cose non sono fin qui però andate secondo i piani di Putin.
L’esercito ucraino, equipaggiato con artiglieria e razzi occidentali, ha infatti
trascorso mesi a martellare le posizioni nemiche e demolire ponti sull’ampio
fiume Dnipro, rendendo sempre più difficile per i russi rifornire i militari
sulla sponda occidentale del fiume.
Il ritiro russo da
Kherson è arrivato dopo un’altra fuga, molto più precipitosa, riguardante la
regione di Kharkiv, avvenuta due mesi prima.
Il futuro di Kherson
La perdita di
Kherson ha di fatto lasciato la Russia con pochi guadagni territoriali
dall’offensiva del 24 febbraio. Per l’Ucraina la liberazione della città
meridionale è una vittoria importante. Ha permesso a Kiev di concentrare le sue
forze nel nord-est e ha dimostrato agli alleati occidentali che combattere
astutamente può portare alla liberazione del territorio, senza la necessità di
assaltare deliberatamente ogni città occupata dai russi.
Allo stesso tempo,
il ritiro della Russia pone l’Ucraina di fronte ad alcune sfide. Come ha
sottolineato il Guardian, la Russia ora ha un fronte più ristretto da difendere,
mentre l’Ucraina non ha più l’opportunità di uccidere un gran numero di nemici
dotati di una capacità limitata di contrattaccare. Anche se combattere
attraverso le nuove linee di difesa russe rischia di esaurire le unità ucraine,
per Zelensky è fondamentale che le truppe russe non abbiano la possibilità di
riprendersi durante l’inverno.
La riconquista
ucraina di Kherson è inoltre fondamentale per almeno tre ragioni. Dal punto di
vista strategico, Kiev intende fare leva sulla presunta fragilità del controllo
russo sulle aree occupate da Mosca. Dopo di che, l’Ucraina intende rimettere in
discussione il controllo della Russia sulla Crimea e blindare la sponda
occidentale del Dnper. Così da recuperare energie in vista di possibili, nuove
offensive.
Nel frattempo
l’esercito russo si è ritirato attraverso il citato fiume Dnper, prendendo di
mira Kherson con i suoi cannoni pesanti. Per oltre due mesi, il Cremlino
ha bombardato la città con l’artiglieria. L’amministrazione locale ha spiegato
che più di 1.700 razzi sono stati lanciati contro Kherson negli ultimi due
mesi, causando 74 morti e 207 feriti. Sono stati colpiti appartamenti, case,
scuole, ospedali ed edifici governativi. Un chiaro segnale di come il pericolo
non è ancora passato. FEDERICO GIULIANI
Linee rosse e
ipotesi di riconquista. La Crimea al centro della guerra.
Lorenzo Vita il 20
Febbraio 2023 su Inside Over.
La Crimea è uno dei
grandi epicentri della guerra in Ucraina. Perché se è vero che l’invasione russa
è iniziata ufficialmente il 24 febbraio 2022 con l’annuncio della “operazione
militare speciale” di Vladimir Putin, è altrettanto vero che sarebbe impossibile
parlare di un conflitto iniziato esclusivamente lo scorso anno. La guerra in
Ucraina dell’ultimo anno si può infatti descrivere come la più drammatica
espressione di un conflitto che fino a più di un anno fa era ritenuto di “bassa
intensità” e che aveva avuto, come questa volta, due grandi teatri: il Donbass e
la Crimea. Con quest’ultima a essere stata annessa alla Russia da un referendum
non riconosciuto dalla comunità internazionale ma ritenuto valido da Mosca.
Stesso metodo utilizzato nei territori occupati dopo febbraio 2022.
Proprio per questo
motivo, e naturalmente per la sua ben nota importanza strategica, la Crimea
viene considerata una sorta di ipotetico spartiacque della guerra. Il presidente
russo Vladimir Putin la ritiene forse la principale linea rossa: dal momento che
quel territorio è annesso da otto anni, quello è considerato ormai parte
integrante della Federazione Russa e non può essere messo in discussione. Da
parte ucraina, invece, il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto più volte
capire che la penisola sul Mar Nero non può considerarsi definitivamente persa,
ma anzi è messa in cima alla lista delle possibili controffensive di Kiev.
La posizione
dell’Occidente sulla Crimea
Sul punto, i recenti
dibattiti in sede occidentale, tra i sostenitori della causa ucraina, confermano
che la Crimea, nonostante lo stallo sul fronte ucraino, non è passata affatto in
secondo piano. Dagli Stati Uniti, sono arrivate indiscrezioni che certificano un
grosso dibattito in seno alla Casa Bianca, al Pentagono e al dipartimento di
Stato sulla possibilità ma anche sulla opportunità di dare il via libera a un
attacco ucraino alla Crimea. A un certo punto, Washington sembrava essersi
convinta sulla possibilità che Kiev iniziasse le operazioni per riprendersi la
penisola, in particolare tagliando i collegamenti con il Donbass.
Alcuni analisti
hanno tirato il freno a mano, ricordando il rischio di andare a colpire un
territorio che per il Cremlino è inviolabile con conseguente pericolo di una
escalation dai contorni oscuri. Altri ritengono invece che l’ingresso delle
truppe ucraine nella penisola di Sebastopoli sarebbe il vero “big bang” del
conflitto, un momento decisivo e rivoluzionario per le sorti della cosiddetta
operazione militare speciale.
Poi, negli ultimi
giorni, è apparso un articolo di Politico in cui si sottolinea che fonti
della Difesa degli Stati Uniti ritengono che l’esercito ucraino non sia in grado
di riconquistare la Crimea, almeno in questa fase della guerra. Il punto di
vista del Pentagono sarebbe arrivato durante un’audizione riservata della
commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa. Non c’è modo di
conoscere le basi di queste affermazioni, tuttavia Politico ha scritto che
all’incontro avrebbero preso parte Laura Cooper, vice assistente segretaria alla
Difesa per Russia, Ucraina ed Eurasia, e il tenente generale Douglas Sims,
direttore delle operazioni dello Stato maggiore congiunto Usa.
Il botta e risposta
tra Mosca e Kiev
In attesa degli
sviluppi sul campo di battaglia, le due parti in conflitto continuano intanto a
parlare della penisola e del suo destino. Il vicepresidente del Consiglio di
sicurezza russo, ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev, ha come al
solito utilizzato i suoi toni più incendiari per ribadire quanto espresso già da
tempo da Mosca. “La Crimea è Russia. Attaccare la Crimea significa attaccare la
Russia e un’escalation del conflitto” ha scritto l’ex delfino di Putin, dicendo
che in caso di attacco sono “inevitabili ritorsioni con armi di qualsiasi tipo”.
A rispondere a
Medvedev è stato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, che
con un messaggio molto netto ha scritto su Twitter: “Il diritto internazionale
parla chiaro. L’Ucraina può liberare i suoi territori utilizzando qualsiasi
mezzo. La Crimea è Ucraina”.
Il Cremlino ha
parlato attraverso il portavoce Dmitry Peskov, che parlando del proseguimento
della guerra per garantire la “sicurezza del Donbass”, ha fatto riferimento a
quella della Crimea come qualcosa di “garantito”. Ribadendo quindi l’idea che
per Mosca quella penisola sia ormai qualcosa di irrinunciabile.
Il nodo
dell’offensiva contro la penisola
La possibilità di
una nuova offensiva verso la Crimea da parte delle forze ucraine è in ogni caso
reale. Se infatti le forze russe hanno cercato di rafforzare le posizioni
nell’area di Kherson per blindare la penisola, è altrettanto vero che la
convinzione di Zelensky e degli apparati ucraini si unisce all’invio di nuove
armi e mezzi dall’Occidente a supporto di Kiev. Il nuovo pacchetto di armi
Usa da 2,2 miliardi di dollari prevede anche bombe GLSDB che possono viaggiare
fino a 150 chilometri, quindi potenzialmente in grado di colpire almeno il nord
della Crimea.
Inoltre, da tempo la
penisola è oggetto di attacchi e sabotaggi che hanno confermato le capacità
dell’intelligence ucraina e delle forze speciali di penetrare oltre le linee
nemiche proprio nel cuore del territorio occupato dalla Russia. Per mesi, tutto
il territorio ha assistito a esplosioni, incendi, raid più o meno rivendicati,
con incendi e attacchi che hanno raggiunto anche Sebastopoli. Intorno al porto
della Flotta russa del Mar Nero è stato anche trovato un misterioso (e
tecnologicamente avanzato) drone dalla forma di un barchino che sembrava il
preludio a un possibile attacco su vasta scala dalla costa ucraina. E
l’intelligence britannica, a metà gennaio, ha segnalato che diverse unità della
Marina di Mosca si erano spostate da Sebastopoli
verso Novorossiysk probabilmente per timore di un’operazione di Kiev.
Dall’altro lato, la
Russia sembra propendere per il rafforzamento della presenza militare nella
penisola e soprattutto per un rafforzamento di quello che appare come uno dei
principali obiettivi strategici della guerra: la realizzazione del corridoio
terrestre che unisca la Crimea alle regioni del Donbass. Molti osservatori, ma
anche i servizi ucraini, sostengono che Mosca voglia blindare quei territori
attraverso una nuova avanzata che, pur non essendo in grande stile, possa
comunque rafforzare l’idea di un Mar d’Azov completamente in mano russa. In
questo senso, le testimonianze di migliaia di nuovi soldati arrivati nella
provincia di Mariupol confermerebbero la volontà di Serghei Shoigu e Valerij
Gerasimov di aumentare la presenza e l’area dei territori conquistati. Mentre i
più recenti attacchi a Kherson sembrerebbero certificare il desiderio russo di
allontanare il più possibile l’ipotesi di una controffensiva ucraina attraverso
il fiume Dnipro. LORENZO VITA
Ecco dove si
decide la guerra in Ucraina.
Paolo Mauri il 20
Febbraio 2023 su Inside Over.
A un anno
dall’inizio del conflitto in Ucraina, Kiev ha perso circa il 20% del proprio
territorio nazionale a seguito dell’invasione russa cominciata il 24 febbraio
2022.
Guardando la mappa
del fronte, possiamo osservare notevoli variazioni rispetto ai primi mesi di
guerra: l’esercito russo dapprima si è ritirato spontaneamente dalla regione di
Kiev e Chernihiv in quanto il fallito tentativo di decapitazione del governo
Zelensky ha consigliato di ridimensionare l’area delle operazioni di guerra in
modo da razionalizzare le – esigue – truppe impiegate; inoltre la controffensiva
ucraina dell’estate scorsa ha portato alla liberazione della regione intorno
a Kharkiv e a Kherson, e negli ultimi mesi l’evidenza ha dimostrato che quei
settori sono rimasti più o meno inattivi, eccezion fatta per azioni di sistemi
d’artiglieria o attività di bombardamento missilistico.
Come è cambiato il
fronte
Il fronte ora è più
corto, e parte di esso è rappresentato da quella barriera naturale data dal
fiume Dnepr, che difficilmente può essere oltrepassata senza la perdita di un
cospicuo numero di uomini e mezzi, entrambi preziosi per Kiev soprattutto in
questa fase del conflitto. Le azioni offensive russe, lente, difficoltose, ma
più o meno costanti fatto salvo alcune controffensive di alleggerimento ucraine
nel Donbass settentrionale, si sviluppano lungo l’intera linea del fronte che va
da Zaporizhzhia sino all’oblast di Luhansk. Prima di ipotizzare dove, in questo
smisurato terreno di battaglia, potrebbe decidersi la sorte del conflitto, è
bene fare alcune puntualizzazioni di tipo politico.
La questione
politica per Mosca
Il Cremlino è
arrivato al punto di considerare l’esito della guerra in Ucraina vitale per i
propri interessi: la sola decisione di intraprendere l’invasione, nonostante 8
anni di sanzioni internazionali scaturite dalla destabilizzazione del Donbass e
dall’annessione della Crimea nel 2014, è indice dell’importanza dell’azione
bellica attualmente in corso. Anche dal punto di vista della politica interna,
la dirigenza russa si trova nella non felice condizione di dover riuscire a
concludere il conflitto in modo “onorevole” per la Russia, pena il sovvertimento
dell’attuale regime, in quanto l’andamento altalenante, e financo disastroso se
pensiamo a quanto successo questa estate, delle operazioni militari ha
risvegliato le frange nazionaliste della politica russa, che potrebbero venire
catalizzate da figure scomode ma in questo momento utili per il Cremlino come il
capo del Gruppo Wagner – Evgenij Prigozhin – o il leader ceceno Ramzan Kadyrov.
Il rischio è doppio:
non solo per la tenuta del potere politico attualmente a capo della Russia, ma
anche per la stessa unità della Federazione: un’eventuale sconfitta militare,
con conseguente ridimensionamento della potenza dell’esercito russo (strumento
principe della proiezione politica della Russia nel suo intorno), potrebbe
facilmente solleticare più di una velleità indipendentista di alcune
repubbliche, come la stessa (un tempo) turbolenta Cecenia. Da questo punto di
vista anche il CSTO (Collective Security Treaty Organization), il trattato di
sicurezza collettiva che lega a Mosca le ex repubbliche sovietiche ora Paesi
sovrani, è stato messo in discussione da alcuni suoi membri: dall’Armenia, che,
avendo richiesto l’intervento della Russia in concomitanza con la ripresa di
scontri armati con l’Azerbaigian si è vista rispondere un secco “niet” per via
dell’onere bellico in Ucraina, e dal Kazakistan, che ha espresso inizialmente
l’intenzione di abbandonarlo salvo poi ritrattare. Una questione di sicurezza ma
anche di immagine, interna ed esterna, per la Russia che non deve essere
sottovalutata in analisi di tipo meccanicistico.
I nodi della Nato
Sul fronte opposto,
più che l’Ucraina la quale, per ovvi motivi, vede in gioco la sua stessa
esistenza come entità autonoma, è la Nato (e partner) ad avere in gioco più di
una semplice vittoria sull’orso russo: in ballo c’è infatti la questione
del rispetto del diritto internazionale, soprattutto perché legato a un Paese –
la Russia – dotata di un arsenale nucleare importante.
Un esito infelice
del conflitto, con la sconfitta ucraina determinata dal disimpegno occidentale,
porterebbe con sé la possibilità di vedere ulteriori guerre (pensiamo allo
scacchiere indo-pacifico) e soprattutto una corsa agli armamenti nucleari, visti
come assicurazione per il non intervento della comunità internazionale.
Siamo davanti,
quindi, a un rebus di difficile soluzione che potrebbe facilmente risolversi,
secondo chi scrive, in uno dei tanti conflitti congelati della periferia russa
stante la scarsa probabilità che Mosca decida di impiegare l’intera sua potenza
militare (incluso il ricorso al nucleare tattico) per vincere la guerra.
Dove può essere
deciso il conflitto
Dopo questa lunga
premessa introduttiva cerchiamo di rispondere alla domanda che dà il titolo alla
nostra trattazione: dove si deciderà il conflitto in Ucraina? Tralasciando il
tavolo della diplomazia, che riteniamo ancora valido e capace di trovare una
soluzione di pace secondo un meccanismo di “congelamento” dello status quo ante
guerra (l’unico che potrebbe essere accettato da Mosca e fatto digerire a Kiev),
proviamo a dare una risposta dal punto di vista strettamente militare.
Escludendo che la
Russia possa mettere in atto una vasta operazione anfibia per aggirare il fronte
lungo il fiume Dnepr e puntare su Odessa e sulla Transnistria – il potenziale
navale da sbarco è fortemente menomato dalla perdita di alcune navi da guerra e
dall’utilizzo dei fanti di marina in operazioni terrestri – e tralasciando anche
la possibilità di una nuova invasione da nord, passando anche dalla Bielorussia
(non si commette lo stesso errore due volte), restano solo tre opzioni sul
tavolo: un nuovo attacco sulla direttrice Kharkiv/Dnepropetrovsk, uno sforzo per
completare la conquista dell’intero Donbass, infine un’avanzata da sud verso
nord nel settore che va da Zaporizhzhia a Donetsk per aumentare lo spessore di
quella fascia costiera che collega la Crimea al territorio della Federazione.
1 – Attacco sulla
direttrice Kharkiv/Dnepropetrovsk
La prima opzione è
quella meno plausibile: il territorio non è dei migliori come hanno scoperto i
russi durante i primi mesi di guerra, e gli ucraini potrebbero facilmente far
affluire rinforzi dall’ovest del Paese. Un’azione simile, poi, richiederebbe una
lunghissima preparazione e l’impiego di un potenziale bellico tale da richiedere
una mobilitazione molto più vasta, senza considerare il rischio di lasciare
sguarniti altri settori dalle forze corazzate necessarie per l’operazione,
essendo queste non infinite.
2 – Conquista del
Donbass
Restano le altre due
possibilità, che potrebbero ugualmente valere la dichiarazione del termine del
conflitto. La conquista dell’intero Donbass permetterebbe al Cremlino di avere
un’importante leva sul fronte interno stante la campagna propagandistica degli
ultimi 8 anni. Un Donbass “messo in sicurezza”, l’aver “salvato” la popolazione
russofona dai “nazisti” ucraini, potrebbe essere sufficiente per gli scopi del
Cremlino.
3 – L’avanzata nel
settore tra Zaporizhzhia-Donetsk
In secondo piano, ma
non così lontano dagli stessi schemi di ragionamento, c’è la conquista
dell’intero oblast di Zaporizhzhia: come già detto, allargherebbe la fascia
costiera occupata rendendo sicure le linee di comunicazione con la Crimea, e
potenzialmente potrebbe portare anche al ritiro delle forze ucraine da parte
dell’oblast di Donetsk.
Si tratta solo di
ipotesi, che potrebbero verificarsi solo con un importante sforzo bellico
complessivo da parte della Russia, che dovrebbe comprendere anche la conversione
di parte della sua economia da una civile a una di guerra: in questo momento
Mosca non ha le risorse per effettuare operazioni di ampio respiro, e forse non
ne ha nemmeno l’intenzione in quanto il conflitto di attrito che si è stabilito
le permette di erodere lentamente il potenziale bellico ucraino stante le
difficoltà incontrate da Kiev a ottenere armamenti pesanti e a lungo raggio
dagli alleati occidentali o anche solo il munizionamento per la propria
artiglieria. PAOLO MAURI
Il populismo di
guerra di Zelensky.
Gianluca Lo Nostro
il 21 febbraio 2023 su Inside Over.
“Sai perché facciamo
una vita da cani? Perché noi la nostra scelta la facciamo nelle cabine
elettorali, capito? Ma non abbiamo tra chi scegliere! Se ci sono due merde, noi
scegliamo solo la meno peggio, ed è così da 25 anni, cazzo. E vuoi sapere una
cosa? Non cambierà neanche questa volta e sai perché? Perché tu, mio padre e io
sceglieremo una di queste merde di nuovo. E diremo: sì, in effetti è una merda
anche lui, ma forse un po’ meno”. Questo turpiloquio qualunquista è lo sfogo del
professore di storia Vasilij Petrovyč Holoborodko, al secolo Volodymyr Zelensky,
protagonista della prima puntata di Servitore del Popolo, la serie Tv più
guardata in Ucraina nell’ultimo decennio.
Holoborodko,
doppiato in lingua italiana da Luca Bizzarri, non sa che mentre discute con tono
rassegnato della situazione politica nel Paese, uno studente lo sta riprendendo.
Il filmato viene pubblicato in rete e viene visto da tutte le famiglie ucraine,
mentre il professore resta all’oscuro dell’enorme notorietà raggiunta, salvo poi
ignorarne le reali conseguenze. Nel giro di alcune settimane, quasi per scherzo
e senza neanche candidarsi ufficialmente, viene proclamato vincitore delle
elezioni presidenziali, diventando capo di Stato della seconda nazione più vasta
d’Europa, dopo la Russia, e imbarcandosi in una folle avventura alla guida del
suo Stato.
Una parabola
incredibile per chiunque, eppure è quello che, con i dovuti distinguo, è
successo a Volodymyr Zelensky. Colui che ha inventato quest’avvincente trama
televisiva è stato eletto presidente dell’Ucraina il 21 aprile 2019,
conquistando oltre 13 milioni di voti e la percentuale record del 73,22% in un
impari battaglia contro l’uscente Petro Poroshenko. Se Holoborodko è un prodotto
del guizzo comico di Zelensky, Zelensky è un Holoborodko più furbo e meno
squattrinato che ce l’ha fatta dopo mille peripezie. E con cui, prima o dopo,
bisognerà fare i conti.
Il comico
imprenditore
Nato a Kryvyi Rih,
Zelensky è cresciuto tra la Mongolia e l’Ucraina insieme alla famiglia. Di
origine ebraica e bilingue (ma russofono), vanta una laurea in legge di cui
davvero poco, se non quasi nulla, è stato scritto. Prima di intraprendere la
carriera nel mondo dello spettacolo, prima di Kvartal 95 Club (la società di
produzione cinematografica fondata nel 2003) e prima di Servitore del Popolo, il
presidente ucraino si è specializzato in diritto costituzionale, studiando per
diventare avvocato. Da questa passione giovanile, evidentemente mai sbocciata ma
rivelatasi utile in futuro, deriva l’eccellente abilità oratoria di Zelensky.
Tuttavia, come
mostrato pocanzi, sono gli anni del cabaret e della commedia a trascinarlo
nell’arena politica. Perché oltre alla fama pregressa e alla spigliatezza c’è
anche uno spirito imprenditoriale che si nasconde dietro la personalità della
persona dell’anno secondo il Time Magazine. Un tratto, quello del self-made
man nazionalpopolare, che ha permesso a Zelensky di penetrare nelle coscienze
critiche di chi lo ha fatto entrare nelle stanze del potere a Kiev.
“Zelensky veniva dal
mondo dell’imprenditoria e gli ucraini erano stanchi delle élite che non
potevano offrire altro che corruzione e nepotismo, quindi cercavano qualcosa di
nuovo“, racconta a InsideOver Iuliia Mendel, portavoce del Presidente fino al
2021. “Ha voluto introdurre la meritocrazia nella lentissima macchina del
governo, ma le istituzioni ucraine non sono così solide come nel vostro Paese,
quindi si è sforzato di renderle più flessibili. È stato il primo presidente a
introdurre la concorrenza per le nomine politiche più importanti e una di queste
era la mia carica di portavoce”.
Mendel racconta
anche un aneddoto sulla sua assunzione, una novità assoluta per un Paese
abituato a raccomandazioni e clientelismo. “Mise l’annuncio su Facebook e non
ero sicura di candidarmi perché c’erano migliaia di persone in lizza. Tutti i
presidenti precedenti sceglievano persone che già conoscevano senza trasparenza.
Ho avuto un colloquio con lui e mi ha chiesto quale fosse la mia motivazione”,
prosegue. “Che cos’è se non il sogno ucraino, quando ognuno può realizzare ciò
che vuole? Zelensky ha fatto appello alle emozioni della gente, capisce la
politica dal punto di vista delle emozioni e i suoi discorsi e video sono
realistici perché cerca di capire la psicologia delle persone”.
Il nuovo populista
che avanza
La vita politica di
Zelensky si può suddividere in tre fasi comunicative. La prima, quella del
debutto, è iniziata nel giorno di Capodanno del 2019, quando annunciò la sua
discesa in campo. Fu una scelta maturata dopo mesi di riflessioni su sondaggi
d’opinione che non facevano altro che ribadire la popolarità dell’allora comico.
Secondo alcune rilevazioni effettuate nel 2018 dal Kiev International Institute
for Sociology (Kiis), Zelensky aveva tassi di approvazione superiori a quelli
dell’allora presidente ucraino. Ma il passaggio dalla satira politica alla
politica autentica non è stato privo di ostacoli.
La campagna
elettorale fu condotta solo online e nessun giornalista poteva sognarsi di
intervistarlo. Lo scontro coi media era perlopiù alimentato dai finanziatori
della campagna elettorale, i mitologici e onnipresenti oligarchi, e meno dal
candidato, che credeva in una maggiore disintermediazione con gli elettori,
evitando di passare dal filtro della stampa. Lui era un tutt’uno coi suoi
sostenitori, che vivevano sul web, e sul web lui comunicava. I giornali
narravano la sua ascesa, ma faticavano a comprenderlo. Chi sta leggendo questo
articolo avrà in mente una sorta di Beppe Grillo slavo: non è un accostamento
così avventato, a essere sinceri.
Ad ogni modo, la
vecchia politica rappresentata dall’establishment lo attaccava con pretesti
assurdi: Poroshenko e il suo team, responsabili in quegli anni di una
controversa stretta sulle popolazioni di lingua russa, arrivarono a definire
Zelensky un traditore filorusso che faceva il gioco di Putin. Ovviamente non
funzionò, non solo perché Zelensky non era mai stato pro-Putin (preso di mira
varie volte nei suoi spettacoli), ma perché la strategia comunicativa usata per
diffamarlo venne facilmente smentita sui social.
Poroshenko invitò
Zelensky a un dibattito prima del ballottaggio, ma il suo sfidante gli rispose
ponendogli le seguenti condizioni: “Ti aspetto allo stadio Olimpico di Kiev. Il
dibattito si terrà qui, di fronte al popolo ucraino. Tutti i canali potranno
acquistare i diritti per trasmetterlo in diretta e tutti i giornalisti avranno
diritto di essere presenti. Tutti i candidati dovranno sottoporsi a un controllo
medico e dimostrare di non essere alcolizzati o drogati. Il Paese ha bisogno di
un presidente in salute”.
Soprendentemente,
Poroshenko accettò (“Stadio? E stadio sia”) e i due fecero persino il test
antidroga, ma alla fine non si trovò un’intesa sulla data e il presidente
uscente, in svantaggio nei sondaggi, si presentò al dibattito da solo davanti
allo stadio Olimpico a pochi giorni dal voto. A nulla valse la buona volontà: il
destino di Poroshenko era già segnato.
Zelensky il
riformatore
Una volta
presidente, l’outsider non più outsider ha dato in pasto ai suoi sostenitori
altre perle di saggezza dal sapore genuinamente populista. Questa, estrapolata
dal suo discorso inaugurale, riguarda l’affissione della sua foto negli uffici
pubblici: “Io non la voglio la mia foto nei vostri uffici”, ha detto
rivolgendosi ai funzionari e ai parlamentari presenti alla Verchovna Rada. “Il
presidente non è un’icona, un idolo o un ritratto. Appendete la foto dei vostri
figli invece e guardateli ogni volta che dovete prendere una decisione”, ha
ammonito.
Sulla scia di quel
dirompente successo, Zelensky ha sciolto il parlamento e ha stravinto le
elezioni legislative, superando peraltro le sue modeste aspettative che lo
vedevano fermarsi a un’ottantina di seggi. D’altronde, Servitore del Popolo, il
nome del suo partito, era un soggetto politico giovanissimo e senza radicamento
sul territorio. Nonostante questo, gli ucraini hanno consegnato al partito di
Zelensky 259 seggi, un’inaudita maggioranza che ha comportato non pochi problemi
al Presidente.
Ritrovare la pace
in Donbass era uno degli obiettivi principali di Zelensky dal suo insediamento.
La guerra con le truppe separatiste sostenute dal Cremlino aveva causato almeno
10 mila morti e per il nuovo capo di Stato la priorità era ritrovare la pace
attraverso le miracolose vie della diplomazia, bilanciando l’esigenza di porre
fine al conflitto con il sentimento nazionalista di chi gli chiedeva la difesa
dell’integrità territoriale dell’Ucraina a tutti i costi. Ma la diplomazia così
tanto miracolosa non è stata.
Tra il 2020 e il
2021 sono state denunciate migliaia e migliaia di violazioni del cessate il
fuoco bilaterale previsto dagli Accordi di Minsk e in trincea non si è mai
smesso veramente di combattere. Zelensky, comparso ogni anno sul fronte per dare
manforte ai suoi soldati, ha pagato il mancato accordo con Putin promesso in
campagna elettorale, perdendo le elezioni locali nel 2020. Lo smacco più
doloroso è stata la sconfitta a Kryvyi Rih, sua città natale, dove il partito
filorusso Piattaforma di Opposizione – Per la Vita (oggi messo al bando) si è
preso l’amministrazione comunale.
Zelensky però è un
uomo parecchio determinato e malgrado la mentalità aziendalistica che mette
l’efficienza al primo posto è anche un inguaribile idealista. Il piano di un
negoziato con il Cremlino non è mai stato abbandonato completamente e
barcamenandosi tra problemi di natura interna e nuove, inaspettate alleanze (la
Francia di Macron), il presidente ucraino ha voluto puntare sulla pace finché ha
avuto senso farlo, perfino quando l’allarme dell’invasione lanciato dalla Cia è
cominciato a circolare in Europa a fine 2021.
Come la guerra
cambia un uomo
È con la guerra che
lo Zelensky politico ha subito la sua più recente e notevole mutazione. E
stavolta a cambiare non è stato soltanto il linguaggio o il carattere, ma
l’aspetto fisico. La giacca e cravatta rimpiazzate dalla mimetica, le guance
glabre e rasate ora coperte da una barba minuziosamente curata, il volto prima
sollevato e solare che adesso ha lasciato spazio a una fronte corrucciata e
tribolante, ma che sa comunque trasmettere empatia: sono i sintomi di un
invecchiamento precoce. Questa piccola ma significativa rivoluzione ha avuto
luogo nei giorni e nelle settimane successive all’invasione, dunque tra febbraio
e marzo del 2022, mentre Zelensky dava ordini dal suo bunker inespugnabile a
Kiev, lontano per mesi dalla sua famiglia e minacciato dagli assassini di Putin
che lo cercavano nella capitale.
Qui il Presidente ha
smesso di avere respiro nazionale. I suoi messaggi pubblicati sui suoi canali
social sono stati letti e ascoltati da milioni di persone in tutto il mondo. Il
suo account Twitter è passato nottetempo da 500 mila a un milione e mezzo di
follower in 24 ore. Oggi è seguito da 7 milioni e 100 mila profili, a cui vanno
aggiunti i quasi 17 milioni di Instagram e i 3 milioni di Facebook. Un leader
globale di uno Stato in guerra, affermatosi sulla scena internazionale
come player e interlocutore fondamentale per gli equilibri del pianeta, ogni
giorno sulle prime pagine di tutti i giornali. Un capo che non comunica più
soltanto con i suoi concittadini, ma sfrutta il piedistallo su cui è poggiato
per mandare richieste pubbliche di aiuto agli altri Paesi, mettendo una
pressione che rischia di risultare stucchevole nel lungo periodo, specie se
l’inerzia del conflitto dovesse spostarsi in favore di Mosca.
C’è una domanda però
che merita una risposta: come ha fatto un politico inesperto, dilettante e per
certi versi inconcludente a guadagnarsi la fiducia di 40 milioni di persone
mentre il suo Paese è sotto attacco da un’opprimente superpotenza nucleare?
Secondo Iuliia Mendel, c’entra la decisione di restare a Kiev nei primi giorni
della guerra.
“Quando è scoppiata
la guerra, la gente si sentiva smarrita e si chiedeva: ‘Cosa devo fare se
all’improvviso tutta la mia vita viene distrutta?’. I primi giorni furono i più
importanti, quando andò dalla gente e disse: ‘Restiamo qui e combattiamo‘.
Questa era in realtà l’identità degli ucraini”, osserva la giornalista. “Non ha
detto ‘ci arrendiamo’ o ‘ci stiamo pensando’. Ha detto ‘stiamo combattendo'”. E
perché gli ucraini gli hanno creduto? “Perché in quel momento ha fatto appello
al cuore di ogni ucraino, perché questo è il nostro Paese, perché questa è la
nostra casa”, conclude.
Zelensky in strada a
Kiev insieme al primo ministro ucraino e i suoi consiglieri rassicura la
popolazione 24 ore dopo l’invasione: “Tutti noi siamo qui per proteggere
l’indipendenza del nostro Paese”
I suoi oppositori lo
accusano di aver forzato l’Ucraina a entrare in questa insulsa guerra, di aver
introdotto la legge marziale e di aver continuato con la repressione anti-russa
voluta dai suoi predecessori, vietando tutti i partiti schierati con
l’aggressore. Le suppliche ai partner occidentali, che secondo Zelensky
dovrebbero incrementare le forniture militari per consentire a Kiev di
sconfiggere la Russia sul campo, causerebbero inevitabilmente
una guerra mondiale, si legge spesso. Ma forse la sua è soltanto retorica che
genera velleità esternate in un plausibile delirio di onnipotenza. Chi, al suo
posto, non chiederebbe più carri armati e cacciabombardieri all’America se
avesse un assegno in bianco illimitato a disposizone? Ma soprattutto, siamo
sicuri che al popolo ucraino non faccia piacere il sostegno a oltranza della
comunità internazionale e che effettivamente Zelensky sia apprezzato in patria
per questo?
Che si ami o che si
odi, che si esalti o che si irrida, Volodymyr Zelensky sta segnando questa epoca
e lo sta facendo in un lasso di tempo troppo corto per elaborare il vero valore
e l’eredità storica della sua testimonianza. Dunque esprimere un giudizio netto,
buono o cattivo, bianco o nero, potrebbe essere un esercizio mentale pericoloso.
E intellettualmente disonesto. Un fatto è nondimeno innegabile. La sua figura
rimarrà scolpita, nel bene o nel male, sulla pietra angolare della nazione
ucraina che sta cercando di risorgere dopo questa traumatica guerra. GIANLUCA LO
NOSTRO
Com’è cambiata la
corte di Putin dall’inizio della guerra.
Lorenzo Vita il 21
febbraio 2023 su Inside Over.
L’invasione
dell’Ucraina è iniziata ufficialmente il 24 febbraio 2022 con un discorso del
presidente russo Vladimir Putin. Da quel momento, la storia dell’Ucraina, della
Russia e del mondo è cambiata forse definitivamente. Ma è cambiata
inevitabilmente anche la vita all’interno del Cremlino, che, dopo l’inizio di
quella che è stata chiamata “operazione militare speciale” (e non guerra), ha
inevitabilmente modificato il modo di gestire il potere di Putin e la rete di
personalità influenti e burocrati intorno alla figura del presidente.
La guerra è infatti
diventata uno spartiacque per Mosca e per la stagione di potere del leader
russo, e questo ha fatto sì che all’interno dello Stato sono state la conduzione
del conflitto e la fedeltà o meno alla linea del presidente a fare la differenza
anche nell’autorità del singolo individuo del “cerchio magico“ moscovita.
I primi segnali
Un primo clamoroso
assaggio di questo nuovo corso del potere russo lo si è visto proprio nelle
primissime fasi della guerra, anche poco prima che essa deflagrasse con l’invio
delle truppe russe in territorio ucraino. L’episodio è quello del rimprovero
pubblico da parte di Putin nei confronti di Sergei Naryshkin, capo dello Svr,
l’intelligence esterna russa.
La scena, per certi
versi drammatica, vedeva il vertice dei servizi esterni di Mosca balbettare di
fronte all’incalzante voce del presidente che quasi lo derideva per parlare
della futura annessione delle regioni occupate (cosa poi avvenuta) e sull’ancora
possibile negoziato con l’Occidente.
Per molti
osservatori, quell’immagine sarebbe stata la condanna all’oblio di Naryshkin,
uno dei “fantasmi di Leningrado”, tra gli uomini più vicini a Putin. Non è
nemmeno da sottovalutare il fatto che Putin, attraverso quella sconfessione
coreografica, abbia in realtà salvato il suo vero delfino nell’intelligence per
un eventuale ruolo da successore. In ogni caso fu il simbolo di un cambiamento
in corso in tutti i palazzi del potere in Russia.
Il ruolo di Lavrov
In questo
sommovimento interno alla Federazione va poi anche osservato il ruolo del
ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. Fino a poche settimane prima della guerra,
il capo della diplomazia russa era considerato non soltanto la parte più
razionale e diplomatica della leadership moscovita, ma per certi versi anche la
voce più lucida per un dialogo con l’Occidente. La guerra ha enormemente
scalfito l’operato di Lavrov, che non è apparso solo in balia delle scelte di
Putin, ma anche provocatorio nelle sue affermazioni.
Molte delle sue
mosse sono apparse inutili o del tutto scenografiche. Alcune affermazioni si
sono rivelate invece del tutto contrarie a quello che sarebbe avvenuto
successivamente. Infine, è stato costretto anche a modificare il suo
tradizionale distacco per piegarsi a un meccanismo
di accuse violente e propaganda.
Lavrov è rimasto
alla guida degli Esteri, come tutti i ministri più influenti sono rimasti al
loro posto, ma senza particolare entusiasmo. Il conflitto ha del resto
condannato la sua figura al pari di quella del suo lavoro diplomatico,
relegandolo al rango di esecutore diplomatico di una strategia che probabilmente
non ha mai considerato utile.
Il “contrappeso” a
Putin
La guerra ha poi
modificato anche la percezione del ruolo dei due principali vertici della Difesa
russa: il ministro Sergej Shoigu e il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov.
I due uomini – nella lettura di molti media occidentali – sono spesso stati
visti come una sorta di contrappeso alle scelte di Putin. L’immagine dei due
uomini che osservavano con preoccupazione il presidente russo durante un
incontro all’inizio della “operazione militare speciale” venne letta da molti
come una sorta di distacco pessimistico tra i militari e il Cremlino.
Poi, a marzo,
qualcuno iniziò anche a parlare di misteriosa scomparsa e di ipotesi di
rimozioni: non apparendo più in immagini pubbliche, sia Shoigu che Gerasimov
erano dati come spacciati, lontani dai radar perché avevano fallito nei piani
bellici. Qualcuno addirittura parlava di un grave problema di salute o di
possibili morti di entrambi.
Tra un susseguirsi
di cambi nella gerarchia militare e soprattutto tra chi comandava le operazioni
in Ucraina, la guerra è andata parallela al coinvolgimento diretto dei due
vertici militari nel conflitto e nella propaganda putiniana. La loro scomparsa è
stata spesso assimilata alle sconfitte, mentre ora, per esempio, con una Russia
che appare in grado di infliggere di nuovo colpi all’Ucraina, Shoigu appare
sempre più spesso, mentre Gerasimov, da gennaio, è addirittura al comando della
“operazione militare speciale”.
Questo potrebbe
essere visto come un nuovo tentativo di rafforzare le forze armate in una fase
in cui apparivano enormemente indebolite le figure apicali, quasi a salvarne la
faccia dopo mesi di rischio di defenestrazione.
Kadyrov e Prigozhin,
mine vaganti
Un cambiamento che
per il Cremlino serve soprattutto in un’ottica politica: valorizzare il ruolo
dei capi delle forze armate russe aiuta infatti a frenare le ambizioni di due
uomini che durante la guerra sono stati ritenuti fondamentali, e cioè il
ceceno Ramzan Kadyrov e il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin. I due capi
militari, esterni alle forze regolari di Mosca, rappresentano da un lato i
vertici di feroci milizie che hanno fornito a Putin le vittorie di cui aveva
bisogno per confermare all’opinione pubblica il momentaneo successo
dell’invasione.
Dall’altro lato, va
anche considerato che un ceceno troppo esuberante e violento e un privato che
gestisce una legione di mercenari più preparata dei reparti dell’esercito al
fronte hanno influito in modo negativo sia sulla percezione delle forze armate
della Federazione sia sulla capacità della Russia, e quindi di Putin, nel
gestire un conflitto.
I due uomini, leader
politici e in un certo senso anche carismatici, sono stati addirittura inseriti
nella lista dei potenziali successori di Putin in caso di golpe dei cosiddetti
“falchi”. E il rischio di uno strisciante golpe di boiardi o di rinascita dei
secessionismi non ha certamente rafforzato la loro posizione nel cerchio magico
di Putin dopo che invece per anni (e nel primo anno di guerra) sono apparsi tra
i fedelissimi dello “zar”.
Intorno alla figura
di Putin, si riconoscono poi una serie di personalità sempre meno fondamentali
nelle logiche pubbliche del potere. La narrazione dei fedelissimi si è andata
perdendo nel corso del conflitto lasciando in disparte personaggi che invece
avevano un peso politico – più o meno pubblico – anche rilevante.
I falchi e
l’intelligence dello zar
Abbiamo parlato del
caso di Naryshkin, primo grande campanello d’allarme per la cerchia di potere
del presidente. Ma all’interno di quel circuito misto di intelligence,
oligarchia e amici di Putin, un altro ad avere assistito ad ascesa e declino
all’interno del Cremlino è Nikolaj Patrushev, segretario del Consiglio di
sicurezza, un uomo considerato tra i più vicini al leader e che addirittura dopo
alcuni mesi dall’inizio dell’invasione era visto come il successore designato
dallo stesso Putin alla guida della Russia. Il “falco” è apparso con alcune
interviste, ma lavora di nuovo nell’ombra, forse anche lui punito per non avere
dato le risposte attese dal capo di Stato.
Una sorte simile
sembra essere toccata anche al direttore del Servizio federale di sicurezza
(Fsb) Aleksandr Bortnikov. Da tempo di lui si sono perse le tracce. Continua il
suo lavoro come vertice del potentissimo Fsb, ma mentre prima anche la stampa
occidentale ne parlava come consigliere fidatissimo e potenziale leader in caso
di regime change soft tra le mura del Cremlino, ora è quasi scomparso. E di
recente, la Stampa ha anche parlato dell’ipotesi della sua
sostituzione con Sergei Korolev, uno dei vice di Bortnikov. Secondo il
quotidiano torinese, il fatto che Korolev sia in quarantena preventiva a Mosca
potrebbe confermare un incontro con Putin nei prossimi giorni: cosa che alimenta
l’ipotesi di un cambio della guardia nelle gerarchie dello Fsb. Questione che
rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per un sistema, quello dei
servizi, dove tutto è ancora fortemente ancorato alla figura di Putin e ai suoi
fedelissimi del fu Kgb sovietico.
In tutto questo, una
serie di altre personalità politiche hanno modificato la loro posizione
all’interno della guerra. L’ex presidente Dimitri Medvedev, per esempio, ha
assunto il ruolo di megafono delle forze più oltranziste e nazionaliste della
Russia dopo essere stato ritenuto, nella sua breve stagione presidenziale, il
delfino moderato di Putin. Anche lui, al pari di altri, ha visto nella guerra
un’occasione di rivalsa pubblica, diventando a tutti gli effetti il leader
carismatico dei falchi e di chi vuole colpire l’Ucraina e la Nato.
Con i suoi canali
social, l’ex presidente alimenta una narrazione bellicista che serve soprattutto
a rafforzarlo nei circoli di potere intransigenti e nell’opinione pubblica
nazionalista. Ma anche in questo caso, la sua figura appare ben lontana da
quello di consigliere fidato di Putin, apparendo semmai come un uomo interessato
semplicemente a rafforzarsi in vista di un possibile mantenimento della
leadership di Putin (o anche solo delle elezioni).
L’imbarazzo dei
tecnici e la solitudine di Putin
Accanto a queste
figure più “pubbliche”, esiste poi un insieme di personalità tecniche che
appaiono sempre meno influenti nel cerchio magico di Putin. Da tempo il primo
ministro Mikhail Mishustin ha aumentato la retorica antioccidentale, ma appare
fondamentalmente lontano dal sistema dei fedelissimi, legandosi in realtà al
blocco dei pragmatici. I ministri più tecnici del governo non sembrano allineati
alle decisioni di Putin. Mentre la direttrice della banca centrale, Elvira
Nabiullina, ha già fatto intendere di avere perplessità sul futuro della Russia
e di volere trasparenza verso imprenditori, cittadini e mercati finanziari
rispetto alle conseguenze delle sanzioni, della guerra e dell’isolamento
internazionale.
In tutto questo
meccanismo di allontanamenti e di prove di convivenza con questo nuovo sistema
di potere di guerra, appare fondamentale quanto scritto di recente su Limes da
Orietta Moscatelli, e cioè che “nella notte del Natale ortodosso al Cremlino è
stato celebrato il funerale del ‘Putin collettivo'”. La scelta comunicativa del
presidente di apparire da solo nella chiesa dell’Annunciazione con pochi monaci
(e neanche con il patriarca Kirill) sembra confermare l’immagine di un leader
volutamente solo, unico e senza altri corresponsabili o complici.
Il Consiglio di
sicurezza della Federazione russa, una sorta di collegio dei più importanti
uomini del potere russo, è ormai distante dal capo del Cremlino. E, come ricorda
Limes, il fatto che la maggioranza dei russi sia ancora saldamente fiduciosa in
Putin, non abbia negato sostegno alla guerra in Ucraina e appaia soprattutto
desiderosa di non perdere, in qualche modo alimenta l’idea che l’uomo solo al
comando sia ancora la scelta politica migliore per il capo dello Stato.
La guerra ha
stravolto il sistema di potere. E in questo senso sarà essa, come appare ormai
chiaro, a decidere le sorti del putinismo. E con esso di un cerchio magico che
ha già cambiato pelle e in cui tutti i personaggi più influenti hanno paura di
essere considerati troppo vicini o troppo lontani dal presidente,
nell’incertezza del destino di Mosca. LORENZO VITA
Corruzione,
purghe e dimissioni: le lotte per il potere in Ucraina.
Andrea Muratore il
21 febbraio 2023 su Inside Over.
Il potere in
Ucraina è stato radicalmente trasformato dalla guerra d’aggressione scatenata
dalla Russia il 24 febbraio 2022. Volodymyr Zelensky, divenuto icona della
resistenza di Kiev, ha beneficiato dell’effetto rally’ around the flag della
popolazione e delle istituzioni. E ha radicalmente modificato il suo approccio
al potere.
Prima del conflitto
Zelensky e il suo partito, Servitore del Popolo, vivevano la classica situazione
della formazione di rottura giunta al potere e costretta a scontrarsi col crollo
di molte illusioni di trasformazione radicale della società. L’evento
straordinario della guerra ha dato alla presidenza poteri pressoché
illimitati nella gestione dei gruppi di influenza, dei rapporti tra lo Stato e
gli apparati economici, nella conduzione del conflitto. A cui nel corso dei mesi
sono però subentrati altri centri di potere a partire dall’intelligence
militare, ghiandola pineale dello Stato e perno del rapporto securitario con
l’Occidente, e delle forze armate.
Quel che è certo è
che il percorso del potere ucraino verso il crescente accentramento delle
funzioni attorno la presidenza non è stato, come si è visto, indolore. E la
gestione della catena del comando e dei rapporti politici più strutturati è
passata attraverso incidenti, scandali e rese dei conti.
Sono almeno tre gli
eventi chiave del percorso di sviluppo del potere in Ucraina dallo scoppio della
guerra in avanti. Il primo è legato alla ridefinizione del rapporto tra Zelensky
e gli oligarchi di Kiev. Il secondo all’onda lunga dello scandalo corruzione che
ha colpito diversi ministeri. Il terzo alle dimissioni di Oleksij Arestovych,
consigliere strategico numero uno di Zelensky. A cui si aggiunge il tema del
misterioso incidente d’elicottero di Brovary, a Kiev, del 18 gennaio che ha
decapitato i vertici della sicurezza interna.
Come cambia il
potere degli oligarchi con la guerra
Tenersi vicini gli
amici e ancora più vicini i propri nemici. Questa la logica che Zelensky ha
seguito nel contesto della gestione dei rapporti di potere tra Stato e oligarchi
a partire dall’invasione.
A luglio Zelensky è
arrivato a inserire il suo storico patron Igor Kolomoisky nella lista di dieci
figure a cui è stato tolto ogni diritto di cittadinanza per presunte attività
sovversive. Kolomoisky, editore delle Tv dai cui canali “Servitore del Popolo”
divenne da serie Tv con Zelensky protagonista un partito con l’ex comico come
leader, si trova ora in Israele.
Tra gli oligarchi
invece è diventato sempre più potente Rinat Akhmetov, patron dello Shaktar
Donetsk e storico avversario del presidente, che a novembre 2021 lo aveva
addirittura accusato pubblicamente di trame golpiste. Akhmetov, magnate della
metallurgia e patron dell’Azovstal di Mariupol, ha perso due terzi del suo
patrimonio con la guerra, ma con circa 4,5 miliardi di dollari è ancora l’uomo
più ricco del Paese e tra i 700 più facoltosi del pianeta. Ha finanziato
attivamente la guerra di resistenza dell’Ucraina e le sue proprietà, assieme a
quelle appartenenti all’ex primo ministro ucraino Arseniy Yatsenyuk, sono state
sequestrate dai russi in Crimea.
Akhmetov ha
negoziato il ritorno nell’alveo dei buoni rapporti col potere in cambio
dell’uscita dal business dei media proprio per sottrarsi alla formale etichetta
di “oligarca” prevista dalla legge contro gli oligopoli dalla dubbia legittimità
democratica prevista dal governo di Kiev per accelerare la lotta alla corruzione
e varata nel 2021. Mano libera al presidente sulla comunicazione e sostegno
fermo a Zelensky, tregua con il potere sulle ambizioni politiche, difesa del
business industriale e finanziario della sua System Capital Management (Scm):
questa la terna di priorità su cui Akhmetov ha patteggiato il suo riconoscimento
dell’autorità presidenziale, al contrario di quanto fatto da Kolomoisky.
Zelensky ha così trasformato un suo strenuo oppositore in un fedele e
indispensabile alleato.
Al contempo, l’ex
presidente Petro Poroshenko, sconfitto da Zelensky nel 2019, appare rientrato a
fianco dell’esecutivo dopo anni di braccio di ferro col suo successore. Ha
lealmente sostenuto la difesa ucraina, si è prestato a consigliare Zelensky su
come chiedere all’Occidente spingere sulle sanzioni alla Russia per colpire
l’economia russa e si è rilanciato per un futuro imprenditoriale e politico.
Sfuggendo alla mannaia anti-corruzione dell’esecutivo.
Lo tsunami
corruzione
La corruzione si
conferma un tarlo nel Paese. La Corte dei Conti Ue a fine 2021 scriveva che “in
Ucraina la corruzione rimane presente ad ogni livello dello Stato” e
rappresentava una minaccia al processo di adesione europea di Kiev. L’Unione
europea, scriveva la Corte, “ha cercato di combattere il fenomeno nel Paese,
convogliando fondi e interventi in svariati settori, dalla concorrenza al
sistema giudiziario, ma il sostegno fornito e le misure attuate non hanno
prodotto i risultati attesi”.
Zelensky è stato
eletto anche con l’obiettivo di ripulire il Paese dalla corruzione, ma la guerra
ha fatto venire alla luce i problemi endemici dei profittatori di guerra e dello
sciacallaggio. Il 21 gennaio il viceministro per lo Sviluppo delle
infrastrutture, Vasyl Lozynski, è stato arrestato e silurato dal governo nel
quadro di un’inchiesta che lo ha visto indagato per presunte manipolazioni di
bandi per l’acquisto di generatori elettrici per garantire la sicurezza di Kiev
contro i raid russi invernali.
A cascata, il
sottogoverno del Paese è stato falcidiato. Tra fine gennaio e inizio febbraio si
sono dimessi o sono stati rimossi il vicecapo dell’Ufficio presidenziale, Kyrylo
Tymoshenko, altri quattro viceministri (dalla Difesa, Vyacheslav Shapovalov,
dalle politiche sociali Vitaliy Muzychenko, dallo Sviluppo delle Comunità, Ivan
Lukerya e Vyacheslav Negoda), il procuratore generale in seconda Oleksiy
Simonenko e i vicecapi del Servizio statale dei Trasporti Marittimi e Fluviali,
Anatoliy Ivankevych e Viktor Vyshnyov.
Ora su questi fatti
indaga la magistratura interna. Zelensky ha preso al balzo la palla per ripulire
l’amministrazione centrale dell’annoso radicamento di sistemi di corruttele
interne agli apparati. E a rischiare di cadere è stata anche la testa
del ministro della Difesa Olekseij Reznikov, colpito dalle accuse di omessa
vigilanza sulle mosse del suo vice per presunte manipolazioni al rialzo di
commesse per le forniture dell’esercito e retrocesso all’Industria. Si è detto
per diversi giorni che Reznikov avrebbe perso la guida della Difesa venendo
sostituito da Kyrylo Budanov, già capo dell’intelligence militare. Ma a quanto
sembra Zelensky avrebbe optato per non muovere troppe pedine.
La militarizzazione
del potere
Budanov, giovane
maggior generale, ha comunque in questa fase contribuito alla militarizzazione
del potere di Kiev. Sempre più marziale e oltre la linea della gestione
diplomatica del conflitto. La Difesa e l’intelligence sono ad oggi le centrali
più importanti vicine alla presidenza, mentre il ministero degli Esteri è
oggigiorno in declino. E Dmitry Kuleba, titolare del dicastero, subisce le
intemperanze e le gaffe del “falco” suo vice, Andriy Melnyk.
A contribuire a
questo processo anche la morte, nella caduta dell’elicottero a Kiev del 18
gennaio scorso, del ministro dell’Interno Denys Monastyrsky, del suo
vice, Yevhen Yenin, e del segretario di Stato del ministero, Yurii Lubkovich. Al
cui posto è stato chiamato Igor Klymenko, ex capo delle polizia e militare di
carriera, “falco” antirusso come Budanov e Melnyk. La cui ascesa ha seguito di
poco l’uscita dal governo del consigliere militare più ascoltato da
Zelensky, Oleksij Arestovych, l’uomo che aveva previsto la guerra, “reo” di aver
aperto all’ipotesi di una soluzione diplomatica del conflitto.
Le stelle polari?
Zaluzhny e Podolyak
Chi invece è rimasto
stabile nella sua posizione e intoccabile è il duo che guida la resistenza
operativa di Kiev. Da un lato, il generale Valery Zaluzhny, comandante in capo
delle Forze Armate. Uomo pragmatico e soldato tutto d’un pezzo. A cui si
aggiunge lo stratega della guerra-ombra ucraina, Mykhalio Podolyak, tra i
capo-consiglieri del presidente, regista della guerra asimmetrica condotta dalle
spie ucraine contro Mosca e in sostegno all’Occidente. Punto di convergenza tra
politica, diplomazia e intelligence, il cui ufficio è la camera di compensazione
tra desideri di Zelensky, richieste occidentali e appunti degli apparati
riguardo la gestione del conflitto.
Zelensky, Zaluzhny,
Podolyak: questo il triumvirato di testa del potere ucraino. Un triangolo, più
che un cerchio magico, attorno cui la sfera del potere di Kiev ruota
vorticosamente.
Tra
militarizzazione, purghe, tragedie e lotte tra clan di potere il conflitto è un
acceleratore. E il sistema di potere di Zelensky si accorge del fatto che il suo
equilibrio interno è ad oggi legato alla guerra stessa, mentre le prospettive
per il post-conflitto appaiono ad oggi assai incerte. ANDREA MURATORE
Il volto della
guerra: cosa ci ha insegnato.
Paolo Mauri il 22
febbraio 2023 su Inside Over.
L’invasione russa
dell’Ucraina cominciata il 24 febbraio 2022 ha riportato lo spettro della guerra
in Europa dopo più di venticinque dal termine delle ostilità nei Balcani
determinate dallo sfaldarsi della Jugoslavia. Quel conflitto aveva
caratteristiche però diverse da quello attualmente in corso: era caratterizzato
infatti da una forte componente indipendentista, e sebbene combattuto
“convenzionalmente” (se pur con la presenza di milizie paramilitari volontarie)
si può ascrivere nel campo dei conflitti etnici/religiosi.
Come il terrorismo
ha cambiato gli eserciti
Una guerra di
conquista in Europa non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale, il cui termine
ha portato la divisione del mondo in blocchi contrapposti e una frontiera
impenetrabile in Europa che ha separato il continente sino al 1989: la Cortina
di Ferro. Questa spartizione, in funzione degli accordi di Jalta, ha garantito
una pace armata in Europa durata decenni – la Guerra Fredda – e il collasso
dell’Unione Sovietica del 1991 ha determinato la nascita di un mondo
unipolare che si credeva falsamente stabile.
La fine delle
dinamiche di opposizione tra due sistemi diversi (capitalismo e socialismo), ha
generato l’insorgenza del terrorismo internazionale di stampo religioso e
consequenzialmente la necessità del suo contrasto attivo anche al di fuori dei
confini nazionali dei Paesi vittima delle sue manifestazioni. Pertanto lo
strumento militare è radicalmente cambiato nel corso del decennio 1990/2000, e
gli eserciti (non solo occidentali) hanno sviluppato dottrine
di counterterrorism e counterinsurgency che hanno portato con sé
l’accantonamento del warfighting tradizionale, ovvero le operazioni belliche tra
enti statuali.
Riduzione del
personale, fine della coscrizione, ridimensionamento delle forze pesanti e di
quelle aeree sono i principali effetti di questa conversione che ha portato con
sé anche la rimodulazione del complesso militare industriale, non più chiamato a
soddisfare ordini per centinaia o migliaia di mezzi ed equipaggiamenti destinati
alle forze armate.
In particolare lo
stato delle forze pesanti è emblematico di questo passaggio epocale: il numero
di Mbt (Main Battle Tank) presenti negli eserciti europei è drasticamente
diminuito in quanto era venuta a cessare la minaccia convenzionale data
dall’URSS e dai Paesi del Patto di Varsavia.
Lo choc della guerra
in Ucraina
Il conflitto in
Ucraina, da questo punto di vista, è stato uno choc: improvvisamente la minaccia
di un’invasione in grande stile, in Europa, si era fatta reale. Eppure segnali
in questo senso c’erano già stati nel corso dei vent’anni precedenti: prima
ancora del colpo di mano russo in Crimea e della destabilizzazione del Donbass
nel 2014, la Federazione si era impegnata in una campagna militare contro
la Georgia per ottenere il controllo dell’Ossezia del Sud nel 2008.
Una prima
lezione che è stata appresa dalla guerra in corso è stata quindi la necessità di
rimodulare le forze armate, in particolare quelle terrestri,
al warfighting convenzionale e simmetrico, quindi dando importanza
all’addestramento in tal senso, all’acquisizione di nuovi/ulteriori sistemi
d’arma di tipo pesante per l’esercito (Mbt e artiglieria), al potenziamento
dello strumento aereo, alla capacità di interdizione e attacco marittima, e al
mantenimento di un’elevata prontezza operativa – il che richiede che tutte le
unità siano alimentate al 100% con personale pronto a muovere.
Il sostegno
militare dei Paesi della Nato e partner a Kiev, poi, ha mostrato sia le carenze
delle scorte di munizioni ed altro equipaggiamento sia i limiti dell’industria
bellica, che a fatica riesce a sostenere i ritmi imposti dalla guerra. Pertanto
questo conflitto sta mutando le politiche industriali di alcuni Paesi
occidentali, da troppo tempo abituati a una condizione di “pace” che
erroneamente si pensava duratura, o comunque essere una condizione quasi
perpetua in prossimità dei propri confini.
Il ritorno della
competizione tra Stati
L’invasione russa
dell’Ucraina ha infatti mostrato che il paradigma di riferimento nell’escalation
dei rapporti tra Stati, ovvero il modello “competizione-crisi-conflitto”,
sebbene sia obsoleto, è ancora possibile nonostante l’introduzione del concetto
di “concorrente” che spiega a livello macro quanto sta accadendo in Europa e in
altri scacchieri mondiali. I rapporti tra potenze globali (e relative alleanze)
sono passati a uno stato di “competizione duratura” (continuum competition),
ovvero di tensione internazionale permanente in cui diventa sempre più complesso
tutelare i propri interessi, che può anche sfruttare attori minori, secondari o
partner. Questa situazione è destinata a perdurare e acuirsi in futuro generando
una ricorrente instabilità (pervasive instability) contraddistinta da fenomeni
imprevedibili e dinamici, spesso con azioni condotte nella “zona grigia” (gray
zone) e quindi al di sotto del livello di innesco di un conflitto aperto. I
concetti di “competizione duratura” e “ricorrente instabilità” non sono del
tutto nuovi: circolano negli ambienti della Difesa da tempo.
La guerra in Ucraina
ha anche riproposto l’importanza dei sistemi unmanned non solo espressamente
costruiti per le forze armate: piccoli droni facilmente reperibili in commercio
sono stati usati per la ricognizione sul campo, per dirigere il tiro di
artiglieria e anche come strumenti di attacco al suolo improvvisati montando
artigianalmente piccole bombe di mortaio o Rpg (Rocket Propelled Grenade).
Qualcosa che si era già visto nel teatro siriano ma che si pensava fosse
limitato ai conflitti asimmetrici.
Sono state fatte
anche importanti valutazioni dello strumento aereo in considerazione
dell’attività di soppressione/distruzione delle difese aeree nemiche effettuata
dalla Vks (Vozdushno-Kosmicheskiye Sily), che hanno dimostrato – soprattutto per
via della dottrina russa di impiego dell’aviazione – l’importanza del
decentramento, l’efficacia dei sistemi standoff, e la necessità di limitare
l’uso di moderni vettori di precisione per mantenere la capacità di deterrenza.
Ancora una volta è
apparsa evidente la caratteristica “multidominio” di un conflitto, in quanto le
operazioni militari vere e proprie sono state anticipate da attacchi cibernetici
e da una pesante campagna di disinformazione (dominio informativo), senza
dimenticare la centralità dello spazio come evidenziato dall’assistenza fornita
all’Ucraina da partner occidentali civili e militari nei settori delle
comunicazioni, navigazione e intelligence.
La fine
dell’illusione unipolare
Passando a
un’analisi politica, la guerra ha sancito la fine dell’illusione
dell’unipolarismo. La Russia ha avviato il conflitto declinando in modo hard la
contestazione delle regole del diritto internazionale (ritenute dal Cremlino
plasmate dall’Occidente per proprio tornaconto) per i propri interessi
strategici. La stessa visione è declinata in modo soft – per ora – dalla Cina
che comunque osserva con vivo interesse quanto sta accadendo in Ucraina perché
avrà riflessi nel suo futuro agire all’interno dello scacchiere del Pacifico
Occidentale.
Da ultimo il
conflitto ha evidenziato come i metodi sanzionatori in ambito commerciale ed
economico sono solo parzialmente efficaci per erodere il potenziale bellico di
una nazione che può contare su vaste risorse, e soprattutto se protratti per
lungo tempo, permettono una rimodulazione del tessuto economico avversario e la
ricerca di canali di approvvigionamento alternativi per i beni necessari colpiti
da embargo; infine la stessa capacità di deterrenza delle sanzioni appare del
tutto inefficace se si considera che la Russia non ha abbandonato l’idea di
attaccare l’Ucraina nonostante la minaccia di ulteriori pesanti sanzioni dopo
quelle elevate nel 2014.
Vogliamo però
concludere questa trattazione, per una volta, con un aspetto umano: la guerra in
Ucraina ci ha insegnato ancora una volta che, nonostante i missili ipersonici, i
droni, l’intelligenza artificiale, la guerra elettronica e tutto quanto di più
moderno e “asettico” possa essere schierato da un esercito, un conflitto è
ancora un affare di uomini che combattono sul campo, e che l’uomo, oltre a
essere la risorsa più preziosa per un esercito, è anche il fattore capace di
generare le più efferate violenze anche senza l’uso di strumenti bellici
avveniristici. PAOLO MAURI
La guerra dei
droni nei cieli dell’Ucraina.
Davide Bartoccini su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
La guerra moderna,
quella che si sta combattendo sul fronte ucraino tra eserciti convenzionali che
mettono in campo ogni strategia e tecnologia, dalla guerriglia alla guerra
ibrida, dal vecchio fucile d’assalto sovietico Ak-47 ai nuovi droni da
battaglia mai in impiegati su così vasta scala e da ambo le parti, ci ha
mostrato, in questo ultimo sofferto e sanguinoso anno di guerra, come i
conflitti e il loro svolgimento sul campo siano in procinto di mutare per
sempre. Se un secolo fa gli uomini assistevano con stupore ai primi “duelli” del
cielo tra pionieri dell’aviazione che si misuravano nelle prime manovre di
combattimento, scambiandosi “bordate” di pallottole da pistole automatiche come
fossero fregate di marina; nei cieli dell’Ucraina che lambiscono l’Europa posta
sotto l’ombrello difensivo della Nato, dove ogni giorno centinaia di droni da
ricognizione e d’attacco portano a termine la loro missione, abbiamo assistito –
per la prima volta – ad un combattimento aereo tra Uav (unmanned aerial
vehicle): gli aeromobile a pilotaggio remoto che fino ad ora non aveva mai
trovato un pari avversario nell’aria.
Si è registrato
pochi mesi fa, nell’ottobre del 2022, e non si può avere un dato certo su quale
sia stato il primo – come non si è ancora accertato veramente quali sono stati i
primi piloti a combattere da un aereo all’altro – ma è stato confermato da un
video, seguito da molti altri simili, come i droni dell’eterogenea flotta
pilotata in remoto dagli ucraini abbia speronato un drone russo provocandone lo
schianto. Provocando l’immediata “emulazione” da parte degli avversari per
quello che è un nuovo e inatteso capitolo della guerra aerea.
La nuova guerra dei
droni
Mentre a terra i
carri armati e le batterei di razzi martellano i trinceramenti dei soldati che
patiscono il gelo dell’inverno in attesa delle offensive e controffensiva di
primavera, nemmeno stessimo leggendo un passo del libro di Erich Maria Remarque,
in cielo piccolo prodigi della tecnologia svolgono un ruolo fondamentale in un
conflitto che fornirà a strateghi, analisti e storici, le basi per studiare la
misura nella “guerra del futuro” che si sta combattendo davvero, sul campo.
Se nei conflitti
contemporanei, i droni considerati come “nuova” piattaforma da battaglia
(sebbene siano impiegato con successo già dalle guerre balcaniche, che video il
battesimo dell’aria dei primi Predator, ndr) erano principalmente impiegati in
teatri dove si combatteva una guerra asimmetrica, per individuare e solo insieme
seguito eliminare con il loro carico di missili guidati – pensiamo ad
Afghanistan e Siraq – nel conflitto tra si sta consumando tra Russia e Ucraina,
per la prima volta entrambe le parti sono dotate di questo tipo di arma e dei
sistemi anti-aerei/di disturbo per sventare rispettivamente la minaccia. Motivo
per il quale siamo assistendo ad un affinamento della strategie per il loro
impiego, o forse, considerando che abbiamo appena parlato di uno speronamento,
di “futuristiche” quanto efficaci regressioni.
Appare chiaro come
questo nuovo approccio possa cambiare del tutto le strategie per l’impiego
operativo degli Uav che sono esposti ad una nuova minaccia e non possono più
essere piattaforme costose, delicate e incapaci di difendersi autonomamente.
Attualmente
l’impiego di droni da parte di Kiev, che ne affida l’utilizzo alle forze
speciali, è comunque incentrato sull’osservazione del campo di battaglia.
Piccole unità dotate di droni da ricognizione che hanno preso il nome di “Ochi”
(Occhi, ndr), che raggiungono varie posizioni sul fronte e liberano i loro droni
per seguire gli spostamenti dall’alto, ed individuare l’avversario per poi
mandare le coordinate di postazioni di comando russe, batterie d’artiglierei e
sistemi da guerra sofisticati che “meritino” l’impiego di munizionamento guidato
fornito dagli Occidentali.
Accanto agli “aerei
in miniatura” noti come i droni Punisher di progettazione ucraina – i preferiti
dalle forze speciali ucraine poiché “incaricato” di recapitare piccole munizioni
con un carico esplosivo di poco superiore ai 2 chilogrammi per un raggio
d’azione di poco inferiore ai 50 chilometri – vengono impiegati prevalentemente
droni di dimensioni ridotte, economici, del tipo para-commerciale (perché
sicuramente vengono apportate più modifiche). Stiamo parlando di
quadricotteri Matrice 300 o Mavic, entrambi prodotti in Cina ma acquistati su
canali paralleli dal momento che ogni azienda produttrice cinese ha preso le
distanze dalla guerra.
Piccoli “giocattoli
della domenica” che come spiegato in dettaglio sul Washington Post, una volta in
prima linea vengono commutati in armi da battaglia per la guerra moderna.
Qualcosa di mai visto, solo teorizzato. Le forze speciali ucraine impiegano i
Mavic con piccole “lattine di Coca-Cola” inzeppate di esplosivo e collegare ad
un sistema di “sgancia” per farle cadere sui campi minati e aprire dei varchi,
ma anche per colpire il nemico e sottoporlo ad una nuova sorta di “guerra
psicologica”, dato che le lattine esplosive vengo impiegate anche sugli
accampamenti russi, e ormai sentir ronzare un piccolo drone “della domenica”
potrebbe equivalere a saltare in aria per una lattina carica di tritolo o
simili.
Dall’altra parte del
fronte, i russi si affidando all’Orlan-10, il principale drone da ricognizione
dell’esercito di Putin che vanta anche capacità di guerra elettronica – che gli
consente acciecare i droni avversari – ma ci ricorda una delle più grandi
problematiche di Mosca: la carenza di componenti microelettroniche, essenziali
per sistemi più avanzati che la Federazione Russa ha sempre acquistato
all’estero, senza farne sufficiente incetta prima della rafforzamento delle
sanzione che le impediscono di acquisirli. Secondo quanto riportato dalla stampa
internazionale, il ministero della Difesa russo avrebbe riconosciuto
ufficialmente questo suo deficit. Svelando il secondo grave “problema di
approvvigionamento“ dopo quello dei sistemi di guida del munizionamento
intelligente che già da mesi si è ipotizzato inizi a “scarseggiare” negli
arsenali di Mosca, o almeno in quelli ai quali si è attinto fino ad ora per le
operazioni militari in Ucraina. Secondo le fonti ucraine, sarebbero 580 Orlan-10
abbattuti durante quest’anno. Un numero enorme per un’arma di questo tipo.
I principali droni
stranieri sul fronte ucraino
Bayraktar Tb2 di
fabbricazione turca. Kiev ha acquistato i primi nel 2019, utilizzandoli
principalmente come droni da ricognizione nel conflitto mai cessato con i
separatisti filo-russi attivi sulla quella che era la linea di demarcazione nel
Donbas. Nell’ottobre 2021 un TB2 ha effettuato il suo primo attacco da “drone
armato”, il suo bersaglio era un obice nemico. I TB2 turchi, che hanno un costo
unitario di cinque milioni di dollari possono essere considerati
come piattaforma UAV più potente della flotta aerea di Kiev, essendo capati ci
trasportare e sganciare sul bersaglio quattro missili a guida laser – MAML o
anticarro UMTAS, entrambi prodotti dall’azienda turca Roktsan – nelle sortite
che possono durare fino a 24 ore, tenendo un’altitudine oltre i 7.000 metri.
Praticamente capacità analoghe ai Predator RQ-1 statunitensi. I Bayraktar hanno
avuto un posto di rilievo nei conflitti in Libia e Siria, svolgendo un ruolo non
meno decisivo nei combattimenti tra Azerbaigian e Armenia nel Nagorno-Karabakh.
L’esercito di Kiev ha usato i TB2 per attaccare le basi e le navi russe
sull’isola dei serpenti nel Mar Nero, da cui le forze di Mosca si sono ritirate
abbandonando un presidio che si credeva perso per sempre.
Per parte sua la
Russia – che pure ha sviluppato negli anni diversi programmi per l’ottenimento e
dispiegamento di droni da battaglia – ha acquistato, e impiegato per bersagliare
obiettivi di ogni tipo, sia militari che civili, centinaia di droni di
fabbricazione iraniana Shahed-136. Droni kamikaze basati sul concetto di ala
volante capaci di trasportare con un carico esplosivo di oltre trenta
chilogrammi per un raggio d’azione di 2.500 chilometri.
Utilizzati, come
opzione a basso costo che oltre a supplire la carenza di munizionamento di
precisione russo, ha attirato i missili terra-aria come ucraini come gli S-300 e
i Buk che erano preposti alla soppressione della minaccia aerea. Un genere di
armamento che non manca nell’arsenale fornito alle truppe di Kiev, che hanno
ricevuto le loitering-munition Switchblade gentilmente concesse dagli Stati
Uniti.
Si tratta di
un piccolo Uav killer lanciabile da un dispositivo portatile simile a un
mortaio, con una tangenza di 15,000 piedi ed è stato impiegato con successo in
Afghanistan contro quelli che gli americani classificano come “high value
targets”, generalmente leader e personalità influenti delle organizzazioni
terroristiche ma anche postazione trincerate come un nido di mitragliatrici.
Un duello tra droni
Entrambe le parti
belligeranti continuano a impiegare droni secondo l’uso convenzionale che se ne
è fatto fino ad ora: compiere voli di ricognizioni per acquisire informazioni e
localizzare bersagli sui quali guidare il fuoco dell’artiglieria. L’uso dei
droni kamikaze da parte dei russi, che hanno messo nel mirino la rete elettrica
ucraina, è una nuova declinazione dell’impiego del drone, ma non essenzialmente
una “novità” dato che i droni kamikaze o “suicide drone” sono stati sviluppati
proprio per questo genere di azione. Ciò ha anche fatto luce sulla difficoltà
d’intercettazione di questi piccoli oggetti volanti che non vengono individuati
dai radar e in ogni caso richiederebbero l’impiego di costosi missili dei
sistema di difesa aerea Patriot o Nasams, senza costringere l’avversario a
sacrificare o mandare a vuoto un sistema d’arma altrettanto costoso. La guerra,
come ben sappiamo, è fatta anche di economia.
I duelli tra droni,
che come abbiamo detto incentrano le loro tattiche su manovre di speronamento,
stanno già assistendo ad un affinamento della tecnica, vedendo gli attaccanti
ucraini compiere dei “tuffi” sui droni russi piombandogli dall’alto e sfruttando
il loro “punto cieco” e mirando, da una parte come dall’altra ai rotori dei
quadricotteri che perdendo anche una singola lama di uno delle pale, perdono il
controllo schiantandosi a terra, potrebbero però passare in secondo piano grazie
a una nuova tecnologia che come le altre potrebbe mostrarci – sul campo –
un’altro scenario delle guerra del futuro: i droni intercettori.
Proprio per ovviare
alle letali incursioni dei droni kamikaze iraniani impiegati dai russi, Kiev sta
pensando – con il supporto di quelli che ormai sono a tutti gli effetti i suoi
“consiglieri” occidentali – all’impiego su vasta scala del sistema
Marss. Fabbricato da una startup attiva nel settore della difesa con sede a
Monaco, tale sistema si basa su una nuova tipologia di drone che utilizzando
l’intelligenza artificiale identifica, traccia e attacca autonomamente i suoi
obiettivi in aria.
Ma questa, come al
solito è soltanto la punta dell’iceberg. Se fino a dieci anni fa – quando le
tensioni tra Russia e Ucraina manifestavamo le avvisaglie di un conflitto che
ancora oggi si combatte – il “drone” era considerato come un’arma pionieristica,
maneggiata da pochi ed estremamente “solitaria” – i primi Uav infatti venivano
mandati a combattere in territori distanti e ostili, contro gruppi di
guerriglieri armati al massimo di Rpg, e mitragliatrici leggere incapaci di
abbatterli – oggi chi ne sa più di noi ipotizza già “flotte di droni
intercettori” a caccia di formazioni di “droni bombardieri” che potrebbero
ricevere a loro volta la copertura di droni da combattimento posti a protezione.
Insomma, lo stesso scenario delle battaglia aeree del passato, quelle della
seconda guerra mondiale, con le stesse tattiche, ma con un piccolo non
trascurabile dettaglio a fare la differenza: l’assenza dell’essere umano in quel
vortice di manovre di combattimento che l’asso da caccia francese Pierre
Clostermann chiamava ai suoi tempi “Le grand cirque“. DAVIDE BARTOCCINI
Missili, tank e
jet: così la guerra è diventata un banco di prova per le armi
Paolo Mauri su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
Il conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina, ha
permesso di schierare nuovi sistemi d’arma e utilizzare nuovi concetti di
impiego di armamenti e mezzi mai usati prima in un reale ambiente bellico.
L’Ucraina è quindi
diventata un laboratorio per le armi come avviene per ogni conflitto, in ogni
tempo, da parte di ogni Paese. Per l’esercito statunitense e per quello russo,
ma anche per le forze armate degli altri alleati della Nato, il conflitto è
un’incredibile fonte di dati sull’utilità dei propri sistemi.
La parte occidentale
Da parte
occidentale, ad esempio, abbiamo visto in azione la loitering
munition “Switchblade”, che nonostante sia uno degli ultimi ritrovati della
tecnologia bellica, non ha trovato il favore delle truppe ucraine che hanno
preferito affidarsi ad altri sistemi simili, anche di produzione locale.
Come non ricordare,
poi, il sistema Mlrs (Multiple Launcher Rocket System) M-142 Himars, che sino a
questo conflitto non si era mai confrontato con un avversario “di pari livello”
rappresentato da un esercito regolare che utilizza tattiche di guerra
convenzionali come quello russo, essendo stato impiegato solamente in
Afghanistan precedentemente. Proprio gli Himars, quando sono arrivati in numero
adeguato, hanno dimostrato tutto il loro effetto dirompente grazie alla loro
gittata (circa 70 chilometri col munizionamento M30 ed M31) e alla loro
precisione, data da un sistema di guida Gps/inerziale. Gli M-142 sono stati
fondamentali per il buon esito delle controffensive ucraine della scorsa estate,
ed il loro successo è dimostrato anche dai nuovi ordini che sono arrivati alla
Lockheed-Martin e dalla decisione di aprire uno stabilimento produttivo in
Europa. Gli osservatori statunitensi, poi, grazie all’impiego intensivo di
questo Mlrs da parte degli ucraini, hanno potuto apprendere preziose lezioni
sulle tempistiche di riparazione e di manutenzione degli Himars.
L’alta mobilità
degli M-142 insieme alla velocità di lancio/ricarica, è servita anche a
effettuare nuove valutazioni sulla classica artiglieria trainata: gli
obici M-777, benché siano strumenti di ottimo livello, hanno dimostrato i loro
limiti dati dall’usura della canna (più colpi si sparano più se ne consuma
l’anima, soprattutto se rigata) e dalla scarsa mobilità, in quanto una batteria
di questo tipo di artiglieria richiede tempo per essere messa “in linea” e per
essere successivamente spostata. Qualcosa di già noto agli eserciti di tutto il
mondo, ma che è emerso in modo molto evidente nella guerra in Ucraina,
caratterizzata da un fuoco di controbatteria molto rapido ed efficace.
Restando tra
gli obici, primo impiego in un conflitto simmetrico anche per il semovente
francese Caesar e per il tedesco Pzh-2000, anch’essi utilizzati prima di questa
guerra solo nella lunga campagna afghana. Debutto anche per i sistemi da difesa
aerea land based Iris-T, forniti dalla Germania all’Ucraina, anche se al momento
non sono stati resi noti dati riguardanti il loro impiego bellico, e sempre
restando nel campo della missilistica, presto arriveranno i sistemi
italo-francesi Samp-T e i razzi del sistema statunitense Glsdb.
Dal punto di
vista tattico, l’esercito ucraino ha impiegato una nuova tattica di
combattimento organizzando squadre/plotoni di fanteria armati di Atgm (Anti Tank
Guided Missile) anche di fabbricazione occidentale come i Javelin o gli Nlaw,
per contrastare le colonne corazzate e meccanizzate russe con tattiche di
guerriglia, sfruttando soprattutto l’assenza della fanteria russa di supporto ai
carri armati. Un errore costato caro all’esercito di Mosca. Medesima tattica
usata anche utilizzando Manpads (Man Portable Air Defence System) come i missili
spalleggiabili “Stinger”.
Soprattutto gli
ucraini, prima dei russi, hanno introdotto un uso molto particolare dei droni di
tipo commerciale, dimostrando anche una notevole capacità di
adattamento/inventiva modificandoli, in alcuni casi, in modo da poter
trasportare munizionamento o mitragliatrici. I piccoli quadricotteri sono stati
usati per dirigere il tiro di artiglieria, oppure come strumenti di ricognizione
sul campo, ma soprattutto sono stati usati come piccola artiglieria volante
aggiungendo meccanismi auto-costruiti di sgancio di granate o bombe da mortaio
di piccolo calibro. Non si tratta solo di una mossa frutto della disperazione:
l’idea infatti è stata ripresa a livello industriale da alcuni costruttori di
sistemi d’arma, come dimostrato dalla vietnamita RT Robotics.
La sperimentazione
russa
Anche dal lato russo
si è dato ampio spazio alla sperimentazione di nuovi sistemi d’arma, sebbene
alcuni di essi già visti in altri teatri asimmetrici come quello siriano.
Risulta infatti che
anche nei cieli ucraini si sia visto il caccia di quinta generazione Sukhoi
Su-57, che, secondo i russi, avrebbe effettuato alcune missioni a fuoco. Sul
terreno, ad aprile, si è visto l’Ugv (Unmanned Ground Vehicle)
sminatore Uran-6 e il 3 febbraio sono comparse immagini che ritraggono il primo
sistema da combattimento terrestre senza pilota “Marker” schierato nell’area di
operazioni. L’ex direttore di Roscosmos, Dmitry Prigozin, ha affermato che il
“Marker” verrà testato in combattimento armandolo con missili anticarro.
Primo impiego in
combattimento anche per il Bmpt-72 “Terminator”, un veicolo corazzato di
supporto per gli Mbt (Main Battle Tank) ma che può anche essere usato in
appoggio alla fanteria come dimostrato dalle immagini giunteci dal fronte. Il
Bmpt-72 è basato sullo chassis del carro T-72 e nella sua prima versione era
armato con un singolo Atgm 2A42, quattro Atgm “Kornet” e una mitragliatrice Pktm
da 7,62 millimetri come armamento secondario. Un ulteriore sviluppo ha visto la
comparsa di una coppia di cannoni automatici da 30 millimetri, ed il “Kornet” è
stato sostituito coi più moderni Atgm “Ataka-T”.
Tornado nei cieli,
l’Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) “Orion” ha effettuato le sue prime missioni
operative, sebbene, dopo alcune settimane di guerra, non risulti che sia stato
più utilizzato ed è probabile che questi droni siano stati messi a terra per
carenza di parti di ricambio, preferendo affidarsi a quelli di fabbricazione
iraniana.
Il conflitto ha
decretato la fine prematura della carriera di un’intera classe di unità navale
in forza nella marina russa: le sei corvette (pattugliatori) della
classe project 22160 sono state ritirate da compiti di prima linea a causa delle
scarse prestazioni dimostrate nel conflitto, e la Vmf (Voenno-Morskoj Flot) ha
deciso lo scorso giugno di rinunciare alla consegna del secondo lotto di sei
unità.
Passando al campo
della missilistica, i russi hanno utilizzato per la prima volta il vettore
ipersonico Kh-47M2 “Kinzhal” e il sistema per missili balistici a corto raggio
(Srbm) Iskander-M. Il “Kinzhal” è un missile balistico aviolanciato (viene
agganciato a una versione speciale del MiG-31, la K) che risulta essere stato
utilizzato diverse volte in questo conflitto, mentre il missile 9M723-1
dell’Iskander-M ha avuto un ruolo centrale insieme ai missili da crociera nel
colpire obiettivi di elevata importanza o che necessitavano di una particolare
precisione. Sembra inoltre che siano stati usati anche i vettori da
crociera 9M729 lanciati dall’Iskander-K, prodotti in violazione del
defunto Trattato Inf, ma attualmente non c’è certezza.
Per le loitering
munitions russe, i Lancet e Kub, vale lo stesso discorso fatto per gli obici
semoventi occidentali o per gli Himars: si tratta del loro primo impiego in un
conflitto simmetrico, essendo già stati usati in Siria. Anche per i droni
iraniani usati dall’esercito di Mosca, in particolare le loitering
munitions Shahed-136 (ridesignate Geran-2 dai russi), i Mohajer-6, insieme ai
Shahed-129 e 191 questo è il primo conflitto simmetrico, e l’Iran – con la
Russia – potrà fare attente valutazioni della loro efficacia sul campo di
battaglia oltre sfruttare l’occasione per piazzare eventuali ordini dall’estero.
PAOLO MAURI
Eserciti di
Russia e Ucraina a confronto: cosa ha insegnato la guerra.
PAOLO MAURI su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
Nella notte del 24
febbraio del 2022 un intenso attacco missilistico ha dato inizio al conflitto in
Ucraina. L’esercito russo ha invaso il Paese dopo che per mesi Mosca aveva
accumulato truppe e mezzi lungo tutto il confine orientale e settentrionale
ucraino, compreso quello con la Bielorussia.
L’invasione si è
sviluppata lungo cinque direttrici principali (sei se consideriamo doppia quella
su Kiev effettuata da nord-est e nord-ovest) con lo scopo di provocare
il collasso dell’esercito ucraino e di arrivare rapidamente alla capitale
per rovesciare il governo Zelensky ed instaurare un regime fantoccio.
La consistenza delle
forze russe
La Russia ha
impiegato, nella fase iniziale dell’invasione, complessivamente un numero
compreso tra i 100 e i 120mila uomini (alcune fonti riportano 150mila) suddivisi
principalmente in circa 120 Btg (Batallion Tactical Group), l’unità base di
manovra dell’esercito russo composta da circa 700 uomini (per i reparti
meccanizzati).
La mobilitazione
russa ha riguardato anche l’aeronautica e la marina militare: le Vks
(Vozdushno-Kosmicheskie Sily), le forze aerospaziali russe, disponevano in
totale di 1434 velivoli da caccia e bombardieri di cui la componente da attacco
al suolo è composta da 234 Sukhoi Su-24, 192 Su-25 e 125 Su-34 a cui si
aggiungono 22 bombardieri Tupolev Tu-22M, 42 Tu-95 e 15 Tu-160. Sono stati
impiegati anche un certo numero di Su-30SM per il lancio di missili da crociera.
In totale, risulta che circa 350 velivoli siano stati usati nelle operazioni in
Ucraina. La Vmf (Voenno-Morskoj Flot), la marina russa, ha utilizzato l’intera
componente della Flotta del Mar Nero rinforzata con unità prelevate da altri
distretti (navi da assalto anfibio della classe Ropucha, Ivan Gren e minori)
fatte giungere nelle settimane antecedenti l’inizio dell’invasione per poter
oltrepassare gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli successivamente chiusi
dalla Turchia al transito di unità navali belligeranti come da Trattato di
Montreux.
Le fregate, le
corvette e i sottomarini russi della classe Kilo presenti in quello specchio
d’acqua sono stati impiegati (e lo sono tutt’ora) per il lancio di missili da
crociera tipo Kalibr, mentre la nave ammiraglia della Flotta del Mar Nero,
l’incrociatore della classe Slava “Moskva” aveva compiti di scoperta, protezione
antinave/antiaerea e centro di comando, controllo e comunicazione (C3) sino al
suo affondamento avvenuto lo scorso aprile.
L’esercito russo
prima del conflitto aveva una forza totale di circa 280mila uomini a cui si
aggiungevano 17mila elementi degli Spetsnaz suddivisi in sette brigate
indipendenti, e 45mila truppe aviotrasportate divise in due divisioni
aviotrasportate, due da assalto aereo e quattro brigate indipendenti da assalto
aereo più un reggimento da ricognizione di Spetsnaz distaccato. La Russia
disponeva di circa 2700 Mbt (Main Battle Tank) in servizio attivo (su più di
12mila totali) composti per la maggiore parte da T-72 (in varie versioni), T-80
e T-90. Da sottolineare che la Federazione mantiene ancora un’importante
aliquota di personale coscritto (circa il 30% del totale).
Le operazioni
terrestri sono cominciate quasi contemporaneamente alla campagna aerea e hanno
puntato su Kiev partendo dalla Bielorussia, su Chernihiv/Kharkiv, sulla regione
del Donbass ancora controllata dall’Ucraina, su Mariupol, su Kherson e Melitopol
partendo dalla Crimea occupata nel 2014. Abbiamo la conferma del tentativo russo
di effettuare un blitz sulla capitale ucraina per cercare di catturare/eliminare
il governo Zelensky in quanto nelle prime ore del conflitto è stata tentata
un’operazione elitrasportata sull’aeroporto di Gostomel (circa 30 Km a
nord-ovest di Kiev) che avrebbe dovuto essere il preludio allo sbarco di forze
aviotrasportate da usare per avanzare verso i palazzi governativi, insieme a
un’altra presumibilmente sull’aeroporto di Vasylkiv, situato a sud-ovest della
capitale.
Queste operazioni
sono fallite per l’immediata reazione avversaria, in quanto gli ucraini sono
stati preventivamente avvisati dall’intelligence occidentale (probabilmente
statunitense e britannica).
Come hanno risposto
le forze ucraine
L’esercito
ucraino poteva contare, prima del conflitto, su circa 145/150mila
uomini (incluse le forze aviotrasportate/paracadutisti) e su approssimativamente
50mila effettivi della Guardia Nazionale, a cui si aggiungevano 10mila della
difesa civile, entrambi però alle dipendenze del ministero degli Interni di
Kiev. Da non dimenticare i riservisti, stimati, nel novembre 2018, in 178mila
unità. L’esercito rappresenta la fetta maggiore delle forze armate ucraine
(12mila uomini facevano parte della marina e 40mila dell’aeronautica).
Con l’inizio del
conflitto il governo ucraino ha stabilito la mobilitazione generale di tutta la
popolazione maschile di età compresa tra i 18 e i 60 anni in successive ondate,
ma l’addestramento procede a rilento. A luglio 2022 il governo di Kiev riferiva
che erano circa 700mila le persone mobilitate per le forze armate, fino a 60mila
per la Guardia di Frontiera, fino a 90mila per la Guardia Nazionale e fino a
100mile per le forze di polizia.
L’esercito ucraino,
prima dell’invasione, aveva in totale 2590 Mbt di vario tipo (T-64, T-72, T-80 e
T-84) di cui la maggior parte, 1790, erano vecchi T-64. Le condizioni generali
dei carri armati ucraini riflettevano quelle dell’esercito ucraino: nonostante
una grande industria della difesa e vaste scorte di armi, gran parte
dell’equipaggiamento era obsoleto oppure non più aggiornato o comunque
abbisognava di riparazioni significative. La marina ucraina è praticamente
inesistente, fatta eccezione per una vecchia fregata di fabbricazione sovietica
classe Krivak III, andata perduta nelle prime fasi del conflitto, è costituita
da poche decine di unità sottili o piccole navi da sbarco che comunque hanno
avuto un ruolo nella battaglia per l’Isola dei Serpenti. L’aeronautica ucraina
disponeva, prima della guerra, di 43 Sukhoi Su-27, 27 MiG-29, 17 Su-25 e 12
Su-24M, insieme a una dozzina di Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) di
fabbricazione turca Bayraktar TB2. Per quanto riguarda l’ala rotante Kiev poteva
contare su solamente su 35 elicotteri da attacco Mil Mi-24 e su 65 multiruolo
Mi-8. Difficile stabilire, invece, il numero degli elicotteri usati dai russi,
ma sappiamo che sono stati usati Kamov Ka-52, Mil Mi-24/35,e Mi-28 da attacco
insieme a Mi-8/17 da trasporto.
Errori e limiti
dell’esercito russo
L’operazione
militare russa ha fallito i suoi obiettivi originari perché, oltre a carenze
strutturali (corruzione endemica, carenze logistiche, catena di comando
macchinosa che lascia poco spazio all’improvvisazione sul campo di battaglia),
c’è stata una sottovalutazione del potenziale bellico e del morale avversario,
determinata principalmente da alcuni fattori.
Innanzitutto
la propaganda russa, che ha dipinto il governo di Kiev come “nazista” e inviso
alla popolazione e la narrazione dei “popoli fratelli”, è stata fallimentare sia
sul fronte interno sia su quello esterno. Internamente, infatti, nei comandanti
locali (e non solo a quanto sembra), c’è stata la convinzione di aver intrapreso
una “guerra di liberazione” che avrebbe avuto il sostegno del popolo ucraino e
di ampie fette delle sue forze armate.
Questo, come
sappiamo, non è avvenuto e, al contrario, l’invasione ha coalizzato la
popolazione ucraina intorno alla dirigenza politica nazionale con anche la
minoranza russofona al di fuori dalle regioni occupate dai russi nel 2014
diventata ostile alle forze russe.
L’ampiezza del
fronte e le numerose direttrici di avanzata molto distanti tra loro hanno
disperso le esigue forze dell’esercito di Mosca che hanno dovuto affrontare
anche enormi difficoltà logistiche date inoltre dall’esigua rete stradale in
alcuni settori invasi. Non è infatti un caso che, dopo alcune settimane di
attacchi infruttuosi verso la capitale e nella regione di Chernihiv, sia stato
dato l’ordine dallo Stato Maggiore russo di ritirarsi.
La stessa tattica di
impiego delle forze corazzate, probabilmente per via della carenza di personale,
è stata erronea: i carri armati molto spesso sono stati fatti avanzare senza il
supporto della fanteria (anche nei centri abitati, vere e proprie trappole per
i tank), diventando facile bersaglio per le truppe avversarie armate di Atgm
(Anti Tank Guided Missile) forniti in gran numero dall’Occidente e altri sistemi
anticarro. Si calcola, infatti, che alla fine di gennaio l’esercito russo abbia
perso 1579 Mbt confermati da fonti Osint (Open Source Intelligence). Cattiva
intelligence, sottovalutazione dell’avversario, difficoltà logistiche e mala
gestione del personale a disposizione sono quindi le cause principali del
fallimento della “operazione militare speciale” di Mosca ed il motivo principale
per cui, a un anno di distanza, l’Ucraina non è crollata sotto il peso
dell’attacco russo.
Gli errori
dell’Ucraina
Spostandoci sul lato
ucraino, l’esercito, nonostante gli sforzi adottati dal 2014 al 2022 per
adeguarlo agli standard occidentali anche tramite attività di addestramento, non
è paragonabile come livello a quelli dei Paesi più moderni: la corruzione,
infatti, è presente anche in Ucraina e soprattutto vengono utilizzati quasi
esclusivamente armamenti obsoleti di fabbricazione sovietica/russa, i cui pezzi
di ricambio hanno cominciato a scarseggiare quasi dalle prime battute del
conflitto in quanto era impossibile accedere ai ricambi in Russia, e i mezzi
rimasti negli ex Paesi del Patto di Varsavia ora passati nell’Alleanza Atlantica
sono ormai pochi rispetto a due decenni fa, essendo stati sostituiti per la
maggior parte da mezzi moderni di fabbricazione occidentale.
Dal punto di vista
tattico, lo Stato Maggiore ucraino ha commesso qualche errore potenzialmente
disastroso nel corso del conflitto. Se il decentramento di sistemi da difesa
aerea e cacciabombardieri ha relativamente funzionato, l’esercito ucraino non ha
distrutto i vitali ponti nel sud del Paese, trovandosi così con le formazioni
corazzate e meccanizzate russe saldamente a ovest del fiume Dnepr dopo
pochissimi giorni di guerra. Un secondo errore ucraino, imputabile però alla
stessa natura dell’esercito che risente ancora dell’impronta sovietica, è stato
lo scarso coordinamento (in numerosi casi del tutto assente) tra le unità nei
primi mesi del conflitto, almeno sino ad agosto. I contrattacchi ucraini,
infatti, sono stati isolati, spesso ad opera di formazioni ridotte e mal
gestite, e se in alcuni settori sono stati efficaci ricacciando indietro i
russi, lo si deve più alla scarsa reazione nemica che all’effettiva capacità dei
comandanti, che anche qui sono apparsi isolati gli uni dagli altri.
Scarso coordinamento
che, nella prima settimana di guerra, ha colpito anche le unità della difesa
aerea le quali, benché decentrate, spesso sono rimaste inattive (anche per via
del primo colpo russo alle infrastrutture C3) costringendo l’aeronautica ucraina
a intervenire subendo perdite.
Siamo in una
situazione in cui la Russia non ha vinto la guerra ma l’Ucraina non l’ha persa:
attualmente si prospetta uno scenario in cui il conflitto, diventato una guerra
d’attrito, assorbirà sempre più risorse senza che nessuno dei due belligeranti
possa ottenere i propri obiettivi strategici (per Kiev è la liberazione dei
territori occupati, Crimea e Donbass compresi), pertanto è facilmente destinato
a diventare uno dei tanti “conflitti congelati” dell’intorno russo. PAOLO MAURI
L’industria
bellica globale dopo la guerra in Ucraina.
LORENZO VITA su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
Quando si parla
di armi e mezzi al fronte, i due temi principali di cui si discute sono il ruolo
che questi strumenti possono avere nel conflitto e il loro peso dal punto di
vista della diplomazia. Ma nella guerra in Ucraina, la quantità e la qualità
delle armi richieste e usate da Kiev e quelle fabbricate e utilizzate da Mosca
sono tali da far sì che vi sia un altro elemento da tenere in considerazione: e
cioè l’impatto che questo conflitto ha avuto e può avere sull’industria bellica.
Dal punto di vista
economico, è chiaro che l’aumento della domanda di armi per l’invasione russa ha
innescato un meccanismo di guadagno da parte delle aziende produttrici. Questo è
un tema che risulta connaturato al fatto che vi sia stato un picco nella domanda
di armi, mezzi e munizioni. Ma la guerra in Ucraina, per l’industria della
difesa, è soprattutto una sfida: si è trattato infatti di reagire non solo
all’aumento degli ordini, ma anche a come gestire il rispetto delle consegne dei
vari clienti, a come rimpiazzare negli arsenali occidentali le armi o i mezzi
inviati a Kiev e soprattutto di come controllare l’intera catena logistica già
messo sotto pressione per altri ostacoli globali.
Se infatti da anni
si assiste, a livello globale, a un aumento della produzione di armi e
soprattutto a un riarmo che indica che diversi Paesi stanno aumentando la
propria capacità militare e modernizzando le proprie forze, il conflitto
russo-ucraino arriva dopo un periodo pandemico in cui la catena di
approvvigionamento di materie prime e prodotti lavorati o semilavorati si è
spesso inceppata, o comunque rallentata. Questo quindi ha comportato due
condizioni di partenza già difficoltose: problemi nel rifornimento
dei materiali (in particolare di materie prime e semiconduttori) e una quantità
di ordini già avviati e che dovevano essere necessariamente rispettati.
La duplice sfida
dell’industria bellica
La guerra ha
comportato poi non solo un’impennata della domanda, ma ha anche costretto molto
spesso a rimodulare l’offerta dell’industria bellica a seconda delle rinnovate
esigenze del mercato delle armi. Lo spiega la Repubblica in un’interessante
analisi. “Nel 2021 la richiesta era concentrata su sistemi hi-tech: aerei da
combattimento, elicotteri, fregate, sottomarini” scrive Floriana Bulfon, “la
guerra in Ucraina ha cambiato le priorità: si cercano cannoni, droni, mezzi
corazzati e soprattutto munizioni”. Questo cambiamento nella richiesta da parte
dei Paesi implica una duplice sfida.
Da un lato c’è un
problema di un’industria che si è ritrovata sotto pressione in modo repentino e
spesso senza adeguate coperture di materie prime e di manodopera. Inoltre, c’è
anche un problema legato al fatto che non tutti i Paesi che hanno le capacità
industriali per produrre armi sono ora in grado di produrre quanto richiesto. E
questo proprio perché il mercato, finora, ha avuto un altro tipo di
domanda. L’Europa appare in ritardo in diversi segmenti fondamentale delle varie
difese. Altri Paesi si sono attrezzati in tempo riuscendo a colmare solo in
parte le richieste del mercato, con un cambiamento fondamentale anche nella
stessa geografia delle partnership e dei flussi finanziari.
Se questo era lo
stato all’inizio del flusso di armi verso l’Ucraina, il sostegno reso ancora più
evidente attraverso l’ok alla cessione di tank, sistemi lanciamissili, antiaerei
e mezzi è possibile che provochi un nuovo cambio di passo già quest’anno. Perché
non c’è solo necessità di rifornire Kiev, ma, come detto, anche di colmare il
vuoto lasciato (o che sarà lasciato) negli arsenali occidentali. I Paesi
occidentali, infatti, hanno già fatto capire di dovere necessariamente evitare
di rimanere indeboliti dalla vendita di tank e missili, e, in attesa di capire
se mai si sbloccherà la partita degli F-16, intanto molti hanno già fatto
comprendere di volere rimpiazzare armi e mezzi inviati in Ucraina con elementi
nuovi e tecnologicamente avanzati. Quindi che devono essere prodotti.
Le ripercussioni
della guerra in Ucraina
Su questo punto, la
guerra in Ucraina può innescare altri processi da tenere in considerazione. Il
primo riguarda il livello prettamente legato alla produzione. L’interruzione dei
rapporti economici con la Russia e le sanzioni per chi opera con essa
costituiscono ostacoli quasi insormontabili al flusso di materie
prime provenienti dal territorio di Mosca. Questione cui si aggiunge anche il
dato dell’aumento esponenziale di produzione di armi e mezzi militari da parte
della Russia per far fronte alle esigenze dell’invasione, e che potrebbe quindi
comportare un’ulteriore diminuzione della quantità disponibile nel mercato.
Lo spiega un
rapporto del Sipri, che sottolinea (citato da Deutsche Welle), come questo
“potrebbe ostacolare gli sforzi in corso negli Stati Uniti e in Europa per
rafforzare le proprie forze armate e ricostituire le scorte dopo aver inviato
miliardi di dollari di munizioni e altre attrezzature in Ucraina”. Naturalmente
è una situazione che vale anche per il Cremlino, che ora deve fare i conti con
il blocco da parte dell’Occidente, con aziende internazionali preoccupate dalle
sanzioni occidentali e soprattutto con il rischio che molte materie prime e
molti elementi fondamentali per la produzione siano destinati ad altri clienti.
Oltre a questo, la
produzione aumentata per l’inizio della guerra ha già fatto capire i gravi
problemi legati alla catena logistica nella produzione delle armi, con la
conseguenza che accorciarla porterà inevitabilmente a un costo in termini
economici e di distribuzione della manodopera. Il Financial Times,
in un’inchiesta sull’effetto della guerra per l’industria bellica americana,
oltre a descrivere il boom di introiti legato alle vendite, segnala un dato su
cui vale la pena riflettere: quello della rete di imprese piccole, medie e
grandi che collaborano nell’assemblaggio di una sola arma. L’esempio citato dal
quotidiano finanziario è quello di Himars, Gmlrs e Javelin: i primi due
assemblati in 141 diverse città degli Stati Uniti, mentre i Javelin addirittura
realizzati in 16 stati diversi.
Il secondo processo
che potrebbe innescarsi con il conflitto ucraino è invece legato alle modifiche
delle esigenze di tutti i Paesi, non solo occidentali, per il prossimo futuro.
Il confronto diretto tra sistemi e armi del blocco Nato e quelli prodotti
dall’industria russa rappresenta, infatti, un enorme test in grado di poter dare
indicazioni molto precise sull’efficacia di certi elementi. L’industria bellica
non deve pertanto solo rispondere alla domanda di ora, ma anche rimodularsi in
base alle esigenze future, dal momento che la guerra in Ucraina, oltre a
sconvolgere il panorama politico, può certamente influire sul modo in cui sono
valutate l’importanza di certe commesse e la loro utilità. Inoltre, la natura
del conflitto e le reazioni innescate a livello politico possono anche far
perdere appeal a certi sistemi o alcuni prodotti di determinate industrie
belliche, rischiando quindi di far deviare alcuni investimenti su altri fronti
in base alla natura degli scenari che vengono realizzati da strateghi militari e
politici. LORENZO VITA
Le spie
anglosassoni al servizio di Kiev.
ANDREA MURATORE su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
I servizi segreti
occidentali hanno sostenuto attivamente la resistenza ucraina all’invasione
russa intensificando dal 24 febbraio 2022 l’appoggio già attivo prima
dell’aggressione di Mosca.
Tra i Paesi più
coinvolti in questa partita, Stati Uniti e Regno Unito sono apparsi in prima
fila nel garantire un consistente appoggio alla resistenza di Kiev. Gli occhi e
le orecchie dell’intelligence anglosassone hanno permesso all’Ucraina di
ottenere informazioni privilegiate, conseguire successi e rafforzare la sua
posizione difensiva. L’altra faccia della medaglia di questa vicenda è stata la
progressiva dipendenza dell’Ucraina dalle informazioni privilegiate
dell’Occidente. Un processo graduale, a cui ha partecipato anche l’Italia, che
ha visto Londra e Washington diventare le centrali di elaborazione del pensiero
strategico ucraino.
Ukusa e Five Eyes,
cuore del sostegno all’Ucraina
Intelligence su
fonti aperte (Osint), sostegno alla diplomazia, trasferimenti protetti di
armamenti, osservazioni satellitari, controspionaggio in Ucraina e nei Paesi
Nato, attività di tutela dai cyberattacchi: il coinvolgimento dei servizi
d’informazione e sicurezza dell’Anglosfera è stato a 360 gradi.
Il nucleo stretto
del sostegno d’intelligence a Kiev è stata l’alleanza Ukusa espansa
all’Australia oltre a Londra e Washington. Canberra ha contribuito a fornire
siti e infrastrutture per espandere la rete strategica alle spie di Londra e
Washington, prima fra tutte quella di Pine Gap da cui la Cia, la Nsa,
il Mi6 britannico e l’australiano Defence Signals Directorate (Dsd) hanno
seguito per mesi la mobilitazione russa nell’Ovest del Paese prima e gli
spostamenti in Ucraina poi.
Attorno al terzetto,
si sono posizionati Canada e Nuova Zelanda, che con i tre Paesi costituiscono la
rete spionistica dei Five Eyes. E in parallelo una serie di intelligence amiche
e di sostegno: Israele, Polonia, Germania, Italia e Paesi baltici. Con le quali
il coordinamento è stato costante per garantire ai servizi segreti e alle forze
armate di Kiev sostegno costante.
Moore e Burns, i
diplomatici che guidano la guerra delle spie
Al centro di tutto,
due uomini: William Burns e Robert Moore. Due diplomatici diventati “zar” delle
rispettive intelligence. Due uomini dall’elevata cultura strategica trovatisi a
essere comandanti in guerre-ombra senza essere bellicisti, al servizio di
governi che hanno oscillato al loro interno tra spinta anti-russa e reticenze
(Usa) o sono stati sconvolti da cambi ai vertici (Usa).
Burns, direttore
della Cia, e Moore, direttore dell’MI6, hanno coordinato le strategie e
soprattutto i ritmi e i tempi della guerra-ombra. Parte più efficace di
una guerra per procura ove ai più alti livelli, con l’impegno di armi pesanti
occidentali contro la Russia, l’escalation è dietro l’angolo. E sostanziatasi
anche per mezzo del sostegno al controspionaggio che sta portando alla scoperta
di spie russe ovunque, dall’Estonia alla Germania.
Come ha operato
l’intelligence
L’intelligence
anglosassone ha avuto anche i suoi fedelissimi per i flussi di informazioni e i
dettagli operativi. In Ucraina la catena del contatto con Volodymyr Zelensky è
stata costruita passando per Kyrylo Budanov e col consigliere presidenziale
Mykhalio Podolyak. Il sostegno operativo si è sostanziato in almeno tre
direttrici.
La prima è quella
della divulgazione massiccia tramite fonti aperte delle mosse russe, dalla
manovra per creare confusione informativa nel cerchio magico di Vladimir Putin
al massiccio passaggio di informazioni alla stampa. Il New York Times in America
e il Times nel Regno Unito sono diventate centrali informative che hanno passato
in continuazione le veline dei servizi segreti. In un contesto di coordinamento
totale che dice molto sulla gestione degli arcana imperii in era di “guerra
senza limiti”.
Le seconda
dimensione è quella del sostegno diretto alle operazioni ucraine. La
sorprendente manovra con cui i russi sono stati inchiodati a Gostomel nelle
prime ore del conflitto, frenando l’operazione aviotrasportata per prendere
Kiev, è stata favorita dalle informazioni di intelligence Usa e britanniche. La
Cia ha sostenuto Kiev con le informazioni necessarie a colpire l’incrociatore
russo Moskva e ad affondarlo a maggio. E il coordinamento tra spie occidentali,
informazioni satellitari e fonti aperte ha favorito i continui bombardamenti
ucraini su centrali operative russe che hanno causato una moria di alti
ufficiali. Ma la svolta più importante si è avuta ai tempi della controffensiva
autunnale nell’Est dell’Ucraina. Di particolare valore le operazioni di signal
intelligence che hanno consentito l’intercettazione di flussi dati provenienti
da e verso i comandi militari di unità e armate russe per indicare i punti
focali delle offensive ucraine. Una vera e propria “intelligence in tempo reale”
a sostegno delle forze di Volodymyr Zelensky.
Ultima, ma non meno
importante questione, è quella della postura diplomatica. Le spie e gli
ambasciatori alla loro guida hanno giocato un ruolo decisivo nella diplomazia
atlantica favorendo sia le strategie a tutto campo della Nato per mantenere la
coesione interna sia gli abboccamenti con terze parti come la Turchia per
organizzare tregue diplomatiche, tenere aperti ponti negoziali e evitare il
precipitare della situazione. Dall’ombra gli 007 anglosassoni non cercano la
guerra a ogni costo. Piuttosto, vogliono governarne le conseguenze più
imprevedibili. Sostenendo l’Ucraina evitando salti nel vuoto all’Occidente. Per
mantenere la presa su un conflitto che possono governare solo finché non
arriverà alle estreme conseguenze. Che non convengono a nessuno, nemmeno alle
spie dell’Anglosfera, chiamate a combattere con la loro intelligenza prima
ancora che con le loro strategie. E messe alla prova con buoni successi nella
tempesta d’Ucraina. ANDREA MURATORE
Tutti gli errori
e i problemi dell’esercito russo nella guerra in Ucraina
PAOLO MAURI su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
L’invasione russa
dell’Ucraina cominciata nella notte del 24 febbraio 2022, avrebbe dovuto
portare, secondo i piani del Cremlino, alla rapida caduta di Zelensky,
alla demilitarizzazione del Paese e all’allontanamento di Kiev dall’orbita
occidentale, determinando una sorta di neutralità forzata dal sapore di un
controllo da parte di Mosca.
La “operazione
militare speciale”, così è stato chiamato il conflitto dalla propaganda
governativa russa, ha dimostrato diverse lacune strutturali nelle forze armate
russe, e palesato alcuni grossolani errori tattici che hanno contribuito a
determinare il fallimento del raggiungimento degli obiettivi originariamente
prefissati dallo Stato maggiore russo.
Gli errori di
valutazione
Mosca
ha sottovalutato la capacità di reazione e resistenza dell’esercito ucraino
perché la sua intelligence è stata scarsamente efficace nel valutare sia il
potenziale bellico di Kiev, sia la volontà di combattere e di opporsi
all’invasione del popolo e delle forze armate ucraine. Testimonianze di fonti
russe giunteci nel corso della guerra dimostrano che i comandi russi si
aspettavano di trovarsi davanti a una popolazione amichevole e che l’esercito
ucraino si sfaldasse sin dalla prime fasi delle operazioni, in quanto si
riteneva, erroneamente, che il governo Zelensky fosse inviso alla maggior parte
del popolo ucraino. Avrebbe quindi dovuto essere una guerra di liberazione,
secondo Mosca, ma come abbiamo visto così non è stato se non per alcune regioni
del Donbass, più per motivazioni determinate da un conflitto che perdura dal
2014 che per reale parteggiamento per la causa russa. Da notare, a tal
proposito, che anche le popolazioni russofone degli oblast’ occupati durante
l’invasione dello scorso febbraio, si sono dimostrate ostili alle forze di Mosca
una volta finite sotto il fuoco russo.
Un altro errore di
valutazione commesso da Mosca è stato l’aver sottovalutato l’aiuto occidentale,
che si è palesato non solo attraverso l’invio di armamenti, munizioni e aiuti
economici, ma anche con la condivisione di preziosi dati di intelligence
raccolti principalmente da Stati Uniti, Regno Uniti e alcuni altri Paesi
dell’Alleanza Atlantica. Difatti è stato possibile neutralizzare il tentato
blitz russo sull’aeroporto di Hostomel, situato a circa 30 chilometri a
nord-ovest della capitale ucraina, effettuato nelle prime ore del conflitto,
grazie alle informazioni raccolte e condivise in tempo reale dall’intelligence
statunitense e britannica.
Cattiva
intelligence, per i russi, ha significato anche non poter eliminare
completamente la minaccia della difesa aerea ucraina: l’attività di
soppressione/distruzione delle difese aeree (Sead/Dead) effettuata nei primi
giorni della campagna, sebbene abbia portato all’eliminazione di un centinaio di
sistemi avversari, non ha completamente disarticolato l’architettura difensiva
ucraina, che in buona parte era stata decentrata nei giorni e nelle ore
immediatamente precedenti l’inizio del conflitto. Questo fattore, insieme alla
stessa dottrina russa di impiego dello strumento aereo, ha comportato
l’impossibilità per le forze aerospaziali russe (le Vks – Vozdushno-Kosmicheskie
Sily) di ottenere la superiorità aerea se non localmente e per un limitato arco
temporale. La Russia, difatti, non postula il dominio dei cieli come lo
intendiamo in Occidente, ma si limita a usare lo strumento aereo in funzione
delle operazioni terrestri, quindi a supporto delle direttrici di avanzata delle
forze meccanizzate/corazzate. Da notare che anche l’attività di interdizione
deputata ai missili (siano essi da crociera o balistici) non ha colpito
pesantemente le infrastrutture strategiche ucraine (porti, aeroporti, snodi
ferroviari, reti elettriche e di comunicazione), forse perché Mosca era convinta
di poter conquistare rapidamente il Paese con un regime change, quindi senza
spargere troppa distruzione.
Le scelte sbagliate
sul campo
Passando
alle operazioni terrestri, un grossolano errore, ma ancora una volta ascrivibile
all’erronea valutazione sulla rapida caduta del governo di Kiev, è stato quello
di invadere l’Ucraina da troppe direttrici con un numero di uomini e mezzi non
sufficiente: si contavano infatti sei linee di avanzata principali (cinque se
consideriamo doppia quella sulla capitale) molto distanti tra di loro e
utilizzanti circa tra i 140 e i 200mila uomini (di cui buona parte tenuta a
guardia dei confini). Questa tattica ha avuto il risultato di disperdere le
esigue forze su un territorio molto vasto, lasciando “le punte di lancia” russe
in balia di loro stesse, non avendo forze di copertura ai fianchi.
Un altro errore
fatale, anch’esso dovuto alla scarsità di personale impiegato, è stato quello di
far avanzare le colonne corazzate e meccanizzate senza un adeguato numero di
fanteria di supporto. In questo modo i fondamentali Mbt (Main Battle Tank) sono
stati facile preda delle truppe ucraine organizzate in piccoli gruppi di fuoco
(dell’ordine di grandezza plotone o compagnia) utilizzanti tattiche di
guerriglia e impieganti i micidiali Atgm (Anti Tank Guided Weapon) forniti in
buona parte dagli alleati occidentali (Javelin, Nlaw e altri).
A tal proposito,
alle unità russe, organizzate in Btg (Batallion Tactical Group), nei primi mesi
del conflitto è mancata una capacità di Counter-Uas (Unmanned Air System)
leggera che potesse essere efficace contro i piccoli droni di derivazione
commerciale utilizzati dagli ucraini per attività di ricognizione, controllo di
fuoco d’artiglieria e come loitering munitions improvvisate.
Se questi sono stati
i principali errori tattici commessi dai russi, come detto esistono
anche carenze strutturali nell’esercito di Mosca che hanno avuto un pesante
effetto sulle operazioni belliche.
Il punto debole di
Mosca: la logistica
Innanzitutto
la capacità logistica russa ha dimostrato tutta la sua macchinosità e
inefficienza: il sistema di approvvigionamento russo si base su grossi centri di
smistamento collegati alla rete ferroviaria da cui partono camion pesanti che
devono per forza utilizzare una rete stradale efficiente. L’Ucraina, in vasti
settori del fronte, non ha né una rete ferroviaria adatta, né una stradale
diffusa, pertanto i camion si sono a volte trovati in pericolosi “ingorghi” e
anche impossibilitati a raggiungere i centri logistici più avanzati, in quanto
lontani da strade percorribili.
Non va nemmeno
dimenticato che la capacità logistica russa è fortemente menomata
dalla corruzione, che nel Paese è endemica e diffusa a tutti i livelli delle
forze armate: pertanto abbiamo assistito a mezzi che restavano senza benzina,
con le ruote sgonfie, oppure molto più semplicemente fermi per problemi
meccanici.
Lo
stesso organigramma dell’esercito ha influito sull’esito dei combattimenti:
sebbene la Russia, nel 2008, abbia lanciato una riforma delle forze
armate (voluta da Anatoly Serdyukov), essa è rimasta incompiuta e ora l’esercito
russo si trova composto da unità livello battaglione insieme a quelle di livello
divisione, mancando, in numerosi casi, di unità intermedie (le brigate), che
sono fondamentali per il coordinamento sul campo di battaglia. Inoltre, è
rimasto l’impianto gerarchico di stile sovietico, che lascia poco spazio di
manovra ai comandanti sul campo, per cui ogni variazione sui piani di battaglia
originari in base alle nuove informazioni raccolte durante le operazioni viene
attuata con molte ore di ritardo (in alcuni casi sino a 24) per seguire la scala
gerarchica.
Il personale e
l’equipaggiamento
Un altro fattore
limitante e derivante sempre dalla mancata riforma delle forze armate, è la
presenza di una buona fetta di personale di leva nelle unità combattenti (circa
il 30% degli effettivi). Si tratta di soldati ufficialmente non impiegabili in
guerre all’estero secondo la legislazione vigente in Russia, e soprattutto molto
meno addestrati e motivati rispetto ai professionisti.
Sempre dal punto di
vista strutturale, ma determinato da cause contingenti, tra i problemi delle
forze armate russe troviamo la carenza di equipaggiamento da alta tecnologia.
L’embargo a cui è sottoposta la Russia sin dal 2014 ha bloccato la possibilità
di accedere liberamente ai microchip di fabbricazione occidentale che andavano a
equipaggiare i sistemi di navigazione (e altri) dei velivoli o dei missili da
crociera e balistici russi. La produzione locale, come abbiamo visto, non è
ancora in grado di poter rimpiazzare i chip costruiti in Occidente (sia per
mancanza di adeguati finanziamenti, sia per gap tecnologico) e pertanto Mosca ha
dovuto usare con parsimonia il proprio munizionamento di precisione affidandosi
per lo più a quello non guidato a caduta libera. Dal punto di vista
missilistico, proprio per evitare di consumare le scorte di vettori ad alta
precisione e quindi non intaccare la capacità di deterrenza missilistica nei
confronti dell’Alleanza Atlantica, Mosca ha dovuto ricorrere ai sistemi obsoleti
(come il Kh-22 o AS-4 “Kitchen” in codice Nato) oppure non nati per l’attacco al
suolo (i missili del sistema di difesa aerea S-300).
Da ultimo, passando
al settore navale il conflitto ha evidenziato come alcune unità della Flotta
russa (anche non obsolete) siano di fatto inadatte ad ambienti contestati
(nemmeno altamente) come la piccola “bolla” A2/Ad stabilita dagli ucraini
nell’area di Odessa utilizzando sistemi missilistici (Neptun ma più
probabilmente gli Harpoon), Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) come i Bayraktar
TB2 e unità sottili veloci. L’affondamento dell’incrociatore Moskva, la fine di
ogni tentativo di rioccupare l’isola dei Serpenti ma soprattutto lo spostamento
delle operazioni navali più a est col trasferimento degli assetti più preziosi
(i sottomarini classe Kilo) da Sebastopoli a Novorossiysk è lì a dimostrarlo.
PAOLO MAURI
Dalla maskirovka
all’impegno del Wagner: un anno di strategie russe in Ucraina
EMMANUEL
KARAGIANNIS su Inside Over il 23 febbraio 2023.
Dopo un anno di
guerra è possibile valutare la strategia militare della Russia in Ucraina. Il
Cremlino aveva inizialmente messo in pratica l’arte dell’inganno (maskirovka) a
livello strategico, sostenendo che non avrebbe attaccato l’Ucraina, con gli
ufficiali russi che per diversi mesi hanno respinto con fervore i report delle
agenzie di intelligence occidentali che presagivano apertamente un’invasione.
Dal punto di vista operativo, l’invasione è cominciata con un’avanzata delle
truppe motorizzate che hanno attaccato allo stesso tempo da tre direzioni: nord,
est e sud.
L’aeronautica
militare russa ha distrutto infrastrutture chiave (quali centrali elettriche)
per gettare il Paese nel caos. In aggiunta, la flotta del Mar Nero ha bloccato i
porti ucraini per interrompere qualsiasi rifornimento da Paesi terzi. A livello
tattico, le forze speciali russe hanno cercato di creare teste di ponte
impadronendosi di aeroporti e compiendo atti di sabotaggio all’interno delle
città. Di fatto, il Cremlino aveva lanciato una guerra lampo contro l’Ucraina.
Il rischio della
guerra urbana in Ucraina
La forte resistenza
degli ucraini ha colto il Cremlino di sorpresa. Mosca aveva sottovalutato la
dottrina militare ucraina, che prevede la mobilitazione di massa della
popolazione nell’eventualità di un’invasione straniera. La leadership ucraina ha
inizialmente spostato la guerra nei pressi delle aree popolate, dove chi difende
gode di un vantaggio tattico. All’interno dell’ambiente urbano, piccoli gruppi
possono tendere imboscate con facilità e colpire i bersagli avversari con
missili anticarro. La guerriglia urbana è infatti l’incubo di ogni esercito
tradizionale, e dal lato ucraino ci si ricordava benissimo quanto Mosca fosse
ancora perseguitata dalla “sindrome di Grozny”, con la prima guerra in Cecenia
(1994-1996) che si concluse con un’umiliante sconfitta per l’esercito russo,
dopo che piccoli gruppi di combattenti determinati avevano distrutto intere
colonne di carri armati russi entrati nel centro e nelle periferie della
capitale cecena.
Eppure ci si
aspettava che le forze russe sovrastassero le postazioni ucraine in meno di una
settimana. L’esercito marchiato dalla guerra di Putin godeva di superiorità
numerica e tecnologica. In seguito alla guerra in Georgia del 2008, le riforme
militari del Ministro alla Difesa Anatoly Serdyukov cambiarono la struttura
dell’esercito russo. La creazione del gruppo tattico di battaglione (in inglese
BTG) serviva ad aumentare la potenza di fuoco e velocità delle forze armate
russe: ciascun BTG dispone infatti di un battaglione di fanteria motorizzata con
carro armato ed elementi di artiglieria, per un totale di 600-800 ufficiali e
uomini. Tuttavia, lo svantaggio principale dei BTG è il numero relativamente
scarso di truppe di fanteria leggera (attorno ai 200 uomini), che li rende
vulnerabili alle imboscate, e durante i primi tre mesi di questa invasione, i
BTG russi sono diventati un bersaglio facile per i combattenti ucraini.
Il test per
l’esercito russo
Apparentemente, le
forze armate russe non erano preparate ad un’invasione su così larga scala. A
causa di una scarsa pianificazione militare, l’esercito di Putin ha fallito nel
condurre operazioni di armi combinate, il che non avrebbe dovuto destare
stupore: nella guerra contro la Georgia del 2008 la performance dell’esercito
russo, il cui coinvolgimento fu limitato in termini di tempo e spazio, venne
definita dagli esperti come piuttosto carente; sei anni dopo, l’annessione della
Crimea ebbe luogo con operazioni ibride e senza spargimenti di sangue; nella
guerra civile siriana, per supportare il regime di Assad il Cremlino fece
principalmente leva su aeronautica, forze speciali e mercenari. In altre parole,
questa è la prima volta dall’invasione dell’Afghanistan nel 1979 che l’esercito
russo è chiamato a sottomettere un grande Paese con una popolazione ostile.
Andrebbe notato come vi fosse stata un’insurrezione nell’Ucraina occidentale
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che durò dieci anni.
Nella primavera ed
estate 2022, i militari russi hanno utilizzato fuoco di artiglieria indiretto e
missili balistici per sconfiggere gli ucraini. Questa non è stata la prima volta
nel corso della storia recente in cui Mosca ha fatto ricorso a tali tattiche:
durante la seconda guerra cecena (2000-2002) il Cremlino bombardò Grozny a
tappeto, senza alcun riguardo per il diritto internazionale dei conflitti
armati; la leadership russa ha scelto di intraprendere la stessa tipologia di
guerra d’assedio anche in alcune parti dell’Ucraina.
Dopo tre mesi di
assedio, le forze russe sono riuscite ad impadronirsi della città
di Mariupol nella regione di Azov. Tuttavia, gli invasori non sono riusciti
a conquistare Kiev e Kharkiv, le due città più grandi del Paese. Secondo il
Prof. Louis DiMarco, due sono i fattori che potrebbero giocare un ruolo decisivo
nell’attacco ai centri urbani: la dimensione della popolazione e quella del
territorio. Più grandi sono, più forze occorrono per occupare una città. Il
professore americano ha messo in dubbio la regola del 3:1 in favore di chi
attacca e sostiene una proporzione di 6:1 per lanciare un attacco in aree
urbane.
Il ruolo delle forze
mercenarie
Una sorpresa, forse,
è stato l’outsourcing delle operazioni militari russe a mercenari. A partire
dall’estate 2022, un numero sconosciuto di mercenari russi e stranieri è entrato
a far parte regolarmente dell’esercito russo, combattendo quello ucraino nel
Donbass. La parziale “privatizzazione” della guerra è un’innovazione di per sé:
durante il periodo zarista, l’esercito veniva posto sotto stretta sorveglianza,
in quanto gli ufficiali erano gli unici a poter sfidare il regime; in era
sovietica, il ruolo del commissario politico era di esercitare il controllo
politico sulle forze armate con presenza a livello sia strategico che
operazionale. L’utilizzo di forze militari private, come il famigerato Gruppo
Wagner, si contrappone alla cultura militare russa che mette al primo posto il
controllo politico dell’esercito. Tuttavia, la mobilitazione di massa non
sarebbe né opportuna né fattibile in un Paese di ceto medio come la Russia.
L’impiego di mercenari consente a Mosca di nascondere le perdite di guerra
all’opinione pubblica russa che non appoggia del tutto la guerra in Ucraina, ed
il Gruppo Wagner funge da piccolo esercito in grado di fornire supporto
operativo e tecnico al momento del bisogno.
Mappa di Alberto
Bellotto
La guerra è entrata
in una nuova fase dal settembre 2022: la controffensiva ucraina ha avuto
successo nella riconquista di territori nell’est e sud del Paese; ciononostante,
le forze russe sono riuscite a fermare l’offensiva ucraina prima di Natale. Al
momento, sul confine orientale aleggia una fase di stallo e di guerra di
trincea. Il Cremlino ha mobilitato risorse umane e materiali per una nuova
offensiva nel Donbass in primavera, e l’Europa e gli Stati Uniti devono fare
tutto il necessario per fermarla prima che abbia inizio. EMMANUEL KARAGIANNIS
Che cos’è il
Gruppo Wagner.
Lorenzo Vita su Inside Over il 27 Febbraio 2023
Uomini pronti a
tutto, addestrati alla guerra, quasi sempre ex militari dell’esercito russo che,
dietro lauto compenso, offrono i propri servigi al Paese attraverso un’impresa
privata. Sono questi i componenti del Gruppo Wagner. Dalla Siria all’Africa fino
alla prima linea del fronte russo in Ucraina, la compagnia di mercenari ha
assunto negli anni un ruolo di primo piano nelle operazioni occulte e pubbliche
della Russia nel mondo, diventando talmente importante da essere considerato una
sorta di apparato all’interno dello Stato russo. Fino a puntare a un ruolo
politico e sfidare anche le gerarchie delle forze armate di Mosca
La nascita del
Gruppo Wagner
Il Gruppo Wagner
nasce almeno ufficialmente nel 2014 per mano di Dmitriy Valeryevich Utkin, ex
colonnello delle forze speciali russe nato nel 1970 in Ucraina e di Evgheny
Prigozhin, lo “chef di Putin”, nato a San Pietroburgo (allora Leningrado) nel
1961.
Da tempo sotto la
scure delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano, Utkin è un uomo
misterioso, di cui si sa pochissimo. L’unica certezza è che viene considerato da
più parti come un uomo legato a doppio filo con il presidente Vladimir Putin al
punto che Utkin ha anche partecipato al ricevimento offerto dallo stesso capo
del Cremlino ai reduci della guerra in Siria. Il Consiglio dell’Unione
europea lo definiva, nel 2021, come il fondatore della Wagner e “responsabile
del coordinamento e della pianificazione delle operazioni per lo schieramento
dei mercenari del Wagner Group in vari paesi”. Di qui l’accusa sull’essere
artefice di numerose violazioni di diritti umani nei teatri dove è stata
impiegata negli anni la compagnia privata, dalla Siria ai Paesi dell’Africa fino
all’Ucraina.
Ma Putin non è il
solo uomo a cui sarebbe legato l’ex colonnello degli Spetsnaz. Ce n’è un altro,
in particolare, che è considerato il fulcro dell’enorme quantità di denaro e
potere che ha assunto nel tempo il gruppo Wagner, ed è appunto Prigozhin.
L’uomo, uno dei più ricchi di Russia. è a capo di decine di società inserite
nell’ambito del catering e dei ristoranti stellati. Il suo nome è apparso anche
nel filone di indagini del Russiagate. Secondo le accuse dei federali americani,
l’impero di Prigozhin sarebbe stata la base delle interferenze russe nelle
elezioni del 2016 con cui Donald Trump ha battuto Hillary Clinton.
Per molti anni, la
fondazione del gruppo è rimasta un mistero. Non solo la Federazione Russa ha
sempre negato di fatto un coinvolgimento nelle mosse della compagnia di
sicurezza, ma addirittura lo stesso Prigozhin aveva sempre smentito un suo ruolo
nell’origine del gruppo. Le cose sono cambiate con l’invasione dell’Ucraina nel
2022, quando la Wagner, dopo anni di accuse e di indagini, è diventata talmente
centrale nelle logiche operative di Mosca che lo stesso “chef” ne ha compreso il
potenziale politico oltre che militare.
Ecco allora che a
settembre del 2022, il concittadino di Putin svela per la prima volta le carte:
è lui la mente dietro Wagner. E attraverso i suoi canali racconta i dettagli
sulla nascita del gruppo. “Ho pulito io stesso le vecchie armi, ho sistemato io
stesso i giubbotti antiproiettile e ho trovato specialisti che potevano
aiutarmi. Da quel momento, il 1 maggio 2014, è nato un gruppo di patrioti, che
in seguito è stato chiamato il battaglione Wagner”, ha detto Prigozhin. E con
quelle frasi ha confermato quanto prima veniva solo sussurrato in Russia o reso
evidente dalle inchieste giornalistiche. La nascita viene quindi fatta risalire
a una data precisa a quelle operazioni russe in Ucraina orientale durante quella
che poi sarebbe diventata la guerra del Donbass. Un supporto alle unità
filorusse, ma anche una sorta di legione straniera nelle mani di Putin per
evitare di essere considerato “boots on the ground” nel delicato e complesso
fronte europeo.
Il nome del gruppo
Wagner
A creare una vera e
propria mitologia della Wagner non è solo il mistero sulla nascita, ora
certificata dalla dichiarazione di Prigozhin, ma anche quella sull’origine del
nome. Un’inchiesta di Foreign Policy del 2021 spiegava come di questo gruppo non
solo non si potesse accertare davvero nemmeno l’esistenza, ma che sull’origine
del nome, che di certo tutto è meno che russo nonostante l’ideologia
nazionalista nei suoi ranghi, vi fossero solo dei sospetti.
Secondo molti
analisti, Wagner deriverebbe dal nome di battaglia di Utkin ai tempi del Gru.
Non sappiamo però quale motivo abbia scelto il nome del noto compositore tedesco
spesso associato alla visione distorta che ne fece il nazismo. Secondo alcuni
potrebbe trattarsi proprio di un tributo di Utkin a questa vicinanza ideale di
Adolf Hitler con il musica wagneriana, cosa che si unirebbe all’ideologia che
animerebbe proprio l’ex agente di servizi russi, vicina alle teorie neonaziste.
Sul punto va però detto che non esistono conferme ufficiali: lo stesso Prigozhin
non ha fatto riferimento all’uomo del Gru quando ha parlato della fondazione
della Wagner, quasi a escludere un ruolo nella nascita della compagnia di
mercenari.
Dov'è impiegato il
Gruppo Wagner
La storia di Utkin
aiuta in ogni caso a capire il ruolo di questo esercito di contractors che,
negli anni, è diventato uno strumento fondamentale della politica di Putin in
molte crisi in cui non poteva far intervenire le forze armate russe.
Dopo aver
abbandonato le forze speciali, il leader di Wagner ha lavorato per la società di
sicurezza Moran. Quest’impresa è un po’ il nucleo da cui è partita l’idea di
Wagner. Fondata da veterani delle forze armate di Mosca per contrastare la
pirateria, i suoi vertici sono stati poi coinvolti in un’altra operazione: la
nascita dei “Corpi Slavi”. Quest’altra organizzazione, registrata inizialmente a
Hong Kong, ha avuto un ruolo fondamentale in quanto probabilmente primo embrione
dell’esperienza Wagner. Infatti, la società apparve nel 2013 con annunci con cui
si reclutavano uomini per la Siria in supporto delle operazioni del governo di
Damasco.
In quello stesso
periodo inizia a circolare il nome del Gruppo Wagner. Le prime notizie parlano
di un impiego dei contractors in Donbass, a sostegno della causa separatista.
Poi, nel 2015, iniziano ad arrivare le prima informazioni sull’impiego di questo
gruppo in Siria, nodo della politica russa in Medio Oriente. Dal dicembre del
2015, la società inizia a contare i suoi primi morti: i media
riportano l’uccisione di una decina di civili russi a Latakia durante gli
scontri con i gruppi armati ribelli. Civili che in realtà sarebbero appunto
contractors impiegati al fronte ma che ufficialmente non risultano in alcun modo
militari.
I numeri del loro
impiego in Siria sono difficili da reperire attraverso fonti ufficiali. I media
parlano di circa 5mila uomini inviati nel tempo in tutto il territorio siriano.
Molto spesso come gregari delle forze di Assad, diventando in pratica il
contatto fisico fra le forze armate russe e quelle di Damasco. Di loro si parla
come i veri artefici della riconquista di Palmira contro i terroristi dell’Isis.
Altre volte, i loro
impiego è stato quello di una vera e propria polizia militare che ha sostituito
le truppe regolari. Si tornò a parlare di loro in Siria dopo il bombardamento
Usa a Deir Ezzor in cui si ritiene siano morti molti di questi uomini. E i
reporter della Reuters individuarono in particolare a Rostov sul Don uno dei
principali punti di partenza e di arrivo del traffico di contractors.
I contractors in
Africa
Non ci sono però
solo Siria e Donbass al centro delle loro operazioni. Il terreno di caccia più
importante della società di Prigozhin, che ha potuto così sfruttare la sua
compagnia anche per proteggere gli affari del proprio impero economico, è
diventata nel tempo soprattutto l’Africa.
L’operazione più
importante e risalente nel tempo per la Wagner in Africa è stata certamente
quella che in Repubblica centrafricana. Nel 2018, la Russia inviò il primo
contingente di “consiglieri militari” nel Paese per sostenere il governo nella
guerra contro i ribelli. Tra gli obiettivi della missione vi era però anche la
protezione dei beni di Prigozhin, che aveva già investito nel territorio
soprattutto per l’estrazione mineraria.
Il ministero della
Difesa russo non ha mai negato la loro presenza, ne ha solo ridotto il numero o
al limite non confermato mai che fosse impiegato nel dettaglio quella compagnia
privata. A marzo, il portavoce del ministero degli esteri russo Artyom
Kozhin, dichiarò che “su richiesta del presidente della Repubblica
Centrafricana, la Russia ha deciso di fornire al paese aiuti militari gratuiti”,
e tutto con il pieno consenso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
avvertito dell’operato di Mosca. Il ministero della Difesa russo consegnò in
quel caso armi e munizioni alle forze armate della Repubblica centrafricana e
inviò cinque militari e 170 istruttori civili per addestrare i militari locali.
Istruttori civili, ossia contractors, confermati anche dalla portavoce Maria
Zakharova mentre parlava della morte dei tre giornalisti russi uccisi in
Repubblica centrafricana. Un primo elemento che certificò l’utilizzo della
Wagner da parte del Cremlino.
Successivamente, fu
il turno del Sudan, dove anche in questo caso i contractors di Prigozhin
arrivarono parallelamente agli interessi dello “chef” di Putin nel Paese e alle
nuove direttrici della politica estera di Mosca. Come racconta Formiche, “Wagner
ha iniziato a operare in Sudan nel 2017, fornendo addestramento militare a forze
speciali e di intelligence e al gruppo paramilitare noto come Rapid Support
Forces”. Quest’ultime, guidate dal generale Mohammed Hamdan Dagalo, hanno
ottimi rapporti con le monarchie del Golfo e rappresentano la spina dorsale
delle forze di Khartoum post-colpo di Stato. Anche in questo caso, numerose
inchieste hanno mostrato i profondi legami tra Prigozhin, i suoi mercenari, gli
interessi nell’oro e le forze armate locali, al punto che anche l’Unione
europea ha di recente sanzionato una controllata della Wagner che opera in Sudan
dopo che la Cnn ne ha scoperto la rete di interessi.
Particolare
importanza ha poi avuto il ruolo della Wagner in Libia, il grande “buco nero”
del Mediterraneo centrale. Nel 2020, il comando Usa per l’Africa (Africom) ha
pubblicato un report in cui si affermava di avere prove crescenti dell’impiego
della compagnia di contractors in Cirenaica per sostenere gli interessi del
Cremlino. In quell’occasione, Africom segnalò anche il supporto di Mosca alle
operazioni della società di Prigozhin con forniture di mezzi e armi, segno di un
interesse russo per la Libia che aveva in Khalifa Haftar il principale
intermediario in loco. Le Nazioni Unite parlavano di circa un migliaio di uomini
della compagnia utilizzati su diversi fronti della guerra libica.
A conferma del
problema rappresentato dalla Wagner in Libia, il direttore della Cia, William
Burns, è volato a gennaio del 2023 a Tripoli per ribadire l’interesse di
Washington riguardo la presenza russa nel Paese e nell’area nordafricana. Il
vertice con il primo ministro Abdul Hamid Dbeibeh è servito a confermare la
linea Usa sulla road-map per le elezioni e la pacificazione: ma il fatto che ad
andare nella capitale sia stato il direttore dell’agenzia di intelligence
sottolinea che la preoccupazione principale riguarda la sicurezza dell’area e le
possibili infiltrazioni di avversari degli Stati Uniti.
Più di recente, è
il Mali a essere al centro dell’interesse russo in Africa, in particolare in
Sahel, e quindi anche della Wagner. Da quando il governo locale ha preteso che
le truppe francesi si ritirassero dal Paese, a sostituire le unità di Parigi
sono stati proprio i mercenari russi. Gli uomini dello “chef” sono già sotto la
lente delle Nazioni Unite e degli Stati occidentali, preoccupati
dall’instabilità della regione africana ma anche dalle accuse di crimini
commessi dai combattenti al soldo di Prigozhin. E con un cambiamento per certi
versi radicale della politica di Mosca, è stato lo stesso ministro degli Esteri,
Sergei Lavrov, a confermare la presenza di quelle forze irregolari dicendo che
le autorità di transizione del Mali si erano “rivolti ad una società militare
privata russa perché la Francia vuole ridurre significativamente il suo
contingente militare schierato nel paese”.
La Wagner in
Ucraina
Con l’invasione di
febbraio 2022, il ruolo della Wagner è cambiato in modo sostanziale,
rivoluzionando non solo la sua percezione pubblica, ma anche il ruolo politico
di Prigozhin e il rapporto con le forze armate.
Dall’inizio
dell’invasione, i mercenari del gruppo si sono sempre più palesati nelle
maggiori battaglie del fronte dell’Ucraina orientale, con il loro impiego in
diverse battaglie del Donbass tra cui spiccano quelle di Popasna, Svitlodarsk,
Sievierodonetsk e Lysychansk e più di recente nei “tritacarne” di Bakhmut
e Soledar (dove Prigozhin ha voluto a ogni costo conquistare l’enorme miniera di
sale). Insieme al loro utilizzo al fronte sono cresciute le accuse di crimine di
guerra commessi dagli uomini di Prigozhin. Molti hanno accusato la compagnia
Wagner di avere avuto un ruolo fondamentale nei fatti di Bucha, mentre nello
stesso tempo sono aumentati i video che mostravano esecuzioni da parte dei
combattenti. Una di queste, la più nota, è quella dell’ex combattente Evgenij
Nužin, giustiziato a colpi di mazza sulla testa per avere tradito la compagnia e
avere scelto di vivere in Ucraina.
Nel frattempo, i
numeri degli uomini usati dalla Wagner in Ucraina sono aumentati non solo
attraverso il reclutamento di uomini di altri Paesi, ma soprattutto attraverso
la concessione della libertà a tutti i detenuti delle carceri russe che
sceglievano di arruolarsi nel gruppo di Prigozhin. L’amnistia in cambio di sei
mesi di guerra al fronte è stata una delle armi più importanti nelle mani della
compagnia privata per ingrossare le file dilaniate dalle varie battaglie.
Reclute che in ogni caso non hanno rappresentato un vero rinforzo, dal momento
che la maggior parte di essi è totalmente priva di addestramento e
fondamentalmente inadatta a essere irregimentata in una compagnia strutturata in
larga parte attraverso i modelli delle forze armate russe. A conferma di questo,
secondo gli Stati Uniti soltanto nella battaglia di Bakhmut sarebbero morti
circa mille contractors di cui la maggior parte ex detenuti. Sulla stessa linea
l’intelligence britannica.
L’impiego così
massiccio – e a volte essenziale – della Wagner in Ucraina orientale ha però
reso possibile a Prigozhin non solo uscire allo scoperto, ma anche aumentare le
sue richieste nei confronti di Mosca. Putin, che per anni ha sfruttato i servizi
della compagnia di sicurezza senza rendere mai pubblico questo impiego, si è
trovato quindi a gestire una situazione inusuale, e cioè la presenza di un uomo
ricco, potente, fondamentale nelle “operazione militare speciale” ma sempre più
percepito come una minaccia dalla stessa Difesa russa. Le offese rilanciate
attraverso i canali Telegram della Wagner contro il ministro Sergei Shoigu e il
capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov sono state seguite anche dalle accuse
di incapacità verso i ranghi dell’esercito e di tradimento per negare le
munizioni ai contractors lasciandoli morire al fronte.
Questa guerra
intestina ha spesso provocato imbarazzo al Cremlino ma anche una certa
preoccupazione, dal momento che molti sottolineano che il potere mediatico e
militare ottenuto dallo “chef” di Putin durante il primo anno di invasione ha
fato ipotizzare un suo possibile ruolo politico di primo piano. Qualcuno ha
anche sostenuto che il capo della Wagner potesse tentare la scalata a Mosca
sfruttando l’eventuale crollo del sistema putiniano. LORENZO VITA
Un anno di guerra
in Ucraina: ecco cosa non abbiamo capito.
ALDO GIANNULI su
Inside Over il 23 febbraio 2023.
Siamo al primo
anniversario della guerra in Ucraina, e sembra che l’opinione pubblica (tanto
occidentale quanto dell’est) dia segni assuefazione, ma ancora non pare che
abbia capito l’importanza del fatto. È strano, veniamo da un trentennio nel
quale si è fatto abbondante uso ed abuso del termine “epocale”, speso anche per
cose di rilievo modesto, ed ora, che ci troviamo davvero a una svolta che
cambierà il mondo, l’aggettivo è scomparso dai media.
Ci limitiamo ad
aspettare che la guerra si concluda per riprendere a fare quello che facevamo
prima. Ad esempio, i tedeschi sperano di riprendere a fare affari con la
Russia, i russi pensano che quello che conta è la quantità di terreno strappato
all’Ucraina e gli ucraini pensano che dopo sarà inevitabile il loro ingresso
nella Nato. La Nato pensa che sarà restaurata la gerarchia mondiale con in testa
gli Usa, che a loro volta pensano che la globalizzazione a trazione americana
riprenderà.
Ma
la globalizzazione ci sarà ancora? Sì, ma come? È poco probabile che avrà le
stesse modalità di prima. E dell’Onu che ce ne facciamo? Può continuare così o,
dopo la guerra, saremo costretti a prendere atto che, così come è, possiamo
anche farne a meno? O proveremo a rifondarla? E della crisi finanziaria (sempre
in agguato), che ne sarà? Pandemia e guerra, paradossalmente, l’hanno
procrastinata, grazie alla alluvione di liquidità che esse hanno comportato ma
che non può durare all’infinito e sarà seguita da una perturbazione senza
precedenti. E il dollaro sarà sempre moneta mondiale?
Potremmo proseguire
con gli intrecci di queste dinamiche con il mutamento climatico, con le
alterazioni demografiche, ecc. A ogni svolta dobbiamo aspettarci che si
accendano nuovi conflitti anche armati. Alla guerra seguirà un dopoguerra non
meno conflittuale ed anzi più drammatico.
Verso il crollo
dell’ordine mondiale
Quello che dobbiamo
capire e a cui dobbiamo prepararci è che questa guerra sta facendo crollare
l’Ordine Mondiale che c’era (ed era giù in crisi almeno dal 2008) ma non ne
produrrà un altro, che verrà dopo un lungo periodo di crisi e scontri
sanguinosi. Il primo bacino che esploderà è già pronto: l’Africa, dove si
profila un conflitto generalizzato a livello continentale, con dietro, la Cina,
gli Usa, la Francia, forse India e Giappone, quanto alla Russia dipende da come
uscirà dalla guerra.
Altrettanto
ragionevole è attendersi una nuova rivoluzione di intelligence; tanto i russi
quanto gli americani in questa guerra hanno fallito completamente per la
raccolta informativa e l’analisi facendo previsioni totalmente sbagliate. E
sappiamo per esperienza che ogni mutamento nel mondo dell’intelligence comporta
le sue sperimentazioni che raramente sono indolori per gli altri. Per esempio,
mettiamo nel conto la probabilità di una forte destabilizzazione monetaria.
Tutte cose non
inevitabili se si avrà la saggezza di pensare a un nuovo ordine più cooperativo
e un po’ meno competitivo, con camere di compensazione, organismi
internazionali di mediazione più efficaci di quelli esistenti. Ma a tutto questo
si oppone una visione basata sul primato imperiale nel quale contano
solo gli equilibri di forza e la capacità di un soggetto di imporre la sua
volontà agli altri. Non che si possa sognare un ordine mondiale non competitivo
e nel quale non contino gli equilibri di forza, questo ci sarà sempre. Il
problema è che questa situazione considera esclusivi questi elementi e cancella
ogni possibile mediazione e cooperazione. Decisamente, dopo la guerra, verrà
il dopoguerra. Che sarà peggiore. ALDO GIANNULI
Sabotaggi dietro
le linee nemiche. Così Kiev colpisce la Russia.
LORENZO VITA su Inside Over il 23 febbraio 2023.
La guerra in
Ucraina, oltre a combattersi sulla prima linea del fronte, si combatte anche
dietro le linee nemiche. Questo vale in particolare per Kiev, che dall’inizio
dell’invasione ha progressivamente aumentato la propria capacità di penetrare in
territorio russo e nei territori occupati da Mosca per colpire in profondità gli
avversari.
Questa capacità
delle forze ucraine è andata generalmente aumentando con l’avanzare del
conflitto e quindi con il miglioramento della capacità di reazione da parte di
Kiev. Lo dimostrano il miglioramento delle capacità tecnologiche, la letalità
degli attacchi, ma anche l’aumento dell’importanza degli obiettivi russi così
come la loro lontananza dal fronte. Un complesso meccanismo di attacchi e
sabotaggi che si è sempre più spostato dal campo di battaglia per riuscire a
infliggere colpi all’interno del territorio russo e in grado non solo di
incidere sull’esercito, ma anche a scalfire quella sicurezza manifestata da
Mosca sin dall’inizio dell’invasione.
Scalfire la
sicurezza di Mosca
L’idea di Vladimir
Putin, dall’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale”, è stata
infatti sempre quella di mantenere la Federazione Russa in una sorta di bolla
protettiva. Il conflitto doveva rimanere circoscritto all’Ucraina, mentre il
Paese dello “zar” doveva rimanere sostanzialmente inattaccabile, dando così
l’immagine di una fortezza in grado di proteggere la popolazione durante tutta
la guerra.
La conferma di
questo processo di ampliamento della capacità di attacco in profondità da parte
di Kiev è data quindi non soltanto dall’evidente ampliamento della portata delle
armi date all’esercito ucraino, ma anche dalla scelta dei “target” prescelti
dall’intelligence ucraina (con l’ausilio o meno della Nato e in particolare di
Regno Unito e Stati Uniti).
La Crimea sotto tiro
I primi esempi di
questa nuova campagna ucraina si sono osservati in estate con le esplosioni
in Crimea. Le colonne di fumo apparse nel sito militare di Novofedorovka hanno
evidenziato, come poi confermato dal ministero della Difesa russo, le esplosioni
di un “deposito di munizioni”. Per Kiev e per l’intelligence britannica si
trattava di aerei, e non di semplici depositi. A essere stati distrutti,
infatti, sarebbero stati Su-24MR, tre Su-30SM e probabilmente almeno un Il-76.
Per molti analisti, l’attacco era probabilmente dovuto a un sabotaggio di forze
speciali ucraine dietro le linee russe, dal momento che non sembrava verosimile
un bombardamento aereo o con armi che ancora non facevano parte degli arsenali
ucraini. Ma in tanti hanno ipotizzato l’utilizzo di droni in grado di perforare
le difese aeree russe.
Successivamente,
altre misteriosi esplosioni (misteriose perché mai rivendicate né definite nelle
modalità) hanno coinvolto un deposito di armi a Maiske, a nord della Crimea, e
si è parlato anche di un sabotaggio nella base di Hvardiiske, non lontano da
Sinferopoli. Su tutti questi casi, Kiev non ha mai dato una risposta alle
domande su un possibile coinvolgimento di forze speciali o sabotatori, ma molte
fonti anonime hanno riferito anche ai più importanti media americani che si
trattava di azioni messe in atto dalle unità ucraine o di “partigiani“. E in
quello stesso periodo, anche Sebastopoli, la grande base della Flotta del Mar
Nero, è stata presa di mira diventando il bersaglio di quella che tutti si
attendono come possibile grande controffensiva ucraina nella penisola.
Un altro esempio è
stato l’incendio del ponte di Kerch, simbolo dell’annessione della Crimea alla
Russia e dell’unione definitiva della penisola del Mar Nero alla nuova
madrepatria. All’alba dell’8 ottobre 2022, un’esplosione ha causato il crollo di
due campate del ponte uccidendo quattro persone e andando a colpire
un’infrastruttura fondamentale per il rifornimento della Crimea. L’episodio,
avvenuto il giorno del 70esimo compleanno di Putin, non è stato rivendicato
ufficialmente dall’Ucraina. La stessa Russia, specialmente all’inizio, aveva
parlato di incidente e non di sabotaggio. Kiev ha tuttavia dato immediata
visibilità all’esplosione esultando per quanto accaduto. Infine, le inchieste di
diversi giornali hanno parlato in maniera sempre più netta di un camion bomba
(il New York Times ha poi riferito della regia dei servizi segreti ucraini),
mentre Mosca ha poi annunciato l’arresto di alcune persone, tra cui cittadini
ucraini, come artefici del sabotaggio.
La campagna segreta
A novembre, invece,
diverse fonti parlavano di un attacco condotto da alcuni sabotatori ucraini
presso la base aerea di Veretye, nella regione occidentale russa di Pskov. In
base alle informazioni dei media, l’attacco avrebbe messo fuori uso almeno due
elicotteri da combattimento KA52 Alligator. In quell’occasione, Kiev non
rivendicò ufficialmente l’attacco, anche se i media ucraini riportarono le
dichiarazioni della Direzione dell’intelligence della Difesa che sostanzialmente
certificavano l’avvenuto sabotaggio.
A dicembre, altre
esplosioni, questa volta all’interno dei confini russi riconosciuti dalla
comunità internazionale. In pochi giorni, a essere colpiti sono stati gli
aeroporti militari di Dyagilevo, nella regione di Ryazan e quello di Engels,
nella regione di Saratov. Circa una settimana dopo quegli attacchi, era stato
segnalato poi un ulteriore attacco, questa volta nel distretto di Kursk, tramite
un drone. E alcune fonti ucraine avevano parlato di un raid, sempre con un
velivolo senza pilota, contro un sito industriale nell’oblast di Bryansk. Sempre
al New York Times, un funzionario ucraino aveva detto che “almeno uno dei due
attacchi – quelli di Dyagilevo e Engels ndr – è stato completato con l’ausilio
di forze speciali che si trovavano in prossimità dell’aerodromo e che hanno
guidato i droni verso il bersaglio”.
Un’informazione che
aveva confermato non solo la capacità ucraina di manovrare i droni centinaia di
chilometri dentro il territorio russo, ma anche, se non soprattutto, di sapere
muovere le proprie unità speciali nel cuore della Federazione. Tre settimane
dopo, sempre la base di Engels era stata oggetto di un attacco con un drone in
cui rimasero uccisi tre soldati russi. E sempre in quel periodo, come
scriveva Adnkronos, i servizi di sicurezza russi dello Fsb hanno annunciato di
avere “liquidato” un “gruppo di sabotatori” che il 25 dicembre cercavano di
entrare nella regione di Bryansk.
Dopo questa lunga
scia di esplosioni, a intervenire è stato poi Vadym Skibitsky, vice capo
dell’intelligence militare ucraina, che ha di fatto ribadito la regia di Kiev
sulle esplosioni e rilanciato sul piano di colpire in profondità la Russia. “Se
possiamo raggiungere Engels, possiamo raggiungere anche il Cremlino“, ha detto
Skibitsky, sottolineando come sia lecito pensare di colpire i campi
d’addestramento e le basi in territorio russo poiché “presto o tardi, da queste
caserme, andranno al fronte ad attaccare i nostri villaggi e le nostre città”.
Un avvertimento che
serve soprattutto da un punto di vista politico: colpire la Russia significa
scalfire quel senso di inattaccabilità con cui Putin ha voluto colpire l’intero
Paese. Sentirsi vulnerabili è un problema enorme per il presidente russo, il
quale però potrebbe anche essere rafforzato dalla possibilità che Kiev decida di
colpire in modo più netto sul territorio dell’avversario. Certificare il senso
d’assedio accusando l’Ucraina di volere colpire la Russia è un elemento tipico
della narrazione putiniana, specialmente ora che vuole far vedere all’opinione
pubblica di essere ancora saldamente alla guida del Cremlino. LORENZO VITA
“Dai russi una
manovra a tenaglia”. Ma è ancora un mistero su dove arriverà Putin.
FAUSTO
BILOSLAVO su Inside Over il 23 febbraio 2023.
Buongiorno, Fausto.
Dove ti trovi?
Sono nel Donbass, in
zona di guerra, a pochi chilometri dal fronte, proprio nell’area di Luhansk dove
le truppe russe stanno attaccando.
Proprio questa notte
è iniziata l’operazione militare della Russia. Abbiamo visto code di civili che
da Kiev stanno lasciando il Paese. I russi dicono che i bombardamenti sono
mirati e che hanno colpito solamente basi militari e luoghi strategici. E’
davvero così?
Quello che posso
mostrarvi è la lunga coda di automobili in attesa di fare benzina. Danno solo 20
litri di benzina. Anche questi ucraini vogliono scappare dal Donbass e dalle
zone di guerra. Il problema è anche il carburante.
Ti trovi molto
vicino alla linea del fronte…
Siamo a una decina
di chilometri dal fronte e, fino a poco fa, si sentiva sia l’artiglieria da
destra e da sinistra. Suppongo fosse l’artiglieria ucraina che cercava di
fermare l’avanzata russa. Credo però che sarà una missione impossibile, anche
perché dalle informazioni che ho i russi stanno cercando di avanzare a tenaglia
e, probabilmente, non si fermeranno al Donbass. Carri armati russi sono stati
avvistati alle porte di Karkiv, a tre ore di macchina da qui, e che è la più
grande città ucraina nel nord est del Paese, a 39 chilometri dal confine con la
Russia, un milione e 400mila abitanti. Anche lì temo stia scoppiando il panico.
Gli ucraini temono
operazioni su larga scala oppure credono che Putin a un certo punto si fermerà?
Sono tutti sorpresi
da questo attacco che sembra essere su larga scala. Si pensava al Donbass, al
porto strategico di Mariupol, sul fronte sud del Donbass, il porto sul mare
d’Azov che è strategico per gli ucraini. Sono scattati anche i primi
bombardamenti su Mariupol sulle batterie anti missilistiche e anti aerei. Non si
capisce se c’è una colonna russa che sta scendendo dalla Bielorussia verso Kiev.
L’unica certezza è che già lunedì, quando Putin aveva riconosciuto le
repubbliche separatiste, le unità di artiglieria dell’esercito ucraino avevano
ricevuto l’ordine di muovere a nord di Kiev, più o meno nella zona di Chernobyl,
proprio perché temevano un attacco russo anche da quella direttrice.
L’importante ora è capire, soprattutto dove mi trovo in questo momento, quale
sarà la manovra a tenaglia delle forze corazzate russe. Questa notte, proprio a
fianco del nostro albergo, sentivo i carri armati ucraini che venivano
trasportati in prima linea durante tutta la notte. Evidentemente, gli ucraini
avevano informazioni di intelligence e hanno cercato di fare una barriera
attorno a questa città. Anche gli operatori dell’Osce, che ho incontrato poco
fa, temevano anche loro di rimanere tagliati fuori dalla manovra a tenaglia
russa. FAUSTO BILOSLAVO
La guerra in
Ucraina e la nuova logica dei blocchi.
Emanuel Pietrobon
il 25 Febbraio 2023 su Inside Over.
Guerre, disastri e
pandemie: acceleratori di tendenze. Non creano e neanche distruggono
nulla: provocano catalisi, accompagnano nella fossa ciò che era morente, fanno
germogliare ciò che era quiescente. Sprigionano forze sino all’istante
precedente della loro comparsa trattenute dai katéchon dell’epoca.
Il terzo decennio
del XXI secolo è profeticamente iniziato con una pandemia e una guerra, due
degli eschaton più potenti e trasfiguranti, con la seconda che ha amplificato
l’impatto globale della prima, la quale, a sua volta, aveva accelerato dei
fenomeni in moto da tempo. Riglobalizzazione. Redistribuzione e dispersione del
potere mondiale. Ricompartimentazione del sistema internazionale in blocchi.
La guerra in Ucraina
e la pandemia di COVID19, in estrema sintesi, hanno liberato quelle forze
rivoluzionarie e destabilizzanti, a lungo e duramente trattenute sotto la soglia
della pericolosità dai katéchon dalla superpotenza solitaria, gli Stati
Uniti, che invocano il superamento del Momento unipolare e, dunque, la fine
della bellicosa Pax americana. E la ristrutturazione della geografia di poli e
poteri a livello internazionale comporterà inevitabilmente il ritorno all’età
dei blocchi.
Il mondo in blocchi,
di nuovo
Il sistema
internazionale si trova in una situazione che mescola elementi del
dopo-Bismarck, cioè il collasso progressivo delle architetture multilaterali e
concertative, e del dopo-Hitler, ovvero la trasformazione di una guerra mondiale
in frammenti in una guerra mondiale fredda. È una situazione che rende il
presente molto simile, ma non interamente uguale, al passato.
Oggi è un insieme di
ieri accaduti tra il 1884 e il 1939, un déjà-vu. L’amicizia senza confini
sino-russa in chiave antiamericana è l’attualizzazione eterodossa dell’Intesa
amichevole franco-britannica in funzione antitedesca. L’AUKUS e i vari patti tra
la sorelle dell’anglosfera sono gli equivalenti contemporanei del Grande
riavvicinamento. Il Sogno cinese di Xi Jinping è il remake giallo
della Weltpolitik di Guglielmo II. La Russia è l’insofferente erede di un vinto
umiliato da una sconfitta totale, della quale vorrebbe riscrivere una parte dei
termini, che a tratti ricorda il revisionismo dell’asse Roma-Berlino.
Oggi è un insieme di
ieri accaduti tra il 1946 e il 1954, durante l’ottennato di transizione che ha
traghettato il mondo verso la Guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
Guerre per procura, colpi di stato e insorgenze a spianare la strada al grande
scontro egemonico. Patti, alleanze, progetti di integrazione economica e
infrastrutturale, conferenze internazionali a preludiare alla partizione del
mondo in tre sottomondi, popolarmente noti come blocchi.
Le funzioni dei
blocchi
Blocchi. Le guerre
interstatali non avrebbero modo di investire l’intero sistema internazionale se
non esistessero dei blocchi, cioè delle alleanze di mutuo soccorso e dei
sistemi-mondo strutturati, traversanti i continenti e le ideologie.
La funzione dei
blocchi, in ogni epoca, è sempre la stessa: essere scudo e lancia dell’egemone
che li comanda. Essi sono stati la ragione, ma non l’origine, delle tre guerre
mondiali del Novecento – due calde e una fredda.
Oggi, su impulso
della pandemia di COVID19 e della guerra in Ucraina, la litosfera sta nuovamente
sperimentando una frammentazione in placche. I due eschaton hanno aggravato
straordinariamente la competizione tra grandi potenze, come emblematizzato
dall’accelerazione di fenomeni pre-esistenti come il friend-shoring e il
disaccoppiamento sinoamericano, dando una spinta determinante alla regressione
globale all’epoca dei blocchi. Che sono tre, per la precisione, ovvero il
redivivo Occidente, il rinato Movimento dei non allineati e l’emergente
coalizione antiegemonica sino-russo-iraniana.
Occidente, un
gigante dai piedi d’argilla
Gli Stati Uniti
possono vantare il controllo su di un blocco omogeneo, l’Occidente, che si
caratterizza per l’alto grado di coesione politica, le familiarità culturali, lo
sviluppo economico, la superiorità tecnologica e una sistematizzazione militare
senza pari nel mondo – dalla NATO agli accordi bilaterali di mutua difesa e
cooperazione militare.
L’Occidente è un
blocco multilivello, transcontinentale, baricentrato tra America settentrionale
ed Europa occidentale, ma esteso fino a Tokyo e Buenos Aires, la cui unità
interna è garantita e consolidata dalla condivisione di catene del valore, mode,
tendenze, cultura pop, social network, nonché dalla presenza di suballeanze di
natura variegata. L’Occidente è un blocco politico, militare, economico, ma è
anche una forma mentis, uno stile di vita. Identità e consumo.
All’apparenza
impenetrabile, perché fondato su valori non negoziabili, l’Occidente è un blocco
afflitto da limiti e debolezze, che il blocco sino-russo in divenire ha
aggredito a cadenza crescente a partire dagli anni Dieci, la cui coesione
politica è superficiale. Inimicizie e rivalità ne minacciano l’integrità, in
primis la guerra sotterranea tra Washington e Berlino, e attori autocentrati,
come Budapest e Ankara, si prestano, quando nel loro interesse, al gioco
dell’asse Mosca-Pechino.
Riunione del G7 il
16 novembre 2022. (Foto: ANSA/Filippo Attili – Uff stampa Palazzo Chig)
Il blocco che non
vuole esserlo
Il cosmo del
Movimento dei non allineati, oggi come ieri, sarà il principale campo di
battaglia dei due blocchi, che proveranno a corteggiare, a destabilizzare, o a
satellizzare, periferie, paesi geostrategici e mercati-chiave per il destino
della nuova guerra fredda.
Il blocco dei
neutrali ha storicamente rivestito la funzione di mercato acquisti dei blocchi
in guerra. Ché il non allineato altro non è, in molti casi, che un allineato
nell’attesa della giusta offerta. Fu strappando alle grinfie del non
allineamento socialisteggiante paesi come l’Indonesia che gli Stati Uniti
poterono vincere la competizione con l’Unione Sovietica.
La multivettorialità delle piccole e medie potenze del Sud globale alla ricerca
di maggiore autonomia dai vecchi padroni può essere considerata il non
allineamento 2.0. Arabia Saudita, Azerbaigian, Egitto, India, Kazakistan,
Serbia; lunga è la lista dei giocatori che provano a dribblare il dilemma
dell’allineamento scegliendo di non scegliere: dialogo con tutti, alleanza con
nessuno.
Alcuni soccomberanno
alle pressioni degli scomodi vicini, taluni percorreranno la rischiosa via
dell’allineamento con sponsor remoti e altri ancora potrebbero tentare la strada
innovativa di un nuovo blocco, autocentrato e identitario, a fare da contraltare
ai tre dominanti – da non sottovalutare il potenziale del panturchismo,
simbolizzato dal Consiglio Turco, del latinoamericanismo e di panarabismi in
miniatura.
Il grande ritorno
del Movimento dei non allineati
L’erede del Secondo
mondo
Russia, Repubblica
Popolare Cinese e Iran, i tre principali sfidanti degli Stati Uniti (e del loro
blocco), non hanno nulla di simile all’Occidente. Hanno delle sfere di
influenza, punti di partenza per la costruzione di blocchi, e dei progetti di
integrazione e coordinamento aperti quando al loro estero vicino e quando ad
altre forze interessate al superamento del Momento unipolare a guida
occidentale.
L’epigono eterodosso
del Secondo mondo è rappresentato dall’insieme dei satelliti e degli organismi
dell’asse Mosca-Pechino, cui potrebbe aggiungersi la propaggine iraniana. A
differenza del Secondo mondo di guerrafreddesca memoria, però, trattasi di un
blocco a doppia regia, internamente disunito, scarsamente vertebrato,
culturalmente diviso e privo di un cianoacrilato identitario.
Il presidente cinese
Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin durante un vertice diplomatico
del 15 September 2022. (Foto: EPA/ALEXANDR DEMYANCHUK/SPUTNIK/KREMLIN)
L’esacerbazione
della competizione tra grandi potenze e il rafforzamento del contenimento
duale hanno facilitato la caduta di diffidenze di fondo e ostilità ancestrali
tra Russia e Cina, spronandole ad amalgamare Unione Economica Eurasiatica e Belt
and Road Initiative, a rivitalizzare e ad espandere il formato BRICS – forse
destinato a diventare l’antitesi del G7 –, a dare manforte all’Iran – aspirante
aiuto regista a lungo bistrattato, rivelatosi leale, però, al momento del
bisogno – e ad investire maggiormente nell’internazionalizzazione della loro
causa in comune: la riforma strutturale del sistema internazionale.
La guerra fredda 2.0
e i destini del mondo
Conservatorismo
sociale – lotta all’universalismo occidentale –, antiamericanismo –
dedollarizzazione –, e revisionismo politico – ricerca della transizione
multipolare – sono i motivi conduttori del germogliante e confuso Blocco
sino-russo-iraniano, che la crescente assertività del sempreverde Primo mondo
sta incoraggiando a farsi reincarnazione pantocratrice del defunto Secondo
mondo.
L’incubo della
geopolitica anglosassone di una grande alleanza tra le potenze egemoni
dell’Eurasia in funzione anti-atlantista sta lentamente facendosi realtà.
L’antiamericanismo è il collante che ha unito le differenze di Mosca, Pechino e
Teheran, e che un giorno potrebbe essere il casus foederis di un blocco formale,
antagonistico all’Occidente, volente e in grado di combattere come un tutt’uno
indistinto la battaglia per la transizione multipolare.
Potrebbe mancare un
minuto alla mezzanotte. L’Iran ha contezza del profondo significato
degli accordi di Abramo, sorti sulle ceneri dell’abortita NATO araba. L’AUKUS,
la radicalizzazione della questione taiwanese e il progressivo spostamento a
Oriente del focus geostrategico dell’Alleanza Atlantica stanno incoraggiando
Pechino a premere l’acceleratore sull’evasione dalla catena di isole. La Russia
ha detto definitivamente addio alla stagione dei compromessi a perdere invadendo
l’Ucraina.
Potrebbe mancare un
minuto alla mezzanotte. La mezzanotte del ritorno ufficiale all’età dei blocchi
formali e formalmente contrapposti, in guerra mondiale fredda, iniziata nel 1955
con la conferenza di Bandung e con la nascita del Patto di Varsavia. Nell’attesa
del rintocco, che il Primo mondo proverà a ritardare e/o ad impedire, nel mondo
è ancora il 1954. EMANUEL PIETROBON
La guerra in
Ucraina: rischi e opportunità per la Cina.
Federico Giuliani il
25 Febbraio 2023 su Inside Over.
Nell’”amicizia senza
limiti” siglata da Vladimir Putin e Xi Jinping ci sono numerose zone d’ombra che
devono essere chiarite per capire il reale peso della partnership sino-russa.
Innanzitutto, a differenza di quanto non si possa pensare, quella
tra Russia e Cina non è affatto un’alleanza né intende in alcun modo
avvicinarvisi.
La prova più
evidente sta nel fatto che la Cina ha scelto di non seguire la Russia
nella guerra in Ucraina. Non solo: a Pechino più di un alto funzionario è
rimasto sorpreso, se non in certi casi contrariato, per la piega presa dagli
eventi sul fronte, per le minacce nucleari, per la distruzione totale di un
Paese, l’Ucraina appunto, che nei piani cinesi avrebbe dovuto far parte della
Belt and Road Initiative (BRI). Ma anche per tutte le conseguenze indirette
dell’escalation ancora in atto, in primis una maggiore assertività
della Nato nell’Indo-Pacifico.
Certo, al governo
cinese non può che far piacere osservare da lontano, a debita distanza di
sicurezza, il rivale statunitense impantanato nel nodo ucraino e impegnato a
rifornire di armamenti Volodymyr Zelensky. Anche perché, banalmente, più armi e
attenzioni americane sono dirette verso l’Europa orientale e meno spazio di
manovra ha Washington per ragionare sull’Asia.
Allo stesso tempo,
tuttavia, l’aggressività di Putin rischia di creare una spaccatura insanabile
tra il blocco occidentale e quello formato da Mosca e dai governi non allineati
o in posizione ambigua. La Cina, a differenza della Russia, non ha infatti
intenzione di ritrovarsi chiusa in un angolo, demonizzata o peggio esclusa dal
commercio globale.
Dal canto suo, Xi ha
più volte auspicato la risoluzione del conflitto mediante colloqui di pace ma
non è mai davvero sceso in campo per impedire al Cremlino di continuare a
sferrare offensive contro Kiev. Il perché è semplice: Pechino non controlla in
nessun modo le azioni di Putin. È vero che la partnership sino-russa pende
nettamente in favore della Cina ma, a quanto pare, la Russia gode di ampissima
autonomia. Giusto per capirsi, il capo del Cremlino non avrebbe neppure
avvertito il suo omologo cinese dell’intenzione di lanciare una simile
“operazione militare speciale” in Ucraina, lasciando perplessa la leadership del
Partito Comunista Cinese.
Una posizione
difficile
È sempre più
difficile per Xi rapportare costi e benefici della guerra in Ucraina. Toppe le
variabili impazzite sul tavolo: su tutte l’imprevedibilità di Putin, che non
sembrerebbe intenzionato a mollare la presa nel suo ormai personalissimo testa a
testa con il blocco occidentale.
E pensare che in un
primo momento, prima del 24 febbraio 2022, la Cina non poteva che nutrire aperto
interesse nei confronti di un leader che stava picconando a suo modo il potere
degli Stati Uniti e, al tempo stesso, mettendo a dura prova le alleanze
statunitensi in Europa, il tutto quasi senza alcun costo per Pechino. Nella
migliore delle ipotesi, intervenendo sull’Ucraina, Putin avrebbe forse persino
spianato la strada a Xi per raggiungere il suo principale obiettivo in politica
estera: riannettere Taiwan alla Cina continentale.
Quando il presunto
piano di Putin per far cadere il governo di Zelensky è fallito – e
probabilmente, come detto, la Cina lo ha scoperto in differita come il resto del
mondo – è apparso evidente che la missione russa in terra ucraina si sarebbe
trasformata in una guerra di logoramento.
Da quel momento in
poi per Pechino sono iniziati i dolori. Come giustificare il fatto che l'”amico
senza limiti” di Xi metta a ferro e fuoco un Paese indipendente, per altro
contraddicendo il solido principio cinese di non interferenza negli affari degli
altri governi? Come ignorare gli ingenti danni causati dalle bombe russe ai
costosissimi investimenti cinesi in Ucraina? Come lasciar perdere lo choc
energetico innescato dal conflitto, con l’aumento del costo di elettricità e
petrolio in Europa, con ricadute nel business globale, ovvero la piscina
prediletta del Dragone cinese?
Anche potendo
rispondere a tali domande, la Cina non può rimproverare apertamente Putin, pena
il prestare il fianco alla narrazione statunitense e rischiare di perdere un
amico che, tutto sommato, fa ancora comodo alla causa cinese.
Finora, Pechino ha
insistito sul fatto che la sua amicizia con Mosca è “solida come una roccia”, ma
la sensazione è che Xi aiuterà il Cremlino finché ciò non comprometterà l’agenda
cinese. È quindi probabile che il matrimonio tra Xi e Putin rimanga
un matrimonio di convenienza.
Indipendentemente
dall’esito della guerra in Ucraina, la coppia potrà ancora causare molti
problemi agli Stati Uniti e ai suoi alleati, ma potrebbe avere grandi difficoltà
a raggiungere una vera alleanza (per intendersi, come quella che Washington ha
con il Giappone o la Gran Bretagna).
Intanto, ad un anno
esatto dallo scoppio della guerra, la Cina ha presentato una proposta formata
da 12 punti per porre fine al conflitto. Il documento è stato pubblicato sul
sito del ministero degli Esteri ed è, di fatto, una sintesi approfondita degli
appelli fin qui lanciati da Pechino. “Il conflitto e la guerra non giovano a
nessuno. Tutte le parti devono restare razionali ed esercitare moderazione,
evitare di alimentare il fuoco e aggravare le tensioni per impedire che la crisi
si deteriori ulteriormente o addirittura vada fuori controllo“, si legge nel
paper. La proposta della Cina include la richiesta di un cessate il
fuoco e colloqui di pace, oltre alla fine delle sanzioni occidentali contro la
Russia. Sottolinea che “i Paesi interessati dovrebbero smettere di abusare delle
sanzioni unilaterali” e “fare la loro parte per ridurre la crisi ucraina”. Tra
le linee troviamo una critica rivolta agli Stati Uniti (la necessità di
archiviare la “mentalità da Guerra Fredda”) ma anche un flebile richiamo alla
Russia (basta bombardare strutture civili e non usare armi nucleari).
Opportunità da
sfruttare
La guerra in Ucraina
offre però alla Cina anche diverse opportunità da sfruttare. Pechino può aiutare
Mosca a eludere le sanzioni statunitensi, privare Washington di qualsiasi leva
finanziaria e costringere il Cremlino a perdere la sua indipendenza economica.
In altre parole, Putin ha un cappio attorno al collo che potrebbe stringersi
sempre di più in base alle necessità di Xi.
Il presidente cinese
ha definito il capo del Cremlino il suo “migliore amico” e, in effetti, molti
fattori li stanno avvicinando. Economicamente, ad esempio, Cina e Russia sono
partner complementari. Per i cinesi, la Russia è un fornitore di
importanti materie prime, mentre i russi hanno bisogno degli investimenti della
Cina e dei suoi prodotti ad alta tecnologia. Il commercio tra i due governi
continua a crescere, mentre non mancano neppure esercitazioni militari
congiunte.
In ogni caso è
inutile girarci attorno: per il Dragone la guerra in Ucraina rappresenta prima
di tutto un evento inatteso che potrebbe contribuire ad indebolire gli Stati
Uniti e modificare l’attuale ordine globale. Il punto è che, mano a mano che
Pechino diventerà più potente, il divario tra Cina e Russia si amplierà sempre
di più. Putin sarà disposto a diventare l’amico subordinato di Xi? FEDERICO
GIULIANI
Turchia, Israele
e Vaticano: a che punto è la mediazione tra Russia e Ucraina.
Mauro Indelicato il
25 Febbraio 2023 su Inside Over.
Quando l’ora “X” è
scaduta e le prime esplosioni hanno illuminato il cielo di Kiev, una parte della
comunità internazionale ha subito provato a intavolare una mediazione tra Russia
e Ucraina. Un modo per fermare da subito il conflitto ed evitare di prolungare
le azioni militari. Tentativi importanti sono stati perpetuati da Israele,
dalla Turchia, in parte anche dal Vaticano. Al momento, nessuno di questi
tentativi è stato coronato da successo. Ma le mediazioni stanno comunque
proseguendo, così come i contatti politici tra alcuni degli attori
internazionali direttamente o indirettamente coinvolti nel dossier.
La mediazione turca
Il presidente turco
Erdogan ha subito condannato l’intervento russo in Ucraina. Poche ore dopo
l’annuncio di Vladimir Putin sull’inizio delle operazioni militari, il governo
di Ankara ha espresso profonda condanna per quanto avvenuto. Tuttavia, né alla
vigilia del conflitto e né in seguito all’inizio della guerra, Erdogan ha
sposato in toto le misure degli altri Paesi Nato relative alle sanzioni contro
Mosca e alla quasi totale rottura dei rapporti diplomatici.
Al contrario, la
Turchia ha continuato ad avere ottimi rapporti con la Russia. E questo
soprattutto perché i due Paesi già da anni appaiono come tra i principali attori
dei vari dossier che seguono in comune. Ankara e Mosca ad esempio sovrintendono
al rispetto del cessate il fuoco nel nord della Siria. Appaiono inoltre i due
protagonisti principali nello scacchiere libico. Dalla Turchia passano poi
fondamentali snodi energetici per il gas e il petrolio russi. Tanti interessi
quindi, impossibili da tranciare improvvisamente.
Allo stesso modo
però, Erdogan negli anni ha intessuto importanti rapporti anche con Kiev. Ankara
non ha mai riconosciuto l’annessione russa della Crimea e si è anzi fatta
portavoce delle istanze della comunità tatara. Inoltre, la Turchia ha venduto
agli ucraini decine di esemplari di Bayraktar, i droni tra i più richiesti in
ambito difensivo e con i quali l’esercito di Kiev ha potuto da subito
bersagliare le postazioni russe.
Alla luce di queste
posizioni, la Turchia si è ritagliata un ruolo di primo piano nei tentativi di
mediazione tra le parti. Ankara è stata percepita da entrambi gli attori
contendenti come un Paese affidabile a cui affidare le proprie istanze
diplomatiche. C’è la mano turca dietro i primi incontri avvenuti in
Bielorussia tra le delegazioni russe e ucraine. Il 30 marzo forse l’evento più
importante: a Istanbul, sotto lo sguardo dello stesso Erdogan, delegazioni di
Mosca e Kiev si sono parlate affrontando alcuni dei punti principali del
conflitto. A partire dal ritiro dei russi nelle posizioni antecedenti al 24
febbraio e al non ingresso nella Nato dell’Ucraina. Le fosse comuni apparse a
Bucha nei primi giorni di aprile, hanno stroncato il percorso inaugurato a
Istanbul.
Tuttavia la
diplomazia turca è rimasta molto attiva nella mediazione. Il ministro degli
Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha più volte incontrato funzionari russi e
ucraini. Ankara e Istanbul hanno inoltre più volte ospitato delegati da Kiev e
Mosca, seppur in separate sedi. E sempre in Turchia si sono tenuti incontri tra
vertici della sicurezza russa e omologhi statunitensi. Ad oggi, il tentativo di
mediazione turco è quello più importante in campo e il più accreditato a essere
preso in considerazione nel caso di ridimensionamento dello sforzo bellico di
entrambe le parti in guerra.
Il tentativo
israeliano
Quella turca è la
mediazione più attiva, ma quella israeliana è stata la prima in assoluto a
essere stata tentata dopo lo scoppio del conflitto. Lo Stato ebraico ha ottimi
rapporti con Mosca e Kiev. Con la Russia, già da diversi anni, Israele ha
costanti relazioni per via del dossier siriano. Inoltre, i rapporti diplomatici
tra i due paesi sono stati cementificati dalla vicinanza tra Putin e Netanyahu.
Con l’Ucraina i rapporti sono sempre stati buoni, per di più il presidente
ucraino Zelensky ha origini ebraiche e questo ha contribuito ad avvicinare le
due sponde.
A febbraio al timone
di Israele c’era il premier Naftali Bennett. È stato lui il primo leader
straniero a recarsi a Mosca dopo l’inizio della guerra per provare una
mediazione. Il tentativo però non è andato a buon fine. E ad oggi le mediazione
israeliana sembrerebbe poco tenuta in considerazione.
I motivi sono da
ricercare nel progressivo disallineamento tra lo Stato ebraico e il Cremlino. La
fuga da Mosca del capo della comunità ebraica, reo di non aver appoggiato
pubblicamente la guerra, la minaccia dell’ex presidente russo Medvedev di
interrompere ogni rapporto diplomatico e le tensioni sulla Siria,
hanno inclinato l’asse tra i due Paesi.
Tuttavia né Bennett
e né il successore Netanyahu, tornato in sella a gennaio dopo le elezioni, hanno
per adesso messo in discussione la neutralità. Israele infatti non ha fornito
aiuti militari all’Ucraina, eccezion fatta per elmetti e caschi girati
all’esercito di Kiev. E ha sempre risposto negativamente alle richieste di
Zelensky. Fonti diplomatiche hanno parlato di recente circa una maggior
pressione degli Usa su Israele per aiutare concretamente l’Ucraina, la posizione
però del governo è rimasta invariata. Segno che ancora forse gli israeliani
credono in una propria mediazione.
Bennett e Putin nel
2021. Foto: EPA/Yevgeny Biyatov/Sputnik
L’attivismo del
Vaticano
Papa Francesco ha
subito condannato l’attacco russo contro l’Ucraina. Il Pontefice ha dedicato
dalla prima ora di guerra discorsi e parole favorevoli a un repentino ritorno al
dialogo. Una posizione, quella della Santa Sede, in linea con quella presa in
altre crisi internazionali passate. Basti pensare, ad esempio, all’opposizione
di Giovanni Paolo II sia alla prima che alla seconda guerra del Golfo. Tuttavia
il richiamo alla pace da parte del Vaticano non era affatto scontato e ha posto
la Chiesa Cattolica su un piano molto diverso rispetto a quella ortodossa russa,
con cui Papa Francesco negli ultimi anni ha stretto molti più legami.
Gli ortodossi russi
infatti, guidati dal patriarca Kirill, hanno subito sostenuto l’azione di Putin.
Anzi, più volte il patriarcato di Mosca ha invitato i fedeli a sostenere
l’operazione in Ucraina, indicata come “giusta” sia per la difesa della patria e
sia per l’attacco contro un occidente considerato oramai lontano dai veri valori
cristiani. Parole a cui il Pontefice romano ha risposto ricordando
l’essenzialità della pace.
Un gesto molto
significativo Papa Francesco lo ha promosso in occasione della via crucis del
Venerdì Santo, quando due infermiere, una ucraina e una russa, hanno portato per
un tratto assieme la Croce. Gesto non ben visto da Kiev, con la tv ucraina che
ha censurato la processione.
Ad ogni modo, al
fianco dei richiami alla pace il Papa ha anche avviato un’intensa opera
diplomatica. Francesco ha promosso l’invio di aiuti umanitari in territorio
ucraino ma, allo stesso tempo, ha anche parlato in un’intervista al Corriere
della Sera di una guerra non esplosa improvvisamente. “L’abbaiare della
Nato alle porte della Russia – ha dichiarato il Pontefice in quell’occasione –
probabilmente ha scatenato l’ira russa”.
La Santa Sede quindi
ha espresso una posizione di netta condanna all’operazione, senza tuttavia
scontrarsi con Mosca e anzi provando a rinforzare il canale diplomatico. Il
segretario di Stato Pietro Parolin, a dicembre ha ufficialmente dichiarato il
Vaticano pronto a farsi mediatore tra le parti. Contatti tra Vaticano e
Mosca sono stati segnalati soprattutto nella seconda metà del 2022. A dicembre
un incidente diplomatico ha rischiato però di comprometterli: il ministero degli
Esteri russo ha infatti espresso condanna e perplessità per le parole del Papa
su presunti crimini attuati in Ucraina da buriati e ceceni. Ad ogni modo, i
canali ad oggi risultano ancora aperti e praticabili.
I contatti tra russi
e statunitensi
Occorre infine
tenere in considerazione i contatti diretti tra Mosca e Washington. Contatti mai
chiusi, come confermato nei mesi scorsi dal consigliere per la sicurezza
nazionale Usa, Jake Sullivan. Statunitensi e russi, anche nella fase più
critica, hanno continuato ad avere canali preferenziali aperti. Un dialogo che
ha avuto come snodo fondamentale la sicurezza nucleare ma che, al tempo stesso,
ha riguardato direttamente la guerra in Ucraina.
Del resto,
l’obiettivo di Mosca è quello di parlare da pari a pari con la Casa Bianca prima
ancora che con Kiev. Ottenendo quindi in tal modo il riconoscimento del suo
status di potenza dagli Stati Uniti. Sul finire del 2022, la stampa turca ha
riferito di incontri ai massimi vertici della sicurezza tra delegazioni
statunitense e delegazioni russe. Si tratta di uno dei tanti segnali emersi
circa il costante contatto tra le due parti. Ed è forse su questo canale che,
nel prossimo futuro, potrebbe svilupparsi il reale incontro diplomatico capace
di far arrivare almeno a un cessate il fuoco.
I colloqui in
Svizzera
Alla vigilia del
primo anniversario della guerra, nel febbraio 2023 il ministro degli Esteri
svizzero Ignazio Cassus ha rivelato l’esistenza di colloqui svolti a Ginevra tra
alcune delegazioni. In un’intervista al quotidiano Le Temps, il titolare della
diplomazia elvetica ha sottolineato che i negoziati si stanno svolgendo tra
rappresentanti non di massimo livello. Tuttavia, le trattative in corso
riguarderebbero punti importanti ed è per questo che vige un certo riserbo.
Cassus ha anche
specificato che la Svizzera si è offerta, in qualità di Paese neutro, a “offrire
tutti i propri servizi a favore di una trattativa”. Nei mesi precedenti, Kiev
aveva proposto a Berna di rappresentare i propri interessi in Russia, ma
l’eventualità era tramontata dopo il diniego di Mosca. MAURO INDELICATO
La guerra e lo
smarrimento Ue: così la Nato si è “ripresa” l’Europa.
Lorenzo Vita il 25
Febbraio 2023 su Inside Over.
La guerra in Ucraina
ha avuto un impatto sensibile sulla politica europea. Il Vecchio Continente è
stato infatti tramortito da un conflitto che non solo ha modificato la
percezione della Russia, ma che ha anche radicalmente mutato il quadro
strategico europeo. Tutto questo ha innescato, rallentato o anche accelerato dei
processi che erano già in corso da diversi anni e che hanno riguardato non
soltanto l’Europa intesa come insieme di Stati geograficamente presente nel
continente, ma anche l’Europa intesa come costruzione comune, e quindi l’Unione
europea.
Dalla “morte
cerebrale” alla resurrezione
Per comprendere
questo complesso meccanismo politico avviato con l’invasione, va compreso
innanzitutto il periodo precedente a essa. Dal punto di vista strategico, il
continente europeo arrivava da una fase di profondo ripensamento rispetto alla
concezione stessa dell’Alleanza Atlantica. Va ricordato, infatti, che appena
pochi mesi prima delle grandi esercitazioni russe al confine con l’Ucraina, il
veloce e confusionario ritiro dall’Afghanistan aveva messo ancora più in dubbio
la leadership di Joe Biden così come la sinergia tra partner Ue e Nato. Emmanuel
Macron aveva definito il blocco euro-atlantico in “morte cerebrale” già dai
tempi della guerra in Siria. E nel frattempo, il dibattito sull’autonomia
strategica europea (insieme a quello sulla difesa comune) sembrava essere una
forma di espressione di desiderio di essere potenza da parte di un’Unione
europea che aveva assaggiato una parvenza di unità successivamente al trauma del
coronavirus.
Molti Paesi,
inoltre, temevano che le richieste di aumento del budget per la Nato fossero
eccessive per le proprie casse, esangui da una stagione di profonda crisi
economica. Infine, si notavano forti divergenze in seno alla stessa Alleanza sia
per i rapporti dei singoli Paesi rispetto alla Russia, da molti vista come un
partner imprescindibile, sia per i dossier ritenuti prioritari. Questa
contrapposizione interna tra alleati si univa, inoltre, a un complesso sistema
di rivalità tra i partner che aveva in qualche modo scalfito la sinergia
all’interno dell’Alleanza. I vari blocchi che compongono l’Europa e le singole
più importanti potenze hanno sempre gestito in modo molto diverso la politica
estera. E questo ha comportato inevitabilmente agende diverse sia nei rapporti
con le alleanze di cui si fa parte, sia verso i partner continentali sia nei
confronti delle superpotenze.
Dal punto di vista
europeo, la scelta di Putin di avviare la sua “operazione militare speciale” ha
quindi rappresentato una sorta di vaso di Pandora e allo stesso tempo un cambio
di rotta di fondamentale. Sotto il primo aspetto, l’attacco russo all’Ucraina ha
palesato quelle “ambiguità” strategiche che da tempo gli Stati Uniti riteneva
prioritario ridurre. Washington non ha mai nascosto l’enorme difficoltà nel
vedere gli idrocarburi russi arrivare in Europa mentre la Nato costituiva
l’ombrello a protezione proprio di un’eventuale escalation con Mosca, né ha mai
digerito i rapporti privilegiati di alcune potenze Ue con la Russia in una fase
di notevole distanza tra le due superpotenze. E questa concezione era condivisa
anche da diversi alleati nella Nato e della stessa Bruxelles.
I limiti dell’Ue
Contemporaneamente a
questi problemi strategici, si univa poi un altro tema, che poi è palesato in
modo evidente sin dalle prime fasi dell’escalation tra Russia e Ucraina, e cioè
la debolezza strutturale dell’Unione come soggetto politico in grado di incidere
sui destini del continente. Va infatti ricordato che, mentre gli Stati Uniti e
il Regno Unito avevano continuato a lanciare allarmi sull’invasione ormai
prossima negando fondamento alle proposte russe, Francia e Germania, le due
“superpotenze” Ue, hanno provato fino all’ultimo a far desistere Putin dai suoi
propositi. Macron e Olaf Scholz hanno anche fatto visita al presidente russo a
Mosca per cercare di trovare una mediazione, ma il risultato è stato
sostanzialmente un nulla di fatto, lasciando anzi intendere che gli Usa erano di
fatto stati gli unici a capire la situazione e a evitare di rimanere “appesi” al
dialogo con il Cremlino. In quel momento dunque si mostravano due debolezze:
quella dei singoli Paesi, incapaci di dialogare con Mosca, e quella dell’Europa
intesa nel suo insieme, lacerata da diverse visioni e soprattutto mai
considerata davvero come un interlocutore né come un “game changer”.
Ecco dunque che con
la guerra in Ucraina, la debolezza di questi soggetti e le diversità di vedute,
unita all’inevitabile riconquista di leadership da parte degli Stati Uniti hanno
fatto sì che l’Ue, di fatto, uscisse di scena come soggetto capace di incidere.
Washington, e con essa la Nato, avevano dimostrato di sapere comprendere
prima degli “europei” il destino dell’Ucraina, e la guerra scatenata a febbraio
2022 aveva invece portato a cancellare ogni ipotesi di dialogo e di
collaborazione con Mosca.
Incontro virtuale
tra Macron e Putin nel 2020. Foto: ANSA/Michel Euler.
Questo ha costretto
l’Ue e con essa i singoli Paesi a compiere una serie di modifiche ai propri
piani. Innanzitutto il dibattito sull’autonomia strategica si è di fatto
annullato per via dell’evidente forza diplomatica e bellica rappresentata da
Oltreoceano. Il vento atlantico ha surclassato le aspirazioni europeiste e ha
rafforzato chi, all’interno dell’Ue, non vi aveva mai creduto: a partire dalla
Polonia e dagli altri membri del gruppo di Visegrád fortemente antirussi (a
eccezione della sola Ungheria). Lo confermano anche le iniziative militari e
politiche sul fronte orientale, che hanno certificato una sorta di cesura tra un
passato distensivo e un presente, e probabilmente un futuro, in cui la Nato ha
assunto un peso estremamente rilevante sia sotto il profilo infrastrutturale
(Trimarium docet) che sotto quello delle nuove forniture militari a tutti i
Paesi coinvolti nel sostegno militare all’Ucraina.
Dal punto di vista
energetico, le sanzioni contro la Russia e il graduale stop agli accordi sulle
forniture hanno inoltre condotto a un enorme cambiamento strategico di tanti
Paesi che avevano fatto affidamento, in larga parte, sulle garanzie fornite da
Mosca. La modifica delle rotte del gas e del petrolio ha riacceso il dibattito
sull’autonomia strategica ma solo in chiave energetica. E, immediatamente dopo
lo scoppio della guerra, l’impressione che si è avuta è che l’unica vera carta
europea da giocare nel conflitto sarebbe stata quella energetica. Oltre a
spezzare l’asse che legava i partner continentali alla Russia, le rotte del gas
e del petrolio sono mutate contestualmente a sanzioni e stop alle forniture. I
Paesi europei più dipendenti da Mosca hanno modificato – almeno parzialmente –
le proprie importazioni, tanti hanno virato sul Gnl e su altri fornitori per
colmare il vuoto russo.
l simbolo di tutto
questo è quanto avvenuto nel Baltico: la fine del Nord Stream 2, le falle nelle
condutture, la virata verso il gas naturale liquefatto di tutti i Paesi della
regione e l’attivazione del gasdotto Baltic Pipe dalla Norvegia alla Polonia.
Una rivoluzione dell’area che però può essere letta anche come cartina di
tornasole di tutto quanto avvenuto in Europa, con nuovi grandi fornitori di gas,
nuove rotte e nuove difficili sfide per quanto riguarda il costo dell’energia,
soprattutto legato alla stagnazione economica in corso e alla crisi
dell’industria (già colpita dalla pandemia, dalle restrizioni e dai problemi
alla catena di approvvigionamento).
La supremazia
americana
In tutto questo, il
corso della guerra ha anche prodotto due altri processi all’interno dell’Europa.
Se infatti tutti i Paesi si sono resi conto dell’importanza ancora fondamentale
della Nato rispetto alle aspirazioni continentali, questo ha significato d’altro
canto un evidente spostamento del baricentro europeo verso occidente. Un
cambiamento che ha reso sempre più chiaro come nessuno degli Stati membri
potesse fare più finta di non vedere quanto accaduto in Ucraina ma nemmeno
tergiversare sulle richieste di Usa e Nato, oltre che di Kiev. I tentennamenti,
pur con vari negoziati, si sono sempre risolti nel graduale e progressivo
sostegno militare all’esercito ucraino, e lo conferma anche la decisione di
inviare i carri armati alle truppe di Volodymyr Zelensky nonostante all’inizio
vi fossero addirittura dubbi se inviare o meno semplici mezzi per evitare
l’escalation con Mosca. La trattativa tra Scholz e Biden per l’invio dei Leopard
è stata in questo senso esemplare.
Infine, un secondo
processo è stato di fatto l’esautoramento delle forze europee come interlocutori
per la Russia o come eventuali mediatori. Al netto della volontà delle parti in
guerra di giungere a un negoziato – cosa che al momento appare molto remota – va
sottolineato che tutti i Paesi che si sono proposti di intercedere tra Kiev e
Mosca e che hanno agito come potenziali ponti anche nei confronti del Cremlino
sono sempre stati esterni all’Ue. Escludendo l’Ungheria di Viktor Orban, che non
ha mai avuto un ruolo realmente da protagonista, gli unici Stati a svolgere un
ruolo riconosciuto in qualche modo anche dallo stesso Putin sono stati
Israele, Turchia, Città del Vaticano, India o al limite la Cina.
L’Unione europea,
schierata apertamente a favore dell’Ucraina, si è di fatto inevitabilmente posta
in una posizione di piena sintonia con gli Stati Uniti, rendendo in sostanza la
Nato il vero contenitore della strategia europea. I singoli Stati membri, per
errori, ambiguità, inadeguatezza o anche semplicemente per difficoltà oggettive
nel parlare con la Russia, non hanno mostrato alcun tipo di reale peso
diplomatico. Lo confermano le inutili, lunghissime ed estenuanti telefonate di
Macron con Putin, così come in vani tentativi di Scholz, su cui pesa anche la
pensate (e criticata) eredità merkeliana. E anche il fatto di dipendere
dall’esterno sotto il profilo energetico, prima con la Russia e poi con altri
partner, si è tradotto in un pesante fardello diplomatico, tagliando larga parte
dell’autonomia rimanendo invece in balia dell’evoluzione bellica. Lorenzo Vita
La guerra in
Ucraina e la partita italiana nella Nato.
Lorenzo Vita su
Inside Over il 26 Febbraio 2023
Con l’attacco della
Russia all’Ucraina, la Nato ha ricevuto un impulso non indifferente per quanto
concerne la sua importanza nel quadro di sicurezza europeo ma anche la sua
proiezione strategica. Il fronte orientale è diventato in modo inequivocabile
come il vero baricentro delle azioni Nato. E il possibile ampliamento
dell’Alleanza a Finlandia e Svezia ha acceso i riflettori anche sul fronte del
Baltico e dell’Alto Nord, sottolineando quindi una complesso politico-militare
che, almeno al momento, appare incentrato verso nord-est.
Le sfide dell’Italia
nella Nato
L’Italia, da sempre
in prima linea nelle varie missioni Nato in Europa, Iraq e Mediterraneo, si
trova quindi al momento coinvolta in quella che è una duplice sfida. Da una
parte sottolineare la propria fedeltà alla linea euro-atlantica dopo un periodo
in cui è apparsa tentennante nei rapporti con i due grandi avversari Nato: Cina
e Russia. Dall’altra parte, far sì che la naturale attenzione di Bruxelles e
Washington verso est non faccia perdere di vista l’importanza del fronte
meridionale, che per l’agenda di Roma rappresenta una questione di natura
essenziale. Se non esistenziale.
Sotto il primo
aspetto, l’Italia, sin dall’inizio della guerra in Ucraina, ha impostato una
rotta profondamente ancorata alle linee euro-atlantiche. I governi di Mario
Draghi prima e di Giorgia Meloni poi hanno dimostrato una netta continuità
strategica e diplomatica, confermando la presa di posizione a favore di Kiev e
di condanna a Mosca, ma anche stabilendo pacchetti di aiuti militari in linea
con la maggior parte degli alleati e le richieste di Usa e Nato.
Per il Belpaese si
tratta di prove di sinergia da non sottovalutare, specialmente perché negli
esecutivi precedenti vi erano stati molteplici avvertimenti di Washington su
alcune mosse diplomatiche ritenute estranee alla fedeltà atlantica. Inoltre, il
tradizionale e profondo legame economico (e non solo) tra Mosca e Roma,
specialmente sul fronte del gas, era visto con sospetto da molti apparati
d’Oltreoceano ed europei che vedevano nell’Italia una sorta di punto
interrogativo europeo al pari della Germania, ritenute troppo divergenti sul
rispetto della linea dell’intransigenza verso la Russia. E questo era stato
percepito non solo da Washington, ma anche dalle varie cancellerie dell’Europa
orientale, che hanno spesso evidenziato difficoltà nella convivenza tra le
strategie di alcuni Paesi dell’Europa centrale e meridionale rispetto alle
esigenze di chi vive fronte est dell’Alleanza Atlantica.
L’Italia e le
missioni dell’Alleanza atlantica
Questa impostazione
strategica italiana è andata in ogni caso sempre parallela a una piena fedeltà e
a un continuo ed efficiente coinvolgimento in tutte le missioni Nato, in cui
Roma, come detto in precedenza, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.
Anzi, la partecipazione attiva e fondamentale dei militari italiani nelle più
importanti operazioni euro-atlantiche è sempre stata la più chiara
certificazione del peso e della piena adesione della nazione al sistema
politico-militare occidentale. E questo si è visto non solo in precedenza nelle
varie missioni Nato (tra cui l’Afghanistan), ma anche ora nei Balcani, in
particolare in Kosovo, in Iraq, nel Mediterraneo, in Lettonia, e nelle varie
missioni di air policing in Europa orientale. Operazioni cui si devono
naturalmente unire quelle sotto il cappello Onu e Ue pur sempre legate al
sistema occidentale.
Se questa è la
premessa, va anche detto che l’Italia, come sottolineato in precedenza, si è
spesso trovata a dover districarsi fra il proprio interesse e quello di altri
Paesi Nato che, nel corso degli anni, hanno spesso dimostrato di potere spostare
il baricentro dell’Alleanza verso est dimenticandosi delle conflittualità e
delle instabilità del fronte meridionale, in particolare quello africano. Sul
punto, è importante sottolineare che la posizione dell’Italia è sempre stata
quella di ribadire che per Bruxelles e Washington quanto accade a sud delle
frontiere euro-atlantiche non è meno importante e urgente di quanto accade a
oriente, soprattutto perché i fattori di insicurezza molto spesso convergono.
Roma ha più volte sostenuto, in diversi summit atlantici, la necessità di far sì
che le forze dell’Alleanza fossero anche in grado di sostenere la sicurezza del
lato meridionale del blocco, e se questo risulta chiaro anche dalle
responsabilità di Roma su questo fronte (basti pensare al Kosovo e al comando
della missione in Iraq), va altresì detto che molto spesso l’attenzione di
Bruxelles è stata minima rispetto alle richieste.
Il nuovo baricentro
della nato dopo la guerra in Ucraina
La guerra in Ucraina
– spostando di nuovo il focus dell’Alleanza a est e a nord-est – sembra avere
nuovamente messo a repentaglio il piano italiano. Tuttavia, in questo anno di
conflitto è altrettanto evidente che l’aumento del protagonismo e dell’impegno
in questo frangente può essere per l’Italia una carta da giocare nel futuro
riequilibrio del blocco. Il summit di Madrid ha confermato che la Nato, pur
ritenendo la Russia la “minaccia più diretta e più significativa” alla sicurezza
degli alleati e inserendo la Cina come rivale, ha dato risalto alla situazione
del fianco sud facendo riferimento ad Africa e Medio Oriente.
Al punto 11
del nuovo Concetto Strategico si legge infatti che “i conflitti, la fragilità e
l’instabilità in Africa e nel Medio Oriente incidono direttamente sulla nostra
sicurezza e su quella dei nostri partner”. Inoltre, si fa riferimento ai vicini
meridionali della Nato che devono “affrontare sfide interconnesse in materia di
sicurezza, demografiche, economiche e politiche” in una situazione che “offre un
terreno fertile per la proliferazione di gruppi armati non statali, comprese le
organizzazioni terroristiche. Consente inoltre interferenze destabilizzanti e
coercitive da parte di concorrenti strategici”. L’Italia ha interesse affinché
questo punto del nuovo “programma” Nato si concretizzi nel prossimo futuro.
In tutto questo,
pesa anche la scelta del futuro segretario generale dell’Alleanza. Jens
Stoltenberg ha confermato che lascerà l’incarico in autunno e non intende
prorogare ulteriormente il mandato. La partita è aperta ed è chiaro che quella
che si gioca in Ucraina è anche una sfida politica su chi ha la capacità di
imporre una propria guida al blocco euro-atlantico. Nei mesi scorsi si era
parlato dell’ipotesi di Draghi alla guida della Nato, visto anche il favore di
cui gode Oltreoceano. Per Roma sarà un banco di prova non indifferente. LORENZO
VITA
Un anno di
guerra: chi ha davvero aiutato l’Ucraina in Italia.
Massimo Balsamo su
Inside Over il 26 Febbraio 2023
È trascorso un anno
dalla guerra voluta da Vladimir Putin, dall’invasione del territorio ucraino,
dall’inizio di morti e scie di sangue. Migliaia di vittime innocenti, soldati
uccisi ed esecuzioni truculente. Nessun segnale degno di nota dalle trattative
per il cessate il fuoco, riflettori accesi sulle dinamiche a livello
internazionale con protagonisti anche Stati Uniti e Cina, senza dimenticare
l’Europa. L’Italia ha sempre mantenuto la barra dritta, nonostante il cambio di
governo e di maggioranza. Il passaggio da Mario Draghi a Giorgia Meloni non ha
visto scossoni per quanto concerne il sostegno a Kiev: totale e incondizionato.
L’esecutivo di unità
nazionale fatto cadere dal Movimento 5 Stelle ha interpretato un ruolo
importante a livello europeo nel sostegno al Paese di Volodymyr Zelensky. Draghi
si è esposto in prima persona con gli altri leader, ribadendo l’importanza di
individuare spiragli di pace e mediazione ma allo stesso tempo rimarcando
l’imperativo di ripristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina. In altre
parole, di garantire il rispetto di un popolo aggredito.
Come anticipato, il
risultato delle elezioni del 25 settembre non hanno segnato svolte o passi
indietro sul sostegno a Kiev. Anzi, hanno rafforzato le garanzie di sostegno. Le
perplessità appartengono sono alla sinistra: il Movimento 5 Stelle si è reso
protagonista dell’ennesima capriola firmata Giuseppe Conte, un riposizionamento
ultra-pacifistica per una logica elettorale. No convinto all’invio di armi da
parte dei grillini, ma anche di Verdi e Sinistra Italiana, alleati del Partito
Democratico.
In politica, come in
molti altri ambiti della vita, contano i fatti più delle parole. E i fatti sono
noti a tutti, a prescindere dalle fake news: il centrodestra ha sempre votato in
maniera compatta pro-Kiev. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato
documenti operativi e di solidarietà sin dall’inizio dell’invasione. Tenere
aperto il dialogo per arrivare alla pace è un conto, smettere di contribuire
alla difesa di un Paese aggredito è tutt’altro discorso. Nonostante la
propaganda e le accuse lanciate in campagna elettorale, la sinistra sul punto è
apparsa quantomeno confusa. Restando all’opposizione, discorso diverso
per Italia Viva e Azione: i partiti guidati da Matteo Renzi e Carlo
Calenda hanno sempre votato per fornire aiuti e armi a Kiev, confermando la
linea tenuta durante la presidenza Draghi.
Il viaggio in
Ucraina di tre giorni fa ha confermato ancora una volta l’indirizzo di Giorgia
Meloni. Il primo ministro ha espresso a parole e con i fatti il sostegno a Kiev
sia dai banchi dell’opposizione, sia da Palazzo Chigi. “Potete contare
sull’Italia. Siamo con voi dall’inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto
il nostro il supporto”, il messaggio della leader di Fratelli d’Italia a
Zelensky.
In prima linea
anche Antonio Tajani e Guido Crosetto. Il titolare della Farnesina ha ribadito a
più riprese la contrarietà azzurra all’invasione russa e l’appoggio
all’indipendenza ucraina, come certificato dalle votazioni in Parlamento.
“Dobbiamo essere ottimisti anche in un momento difficile, non dobbiamo mai
dimenticare che alla fine prevale il bene sul male, che alla fine prevarrà la
pace e dobbiamo impegnarci tutti noi affinchè si arrivi a un accordo che non
penalizzi l’Ucraina perchè la resa sarebbe una cosa diversa dalla pace. Se
aiutiamo quel Paese lo facciamo perchè vogliamo una trattativa”, la sua
posizione. Posizioni condivise dal collega della Difesa, che ha dovuto fare i
conti con minacce e offese personali da parte dell’elite russa, a partire
dall’ex presidente Dimitri Medvedev. MASSIMO BALSAMO
Le armi
dell’Italia a Kiev: cosa abbiamo inviato.
Paolo Mauri su
Inside Over il 26 Febbraio 2023
Il conflitto
scatenato dall’invasione russa dell’Ucraina ha provocato la nascita di un fronte
occidentale (ma non solo) di sostegno a Kiev.
Paesi europei, anche
al di fuori della Nato come Svezia, Svizzera e Finlandia, insieme ad alcune
nazioni dell’emisfero orientale come il Giappone, la Corea del Sud e
l’Australia, si sono impegnati nel fornire all’Ucraina aiuti economici,
umanitari e militari.
Dal punto di vista
strettamente militare, il blocco dei Paesi che stanno fornendo equipaggiamento
di vario tipo per l’esercito ucraino è rappresentato dalla quasi totalità delle
nazioni appartenenti alla Nato con l’aggiunta di Svezia, Finlandia e Australia.
L’intervento
dell’Italia
Anche l’Italia ha
deciso di sostenere Kiev da questo punto di vista, e nel corso del conflitto ha
inviato una serie di armamenti e relativo munizionamento (siamo al sesto
pacchetto) di cui però non se ne conosce ufficialmente né la quantità né la
tipologia eccezion fatta, come vedremo, per un particolare strumento bellico.
La decisione di non
divulgare pubblicamente la lista degli equipaggiamenti ceduti all’Ucraina è in
controtendenza rispetto alla strada percorsa da altri alleati della Nato come
Francia, Germania, Regno Unito e ovviamente gli Stati Uniti. Va comunque notato
che anche Washington, ad esempio, non rivela esattamente il tipo di tutti i
sistemi inviati (si parla ad esempio di generici sistemi “anti-drone”), ma
comunque si è scelto da subito di assottigliare il velo di segretezza che invece
permane nel caso italiano.
Abbiamo già avuto
modo di spiegare come l’aver posto il segreto sulla lista di armamenti, non
significhi che il governo agisca unilateralmente: Palazzo Chigi ha la
prerogativa di dare una classificazione ai suoi atti informandone però
il Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica che
esercita il controllo sull’operato dei servizi segreti italiani, che li ha in
forma integrale. Il Copasir, quindi, esprime il proprio parere sui decreti del
governo in materia, e in merito a questa questione li ha sempre trovati in linea
con le “indicazioni” e gli “indirizzi dettati dal Parlamento”. È difficile
spiegare la decisione di porre il segreto sulla lista degli armamenti inviati
all’Ucraina: molto probabilmente si tratta di una decisione presa in funzione di
una serie di considerazioni legate alla politica interna – in Italia esiste un
fronte “pacifista” importante ereditato dai tempi della Guerra Fredda
e rispondente alle stesse dinamiche internazionali – e per opportunità
diplomatica, ma le vere ragioni ci sono ignote.
In un mondo, però,
in cui la rivoluzione digitale ha generato la possibilità di setacciare il web
alla ricerca di fonti non ufficiali, anche definibili Osint (Open Source
Intelligence), è difficile celare la paternità di certi aiuti militari, se pur
resti la possibilità di negazione plausibile.
Le informazioni che
arrivano da Kiev
Quando non è stato
il singolo osservatore civile a mettere in rete fotografie e video di
equipaggiamenti diretti al fronte, o addirittura in azione, è stato lo stesso
governo ucraino (o l’esercito) ad aver palesato l’aiuto italiano dal punto di
vista militare con post sui social network a volte corredati da alcuni scatti o
filmati: un caso in tal senso è rappresentato da un video del comando operativo
occidentale ucraino in cui viene mostrato un camion militare Iveco trainante un
obice FH-70 che sembra a tutti gli effetti di provenienza italiana.
Possiamo quindi
stabilire una lista di massima degli armamenti italiani ceduti all’Ucraina solo
tramite fonti aperte avendo cura di vagliarle attentamente per stabilirne
l’attendibilità. Da esse abbiamo potuto capire che il nostro Paese ha fornito,
oltre ai già citati obici trainati FH-70 da 155 millimetri, obici
semoventi M-109 (si ritiene più di 20) e probabilmente anche 6 più
moderni Pzh-2000. Sconosciuto, invece, è il numero dei Vtlm (Veicolo Tattico
Leggero Multiruolo) “Lince” che vestono i colori dell’esercito ucraino, ma
sempre da fonti Osint è evidente che i mezzi italiani siano al fronte. Risulta
anche, da queste fonti aperte, che siano stati ceduti due Mlrs (Multiple Launch
Rocket System) tipo M-270A1. Sconosciuta la quantità di equipaggiamento leggero
rappresentato da mitragliatrici Mg 42/59, mortai da 120 millimetri, Atgm (Anti
Tank Ground Missile) “Milan”, granate a razzo anticarro “Panzerfaust”, Manpads
(Man Portable Air Defense System) “Stinger” e mitragliatrici pesanti Browning
M2 insieme a relativo munizionamento, che si ritiene sian stato inviato nei
primi mesi del conflitto.
Il ruolo degli
Samp-T
L’unica deroga al
velo di segretezza caduto sulla lista di armamenti è rappresentato dal sistema
missilistico da difesa aerea Samp-T. Il nostro Paese ha reso noto che,
congiuntamente con la Francia con la quale ne condividiamo la produzione e messa
in servizio, una batteria mista di questo importante strumento difensivo verrà
inviata in Ucraina nel prossimo futuro. La decisione di rendere nota questa
particolare spedizione riteniamo sia stata presa proprio perché il Samp-T viene
prodotto e utilizzato anche dalla Francia, che ha stabilito di non porre la
segretezza sulla maggior parte dell’equipaggiamento militare (anche pesante)
inviato in Ucraina.
Non trova alcun
riscontro, nel momento in cui scriviamo, la ventilata possibilità che l’Italia
possa cedere 5 cacciabombardieri all’aviazione ucraina, che parte della stampa
nazionale ha indicato possano essere composti da Tornado e AMX. La notizia non è
ancora stata smentita da Palazzo Chigi, ma il ministro degli Esteri Antonio
Tajani da Bruxelles, dove si è tenuto il vertice ministeriale dell’Ue, ha
riferito che “di caccia non se n’è parlato” aggiungendo che
vede impossibile l’invio di velivoli italiani, pur restando
possibilista sull’eventualità che l’Alleanza Atlantica in futuro possa decidere
di inviare caccia, che potrebbero facilmente essere gli statunitensi F-16 che
non sono più in dotazione alla nostra Aeronautica Militare.
Del resto la linea
di cacciabombardieri dovrebbe essere unica per evitare le enormi difficoltà
logistiche rappresentate dall’addestramento di piloti e personale di terra
ucraini su velivoli occidentali di diverso tipo, addestramento che già per una
sola tipologia di velivolo risulta essere molto impegnativo e lungo in quanto
l’aviazione ucraina ha usato sempre solo caccia di fabbricazione sovietica/russa
(molto diversi da quelli occidentali), e l’F-16 potrebbe essere il candidato
migliore data la sua enorme disponibilità numerica. PAOLO MAURI
La partita
energetica a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina.
Andrea Muratore su
Inside Over il 26 Febbraio 2023
Un anno fa, mentre i
missili devastavano Kiev e i combattimenti sanguinosi infuriavano in Ucraina,
su Inside Over chi scrive propose, assieme a Emanuel Pietrobon, un focus
politico ed economico su un tema fondamentale per l’Italia e l’Europa:
l’energia. Si scrisse che per l’Europa era giunto il momento di pensare in
grande e a maggior ragione per Roma fosse arrivata un momento decisivo. Finito
il (comprensibile) momento della priorità data all’economicismo, arrivava quella
della geopolitica. Lontana anni luce l’idea di diventare hub energetico del gas
russo dopo la fine di South Stream, restava viva la forza della diversificazione
energetica e la prospettiva della creazione di una “porta” mediterranea all’oro
blu per sostituire le forniture di Mosca.
L’Europa e l’Italia
oltre il gas russo
L’Europa, ha scritto
l’Ispi, “nella sua disperata ricerca di un sostituto del gas russo ha guardato
al pragmatismo più che alla coerenza. Mosca ha gradualmente chiuso i rubinetti
delle sue esportazioni di gas verso l’Europa, che nel corso di quest’anno si
sono ridotte dell’80%. Il peso del gas russo tra i fornitori dell’Ue è così
sceso sotto il 10%“. Anche grazie all’impegno italiano.
Nei mesi è nata la
più ambiziosa strategia energetica mai sviluppata dal sistema-Paese italia dai
tempi di Enrico Mattei: una corsa alle fonti ottimali di gas naturale per
sostituire la dominanza russa, vicina al 40% delle forniture nel 2021, avviata
da Mario Draghi e proseguita da Giorgia Meloni, che proprio al visionario
manager democristiano di origini marchigiane ha intitolato il piano per la
“caccia” al gas africano.
Il piano di Draghi e
Meloni
L’Italia deve
pensare in grande e Draghi e Meloni, in continuità, sembrano averlo compreso.
Draghi ha avviato, e gli va riconosciuto il merito, una strategia di
diversificazione a tutto campo. Ha fino all’ultimo giorno del suo mandato dato
la caccia fino all’ultimo metro cubo di gas tra Algeria, Azerbaijan, Congo e
altri Paesi. Ha spinto sul price cap al gas russo prima che il boom di agosto
rendesse inattuabile la sua proposta di 80 euro al MWh, oggi riposizionata a 180
euro.
Ha costruito un asse
con la Norvegia che oggi fornisce mediamente un quarto del gas naturale che
arriva all’Italia, divenendo suo primo fornitore. In sinergia con Claudio
Descalzi, Ceo dell’Eni e ministro degli Esteri-ombra del suo governo, Draghi ha
costruito un sistema vincente di relazioni energetiche che Meloni ha
approfondito. Mirando a rompere la maggiore diffidenza possibile che si poteva
incontrare sul percorso: il timore dei Paesi “sostituti” della Russia che la
corsa alle forniture avrebbe avuto carattere provvisorio.
Sfide di sistema
Il governo Meloni
sta in quest’ottica accelerando su un grande progetto di sistema che proprio
dall’energia prende il là: quello dell’alleanza dei gasdotti nel Mediterraneo.
Capace di dare struttura al “piano Mattei”, di vivificarlo, di renderlo
competitivo. In primo luogo il governo Meloni punta fortemente EastMed, gasdotto
che può unire tra di loro Grecia, Cipro, Egitto; in secondo luogo sta costruendo
un asse sistemico con Israele per promuovere la triangolazione tra l’apertura di
Tel Aviv a East Med e lo smussamento delle pressioni turche sul
progetto. Infine, dopo la distruzione di Nord Stream nel controverso incidente
vuole riprendere in mano l’idea di fare dell’Italia l’hub del gas nel
Mediterraneo con vista Europa.
Il grande progetto,
in quest’ottica, è fondato sulla sinergia tra tre assi. In primo luogo, la
garanzia delle forniture algerine e libiche. In cui Roma deve essere garante e
protagonista, tenendo conto che il gas di Algeri contribuisce a finanziare
indirettamente la Russia tramite armi e accordi e che la Libia va tutelata
securitariamente. In secondo luogo, il grande gioco dei gasdotti nei Balcani per
la distribuzione dell’oro blu, che vede protagoniste aziende quali Eni e Snam.
In terzo luogo, l’apertura a una strategia pragmatica in Europa sulla gestione
dei mercati energetici.
In quest’ottica il
passaggio è, per citare le riflessioni di Stefano Zamagni, da un’etica
dell’utilità a una delle virtù. Nell’utilitarismo energetico a fare la
differenza è stato unicamente il fattore-prezzo. E questo ha alimentato il
crescente legame con la Russia e la conseguente dipendenza. Nell’epoca del
“virtuosismo” energetico a farla da padrone sono la geopolitica e l’interesse
nazionale. L’Italia si è trovata a cambiare domanda prospettica nella sua
politica energetica. Da “dove trovare gas a buon mercato?” si è passati a
riflette sul tema di “dove trovare approvvigionamenti sicuri da partner
affidabili?”. Un friendshoring energetico guidato direttamente da Palazzo Chigi
oltre le competenze di ogni ministero, data la dipendenza sistemica della
sicurezza economica nazionale da questa partita.
Rischi e opportunità
Tale approccio
impone ovviamente rischi e opportunità. L’Italia spinge per il decoupling
energetico dalla Russia e un domani potrà far pesare nei suoi confronti una
maggiore resilienza, ma nel breve periodo questa strategia impone dei costi.
L’esempio dello sviluppo dei terminal di gas naturale liquefatto da parte di
Snam lo testimonia: serviranno centinaia di milioni di euro di spesa per
aumentare la capacità di rigassificazione.
La seconda
problematica è quella del fatto che l’Italia mira a essere un hub del gas in una
fase in cui la domanda di oro blu dell’Europa è data in declino del 25-30% in un
decennio. Ma lo sviluppo infrastrutturale consente di pensare alla sinergia tra
opportunità di rafforzamento del Paese sul gas e infrastrutture dual use con
ricadute sulla transizione energetica: si pensi al caso dell’idrogeno.
Infine, la
diversificazione delle forniture impone di diversificare a sua volta
l’attenzione nei confronti dei Paesi di riferimento per la crescita delle
forniture di oro blu. Casi come le tensioni tra Algeria e Marocco o Azerbaijan e
Armenia riguarderanno da vicino anche il sistema-Paese. Ma uno Stato maturo deve
tenere in conto anche la prospettiva di sfide mulltidimensionali.
Infine, l’Italia
delega una fetta importante della sua sicurezza energetica alle sue partecipate
pubbliche come Eni e Snam. La sicurezza diventa funzione della corretta
governance di queste aziende e ciò pone un problema di corretta gestione dei
processi di rinnovo dei Cda, che per il Cane a sei zampe si avvieranno a breve..
Ma si pone anche un’attenzione sull’italianità assoluta del processo di
diversificazione. Pensato a Palazzo Chigi, non imposto da terzi e attuato dalle
energie dell’impresa e del mercato. Per permettere all’Italia di navigare
nell’attuale caos energetico. ANDREA MURATORE
Con l’Ucraina ma
divisa sugli armamenti a Kiev: il paradosso della sinistra in Italia.
Marco
Leardi su Inside Over il 26 Febbraio 2023
Quando si parla di
armamenti, il fronte progressista è tutt’altro che compatto. A sinistra,
infatti, sull’argomento persiste una storica idiosincrasia in grado di creare
cortocircuiti ideologici non indifferenti. I motivi di tale fenomeno sono
molteplici, spesso riconducibili a un anti-militarismo di fondo che da sempre
pervade alcuni settori della gauche italica. Con lo scoppio della guerra in
Ucraina, di cui è ricorso il primo triste anniversario, anche i progressisti di
casa nostra hanno però dovuto fare i conti con la realtà. Ovvero, con la
pragmatica decisione di scegliere da che parte stare. All’indomani dell’attacco
russo, Pd e Cinque Stelle avevano quindi indossato l’elmetto e di getto avevano
assecondato l’unica scelta di buon senso: quella di difendere il Paese
aggredito. Ma è col passare dei mesi che il vecchio istinto al pacifismo tout
court è tornato a fare capolino, spaccando la linea progressista sull’argomento.
In particolare, i
dem hanno dovuto fare i conti con i malumori di alcuni loro esponenti rispetto
alla decisione del loro partito di rinnovare il sostegno militare all’Ucraina
almeno fino al 31 dicembre prossimo. Lo scorso 11 gennaio, a palazzo Madama, due
senatori Pd avevano votato contro la proroga agli armamenti e altri due si erano
astenuti. Tra questi ultimi anche l’ex sindacalista Susanna Camusso. E alla
Camera, pochi giorni dopo, il deputato Paolo Ciani aveva analogamente espresso
parere negativo.
Stranamente a quelle
voci dissenzienti non era stato dato risalto, peraltro proprio mentre i vertici
dem si stracciavano le vesti che per chiunque – fuori dal Pd – sollevasse anche
solo qualche dubbio sul tema. Allo stesso modo, un silenzio imbarazzato aveva
accolto le fragorose affermazioni di Vincenzo De Luca contro il segretario
generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Ha detto che dobbiamo produrre più
munizioni, più armi e più cannoni. Queste sue dichiarazioni mi confermano
l’urgenza di affidarlo ai servizi sociali”, aveva picconato il governatore della
Campania. Ma tra i piddini nessuno aveva battuto ciglio. Sul tema degli
armamenti va poi registrata la schizofrenia politica di chi, come Elly Schlein,
appoggia il sostegno a Kiev ma con ampie riserve. “Credo che sia stato giusto
sostenere la resistenza ucraina, ma penso che la guerra non si risolve con le
armi”, aveva detto in tempi non sospetti la deputata.
Chi invece si è
spostato sull’irremovibile contrarietà alle forniture militari all’Ucraina sono
stati i Cinque Stelle, con il loro leader in testa. I grillini in realtà sono
abituati a sostenere tutto e il contrario di tutto, dunque il loro mutato
orientamento non ha stupito i più. Il punto è che, a oggi, i pentastellati non
hanno offerto soluzioni alternative all’invio di armi, se non quelle generiche
dei negoziati che al momento non hanno prodotto gli esiti sperati. Peraltro
anche tra i 5s non sono mancate le contraddizioni sull’argomento. Non più tardi
di un mese fa, Giuseppe Conte aveva incontrato i Verdi europei in vista di un
possibile ingresso del Movimento nel gruppo. Piccolo dettaglio: i Verdi,
soprattutto in Germania, sono in prima linea nel sostegno militare all’Ucraina.
Non accade così in Italia, dove invece l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana aveva
sin da subito osteggiato qualsiasi soluzione armata.
Nel nostro Paese,
più che altrove, la sinistra sembra costretta un equilibrio precario dovuto alle
varie anime che la popolano. Dai filo-atlantisti agli irriducibili “No war”,
passando per gli indecisi sul da farsi, i progressisti di casa nostra si
dividono pure sulla guerra. Ma così non fanno pace nemmeno con se stessi. MARCO
LEARDI
Tutte le
innovazioni belliche in un anno di guerra in Ucraina.
Joost Oliemans
, Stijn Mitzer su Inside Over il 24 Febbraio 2023
Questo articolo è la
traduzione italiana di un articolo apparso sul ventesimo numero del magazine
inglese di Inside Over, “The Perfect Storm”, dedicato alle conseguenze di un
anno di guerra in Ucraina. Il magazine intero è leggibile a questo link,
l’articolo in inglese è invece disponibile qui.
Giunto il primo
anniversario della guerra in Ucraina e con pochi segni di cedimento, gli
analisti militari stanno facendo il punto su come un anno di conflitto
convenzionale su larga scala in Europa abbia avuto impatto sul nostro modo di
pensare alla guerra moderna, sperando di trarre delle lezioni dal più grande
scontro via terra in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Sebbene i
report sulla morte del carro armato siano stati parecchio esagerati, questa
guerra ha evidenziato la vulnerabilità di più di un sistema di armi, e nel
frattempo una moltitudine di nuove tecnologie ed armamenti hanno fatto il
proprio debutto sul campo di battaglia.
La guerra in
Ucraina ha visto varie fasi chiave: dalle prime avanzate russe ad inizio 2022,
alle controffensive ucraine per riprendersi i territori perduti nell’estate
2022, ed infine al duello di artiglieria diffuso lungo un fronte perlopiù
statico dal tardo 2022. Nel corso di ciascuna di queste fasi, l’abilità di
individuare la concentrazione delle truppe avversarie, i loro depositi di
munizioni ed altri bersagli di alto valore ben aldilà delle linee nemiche è
diventata di cruciale importanza per prendere il sopravvento in battaglia.
Sin dallo scoppio
della Guerra del Donbass nel 2014, artiglieria e lanciarazzi multipli hanno
giocato un ruolo di spicco in Ucraina, con quest’ultimi che si sono rivelati in
grado di distruggere le fortificazioni avversarie e rompere le avanzate
utilizzando soltanto qualche raffica di razzi. Eppure è proprio questa capacità
che palesemente manca, o quantomeno scarseggia, negli inventori della maggior
parte degli Stati membri della NATO, e forse in maniera prevedibile, nell’ultimo
anno molti Paesi europei hanno cercato di (re)introdurre questo tipo di sistema
di armi nei propri inventori militari.
La Russia era
entrata in guerra con un significativo vantaggio in termini di artiglieria e
potenza di fuoco. Inizialmente meno armati e messi alle strette lungo la maggior
parte del fronte, per gli ucraini la situazione iniziò a cambiare con la
consegna di circa 300 obici a rimorchio e semoventi d’artiglieria occidentali e
circa 40 lanciarazzi HIMARS e MLRS, che hanno gradualmente permesso all’Ucraina
di prendere il sopravvento in maniera significativa, fino al punto da sostenere
che le forze russe non siano state in grado di colmare il divario da allora.
Tale disparità non è stata raggiunta semplicemente tramite la consegna delle
sole armi da fuoco, ma quest’ultime sono arrivate insieme ad un arsenale di
munizioni a mira assistita, mine terrestri FASCAM e radar per la localizzazione
di armi. Benché le prime siano generalmente considerate troppo costose per un
impiego diffuso, hanno permesso all’Ucraina di affrontare bersagli di alto
valore, presumibilmente giustificandone gli elevati costi di produzione. Lo
schieramento di mine da artiglieria ha visto le offensive russe venire fermate
lungo il proprio percorso, con nuove mine appena deposte che formano ostacoli
impenetrabili in campi liberati soltanto un giorno fa. I radar per la
localizzazione di armi, dal canto loro, hanno permesso alle forze ucraine di
rispondere al fuoco in maniera sempre più efficace, grazie al rilevamento dei
proiettili di artiglieria in arrivo e all’immediato calcolo del loro punto di
origine; una volta nel mirino, le armi da fuoco che hanno sparato tali
proiettili possono essere distrutte prima ancora che siano in grado di cambiare
posizione.
Inoltre, la guerra
in Ucraina ha evidenziato la necessità di ben più scorte di munizioni di quante
ne erano state previste per una guerra via terra di questa intensità. Occorrono
anche una logistica dettagliata ed una rete di riparazioni per armamenti
sofisticati ed inclini ad incepparsi frequentemente sotto lo stress di tale
utilizzo intensivo.
Come in ogni
conflitto, è solo questione di tempo prima che l’avversario cominci ad adottare
soluzioni per fare fronte a determinate minacce. L’utilizzo su larga scala
di munizioni circuitanti, che sono sostanzialmente droni kamikaze senza
equipaggio ma carichi di testate esplosive che volano da soli su un bersaglio
nemico, era stato considerato con largo anticipo. Tuttavia lo schieramento di
Switchblade statunitensi sul lato ucraino hanno lasciato molto a desiderare, ed
è stata infine la Russia che per prima è riuscita ad introdurre sul campo con
successo questa nuova modalità di attacco bellico. I video che hanno ripreso le
operazioni finora confermano come la Russia abbia utilizzato munizioni
circuitanti Lancet per colpire circa cento bersagli ucraini, tra cui dozzine di
sistemi di artiglieria occidentali. L’Ucraina ha tentato di mitigare la loro
minaccia installando reti metalliche sopra le postazioni degli obici, i quali
sono particolarmente vulnerabili ai droni nemici per la propria incapacità di
riposizionarsi in fretta dopo aver sparato. Il ciclo apparentemente senza fine
di innovazione letale, evidentemente, sta continuando in tempo reale nell’est di
un’Ucraina sfregiata dalle bombe.
Ad attrarre più
attenzione delle munizioni circuitanti è stata la flotta ucraina (e anche quella
russa, seppure in maniera minore) di piccoli droni usati per l’acquisizione di
bersagli e, sempre più, per il bombardamento di carri armati ed avamposti
nemici. Piccole, agili ed estremamente difficili da individuare, queste
apparecchiature hanno superato le prestazioni che ci si aspettava da droni più
grandi, anche se operando ad una distanza ben più ravvicinata. Specialmente in
questa fase segnata da fronti perlopiù stazionari, il tormento continuo da parte
di questi piccoli sistemi può rendere la vita di trincea in prima linea un vero
e proprio inferno. Al momento sta venendo schierata una miriade di tipologie
diverse con armamenti integrati, da ottocotteri pesanti che trasportano mortai
multipli a piccoli modelli con singole armi anticarro, operate con visuale in
prima persona usando degli occhiali speciali. E la loro popolarità è
giustificata: il logoramento dei soldati e dei veicoli da combattimento (in
particolare russi) provocato da questi nuovi strumenti è stato tutt’altro che
insignificante.
Nonostante
l’apparente situazione di stallo, il conflitto si sta in realtà evolvendo più in
fretta di quanto le forze armate occidentali siano in grado di seguire ed
analizzare, figurarsi di trarne delle le lezioni. Sebbene gli armamenti
tradizionali possano avere ed avranno un impatto significativo sul corso del
conflitto, gli strumenti veramente efficaci che riflettono tutte le necessità e
particolarità di questa guerra emergeranno soltanto man mano. In altre parole,
come aveva osservato il leggendario Will Rogers nel 1929:
“Non si può dire che
la civiltà non progredisca, poiché in ogni guerra uccide in una nuova maniera”.
JOOST OLIEMANS
Il fronte
spaziale della guerra in Ucraina: il ruolo dei satelliti.
Robert Cardillo su
Inside Over il 23 Febbraio 2023
Questo articolo è la
traduzione italiana di un articolo apparso sul ventesimo numero del magazine
inglese di Inside Over, “The Perfect Storm”, dedicato alle conseguenze di un
anno di guerra in Ucraina. Il magazine intero è leggibile a questo link,
l’articolo in inglese è invece disponibile qui.
Mentre la Russia si
preparava per un’invasione non provocata dell’Ucraina all’inizio del 2022, i
satelliti di imaging commerciale hanno fatto luce sul dispiegamento delle forze
armate di Mosca individuando le loro loro truppe e armi in avanzata verso il
loro confine. Questa trasparenza spaziale, guidata dagli attori attivi per i
servizi al commercio, ha fornito chiarezza e ha contribuito a combattere la
disinformazione prima dell’invasione.
Prendiamo questo
esempio specifico: quando il presidente Putin ha dichiarato che le unità russe
stavano tornando alla base il 17 febbraio 2022, i satelliti commerciali hanno
fotografato un ponte di barche di nuova costruzione che è apparso durante la
notte attraverso il fiume Pripyat, un fiume chiave in Bielorussia a meno di
quattro miglia dal confine ucraino. Questa costruzione del ponte contraddiceva
le affermazioni di Putin e, come riportato dai media, è stata vista
dall’intelligence occidentale e dai funzionari militari come parte di una serie
di infrastrutture di supporto costruite prima di un’invasione.
All’inizio
dell’invasione, l’Ucraina non aveva alcuna capacità spaziale nazionale. Ma la
disponibilità di servizi satellitari commerciali esistenti e crescenti e di
tecnologie avanzate ha drasticamente alterato l’accesso di tutte le nazioni allo
spazio e quindi alla guerra moderna. I funzionari ucraini e i civili sono in
grado di comunicare aggiornamenti sul campo di battaglia con i colleghi di tutto
il mondo, prevenendo la diffusione di false informazioni e aumentando la
probabilità di sostegno alleato a favore degli ucraini. Secondo CNBC, “pochi
giorni dopo l’invasione della Russia del 24 febbraio – e a seguito di una
richiesta di supporto internet satellitare via Twitter da parte del ministro
digitale ucraino Mykhailo Federov – SpaceX ha iniziato a inviare kit terminali
Starlink in Ucraina e da allora ne ha inviati migliaia”. Starlink ha fornito
un’ancora di salvezza e garantito la sicurezza delle comunicazioni critiche alle
forze ucraine nonostante i ripetuti tentativi russi di oscurare il paese sia con
attacchi cinetici che con attacchi informatici. I satelliti Starlink che volano
fino a 130 miglia sopra lo spazio di battaglia trasmettono l’accesso a Internet
ad alta velocità, consentendo alle truppe ucraine in prima linea nell’est
fortemente conteso di comunicare con una catena di comando che si estende per
centinaia di miglia, fino alla capitale Kiev.
Federov ha anche
invitato le società satellitari commerciali a condividere immagini e dati
direttamente con l’Ucraina. Il governo degli Stati Uniti ha contribuito
attraverso la condivisione delle informazioni. Quando sono iniziati i
preparativi per l’invasione, la National Geospatial-Intelligence Agency
(NGA) “ha aumentato e accelerato diversi sforzi che erano in corso
commercialmente”, secondo David Gauthier, direttore delle operazioni commerciali
e commerciali pressola NGA. Ora c’è una nuova relazione ibrida tra le capacità
spaziali governative e commerciali. Una relazione che è reciprocamente
vantaggiosa ed è rafforzata dalla sua interdipendenza.
Ora, a un anno
dall’inizio della guerra, la mancata fine dell’invasione non provocata
dell’Ucraina da parte della Russia getta nuova luce sullo stato di guerra in
evoluzione. La prima osservazione piuttosto ovvia è che lo spazio è fondamentale
per la condotta della guerra moderna, sia in termini di puntamento di precisione
con armi a guida GPS, comunicazioni commerciali o sorveglianza satellitare.
Inoltre, la grande quantità di immagini commerciali raccolte ha creato uno
spazio di battaglia in Ucraina che è uno dei più trasparenti della storia.
Inoltre, ora sembra che la capacità di guerra elettronica della Russia non sia
buona come pensavamo. Le forze russe hanno una reputazione temibile quando si
tratta di guerra elettronica e fanno di tutto per rafforzare questa narrativa. A
un certo punto, l’agenzia di stampa statale Sputnik ha proclamato che le
capacità di guerra elettronica russe “rendono inutili le portaerei”. Quel vanto
sembra essere molto più un tributo allo spettacolo che qualcosa di reale
sostanza. Anche la manciata di tentativi di interrompere la rete StarLink non
hanno prodotto risultati. Tuttavia, non dovremmo presumere che la Russia abbia
usato tutto il suo arsenale di opzioni di guerra elettronica.
Più minacciosamente,
la Russia continua la sua tendenza a fare dichiarazioni provocatorie sull’ordine
internazionale nello spazio. Mentre gli Stati Uniti e l’Occidente continuano a
sfruttare i satelliti commerciali per il lavoro di intelligence e comunicazione,
la Russia ha emesso un avvertimento che questi potrebbero diventare un
“obiettivo legittimo” per le operazioni in tempo di guerra.
La guerra in
Ucraina ci ha insegnato che una nazione non ha bisogno di possedere satelliti o
avere un forte programma spaziale per partecipare e prosperare nelle guerre
moderne. La “nebbia di guerra” esisterà sempre per i combattenti sul terreno, ma
nuove fonti di dati fattuali raccolti dallo spazio possono aiutare a illuminare,
chiarire e livellare il campo di gioco delle informazioni e avvantaggiare
cittadini, imprese, attori umanitari o funzionari militari e di intelligence che
cercano una maggiore chiarezza nelle attività che si svolgono in tutto il mondo.
I governi non sono più l’unico arbitro di ciò che i cittadini sanno. Questa luce
può esporre la disinformazione e i misfatti di attori nefasti, creando risposte
più informate e partecipative da parte dei media, delle organizzazioni
umanitarie e dei cittadini globali.
Come dice un vecchio
proverbio americano, la luce solare è il miglior disinfettante per le
democrazie. Il mondo libero ha un netto vantaggio date le capacità avanzate
dell’ecosistema delle immagini commerciali di fornire quella luce solare e
guidare in una nuova era di consapevolezza condivisa. Dobbiamo sfruttare questo
vantaggio per illuminare e denunciare azioni e attori nefasti. Questa
prospettiva può portare a una maggiore consapevolezza sulla strada della verità
condivisa, rafforzando il rispetto della libertà individuale e della sicurezza
collettiva. ROBERT CARDILLO
Armi e
tecnologia: cosa sta insegnando la guerra ucraina.
Sergio Barlocchetti su Panorama il 28 Febbraio 2023
Terra, cielo, acqua
e spazio (anche cibernetico), il conflitto in terra si sta rivelando un momento
di riscrittura della dottrina militare
Oltre la tragedia,
la guerra russo-ucraina si sta rivelando non soltanto una vetrina per
l’industria degli armamenti ma sta anche riscrivendo parte della dottrina
militare. Contrariamente a quando accadeva nelle recenti campagne in Iraq e
Afghanistan, Il fatto che i territori contesi siano in Europa e che il tipo di
scontri sia definibile “ad alta intensità intermittente” , la situazione sta
offrendo ai militari uno scenario prezioso per analizzare e aggiornare gli studi
militari. Del resto, guardare due forze armate relativamente avanzate
confrontarsi direttamente per dodici mesi ha fornito una nuova visuale sulla
guerra, e l’anno di combattimenti prevalentemente terrestri ha fornito agli
studiosi di strategia e tattica l'opportunità di esaminarne meglio, per esempio,
complessità e necessità di rifornimenti continui.
Christine Wormuth,
segretario dell’esercito Usa, ha recentemente dichiarato alla stampa del settore
difesa: “Stiamo osservando ogni singolo giorno, praticamente in diretta, ciò che
sta accadendo in Ucraina: l'esercito russo sta cercando di raccogliere quante
più lezioni possibile, per evitare errori in futuro”. Un esempio sono state le
immagini riprese nei primi giorni del conflitto che mostravano i carri armati
russi intrappolati nel fango sollevando una domanda chiave: che ruolo hanno sul
campo di battaglia di oggi? La risposta è che senza i mezzi pesanti sia ancora
impossibile far avanzare le truppe e dunque in un territorio pianeggiante come
quello ucraino si è arrivati alla richiesta urgente di carri da parte di
Zelensky. Ma da soli i carri armati possono fare poco, servono anche la
fanteria, l’aviazione per l’attacco al suolo ma anche quella per la superiorità
aerea che li protegge. E da qui la richiesta di caccia F16, aerei utilizzabili
per entrambi gli scopi. Ma per proteggere le basi servono poi missili a media e
lunga gittata e sempre una intelligence dotata di dispositivi tecnologici.
Insomma, contrariamente all’Afghanistan, dove la supremazia aerea alleata era
dominante, in questa guerra si torna a dover impiegare ogni tipo di forza.
Sempre riguardo i carri armati, questi raramente affrontano direttamente quelli
nemici; il più delle volte si tratta di utilizzarli per penetrare territori e
quindi occorre proteggerli da attacchi aerei fatti con droni e aerei, ma anche
dalle armi portatili. La conseguenza è che gli Usa, ma anche altre nazioni,
stanno guardando a come modificare i mezzi di nuova costruzione per poter
diventare meno vulnerabili in un simile contesto. Se un carro armato Abrams M1
per essere efficace in Medioriente doveva essere modificato per sopportare clima
e la sabbia delle zone desertiche, in Ucraina è più importante la manovrabilità
e la velocità di avanzamento su terreni fangosi. Un’altra sfida tecnologica e
organizzativa che questa guerra sta imponendo è quella degli approvvigionamenti
continui, non tanto per le consegne su un fronte lungo quasi mille chilometri,
quanto sul piano della capacità produttiva di armamenti, che dopo tre decenni di
riduzioni è tornata a essere una priorità, ma in un contesto globale nel quale
non si trova più “tutto quasi ovunque”. Altro argomento di studio l’uso armato
di droni civili commerciali. Già Iraq e Afghanistan avevano mostrato i pericoli
derivanti dai piccoli UAS modificati con cariche esplosive, ma l’Ucraina rivela
che questi possono dare un contributo inimmaginabile fino a qualche mese fa,
costituendo un grande pericolo per i soldati sul campo. I piccoli droni vengono
individuati con fatica e una volta a portata dell’obiettivo non c’è tempo per
ripararsi. E i sistemi anti-drone sono ancora poco diffusi e non possono
intercettare ogni tipologia esistente. Spazio, mare e qualità dell’addestramento
Se riguardo l’aviazione lo scenario ucraino è stato chiaro in poche settimane,
con la superiorità aerea russa inizialmente vittoriosa sui pochi caccia di Kiev,
ma poi vulnerabile alla progressiva saturazione di difese antiaeree che le hanno
causato gravi perdite, l’osservazione interessante riguarda lo spazio. Il capo
delle forze spaziali Usa, generale Chance Salzman, il 13 gennaio scorso aveva
affermato che la guerra in Ucraina stava evidenziando la centralità delle
risorse spaziali per vincere la guerra. Se il nemico, in questo caso la Russia,
può annientare un singolo satellite, neutralizzare intere costellazioni di
piccoli congegni orbitanti è impossibile, come dimostra l’efficacia del sistema
Starlink di SpaceX per mantenere i collegamenti internet.
Gli attacchi
informatici hanno bloccato rapidamente la rete Viasat ucraina, ma poco hanno
sortito finora contro i satelliti di Elon Musk. Diversamente, i russi sono
riusciti molte volte a disturbare il sistema Gps, che sta mostrando i limiti di
una tecnologia che, seppure aggiornata, a livello progettuale risale agli anni
Settanta e, operativamente, alla fine degli anni Ottanta. Il generale Saltzman
ha anche sottolineato l’importanza dei satelliti commerciali sia per le
comunicazioni sia per il telerilevamento per l'intelligence, la sorveglianza e
la ricognizione. Tra questi le costellazioni Maxar, Planet e BlackSky, hanno
contribuito a riprendere e diffondere nel mondo le immagini della devastazione
causata dalle forze d'invasione russe giocando un ruolo importante nel sostegno
pubblico alla causa dell'Ucraina, oltre a fornire informazioni all'intelligence
di Kiev quando i satelliti spia statunitensi non potevano essere usati a causa
dei vincoli di segretezza. Non meno importante è la guerra delle informazioni e
quella che si combatte nell’etere per le comunicazioni. Una delle differenze con
le altre guerre moderne è l’ampio e continuo utilizzo dei social media, che
riportano situazioni anche veritiere ma non contestualizzate alla situazione
globale. Ma lo fanno con immediatezza e in modo globale. Le operazioni sullo
spettro elettromagnetico, dalle comunicazioni radio dei carristi russi captate
in chiaro fino all’uso di vecchi radar a onde corte, ha evidenziato la necessità
di maggiori investimenti e collaborazione tra i servizi militari di diverse
nazioni occidentali. Infine, la guerra sul mare: la Marina russa ha mostrato
grande vulnerabilità e le sue infrastrutture sono state colpite sia da missili,
sia da barche senza pilota armate di esplosivo. In altre parole, la guerra ha
mostrato che avere tante navi, come la Marina militare russa, non compete con
una flotta composta da unità meno numerose ma dalle capacità moderne e dotate di
sistemi d’arma dell’ultima generazione. E in ogni dominio, comunque, la
differenza la sta facendo la qualità dell’addestramento dei combattenti.
Tutti i problemi
della leva obbligatoria in Ucraina.
Andrea Muratore l’1
Marzo 2023 su Inside Over.
La chiamata alle
armi della popolazione in Ucraina si sta razionalizzando ma continua a essere un
processo complicato. Tra una definizione complessa del perimetro della
coscrizione, abusi e rischi di incertezze nel processo le regole della chiamata
alle armi faticano a tenere il passo delle esigenze della guerra contro
l’invasore russo.
In un primo momento,
nel marzo scorso, l’Ucraina aveva impedito l’uscita dal Paese di tutti i
cittadini tra i 18 e i 60 anni, potenzialmente arruolabili. A ottobre la
Verchovna Rada ha approvato la Legge 8109 sulle specifiche della coscrizione per
il servizio militare e il funzionamento delle commissioni di coscrizione, che
dovranno programmare esami medici a ogni cittadino oltre i 27 anni per capire la
sua eleggibilità o meno ai requisiti della leva e scegliere eventualmente quali
potenziali militari inserire nelle liste privilegiate per forze speciali e
intelligence.
Le esenzioni e le
retate
Una circolare
ufficiale firmata da Volodymyr Zelensky del 27 gennaio 2023 non ha però ampliato
le maglie della leva di massa indicando sulla carta un tentativo di
razionalizzazione per la chiamata alle armi di lavoratori appartenenti a settori
strategici come la produzione e distribuzione di energia e la fabbricazione e il
trasporto di armi, anche alla luce dei rischi legati ai recenti scandali di
corruzione che richiedono la presenza di personale rodato e esperto. Anche le
agenzie statali, gli enti di governo locale e il sistema sanitario hanno la
facoltà di esentare loro lavoratori dal servizio. Al tempo stesso tutti
i tecnici qualificati indispensabili lontani dal fronte non saranno chiamati a
presentarsi alle obbligatorie visite di leva.
Così sulla carta.
Nei fatti la realtà è complessa. E l’Economist ha parlato di
potenziali abusi legati al caos dei primi mesi del nuovo sistema e
all’emergenza. Tra questi, da un lato, ciechi o persone senza uno o più arti a
cui veniva recapitata la cartolina precetto perchè il loro posto era stato preso
da altri autocertificati falsi invalidi. O dall’altro “retate” di militari e
poliziotti per colmare i vuoti: “Ci sono state segnalazioni di avvisi di leva
emessi (e talvolta applicati con la violenza) ai funerali militari a Lviv, posti
di blocco a Kharkiv, centri commerciali a Kiev e agli angoli delle strade a
Odessa. Le famose località sciistiche giacciono deserte nonostante le prime
nevicate dell’inverno: le riprese di funzionari militari che curiosavano sulle
piste sono bastate a tenere lontana la folla”, ha scritto la prestigiosa testata
britannica
Non c’è ancora
una valutazione piena della capacità di arruolamento dell’Ucraina o della
quantità e della qualità del materiale umano mandato in campo nell’anno di
guerra. Si sa solo la soglia massima che il Paese può gestire: fino al 3-4%
della popolazione abile, oltre un milione di uomini. Npr stima che solo il 10%
dei coscritti sia arrivato al fronte prima che fosse passato un mese
dall’arruolamento, ma ad oggi si possono decisamente derubricare
a esagerazioni e casi singolari i video circolanti sui social e sfruttati dalla
propaganda russa sull’arruolamento a forza avvenuto in diversi casi. Di cui,
peraltro, non è dato sapere se l’esito finale sia stata la coscrizione o invece
l’effettuazione della citata visita di leva, che non è viatico immediato per il
fronte.
L’addestramento e i
renitenti alla leva
Il vero problema per
Zelensky e i suoi sarà, nei prossimi mesi, capire come rafforzare la capacità di
addestramento delle truppe per le armi sofisticate in arrivo o già arrivate,
dai Leopard ai sistemi Samp-T. E al tempo stesso decidere in che misura muoversi
sul fronte della gestione della leva senza mantenere nell’incertezza i cittadini
non ancora chiamati alle armi, creare strozzature nel processo di addestramento,
vedere problemi logistici nella gestione del reclutamento.
Altra questione la
punizione dei renitenti alla leva. “Migliaia di persone sono state accusate di
aver tentato di eludere la coscrizione, e mentre molte delle accuse sono state
respinte, centinaia di casi si stanno ora facendo strada attraverso il sistema
legale notoriamente losco dell’Ucraina”, nota Almayadeen. Capire quanti processi
faranno riferimento a casi reali e quanti invece a coloro che sono stati
sostituiti nelle liste dagli imboscati di tutta Ucraina sarà una sfida ardua. E
sul fronte della leva, si notano anche problemi nella tutela dei diritti umani
come diversi casi d’arresto di persone che già prima dell’invasione si erano
dichiarate obiettrici di coscienza. Vitaly Alekseenko, 46enne di
Ivano-Frankivsk, è stato arrestato a febbraio dopo aver chiesto invano di
sostituire la leva col servizio civile e il suo caso ha fatto scalpore a livello
nazionale.
Qual è il confine
tra sicurezza nazionale e prerogative individuali? Contando che l’Ucraina
combatte, tra le altre cose, per entrare anche nell’affluente e democratico
Occidente la risposta a questa domanda non è questione di lana caprina. E invita
a riflettere sulla reale efficacia di questi processi in era di guerra
iper-tecnologica e, tendenzialmente, senza limiti. ANDREA MURATORE
Dai gruppi
tattici di battaglione alle unità d’assalto: com’è cambiato l’esercito russo.
Paolo Mauri il 2 Marzo 2023 su Inside Over.
Col ritorno
della rasputitsa sul campo di battaglia, il fango causato dal disgelo
determinato da un inverno relativamente mite e una primavera alle porte,
l’esercito russo sta cercando di spingere la sua lenta avanzata ostacolata dalla
resistenza ucraina.
L’offensiva
invernale russa, come già analizzato, si è sviluppata in una miriade di attacchi
lungo tutta la linea del fronte invece di palesarsi in un’operazione in grande
stile, e lo Stato maggiore russo vuole capitalizzare la ripresa dell’iniziativa
tattica sfruttando questo particolare momento in cui l’esercito ucraino appare a
corto di munizioni e mezzi pesanti come i fondamentali Mbt (Main Battle Tank).
Le unità d’assalto
Qualcosa, tra le
fila russe, è cambiato anche a livello organizzativo: il Corriere della
Sera riferisce che l’esercito di Mosca si è riorganizzato con la creazione di
distaccamenti o unità d’assalto, che sembra stiano sostituendo i Gruppi Tattici
di Battaglioni (o Btg nel loro acronimo anglosassone), l’unità base
dell’esercito russo formata da circa 700 uomini (per i reparti meccanizzati) e
impiegati dall’inizio del conflitto con non poche difficoltà.
Queste unità
d’assalto risulta siano formazioni più piccole e quindi agili, composte da tre
carri armati, sei pezzi d’artiglieria, sei mezzi blindati, e relativa fanteria
di supporto armata di mitragliatrici pesanti, sistemi anticarro e lanciagranate.
I dettagli sono descritti in un manuale che sarebbe stato trovato al fronte e
che descriverebbe anche la dottrina di impiego di questi reparti: apparentemente
i soldati devono attaccare non oltre un minuto dalla fine del fuoco di
copertura, e sarebbe vietato occupare le trincee nemiche in quanto possono
nascondere trappole esplosive. I feriti devono essere evacuati da team di
soccorso ma non dai militari impegnati nella missione. Ci sarebbero anche regole
ben precise per l’utilizzo dei piccoli droni (alcuni dei quali armati
artigianalmente come visto dal lato ucraino) in quanto vanno usati con
parsimonia, idem per il fuoco di supporto.
Questi ultimi due
passaggi, in particolare, farebbero pensare che i russi si trovano costretti
a fare economia di mezzi e munizioni e affidandosi alle nuove unità –
dell’ordine compagnia e plotone — ritengono di poter continuare a mantenere
l’iniziativa tattica nel conflitto.
Un Btg, sulla
carta, è composto da una compagnia di carri, due di veicoli corazzati (Apc e
Aifv), una di artiglieria semovente, una di veicoli da difesa aerea oltre a
tutti i veicoli per il sistema logistico necessario atto a muoversi in autonomia
per un totale di, in media, 700/900 uomini e sono presenti anche assetti
unmanned (UAV) e da guerra elettronica (Ew – Electronic Warfare).
Da quanto sappiamo i
Btg russi non erano al completo nemmeno all’inizio del conflitto – i video in
cui le colonne corazzate russe procedevano senza fanteria di supporto lo
dimostra – e ora, dopo un anno di guerra, si ritiene che il consumo di mezzi ma
soprattutto della risorsa più preziosa, gli uomini, abbia ridimensionato tutte
le unità combattenti presenti al fronte, quindi quelle che vengono indicate come
“Brigate”, in realtà sono dell’ordine “Battaglione” e via discorrendo.
Del resto, sebbene
la Russia abbia indetto una mobilitazione parziale, il personale va addestrato e
questo richiede tempo, anche se sappiamo che a volte le reclute venivano spedite
al fronte dopo sole due o tre settimane di addestramento, facendole diventare
“carne da cannone”.
La nascita di nuovi
“reparti d’assalto”, più snelli e agili, potrebbe quindi rispondere all’esigenza
di ridefinire l’organigramma dell’esercito russo creando unità più piccole
inserite nella catena di comando, e quindi, sostanzialmente, averle “in linea”
al completo.
La catena di comando
dell’esercito russo
Esiste però
un limite che va ancora capito se sia stato superato o meno, e riguarda proprio
la catena di comando dell’esercito russo.
La riforma “New
Look” del 2008, voluta dall’allora ministro della Difesa Anatoly Serdyukov, è
stata “abortita” allorquando gli succedette Sergej Shoigu. La riforma, che
avrebbe dovuto snellire l’impianto dell’esercito russo che era ancora di stampo
sovietico, ha stabilito la nascita dei Btg ma essi, per via dello stop subito,
si trovano in una struttura in cui spesso manca un livello intermedio – quello
Brigata – che possa fare da tramite sino ai comandi divisionali. Pertanto
la catena di comando, oltre a essere rimasta sostanzialmente la stessa dei tempi
dell’Urss, si trova a mancare di un organo intermedio, più “vicino al fronte” in
grado di ricevere informazioni e distribuire ordini.
Proprio la
distribuzione degli ordini, fortemente gerarchizzata, ha dimostrato tutti i suoi
limiti: i comandanti sul campo (sia di compagnia sia di plotone) non hanno la
stessa libertà di manovra dei loro omologhi occidentali dovendo attendere gli
ordini dello Stato maggiore della rispettiva divisione, quindi dovendo perdere
numerose e preziose ore.
Non sappiamo, come
dicevamo, se queste nuove unità potranno eludere questa dinamica, e quindi se
gli ufficiali comandanti avranno modo di agire liberamente per ottenere un
obiettivo (esattamente come avviene negli eserciti occidentali), ma se così
fosse rappresenterebbe una vera rivoluzione per l’esercito russo, ed è anche
probabile che questa novità sia stata determinata dal raffronto coi reparti del
gruppo Wagner, che sembra godano di una maggiore libertà rispetto ai regolari.
Di certo lo
“slancio” dei reparti, di qualsiasi grandezza essi siano, è determinato dalla
capacità logistica di un esercito – che nel caso russo è carente -,
dall’addestramento ricevuto – generalmente scarso come visto – e dalla
disponibilità di mezzi e armamenti, inoltre una nuova tattica di combattimento
ha bisogno di venire assimilata dai quadri, che in Russia sono stati formati in
modo diverso come da tradizione pluridecennale, quindi solo gli esisti futuri
sul campo di battaglia ci permetteranno di stabilire se questa piccola riforma
dei reparti sarà efficace.
PAOLO MAURI
Ucraina, un anno
di guerra senza limiti.
George Allison su
Inside Over il 24 Febbraio 2023
Questo articolo è la
traduzione italiana di un articolo apparso sul ventesimo numero del magazine
inglese di Inside Over, “The Perfect Storm”, dedicato alle conseguenze di un
anno di guerra in Ucraina. Il magazine intero è leggibile a questo link,
l’articolo in inglese è invece disponibile qui.
Inizialmente,
l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte del Cremlino, lanciata il 24
febbraio dello scorso anno, avrebbe dovuto avere vita breve e si sarebbe dovuta
concludere con la rapida conquista di Kiev. Tuttavia, ad un anno di distanza,
quel piano è fallito: le forze ucraine hanno respinto con successo le truppe
russe grazie ad una combinazione di determinazione e supporto dei Paesi
occidentali.
Il conflitto ha
avuto un impatto di ampia portata, rimodellando le nostre conoscenze in vari
ambiti, tra cui operazioni e strategie militari, diplomazia, servizi segreti,
sicurezza nazionale ed energetica, governance economica, e molti altri. In
occasione del primo anniversario di questo conflitto che ancora imperversa, è
fondamentale riflettere sulle sue lezioni chiavi da imparare.
Innanzitutto, del
regine di Putin non ci si può fidare
Gli ultimi sei mesi
della campagna militare russa contro l’Ucraina, insieme alle ripetute invasioni
degli Stati confinanti e alla recente guerra ibrida contro l’Occidente, hanno
dimostrato come gli accordi con il regime di Putin siano inaffidabili e possano
rivelarsi anche deleteri. Nel 2014 la Russia invase l’Ucraina benché si fosse
impegnata con il Memorandum di Budapest a rispettarne la sovranità nazionale e
l’integrità territoriale. Più recentemente, nonostante anni di trattative
nell’ambito del Formato Normandia e del Protocollo di Minsk, il Cremlino ha
conquistato un quinto del territorio ucraino. Azioni che evidenziano come
qualsivoglia accordo stipulato con il governo russo andrebbe approcciato con
cautela.
Il governo russo ha
manifestato costantemente la propria inosservanza verso il diritto
internazionale, le istituzioni liberali e vari accordi a livello globale, sia
nei confronti dei propri alleati che dei propri rivali. Coinvolto in crimini
contro l’umanità in Ucraina, violazione del principio di libera navigazione,
militarizzazione alimentare e ricatto energetico, il regime di Putin costituisce
una significativa minaccia per il futuro della nazione ucraina e le regole
dell’ordine mondiale.
L’approccio della
pacificazione, del dialogo e del compromesso con un aggressore si è rivelato
inefficace in passato. Per raggiungere la pace nella regione è necessario che
l’Occidente adotti una posizione forte e dura, in quanto è l’unica lingua a cui
risponde il regime di Putin.
La vittoria del
conflitto dipende dalle persone, non soltanto dagli armamenti
Nel 2021 la Russia
stanziò per le spese di difesa circa 65 miliardi di dollari, una cifra dieci
volte più grande di quella dello stanziamento ucraino. Nonostante il
significativo investimento in attrezzature, il risultato del conflitto non ha
però soddisfatto le aspettative russe. Il divario nella performance militare
evidenzia l’impatto della leadership e dell’addestramento sull’esito del campo
di battaglia.
Con un retaggio
militare condiviso risalente ai tempi della Russia imperiale, i risultati
contrastanti del conflitto offrono interessanti spunti di riflessione. Dal 1933
l’Ucraina ha preso parte al National Guard’s State Partnership Program,
sottoponendosi ad addestramenti sul modello statunitense: un approccio che
promuove l’emancipazione di giovani ufficiali e sottufficiali con ordini
tattici, chiare spiegazioni delle intenzioni del comandante, e l’abilità di
prendere decisioni in tempo reale sulla base di sviluppi situazionali.
Attraverso esercitazioni realistiche, l’Ucraina ha coltivato una mentalità
bellica che favorisce l’iniziativa individuale ed incoraggia una rigorosa
valutazione, e tali pratiche hanno contribuito al morale elevato e alle
prestazioni efficaci dei suoi combattenti.
In confronto, le
forze armate russe fanno in larga parte affidamento su reclute e soffrono della
mancanza di plotoni di sottufficiali professionisti, il che disincentiva sia
l’iniziativa che i riscontri; le decisioni rimangono estremamente centralizzate
e l’autonomia è limitata ai soli superiori. L’approccio bellico adottato dalla
Russia è caratterizzato dall’assenza di flessibilità e da uno scarso livello di
morale davanti a condizioni sfavorevoli sul campo di battaglia.
L’Ucraina è una
lezione chiave nelle insidie del pensiero lineare
Inizialmente si
pensava che un attacco russo ai danni dell’Ucraina si sarebbe concluso con la
vittoria di Mosca. Tuttavia, in seguito alla sconfitta russa nella battaglia di
Kiev, ci è voluto del tempo affinché gli esperti riconoscessero che i fallimenti
iniziali non erano soltanto temporanei e che in questa guerra la Russia stava in
realtà avendo la peggio.
Secondo un’altra
ricorrente previsione, il conflitto avrebbe raggiunto un punto morto, simile a
quello della Prima Guerra Mondiale, con le forze ucraine e russe entrambe
barricate in trincea ed incapaci di compiere significativi passi in avanti. Tale
previsione è stata smentita dalle varie controffensive ucraine, ma così come non
è saggio presumere che tali controffensive perdureranno in futuro, è plausibile
che questa guerra possa condurre a degli sviluppi imprevisti anziché protrarre
gli stessi schemi.
La guerra ha
dimostrato che il cyberspazio è un settore di conflitto a tutti gli effetti
Gli ultimi
avvenimenti in Ucraina, tra cui l’invasione da parte della Russia, hanno dato
vita ad un nuovo ruolo per il settore privato nei conflitti cyber, in quanto le
aziende stanno partecipando attivamente ad operazioni cyber dirette. Ovviamente
l’Ucraina dispone di un team competente per la difesa della cybersicurezza e che
ha sventato con successo diversi attacchi, ma i loro sforzi hanno potuto contare
sul sostegno di aziende private che hanno collaborato con il governo ucraino per
incrementare il livello di cybersecurity del Paese.
Aziende leader nel
settore tech quali Microsoft e Cisco hanno pubblicato dei report sul loro
impegno difensivo, e anche aziende europee di cybersicurezza quali ESET sono
state coinvolte.
È fondamentale che
gli Stati Uniti, la NATO e i Paesi democratici della regione Indo-Pacifica
instaurino collaborazioni efficienti con membri di rilievo del settore privato
per assicurare operazioni nel cyberspazio senza interruzioni nel caso di un
conflitto armato. Il National Cyber Security Centre del Regno Unito e la Joint
Cyber Defense statunitense sono iniziative encomiabili, ma non dispongono delle
capacità per fare fronte alle sfide poste da scenari bellici su vasta scala. Un
lezione importante, che ha insegnato al mondo come sia essenziale pianificare ed
implementare meccanismi operativi all’altezza di tale sfida.
Imparare dalle
lezioni
L’invasione ucraina
ha fornito un’opportunità unica per valutare le capacità delle forze armate
russe e l’impatto di varie tecnologie e strategie militari per la guerra
moderna. Questo resoconto ha lo scopo di fare luce sulle lezioni chiave da
trarre da questo conflitto, ma andrebbe anche tenuto a mente che, trattandosi di
un conflitto in corso, impareremo altre lezioni negli anni a venire. Tra un anno
esatto potremmo senza dubbio comprendere molto di più di ciò che si può imparare
da questo conflitto. GEORGE ALLISON
Parla il generale
Petraeus: “Putin ha reso la Nato nuovamente grande”.
Andrea Muratore su
Inside Over il 26 Febbraio 2023
Dopo un anno
di guerra in Ucraina, la NATO è più forte e più unita. Inside Over dialoga con
il generale David Petraeus sulle dinamiche plasmate dal conflitto a livello
globale, sul ruolo dell’Alleanza nella competizione mondiale tra potenze e sui
possibili fini della guerra. Petraeus, nato nel 1952, ha prestato servizio per
37 anni nell’esercito degli Stati Uniti e ha ricoperto molti ruoli di primo
piano. Dal 2007 al 2008 è stato comandante generale della Multi-National Force –
Iraq (MNF-I), dal 2008 al 2010 è stato comandante del Comando Centrale degli
Stati Uniti (Centcom), tra il 2010 e il 2011 è stato comandante
dell’International Security Assistance Force (ISAF) e comandante delle Forze USA
– Afghanistan (USFOR-A). Dal 2011 al 2012 è stato il 4° Direttore della Central
Intelligence Agency (Cia). Ora è partner di KKR e presidente del KKR Global
Institute,
In che modo la
guerra in Ucraina ha cambiato il contesto strategico in Europa?
“Penso che sia
accurato osservare che mentre Vladimir Putin si proponeva di “rendere la Russia
di nuovo grande”, ciò che ha realmente fatto è rendere di nuovo grande la NATO:
spingendo due paesi storicamente neutrali (e molto capaci) a cercare l’adesione
alla NATO; promuovendo un livello di unità nella NATO che non si vedeva dalla
fine della guerra fredda;,con conseguente aumento dei bilanci della difesa in
Europa e negli Stati Uniti, con la Germania, in particolare, ora impegnata a
raggiungere l’obiettivo della NATO di spendere il 2% del PIL per la difesa, dopo
non essere arrivata all’1,5% in precedenza. La guerra inoltre ha portato
all’aumento delle forze negli Stati baltici e nell’Europa orientale; e, infine,
ha spinto a ridurre drasticamente la capacità militare della Russia, con le
forze russe che hanno subito enormi perdite e perdite sconcertanti di sistemi
d’arma e veicoli, oltre a ridurre drasticamente le sue scorte di munizioni. In
sintesi, la Russia è sostanzialmente uscita indebolita e la NATO sostanzialmente
rafforzata”.
Possiamo affermare
che l’Occidente è più unito un anno dopo l’inizio della guerra?
“Sì, assolutamente,
nonostante occasionali esitazioni sulla fornitura di alcune armi all’Ucraina
(come nella decisione sulla fornitura di carri armati occidentali all’Ucraina,
che ora è concordata, ovviamente). Come ho notato in precedenza, la NATO e altri
paesi occidentali non sono stati così uniti dalla fine della Guerra Fredda”.
Qual è stato il
ruolo delle armi occidentali e del sostegno dell’intelligence nel rafforzare la
resistenza ucraina?
“Assolutamente
vitale. L’Ucraina ha fatto un lavoro davvero straordinario nel mobilitare
l’intero paese per combattere ciò che gli ucraini vedono come la loro guerra
d’indipendenza; hanno fatto molto meglio della Russia nel reclutamento,
nell’addestramento, nell’equipaggiamento, nell’organizzazione e nell’impiego di
forze e capacità aggiuntive. Ma ciò non sarebbe stato possibile senza la
massiccia assistenza degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali. Gli Stati
Uniti da soli hanno ora fornito oltre 27 miliardi di dollari in armi, munizioni
e materiale all’esercito ucraino dall’invasione dello scorso febbraio, con altri
2 miliardi di dollari che stanno per essere aggiunti. E i sistemi d’arma forniti
continuano ad essere sempre più efficaci. E, secondo quanto riferito, anche la
condivisione dell’intelligence è stata molto utile, anche se non voglio
speculare ulteriormente su questo”.
Quali errori sono
stati commessi dall’esercito russo?
Un numero
impressionante di errori, – tutto, dal disegno terribilmente carente della
campagna iniziale, alla sopravvalutazione delle capacità russe, alla completa
sottovalutazione delle capacità (e all’incredibile determinazione) delle forze e
del popolo ucraino, alla mancanza di apprezzamento del sostegno occidentale
all’Ucraina, allo scarso comando e controllo e comunicazioni, al mancato
raggiungimento degli effetti combinati delle armi (corazzati, fanteria,
artiglieria, genieri, supporto aereo ravvicinato, difesa aerea e guerra
elettronica che lavorano tutti insieme). A cui aggiungiamo una logistica del
tutto inadeguata, la terribile indisciplina da parte delle forze russe, la
mancanza di un corpo di sottufficiali professionisti, la carenza leadership (che
è il motivo per cui più leader sono stati licenziati) e, chiaramente, un
fallimento nell’approfittare di tutto il tempo che le forze russe hanno avuto in
Bielorussia e Russia per addestrare e preparare effettivamente le forze per
l’invasione.
La prospettiva di
una vittoria dell’Ucraina è fattibile come esito finale della guerra?
Sì, anche se la
risposta a questa domanda dipende ovviamente da come si definisce la “vittoria”
e dipende anche da una serie di fattori, in particolare la continuità di un
forte sostegno occidentale e dell’assistenza economica per l’Ucraina e
l’ulteriore inasprimento delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni sulla
Russia. In definitva, credo che la guerra finirà con una risoluzione negoziata
quando la Russia si renderà conto che il conflitto è insostenibile sul campo di
battaglia (dove la Russia ha già perso più di 8 volte i soldati che l’URSS ha
perso in quasi 10 anni in Afghanistan) e anche sul fronte interno, date le
sanzioni sempre più severe e i controlli sulle esportazioni. E dobbiamo fare
tutto il possibile per affrettare quel giorno – e anche per essere pronti con un
Piano Marshall per aiutare a ricostruire l’Ucraina. A cui aggiungere anche una
garanzia di sicurezza ferrea per l’Ucraina, sia che si tratti dell’adesione alla
NATO, che sarebbe l’ideale, o di un impegno di coalizione guidato dagli Stati
Uniti, se l’adesione alla NATO non sarà realizzabile “.
Il presidente Biden
ha dichiarato nel suo discorso di insediamento che l’America stava tornando come
leader globale e affidabile. La guerra in Ucraina ha dimostrato che aveva
ragione o la leadership americana è ancora in dubbio?
“Penso che la
leadership americana della NATO e lo sforzo occidentale per sostenere l’Ucraina
e imporre sanzioni e controlli sulle esportazioni alla Russia abbiano dimostrato
che gli Stati Uniti sono “tornati”, per usare il termine del presidente Biden. E
questo è particolarmente importante sulla scia del ritiro dall’Afghanistan
nell’agosto 2021, che ha permesso ai potenziali avversari di sostenere che gli
Stati Uniti erano un partner inaffidabile e una grande potenza in declino. E
nell’offrire questa valutazione, ci tengo a ribadire che non sono membro di
alcun partito politico negli Stati Uniti e non mi registro nemmeno per votare.
Ho smesso di votare quando sono stato promosso generale a due stelle e da allora
ho cercato di rimanere apolitico”.
A livello globale,
gli Stati Uniti stanno affrontando l’espansionismo della Russia in Europa e le
ambizioni della Cina in Estremo Oriente. Quale sarà la questione più importante
per Washington nei prossimi anni?
“Penso che non ci
siano dubbi sul fatto che la partita più importante al mondo sia quella tra gli
Stati Uniti – insieme ai nostri alleati e partner – e la Cina. Jake Sullivan,
consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, ha descritto il
rapporto con la Cina come una “forte concorrenza”. E tutti noi – tutte le
nazioni che la pensano allo stesso modo – dobbiamo lavorare insieme per
garantire che la competizione non si trasformi in conflitto. Si potrebbe sperare
che un impegno paziente, pragmatico e fermo possa aiutare a ridurre il senso di
competizione e aumentare le aree di cooperazione, producendo infine una
relazione che sia il più reciprocamente vantaggiosa possibile. Ma dobbiamo
essere chiari e freddamente realisti, anche se cerchiamo di affrontare le
differenze e, ancora una volta, garantire che non sfocino in veri conflitti. E
dobbiamo anche lavorare tutti insieme per garantire che gli elementi di
deterrenza (capacità e volontà di impiegarli) siano solidi come una roccia”.
Questo articolo è la
traduzione italiana di un articolo apparso sul ventesimo numero del magazine
inglese di Inside Over, “The Perfect Storm”, dedicato alle conseguenze di un
anno di guerra in Ucraina.
Un anno esatto di
guerra che no, non è stata affatto un lampo.
La notte del 24
febbraio 2022 e dopo tre settimane di schermaglie e false prospettive di
arretramento quattro divisioni meccanizzate di Vladimir Putin e di una Russia a
lui supina attraversano il confine ed entrano in Ucraina. Giampiero Casoni il 24
Febbraio 2023 su Notizie.it.
Trecentosessantacinque giorni di conflitto, un anno esatto di una guerra che no,
non è stata affatto quella guerra lampo che l’invasore e molti analisti
prefiguravano e che si è trascinata fino ad oggi, 24 febbraio 2023, fra orrori,
contrapposizioni, assetti geopolitici mutati e tutte le sconfitte della
soluzione diplomatica al primo conflitto europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale
e dopo la guerra civile nella ex Jugoslavia che ebbe vita e collocazione sua,
ancorché altrettanto orribile.
La notte del 24
febbraio 2022 e dopo tre settimane di schermaglie e false prospettive di
arretramento quattro divisioni meccanizzate di Vladimir Putin e di una Russia a
lui supina attraversano il confine ed entrano un Ucraina, entrano con il motivo
di uccidere, il movente di “denazificare” un paese che nella sua ricerca di
democrazia si era affidato molto agli Usa e con lo scopo strategico di togliere
a quel paese le due repubbliche indipendentiste nel Dondass, russofile, quasi
tutte russofone e in conflitto fin dal 2014 con il governo di Kiev.
Non è stata affatto
una guerra lampo
Governo che ha un
presidente semisconosciuto, ex attore, che sale alla ribalta delle cronache
mondiali: si chiama Volodymyr Zelensky ed ha l’aura del capo di stato
coraggioso, indomito e resistente. Le truppe corazzate contrassegnate da una
misteriosa Z bianca sembrano avanzare senza ostacoli mentre il mondo inorridisce
per quello che molti, forse troppi, avevano considerato un bluff. Da Bielorussia
e Crimea le divisioni di Vladimir Putin dilagano verso Kiev e fanno tappa
nell’aeroporto di Hostomel dove ricevono la prima di una lunga serie di amare
sorprese: la Cia era in allerta da tempo ed ha passato agli ucraini,
bellicosissimi e preparati militarmente, informazioni tali da sterminare i parà
spetznats che avevano il compito di raggiungere il palazzo presidenziale ed
uccidere Zelensky.
Gli ucraini
resistono e resistono bene e quella che sembrava dover essere una spocchiosa
guerra lampo diventa fin dalla fine di marzo 2022 una tremenda guerra di
contatto alternato e di avanzate tutt’altro che repentine.
Mentre entrano in
gioco i terribili reggimenti ceceni del tiranno satrapo di Putin Razman Kadyrov
l’Occidente reagisce e mette a punto le prime sanzioni economiche: i gerarchi di
Putin e ed il miliardari del suo cerchio magico si vedranno sequestrare tutti i
beni ed i mezzi che hanno fuori dal loro paese, sono tanti e il Regno Unito,
prossimo a dire addio al governo di Boris Johnson per uno scandalo, ottiene
risultati micidiali su questo fronte.
Un primo tentativo
di colloqui di pace, praticamente il solo ufficiale di tutto il conflitto,
fallisce nella Bielorussia del filoputiniano Lucashenko e il fronte vivo si
sposta a sud: Maiurpol, affacciata sul Mar Nero, diventa il simbolo della
resistenza ucraina e con essa il famigerato Battaglione Azov, che resisterà per
mesi dell’acciaieria Azovstal: per alcuni sono patrioti meritevoli, per altri
sono la prova provata che le forze armate ucraine contenevano il germe del
neonazismo usato come movente da Putin per attaccare.
Mariupol e l’epopea
del battaglione Azov
La Federazione di
Mosca entra a Kherson e prende Zaporizhzia, la più grande centrale nucleare
d’Europa, Europa che pensa a Chernobyl e inorridisce. Ma l’orrore ha anche
connotazioni peggiori: ad inizio aprile emergono gli orrori di Bucha ed Irpin,
con cittadini inermi giustiziati e lasciati morti in strada, esecuzioni sommarie
e violenze terribili. Il mondo si indigna con le truppe buriate dei confini
mongoli dell’impero di Putin e l’Occidente inasprisce le sanzioni. A quel punto
la Nato diventa un ombrello e Svezia e Finlandia chiedono di entrare mentre
l’Ucraina si candida ad essere membro dell’Ue.
Dagli orrori di
Bucha al blitz su Odessa
L’estate 2022 si
apre con il tentativo di sfondamento a Odessa e con la manovra strategica con
cui la Russia vorrebbe arrivare a chiudere ogni sbocco al mare all’Ucraina,
congiungendosi idealmente con la sua “dependance” della Transnistria, che sta
accatta all’indifesa Moldavia e che potrebbe diventare la porta per un secondo
inferno ed un attacco a Kiev da ovest. Usa, Nato ed Ue inviano dopo
deliberazioni dei singoli governi non sempre omogenee le prime armi che hanno ed
avranno un’influenza decisiva sul conflitto.
L’invio di armi e il
gas: Nord Stream “salta”
A quel punto è già
scoppiata la guerra del gas, quasi tutto russo, che arriva in Europa e i
sabotaggi al Nord Stream uno e due diventano il simbolo di una crisi mondiale
che è anche energetica, con le nazioni che si affannano a trovare un “sostituto”
di Mosca nelle forniture, in primis l’Italia di Mario Draghi che manda il
ministro degli Estero Di Maio in Algeria, Azerbaigian ed Africa centrale a
cercare nuove risorse e che stringe con gli Usa di Biden un accordo per il gas
liquido. L’autunno esordisce con due eventi: quello singolo dell’esplosione del
ponte di Kerch verso la Crimea e quello strategico con cui l’arrivo di armi
chiesee con insistenza dalle dirette quotidiane social di Volodymyr Zelensky,
inizia a far sentire il suo effetto: l’Ucraina non si difende solo ma
contrattacca e riconquista molti territori ad est.
Kiev contrattacca: i
missili e i rerefendum-farsa
I russi cambiano
strategia ed iniziano a bombardare con missili tutto ciò che nel paese aggredito
può produrre energia: l’inverno rigidissimo è alle porte e lo scopo è piegare il
paese dove non può dare prova di coraggio militare. A quel punto Putin capisce
che deve forzare la mano non solo sui campi di battaglia ed indice dei
referendum popolari con cui Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhizhia si auto
annettono a Mosca. Pochi giorni dopo un missile antiaereo ucraino cade in
territorio polacco e ammazza due lavoratori: quelle sono le ore in cui, dopo le
reiterate minacce degli uomini di Putin di usare l’arma nucleare, si teme di più
che la guerra diventi mondiale ed atomica in base all’articolo Nato di mutua
assistenza. Poi di scopre che il missile non era russo e l’incidente recede.
Zelensky vola da
Biden: “Dateci altre armi!”
Dicembre vede
Volodymyr Zelensky in volo verso il primo partner dell’Ucraina aggredita, gli
usa di Joe Biden che però ha perso le elezioni di mid term ed è molto più cauto
nel promettere aiuti. In Italia intanto al governo Draghi è succeduto quello di
Giorgia Meloni che conferma in tutto e per tutto l’appoggio a Kiev, fatta
eccezione per una mutata opinione pubblica ed alcune “uscite” del suo alleato di
governo Silvio Berlusconi.
Il 2023 e il caso
dei carri “Leopard 2”
Il mese che precede
il “compleanno dell’orrore” di oggi, gennaio 2023, è segnato dalla questione
dell’invio dei carri Leopard e da una generale sensazione di escalation che dice
due cose. La prima è che no, non è stata affatto una guerra lampo e che Putin
ormai è un attaccante che gode di meno credito di quando aveva avviato
l’attacco. La seconda è che quella guerra e la condotta dell’Occidente poco
propenso a cercare soluzioni diplomatiche ha di fatto visto l’unità degli stati
tenere, ma le convinzioni delle singole popolazioni vacillare di fronte
all’opportunità di cercare la pace inviando armi. Oggi il mondo è diviso ed in
pericolo più che mai, ad un anno esatto dall’inizio di quell’orrore.
La battaglia di
Kiev, spiegata.
Mauro Indelicato il 10 febbraio 2023 su Inside Over.
La battaglia
di Kiev, nell’ambito della guerra in Ucraina del 2022, ha inizio lo stesso
giorno del conflitto, ossia il 24 febbraio, e termina tra il 30 marzo e il 3 di
aprile. L’assedio prende le sembianze di un vero accerchiamento, operato dalle
forze russe, ai danni della capitale ucraina. Le truppe di Mosca avanzano,
durante questa fase, tra le direttrici di nord ovest ed est, colpendo
particolarmente le cittadine di Gostomel, Bucha, Irpin, Makariv e Brovary.
L’assedio termina con l’annuncio da parte russa di un ridispiegamento di forze
nel Donbass e quindi un indietreggiamento delle proprie truppe dall’area di
Kiev.
Il contesto
dell'assedio di Kiev
La capitale ucraina
vive tumulti e tensioni tra il 2013 e il 2014, quando le proteste contro
l’intenzione dell’allora presidente ucraino Yanukovich di aderire a un
partenariato con la Russia degenerano in guerriglia. Kiev dal novembre 2013 fino
al 22 febbraio 2014, giorno della destituzione di Yanukovich, è al centro
di scontri violenti e una vera e propria guerriglia urbana. Prima della fine
della presidenza Yanukovich, a scontrarsi sono soprattutto forze di Polizia
contro gruppi nazionalisti di estrema destra, quali Svoboda e Pravij Sektor.
Successivamente le
tensioni si spostano nelle regioni orientali dell’Ucraina. A marzo la Crimea,
dopo le proteste scoppiate questa volta nei gruppi filorussi, è annessa alla
Russia. Mentre nell’aprile sempre del 2014 la situazione degenera fino allo
scoppio della guerra del Donbass tra l’esercito ucraino e i separatisti di
Donetsk e Lugansk.
Kiev vive questo
conflitto da lontano. La città torna alla sua normalità e gli abitanti non
vengono coinvolti in scontri, anche per la distanza geografica tra la capitale e
l’est del Paese. La tensione ritorna sul finire del 2021, quando dalla Russia
arrivano notizie di assembramenti di truppe lungo i confini con l’Ucraina e
dagli Usa gli allarmi su una possibile operazione russa nel Paese.
A Kiev si comincia a
restaurare antichi bunker, la gente inizia a fare scorta di cibo e viveri. Per
la verità, a dispetto dei timori statunitensi, buona parte della popolazione non
crede subito all’eventualità di un’invasione russa. La situazione però precipita
tra gennaio e febbraio, quando molte ambasciate occidentali decidono di
trasferire la propria sede a Leopoli e un attacco russo è oramai dato per certo.
La capitale ucraina
teme particolarmente le manovre svolte in Bielorussia dai soldati locali e dalle
truppe russe. Kiev infatti si trova a meno di 200 km dal confine bielorusso e un
ingresso da qui dei militari di Mosca rappresenterebbe la volontà russa di
prendere la città. L’unica speranza per gli abitanti della capitale è data dalla
distanza con il Donbass e dalla possibilità quindi che la guerra si concentri
unicamente nell’est dell’Ucraina. Sotto il profilo prettamente strategico
infatti, Kiev è molto lontana dai fronti in cui si combatte dal 2014 e dalle
terre considerate russofone. Ma a livello politico è il cuore delle istituzioni
ucraine ed è sede del governo del presidente Zelensky. Se l’obiettivo russo è
quello di far crollare l’attuale Stato ucraino, Kiev non può sfuggire
dall’accerchiamento.
Le operazioni di
Gostomel del 24 febbraio
Il primo vero
intervento volto ad accerchiare Kiev si ha al mattino del 24 febbraio, poche ore
dopo l’inizio delle operazioni militari. Un’azione compiuta da unità
aviotrasportate prende di mira l’aeroporto di Gostomel, situato a circa 25 km a
nord ovest dal centro della capitale. Mentre in città gli abitanti temono
soprattutto i raid e si rifugiano nei bunker e nei tunnel della metropolitana, a
Gostomel va in scena la prima battaglia di terra tra russi e ucraini.
Intorno alle 13:00,
Mosca rivendica il controllo dell’aeroporto. Tuttavia gli ucraini affermano di
essere riusciti ad abbattere alcuni mezzi russi. A dispetto delle dichiarazioni
sorte poco dopo l’alba da parte dell’esercito russo, l’aviazione ucraina è
ancora in grado di replicare e non appare annientata.
La battaglia a
Gostomel va avanti per diversi giorni. Più volte, prima della fine di febbraio,
le due parti ne rivendicano il controllo. L’aeroporto, a giudicare dalle prime
immagini trapelate sui social, appare distrutto. L’hangar che ospita l’Antonov
An-225, l’aereo più grande del mondo, è anch’esso distrutto e il mezzo ridotto
in frantumi. I russi comunque, nonostante le controffensive ucraine, riescono a
controllare la cittadina di Gostomel.
L'avanzata lungo
l'asse occidentale
A dare manforte alle
truppe aviotrasportate su Gostomel sono i reparti entrati, sempre il 24
febbraio, dal confine con la Bielorussia nell’area di Chernobyl. La regione si
trova a 150 km dal centro di Kiev. Nel pomeriggio i russi riescono a conquistare
la zona attorno l’ex centrale nucleare teatro del disastro del 1986.
In questo modo
raggiungono nel giro di un paio di giorni la regione di Makariv e provano ad
aiutare le truppe stanziate a Gostomel. Prende forma in questa maniera
l’avanzata russa lungo il fronte nord occidentale di Kiev. È da qui che per gli
ucraini arrivano le principali minacce per la difesa della capitale.
Nel frattempo il
ministero della Difesa russo mostra alcune immagini di un lungo convoglio
attestato tra il confine bielorusso e la regione a nord di Kiev. Secondo
l’intelligence britannica, la prima a lanciare indiscrezioni in tal senso, il
convoglio di carri armati e mezzi russi è lungo 60 km. Una lunga carovana con la
quale Mosca intende mostrare l’intenzione di entrare nella più grande città
ucraina.
Già a cavallo tra
febbraio e marzo inizia quindi l’esodo di migliaia di cittadini verso ovest,
zona dell’Ucraina meno coinvolta dal conflitto. Si teme una battaglia casa per
casa, per cui i residenti della capitale preferiscono uscire. Si scappa con i
treni oppure sfruttando l’asse meridionale della viabilità di Kiev.
Il 25 febbraio il
presidente ucraino Zelensky dichiara di essere a conoscenza di “sabotatori russi
già presenti in città”. Tra il 26 e il 27 febbraio alcuni scontri hanno luogo
nel settore occidentale della periferia di Kiev e, in particolare, lungo Victory
Avenue, non lontano dalla stazione di Beresteiska. Si tratterebbe, secondo gli
ucraini, di un primo tentativo di infiltrazione di reparti russi all’interno
della capitale. Un tentativo però respinto o comunque abbandonato dai soldati di
Mosca.
Nel primo fine
settimana di guerra si ha la sensazione di un imminente ingresso russo in città.
A testimoniarlo è l’aumento dei raid attorno i quartieri occidentali e i
continui allarmi che corrono via social. Sabato 26 i bagliori dei traccianti
della contraerea ucraina vengono scambiati per paracadutisti russi in procinto
di assediare il centro di Kiev. Nei primi giorni di marzo tuttavia i quartieri
centrali appaiono risparmiati da sortite di Mosca. La battaglia è invece
confinata lungo il settore nord occidentale.
La battaglia tra
Bucha e Irpin
Il 27 febbraio il
giornalista ucraino Andriy Tsaplienko parla di violenti combattimenti in corso
a Bucha. È la prima volta che il nome della cittadina viene menzionato nel
conflitto. E, purtroppo, non sarà l’unica. Il suo territorio si trova a metà
strada tra Gostomel e Irpin. Quest’ultima è la località che confina direttamente
con il territorio di Kiev. Dunque sfondare su questo fronte per i russi appare
importante per raggiungere la capitale.
Le truppe di Mosca
nei giorni successivi avanzano su Bucha, anche sfruttando gli ulteriori rinforzi
arrivanti dal fronte di Chernobyl e dalla paralisi dell’esercito ucraino nella
zona di Borodyanka, località più a ovest rispetto alla periferia di Kiev.
Tuttavia la battaglia appare molto aspra. Tanto è vero che il 3 marzo gli
ucraini rivendicano la ripresa di Bucha e una bandiera ucraina viene di nuovo
issata davanti il municipio della cittadina.
Le forze russe però
controbattono. Per almeno dieci giorni il territorio risulta conteso. Nel
frattempo i civili vivono una situazione drammatica. Bucha, assieme alle altre
cittadine del fronte occidentale di Kiev, sono senza i servizi essenziali, senza
acqua e con pochi viveri a disposizione. I raid da parte degli eserciti in lotta
poi provocano la morte di molte persone. Tanto è vero che la Bbc, in un articolo
del 14 marzo, sottolinea come gli stessi abitanti sono costretti a scavare una
fossa dove seppellire i civili deceduti.
Il 13 marzo i russi
annunciano di aver ripreso il controllo di Bucha e passano all’attacco anche
sulla confinante Irpin. Qui va in scena un’autentica battaglia urbana, con gli
ucraini che si difendono riuscendo a sfruttare la conoscenza del territorio e le
tattiche delle imboscate tra i palazzi residenziali che caratterizzano la città.
Contestualmente
vengono allagati diversi terreni attorno il fiume Irpin, corso d’acqua che
divide l’omonima cittadina con la municipalità di Kiev. La battaglia a Irpin va
avanti per giorni, tuttavia i russi non sembrano in grado questa volta di
sfondare. La violenza degli scontri da queste parti è testimoniata anche dal
decesso di alcuni giornalisti stranieri presenti non lontano dalle linee del
fronte. Buona parte dei cronisti morti in Ucraina era a lavoro proprio nella
zona di Irpin.
I civili con non
poca difficoltà vengono evacuati verso Kiev, da cui poi è possibile salire a
bordo dei treni diretti verso le regioni occidentali dell’Ucraina. Per tutto il
mese di marzo la battaglia nel quadrante nordoccidentale della capitale appare
in stallo. Con i russi che non riescono a superare le difese ucraine poste a
Irpin e lungo i limiti della periferia di Kiev.
La situazione a Kiev
a marzo
Le notizie dello
stallo tra Bucha e Irpin assicurano agli abitanti della più importante metropoli
ucraina il tempo necessario per procedere con le evacuazioni. Passato il timore
per un’imminente invasione nel primo fine settimana di guerra, a Kiev si
intuisce nella prima decade di marzo che il centro città è lontano dalle prime
linee del fronte.
Questo tuttavia non
permette ai cittadini di vivere normalmente. Vengono approvati diversi
coprifuoco, in alcuni casi lunghi anche 36 ore. Le attività non basilari sono
chiuse, stesso discorso vale per le scuole e diversi uffici. Migliaia di persone
vivono nei rifugi e all’interno delle gallerie della metropolitana. L’unica zona
dove tutto sembra normale è quella della stazione centrale. Qui ogni giorno in
centinaia si ammassano per salire a bordo dei treni e fuggire via. Si calcola
che a marzo un abitante su due di Kiev è riuscito ad andare via. Dei tre milioni
di abitanti prima del conflitto quindi, la città dopo un mese di guerra potrebbe
contare non più di 1.5 milioni di residenti rimasti.
La situazione si
mantiene tesa poi a causa dei raid sempre più frequenti all’interno del
perimetro cittadino. Diversi missili piombano su alcuni palazzi e in alcuni
punti nevralgici di Kiev. Si piangono diverse vittime civili e, al contempo, chi
rimane in città teme di ritrovarsi nel mezzo di un bombardamento.
L'avanzata lungo
l'asse orientale
Da est i russi già
dal primo giorno di guerra provano ad avanzare lungo l’asse che va dalle
province di Sumy e Chernihiv fino alla periferia orientale della capitale
ucraina. Obiettivo principale qui è prendere Brovary, cittadina che segna il
confine tra l’oblast e la municipalità di Kiev. L’azione russa si concentra
soprattutto lungo le vie principali della regione.
Le truppe di Mosca,
in particolare, provano da subito a consolidare le proprie avanzate nelle
arterie autostradali che collegano il confine russo-ucraino con Chernihiv,
importante città messa subito sotto assedio. Tuttavia i battaglioni inviati dal
Cremlino raramente provano a sfondare nelle zone più interne. La strategia è
quella di arrivare il prima possibile a Brovary, aumentando così la pressione su
Kiev, già in parte circondata nella periferia occidentale.
A metà marzo le
forze russe si trovano in prossimità di Brovary, ma riscontrano notevoli
difficoltà nelle retrovie. Avendo consolidato unicamente le posizioni lungo le
autostrade principali, intere squadre ucraine rimaste dietro le posizioni di
Mosca riescono a infliggere pesanti perdite al nemico. Sia con l’ausilio di
droni che con mezzi di artiglieria, unitamente all’organizzazione di imboscate
nelle foreste tra Kiev e Chernihiv, gli ucraini distruggono molti mezzi russi e
causano la perdita di centinaia di unità di Mosca.
Anche sul fronte
orientale quindi la situazione può considerarsi, sul finire del mese di marzo,
in una fase di stallo. I russi non hanno la forza per raggiungere i confini
orientali della città di Kiev, gli ucraini non hanno invece concrete possibilità
di contrattacco.
La fine dell'assedio
Il 30 marzo 2022
a Istanbul si tiene una delicata e importante riunione tra due delegazioni russe
e ucraine. L’incontro è organizzato e voluto dal presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, il quale ben presto subito dopo l’inizio delle ostilità si erge quale
principale mediatore tra le parti. Il governo di Ankara ha infatti sì condannato
l’azione russa, ma non ha aderito alle sanzioni contro Mosca promosse invece
dagli altri Paesi della Nato.
Il vertice termina
con una fumata nera, anche se trapelano alcuni passi avanti nelle trattative.
Quel giorno stesso il ministero della Difesa russo annuncia un
“riposizionamento” delle proprie truppe impegnate nelle operazioni in Ucraina.
In particolare, i soldati presenti nell’area di Kiev vengono dislocati nella
regione del Donbass, da questo momento in poi principale obiettivo del Cremlino.
Si tratta nei fatti di un integrale ritiro dall’area attorno a Kiev.
Difficile dire se
questa mossa dipenda o meno dall’incontro di Istanbul, l’unica cosa certa è che
dal 30 marzo iniziano le operazioni volte a riportare le truppe russe in
territorio russo per assegnare poi ai vari reparti le nuove missioni nel
Donbass. Per Mosca, come detto, si tratta di un semplice riposizionamento. Per
Kiev invece si vero e proprio ritiro e di una grave battuta d’arresto del
Cremlino.
Nei giorni
successivi tutte le località a nord, a ovest e a est di Kiev in mano ai russi
vengono abbandonate. Entro la prima decade di aprile i reparti ucraini possono
quindi rientrare nelle cittadine perdute durante il primo mese di guerra.
Termina così l’assedio della capitale ucraina. Tra aprile e maggio molti tra
coloro che erano scappati in precedenza fanno rientro nelle proprie case, in
città molte attività riaprono e il conflitto viene temuto quasi unicamente
soltanto quando nella regione di Kiev risuonano gli allarmi per possibili
attacchi aerei.
Le notizie relative
alle fosse comuni
Subito dopo il
ritiro russo i media ucraini danno conto del ritrovamento di diversi corpi
abbandonati all’interno di alcune fosse comuni, soprattutto nell’area nord
occidentale di Kiev. Secondo il governo ucraino, si tratta della principale
testimonianza del comportamento russo durante l’assedio della capitale. Mosca
invece nega ogni accusa e punta il dito contro una possibile propaganda da parte
di Kiev.
Cosa è successo a
Bucha?
Fosse comuni vengono
ritrovate sia all’interno di alcune cittadine che nei boschi dove per oltre un
mese si è combattuto. La località simbolo del ritrovamento delle fosse comuni è
quella di Bucha: qui diversi corpi vengono scoperti dietro una delle più grandi
chiese cittadine, attirando anche un’inchiesta del New York Times. Ritrovamenti
del genere avvengono anche a Irpin e Borodyanka.
Attualmente sono in
corso delle inchieste da parte della procura generale di Kiev, ma sono diversi
anche gli investigatori internazionali giunti in Ucraina per approfondire la
vicenda.
Il raid del 10
ottobre 2022
Dopo mesi di
relativa calma nella capitale ucraina, Kiev torna a essere nel mirino dei russi
la mattina del 10 ottobre 2022. Poco prima dell’alba, le prime allerte aree
annunciano ai cittadini l’inizio di una delle giornate più difficili per la
città. Diverse le esplosioni che questa volta riguardano soprattutto il centro.
Mai prima di allora i quartieri limitrofi alle zone governative risultano così
pesantemente attaccati. Un missile cruise, probabilmente sparato dalla flotta
russa del Mar Nero, colpisce un’area a metà strada tra il palazzo presidenziale
di via Bankova e la sede dei servizi segreti.
Un altro ordigno
invece distrugge parzialmente il Glass Bridge. Si tratta del ponte pedonale
situato in uno dei parchi del centro della capitale. Possibile che quest’ultimo
attacco costituisca in qualche modo un segnale per il governo ucraino: pochi
giorni prima infatti, precisamente l’8 ottobre, un sabotaggio attribuito dai
russi all’intelligence ucraina danneggia pesantemente il Ponte di Kerch, in
Crimea. L’opera è considerata da Mosca strategica: è l’unico collegamento via
terra tra la penisola e la federazione, nonché simbolo stesso dell’annessione
del territorio della Crimea.
Alla luce di ciò, il
bombardamento del 10 ottobre, che colpisce Kiev e altre città dell’Ucraina sia a
ovest che a est, può essere visto come una rappresaglia del Cremlino per il
sabotaggio del Kerch. A fine giornata la capitale ucraina conta almeno 11
vittime. Diversi gli edifici distrutti, i servizi di emergenza rilevano 30
incendi in tutta l’area urbana. Colpite anche centrali elettriche e danneggiato
inoltre il tetto della stazione centrale. Per Kiev il 10 ottobre rappresenta un
ritorno ai primi mesi di guerra, con i cittadini costretti per ore a stare nei
rifugi e successivamente a iniziare la corsa nei supermercati e nei distributori
di carburante per accaparrarsi le provviste.
Kiev al buio
Il raid del 10
ottobre non è l’unico che coinvolge la capitale ucraina negli ultimi mesi del
2022. Più volte Kiev deve far fronte ad allarmi aerei, così come anche
all’incursione di droni. La novità, rispetto alle fasi iniziali del conflitto,
riguarda proprio l’uso da parte dei russi degli aerei senza pilota per colpire
specifici obiettivi in periferia e in centro. Si tratta il più delle volte di
droni di fabbricazione iraniana, girati da Teheran prima della guerra. Almeno
stando alla versione fornita dai vertici della Repubblica Islamica.
Non solo, ma tra
novembre 2022 e gennaio 2023, i bombardamenti riguardano diverse infrastrutture
elettriche sia di Kiev che dell’intera Ucraina. Si calcola che più della metà
delle centrali presenti nel Paese sono soggette a danni parziali o totali. Il
risultato è che il governo viene costretto a razionare l’erogazione di energia
elettrica. La stessa capitale è al buio. Le immagini della metropoli senza luce
per le strade e con i grattaceli spenti fanno il giro del mondo.
Il pericolo maggiore
riguarda la mancanza di riscaldamenti nel momento in cui l’inverno avanza e le
temperature scendono costantemente sotto lo zero. Le autorità locali forniscono
in questo periodo elettricità per sole due ore al giorno. La guerra quindi, con
tutti i suoi effetti più deleteri, continua a farsi sentire anche a Kiev e anche
dopo l’allontanamento del fronte. MAURO INDELICATO
La battaglia di
Kherson, spiegata.
Mauro Indelicato il
17 febbraio 2023 su Inside Over.
La battaglia
di Kherson ha luogo nell’ambito della guerra russo-ucraina del 2022. Si sviluppa
all’interno e attorno la città di Kherson, capoluogo dell’omonimo oblast e
situata in una zona strategica tra la foce del fiume Dnepr e il Mar Nero. La
battaglia è nota per aver dato ai russi la prima città capoluogo nella loro
avanzata in territorio ucraino. Per gli ucraini, la battaglia risulta importante
per le sorti militari e politiche delle regioni meridionali e della città
di Odessa.
Il contesto della
battaglia di Kherson
L’oblast’ di Kherson
è situato in uno dei punti più nevralgici dell’Ucraina. Qui passa l’estuario del
Dnepr, il quale si getta poi sul Mar Nero. Non solo, ma poco più a sud vi è il
confine con la Crimea. Una linea di frontiera diventata molto calda da quando, a
partire dal 2014, la Russia ha annesso la penisola. Inoltre a ovest di Kherson
sono situate tutte le principali infrastrutture per collegare la Crimea e le
regioni sud orientali dell’Ucraina con Odessa.
L’intera area
risulta quindi strategica sia per i russi che per gli ucraini. Per i primi
appare essenziale prenderla, per i secondi invece è vitale difenderla. Mosca,
nell’avviare le operazioni militari nella regione, punta anche sulla nomina di
città russofona di Kherson. Molti dei suoi trecentomila abitanti infatti parlano
regolarmente il russo e, assieme alle regioni di Odessa e Mykolaiv, l’area di
Kherson è tradizionalmente collocata nella parte russofona dell’Ucraina,
unendosi idealmente con il Donbass e l’est del Paese.
Una circostanza però
che non determina, nel corso delle fasi più delicate della battaglia, un’unanime
accondiscendenza per il passaggio della regione al definitivo controllo russo.
Anzi, proprio la risposta della popolazione alle prime operazioni di Mosca
nell’area risulta in futuro una delle variabili maggiormente sottovalutate dal
Cremlino tanto a Kherson quanto in altre aree dell’Ucraina.
L'inizio della
battaglia
Nella notte del 24
febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo
annuncia il via libera all’operazione militare in Ucraina. La regione di Kherson
è una delle prime a essere bersagliate. Già prima dell’alba vengono segnalate
numerose incursioni aeree e diversi bombardamenti missilistici.
Ma nelle prime ore
del conflitto si registrano anche primi interventi russi con le truppe di terra.
I soldati, in particolare, entrano dalla Crimea e si dirigono subito verso il
Dnepr. Alla fine della prima mattinata di guerra, i soldati di Mosca riescono a
occupare la strategica località di Nova Kachovka. Si tratta di uno snodo
strategico: situata sulle rive del Dnepr, avanzando a est è possibile
raggiungere facilmente Melitopol e quindi la regione di Mariupol, mentre andando
verso ovest si entra nell’hinterland di Kherson.
Così come ammesso
dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la sera del 24 febbraio i
russi sono alle porte di Kherson e le truppe di Kiev stanno cercando di
respingere l’assalto. Epicentro di questa prima fase della battaglia è il ponte
Antonovskiy, struttura che permette di attraversare il Dnepr ed entrare
nell’area urbana di Kherson. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, il ponte è
rivendicato dai russi e Mosca sembra avere gioco facile per entrare
definitivamente nella città contesa.
Tuttavia è proprio
in quest’area che si hanno le prime sorprese. La resistenza dei soldati ucraini
è molto forte e il mattino seguente le truppe di Kiev riprendono in mano la
struttura. Forse è questa la fase più cruenta della battaglia ed è questo il
primo vero episodio di scontro frontale tra le parti nell’arco dell’intero
conflitto. Sul campo restano decine di vittime sia tra gli ucraini che tra i
russi, nonché una distesa di mezzi e carri armati distrutti. Il ponte passa di
mano varie volte tra il 25 e il 26 febbraio. Il sindaco di Kherson, Ihor
Kolykhaiev, annuncia nella sera del 26 che i russi sono costretti a un
ripiegamento per via delle difficoltà incontrate nella periferia sud della
città.
2 marzo 2022:
l'arrivo dei russi
A guidare la
resistenza dell’esercito ucraino è la 59esima brigata motorizzata, contrapposta
dall’altro lato alla 58esima armata combinata russa. Mosca qui schiera anche la
settima divisione d’assalto aereo delle guardie di montagna. Lo scontro continua
a essere duro, ma la svolta si ha il 27 febbraio, quando i russi dichiarano di
aver oltrepassato il Dnepr.
Quello stesso
giorno, da Mosca il ministero della Difesa fa sapere di aver circondato Kherson
e di aver preso l’aeroporto internazionale. Il 28 febbraio anche le autorità
ucraine confermano l’accerchiamento della città. Nei giorni successivi, le
truppe russe avanzano lungo la tangenziale e occupano i principali punti di
accesso verso il centro cittadino.
L’impressione è che
la resistenza ucraina è concentrata soprattutto lungo il Dnepr e nella
periferia. Una volta oltrepassate le difese di Kiev in questi punti, i russi
riescono a dilagare fino a mettere una seria ipoteca sulla presa di Kherson.
E infatti il 2 marzo
le prime avanguardie delle truppe russe vengono avvistate in piazza Svobody, nel
cuore della città. All’interno del centro urbano si sparano pochi colpi. A
differenza di Bucha, Irpin, Mariupol e altre città ucraine di lì a breve
coinvolte nelle battaglie urbane, Kherson non subisce gravi danni e le sue
infrastrutture appaiono integre.
Sui social diversi
cittadini rintanati a casa mostrano il passaggio di truppe russe nelle vie
principali. La sera del 2 marzo è lo stesso sindaco Kolykhaiev ad ammettere la
caduta di Kherson che, in questa maniera, diventa il primo capoluogo di regione
dell’Ucraina a essere in mano russa.
Le manifestazioni
contro la presenza russa
Come detto,
nonostante una presenza importante di russofoni nel territorio di Kherson, la
gente non accoglie con molto favore l’arrivo dei soldati russi. Difficile dire
in che modo è divisa l’opinione pubblica in città. Non ci sono riscontri
ufficiali, né dati plausibili. L’unica cosa certa è che, a livello generale, non
ci sono scene di parate e accoglienze calorose in favore dei soldati russi.
Molte delle
informazioni che dal 2 marzo trapelano da Kherson sono foraggiate dalla
propaganda di entrambe le parti. I russi presentano infatti come un proprio
successo il ritorno a una certa normalità della situazione, mostrando parchi
pieni di cittadini e scuole e uffici nuovamente riaperti. Dall’altro lato però,
gli ucraini sottolineano la costante presenza, soprattutto nelle prime settimane
di occupazione, di manifestanti in piazza. Per Mosca si tratta di una sparuta
minoranza, per Kiev invece del segno della resistenza popolare anti russa.
Le proteste sono
documentate soprattutto sui social. A marzo quasi ogni giorno vanno in scena
manifestazioni di persone che espongono la bandiera ucraina, contrapposta invece
a quella russa issata sugli edifici pubblici e a quella della vittoria nella
seconda guerra mondiale esposta in occasione della festa del 9 maggio. In almeno
un’occasione i manifestanti hanno intonato l’inno ucraino difronte a
schieramenti di truppe russe che, per risposta, hanno invece fatto risuonare in
filodiffusione l’inno russo.
Con il passare delle
settimane il numero delle manifestazioni risulta diminuito. Tuttavia all’interno
di Kherson, così come segnalato dai servizi di intelligence britannici e degli
Stati Uniti, sarebbero attivi gruppi di sabotatori ucraini. Si tratta di cellule
fedeli a Kiev, attivate per colpire membri della nuova amministrazione filo
Mosca o soldati russi stanziati nel territorio occupato. Si ha notizia, da marzo
in poi, di alcuni episodi verosimilmente attuati da sabotatori ucraini. Il più
grave dei quali riguarda l’uccisione, a seguito di un’esplosione avvenuta il 7
settembre, del colonnello russo Atem Bardin.
La nuova
amministrazione pro Mosca
Tra scene di
normalità e manifestazioni pro Kiev, i comandi militari russi si muovono per
dare a Kherson un’amministrazione politicamente legata al Cremlino. Il 18 aprile
da Mosca arriva la designazione di Igor Kastyukevich quale nuovo sindaco della
città, anche se il diretto interessato nega l’incarico ricevuto. Il 22 aprile
invece si insedia quale nuovo governatore Volodymir Saldo, pochi giorni dopo
viene annunciata invece la designazione di Oleksandr Kobets come nuovo sindaco
facente funzioni.
L’obiettivo
principale delle nuove amministrazioni pro Mosca è l’organizzazione di
un referendum in grado di sancire l’annessione di Kherson alla federazione
russa. Per preparare l’intera regione a questa chiamata elettorale, vengono
prese nel frattempo alcune decisioni volte ad agganciare sempre più il destino
di Kherson alla Russia. Da maggio ad esempio circola il Rublo, ossia la moneta
della federazione, che sostituisce la Grivnia ucraina.
Tra maggio e giugno
le utenze telefoniche e la linea internet vengono agganciate alle infrastrutture
russe, così come iniziano a essere rilasciati i passaporti russi. Diversi
cittadini ottengono la cittadinanza della federazione, altro modo per provare a
rendere indelebile il passaggio di Kherson a Mosca.
Il referendum di
Kherson
In un primo momento
si parla di aprile o di maggio come data per tenere un referendum di annessione
alla Russia. Il modello, seppur differente per modalità e per situazioni, non
sarebbe così diverso da quello applicato in Crimea. Ossia far arrivare
direttamente dai cittadini la legittimazione per l’annessione a Mosca.
Il referendum viene
organizzato tra il 23 e il 27 settembre. Kiev non riconosce il voto e lo
considera solo uno strumento pilotato dalla Russia per legittimare
l’occupazione. Anche gran parte della comunità internazionale non dà rilevanza
politica al referendum. Ad ogni modo, il Cremlino il 29 settembre rende nota la
vittoria del Sì all’annessione e, il giorno successivo, è Vladimir Putin ad
annunciare il passaggio di Kherson alla federazione russa assieme alle altre
province dell’Ucraina occupate.
Lo stallo estivo
La battaglia di
Kherson però non termina con la conquista russa della città. Dopo il ritiro
delle proprie forze, Kiev si dice convinta di poter recuperare il territorio. Si
organizza così una più solida linea difensiva a ovest del centro urbano, lungo
la strada per Mykolaiv. Quest’ultima diventa a sua volta un’altra città
strategica, considerata infatti la vera e propria porta verso Odessa. L’esercito
ucraino quindi ha un duplice obiettivo nella regione: impedire l’avanzata dei
russi verso Mykolaiv e iniziare ad allestire il piano per una controffensiva
verso Kherson.
In un primo momento
le forze di Mosca sembrano poter procedere verso Mykolaiv, ma l’avanzata viene
effettivamente bloccata dagli ucraini. Un colpo molto duro per le ambizioni
russe nell’area è inferto il 23 marzo, quando le forze di Kiev lanciano missili
contro l’aeroporto militare di Kherson, distruggendo una grande quantità di
mezzi russi. Mosca quindi è costretta a fermare o comunque ridimensionare le
proprie velleità.
Il fronte rimane in
una fase di stallo per diverse settimane. Ad aprile gli ucraini rivendicano una
prima avanzata verso Kherson. In particolare, il 23 aprile l’esercito di Kiev
annuncia la riconquista di otto località nell’oblast’ di Kherson. Il fronte
viene spostato verso la città occupata, facendolo definitivamente allontanare da
Mykolaiv.
La linea di contatto
tra i due eserciti rimane immobile per tutta l’estate. Sul finire del mese di
agosto, l’esercito ucraino fa sapere di aver messo a punto le strategie per
iniziare una controffensiva. Gli attacchi partono effettivamente i primi giorni
di settembre, ma appaiono concentrati su alcuni specifici obiettivi locali. In
realtà, la vera controffensiva ucraina ha luogo negli stessi giorni lungo il
fronte di Kharkiv, dove Kiev riesce ad avanzare recuperando diverse aree andate
perse tra marzo e aprile. A Kherson invece la situazione al momento è quasi
immutata. Si registrano diversi scontri tra le parti, ma le variazioni
territoriale sono poco significative.
La controffensiva
ucraina
La svolta definitiva
avviene il 4 ottobre. Penetrando dal settore nord occidentale dell’oblast’ di
Kherson, le forze ucraine riescono a sfondare le difese russe. Mosca nella parte
attaccata da Kiev è in evidente inferiorità numerica e le truppe presenti sul
campo possono solo pensare a un’ordinata ritirata. Nel giro di poche ore, gli
ucraini guadagnano terreno e si spingono per diversi chilometri in profondità
costeggiando la riva occidentale del Dnestr. C’è un dettaglio politico non
secondario da considerare nel valutare la nuova avanzata degli uomini agli
ordini di Zelensky: appena quattro giorni prima infatti, al Cremlino si era
svolta la cerimonia di annessione dell’intero oblast’ di Kherson alla Russia,
assieme a quelli di Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk.
Dunque, per la prima
volta le truppe di Kiev si spingono in profondità in un territorio considerato
unilateralmente da Mosca come parte integrante della federazione. A livello
internazionale, l’annessione non viene riconosciuta e dunque le operazioni
ucraine vengono legittimate come parte dei tentativi per recuperare la sovranità
nelle zone occupate.
La prima spinta
ucraina da nord si esaurisce dopo qualche giorno, ma produce significative
avanzate all’interno del distretto di Beryslav. Nel frattempo la pressione
ucraina aumenta anche da ovest, con le truppe che spingono dalla direzione di
Mykolaiv. Mosca intuisce che la difesa della città di Kherson non può durare a
lungo. Con l’avanzata delle forze di Kiev non si hanno infatti grossi scontri,
segno di come dal Cremlino venga messa in conto la possibilità di ordinare un
ritiro definitivo dalla zona evitando battaglie in grado di debilitare
ulteriormente l’esercito russo.
Il 10 novembre, il
ministro della Difesa Sergej Shoigu annuncia da Mosca l’ordine di ritiro da
Kherson. Il giorno dopo, truppe russe vengono avvistate in ponti provvisori
realizzati dall’esercito sul Dnepr. In questo modo, le forze di Mosca presenti
in città oltrepassano il fiume e lasciano il territorio. Il giorno dopo, gli
ucraini entrano in città e Kherson viene considerata ufficialmente nelle mani di
Kiev.
Kherson dopo il
ritiro russo
In città però la
guerra non è finita. Dalla sponda in cui si sono ritirati, i russi lanciano
diversi attacchi con colpi di artiglieria causando ulteriori danni agli edifici
e pericoli per l’incolumità delle persone. Inoltre, anche Kherson è soggetta ai
disagi derivanti dalla distruzione di diverse infrastrutture energetiche causate
dai bombardamenti attuati in quelle settimane in tutta l’Ucraina. Le strade sono
al buio, la distribuzione di luce e acqua è razionata, i cittadini temono di
dover affrontare il grande gelo invernale senza riscaldamenti.
Ad ogni modo, sotto
il profilo prettamente militare, Kherson è saldamente in mano alle forze ucraine
e i russi al di là del fiume non sembrano avere la possibilità di attuare un
contrattacco. MAURO INDELICATO
La battaglia di
Mariupol, spiegata.
Mauro Indelicato il
18 febbraio 2023 su Inside Over.
La battaglia
di Mariupol è inquadrata all’interno del conflitto russo-ucraino scoppiato il 24
febbraio 2022. Ha per teatro la città di Mariupol, importante scalo portuale sul
Mar d’Azov all’interno dell’oblast di Donetsk. I combattimenti vanno avanti dal
primo giorno di guerra fino al 21 maggio, quando Mosca dichiara la città
integralmente nelle proprie mani. Oggi Mariupol è controllata da forze russe e
filorusse.
Il contesto della
battaglia di Mariupol
Quando il 24
febbraio scatta l’operazione russa in Ucraina, si intuisce subito come Mariupol
appaia uno degli obiettivi più importanti per il Cremlino. I motivi sono tanti.
In primo luogo, la città (di quasi mezzo milione di abitanti) si trova
all’interno dell’oblast di Donetsk e dunque in un territorio rivendicato dalla
Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr), l’entità filorussa autoproclamatasi
indipendente dall’Ucraina durante i moti del 2014.
In secondo luogo,
Mariupol è un importante centro portuale situato sul Mar d’Azov. Per Mosca
quindi prendere lo scalo significa dominare l’intero specchio d’acqua a est
della penisola di Crimea. Infine, la città viene storicamente identificata come
“russofona”. Tanto è vero che proprio nel 2014 più volte passa di mano tra
l’esercito ucraino e i combattenti filorussi della Dpr.
In quell’anno, a
seguito delle rivolte di Piazza Maidan a Kiev e dell’insediamento nella capitale
ucraina di un governo filo-occidentale non favorevole al mantenimento del
bilinguismo russo-ucraino nell’est, a Donetsk e Lugansk vanno in scena
contromanifestazioni sfocianti per l’appunto nella creazione delle repubbliche
autoproclamate. Proteste del genere vanno in scena anche a Mariupol, lì dove per
l’appunto il controllo del territorio varia più volte tra esercito regolare e
milizie filorusse.
Alla fine però Kiev
riesce a mantenere la città sotto la propria ala. Questo grazie anche al
supporto di un gruppo di combattenti, provenienti dai settori più estremisti
della destra nazionalista, che inizia a farsi riconoscere con il nome
di “Battaglione Azov”. Dal 2014 in poi il gruppo stanzia la sua sede proprio a
pochi passi da Mariupol. E forse è questo un quarto motivo per cui la Russia
vuole concentrare, nell’operazione iniziata nel febbraio 2022, le sue forze in
questo angolo di Mar d’Azov.
Cos’è il Battaglione
Azov
Negli otto anni che
separano gli eventi del 2014 dalla guerra del 2022, Mariupol appare in continua
mutazione. La città di fatto diventa confine dei possedimenti ucraini del
Donbass, visto che la linea di contatto proclamata con il cessate il fuoco e con
i successivi accordi di Minsk siglati tra il 2014 e il 2015 passa proprio a
pochi passi dalla periferia di Mariupol. Molte famiglie russofone emigrano
altrove, cambiando quindi anche la composizione etnica e linguistica. In poche
parole, la città diventa un bastione di Kiev nell’est del Paese.
L'inizio delle
operazioni russe in Ucraina
Non c’è quindi
sorpresa nel constatare che, a poche ore dal discorso della notte del 24
febbraio 2022 con cui il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera
all’attacco contro Kiev, i primi bombardamenti riguardano proprio Mariupol. Si
ha anche notizia di un possibile sbarco anfibio di unità russe, circostanza però
smentita durante il primo giorno di guerra.
Mosca si muove
comunque in Ucraina sia a nord che a sud. Nelle regioni settentrionali entra
dalla Bielorussia, in quelle meridionali dalla Crimea. Su quest’ultimo fronte,
molte unità sembrano puntare verso Melitopol e verso quindi le coste del Mar
d’Azov. Oltre che per i bombardamenti, i cittadini di Mariupol avvertono di
essere nel mirino delle operazioni militari anche per via dei primi movimenti
delle truppe russe in territorio ucraino.
Le avanzate di Mosca
e dei soldati della Dpr
La mattina del 24
febbraio le truppe del Cremlino entrate dalla Crimea conquistano la cittadina
di Nova Kachova, lungo le sponde del Dnepr. Nel giro di poche ore appare chiaro
come l’intenzione russa sia quella di dilagare dirigendosi verso est. A inizio
marzo i soldati inviati dal Cremlino controllano Melitopol e avanzano
verso Berdyansk, altro porto importante ad appena 30 km da Mariupol.
Contestualmente,
primi movimenti si hanno anche a est e a nord della città portuale. Il leader
della Dpr, Denis Pushilin, il primo marzo rende noto che alcuni reparti
dell’esercito dell’autoproclamata repubblica filorussa avanzano
verso Volnovakha, cittadina a nord di Mariupol. La località, nel giro di pochi
giorni, viene circondata e conquistata. Si tratta di un episodio forse decisivo
per le sorti della battaglia: perdendo Volnovakha, le difese ucraine attorno
Mariupol iniziano a cedere e russi e filorussi possono seriamente pensare di
attaccare il centro urbano, adesso a portata di artiglieria. Per questo la
battaglia di Volnovakha appare molto cruenta: molti cittadini sono costretti a
fuggire, altri sono morti e gran parte delle abitazioni al termine dei
combattimenti sono distrutte.
Intuendo l’imminenza
della battaglia per Mariupol, centinaia di persone provano a scappare. Le strade
però sono blindate. Diverse testimonianze sui social riportano l’impossibilità
di andare via dalla città e il nervosismo soprattutto dei membri del Battaglione
Azov nei posti di blocco organizzati alle porte di Mariupol.
I bombardamenti su
Mariupol
A contribuire
all’aumento della tensione sono i continui raid sulla città. I russi bombardano
per via aerea e con l’avanzata nelle campagne attorno Mariupol anche con
l’artiglieria. Sui social nei primi giorni di marzo si leggono testimonianze
relative a continui bombardamenti, i quali oltre a mettere paura provocano danni
e morti.
E infatti la
situazione umanitaria peggiora rapidamente. Il sindaco di Mariupol, Vadym
Boichenko, denuncia carenze nell’erogazione dei servizi essenziali, il tutto a
causa del danneggiamento di condotte idriche e di impianti di energia elettrica.
Molte famiglie rimangono al buio e senza riscaldamenti, fatto grave considerando
che a inizio marzo le temperature sono ancora rigide e la neve imperversa tra le
strade di Mariupol.
Da Mosca i vertici
della difesa sottolineano di colpire unicamente obiettivi militari. Il 9 marzo
però avviene il primo grave episodio legato ai raid sulla città. In particolare,
viene bombardato e distrutto l’ospedale pediatrico. Secondo le autorità ucraine,
l’esplosione provoca decine di vittime soprattutto tra le donne e i bambini
ricoverati al suo interno. L’episodio ha un volto simbolo, quello di Marianna.
Quest’ultima viene presentata dai video rilanciati dagli ucraini come una donna
in procinto di partorire ferita a seguito del raid. Viene filmata mentre, con il
volto tumefatto, scende le scale aiutata dai soccorritori.
La donna viene data
per morta alcuni giorni dopo. In realtà Marianna, una influencer e blogger prima
della guerra, poi riappare sia nelle tv ucraine che in quelle russe. Per Mosca
la sua storia risulta manipolata da Kiev per fini propagandistici. La difesa
russa sostiene come in realtà l’ospedale preso di mira già da giorni risulta
evacuato e trasformato in una base militare del Battaglione Azov. La stessa
Marianna riappare in un’intervista diffusa da canali filorussi alcuni giorni
dopo e dichiara di aver visto trasformare la struttura in un obiettivo militare.
Di certo la donna, probabilmente oggi rifugiata in un’area controllata dai
separatisti filorussi, rimane invischiata in un gioco propagandistico molto più
grande di lei.
I bombardamenti
intanto proseguono in tutto il territorio di Mariupol. Il 12 marzo viene
centrato dalle bombe il teatro di arte drammatica. Si tratta di una delle
strutture più emblematiche e storiche di Mariupol, in quel momento usato come
rifugio. Per le autorità ucraine quando il teatro viene raggiunto dal raid al
suo interno ci sono almeno mille persone e le vittime potrebbero essere 600. Per
Mosca invece i rifugiati si trovano in un sotterraneo non raggiunto dai crolli.
Anche in questo caso è difficile accertare la verità.
Ad ogni modo,
episodi come quelli narrati denotano una città in preda alla guerra e devastata
già nelle prime settimane di conflitto. Scarseggiano i generi di prima
necessità, gli ospedali non riescono a lavorare a pieno regime, nella gran parte
delle case mancano acqua e riscaldamento, i rifugi sono ricavati in località di
fortuna.
La gente è in preda
al panico e alla disperazione in molti distretti. I primi contatti diretti tra
delegazioni russe e ucraine danno il via libera a corridoi umanitari per
evacuare i civili. Vengono aperte le strade dirette a Zaporizhzhia per far
confluire verso lì i profughi, ma spesso i bus preposti alle evacuazioni sono
costretti a rimanere fermi. Con un successivo rimpallo di responsabilità per il
fallimento di molti dei corridoi organizzati. Kiev accusa Mosca di voler portare
i rifugiati in territorio russo, dal canto suo il Cremlino accusa il Battaglione
Azov di voler usare i civili come scudi umani.
Le prime avanzate
russe in città
Entro la prima
decade di marzo, a seguito delle avanzate russe e filorusse sia a ovest che a
nord di Mariupol, la città portuale risulta assediata. I combattenti ucraini al
suo interno sono lontani e scollegati dal resto dei reparti di Kiev. L’assedio
vero e proprio inizia il 18 marzo, quando le forze di Mosca conquistano
l’aeroporto. Da allora in poi si assiste a un costante avvicinamento delle
truppe russe verso il centro.
Il 23 marzo la
guerra arriva nei distretti centrali di Mariupol e dunque all’interno della
cinta urbana della città. Tanto è vero che in quello stesso giorno il sindaco
Boichenko viene evacuato assieme agli altri membri dell’amministrazione
cittadina. La battaglia urbana per la presa di Mariupol è oramai cominciata.
Le forze schierate
in campo a Mariupol
Sul versante ucraino
combattono diversi reparti dell’esercito regolare, così come gruppi
di volontari e, come detto, una corposa rappresentanza del Battaglione Azov.
Kiev per difendere Mariupol schiera sul campo la 36esima Brigata fanteria di
marina “Contrammiraglio Michajlo Bilyns’kyj”, il 501esimo Battaglione di
Fanteria di Marina, così come reparti della polizia militare. In totale, le
forze armate ucraine dispongo di almeno 3.500 effettivi. A questi si aggiungono
800 combattenti del Battaglione Azov e altri 300 tra volontari e miliziani.
Dall’altro lato, la
Russia invia verso Mariupol almeno 14.000 soldati dell’esercito regolare, tra
forze terrestri, truppe aviotrasportate e membri della guardia nazionale.
Presenti nel contesto della battalia urbana anche membri della compagnia privata
Wagner. A Mariupol a combattere ci sono però anche i ceceni. Il gruppo agli
ordini del leader ceceno Ramzan Kadyrov è presente con decine di unità in città,
le quali appaiono molto motivate e hanno una maggiore abitudine, rispetto alle
forze regolari russe, alla battaglia urbana. I ceceni inoltre sono molto attivi
sui social: specialmente su Telegram, pubblicano quotidianamente immagini e
video dei combattimenti. Infine, a supportare l’azione russa ci sono ovviamente
i soldati dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Le unità presenti
a Mariupol sarebbero 1.500.
I combattimenti in
centro
La prima svolta
nella battaglia urbana si ha il 29 marzo. L’avanzata di russi e filorussi nei
quartieri centrali di Mariupol, determina quel giorno la separazione in
due sacche dei territori ancora in mano ucraina. Le forze di Kiev, già assediate
e impossibilitate a ricevere rifornimenti, adesso faticano a comunicare tra loro
e sono separate dalle avanguardie russe.
Il 2 aprile, con la
conquista da parte di Mosca dell’edificio che ospita la sede dei servizi segreti
ucraini a Mariupol, viene ritenuta conclusa la battaglia nel centro storico.
Prosegue però nelle altre parti della città. I combattimenti sono letteralmente
casa per casa. Spesso sono i ceceni ad assaltare gli edifici più alti, da cui
poter avere il controllo del fuoco nelle vie circostanti. Si va avanti così in
ogni ora del giorno, si combatte anche in piena notte.
Con il centro di
Mariupol ormai in mano russa, le sorti della battaglia appaiono segnate. Il 4
aprile si ha la resa del 501esimo Battaglione di Fanteria Marina, con almeno 267
soldati ucraini che depongono le armi e si consegnano ai russi. Il 7 aprile
inizia l’avanzata russa all’interno del porto. A cadere per prima è l’area dove
sono ormeggiati i pescherecci. Al 10 aprile la situazione è la seguente: circa
l’80% di Mariupol è in mano a Mosca, gli ucraini sono concentrati adesso
all’interno di tre sacche. La prima è quella situata nella zona portuale, c’è
poi quella dove sono presenti i soldati della 36esima brigata di fanteria
marina, guidata dal colonnello Baranyuk, corrispondente all’area dell’acciaieria
Illich. Infine ci sono i combattenti del Battaglione Azov all’interno
dell’acciaieria Azovstal, comandati da Denys Prokopenko.
Nella notte tra l’11
e il 12 aprile, il colonnello Baranyuk prova a rompere l’assedio dell’acciaieria
Illich, il tentativo però viene stroncato dai russi. Molti membri della sua
brigata periscono oppure vengono catturati, altri si arrendono. In pochi
riescono a raggiungere i membri dell’Azov nell’acciaieria Azovstal. Poche ore
dopo più di mille marines della 36esima brigata si arrendono e le truppe russe
possono quindi conquistare la Illich.
A questo punto, le
sacche in mano agli ucraini sono due: quella riguardante l’area portuale e
quella situata nell’acciaieria Azovstal.
21 aprile: Mosca
dichiara caduta Mariupol
Il 13 aprile fonti
della Dpr danno per conquistata l’area commerciale del porto, mentre il 18
aprile l’intero scalo risulta nelle mani russe e filorusse. Il 21 aprile il
ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, incontra al Cremlino il presidente
della federazione russa Vladimir Putin. Nel corso del colloquio il numero uno
della difesa rende conto degli aggiornamenti relativi ai combattimenti a
Mariupol.
Vladimir Putin
dichiara conquistata la città, dando ordine alle truppe di sorvegliare l’area
attorno l’acciaieria Azovstal, ultima sacca controllata dagli ucraini. Il
presidente russo decide quindi di evitare nuovi combattimenti, considerando la
possibilità molto forte di perdere unità all’interno dell’impianto industriale e
tenendo conto di come il resto della città è oramai nelle mani di Mosca. I russi
puntano inoltre sulla difficoltà degli ultimi combattenti ucraini di ricevere
rifornimenti e munizioni.
La resistenza
all'interno dell'acciaieria Azovstal
Tuttavia la mancata
resa delle forze di Kiev relegate e rinchiuse dentro Azovstal non spegne del
tutto la battaglia. All’interno dello stabilimento sono presenti soprattutto i
membri del Battaglione Azov, oltre che i marines della 36esima brigata riusciti
ad uscire dalla Illich. Il loro intento è quello di non consegnarsi alle forze
russe. Dentro l’area industriale sono presenti anche i civili.
Viene invocata a più
riprese una mediazione internazionale per garantire l’evacuazione tanto dei
civili, quanto dei combattenti. Sono pochi i rifornimenti a disposizione, sia in
termini militari che sanitari e alimentari. Si ha notizia di soldati feriti
morti per mancanza di cure e di altri in grave pericolo di vita per lo stesso
motivo.
Per tutto il mese di
maggio vanno avanti importanti contrattazioni tra le parti, mediate soprattutto
da Turchia e Nazioni Unite. L’episodio relativo all’assedio dell’acciaieria
Azovstal è destinato a diventare uno dei più emblematici della guerra in
Ucraina.
La fine della
battaglia di Mariupol
I primi giorni di
maggio non sono contrassegnati soltanto dalle trattative, mediate anche dalle
Nazioni Unite, per l’evacuazione dello stabilimento. Sono segnalate infatti
importanti schermaglie attorno l’area di Azovstal. Probabilmente si tratta di
tentativi russi di mettere pressione sugli ultimi combattenti ucraini, al fine
di accelerarne la resa.
Si ha notizia però
anche delle prime evacuazioni di civili. Diversi gruppi vengono fatti uscire,
con l’ausilio della Croce Rossa internazionale inviata sul posto. All’interno
dell’acciaieria ci sono diversi gruppi di cittadini che qui trovano rifugio già
dai primi giorni di bombardamenti, così come parenti e mogli dei soldati. Alla
fine, così come redatto dai vari report della stessa Croce Rossa e delle
autorità ucraine, gli ultimi civili vengono fatti uscire il 6 maggio.
Da Kiev intanto si
prende atto della situazione considerata oramai compromessa a livello militare.
Il 5 maggio, così come riportato da diverse fonti governative, è lo
stesso presidente Zelensky a dare ordine di resa “qualora le circostanze
dovessero renderla inevitabile”. Tuttavia i vertici del Battaglione Azov
rifiutano qualsiasi ipotesi relativa al deporre le armi.
Le trattative vanno
comunque avanti e il 16 maggio arriva la svolta definitiva che sancisce di fatto
la fine della battaglia di Mariupol. C’è l’ordine da parte dei comandi ucraini
di uscire da Azovstal. Kiev non parla ufficialmente di resa, ma di compimento
della missione da parte dei difensori ucraini “i quali hanno consentito
all’esercito di rafforzarsi e guadagnare tempo”. Per Mosca si tratta invece di
una vera e propria resa.
L’evacuazione inizia
il 16 maggio e termina cinque giorni dopo con l’uscita degli ultimi combattenti
asserragliati dentro l’acciaieria, i quali vengono portati in territori
controllati dalla Dpr. I russi prendono possesso dell’ultima area in mano
ucraina e Mariupol viene considerata interamente conquistata da Mosca.
Difficile
attualmente stabilire una stima delle vittime civili e militari. Considerando la
portata degli scontri e delle distruzioni all’interno di Mariupol, è possibile
azzardare cifre nell’ordine delle migliaia di unità.
Mariupol dopo la
battaglia
Ad oggi, Mariupol
è l’unica vera grande città conquistata da Mosca dopo il 24 febbraio 2022.
Kherson, altra grande città e unico capoluogo di regione preso dalle truppe del
Cremlino, è tornata sotto il controllo di Kiev nel mese di novembre. Sono
diversi i video dei media russi che mostrano la situazione a Mariupol dopo la
battaglia. Lì dove ci sono le macerie del teatro bombardato il 12 marzo, è stato
innalzato un telo raffigurante la vecchia facciata. Forse a indicare un prossimo
restauro di uno dei simboli del Donbass.
In altri video si
nota la costruzione di nuovi e moderni palazzi residenziali lungo l’autostrada
che collega l’aeroporto con il centro. Mostrate anche alcune scuole riaperte ed
altri edifici pubblici resi agibili. Si tratta tuttavia di immagini girate da
media vicini a Mosca. Chi, tra le poche testate indipendenti, è riuscito a
raggiungere Mariupol è stato in grado di confermare una parte della
ricostruzione già avviata. Ma, al tempo stesso, ha descritto la situazione come
molto critica.
Il centro storico è
ancora un cumulo di macerie, più della metà degli edifici dell’intero perimetro
urbano non sono agibili e abitabili. Mancano inoltre molti servizi, mentre per
rifornirsi d’acqua i cittadini sono ancora costretti a mettersi in fila in
alcuni distributori oppure davanti i presidi creati dalle autorità locali. Le
funzioni amministrative sono demandate ad organismi locali nominati da Mosca. Le
autorità ucraine che hanno governato Mariupol fino ad aprile, sono oggi in
esilio nei territori controllati da Kiev.
Il 23 gennaio è
stata segnalata su diversi canali Telegram una forte esplosione non lontano dal
centro di Mariupol. Secondo i media filo ucraini, si sarebbe trattato di un atto
di sabotaggio. A testimonianza di come, anche dopo la battaglia, alcune cellule
di sabotatori sarebbero attive nella regione. MAURO INDELICATO
La storia della
battaglia di Kharkiv.
Mauro Indelicato il
18 febbraio 2023 su Inside Over.
La battaglia
di Kharkiv ha avuto come obiettivo la conquista della seconda città ucraina da
parte dell’esercito russo, nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina
scoppiata il 24 febbraio 2022. I combattimenti hanno coinvolto la città già
nelle prime ore di guerra e sono andati avanti per diversi mesi. La battaglia
viene considerata conclusa solo con il contrattacco ucraino sferrato nel
settembre 2022, con il quale i russi sono costretti al ritiro verso i propri
confini.
L'importanza
politica di Kharkiv per i russi
Kharkiv nella storia
viene attraversata da diverse battaglie. L’ultima, prima della crisi del 2022,
riguarda la battaglia che porta il nome di Kharkiv-Izyum combattuta durante
la Seconda guerra mondiale, con l’esercito sovietico che riesce a contrapporsi a
quello nazista. Anche per questo la città viene vista dai russi come tra le più
importanti a livello storico e culturale.
La sua posizione la
pone poi in un nodo strategico, tanto a livello militare quanto forse
soprattutto a livello politico. Situata infatti ad appena 100 km dal confine con
la regione russa di Belgorod, Kharkiv ha al suo interno un’importante minoranza
russofona. Tanto che nel 2014, quando a seguito della rivoluzione di Maidan a
Kiev si insedia un governo filo occidentale, il suo territorio sembra destinato
a seguire gli oblast di Lugansk e Donetsk nella rivolta organizzata da
secessionisti filorussi.
In quell’anno
Kharkiv vive momenti di forte tensione, tuttavia la città rimane in mano ucraina
e non si ha la prevalenza di gruppi separatisti anti Kiev. Ad ogni modo, quando
da Mosca si preparano i piani per un attacco contro l’Ucraina nel 2022, Kharkiv
sembra rappresentare una delle priorità degli alti comandi russi. Proprio in
virtù della vicinanza al confine e della popolazione russofona al suo interno, i
vertici del Cremlino sperano di vedere una flebile resistenza ucraina e poter
avanzare subito verso il centro cittadino.
I primi tentativi di
avanzata russa
Quando alle 3:51 del
24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin annuncia, durante un
discorso alla nazione, l’inizio di quella che viene chiamata “operazione
militare speciale”, Kharkiv è tra le prime città a essere raggiunta
dai bombardamenti. La popolazione viene svegliata dal rumore delle esplosioni
provocate da raid che, nelle prime ore, prendono di mira soprattutto obiettivi
militari situati in periferia.
All’alba nel
territorio della regione di Kharkiv entrano i primi carri armati
russi provenienti da Belgorod e ammassati a ridosso del confine già da diverse
settimane. Mosca sembra puntare a una veloce avanzata almeno alle porte di
Kharkiv. Si hanno infatti notizie di mezzi inviati dal Cremlino in prossimità
della periferia nord e della periferia est al mattino del 24 febbraio.
Gli ucraini nella
zona non sono colti di sorpresa, ma i comandi generali a Kiev sono alle prese
con una situazione generale molto problematica dovendo fronteggiare un attacco
su più fronti da parte russa. Viene però dato l’ordine, nonostante una veloce
prima avanzata delle forze di Mosca, di non cedere la città e di preservarla. Se
per il Cremlino prendere Kharkiv è importante a livello politico e strategico, è
altrettanto vitale per Kiev evitare di perdere la seconda città ucraina e la
prima capitale della vecchia Repubblica Socialista ucraina.
Tra i principali
reparti ucraini in città c’è senza dubbio la 92esima Brigata meccanizzata,
comandata da Pavlo Fedosenko. È lui a organizzare le prime linee di difesa a
ridosso del centro urbano di Kharkiv. Gli ucraini riescono, nella giornata di
sabato 26 febbraio, a ingaggiare importanti combattimenti nel villaggio
di Tsyrkuny. Si tratta probabilmente della prima vera battaglia difensiva delle
forze di Kiev nella regione di Kharkiv. I cronisti del New York Times arrivati
nell’area descrivono scene di devastazione: si notano diverse vittime da
entrambe le parti, così come mezzi corazzati distrutti e molti crateri sul
terreno. Segno quindi di una battaglia molto aspra.
La giornata decisiva
per questa prima fase della guerra è quella di domenica 27 febbraio. I russi
spingono da nord e iniziano a spingere anche da ovest, provando ad aggirare le
difese ucraine lungo la strada che attraversa i boschi in prossimità della
località di Pisochyn. Il comandante della 92esima brigata intercetta però i
mezzi corazzati russi, arrestando parzialmente l’avanzata.
La doppia spinta
delle forze di Mosca permette comunque ai primi reparti russi di entrare a
Kharkiv. Per l’intera giornata si susseguono notizie contraddittorie: da un lato
fonti russe che danno per imminente la caduta della città, dall’altra però fonti
ucraine che, oltre a invocare alla resistenza da parte di militari e civili,
sostengono di avere ancora in mano il controllo del territorio.
Nemmeno i cittadini
hanno contezza della situazione, specialmente quelli residenti a ridosso dei
quartieri coinvolti dalla battaglia. Sui social spuntano video girati dagli
abitanti asserragliati in casa, in cui si notano scontri strada per strada tra
russi e ucraini in alcune zone della periferia. Immagini che testimoniano un
primo serio tentativo di Mosca di sconfiggere nel giro di poche ore ogni
resistenza. Sembra il preludio alla capitolazione delle forze ucraine locale.
In serata però
arriva il dietrofront: da Kiev danno per ufficiale il respingimento dei russi
lungo gli assi difensivi di Kharkiv. Il governatore della regione, Oleh
Synyehubov, dichiara il 27 sera che la città è interamente in mano ucraina e che
i russi penetrati nel territorio urbano sono da considerarsi respinti.
Circostanza confermata il giorno successivo dal sindaco, Ihor Terekhov.
Tra raid e battaglie
urbane
L’esercito ucraino
riesce quindi a respingere le prime incursioni russe in centro, Kharkiv però non
è risparmiata dalla guerra. Al contrario, per superare le difese di Kiev le
forze di Mosca iniziano a bersagliare in modo molto pesante la città. Nei primi
giorni è la periferia a essere colpita, a marzo invece anche il centro non è
risparmiato.
La dimostrazione è
data dal bombardamento subito dal palazzo che ospita la sede delle istituzioni
regionali, nel cuore di Kharkiv. L’edificio il primo marzo viene colpito da un
missile, la deflagrazione lo danneggia pesantemente e causa anche diversi feriti
tra i civili. L’episodio diventa il simbolo di questa prima parte della
battaglia per la seconda città ucraina, da subito considerata la più colpita
dall’inizio della guerra.
I raid si susseguono
giorno dopo giorno. I russi usano l’aviazione, così come i missili a media
gittata e l’artiglieria nelle zone più vicine alla linea del fronte oramai
consolidata poco più a nord dell’area urbana. In migliaia scappano in zone
ritenute più sicure. Vengono organizzati treni e autobus per permettere alla
popolazione di raggiungere Kiev e le regioni occidentali del Paese. Si calcola
che almeno mezzo milione, sul milione e mezzo di abitanti dichiarati prima del
conflitto, scappano da Kharkiv per le conseguenze della battaglia. Quasi un
abitante su tre va via, lasciandosi dietro macerie e ansie per il futuro.
Chi rimane ogni
notte è costretto a convivere con i rumori delle sirene antiaeree che risuonano
costantemente. L’amministrazione comunale introduce più volte il coprifuoco sia
come misura di sicurezza per i cittadini che come misura per coprire gli
spostamenti notturni dell’esercito. I servizi essenziali sono erogati in modo
discontinuo, anche se la popolazione non patisce comunque la penuria di cibo e
acqua.
Sul campo i russi
avanzano nelle campagne a nord di Kharkiv, lungo le linee di frontiera. Così
come iniziano a marzo a guadagnare terreno nella regione meridionale dell’oblast
di Kharkiv, puntando su Izyum, vera e propria porta del Donbass e dunque
obiettivo strategico vitale per il Cremlino.
Lo stallo a Kharkiv
nel mese di aprile
Se nella regione
circostante i russi controllano i confini e avanzano nelle aree a ridosso di
Izyum e del fiume Siversky Donetsk, nell’area urbana di Kharkiv invece si
assiste a un vero e proprio stallo. Le forze di Mosca non riescono a sfondare,
nonostante l’uso massiccio dell’artiglieria e nonostante i costanti
bombardamenti, le linee difensive ucraine.
Si crea una linea di
fronte stabile e sostanzialmente immobile per tutto il mese di aprile, con i
russi alle porte di Kharkiv impossibilitati però ad avanzare verso il centro. Lo
stallo fa venire meno anche una delle prime convinzioni politiche di Mosca. E
cioè che la popolazione russofona della città viene incontro ai russi
facilitandone l’avanzata. Al contrario, i cittadini di Kharkiv vedono nei raid e
nelle azioni delle truppe di Mosca degli atti ostili che porta loro a supportare
la difesa ucraina. Peraltro l’amministrazione cittadina è retta da una giunta
che, pur avendo avuto in passato legami con il Partito delle Regioni, la
formazione dell’ultimo presidente filorusso Viktor Yanukovich, dal 2014 in poi
prende le distanze dal Cremlino evitando l’instaurarsi di repubbliche
separatiste come nel Donbass.
Uno scenario
politico quindi strettamente connesso a quello militare: Kharkiv mantiene una
posizione legata al governo di Kiev e dalla capitale ucraina giungono continui
input affinché la città non cada in mano alla Russia.
Maggio 2022: la
prima controffensiva ucraina
La situazione di
stallo a nord di Kharkiv termina nei primi giorni di maggio. Gli ucraini infatti
iniziano a contrattaccare e a guadagnare diverse posizioni. L’avanzata ha luogo
il primo maggio e per i successivi 12 giorni le forze di Kiev rivendicano la
riconquista di alcune importanti località, spingendosi in alcuni tratti anche a
ridosso del confine russo.
A muoversi ancora
una volta è la 92esima brigata meccanizzata, aiutata dalla 93esima. A confermare
il successo del contrattacco ucraino sono i servizi segreti di Usa e Regno
Unito. I russi dal canto loro sembrano preferire una
progressiva ritirata ordinata, rimanendo in possesso solo di una zona cuscinetto
importante per proteggere il confine.
Kiev dà il via
libera alla controffensiva forse confortata dalle notizie passate
dall’intelligence alleata, a partire da Washington e Londra. I servizi, in
particolare, notano una certa debolezza russa nel quadrante attorno l’area
urbana di Kharkiv. Una debolezza dovuta principalmente allo sforzo di Mosca
attuato nell’area meridionale dell’oblast di Kharkiv, lì dove i russi a fine
aprile conquistano Izyum e iniziano ad avanzare verso le aree di Lugansk e
Donetsk. In qualche modo il Cremlino sembra accettare l’idea, una volta iniziato
il contrattacco ucraino, di indietreggiare rispetto all’area urbana di Kharkiv.
L’azione ucraina si
arresta intorno al 13 maggio, dopo aver permesso alle truppe di Kiev di
riprendere in proprio possesso l’hinterland di Kharkiv e aver fatto
indietreggiare verso il confine i soldati russi. Al termine del contrattacco, la
seconda città ucraina non può più considerarsi “contesa” ma definitivamente in
mano a Kiev. Inoltre il centro non è più a portata di artiglieria russa, con
quindi un sostanziale alleggerimento della pressione bellica anche sugli stessi
cittadini di Kharkiv. C’è però da sottolineare come i bombardamenti missilistici
continuano a non dare tregua.
La seconda
controffensiva ucraina attorno Kharkiv
Per tutta l’estate
non si assiste a significative variazioni lungo la nuova linea del fronte
imposta dalla controffensiva di maggio. Una nuova svolta si ha però nel secondo
fine settimana di settembre. Kiev infatti dà il via libera a un nuovo
contrattacco, il cui obiettivo questa volta è la riconquista dell’intera area a
nord e a est di Kharkiv.
La seconda
controffensiva attorno alla seconda città ucraina è figlia in realtà dell’azione
ordinata dagli alti comandi militari di Kiev nella regione meridionale
dell’oblast’ di Kharkiv. Qui, tra l’8 e il 12 settembre in poche ore gli ucraini
riprendono tutti i territori persi a vantaggio dei russi tra aprile e maggio. Le
truppe ucraine entrano infatti a Izyum e in tutte le altre città a ovest del
fiume Oskil, costringendo le forze di Mosca a una frettolosa ritirata verso est.
Forti del successo
del contrattacco a sud di Kharkiv, domenica 11 settembre i soldati agli ordini
del presidente Zelensky si muovono verso le posizioni russe a nord della città.
In poche ore l’intero territorio posto tra il confine con la federazione russa e
il fronte a ridosso di Kharkiv risulta tornato in mano ucraina.
La città non solo,
come dopo la prima controffensiva di maggio, non ha più forze russe vicino
l’area urbana, ma adesso assiste all’indietreggiamento di Mosca da tutta la
regione a sé circostante. Secondo molti analisti, in questo modo può dirsi
conclusa la battaglia di Kharkiv iniziata il 24 febbraio 2022.
I bombardamenti
russi di fine anno colpiscono anche Kharkiv
Come a Kiev e
a Kherson, altre città da dove i russi si sono ritirati oppure, come nel caso
della capitale ucraina, in cui hanno dovuto rinunciare all’attacco, anche a
Kharkiv sul finire del 2022 vengono registrati numerosi bombardamenti. Centrali
elettriche ed infrastrutture energetiche sono costantemente prese di mira, con
le autorità costrette a razionare l’erogazione di energia.
Kharkiv è costretta
così a patire un inverno rigido affrontato senza riscaldamenti e con gravi
disagi per i propri cittadini. La città non sente più i rumori dell’artiglieria,
essendo i russi oramai lontani. Tuttavia subisce gli effetti del conflitto
tramite bombardamenti e carenze di servizi basilari. La situazione al suo
interno viene descritta come molto critica.
Ad ogni modo, sotto
il profilo strettamente militare, il suo territorio è saldamente in mano
ucraina con l’esercito di Kiev che ne mantiene il controllo. Questo nonostante,
all’inizio del conflitto, nei piani di Mosca la presenza di una solida minoranza
russofona doveva garantire appoggio alle operazioni del Cremlino. In realtà,
anche alla luce degli esiti della battaglia, la popolazione di Kharkiv sembra
aver scelto di rimanere vicina alle istituzioni ucraine.
MAURO INDELICATO
“Così la Nato
uccide l’Europa”
il 20 Febbraio 2023 su Inside Over.
Dopo esser entrato
nel Kgb, Vladimir Putin passò cinque anni di servizio a Dresda, nella Repubblica
democratica tedesca. Qui ebbe accesso a numerosi documenti (il suo era infatti
un lavoro di “desk”), riguardanti sia la politica occidentale che quella
dell’Urss.
In un’intervista
concessa alla Bild, il presidente russo ha mostrato un documento inedito che
riporta un colloquio del 1990 tra dirigenti sovietici (Mikhail Gorbachev e
Valentin Mikhaylovich) e politici tedeschi (Hekmut Kohl ed Egon Bahr) in cui
viene delineato il futuro politico dell’Europa.
Quello portato da
Putin è un documento interessante perché dimostra come, all’inizio degli anni
Novanta, si stava pensando alla creazione di un’Europa indipendente – se
vogliamo equidistante – sia dalla Nato che dall’Urss. Bahr in quel colloquio
disse: “Se con la riunificazione della Germania, non si faranno passi risolutivi
sulla divisione dell’Europa in aree di interesse, lo sviluppo degli eventi può
portare l’Urss ad un isolamento internazionale”.
In pratica, come
spiega Putin, Bahr stava parlando “della necessità di formare al centro
dell’Europa una nuova Unione che non si sarebbe dovuta avvicinare alla Nato. (…)
Un’Unione separata con la partecipazione sia degli Usa che dell’Urss”.
Prosegue Bahr: “La
Nato come organizzazione, soprattutto nella sua componente militare, non deve
ampliarsi militarmente nell’Europa centrale”. Ed era questa – sottolinea Putin
nell’intervista – la chiave per porre fine alla Guerra fredda. Non solo, sembra
dire Putin: attualizzando il pensiero di Bahr si eviteranno contrasti tra Russia
e Nato anche in futuro.Non a caso il conflitto tra Federazione Russa e Nato si è
inasprito con la questione ucraina o, più recentemente, con il tentativo di
portare il Montenegro nella Nato. Giustamente Sergio Romano ha scritto
sul Corriere della Sera: “Invece di rinnovare le sue finalità, la Nato è
diventata il braccio militare degli Stati Uniti […] e si è allargata sino a
includere fra i suoi soci gli Stati che appartenevano al patto di Varsavia, tre
repubbliche ex-sovietiche, due repubbliche ex jugoslave”. Una provocazione
chiara. Ma per pensare a una pace efficace e duratura tra Russia e Occidente è
necessario un ripensamento della politica della Nato.
The post “Così la
Nato uccide l’Europa” appeared first on InsideOver.
A un anno
dall’invasione. La nostra colpa peggiore sta in tutto quello che non abbiamo
voluto imparare.
Francesco Cundari su L’Inchiesta il 21 Febbraio 2023.
Dal 24 febbraio in
poi, anche l’osservatore più distratto ha avuto tutte le controprove possibili:
su chi diceva la verità e chi mentiva, su chi era l’aggressore e chi
l’aggredito, su chi torturava e uccideva civili innocenti e chi tentava di
difenderli. E su chi negava sistematicamente l’evidenza
Con l’avvicinarsi
del primo anniversario dell’invasione russa, giustamente, in molti hanno
cominciato a rilanciare sui social network le infelici previsioni pronunciate un
anno fa, alla vigilia dell’attacco, da tanti autorevoli analisti, politologi e
geopolitologi. È sempre istruttivo riascoltare o rileggere il superiore
disprezzo con cui si liquidavano le «fake news» americane circa un inesistente
piano d’invasione russa dell’Ucraina, l’incrollabile assertività con cui si
garantiva che in ogni caso gli Stati Uniti non ne avrebbero mai preso le difese,
il tono oracolare con cui si tracciavano futuri scenari in cui Vladimir Putin
non si sarebbe nemmeno sognato di spostare un carrarmato ed era semmai la Nato a
provocare, accerchiare, assediare la pacifica Russia.
Rileggere e
riascoltare tutto questo è sempre istruttivo, certo, ma non decisivo. A ben
vedere, non ci dice nulla – dei nostri esperti, dei nostri giornalisti e in
fondo dell’Italia – che non sapessimo già.
Più significativo mi
pare quello che è accaduto dopo. Fino al 24 febbraio, infatti, almeno per chi
esperto non era e non aveva mai pensato di doverlo diventare, era più che lecito
non conoscere la genesi e tutti i dettagli degli accordi di Minsk o del
conflitto nel Donbas, avere un’idea vaga dello stesso regime di Putin e magari
anche prenderne per buoni alcuni argomenti: dalla lotta al terrorismo islamico,
con cui si erano coperte fino a quel momento molte delle peggiori atrocità
commesse in patria e all’estero, fino alla necessità di ricostruire un Paese
uscito a pezzi dalla crisi dell’Unione sovietica.
Certo, c’era già
stata l’occupazione della Crimea nel 2014. Ma fino a quel momento poteva
apparire ragionevole anche una certa diffidenza nei confronti del ruolo giocato
dagli Stati Uniti e dall’occidente in generale nei rapporti con la Russia,
considerando la piega che avevano preso gli eventi ai tempi di Boris Eltsin,
rispetto ai quali la leadership di Putin poteva anche apparire come un passo
avanti, come il tentativo di ristabilire un principio di ordine, dinanzi allo
spettacolo di un Paese in cui i cittadini comuni erano ridotti alla fame e
piccoli gruppi di affaristi spuntati dal nulla si trasformavano in
multimiliardari spartendosi le ricchezze nazionali.
Non faccio l’elenco
completo di tutti gli argomenti della propaganda putiniana perché ormai li
sappiamo tutti a memoria. Il punto è che, per le ragioni qui sommariamente
ricordate, fino al 24 febbraio la situazione poteva anche presentarsi, perlomeno
agli occhi di un osservatore distratto, come un dilemma. Ma non dopo.
Dal 24 febbraio in
poi, anche il meno esperto e il più disattento degli osservatori ha avuto la
controprova, ha avuto tutte le controprove che potesse desiderare: su chi diceva
la verità e chi diceva il falso, su chi era l’aggressore e chi l’aggredito, su
chi torturava, stuprava e faceva strage di civili innocenti e chi tentava solo
di difendersi. E su chi, puntualmente, tentava di negare o mettere in dubbio
ciascuna di quelle tragedie, che sarebbero poi state ampiamente documentate da
centinaia di riprese via telefonino e via satellite, da intercettazioni
telefoniche e da documenti di ogni genere, nonché dalle dirette testimonianze di
giornalisti indipendenti provenienti da ogni parte del mondo.
A chiamare in causa
la coscienza di ciascuno di noi non è solo la classica domanda: come abbiamo
fatto a non accorgerci prima di quanto stava per accadere? Il peggio è che, dopo
aver visto e avere saputo e avere avuto la prova e la dimostrazione di tutto,
abbiamo continuato a fingere di non vedere e di non capire.
Abbiamo continuato a
intervistare gli stessi esperti del giorno prima, senza mai chiedere conto dei
fatti del giorno dopo, delle loro previsioni completamente sballate e delle loro
analisi distorte, lasciando anzi che continuassero implacabilmente a sbagliarle
tutte, e sempre ovviamente nella stessa direzione: così la Russia che fino al 24
febbraio mai e poi mai avrebbe invaso l’Ucraina dal 25 avrebbe vinto in due
settimane al massimo, e così via. E più analisi, previsioni e commenti
apparivano clamorosamente smentiti dalla realtà, più insistevamo, e ancora
insistiamo, a non prenderne atto e a non chiederne conto a nessuno.
Piuttosto
continuiamo a presentare la questione avvolta in una nebbia di considerazioni
politiche e geopolitiche che sono un misto di vere e proprie falsità costruite
dalla propaganda russa e affermazioni di banale buon senso che potevano reggere
prima del 24 febbraio. Ma dal 24 febbraio 2022 è passato un anno. Un anno in cui
abbiamo potuto osservare in diretta, minuto per minuto, l’invasione e il
tentativo di soggiogare un intero Paese. Un anno in cui a Bucha e in gran parte
delle città liberate dalla controffensiva ucraina abbiamo visto le fosse comuni,
le camere di tortura e tutte le atrocità commesse contro la popolazione civile.
Di cosa ancora dobbiamo discutere?
La nostra colpa più
grave sta in quello che non abbiamo voluto imparare. Sta in quello che ci
ostiniamo a non volere imparare. Se ci mettessimo a rileggere e riascoltare una
a una analisi e previsioni di quest’anno, ci sarebbe ampia materia per un severo
esame di coscienza.
Un anno di una
guerra che non avrà vincitori.
Stefano Piazza su Panorama il 24 Febbraio 2023. Colloquio con Maurizio Boni,
Generale di Corpo d’Armata, Leonardo Tricarico, Generale di Squadra Aerea e
Giorgio Battisti Generale di Corpo d’Armata sullo stato della battaglia sul
campo
La Russia ha invaso
l'Ucraina il 24 febbraio 2022, in quella che definisce «una operazione militare
speciale per denazificare il paese e proteggere i russofoni». In realtà sappiamo
che non è stato altro che un accaparramento di terre dove sono stati commesse
indicibili atrocità e crimini di guerra. L'ufficio per i diritti umani delle
Nazioni Unite ha dichiarato lunedì di aver registrato 7.199 morti civili e
11.756 feriti dall'invasione russa del 24 febbraio, principalmente a causa di
bombardamenti, attacchi missilistici e aerei. Tuttavia, si ritiene come scrive
la Reuters che la cifra effettiva sia molto più alta. Morti
Almeno 42’295
persone Ferite non mortali Almeno 56’756 persone Dispersi Almeno 15’000 persone
Profughi Circa 14 Mln persone Edifici distrutti Almeno 140’000 Danni materiali
Circa 350 Mrd USD Nella sola giornata di sabato 11 febbraio, riporta il
ministero della Difesa ucraino su Twitter, la Russia ha perso 900 uomini, mentre
dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio 2022 sono morti in Ucraina circa
137.780 soldati russi. Ne parliamo con: Leonardo Tricarico è un generale di
Squadra Aerea che ha ricoperto nella sua lunga carriera, anche l'incarico di
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare italiana. Maurizio Boni è un
Generale di Corpo d’Armata. Nella sua carriera molte le missioni all’estero tra
le quali è stato Capo di Stato Maggiore del NATO Rapid Deployable Corps
(Italia). Giorgio Battisti Generale di Corpo d’Armata. Ha partecipato alle
operazioni in Somalia (1993), in Bosnia (1997) e in Afghanistan.
In un anno di
guerra in Ucraina il mondo è peggiorato, compreso ciascuno di noi.
Andrea Soglio su Panorama il 24 Febbraio 2023
Un anno fa la Russia
invadeva l'Ucraina portando la guerra in Europa. Oggi ci siamo dimenticati dei
morti e litighiamo come dei tifosi di calcio
È passato
esattamente un anno dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. Non è un
caso che abbiamo usato il termine «invasione» e non guerra; perché non dobbiamo
mai dimenticare che la mattina del 24 febbraio 2022 (data che resterà di certo
nei libri di storia) un paese ha deciso di invadere un’altra nazione, a lui
confinante, cercando di conquistarlo con la forza delle bombe, dei carri armati,
dei missili a lungo raggio e dei soldati. Anzi, non è stato un paese, ma un
uomo, Vladimir Putin, a volere l’invasione dell’Ucraina. Ma oggi non è il
momento di pensare a colpevoli ed innocenti, a chi ha ragione e chi invece
torto. Oggi per prima cosa dobbiamo pensare che in un anno le vittime di questa
follia sono state circa mezzo milione. Su questo Kiev e Mosca non hanno mai
rilasciato comunicazioni ufficiali perché sanno che fare il conteggio dei morti
è la cosa più dolorosa in assoluto. Di questo ci si vergogna. In realtà ogni
giorno il ministero della difesa di Kiev pubblica l’elenco degli aerei
abbattuti, dei carri armati distrutti, dei droni eliminati dall’antiaerea. E
anche il presunto numero di soldati russi uccisi; ad oggi siamo a quota 146
mila. E lo stesso per logica dovrebbe essere accaduto dall’altra parte della
barricata. Poi ci sono i civili. Una strage, in Europa. Purtroppo la seconda
considerazione è che il tempo, questi 12 mesi, ci hanno anestetizzato. Ci siamo
abituati ai video dei missili sulle case, alle scuole ed agli ospedali distrutti
dai bombardamenti, ai corpi per strada. Abbiamo capito ad esempio che il
massacro immotivato di civili a Bucha è stato un crimine contro l’umanità dopo
averla negata o raccontata come propaganda di Kiev, e nessuno ha battuto ciglio.
Nessuno ha detto: «Scusate, ci eravamo sbagliati». Siamo anestetizzati,
assuefatti. Oggi vorremmo che la guerra finisse non solo per far cessare il
dolore ma anche per far tornare la benzina ai prezzi di un anno fa, far calare
l’inflazione e far crescere l’economia, che dopo la pandemia aveva nel 2022
l’anno della grande rivincita. E ci nascondiamo dietro una parola bellissima,
Pace. Parola che è stata utilizzata come scudo e per certi versi persino
«violentata», Ci sono persone, opinionisti, politici, gente comune, convinti,
anzi certi, che ci sia qualcuno davvero contento di fare la guerra; qualcuno a
cui la morte ed il dolore piace. Su tutti il Presidente Usa, Biden, ovviamente
lo stesso dicasi per Putin ma anche Giorgia Meloni. Ci sono persone ed
opinionisti che da 12 mesi raccontano che «bisogna aprire un tavolo per la
Pace», ed è fatta. Come se fosse un invito a cena, o ad un matrimonio. Ci sono
persone per cui dietro la parola Pace in realtà si nasconde il termine «resa».
D’altronde l’Ucraina è lontana e se invece del loro governo democraticamente
eletto arriva un regime straniero a comandare, chissenefrega. Sono fatti loro.
Ci sono poi quelli che alla parola Pace aggiungono un aggettivo: «giusta».
Capite bene come uscirne sia praticamente impossibile. Abbiamo accennato al
nostro Presidente del Consiglio cui va dato il merito in questi 6 mesi di
governo di aver rispettato la parola e la posizione presentata agli italiani in
campagna elettorale ed in continuità con l’esecutivo precedente.
Atlantista e pro
Zelensky fu Mario Draghi, atlantista e pro Ucraina è anche la leader di Fratelli
d’Italia. E tutto questo malgrado qualche alleato della maggioranza non faccia
più mistero della propria opinione, sempre più lontana da quella di Palazzo
Chigi. Giorgia Meloni magari un giorno cambierà idea, ma questo succederà se e
solo se sarà la Nato e l’Europa intera a farlo. Altrimenti la strada è segnata e
non si torna indietro perché l’Italia non può più rimangiarsi la parola data al
mondo. Nell’avvicinarsi dell’anniversario dell’invasione russa abbiamo letto e
sentito il parere di numerosi generali e militari che ci raccontano del fango,
il pantano, un simbolo di questa guerra. I due eserciti faticano ad avanzare
bloccati dalla melma dei campi di grano il cui ghiaccio si sta sciogliendo.
Tutto fermo, tutti in trincea sul campo di battaglia come nella diplomazia.
Abbiamo sentito negli ultimi giorni una sequela di frasi fatte e già ripetute
mille volte dai principali leader del mondo, buone solo per la propaganda di una
o dell’altra parte. Ormai è chiaro che si tratta di una guerra mondiale, anzi,
di un problema mondiale. A fianco della Russia si è schierato da mesi l’Iran
(altro regime che nel 2022 ha vissuto uno dei suoi anni più bui con la protesta
delle donne e le decine di giovani ragazze uccise per un velo non indossato) e
forse, lo sostiene la Cia, anche la Cina (che dall’altra parte del globo ha il
problema Taiwan da risolvere, magari seguendo proprio la strategia usata dal
Cremlino con l’Ucraina). Dall’altra c’è l’occidente che però sembra avere il
fittone e che soprattutto si è accorto di essere «minoranza» in un mondo dove le
democrazie sono sovrastate per numero de regimi e monarchie varie. È passato un
anno e di sicuro il mondo è molto peggiore di quanto fosse 12 mesi fa. Mentre
noi, impegnati a fare il tifo come allo stadio contro Putin o contro Zelensky ci
dimentichiamo che anche domani poco meno di duemila persone moriranno.
Ucraina, un anno
di guerra, lo speciale della «Gazzetta»: «Luce su una tragedia che non deve
lasciare indifferenti».
Analisi, punti di
vista e storie nel tentativo di aiutare il lettore a capire meglio uno scenario
che ci riguarda ogni giorno di più. OSCAR IARUSSI su La Gazzetta del Mezzogiorno
il 24 Febbraio 2023
Un abbraccio, anzi
l'abbraccio. Un militare ucraino si accomiata dalla madre nello straordinario
scatto del fotoreporter barese Lorenzo Turi, datato aprile 2022. Siamo nel
villaggio di Ukrainka, oblast' di Mykolaïv-Nicolaev (in omaggio a San Nicola),
non lontano da Cherson invasa dall'esercito russo la mattina del 24 febbraio
2022, giusto un anno fa. Cherson sorge sulla riva destra dell'estuario del
Dnepr, a una trentina di chilometri dal Mar Nero. Dopo oltre otto mesi di
occupazione, il 12 novembre 2022 è stata liberata dalla controffensiva ucraina,
però continua tutt'oggi a essere bombardata. I testimoni la descrivono come una
città fantasma: contava circa trecentomila abitanti (più o meno quanto Bari),
adesso ne saranno rimasti forse trentamila ad aggirarsi fra le rovine. Sono due
"fantasmi" anche il soldato e la mamma che si stringono. Non vediamo i loro
volti ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa immagine: corpi, carne,
sangue, calore, pensieri, paure, sentimenti, parole sussurrate... Ma non abbiamo
il diritto di violare il riserbo di persone che hanno già perso tutto. Vero è
che il presidente ucraino Zelensky, da ex attore qual è, ha fatto
dell'esibizione ossessiva di sé e del suo popolo un'arma mediatica importante
presso l'opinione pubblica mondiale, tuttavia a chi è in guerra è concesso quel
che lo "spet-tatore" non dovrebbe permettersi. Invece nel corso dell'ultimo anno
abbiamo spesso peccato di impudicizia televisiva "davanti al dolore degli
altri", per dirla con un titolo della grande scrittrice Susan Sontag.
Il conflitto
parrebbe a una terribile svolta, si allarga lo scenario dei nemici e altri
fantasmi si sono palesati o si stagliano all'orizzonte: da un lato la
determinazione statunitense che profitta dell'impotenza europea e del tramonto
della terzietà dell'ONU, dall'altro il possibile ruolo della Cina "dietro" la
sagoma neo-zarista di Putin. In questo "speciale" della Gazzetta proponiamo
analisi, punti di vista e storie nel tentativo di aiutare il Lettore a capire
meglio una tragedia che ci riguarda ogni giorno di più, a dispetto
dell'indifferenza crescente. Si dice Ucraina, ma parliamo anche del Mediterraneo
e quindi di casa nostra. Siamo d'accordo con i governi Draghi e Meloni: è giusto
schierarsi dalla parte degli invasi e degli oppressi, è legittimo armarne la
resistenza come gli alleati angloamericani armarono i partigiani italiani contro
il nazifascismo. D'altro canto, è altrettanto doveroso cercare una via per la
Pace, forse il sentiero nascosto che si addice alla diplomazia, fino a
raggiungere quel soldato e quella madre. Fino a ritrovarne l'abbraccio, se sono
ancora vivi.
Un anno di bugie.
La disinformazione della Russia contro l’Ucraina (e quelli che ci cascano).
Olga Tokariuk su L’Inkiesta il 24 Febbraio 2023
La fake news del
Cremlino nei prossimi mesi continueranno ad alimentare la narrazione dell’alto
costo del sostegno a Kyjiv e della stanchezza psicologica nei confronti del
conflitto. Ma non è detto che saranno efficaci
Uno dei luoghi
comuni preferiti del Cremlino per anni, l’affermazione che l’Ucraina è “piena di
nazisti”, è stata una delle motivazioni addotte da Vladimir Putin per la sua
“operazione militare speciale” del 24 febbraio dello scorso anno. La necessità
di “denazificare l’Ucraina” si è poi estesa ad altri obiettivi nel suo discorso
ufficiale, ma questa narrazione, presente nella propaganda di Mosca almeno
dall’invasione russa del Donbas e dall’annessione della Crimea nel 2014, ha
trovato il favore del popolo russo. Gran parte della popolazione russa sostiene
ancora la guerra e la continua propaganda disumanizzante sull’Ucraina ha
giustificato e permesso l’attuale genocidio.
La manciata di media
indipendenti russi rimasti è stata costretta all’esilio e per loro è una lotta
continua per superare la macchina della propaganda del Cremlino, che rimane la
fonte primaria di informazione per la maggior parte dei russi. Sebbene i media
indipendenti in esilio cerchino di riportare in modo più o meno oggettivo ciò
che accade in guerra, rimangono dubbi sull’uso talvolta compassionevole del loro
linguaggio nei confronti dei soldati russi, come dimostrato di recente dalla
controversia che ha visto Rain TV privata della sua licenza dalle autorità
lettoni.
Il fallimento del
Cremlino nel convincere gli ucraini
In Ucraina, la
resistenza alla propaganda e alla disinformazione russa, sviluppata dal 2014, ha
aiutato il Paese a evitare il caos informativo nel 2022. Le stazioni televisive
filorusse sono state tolte dalla circolazione non appena è iniziata l’invasione
e la maratona televisiva United, lanciata da alcune delle più importanti
emittenti nei primi giorni di guerra, ha fatto sì che gli ucraini avessero
informazioni affidabili 24 ore su 24 da parte di presentatori televisivi ed
emittenti che conoscevano e di cui si fidavano. Questa iniziativa ha inoltre
contribuito a contrastare le informazioni non verificate e i post dannosi sui
social media da parte dei tirapiedi del Cremlino nella fase iniziale della
guerra. Fake news che avrebbero potuto scatenare il panico e ostacolare la
capacità di resistere alla avanzata iniziale della Russia.
Con il proseguire
della guerra, sono sorti interrogativi sull’opportunità di mantenere la maratona
televisiva, sempre più giudicata come troppo filogovernativa e fonte solo di
buone notizie. Tuttavia i media ucraini, che hanno affrontato sfide
significative nel 2022 (secondo l’Istituto per l’informazione di massa, più di
200 punti vendita sono stati costretti a chiudere a causa della bancarotta o
dell’occupazione russa), rimangono diversi e vivaci. C’è spazio per il dibattito
e i giornalisti ucraini non solo hanno raccontato la guerra e denunciato i
crimini di guerra russi, ma hanno anche portato alla luce esempi di corruzione
ucraina.
Le operazioni di
disinformazione della Russia in Ucraina dopo l’invasione sono in gran parte
fallite. Molti ucraini che un tempo simpatizzavano con la Russia hanno cambiato
opinione dopo aver assistito e sperimentato le atrocità dell’esercito russo, e i
russofoni sono passati alla lingua ucraina nella loro vita quotidiana, spinti
dal desiderio di tagliare tutti i legami con tutto ciò che è russo.
La disinformazione
russa inciampa in Occidente
La Russia non è
riuscita finora a convincere le popolazioni e i governi occidentali della
necessità dell’invasione, né a minare la loro unità nel sostenere l’Ucraina. Al
contrario, il sostegno dell’opinione pubblica occidentale è rimasto notevolmente
solido tra aprile e gennaio di quest’anno, esprimendo una diffusa disponibilità
a sopportare l’aumento dei prezzi dell’energia a causa dell’aggressione russa.
Secondo un sondaggio di Ipsos su 28 Paesi «la piena maggioranza della
popolazione di Stati Uniti, Canada, Regno, Francia, Paesi Bassi e Polonia
sostiene la fornitura di armi e/o sistemi di difesa aerea alle forze armate
ucraine da parte del loro Paese».
Il sostegno militare
dell’Occidente all’Ucraina è in costante aumento dal febbraio 2022 e la
posizione ufficiale è che continuerà «finché sarà necessario», come ha
sottolineato il presidente Joe Biden durante la sua visita a Kyjiv il 20
febbraio. I tentativi russi di negare i propri crimini di guerra a Bucha e
altrove, così come i successi delle controffensive militari ucraine, hanno solo
rafforzato questa determinazione.
Alcune narrazioni
distorte, tuttavia, hanno avuto risonanza presso alcuni politici e parti
dell’opinione pubblica occidentale. In Italia, ad esempio, il sostegno pubblico
all’invio di armi all’Ucraina sta diminuendo, dopo mesi di retorica da parte dei
partiti della coalizione del governo Meloni, in particolare Matteo Salvini e
Silvio Berlusconi, politici noti per gli stretti legami prebellici con il
Cremlino, nonché del Movimento 5 Stelle all’opposizione e degli opinionisti
filorussi nei media. La Russia cercherà di sfruttare queste divisioni per minare
l’unità dell’Unione europea e della NATO in Ucraina.
La Russia ha
utilizzato altre narrazioni in Occidente e continuerà a farlo nel 2023. Per
esempio, evidenziare il costo economico del sostegno all’Ucraina per i
contribuenti occidentali; screditare il governo e i vertici militari ucraini
facendoli passare come corrotti, avidi e ingrati; fomentare il risentimento per
i rifugiati ucraini nei Paesi che ne hanno ospitato la maggior parte (Polonia,
Germania, ecc.); incoraggiare la stanchezza psicologica verso la guerra e la
stanchezza morale nel sostenere l’Ucraina.
La Russia trova
sostegno nel mondo non occidentale
Nei Paesi del Sud
globale, tra cui India, Brasile e alcuni Stati africani, così come la Turchia,
membro della NATO, le operazioni di disinformazione russa hanno avuto un
parziale successo. In molti di questi luoghi i canali di propaganda russi, come
RT e Sputnik, non sono stati limitati, a differenza di quanto avviene in
Occidente, e i funzionari russi e i loro sostenitori hanno accesso incontrastato
ai media locali.
La Russia sfrutta i
sentimenti anti-occidentali e anti-imperialisti dei Paesi in via di sviluppo,
dipingendosi come “vittima della NATO” e come alternativa all’Occidente
imperialista (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, ecc.) e promuovendo relazioni
diplomatiche e commerciali di reciproco vantaggio, un argomento importante per
molti Paesi in via di sviluppo che devono affrontare sfide economiche e
provvedere al sostentamento delle loro popolazioni in crescita. Alla Russia,
questo serve a presentare sé stessa come parte della comunità globale, come un
Paese che non è isolato ma ha ancora amici sulla scena mondiale.
Nel Sud globale, la
Russia manipola anche la narrazione del presunto razzismo degli ucraini e degli
occidentali. Ad esempio, sfrutta le tensioni per il trattamento più favorevole
riservato ai rifugiati ucraini rispetto a quelli provenienti da Africa, Medio
Oriente o America Latina.
Quale sarà il
prossimo passo?
Con l’inizio del
secondo anno della guerra russa contro l’Ucraina, è prevedibile che le campagne
di disinformazione e influenza del Cremlino si intensifichino. Molto
probabilmente saranno più sofisticate e più sfumate, mirando al pubblico di
specifici Paesi ritenuti più suscettibili.
L’obiettivo primario
è quello di minare l’unità dell’Occidente e la sua solidarietà con l’Ucraina,
concentrandosi sull’interruzione del sostegno militare. In altre parti del
mondo, gli sforzi di disinformazione del Cremlino saranno finalizzati a favorire
la ricerca di alleati che aiutino la Russia a consolidare la reputazione
internazionale di potenza forte, inserita nella comunità internazionale
nonostante la guerra all’Ucraina.
Per quanto riguarda
gli argomenti di queste campagne di disinformazione, dobbiamo aspettarci
maggiori sforzi per screditare il governo, le forze armate e la società civile
ucraina. Ci si concentrerà sempre di più sull’alto costo percepito del sostegno
all’Ucraina, sullo sfruttamento della stanchezza della guerra e sul dissenso per
i rifugiati ucraini all’estero.
Articolo pubblicato
in inglese su Center for European Policy Analysis
Tra le palazzine
a fuoco. No, noi ucraini non ci abitueremo mai alla guerra (e speriamo ci sia
solo un anniversario).
Yaryna Grusha
Possamai su L’Inkiesta il 24 Febbraio 2023
A un anno dalla
sciagurata invasione della Russia nessun ucraino sta facendo quello che voleva
fare nella vita. Ognuno porta i segni del conflitto, quelli visibili e quelli
nascosti
La parola
“anniversario” gira, pesa, logora da ormai due settimane. Qualcuno accanto a lei
aggiunge “il primo”. Ognuno ha il suo motivo per farlo, dico solo che è molto
doloroso da sentire quel numero ordinale che sembra che imponga qualche
continuazione.
Tutti noi ricordiamo
che cosa abbiamo fatto il 24 Febbraio 2022, ma tutti noi ricordiamo bene anche
che cosa abbiamo fatto il giorno prima, l’ultimo giorno di quella vita che non
ci sarebbe stata mai più. Io sono andata a scegliere nuovi occhiali da vista e
le lenti a contatto. La mia vista era peggiorata e l’occhio destro aveva ormai
bisogno della lente astigmatica. L’ottico mi ha chiesto perché volevo così male
al mio occhio destro e ho pensato alle truppe russe ammassate da settimane al
confine con l’Ucraina. Negli ultimi giorni, mentre l’occhio destro mi sabotava,
con i miei genitori abbiamo pensato a un piano B: loro avevano tutti i miei
documenti scannerizzati, avevano la macchina pronta con il pieno, le taniche con
la benzina di scorta, una valigetta con il necessario. Eppure credevo che vivere
vicino alla capitale li avrebbe salvati in qualche modo, perché sembrava davvero
impossibile l’idea che la Russia tentasse di prendere Kyjiv, una città enorme,
una capitale europea, che ti fa perdere mezza giornata solo per arrivare da una
parte all’altra.
Il tempo spensierato
di quella vita è scaduto alle cinque del mattino del 24 febbraio. Da quell’ora
lì abbiamo fatto quello che ognuno di noi si sentiva di fare, senza tornare mai
a fare e a essere quelli che eravamo il giorno prima. Non mi ricordo nemmeno
come ho ritirato gli occhiali nuovi e le lenti a contatto nuove. So di non
averlo visto per un anno il mio ottico perché le lenti me le spedisce per posta
e così è stato con tante altre persone. Però mi ricordo benissimo i messaggi
disperati: «Mamma, mamma, mamma», quando la linea è caduta, anzi quando la
connessione è stata interrotta dai soldati russi entrati nella loro regione. Il
nostro piano B era fallito. Mi ricordo benissimo la prima volta in cui i miei
genitori si sono fatti vivi. Mi ricordo benissimo le lacrime della mia migliore
amica che lasciava la casa di Kyjiv all’inizio di marzo, la casa che aveva
appena comprato e appena restaurato. Mi ricordo benissimo le notti senza sonno a
scriversi con l’altra amica che stava nascosta nel seminterrato di casa nei
pressi della capitale, mentre il fidanzato era in giro per la città per aiutare
le forze di difesa locale. Mi ricordo di Tanya e del suo figlio Matvij che ho
ospitato a casa mia a marzo. Mi ricordo le bandiere ucraine in piazza a Milano.
Mi ricordo di aver imparato a prendere gli ansiolitici e i sonniferi. Mi ricordo
di aver ricevuto aiuto e sostegno da chi avevo appena conosciuto e di non aver
ricevuto affatto da chi conoscevo da anni. Mi ricordo di essere tornata in
Ucraina in estate. Mi ricordo di lavorare tanto e di scrivere tanto. E così da
365 giorni.
No, nessun ucraino
si è abituato e si abituerà mai alla guerra a un anno dal suo inizio su vasta
scala. No, nessun ucraino sta facendo quello che voleva fare nella vita, né gli
sfollati ucraini lontani dalle loro case, case anche distrutte e rase al suolo
insieme con la vita bombardata che giace a pezzi per terra. No, nessun ucraino
si è abituato e si abituerà a perdere e a seppellire le persone care, le persone
che come tutti noi non hanno scelto questa vita. No, nessun ucraino si sentirà
mai a casa in un posto, anche accogliente, ma che non ha scelto per viverci.
Nessuno di noi ha scelto questa vita, nessuno l’ha mai voluta o cercata, ma
ormai è questa.
Sarà per sempre come
camminare con una gamba rotta che farà male per il maltempo, che tradirà su
qualche salita o una semplice scala fatta di quattro gradini. Un intero popolo
con le gambe rotte, braccia mancate, facce lese. Ognuno porta i segni della
guerra, quelli visibili e quelli non tanto, quelli nascosti dentro, dietro la
facciata di un corpo che porta il peso delle ferite interne, delle memorie che
non si potranno mai cancellare né facilmente condividere. I ricordi che sono
compressi in un anno, come se una vita vissuta dagli altri e non da quelle
persone che eravamo il 23 Febbraio 2022. Un anno marcato con il numero ordinale
“primo”, con la speranza che il secondo non dovrà mai arrivare.
La lezione di
Kyjiv. L’invasione russa in Ucraina ha segnato il ritorno della guerra
industriale.
Michelangelo Freyrie su L’Inkiesta il 24 Febbraio 2023
Dopo un anno di
scontri la resistenza ucraina e i fallimenti russi dimostrano che tenere riserve
di munizioni sufficienti per conflitti prolungati è un’importante forma di
assicurazione che hanno le nazioni del mondo libero per possibili escalation
militari di potenze ostili
Il mondo non è
cambiato il 24 febbraio 2022. La guerra ci ha per lo più rivelato dei fatti
politici dei quali avremmo dovuto essere consapevoli ben prima dell’invasione
russa, ma che per convenienza o miopia abbiamo invece deciso di ignorare. Il 24
febbraio, i nodi che speravamo non sarebbero mai venuti al pettine si sono
manifestati. La mancata democratizzazione della Federazione Russa, la debolezza
dell’Unione europea come garante di sicurezza, una dipendenza eccessiva dalle
energie fossili e il dilagare del nazionalismo sono i tarli che hanno indebolito
l’impalcatura dell’ordine europeo, schiantatosi un anno fa sotto il peso delle
sue stesse contraddizioni ancor prima che dei carri armati russi. Ricostruire i
fattori strutturali che stanno animando lo scontro è necessario per provare a
trarre degli insegnamenti dalla guerra e contenerne i contraccolpi.
Basta pensare alla
dimensione militare: la lotta per l’Ucraina rappresenta il culmine di una serie
di cambiamenti affiorati nel corso dei decenni. La digitalizzazione dei sistemi
d’arma, l’affermazione di attori privati sul campo di battaglia (che si tratti
di Elon Musk con i satelliti Starlink o Evgenij Prigozhin con i mercenari
Wagner) e il ruolo cruciale dei media e dell’informazione in tempo reale sono
elementi rilevanti fin dai tempi dell’operazione Desert Storm. Che lo siano
ancora oggi non deve sorprendere: le guerre sono plasmate dalle società che le
combattono, e la maniera con cui russi e ucraini si stanno battono è la
manifestazione di come sono organizzate le società contemporanee.
Non bisogna credere
che la violenza sia il motore della storia per vedere nelle scelte strategiche
(e nei sacrifici compiuti dalle truppe) modelli di società a cui corrispondono
precise coordinate morali e politiche. Il Cremlino sta combattendo un conflitto
coloniale, con l’intenzione di cancellare il proprio vicino. Lo sta facendo con
tutta la potenza e i limiti di una dittatura con tratti tecnocratici e una
profonda frammentazione gerarchica. L’Ucraina si sta difendendo costi quel che
costi, partendo da una posizione di inferiorità nella quale si deve
improvvisare. Oggi Kyiv può ricorrere all’arsenale del mondo libero, la cui
solidarietà è vincolata a un continuo scrutinio su come le armi sono
effettivamente utilizzate.
Questi approcci sono
due facce della stessa medaglia, ovvero la necessità di adeguare le regole della
guerra e della pace a un mondo profondamente cambiato dalla fine della Guerra
Fredda. Anche per questo è possibile considerare questo conflitto come un triste
palco sul quale stanno andando in scena, sulla pelle degli ucraini, le novità
degli ultimi trent’anni.
Il ritorno della
guerra industriale
In una prospettiva
puramente militare, il 2022 ha segnato un ritorno della guerra di massa, dove
“massa” va intesa sia in senso di quantità materiale, sia come sinonimo di
pubblico. Il numero di persone mobilitate dal conflitto non ha precedenti in
Europa dalla Seconda guerra mondiale (no, nemmeno le guerre in Jugoslavia), e lo
stesso vale per il numero di sistemi d’arma impiegati sul campo.
Le perdite umane
subite da entrambe le parti sono da capogiro: nei primi nove mesi di guerra, i
russi avrebbero perso più di centomila soldati fra morti e feriti, una città
delle dimensioni di Terni spazzata via in dieci mesi. É la conferma di tendenze
già emerse nella guerra in Nagorno-Karabakh e altrove: i combattimenti sono
diventati molto più intensi e letali. I soldati sono oggi costretti in campi di
battaglia molto più “angusti”: la gittata di missili, droni e munizioni
circuitanti accorcia sensibilmente le distanze fra posizioni avverse, rendendo
più “profonda” e pericolosa la linea del fronte. Ciò rende fondamentale gli
investimenti nella cosiddetta protezione delle forze, ovvero in sistemi
antimissile, in difesa aerea ravvicinata e altri sistemi per mitigare queste
minacce.
Meno tragica ma
altrettanto importante è l’emorragia di equipaggiamento, veicoli, munizioni,
aerei, blindati, fucili, cannoni, missili, droni e navi persi in dodici mesi. Si
tratta dell’equivalente di anni di produzione industriale, insostituibile in
tempi brevi. Le forze armate Nato hanno per anni scommesso che la superiorità
tecnologica data da sensori, armi digitalizzate e sistemi automatizzati
avrebbero potuto sopperire alla mancanza di massa nelle nostre forze armate:
meglio pochi assetti altamente letali (e costosi) piuttosto che una massa poco
sofisticata. Questo ragionamento si è visto ad esempio nel campo aeronautico,
dove i costi dei velivoli sono aumentati a dismisura per accomodare innovazioni
sempre più avanzate.
Tecnologie più
accessibili
La guerra in Ucraina
ha ribaltato il paradigma: la guerra tecnologica in realtà ha “democratizzato”
la violenza, rendendo accessibile anche a milizie e Paesi più piccoli capacità
che una volta erano accessibili solo agli stati ricchi. Un approccio “aperto”
all’innovazione della difesa ha reso possibile adattare gli strumenti militari
alle lezioni del conflitto nel giro di poche settimane, non anni o decenni.
Basti pensare ai soldati russi, che spesso utilizzano droni acquistati su
internet dalla Cina, o l’artiglieria ucraina, che usa una app simile a Uber per
creare un ciclo di acquisizione del bersaglio, attacco e correzione del tiro da
far invidia ai sistemi occidentali più avanzati. Il risultato è un peculiare mix
di alta e bassa tecnologia. La battaglia per la cittadina di Bakhmut
nell’inverno del 2022 è istruttiva: da un lato si hanno assalti alle trincee,
baionette alla mano come se fosse l’Isonzo o la Somme nel 1916; dall’altro, si
ha il ricorso a satelliti e droni kamikaze.
Questa prospettiva è
fondamentale anche se si considera la questione degli stock di armamenti. La
guerra in Ucraina dimostra che tenere riserve di munizioni sufficienti per
conflitti prolungati è un’importante forma di assicurazione. La resistenza
ucraina e i fallimenti russi dimostrano che è inverosimile che una guerra su
larga scala verrebbe risolta nelle prime settimane (una conclusione a cui erano
invece giunti diversi analisti in simulazioni di conflitti con la Russia),
rendendo necessario creare sufficienti risorse per sostenere uno scontro
prolungato.
Se, come è lecito
sperare, i Paesi europei non andranno mai in guerra per propria scelta, allora è
verosimile che essi non avranno il lusso di decidere come combattere il prossimo
scontro. Visto che lo stoccaggio di veicoli e equipaggiamento è estremamente
costoso, va anche capito se e come far sì che l’industria della difesa possa far
partire “a freddo” le catene di montaggio, cioè raggiungere in tempi brevi
grossi volumi di munizioni e armi senza incorrere in spese folli in tempi di
pace.
Deterrenza e
coesione sociale
Questi sono fattori
importanti non solo perché fungono da assicurazione in caso di guerra, ma anche
perché rappresentano una forma di deterrenza nei confronti di potenze ostili.
Dimostrare di poter difendersi per tempi prolungati, soprattutto per una
comunità di Stati che giustamente esclude un uso preventivo delle armi nucleari,
è un importante strumento per scoraggiare escalation.
Ma i mezzi per
resistere sono inutili se manca la determinazione per farlo. Al di là della
facile retorica, è piuttosto evidente che il Cremlino pensasse che l’Occidente
non sarebbe stato disposto a pagare il prezzo di un supporto prolungato
all’Ucraina. Il costo delle sanzioni, del caro-energia e delle spese militari in
crescita dimostrano una profonda interconnessione tra politica estera e sfera
domestica, e le operazioni di influenza russe hanno sempre teso a sfruttare e
aggravare un dibattito pubblico polarizzato per minare la fermezza dei governi,
soprattutto europei, nel confronto politico con Mosca.
Ciò richiede un
cambio di marcia da parte dei governi europei, e soprattutto quello italiano. La
forza russa si nutre infatti della debolezza e delle contraddizioni delle nostre
società. Le diseguaglianze sociali possono essere sfruttate per infiacchire la
fiducia nelle istituzioni; l’analfabetismo funzionale è terreno di coltura per
la disinformazione; una democrazia debole è più vulnerabile agli sbandamenti
demagogici. In questo contesto, la tradizionale lontananza delle istituzioni di
esteri e difesa dal dibattito pubblico lascia spazi informativi non presidiati,
nei quali chi commercia in propaganda e falsità può prosperare.
Guerra, anno 2
È impossibile
prevedere cosa avverrà in questo secondo anno di guerra. Tuttavia, ci sono già
oggi alcuni punti che possiamo analizzare partendo dagli elementi qui fissati.
Prima di tutto,
bisogna essere onesti sul rischio di una potenziale escalation del conflitto,
anche con l’impiego di armi nucleari. Ad oggi, la probabilità che ciò avvenga è
bassissimo, e l’uso dell’atomica e andrebbe contro ogni logica militare e
politica. Sarebbe tuttavia un errore liquidare le preoccupazioni del pubblico,
senza spiegare il perché di questa ragionevole certezza. La dottrina russa (e la
logica militare) suggeriscono, ad esempio, che prima di rompere il tabù nucleare
Mosca potrebbe compiere atti di intimidazione, ad esempio attraverso il
sabotaggio di infrastrutture Nato in Polonia o con attacchi ai rifornimenti per
l’Ucraina. Sarebbero comunque eventi gravi, ma che fornirebbero sufficiente
spazio di manovra per evitare l’impensabile. Allo stato attuale, non ci troviamo
a “pochi centimetri dalla catastrofe”, ma parecchie decine di metri. È un
pensiero poco rassicurante, ma sicuramente consolatorio rispetto all’alternativa
atomica.
L’altra cosa che
sembra chiara è che nulla, ad oggi, indica un prossimo collasso della
Federazione Russa o l’intenzione da parte di Putin di trovare un compromesso.
Stiamo assistendo a una sorta di ristrutturazione autocratica del regime, che ha
adottato lo sforzo bellico come principale raison d’étre dell’economia e dello
stato russo. Per quanto ciò ne limiti la capacità di fare la guerra, ciò non
porterà alla fine del regno putiniano (detto questo, va ricordata la citazione
di un grande cremlinologo degli anni 80: “In Russia, le cose sono sempre sul
punto di andare estremamente bene o estremamente male”).
La spesa militare
italiana
In ragione di
questo, non è realistico pensare che le spese militari possano rimanere su
livelli di pace. Il 24 febbraio il mondo non è cambiato; tuttavia, oggi siamo
molto più consapevoli di quanto poco esso fosse sicuro anche prima dello scoppio
della guerra. Per la lentezza del procurement militare, le decisioni di bilancio
prese oggi inizieranno ad avere un impatto fra cinque o dieci anni, quando la
situazione globale potrebbe essere ulteriormente deteriorata. Il principio di
precauzione ci impone quindi un investimento adeguato nella difesa, facendo di
tutto affinché essa sia sostenibile. Una stima del think tank IISS del 2019
sostiene che per difendere il continente, gli stati europei dovrebbero spendere
fra i 264 e i 328 miliardi di euro in più, una stima conservatrice se si
considera lo svuotamento dei magazzini a beneficio degli ucraini. Le forze
armate italiane invece lamentano un buco di quasi 4,5 miliardi per i prossimi
tre anni. Per questo, a livello europeo l’integrazione dell’industria della
difesa e una migliore distribuzione dei costi deve essere la priorità numero 1.
Per un Paese come l’Italia la questione è particolarmente urgente: oltre
all’impegno sul fianco est della Nato, Roma non può non mantenere una capacità
di intervento nel Mediterraneo.
È evidente che serve
coordinamento europeo per colmare questo enorme divario senza sacrificare altri
capitoli di spesa. Un taglio alle spese sociali sarebbe drammaticamente
controproduttivo per i motivi di cui sopra: una società debole è una società
vulnerabile. È imperativo che diventiamo quella che i tedeschi chiamano una
“wehrhafte Demokratie”, una democrazia capace di proteggersi e di decidere
autonomamente e senza paura il proprio destino.
Tre domande per
l’Italia
Per far ciò servirà
tuttavia un dibattito sociale e politico più maturo e sofisticato sui temi della
politica internazionale. L’Italia deve urgentemente rispondere a tre domande,
senza cadere nel solito, rassicurante provincialismo. Che ruolo vuole avere Roma
nell’ordine europeo? Rimpiangere la nostalgia per Draghi o lagnarsi per inviti a
cena non pervenuti da Parigi non sono risposte valide. Che strategia globale
deve perseguire il Paese per completare la transizione energetica e emanciparsi
dai diktat di stati autoritari? Nota bene, limitarsi al namedropping di vecchie
glorie come Mattei non vale. E come possiamo sostenere l’alleato ucraino senza
perdere di vista le esigenze strategiche italiane? Tanto per essere chiari: si
parla qui di stabilità dell’area Euro-Mediterranea, non della serenità degli
spettatori di Sanremo.
Diario di
un’ucraina. La guerra dei russi ci ha reso sporchi, grigi e malconci, ma
aspettiamo ostinati la vittoria.
Olena Stiazhkina su
L’Inkiesta il 22 Febbraio 2023
La scrittrice in
passato era sfollata dal Donbas, ma stavolta non ha lasciato Kyjiv e se ora le
chiedono «come stai, mobiletto?» invece di offendersi a morte risponde «reggo»
In una Makariv
liberata dagli occupanti ci sono tante case distrutte. Sulla soglia di una di
queste case c’è un cane. È di razza alabai. È grigio, sporco, malconcio,
affamato. Prende il cibo e l’acqua dai volontari. Si lascia accarezzare. Però
non segue nessuno. Non si schioda dal suo posto. Guarda negli occhi della gente
che passa. Guarda oltre quelli che si avvicinano. Aspetta i suoi. Aspetta
ostinato. Forse i suoi non ci sono più. Forse aspetta invano, o forse non è poi
così invano. Lui mangia, lui beve. Solo che non segue nessuno. Lui crede che
tutti quelli a cui vuole bene torneranno. Prima o poi. I volontari lo chiamano
“il nostro Hachi”.
Oggi sono tornati i
nostri vicini di pianerottolo. Li sentiamo oltre la parete. Sembra che quella
parete tra di noi non ci sia neanche. Le nostre orecchie hanno imparato i nuovi
suoni dal cielo ancora prima dell’arrivo delle sirene. Che cosa vuoi che sia
allora quella parete?
Oggi il confine con
la Polonia lo hanno attraversato 24mila persone. Stanno tornando a casa. Loro
qua sono molto attesi, anche se non c’è più nessuno ad aspettarli.
Mi sembra che tutti
noi siamo degli “Hachi”. Nelle città distrutte e desolate siamo sporchi, grigi e
malconci e aspettiamo ostinati il senso della nostra vita. Stiamo aspettando i
nostri soldati, i vicini di casa, gli amici. Stiamo aspettando la vittoria e non
ci schiodiamo da questo posto anche se sarà difficile e lunga. Solo che al posto
del cibo e dell’acqua a noi servono armi.
Lo chiamo l’infuso
concentrato della tragedia. Si tratta di un corpo ucraino, che sa già dove fa
male, poiché fa male ovunque. Sentiamo ogni movimento delle auto bucate dalle
pallottole nei corridoi umanitari russi, il tricolore russo disegnato sui
cartelli all’ingresso in città, le fosse comuni sui territori occupati che si
vedono sulle foto dei satelliti. Il collo non si muove, gli occhi sono secchi,
le orecchie non sentono, la schiena non si piega…
Ed è proprio sulla
schiena, che non vuole piegarsi, che sono scritti tutti i nomi e i toponimi.
Sono tatuati sulla schiena che non vuole piegarsi. Su quella schiena che non
vuole piegarsi ci sono la rabbia, la furia, il dolore e le armi. Oltre quella
schiena c’è l’infuso della tragedia. Se farai un movimento, i cristalli
tradiranno la loro fragilità. Le lacrime scioglieranno tutto, le orecchie
sentiranno tutto, il collo riacquisterà la propria forza. Ma la schiena non
vuole piegarsi.
L’infuso concentrato
della tragedia sarà sul nostro tavolo ancora per tanto tempo, come lo scudo e la
spada.
Nel dizionario
internazionale ci sono delle novità: il lemma “russo” ora significherà la stessa
cosa che “nazista”. La parola “Ucraina” però potrebbe essere rivista come una
versione nuova della storia di Davide o Golia. Per via dell’Ucraina questa
parabola non sembrerà più così esagerata.
Da allora il nostro
incubo più grande e senza fine sono le torture, inflitte ai bambini davanti ai
nostri occhi. Non sono stati i russi a inventarle, ma sono stati loro a
perfezionarle: bambini stuprati con i denti tolti, le unghie strappate, le
braccia e le gambe spezzate. I bambini ammazzati sono il loro marchio di
qualità, per il quale l’intero battaglione riceve le onorificenze militari.
Ogni volta che
incontri un russo devi tenere in mente che lui, suo figlio, sua figlia, il suo
parente, il suo vicino, il suo collega – tutti loro, insieme o separatamente —
tortureranno i bambini. La questione di un russo che abita in Europa non cambia
niente.
Come fare allora? Il
piano d’azione c’è. Anzi sono due. E tutti e due sono imperfetti. Il primo
consiste nel non avere i russi da nessuna parte. Il secondo nell’avere le armi.
Nelle condizioni di necessità un’arma puntata contro un russo potrebbe salvare
dal non essere torturati a morte.
Mettere in atto il
primo piano è difficile, per via dell’indifferenza dell’anima del mondo moderno.
È difficile convincere gli europei non stuprati che i loro figli saranno i
prossimi. La difficoltà del secondo piano sta nel distribuire le armi tra i
bambini per dar loro la possibilità di morire in fretta ed evitare le torture.
Tutti i territori
occupati sono campi di concentramento. Tutte le persone che ci si sono trovate
dentro sono condannate. Oggi, domani o dopodomani. Sono condannate.
Anche nella
tranquillità apparente di Donets’k e Kherson, rimangono tranquille solo le case
ancora non distrutte, che verranno comunque distrutte alla prima necessità.
Le persone sono vive
solo perché non è stato ancora dato un ordine di ammazzarle o c’è ancora bisogno
di tenerle in vita. Le donne non sono state stuprate non perché non sono uscite
in strada, ma perché gli animali non sono entrati nelle loro case. Ma per gli
uomini la morte è già arrivata: vengono arruolati come carne da macello
nell’esercito degli invasori. Non si può scappare. Se provi a scappare ti
spareranno alla nuca o ti toglieranno le budella dal ventre.
È impossibile andare
via. Ai posti di blocco nemici si gioca alla roulette russa, come dice il loro
capo: piace, non piace… Se qualcuno non piace, un orco gli potrà fare qualsiasi
cosa, e se qualcuna invece piace anche con lei faranno qualsiasi cosa.
Se nel 2014 ero
diventata esperta nei suoni e nei segni delle “peonie”, dei “giacinti” e dei
“tulipani”, ora sto imparando i nomi delle armi nuove e più moderne. Dubito che
potrò applicare queste nozioni nella pratica. Però mi piacciono. E non soltanto
a me.
C’è una vignetta che
gira nei social, in cui un bambino e una bambina piccoli giocano nella sabbia.
Lei lo guarda e gli chiede: «Come ti chiami?». E lui risponde: «Bayraktar. E
tu?». « Io sono Javelina».
L’amica di Leopoli
dice: «Ho paura. Solo ora ho iniziato ad avere paura. Penso che sarà Leopoli…».
«In che senso “sarà Leopoli”? Certo che sarà Leopoli o avete deciso di chiamare
la città diversamente?». « Ma no. Penso, che le armi nucleari tattiche verranno
usate a Leopoli. E dopo?». « Ah, menomale. Non ti preoccupare, cara, hanno detto
che verranno distrutti tutti i centri di comando. E dove sono? Esatto! A Kyjiv!
A casa mia! ». « Non mi hai tranquillizzata per niente… Quindi che cosa
facciamo?». « Ce ne freghiamo. Un po’ di fatalismo non farà male alla fiducia
nel nostro esercito ». « E dove devo andarlo a cercare ’sto fatalismo?».
Nel nostro centro di
volontariato c’è una signora della città di Popasna. Tranquilla, silenziosa,
assente. Dice: «Ragazze, avete una fotocopiatrice qui? ». « Possiamo trovarla,
per che cosa le serve? ». « Si potrebbe anche fare una foto con il telefono.
Perché ce l’ho su un pezzo di carta… Ma dobbiamo cancellare tutte le foto dal
telefono, perché, se si capita in mano a quelli, loro, per prima cosa, guardano
i telefoni. Il pezzo di carta puoi nasconderlo nel reggiseno o nelle mutande… ».
« Allora fotocopiamolo! ». « Però fatelo vedere a tutti, non dimenticatelo. Un
terzo del nostro Paese ormai è una Popasna. Ma io di questo foglio ne ho una
sola copia ».
Sul pezzo di carta
c’è la lista dei morti. Accanto ad alcuni nomi ci sono le date e gli indirizzi.
Accanto ad altri solo le date e i nomi. In alcuni casi non ci sono neppure i
nomi, solo “una donna”, “un uomo vecchio”, “una ragazza”.
« Erano ancora lì,
mentre io lasciavo la città. Non a Popasna, ma sulla strada. Prendevo nota di
quelli che ho visto. Non ho visto tutti, ma alcuni sì… Sono sotto la riga. Sopra
la riga ci sono i nostri… ».
Perché sto scrivendo
questo diario? Che senso ha, se l’unico senso che può esserci per noi, per
quelli non al fronte, è fare le mappe con dei punti con i nostri morti?
*Olena Stiazhkina è
una storica e scrittrice, insegna all’Università di Donec’k (che ha poi
trasferito la sua sede a Vinnycia, in seguito all’occupazione del Donbas nel
2014). È autrice del romanzo La morte del leone Sesil aveva un senso, scritto a
metà in russo e a metà in ucraino, con una scelta-manifesto che mostra la sua
decisione di passare dal russo all’ucraino come lingua di scrittura.
Slava Evropi.
Tutto ciò che l’Ue ha fatto per l’Ucraina finora (e quello che può ancora fare).
Vincenzo Genovese su L’Inkiesta il 24 Febbraio 2023
L’Unione europea ha
preso decisioni senza precedenti per sostenere Kyjiv nel primo anno di guerra:
aiuti economici e militari, porte aperte ai profughi e spiragli per l’adesione
Un anno è passato
dall’inizio della guerra in Ucraina. Che non è solo una guerra contro l’Ucraina
ma «contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori e il nostro
futuro»: parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea
nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 2022. Questi dodici mesi
hanno visto un coinvolgimento graduale ma inesorabile dell’Ue nel conflitto,
portando i suoi leader a compiere passi difficilmente immaginabili prima che un
evento così epocale stravolgesse i loro orizzonti.
Armi, denaro e
permessi di soggiorno
Le istituzioni
dell’Ue stimano in circa cinquanta miliardi di euro il sostegno complessivo
garantito all’Ucraina, sia tramite strumenti comunitari che nazionali dei
ventisette Stati membri.
La parte più
consistente, 37,8 miliardi, riguarda la cosiddetta «assistenza
macro-finanziaria» e umanitaria: cioè i soldi che servono al governo di Kyjiv
per mantenere a galla i conti del Paese nonostante l’aggressione.
Non tutti sono
versamenti a fondo perduto: ci sono ad esempio i diciotto miliardi promessi per
il 2023 sottoforma di «prestiti altamente agevolati» (tre già erogati a
gennaio), i 2,3 prestati dalla Banca europea per gli investimenti e andrà
restituita anche una quota dei 7,8 miliardi assicurati dai singoli Stati
dell’Ue.
Quasi un miliardo
riguarda l’assistenza umanitaria in senso stretto: 668 milioni di euro per
programmi di supporto favore dei civili colpiti dalla guerra (630 per l’Ucraina
e trentotto per la Moldova), più 330 milioni di euro volti ad assicurare
l’accesso a beni e servizi di prima necessità fra cui l’istruzione, l’assistenza
sanitaria e l’alimentazione.
Ma per sostenere lo
sforzo bellico di un Paese servono anche aiuti militari. E l’Unione non si è
tirata indietro, con uno stanziamento complessivo di circa 12 miliardi. I tre
quarti di questa cifra rappresentano il valore delle armi e dell’equipaggiamento
militare fornito dai vari Stati membri, le cui consegne vengono quasi sempre
mantenute segrete.
Arrivano
direttamente dal bilancio europeo 3,6 miliardi, attraverso uno strumento
chiamato European Peace Facility (Epf) e istituito nel 2021 per finanziare le
operazioni militari svolte in Paesi terzi nell’interesse dell’Ue.
Le sette tranche di
versamenti destinati all’Ucraina ne hanno più che dimezzato la dotazione
complessiva, circa cinque miliardi e mezzo di euro fino al 2027. Finora l’Epf
era stato utilizzato soprattutto per finanziare missioni di addestramento, in
Paesi come Mali, Somalia o Niger. In questo caso invece si tratta di
una «missione di assitenza militare»: per la prima volta l’Unione «compra» le
armi a un Paese straniero, rimborsando i costi sostenuti dai suoi Stati membri
per le forniture.
Accanto ai
rifornimenti militari, distinti in equipaggiamento «letale» e «non-letale», ci
sono comunque moduli di addestramento dei soldati ucraini organizzati in
territorio europeo: a questo proposito l’Unione ha stanziato altri
quarantacinque milioni di euro, oltre ai fondi dell’Epf.
La scelta di quante
e quali armi inviare all’Ucraina non dipende dall’Unione Europea, ma dai singoli
Stati. Tuttavia, come è stato evidenziato dal cambio di rotta del governo
tedesco sulla fornitura di carri armati Leopard, il dialogo a livello
comunitario influisce su ogni decisione. Anche perché, spiegano fonti
diplomatiche a Linkiesta, spesso gli eserciti degli Stati membri hanno in
dotazione armi assemblate in altri Paesi e per inviarle altrove serve l’assenso,
o quantomeno la notifica, al produttore.
Dopo che alcuni
governi dell’Unione si sono impegnati a consegnare carri armati a Kyjiv e mentre
il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere loro aerei da
combattimento, il prossimo passo a livello europeo potrebbe essere acquistare
armi in maniera congiunta, come fatto per i vaccini anti-Covid19 nel 2021: la
stessa von der Leyen ha vagheggiato questa possibilità e il ministro degli
Esteri dell’Estonia ha perfino presentato un piano da quattro miliardi per
l’approvvigionamento comune di proiettili di artiglieria da 155 millimetri.
L’acquisto comune di
munizioni rappresenta un tabù da sfatare per l’Unione, ma in questo anno di
guerra infrangere le consuetudini non è una novità. Sul piano della politica
migratoria, ad esempio, l’Ue ha adottato uno strumento mai utilizzato prima:
la Direttiva sulla protezione temporanea (2001/55), che concede a tutti i
cittadini ucraini un permesso di soggiorno nei suoi Stati membri.
I Ventisette non
avevano voluto attivarla per i profughi afghani dopo il colpo di stato talebano
dell’estate 2021, ma hanno impiegato pochi giorni per trovare un accordo dopo
l’invasione dell’Ucraina.
In pratica, tutti
gli ucraini (e i non ucraini che risiedevano nel Paese e che non possono tornare
nel proprio) hanno diritto a restare nell’Ue fino a marzo 2024, senza la
necessità di fare richiesta di asilo, come invece avviene per tutti gli altri
migranti.
Secondo i dati
Eurostat, al momento beneficiano della direttiva quattro milioni di persone, con
Polonia e Germania che ne ospitano quasi un milione a testa. Ma di sicuro gli
ucraini che hanno attraversato i confini dell’Unione in questi dodici mesi sono
molti di più: alcuni non si sono registrati per la protezione, altri hanno già
fatto ritorno nel proprio Paese.
Chi resta ha
garantita assistenza sociale e sanitaria e può accedere al mercato del lavoro:
la Commissione per facilitarne l’inserimento ha anche istituito una piattaforma
di ricerca di lavoro online, chiamata EU Talent Pool.
Avvelenamento lento
Oltre ad aiutare gli
ucraini, l’Unione Europea ha provato per un anno a fiaccare i russi, attraverso
una lunga e articolata serie di sanzioni.
Nove pacchetti di
misure restrittive sono stati approvati dal febbraio 2022: il primo un giorno
prima dell’invasione, per punire il riconoscimento russo delle due repubbliche
separatiste di Donestk e Lugansk, e il decimo dovrebbe scattare all’anniversario
del conflitto.
In mezzo, il divieto
per i velivoli russi di sorvolare lo spazio aereo europeo, il blocco delle
esportazioni verso la Russia di prodotti di lusso e tecnologie utilizzabili in
guerra, e delle importazioni da Mosca delle materie prime (esclusi cibo e
fertilizzanti). Gli organi di informazione legati in qualche modo al Cremlino,
come Sputnik e Russia Today sono stati oscurati nell’Ue ed è stato sospeso un
accordo in vigore dal 2007 che consentiva ai cittadini russi di prendere il
visto per l’Europa in maniera più rapida.
Con il passare dei
mesi, la spirale delle sanzioni è cresciuta di forza e volume. Il terzo
pacchetto, a marzo 2022, ha escluso la Banca centrale russa e altre banche dal
sistema di pagamenti Swift; il quinto ad aprile ha messo il bando il carbone
russo, il sesto a giugno il petrolio, pur tra deroghe ed eccezioni, mentre a
dicembre gli Stati dell’Ue hanno faticosamente raggiunto l’accordo per un tetto
ai prodotti petroliferi raffinati russi, che si applica anche alle esportazioni
via mare di Mosca verso altri Paesi.
Al momento l’Unione
non ha azzerato le sue forniture di combustibili fossili dalla Russia, ma
ridotto considerevolmente la sua dipendenza. Il petrolio russo, che nel 2020
formava più di un quarto del totale importato, ora è passato al 14,4 per cento
secondo i dati Eurostat relativi al terzo trimestre 2022. Ancora più
impressionante il calo del gas, dal trentotto per cento al quindici per
cento: il tetto al prezzo concordato a fine anno, che si applica al combustibile
proveniente da tutto il mondo, contribuisce a ridurre le entrate russe.
Quasi 1400 persone,
nel frattempo, sono entrate nella «lista nera» dell’Ue, con il divieto
d’ingresso negli Stati del blocco comunitario e il congelamento dei beni
detenuti in Europa. Tra questi ovviamente il presidente Vladimir Putin e il
ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il capo della milizia mercenaria
Wagner Yevgeny Prigozhin, tutti i parlamentari della Duma, le alte cariche del
Cremlino e un lungo elenco di oligarchi.
Secondo le stime, le
loro proprietà nell’Ue valgono quasi venti miliardi, da aggiungere ai circa
trecento di riserve congelate alla Banca centrale russa: la Commissione europea
sta cercando un modo valido dal punto di vista giuridico per finanziare con
questi soldi la ricostruzione dell’Ucraina.
L’impatto delle
sanzioni europee sulla Russia è oggetto di ampio dibattito a livello
comunitario: di sicuro non hanno fermato la guerra, ma altrettanto certamente
stanno danneggiando l’economia russa. L’Alto rappresentante dell’Ue per gli
Affari esteri Josep Borrell le definisce un «veleno lento», che darà il meglio
di sé con il passare del tempo. Per il momento, la Russia ha subito una
contrazione del 4,5 per cento nel 2022 secondo la Banca mondiale, ma per il
Fondo monetario internazionale la decrescita è più ridotta e nel 2023 il Paese
potrebbe tornare a crescere dello 0,3 per cento.
I prossimi passi
Nell’arco
dell’Unione, comunque, ci sono ancora diverse frecce per colpire la Russia.
Alcune dalla portata limitata, come il divieto di importazione dei diamanti
provenienti dalla Russia, un business complessivo da oltre quattro miliardi
all’anno.
Altre forse più
significative per scoraggiare il prosieguo del conflitto o minare ulteriormente
l’economia russa, come l’istituzione di un tribunale speciale per giudicare il
«crimine di aggressione» nei confronti dell’Ucraina: una sorta di «Norimberga»
per Putin e gli alti ranghi del Cremlino. Oppure l’inclusione nelle sanzioni
dell’industria nucleare russa, che fornisce circa un quinto
dell’uranio importato dall’Ue: l’ultimo tassello in tema di disconnessione
energetica da Mosca.
Nei confronti
dell’Ucraina, invece, l’Unione sembra disposta a mantenere il sostegno
umanitario, finanziario e militare per tutto il tempo necessario, «as long as it
takes», come amano ripetere i vertici comunitari.
Meno decisione e
meno concordia su un altro punto cruciale: l’ingresso nell’Unione dell’Ucraina.
Che finora ha percorso a marce forzate un cammino di solito molto più lento, con
lo status di Paese candidato garantito in meno di quattro mesi e segnali
positivi nelle occasioni solenni. Ma che difficilmente avrà una corsia
preferenziale in futuro, secondo chi conosce l’ambiente comunitario.
«La concessione
dello status di Paese candidato si è basata sull’empatia e sulla volontà di dare
al popolo ucraino la prospettiva di un futuro. Ma l’ingresso nell’Unione non
dipenderà dall’empatia», dice a Linkiesta André Sapir, analista del think
tank Bruegel e consigliere di Romano Prodi nella Commissione europea che ha
presieduto il più grande allargamento nella storia dell’Unione, nel 2004.
A suo giudizio, la
valutazione verrà effettuata dopo la fine del conflitto in modo oggettivo,
tenendo in considerazione le riforme e i progressi del Paese. Se davvero c’è un
«debito morale» degli europei nei confronti degli ucraini per questa guerra,
sarà pagato in un altro modo.
Contro la
cancellazione. La Russia vuole farvi credere che la cultura del Donbas non sia
mai stata Ucraina. Ma non è vero.
Kateryna Zarembo su
L’Inkiesta il 24 Febbraio 2023
Anche nel 2022 la
Russia cerca di eliminare la memoria usando i vecchi metodi sovietici. Stavolta
sarà più difficile: ci sono ancora tanti testimoni oculari. E sono morti in
troppi per difendere le regioni di Donec’k e della Luhans’k
La storia si ripete.
In questo preciso istante i russi, sotto gli occhi di tutti, stanno cancellando
dalla faccia della terra Mariupol’, Severodonec’k, Lysyčans’k e altri piccoli
paesini della regione di Donec’k e Luhans’k. Si tratta non soltanto di
conquistare i territori, ma di far sì che tutti dimentichino che in quei posti
c’è stata e c’è ancora l’Ucraina.
I russi lo hanno
già fatto nel passato. I vertici del Partito comunista hanno cercato in tutti i
modi di cancellare qualsiasi storia del Donbas che non fosse quella sovietica.
Per questo è stata
taciuta la storia di un’epoca più antica di queste terre, che costituivano una
parte dello Stato cosacco. Per contrastarla è stato inventato un mito del
Donbas come terra di minatori e metallurgici che faticavano duro in nome
dell’Unione dei Paesi Socialisti Sovietici.
Per lo stesso
motivo, la lingua ucraina è stata cancellata. Secondo il censimento del 1897,
il 68,9 per cento degli abitanti della regione di Donec’k e il 62 per cento di
quelli della regione di Luhans’k consideravano l’ucraino lingua madre. Nel 1989
questo indice cala fino al 30,6 per cento nella regione di Donec’k e fino al
34,9 per cento in quella di Luhans’k. Gli insegnanti di ucraino sono stati
licenziati, gli scrittori ucraini, gli attivisti per i diritti umani e i
dissidenti sono stati oggetto di repressione.
Per questo il
capoluogo della regione è stato spostato dalla Bakhmut ucraina, la città dove
per la prima volta è stata alzata la bandiera ucraina nel 1917, a Donec’k
(all’epoca Stalino). Bakhmut aveva una tradizione ucraina troppo forte.
L’ironia della sorte
sta nel fatto che la potenza industriale della regione non fu nemmeno creata dai
sovietici, ma dagli europei: tedeschi, francesi, britannici e belgi. I sovietici
si sono appropriati delle miniere e delle fabbriche nell’Ucraina orientale
durante il caos della Prima guerra mondiale. Per questo motivo, il Belgio non ha
riconosciuto l’Unione Sovietica come Stato fino al 1935.
Nell’Ucraina
indipendente dopo il 1991, il mito del Donbas non è stato cancellato, ma è
stato anzi rafforzato dalle locali élite politiche. Perfino il termine
“Donbas”, una delle poche abbreviazioni sovietiche rimaste (Donbas sta per
Donec’kyj vuhilnyj basejn – bacino del carbone di Donec’k ), ha continuato a
vivere in Ucraina senza badare a quale fosse la provenienza e al significato del
toponimo.
In seguito,
all’immagine del Donbas come terra di proletariato è stata aggiunta un’immagine
del Donbas come terra di criminali: negli anni Novanta, nella regione sono stati
uccisi alcuni uomini d’affari di successo. E poi è stata aggiunta anche
un’immagine del Donbas come terra di lingua russa, una tragica conseguenza della
sanguinosa politica di russificazione avvenuta negli anni sovietici. E, ancora,
un’immagine di terra filorussa, fomentata dalla figura dell’ex presidente
ucraino, originario del Donbas, Viktor Janukovyč.
Il suo Partito delle
regioni ha monopolizzato quella parte del Paese fino a stroncare le voci meno
rumorose che non entravano nel quadro del mito del Donbas. Questo mito è stato
così fortemente radicato nel presente ucraino al punto che fino al 2014 si
sapeva molto poco del movimento filoucraino nelle zone di Donec’k e di Luhans’k.
Per esempio, nel 2006-2009, all’università di Donec’k era attiva
l’organizzazione giovanile Poštovkh (La Spinta) che lavorava per riportare nel
Donbas l’identità ucraina. E poi c’erano gli scout ucraini Plast nelle varie
città del Donbas e poi i gruppi letterari e artistici e i tifosi di calcio che
si sentivano parte di un tutt’uno ucraino e non solo di un contesto locale.
Questa lista potrebbe continuare.
Sia a Donec’k sia a
Luhans’k hanno avuto luogo le proteste di Euromajdan, non così numerose come
nelle altre città, però nemmeno così scontate. Dopo la vittoria
dell’Euromajdan a Kyjiv e dopo che la Russia ha iniziato a occupare le regioni
di Donec’k e Luhans’k, la piazza di Donec’k ha risposto con una protesta di
diecimila persone il 13 marzo 2014. Non è tanto, se consideriamo che la città
aveva più di un milione di abitanti, ma non è neanche così poco, considerate
le poche speranze che gli altri ucraini nutrivano nei confronti degli abitanti
del Donbas.
In seguito, nella
Donec’k occupata, è stato organizzato il primo festival di letteratura con la
partecipazione di scrittori ucraini. Secondo l’opinione dei militanti locali, al
Donbas sono mancati altri cinque o dieci anni per rafforzare definitivamente
un’identità ucraina.
Dopo il 2014, quando
quasi metà della popolazione di Donec’k e di Luhans’k è sfollata per via
dell’occupazione russa, la voce ucraina del Donbas si è fatta più forte. La
scrittrice e storica Olena Stiazhkina (che scrive su questo numero del Magazine
de Linkiesta, ndr), lo studioso di religione Ihor Kozlovs’kyj, i giornalisti
Denys Kazans’kyj e Serhij Stukanov e tanti altri sono diventati una voce
alternativa del Donbas in Ucraina e nel mondo. Alcuni di loro, però,
preferiscono non usare il termine Donbas in quanto retaggio del falso mito
sovietico.
Dal 2014, nelle
varie città delle regioni di Donec’k e di Luhans’k non occupate dai russi, si
è rafforzato il movimento civile progressista, che promuove idee per una
gestione locale più organizzata, per una salvaguardia dell’ambiente e per una
popolazione più patriottica: a Konstiantynivka è stata attiva l’associazione
Vil’na khata (La casa libera) e a Drużkivka l’associazione Točka dostupu (Il
punto di accesso), mentre l’Università orientale si è trasferita da Luhans’k a
Severodonec’k. In questi posti si è scritta una nuova storia dell’Est ucraino
basata sulle forti tradizioni locali.
La popolazione che
tuttora vive sotto l’occupazione russa continua a credere nell’Ucraina. Ne è un
esempio lo scrittore Stanislav Asejev, rimasto nella Donec’k occupata a
testimoniare e a mandare i suoi scritti al giornale ucraino Dzerkalo tynhnia (Lo
specchio della settimana) fino al 2017, quando è stato rapito dagli occupanti.
Dopo due anni di prigionia è stato liberato durante uno scambio di prigionieri.
Le persone come
Asejev continuano a vivere anche adesso sotto occupazione. Sono loro che
disegnano la bandiera gialloblu sulle case e sulle strade. Sono loro che passano
le informazioni importanti all’esercito ucraino. I maturandi di Donets’k si
preparano per entrare nelle università ucraine. Anche un’amica della scrittrice
Olena Stiazhkina ha deciso di rimanere e di aspettare, perché ci dovrà pur
essere «qualcuno ad accogliere l’esercito ucraino con i fiori dopo la nostra
vittoria».
Nel 2022, la Russia
si è posta l’obiettivo non solo di occupare l’Ucraina orientale, ma di
annientarla. Mariupol’ e Severodonec’k sono state rase al suolo. Nella basilica
di San Petro Mohyla a Mariupol’, gli occupanti hanno bruciato tutta la
biblioteca che includeva anche testi unici. Nelle scuole occupate sono arrivati
i professori da Rostov e da San Pietroburgo. Bruciano i libri, cambiano i
docenti, riscrivono i testi, cancellano la memoria usando i soliti vecchi metodi
sovietici.
Però questa volta
sarà più difficile. Ci sono ancora troppi testimoni oculari, sono ancora in
troppi a ricordare, sono morti troppi ucraini per difendere la Donec’k e la
Luhans’k ucraine.
Le città distrutte
saranno ricostruite e noi ci ritorneremo, per continuare a scrivere la storia
dell’Est ucraino.
Kateryna Zarembo è
analista politica e professoressa universitaria, si occupa di politica estera,
di politica di sicurezza e di studi sulla società civile ucraina. Da maggio 2022
è ricercatrice presso la Technical University di Darmstadt in Germania. È membro
associato del New Europe Center di Kyjiv e insegna alla Kyjiv-Mohyla Academy. In
autunno uscirà presso la casa editrice ucraina Choven il suo libro “Il sole
ucraino sorge nel Donbas” sui movimenti filoucraini nella parte orientale del
Paese.
L’Unione in cui
credo. I destini di noi europei sono intrecciati (anche con l’Ucraina), dice von
der Leyen a Palermo.
Ursula Von der Leyen
su L’Inkiesta il 23 Febbraio 2023
«Spesso è nell’ora
più buia che troviamo la nostra forza interiore. È ciò che sta accadendo», è
il messaggio di speranza della presidente della Commissione europea
Pubblichiamo un
passaggio del discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università
di Palermo.
La giornata in cui
ci incontriamo ha un valore speciale per l’Europa. Domani sarà trascorso un
anno da quando la Russia ha dato inizio alla brutale invasione dell’Ucraina.
Visto dalla Sicilia, potrebbe sembrare un conflitto lontano. Ma non lo è. I
giovani ucraini condividono con voi gli stessi desideri, che sono quelli di
tutti i giovani europei. Vogliono essere indipendenti e padroni del proprio
futuro. Vogliono vivere liberamente in un paese democratico. Vogliono libertà
di parola, libertà di pensiero, libertà di circolazione.
Questo è il motivo
per cui nel 2014 i giovani ucraini sono scesi in strada avvolti nelle bandiere
europee. Per tutta risposta, Putin ha invaso per la prima volta il loro paese.
È tornato a farlo otto anni dopo, il 24 febbraio 2022. Putin nega all’Ucraina
il diritto di esistere. Attaccandola un anno fa, ha attaccato anche i principi
di sovranità e integrità territoriale. E ha attaccato i principi della
democrazia.
Gli autocrati hanno
paura proprio di ciò che rende attrattive le nostre democrazie liberali: il
nostro successo economico, le nostre libertà civili e la libertà di parola e
di opinione. Ecco perché il coraggioso popolo ucraino non sta solo difendendo
il proprio paese, ma sta anche combattendo per i nostri valori. Per questo
resteremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Libertà per
l’Ucraina.
Spesso è nell’ora
più buia che troviamo la nostra forza interiore. È ciò che sta accadendo
nella nostra Unione. Le prove di questi tre anni sono probabilmente le più
difficili mai affrontate dall’Europa. Prima la pandemia e le sue ripercussioni
economiche, poi la guerra e l’impennata del costo della vita. Ma queste crisi ci
hanno insegnato qualcosa. Abbiamo imparato che i destini di noi europei sono
intrecciati tra loro.
Quando ci siamo
procurati i vaccini, abbiamo fatto in modo che fossero distribuiti
contemporaneamente in tutta Europa, allo stesso prezzo. Quando abbiamo tracciato
il nostro piano di ripresa, ci siamo concentrati soprattutto sulle regioni e sui
settori che avevano più bisogno di sostegno. E quando la Russia ha chiuso i
rubinetti del gas, rendendo le nostre bollette energetiche molto più costose,
abbiamo risposto all’insegna della solidarietà europea, proteggendo le famiglie
e le imprese più fragili. È questa l’Europa in cui credo. Un’unione che è
sempre al fianco dei suoi cittadini. Ed è questa idea di Europa che oggi mi
porta in Sicilia. […]
Così la Cina dice
basta all’Occidente giudice e poliziotto globale.
Redazione su
L’Identità il 25 Febbraio 2023
Di DIEGO BERTOZZI
Come da più parti
anticipato nei giorni scorsi, e all’indomani della visita di Wang Yi, a capo
della Commissione Affari Esteri del Partito comunista cinese, Pechino ha
presentato il proprio documento, suddiviso in 12 punti, per una possibile
soluzione della crisi ucraina. Prima di descriverlo, va detto che esso è in
linea con le tendenze tradizionali della diplomazia cinese e che ribadisce
alcuni concetti più volte espressi, su tutti quello della natura “non esclusiva”
e particolaristica della sicurezza. Altra considerazione che va tenuta ben
presente: benché sia rivolto principalmente alla soluzione del conflitto
militare in essere da ormai un anno, il documento si situa in una cornice di
crescenti tensioni anche in Estremo Oriente, con particolare riferimento alla
delicata questione di Taiwan (è di queste ore la notizia di un aumento della
presenza di militari Usa nell’isola cinese).
Si parte quindi con
la richiesta del pieno rispetto della sovranità di tutti i Paesi, in rispetto
della Carta delle Nazioni Unite: “La sovranità, l’indipendenza e l’integrità
territoriale di tutti i paesi devono essere efficacemente sostenute. Tutti i
paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, ricchi o poveri, sono membri uguali
della comunità internazionale. Tutte le parti dovrebbero sostenere
congiuntamente le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali e
difendere l’equità e la giustizia internazionali”. Viene certo ribadita la
condanna di ogni aggressione militare, compresa quella russa ai danni
dell’Ucraina, ma tale condanna vale anche per un passato, anche recente, troppo
spesso “rimosso” fatto di guerre scatenate da Usa e alleati; rimozione che rende
poco credibili le attuali condanne espresse nei confronti di Mosca. Il primo
punto termina, infatti, con questa specificazione: “Dovrebbe essere promossa
un’applicazione paritaria e uniforme del diritto internazionale, mentre i doppi
standard devono essere respinti”.
Il secondo punto
possiamo considerarlo un “classico” della diplomazia cinese post 1989 e
disintegrazione dell’Unione sovietica quale l’abbandono della “mentalità da
guerra fredda”. Ad essere presi di mira sono l’unipolarismo statunitense e
l’allargamento della Nato, con la conseguente disseminazione di tensioni e
destabilizzazioni, in un quadro internazionale oggettivamente avviato sulla
strada della multipolarità: “La sicurezza di un paese non dovrebbe essere
perseguita a spese di altri. La sicurezza di una regione non dovrebbe essere
raggiunta rafforzando o espandendo i blocchi militari. I legittimi interessi e
preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere presi sul serio e
affrontati adeguatamente. Non esiste una soluzione semplice a un problema
complesso. Tutte le parti dovrebbero, seguendo la visione di una sicurezza
comune, globale, cooperativa e sostenibile e tenendo presente la pace e la
stabilità a lungo termine del mondo, contribuire a creare un’architettura di
sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile. Tutte le parti dovrebbero
opporsi al perseguimento della propria sicurezza a scapito della sicurezza
altrui, prevenire il confronto tra blocchi e lavorare insieme per la pace e la
stabilità nel continente eurasiatico”. Nella sostanza si sottolinea come la
decisione russa di procedere all’invasione e all’occupazione di una parte del
territorio ucraino sia anche il risultato di una politica sconsiderata –
anch’essa aggressiva – che ha indebitamente elevato il particolare (l’espansione
della Nato a Est) a universale (Occidente come garante della pace e del rispetto
del diritto internazionale) minando gravemente la sicurezza della Russia.
In altre parti
(punti 3 e 10) il documento individua nell’abbassamento della tensione a favore
di una progressiva moderazione delle politiche delle parti contrapposte (Russia
e Nato, più che Russia e Ucraina, come è ormai evidente a tutti). Accanto alla
richiesta di evitare ogni minaccia di ricorso all’arma nucleare (avviso
recapitato a Mosca), resta la ferma condanna di alcune pratiche quali
l’innalzamento in quantità e qualità delle armi a Kiev, il sanzionismo
unilaterale occidentale (del quale Pechino è storica vittima) da troppo tempo
utilizzato come arma di ricatto, e la tendenza tutta occidentale di farsi
poliziotto e giudice globale (facendo saltare la classica e liberale distinzione
dei poteri). Riportiamo direttamente dal documento: “Tutte le parti devono
rimanere razionali ed esercitare moderazione, evitare di alimentare il fuoco e
aggravare le tensioni e impedire che la crisi si deteriori ulteriormente o
addirittura sfugga al controllo. Tutte le parti dovrebbero sostenere la Russia e
l’Ucraina nel lavorare nella stessa direzione e riprendere il dialogo diretto il
più rapidamente possibile, in modo da ridurre gradualmente la situazione e
raggiungere infine un cessate il fuoco globale”. Inoltre “le sanzioni
unilaterali non possono risolvere la questione; creano solo nuovi problemi. La
Cina si oppone alle sanzioni unilaterali non autorizzate dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. I paesi interessati dovrebbero smettere di
abusare delle sanzioni unilaterali e della ‘giurisdizione a braccio lungo’ nei
confronti di altri paesi, in modo da fare la loro parte per ridurre la crisi
ucraina e creare le condizioni affinché i paesi in via di sviluppo possano far
crescere le loro economie e migliorare la vita della loro popolazione”.
Ucraina. Il piano
di pace cinese e il modello coreano.
Piccole Note
(putiniano) su Il Giornale il 24 Febbraio 2023.
A un anno
dall’inizio della guerra non si intravedono vie di uscita. Il piano di pace
della Cina, pubblicizzato ieri, è già stato rifiutato da Mosca. Infatti, la
portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, aveva detto che durante la visita del
ministro degli Esteri cinese a Mosca di questi giorni “non si è parlato di un
piano di pace”.
Ciò perché il
documento cinese, composto da 12 punti, prevede il reintegro dei territori
ucraini sotto la sovranità di Kiev, cosa che Mosca, dopo aver speso tante
risorse, non può accettare. Analoga accoglienza ha avuto in Occidente, che non
può accettare che la pace sia fatta dalla Cina.
E però, la Cina ha
fatto la sua mossa, un’operazione di marketing che, ben sapendo che non ha
possibilità nel suo insieme, Pechino ha pubblicizzato per smuovere le acque. Dei
punti elencati, quelli cruciali, e fattibili, sono quelli riguardanti il cessate
il fuoco e l’avvio di negoziati. Vedremo.
Intanto, arriva
la smentita della Casa Bianca sul fatto che Pechino invii aiuti militari a
Mosca, cosa accreditata dalla stampa internazionale. Non è la prima volta che
tale notizia senza fondamento viene diffusa in Occidente e non sarà l’ultima.
Ma più che una
smentita, la presa di posizione della Casa Bianca sembra soprattutto un’apertura
di credito alla possibilità di avviare negoziati sull’Ucraina, dal momento che
arriva in contemporanea con la pubblicazione del piano di pace. Non ora, non
ancora, ma l’apertura c’è perché la notizia dell’aiuto militare a Mosca serviva
ad affondare sul nascere le prospettive evocate dal piano cinese.
Peraltro, al netto
della retorica bellicista, proseguono i segnali possibilisti in tal senso sui
media mainstream. Di oggi un articolo di Sergej Radchenko sul New York Times nel
quale si afferma che la guerra ucraina “potrebbe essere destinata a un cessate
il fuoco” (riprendiamo il titolo). Lo schema è quello di un conflitto congelato
in stile coreano.
Modello coreano
Così nel testo: “Se
nessuna delle parti otterrà successi significativi nei prossimi mesi, il
conflitto potrebbe dirigersi verso un cessate il fuoco. Gli ucraini, anche se
forse non avranno recuperato completamente i loro territori, avranno respinto un
nemico aggressivo. I russi, da parte loro, possono mascherare la loro sconfitta
strategica spacciandola come una vittoria tattica. Il conflitto sarà congelato,
un risultato tutt’altro che ideale. Tuttavia, se abbiamo imparato qualcosa dalla
guerra di Corea, è che un conflitto congelato è meglio di una sconfitta totale o
di un’estenuante guerra di logoramento”.
Molto interessante
anche un altro cenno dell’articolo, quando si spiega che l’invasione della Corea
del Sud da parte del Nord – che fu spinto a compiere questo passo da Stalin –
che diede avvio a quella guerra, fu favorita dai “segnali fuorvianti provenienti
dagli Stati Uniti. Primo tra tutti la famosa dichiarazione del Segretario di
Stato Dean Acheson del 12 gennaio 1950, che escludeva la Corea dal ‘perimetro
difensivo’ americano. Combinato con intercettazioni di intelligence, ciò fu
sufficiente per rassicurare Stalin – a torto – che gli Stati Uniti non sarebbero
intervenuti in Corea”.
È quanto successo
anche in Ucraina, quando, prima del 24 febbraio, Biden, rispondendo alle domande
su una possibile invasione russa, spiegava che l’America avrebbe difeso ogni
centimetro dei Paesi Nato, aggiungendo, però, significativamente che l’Ucraina
non era parte della Nato. Dinamica identica, dunque, anche se diverse le
motivazioni.
Sulla stessa linea
del Nyt, Josh Hammer il quale su Newsweek spiega che gli interessi dell’Ucraina
e degli Stati Uniti non coincidono e quindi c’è “un interesse estremamente
scarso (se non nullo) negli Stati Uniti su dove saranno tracciate esattamente le
linee di confine [delle due nazioni] nell’Ucraina orientale, dove la popolazione
è estremamente divisa tra etnia ucraina e etnia russa”.
Addolcire la pillola
con la ricostruzione
In parallelo a
questi articoli, lo scritto di Philip Short sul Time, nel quale si legge:
“Sebbene nessuno sia pronto a dirlo apertamente, si può dubitare che la Casa
Bianca segua l’Ucraina sul fatto di scacciare le truppe russe da tutti i
territori che ha occupato”. Aggiungendo che la riconquista delle Crimea, “nella
quale la maggior parte della popolazione si considera russa e che, dal punto di
vista di Mosca, è una regione russa come le altre, pone il rischio di innescare
quel tipo di escalation ingestibile che l’amministrazione Biden intende
prevenire”.
E dal momento che la
vittoria non può arridere a nessuno dei due contendenti, prosegue Short, è
probabile che l’America alla fine si accordi con Mosca accettando che essa
conservi parte del territorio ucraino. Ovviamente, la leadership ucraina
percepirà tale intesa come un “tradimento”, ma alla fine si allineerà e
“l’Occidente addolcirà la pillola inviando massicci aiuti per la ricostruzione”.
Si può facilmente
immaginare che la maggior parte di tali aiuti saranno richiesti alla Ue, cosa
che consentirà agli Stati Uniti di depauperare/subordinare ulteriormente
l’Europa occidentale e di rafforzare quella orientale, scelta da Washington come
gendarme armato sia nei confronti di Mosca che verso il resto del Vecchio
Continente.
Non è una buona
prospettiva per i cittadini europei e la loro libertà, se si tiene presente,
solo a titolo di esempio, che attualmente esiste un sito semiufficiale nel quale
sono iscritti i nemici dell’Ucraina da eliminare, elenco nel quale è stato
inserito anche l’iconico cantante Rogers Waters.
La macelleria e la
follia
Intanto prosegue la
macelleria, che i media d’Occidente derubricano a fattore secondario per evitare
che si pongano domande scomode sulla necessità di inviare armi a Kiev. Se ogni
giorno si leggono notizie, più o meno enfatizzate, sulle enormi perdite russe,
poco ci si sofferma sui militari ucraini inviati a morire al fronte, esaltandone
invece l’eroismo.
La realtà di quanto
sta avvenendo è stata accennata da un mercenario americano alla Abc, il quale ha
affermato che la vita media in prima linea è di “quattro ore”. Questa macelleria
va fermata. Continuare a inviare armi e a parlare di una vittoria ucraina, che
tutti sanno che non arriverà, serve solo a perpetuarla.
Ma come detto, non
sembrano prospettarsi svolte a breve. E nel frattempo si addensano nuove
criticità sulla Transnistria, regione della Moldavia al confine ucraino rimasta
sotto il controllo di Mosca dopo il crollo dell’URSS. La Russia allarma su una
possibile invasione da parte delle forze ucraine, la Moldavia smentisce.
Se ciò avvenisse, la
guerra prenderebbe una piega ancora più pericolosa dell’attuale. Sarebbe un
attacco alla Russia… solo pensare tale possibilità è pura follia, ma ad oggi a
questa non sembra esserci un limite (vedi le dichiarazioni sulla Transnistria
rilasciate al tempo dall’allora consigliere di Zelensky Oleksij Arestovich).
La sconfitta
della 'guerra globale' e della 'vittoria totale' di Kiev.
Piccole Note
(filoPutin) il 4 Marzo 2023 su Il Giornale.
“È passato un anno
dall’invasione russa dell’Ucraina. Nonostante le affermazioni del regime e dei
suoi alleati dei media secondo cui la Russia rappresentava il nuovo Terzo Reich
e avrebbe presto conquistato mezza Europa, è ormai evidente che ciò non è mai
stato neanche lontanamente vero”. Così Ryan McMaken in un articolo pubblicato
sul Mises Institute.
In realtà, prosegue
McMaken, “i russi non sono nemmeno vicini ad occupare alcunché in Europa oltre
l’Ucraina orientale. Non è Monaco 1938. Le sanzioni economiche non hanno
paralizzato il regime russo. La maggior parte del mondo resta neutrale sul
conflitto. E questo finirà probabilmente con una soluzione negoziata,
contrariamente ai desideri di Washington”.
“Il fatto è che,
nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e della NATO per fare della guerra
ucraina la terza guerra mondiale, essa rimane un conflitto regionale. E sembra
che la maggior parte del mondo non sia interessata a fare sacrifici per favorire
la politica degli Stati Uniti in Ucraina e che molti rilevino l’ipocrisia
intrinseca nei discorsi degli Stati Uniti sul rispetto della sovranità
nazionale”.
“Si può trarre
un’importante lezione dai massimalisti della guerra, i quali sostengono senza
tregua la guerra su vasta scala come ‘soluzione’ di tutte le crisi
internazionali. Gli Stati Uniti vogliono chiaramente combattere la guerra fino
all’ultimo ucraino, in questo conflitto che stanno rivendendo alla stregua di
una crociata globale in stile Seconda guerra mondiale. Ma sembra che adesso i
pensatori più pragmatici […] siano ben consapevoli che i negoziati sono la
soluzione più umana”.
La neutralità del
mondo e l’invasione (anche ucraina) dell’Iraq
Proprio la
neutralità di gran parte del mondo, cioè tutti i Paesi dell’Asia, del Sud
America e dell’Africa (a parte eccezioni che confermano la regola) appare la
parte più interessante dell’articolo perché di stretta attualità. Infatti, nel
corso del recente G-20, convocato a New Delhi, la neutralità suddetta si è
nuovamente palesata in tutta la sua plasticità dal momento che gli Stati Uniti
hanno provato a isolare nuovamente la Russia, fallendo ancora una volta.
Sul punto, appaiono
interessanti le annotazioni di McMaken, il quale scrive che tale neutralità si
deve “in parte a motivazioni pratiche. La leadership politica di questi Paesi
semplicemente non è disposta a impoverire la propria popolazione per compiacere
Washington. Ma la resistenza deriva anche dal fatto che la maggior parte del
mondo sa che le pretese statunitensi per il rispetto della sovranità nazionale e
del diritto internazionale sono del tutto menzognere”.
“Le invasioni
statunitensi e i bombardamenti in Iraq, Afghanistan, Libia e Siria hanno
chiarito che gli Stati Uniti sono perfettamente a loro agio nel violare la
sovranità nazionale quando ciò si è utile alle loro ambizioni. Il cosiddetto
ordine internazionale basato sulle regole ovviamente non significa nulla per gli
Stati Uniti quando diventa scomodo per Washington (va anche notato che il regime
ucraino ha sostenuto l’invasione dell’Iraq e inviato almeno cinquemila militari
per aiutare gli Stati Uniti a occupare quella nazione sovrana).
L’ultima annotazione
appare significativa ed è ignota ai più (compreso lo scrivente). Così abbiamo
fatto una ricerca e… sorpresa! Così il New York Times del 14 agosto 2004: “Il
governo ucraino, Paese tra i più attivi nel rifornire di truppe il contingente
straniero in Iraq, ha posto fine alle speculazioni sul suo impegno nella
missione a guida americana annunciando venerdì che avrebbe inviato una nuova
brigata per sostituire quella che tornerà in patria questo autunno”.
Un impegno lodato
dall’allora Segretario per la Difesa degli Stati Uniti, il famigerato Donald
Rumsfield, il quale “ha ringraziato l’Ucraina per il suo ”eccellente supporto”
nella campagna dell’amministrazione contro i terroristi”.
La follia di
chiedere la resa incondizionata di Mosca
Tornando allo
scritto di McMaken, egli annota come gli Stati Uniti abbiano applicato alla
Russia lo stesso approccio riservato ai “paesi piccoli e poverissimi non in
grado di reagire” che negli ultimi decenni hanno subito le loro attenzioni
belliche. Infatti, così, come per l’Iraq e gli altri Paesi in questione, anche
per la Russia si è auspicato un regime-change che sancisse la vittoria
americana.
Non solo tale
pretesa era alquanto esagerata, ma era anche pericolosa, dal momento che avrebbe
potuto portare al potere un leader più duro e determinato. “Una pillola
difficile da ingoiare per gli americani che da tempo hanno una vera e propria
ossessione per la ‘resa incondizionata’” come punto terminale di un conflitto,
sul modello della resa del Giappone alla fine della Seconda guerra mondiale. “Ma
la realtà è che la stragrande maggioranza dei conflitti militari si conclude con
degli accordi negoziati”.
“Tuttavia, per tutta
la prima metà del 2022, quanti hanno chiesto l’avvio di negoziati […] sono stati
etichettati come apologeti russi. L’unico esito accettabile, ci è stato detto, è
la vittoria totale”.
“Quei giorni stanno
rapidamente volgendo al termine. La ‘vittoria totale’ dell’Ucraina, definita
come il ritiro totale della Russia, non è mai stata probabile […]. La fine dei
giochi sta arrivando ed è una soluzione negoziata. Sfortunatamente, l’accordo
arriverà solo dopo un’immensa perdita di vite umane, sia ucraini che russi, e al
prezzo di un’enorme perdita di capitali e infrastrutture”. E tale accordo,
prevede McMaken, sarà quello ovvio anche a inizio guerra: la cessione di parte
del Donbass alla Russia.
Questa la
conclusione di McMaken: “Coloro che hanno sostenuto la necessità di una guerra
su vasta scala e ‘niente pace fino alla vittoria totale’ si sono sbagliati in
modo sbalorditivo”. Un errore “molto costoso”, chiosa McMaken; infatti è stato
pagato a caro prezzo, sia in termini di vite umane che di tanto altro…
Sembra che la
direttrice sia tracciata. Ma torna alla mente il vecchio detto che recita così:
“Una guerra si sa quando inizia, ma non si sa quanto finisce”. Tanti e lucrosi
gli interessi in gioco.
La guerra illegale della Nato nel "cortile di casa" degli Usa.
Per gentile
concessione di Fazi Editore pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Daniele
Ganser, "Le guerre illegali della NATO". Daniele Ganser su Il Giornale il 28
Febbraio 2023
Per gentile
concessione di Fazi Editore pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Daniele
Ganser, Le guerre illegali della NATO
La guerra illegale
degli Usa contro il Guatemala iniziò il 18 giugno 1954. Un conflitto del genere
era interdetto non soltanto dall’ONU, ma anche dalla Carta dell’Organizzazione
degli Stati americani (Oas, ratificata a Bogotà il 30 aprile 1948 ed entrata in
vigore alla fine del 1951), che afferma: "Nessuno Stato o confederazione di
Stati ha il diritto di interferire direttamente o indirettamente, per qualsiasi
ragione, negli affari interni o esterni di qualsiasi altro Stato". Ma
alla Cia non importava nulla della Carta dell’Oas e nemmeno dello Statuto delle
Nazioni Unite: il diritto internazionale fu violato intenzionalmente.
Dal vicino Honduras
le bande armate dalla Cia invasero il Guatemala, di cui vennero bombardati
porti, strutture militari, una scuola, l’aeroporto internazionale e diverse
città. Il fattore risolutivo furono le notizie diffuse a tamburo battente da
stazioni radio controllate dalla Cia, secondo le quali i ribelli aumentavano
ovunque a vista d’occhio. Si trattava di notizie gonfiate ad arte, ma
la guerra combattuta a suon di informazioni funzionò, facendo credere al
presidente Árbenz di stare affrontando forze soverchianti. La propaganda servì
alla Cia per dare l’impressione di essere più forte di quanto fosse in realtà.
La guerra psicologica via radio in Guatemala era guidata da Howard Hunt, un
funzionario della Cia specializzato in operazioni illegali sotto copertura che
durante la campagna elettorale del 1972 si sarebbe infiltrato nel quartier
generale dei democratici, all’interno del complesso residenziale del Watergate a
Washington, per spiare gli avversari politici. La scoperta dell’operazione
avrebbe portato al famigerato scandalo Watergate e alle dimissioni del
presidente Richard Nixon. In quell’occasione, Hunt fu condannato a trentatré
mesi di detenzione per effrazione, cospirazione e intercettazione telefonica.
Ma tramando
la caduta del governo guatemalteco, Hunt aveva commesso crimini ben peggiori,
causando la morte di parecchie persone: eppure lavorava per conto dell’impero
Usa e quindi non fu condannato negli Stati Uniti. È importante tenere presente
che gli Stati Uniti separano nettamente il diritto nazionale da quello
internazionale. Se si violano le leggi interne, come nel caso del Watergate,
vengono arrestati e condannati anche i mandanti, ma la situazione cambia
completamente se le stesse azioni o altre persino peggiori vengono commesse
all’estero: coloro che violano il diritto internazionale ricevono dalla Cia una
ricompensa, finanziata dall’erario. Chiaramente queste disparità disorientano.
David Atlee Philips, entrato alla Cia nel 1950, collaborò al sovvertimento di
Árbenz e all’epoca dei fatti pose al suo superiore Tracey Barnes una questione
ragionevole: "Però Árbenz è stato eletto presidente in maniera democratica. Che
diritto abbiamo di aiutare qualcuno a rovesciare questo governo e cacciare via
Árbenz?". La domanda era giusta, ma non ebbe risposta, dato che gli Stati Uniti
non avevano alcun diritto dalla loro parte, tranne quello del più forte.
Appena ebbe inizio
l’invasione, il Guatemala si rivolse immediatamente all’Onu chiedendo aiuto. Ma
c’era poco tempo, perché alti ufficiali dell’esercito guatemalteco si
rifiutavano di reagire all’attacco della Cia, addirittura alcuni minacciavano di
passare al nemico. Árbenz era con le spalle al muro: tentò di armare i civili
che lo sostenevano, ma gli ufficiali dell’esercito glielo impedirono. La Cia non
lasciava nulla al caso. Un cargo britannico ancorato in Guatemala con un carico
di caffè e cotone venne affondato per errore, perché la Cia pensava che avesse a
bordo munizioni per l’esercito del presidente Árbenz. Il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite si riunì il 20 giugno 1954 e l’ambasciatore Henry Lodge, in
rappresentanza degli Usa, professò con grande ipocrisia che il suo paese era
innocente: mentiva, dichiarando che si trattava di una "rivolta di guatemaltechi
contro guatemaltechi". I fatti avevano suscitato "grande preoccupazione nel
governo degli Stati Uniti", affermò Lodge, assicurando poi che gli Usa "non
erano legati in alcun modo a essi". A coloro che non lo trovavano convincente,
Lodge fornì anche una descrizione del carattere del rappresentante supremo degli
Usa: "Chiunque conosca il presidente Eisenhower, e molti in questo consesso lo
conoscono, saprà benissimo che è un uomo totalmente dedito ai principi della
democrazia, ai diritti umani, che respinge tutte le forme di imperialismo",
disse Lodge. "È un uomo che [...] ha dimostrato [...] sin da quando era
ragazzino in Kansas, che il suo cuore è sempre stato dalla parte dell’uomo
comune, intento a farsi strada nella vita".
Certo Lodge aveva
ragione quando ricordava che Eisenhower era stato un ragazzino in Kansas,
ma mentiva quando asseriva che non avrebbe rovesciato nessun governo
regolarmente eletto, dato che un anno prima aveva fatto proprio questo, con
Mossadeq in Iran. Nonostante le proteste del Guatemala e dell’Unione Sovietica,
gli Usa riuscirono a rinviare la questione all’Oas, che ci mise parecchio tempo
a reagire, anche se nessuno se ne stupì. Nel frattempo, dietro le quinte gli Usa
facevano in modo che passasse più tempo possibile prima che venisse affrontato
il caso del Guatemala. Il paese centroamericano era quasi del tutto nelle mani
degli insorti, quando il 25 giugno 1954 si appellò nuovamente al Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo gli Stati Uniti, non era più quella la
sede in cui occuparsene, dato che la questione era stata demandata all’Oas.
L’Unione Sovietica tornò a protestare, ribadendo che invece era dovere del
Consiglio di sicurezza proteggere dagli attacchi uno dei suoi Stati membri, ma
la faccenda non fu messa all’ordine del giorno.
Oltre all’Unione
Sovietica, soltanto Danimarca, Nuova Zelanda e Libano sostennero il piccolo
Guatemala nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, chiedendo di affrontare la sua
delicata situazione. I paesi della Nato Francia e Gran Bretagna, che secondo il
giornalista americano William Blum "erano stati messi notevolmente sotto
pressione" da Eisenhower e Dulles, si astennero dal voto perché sapevano che
senza di loro non ci sarebbe stata una maggioranza sufficiente per porre
all’ordine del giorno la questione del Guatemala. L’Onu, dunque, non riuscì a
bloccare la guerra illegale della Cia in Guatemala, grazie alla collaborazione
in questa specie di complotto di tre dei paesi della Nato con un seggio
permanente nel Consiglio di sicurezza: Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna.
L’Oas si prese
parecchio tempo: la sua commissione d’inchiesta arrivò in Guatemala soltanto il
30 giugno 1954, esattamente tre giorni dopo che Árbenz aveva rinunciato al suo
incarico. Era un ritardo programmato. Il segretario generale delle Nazioni
Unite, lo svedese Dag Hammarskjöld, era così seccato per le macchinazioni degli
Stati Uniti e per l’impotenza dell’Onu da dichiarare a una cerchia di persone
fidate che doveva "rivedere un po’ la sua posizione nelle Nazioni Unite". Per
l’Onu, il cambio di regime in Guatemala fu una catastrofe. "Forse nella storia
delle Nazioni Unite non c’è nessun episodio che le abbia screditate di più", è
stata la conclusione di Evan Luard, che ha scritto varie opere sulla storia di
quell’organismo internazionale. "Invece di attivarsi come un’organizzazione che
ha il dovere di opporsi all’aggressione, si è comportata come se dovesse
giustificarla. Il fatto era che in questo caso gli Stati Uniti [...] non
volevano che l’Onu entrasse in gioco per fermare o semplicemente condannare
l’aggressione".
Dopo aver rovesciato
il presidente Árbenz, le forze di invasione sostenute dalla Cia tentarono di
screditare l’ex presidente facendolo passare per un burattino manovrato da
Mosca. I corrispondenti esteri della stampa furono invitati a visitare il
palazzo occupato da Árbenz e condotti in alcune stanze in cui erano accatastate
pile di testi scolastici stampati in Unione Sovietica. Questa operazione doveva
servire a convincere i media che Árbenz era un pericoloso comunista.
Ucraina: Biden
stronca il piano cinese, 'se piace a Putin non va'.
Il presidente Usa
ribadisce: "Gli Usa reagirebbero se la Cina fornisse armi alla Russia". Di
Antonio Fatiguso su ANSA il 26 febbraio 2023
Il presidente
americano Joe Biden ha liquidato la proposta della Cina per una soluzione della
guerra in Ucraina, mentre Pechino si avvia a diventare un importante crocevia
sui destini del conflitto tra Mosca e Kiev con la visita di Stato della prossima
settimana del presidente bielorusso Alexander Lukashenko - fedele alleato del
Cremlino - e quella del presidente francese Emmanuel Macron di inizio aprile.
"Se a Putin piace,
come può essere un buon piano?", ha tagliato corto Biden ad una domanda sul
documento di 12 punti promosso dal presidente Xi Jinping, che sollecita una
"soluzione politica", il ritiro delle sanzioni e sollecita tutti a sostenere
Russia e Ucraina nella ripresa "del dialogo diretto" il più rapidamente
possibile.
"Ci sono vantaggi
solo per la Russia in quel piano", ha rincarato il presidente Usa in
un'intervista a Abc News sottolineando che l'idea che la Cina "negozi l'esito di
una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale".
Mentre, ha
assicurato, se il Dragone fornisse armi alla Russia gli Usa "risponderebbero".
Dopo le bocciature
di Ue, Usa e Nato, anche i leader ucraini hanno espresso giudizi più netti.
Nel documento "ci
sono vari elementi sui quali siamo d'accordo, ma almeno uno su cui non lo siamo,
ed è la richiesta della fine delle sanzioni unilaterali", ha notato il ministro
degli Esteri Dmytro Kuleba. Bocciatura piena per il consigliere presidenziale
Mykhailo Podolyak: "Se si pretende di essere un attore globale, non si offre un
piano irrealistico. Non si scommette su un aggressore che ha violato la legge
internazionale e che perderà la guerra. Non è lungimirante. Cina, la finestra di
opportunità non è infinita", afferma in un tweet.
Joe Biden torna a
parlare di aborto sul suo account Twitter personale. "Se il Congresso passerà un
bando nazionale, io metterò il veto", annuncia il presidente sul profilo
@JoeBiden, il secondo oltre a @Potus, che sta per 'President of the United
States'. Il tema dell'aborto è molto caldo negli Stati Uniti dopo che lo scorso
giugno, con una decisione storica la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza
degli anni '70 'Roe w Wade' che ne garantiva il diritto a livello nazionale
lasciando agli Stati la libertà di legiferare. Da allora molti Stati a guida
repubblicana hanno imposto regole rigidissime se non il divieto totale.
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha accolto con favore alcuni elementi
della mossa cinese ma ha chiarito che solo il Paese in cui si sta combattendo
una guerra dovrebbe essere iniziatore di un piano di pace, puntando ancora a
incontrare Xi e notando che il piano di Pechino sembrava dimostrare che "c'è
rispetto per la nostra integrità territoriale e per i problemi di sicurezza".
Il Dragone non
appare però intenzionato a mollare la partnership "senza limiti" con la
Russia. Ma rivendica la sua neutralità anche diplomatica. Lukashenko, il
presidente bielorusso, che ha fatto sapere di aver avuto ieri "una lunga
conversazione" con Putin, sarà a Pechino dal 28 febbraio al 2 marzo "su invito
di Xi", ha riferito una nota della diplomazia cinese. Il fedele alleato di Mosca
e il leader del Pcc hanno siglato una partnership strategica quando si sono
visti nella città uzbeka di Samarcanda a settembre 2022.
Un anno fa la
Bielorussia ha permesso alle truppe del Cremlino di usare il suo territorio come
trampolino per aggredire Kiev. Lukashenko, a inizio mese, ha detto che il suo
Paese era pronto a farlo di nuovo alimentando nuovi timori in Ucraina.
Sul fronte opposto
Macron, invece, sarà in Cina "all'inizio di aprile": ha invitato Pechino a
"premere sulla Russia" per porre fine alla guerra. La pace è possibile solo se
"l'aggressione viene fermata, le truppe ritirate e la sovranità territoriale
dell'Ucraina e del suo popolo rispettata.
Il fatto che la Cina
si stia impegnando negli sforzi di pace è una buona cosa". Ma anche il capo
dell'Eliseo ha chiesto "di non dare armi alla Russia". Anche l'Ue è impegnata a
tenere un canale diplomatico aperto con il Dragone: come ha reso noto il
ministero della Difesa cinese, giovedì a Bruxelles c'è stato un incontro tra una
delegazione di suoi militari e quella della Nato, riavviando così "il dialogo e
le consultazioni istituzionali" per la prima volta dallo scoppio della guerra
ucraina e della pandemia del Covid.
Estratto
dell’articolo di V.Ma. per il “Corriere della Sera” il 25 febbraio 2023.
A un anno
dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
approvato, con maggioranza di 141 voti su 193, una risoluzione che invita la
Russia a ritirarsi «incondizionatamente e immediatamente» dall’Ucraina per il
raggiungimento, il prima possibile, di una pace «complessiva, giusta e duratura»
nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Oltre 70 Paesi tra cui l’Italia
hanno co-sponsorizzato la risoluzione presentata da Kiev.
Sette i voti
contrari (Russia, Bielorussia, Siria, Nord Corea, Eritrea, Mali, Nicaragua). Ma
la Cina, il Sudafrica, l’India e altri Paesi del Sud del mondo (per un totale di
32 voti) hanno continuato ad astenersi, sottolineando la loro distanza da quella
che considerano una guerra dell’Occidente. Il numero totale è lo stesso del 2
marzo scorso, quando 141 Stati votarono per condannare l’invasione russa
dell’Ucraina e chiedere che Mosca ritirasse le truppe (allora i contrari erano
5, ai quali si sono aggiunti Mali e Nicaragua, che prima erano tra gli
astenuti). Sei mesi dopo, un numero più ampio (143 Paesi) difese l’integrità
territoriale e sovranità dell’Ucraina, dopo che Putin dichiarò l’annessione di
quattro regioni.
La risoluzione di
ieri è il risultato di settimane di negoziati, in cui gli alleati del G7 hanno
convinto Kiev a non premere per richieste molto specifiche o ampie, rischiando
che alcuni Paesi che in passato hanno votato a favore della sovranità ucraina si
tirassero indietro (il timore era che il sostegno scendesse a 135 voti).
All’inizio
l’Ucraina sperava di includere un riferimento al piano di pace in dieci punti di
Zelensky, ma il ministro Dmytro Kuleba si è limitato a menzionarlo nel suo
intervento iniziale, in cui ha affermato che nonostante «le vuote richieste» di
negoziati la Russia vuole ancora «distruggere l’Ucraina come nazione». […]
Kiev sperava
inoltre in una richiesta più specifica per la costituzione di un tribunale
speciale che giudichi Putin per il crimine di aggressione, ma l’Occidente non è
unito sul tema. L’idea viene considerata troppo punitiva da alcuni. Molti Paesi
del Sud del mondo, inoltre, desiderano la fine della guerra «al più presto
possibile» (come indica la risoluzione) e temono che un tribunale che giudica i
crimini di guerra possa rendere più restia l’elite politica russa a raggiungere
una soluzione.
Mentre si teneva
questo voto diventato un barometro sull’opinione mondiale sulla guerra, all’Onu
c’era grande attesa per il «piano di pace cinese». Pechino afferma che
presenterà un documento che contiene riferimenti alla Carta delle Nazioni Unite
e terrà conto dunque dell’integrità territoriale, della sovranità e della
sicurezza. Oggi Xi Jinping dovrebbe fare un «discorso sulla pace». […]
Ucraina: la
sconfitta del negoziato e il sosia di Zelensky.
Piccole Note
(Putinista) su Il Giornale il 27 Febbraio 2023
Zelensky rilancia. E
in un fantasmagorico uno-due dichiara che il suo Paese combatterà per altri
dieci anni e che si accinge ad attaccare la Crimea, mentre accumula un piccolo
esercito di 6-7mila armati ai confini della Transnistria, enclave russa situata
tra Ucraina e Moldovia (con Mosca che ha già avvertito sulle gravi conseguenze
di un eventuale attacco).
La visita di Biden
lo ha rafforzato, con Politico che spiega come il presidente americano l’avrebbe
incitato a lanciare una controffensiva. Operazione votata al suicidio, dal
momento che i russi si apprestano a completare il dispiegamento delle reclute,
ormai addestrate, provenienti dalla coscrizione obbligatoria lanciata quando è
iniziata la seconda fase del conflitto, cioè la guerra di logoramento in
Donbass.
Le pressioni su Kiev
per chiudere il conflitto
La pace può
attendere, dal momento che le pressioni per aprire un negoziato sembrano essere
state contrastate con efficacia. Tali pressioni erano iniziate con la visita del
Capo della Cia a Kiev a inizio gennaio, nella quale William Burns aveva spiegato
al suo interlocutore che l’America poteva sostenerlo per pochi mesi ancora e che
quindi si aprisse al negoziato.
Non il solo Burns,
ma, come rivelava il Washington Post, anche altri esponenti dell’amministrazione
Biden in quei giorni avevano visitato Kiev in segreto per sollecitare Zelensky a
mollare. Non è nell’interesse degli Stati Uniti che la guerra prosegua, ribadiva
in parallelo un documento della Rand Corporation.
Esplicitato, vuol
dire che gli Stati Uniti temono che la Russia possa vincere la guerra nei modi e
nelle forme con cui ciò potrebbe avvenire (collasso dell’Ucraina, collasso
improvviso delle forniture di armi Nato a Kiev etc).
Non essendosi
piegato alle sollecitazioni, la Cia aveva organizzato una sorta di golpe a Kiev,
costringendo il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, fedelissimo di Zelensky,
ad annunciare le proprie dimissioni, dopo una serie di scandali (relativi alla
corruzione) che avevano falcidiato l’inner circle del presidente ucraino,
finendo per lambire anche il ministro suddetto. Avrebbe dovuto sostituirlo il
capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov, più realista e soprattutto
legato a Burns per ragioni di intelligence.
Non solo, alcuni
giorni prima, Benjamin Netanyahu aveva annunciato di essere pronto a mediare tra
i contendenti, se ci fossero state le condizioni adeguate, ovvio. E,
successivamente, l’ex primo ministro d’Israele Naftali Bennet rivelava per la
prima volta che la sua mediazione tra Russia e Ucraina, svolta all’inizio della
guerra, era quasi riuscita, ma era stata fatta saltare da Regno Unito e Stati
Uniti (ma il riferimento al tentennamento di Biden era significativo… nasconde
le pressioni dei neocon sul presidente Usa, più conciliante).
Quando Sholz e
Macron hanno invitato Keiv ai negoziati
Così giungiamo a
metà febbraio, quando il Capo degli Stati Maggiori congiunti degli Stati Uniti,
generale Mark Milley, dichiarava che nessuno dei due contendenti poteva vincere,
da cui l’inevitabilità di aprire un negoziato.
Il canto del cigno
di tale pressioni si è consumato nel tour europeo di Zelensky. Pur se acclamato
come un eroe dal Parlamento di Bruxelles, nell’incontro a porte chiuse con Sholz
e Macron il presidente ucraino era stato pressato perché avviasse una trattativa
con i russi, come avevamo accennato in una nota pregressa, confermata da una
rivelazione della scorsa settimana del Wall Street Journal (Zelensky aveva
detto, invece, che avevano fatto un accordo segreto per l’invio di ulteriori
armamenti…).
Ma la pressione è
andata a vuoto. Qualcuno, molto potente (leggi Nato, neocon, Regno Unito etc) ha
spinto Zelensky a resistere, mandando a vuoto le pressioni per la pace e il
malcelato golpe a Kiev. Simbolo di tale fallimento, è appunto il fatto che le
dimissioni del ministro della Difesa sono rientrate (ma qualche maretta
continua: oggi Zelensky ha licenziato un alto comandante militare). Reznikov è
ancora saldamente al potere e della sua sostituzione non parla più nessuno.
A favorire tale
sviluppo anche il terremoto in Turchia, che ha reso fragile Erdogan, il quale è
una pedina fondamentale di questo puzzle geostrategico. dal momento che il
sultano ha stretto relazioni molto forti con Mosca, aiutandola a resistere alle
sanzioni in vari modi. Da ultimo accettando l’idea di creare di un hub per la
vendita del gas russo, progetto di cui si doveva parlare a metà febbraio, con
appuntamento rimandato causa sisma (peraltro, dopo il terremoto, la sua
opposizione all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato si è ammorbidita).
Il Che Guevara
ucraino e il suo sosia
Così Zelensky in
questi giorni ha rilanciato, annunciando, al solito, azioni potenzialmente
foriere di portare a una guerra termonucleare. Tale il lucido delirio del
presidente ucraino (e dei suoi sponsor), che pure è presentato come una sorta di
novello Che Guevara. Tale la proiezione che gli hanno cucito addosso i suoi
sceneggiatori e sponsor (insieme alla magliettina military style).
Resta, però, quanto
scrive William Schryver in un meditato articolo pubblicato sul Ron Paul
Institute: “La mossa di usare l’Ucraina come un attentatore kamikaze per ferire
mortalmente la Russia è fallita miseramente sotto ogni aspetto geostrategico
fondamentale”.
La fazione più
realista dell’Occidente vuole incassare quanto guadagnato finora, in particolare
la subordinazione totale e provvisoriamente definitiva dell’Europa agli Stati
Uniti, cosa descritta in maniera implicita un articolo del New York Times dal
titolo “La guerra in Ucraina ha cambiato l’Europa per sempre”.
Teme, tale fazione,
che il prolungamento della guerra, oltre a devastare in maniera irreversibile
l’Ucraina (rendendola inservibile in futuro), logori eccessivamente il Vecchio
Continente e soprattutto la rete di alleanza globale degli Usa, forse più di
quanto possa logorare la Russia e il suo ruolo internazionale. E soprattutto
tema che il conflitto distragga troppe risorse dal confronto con la Cina.
Ma per ora tale
fazione, sconfitta, deve accodarsi all’assertività dei neocon, limitandosi a
tentare di frenarne le spinte eversive in attesa di future opportunità.
Chissà se una nuova
possibilità in tal senso andrà a svilupparsi, come la precedente, attraverso un
golpe più o meno mascherato in Ucraina. Nel caso servisse sostituire Zelensky,
c’è già pronto un suo sosia a Kiev, che potrebbe eventualmente prenderne il
posto.
L’esistenza del
sosia del presidente ucraino è stata svelata accidentalmente da un
simpatico filmato girato durante la visita di Biden a Kiev. E dire che Zelensky
aveva avanzato l’ipotesi che Putin fosse morto e a guidare la Russia fosse un
suo sostituto… Evidentemente era preparato sul tema…
Chissà se il sosia
in questione è lo stesso di cui aveva parlato il Washington Post che, a inizio
guerra, aveva rivelato che un sosia di Zelensky era riuscito a scappare in
Polonia “grazie all’aiuto dei sosia di Putin e di Kim Jong-un”.
Ma al di là
dell’ipotesi ironica sulla sostituzione di Zelensky e di altre, aleatorie, sul
presente e sul futuro, resta una guerra che non vuole finire. Una guerra
infinita, appunto, di quelle per le quali vanno matti, nel senso letterale del
termine, i neocon. Vedremo.
Quanto ci costi
guerra.
Giovanni Vasso su L’Identità il 28 Febbraio 2023
Dopo un anno di
guerra, la capacità di spesa delle famiglie italiane si è più che dimezzata e,
oggi, il 26% degli italiani teme di non riuscire più ad arrivare nemmeno a fine
mese. Un’indagine dell’osservatorio Changing World di Nomisma snocciola i numeri
della crisi, che morde la carne viva di un Paese in cui l’88% delle famiglie è
stata costretta a cambiare il proprio regime di vita per far fronte
all’impennata del carovita. Una famiglia su quattro spende tutto in spese
necessarie, dal cibo alle bollette; il 14% degli italiani lavora per guadagnare
meno di quanto servirebbe per affrontare le spese minime per vivere. Solo un
italiano su due riesce (ancora) a risparmiare. E lo fa con la paura del futuro,
non per la speranza del domani: il 38% mette quel che può da parte perché non sa
cosa può accadergli, il 23%, invece, si prepara ad affrontare con tranquillità
le spese impreviste che potrebbero insorgere. “Abbiamo preso coscienza del fatto
che si è delineato un new normal – ha spiegato in una nota l’analista Valentina
Quaglietti -, ma si è diffusa anche la consapevolezza che sarà sempre più
ricorrente il verificarsi di nuove normalità”. E tutte al ribasso.
Proprio per fare il
punto della situazione sulle difficoltà delle famiglie, la Cassa di previdenza
di ragionieri ed esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha organizzato
un webinair intitolato “Guerra, inflazione, aumento dei tassi e del debito. Come
aiutare famiglie e imprese nell’anno dell’incertezza?”. All’incontro hanno preso
parte tecnici e politici. Come Ylenja Lucaselli, parlamentare di Fdi e membro
della Commissione bilancio alla Camera secondo cui “il modo migliore per aiutare
famiglie e imprese in una congiuntura economica difficile, come quella cui
stiamo assistendo in tutto il mondo, è fare in modo che le risorse economiche a
disposizione vengano indirizzate non più attraverso una sterile politica di
bonus a pioggia bensì indirizzandole prioritariamente a chi è più in
difficoltà”. Per Fratelli d’Italia occorre aiutare i più poveri “a sostenere i
costi energetici, l’aumento dei costi delle materie prime e quello dei beni di
prima necessità; dall’altro cercando di aumentare il potere d’acquisto degli
stipendi più bassi, aiutando anche chi uno stipendio non lo ha”.
Il capogruppo M5s
in commissione Finanze Emiliano Fenu batte dove il Superbonus (e non solo)
duole: “Possiamo aiutare famiglie e imprese in questo anno di incertezza tenendo
in piedi quelle che erano le misure già esistenti. Anziché definanziare il fondo
per le morosità incolpevoli lo si poteva tenere attivo o lasciare attivi gli
sconti su carburanti e accise. Altro modo per aiutare milioni di italiani è
quello di cercare di non eliminare il Reddito di cittadinanza. Si possono
sostenere le imprese cercando di tenere in piedi le misure che hanno creato
sviluppo economico in questi due anni, a cominciare dai bonus edilizi che hanno
consentito all’edilizia e tutto quello che si porta con sé una buona fetta del
6,7 per cento del Pil del 2021 di continuare alimentare la crescita senza
inventarsi nulla di nuovo”. Il deputato PiùEuropa Luca Pastorino avverte:
“L’aumento dei tassi incide pesantemente sui prestiti e sulle rate dei mutui
stipulati dai nostri concittadini. Se è vero che l’inflazione si combatte
alzando i tassi d’interesse, dall’altro non possiamo esporre le famiglie a
questa ‘tempesta perfetta’ i cui effetti devastanti vanno a incidere proprio sui
redditi più bassi”. Occorrono interventi di sostegno mirati e un approccio alla
riforma fiscale che parta proprio da chi sta peggio, dalle esigenze di coloro
che non ce la fanno a pagare i debiti con il Fisco perché colpiti dalla crisi
economica”.
Previsioni
errate. La guerra di Putin non ha impoverito l’Italia e il sostegno all’Ucraina
non è un vero problema.
Gianni Balduzzi su
L’Inkiesta il 28 Febbraio 2023.
Gli effetti
economici dello scontro con Mosca sono molto ridotti rispetto alle attese. Ma
molti cittadini seguono ancora la propaganda dei neutrali che vorrebbero vendere
la libertà di Kyjiv in cambio di guadagni irrisori
«Le sanzioni alla
Russia fanno male più a noi che a loro», quante volte abbiamo sentito ripetere
questa frase nell’ultimo anno? È stata anche la posizione dell’ex premier
Giuseppe Conte, sempre in prima fila nel chiedere il disimpegno italiano,
l’interruzione dell’invio, peraltro estremamente limitato, di armi all’Ucraina.
Non si tratta solo
del consueto pessimismo, dell’inclinazione alla lamentela dell’italiano medio,
abituato a decenni di declino economico, a previsioni positive smentite da una
realtà più fosca.
È anche il risultato
di una narrazione precisa, in parte pilotata, ma soprattutto spontanea, che
vuole la Russia e il suo leader, Vladimir Putin, come potenti, quasi invincibili
di fronte a un Occidente fragile e visto sempre sul bilico del declino.
È una visione
presente anche in altri Paesi ma, mentre lì è assolutamente minoritaria, in
Italia affascina tantissimi, e non solo coloro che sono esplicitamente
filorussi, ma anche chi Putin lo teme. Lo teme, appunto, perché lo ritiene più
forte di quanto sia, mentre considera l’Italia, l’Unione europea, il mondo
occidentale più debole di quel che in realtà si sta dimostrando essere.
Non è un caso,
infatti, che questa narrazione resiste anche di fronte ai fatti, ovvero alla
smentita delle fosche previsioni fatte all’indomani dell’inizio dell’invasione
dell’Ucraina.
Allora i centri
studio di due delle maggiori organizzazioni del nostro sistema produttivo,
Confindustria e Confcommercio, avevano elaborato stime molto pessimiste sulla
nostra economia.
La prima prevedeva
che il Pil sarebbe cresciuto nel 2022 solo l’1,9 per cento nel migliore dei
casi, e meno, l’1,6 per cento, in uno scenario, definito «avverso», ovvero se la
guerra fosse durata fino a dicembre, o l’1,5 per cento se invece fosse andata
anche oltre, come sta facendo. Per i commercianti invece l’economia si sarebbe
fermata al 2,1 per cento. La realtà è che il prodotto interno lordo è aumentato
del 3,9 per cento.
Dati Confindustria,
Confcommercio, Istat
Naturalmente è
facile ora, con il senno di poi, fare le pulci a chi allora era in ambasce per
quel che accadeva, si potrebbe dire. Però è interessante notare che nello stesso
periodo, l’aprile scorso, altri previsori, come il Governo italiano con il Def,
e il Fondo Internazionale con il suo outlook periodico, vedessero un po’ meno
nero, rispettivamente una crescita del 3,1 per cento e del 2,3 per cento.
Il tessuto
produttivo, insomma, era ancora più negativo delle istituzioni nazionali o
internazionali. Vi erano alla base degli assunti, la convinzione che
l’incertezza economica e finanziaria e i costi delle materie prime sarebbero
stati molto alti.
Per quanto riguarda
la prima Confindustria prevedeva che il Financial Stress Index (FSI), che
raccoglie ben trentatré variabili (nell’ambito del credito, dei tassi di
interesse, della volatilità della Borsa, ecc) sarebbe schizzato in alto, oltre i
tre punti negli scenari che prevedevano una maggiore durata del conflitto. In
realtà sono stati toccati quei valori solo per alcune settimane in autunno e da
fine dicembre si è scesi al livello base e sotto.
Dati Confindustria,
OFR
Tra i motivi del
miglioramento c’è il calo del prezzo delle materie prime. Il petrolio per Viale
dell’Astronomia sarebbe schizzato a 111,91 dollari al barile (prezzo del Brent),
rimanendo vicino ai cento o oltre anche nel 2023. Da fine 2022, invece, la
quotazione oscilla tra ottanta e novanta.
Dati Confindustria,
Brent
Confindustria, poi,
temeva che il gas sarebbe rimasto intorno ai 126,4 euro per MWh fino a fine anno
non scendendo sotto i cento neanche nel 2023. Qui la smentita delle previsioni è
stata ben più spettacolare.
La capacità del
mercato di trovare e aprire nuove fonti di approvvigionamento (più un
autunno/inverno mite) hanno fatto in modo che dopo un picco in agosto, quando fu
superata quota duecento euro, le quotazioni siano scese nell’ultima parte
dell’anno. Anzi, si è arrivati ora a livelli più bassi di quelli precedenti alla
guerra, anche sotto i cinquanta euro.
Non solo, in Europa
gli stoccaggi non sono mai stati così pieni, superiori ai sessanta miliardi di
metri cubi, il cinquanta per cento maggiori di quelli medi del periodo 2015-19,
mentre il gettito russo dalla vendita del gas naturale è un terzo di quello che
era prima dell’invasione.
Dati Confindustria,
TTF
Dal punto di vista
macroeconomico il dato del Pil molto migliore delle stime è motivato
dall’andamento più lusinghiero degli investimenti, dei consumi, dell’export.
I primi avrebbero
dovuto subire una brusca frenata dopo l’impennata del 2021, fermandosi ad
aumenti del 3,4 per cento (per Confcommercio), o del 4,1 per cento (per
Confindustria). In realtà almeno nei primi tre trimestri dell’anno gli
incrementi sono stati più che doppi, se non tripli.
Dati Confindustria,
Confcommercio, Istat
Le esportazioni,
poi, non sarebbero dovute andare oltre un +2,8 per cento (per Confindustria) o
un +3,6 per cento (per Confcommercio), ma almeno in volume sono salite in realtà
del 7,7 per cento.
Anche l’occupazione
sta avendo performance migliori delle stime. L’andamento delle unità di lavoro è
un buon indicatore. Rappresentano il numero dei lavoratori a tempo pieno che vi
sarebbe mettendo insieme sia chi è impiegato quaranta ore sia chi è part
time (due part time a venti ore valgono quindi uno).
È cresciuto del 4,5
per cento contro previsioni molto più asfittiche, che preventivavano incrementi
inferiori al due per cento.
Il risultato è che
la disoccupazione è scesa al 7,8 per cento, mentre gli imprenditori pensavano
che non sarebbe andata al di sotto dell’8,8 per cento neanche nel 2023.
Dati Confindustria,
Confcommercio, Istat, Upb Camera
Si tratta di dati
nel complesso molto positivi, che però non stanno emergendo molto nel discorso
pubblico. Neanche le forze politiche che potrebbero provare a intestarsele ne
parlano molto.
Potrebbe farlo
quella parte del centro e della sinistra che appoggiava il Governo Draghi,
oppure ora anche il centrodestra che governa da almeno quattro mesi. Invece
prosegue la narrazione della crisi provocata dalla guerra, dalle sanzioni, passa
l’idea che l’inflazione sia causata quasi solo dalla scelta di emanciparsi dalla
dipendenza energetica dalla Russia.
In fondo non è un
caso che il Paese occidentale in cui la propaganda anti-Nato, anti-Stati Uniti,
anti-Unione europea e allo stesso tempo filorussa fa più presa sia anche quello
in cui una volta si parlava di lotta dell’«oro contro il sangue».
Questa retorica
nazionalista che contrappone l’ideologia patriottica alla forza economica e
tecnologica, privilegiando la prima, come fanno oggi i propagandisti di Mosca,
sembra essere sempre viva in Italia.
E del resto è
strettamente collegata a una sottovalutazione diffusa dell’importanza delle
dinamiche dell’economia e della ricerca e si accompagna a un analfabetismo
finanziario sempre molto alto, oltre che a vaghi sentimenti anti-capitalisti
mutuati dagli -ismi più popolari in Italia, fascismo, socialismo e comunismo
(spesso catto-comunismo).
Anche qui nasce la
fascinazione verso Vladimir Putin o perlomeno il timore verso la sua presunta
potenza, la concezione che avere un presunto pensiero forte valga di più che
avere a disposizione i miliardi di dollari o sistemi militari e satellitari più
avanzati.
Non è così: l’oro
batte il sangue, la tecnologia e il denaro, la capacità industriale batte
l’ideologia e lo sciovinismo. Il paradosso è che di questa “vittoria dell’oro”
stiamo beneficiando anche noi ora, i dati, appunto, lo dimostrano, ma ne siamo
inconsapevoli.
Nonostante gli
effetti economici dello scontro con Mosca siano molto minori del previsto, la
maggior parte degli italiani è pronta a vendere la libertà degli ucraini in
cambio di guadagni quasi inesistenti, il tutto in nome di una narrazione
fasulla, frutto di vecchie ideologie mai morte.
Estratto
dell’articolo di Federico Rampini per il “Corriere della Sera” il 7 marzo 2023.
Dovremmo imparare
qualcosa dall’Apocalisse che non è mai avvenuta. Un anno fa a quest’epoca
l’Occidente cominciava ad applicare le sanzioni economiche contro la Russia. Ne
seguì uno psicodramma nazionale, sui danni tremendi che ci saremmo auto-inflitti
con quelle sanzioni. […] Una maxi-recessione con crolli di reddito e di
occupazione doveva abbattersi su di noi, causata dalla perdita del mercato russo
e dal rincaro energetico.
Avremmo passato un
inverno al gelo.
Le penurie
alimentari, oltre ad affamare il popolo italiano, avrebbero gettato in una
carestia senza precedenti il «grande Sud globale»: con guerre civili e altre
gigantesche ondate di profughi verso le nostre terre. Un anno dopo, nulla di
tutto ciò si è verificato.
L’arrivo di una
recessione continua a slittare […] Sul mercato del lavoro fa notizia la
difficoltà delle imprese a trovare la manodopera […] Non abbiamo passato
l’inverno al gelo. Il gas oggi costa meno di prima della guerra. Un dato spicca
su tutti, è l’exploit delle esportazioni italiane in questi dodici mesi che
dovevano essere rovinati dall’impatto delle sanzioni.
L’export del made
in Italy ha conosciuto un rialzo del 20% nel 2022. […] Per spiegare l’anno
felice del «made in Italy», la chiave ce la fornisce l’Istat: è il formidabile
incremento negli acquisti di prodotti italiani da parte degli Stati Uniti
(+22,5%). La distanza dalle profezie apocalittiche di un anno fa è abissale. Ci
impone di analizzare le cause di una previsione così clamorosamente sbagliata.
La Russia […] ha
un’economia minuscola: pesa un quattordicesimo di quella americana, non si
classifica tra le prime dieci economie del pianeta. […] Viceversa, ciò che è
avvenuto all’economia italiana nel 2022 ci ricorda a quale mondo apparteniamo.
Il concetto di Occidente non evoca soltanto una realtà geopolitica, un sistema
di alleanze, un modello di valori […] è anche un aggregato di interessi
materiali, costruito in molti decenni di scambi commerciali e investimenti. I
nostri mercati di gran lunga più importanti sono e resteranno sempre dislocati
sull’asse atlantico, situati nell’Unione europea e nel Nordamerica.
Un altro allarme da
ridimensionare riguarda il costo dei nostri aiuti all’Ucraina. […] Il grosso di
quanto abbiamo speso «per l’Ucraina», in realtà lo abbiamo dato a noi stessi:
aiuti pubblici per attutire l’impatto del caro-energia sulle nostre famiglie e
imprese. All’Ucraina sono andate le briciole, in confronto. […]
Dopo aver
constatato che anche questa Apocalisse era un’allucinazione, dovremmo concederci
un riconoscimento. Se i danni paventati non si sono verificati, lo dobbiamo ai
due ingredienti del modello occidentale: l’economia di mercato e la democrazia.
Il sistema capitalistico è fatto per reagire con flessibilità agli shock
esterni, per esempio con i risparmi energetici e le innovazioni sostenibili nel
mondo delle imprese. La liberaldemocrazia è per sua natura reattiva di fronte ai
disagi dei cittadini, lo si è visto nella prontezza con cui le risorse pubbliche
sono state mobilitate per attenuare il caro-bollette […] Un anno fa nessuno
immaginava che ci saremmo emancipati così velocemente dal gas russo. […]
Articolo di “El
Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione” il 7 marzo 2023.
Il forte calo dei
consumi di gas, gli arrivi record di navi metaniere e le temperature più miti
del normale hanno permesso all'Europa di superare il taglio delle forniture
russe.
Solo un anno fa,
con la guerra appena iniziata e la Russia che minacciava di tagliare le
forniture, l'Europa temeva lo scenario peggiore: un inverno freddo senza
carburante per l'industria e le famiglie. Oggi, con la primavera alle porte,
l'UE ha attraversato il Rubicone della stagione fredda più comodamente del
previsto – scrivono i giornalisti di El Pais
L'UE ha consumato
circa 500 miliardi di metri cubi (bcm) di gas, di cui la Russia ha fornito circa
140 miliardi di metri cubi (bcm), quasi il 30%. La dipendenza dal gas russo è
stata massima in grandi Paesi come l'Italia (40%) e la Germania (60%). La
chiusura all'inizio di settembre del gasdotto Nord Stream, la principale via di
importazione del gas russo, ha ridotto questi 140 miliardi di metri cubi ad
appena 60 miliardi di metri cubi nel 2022. I conti non tornano.
Come ha fatto il
continente a superare la più grande crisi energetica della sua storia? In breve,
tutto ciò che poteva andare bene è andato bene; e ciò che poteva andare male non
è andato male. Di seguito, una rassegna dettagliata dei fattori chiave che hanno
caratterizzato il primo inverno senza gas russo.
Temperature più
calde del solito
Il clima ha aiutato
molto a superare questo primo test. Se l'inverno del 2022 fosse stato rigido,
con livelli di mercurio costantemente sotto lo zero nel quadrilatero immaginario
tra Parigi, Monaco, Amsterdam e Berlino - dove vive un'altissima percentuale
della popolazione dell'UE - la situazione sarebbe stata radicalmente diversa. Ma
la fortuna è stata dalla parte del blocco: le temperature sono state miti, con
alcuni dei mesi più caldi degli ultimi 20 anni e intere settimane più tipiche
della primavera.
Questo è stato
fondamentale: secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE),
poco più della metà del calo della domanda domestica è direttamente collegato a
questa anomalia.
Ma queste
temperature straordinariamente elevate hanno anche un rovescio della medaglia.
Il cambiamento climatico sta riducendo le precipitazioni e aumentando gli
episodi di siccità anche al di fuori della penisola iberica: la Francia sta
vivendo l'inverno più secco dal 1959 e le centrali nucleari, che generano il 70%
dell'elettricità, hanno bisogno di acqua per il raffreddamento.
In Spagna - e anche
in Portogallo - il buon tono dei bacini è essenziale per il funzionamento
dell'energia idroelettrica. E, come è emerso chiaramente negli ultimi tempi, una
minore attività in entrambe le tecnologie è sinonimo di un maggiore utilizzo di
impianti a ciclo combinato, dove il gas viene bruciato per produrre elettricità.
I prezzi record
frenano la domanda
Il consumo di gas
nell'Unione Europea nel 2022 è diminuito del 13%, con un risparmio di 70
miliardi di metri cubi rispetto al 2021, la più grande riduzione in termini
assoluti della storia, ha pubblicato l'AIE nella sua ultima monografia
sull'argomento.
"L'aspetto
principale è che l'UE è stata in grado di ridurre i propri consumi, uno sforzo
che è stato quasi equamente condiviso tra industria e famiglie", afferma Ben
McWilliams del think tank Bruegel di Bruxelles. I prezzi elevati hanno stimolato
il calo della domanda delle famiglie e sono stati fondamentali per il passaggio
di alcune industrie al petrolio".
Secondo i dati del
think tank, tutti i Paesi dell'UE hanno ridotto i loro consumi nel 2022, ma il
calo è stato drastico nei Paesi del Nord. La Finlandia ha speso il 48% in meno
di gas rispetto alla media dei tre anni precedenti. Tra i Paesi con la domanda
più elevata, la Germania ha diminuito il consumo del 14%, l'Italia del 7%, la
Francia del 9% e la Spagna solo del 3%.
Alla fine di
febbraio, il responsabile dell'azienda energetica italiana Enel, Francesco
Starace, ha dichiarato a EL PAÍS che l'eccesso di domanda - il grasso, potremmo
dire: quello che può essere ridotto senza quasi alcun impatto economico - si
aggirava in media intorno al 15% nei Paesi del blocco. Al di sopra di questa
cifra, i dubbi aumentano: cosa succederà quando i prezzi scenderanno, sarà
temporaneo o permanente? Una parte di questo impatto deriverà
dall'elettrificazione - ad esempio, la sostituzione delle caldaie a gas con
pompe di calore nelle case; una parte - la più pericolosa - dalla migrazione di
industrie precedentemente basate in Europa verso altri continenti.
"In alcuni settori,
le perdite di imprese sono state molto significative", ricorda Jorge Fernández,
coordinatore del Laboratorio per l'energia dell'Istituto basco per la
competitività (Orkestra). Notizie come la delocalizzazione degli stabilimenti
della BASF [il colosso chimico tedesco] sono un esempio di come la crisi
energetica stia colpendo l'industria". Anche Samantha Dart, responsabile
dell'analisi del gas presso Goldman Sachs, mette in guardia dal sintomo BASF:
"Alcune perdite nell'attività industriale europea saranno permanenti". Il fatto
che la distruzione della domanda sia stata particolarmente intensa nel settore
industriale, afferma José María Yusta, esperto di mercati energetici e
infrastrutture critiche presso l'Università di Saragozza, "non è una buona
notizia e anticipa la delocalizzazione di impianti che dipendono fortemente da
costi energetici competitivi".
L'Atlantico
trasformato in un gigantesco corridoio per il GNL
Tre lettere hanno
cambiato completamente il paradigma energetico europeo: LNG, l'acronimo di gas
naturale liquefatto che viaggia (congelato) in grandi navi metaniere. Nel 2022
sono arrivati nei porti europei 60 bcm di GNL in più rispetto al 2021, con un
aumento del 60%. Due terzi di queste nuove importazioni provengono dagli Stati
Uniti, secondo i dati dell'AIE, trasformando l'Oceano Atlantico in un enorme
corridoio energetico. Gli altri fornitori sono anni luce indietro rispetto al
gigante statunitense, ma la Russia è ancora tra questi, con 2 miliardi di metri
cubi di gas liquefatto in arrivo dalla Russia. Consapevole delle sue debolezze,
Bruxelles si è preoccupata di porre il veto al GNL proveniente da Mosca.
In totale, il GNL ha
rappresentato un terzo del gas importato nel 2022 e, sommato, è diventato la
principale alternativa di approvvigionamento per i Paesi dell'UE, davanti alla
Norvegia e, soprattutto, alla Russia, che era il partner principale.
Per poter ricevere
questo enorme volume di gas via mare, l'Europa ha fatto un passo avanti nelle
infrastrutture. La Germania, il maggior consumatore, è arrivata alla crisi senza
un solo impianto di rigassificazione, necessario per trattare il GNL. Da allora
ne ha già messi in funzione due, più un altro nei Paesi Bassi. Nei prossimi mesi
è prevista la costruzione di altri venti impianti, non solo nel nord: l'Italia
ne ha in programma tre e Grecia, Cipro e Croazia uno ciascuno, secondo Gas
Infrastructure Europe (GIE). Dall'altra parte dell'equazione, gli Stati Uniti
prevedono di triplicare la loro capacità di liquefazione entro il 2027, secondo
i dati di Adrian Mason di GlobalData Energy.
Non si tratta di
un'autocelebrazione o di una risposta - da parte di acquirenti e venditori di
gas - ai prezzi alle stelle degli ultimi tempi: nel 2022, anche le stelle si
sono allineate a migliaia di chilometri di distanza. L'appetito vorace
dell'UE-27 ha coinciso con un ritiro senza precedenti del più grande importatore
mondiale di GNL, la cui domanda è crollata a causa della politica di zero covid,
lasciando un inaspettato spazio di manovra al resto dei principali consumatori,
la maggior parte dei quali sono europei.
La fine delle
restrizioni alla mobilità nel gigante asiatico solleva ora diverse domande:
l'Europa avrà un nuovo rivale nella sua lotta per i carichi di gas? La risposta
più probabile della mezza dozzina di esperti consultati è sì. Ciò ridurrà la
quantità di gas disponibile sui mercati internazionali e renderà più costosi i
prezzi del gas. "La domanda globale si modererà, ma non si prevede una
recessione e la ripresa della Cina potrebbe avere un impatto positivo", afferma
Fernández di Orkestra. "Quest'anno alcune di queste circostanze non si
ripeteranno: saremo in concorrenza con le importazioni di GNL dalla Cina e
dall'Asia in generale (Thailandia, India...), che stanno già aumentando".
Anche se la ripresa
della Cina non è immediata, la situazione potrebbe peggiorare. "I Paesi europei
non firmano contratti pluriennali, il che ci lascia nelle mani di un mercato a
breve termine, più volatile e speculativo", sottolinea Yusta, professore
dell'Università di Saragozza. Questa riluttanza a firmare accordi pluriennali ha
a che fare soprattutto con l'impossibilità di prevedere il ritmo della
transizione energetica: l'andamento futuro del consumo di gas fossile dipenderà
in larga misura dalla velocità di crescita del biometano (una molecola identica,
ma prodotta dai rifiuti) e delle energie rinnovabili.
Serbatoi
notevolmente più pieni: un cuscino inaspettato per il prossimo inverno
La riduzione dei
consumi e l'aumento delle importazioni di GNL hanno fatto sì che l'Unione
europea registrasse un livello record di stoccaggio di gas in questa fase
dell'anno, con impianti di stoccaggio pieni per quasi il 60%. "Si tratta di un
record storico [per questo periodo dell'anno]: lo scenario di riferimento
prevedeva un livello di circa il 40%, inferiore al 30% nel caso di un inverno
freddo", ricorda Yusta. Questo tono migliore semplificherà il compito di
rifornimento "con le forniture di gasdotti dall'Algeria e dalla Norvegia e
l'arrivo di navi metaniere durante la primavera e l'estate". Bruxelles ha
fissato l'obiettivo di riempire i serbatoi di stoccaggio del blocco al 90% entro
il 1° novembre. Una cifra che, ai livelli attuali, sembra fattibile.
L'anno scorso,
l'istruzione dell'UE di arrivare a questa data con lo stoccaggio all'80% "ha
portato a una pressione al rialzo sul prezzo del gas naturale in tutta Europa
durante l'estate", ricorda Fernández. "Ora è possibile riempire lo stoccaggio a
livelli superiori al 90%, ma il contesto è quello di una maggiore concorrenza
per il GNL". In questo contesto, afferma Fernández, "la sicurezza
dell'approvvigionamento per l'inverno dipenderà anche dal mantenimento delle
politiche di riduzione dei consumi, dalla continua promozione del cambio di
combustibile nell'industria e nelle famiglie e dalla penetrazione delle energie
rinnovabili". Soprattutto se il prossimo inverno sarà più freddo.
Gonzalo Escribano,
dell'Istituto Reale Elcano, è più ottimista: "Guardando all'attuale livello di
riempimento, se non raggiungeremo il 100%, ci andremo vicini. E questo significa
che le cose dovranno cambiare molto perché l'anno prossimo ci siano problemi di
approvvigionamento". Ma avverte: "Quale prezzo dovremo pagare? Gli Stati Uniti
invieranno quanto più possibile, ma sarà costoso".
Prezzi: calma o calo
definitivo?
Tra l'agosto 2021 e
l'agosto 2022, il prezzo del gas in Europa si è moltiplicato per 15: da 20 euro
per megawatt/ora a più di 300. Oggi, a inverno quasi finito, il prezzo del gas è
stato contenuto e si aggira intorno ai 50 euro. Nemmeno la recente ondata di
freddo ha intaccato questo nuovo - e fragile - equilibrio di potere.
Il prezzo attuale è
molto buono rispetto all'estate, ma è ancora il doppio rispetto a prima della
crisi e non sappiamo ancora se questa stabilizzazione sarà permanente. "Questo
livello non è sostenibile per il resto dell'anno", afferma Dart di Goldman
Sachs. Il motivo? Gli stessi prezzi attuali che, a suo avviso, eserciteranno una
pressione al rialzo sulla domanda, sia in Europa che nel resto del mondo. "Non
raggiungeranno i 350 euro dell'estate scorsa, ma pensiamo che potrebbero essere
intorno ai 100 euro nel terzo trimestre di quest'anno", scrive via e-mail. Cioè
nel bel mezzo della stagione dei rifornimenti.
Ora che l'anno della
crisi energetica è finito, è tempo di guardare alla prossima cartina di
tornasole: i serbatoi dovranno presto essere riempiti di nuovo per il prossimo
inverno. Dopo un anno di guerra, e nonostante la chiusura del Nord Stream 1,
Mosca continua a fornire circa il 10% della domanda europea di gas. Se chiudesse
completamente questo flusso residuo, il prossimo sarebbe in sanscrito.
"Tuttavia, se la storia dei mercati energetici ci ha insegnato qualcosa, è che
le condizioni possono cambiare in un tempo molto breve", avverte Fernández di
Orkestra. "C'è una falsa sensazione che la crisi sia finita", afferma Thierry
Bros di Sciences Po.
L’altra guerra:
in un anno l’Ucraina ha perso 3 milioni di ettari di foreste.
Simone Valeri su
L'Indipendente il 28 Febbraio 2023.
La guerra, qualunque
essa sia, non comporta solo morti e danni alle infrastrutture. Nonostante se ne
parli poco, a rimetterci vi è anche una vittima silenziosa: il già martoriato
ambiente naturale. Motivo per cui l’organizzazione internazionale Greenpeace e
l’ucraina Ecoaction hanno deciso di pubblicare una “Mappa dei danni ambientali”
causati dalla guerra. L’obiettivo è quello di denunciare i gravissimi impatti
sugli ecosistemi ucraini e chiedere l’istituzione di un fondo per il ripristino
dell’ambiente. Elaborando le informazioni ufficiali, è emerso come il conflitto
abbia già danneggiato circa il 20% delle aree naturali protette dell’Ucraina e 3
milioni di ettari di foresta. Altri 450 mila ettari si trovano poi in zone
occupate o interessate dai combattimenti. Nel complesso, si hanno incendi, danni
agli habitat, inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Le esplosioni, in
particolare, rilasciano nell’atmosfera anidride carbonica, la quale contribuisce
al cambiamento climatico, e ossidi di zolfo e di azoto, che possono provocare
piogge acide andando ad alterare il pH del suolo. Inoltre – spiegano le
organizzazioni ambientaliste – «anche i frammenti metallici delle granate sono
pericolosi per l’ambiente, la ghisa mista ad acciaio è il materiale più comune
per i bossoli delle munizioni e non contiene solo ferro e carbonio, ma anche
zolfo e rame. Queste sostanze si infiltrano nel terreno e possono finire nelle
acque sotterranee, entrando nelle catene alimentari di esseri umani e animali.
L’intera regione è pertanto a rischio di catastrofe e presenta gravi pericoli
per la salute della popolazione circostante». Alla luce di questi presupposti,
con l’occasione, gli ambientalisti hanno quindi anche chiesto al governo ucraino
e alla Commissione europea l’istituzione di un fondo per il ripristino
dell’ambiente, il quale dovrebbe andare di pari passo con la già preannunciata
ricostruzione delle città distrutte.
Già dal 2014, anno
dell’inizio del conflitto nel Donbass, parte dell’Ucraina è stata
progressivamente esposta ad un elevato rischio di contaminazione ambientale.
Soprattutto poiché, nella sola area del Donbass, vi sono oltre 4.500 imprese
minerarie metallurgiche e chimiche. Nel complesso, infatti, oltre ai già
descritti impatti ecologici intrinseci del conflitto, vi è un aumentato rischio
di danneggiamento dei siti industriali. Rischio che, tra l’altro, si è già
concretizzato. Il 13 marzo del 2022, ad esempio, le bombe russe hanno colpito e
gravemente danneggiato i centri di produzione e le tubature della centrale a
carbone di Avdiivka, il principale centro di gestione del combustibile in
Ucraina. La stessa sorte è toccata a Sumy, città nord orientale, dove i
bombardamenti hanno provocato nuvole di ammoniaca tossica, mentre nella regione
di Ternopil il danneggiamento di alcuni serbatoi di fertilizzanti ha riversato
nell’acqua una quantità della medesima sostanza 163 volte superiore rispetto
alla media. Lo scorso anno, ONG ed osservatori internazionali hanno stimato che,
in generale, sul territorio ucraino si siano verificati danni a più di 100
infrastrutture, quali centrali elettriche, depositi di carburante e impianti per
il trattamento e depurazione dell’acqua. Ad allarmare, in particolare, ci sono
poi le 465 installazioni di stoccaggio, situate vicino a centri abitati o fonti
di acqua (come i fiumi Dniester, Dnipro e Siverskyi Donets), che contengono 6
miliardi di tonnellate di rifiuti tossici. [di Simone Valeri]
Ecocidio. I
crimini ambientali dell’esercito russo in Ucraina investiranno l’Europa intera.
Fabrizio Fasanella su L’Inkiesta il 28 Febbraio 2023.
Non solo emissioni e
inquinamento (idrico e atmosferico): la guerra sta smantellando il settore
agricolo ucraino, distruggendo ettari di foreste (trasformate in campi di
battaglia) e compromettendo la sopravvivenza di centinaia di specie animali e
vegetali. Mosca ha invaso la patria della biodiversità europea
Aria e acqua sempre
più inquinate a causa dei danni alle strutture industriali. Foreste andate in
fumo per sempre. Parchi nazionali e riserve naturali sotto occupazione. Terreni
agricoli impossibili da coltivare per via delle mine e di tutti i metalli
pesanti contenuti nelle granate e nei missili. La minaccia dell’incidente
nucleare per i bombardamenti attorno alla centrale di Zaporizhzhia.
L’invasione russa
dell’Ucraina – che, secondo i dati della Convenzione per la diversità biologica,
ospita il trentacinque per cento della biodiversità del continente europeo – sta
causando danni ambientali dalla portata ancora difficile da definire, ma che
avranno senza dubbio delle conseguenze dirette sulla vita dei cittadini. A
partire dalla sicurezza alimentare. «L’impatto durerà decenni e avrà effetti a
lungo termine sui mezzi di sussistenza e sulla salute delle persone», ha detto
Doug Weir, policy director del Conflict and environment observatory,
al Geographical Magazine.
Ecocidio è il
termine più adatto a definire le azioni di Mosca sul territorio ucraino. Per
citare la Treccani: «Un’opera di consapevole distruzione dell’ambiente
naturale», con un impatto potenzialmente devastante sul sostentamento e sulla
salute della popolazione, oltre che sulla sopravvivenza di migliaia di specie
animali e vegetali che popolano un territorio vastissimo (il Paese più grande
d’Europa, esclusa la Russia) e ricco di risorse naturali come quello ucraino.
In una mail inviata
a Politico.eu, Ruslan Strilets, ministro dell’Ambiente e delle Risorse naturali
dell’Ucraina, ha scritto che l’invasione russa ha causato più di duemilatrecento
crimini ambientali: 1.078 di questi sono già stati denunciati alle autorità
competenti, con l’obiettivo di accumulare il materiale necessario per portare
Mosca in tribunale per ecocidio. I danni stimati superano quota 51,45 miliardi
di dollari (48,33 miliardi di euro).
Anche nel pieno di
una guerra in corso da più di un anno, segnalare questi eventi è fondamentale
non solo per ottenere eventuali risarcimenti dalla Russia, ma anche per
organizzare e attuare piani mirati di ripristino della natura e di bonifica del
suolo contaminato. Tuttavia, l’instabilità dovuta al conflitto innescato dai
russi rende queste attività molto complesse.
In tal senso stanno
giocando un ruolo chiave le Ong come l’olandese PAX: assieme al Center for
information resilience (Cir), continua a mettere nero su bianco tutti i danni
ambientali causati dalla guerra. Ovviamente, all’interno di un conflitto del
genere, le priorità assolute sono altre, e diversi progetti di conservazione
degli ecosistemi sono stati costretti a fermarsi temporaneamente (o, ancor
peggio, a chiudere i battenti).
Come anticipato, la
sicurezza alimentare dell’Ucraina – ma anche dell’intero continente,
considerando che in tempo di pace il Paese esportava anche sei milioni di
tonnellate di grano al mese – potrebbe essere a rischio a causa dello stato dei
terreni agricoli, in parte compromessi dai metalli pesanti delle munizioni. In
più, secondo il rapporto Agribusiness of Ukraine during the war, il quindici per
cento dei campi è contaminato dalle mine.
Queste ultime, in
particolare, rendono attualmente impossibile la coltivazione, e le operazioni di
sminamento coinvolgeranno in via prioritaria le aree urbane e residenziali. Un
ritardo che, come spiega a Politico.eu Oksana Omelchuk dell’Ong ucraina
EcoAction, ostacolerà «l’attuazione di qualsiasi progetto per il ripristino e la
conservazione delle specie».
Secondo il governo,
i danni diretti all’agricoltura del Paese (dovuti anche alla distruzione dei
macchinari e delle fattorie, alla perdita di carburanti e alla morte del
bestiame) ammontano a quota 6,6 miliardi di dollari: una cifra destinata a
crescere vertiginosamente, anche perché – come scrive su Twitter il ministero
della Difesa ucraino – i russi hanno rubato 400mila tonnellate di grano nel sud
dell’Ucraina. Il settore primario dell’Ucraina impiegherà circa cent’anni,
secondo uno studio pubblicato sull’European journal of soil science, per
riprendersi totalmente.
Ma i danni
ambientali della guerra non finiscono qui. Il venti per cento delle aree
protette, stando ai dati ufficiali, è considerato a rischio, compresi dieci
parchi nazionali e otto riserve naturali. La maggior parte dei combattimenti si
svolge nelle foreste, e infatti 450mila ettari sono occupati dai russi o teatri
di sanguinose battaglie tra i due eserciti. I russi, ha spiegato Strilets
durante la Cop15 di Montreal sulla biodiversità, «stanno trasformando le risorse
naturali ucraine in basi militari».
Da non
sottovalutare, inoltre, l’amianto rilasciato dagli edifici danneggiati o
distrutti dai bombardamenti; l’inquinamento prodotto dai veicoli e dai rifiuti
militari; i danni alle risorse idriche e al mare dovuti (anche) al carburante
delle navi affondate riversato in acqua. Un vero e proprio ecocidio che non sta
risparmiando nemmeno le specie animali del Paese.
«Sono stati
segnalati più di mille casi di delfini morti nel mar Nero, non solo nei pressi
delle nostre coste, ma anche in quelle delle regioni confinanti. Sulla base
delle rilevazioni che abbiamo a disposizione, i decessi aumentano in coincidenza
con il lancio dei missili da parte dei sottomarini di Putin», ha detto a Wired
il viceministro alla Protezione ambientale e alle Risorse naturali, Ruslan
Hrechanyk.
«L’anno scorso
abbiamo trovato solo tre delfini su tutta la nostra costa di quarantaquattro
chilometri (fa parte del Tuzly Estuaries National Nature Park, ndr). Quest’anno,
lungo i cinque chilometri a cui possiamo ancora accedere, ne abbiamo trovati già
trentacinque», sono le parole del ricercatore ucraino Ivan Rusevdi in
un’intervista concessa lo scorso agosto all’Angence France Press. Secondo Anton
Gerashchenko, consulente del ministero degli Interni ucraino, in dieci mesi di
guerra sono morti circa cinquantamila mammiferi marini.
La colpa è anche dei
rumori dei bombadardamenti in mare e delle navi da guerra, che stordiscono e
disorientano queste specie che popolano le acque del mar Nero. Secondo il
governo, i combattimenti stanno minacciando la sopravvivenza di circa seicento
animali e settecentocinquanta piante e funghi.
Tutto ciò va
inserito nel seguente contesto: la guerra, finora, ha causato l’emissione
diretta di trentatré milioni di tonnellate di gas serra. Inoltre, le attività
necessarie alla ricostruzione dell’Ucraina, stima il ministro dell’Ambiente,
potrebbero produrre fino a quarantanove milioni di tonnellate di anidride
carbonica. Come spiega Ruslan Strilets, «la Russia sta facendo di tutto per
accorciare i nostri e i vostri orizzonti. A causa degli scontri dovremo fare
ancora più sforzi per combattere la crisi climatica».
Onu: i ceceni
stanno «educando» i bambini portati via dai territori occupati.
Storia di Nello
Scavo, inviato a Kiev, su Avvenire il 24 Febbraio 2023
In Ucraina li
chiamano «orchi» perché «rubano i bambini». Per i russi sono «generosi
rieducatori». Come il ceceno Chalayev, che dopo la carneficina di Mariupol guida
la formazione degli adolescenti deportati a Grozny. Rinchiusi nel centro di
addestramento dei corpi speciali islamisti del dittatore Kadyrov. Oppure come
gli orfani condotti in una “colonia” in Crimea, dove hanno ricevuto un
passaporto russo. Il piano per l’indottrinamento dei “figli della guerra” non è
stato improvvisato. E dopo mesi di accuse e sospetti arrivano le conferme dai
funzionari Onu e dalle verifiche incrociate. Ora conosciamo i nomi e i volti dei
“cattivi maestri”. L’unica incertezza sono i numeri. «Al momento ci sono solo
delle stime e nessun dato certo. Quello che sappiamo è che sono state varate
delle norme in conflitto con il diritto internazionale», ci aveva risposto due
giorni fa l’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, che ha
confermato la pratica del cambio di cittadinanza per i minorenni soli portati
sotto il controllo delle autorità russe, e «altre norme approvate di recente che
facilitano l’adozione di questi bambini», in spregio al diritto internazionale.
Le famiglie ne hanno perso le tracce da mesi.
Alcune volte erano
state le mamme, rimaste senza marito a causa della guerra, a consegnare i figli
alle autorità russe o ai separatisti, con la promessa che li avrebbero portati
al sicuro e lontano dagli scontri. Adesso hanno paura di parlare con i
giornalisti. Temono di venire identificate dai russi e per rappresaglia perdere
ogni speranza di rivedere un giorno i loro bambini. «Credevo che Putin ci
avrebbe aiutati – racconta una sfollata di Mariupol –. Prima della guerra mi
piaceva l’idea di tornare ad avvicinarci a Mosca, ma quando ho visto come ci
hanno trattati veramente mi sono pentita. È colpa mia: ho affidato loro il mio
bambino e non mi dicono dove l’hanno portato». Nelle settimane scorse una mamma
del Donbass sfollata vicino a Kiev ha provato a raggiungere la Russia attraverso
la Bielorussia. Un disperato viaggio della speranza per trovare la figlia di
pochi anni. È stata respinta dai doganieri di Mosca.
In Crimea, oppure
sulla costa russa del pacifico, a 8.500 chilometri da qui, suo figlio potrebbe
essere ovunque. Le testimonianze dei genitori o dei familiari dei bambini
volontariamente consegnati a russi non sono sempre chiare. Ma c’è chi racconta
di non avere avuto scelta, sperando di potere offrire ai propri figli una
possibilità per sopravvivere ai bombardamenti e ai massacri avvenuti in molte
delle cantine “ripulite” dalle forze di occupazione.
I ricercatori del
Centro per i diritti umani dell’università di Yale hanno esaminato
testimonianze, immagini satellitari, foto che circolano sui social media russi.
Lo stesso fanno altre organizzazioni umanitarie indipendenti,
da Amnesty ad Human Right Watch, fino agli investigatori della Corte penale
dell’Aja, oltre alla procura generale di Kiev. Secondo Yale le strutture
dedicate ai ragazzini ucraini in Russia sono almeno 43. Stime prudenziali dicono
che i minorenni in mano russa siano almeno seimila, ma «ulteriori dati
suggeriscono che il numero totale di strutture e di bambini detenuti – spiegano
i ricercatori – è probabilmente molto più alto». Molti sono orfani prelevati
dagli istituti minorili ucraini. Tanti sono adolescenti prelevati all’inizio del
conflitto nei “campi di filtrazione”. Tra quelli individuati, il centro più
lontano si trova a Magadan, nell’Estremo Oriente russo, tre volte più vicino
agli Usa che al confine con l’Ucraina.
Per ottenere
conferme visive e facilitare l’identificazione, gli investigatori internazionali
si sono avvalsi di alcune soffiate e di materiali forniti da “Cc030 e Cc0301”
(Ceceno 030 – Ceceno 031), nome in codice di alcune fonti riservate in
territorio russo. Grazie ad essi è stato possibile, fra gli altri, avere
certezza del coinvolgimento dei kadyroviti, i soldati agli ordini di Ramzan
Kadyrov. In una delle immagini, che oggi pubblichiamo con i volti parzialmente
coperti, i ragazzi sono con quattro adulti. Non i migliori compagni di strada.
Nella foto sopra, si vedono da sinistra Vladimir Khromov (rappresentante del
Commissario presidenziale della Federazione Russa per i diritti dei bambini),
Zamid Chalayev (comandante del “Reggimento speciale Kadyrov”), Akhmed Dudayev
(ministro della Repubblica Cecena per la politica nazionale, le relazioni
estere, la stampa e l’informazione). Una serie di filmati raccolti da Avvenire,
riguardano proprio Chalayev. La propaganda cecena lo riprende mentre ordina gli
assalti, partecipa agli scontri a fuoco, mostra i cadaveri, studia le mappe
delle città che a mano a mano saranno rase al suolo.
Nel gennaio di
quest’anno Mosca ha dichiarato che 728.000 minorenni erano arrivati in Russia
dal febbraio 2022. La maggior parte di questi si trova ancora con le famiglie o
con adulti di riferimento. Il governo ucraino ha raccolto segnalazioni su oltre
14.700 bambini non accompagnati da adulti e classificati come «deportati».
Secondo documenti di Unicef e Unhcr-Acnur visionati da Avvenire, molti dei circa
100 mila bambini ospitati fino allo scoppio della guerra in istituti o collegi
ucraini, hanno parenti e tutori viventi. Già il 14 luglio 2022 Maria
Lvova-Belova, Commissario presidenziale per i diritti dell’infanzia della
Russia, aveva annunciato che «un totale di 108 “orfani del Donbass” che hanno
ricevuto la cittadinanza russa saranno assegnati a nuovi genitori in sei regioni
della Russia». Lei stessa, raffigurata dai media come donna pia e devota alla
causa dei più indifesi, il 21 settembre ha fatto sapere che il suo «figlio
adottivo di Mariupol» aveva appena ricevuto la cittadinanza russa. Per dare
l’esempio Lvova-Belova avrebbe adottato almeno otto bambini ucraini.
L’allontanamento
forzato dei minori è «un crimine gravissimo», commenta Filippo Ungaro, capo
della comunicazione di Save The Children: «Chiediamo una commissione
internazionale indipendente guidata dall’Onu che sia in grado di investigare e
approfondire, per determinare con precisione questi crimini e per tutelare
questi bambini e restituirli alle loro famiglie e alle comunità di origine».
Cosa sarebbe
successo se Putin non avesse invaso l’Ucraina? L’incredibile occasione mancata
dallo «zar».
Federico Rampini su Il Corriere della Sera il 25 Febbraio 2023.
Agli inizi del 2022,
lo zar aveva creato il clima a lui favorevole per ottenere (anche con l’arma del
ricatto energetico) grandi concessioni da parte dell’Occidente sulla sua
influenza nei Paesi dell’Est. Analisi di un storia possibile svanita con la
catastrofica scelta di aggressione militare
A quest’ora Vladimir
Putin avrebbe stravinto, già da un anno, e senza perdere un solo soldato. Se
solo avesse evitato l’invasione. Facciamo un balzo indietro con la memoria per
ricostruire il clima di inizio febbraio 2022.
Lo scetticismo
europeo sui preparativi di un’invasione russa. La processione di leader alla
corte dello Zar, disponibili a fare concessioni enormi. Perfino in America, il
peso allora influente di correnti di realpolitik che volevano dare a Mosca un
veto sull’adesione di Kiev alla Nato, trasformando l’Ucraina in un cuscinetto
neutrale e filorusso. Quell’inizio del febbraio 2022 fu un momento «magico» in
cui la Russia poteva esercitare il massimo della sua influenza senza colpo
ferire.
Immaginare una
storia alternativa — un’invasione solo minacciata e mai realizzata — dà la
misura di tutto ciò che Putin ha distrutto, oltre a tante vite innocenti: un
ruolo diverso per la Russia nel mondo, un Occidente più amichevole e perfino
arrendevole nei suoi confronti. Dettaglio finale, lo Zar ha frantumato il mito
di se stesso come grande stratega .
All’inizio di quel
febbraio 2022 l’allarme lanciato dall’intelligence anglo-americana sui
preparativi di un’aggressione imminente, veniva liquidato dai governi europei
come propaganda anti-russa. Molti preferivano abboccare alla versione ufficiale
di Mosca secondo cui quelle truppe ammassate al confine conducevano una
mega-esercitazione. Perfino Zelensky, all’inizio, fu scettico di fronte alle
informazioni che gli offrivano Washington e Londra.
Aria di
arrendevolezza
Tant’è, per evitare
che Putin passasse dalle «esercitazioni» agli atti, il mondo intero si
mobilitò. Visite, telefonate, tutti avevano qualcosa da offrirgli. Omaggio,
rispetto, visibilità, credibilità, ma anche concessioni concrete e sostanziose
sul piano geopolitico, per placare l’espansionismo russo. Era una gara a
prendere sul serio la teoria secondo cui Putin si sentiva «accerchiato», quindi
agiva mosso da un genuino senso di insicurezza, che andava curato regalandogli
una sfera d’influenza più larga. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz disse chiaro
e tondo che l’Unione europea si sarebbe allargata al massimo fino ai
Balcani, poi basta. Emmanuel Macron, che poco tempo prima aveva dichiarato «la
morte cerebrale della Nato», metteva in dubbio perfino l’allargamento Ue nei
Balcani, popolati da slavi che era pronto a regalare alla Russia.
Il piano B di
Washington
Il vento
dell’appeasement — arrendevolezza o cedimento — non soffiava solo sull’Europa
occidentale. Il 13 febbraio 2022 scrivevo sul Corriere di un «piano B» in
discussione a Washington, un elenco di concessioni a Putin. Biden aveva una
priorità, stare alla larga dal conflitto, evitare ogni coinvolgimento. Lanciò un
appello ai cittadini americani presenti sul territorio ucraino perché partissero
subito, avvisandoli che non avrebbe mandato un solo soldato per evacuarli. L’ex
ambasciatore di Barack Obama a Mosca, Michael McFaul, evocò un «grande patto con
Putin per evitare la guerra». Due tra i maggiori think tank strategici ascoltati
dalla Casa Bianca e le riviste geopolitiche dell’establishment americano,
Foreign Affairs e Foreign Policy, si sforzavano di trovare compromessi da
offrire a Putin. Tra questi una «finlandizzazione» dell’Ucraina, termine che
evocava la neutralità imposta alla Finlandia per rassicurare l’Unione sovietica
durante la prima guerra fredda. Spuntava anche l’ipotesi di un grande negoziato
con Putin, per concordare con lui varie garanzie sulla sicurezza della Russia,
sul modello degli Accordi di Helsinki nella seconda metà degli anni Settanta. A
ispirare le concessioni c’era, tra l’altro, una profonda sfiducia sulla capacità
dell’Occidente di reagire compatto di fronte all’invasione di uno Stato sovrano.
Sul fronte delle future e ipotetiche sanzioni da prendere, per esempio, Scholz
si era rifiutato di mettere in gioco il gasdotto Nord Stream 2. Vista la
dipendenza dell’Europa dalla Russia per il 55% delle sue forniture di gas,
Washington non s’illudeva di poter convincere gli europei a mollare quel cordone
ombelicale.
Putin era in una
posizione invidiabile: con un prestigio ai massimi, molti leader occidentali
genuflessi, pronti a concedergli un diritto di signoraggio su paesi ex-satelliti
dell’Urss che presto rischiavano di tornare ad essere Stati vassalli della
Russia. Dietro l’Ucraina: Georgia, Moldova e poi un giorno, forse, i Baltici, se
funzionava il ricatto che consiste nel fare leva sulla «difesa delle minoranze
russofone». Se soltanto Putin fosse rimasto allo stadio della minaccia, del
bluff, di una guerra solo virtuale, oggi staremmo analizzando la rinascita di un
impero russo, con la Nato allo sbando, l’Occidente umiliato, l’Unione europea
costretta a sottoporre ogni futura candidatura al vaglio di un vicino
prepotente.
Danni autoinflitti
Chiuso lo scenario
della storia ipotetica, resta l’elenco delle perdite che Putin si è inflitto da
solo. Oltre, naturalmente, ai duecentomila soldati russi che ha mandato a morire
al fronte.
Ben lungi
dall’essere «finlandizzata», l’Ucraina dopo un anno di massacri ha poche
certezze se non questa: il suo destino è a Occidente, il suo popolo non
perdonerà alla Russia gli orrori subiti, la scelta di campo è irreversibile. Una
nazione di 43 milioni di abitanti che per gran parte della sua storia fu legata
strettamente alla sua vicina orientale, ora le volta le spalle. Già nel giugno
2022, rispondendo agli accorati appelli di Zelensky, Scholz e Macron erano a
Kiev con Mario Draghi e con il presidente romeno Iohannis, per dare via libera
alla candidatura dell’Ucraina nell’Unione europea. Il percorso sarà lungo, gli
esami da superare sono tanti (incluse le riforme anti-corruzione), però lo
status formale di candidata è acquisito. La Commissione europea ha varato aiuti
economici, ha annunciato progetti per la ricostruzione, perfino la costituzione
di un nuovo centro giudiziario all’Aia per raccogliere prove sui crimini di
guerra dell’armata russa.
Sul fronte Nato le
novità sono addirittura più impressionanti. La stessa Finlandia non sarà più
«finlandizzata», insieme con la Svezia ha scelto di uscire da un’antica
neutralità per schierarsi con l’Alleanza atlantica. Il presidente turco Erdogan
ha preso in ostaggio queste due domande di adesione esercitando il suo veto, ma
anche se dovesse ritardare a lungo quell’ingresso, nei fatti gli eserciti
svedese e finlandese si stanno coordinando con la Nato. È un danno strategico
enorme per la Russia, che condivide un ampio confine terrestre con Helsinki e
marittimo con Stoccolma.
Sul futuro
posizionamento strategico dell’Ucraina ci sono pochi dubbi: sarà in qualche modo
associata alla Nato, o la sua sicurezza sarà garantita dagli alleati atlantici
nell’ambito di futuri accordi di pace, se e quando arriveranno. Ormai si è
convertito a questa idea perfino Henry Kissinger, il patriarca della
realpolitik, che all’inizio aveva posizioni più concilianti verso Putin.
Lungi dall’essere in
uno stato di «morte cerebrale», la Nato è stata resuscitata da Putin. Certo,
ancora tardano a realizzarsi le promesse di alcuni Stati membri (Germania e
Italia) di alzare le loro spese per la difesa fino al 2% del Pil. Certo, gli
eserciti europei si sono scoperti sottodimensionati, impreparati, con arsenali
esigui; ci vorrà tempo e perseveranza politica perché tutte le lezioni della
tragedia ucraina vengano apprese. Però, paradossalmente, questo ha spinto
l’Europa ancora più nelle braccia degli Stati Uniti: il contrario di ciò che
auspicava Putin. Le velleità — soprattutto francesi — di costruire una difesa
europea autonoma dalla Nato si sono infrante davanti alla dura realtà. Putin ha
cementato coloro che voleva dividere.
Danno di lungo
periodo
Lo stesso bilancio
si applica alle sanzioni. Non sono invalicabili, anzi, in alcuni settori sono un
colabrodo. Da sempre le sanzioni economiche vengono aggirate, Cuba, Corea del
Nord e Iran insegnano. Il mercato nero fiorisce. Ampie zone del pianeta, da Cina
e India al Golfo Persico, più Africa e America latina, non le applicano.
L’economia russa non è agonizzante, anche se conosce tante difficoltà. Però quel
che conta è il danno di lungo periodo nel settore energetico. Con pazienza,
cinismo e lungimiranza, generazioni di leader sovietici avevano costruito
infrastrutture pesanti per portare energia a buon mercato all’Europa, in modo da
renderla dipendente. Putin ha distrutto il lavoro dei suoi predecessori. La
Germania di Scholz — pur essendo lenta e impacciata nel riarmarsi — ha
realizzato in cinque mesi un exploit che si credeva richiedesse cinque anni: ha
investito in numerosi rigassificatori che le consentono di comprare gas dal
mondo intero. La Germania russo-dipendente era un asso nella manica per il peso
geopolitico della Russia nel mondo. Ancora dodici mesi fa era una realtà.
(AGI il 7 marzo
2023) – Sarebbe stato un gruppo pro-ucraino, secondo le fonti di intelligence
citate dal New York Times, ad avere ordito il sabotaggio del gasdotto Nord
Stream. E' quanto si legge sul quotidiano Usa che cita un "nuovo rapporto di
intelligence".
Il nuovo rapporto,
secondo il NYT, è la "prima pista significativa sui responsabili dell'attacco ai
gasdotti Nord Stream" sui quali viaggia il gas naturale dalla Russia al Nord
Europa, avvenuto l'anno scorso. I funzionari statunitensi citati dal giornale
hanno dichiarato di non avere alcuna prova che il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky o i suoi principali luogotenenti fossero coinvolti nell'operazione, o
che gli autori agissero sotto la direzione di funzionari del governo ucraino.
L'attacco ai
gasdotti naturali che collegano la Russia all'Europa ha alimentato le
speculazioni sulle responsabilità: da Mosca a Kiev, da Londra a Washington si
sono rimbalzate le ipotesi, ma quello dei sabotaggi al gasdotto è rimasto uno
dei più importanti misteri irrisolti della guerra della Russia in Ucraina.
L'Ucraina e i suoi
alleati sono considerati in questo rapporto come i potenziali attentatori più
verosimili. Da anni si oppongono al progetto, definendolo una minaccia per la
sicurezza nazionale perchè permetterebbe alla Russia di vendere più facilmente
gas all'Europa. I funzionari del governo ucraino e dell'intelligence militare
affermano di non aver avuto alcun ruolo nell'attacco e di non sapere chi lo
abbia compiuto.
Sabotaggio
Nord Stream, il mistero dei sei uomini e dello yacht Andromeda.
Redazione su
Il Riformista il 17 Marzo 2023
Secondo Der
Spiegel l’equipaggio non identificato di sei persone (il capitano, due sub, due
aiutanti per i subacquei e un medico che si esprimevano in ceco e polacco) che
ha navigato verso l’area dell’esplosione del condotto Nord stream 2 nel Mar
Baltico era sullo yacht – già perquisito a gennaio – Andromeda, come il
personaggio della mitologia greca sposa di Perseo. Di questa storia si inizia a
ricomporre i pezzi offerti dalle numerose ricostruzioni, ma sui responsabili si
sa poco o nulla. La scorsa settimana la Procura generale tedesca aveva
dichiarato di aver perquisito un’imbarcazione senza fornire il nome o altri
dettagli. Secondo i siti web marittimi vesselfinder.com e marinetraffic.com,
l’Andromeda batte bandiera tedesca e misura 13 metri di lunghezza e 4 metri di
larghezza. La Cnn ha contattato la società che noleggia lo yacht ma senza
ottenere risposte.
Secondo una
seconda ma similare ricostruzione, questa volta ad opera del Wall Street
Journal, il 6 settembre il l’imbarcazione con il suo equipaggio sarebbe partita
dal porto tedesco di Rostock apparentemente per una crociera di piacere nei
porti del Mar Baltico. Qui viene specificato il modello dello yacht, una Bavaria
C50 da quindici metri, con 5 cabine, interno in legno e a poppa una piattaforma
reclinabile. Il contratto da circa 3mila euro a settimana per l’affitto sarebbe
stato pagato da una ditta polacca gestita da ucraini. I clienti – per Der
Spiegel – presentano dei passaporti probabilmente falsificati: documenti
“bulgari”, ma è solo un’ipotesi. Nell’equipaggio c’è anche una donna come
sostiene un testimone: “erano vestiti in modo normale, avevano buste del
supermercato con viveri, parlavano ceco o polacco”. Nel giro di due settimane,
il gruppo ha restituito lo yacht ed è scomparso.
Il battello
parte, fa scalo a Wiek, un piccolo porto lontano da formalità di registrazione
ed occhi indiscreti dove si suppone che il gruppo abbia imbarcato quattro
ordigni per un totale di 500 chilogrammi d’esplosivo arrivato sul molo con un
furgone. Sullo yacht a questo punto si troverebbero i sei membri del team, tutta
l’attrezzatura per operare a 70-80 metri di profondità, le bombe e i
rifornimenti. Troppo secondo alcuni. Comunque l’Andromeda riprende il viaggio ed
effettua la sua seconda tappa a Christiansø, in Danimarca. Un approdo di
tipologia non differente dal precedente.
Dopo le due
devastanti deflagrazioni i primi sospetti ricadono sui russi e Mosca punta il
dito sugli anglosassoni. L’unica cosa di cui sono certi gli inquirenti è che la
missione è stata condotta da professionisti: deve esserci la mano di uno Stato.
Alcuni esperti sono invece convinti che sub con esperienza e attrezzatura
sarebbero in grado di farlo. Rimane il dubbio se quella barca fosse davvero
sufficiente per trasportare tutta l’attrezzatura. Il giornalista Seymour
Hersch chiama in causa la Cia, mentre l’intelligence statunitense — citata
dal New York Times — ipotizza l’azione di un commando autonomo ucraino, con Kiev
che non sapeva dell’operazione. Le indiscrezioni dei giornali si rincorrono e
non fanno altro che aumentare esponenzialmente il numero degli scenari.
Sull’Andromeda i
tedeschi avrebbero trovato tracce d’esplosivo. Un pezzo importante del puzzle,
però non decisivo. La barca è finita in una rimessa sull’isola tedesca di Rügen,
nel Baltico, scovata dai reporter di Rtl.de: pare che non sia stata più stata
affittata. I presunti sabotatori, la loro nazionalità, dove siano finiti e chi
abbia dato l’ordine sono le uniche cose che si sa di non sapere.
I gasdotti Nord
Stream e Nord Stream 2.
Lorenzo Vita su
Inside Over il 28 Febbraio 2023
Il gasdotto Nord
Stream è stato per molto tempo al centro dello scontro fra Occidente e Russia,
con la Germania che si è trasformata nel corso degli anni in un vero e proprio
hub energetico del gas russo in Europa. Questo condotto, infatti, ha
rappresentato per gli anni di servizio la saldatura geopolitica tra Germania e
Russia, con il gas che, passando attraverso il Baltico, trasportava miliardi di
metri cubo l’anno di gas nel cuore del Vecchio Continente escludendo il transito
attraverso Paesi Baltici, Ucraina e Bielorussia. Non deve sorprendere dunque che
il Nord Stream, insieme al suo raddoppio Nord Stream 2, abbia allarmato da
sempre sia i Paesi dell’Europa orientale dentro la Nato sia gli Stati Uniti,
preoccupati da quell’immenso flusso di gas russo diretto in Germania che non ha
solo rafforzato il peso del Cremlino in Europa, ma anche arricchito Mosca
attraverso i proventi del gas da quello che è stato il suo principale alleato in
seno all’Unione europea e all’Alleanza Atlantica, ovvero Berlino. La guerra in
Ucraina ha poi travolto ogni cosa.
La storia del Nord
Stream
La storia del Nord
Stream inizia nel 1997 quando la società russa Gazprom e la finlandese Neste
costituiscono una società (North Transgas Oy) per realizzare un gasdotto che
vada dalla costa russa a quella tedesca passando per il Baltico. Gli studi di
fattibilità proseguono per diversi anni con il coinvolgimento di più società,
tra le quali ovviamente Gazprom, Neste (che nel frattempo diventa Fortum),
Ruhrgas e Wintershall finche la società North Transgas passa totalmente sotto il
controllo di un unico proprietario, ovvero il colosso russo.
Il piano per Nord
Stream prosegue. Il 30 novembre 2005 nasce un’altra società appositamente creata
per realizzare il gasdotto: la North European Gas Pipeline Company. L’azienda
nel 2006 diventa Nord Stream AG e da quel momento assorbe tutte le competenze
sulla nuova e rivoluzionaria conduttura energetica. In quello stesso periodo,
Gazprom dà il via ai cantieri sul territorio russo, mentre iniziano a essere
coinvolte diverse società internazionali, in particolare europee tra cui
importanti quelle italiane, per la realizzazione delle condutture sottomarine e
i relativi e complessi lavori di dragaggio, posa dei tubi, messa in sicurezza e
di costruzione di tutti gli elementi utili al trasporto di gas.
I lavori terminano
nel 2011: a settembre di quell’anno il Nord Stream riceve il primo quantitativo
di gas russo e sarà poi inaugurato e novembre con una cerimonia a cui
partecipano la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente russo Dmitrij
Medvedev, il primo ministro francese François Fillon e il premier dei Paesi
Bassi Mark Rutte. La foto scattata l’8 novembre 2011 a Lubmin, in Germania,
rappresenta un momento fondamentale della più recente storia europea o forse
l’immagine di un momento straordinario che però ha modificato radicalmente la
percezione della Russia e dell’Europa anche nei pensieri strategici degli Stati
Uniti.
Il percorso di Nord
Stream
Il gasdotto Nord
Stream 1 faceva parte di una complessa rete di condutture che si univa ai
giacimenti della Federazione Russa attraverso un ramo del gasdotto
Gryazovets-Vyborg.
Da Vyborg iniziava
la parte off-shore composta da due linee parallele di condutture in grado di
trasportare ciascuna 27,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno e dalla
lunghezza di 1.220 chilometri, giungendo a Greifswald, in Germania. A quel
punto, il gas si collegava alla rete tedesca entrando nel mercato europeo e nel
sistema continentale di distribuzione dell’oro blu attraverso due gasdotti:
il gasdotto Opal da Greifswald a Olbernhau e il Nel, che va da Greifswald ad
Achim. Entrambe queste condutture trasferivano poi l’energia ad altri Paesi:
motivo per il quale la Germania si era trasformata non solo
nella migliore cliente europea del gas russo, ma anche nella sua
più grande centrale di distribuzione in tutto il continente.
Il percorso del
gasdotto off-shore, evitando accuratamente di passare nella zona economica e
nelle acque territoriali di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e nei loro
territori, è stata una chiara scelta strategica. Questi Stati hanno da sempre
una visione estremamente negativa della Russia e dei suoi rapporti con il resto
dell’Europa. Proprio per questo motivo, Mosca ha preferito scavalcare le
possibile contestazioni baltiche affidandosi a un gasdotto subacqueo che esclude
le aree sotto la giurisdizione dei Paesi che sono più avversi alla strategia del
Cremlino.
Il Nord Stream 2
Se il Nord Stream ha
sempre rappresentato il simbolo dell’esportazione russa di gas, non deve stupire
che il suo raddoppio sia stato visto immediatamente con sospetto da tutti coloro
che volevano e vogliono scindere Mosca dai destini energetici europei.
La storia del
progetto del raddoppio evidenzia proprio questo scontro. Nel 2011, gli azionisti
di Nord Stream decisero di dare il via agli studi per raddoppiare le condutture
e aumentare così la portata della rete a 110 miliardi di metri cubi annui di
gas. Dopo un attento di studio fattibilità, Nord Stream AG nel 2012 conferma la
fattibilità della costruzione di una terza e quarta conduttura, e da quel
momento, si inizia a parlare con sempre maggiore insistenza e chiarezza di Nord
Stream 2.
Il progetto va
avanti fino al gennaio del 2015, quando c’è una prima interruzione: il piano di
raddoppio viene sospeso poiché le linee esistenti funzionavano a metà della
capacità a causa delle sanzioni europee a Gazprom dovuto all’annessione della
Crimea da parte della Russia.
Il progetto
riprende dopo sei mesi, a giugno 2015, con un accordo per la costruzione di due
linee aggiuntive concluso tra Gazprom, Royal Dutch Shell, E.on, Omv ed Engie.
Due anni dopo, nel 2017, per ovviare al veto polacco, Uniper, Wintershall,
Engie, Omve Royal Dutch Shell firmano un nuovo accordo di finanziamento con Nord
Stream 2 Ag, società sempre controllata da Gazprom, secondo il quale ciascuna
società avrebbe fornito 950 milioni di euro per coprire il 50% dei costi di
progetto, mentre il resto sarebbe stato finanziato da Gazprom. Nel maggio 2018
inizia la costruzione del terminale di Greifswald.
Con alterne fortune,
stop ai lavori, e nonostante avvertimenti da parte degli Stati Uniti e multe e
sanzioni inflitte sia da parte americana che da singoli Stati dell’Unione
europea e da Bruxelles, i lavori procedono. Con due navi posatubi, la Akademik
Cherskiy e la Fortuna, Vladimir Putin è in grado di annunciare nel 2021 il
completamento della posa della prima e della seconda linea del Nord Stream 2.
L’operatività delle nuove linee si sarebbe dovuta verificare a dicembre del
2021, ma dopo i tentennamenti dell’autorità tedesca nel fornire il placet
all’attività del gasdotto, il nuovo cancelliere Olaf Scholz ordina, come primo
atto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la sospensione della certificazione
del progetto. Dopo alcune mesi, Nord Stream 2 Ag dichiara bancarotta.
Il nuovo gasdotto
Nord Stream 2
prevedeva la posa di 200mila tubi di acciaio ricoperti di cemento e
successivamente rinforzati con un’armatura di ferro. Ogni tubo è lungo 12 metri
e pesa 24 tonnellate. In tutto sono state necessarie 2.424 migliaia di
tonnellate di acciaio. Le condutture sono state posate sul fondo del Mar Baltico
da navi che prima li assemblavano a bordo e poi li hanno posti sul fondo del
mare. Il progetto era quello di costituire due linee parallele, ciascuna con una
capacità di trasporto di 27,5 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno.
Il tracciato è
sostanzialmente identico a quello dell’esistente Nord Stream, con la differenza
che il secondo parte, per quanto riguarda il tracciato off-shore, dalla stazione
di compressione di Slavyanskaya, nei pressi di Ust Luga, non lontano da San
Pietroburgo. Da lì, il gasdotto procede per il Baltico attraverso le acque
finlandesi, svedesi, danesi e infine tedesche. Ultima tappa: Lubmin, Germania,
vicino Greifswald.
L'opposizione al
Nord Stream 2
Il Nord Stream 2 ha
trovato da subito l’opposizione dei Pasi dell’Europa nord-orientale e degli
Stati Uniti. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno visto in questo
progetto da un lato l’aggiramento russo dei propri territori, dall’altro il
fatto che Mosca e Berlino fossero collegate in modo sempre più solido. Il
raddoppio del Nord Stream era dunque visto non solo come una pericolosa leva
negoziale di Putin in seno all’Ue, ma anche una possibile arma di ricatto verso
gli altri clienti russi che avrebbero potuto essere tagliati fuori
dall’approvvigionamento energetico russo potendo Mosca fare affidamento
direttamente sul nuovo gasdotto baltico.
Le perplessità sul
Nord Stream 2 furono manifestate anche più a sud, in particolare da Repubblica
Ceca e Bulgaria, contrarie non tanto per una politica antirussa
(tradizionalmente più evidente a Varsavia e in altre capitali baltiche) ma per
il timore di perdere l’opportunità di essere Paesi di arrivo e transito del gas
russo in Europa. Questi due Stati, temendo la scelta del Baltico come strumento
per aggirare l’Ucraina, si vedevano quali prime vittime di un eventuale stop,
colpendo sia la loro capacità di sopperire al fabbisogno energetico, sia gli
introiti legati al transito del gas.
Le paure dei Paesi
baltici sono, non casualmente, le stesse degli Stati Uniti e della Nato e
dell’Unione europea. Anzi, l’opposizione al raddoppio del Nord Stream 2 è stata
forse una delle costanti delle amministrazioni Usa che si sono succedute durante
la nascita e la realizzazione del progetto. A palesare la contrarietà Usa al
raddoppio del Nord Stream sono già nel 2016 alcuni esponenti politici Usa, tra
cui John McCain e Marco Rubio, che si rivolgono direttamente alla Commissione
europea. Poi il segretario di Stato Rex Tillerson, nel 2018, lo definisce senza
mezzi termini una minaccia per la sicurezza europea. Dello stesso avviso il
presidente Donald Trump, che ha più volte ricordato come la Germania fosse
dipendente dal gas russo nonostante facesse affidamento sulle forze Usa per la
propria protezione. Nel 2019, l’ambasciatore degli Stati Uniti in
Germania, Richard Grenell, uno dei più acerrimi nemici di Angela Merkel, esorta
tutte le aziende internazionali coinvolte nel Nord Stream 2 ad abbandonarlo
immediatamente.
Con il passaggio
dall’amministrazione repubblicana a quella democratica, il Nord Stream 2 sembra
essere meno oggetto delle attenzione statunitensi. Joe Biden, impegnato a
ricucire i rapporti con l’Europa dopo la traumatica esperienza trumpiana, dà
l’idea di avere accettato ormai la realizzazione del progetto. Sia il presidente
che il segretario di Stato Antony Blinken manifestano più volte l’idea che quel
gasdotto non sia più un’ipotesi, spostando l’attenzione della Casa Bianca
soprattutto sulla necessità di rassicurare tutti gli alleati dell’Europa
orientale, dall’Ucraina alla Polonia, sostenendo la possibilità che sia
garantita la diversificazione energetica, l’approvvigionamento e che siano
fornite anche rassicurazioni di tipo economico.
La questione però
non viene accolta con favore dai Paesi baltici e da quella che diventerà la vera
potenza politica del fronte antirusso, la Polonia, il cui primo ministro Mateusz
Morawiecki preme su Biden e sul cancelliere tedesco Scholz per evitare che quel
gasdotto certifichi la saldatura russo-tedesca e si trasformi in un’arma in mano
a Putin.
La guerra in Ucraina
cambia radicalmente il corso degli eventi, aumentando immediatamente la
pressione proprio sul Nord Stream 2. Biden, incontrando Scholz alla Casa
Bianca prima dell’invasione russa, conferma che il gasdotto è al centro di
colloqui tra i due alleati. Le fonti Usa ribadiscono il grande nodo della
questione: Nord Stream 2 va contro la diversificazione delle fonti europee del
gas ed è esclusivamente “un progetto geopolitico” della Russia che “compromette
la sicurezza energetica e la sicurezza nazionale di una parte significativa
della comunità euro-atlantica”.
La posizione
americana, fatta trapelare attraverso numerose indiscrezioni e fonti anonime, è
che il Nord Stream 2 deve essere immediatamente bloccato in caso di attacco
russo. Cosa che puntualmente avviene nel febbraio 2022, quando Scholz sospende
la certificazione del Nord Stream 2 – ultimo atto per la sua attivazione – dopo
che Putin dà il via alla cosiddetta “operazione militare speciale”.
L'Ucraina e il Nord
Stream 2
Secondo molti
osservatori, l’obiettivo di Putin nella realizzazione del raddoppio del Nord
Stream è sempre stato quello di scavalcare non solo i Paesi baltici, ma anche
l’Ucraina. Essendo questa, da sempre, uno dei Paesi di transito del gas
russo, l’obiettivo del Cremlino sarebbe stato quello di evitare di passare per
il territorio ucraino dopo che il Paese aveva deciso di abbandonare l’orbita
russa per dirigersi verso quella occidentale, avvertendo anche della possibilità
di fare richiesta di entrare nella Nato.
Dal momento che Kiev
incassava miliardi di euro per il passaggio del gas russo sul suo territorio, è
del tutto evidente che la riduzione, o il progressivo azzeramento del transito
di oro blu sarebbe stata per Kiev una perdita economica di grandissimo impatto.
Perdita economica ma anche politica, poiché la costruzione di un gasdotto in
grado di raddoppiare la portata verso la Germania, di fatto indeboliva
totalmente la posizione negoziale ucraina in un periodo in cui si combatteva
quotidianamente in Donbass. Non solo avrebbe potuto perdere le royalties, ma
soprattutto Kiev si trovava da un lato sotto la spada di Damocle di un’eventuale
chiusura del rubinetto del gas da parte di Mosca, dall’altro con una Germania
saldamente ancorata alla Russia, quindi possibilmente meno attenta alle
aspettative ucraine negli Accordi di Minsk e in quella che, all’epoca, era la
crisi del Donbass e la questione della Crimea.
Proprio per questo
motivo, Petro Poroshenko chiede subito garanzie a Merkel sul ruolo del nuovo
gasdotto. Ma gli interessi tedeschi sono ovviamente per la sua realizzazione. Il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky non cambia registro. Nel 2021, in
un’intervista rilasciata a più media internazionali, indica il Nord Stream 2
come “una minaccia”, dicendo che quelle nuove linee possono portare a una
pericolosa carenza di materie prime e di gas e facendo perdere 1,7 miliardi di
euro all’anno all’Ucraina. Il presidente ucraino conferma il pressing per
tutelare gli interessi di Kiev. Ino altre circostanze, Zelensky sottolinea la
“delusione” per la decisione di Washington di sospendere le sanzioni contro le
aziende che lavorano alla finalizzazione del Nord Stream 2 e lo definisce come
“una vera arma nelle mani della Russia”. Accuse cui l’amministrazione
Usa risponde in modo netto dicendo a Kiev di non rendere pubbliche certe
affermazioni sul gasdotto né sostanzialmente di discutere il potenziale accordo
tra Stati Uniti e Germania sul nuovo gasdotto scatenando anche le opposizioni
interne al Congresso.
Con l’invasione da
parte della Russia, il Nord Stream 2 torna a essere al centro del rapporto
triangolare tra Kiev, Berlino e Washington e, come visto in precedenza, gli
Stati Uniti affermano chiaramente che quel progetto deve essere immediatamente
fermato come primo prezzo imposto a Putin per l’attacco. Scholz, dopo una
drammatica scelta interna, decide per la sospensione della
certificazione interrompendo così una politica tradizionalmente incline a est.
Pochi giorni dopo l’inizio della campagna militare russa in Ucraina e le
sanzioni al progetto, la sottosegretaria agli Esteri Usa, Victoria Nuland, in
un’audizione al Senato esprime la posizione di Washington in maniera
cristallina. “Penso che il Nord Stream 2 sia ormai morto” dice Nuland con
evidente soddisfazione, “è un grosso pezzo di metallo in fondo al mare, e non
credo che possa essere resuscitato”.
Con le sanzioni e le
successive interruzioni del gas da parte di Mosca, anche il Nord Stream 1 inizia
a non far fluire più gas verso la Germania.
Il sabotaggio al
Nord Stream
Il 26 settembre del
2022 si verificano grosse falle sottomarine che hanno coinvolto sia il Nord
Stream 1 che il Nord Stream 2.
La prima
esplosione è avvertita alle due di notte ora locale a sud-est dell’isola danese
di Bornholm, coinvolgendo il tracciato del Nord Stream 2. Successivamente sono
avvertite altre esplosioni e perdite di pressione sull’altro tracciato, il Nord
Stream 1, sempre vicino l’isola danese. Dalle falle si elevano grandi quantità
di gas: i gasdotti, infatti, pur inutilizzati, hanno al loro interno gas
naturale. Dopo un primo momento di dubbio sulla possibilità di un incidente, sia
le autorità svedesi che quelle russe parlano di sabotaggio o, come fa Putin, di
“atto di terrorismo internazionale”.
Le indagini al
momento proseguono senza che sia ancora certa e verificata né la modalità di
attacco né la responsabilità. La Russia accusa direttamente le forze Nato, in
particolare parla di “anglosassoni”, colpevole a suo dire di avere voluto
infliggere un colpo pubblico e letale ai rapporti tra Mosca e Berlino (e
l’Europa). Molti sottolineano a questo proposito la concomitanza del sabotaggio
con l’inaugurazione del gasdotto Baltic Pipe tra Polonia e Norvegia: simbolo
della nuova geopolitica dell’energia continentale a trazione atlantica e con
Varsavia, primo nemico di Nord Stream, quale protagonista. Sul punto, vale la
pena ricordare anche l’ultima e dibattuta inchiesta del giornalista premio
Pulitzer Seymour Hersh secondo il quale a colpire i due gasdotti sarebbero stati
i sommozzatori della Marina degli Stati Uniti dopo avere piazzato delle mine
subacquee durante l’esercitazione Nato Baltops 22.
Oltreoceano e nel
blocco atlantico la situazione è stata vista in maniera diversa. Molti accusano
Putin di avere voluto sabotare la propria infrastruttura come segnale di
frattura definitiva con l’Europa e come simbolo della volontà di non rifornire
più di gas il continente anche in futuro. Il tracciato, secondo questa linea di
pensiero, proprio perché inutilizzato, non serviva più al Cremlino, diventando
quindi un’arma al contrario senza perdite economiche. Secondo la Cnn, navi di
supporto della Marina russa si sarebbero mosse nelle vicinanze delle aree delle
falle alcuni giorni prima delle esplosioni, ma non si sono trovate conferme di
eventuali movimenti anomali. A puntare il dito contro la Russia è stato anche
l’ex capo dell’intelligence tedesca, Gerhard Schindler, così come altri
esponenti baltici.
Tuttavia, le
indagini, al momento divise tra i vari Paesi coinvolti nelle esplosioni o per
motivi geografici o motivi economici (Danimarca, Germania, Svezia e Russia) non
hanno condotto ad alcuna prova che possa portare a un responsabile. E, come
confermato anche da diversi media Usa, nessuno ha trovato prove certe sul
coinvolgimento russo.
A febbraio, anche
la Cina, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, chiede
che venga fatta luce sul sabotaggio con un’indagine internazionale visto
“l’impatto delle esplosioni sui mercati dell’energia e sull’ambiente”. L’Unione
europea, dopo l’uscita dell’articolo di Hersh, ha parlato attraverso la
portavoce della Commissione, Anitta Hipper, sottolineando che le indagini sono
“responsabilità degli Stati membri” interessati e di queste indagini Bruxelles
non sarebbe al corrente. Sul punto si esprime anche Nuland, la quale ribadisce
che l’indagine “è condotta dagli Stati collegati a questa infrastruttura” e
afferma “in modo definitivo e irrevocabile che gli Stati Uniti non hanno nulla a
che fare con queste esplosioni”. LORENZO VITA
Le relazioni tra
Stati Uniti e Cina, spiegate.
Federico Giuliani su
Inside Over il 28 Febbraio 2023
Da un lato la
necessità di mantenere stretti legami economici, dall’altro grande diffidenza
politica. Le relazioni tra Usa e Cina, o meglio quelle tra gli Usa e la
Repubblica Popolare Cinese fondata nel 1949, hanno sempre oscillato tra momenti
di apertura e altri di ostracismo.
C’è chi, come lo
studioso Graham Allison, ha addirittura tirato in ballo la Trappola di
Tucidide per spiegarle. Secondo questa teoria, Washington e Pechino sono
destinati alla guerra perché la Cina è una nazione in ascesa che rischia di
“rubare” il ruolo geopolitico fin qui ricoperto da quella statunitense,
progressivamente in declino. Uno scenario del genere ricalcherebbe insomma
quanto avvenuto tra Atene e Sparta.
Nel frattempo, in
mezzo a crisi internazionali e problemi globali, le due grandi potenze mondiali
stanno cercando un complicato modo per smussare gli angoli e collaborare là dove
possibile. Evitando di scatenare un conflitto dagli esiti imprevedibili,
soprattutto sul fronte dell’economia.
Il gelo con la Cina
comunista
Gli Stati Uniti e la
Cina comunista hanno una delle relazioni bilaterali più importanti e complesse
al mondo. Nel ripercorrerle possiamo partire dal 1949, anno in cui Mao
Zedong istituì la Repubblica Popolare Cinese dopo che i comunisti sostenuti dai
contadini sconfissero il governo nazionalista di Chiang Kai Shek.
Chiang e migliaia
delle sue truppe fuggirono a Taiwan. Gli Stati Uniti, che avevano già sostenuto
i nazionalisti contro l’invasione delle forze giapponesi durante la seconda
guerra mondiale, continuarono a sostenere il governo della Repubblica di Cina in
esilio a Taipei, ponendo le basi per diversi decenni di limitate relazioni con
Pechino.
Nel 1953 il
presidente statunitense Dwight Eisenhower revocò il blocco della marina
statunitense a Taiwan, portando Chiang Kai Shek a dispiegare migliaia di truppe
nelle isole Quemoy e Matsu, nello stretto di Taiwan nell’agosto 1954. L’Esercito
popolare di liberazione cinese rispose bombardando le isole.
Il riavvicinamento
Nel frattempo la
luna di miele tra l’Unione Sovietica e la Cina iniziò a scricchiolare. I
disaccordi culminarono nelle schermaglie di confine nel marzo 1969. Mosca
sostituì così Washington come la più grande minaccia della Cina, e la scissione
sino-sovietica contribuì di fatto al graduale riavvicinamento di Pechino con gli
Stati Uniti.
Nel luglio del 1971
il Segretario di Stato Usa Henry Kissinger effettuò un viaggio segreto in
Cina. Poco dopo, le Nazioni Unite riconobbero la Repubblica Popolare Cinese,
dotandola del seggio permanente del Consiglio di sicurezza detenuto dalla
Repubblica cinese di Chiang Kai Shek.
Nel 1972 il
presidente Richard Nixon trascorse otto giorni in Cina, durante i quali incontrò
Mao e firmò il comunicato di Shanghai con il premier cinese Zhou Enlai. Il
comunicato pose le basi per migliorare le relazioni Usa-Cina, consentendo così
ai due Paesi di discutere in merito a questioni complesse, su tutte Taiwan. La
normalizzazione delle relazioni tra i due paesi procedette a ritmi lenti per
gran parte del decennio, fino al 1979, quando il presidente degli Stati
Uniti Jimmy Carter concesse alla Cina il pieno riconoscimento diplomatico
L’amministrazione
Reagan firmò quindi nell’agosto 1982 un terzo comunicato congiunto con la
Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni, riaffermando l’impegno
degli Stati Uniti per la sua politica di una sola Cina.
Uniti in nome del
commercio
Nel 1999 avvenne un
incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. La Nato bombardò
accidentalmente l’ambasciata cinese a Belgrado durante la sua campagna militare
contro le forze serbe che occupavano il Kosovo. Le relazioni Usa-Cina, già al
limite dopo i fatti di Piazza Tienanmen, ne risentirono parecchio. Gli Stati
Uniti e l’Alleanza Atlantica si scusarono per la serie di errori
dell’intelligence statunitense che portò al micidiale bombardamento.
Nel 2000 avvenne la
prima, grande svolta. Bill Clinton firmò l’ US-China Relations Act, garantendo a
Pechino normali relazioni commerciali permanenti con gli Stati Uniti e aprendo
la strada all’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del
commercio (Wto) nel 2001.
Numeri alla mano,
tra il 1980 e il 2004, il commercio Usa-Cina era passato da 5 miliardi a 231
miliardi di dollari. Nel 2006, la Cina superò il Messico come secondo partner
commerciale degli Stati Uniti, dopo il Canada.
Agli albori dei
primi anni Duemila si pensava che un graduale inserimento cinese nel commercio
avrebbe potuto trasformare, quasi per osmosi, anche il sistema politico di
Pechino. Non solo: riconoscendo il gigante asiatico come una potenza emergente,
gli Stati Uniti invitarono la Cina a fungere da “stakeholder responsabile” e ad
usare la sua influenza per attirare nazioni come il Sudan, la Corea del Nord e
l’Iran nel sistema internazionale. Non sarebbe mai avvenuto niente del genere.
L’ascesa cinese e il
Pivot to Asia
La Cina ha
semplicemente saputo sfruttare al meglio l’ingresso nel Wto e le numerose
delocalizzazioni di aziende occidentali sul proprio territorio per rimpinguare
le proprie casse. Come se non bastasse, una volta che Pechino ha iniziato a
capitalizzare l’enorme disavanzo collezionato grazie alle sue esportazioni,
rafforzando l’esercito e modernizzando il Paese, si è iniziato a parlare
di ascesa cinese in accezione negativa del termine.
Intanto, nel
settembre 2008, la Cina superò il Giappone diventando il maggior detentore del
debito statunitense, o titoli del Tesoro, con circa 600 miliardi di dollari. Due
anni più tardi la Cina avrebbe superato il Giappone come seconda economia
mondiale mentre entro il 2027 Pechino potrebbe detronizzare Washington.
Nel 2011, in
un saggio per Foreign Policy , il segretario di Stato americano Hillary Clinton
ha delineato un “perno” degli Stati Uniti verso l’Asia. L’appello di Clinton per
“maggiori investimenti – diplomatici, economici, strategici e altro – nella
regione Asia-Pacifico” era visto come una mossa per contrastare il crescente
peso della Cina.
Intanto Il deficit
commerciale degli Stati Uniti con la Cina è passato da 273,1 miliardi di dollari
nel 2010 al massimo storico di 295,5 miliardi di dollari nel 2011.
A margine del
vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico del 2014, il presidente Barack
Obama e il presidente Xi Jinping hanno rilasciato una dichiarazione
congiunta sul cambiamento climatico, impegnandosi a ridurre le emissioni di
carbonio.
Trump, Xi e la
guerra dei dazi
Con l’avvento
di Donald Trump le relazioni tra Cina e Stati Uniti subiscono un’inversione di
rotta. Nel 2017, dopo aver vinto le elezioni presidenziali, Trump rompe con la
pratica consolidata parlando al telefono con il presidente taiwanese Tsai Ing
Wen e mette in discussione l’impegno Usa nei confronti della politica di una
sola Cina.
Nonostante incontri
e dialoghi, nel 2018 l’amministrazione Trump annuncia tariffe radicali sulle
importazioni cinesi, per un valore di almeno 50 miliardi di dollari, in risposta
a quello che la Casa Bianca sostiene sia il furto cinese di tecnologia e
proprietà intellettuale statunitensi.
La guerra
commerciale entra nel vivo e si allevierà solo nel 2020, quando il presidente
Trump e il vice premier cinese Liu He firmano un accordo di “fase uno”, per una
svolta parziale nella Trade War. La pandemia di Covid avrebbe in seguito
riacceso le tensioni tra i due colossi.
Una sfida per la
sicurezza
La Nato, che negli
ultimi anni si è concentrata per lo più sulla deterrenza dell’aggressione russa,
ha recentemente rilasciato un comunicato che ha ampliato l’attenzione
dell’Alleanza fino ad includere le minacce dalla Cina, come lo sviluppo di armi
nucleari e la modernizzazione militare.
È la prima volta che
un comunicato della Nato fa riferimento a minacce provenienti dalla Cina. La
dichiarazione è arrivata mentre l’amministrazione di Joe Biden sta spingendo i
partner Usa a rispondere collettivamente contro l’ascesa di Pechino.
Il continuo tira e
molla tra Usa e Cina viene interrotto dalla vicenda dei presunti palloni spia.
Un giallo, ancora avvolto nella nebbia, che ha nuovamente complicato i rapporti
tra le due superpotenze. FEDERICO GIULIANI
Gli USA stanno
cercando alleati per imporre sanzioni anche alla Cina.
Giorgia Audiello su
L'Indipendente il 6 marzo 2023.
Si allarga sempre di
più la guerra ibrida internazionale tra le grandi potenze, con la Cina che ora
potrebbe essere direttamente coinvolta nel contesto di sanzioni imposte
dall’Occidente alla Russia e, in generale, alla quasi totalità dei Paesi non
allineati agli interessi geopolitici di Washington. Dopo che qualche settimana
fa la Casa Bianca ha lanciato l’allarme sul fatto che Pechino sarebbe
intenzionata a fornire armi a Mosca, infatti, ora l’amministrazione statunitense
ha cominciato a sondare la disponibilità degli alleati più stretti ad imporre
sanzioni a quella che è la seconda economia mondiale, creando così una frattura
sempre più evidente e profonda tra due blocchi: quello occidentale e quello
rappresentato dall’asse Mosca-Pechino, mentre tutti gli altri attori geopolitici
non occidentali cercano faticosamente di mantenere una posizione neutrale. Gli
Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina dall’idea di fornire armi alla Russia
sia durante le conversazioni a distanza tra Biden e Xi Jinping, sia durante
l’incontro di persona, avvenuto lo scorso 18 febbraio, tra il segretario di
Stato americano Antony Blinken e l’alto diplomatico cinese Wang Yi a margine di
un conferenza sulla sicurezza globale a Monaco di Baviera.
Le consultazioni per
imporre restrizioni economiche alla Cina sono ancora in una fase preliminare e
hanno lo scopo di compattare il G7 per coordinare eventuali sanzioni, anche se
non è ancora chiaro quali beni o aziende potrebbero venire colpite dalla misura,
in quanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per ora ha rifiutato di
commentare. A una domanda in merito alle consultazioni, un portavoce del
Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha risposto che la guerra
della Russia ha reso difficili le relazioni della Cina con l’Europa e altre
nazioni: «è una distrazione per la Cina e un potenziale colpo alle loro
relazioni internazionali di cui non hanno bisogno né dovrebbero volere», ha
affermato.
Già a fine febbraio,
alcuni organi di stampa occidentali come il Wall Street Journal (WSJ) avevano
fatto trapelare informazioni fornitegli da fonti di intelligence da cui emergeva
come Pechino stesse dotando la Russia di piccoli droni commerciali per aiutare
le forze del Cremlino nella guerra contro l’Ucraina. Secondo il Pentagono, i
droni non avrebbero aiutato solo Mosca nel conflitto, ma avrebbero anche
permesso alla Cina di raccogliere informazioni cruciali sul campo di battaglia.
Tuttavia, la tempistica con cui il WSJ ha rilasciato le informazioni
dell’intelligence appare strumentale alla strategia sanzionatoria
dell’Occidente che è il principale strumento per combatte gli avversari
sistemici. Tanto più che l’agenzia britannica Reuters ha ammesso che,
relativamente alla fornitura d’armi di Pechino a Mosca, «Gli aiutanti del
presidente degli Stati Uniti Joe Biden non hanno fornito prove pubblicamente».
Da parte sua, il gigante asiatico ha negato ogni accusa.
Del resto, già
nel documento intitolato “Nato 2030. United for a new Era”, la Cina viene posta
subito dopo la Russia come rivale sistemico, mentre nel rapporto intitolato
“Strategic Concept 2022”, la Cina viene definita come una «sfida» per gli
«interessi, la sicurezza e i valori» della NATO. Inoltre, secondo diversi
analisti, la Russia rimane l’ultimo ostacolo prima di concentrarsi su quella che
è considerata la minaccia più grave alla stabilità dell’ordine mondiale
unipolare, ossia Pechino. Non stupisce, dunque, che Washington – con il
prolungarsi del conflitto in Ucraina e il consolidamento sempre più forte tra
Russia e Cina – stia cominciando a considerare seriamente l’ipotesi di
sanzionare la Cina, coinvolgendo in questo anche gli alleati europei, secondo il
copione già seguito con Mosca. Tuttavia, imporre sanzioni a Pechino potrebbe non
essere così semplice per via della sua completa integrazione nelle principali
economie dell’Europa e dell’Asia, rischiando così di bloccare o rallentare
l’intero commercio globale, già parzialmente interrotto dalle conseguenze dei
lockdown, prima, e dalla guerra in Ucraina, dopo. Per questo alcuni alleati
degli Stati Uniti come la Germania e la Corea del Sud sono riluttanti a imporre
sanzioni alla seconda economia mondiale.
Nonostante la
divergenza di alcune nazioni e la dipendenza energetica e commerciale
dell’Unione Europea, un funzionario di Bruxelles ha affermato che se la Cina
fornisse armi alla Russia supererebbe una «linea rossa» a cui l’UE risponderebbe
con sanzioni. Il commento del funzionario fa eco all’intervento del cancelliere
Olaf Scholz al parlamento tedesco in cui – prima del suo incontro con Joe Biden
– aveva ammonito Pechino: «non consegnate armi all’aggressore Russia».
Nel frattempo, gli
Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a persone e aziende accusate di aiutare
la Russia a eludere le sanzioni. Le misure includono anche limiti
all’esportazione per le società cinesi che non potranno acquistare articoli come
i semiconduttori. Inoltre, non è escluso che gli USA possano estromettere
Pechino dal sistema finanziario statunitense – lo SWIFT – sulla scia di quanto
hanno già fatto con Russia, Iran e Corea del Nord. Motivo per cui da tempo
Russia, Cina e Iran stanno lavorando alla creazione di un sistema finanziario
alternativo che, se da un lato, è la diretta conseguenza delle azioni di
Washington per preservare il “vecchio” ordine globale, dall’altro, è anche lo
strumento più potente per instaurare un nuovo sistema finanziario internazionale
e, dunque, nuovi assetti geopolitici e di potere. [di Giorgia Audiello]
Da Emanuel Pietrobon
su Inside Over il 28 Febbraio 2023
Turkestan, crocevia
dei grandi imperi eurasiatici e teatro di tornei di ombre tra gli aspiranti
all’egemonia globale. Ieri Londra contro Mosca. Oggi Washington contro Mosca e
Pechino, ma non solo. Ieri Edward Law, Charles MacGregor e la Compagnia
britannica delle Indie orientali contro Bronisław Grąbczewski, Mikhail
Chernyayev e Mikhail Skobelev. Oggi Antony Blinken all’inseguimento del sogno di
Law, primo conte di Ellenborough e signore del Grande Gioco, ovvero la
costruzione di un avamposto anglofono tra Turkestan e valle dell’Indo.
Il tour fra
Turkestan e valle dell’Indo di Antony Blinken, l’eminenza grigia di Joe Biden, è
iniziato oggi, 28 febbraio, e lo terrà lontano da casa fino al 3 marzo. Lo
attendono quattro giorni di lavoro non-stop, che, dopo la puntata kazaka, lo
condurranno nella storica fermata dell’antica Via della seta, l’Uzbekistan, con
capolinea la fu perla della Corona britannica, l’India.
L’agenda
centroasiatica di Blinken è fitta. La partecipazione alla riunione del C5+1, un
formato di dialogo tra Stati Uniti e –stan istituito nel 2015 e che lui stesso
ha contribuito a creare. Incontri separati, ai margini del C5+1, con gli
omologhi dei paesi partecipanti. E tavole rotonde su cooperazione ambientale,
economica, energetica e securitaria.
Nel nome della
prevedibilità patrocinata da Biden, veterano della Guerra fredda, la Casa
Bianca non ha fatto segreto dell’obiettivo ultimo dell’invio dell’abile Blinken
nelle terre del Grande Gioco: “Strappare le repubbliche ex sovietiche dalle
orbite cinese e russa”. Obiettivo che vede e vedrà gli sforzi
dell’amministrazione Biden concentrati, in particolare, su Astana e Tashkent,
cioè gli –stan più insofferenti verso l’egemonia regionale di Mosca, nonché i
più scettici nei riguardi dell’invasione militare dell’Ucraina.
La Casa Bianca ha da
offrire qualcosa sull’altare del riallineamento di Astana, che non per forza
deve e/o dovrà significare schieramento nel campo occidentale – un non
allineamento antagonistico a Mosca sarebbe più che sufficiente. Astana vuole
capire se il gioco vale la candela, se potrebbe trattarsi di aiuto in caso di
scenari di donbassizzazione – perciò il focus di Blinken sull'”impegno americano
[a difendere] indipendenza, sovranità e integrità territoriale dei paesi
centroasiatici”? –, e, nell’attesa di prendere una decisione, ha porto un
ramoscello d’ulivo al messo arrivato da Washington: la chiusura della
rappresentanza commerciale a Mosca.
L’India è tutto
L’India, il gigante
anglofono che nel 2022 è diventato il Paese più popoloso del mondo, sarà uno
degli obiettivi geostrategici di ogni amministrazione americana nei decenni a
venire. Giacché dal posizionamento di Nuova Delhi sulla scacchiera globale, se a
favore o contro l’Occidente, dipenderà parte significativa dell’esito della
grande battaglia per la riforma del sistema internazionale.
Se le relazioni tra
Pechino e Nuova Delhi non sono mai state semplici, quelle tra Washington e Nuova
Delhi non sono state prive di incomprensioni e reciproche diffidenze. Nonostante
l’appartenenza al Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad), calcoli economici
e sensibilità geografiche impediscono all’India di prestarsi nel ruolo di ariete
lanciato contro la Cina. E nonostante la special relationship coi mercati
occidentali e con l’Ucraina, tanto che si parla di Ucraindia, l’India non ha
intenzione di aderire al regime sanzionatorio antirusso, che ha arricchito
enormemente le industrie nazionali.
Blinken si recherà a
Nuova Delhi nelle vesti ufficiali di partecipante all’Incontro dei ministri
degli esteri del G20, che si terrà nella giornata del primo marzo, ma la
speranza-aspettativa della diplomazia statunitense è la produzione di due
bilaterali ai margini dell’evento: una con Sergej Lavrov, una con Qin Gang. Non
per porre fine alla competizione tra grandi potenze, ormai entrata nel vivo,
quanto per “mantenere aperti i canali di comunicazione”.
L’India, all’interno
del Bidenverso, è una superpotenza in divenire che potrebbe rivelarsi
fondamentale nei contesti del contenimento della Cina in una dimensione
terrestre, per via del controllo esercitato sui mari dell’Oceano Indiano, e
della riedizione in salsa multipolare del Grande Gioco, nel quale l’hindi è già
diffuso e potrebbe trarre giovamento dalla ritirata americana dall’Afghanistan.
Continuare a
corteggiare Nuova Delhi, onde evitarne l’appiattimento totale sulle posizioni di
Mosca e Pechino, sarà uno degli imperativi che guiderà Blinken e successori. Far
maturare i semi della zizzania sparsi nel Turkestan, per aggredire l’egemonia
regionale declinante della Russia (e per destabilizzare le vie della Belt and
Road Initiative), sarà un altro categorico di primo livello per Washington e
alleati. La strada da percorrere è stata tracciata dagli antenati – divide et
impera, guerre per procura, insorgenze, diplomazia della sterlina –, ma resta da
vedere se il finale sarà un remake dal sapore multipolare dell’entente
anglo-russa per l’Asia. EMANUEL PIETROBON
Gli orrori di
Izyum hanno un volto: esumate 440 salme di prigionieri torturati.
Storia di Nello
Scavo, inviato a Odessa su Avvenire il 28 febbraio 2023.
Ce n’è voluto di
tempo. Uno alla volta. Interrogati, torturati, orribilmente seviziati. Compresi
cinque bambini. E cinque numeri su un fascicolo per riassumere l’inferno in
cifre: «194 corpi di sesso maschile; 215 corpi di sesso femminile; 22 corpi di
militari; 5 corpi di bambini; 11 resti non identificati». Un totale di 440
cadaveri. A Izyum è andata peggio di Bucha. Non per i numeri, ma per la ferocia
sadica di chi più per capriccio che per necessità voleva imporre la legge
dell’invasore facendo ascoltare i supplizi alla gente di fuori, chiusa in casa
disperando che la resistenza arrivasse.
Mancavano da mettere
insieme gli ultimi pezzi, quel che resta di un uomo mutilato quand’era ancora
vivo. «Per ucciderli hanno risparmiato proiettili», dice un medico. Non per
ridurre lo spreco di munizioni, ma per impiegare il tempo nelle camere delle
torture. Ad alcuni hanno amputato le mani durante gli interrogatori, ad altri i
piedi, molti hanno segni di coltellate profonde e reiterate. C’è chi è morto
dissanguato dopo essere stato evirato. E cosa abbiano fatto alle donne prima di
ucciderle, ciascuno lo può immaginare. Ieri i tecnici forensi hanno finito il
lavoro in mezzo alle croci nel bosco, tra le buche di fango dove i russi prima
di scappare avevano gettato i corpi. Sul registro degli esperti forensi
internazionali l’ultima pagina si chiude con poche righe. Da ottobre, quando i
russi sono stati costretti alla ritirata, lavoravano nelle fosse comuni, con il
timore che insieme ai resti umani i soldati avessero gettato delle mine, come
poi è stato accertato con il lavoro degli artificieri che hanno messo in
sicurezza l’area. Anche a Snigurivka, più a Sud in direzione di Kherson, gli
occupanti prima di essere messi in fuga hanno minato il cimitero, e uno
sminatore ucraino ci ha rimesso le gambe.
Non è un caso che
proprio ieri il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha spiegato che
l’invasione russa ha provocato «le più massicce violazioni dei diritti umani di
questi tempi». Lo ha detto nel suo intervento al Consiglio per i diritti umani a
Ginevra. «L’ufficio dell’alto commissario per i diritti umani – ha ricordato
Guterres – ha documentato decine di casi di violenze sessuali collegate al
conflitto a danni uomini, donne e ragazze”. Ieri la first lady ucraina Olena
Zelenska ha chiesto alle Nazioni Unite l’istituzione di un tribunale speciale
per i crimini commessi dai russi, in modo che «un’aggressione» come l’invasione
del suo Paese «non possa accadere di nuovo».
A sorpresa a Kiev è
giunta Janet Yellen, la segretaria al Tesoro Usa per confermare il sostegno
dell’amministrazione americana nel corso di un incontro con il presidente
Zelensky e il primo ministro Shmyhal. Kiev non ha ancora del tutto chiuso la
porta ai “principi” elencati dalla Cina per un possibile avvio di negoziato. E
gli Usa, pur bocciando il “piano”, confermano che Pechino non starebbe inviando
armi a Mosca e non avrebbe intenzione di farlo. Segno che un spiraglio per
continuare a parlarsi c’è ancora.
Nella notte tra
domenica e ieri due ondate di attacchi con droni kamikaze di fabbricazione
iraniana hanno messo a dura prova la contraerea. Nove velivoli sono stati
abbattuti, ma altri hanno raggiunto infrastrutture civili, mettendo di nuovo in
ginocchio il sistema elettrico di Odessa, nel sud, e di altre città non lontano
da Kiev. Nell’Ovest, sulla direttrice tra la capitale e Leopoli un drone è
caduto non lontano da alcune abitazioni e un soccorritore, intento a mettere a
sicuro i civili è stato ucciso da una successiva esplosione. Potrebbe essersi
trattato anche di una rappresaglia partita dalla Bielorussia, dove i partigiani
anti-governativi hanno rivendicato la distruzione di un aereo militare russo di
sorveglianza, colpito da un drone in un campo dell’aviazione nei pressi della
capitale Minsk. L’aereo, un Beriev A-50, è in grado di seguire fino a 60
obiettivi alla volta. Aliaksandr Azarov, leader dell’organizzazione
antigovernativa bielorussa “Bypol”, ha rivendicato l’attacco.
La difficile
modernizzazione della portaerei russa Admiral Kuznetsov.
Paolo Mauri il 4
Marzo 2023 su Inside Over.
La “Admiral
Kuznetsov” (codice identificativo 063) è l’unica portaerei in servizio
nella Voenno-Morskoj Flot (Vmf), la Flotta Russa e ne è la nave ammiraglia.
L’unità è
formalmente assegnata alla Flotta del Nord (distribuita tra Murmansk e
Severomorsk) e nell’ottobre del 2016 ha preso il mare insieme alla sua scorta,
composta dall’incrociatore classe Kirov “Piotr Velikiy”, da due
cacciatorpediniere classe Udaloy e un rimorchiatore d’altura, per entrare in
Mediterraneo dove ha effettuato operazioni nella lotta all’Is in appoggio al
governo di Damasco sino al mese di gennaio del 2017. Operazioni costellate da
due incidenti riguardanti il sistema di arresto dei velivoli sul ponte di volo
che hanno causato lo spostamento della componente aerea imbarcata a terra presso
l’aeroporto siriano di Hmeimim. Nonostante questo il gruppo di volo della
“Kuznetsov” ha effettuato 420 sortite colpendo 1252 obiettivi in Siria.
La portaerei è
rientrata in porto il 9 febbraio 2017 per cominciare una serie di lavori di
rimodernamento a lungo attesi. Durante il refit la “Kuznetsov” è andata incontro
a una serie di incidenti, di cui almeno tre rilevanti. Il primo, occorso il 30
ottobre del 2018, ha visto il parziale affondamento del bacino di carenaggio
galleggiante che la stava ospitando provocando danni alla nave a causa
dell’impatto di una gru sul ponte di volo che ha aperto una voragine di 19 metri
quadrati. La struttura e la gru sono state ripristinate in circa tre mesi. Il
secondo incidente, occorso il 12 dicembre del 2019, ha visto lo scoppio di un
incendio a bordo a causa di errori nelle procedure di saldatura: in quella
occasione un operaio è rimasto ucciso ed altri 12 feriti. Il terzo, sempre per
incendio ma di minore entità, è occorso il 22 dicembre 2022: il fuoco in quella
occasione è stato prontamente estinto ma 20 persone sono rimaste intossicate.
I lavori, funestati
da incidenti, sono stati decisi per prolungare la vita utile della nave di 25
anni, ma si crede che in realtà possa restare in servizio per altri 10/15. In
particolare la revisione ha incluso l’installazione di nuovi sistemi di guerra
elettronica, comunicazione, propulsione e combattimento e soprattutto
prevedevano lo sbarco dei missili antinave P-700 “Granit”, che occupavano un Vls
(Vertical Launch System) a livello del ponte di volo, per imbarcare la versione
navalizzata del sistema Pantsir S1 (la M) e, si pensava, di vedere
l’installazione di catapulte. Le riparazioni avrebbero dovuto essere terminate
entro il 2020 o il 2021 ma come abbiamo visto la serie di incidenti ha
prolungato notevolmente il loro termine. A marzo 2021, poi, il direttore del
cantiere navale di Polyarny è stato arrestato per presunta appropriazione
indebita di 589 milioni di dollari assegnati alla riparazione della “Kuznetsov”,
a sottolineare ancora una volta come la corruzione in Russia sia una piaga
endemica.
A ritardare i lavori
ha contribuito sicuramente anche la perdita del bacino di carenaggio
galleggiante, che era l’unico in grado di accogliere la grande nave, e infatti
l’unità è stata accolta in banchina a Murmansk dove i tecnici della Flotta hanno
allestito un bacino improvvisato.
Verso la fine del
mese scorso siamo venuti a sapere che la portaerei ha lasciato il molo di
Murmansk, tuttavia, come riportato da Naval News la scorsa settimana, la
manutenzione della “Kuznetsov” continuerà per tutto il 2023 e l”unità non sarà
disponibile almeno fino alla prima metà del 2024, quando sarà pronta per
iniziare le prove in mare. A questo punto, è probabile che la portaerei possa
rientrare in servizio entro la fine del prossimo anno, a condizione di evitare
ulteriori contrattempi. L’operazione di spostamento della portaerei fuori dal
bacino di carenaggio improvvisato è stata possibile dopo il completamento delle
riparazioni alla sezione sottomarina dello scafo.
L’odissea delle
riparazioni della “Kuznetsov” è la cartina tornasole perfetta
delle difficoltà in cui versa la cantieristica russa, che è stata pesantemente
colpita dalle sanzioni internazionali derivanti dalla crisi per la Crimea del
2014. Ancora oggi nei cantieri navali russi le ore/uomo di lavoro per tonnellata
di naviglio prodotta sono 3 volte quelle necessarie in un cantiere occidentale,
effetto della scarsa modernizzazione e soprattutto della situazione economica e
geopolitica. Dall’Ucraina, poi, arrivavano componenti essenziali per l’industria
navale di Mosca: basti pensare che per sostituire i prodotti importati da Kiev
il Ministero delle Finanze russo aveva stimato una spesa di circa 50 miliardi di
rubli, pari a circa 1,4 miliardi di dollari. Cifra che aumenta vertiginosamente
a 4,5 miliardi di dollari se si considerano le spese globali per acquistare i
sostituti russi dei prodotti ucraini ed europei bloccati dalle sanzioni.
Questa insufficienza
di materiali e tecnologie porta con sé, oltre a immaginabili ritardi nelle
consegne che non sono stati tamponati nemmeno dall’acquisizione dei cantieri
della Crimea – dediti a costruire vascelli di piccolo tonnellaggio – dei
problemi di affidabilità che sono risultati evidenti in tutta la loro gravità
sia durante le operazioni effettuate in Mediterraneo Orientale a sostegno della
campagna di Siria, sia durante i lavori di rimodernamento della portaerei
“Kuznetsov”.
Guardando oltre,
nonostante le riforme dottrinali emanate dal Cremlino, la Russia, per mancanza
di fondi, ha dovuto rinunciare o allungare le tempistiche di alcuni progetti per
nuove navi da guerra: quello per il nuovo cacciatorpediniere classe Lider,
abbandonato, quello per una nuova fregata, un vascello classe Admiral Gorshkov
migliorata (project 22350M) che è stato posticipato, e quello per una nuova
portaerei di grande tonnellaggio (definita “Shtorm”) che non è mai andato oltre
un modello in scala e alcuni disegni sulla carta.
Del resto la
cantieristica russa è impegnata a rimodernare la componente principale e più
importante, quella dei sottomarini (soprattutto i lanciamissili balistici), e ha
intrapreso il refit di un’importante unità di superficie: l’incrociatore classe
Kirov “Admiral Nakhimov”, che dovrebbe procedere alle prove in mare entro la
fine di quest’anno e tornare in servizio nella flotta nel 2024, dopo aver subito
anch’esso dei lavori di lunga durata. Una mole di lavoro che è stata molto
difficile da sobbarcarsi per la cantieristica russa stante le difficoltà
strutturale e contingenti, queste ultime determinate dalla crisi ucraina
sfociata nell’attuale conflitto che ha ulteriormente dato un giro di vite ai
beni sottoposti a embargo. PAOLO MAURI
Il vero problema
dei carri armati europei per l’Ucraina.
Paolo Mauri il 2
Marzo 2023 su Inside Over
La decisione di
alcuni Paesi europei di sostenere l’esercito ucraino nel suo sforzo di resistere
all’invasione russa con l’invio di Mbt (Main Battle Tank), ha “scoperto un
nervo” molto sensibile negli eserciti del Vecchio Continente. Un nervo che, con
ogni probabilità, è alla base della riluttanza di alcuni alleati, come
la Germania, ad inviare i carri armati a Kiev, e non ha nulla a che vedere col
fronte del consenso interno.
Come sappiamo,
la Bundeswehr – le forze armate tedesche – ha appena cominciato una fase di
profonda ristrutturazione a seguito di anni, decenni, di quasi abbandono. Un
abbandono che ha provocato evidenti carenze della sua struttura logistica,
incapace di mantenere in efficienza i mezzi in dotazione, e una “crisi di
valori” che da un lato è evidenziata dalla difficoltà di reclutamento,
dall’altra si è riflessa in una politica di marginalizzazione delle esigenze
delle forze armate, che, in tutti i loro rami, hanno dimostrato profondi deficit
di operatività. Abbiamo già ampiamente documentato questa situazione
della Bundeswehr, ma a quanto pare anche altre nazioni europee stanno
affrontando problemi, se non identici, quantomeno paragonabili a quelli
tedeschi.
L’Europa – o per
meglio dire parte di essa – fatica infatti a racimolare gli Mbt da inviare in
Ucraina, quindi si sta palesando un ritardo nelle consegne che ci sarebbe anche
se non ci fossero problemi di addestramento e di moltiplicazione della linea
carri dell’esercito ucraino, questione affatto secondaria per il personale
addetto alla manutenzione.
Il New York Times,
in un articolo recentemente pubblicato, ha definito – un po’ impietosamente – il
flusso di carri europei come “un rivolo”, ma il quotidiano statunitense non ha
tutti i torti.
Il Nyt riferisce che
alcuni Paesi hanno scoperto che i carri armati in proprio possesso in realtà non
funzionano o mancano di pezzi di ricambio. I leader politici hanno quindi
incontrato una resistenza imprevista all’interno delle loro stesse coalizioni e
persino dei loro ministeri della Difesa e alcuni eserciti hanno dovuto
richiamare gli addestratori dalla pensione per insegnare ai soldati ucraini come
usare gli Mbt vecchio modello.
Anche la Spagna, ad
esempio, che si è detta disposta a fornire Mbt tipo Leopard 2A4 all’Ucraina, si
è resa conto che i propri mezzi necessitano di manutenzione straordinaria, per
non parlare poi di quelle nazioni che nei depositi hanno ancora il modello
precedente, il Leopard 1.
Il problema è di
lunga data, tanto da essere diventato strutturale per tutti gli eserciti europei
con pochissime eccezioni, tra di esse la Polonia, la Svezia e la Finlandia che
però hanno “tradizioni” e storie diverse rispetto agli altri Paesi del Vecchio
continente.
La fine della Guerra
fredda, infatti, e la nascita di un mondo “unipolare” (che è stato di breve
durata), ha illuso l’Europa che l’”hard power” fosse obsoleto, pertanto non era
più necessario mantenere un esercito convenzionale “di livello” con un adeguato
(ed efficiente) numero di forze corazzate e meccanizzate.
La quantità di Mbt
prodotti in Europa è scesa a cominciare dalla metà degli anni ’90 e, nonostante
Paesi come la Germania abbiano fabbricato un numero notevole di nuovi tank
(proprio le ultime versioni di Leopard 2), esso non è paragonabile a quello del
periodo della contrapposizione in blocchi, quando il warfighting era in cima
all’attività addestrativa degli eserciti della Nato.
Riassumendo,
credendo che la guerra terrestre su larga scala fosse una cosa del passato e
crogiolandosi nel disgelo della Guerra fredda, le nazioni europee hanno sotto
finanziato la Difesa cronicamente, e a queste latitudini lo sappiamo bene:
in Italia, nonostante gli eventi bellici, si fa ancora fatica a stanziare
finanziamenti per avvicinarsi a quel 2% del Pil per la Difesa stabilito al
vertice Nato in Galles nel 2014.
Quando la Russia ha
lanciato la prima guerra di conquista nel continente europeo dalla fine della
Seconda guerra mondiale, l’Europa si è destata bruscamente da un sogno e si è
scoperta tristemente impreparata.
Eppure di segnali
premonitori ce ne sono stati: senza considerare il vertice di Monaco del 2007 in
cui il presidente russo Vladimir Putin per la prima volta ha evidenziato la
frattura con l’Occidente, reo, secondo il Cremlino, di minacciare la Russia
attraverso l’espansione dell’Alleanza Atlantica (e dell’Unione europea) verso
est, la breve guerra in Georgia nel 2008 avrebbe dovuto destare un primo sonoro
allarme nelle cancellerie europee. Invece abbiamo dovuto attendere il colpo di
mano russo in Crimea e la destabilizzazione del Donbass ucraino nel 2014 per
vedere un primo effettivo allarme in seno alla Nato, peraltro poco o nulla
recepito al di qua dell’Oceano Atlantico fatto salvo per i soliti britannici e
alcuni tra i Paesi più orientali dell’Alleanza, che da sempre hanno dimostrato
di avere sentimenti russofobi, peraltro giustificati (e giustificabili) sia
dalla loro storia sia dagli eventi del tempo e correnti.
Così mentre a Mosca
si varavano piani di produzione bellica (peraltro azzoppati dalle sanzioni post
annessione della Crimea) e mentre a Washington si provvedeva malvolentieri al
sostegno militare dell’Europa (con la European Deterrence Initative voluta da
Obama) in quanto ci si stava concentrando su una minaccia emergente (la Cina),
da queste parti si continuava generalmente a sonnecchiare nell’errata
convinzione che una guerra convenzionale fosse un orizzonte molto lontano, in
altri scacchieri globali (quello orientale) e perfino irrealizzabile nel Vecchio
continente. Il 24 febbraio 2022 Mosca ha dimostrato che si stavano sbagliando.
La fornitura di
armamenti all’Ucraina ha rivelato una realtà ironicamente amara: i depositi
europei non possono sostenere Kiev come vorrebbe senza intaccare la capacità di
deterrenza degli eserciti. Ecco perché, oltre alla questione della scarsa
manutenzione generata da anni di sottofinanziamenti, si fatica a inviare Mbt
all’Ucraina: la Germania ha offerto 18 Leopard 2 e la Polonia altri 14, il Regno
Unito 14 Challenger 2, i Paesi nordici come la Svezia, che da tempo spingevano
per le consegne di questi tank (ma ne offrivano solo “fino a 10”), ora stanno
frenando essendo alle prese con le preoccupazioni dei militari che non vogliono
sguarnire le proprie fila senza che ci siano nuovi mezzi in arrivo. Mezzi
che, come abbiamo già ampiamente discusso, faticano ad arrivare: l’industria
bellica europea in questo momento non può garantire un’elevata produzione di Mbt
(e non solo) e allora chi ha fretta di armarsi si affida altrove.
La Polonia (membro
della Nato e dell’Ue), si è rivolta al mercato statunitense e sudcoreano: in
arrivo, giusto per fare un esempio, gli Mbt K2 fabbricati dalla Hyundai e
altri M1 Abrams statunitensi. Anche Varsavia però, come altri, non è molto
propensa a cedere i suoi carri più moderni (ancora i Leopard 2) e ne invierà
solo 14 (di 200 presenti negli arsenali polacchi), optando per continuare
spedire all’esercito ucraino i suoi più vetusti T-72 e PT-91 ereditati dai tempi
in cui faceva parte del Patto di Varsavia.
L’unica soluzione
per continuare a sostenere l’Ucraina nel suo sforzo bellico e non intaccare la
capacità di deterrenza europea è quella di avviare nuove produzioni – che
richiedono comunque tempo -, ma per farlo servono ordini e quindi soldi:
qualcuno ha recepito questo messaggio, qualcun altro fa ancora fatica a
recepirlo.
A ben
vedere servirebbero più investimenti (e produzioni) in ogni caso, anche se
l’Europa non stesse sostenendo militarmente Kiev. PAOLO MAURI
Le casse di
Kyjiv. Lo stato dell’economia ucraina dopo un anno di guerra.
Andrea Galliano su
L’Inkiesta il 3 Marzo 2023.
L’ultimo report
della Banca mondiale ha stimato in 252 miliardi le perdite totali per la
chiusura delle attività commerciali. Ma la comunità internazionale, dagli Usa
all’Europa, sostiene Kyiv con pacchetti di aiuti consistenti
Tratto da Morning
Future
L’inflazione al 26
per cento, i tassi d’interesse al 25 e il crollo di un terzo del PIL. Ecco la
fotografia dell’economia ucraina dopo un anno dall’inizio del conflitto,
mostrata dai dati del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale
Ucraina.
Il Prodotto Interno
Lordo di Kyiv negli anni precedenti viaggiava sopra il 3 per cento, senza
contare il 2020 falsato dalla pandemia. L’aumento dei prezzi al consumo in
dodici mesi è più che raddoppiato. Inoltre, il 24 gennaio la Kyiv School of
Economics ha quantificato in 138 miliardi i danni subiti dalle infrastrutture,
con gli edifici residenziali danneggiati o distrutti che ammontano a 149.300.
L’ultimo report della Banca mondiale ha stimato in 252 miliardi le perdite
totali per la chiusura delle attività commerciali.
A fronte di tutto
ciò e per evitare che – una volta finita dalla guerra – non sia l’economia a
dare il colpo di grazia agli ucraini, sono stati previsti diversi aiuti
finanziari. Con l’obiettivo di schivare il default, i creditori internazionali
hanno congelato fino al termine del 2023 il pagamento di 20 miliardi di dollari
di obbligazioni. Il debito pubblico per il momento è salvo.
Gli aiuti finanziari
internazionali
Lo scorso 19
dicembre il Fondo Monetario Internazionale ha approvato il “Program Monitoring
with Board involvement”, un progetto di quattro mesi per mantenere la stabilità
economica nel Paese e attrarre donazioni.
Dopo aver erogato 13
miliardi di dollari nel 2022, l’amministrazione americana guidata da Joe
Biden intende continuare il proprio supporto offrendone altri 14,5. Ma gli aiuti
non sono previsti solo da Washington.
Tre miliardi sono
arrivati a Kyiv il 17 gennaio come prima tranche, a copertura dei mesi di
gennaio e febbraio, di un pacchetto da 18 miliardi che l’Unione Europea invierà
all’Ucraina distribuendolo per tutto il 2023. Lo scopo è soddisfare il
fabbisogno finanziario del Paese sotto attacco. Nello specifico servirà a pagare
gli stipendi e le pensioni, a garantire i servizi pubblici essenziali (come
ospedali e scuole) e a riparare le infrastrutture critiche danneggiate.
Tra le richieste
avanzate da Bruxelles a Kyiv per ricevere le successive rate mensili da un
miliardo e mezzo, c’è l’approvazione di riforme per rafforzare lo Stato di
diritto e la lotta alle frodi e alla corruzione. L’obiettivo ultimo è sostenere
il Paese guidato da Volodymyr Zelensky nel percorso verso l’integrazione
europea. Questo strumento di assistenza macrofinanziaria è un prestito che
l’Ucraina ripagherà in 35 anni a partire dal 2033. Gli Stati membri dell’UE si
occuperanno di coprire il costo degli interessi. Il pacchetto era stato
approvato dal Consiglio il 14 dicembre, dopo la proposta della Commissione dello
scorso 9 novembre.
Non si sono mosse
solo le istituzioni dell’Unione Europea. Dopo la conferenza di Parigi del 13
dicembre 2022, intitolata “Solidali con il popolo ucraino” e organizzata dal
presidente francese Emmanuel Macron, è stata decisa l’erogazione di 1 miliardo
di euro da parte di 47 Paesi, con lo scopo di aiutare il popolo ucraino a
superare l’inverno. In particolare, 415 milioni saranno destinati al settore
energetico, 38 all’alimentazione, 25 all’acqua, 22 ai trasporti, 17 alla salute
e il resto da stabilire in base alle necessità. Volodymyr Zelensky aveva chiesto
almeno 800 milioni per far fronte al blackout e al terrore energetico causati
dai bombardamenti: il risultato ha superato la richiesta.
L’appuntamento nella
capitale francese ha fatto seguito alle conferenze di Lugano, Varsavia e Berlino
dei mesi precedenti ed è stato reso necessario dal cambio di strategia della
Russia, che sta cercando di indebolire la resistenza ucraina colpendo le
infrastrutture civili.
Articolo di “The
Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione” il 3 marzo
2023.
Durante la seconda
guerra mondiale, le forze armate tedesche hanno distrutto i carri armati
sovietici a un ritmo fenomenale. Ma anche se l'Armata Rossa perse 80.000 carri
armati, la potenza industriale dell'Unione Sovietica le permise di terminare la
guerra con più carri armati di quanti ne avesse all'inizio del conflitto.
Oggi i carri armati
sono molto più sofisticati e costosi e vengono quindi impiegati in numero molto
inferiore. Tuttavia, nella guerra con l'Ucraina la Russia, come l'Unione
Sovietica, ha perso un numero enorme di carri armati. L'Ucraina sostiene di
averne distrutti più di 3.250.
Oryx, un blog di
intelligence open-source, ha documentato 1.700 perdite. L'Istituto
internazionale per gli studi strategici, un think tank, sostiene che circa la
metà della dotazione russa di t-72 di prima della guerra, che contava circa
2.000 esemplari e costituiva il grosso della sua forza di carri armati, è stata
distrutta.
I carri armati
della Russia non sono riusciti a darle un vantaggio in Ucraina e le sue forze
faranno fatica a portare avanti un'altra grande offensiva senza un sufficiente
supporto corazzato. Nelle ultime settimane l'Ucraina si è assicurata carri
armati dai suoi alleati occidentali, che probabilmente utilizzerà in una
controffensiva di primavera. La Russia dovrà rafforzare la propria flotta se
spera di mantenere il territorio conquistato. Riuscirà a sostituire i carri
armati persi questa volta?
Negli anni '40 le
fabbriche sovietiche potevano produrre più di 1.000 carri armati al mese. Agli
impianti che producevano trattori e motori ferroviari fu detto di costruire
carri armati. Oggi è più difficile aumentare la produzione. L'elettronica dei
carri armati moderni - per la visione notturna, il puntamento delle armi e una
serie di altre funzioni - è molto sofisticata. Ciò rende la produzione più lenta
e significa che molte fabbriche progettate per altri tipi di produzione non
possono facilmente produrre carri armati.
In Russia è rimasta
solo una fabbrica di carri armati: UralVagonZavod, un enorme complesso costruito
negli anni Trenta. Ma la cattiva gestione finanziaria e gli enormi debiti hanno
rallentato la modernizzazione. Gli operai scherzano dicendo che assemblano i
carri armati a mano. Novaya Gazeta, un quotidiano russo liberale, riferisce che
l'impianto ne produce appena 20 al mese. Un funzionario occidentale ha
dichiarato a The Economist che, in totale, la domanda di carri armati da parte
delle forze armate russe supera di dieci volte la produzione.
Nel tentativo di
soddisfare la domanda, la Russia ha aumentato il ritmo di ripristino dei vecchi
carri armati, di cui ha migliaia in deposito. In Ucraina i moderni carri armati
russi, come i t-90, combattono ora accanto a un gran numero di t-72b3, costruiti
decenni fa ma aggiornati con cannoni, corazze reattive (che riducono la
possibilità che un colpo penetri nel veicolo) e comunicazioni digitali.
Anche con questi
miglioramenti, i carri armati più vecchi sono inferiori ai nuovi modelli e hanno
meno probabilità di sopravvivere a un colpo delle forze ucraine, ma sono ancora
utili. Secondo i media russi, UralVagonZavod ricostruisce circa otto carri
armati al mese e altri tre impianti di riparazione di veicoli blindati ne
riparano circa 17 ciascuno. Altri due impianti di dimensioni simili dovrebbero
entrare in funzione nei prossimi mesi.
Ciò significa che,
sebbene la Russia sia in grado di costruire solo 20 nuovi carri armati al mese,
potrebbe presto essere in grado di recuperarne circa 90 al mese dai suoi
depositi. Ma questo non basterebbe a compensare le 150 unità che si stima
perdano ogni mese, secondo l'analisi di Oryx. Inoltre, la produzione potrebbe
essere ostacolata dalla carenza di componenti.
I semiconduttori, i
chip per computer che controllano i moderni carri armati, sono particolarmente
scarsi. La Commissione europea sostiene che la Russia stia utilizzando
nell'hardware militare chip provenienti da lavastoviglie e frigoriferi
importati. Alcuni carri armati recentemente ristrutturati in Ucraina contengono
un guazzabuglio di hardware di modelli diversi e mancano di attrezzature ad alta
tecnologia, come i sensori di velocità del vento, che consentono di sparare con
precisione.
La Russia non è sola
in questi problemi. Anche l'Ucraina e i suoi alleati non hanno la capacità di
produrre carri armati in tempi rapidi. L'unica fabbrica di carri armati
dell'Ucraina, vicino a Kharkiv, è stata distrutta all'inizio della guerra.
L'America, che ha promesso di inviare 31 carri armati M1A2 Abrams all'Ucraina,
ha una sola fabbrica, con una capacità di produrre 15 carri armati al mese.
La produzione in
altre parti dell'Occidente è altrettanto lenta, il che ha portato a una corsa
alla ricerca di vecchi carri armati da donare. Ma in generale, le forze che
attaccano usano più carri armati dei difensori. Con l'avanzare del conflitto, è
probabile che la Russia veda la sua flotta ridursi costantemente sia in termini
di quantità che di qualità. Questa volta, la produzione potrebbe non salvarla.
(ANSA il 4 marzo
2023) - Sono oltre 200.000 i soldati russi morti o feriti dall'inizio
dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022: lo ha detto il Comandante
supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale statunitense
Christopher Cavoli, definendo "incredibile" la portata della guerra. Lo riporta
il settimanale tedesco Der Spiegel.
Finora, oltre 1.800
ufficiali russi sono stati uccisi o feriti e Mosca ha perso più di 2.000 carri
armati, ha aggiunto Cavoli, sottolineando che l'esercito russo spara più di
23.000 proiettili di artiglieria al giorno. Secondo Kiev, dall'inizio della
guerra la Russia ha perso 152.190 soldati, di cui 820 ieri.
Guerra in
Ucraina, “centinaia di migliaia di morti”. Il bollettino che inguaia la Russia
Il
Tempo il 04 marzo 2023
Un bollettino da
incubo. Il comandante supremo alleato della Nato in Europa, il generale
dell’esercito americano Christopher Cavoli, ha dichiarato che la Russia ha perso
più di 200.000 soldati dall’inizio della sua invasione in Ucraina il 24 febbraio
2022, descrivendo la portata della guerra come «incredibile». Il generale ha
aggiunto che oltre 1.800 ufficiali russi sono stati uccisi o feriti, dati
rivelati nel colloqui con la rivista tedesca Der Spiegel. Cavoli ha anche detto
che la Russia ha perso «molto più» di 2.000 grandi carri armati e che il suo
esercito spara una media di 23.000 proiettili di artiglieria al giorno.
Il ministero della
Difesa del Regno Unito aveva già diffuso una stima secondo la quale l’esercito
russo e i gruppi mercenari hanno probabilmente perso tra 175.000 e 200.000
persone in Ucraina, con un picco massimo di 60.000 uccisi. Secondo un rapporto,
i prigionieri reclutati dal gruppo mercenario privato Wagner, sostenuto dal
Cremlino, hanno subito un tasso di vittime fino al 50%. Un fallimento rispetto
all’operazione lampo che si prospettava nel febbraio 2022 per gli uomini di
Vladimir Putin.
Il Bestiario, il
Parrocchino.
Giovanni Zola il 2 Marzo 2023 su Il Giornale.
Il Parrocchino è un
leggendario animale che sta chiuso in sacrestia e quando esce sventola le
bandiere arcobaleno della pace
Il Parrocchino è un
leggendario animale che sta chiuso in sacrestia e quando esce sventola le
bandiere arcobaleno della pace.
Il Parrocchino è un
essere mitologico che, come suggerisce il nome, un po’ è parroco e un po’ è
chino. All’origine questo essere era un punto di riferimento per i parrocchiani
che si riunivano intorno al campanile della chiesa del paese per trovare
conforto nelle parole e nelle opere del Parrocchino. Si narra che a quei tempi
il popolo entrasse addirittura in chiesa. La grande forza di questa creatura
leggendaria era che, amando l’incontro fatto con Gesù Cristo, proponeva una
parola diversa da quella della falsa speranza mondana mettendo al centro Cristo
stesso.
Nel corso dei secoli
però il Parrocchino, dovendo andare contro corrente e non ottenendo sempre il
successo sperato, perse entusiasmo e sostituì Cristo con i “valori” fino a
quando, col passare del tempo, oltre a dimenticarsi del motivo per cui era
diventato prete cominciò a vergognarsi proprio di Cristo. Non avendo più niente
da dire il Parrocchino si trovò a inchinarsi al pensiero più in voga del momento
perdendo il senso vero della vita, sua e dei parrocchiani.
Venendo ai giorni
nostri il Parrocchino si è ridotto a un buon uomo costretto a qualche
restrizione in più rispetto ai comuni mortali (infatti il sinodo tedesco sta
proprio lavorando sull’eliminazione delle ormai inutili restrizioni). Per
questo, cioè in quanto uomo di buona volontà che però non è la sua, il
Parrocchino organizza manifestazioni inclusive a favore della sacro santa pace
nel mondo munendosi di bandierine arcobaleno da agitare durante la marcia in
silenzio e con il divieto di esibire qualsiasi segno di appartenenza alla
Chiesa. Putin, secondo fonti dei servizi segreti, se la sta già facendo addosso.
Inoltre non si capisce che differenza ci possa essere tra una marcia pacifista
indetta dal Parrocchino e una iniziativa organizzata da schleineriani
accompagnati da attivisti LGBTQYZ mezzi nudi e al ritmo di musica da rave party.
Anzi, una differenza ci sarebbe perché nel secondo caso, se non altro, ci si
potrebbe divertire di più.
Alcuni esperti
studiosi sottolineano che anche la preghiera non basta a fermare la guerra. Il
problema è che la guerra si potrebbe fermare solo grazie alla conversione. Per
questo la preghiera, al contrario della manifestazione con la bandierina buona
sola a lavarsi la coscienza, ha il potere di convertire il singolo, il che
sarebbe già un grande cambiamento per il mondo.
I disarmisti. I nostri cremlinofili si lamentano di essere
chiamati putiniani, ma sarebbe un’attenuante.
Francesco Cundari su
L’Inkiesta il 24 Marzo 2023
Se davvero stiamo
con Kyjiv, l’unica cosa che non possiamo fare è respingere la richiesta di aiuto
degli ucraini, sostenendo al tempo stesso che lo facciamo per il loro bene
Ogni giorno decine
di commentatori ripetono le tesi della propaganda russa, anche le più assurde e
autocontraddittorie, da tutti i principali quotidiani e talk show del Paese,
lamentando nel contempo le continue angherie cui sarebbero sottoposti dalla
dittatura del pensiero unico. Non è una novità, intendiamoci. Mi è capitato di
notarlo ben prima della guerra in Ucraina: in Italia gli anticonformisti sono
sempre una maggioranza schiacciante.
Al consueto
miscuglio di arroganza e vittimismo si aggiunge però in questo caso una
contraddizione ulteriore, tipica di questa specifica categoria di opinionisti.
Parlo di quel variegato universo di giornalisti, politici e intellettuali che
sarebbe improprio definire pacifisti, sia perché ci sono tra loro fior di
guerrafondai, sia perché chiedere di disarmare gli aggrediti è l’idea di pace
tipica di tutti gli imperialisti del mondo, almeno dai tempi dell’impero
persiano. Motivo per cui li chiamerei piuttosto disarmisti, o semplicemente
cremlinofili.
Ebbene, questo
nutrito esercito di opinionisti passa le giornate in tv e sulla stampa a
spiegarci in modi complicati e fumosi perché, per ottenere la pace, stringi
stringi, bisogna fermare gli ucraini, fermare coloro che li aiutano e li
sostengono, fermare gli Stati Uniti, fermare la Nato, fermare tutti meno che i
russi. Quando però qualcuno si permette di osservare che usano proprio gli
stessi argomenti della propaganda putiniana, curiosamente, se la prendono
moltissimo, s’indignano e reagiscono come se la qualifica di putiniani fosse per
loro un insulto. Mentre con ogni evidenza, dato quel che sostengono, sarebbe
semmai un’attenuante.
Se infatti si
dichiarassero convinti del fatto che Vladimir Putin abbia pienamente ragione,
almeno la logica del loro discorso sarebbe salva. Resterebbe ovviamente un
cumulo di balle, ma sarebbe almeno un cumulo di balle che rispetta il nesso di
causa-effetto.
La contraddizione
più insopportabile del fronte disarmista è invece la pretesa di respingere la
richiesta di aiuto degli ucraini, sostenendo però che lo facciamo per il loro
bene. È questo il punto, ricorrente soprattutto nella propaganda grillina, come
sempre la più sfacciata di tutte, che trasforma la discussione in una
barzelletta di cattivo gusto. Se si dicessero apertamente putiniani, si potrebbe
almeno concedere loro la buona fede. Se davvero fossero convinti che sono gli
ucraini ad avere aggredito i russi, si potrebbe dubitare della loro cognizione
dello spazio e del tempo, eppure bisognerebbe anche riconoscere la
consequenzialità del loro discorso.
Ma se nemmeno loro
sono disposti a credere davvero che sia l’Ucraina ad avere scatenato la guerra
contro la Russia (come ha detto Sergej Lavrov), o che i bambini ucraini siano
stati deportati in Russia per metterli al sicuro dalle atrocità dell’esercito
ucraino (dichiarazione dell’ambasciata russa in Italia, giuro: «La Russia ha
dato rifugio ai bambini costretti a fuggire con le loro famiglie dai
bombardamenti e dalle atrocità dell’esercito ucraino»), o che Putin è dovuto
intervenire per fermare un genocidio in atto nel Donbas e tutto il resto del
delirante repertorio, come possono giustificare la proposta di negare agli
aggrediti persino gli strumenti per difendersi da soli? E con che coraggio si
può continuare a dire che dobbiamo rifiutarci di aiutarli, ma nel loro
interesse, sostenendo al tempo stesso di stare dalla loro parte, di fare il tifo
per loro, di augurare loro ogni bene?
E tu pensa che
avremmo fatto se li avessimo odiati.
Rischio guerra
per l'Italia, Rampini a valanga. E stronca Conte.
Giada Oricchio su Il
Tempo il 22 marzo 2023
La Camera ha
approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni della
presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio europeo in programma
domani e dopodomani a Bruxelles. In Aula il confronto tra governo e opposizioni
è stato acceso, in particolare sull’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha accusato la premier: “Ci state
trascinando di gran carriera in guerra. È vero ci mette la faccia, ma è una
faccia di bronzo. Le armi che inviamo sono sempre più pesanti. Si ragiona di
ammassare centinaia di migliaia di soldati Nato al confine. Lei sta portando
l'Italia in guerra con un piglio coraggioso”.
Affermazioni
destituite di ogni fondamento secondo Federico Rampini, inviato del Corriere
della Sera. In collegamento con la trasmissione di LA7 Tagadà, mercoledì 22
marzo, il politologo ha liquidato come “fantasiose” le frasi di Conte: “È una
forzatura dire che l’Italia è in guerra. Noi c’entriamo pochissimo. Anche dal
punto di vista economico il nostro apporto all’Ucraina è pressoché invisibile.
Faccio un esempio: l’America dall’inizio della guerra ha speso lo 0,2% del suo
Pil in armi e aiuti all’Ucraina. E fa un multiplo degli europei. La verità è che
quello che l’Italia ha speso per la guerra, lo ha speso per sé stessa cioè gli
aiuti alle famiglie italiane e alle imprese per attutire l’impatto del caro
bollette. È questa l’unica vera spesa sostanziale”.
Secondo Rampini,
l’Italia ha speso per proteggersi dalle conseguenze dirette e indirette
dell’invasione: “Per descriverci come un Paese in guerra ci vuole molta, molta
immaginazione”.
La mozione del
Carroccio poi ritirata. Armi a Kiev, la Lega si scaglia contro Meloni.
Claudia
Fusani su Il Riformista il 22 Marzo 2023
La premier si
lamenta di “mezzo Parlamento che manda il governo al Consiglio europeo
accusandolo di strage a Cutro”. Ma sbaglia il focus. Due volte: la prima perché
le opposizioni sono cosi divise su tutto da presentare e votare quattro diverse
mozioni, Pd, 5 Stelle, Terzo Polo, Sinistra; la seconda volta perché il vero
problema di Meloni è presentarsi al Consiglio europeo di giovedì e venerdì con
la sua stessa maggioranza spaccata come una mela. Una parte ha fatto outing
ieri, senza e senza ma, direttamente in aula nella persona del
capogruppo Massimiliano Romeo che nella dichiarazione di voto finale ha
attaccato il governo sulla politica estera e nello specifico
sull’Ucraina. “Contiamo su di lei Presidente Meloni perché insista sulla strada
del dialogo”.
Un “saggio
consiglio – ha proseguito – è quello di evitare escalation”. Guai, ha
aggiunto, “alla dolce tirannia del pensiero unico”. Quindi, “nel comunicare il
voto favorevole alla risoluzione della maggioranza, esprimiamo forte
preoccupazione per come stanno andando le cose sul fronte della guerra
russo-ucraina. L’obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una
dichiarazione di principio. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa
ad armamenti sempre più potenti con il rischio di un incidente da cui non si
possa tornare indietro”. Una vera e propria escalation di dichiarazioni
“pacifiste” che spiazza la premier e la lascia “sola” nei banchi del governo del
Senato senza neppure un rappresentante della Lega. Il
sottosegretario Ostellari arriverà una volta che Romeo ha concluso l’intervento.
Neppure l’ombra di un ministro. A cominciare da Salvini alle prese con ponti,
infrastrutture e crisi idrica.
Alla viglia della
riunione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì Giorgia Meloni si ritrova
così indebolita ma non dalle opposizioni. Bensì dal suo principale alleato. E
questo non è un bel viatico per una riunione, a Bruxelles da cui palazzo Chigi
si aspetta molto soprattutto sul dossier immigrazione. Giallo Lega, dunque. Ci
vuole poco per capire che il problema è ben oltre le parole. La verità è che la
Lega aveva scritto una diversa risoluzione. Tanto che su quella poi messa in
votazione c’è “solo” la firma di Gian Marco Centinaio, il vicepresidente della
Camera, fedelissimo di Salvini, ma non quella del capogruppo Romeo. Che ne aveva
presentata un’altra. Un testo assai diverso di cui Il Riformista è entrato in
possesso. Diverso sia per quella che riguarda l’impegno militare in Ucraina. Che
sui dossier economici, patto di stabilità e transizione green.
Nella bozza
della Lega, ad esempio, per limitarsi ai 12 punti a cui si vuole impegnare
l’azione del governo, la bozza leghista parla di “favorire ogni iniziativa
finalizzata alla cessazione immediata dei combattimenti” mentre quella di
maggioranza votata in aula parla, in modo assai più blando, di “risoluzione del
conflitto nel rispetto del diritto internazionale lavorando con la comunità
internazionale nel quadro delle Nazioni Unite”. Romeo parla di “pianificare
specifiche iniziative per la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina” perché ci
mancherebbe solo che la ricostruzione toccasse, un domani, alla Cina e sarebbe
il colmo. La risoluzione della maggioranza mette al primo posto il “continuare a
far fronte alle immediate esigenze per la resilienza dell’Ucraina insieme agli
altri Stati membri”. Nel testo della maggioranza si fa specifico riferimento
a “Georgia e Moldavia per garantire loro l’ingresso nell’Unione”. La Lega non fa
alcuna menzione dei due paesi che più di tutti nell’immediato rischiano/temono
l’invasione dei carri russi.
Fin qui la
parte “guerra”. Le differenze sono altrettanto sostanziali nella parte economica
della risoluzione. Il punto 10, ad esempio, è stato totalmente riscritto. Si
legge nella bozza leghista: “Nelle more di una riforma del patto di Stabilità
che consenta di poter affrontare la transizione nel 2024 in maniera realistica e
con obiettivi raggiungibili, il governo dovrà prevedere che le future regole
fiscali promuovano gli investimenti in tutti i settori strategici, ambiente,
digitalizzazione, difesa e natalità”. Sono dodici punti per cui si chiede al
governo un “impegno specifico”. E in quasi tutti la Lega ha chiesto modifiche
che non sono state accolte o solo in minima parte (come il passaggio “aumentare
e garantire rimpatri efficaci” presente anche nel testo finale della
risoluzione). Il dissenso quindi era non solo noto. Anzi, era scritto. In nome
dell’unità di governo, è stato una volta di più messo da parte.
Tanto che, nei
banchi della Lega, quando Centinaio e Romeo ieri era al Senato preparavano i
rispettivi interventi – Centinaio nella discussione generale, Romeo nelle
dichiarazioni di voto finali – si suggeriva loro in amicizia di preparare un
testo scritto. Così da “evitare fraintendimenti” che su questi temi sono sempre
in agguato. Centinaio l’ha fatto e ha detto quanto previsto. Quando ha preso la
parola Romeo, i primi a tirarsi i pizzicotti sono stati gli stessi leghisti.
“Constatiamo purtroppo che negli ultimi tre mesi ben poco è stato fatto specie
sul cessate il fuoco e sulla tregua. Quindi, contiamo su di lei Presidente
Meloni. La gente dice che lei è una tosta, spero non solo perché è andata al
congresso della Cgil”. Romeo peggio di Patuanelli o Licheri, i pasdaran
pacifisti di Conte. Giorgia Meloni non se lo aspettava. “Conta il voto e la Lega
ha votato compatta” ha commentato il ministro per i Rapporti col parlamento Luca
Ciriani. Ma è chiaro che non basta più il voto.
Claudia Fusani.
Giornalista originaria di Firenze laureata in letteratura italiana con 110 e
lode. Vent'anni a Repubblica, nove a L'Unità.
Loro di Mosca.
L’antioccidentalismo di Salvini e Conte e il ritorno dei gialloverdi.
Mario Lavia su L’Inkiesta il 23 Marzo 2023
Su sponde opposte, i
leader di Lega e Movimento 5 stelle tentano di boicottare l’invio di armi
all’Ucraina per recuperare qualche voto a danno di Meloni e Schlein, nella
speranza di non crollare nei sondaggi
Se oggi ci fosse
ancora il Conte uno l’Italia non manderebbe le armi all’Ucraina e dunque si
collocherebbe contro l’Alleanza atlantica, cioè fuori dal novero dei Paesi
civili e democratici. Meno sicuro, ma non impossibile, che ciò avverrebbe anche
con il Conte 2: è meno probabile perché lì c’era un Partito democratico che pur
con tutti i mal di pancia sostiene l’invio di armi a Kyjiv.
Comunque sia, in
questi giorni l’intesa giallo-verde si sta rinsaldando attorno alla questione
principale dell’agenda mondiale grazie alla dichiarata opposizione al sostegno
armato all’Ucraina da parte del Movimento 5 stelle e all’evidente insofferenza
della Lega nel confermarlo.
Poi è ovvio che alla
fine i leghisti votino le risoluzioni del governo, mica siamo al tempo del
Papeete, e però la differenza tra Lega e Fratelli d’Italia sul punto è risultata
chiarissima dai discorsi parlamentari dei salviniani che come ha sconsolatamente
osservato Claudio Borghi «purtroppo loro hanno molti più voti di noi».
La guerra di Mosca
c’entra relativamente. Il fatto è che su questa questione Giuseppe Conte e
Matteo Salvini tentano di fare concorrenza (sleale) alle due leader del momento,
Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che a stare ai risultati elettorali nel primo
caso e ai sondaggi nel secondo gli stanno mangiando i consensi.
Si tratta di
concorrenza sleale – ma qui non servono tante spiegazioni – perché è molto
facile fare i pacifisti sulla pelle di un popolo che sopravvive con tutte le sue
forze a una aggressione vigliacca e forsennata facendo credere che chi è a
fianco della Resistenza sia un guerrafondaio. È la litania di Giuseppe Conte
che, scippato delle proposte sociali e totalmente assente su quello dei diritti
civili sui quali Schlein domina la scena, prova a presidiare l’area pacifista e
a cavalcare le pulsioni antioccidentali se non dichiaratamente filoputiniane
cercando per questa via di risalire la china.
Speculare è la
situazione di Salvini, ormai chiaramente escluso dalla direzione reale del
governo che è tutta in mano alla presidente del Consiglio e ai suoi uomini – di
fatto, siamo davanti a un monocolore di Fratelli d’Italia – e non basta certo la
propaganda sul ponte di Messina a farne un protagonista di questa stagione: ecco
perché egli ha bisogno di uno spazio vitale come il “pacifismo” che nel cuore
della Lega ben si mescola al tradizionale filoputinismo dell’epoca dei Gianluca
Savoini e degli incontri nella hall dell’hotel Metropol di Mosca, luogo
prediletto per faccendieri di ogni risma.
Più in generale va
notato che di fronte alla guerra di Putin si sta nuovamente disegnando uno
spartiacque tra politica e antipolitica, tra ragione e demagogia, tra
responsabilità e populismo, per cui da una parte – pur con tutte le
contraddizioni – resiste un asse FdI-Pd-Terzo Polo che continua a difendere la
lotta di un popolo oppresso e le ragioni dell’Occidente democratico e dall’altra
una piccola intesa gialloverde che innaffia il terreno del populismo e del
pacifismo più o meno in buonafede, tornando a saldare quell’alleanza che a suo
tempo Steve Bannon definiva come «avamposto della rivoluzione sovranista»
(quando anche il partitino di Giorgia Meloni, erede del Movimento sociale
italiano, ne faceva parte).
Da allora i processi
politici hanno spinto Salvini ancora più a destra e Conte verso una sua
“sinistra” modellata sui canoni della demagogia e addirittura del clientelismo,
e dunque i gemelli del populismo si sono allontanati, ma oggi c’è da chiedersi
se questa oggettiva convergenza sul tema dei temi – la guerra – non preluda a
una contemporanea ribellione di contiani e salviniani nei confronti delle due
leadership che contano, quelle di Schlein e Meloni. A occhio e croce, visti i
personaggi, è prevedibile un duplice fallimento.
Nemici miei. Tre
anni fa Conte fece sfilare l’esercito russo in Italia, ovvio che oggi non voglia
aiutare l’Ucraina.
Christian Rocca su
L’Inkiesta il 23 Marzo 2023
Era il 23 marzo 2020
quando ventidue mezzi militari di Mosca con a bordo oltre cento uomini
risalirono l’Italia rinchiusa in casa dal lockdown. Una delle pagine più
imbarazzanti e tragicomiche della nostra storia, che spiega però perché i
volenterosi complici di Putin ancora adesso si battano per la resa di Kyjiv e
non chiedano mai al Cremlino di fare l’unica cosa che fermerebbe la guerra:
lasciare in pace gli ucraini e tornarsene a casa
Mentre i
suprematisti russi continuano a bombardare indiscriminatamente le città e i
civili ucraini nel tentativo genocida di spezzare la resistenza di un favoloso e
coraggioso popolo che lotta ogni giorno per la sopravvivenza fisica e culturale
della propria comunità, l’oscena Bieloitalia che va in onda a reti unificate
tutte le sere in tv dimentica stranamente di celebrare il terzo anniversario
della pagina più umiliante della nostra storia repubblicana recente.
Una pagina surreale,
da commedia all’italiana, con protagonisti grotteschi tipo ”Amici miei”, se non
fosse per ciò che è successo dopo, ovvero la guerra all’Ucraina e all’Europa
scatenata da Vladimir Putin.
Il 23 marzo del
2020, su iniziativa di Giuseppe Conte e di Putin – il bellimbusto di Volturara
Appula e il criminale di guerra dell’Aja – allo stesso esercito russo che dal
2022 bombarda ogni giorno gli ucraini è stato consentito di sfilare lungo
l’Autostrada del Sole con tanto di bandiere e di coccarde, da sud a nord, mentre
l’Italia era rinchiusa in casa dal lockdown, realizzando la più tragicomica
sceneggiata geopolitica mai progettata da una mente umana.
Esattamente tre anni
fa, una colonna di ventidue veicoli militari russi con a bordo oltre cento
addetti dell’esercito e dei servizi segreti di Mosca, di cui solo una trentina
medici e infermieri, ha solcato per la prima volta dal secondo dopoguerra il
territorio di un paese Nato, dopo essere sbarcata a Pratica di Mare dove era
stata accolta dai grillini Luigi Di Maio e Marcello Minenna, ma fortunatamente
affiancati dal capo di stato maggiore dell’esercito italiano che riuscì a
limitare l’azione di intelligence dell’esercito russo che Gius aveva concesso a
Vlad nel corso di una telefonata imbarazzante che resterà nella storia
raccapricciante del nostro paese.
Putin era un
criminale di guerra già allora, decorato sul campo di battaglia ceceno, siriano,
georgiano, ucraino e anche sul fronte interno russo con omicidi mirati di
oppositori politici, di dissidenti e di giornalisti e con una strategia
stragista da Mosca e a Beslan.
Nonostante ciò, o
forse proprio grazie a cotanto curriculum, il duce del Cremlino è stato il
beniamino del primo governo Conte, il leader amato da Matteo Salvini, l’alleato
formale della Lega, il condottiero ammirato dai Cinquestelle più fessi e anche
l’amico carissimo di Silvio Berlusconi, oltre che un riferimento culturale per
l’allora oppositrice Giorgia Meloni (la Meloni di governo invece sa come
comportarsi, almeno per ora).
Lo sbarco in Italia
dell’esercito russo è stata un’operazione di tentato spionaggio e di realizzata
propaganda mascherata da aiuti di valore sanitario inesistente e comunque a
carico economico del nostro paese.
“Dalla Russia con
amore”, così si chiamava l’operazione speciale di Putin, è stata la naturale
conseguenza della dipendenza politica da Mosca dell’allora governo “Conte uno” e
di parte dell’opposizione, malgrado poi sia arrivata durante il governo “Conte
due”, con il Pd al posto della Lega a testimoniare plasticamente la catastrofe
civile e morale dell’alleanza tra la sinistra e i Cinquestelle tornata di moda
in queste settimane.
I bieloitaliani sono
quegli italiani colonizzati dalle fregnacce russe e li vedete ogni sera in tv e
anche in Parlamento. I bieloitaliani continuano a manipolare il dibattito
pubblico e a condizionare la ferma posizione del nostro paese a sostegno
dell’Ucraina, dell’Europa e dell’Occidente liberal-democratico.
I bieloitaliani sono
seguaci di uno stravagante tipo di “pacifismo guerrafondaio” che invoca la resa
delle vittime, che si batte per non proteggere gli aggrediti, che difende le
ragioni imperialiste dell’aggressore dotato di bomba atomica e di palmares da
sterminatore di civili.
Mai i
bieloitaliani chiedono al genocida di Mosca di fermare i missili, mai lo
invitano a ritirarsi dai territori dove ha imposto la pulizia etnica e creato le
fosse comuni, mai gli spiegano che non si strappano i bambini ai legittimi
genitori e non si deportano nella grande madre Russia per lavargli il cervello,
come da secolare tradizione zarista e sovietica.
Al contrario, i
sedicenti pacifisti italiani accusano Volodymyr Zelensky di resistere troppo, si
bevono i complotti contro la Nato elaborati in Russia come ai tempi dei falsi
protocolli dei Savi di Sion, e non sopportano che gli ucraini incredibilmente
preferiscano difendersi anziché abbonarsi a Limes.
I sedicenti
pacifisti italiani vogliono che gli ucraini si arrendano e non credono che Putin
e la Russia siano i responsabili unici della carneficina in Europa.
Il leader di questa
volenterosa Italia complice di Putin è il
conduttore-unico-del-talk-show-collettivo che quotidianamente diffonde
disinformazione e propaganda servendosi di utili idioti, di saltimbanchi e di
quaqquaraquà.
Il leader politico
di quest’area è Giuseppe Conte (Salvini è così scarso da essersi fatto superare
in putinismo perfino dall’avvocato del populismo). Conte ha accompagnato
l’Italia durante la più catastrofica crisi economica e sanitaria della sua
storia recente, da cui ne è uscita solo cacciandolo da Palazzo Chigi e
mettendoci al suo posto qualcuno in grado di cancellarne ogni traccia nel più
breve tempo possibile.
Il Conte prima
sovranista, poi berlingueriano, ma sempre putiniano, rappresenta la forma più
esatta di trasformismo nichilista di questa epoca. Nel giorno del terzo
anniversario di “Dalla Russia con amore”, va sottolineato a imperitura memoria
che il Conte che non vuole aiutare gli ucraini a difendersi è colui che ha
consentito all’Armata russa di marciare in Italia come nel Donbas.
Quarta
Repubblica, Toni Capuozzo attacca l'Europa: "Il sapore dello sfregio a Putin".
su
Libero Quotidiano il 20 marzo 2023
No, Toni
Capuozzo non è uno che usa giri di parole. Spesso controcorrente, spesso
contestato. Ma dice sempre quel che pensa, soprattutto sulla guerra mossa dalla
Russia all'Ucraina, conflitto sulla quale ha in passato espresso opinioni
controverse, molto dibattute e altrettanto criticate, in particolare quando mise
in discussione l'eccidio di Bucha, uno dei principali orrori del Cremlino in
territorio ucraino.
E Toni Capuozzo
torna a far discutere a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola
Porro in prima serata su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 20 marzo.
Sapevi che a
Favignana si coltiva l'alga Posidonia? Scopri i suoi benefici per la pelleLa
crema protezione viso Posidonia è un’emulsione leggera e trasparente, che offre
un’elevata protezione solare, idrata e nutre la p…radiocittafujiko.it
Passi tanto tempo al
PC? Scopri l'Astaxantina per il benessere dei tuoi occhi!Prova l’Astaxantina
Marcus Rohrer, brand leader nella produzione di integratori alimentari di alta
qualitàleggilanotizia.it
L'esperto di guerra
e geopolitica è ospite in collegamento e viene chiamato a dire la sua sul
mandato di cattura internazionale emesso contro Vladimir Putin la scorsa
settimana dalla Corte di giustizia dell'Aja: in virtù del provvedimento, lo zar
dovrà essere arrestato non appena metterà piede in tutti i paesi che
sottoscrivono il trattato (tra i quali non ci sono Russia, Cina e anche Stati
Uniti, dove però per ovvie ragioni lo zar non metterebbe mai piede).
E Toni Capuozzo, sul
mandato di cattura, ha un'opinione netta, forte. "Quello della corte di
giustizia europea è un atto di guerra prolungata - premette -. Ha il sapore di
uno sfregio sull'avversario", ovvero uno sfregio a Vladimir Putin, conclude un
Toni Capuozzo che come sempre farà discutere.
Estratto
dell’articolo di Massimo Fini per “il Fatto quotidiano” il 14 marzo 2023.
Sono abbastanza
convinto che con Donald Trump Presidente la guerra all’Ucraina non ci sarebbe
mai stata o sarebbe durata pochi mesi. Il Tycoon […] è di base un imprenditore.
E ragiona da imprenditore, per questo ha ritirato il contingente americano
dall’Afghanistan sembrandogli assurdo che gli Stati Uniti avessero speso 2.300
miliardi di dollari per “una guerra che non si poteva vincere” come ammetteva lo
stesso Pentagono […]
Credo che […] “the
Donald” pensi che sia assurdo che gli Stati Uniti spendano 73 miliardi di
dollari […] per una guerra ideologica che non è proporzionata ai vantaggi
economici. […] Trump ha fatto notare: “Sono stato l’unico presidente a non fare
guerre; e durante il mio mandato la Russia non ha preso alcun Paese”. A Trump
[…] le guerre ideologiche, tipo quelle alla Serbia, all’Afghanistan, alla Libia
non interessano un fico secco.
Come Trump potrebbe
convincere Putin a farla finita? Putin è […] sufficientemente intelligente per
capire che andando avanti di questo passo si troverebbe economicamente col culo
per terra. Ecco perché Trump è convinto di poterlo ridurre a più miti consigli
[…] poiché la guerra danneggia la Russia, danneggia ancor più i Paesi europei
storicamente sottomessi agli USA dando agli americani dei vantaggi economici
irrisori, mentre […] la Cina […] si avvantaggia nella guerra russo-americana
conquistando mezzo mondo […]
Credo infine che
Trump appena si sarà di nuovo insediato alla Casa Bianca […] smetterà di dare un
solo dollaro a Zelensky e a quest’ultimo, senza l’appoggio americano, non
resterà che sperare in un ingaggio, il prossimo anno, al Festival di Sanremo.
Estratto
dell’articolo di Marco Leardi per ilgiornale.it il 15 marzo 2023.
Gli americani? "Sono
70 anni che rompono il caz*o". Altro che gli ormai prevedibili dibattiti tv.
Stavolta il confronto non era programmato e Marco Travaglio si è lasciato andare
più del solito. Sui social sta girando un video che mostra la reazione stizzita
del giornalista di fronte a un giovane dalle idee molto chiare.
Messo alle strette
da quest'ultimo sulla guerra in Ucraina, il direttore del Fatto - seduto al
tavolo di un ristorante - perde il controllo e inveisce contro gli Stati Uniti
con espressioni colorite.
Il filmato,
ambientato per l'appunto in un locale, parte con le argomentazioni del giovane
interlocutore, che spiega a Travaglio l'importanza di frenare l'avanzata russa.
"Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po' a casa nostra
arrivano", dice.
E il direttore lì
per lì sembra percularlo. "Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo...",
commenta con una certa sufficienza. Ma il ragazzo non si lascia intimorire dal
popolare giornalista e lo incalza nuovamente: "No, però non si sa mai dove
vorrebbe arrivare".
Travaglio a quel
punto, ignaro di essere ripreso da uno smartphone alle sue spalle, si lascia
andare a questa considerazione: "Io penso che siano più gli americani che
vogliono colonizzarci". Un'uscita destinata a rafforzare le critiche di chi
accusa il Fatto di aver assunto posizioni anti-Usa sulla guerra in Ucraina.
A quel punto, i
ruoli si ribaltano ed è il giovane contestatore a rivolgersi al giornalista con
un sorrisetto di sfida. "No, gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo
con la Coca Cola, un po' di cioccolata, di cinema...", dice il ragazzo,
smontando la tesi dell'interlocutore. E Travaglio allora non si trattiene.
"Sono 70 anni che
rompono il caz*o", esclama. "No, non rompono il caz*o a nessuno", gli replica il
giovane. Ma il giornalista non ne vuole sapere: "A me lo rompono molto più di
tutti…
Gli implacabili.
La grottesca campagna di Conte e del Fatto per impedire a Kyjiv di proteggersi
dalle bombe.
Francesco Cundari su L’Inkiesta il 21 Marzo 2023.
Mentre il mondo
civile accusa Putin di crimini di guerra per la deportazione dei bambini ucraini
in Russia, l’Avvocato del popolo protesta contro la scelta di fornire agli
aggrediti un sistema anti-missile per difendere le loro città
Da due giorni,
mentre giornalisti, giuristi e politici di tutto il mondo civile si univano nel
denunciare il più odioso di tutti i crimini commessi in Ucraina dall’esercito
invasore agli ordini di Vladimir Putin – la deportazione di centinaia di bambini
in Russia – il Fatto quotidiano prima e Giuseppe Conte poi denunciavano ben
altro scandalo: l’addestramento in Italia di alcuni militari ucraini all’uso
del sistema di difesa anti-missile Samp-T che Italia e Francia hanno deciso di
fornire a Kiev per proteggersi dai bombardamenti.
Già la tempistica
dice molto. Domenica, mentre le prime pagine dei giornali di tutto il mondo
parlavano dell’incriminazione di Putin da parte della Corte penale
internazionale, il Fatto quotidiano apriva infatti con il titolo: «Decine di
soldati ucraini in Italia per addestrarsi». Dettaglio divertente – che devo a
un’osservazione fatta ieri da Francesco Costa durante la rassegna stampa del
Post – nell’articolo in verità si parlava di «una ventina» di soldati, dunque si
direbbe che le «decine» si riducano a due (in pratica, il minimo grammaticale
per giustificare il titolo: è da questi particolari che si giudica un
direttore).
Così, grazie alla
non imprevedibile adesione del leader Cinquestelle, anche ieri il titolo di
apertura del Fatto era dedicato allo stesso tema: «Conte e i soldati ucraini in
Italia: “Il governo ci trascina in guerra”». Questa la dichiarazione dell’ex
presidente del Consiglio al giornale: «L’addestramento militare dei soldati
ucraini in Italia conferma un’ulteriore escalation militare del conflitto e la
partecipazione sempre più attiva del nostro paese. Ci è stato raccontato che
avremmo messo in ginocchio la Russia con le sanzioni, poi che il sostegno
militare ci avrebbe spianato una risolutiva vittoria. La verità è che passo dopo
passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa
guerra senza che il nostro governo e l’Europa tentino una strategia alternativa
per percorrere una via negoziale e arrivare a una soluzione di pace». E ancora:
«Bisogna concentrare tutti gli sforzi sul piano diplomatico perché stiamo
rischiando di ritrovarci in una terza guerra mondiale».
Per quanto riguarda
le balle circa la presunta promessa di una vittoria risolutiva (da parte di chi?
dove? quando?) o l’assenza di tentativi diplomatici (non c’è leader europeo che
non abbia tentato di trattare con Putin in tutti i modi possibili, di persona,
per telefono, in videocollegamento) o ancora l’allarmismo da quattro soldi sulla
terza guerra mondiale, preferisco passare oltre senza spenderci altre parole,
per rispetto dell’intelligenza del lettore.
Aggiungo solo due
informazioni. La prima, diciamo così, di contesto. Giusto ieri, mentre in Italia
discutevamo di questo, alla conferenza di Londra fra i ministri della Giustizia
dei circa quaranta paesi impegnati a sostenere le indagini sui crimini russi, il
procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha pronunciato parole
molto chiare. «Se c’è un minimo di apparenza di verità» nell’argomentazione di
Mosca secondo cui il trasferimento di bambini dall’Ucraina in Russia dall’inizio
della guerra sarebbe stato deciso a loro tutela, ha detto, allora quei bimbi
adesso devono «essere rimpatriati, non dotati d’un passaporto straniero». E se
l’elementare logica di questa affermazione non vi ha fatto rabbrividire,
sinceramente, non vorrei conoscervi.
La seconda
informazione, per essere onesti, ve l’ho già data, ma merita di essere ribadita
(con una piccola chiosa) ed è che stiamo parlando di addestramento all’uso di un
sistema di difesa anti-missile.
Ricordate quando,
appena l’anno scorso, Conte votava a favore dell’invio di armi, chiedendo però
che si trattasse solo di «armi difensive»? La postilla era ovviamente
pretestuosa, a meno che non pensasse alla distinzione tra scudi e scimitarre,
elmi e giavellotti, ma prendiamola pure per buona: ebbene, cosa c’è di più
difensivo di un sistema anti-missile costruito appositamente per proteggersi dai
bombardamenti nemici? O forse il problema è solo l’addestramento per imparare a
usarlo, e quindi, per far contento Conte, dovremmo limitarci a consegnarlo agli
ucraini, per dir così, senza libretto di istruzioni? O dobbiamo credere
piuttosto – è l’unica alternativa rimasta – che quando Conte si diceva
favorevole alla consegna di armi difensive, intendeva ai russi?
Mi scuso se il tono
di questo articolo ha finito per scivolare nel grottesco, ma l’argomentazione
contiana è talmente assurda da suscitare ilarità, nonostante si tratti di una
delle più grandi tragedie dei nostri tempi. Parlo ovviamente dell’Ucraina, ma un
po’ anche dell’Italia.
Dal giorno zero.
I mascalzoni filoputiniani delle tv italiane hanno trovato un pubblico fin
troppo compiacente. Iuri Maria Prado su L’Inkiesta il 21 Marzo 2023.
Le notizie
sull’aggressione all’Ucraina sono arrivate fin dall’inizio e denunciavano
l’attacco di una dittatura a un Paese libero. Tutti potevano saperlo, a pochi
importava
È solo una parte di
verità, ed è la più consolante: che la guerra all’Ucraina sia stata qui
avvertita come un pericolo anche per noi, per un Paese cui quell’aggressione
ripugnava non soltanto perché chi l’ha scatenata non ha avuto pudore di
massacrare, torturare, stuprare e deportare la popolazione civile, di
distruggere scuole, ospedali e chiese, di tirare alla presa per fame, per sete e
per freddo di intere città assediate, ma perché era rivolta a schiacciare
libertà e diritti che consideriamo anche nostri.
L’altra parte di
verità è invece che né quello scempio né quel programma di soppressione delle
aspirazioni democratiche di un popolo aggredito sono stati sufficienti a
impedire che l’Italia profonda e maggioritaria si dimostrasse disposta, anzi
proclive, a considerare la libertà e i diritti degli ucraini altrettante materie
dopotutto transigibili, e dopotutto trascurabile la circostanza che potessero
essere sacrificati in omaggio al programma diretto a sostituire una schiatta di
drogati e omosessuali con una compagine di persone perbene.
È fuorviante l’idea
che questa sostanziale impassibilità, questa indifferenza del nostro ordinamento
sociale davanti all’attuazione plateale e addirittura rivendicata di quel
progetto stragista e di sostituzione civile e culturale siano l’effetto della
propaganda contraffattoria, effettivamente pervasiva, che il pacifismo
collaborazionista ha avuto modo di insinuare nel dibattito pubblico.
Bisogna avere
l’onestà di riconoscere che i manipoli di mascalzoni editoriali e
televisivi impegnati quotidianamente a censurare i crimini degli aggressori, a
giustificarli, a imputarli alle complessità geopolitiche del mondo afflitto dal
neoliberismo e dalla finanza apolide, hanno lavorato in faccia a un pubblico
molto riluttante a rintuzzare quegli spropositi e invece molto incline ad
accreditarli.
Le notizie c’erano.
Per quanto immagliate nel saio di disinformazione che uniformava la quasi
generalità del nostro giornalismo nella compiacenza di pressoché tutta la classe
politica, anche quella che affettava convincimenti atlantisti, le notizie
arrivavano: e dicevano, appunto, non solo che un Paese ne aveva aggredito un
altro, ma che l’aggressione era portata da una dittatura e per imporre una
dittatura, per subordinare la vita, la libertà e i diritti degli aggrediti alla
legge dell’autocrate.
Queste non erano
verità sepolte dalla propaganda del collaborazionismo pacifista, per quanto
questo si impegnasse a renderle clandestine: erano verità visibilissime
nonostante quella propaganda, ed erano così forti da far capolino comunque.
Perché a nessun lettore, a nessun telespettatore, a nessun elettore serviva
darsi al fact checking per scoprire che l’operazione speciale per denazificare
l’Ucraina era il nome che un regime dittatoriale dava a un ulteriore tentativo
di annessione. Un tentativo che per ottenere il risultato non escludeva il
genocidio. Si sapeva. Si vedeva. Si capiva. Ma non importava.
Travaglio odia
gli "amerikani"? Cosa dimentica...Giovanni
Sallusti su Libero Quotidiano il 17 marzo 2023
La libertà può
essere una gran rottura di ca***, e il lettore scuserà se questo pezzo sarà
scurrile oltre il livello di guardia, ma stiamo solo citando un collega molto
più introdotto di noi, un vero e proprio prezzemolino del luogocomunismo
italico, Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Putiniano, durante una
discussione con un ragazzo in un ristorante ripresa in un video diventato
virale, ci ha tenuto a condividere le profondità del suo pensiero geopolitico,
secondo cui «sono settant’anni che gli americani rompono il ca***». Di fronte
alla complessa argomentazione, il più saggio dei due, ovviamente il ragazzo,
ironizza placidamente: «Al massimo con la Coca Cola, un po’ di cioccolata, il
cinema...». E Travaglio, rispetto a cui Lavrov è un moderato con sfumature
critiche sull’operato del Cremlino, sbotta: «A me lo rompono più di tutti!».
Proprio così, più
di tutti, più dei tagliagole iraniani che da mesi massacrano giovani donne ree
di scoprirsi il capo, più dello psicotico nordcoreano che ogni tanto lancia
missili basilistici a casaccio nel calderone del Pacifico, più ovviamente dei
benemeriti gentiluomini russi della Wagner scannatori di ucraini. No, i veri
“rompic***”, oggi e nella seconda metà del Novecento, sono i dannati yankee che
«vogliono colonizzarci» (parla proprio così Travaglio, come un ciclostile
dell’estrema sinistra degli anni Settanta, o dell’estrema destra, che è lo
stesso).
GLI EROI DELLA
NORMANDIA Ecco, allora vorremmo dare qualche consiglio, al direttorissimo con le
pudenda martoriate dallo Zio Sam. Se vuole provare la soddisfazione di vedere
circa diecimila “rompic***” seppelliti nello stesso posto, può recarsi
tranquillamente al cimitero di Colleville-sur-Mer, paesino della costa normanna,
meglio noto come cimitero di Omaha Beach. Ci devastarono talmente i genitali,
questi ventenni o poco più che venivano dallo Utah, dal Montana, dal Kansas, che
il 6 giugno del 1944 sbarcarono in massa su quella spiaggia, totalmente esposti
al fuoco della mitraglia nazista, accusando un tasso di mortalità superiore al
90% durante le prime tre ondate, e l’unico motivo per cui noi, Travaglio, i
nostri figli, i figli di Travaglio, non viviamo in un protettorato del Terzo
Reich, è che continuarono a sbarcare.
Dopodiché, questi
stracciatori di palle professionisti continuarono a stracciarcele col Piano
Marshall, senza cui dalle macerie di una guerra persa per le scelte scellerate
di un tizio che sugli americani la pensava più o meno come Travaglio (nome di
battesimo Benito) non sarebbe scaturito alcun boom industriale e dunque alcun
benessere economico, né per i nostri/suoi padri né per noi/lui né per i
nostri/suoi figli eccetera... In cambio, questi demolitori di attributi ci
imposero addirittura la Nato, garantendo con i loro missili e le loro testate
nucleari la prosperità del mondo libero e la sua inattaccabilità da parte di ciò
che stava al di là del Muro, il totalitarismo sovietico (nemmeno Travaglio può
credere alla fola che la pace venne tutelata dal cosiddetto “processo di
unificazione europea”, la pace può essere solo armata e venne tutelata
dall’esposizione militare americana).
GLI AGENTI DEL
KGB - Pensate che, incredibilmente, frotte di masochisti rischiavano la vita
scavalcando il suddetto Muro dall’Eden comunista verso il mondo dei “rompic***”,
mai viceversa. Finché uno dei martellatori di membri principali, Ronald Reagan,
quel Muro lo fece persino crollare, ché se si fosse fatto gli affari suoi
milioni di cechi, slovacchi, polacchi, ungheresi sarebbero ancora
tranquillamente oppressi da Mosca. E anche oggi, di fronte all’idolo di
Travaglio, allora dirigente di un’organizzazione la quale non ha mai fracassato
le scatole a nessuno, nota come Kgb, che vuole semplicemente restaurare i
benemeriti confini dell’Impero, questi “rompic***” persistono a cavillare e a
sostenere un popolo che a quella rottura di cazzo della libertà non vuole
rinunciare. Per tacer dello sfracellamento di balle principale, il dato storico
macroscopico per cui questi irritantissimi cowboy rifiutano di farsi da parte e
lasciare il campo sgombro per le magnifiche sorti e progressive che ha in serbo
per noi Xi Jinping, il Secolo Cinese. E dire che Malco Tlavaglio ha le idee così
chiare in proposito, come esplicitò in un editoriale per sostenere le politiche
dagli occhi a mandorla del suo protetto, l’allora premier giallorosso Peppino
Conte: «L’Italia può fare a meno più degli Stati Uniti che della Cina». È di
bocca buona, lui, basta che gli togliate dai piedi quella rottura di cazzo della
libertà. Anche in questo, la pensa come quel suo precursore in camicia nera che
non settant’anni, ma ottant’anni fa aveva in mano l’Italia, prima che queste
maledette demoplutocrazie vincessero la guerra e sì, iniziassero a rompere
il...
Estratto
dell'articolo di lastampa.it il 16 marzo 2023.
Sono arrivati da
tutto il mondo per partecipare al primo congresso del Movimento dei russofili.
Centoventi «amici di Putin» di diverse estrazioni e dai mestieri più diversi,
volati a Mosca per l’incontro del movimento nella sala vetrata del Museo statale
Pushkin.
Tra loro l’attore
americano Steven Seagal, Pierre de Gaulle, nipote dello statista francese, e
persino una principessa italiana e studiosa di Tolkien, Vittoria Alliata di
Villafranca.
«Sono qui per
promuovere la pace e l'amicizia e credo che questo conflitto sia stato provocato
e causato da interessi anglosassoni. Penso che stia mettendo il mondo in grave
pericolo, e sono qui per combatterlo», ha detto al Guardian Pierre de Gaulle,
relatore al convegno.
Le posizioni del
giovane de Gaulle hanno già suscitato molte polemiche. Il mese scorso a Le
Parisien , ha detto che «l'Occidente ha purtroppo lasciato che Zelensky, i suoi
oligarchi e gruppi militari neonazisti si chiudessero in una spirale di guerra»
Yves de Gaulle,
fratello maggiore di Pierre, ha preso le distanze, precisando che le opinioni di
suo fratello «non riguardano nessuno tranne lui, Non me, non la nostra famiglia
e ancor meno il generale».
[…]
Nikolay Malinov, ex
membro del parlamento bulgaro che ora è sotto sanzioni statunitensi, ha aperto
l'evento dicendo che era giunto il momento per le «forze della luce di
sconfiggere le forze dell'oscurità».
Sul palco, vestito
di nero, è salito Steven Seagal, star delle arti marziali, nominato
rappresentante speciale per i legami culturali tra Russia e Stati Uniti. «Sono
100% russofilo e 1 milione% russo», ha detto senza esitazioni.
Al meeting dei
russofili c’era anche Sergei Lavrov, ministro degli Esteri, che ha dato un
imprimatur ufficiale all’incontro, un sigillo di ufficialità. […]
Tra i sostenitori
di Putin la principessa siciliana Vittoria Alliata di Villafranca, nobildonna
siciliana di 73 anni, studiosa del mondo arabo, nota in Italia soprattutto come
prima traduttrice in italiano di Tolkien. Afferma di aver combattuto l'Opus Dei
e la mafia per reclamare il suo palazzo di famiglia a Bagheria, dove ha detto
che i produttori cinematografici stavano girando un remake moderno del romanzo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo.
In un discorso ha
definito la «russofobia» una delle «molte versioni della colonizzazione» e l'ha
collegata allo sbarco degli Stati Uniti in Sicilia durante la seconda guerra
mondiale, che ha definito un pretesto per la diffusione dell'influenza di
Washington. «È stata la prima Isis», ha detto.
Estratto
dell'articolo di Samuele Finetti per corriere.it
il 17 marzo 2023.
Ci sono Steven
Seagal, un nipote di De Gaulle e una principessa siciliana. No, non è l’incipit
di una barzelletta: sono tre dei 90 delegati invitati al primo congresso del
«Movimento internazionale dei Russofili» organizzato al museo Pushkin di Mosca
[…]
L’imprimatur
ufficiale (e una parvenza di serietà) alla manifestazione l’ha data Sergej
Lavrov in persona, che ha aperto i lavori con la lettura di una breve discorso
firmato da Vladimir Putin: «Siamo testimoni non solo di forme di neo-nazismo, ma
direttamente di nazismo vero e proprio, che si sta diffondendo ogni giorno in
più Paesi europei».
Sceso dal palco
l’arcigno ministro degli Esteri, ecco a turno i russofili dichiarati: l’ex
parlamentare bulgaro Nikolay Malinov, secondo il quale «è ora che le forze della
luce sconfiggano le forze delle tenebre», poi Aleksandr Dugin, il filosofo
ultranazionalista che molti definiscono «l’ideologo di Putin».
Poi c’è la
principessa Vittoria Alliata di Villafranca, che ha lasciato le sontuose stanze
del palazzo di famiglia a Bagheria – «per riaverlo ho dovuto vedermela con la
mafia e l’Opus Dei», ha poi raccontato al Guardian – per volare nella città del
Cremlino in qualità di presidente dell’Associazione araba tedesca e consegnare
il suo «messaggio di pace».
[…] dal palco
della kermesse si è rivolta a una platea composta anche di un buon numero di
complottisti per denunciare la «creazione della russofobia come nuova forma di
colonizzazione» voluta dagli americani già colpevoli di aver invaso la sua amata
isola nell’estate del 1943. Ma anche per dirsi soddisfatta di poter condividere
«le proprie opinioni» con altre persone, lei che è «la signora di un villaggio
siciliano che guarda con un po’ di sgomento suo figlio che vuole sposare una
vacca (e qui non si capisce se stesse parlando di un animale da pascolo o di una
poco gradita futura nuora, ndr)».
[…] Altre
connessioni (di certo non zariste) con il mondo moscovita ha l’ex star dei film
d’azione hollywoodiani Steven Seagal, da anni divenuto un ambasciatore
semiufficiale della Russia all’estero: «Sono russofilo al 100 percento e russo
ad un milione percento». Mentre Pierre de Gaulle, nipote del grande generale,
più che la Russia gradisce i soldi dei russi. Lo ha ammesso lui stesso, che
quando non vola a Mosca fa il banchiere: alla convention cercava sì persone con
cui «condividere una visione per la pace», ma anche con cui siglare «contratti
finanziari e d’investimento».
Z Movie. Steven
Seagal e la sgangherata internazionale putiniana.
Matteo Castellucci
su L’Inkiesta il 16 Marzo 2023.
Il caso dell’ex
stella del cinema action descrive bene il profilo degli impresentabili che
fiancheggiano il Cremlino. Questo manipolo di improbabili accoliti aliena più
simpatie di quante non ne conquisti
Non sono molti ad
aver ricevuto il passaporto russo direttamente dalle mani di Vladimir Putin.
Steven Seagal è uno di questi. Se la sua filmografia ve lo fa ritenere un
personaggio trash, le sue posizioni politiche sono peggiori. Martedì ha
officiato a Mosca la nascita di uno movimento internazionale filorusso, alla
presenza del ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il congresso nasce da un
timore da minorati mentali: la cancellazione della cultura russa.
Non è un mistero che
l’attore sia su posizioni putiniane. Nel 2014 ha difeso l’annessione illegale
della Crimea e due anni dopo Putin gli ha conferito la cittadinanza, ricevendolo
al Cremlino. Avranno aiutato le origini, attraverso il nonno paterno, ma
soprattutto i suoi buoni uffici. Seagal ha festeggiato i suoi settant’anni a
Mosca, l’aprile di un anno fa, con gli amici russi, quelli della sua nuova vita
(da fallito).
Ha visitato il
Donbas occupato, lo scorso agosto, con tanto di giro al fronte e nella città di
Olenivka, dove c’è stata una strage di prigionieri di guerra. Nelle interviste
televisive, continua a blaterare sulla «minaccia esistenziale» rappresentata
dall’Ucraina per la Federazione. Che un personaggio del genere abbia condiviso
la sala con l’«ideologo» Alexander Dugin dà un’idea del tipo
di intellighenzia su cui può contare il regime.
Da trent’anni il
successo ha sfrattato Seagal. Deve il debutto all’essere stato allenatore di
arti marziali di Mike Ovitz, potente agente cinematografico. Vecchia gloria di
un cinema action che non l’ha più ricambiato, invecchiando ha inanellato
insuccessi al botteghino. Di sé ha detto: «Spero di essere ricordato un giorno
come un grande scrittore e attore piuttosto che come un sex symbol». È finito a
promuovere Nft fumettosi su Twitter.
Da dove cominciare.
La stazza e il cerone sono trumpiani, proprio come la fede politica. Nel 2015,
già imbolsito, si era offerto di addestrare le forze speciali serbe e Belgrado
lo aveva ricompensato con un passaporto, sponsorizzato – anche lì – dai
filorussi. In quel periodo, l’attore era praticamente in tour tra le Repubbliche
post-sovietiche, per esempio l’Azerbaijan. Il copione era sempre lo stesso:
accettava di buon grado l’invito, di populisti o autocrati, con la scusa
dell’Aikido. Hai voglia stendere un maestro più giovane, se l’hanno istruito
così.
I monaci buddhisti
hanno addirittura visto in lui un «tulku», un Lama reincarnato. Lui incontrava
il Dalai Lama, difendendo l’indipendenza tibetana, poi da specchiato animalista
faceva da testimonial a una fabbrica di armi russa. Ormai residente nella
Federazione, ne viene nominato «inviato speciale» in Giappone e negli Stati
Uniti. Una carriera parallela: nei film interpretava un super poliziotto contro
il crimine mondiale, oggi lavora per i suoi vecchi nemici.
A febbraio ha
ricevuto l’Ordine dell’amicizia della Russia, onorificenza meritata «per il suo
impegno umanitario». Ma quale? I «veri patrioti», come si chiamano tra di loro,
del summit di martedì chiedono piuttosto all’Europa di rimuovere le sanzioni.
Sono loro, invece, che le meritano. Tra i partecipanti, il bulgaro Nikolay
Malinov, capo di una sigla filorussa indagato in patria per spionaggio.
Quanto a Seagal,
numerosi politici tra Ue e America hanno chiesto che sconti un prezzo simbolico
per l’attività di propaganda. Se il suo soft power è appannato, beneficia
indebitamente di quanto resta della fama hollywoodiana, soprattutto all’estero,
dove le celebrità vengono imbalsamate nei cult. Ma gli agenti del Cremlino vanno
riconosciuti come tali: tanto più se visitano le sue truppe, oltre a bersi le
palle di Stato come ha fatto Roger Waters.
Il dubbio – anzi, la
speranza – è che questi improbabili accoliti alienino più simpatie a Putin di
quante non gliene portino. Invece di dimostrare che «nell’Occidente qualcuno
capisce dove sta la verità», ne sono la speculare confutazione. Solo i
picchiatelli del mondo hanno risposto alla chiamata alle armi del tiranno
sanguinario. Più dei B-movies a cui ci hanno abituato, questo è uno Z-movie: di
qualità infima, sotto la lettera che è l’insegna fascista di annientamento.
I patrioti
dell’Europa. Alla fine, dai, di che altro vuoi parlare se non di Ucraina?
Christian Rocca su L’Inkiesta il 15 Marzo 2023
È sconcertante come
parte della sinistra politica, sindacale e pubblicistica italiana non comprenda
la natura fascista del suprematismo russo. È arrivato il momento di accogliere
gli eroi antifascisti nell’Unione europea
Ogni giorno penso
all’Ucraina, cerco notizie sull’Ucraina, commissiono articoli
sull’Ucraina, pubblico un giornale in lingua ucraina, e, guarda che
combinazione, mi viene da scrivere solo di Ucraina.
È un’ossessione,
forse? È una malattia seria? O, più semplicemente, l’Ucraina è la questione più
importante del nostro tempo, del nostro presente e del nostro futuro (per non
parlare del presente e del futuro degli ucraini che si devono quotidianamente
proteggere dalle bombe dei fanatici russi)?
Solo il 1989 con la
caduta del Muro di Berlino e il 2001 con l’attacco islamista a New York hanno
per la Generazione X (i fortunati occidentali nati tra il 1965 e il 1989) una
rilevanza ideale pari agli anni che stiamo vivendo dal 2022 con l’invasione
russa, anche se è cominciata nel 2014 con l’Anschluss della Crimea e del Donbas,
e si spera anche in questo 2023 con la vittoria definitiva dell’Ucraina sui
criminali di guerra del Cremlino.
Una bella canzone di
Dario Brunori di qualche anno fa, “Canzone contro la paura”, a un certo punto
diceva «perché alla fine, dai, di che altro vuoi parlare?».
E, appunto, di che
altro vuoi parlare se non dell’Ucraina e della sua ammirevole e coraggiosa
battaglia contro le tenebre dell’autoritarismo russo che martorizza gli ucraini
e minaccia da vicino l’Europa e il modello di vita occidentale.
Non si può parlare
d’altro anche perché siamo tutti corresponsabili delle sofferenze del popolo
ucraino, non per le ragioni che i fessi ripetono nelle fogne dei talk show
italiani («guerra per procura», «colpa della Nato» e altre immonde oscenità), ma
perché non ci siamo accorti in tempo delle palesi intenzioni del Cremlino e
delle inevitabili conseguenze del suprematismo russo, malgrado fossero ben
evidenti già durante la rivoluzione arancione (2004), durante la rivoluzione
della dignità (le proteste pro Europa del 2013 a Maidan) e in seguito
all’annessione illegale nel 2014 della Crimea e del Donbas.
Uno dei pochi che se
ne era accorto in tempo e che invano ci aveva avvertiti è stato Bernard-Henri
Levy, uno dei più lucidi intellettuali della nostra epoca, i cui ripetuti e
ignorati appelli sono stati appena raccolti dalla Nave di Teseo nel libro
“Dunque, la guerra”.
La congiunzione
conclusiva, “dunque”, è usata da BHL per sottolineare che la guerra altro non è
che la conclusione logica dell’inascoltato grido del 2004 e poi del 2013-2014.
Oggi gli
ucraini sono i patrioti e i partigiani dell’Europa,, probabilmente gli unici del
continente, e combattono contro gli «abiti nuovi del fascismo» (definizione di
Paul Berman) indossati da Vladimir Putin.
Questa cosa che una
buona parte della sinistra politica, sindacale e pubblicistica italiana non
comprenda, o faccia finta di non comprendere, la natura tipicamente fascista
dell’ideologia russa alla base dell’aggressione all’Ucraina, e anzi ripeta le
bufale della propaganda del Cremlino che sostengono l’opposto, ovvero che gli
aggrediti guidati da un presidente ebreo siano loro stessi i fascisti, è un
elemento sconcertante e un’ulteriore dimostrazione che viviamo nell’epoca della
post verità e della società dove non contano i dati di fatto.
Non esiste niente di
più visibile e riconoscibile del bianco e del nero nella questione imperialista
russa. Il male è da una sola parte e il bene è sotto attacco indiscriminato.
Chi invoca la
complessità o altre ignobili scemenze come «la guerra di Biden» è soltanto un
manutengolo del Cremlino.
Non c’è alcuna
differenza tra la politica basata sulle bugie di un artista della truffa come
Trump e quelle di Putin e dei suoi volenterosi complici di sinistra e di destra
nella politica e nella televisione italiana.
Non c’è alcuna
differenza tra l’ideologia fascista storica e il revanscismo eurasiatico e
antioccidentale di ideologi come Alexander Dugin, uno che è stato allontanato da
Putin per eccessivo estremismo senza però perdere lo status di ospite d’onore
dei nazibol italiani e del telegiornale Rai diretto dall’attuale ministro
italiano della Cultura, nonché agiografo di Putin e di Trump, Gennaro
Sangiuliano.
Aggiungo una cosa
che alcuni sedicenti intelligentoni, insufflati a loro insaputa dalla
disinformazione russa, fastidiosamente ripetono ogni volta che sentono gli amici
dell’Ucraina dire “Slava Ukraini”, gloria all’Ucraina, cui gli ucraini
rispondono immancabilmente con “Heroiam slava”, Gloria agli eroi, come in
un call-and-response tipico della tradizione della musica gospel.
Slava Ukraini,
dicono i dotti e i sapienti che ci possiamo permettere in questi tempi
impazziti, è uno slogan fascista usato da Stepan Bandera un secolo fa. Bandera
era certamente antisemita ed era di simpatie fasciste, anche se le atrocità di
cui è accusato in realtà sono state condotte dai suoi seguaci mentre lui era
rinchiuso in un lager nazista, ma Bandera era anche un indipendentista ucraino
che voleva liberare il suo popolo dal giogo sterminatore di Mosca e per questo
si appoggiava alla Germania, tanto poi da essere stato ucciso dai sovietici nel
secondo dopoguerra a Monaco di Baviera. Il punto però non è quanto sia
deprecabile oggi il pensiero di Bandera negli anni 20 del secolo scorso, ma che
l’invocazione gloriosa all’Ucraina si trovi invece nei testi ottocenteschi del
principale poeta e scrittore ucraino, il Manzoni e il Dante degli ucraini, Taras
Shevchenko:
«La nostra idea, il
nostro cantare
Non può morire né
cadere…
Ecco dov’è la nostra
gloria,
La gloria ch’è
dell’Ucraina».
Soprattutto, Slava
Ukraini è diventato il segno di riconoscimento dell’indipendenza, della libertà
e dello spirito democratico di Kyjiv, coniato nelle fredde notti di Maidan, tra
la fine del 2013 e l’inizio del 2014, mentre il fantoccio del Cremlino che
guidava l’Ucraina grazie ai brogli elettorali strappava gli accordi di amicizia
con l’Europa e sparava sui connazionali che pretendevano il rispetto del
processo di integrazione europea e di affrancamento dall’imperialismo russo.
Quindi, sia
storicamente sia politicamente, Bandera non detiene né la primogenitura né il
senso indipendentista dell’espressione Slava Ukraini, che invece è molto più
recente, liberale, democratica e antifascista.
Che fare, quindi,
per sostenere ancora la lotta ucraina? Certamente bisogna continuare a
informare, ad aiutare (magari donando a Come back alive) e a tenere alto il
dibattito pubblico sui pericoli dell’autoritarismo russo e sull’importanza degli
aiuti militari a Kyjiv in vista della controffensiva di primavera volta a
rimandare l’Armata rossa a casa e in rovina.
Ma forse è arrivato
anche il momento di accelerare le procedure di adesione dell’Ucraina all’Europa,
di aprire subito i negoziati con cerimonia pubblica e solenne a Kyjiv con tutti
i capi di stato e di governo dei ventisette paesi membri. L’Ucraina se lo merita
e noi lo dobbiamo ai patrioti e ai partigiani dell’Europa.
L’Ungheria è il primo Paese
NATO a chiedere ufficialmente la pace in Ucraina.
Stefano Baudino su
L'Indipendente il 13 marzo 2023.
Il parlamento dell’Ungheria,
su iniziativa dell’Esecutivo, ha approvato una risoluzione a favore della
pace in Ucraina. “Dopo un anno di guerra tra russi e ucraini – si legge
all’interno del documento – è venuto il tempo della pace. Il nostro impegno è
rivolto a un cessate il fuoco che avvenga quanto prima”. Un’ottica che riproduce
fedelmente l’approccio del governo di Victor Orban, che è sempre rimasto fedele
alla linea del no all’invio delle armi a Kiev. Per la prima volta, insomma, uno
Stato membro della Nato ha reclamato ufficialmente la pace in Ucraina.
Il mese scorso, ad un anno
dall’inizio della guerra, nel messaggio annuale alla Nazione il premier
aveva sottolineato il ruolo chiave del suo Paese nell’attuale scenario
geopolitico: «L’Ungheria – aveva detto – è l’unico paese che è per la pace, il
resto dell’Ue alimenta la guerra. Questa non è la nostra guerra, dobbiamo
rimanerne fuori, sollecitiamo un cessate di fuoco immediato, la Russia è un
partner importante per l’energia, per cui dobbiamo dialogare, mantenere i
rapporti con Mosca». Un messaggio ribadito con parole molto nette solo pochi
giorni fa in occasione di un’intervista radiofonica: «La terza guerra mondiale
non è mai stata così vicina», ha dichiarato Orban, criticando fortemente la
«febbre da guerra» dei leader occidentali, che continuerebbero imperterriti a
inviare «armi sempre più pericolose all’Ucraina». Parole che si specchiano con
quelle del ministro degli Esteri Péter Szijjártó, che la scorsa settimana ha
dichiarato che «le vite umane non si salvano non con le armi e con le sanzioni,
ma con accordi di pace», evidenziando che «non vediamo da nessuna parte al mondo
forze che vogliano davvero mettere fine a questa guerra. Siamo sempre più vicini
alla possibilità di un nuovo conflitto mondiale».
Il testo della risoluzione si
focalizza dunque sulla promozione di una tregua e di un accordo di pace. Se, da
una parte, si condanna l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e il diritto
di Kiev all’autodifesa, dall’altra – al contrario di quanto fatto dal documento
approvato dall’assemblea dell’Onu – non si chiede però il ritiro delle truppe
russe dal suolo ucraino. Sul punto si è espressa criticamente l’opposizione, che
ha evidenziato come il ritiro dei russi sia invece una conditio sine qua non per
giungere alla pace. Mentre la maggioranza ungherese si è schierata contro le
sanzioni imposte alla Russia, giudicandole un autogol, in quanto avrebbero
prodotto l’aumento dei costi dell’energia, dai banchi dell’opposizione i
socialisti hanno invece criticato l’azione del governo, dal momento che
«l’Ungheria è l’unico stato membro dell’Ue che acquista ancora petrolio e gas
russi, mentre gli altri paesi si stanno rivolgendo con successo a fonti
energetiche diverse».
Le strategie di politica
estera dell’Ungheria, è evidente, rimangono legate a doppio filo all’influenza
di Mosca. Nel contesto di una crisi dalle radici così profonde, esplosa da un
anno in una guerra sul campo proiettata ora in maniera sempre più chiara verso
il rischio di un’escalation militare, il governo di Budapest sbandiera però come
“responsabile” la sua posizione, che sostiene essere volta a evitare il
coinvolgimento del paese nella guerra e ad aprire concreti spiragli di pace. [di
Stefano Baudino]
Epurazioni politiche. Orbán
rafforza la sua presa sull’esercito e sull’industria militare ungherese.
Francesco Del
Vecchio su L’Inkiesta il 14 Marzo 2023
Un decreto del primo ministro
consente di licenziare gli ufficiali che hanno prestato servizio per più di
venticinque anni e hanno almeno quarantacinque anni. Il cerchio magico svuota le
istituzioni per controllarle meglio, come ha fatto con la diplomazia
Ci è voluta più di una
settimana al ministro della Difesa ungherese Kristóf Szalay-Bobrovniczky per
confermare la più grande revisione nei ranghi dell’esercito degli ultimi
vent’anni, dopo i primi articoli che hanno raccontato l’ondata di licenziamenti.
Per giorni, le notizie sull’epurazione di centinaia di ufficiali di alto rango,
alcuni dei quali promossi di recente, sono circolate sulla stampa ungherese
senza alcun commento ufficiale da parte del governo.
«Denatificazione»
Szalay-Bobrovniczky ha
dichiarato poi che la mossa favorirà «la meritocrazia e la competizione»
nell’esercito, e renderà l’organizzazione generale più flessibile. Le
liquidazioni sono avvenute sulla base di un decreto firmato da Viktor Orbán, che
consente di licenziare gli ufficiali che hanno prestato servizio per più di
venticinque anni e hanno almeno quarantacinque anni, con un preavviso di due
mesi.
La deputata dell’opposizione e
membro dell’Assemblea parlamentare della Nato, Ágnes Vadai, ha definito la
decisione una «epurazione politica». Ex Segretario di Stato del ministero della
Difesa, ha affermato che questo è un tentativo del governo di
«deoccidentalizzare» le forze armate (una specie di «denatificazione», calcando
linguisticamente la «denazificazione» millantata in questi mesi da Vladimir
Putin).
Gli esponenti filogovernativi
hanno contestato queste ipotesi, sostenendo che molti degli ufficiali erano
stati promossi dall’inizio del mandato governativo di Orbán nel 2010; i
licenziamenti sarebbero stati effettuati per fare largo a personale più giovane
con maggiore esperienza internazionale. Tuttavia, se lo scopo è quello di
rivitalizzare l’esercito con persone più giovani, è difficile spiegare perché il
decreto di Orbán abbia posto il limite a quarantacinque anni, quando tutto si è
fuorché anziani.
La revisione militare e
politica si intreccia con gli aspetti economici, che vedono Orbán impegnato su
diversi fronti, sempre insieme al fido Szalay-Bobrovniczky. I piani del primo
ministro magiaro per l’industria della difesa sono stati chiariti l’anno scorso,
quando ha partecipato a una cerimonia per le reclute dell’esercito: «Stiamo
costruendo un’industria militare qui, in Ungheria, in grado di produrre armi
moderne».
Il cerchio magico delle armi
Szalay-Bobrovniczky è
considerato l’uomo giusto per attuare questa strategia, anche perché in passato
ha partecipato al settore come investitore: nel 2021 ha acquistato una ditta
produttrice di aerei della Repubblica Ceca, Aero Vodochody, con l’aiuto di un
prestito da centocinquanta milioni di euro della Banca ungherese per lo
sviluppo, di proprietà statale. Poche settimane prima della sua nomina,
l’azienda ha ricevuto una commessa governativa di dodici jet da addestramento e
ricognizione: un affare stimato in centottanta milioni di euro.
Il fatto che i cambiamenti
significativi del personale siano stati eseguiti da Szalay-Bobrovniczky, un uomo
d’affari senza competenze sostanziali nel campo della difesa, è forse più
preoccupante se si considera che, prima di assumere l’incarico, era
co-proprietario di una società con la russa Transmashholding (il cui ex
presidente è ora sottoposto a sanzioni).
Ex leader di un think tank e
di un settimanale filogovernativo, Szalay-Bobrovniczky ha mantenuto stretti
legami con il Sistema di Cooperazione Nazionale (Ner), la rete di istituzioni e
società private di Orbán che sta guidando lo sviluppo dell’industria della
difesa ungherese. Dopo aver assunto l’incarico, ha venduto le sue quote nel
produttore di aerei a un fondo di investimento controllato da Zsolt Hernádi,
amministratore delegato del gruppo petrolifero Mol.
Quella di Szalay è soltanto
una tra le tante figure coinvolte nel cerchio magico di Orbán. L’assegnazione di
appalti pubblici alla cricca del premier ungherese, anche per progetti
finanziati dall’Unione europea, sarebbe uno dei motivi per cui Budapest non è
riuscita a sbloccare circa trenta miliardi di euro di fondi europei, nonostante
i tentativi del premier di fare pressione su Bruxelles ritardando le sanzioni
contro la Russia e l’assistenza finanziaria all’Ucraina.
Le mani sull’industria
Un esempio lampante
dell’orbanizzazione economica e militare è 4iG, gruppo di telecomunicazioni
quotato in borsa che ricopre un ruolo di punta nelle strategie per la difesa di
Budapest. Per anni in perdita, nel 2018 l’azienda è stata acquisita da un amico
d’infanzia di Orbán, Lőrinc Mészáros, uno degli uomini più ricchi d’Ungheria. Da
questo punto in poi, 4iG ha siglato contratti statali che hanno innescato una
rapida espansione: le entrate nei primi tre trimestri del 2022 hanno superato di
circa dieci volte i numeri dell’intero 2017. Il prezzo delle sue azioni è salito
da 40 fiorini (0,10 euro) nel 2017 a ben settecento.
Passata nel 2020 a un ex socio
di Mészáros, Gellért Jászai, 4iG da allora ha acquistato l’operatore di
proprietà statale Antenna Hungária, ha utilizzato prestiti statali per comprare
le attività ungheresi di Vodafone e ha acquisito una serie di società di
telecomunicazioni dei Balcani. L’azienda ha dichiarato che la
sua partnership con il governo ungherese è limitata al settore delle
telecomunicazioni, sebbene nel maggio scorso abbia firmato un accordo
preliminare per la creazione di una joint venture con la tedesca Rheinmetall,
finalizzato alla digitalizzazione delle forze armate ungheresi.
Qualunque siano le vere
ragioni di questo sviluppo, le circostanze e il modo in cui è stato gestito dal
governo evidenziano problemi più grandi e più radicati: di natura politica, non
militare. Data la politica estera sovversiva di Orbán, è facile capire perché ci
siano dei sospetti, e si teme anche che questi cambiamenti così repentini
possano erodere ulteriormente la fiducia tra l’Ungheria e i suoi alleati.
Svuotare le istituzioni (per
controllarle)
Orbán si è spesso espresso in
maniera controversa sulle sanzioni occidentali e gli aiuti militari all’Ucraina,
ha posto il veto a iniziative per avvicinare Kyjiv alla Nato e ha adottato un
approccio indulgente nei confronti dei diplomatici russi.
Anche se i licenziamenti in sé
non equivalgono a un’epurazione a sfondo politico, è difficile sostenere le
ragioni del governo. Il Paese è attualmente lo Stato membro più corrotto
dell’Unione europea secondo Transparency International, ed è possibile pensare
che il decreto possa essere utilizzato per esercitare pressioni politiche sui
giovani ufficiali che si avvicinano ai quarantacinque anni di età.
È improbabile che questi
licenziamenti possano risollevare Budapest a livello militare. Proprio come nel
caso del corpo diplomatico ungherese, che ha subito licenziamenti di massa e
l’afflusso di una nuova schiera di funzionari con un approccio «orientato al
business», c’è il rischio chiaro che le istituzioni chiave dello Stato, che
garantiscono la sicurezza e l’etica dello Stato, si svuotino e vadano in crisi.
Incalzato dalla
Fagnani, dice: "Canterò sempre per il popolo russo".
Al Bano condanna la
guerra ma difende Putin: “Ucraina sempre stata russa poi la Nato se n’è
appropriata”. Redazione su Il Riformista l’8 Marzo 2023
“Vladimir Putin in
qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha. L’Ucraina è sempre stata sotto
la giurisdizione russa, la Nato se n’è appropriata… Certo poi Putin ha anche
torto”. Lo ha dichiarato Al Bano, all’anagrafe Albano Antonio Carrisi,
raccontandosi ai microfoni di Francesca Fagnani, durante la puntata di ieri sera
di “Belve”. Si è parlato di musica, di famiglia, e di guerra… Quella che da più
di un anno sta devastando l’Ucraina, mietendo dall’inizio del conflitto più di
centomila vittime. “Questa guerra è terribile, squallida – ha detto ancora Al
Bano – Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere
come ha fatto quel paese a me ha dato fastidio, e non solo a me”. Poi ha
chiosato: “Io dico quello che in tanti pensano, ma che non hanno il coraggio di
dire”.
La Fagnani chiede
quindi se anche oggi sarebbe disposto a suonare le sue canzoni per Putin, e Al
Bano risponde: “Io suono e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo
e io ho cantato anche per lui”. Dalla guerra all’amore, all’amore perduto, a
quella figlia svanita nel nulla. Sulla scomparsa della sua Ylenia, Al Bano ha
racconta commosso: “È stato l’unico momento dove sono diventato un anticristo,
un anti – Dio. Mi sono sentito violentato da quella forza superiore che è Dio.
Erano notti in cui per dormire prendevo il Lexotan. Erano quelle notti che non
finivano mai neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche
adesso. Ma io sono cristiano e mi sono detto: se lui l’ha perso e tutto
continua, chi sei tu per ribellarti a questa realtà?'”.
L’allarme di
Berlusconi: “Se si umilia Putin, mondo a rischio nucleare”.
Paolo Guzzanti su Il
Riformista l’8 Marzo 2023
“Sono stato io a
convincere Putin a ritrarsi dalla Georgia nel 2008”. E aggiunse che nell’attuale
mostruosa guerra in Ucraina col mondo che rischia l’apocalisse nucleare, si
sarebbe aspettato di esser messo nelle condizioni di fare quel che poteva. Ero
fra i commentatori di quella edizione e rimasi di stucco: come sarebbe a dire?
Io nel 2008 lasciai Forza Italia frustrato dal sodalizio fra il premier italiano
e quello russo mentre presiedevo la Commissione Mitrokhin e il mio informatore
segreto Alexander Litvinenko era stato avvelenato e ucciso per ordine
di Putin, e adesso sentivo Berlusconi fare una rivelazione sorprendente, per me,
enorme.
Putin in quel mese
d’agosto aveva lanciato un attacco militare contro a Georgia, il primo da Stato
a Stato in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, nell’indifferenza generale
sia in Italia e nel mondo. Ma è vero: Putin si era poi ritirato si era ritirato,
lasciando qualche presidio di frontiera. Io ero rimasto profondamente deluso
perché l’Italia, salvo una precipitosa riunione delle Commissioni Esteri di
Camera e Senato, aveva lasciato correre, come tutti i Paesi del mondo
occidentale. E adesso? Adesso mi trovavo di fronte al presidente del consiglio
di allora, dichiarare che nel 2008 quando Putin mosse le sue truppe
in Georgia, lui che aveva col presidente russo un noto e profondo rapporto
personale, dice di averlo fermato.
È un fatto
che Putin allora si fermò, anche se tutto rimase incandescente. Ma ignoravo,
credo come tutti, che Berlusconi fosse entrato in gioco riuscendo a bloccare una
guerra. Come? Eravamo ancora in diretta e io dissi: “Un momento, Presidente
Berlusconi, abbiamo diritto di sapere come è andata e le chiedo una
intervista”. Quella intervista non è mai avvenuta e penso che l’ex Presidente
del Consiglio e fondatore del centro destra si sia chiuso nel suo piccolo
castello di Arcore. Ho passato un paio di settimane a ristudiare i fatti di
allora per metterli in relazione con la guerra di oggi e capire se e che
cosa Berlusconi potrebbe fare davvero per fermare una guerra (quella ucraina con
le due implicazioni cinesi a Taiwan) che proprio nella fase in cui si trova
adesso, con massacro di Bakhmut in cui Putin e Zelensky sembrano giocarsi il
tutto per tutto, potrebbe diventare nucleare.
La tesi
di Berlusconi è che sono degli incoscienti tutti coloro che spendono fortune per
mandare cari armati e cannoni all’Ucraina pensando di sconfiggere la Russia sul
campo con le armi convenzionali, perché questa gente dissennata e incompetente
non ha idea del temperamento di Putin. Berlusconi ha ripetuto in privato che “se
gli lasciano come unica alternativa l’umiliazione e la sconfitta, Vladimir è il
tipo che dirà: muoia Sansone con tutti i filistei e passerà all’arsenale
atomico”. Molto preoccupato fino a rasentare la depressione, Berlusconi finge di
scherzarci sopra: “Sarà meglio fuggire per la terra del fuoco, o costruirai un
bunker con tutti i comfort nel guardino di casa?”. Qui non siamo
nell’aneddotica: è realistico quello che pensa Berlusconi che conosce e
frequenta Putin da un quarto di secolo? E che mantenga ancora quel tipo di
relazione che può modificare sul corso degli eventi?
Il fondatore
di Forza Italia è evidentemente frustrato e anche sbalordito perché l’attuale
governo non lo ha messo nelle condizioni di agire sulla guerra e possibilmente
fermarla. È rimasto malissimo quando con un colpaccio di maggioranza concordato
col Terzo polo hanno affidato ad Ignazio La Russa presidente del Senato
perché Berlusconi considerava la statura “istituzionale” della seconda carica
dello Stato come quella più adatta per giocare tutte le sue carte europee e
internazionali. E quando si è visto messo da parte anche in maniera scortese e
anzi provocatoria si è chiuso in un mutismo addolorato e sdegnoso. Ma la
questione resta aperta, perché non soltanto questa guerra ma le sue premesse che
risalgono agli anni Novanta, agli accordi sulla Nato, al trattato di
Budapest, agli accordi di Minsk.
Ho cercato di
ricostruire qualche aspetto di quel che accadde nel 2008 quando avvenne la
cosiddetta seconda guerra georgiana essendoci già stato un primo scontro
tra Russia e Georgia nel 1991. Il secondo scontro avvenne nel 2008. Io avevo
preceduto una commissione d’inchiesta sulle indebite influenze russe durante la
guerra fredda in Italia ed ero rimasto scioccato dall’omicidio di Alexander
Litvinenko che era un mio segreto è prezioso collaboratore dal quale la polizia
italiana raccolse informazioni preziose su un ordigno che consentì di
intercettare prima che fosse usato per un attentato. Da allora sono passati
molti anni e dal febbraio del 2022 la guerra Ucraina è diventata un pantano di
sangue per sacrifici umani pari a mille corpi al giorno. Il dilemma della
ragione e del torno resta, e non è un dilemma. Ma come andrà a finire, è più che
un dilemma, una apocalittica maledizione.
Se moriremo o no di
morte atomica è un quesito inutile perché somiglia più all’esempio logico della
meccanica quantistica dell’ipotetico gatto di Schroeder, chiuso in una scatola
in cui o è già morto oppure è vivo, ma di cui non si può dire che forse è vivo o
forse è morto.
Secondo Berlusconi, il presidente russo in alcun caso si lascerà sconfiggere e
ha già alluso in maniera obliqua all’uso, se indispensabile per l’esistenza
della Russia, delle armi nucleari. In queste ore tutti i grandi della terra che
hanno conosciuto bene sia il primo Putin attratto dall’occidente, quasi convinto
ad entrare nella Nato e nell’Unione europea, e il secondo Putin che poi ha avuto
una mutazione a partire dalla guerra in Iraq. Vale la pena parlarne oggi? Il
motivo è molto pratico e drammatico. La Storia non è determinata soltanto
dall’economia ma da molte altre cose fra cui la stupidità, la sete di egemonia e
persino dal fattore umano. Oggi trionfa sulle piattaforme il genere di romanzi
in cui ci si chiede come sarebbe andata se il piccolo Adolf Hitler fosse stato
strozzato in culla.
La Storia reale è
più perfida: come sarebbe andata la Storia se il ventottesimo Presidente degli
Stati Uniti, Woodrow Wilson, che capovolse le sorti della Prima guerra
mondiale e che si piazzò a Parigi per due anni per rifare il mondo, non avesse
contratto una forma cerebrale di “influenza spagnola” per cui diventò paranoico,
pretendendo lo smembramento del popolo tedesco e aprendo così la strada
a Hitler? Oggi, tutti si occupano di Putin per rispondere a domande senza
risposta, mentre la guerra ristagna oggi a Bakhmut dove
sia Putin che Zelensky, con le vite degli altri si stanno giocando la propria.
Da ieri Evgenij Prigozhin, padrone dei mercenari del battaglione Wagner manda in
giro un video in cui accusa l’esercito russo di non fornirgli le munizioni per
cui annuncia che perderà Bakhmut e il ministro della difesa russo è piombato
a Mariupol per contestare il suo migliore alleato e peggior nemico.
Mosca è divisa.
L’Occidente anche. Zelensky è incerto fra salvare o far perire le sue truppe o
durare un minuto più dei russi per innescare una crisi al Cremlino. Le
diplomazie sono di fatto impotenti e la Cina, da grande minaccia per il mondo
occidentale, si comporta da arbitro. Berlusconi dice di essere rimasto
stupefatto per la spudorata franchezza con cui il presidente cinese si vanta di
avere il controllo quasi totale dell’Africa e di aspirare al controllo
dell’intero mondo. Lo aveva lasciato esterrefatto la totale miopia
dell’occidente che rischia di suicidarsi prendendo parte alle contese nell’ex
Unione Sovietica senza saper valutare l’attacco globale cinese.
Paolo Guzzanti.
Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della
Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza
Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Secondo il
ministro russo, l'ex premier "non intensifica le tensioni".
Lavrov esalta
Berlusconi: “Leader ragionevole, non dipinge tutto in bianco o nero”.
Redazione su Il Riformista il 2 Marzo 2023
“Berlusconi leader
ragionevole che non intensifica le tensioni”. Parole di Sergei Lavrov, ministro
degli Esteri russo che esalta le recenti dichiarazioni dell’ex premier italiano
sul conflitto in Ucraina dove rimproverava la premier Giorgia Meloni alla
vigilia dell’incontro a Kiev con il presidente Volodymhyr Zelensky avvenuto a
metà febbraio. “Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del
Consiglio non ci sarei mai andato – dichiarò Berlusconi – perché stiamo
assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei
suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del
Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto
negativamente il comportamento di questo signore”.
Venti giorni dopo
Lavrov, che in questi giorni si trova in India per partecipare al G20 e alloggia
nello stesso albergo della premier Giorgia Meloni, ha voluto ringraziare
pubblicamente il leader di Forza Italia: “Sentiamo le valutazioni e le
dichiarazioni di tanti leader internazionali e politici con esperienza.
Ovviamente, Silvio Berlusconi è uno di loro. È un uomo ragionevole che non cerca
di dipingere tutto in bianco e nero, non cerca di intensificare tensioni nel
mondo sotto lo slogan della lotta della democrazia contro l’autocrazia”. Poi
aggiunge: “Berlusconi comprende la necessità di risolvere i problemi da cui
dipende la nostra vita”.
La settimana
Zelensky, durante la visita di Giorgia Meloni a Kiev, aveva commentato le parole
del Cavaliere notando come le sue posizioni sul conflitto fossero dovute al
fatto che “la sua casa non è mai stata bombardata”. Di recente Lavrov ha
sottolineato come l’Italia, da Paese con le “relazioni tra le più amichevoli”
con Mosca, si è trasformata rapidamente in uno “dei leader delle azioni e della
retorica antirusse”.
Schlein, Vendola
in pressing su Elly Schlein: "Pace e disarmo".
Libero Quotidiano
l’08 marzo 2023
Con la vittoria
di Elly Schlein alle primarie dem, diversi ex esponenti di sinistra si sono
rifatti vivi. Tra questi Nichi Vendola che, in un'intervista al Giorno, ha
detto: "Questo cambio imprevisto al vertice del Pd è una cosa buona su cui
investire. Lo dico da militante di un altro partito, cioè Sinistra italiana.
Spero che con la nuova leadership democratica il “processo costituente” della
sinistra del futuro possa cominciare davvero".
Secondo lui, però,
è fondamentale che la nuova segretaria metta due cose in cima alla sua agenda:
"Considero cruciale rimettere al centro di questo impegno due parole
marginalizzate e neglette: pace e disarmo. Senza queste due parole è difficile
persino nominarlo, il futuro. La sinistra ha il dovere di contrapporre alla
visione distopica della bomba atomica la profezia della pace".
In ogni caso Vendola
sembra avere fiducia nella Schlein: "Lei è innanzitutto l’espressione di una
nuova generazione, di un nuovo linguaggio, di un nuovo paradigma della sinistra.
Il suo pathos, la sua fisicità, la sua narrazione, tutto questo appare come una
rottura profonda con l’immagine desolante di un Pd specchio
dell’establishment: un partito malato di moderatismo e governista fino allo
spasimo". Il suo compito, comunque, non sarà facile: "Elly rappresenta una sfida
seria e difficilissima, direi quasi acrobatica e contronatura, rispetto
all’attuale organizzazione del corpo democratico. Non si tratta solo di
liberarsi dagli artigli dei cacicchi locali e dei signori delle tessere, e di
purificarsi dalle degenerazioni trasformistiche o familistiche che macchiano la
vita del Pd: si tratta soprattutto di ricostruire una visione e una prassi
politica fondate sulla critica radicale del mondo che abitiamo, della sua forma
economico-sociale, del moderno cannibalismo che produce".
Dagospia l’8 marzo
2023. Da “Un Giorno da Pecora - Rai Radio1”
Bossi mi disse che
ero uno stronzo e che avevo portato nella Lega i fascisti? “E io gli ho risposi
che tutti siamo un po' stronzi, e tra le due cose mi sento semmai più stronzo…”
A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato Fi ed ex
sindaco di Verona Flavio Tosi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.
Anche perché una
cosa è un reato e l’altra no. “Non è più un reato definirsi fascisti, e
l’apologia ad esserlo, essere fascisti non lo è secondo me”. Quindi oggi si
sente più l’uno o più l’altro? “Mi sento un po’ stronzo ed un po’ fascista, un
pochino però”.
“La guerra è colpa
di Zelensky, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su
questo non ci piove”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è
il deputato Fi ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi, intervistato da Geppi
Cucciari e Giorgio Lauro. Onorevole - hanno fatto presente i conduttori - ma è
Putin che ha invaso il paese. “Su questo non c’è dubbio. Però se ci fosse stato
Poroshenko o un presidente politico forse non si sarebbe arrivati a questo
punto”.
Putin è stato
provocato secondo lei? “No. Ma ci sono le diplomazie, i servizi e tutta una
serie di strutture per evitare di arrivare a quella conseguenza. Nel momento in
cui il tuo leader è un comico forse certi schemi saltano, Zelensky non è capace
di governare perché faceva il comico - ha affermato a Un Giorno da Pecora Tosi -
non è in grado di gestire la situazione per mancanza di competenza”.
La pensa in modo
simile a Berlusconi sull’Ucraina. “Condivido in pieno quanto ha detto
Berlusconi. Zelensky prima di fare il presidente, il giorno prima, faceva il
comico. E forse poteva lavorare come comico nelle reti Mediaset invece che fare
il premier. E’ un dato di fatto che se ci fosse stato un presidente diverso - ha
detto Tosi a Rai Radio1 - probabilmente non ci sarebbe stata la guerra”.
Ma Zelensky è stato
eletto democraticamente. “E che vuol dire? In Italia sono stati votati pure i
grillini e poi se ne sono amaramente pentiti”. Lei che soluzioni vede al
conflitto ucraino? “La guerra finisce se Zelensky accetta di sedersi con Putin o
viceversa. Bisogna sedersi ad un tavolo per arrivare alla pace, come ha detto
Berlusconi, questa non è la nostra guerra, è il conflitto degli americani e dei
cinesi”.
Le mie pistole? “Non
ce l’ho dietro ovviamente, portarle in viaggio non è il massimo, le tengo solo a
casa. Ne ho quattro, tre da difesa e una da poligono, a gas. Sul comodino, dove
c’è l’abat jour, ne tengo una sola, la Pardini, senza il colpo in canna. Devi
scarrellare e poi puoi sparare”. Lo racconta, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno
da Pecora, il deputato Fi ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi, oggi ospite della
trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.
“Durante il giorno
la pistola la metto nel cassetto, a casa siamo solo io e mia moglie, non ci sono
bambini. Finora non ho mai sparato a nessuno ma se ci fosse qualcuno che entra
in camera di notte, che non sia moglie, io sparerei”. Le è mai successo di
alzarsi con la pistola per aver sentito dei rumori in casa? “Si, mi è capitato
qualche volta di alzarmi di notte - ha spiegato a Un Giorno da Pecora Tosi - con
la pistola in mano e le luci accese, per vedere se c’era qualcuno”.
“Ripudia la
guerra”: al via il referendum popolare contro le armi all’Ucraina.
Salvatore
Toscano su L'Indipendente l’8 Marzo 2023
Un gruppo di
cittadini si è costituito nel comitato promotore del referendum “Ripudia la
guerra”, avviando la raccolta delle 500mila firme necessarie alla presentazione
della proposta. Secondo i promotori, che fanno appello all’articolo 11 della
Costituzione, le autorità italiane dovrebbero impegnarsi nei conflitti
internazionali non mediante l’invio di armi bensì con un lavoro diplomatico
volto a ottenere il cessate il fuoco e delle trattative di pace. Così sono stati
elaborati tre quesiti riguardo l’abrogazione delle disposizioni sull’invio
di armi all’Ucraina contenute nell’art. 2 bis della Legge 28/2022 e nell’art.1
della legge n. 8/2023; nonché delle disposizioni contenute all’art. 1, comma 6,
lettera a) della legge 185/1990 che ammettono eccezioni al divieto di invio di
armi ai Paesi in stato di conflitto armato.
«Riteniamo che
nessun governo o anche parlamento possano ritenersi investiti della
responsabilità di condurre il Paese in un conflitto che rischia di degenerare in
modo irreversibile, senza interpellare la popolazione», ha dichiarato il
comitato promotore del referendum “Ripudia la guerra”. Il riferimento è
all’attuale guerra in Ucraina, salvo poi estendere la richiesta a una previsione
generale. A tal proposito, i quesiti referendari intendono abrogare tre articoli
di legge, o parte di essi. Il primo riguarda l’art. 1, comma 6, lettera a)
della legge n. 185 del 9 luglio 1990, che vieta “l’esportazione, il transito, il
trasferimento di armi verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto
con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il
rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni
del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”. Il quesito
intende eliminare l’ultima deroga, dunque “o le diverse deliberazioni del
Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”.
Il secondo quesito
intende, invece, abrogare l’articolo 2 bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, nella parte afferente alla cessione delle armi a Kiev. Il terzo
riguarda, infine, l’abrogazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 185 del 2
dicembre 2022, riguardante la proroga della cessione delle armi all’Ucraina fino
al 31 dicembre 2023. [di Salvatore Toscano]
Il rapporto
degli italiano con la Guerra.
La guerra tra
Putin e le “truffe liberaldemocratiche” dell’Occidente e il ruolo da “pianeta a
parte” dell’Italia. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 5 Marzo 2023
Ho passato una
notte allucinata seguendo quel che dicono e fanno i grandi paesi
dell’Occidente discutendo della guerra. Potete farlo facilmente: si va su
YouTube, si cercano le conferenze e i dibattiti e si passano le ore. Di che
discutono? Faccio una sintesi senza nomi anche se ce ne sono di eccellenti
come Tony Blair, i segretari di Stato americani, ambasciatori, giornalisti premi
Pulitzer che svolgono un’analisi divertentissima se così si può dire.
L’intervistatore
chiede: “Secondo lei Putin è sempre stato così?”. La risposta: “No, fino al 2004
era un tipo duro ma normale a tavola si parlava in maniera diplomatica e
scherzosa. Sembrava uno dei nostri. Lo abbiamo invitato nella Nato e girava voce
che la Russia sarebbe entrata nell’Unione europea “E allora? Quando è
cambiato?”, è la naturale e successiva domanda. Un ambasciatore americano dice
che Putin si infuriò per la guerra in Iraq e che fu lì che cambiò strada. Quasi
tutti convengono che fu l’Iraq a mandarlo in bestia. Sì, ma da qui all’invasione
dell’Ucraina il passo è lungo. E così, sul divertente palcoscenico di YouTube
decine di testimoni, protagonisti e testimoni rimettono insieme i pezzi
dell’accaduto degli ultimi vent’anni e ne viene fuori una storia che sembra
avere un senso perché ci fu un giorno in cui il rigidissimo ma anche atletico e
sorridente Vladimir Putin disse: “Voi occidentali e le vostre maledette truffe
liberaldemocratiche mi avete rotto le scatole. Da adesso rivoglio l’impero, sì
proprio l’impero perché – l’ho detto e stradetto, non fate finta di non avermi
capito – tutto ciò che fu russo nei secoli, russo deve tornare”.
Noi italiani
siamo diversi, tant’è vero che anche il fascismo che voleva giocare agli imperi
si mise sotto la luce del ridicolo e del brigantesco, Feroce ma mai serio. E se
dobbiamo sbrogliare la matassa del nostro dna e scoprire come ci proponiamo
davanti alla guerra, alle guerre, alla fermezza di fronte ai principi, si vede
subito che siamo non solo un pianeta a parte, probabilmente un bellissimo
pianeta ma i nostri abitanti somigliano ai personaggi più arcitaliani della
nostra memoria: chi meglio di Gianburrasca può impersonare il lestofante
burocrate che frega i soldi dalle tasche del fidanzato della sorella, o la
guerra fredda raccontata da Giovannino Guareschi, che si fece qualche anno di
galera per aver dato del traditore a De Gasperi, i cui deuteragonisti nella saga
perfetta, don Camillo e Peppone, sono arcitaliani e, se occorre, anche con lo
schioppo.
E capaci di
inaudite e bastarde ferocie quasi sempre bastarde e vendicative, prive di
decoro, salvo rari casi. L’atteggiamento di noi italiani nei confronti di una
guerra, di questa guerra che sta dilagando per maree in tutto il mondo, somiglia
e veste benissimo eroi del nostro Ottocento e Novecento, come il bambino di
legno Pinocchio, ossessionato da una stalker punk con i capelli turchini,
violentato in un campo di spacciatori detto “dei miracoli”, derubato degli
zecchini d’oro del trafficante di esseri umani Mangiafuoco, impiccato a testa in
giù come a piazzale Loreto e che poi, quando si rivolge al suo giudice si sente
dire: “Povero ragazzo, sei chiaramente innocente, dunque ti condanno alla
prigione”.
Forse fa
eccezione quella disgraziata piccola vedetta lombarda che ogni mattino all’alba
sale sul pero, grida “Gli austriaci! e cade con un fiore rosso che si allarga
sulla sua fronte”. Sulla Grande Guerra sì, gli italiani trovarono la vera guerra
ma fatta dalle nuove macchine mitragliatrici che da sole facevano il lavoro di
una divisione e poi c’erano quegli altri soldati altrettanto italiani che
stavano dall’altra parte in uniforme austriaca e che gridavano “Che tirè? No
vedé che ghe z’è omini?” Da cui il canzoniere dell’orrore, “oh Gorizia tu sia
maledetta”, “maledetti signori ufficiali, fuoco e mitragliatrici”, “cara madre
ti scrivo morendo e quanto al capitano della compagnia i suoi alpini manda a
chiamar per farsi dividere in pezzi dopo morto e spedire il cuore alla sua
bella, ai suoi alpini gli manda a dire che non han scarpe per camminar, ma o con
le scarpe o senza scarpe i miei alpini li voglio qua”.
Come colonialisti che si fanno un impero, sognano di farsi tutte le faccette
nere trasformate in cheerleader da portarsi in parata e da trombare con comodo
nella finzione di un matrimonio coloniale. Poi si entra nel buio profondo delle
altre stragi di puro terrorismo sui civili.
Cavour mandò un
minuscolo contingente sabaudo a combattere contro i russi in Crimea, ma fu
qualcosa di simbolico: come dire “ci siamo ma non ci siamo”, o come la tenda
sanitaria con cui l’Italia contribuì alla guerra delle Nazioni Unite contro
la Corea del Nord ma condotta quasi esclusivamente dai soldati americani del
generale Donald McArthur dalla pipa di schiuma e il bocchino di paglia di mais.
Per associazione
inspiegabile: Alcide De Gasperi che a Vienna fu informato del fatto che l’Italia
aveva dichiarato guerra all’Austria, schierandosi con l’Intesa e il povero
Alcide che nelle osterie di Trento aveva litigato a sangue sia con il
socialista Cesare Battisti (che poi verrà impiccato in piazza come disertore
asburgico), che col giovane attaccabrighe allucinato e affamato Benito
Mussolini sempre col suo revolver in vista sulla tovaglia sul tavolo, ebbe un
malore piangendo di vergogna davanti al primo ministro viennese incapace di
consolarlo per dover tradire il suo impero, soltanto perché la sua madrelingua è
di un Paese straniero di cui diventerà Primo ministro. Gli italiani, noi
italiani, non abbiamo mai avuto modo di digerire, processare la guerra come
frutto di cause. Per una sorta di salvaguardia naturale non ce ne importa
storicamente nulla e nessun detto di bassa fureria fu più vero dell’abusato “o
Franza o Spagna purché se magna”.
E invece, in
queste ore – “as we speak, write and read”- una parte del mondo discendente
dagli imperi (britannico, russo, cinese, ottomano) stanno discutendo con le
diverse ma dialoganti mentalità imperiali sulla sorprese che la mancata fine
degli imperi riesce ancora oggi a generare. Il loro argomento di discussione è:
dove abbiamo sbagliato, chi ha sbagliato per primo, se si può riparare, e a
quale condizione. E si sentono tutte le voci di sinistra e di destra ma che
appartengono a uno spirito della tribus da cui siamo, o ci siamo voluti,
tagliare fuori.
Quale il senso,
ammesso che ne abbia uno, di quel che mi è capitato di osservare nella
differenza fra gli altri e noi? La ricerca dell’auto accusa, la questione
americana e quella europea, l’imperialismo di Putin che nulla ha a che fare con
il Donbass perché lui rivuole la Santa Madre Russia: lo stesso spirito che
distrusse l’equilibrio del suddito dell’Imperial regio governo Alcide De
Gasperi, deputato a Vienna, quando apprese che la sua patria linguistica era in
guerra con la sua patria imperiale.
Paolo Guzzanti.
Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della
Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza
Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.
L’Ucraina
proibita. La manifestazione antifascista di Firenze senza la vera grande
battaglia contro il fascismo russo.
Carmelo Palma su
L’Inkiesta il 6 Marzo 2023.
Sabato hanno
marciato tutte le diverse componenti del mondo progressista di osservanza
demo-populista, ma non c’erano bandiere della resistenza di Kyjiv, il vero
simbolo dell’antifascismo europeo
Ci si può certamente
appassionare – chi siamo noi per giudicare – a quella pagina esemplare di
monopolarismo bipopulista rappresentata dalla mobilitazione indignata contro il
pericolo “fascista” e “comunista”, parteggiando per la sussiegosa retorica del
compagno rettore Montanari, che parla melonianamente da padre di uno studente
del Liceo Michelangiolo, nella parata della #FirenzeAntifascista, o per le
geometrie variabili, con cui il ministro Valditara nobilita o liquida
l’epistolario anti-violenza dei dirigenti scolastici alle prese con una patetica
riedizione del “settantasettismo” destrorso e sinistrorso: bravo il preside
milanese a bacchettare chi lo ha raffigurato a testa in giù, cattiva la preside
fiorentina insorta contro il pestaggio dei post-camerati vicini o interni al
partito della madre, italiana e cristiana presidente del Consiglio.
Una riflessione più
fredda e meno appassionata, ma più veritiera, dovrebbe portare a concludere che
la ragione di tutto questo calore, di tutta questa indignata militanza
contrapposta continua – esattamente come ai tempi (non) eroici della violenza
politica rossa e nera – a poggiare su una denegata contiguità e parentela tra
questa destra e questa sinistra nel modo di intendere il rapporto tra i mezzi e
i fini e di giustificare i primi alla luce dei secondi. Per gli uni e per gli
altri, il problema della violenza cambia con il colore della violenza.
Solo questo spiega
perché il partito di maggioranza relativa non abbia pensato di dire una parola
sulle violenze che hanno visto protagonisti non dei provocatori, ma dei –
chiamiamoli così – camerati che sbagliano, e perché d’altra parte nella
manifestazione dell’antifascismo ufficiale, con tutti i leader della sinistra
politica e sindacale bella e buona in prima fila, gli slogan tipo «Tito ci ha
insegnato che uccidere un fascista non è reato» continuano a essere ascoltati
con divertimento o con fastidio, ma non con sdegno, non con un senso di
estraneità tale da allontanare questi antifascisti retrò, anche se giovanissimi,
da un corteo teoricamente super-democratico.
Ma veniamo al punto
centrale, in una prospettiva attualmente antifascista. A Firenze hanno marciato
tutte le diverse componenti della composita koinè progressista di osservanza
demo-populista. C’era il Partito democratico, c’era il Movimento 5 stelle, c’era
la Cgil, c’era l’Arci, c’era l’Anpi, c’erano – qualunque cosa significhi – i
movimenti, c’era il ceto medio riflessivo, c’erano gli antagonisti pavloviani
nei loro riflessi anti-imperialisti, c’erano tutti i colori dello spettro
antifascista nazionale e c’erano ovviamente i pacifisti. C’erano le immancabili
bandiere palestinesi e di tutti gli infiniti rivoli della diaspora comunista.
Non c’era però una
bandiera dell’Ucraina, che è oggi la vera frontiera della resistenza
antifascista europea. Il compenso c’erano svariati censori dei “fascisti
ucraini”, che per gli antifascisti di rito anpista-pagliaruliano sono quelli che
si difendono dall’aggressione putinana, ma hanno il torto inemendabile di farlo
con i soldi e le armi degli alleati atlantici, quindi, secondo la vulgata, del
fascismo vincente nell’eterno dopoguerra europeo e planetario.
Non c’era una
bandiera ucraina, non c’era uno striscione pro Ucraina e non c’è stata una
parola e un briciolo di solidarietà e di commozione per l’esempio di una vera
Resistenza di popolo e democratica (in questo certamente diversa da quella
italiana, popolata da furbissimi partigiani del 26 aprile e di stolidi banditori
di distopie totalitarie).
Cosa questo
significhi è troppo chiaro ed eloquente: che l’antifascismo reale è oggi
letteralmente proibito nelle piazze della bella gente antifascista della
sinistra italiana e che la sua presenza sarebbe suonata sabato addirittura
provocatoria, di fronte al generoso sforzo di unità di Elly e Giuseppe che,
pronubo Maurizio Landini, si parlavano nell’orecchio, si abbracciavano e si
sorridevano.
Le dovute
differenze. Il putinismo della destra e il collaborazionismo della sinistra che
fa propaganda per l’aggressore.
Iuri Maria Prado su
L’Inkiesta il 6 Marzo 2023.
Le simpatie e gli
interessi dei Berlusconi e dei Salvini per l’autocrate russo sono indecenti, ma
chi è diventato il megafono della propaganda del Cremlino ha dichiarato guerra a
noi stessi
C’è una differenza
enorme tra il putinismo che via via è andato sbrigliandosi a destra – nel
cedimento delle inibizioni che l’evidenza delle colpe e lo scandalo iniziale
degli eccidi frapponevano alla voglia matta della soluzione finale – e un
governo di persone perbene messo al posto di quello dei drogati e degli
omosessuali di Kyjiv.
Una differenza
enorme, dicevo, c’è tra quel riformularsi in progress e sempre meno verecondo
delle antiche predilezioni amicali e affaristiche di Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini, da un lato, e il collaborazionismo pacifista che dall’altro lato, e
ormai da un anno, si è fatto ripetitore della propaganda degli aggressori e ha
trovato nella guerra all’Ucraina l’occasione per riaffermare una dopo l’altra
tutte le proprie qualità essenziali – il ripudio della verità e il richiamo
invincibile a farne contraffazione, l’odio irriducibile verso la libertà e verso
l’ambizione altrui di difenderla, l’estraneità aggressiva e budellare alle
ragioni del diritto e la pretesa di vederle sostituite dalla regola della forza
che a fin di bene, a fin di giustizia, a fin di pace, si impone con i massacri,
con gli stupri e con le deportazioni sugli intollerabili vagheggiamenti di
democrazia degli insubordinati al dovere morale della resa.
Non è la stessa
minestra. Le simpatie e gli interessi che legano certuni ai plenipotenziari di
quel sistema autocratico hanno lo stesso effetto del pacifismo
collaborazionista, ma di quest’ultimo non condividono la causa per così dire
costituzionale, l’origine sistematica, l’attitudine a farsi programma politico.
La t-shirt con il profilo del denazificatore non ha la portata, né l’intenzione,
della vignetta che raffigura Volodymyr Zelensky col braccio fasciato di
svastica. Lo sproloquio sulla guerra che comincia per le avidità territoriali
ucraine non ha il significato, né l’obiettivo, delle teorie cospirazioniste che
l’accademia malvissuta ha messo in scena in un anno di teatro sui crimini
dell’occidente.
Sono differenze che
non descrivono differenti gradi di colpa, anche perché quelli che ne sono
rispettivamente portatori si consorziano in un fronte comune, come abbiamo
constatato recentemente. Ma sarebbe un errore capitale considerarle una stessa
cosa. Una è complicità da clan, una specie di favoreggiamento parentale, l’altra
è la guerra aperta a tutto ciò che dovremmo essere e rappresentare.
"Comunismo unica soluzione". Tornano i volantinaggi rossi porta a porta.
Volantini dei "Circoli operai" dei "Comitati internazionalisti" sono stati
distribuiti casa per casa in Lombardia con richiami al comunismo proletario di
Marx. Francesca Galici
il 6 Marzo 2023 su
Il Giornale.
Formalmente siamo
nel 2023 e abbiamo messo cinquant'anni tra noi e gli Anni di piombo, quei bui
anni Settanta che nessuno pensava mai di poter rivivere, nemmeno lontanamente,
nemmeno nel vago retrogusto di un rigurgito di violenza. Eppure, gli scontri
nelle piazze, l'anarchismo violento che rialza la testa, le lotte politiche nei
licei che tornano a far notizia e quel sentore di strategia della tensione che
torna prepotentemente. Se poi, a questo, si aggiunge anche il volantinaggio casa
per casa, il risultato è un vero e proprio salto nel passato.
Questa mattina
abbiamo ricevuto un volantino dei "Volontari dei circoli operai, comitati
internazionalisti" dal titolo "A ogni governo il suo naufragio e le lacrime di
coccodrillo". Già da qui è evidente il tentativo di strumentalizzare la tragedia
di Cutro a fine politico ma questo è quanto fanno, da una settimana ormai, quasi
tutte le forze politiche dell'opposizione e le Ong. Quindi, niente di nuovo su
questo fronte. A colpire maggiormente del volantino che è stato consegnato casa
per casa, lasciato davanti agli usci degli appartamenti dei palazzi in una
domenica di marzo, è il registro linguistico utilizzato per vergare il
manifesto. "Che l'imperialismo sia nemico della vita in molte direzioni è un
fatto risaputo. Dalle trincee del Donbass fino alle spiagge del Mediterraneo,
la borghesia alimenta le sue mortali contraddizioni", si legge nell'incipit del
manifesto, che si rifà evidentemente alle parole d'ordine del Manifesto del
Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels, redatto nel lontano 1848.
Nel volantino di
parla di "padroni", "parassitismo", "palazzi del potere" e di "eserciti
di sgherri". I "volontari dei circoli operai" che hanno redato il documento
attaccano con medesima veemenza tutti i partiti dell'arco parlamentare: "I
partiti parlamentari di destra, di sinistra, progressisti, sovranisti e
populisti hanno edificato in questi anni una politica spietata". Si riferiscono
alle politiche d'immigrazione "ascopo elettorale", alle lacrime versate "per
spillare ancora un po' di soldi a Bruxelles". Secondo questi nuovi volontari
rossi, tutti gli esponenti politici "seminano razzismo verso i più deboli e i
più deboli e raccoglieranno disprezzo".
Quindi, ecco la
chiamata, immancabile in questo genere di manifesti: "Nei posti di lavoro, su
banchi di scuola, nei quartieri delle città di tutto il Continente una vera e
propria classe internazionale sta crescendo". La conclusione, poi, svela la vera
natura di questi volantini: "L'internazionalismo è l'unica via,
il comunismo l'unica soluzione".
La "Net War" tra
Ucraina e giornalismo: così guerra e informazione si influenzano.
Federico
Giuliani su Il Giornale il 1 Marzo 2023.
Le armi con cui
viene condotta la guerra in Ucraina coincidono con le infrastrutture digitali
dell’informazione. Lo ricostruisce Net-war. Ucraina: come il giornalismo sta
cambiando la guerra, l'ottimo libro di Michele Mazza
Tabella dei
contenuti
Informazioni e
tecnologie: le nuove armi
L'importanza della
comunicazione
Net-war
La guerra che si sta
combattendo in Ucraina ha segnato uno spartiacque nella storia dell'Europa.
Tralasciando gli aspetti geopolitici e militari, questo conflitto è il primo
caso di guerra ibrida a tutto campo. Dove il combattimento sul terreno si svolge
nel contesto di una strategia di comunicazione che va oltre la semplice
propaganda e si trasforma in logistica militare. Lo ricostruisce alla
perfezione Net-war. Ucraina: come il giornalismo sta cambiando la guerra,
l'ottimo libro di Michele Mazza appena uscito per Donzelli Editore.
Informazioni e
tecnologie: le nuove armi
Sono innumerevoli
gli esempi che possiamo citare, ricostruiti alla perfezione in un testo tanto
approfondito quanto scorrevole. I gruppi privati come quello di Elon Musk,
Google e Microsoft diventano vere e proprie potenze geopolitiche, offuscando il
ruolo militare di interi apparati statali.
Le armi con cui
viene condotta la guerra in Ucraina coincidono con le infrastrutture digitali
dell’informazione. Siti web, smartphone, droni, sistemi di geolocalizzazione e
piattaforme social sono strumenti che hanno costituito il principale arsenale
del confronto fra i due eserciti sul campo. Le forze di Kiev, facendo leva
proprio su questo, hanno localizzato e colpito con estrema precisione i soldati
del Cremlino, anche grazie al supporto diretto della popolazione che rimaneva
connessa (persino sotto i bombardamenti).
L'importanza della
comunicazione
E poi c'è' da
considerare la comunicazione. Già, perché le azioni militari vengono
strategicamente studiate e messe in atto proprio pensando al loro effetto
comunicativo, perché il modo in cui verranno raccontate determinerà la
percezione del conflitto e, in ultima analisi, il suo esito. Se non è una novità
che la comunicazione della guerra sia un terreno cruciale e delicato, oggi essa
è diventata l’oggetto del contendere, sottolinea il libro di Mazza.
La censura applicata
ai media russi, dove la stessa parola "guerra" è bandita e va sostituita con
l’edulcorata definizione di "operazione militare speciale", è l’esempio più
lampante di un giornalismo che ha perso il suo carattere di autonomia. Ma ciò
che accade in Russia, in forme diverse e meno radicali, sta avvenendo anche da
noi.
Come nota l’autore,
con la guerra in Ucraina il giornalismo diventa tutto embedded, non solo per
un’integrazione di ogni mediatore con una delle due parti, quanto perché
l’informazione, per i suoi strumenti e le sue tecnicalità, si confonde e si
combina con la cyber security, lo scontro sulla sovranità di memorie e contenuti
digitali.
Net-war
La manomissione
dell’evidenza di immagini e news ci dice che siamo oltre il contrasto rispetto a
un supposto mainstream ideologico, siamo nel pieno della guerra
ibrida teorizzata proprio dalla Russia. In questo scenario, l’informazione che
scorre in rete è il prolungamento del perenne conflitto che i due schieramenti
animano, attaccando e inibendo le risorse del nemico.
Tutto questo porta a
un cambiamento epocale nel giornalismo, dove a mutare radicalmente è il rapporto
tra la redazione e le fonti: le notizie sono alluvionali testimonianze civili,
che affiorano in abbondanza dalla rete e devono essere validate e
contestualizzate più che rintracciate.
In questo gorgo il
giornalista si misura innanzitutto con la sua autonomia da saperi e competenze
tecnologiche che tendono a soverchiarlo, trasformandolo in un funzionario del
sistema di calcolo che si afferma mediante "interferenza nelle psicologie
altrui". La Net-war è dunque "mediamorfosi" che trasforma guerra e giornalismo
in una contesa matematica.
Dezinformacija.
Chi sono i putiniani italiani e come funziona la loro narrazione anti
occidentale.
Maurizio Stefanini su L’Inkiesta l’1 Marzo 2023.
Esponenti di estrema
destra e sinistra veicolano la propaganda del Cremlino adattandola alle corde
più sensibili della nostra opinione pubblica, ma i temi sono talmente ripetitivi
e deboli che diventa facile capirne la fonte comune, basta saper guardare con
attenzione
«Più di mille
persone hanno protestato contro le sanzioni anti-russe davanti a una base Nato
in Italia. L’azione è stata organizzata dall’associazione socio-politica Italia
Unita, in collaborazione con il partito Russia Unita». Così la Tass riferì della
«Manifestazione 20221218 Aviano – Italia fuori dalla guerra», con l’adesione di
una cinquantina di sigle, sia di sinistra che di destra. Organizzatore Amedeo
Avondet: un ex-esponente di Fratelli d’Italia spesso presente sulle tv russe,
che scrive sulla stessa Tass.
Un esempio che è
stato il culmine di «La critica di matrice filo-Cremlino alla Nato nell’ecologia
mediatica italiana»: l’intervento che Giovanni Ramunno, generale dell’Esercito e
giornalista, già consigliere militare per la comunicazione del Presidente del
Comitato Militare dell’Unione Europea, ha svolto lunedì nel corso di
«Dezinformacija e misure attive: le narrazioni strategiche filo-Cremlino in
Italia sulla NATO, le politiche estere e di sicurezza dell’Occidente, e i rischi
di guerra nucleare». il zecondo di tre incontri che l’Istituto Gino Germani di
Scienze Sociali e Studi Strategici ha organizzato su «Dezinformacija e misure
attive: le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italia» e di cui il primo
appuntamento c’era stato il 26 gennaio.
«I filo-putiniani
sono di destra e di sinistra», ha spiegato infatti Ramunno. «I filo-putiniani
sono la destra e la sinistra estrema con i sovranisti». Ricordata una serie di
studiosi sul tema delle «narrative» – da Alec Fischer a Jerome Bruner, Alister
Miskimmon e William Labov – ha spiegato come, utilizzando determinate
metodologie, sia relativamente facile individuare l’origine russa di alcune
«narrazioni» oggi presenti nei discorsi di contestazione al sostegno per
l’Ucraina. Una, ad esempio, è quella della «gabbia di ferro» in cui Paesi come
l’Italia sarebbero costretti da organizzazioni come Nato e Ue. Un’altra,
quell’«abbandono» cui l’Italia e altri Paesi sarebbero stati lasciati da queste
organizzazioni di fronte a problemi come il Covid o il rincaro delle bollette
che per via delle sanzioni veniva annunciato come inevitabile.
Due appunti in
teoria opposti, quelli di essere troppo o troppo poco presenti allo stesso
tempo. Ma è caratteristica della «dezinformacija» russa quella di dire allo
stesso tempo cose anche opposte.
Ma confrontiamo
alcune dei messaggi che Ramunno ha presentato nelle sue slides. «Fermiamo i
golpisti di Kiev. La Federazione Russa sta attuando un’azione di autodifesa
contro le continue provocazioni dei golpisti di Kiev e della Nato.». E questo è
il «Veneto serenissimo Governo. Ufficio di presidenza». Eredi dei separatisti
veneti che loro sì avevano «rappresentato» un grottesco tentativo di
insurrezione con l’assalto del «tanko» fatto in casa contro il Campanile di San
Marco.
«La Nato, come altre
simili organizzazioni politico-militari in zone diverse dello scacchiere
mondiale, è il cane da guardia degli interessi dei monopoli, pronta a osannare
chiunque osi contraddire il diktat imperialista. I costi della guerra
imperialista, mascherate da missioni di pace, vengono anch’essi scaricati sulle
masse popolari, costrette a pagare il conto della spartizione della ricchezza
mondiale tra le borghesie imperialiste. Negli ultimi tre decenni, abbiamo dovuto
assistere alle continue iniziative belliche della Nato, organizzazione mondiale
dell’Occidente capitalistico posta sotto stretto controllo statunitense». Questo
è il Pci: partito creato nel 2016 con l’ambizione di essere l’erede della
vecchia sigla disciolta da Achille Occhetto, e che alle ultime politiche non è
arrivato ai venticinquemila voti alla Camera.
«Una scellerata
classe politica, culturalmente succube degli Stati Uniti d’America, ha accettato
servilmente un modello antropologico illuminato e rafforzato dalle direttive
economiche e politiche dell’Unione Europea. I politici italiani,
deresponsabilizzati dalla pseudocultura individualistica e sovranazionale hanno
scelto la fellonia di tutelare gli interessi di potentati economici stranieri».
Questa è Riconquistare l’Italia: sigla che alle ultime elezioni assieme al
Partito Comunista di Rizzo ha fatto parte del cartello Italia Sovrana e Popolare
di Antonio Ingroia.
«Non temo tanto i
servizi ucraini ma anche quelli americani e/o occidentali, noti per le loro
pratiche provocatorie. Continuerò la mia lotta contro la guerra e le sanzioni,
sapendo di avere con me la maggioranza degli italiani». Questo è Roberto Fiore,
il leader di Forza Nuova arrestato per l’assalto alla Cgil.
«La Nato è il
protagonista e il creatore di dozzine di conflitti in tutto il mondo, travisando
la sua vocazione difensiva mutandola in operatività offensiva e militare».
Questa è La Pekora Nera: sito di una Federazione Popolo Sovrano che si è
mobilitata in particolare contro il Green Pass. In particolare su questo testo
sottolinea Ramunno che «è un messaggio russo. Andate in qualsiasi giornale russo
e troverete questo».
«La trasformazione
della Nato da organizzazione militare difensiva nordatlantica a organizzazione
militare offensiva mondiale guidata dagli Stati Uniti avrà profonde conseguenze
geopolitiche internazionali in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa». Questo
è resistenze.org, del Centro di Cultura e Documentazione Popolare.
Organizzazione che si proclama apartitica per «la salvaguardia e la diffusione
della cultura e della memoria dei movimenti sociali che lottarono e lottano
contro le disuguaglianze sociali e la guerra, in particolare del movimento
operaio italiano e internazionale, dell’antifascismo e dei movimenti per la
pace».
«Non che qualcuno
abbia mai veramente creduto che questa Europa potesse svincolarsi dal padrone di
oltre Atlantico». Questo è Primato Nazionale, testata di CasaPound.
«Occorre ribadire
che, sul, piano geopolitico, il nemico sono gli Usa, non la Russia. E che
l’Italia dovrebbe uscire il prima possibile dalla Nato ed evitare il proprio
ingresso in qualsivoglia guerra». Questo è Diego Fusaro: noto turbo-filosofo
rosso-bruno, ma citato «in maniera asettica», ricorda Ramunno, da un quotidiano
un tempo fanfaniano e andreottiano come Il Tempo.
«Fermiamo la guerra
né con Putin né con la Nato». Questa è Rifondazione Comunista. Che prende le
distanze apparenti da Putin ma ignorando del tutto l’Ucraina.
«La nostra lotta
contro la Nato è una lotta contro le forze di occupazione. Fermiamo la guerra
via le basi dai nostri quartieri. L’alleanza militare offensiva è stata al
centro del conflitto in corso in Ucraina, che ha portato molti a mettere in
discussione l’alleanza stessa e cosa significhi farne parte». Questo è Giuliano
Brumetti di Potere al Popolo, che parla delle prospettive della sinistra
italiana citato l’Ucraina come mero teatro di conflitto, e lui senza prendere
alcuna distanza.
«Ci opponiamo alla
Russofobia, all’invio di armi agli ucraini, alle sanzioni che danneggiano la
nostra economia. E ai diktat imposti dall’Unione Europea e dalla Nato”. E questo
è appunto, Amedeo Avondet, presentato come top per la serie di manifestazioni
organizzate a partire da quella di Torino del 13 maggio, in cui è stata spesso
presente o ha comunque mandato il suo messaggio Irina Elyfiorova, capo del
dipartimento Agitazione e Propaganda della sezione moscovita di Russia Unita.
Ripetiamo: a manifestazioni in Italia. Proprio lei, ricorda Ramunno, il giorno
dopo la prima manifestazione lo accredita come giornalista della Tass. «Colui
che parla e che porta il verbo», chiosa sempre Ramunno Tass a parte, le sue
iniziative sono riportate da Ria Novosti: «In Italia si sono svolte
manifestazioni all’insegna dello slogan “Nato e Ue, lasciateci in pace”». E da
Izvestia, collegata con il mondo militare russo: «In Italia si sono svolte
proteste contro la politica delle autorità nei confronti dell’Ucraina».
Genova, in
migliaia contro la guerra: la Digos ferma il treno dei manifestanti.
Valeria
Casolaro su L'Indipendente il 27 febbraio 2023.
Sono centinaia le
iniziative che hanno avuto luogo in tutta Italia nel fine settimana per chiedere
la fine del conflitto in Ucraina e lo stop all’invio di armi a Kiev. Il corteo
più numeroso, con alcune migliaia di persone a prendervi parte, è stato quello
di Genova contro il transito di armi che avviene nel porto cittadino. Convocato
dai portuali genovesi, vi hanno preso parte studenti, operai, attivisti
afferenti a varie realtà e i sindacati di base SI COBAS e USB, oltre a
Rifondazione, Potere al Popolo, Unione Popolare e Uniti per la Costituzione. È
la prima volta in cui un corteo riesce ad attraversare l’area portuale di
Genova, il cui ingresso è in genere consentito solamente agli addetti ai lavori.
Nonostante la manifestazione, come tutte le altre svoltesi nel corso del week
end, sia stata pacifica, i manifestanti hanno denunciato il blocco da parte
della Digos di un treno carico di persone dirette al corteo.
“Questo è lo stato
della democrazia del nostro paese – il supposto modello di libertà che la nostra
classe politica vorrebbe esportare nel mondo – dove le forze dell’ordine
decidono arbitrariamente di ostacolare la libera partecipazione a iniziative
pacifiste, dato che a quanto pare non può essere messa in discussione la linea
politica guerrafondaia occidentale” si legge nel comunicato diffuso dalla
sezione torinese di Potere al Popolo. Il treno è stato lasciato partire intorno
alle 12.30. Numerose altre iniziative hanno potuto contare su una forte
partecipazione cittadina: a Milano italiani e ucraini sono hanno sfilato in
corteo per la città intonando l’inno nazionale ucraino, per fermarsi di fronte
ai gradini del Duomo. Corteo molto partecipato anche a Roma, dove a reggere lo
striscione di Europe for Peace vi erano, tra gli altri, il segretario della CGIL
Maurizio Landini e il sindaco Roberto Gualtieri. Nella capitale si è anche
svolta, in serata, una fiaccolata che ha percorso via dei Fori Imperiali per
arrivare fino in piazza del Campidoglio. Anche a Niscemi, in Sicilia, centinaia
di persone si sono ritrovate, nonostante il maltempo, per manifestare contro la
guerra e contro la militarizzazione del territorio e delle scuole
siciliane. Migliaia di persone in piazza anche a Napoli, dove il corteo è stato
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, insieme al Comune di Napoli e
all’Arcidiocesi. [di Valeria Casolaro]
Ucraina, perché è
sbagliato criminalizzare i “putiniani d’Italia”.
Fioccano i richiami
all’indelebile antiamericanismo anche da parte di politici e giornalisti. Dino
Cofrancesco su Nicola Porro .it il 26 Febbraio 2023,
“Chi non ‘è con me è
contro di me”, si legge in ‘Matteo’ 12,30. Le parole di Gesù avevano un senso,
per i credenti, giacché essere contro di lui, significava stare dalla parte
dell’Inferno. Con la ‘secolarizzazione’, però, non ci sono più potenze
demoniache e schiere angeliche che le combattono ma è rimasto il senso religioso
di un mondo diviso in buoni e cattivi. “Qui non est mecum contra me est!” Chi
non condivide i miei valori è mio nemico. Un manicheismo che può considerarsi
l’ultima traccia delle età teologiche. ”Chi non è con noi è contro di noi”,
ammonì Benito Mussolini nel discorso di Roma del 24 marzo 1924. La grandezza
della democrazia liberale sta nell’aver trasformato il nemico (ontologico) in un
avversario politico al quale è riconosciuto il diritto di dire ciò che vuole, di
associarsi con chi crede, di criticare liberamente il governo, senza dover
temere sanzioni: purché, naturalmente, rispetti le regole del gioco.
È un “costume della
mente e un abito del cuore”, per citare Tocqueville, che da noi non hanno mai
messo solide radici giacché il pluralismo, che ha in mente la cultura politica
italiana, è una tavolozza con le diverse tonalità di un unico colore. È vero
che, in linea di massima, sono tutti ammessi nel dibattito pubblico ma ciò che
si esige da quanti provengono da formazioni non liberali è un’abiura certo
comprensibile, se limitata al giuramento di fedeltà alla Costituzione e al
riconoscimento dei ‘delitti contro l’umanità’, di cui si erano resi colpevoli i
partiti ai quali si era aderito un tempo, sennonché tale abiura è resa assurda
da richieste degne di un Inquisitore.
Il ‘velen
dell’argomento’, infatti, sta nel ‘non accontentarsi’, nel dire: ‘non basta’,
“è troppo comodo condannare oggi certe pratiche se non vengono fatte risalire
alla natura stessa dell’ideologia dalla quale sono nate”. Meloni, La Russa e
altri possono pure definire le leggi razziali una pagina nera della storia
italiana, possono pure ritenere che l’Asse Roma/Berlino sia stato un delitto
contro il Risorgimento e la sua filosofia civile: non basta, dovrebbero
aggiungere che fin dai giorni di San Sepolcro quelle scelte tragiche erano
iscritte nel dna del fascismo.
Nessuno, a quel che
mi risulta, ha rilevato il carattere grottesco di tale pretesa. Ammettiamo pure
che fin dalle origini Mussolini pensasse a una politica antisemita (nonostante
il seguito che i fasci ebbero tra gli ebrei italiani, sol che si pensi al grande
antichista Arnaldo Momigliano) ma chi autorizza il politico, il giurista,
il maître-à-penser dei giornaloni, a farsi storico? Ai comunisti che, in buona
fede, si dissociano dallo stalinismo e lo ritengono un tradimento rispetto a
Marx e a Lenin, diremo che, in realtà il totalitarismo era connaturato a
Rousseau e all’ideologia giacobina che indubbiamente ispirarono il Manifesto del
partito comunista del 1848? Lo riteneva un grande storico Jacob L. Talmon (v. la
sua opera magistrale Le origini della democrazia totalitaria del 1952) ma perché
dovrebbero pensarlo i custodi delle istituzioni che credono ai comunisti, quando
questi dichiarano la loro estraneità ideale ai gulag e allo stalinismo? Si
pretende forse che siano tutti d’accordo con Talmon e che la loro lealtà
costituzionale venga accertata da un esame di storia moderna e contemporanea?
Il copione si
rinnova oggi con la guerra in Ucraina. Ormai è caccia aperta ai ‘putiniani
d’Italia’ e fioccano i richiami all’indelebile antiamericanismo anche da parte
di politici e giornalisti che di quell’antiamericanismo in passato hanno dato un
massiccio contributo di idee e… di cortei. È proprio vero che, nel nostro paese,
la vergogna è stata da tempo messa al bando. Alle innumerevoli voci (non
proprio) bianche di questo coro — v. il Corriere della Sera, la Repubblica, La
Stampa con i suoi satelliti regionali, La Ragione, Il Foglio etc. etc. —
vogliamo chiedere, sulla linea del ‘non basta’: se si considera (come considero
io) Putin un gangster internazionale, l’aggressore di uno stato sovrano, un
cinico giocatore sulla scacchiera internazionale, si è tenuti a sottoscrivere le
visioni apocalittiche di una civiltà occidentale, democratica e liberale,
minacciata dall’eterno dispotismo orientale?
Chi non sta con
Angelo Panebianco, Antonio Polito, Giuliano Ferrara, Adriano Sofri etc etc.
diventa una quinta colonna del nuovo Ivan il terribile? A scanso di
fraintendimenti (che non mancheranno), gli argomenti usati contro i ‘pacifisti’
hanno un loro peso e vanno considerati seriamente: si vis pacem para bellum,
bisogna procurare tante e così gravi perdite ai russi da indurli a sedere al
tavolo della pace, i discorsi ufficiali del Cremlino non lasciano intravedere
vie di uscita etc. etc. Ma da qui se ne deve dedurre che quanti non sono del
tutto convinti di tali argomenti – e pensano, ad es., che se un rapinatore
armato entra in una banca e minaccia di uccidere tutti e far saltare il locale è
meglio venire a patti—sono persone scriteriate se non in malafede? Qualcuno ha
scritto ironicamente, riportando i discorsi dei presunti putiniani’: “Ma davvero
vogliamo rischiare l’olocausto nucleare per non voler cedere la Crimea a Mosca e
non fare del Donbass l’Alto Adige ucraino?” E se così fosse, ammesso e non
concesso che Putin se ne accontenterebbe?
Forse non si ha
presente che Crimea e Donbass non sono regioni omogenee dal punto di vista
etno-culturale, come sarebbero un Lazio e una Toscana qualora venissero invase
da un rinato Impero austroungarico. È la tragica convivenza tra popoli diversi
che scatena le guerre e la seconda guerra mondiale ne è un esempio. “Sui libri
di storia – si legge ne La Ragione – c’è la vicenda dei Sudeti consegnati alla
Germania hitleriana: forse converrebbe tornare a consultarli”. Certamente ma
soprattutto per rendersi conto che l’annessione dei Sudeti (4 milioni di
tedeschi) alla Cecoslovacchia fu uno dei tragici errori della infelice Pace di
Versailles, in violazione, tra l’altro, del principio di nazionalità fatto
valere dal presidente Woodrow Wilson.(a tali violazioni non si sottrassero gli
italiani, quando occuparono l’Alto Adige tedesco, briciole del pingue bottino di
guerra assegnato agli altri vincitori della Grande Guerra).
Forse è venuto il
momento di dare un taglio alla caccia alle streghe e allo stanamento dei
putiniani sotto mentite spoglie democratiche. Le ‘buone ragioni’ stanno sia
dalla parte degli occidentalisti che vorrebbero piegare l’orso russo sia di
quanti mettono in guardia (Silvio Berlusconi, Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini
etc.) da retoriche che allontanano la pace. L’Occidente significa ragione e
dialogo e accusare chi non la pensa come noi di ‘distorcere “ideali e
appartenenze”, significa fuoruscirne, scegliendo la via della crociata.
Un ultimo invito
a opinion makers come Antonio Polito (ma non solo lui). E se la piantassimo di
fare gratuita ironia sullo ‘scontro di civiltà’(ma non è il titolo del saggio di
uno dei grandi scienziati politici del nostro tempo, il compianto Samuel P.
Huntington?) o sulla “consistente fetta di opinione pubblica che ha ereditato
dalla cultura cattolica e da quella comunista un’istanza morale
anti-capitalistica, contraria all’individualismo, ostile all’american way of
life, convinta che il valore dei popoli non sia dato dal loro successo economico
ma dalla loro unità mistica, perché le società non sono meccanismi ma
organismi..”? È lecito o no diffidare del modello americano, come faceva il più
grande filosofo politico italiano della seconda metà del 900, Augusto Del Noce?
O bisogna pensare che l’anti-americanismo non si richiama ad alcun valore
rispettabile e che è soltanto l’espressione di un paese arretrato, provinciale,
nemico giurato della modernità?
Di questo
neo-illuminismo se ne ha davvero abbastanza anche perché potrebbe attivare
reazioni che distruggerebbero le grande conquiste del secolo di Voltaire: la
libertà di pensiero (oggi non a caso insidiata dal politicamente corretto),
l’autonomia dello spirito, la ricerca scientifica non vincolata ai dogmi, il
diritto di ciascuno a vivre sa vie.
E non si tratta solo
di cultura. Basta leggere un manuale di storia contemporanea per rendersi conto
che la politica estera degli Stati Uniti è stata spesso un disastro
irrimediabile, di cui per chissà per quanto tempo porteremo ancora il peso. E
non solo nel Medio Oriente dove la casa Bianca ha portato il caos, la morte, i
genocidi, come conseguenza di rottura di antichi equilibri faticosamente
raggiunti nelle aree più calde. Uno stimato collega liberale (anzi liberal) al
quale ricordavo tutto questo, mi rispose tempo fa “Tutto vero, ma sono gli unici
americani che abbiamo”.
Credo che il collega
avesse sostanzialmente ragione e che, volere o volare, dobbiamo fare i conti con
la grande potenza atlantica che con la Nato continua a garantire la nostra
sicurezza. Ma questo ci condanna al destino di yes men e di portaborse?
All’Europa non è accordata la libertà di esporre il proprio punto di vista, che
non sempre è detto che coincida con quello statunitense? Gli Stati, come
ricordava Benedetto Croce, sono leviatani dalle viscere di bronzo, i cui
interessi possono divergere e quando si pongono al servizio di ideali umanitari
è perché la difesa di questi si accorda con i loro corposi interessi. (Gli Stati
Uniti ci salvarono, sì, dal giogo nazista—e per questo meritano eterna
gratitudine—ma lo avrebbero fatto senza l’incubo di una Fortezza Europa in mano
a Hitler e libera di riversarsi a est, verso le terre dei sub-umani popoli
slavi?).
Non viviamo
certamente in un paese totalitario, sotto il profilo delle istituzioni politiche
e delle garanzie giuridiche, ma il totalitarismo si è insediato nelle menti,
nella cultura ufficiale, nelle scuole e si converte – lo vediamo ogni giorno –
nel mancato rispetto dell’altro, di chi non la pensa come noi. Tra i
giornalisti più noti non ce n’è uno che cerchi di comprendere i cosiddetti
putiniani, che non ipotizzi, neppure per un attimo, che tra i loro argomenti ce
ne possano essere di quelli da prendere in seria considerazione.
“Non ci può essere
un posto della guerra nei rapporti di quelle comunità che condividono
istituzioni democratiche rappresentative, economie di mercato e società aperte,
ha scritto Vittorio E. Parsi sul Foglio del 24 febbraio, Dopo un anno di guerra.
Con l’Ucraina, tutti più forti.” La pace passa attraverso la democrazia e non
viceversa, per cui fintano che ci saranno dispotismi, le democrazie saranno
sempre esposte alla potenziale minaccia di aggressioni da parte delle
non-democrazie e dovranno sempre difendersi”. Chi non condivide questa antica
vulgata—su cui già ironizzava tre secoli fa Alexander Hamilton nei suoi saggi
sul Federalist (1788)—dimostrerebbe una cosa sola: di essere un incallito
putiniano! Più pensiero unico di così!
C’è qualche
scienziato politico che è arrivato a lamentarsi dell’eccessivo spazio dato,
nelle tv, ai ‘putiniani’ d’Italia: non me n’ero mai accorto, pur vedendo spesso
gli incriminati talk show. Un accademico, Sofia Ventura, in un articolo su la
’Nazione’ del 29 gennaio u.s. si doleva per la mancata partecipazione di
Zelensky al Festival di Sanremo, prendendosela con chi ne voleva tener fuori la
politica. ”Ascoltare quanti si crucciano per la tranquillità turbata o la
percezione degli spettatori deviata da un racconto di guerra fuori contesto
ricorda || chissà perché || Maria Antonietta e le se brioches”. Stando a questo
‘stile di pensiero’, non mi è consentito, se compro un biglietto per assistere a
uno spettacolo pensando di svagarmi, esigere di non sentire appelli umanitari e
testimonianze di tragedie che voglio dimenticare proprio mettendo piede a
teatro. Negli ‘anni formidabili’ della conte-stazione, il pianista Maurizio
Pollini interruppe il concerto di Chopin che stava eseguendo per leggere un
proclama di solidarietà col Vietnam invaso dall’esercito americano. Pollini era
(è) un grande artista e, forse, non aveva mai sentito parlare del liberalismo
come ‘arte della separazione’. Il caso di Ventura è diverso.
Uno scienziato
politico, lungi dall’ unirsi alla caccia grossa ai putiniani, dovrebbe guardarsi
dall’incriminare, per il mancato show di Zelensky, “l’ostilità verso di lui
della nostra opinione pubblica, complici una forte tradizione liberale e
antioccidentale e la penetrazione della propaganda russa”. Quantum potuit
religio! E le religioni secolari ancor più di quelle tradizionali…
Dino Cofrancesco, 26
febbraio 2023
Estratto
dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica” il 25 febbraio 2023.
[…] In una
intervista a Repubblica Shawn Crowley, l’incaricato d’affari dell’ambasciata
americana a Roma, ha risposto al fondatore di Forza Italia sminuendo anche il
ruolo di Berlusconi negli accordi di Pratica di Mare da America e Russia: «[…]
Penso che Berlusconi stia pensando al 2002, a Pratica di Mare, l’anno in cui
crede di aver aiutato a metter fine alla guerra fredda […]».
Frasi, quelle di
Crowley, che fanno scattare la reazione di Forza Italia. Il senatore Maurizio
Gasparri attacca l’ambasciata americana senza molti giri di parole, prima in un
tweet e poi intervenendo a Metropolis sul sito di Repubblica : «Chi parla di
Monaco 1938 oggi dice una sciocchezza. Comunque l’incaricato di affari Usa a
Roma Crowley — afferma Gasparri — che dice che per Pratica di mare 2002
Berlusconi “crede” di aver aiutato a mettere fine alla guerra fredda, è molto
sgradevole. Come se Berlusconi non avesse dato un importante contributo in
quella fase di dialogo e di pace. Crowley precisi e sia più rispettoso della
verità e della storia».
I toni del senatore
forzista sono molto accesi, ma da Forza Italia fanno sapere che lo stesso
Berlusconi non vuole andare in rotta di collisione con l’ambasciata americana:
ieri era attesa una sua nota, che però non arriverà mai. […]
Estratto
da repubblica.it il 25 febbraio 2023.
Quella in Ucraina è
"una guerra voluta e perseguita da alcuni strateghi Usa ormai da molti anni,
nella teoria come nella prassi". Sul blog di Beppe Grillo il pezzo odierno di
apertura è un'analisi di Fabio Massimo Parenti, professore associato di Economia
Politica Internazionale alla China Foreign Affairs University di Beijing, in
Cina.
Un pezzo che
comincia pacifista, perlomeno visivamente con il simbolo della pace che apre
l'illustrazione iniziale; ma che poi finisce per prendere una posizione netta.
Ovvero che Vladimir Putin non c'entra nulla, visto che non viene neanche mai
citato. Piuttosto si tratta di "una guerra globale rivolta contro la Russia, ma
proiettata contestualmente verso la Cina, l’Iran e tutti coloro che osano non
seguire più l’agenda unipolarista ed imperialista degli Usa. Ciò è stato più
volte analizzato e spiegato da autorevolissimi studiosi e politici statunitensi
prima di altri".
L'articolo ospitato
con grande evidenza dal fondatore del Movimento 5 Stelle, che giusto tre giorni
fa era stato a Roma per un ricevimento all'ambasciata cinese proprio assieme a
Parenti, punta il dito contro "i macro-interessi economico-politici
dell’apparato industriale militare e di intelligence americano, desideroso di
destrutturare i processi di integrazione euroasiatica, con al centro Russia,
Iran e Cina. Non deve sorprendere, pertanto, che Washington non si muova in
alcun modo per un cessate il fuoco e una trattativa in Ucraina (sorprendente è
invece la servile viltà europea), bensì per collegare questo scenario di guerra
vasta – da alimentare a discapito di tutta l’Europa e dell’economia mondiale – a
quello cinese".
Lettera di Paolo
Cirino Pomicino a Dagospia il 25 febbraio 2023.
Silvio Berlusconi
sembra abbia perplessità al nuovo invio di armi all’Ucraina sia sul piano della
quantità che della qualità. Una curiosità: perché Berlusconi non fa un viaggio a
Mosca come iniziativa personale a trovare il suo vecchio amico Vladimir Putin,
prodigo di regali e di affetto nei suoi confronti, per spiegare le ragioni
dell’occidente? Non lo fa perché non ha il coraggio?
Tra le tante cose
che non mancano al Cavaliere è, proprio il coraggio. Berlusconi non va perché sa
già la risposta di Putin. Ed allora il mancato invio di armi sufficienti
all’Ucraina per difendersi dall’aggressione significa tifare, forse
inconsapevolmente, per la vittoria militare e politica di Putin. Questo errore
fu già fatto a Monaco nel 1938.
Il pensiero di un
vecchio democristiano, che da tempo ha scelto altre vie, per essere appieno
compreso ha bisogno di essere analizzato da un altro democristiano. Romano Prodi
in una intervista sul Corriere della Sera si chiede preoccupato il perché Biden
sia andato a Varsavia e non a Bruxelles dopo la visita lampo a Kiev.
La sua
preoccupazione è che Biden voglia dividere l’UE facendo leva sui paesi orientali
rispetto agli altri 18 dell’Europa centro-occidentale “che sanno come declinare
l’alleanza atlantica”. Spiegazione: Prodi non condivide la decisione
franco-tedesca, e con esse quelle di tutti gli altri a cominciare dall’Italia,
di compattare l’Occidente a fronte dell’aggressione russa all’ucraina.
Un’aggressione che è
stata preceduta dall’acquisizione della Crimea senza che l’Occidente battesse
ciglia e prima ancora di alcuni territori georgiani. Non la condivide e
trasferisce il suo desiderio su presunti tentativi di divisione dell’Europa da
parte del presidente americano. Anche Prodi dimentica il 1938! Chi per affetto
chi per altro entrambi non ricordano più la storia e l’eterna ipocrisia dei
dittatori.
Subito dopo
l’accordo di Monaco ci fu l’accordo Molotov-von Ribentropp (Hitler e Stalin) e
18 mesi dopo Hitler attaccò la Russia di Stalin che intanto grazie a quel patto
con Hitler si era preso mezza Polonia. Sono eternamente questi i comportamenti
degli autocrati come si dice nella lingua di oggi. Ed allora determinazione e
prudenza ma sapendo che quel che farebbe male a noi farebbe male, molto male,
anche a loro
Nell’anniversario
della guerra in tutta Italia manifestazioni per la pace.
Valeria Casolaro su
L'Indipendente il 24 febbraio 2023
Nell’anniversario
dello scoppio della guerra in Ucraina, avvenuto a seguito dell’invasione russa
lo scorso 24 febbraio 2022, in tutta Europa si svolgeranno manifestazioni per
chiedere la pace e lo stop alle forniture militari a Kiev. In Italia, in
particolare, sono oltre un centinaio le iniziative previste, tra sit-in, marce,
fiaccolate, manifestazioni e dibattiti organizzate su tutto il territorio, dalla
marcia No MUOS a Niscemi (in Sicilia) fino al presidio di domani a Bolzano. A
dare il via è stata la marcia notturna per la pace da Perugia ad Assisi la
quale, iniziata poco dopo la mezzanotte di oggi, ha visto la partecipazione di
circa un migliaio di persone. A sancire la chiusura degli eventi sarà la
fiaccolata al Colosseo di Roma, domenica sera.
A muoversi tutto il
mondo civico che chiede la pace: cittadini comuni, preti e vescovi, sindaci ed
amministratori locali, artisti e sindacalisti riuniti nella “Tavola della Pace”
che annuncia che l’obiettivo della mobilitazione è duplice, sociale e politico:
invitare la maggioranza dei cittadini italiani contrari all’invio di armi a fare
sentire la propria voce e chiedere al governo italiano di farsi promotore di una
iniziativa per il cessate il fuoco e per l’apertura immediata di una trattativa
di pace. L’elenco completo delle iniziative, che avranno luogo in tutte le
principali città italiane, è disponibile sul sito Europe for Peace.
Piazza Italia.
Domenico Pecile su L’Identità il 25 Febbraio 2023
Lo dicono i dati:
risicata, ma è una maggioranza. Quella degli italiani contrari alla guerra. Una
maggioranza trasversale, che agisce autonomamente senza attendere le direttive
degli eventuali partiti di riferimento. È scesa in piazza in oltre cento città
italiane per altrettante manifestazioni organizzate dal mdi
dell’associazionismo, dalla Chiesa, dai sindacati, da pacifisti uniti da una
comune richiesta: la richiesta di immediate trattative di pace e lo stop alla
fornitura di armi e attrezzature militari da parte dei Paesi occidentali a Kiev.
Già lo scorso 5 novembre erano state oltre 100 mila le persone che erano scese
in piazza a Roma. Ma manifestazioni e iniziative sono state organizzate in tutta
Europa, coordinate da Europe for Peace, con oltre 20 eventi programmati in
Germania, Spagna e Portogallo e una quindicina in Francia. Manifestazioni anche
nel Regno unito, in Austria e nei Paesi Bassi. La prima di queste manifestazioni
si è svolta in notte tra Perugia e Assisi. Ad aprire la marcia uno striscione
con la scritta “fermiamo la guerra”. Il punto di arrivo è stato la basilica di
San Francesco. Tra i marciatori anche alcuni frati del Sacro Convento di Assisi.
Con loro pacifisti storici come l’organizzatore della marcia Flavio Lotti, molti
giovani e il gonfalone della Regione Umbria. “Siamo qui in questo tragico
anniversario per assumerci una responsabilità in più – ha dichiarato – per fare
quello che ancora non è stato fatto”. I marciatori sono quindi scesi alla tomba
di San Francesco per quello che gli organizzatori hanno definito un momento “di
raccoglimento, preghiera (per i credenti) e riflessione. A Napoli sono sfilati
assieme le associazioni cattoliche, il Comune e la comunata di S. Egidio. La
manifestazione è partita da piazza Dante per arrivare a piazza municipio. In
piazza accanto ai cittadini ucraini, moltissimi studenti e cittadini di altre
comunità straniere. Ad aprire la marcia uno striscione “Napoli città di pace”. A
sfilare anche una banda di giovani ragazzi cingalesi. “La pace è possibile e
siamo felici che tanti giovani hanno accolto l’appello – ha detto Paola
Cartellessa, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio – la pace assicura il
futuro dei giovani di tutto il mondo, la guerra è soltanto distruzione e dove
c’è guerra non c’è futuro. Purtroppo la guerra sta diventando il mezzo per la
risoluzione dei problemi, invece la pace va ricercata”. Sul palo si sono
alternati momenti musicali, interventi di personalità del mondo9 della cultura e
dello spettacolo, tra cui lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Patrizio
Raspi, e testimonianze di ragazzi ucraini. I manifestanti sventolavano bandiere
della pace e cartelli giallo-blu a ricordare i colori della bandiera ucraina. E
sulla giornata della pace è piombata la richiesta delle Acli di valutare il
piano della Cina per arrivare alla pace, invitando l’Ue di seguire la strada
della diplomazia. I dodici punti proposti dalla Cina “vanno approfonditi con
attenzione e, pur non essendo slegati dagli interessi e dalle trame egemoniche
di Pechino in Europa e nel mondo, possono e devono essere però una sponda per
quella tregua ad oltranza che la via della pace possibile adesso”. Questa, in
sintesi la nota delle Acli. L’Ue – osservano – “deve immediatamente uscire dalla
chiusura politica in cui si è impantanata, con la decisione di intraprendere una
vera strada per la diplomazia all’altezza delle sue origini”. Poi, su questa
tregua “si può discutere e giungere faticosamente a una soluzione definitiva ma
l’urgenza ora è che tacciano le armi e che si smetta di fare morire la gente,
dando il via a un intervento umanitario che sia internazionale, sotto l’egida
delle Nazioni unite”. E sul consolidarsi di una tregua, secondo le Acli “si
potranno lentamente rinsaldare le radici e la politica comune europea di
entrambe le nazioni coinvolto, facendo fare un passo indietro alle armi,
compreso il ritiro dell’esercito russo, e alla logica delle alleanze militari e
un passo in avanti al disarmo nucleare, senza il quale ogni conflitto può
prendere in ostaggio il mondo intero”. E un invito al cessate il fuoco, come
“valore assoluto e universale e con massima espressione della dignità umana è
arrivato dal professor Francesco Barone, dicente dell’università dell’Aquila e
portavoce del premio Nobel per la pace 2018, Denis Mukwenge. “Trovo importante
ribadire, anche alla luce degli equilibri delicati a livello attuale che la pace
è il punto di incontro tra morale, libertà e democrazia. È la lotta contro la
disumanizzazione, è l’idea secondo la quale non deve mai prevalere il lato
oscuro della ragione. E tale, quando assume lo stesso significato e viene difesa
in ogni luogo del pianeta. Conosco una possibile terapia: la pace si pratica,
secondo l’esempio di Mukwege”. E nella giornata della pace si è fatto sentire
anche il segretario del Pd, Enrico Letta. “Abbiamo portato la nostra solidarietà
tramute l’ambasciata ucraina. Abbiamo riconfermato – ha detto – il nostro
impegno a sostenere la resistenza dell’Ucraina. Tutti i morti, le vittime, le
distruzioni, deve tutto questo cessare, è l’unico modo è che l’Ucraina possa
difendersi”.
Se il pacifismo
passa dalla bolletta del gas.
Storia di Aldo
Grasso su Il Corriere della Sera il 25 Febbraio 2023
Pacifisti o
pacifinti? Venerdì sera, a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, Michele
Santoro ha chiamato a raccolta al teatro Piccolo Eliseo di Roma la galassia
ecopacifista italiana per una sua nuova app: «Servizio pubblico». Ha ricordato
il suo amico e sodale Maurizio Costanzo e poi ha mostrato immagini per
documentare come anche gli ucraini vogliano la pace. Tutti vorremmo la pace, ma
non a spese dell’Ucraina. Ormai crescono i «sensibili alle ragioni di Putin»,
come dice Paolo Mieli: chiedono agli ucraini di smettere di difendersi e di
scendere a patti con l’invasore (ovvero cedere territori alla Russia). Mai una
parola sulle fosse comuni di Bucha, sul martirio di Mariupol, sulle atrocità
contro la popolazione civile: la Russia ha aggredito ma anche chi doveva
custodire l’aggredito ha le sue colpe. È come se avessimo dimenticato che la
libertà ha un prezzo, morale e materiale. Basta l’aumento delle bollette del gas
o della luce perché le preoccupazioni economiche prendano il sopravvento su
quelle umanitarie. Così l’ideologia pacifista trova terreno fertile in chi pensa
che la libertà coincida solo con la sicurezza, con la quiete, con un accesso
garantito alla vita di prima. Certi tristi giorni, dietro la maschera delle
buone intenzioni, s’intravvedono le fosse comuni dell’Occidente e della libertà.
Brigata boomer.
Quelli che vorrebbero dare lezioni di anti-imperialismo alla resistenza ucraina
e altri bias politico-cognitivi.
Francesco Cundari su
L’Inchiesta il 25 febbraio 2023.
A un anno
dall’invasione russa, nella sinistra italiana è ancora diffuso un atteggiamento
di superiore condiscendenza (nel migliore dei casi) nei confronti dell’Europa
dell’Est
Non sempre la storia
è maestra di vita, spesso però l’attualità è maestra di storia. Per anni a
sinistra, in tanti, me compreso, ci siamo cullati nell’idea della diversità del
Partito comunista italiano rispetto agli altri partiti comunisti dell’Est.
Un’idea che conteneva peraltro una buona dose d’ingenerosità nei confronti di
dirigenti politici e intellettuali che i loro tentativi di elaborazione autonoma
e originale li avevano pagati a caro prezzo, davanti ai carri armati sovietici,
per giunta inviati con la piena approvazione (se non su diretta esortazione)
degli autonomi e originalissimi compagni italiani. Ma quello del 1956, ci
dicevamo, era un errore, che aprì già allora una discussione lacerante e che
sarebbe stato corretto in seguito: appena una dozzina di anni dopo, s’intende,
con la condanna dell’intervento sovietico a Praga da parte del Pci.
Per rivendicare
autonomia e originalità del comunismo italiano abbiamo esaltato gli strappi di
Enrico Berlinguer, e prima ancora la via italiana al socialismo di Palmiro
Togliatti, e prima ancora qualunque cosa nei Quaderni del carcere e negli altri
scritti di Antonio Gramsci consentisse di sostenere la tesi che ci stava a
cuore. Ma se l’albero si riconosce dai frutti, la qualità di quella scuola si
riconosce dai suoi ultimi epigoni, da quanti politici, intellettuali,
giornalisti oggi vorrebbero dare lezioni di anti-imperialismo a chi combatte
nelle trincee per difendere la propria casa e la propria famiglia
dall’espansionismo russo. Da come rimasticano malamente la peggiore propaganda
putiniana sulle malefatte della Nato, gli accordi di Minsk e il Donbas, con la
stessa sicumera con cui un tempo i loro padri parlavano dei provocatori e degli
elementi controrivoluzionari dietro le rivolte polacche o ungheresi.
È il fardello del
post-comunista occidentale, cui tocca far capire a tanti rozzi europei del Nord
e dell’Est, preoccupati dall’imperialismo russo, le sottigliezze della
geopolitica e della Realpolitik. È il marxplaining di chi sarebbe capace di
insegnare pure ai superstiti di Bucha la necessità di lottare contro
l’allargamento della Nato (o di spiegare ai socialdemocratici finlandesi e
svedesi perché non dovrebbero neanche chiederci di entrare nell’Alleanza
atlantica, per usare un esempio tratto da una storia vera).
Accettare che oggi
gli Stati Uniti e l’occidente abbiano semplicemente e completamente ragione, e
la Russia di Vladimir Putin semplicemente e completamente torto, autorizzerebbe
quanto meno il sospetto che potesse essere così anche prima. Per questo, anche
quando non si ha il coraggio di mettere in dubbio i crimini russi, i
bombardamenti quotidiani sui civili, le camere di tortura, i massacri
indiscriminati, non c’è demagogo a sinistra che non raccolga applausi
prendendosela con Jens Stoltenberg, la Nato e gli americani.
C’è qualcosa di
moralmente insopportabile, oltre che patetico, nella dissonanza cognitiva di
questa brigata boomer schierata a sostegno dei responsabili dei peggiori crimini
contro l’umanità. Tanto più insopportabile per lo smaccato contrasto con la
retorica antifascista esibita in ogni altra occasione, in tutte le occasioni
possibili, tranne che dinanzi al fascismo dichiarato e messo in atto dal regime
di Putin, con il suo esibito nazionalismo militarista, la sua repressione
violenta di ogni dissenso, la sua esplicita negazione di ogni diritto e libertà
civile, in nome della vecchia triade Dio Patria Famiglia.
Un anno di
resistenza, tra bandiere europee e ucraine, in piazza Duomo.
L’Inchiesta il 24
febbraio 2023.
Il presidio della
comunità che si difende dall’aggressione russa è qui ogni giorno da 365 giorni.
Oggi più che mai, il vessillo gialloblu si intreccia con quello stellato
dell’Unione. Perché l’integrazione è già cominciata, perché l’Ucraina è Europa
Le bandiere ucraine
e quelle europee da Brera raggiungono piazza Duomo. Il presidio della comunità
ucraina sta qui ogni giorno, non solo in questo 24 febbraio di ricorrenza.
Le telecamere delle
tv, i fotografi, persino i turisti o il pubblico della Fashion Week rallentano
per immortalare questi ragazzi che reggono lo striscione giallo e blu.
Le bandiere stellate
dell’Unione in cui Kyjiv vorrebbe entrare convivono già con il vessillo ucraino.
Perché l’integrazione è già cominciata, perché l’Ucraina è Europa, come hanno
ribadito i rappresentanti delle sue istituzioni all’evento del Premio Sakharov.
La noti da lontano
questa folla. Per le luci degli smartphone accese a rischiarare simbolicamente
la notte. La luce trionferà sulle tenebre: non è solo un mantra per non mollare,
stasera è una certezza. Quella Ucraina è a pieno titolo Resistenza.
A ricordarlo ci sono
centinaia di persone – più probabilmente un migliaio – sotto il Duomo che, così
illuminato, è un fondale dorato dello stesso bagliore delle bandiere.
Quando riecheggia il
grido «Slava Ukraïni!», abbiamo tutti imparato la risposta.
Contro le
tenebre, per la Resistenza. La sala strapiena del Centro Brera per abbracciare
il popolo ucraino che combatte da un anno.
L’Inchiesta il 24
febbraio 2023.
L’iniziativa
organizzata da Linkiesta e Slava Evropi nell’anniversario dell’invasione russa è
l’occasione per stringersi, in un giorno doloroso, al fianco di una comunità che
lotta per la possibilità di esistere
L’Ucraina è Europa.
Al Centro Brera non contiamo gli anniversari, ricordiamo il Premio
Sakharov conferito dal Parlamento europeo al coraggioso popolo ucraino. Proviamo
a stringerci – idealmente prima di farlo fisicamente in piazza Duomo – attorno a
una comunità in un giorno doloroso. È stracolma la sala dell’evento organizzato
a Milano da Linkiesta e Slava Evropi, in collaborazione, oltre che con
l’Europarlamento, con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea e il
Consolato generale ucraino a Milano.
«Per quelli della
nostra generazione, quelli che vivono il nostro tempo – dice il direttore
di Linkiesta, Christian Rocca –, il 24 febbraio è una di quelle date che non si
dimenticheranno, come l’11 settembre 2001. Non serve neppure specificare l’anno.
Oggi cerchiamo di celebrare il coraggioso popolo ucraino che ha resistito per un
anno alla barbarie e alle tenebre».
Dopo il violino
struggente di Nelly Kolodii dell’orchestra dell’Accademia della Scala, i saluti
istituzionali. Ci sono diversi rappresentanti diplomatici: il console della
Germania e quello della Finlandia, delegati del consolato dei Paesi Bassi, della
Slovenia, della Croazia, Repubblica Ceca e Bulgaria. Ci sono anche l’ex ministro
della Difesa del governo Draghi, Lorenzo Guerini, attuale presidente del
Copasir, e Marco Cappato.
«Il parlamento
europeo non ha scelto parole a caso quando ha dato il Premio Sakharov al
coraggioso popolo ucraino. La guerra dei russi all’Ucraina è una guerra a tutti
noi – dice il capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Maurizio
Molinari –. Nella società russa la libertà di pensiero non esiste. Il coraggioso
popolo ucraino combatte per la possibilità di esistere, un’esigenza anche della
nostra società. Il Parlamento europeo ha sostenuto il popolo e il governo
ucraino nella battaglia contro l’invasore, chiedendo anche l’invio di armi. Per
permettere al popolo ucraino di difendersi. Credo che durante la Seconda guerra
mondiale nessuno avrebbe detto che la Resistenza avrebbe dovuto arrendersi a
Hitler. Anche la Resistenza ucraina ha diritto a essere chiamata Resistenza».
«È difficile essere
freddi e razionali come un’istituzione dovrebbe sempre essere. È assolutamente
impossibile – aggiunge Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza della
Commissione Europea a Milano –. Sin dal primo giorno la Commissione europea ha
voluto schierarsi non solo a parole, ma con tanti fatti a fianco della
popolazione Ucraina». Cita i miliardi di aiuti e donazioni, le otto milioni di
persone accolte, soprattutto donne e bambini, metà dei quali beneficiano già del
meccanismo di protezione temporanea. «L’Ucraina appartiene alla famiglia
europea. Stasera non possiamo non dirci europei, ma non possiamo neppure non
dirci ucraini».
Viktoriia Fufalko
del Consolato generale dell’Ucraina a Milano esprime la «profonda gratitudine
agli organizzatori e a tutti i presenti per il colossale supporto che ci fanno
sentire. Il coraggio non è scontato. È chiaro che siamo combattuti, che c’è una
dualità quasi amletica in noi. Ma lottiamo per la libertà. Che la pace possa
essere garantita soddisfacendo gli appetiti dei regimi autoritari è un
controsenso».
«Oggi il mondo
libero ricorda la brutale aggressione – dice la vicepresidente del Parlamento
europeo, Pina Picerno –, che tendeva non solo a mettere fine all’esperienza
democratica di Kyjiv ma anche ad attaccare i nostri valori in tutte le nostre
democrazie, dopo anni di un’escalation poderosa attraverso le armi della
propaganda, che si è attivata attraverso le interferenze nella nostra politica
europea, che negli anni passati ha purtroppo incontrato indifferenza».
L’assalto a Kyjiv ha
aperto gli occhi «su una generazione di donne e uomini che ha fatto dell’Europa
la propria ragione di vita». L’assegnazione del Premio Sakharov per la libertà
di pensiero al coraggioso popolo ucraino, spiega Picierno, è «un riconoscimento
doveroso». La vicepresidente conclude con un elogio a Linkiesta e alla sua
redazione, diventate «la voce di quell’Europa che non sia arrende al buio della
ragione e la voce di un’Ucraina coraggiosa e valorosa che tra qualche anno, ne
sono sicura, diventerà una stella sulla bandiera della nostra Unione europea».
«Non avremmo mai
voluto esser qui oggi a ricordare questo anniversario, di un anno di sofferenza
dovuto all’aggressione ingiustificabile e ingiustificata di Putin – interviene
Lorenzo Guerini –. Torno con la mente allo scorso anno: alle 4.01 venivo
chiamato al telefono dal capo di Stato maggiore della Difesa che mi diceva che
l’invasione era iniziata. Un momento che sembrava avvicinarsi in maniera
inesorabile, sempre di più. Quella notte tutte le nostre paure si sono
materializzate improvvisamente, l’Italia si è messa subito al fianco
dell’Ucraina».
«Ho firmato cinque
decreti firmati per l’invio di armamenti – ricorda l’ex ministro –. Non è mai
facile fare scelte di questo tipo, però ci sono tornati della Storia in cui il
Male si manifesta. Il dovere di chi crede nella pace e delle democrazia, allora,
è sostenere chi viene aggredito. A quel Male abbiamo dato una risposta forte.
Putin pensava di risolverla in pochi giorni, ha continuato a chiamare operazione
speciale una guerra con tutti i canoni della guerra».
«Contava su un
popolo che si sarebbe piegato, su comunità occidentale che non avrebbe saputo
dare una risposta. Ma il mondo ha dimostrato che i calcoli di Putin erano
sbagliati. Voleva meno Nato e ha avuto più Nato, un’Europa divisa e l’ha trovata
coesa, ma ha sbagliato soprattutto a non considerare coraggio eroismo del popolo
ucraino», continua Guerini.
Il presidente del
Copasir cita le parole di Sergio Mattarella: «Una pace per essere chiamata tale
deve ristabilire la verità, il diritto internazionale e la sovranità». Poi si
rivolge ai connazionali: «Capisco che un anno di guerra porti a essere stanchi,
a sperare che tutto possa finire presto, ma se guardiamo negli occhi chi sta
combattendo, capiamo che per chi sta resistendo la stanchezza non ci può essere.
Se si ferma l’Ucraina non c’è più l’Ucraina, se si ferma Putin non c’è più la
guerra».
«Dobbiamo essere
cauti prima di dire che la Russia sta perdendo anche la guerra della
disinformazione», ammonisce la giornalista ucraina Olga Tokariuk, fellow al
Reuters Institute. «Possiamo dire con certezza che la propaganda russa funziona
molto bene dentro la Russia. Nei russi che hanno lasciato il Paese non notiamo
un grande movimento di protesta. Non abbiamo visto crepe nella società ucraina.
Certamente la Russia continuerà invece a cercare di fermare il sostegno che
arriva dai Paesi liberi sul piano politico, militare e finanziario. In alcuni
Stati, Italia inclusa, vediamo il manifestarsi di questi tentativi».
Il copione della
macchina del Cremlino è quello noto: accuse di corruzione al governo di
Volodymyr Zelensky, la balla che sia inutile armare «perché tanto Kyjiv perderà
la guerra». Secondo la studiosa, le operazioni di disinformazioni potrebbero
intensificarsi nei prossimi mesi. Nel Sud globale, le offensive mistificatorie
di Mosca riescono ad attecchire più che in Occidente.
«La cosa più
importante dei nostri progetti è stato dare una voce, ma anche un volto agli
ucraini – spiega la nostra Yaryna Grusha Possamai, scrittrice, docente di lingua
e letteratura ucraina, curatrice di Slava Evropi –. Finalmente in Italia gli
ucraini hanno cominciato a parlare per se stessi. È stato un anno in cui non
siamo più esistiti noi, ma è esistito qualcosa di più grande di noi, la Storia
che si è rimessa in moto. Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina è stata messa sulla
mappa dell’Europa, dove in realtà era sempre stata. Formalmente inizia il
secondo anno, ma noi stiamo ancora vivendo la mattina brusca del 24 febbraio
2022».
«Quando abbiamo
chiesto alla polizia di Milano l’autorizzazione per venire ogni sera a
manifestare, loro non ci credevano. Dopo un anno noi ancora siamo lì. Ci sono
persone che ogni sera portano in metro la cassa grande lì in piazza», testimonia
Viktoriia Lapa, del network UaMi nonché lecturer dell’Università Bocconi.
«Adesso la nostra bandiera è diventata quella della libertà, con noi vengono
anche tanti iraniani».
«Paghiamo un prezzo
molto alto per la guerra: purtroppo non si può calcolare in soldi, ma in vite
umane. Per tanti di noi ucraini questa è diventata una guerra personale –
conclude Artem Zaitsev, rappresentante di UaMi –. Ho perso il fratello in
guerra, aveva trentasette anni. Non era un militare di professione, ma se la
sentiva di arruolarsi e andare a difendere l’Ucraina. Si è arruolato nei primi
giorni ed era distaccato in Donbas, nei pressi di Bakhmut». Poi mostra le foto
sul telefono. «Credo che la Storia possa rimettere tutto a posto. La luce
vincerà sulle tenebre».
Pregiudizio
antiamericano. Il pacifismo italiano è destinato a perdersi nei meandri
dell’ideologia.
Mario Lavia su L’Inchiesta il 25 febbraio 2023.
Il flop della marcia
notturna Perugia-Assisi è l’ennesima conferma che chi ancora non ha il coraggio
di condannare l’aggressione di Putin è ancorato a quell’odio per Washington,
quindi per il mondo libero, che in questi mesi è diventato sempre più ridicolo
La manifestazione
notturna Perugia-Assisi che si è svolta appunto nelle ore tra giovedì e venerdì
non è stata molto partecipata, non se n’è parlato, non ha suscitato l’attenzione
dei media né dei partiti. L’animatore della marcia Flavio Lotti ha molto
duramente criticato l’assenza della politica da questo appuntamento per la pace.
Non diremo che l’insuccesso sia dovuto alla genericità della piattaforma nella
quale, ancora una volta, non si dice l’unica cosa chiara che andrebbe detta –
Putin go home – e che inevitabilmente trasmette l’idea di una equidistanza tra
aggressore e aggredito: non diremo questo ma il mezzo flop umbro fa venire il
dubbio che questo tipo di pacifismo generico non sia in sintonia con questa
preciso momento della guerra.
È andato meglio
invece l’appuntamento di ieri pomeriggio sotto l’ambasciata russa, chiarissimo
nel suo messaggio di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, lì un po’ di
politica c’era (Partito democratico, Terzo Polo, radicali).
La questione è che
la fase è cambiata. Di quale pace parlano i pacifisti? Non c’è nessuno tra loro
che in questo lunghissimo anno abbia saputo indicare concretamente una soluzione
di pace che non fosse troppo dissimile dalle banalità contenute nel cosiddetto
“Piano” della Cina. Forse sta anche in questa incapacità una radice psicologica
alla base dell’antiamericanismo di sinistra e di quello di matrice cattolica – i
due grandi fiumi della cultura politica di questo Paese nei quali scorre più o
meno esplicitamente l’idea che alla fine se la pace non si fa è per colpa degli
americani. Gira gira, il pacifismo cattolico finisce sempre lì.
Un esempio? In un
momento delicatissimo come questo, Joe Biden è andato ad abbracciare Volodymir
Zelensky con un gesto più potente di cento carri armati, ed è andato poi a
Varsavia perché sa che la Polonia è un bastione essenziale per scoraggiare il
neoimperialismo di Mosca: un viaggio europeo di gigantesco valore che però ha
fatto storcere il naso a un grande leader democratico come Romano Prodi, che ha
chiesto perché il presidente americano fosse andato a Varsavia e non a
Bruxelles.
Neanche a farlo
apposta glielo ha indirettamente spiegato Marco Minniti, intervistato da
Huffington Post: «Con l’aumento delle spese militari al quattro per cento del
Pil la Polonia diventerà nei prossimi anni una delle potenze più forti
nell’ambito dell’Alleanza atlantica». Ecco perché Biden è andato nella capitale
polacca, a Bruxelles che avrebbe concluso? Ma non c’è niente da fare. Per Prodi,
Biden lavora a dividere l’Europa. Alimenta la contrapposizione con la Cina.
Insomma, il giudizio sugli Stati Uniti è sempre ammantato da un’incancellabile
coltre di sospetto anche se la Casa Bianca oggi è oggettivamente la
postazione-chiave dal punto di vista politico della guerra di liberazione
ucraina. Ma il senso comune è antiamericano.
Ora, se è facilmente
spiegabile la voglia di pace rilevata dai sondaggi, magari corroborata da
qualunquismi di vario tipo («se la sbrighino tra di loro»), assume davvero un
gran rilievo il problema culturale ancora prima che politico del pregiudizio
antiamericano dei cattolici democratici italiani, allevati d’altra parte al
dossettismo filosoficamente distante se non ostile al mondo nuovo e sempre
timoroso dell’egemonia americana: facendo così oltre tutto il gioco di chi
lavora per separare le due sponde dell’Atlantico, cioè i nemici della democrazia
e della pace.
Il pacifismo
italiano dunque rischia di perdersi nei meandri dell’ideologia e dei pregiudizi,
e di pesare sempre meno. Forse è venuta l’ora di scegliere con più coraggio,
soprattutto per il mondo cattolico democratico che forse attende un gesto forte
da papa Francesco (un viaggio a Kijiv?) per mettersi in cammino dalla parte
giusta.
Russlandvesteher.
Come la disinformazione del Cremlino ha inquinato il dibattito pubblico italiano
sull’Ucraina.
Maurizio Stefanini su L’Inchiesta il 25 febbraio 2023.
La propaganda russa
ha contribuito a rafforzare sia il rossobrunismo, storicamente vicino a Mosca,
sia chi ammira Putin come leader politico e magari ne riconosce un ruolo
nell’aggressione ma non fa nulla per condannarlo (come Giuseppe Conte)
«Con l’invasione su
larga scala del 24 febbraio 2022 molte chat Telegram, sorte all’epoca del Covid
per negare l’esistenza del virus e l’inutilità dei vaccini, si convertiranno da
chat No-Vax in chat pro-Putin». Così, tra le altre cose, attesta “Dezinformacija
e misure attive: Le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italia”, un research
paper a firma Massimiliano Di Pasquale e Luigi Sergio Germani che l’Istituto
Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici rende noto nel primo
anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, e che abbiamo avuto modo di
vedere in anteprima.
«Questo studio non
intende in alcun modo affermare che le persone, le organizzazioni e i media
italiani citati abbiano delle connessioni con la Federazione Russa o con attori
governativi o non-governativi al suo interno», viene subito chiarito.
A parte alcune cose
alla luce del sole, come il famigerato accordo tra la Lega e il partito
putiniano Russia Unita, per attestare cose del genere, probabilmente, ci vorrà
un nuovo Mitrokhin di un auspicabile dopo Vladimir Putin.
Resta tuttavia la
constatazione di una certa presenza di parole d’ordine e interpretazioni che
sono quelle volute da Putin. E ciò è facilmente attestabile. A partire
dall’insistenza di Silvio Berlusconi sul fatto che non sarebbe stato l’attacco
di Putin all’Ucraina a scatenare la guerra, ma un attacco di Volodymyr Zelensky
al Donbas.
In particolare, lo
studio «si occupa delle narrazioni strategiche filo-Cremlino relative alla
guerra in Ucraina diffuse in Italia da media russi attivi nel nostro Paese e
amplificati da media e influencer italiani. Analizza l’evoluzione di tali
narrazioni nell’arco temporale che va dal 24 febbraio 2022 – data di inizio
dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, ribattezzata da Putin
«Operazione Militare Speciale» – al gennaio 2023, mettendole in relazione agli
eventi più rilevanti legati all’aggressione russa in Ucraina (i massacri di
Bucha, le sanzioni alla Russia, la crisi alimentare e del grano, i “referendum”
di Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, ecc)».
Gli obiettivi
manipolatori di fondo delle narrazioni strategiche filo-Cremlino sulla guerra
sono «confondere l’opinione pubblica italiana circa le cause e l’andamento della
guerra in Ucraina, offuscare la verità sulla natura espansionista e
neo-imperiale della politica estera russa, indurre l’opinione pubblica e i
decisori politici ad abbandonare l’orientamento atlantista ed europeista della
politica estera italiana, ed erodere la fiducia dell’opinione pubblica nei
valori e nelle istituzioni della democrazia liberale».
L’obiettivo è
«comprendere meglio il perché molti miti disinformativi sulla guerra, divulgate
dall’ecosistema di disinformazione e propaganda filo-Cremlino, continuano a
esercitare una influenza notevole sui dibattiti politici, mediatici e culturali
italiani» e anche proporre «alcune linee-guida di una strategia culturale per
difendere efficacemente il sistema-Italia dalle operazioni di disinformazione e
propaganda promosse da potenze straniere autocratiche per influenzare settori
significativi della società italiana in funzione dei propri interessi
geopolitici».
Le grandi potenze
autocratiche del mondo non-occidentale, si ricorda, «ricorrono sistematicamente
alla guerra cognitiva sia all’interno (per controllare le proprie popolazioni)
sia all’estero, per tentare di influenzare e destabilizzare le democrazie
occidentali tramite la diffusione massiccia di narrazioni strategiche false o
fuorvianti».
Come definizione,
«una narrazione strategica è un mezzo di cui si avvale un attore politico per
costruire un significato condiviso del passato, del presente e del futuro delle
relazioni internazionali al fine di plasmare le opinioni e condizionare i
comportamenti di attori all’interno e all’estero», per creare una percezione
distorta della realtà, nell’opinione pubblica e nei decisori politici dei
Paesi-bersaglio, per favorire gli interessi geopolitici dello Stato aggressore.
«Uno degli attori geopolitici che praticano la guerra cognitiva con maggiore
intensità e sistematicità a livello globale», si ricorda, «è la Russia di
Vladimir Putin, che ha elaborato una strategia di “guerra non-lineare” tesa a
indebolire e sconfiggere l’avversario destabilizzandolo dall’interno tramite la
disinformazione, la propaganda e altre tecniche sovversive, come il sostegno
occulto a partiti politici anti-sistema, movimenti eversivi, e gruppi violenti
di matrice etnico-separatista”. In ciò, ereditando la tradizione sovietica delle
misure attive, ma integrandola con le nuove potenzialità offerte dal cyberspazio
per la manipolazione delle percezioni.
L’aggressività di
queste misure verso l’Occidente aumenta a partire dal 2012, e ha un’ulteriore
scalata rispetto all’Euromaidan. Obiettivi sono proteggere la sicurezza e la
stabilità del regime di Putin nei confronti di possibili rivoluzioni e rivolte
interne, ristabilire una sfera di influenza e di controllo di Mosca nell’Europa
orientale e altri paesi post-sovietici, riacquisire lo status di grande potenza
mondiale, assicurare a Mosca un ruolo indispensabile nella risoluzione di
qualunque crisi internazionale, erodere sempre di più il potere e l’influenza
degli Stati Uniti e dell’Occidente a livello globale, indebolire ed
eventualmente disgregare la Nato e l’Unione europea, screditare e destabilizzare
i sistemi liberal-democratici.
Lo strumento è un
vero e proprio «ecosistema di disinformazione e propaganda filo-Cremlino tramite
il quale vengono create e diffuse, a livello globale e tramite canali
molteplici, narrazioni strategiche che favoriscono gli interessi geopolitici di
Mosca». Strumenti ne sono in primo luogo le comunicazioni ufficiali del governo
russo e dichiarazioni di esponenti politici e istituzionali russi.
Poi ci sono media
palesemente finanziati dal Cremlino e rivolti verso il pubblico interno (la
popolazione russa) oppure verso pubblici di destinazione di Paesi esteri (Pervyy
Kanal, Rossiya 24, TV Zvezda, RIA-Novosti, RT, Sputnik).
Numero tre, siti
Internet rivolti a un pubblico internazionale che si presentano come fonti
indipendenti di informazione e analisi geopolitica ma che in realtà sono o
strettamente collegati con i servizi d’intelligence russi, come The Strategic
Culture Foundation, New Eastern Outlook, News Front, South Front, Brics,
Info-Ros; oppure sono finanziati da oligarchi vicini al Cremlino, come
Geopolitica.ru e Kathehon).
Numero quattro:
«Media di “informazione alternativa” e influencer in tutti i paesi-bersaglio
che, consapevolmente o inconsapevolmente (e in molti casi per convinzione
autentica), diffondono sistematicamente messaggi che amplificano le narrazioni
strategiche filo-Cremlino. Tra questi influencer, spesso bene inseriti nei media
mainstream o nel mondo politico del proprio Paese, vi possono essere anche
agenti di influenza reclutati dai servizi d’intelligence russi».
Numero cinque:
«campagne di disinformazione e propaganda sul web condotte tramite Bot e falsi
profili sui social media». Numero sei: «operazioni di aggressione cibernetica
per sottrarre dati politici sensibili che poi vengono diffusi – spesso dopo
essere stati manipolati – all’opinione pubblica per orientarne gli atteggiamenti
(cyber-enabled disinformation operations)».
Sin dai tempi della
Guerra Fredda, e anche per la Russia di Vladimir Putin, l’Italia rappresenta un
bersaglio importante delle misure attive di Mosca, per essere un Paese pilastro
della Nato e dell’Unione Europea nel Mediterraneo, percepito però come un anello
debole. «Un Paese che ha diverse vulnerabilità da sfruttare per accrescere
l’influenza russa, tra cui: la diffidenza o ostilità nei confronti della Nato,
degli Stati Uniti e dell’Unione Europea che caratterizza ampi settori della
società; l’ingenuità riguardante la politica interna ed estera della Russia
molto diffusa presso le élite politico-amministrativa e intellettuale italiana;
la scarsa conoscenza ed expertise analitica sulla Russia e la regione
post-sovietica nel mondo accademico e dei think tank italiani; la presenza di
influenti lobby politiche ed economiche filo- Cremlino; un deficit di cultura
della sicurezza nazionale che contraddistingue, a parte alcune notevoli
eccezioni, il mondo politico italiano».
Per questo, da
almeno dieci o quindici anni l’ecosistema di disinformazione e propaganda
filo-Cremlino si è messo a diffondere nello spazio informativo italiano
molteplici narrazioni strategiche finalizzate a confondere l’opinione pubblica
circa gli obiettivi e gli strumenti della politica estera russa, nonché a minare
l’orientamento atlantista ed europeista dell’Italia e i suoi valori democratici.
Di conseguenza,
«l’Italia è attualmente tra i Paesi occidentali più condizionati dalle
narrazioni strategiche filo-Cremlino. Persino dopo l’invasione russa
dell’Ucraina, che in Italia ha suscitato forti condanne del regime di Putin, le
narrazioni filo-Cremlino, spesso divulgate da esperti e commentatori mainstream,
continuano a esercitare una notevole influenza sui dibattiti politici, mediatici
e culturali italiani».
Alla storica eredità
filo-russa del Pci dagli anni Novanta si è aggiunto il fenomeno del
rossobrunismo. «Una sintesi ideologica di fascismo e social-comunismo,
caratterizzata da estremo nazionalismo e “sovranismo”, lotta alla
globalizzazione e al capitalismo, anti-americanismo, ostilità nei confronti
dell’Unione Europea, tradizionalismo e critica radicale alla “decadenza” delle
società liberal-democratiche dell’Occidente. L’area rossobruna ben presto avvia
una intensa collaborazione con intellettuali e politici ultranazionalisti russi,
tra cui il filosofo e geopolitico neo-Eurasista Aleksandr Dugin, che dopo il
collasso del sistema sovietico si reca con frequenza nel nostro Paese,
diventando un punto di riferimento per la destra radicale e la nascente galassia
rossobruna».
Dopo l’ascesa di
Vladimir Putin nel 1999, e soprattutto dopo la svolta del Cremlino nella seconda
metà degli anni 2000 verso una politica estera più assertiva, nazionalista e di
contrapposizione all’Occidente, la galassia rossobruna cresce e acquisisce un
profilo sempre più marcatamente filo-russo e putiniano. «Il rossobrunismo
diventa un fenomeno politicamente rilevante a partire dal 2012-13, e le idee di
quest’area entrano nei dibattici politici e mediatici mainstream, grazie
all’onda populista-sovranista che allora sconvolge il sistema politico
italiano». Allo stesso tempo, a partire dalla seconda metà degli anni Duemila si
afferma in Italia un’altra scuola di pensiero filo-russo, più pragmatica e
moderata: quella degli intellettuali e politici Russlandvesteher, termine
tedesco per indicare «chi mostra comprensione per la Russia»: è gente che non
considera Putin un modello politico, ma sicuramente un importante partner
strategico e economico, che le cui ragioni bisogna tenere presenti.
Le misure attive di
Mosca in Italia nell’era Putin mirano a rafforzare sia il rossobrunismo sia la
corrente Russlandvesteher. A differenza dei rossobruni,
i Russlandvesteher italiani non attaccano l’Occidente, la Nato e l’Unione
europea, ma ammirano Putin come leader politico e statista. «Quando scoppia la
crisi ucraina nel 2013-2014 l’orientamento Russlandvesteher occupa già una
posizione dominante nel mondo accademico e nella comunità di esperti di politica
estera in Italia». Motivo per cui in tanti un anno fa considerano «impossibile»
l’attacco russo.
Dall’inizio del
conflitto nel 2014, tante sono state le narrazioni strategiche utilizzate dal
Cremlino per indebolire e destabilizzare l’Ucraina, e per confondere le opinioni
pubbliche in Occidente circa gli obiettivi e gli strumenti della politica estera
russa in Ucraina.
Tra le principali:
1) Euromaidan, ossia
la rivoluzione di piazza dell’inverno 2013-2014, dipinta come un colpo di stato
nazista sostenuto dagli Stati Uniti;
2) L’annessione
illegale della Crimea definita un «regolare referendum con cui i residenti della
Crimea hanno deciso di ricongiungersi alla Russia attraverso una procedura
democratica» (e accreditata da molti amministratori locali e osservatori di area
Lega e Forza Italia);
3) La tesi secondo
cui la Nato si fosse impegnata politicamente e giuridicamente a non estendere
l’alleanza oltre i confini della Germania riunificata, circostanza smentita più
volte anche dallo stesso Gorbaciov;
4) La tesi secondo
cui l’aereo malaysiano Boeing-777, che stava effettuando il volo MH17 da
Amsterdam a Kuala Lumpur precipitato vicino a Donetsk fosse stato abbattuto da
un territorio controllato dall’esercito ucraino;
5) La presunta non
partecipazione della Russia al conflitto armato nel Donbas e l’idea che Mosca
non fornisse ai rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e
Luhansk alcun supporto materiale o tecnico;
6) La presunta
proclamazione dell’indipendenza delle Repubblica Popolari di Donetsk e Lugansk,
che sarebbe avvenuta dopo il colpo di stato a Kyjiv;
7) La tesi secondo
cui in Ucraina fosse in corso una guerra civile anziché una vera e propria
aggressione militare russa a uno Stato sovrano.
Torna al punto da
cui siamo partiti, per circa un anno, dal marzo 2020 all’aprile 2021, la guerra
in Ucraina, definibile all’epoca come un conflitto a intensità medio bassa,
passa apparentemente in secondo piano nelle narrazioni strategiche del Cremlino,
e viene soppiantata da messaggi disinformativi e propagandistici legati alla
pandemia da Covid-19 e alla presunta superiorità del vaccino russo Sputnik
rispetto a quelli occidentali.
Vari giornali
italiani osservano subito come tanti gruppi «dormienti» dopo l’invasione abbiano
spostato il focus di discussione dalla pandemia al conflitto bellico in Ucraina.
«Basta Dittatura», ad esempio, è il nome di una chat con quasi centomila utenti
dove si parlato del bambino morto a Kyjiv durante gli scontri. «Di bambini
purtroppo ne moriranno tanti», scrivono, «perché il regime di Kyjiv, pilotato
dalla Nato e finanziato da Soros, non pare intenzionato a cercare una tregua. Ma
ora il condizionale è d’obbligo». Per loro, il bimbo mostrato da tutti i Tg del
mondo non è reale e la foto scattata «in posa». Un altro con il nick “Giù la
mascherina” scrive che «i giornalisti sono con casco e giubbotto antiproiettile,
l’abito ufficiale della “modalità guerra”, proprio come quando sono con le
mascherine, mentre dietro i cittadini ucraini serenamente fanno la coda
all’ufficio postale».
The Vision, in un
articolo del 31 marzo 2022, farà appunto notare come in un batter d’occhio i
No-Vax si siano trasformati in sostenitori di Putin e della sua aggressione in
Ucraina, sollevando anche legittimi sospetti su chi abbia davvero alimentato e
sobillato la galassia negazionista negli ultimi due anni di pandemia e come le
loro motivazioni a sostegno della causa di Putin siano la denazificazione
dell’Ucraina, l’espansione della Nato a Est e il presunto “genocidio” degli
abitanti russofoni del Donbas.
Questi canali dunque
iniziano a diffondere un tipo di messaggi che erano stati anticipati da Sputnik,
outlet creato nel 2013 mediante decreto presidenziale al fine di «comunicare la
politica statale della Russia all’estero», e che il sito EUvsDisinfo riassume
così: «La Nato inonda l’Ucraina di armi moderne per spingere Kyjiv a una
soluzione militare nel Donbas; i nazionalisti ucraini non lasciano evacuare i
civili e li usano come scudi umani; Kyijv sta attuando una politica genocida nei
confronti della popolazione del Donbas; la liberazione russa di Lysychansk e
Severodonetsk pone fine a discriminazioni e abusi da parte della giunta nazista
di Kyjiv; in Ucraina, nel febbraio 2014, c’è stato un colpo di Stato orchestrato
dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea; gli attacchi ucraini con droni kamikaze
all’impianto di Zaporizhzhia dimostrano che gli Stati Uniti non accettano la
sconfitta; le forze armate ucraine hanno bombardato il luogo di incontro della
missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e la centrale
nucleare di Zaporizhzhia; le sanzioni imposte da Washington e Bruxelles spingono
l’Italia al suicidio economico; l’esercito ucraino attacca con l’artiglieria le
aree civili di Donetsk da otto anni: gli abitanti del Donbas, di Zaporizhzhia e
Kherson vogliono unirsi liberamente alla Russia; solo il cinque per cento del
grano che l’Occidente esporta dall’Ucraina va ai paesi più poveri; l’Ucraina
vuole far saltare la diga di Kakhovka per bloccare la fornitura di acqua alla
Crimea; Kyjiv farà esplodere una “bomba sporca” per accusare la Russia;
l’Ucraina è il principale focolaio di neonazismo al mondo; la tempestiva
sentenza di un tribunale olandese che attesta la responsabilità dei separatisti
del Donbas e dei servizi segreti russi nell’abbattimento dell’aereo della
Malaysia Airlines nel 2014 è un’arma di distrazione di massa per far dimenticare
che Zelensky, per non essere detronizzato, ha lanciato missili contro la Polonia
e portato il mondo sull’orlo di una guerra mondiale; i russi si sono ritirati da
Kherson perché l’Ucraina vuole far saltare la diga di Kakhovka; la proposta di
Borrell sulla crisi ucraina del 2014 dimostra che il colpo di Stato in Ucraina è
stato creato artificialmente come copertura ideologica per il contenimento
politico, economico, tecnologico e umanitario della Russia; Kyjiv cerca
un’escalation del conflitto, come dimostra l’esecuzione di prigionieri di guerra
russi da parte dell’esercito ucraino. Tutto ciò dimostra che gli Stati Uniti
hanno un controllo totale sull’Ucraina; gli accordi di Minsk sono stati un
tentativo di guadagnare tempo per l’Ucraina; Francia e Germania hanno mentito
sulla loro volontà di porre fine al conflitto nel Donbas, volevano solo riempire
l’Ucraina di armi e prepararla al combattimento; la tragedia del rogo di Odessa
è stata un’azione premeditata dai neonazisti ucraini; il conflitto in Ucraina è
iniziato nel 2014 a seguito della decisione degli Stati Uniti di armare
l’Ucraina; Kyjiv perseguita la Chiesa ortodossa ucraina; ci sono gli Stati Uniti
dietro il colpo di Stato nazista ucraino del 2014 che ha portato a una
sanguinosa guerra civile; i neonazisti ucraini commettono crimini contro la
popolazione indifesa, fanno pulizia etnica, compiono azioni punitive. È proprio
contro questo male [Olocausto] che i soldati russi combattono coraggiosamente».
Il rapporto fa su
queste asserzioni un lavoro di debunking, simile quello che ha peraltro fatto
anche l’autore di queste note. Rossobrunismo a parte, si può osservare come
effettivamente l’invasione dell’Ucraina abbia fatto ricredere
molti Russlandvesteher: a partire dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia
Meloni, che ha cancellato dai social sue prese di posizione filo-Putin del
passato.
Ma in qualche caso
invece si è arrivati a posizioni che nel caso delle narrazioni sull’uccisione
dei civili a Bucha sono arrivate a livelli da negazionismo sulle camere a gas.
Più in generale, il Russlandvesteher medio ha oggi il tipo di posizione espresso
da Giuseppe Conte. Sì, Putin è l’aggressore, ma le sanzioni non servono, la
guerra non va alimentata, e alla fine se non è detto espressamente viene
sottinteso a questo povero Putin bisognerà pure lasciare qualcosa, per non farlo
rimanere male.
La Repubblica.
Gli ultimi
aggiornamenti dalla crisi Russia-Ucraina. Der Spiegel, "Droni kamikaze cinesi
alla Russia". Usa pronti a mostrare le informazioni sul possibile invio di armi
cinesi a Mosca. Blinken annuncia nuove sanzioni. Nato: "Rafforzare difesa della
Moldavia". Zelensky: "I negoziati ci saranno, serve un vertice di pace. Prevedo
incontro con presidente cinese Xi". Zelensky: "Serve un vertice di pace"
Punti chiave
18:50
Zelensky, prevedo
incontro con presidente cinese Xi
13:40
Moldavia: "Nessuna
minaccia diretta dall'Ucraina alla Transnistria"
13:35
Mosca: "Kiev ammassa
truppe al confine con la Transnistria"
12:21
Ue: "Proposta di
pace cinese non distingue vittime da aggressori"
11:50
Cina: "Droni alla
Russia? Troppe falsità su di noi"
11:26
Stoltenberg:
"Rafforzare sistema difesa della Moldavia"
11:04
G7: "Oggi lanceremo
un appello affinché nessuno sostenga militarmente Mosca"
10:26
Il tweet di Biden:
"Putin credeva di spaccare la Nato, mai così forti"
09:19
Zelensky parla ai
soldati: "L'Ucraina è viva, orgogliosi di voi"
08:32
L'ambasciatore
europeo in Cina: "Non è un documento di pace, ma un insieme di punti di vista.
Però studieremo documento della Cina"
08:27
Kiev, 'documento
Cina buon segnale'
06:48
Zelensky, 2023 sarà
anno nostra vittoria
02:48
Cina, "intavolare
negoziati, no a minaccia nucleare"
02:24
Usa, alle 15 meeting
virtuale del G7 con Zelensky
00:13
Von der Leyen: "141
Paesi all'Onu con Kiev. Russia fermi guerra di aggressione"
"141 paesi hanno
chiesto il ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale
dell'Ucraina. Un anno dopo, la comunità internazionale è forte con l'Ucraina. La
richiesta è chiara: la Russia deve porre fine alla sua guerra di aggressione".
Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
02:24
Usa, alle 15 meeting
virtuale del G7 con Zelensky
Joe Biden avrà un
incontro virtuale con i leader del G7 e il presidente Volodymyr Zelensky domani
alle 9 ora locale, le 15 in Italia, in occasione del primo anniversario
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce la Casa Bianca
in una nota.
02:33
Usa, "con G7
impegnati a continuare a sostenere l'Ucraina. E a far pagare alla Russia i costi
della guerra"
Joe Biden e gli
altri leader del G7 ribadiranno l'impegno a "continuare a coordinare gli sforzi
per sostenere l'Ucraina e far pagare alla Russia i costi di questa guerra",
nell'incontro virtuale che si terrà alle 9 ora locale, le 15 in Italia, in
occasione del primo anniversario dell'invasione. Lo riferisce la Casa Bianca in
una nota.
02:48
Cina, "intavolare
negoziati, no a minaccia nucleare"
La Cina rivolge un
appello a Russia e Ucraina affinchè intavolino al più presto i negoziati di
pace, auspicando che il ricorso alle armi nucleari non abbia corso nel
conflitto. "Tutte le parti devono sostenere la Russia e l'Ucraina per lavorare
nella stessa direzione e riprendere un dialogo diretto il più rapidamente
possibile" ha affermato il Ministero degli Esteri cinese, sottolineando che "le
armi atomiche non devono essere impiegate e guerre nucleari non devono essere
combattute"
03:38
La Cina sollecita
cessate fuoco e stop attacchi a siti civili
La Cina sollecita
il cessate il fuoco e la fine dei combattimenti in Ucraina perché la guerra "non
prevede vincitori", invitando "a mantenere razionalità e moderazione", ad
evitare che la crisi si aggravi o vada fuori controllo e "a sostenere Russia e
Ucraina affinché si incontrino" e riprendano "il dialogo diretto non appena
possibile". Nel preannunciato documento di soluzione della crisi ucraina,
strutturato in 12 punti e diffuso dal ministero degli Esteri, c'è anche l'invito
"ad astenersi dall'attaccare civili e strutture civili".
03:38
Usa, Sullivan
annuncia altri due miliardi di sostegno all'Ucraina
05:50
Der Spiegel, "Droni
kamikaze cinesi alla Russia"
L'esercito russo è
impegnato in trattative con la cinese Xìan Bingo Intelligent Aviation Technology
per la produzione di massa di droni kamikaze alle sue forze armate. E' quanto
riporta Der Spiegel, secondo cui la vicenda crea una nuova urgenza nel dibattito
sul possibile sostegno militare cinese alla Russia.
Bingo, in base alle
informazioni raccolte dalla testata tedesca, ha accettato di produrre e testare
100 prototipi di droni ZT-180 prima di consegnarli alla Difesa russa entro
aprile 2023. Gli esperti militari ritengono che lo ZT-180 sia in grado di
trasportare una testata da 35 a 50 chilogrammi.
06:48
Zelensky, 2023 sarà
anno nostra vittoria
"Il 24 febbraio
milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e
gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di
dolore, tristezza, fede e unità. E quest'anno siamo rimasti invincibili.
Sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria". Lo scrive su Twitter il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un video con le immagini del
conflitto a un anno di distanza dal suo inizio.
07:27
Prigozhin: "Wagner
ha controllo villaggio Berkhovk"
Yevgeny Prigozhin,
il leader del gruppo paramilitare Wagner, ha dichiarato di aver preso il
controllo del villaggio di Berkhovka in quella che i russi chiamano la
Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), vicino a Bakhmut. "Le unità del PMC Wagner
hanno il pieno controllo di Berkhovka", ha dichiarato.
08:27
Kiev, 'documento
Cina buon segnale'
L'Ucraina ha fatto
conoscere una prima reazione al documento che esprime ufficialmente la
posizione di Pechino sulla guerra, definendola "un buon segnale e un segno che
la Cina vuole essere coinvolta negli sforzi globali per mettere fine al
conflitto ucraino". Questo è quanto ha dichiarato l'incaricata d'affari
dell'ambasciata Ucraina nella capitale cinese, Leshchynska Zhanna. "All'Ucraina
piacerebbe vedere la Cina dalla sua parte", anche se "al momento non sta
appoggiando gli sforzi ucraini".
Zelensky finora ha
detto di non essere ancora a conoscenza dei dettagli del piano cinese, ma di
considerare il fatto che Pechino sia intervenuta "un fatto non negativo".
08:32
L'ambasciatore
europeo in Cina: "Non è un documento di pace, ma un insieme di punti di vista.
Però studieremo documento della Cina"
La Cina ha
rilasciato "un documento di posizione, non una proposta di pace, e l'Ue lo
studierà. Se il documento di posizione è un segnale positivo per l'Ucraina,
allora lo è per l'Unone, anche se lo stiamo studiando attentamente". È il
commento dell'ambasciatore europeo in Cina, Jorge Toledo, in merito alla
'Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina', il
documento rilasciato oggi da Pechino che si profila come un insieme di punti di
vista per raggiungere la de-escalation
09:00
Il segretario alla
Difesa britannico Wallace: "Se la Cina dà armi alla Russia non aiuta a risolvere
il conflitto"
Il segretario alla
Difesa britannico Ben Wallace ha detto che l'idea che la Cina possa fornire armi
per sostenere l'invasione russa dell'Ucraina non aiuterebbe a risolvere il
conflitto, un risultato che era fiducioso che la Cina volesse. "Non può aiutare
la pace se la Cina rifornisce effettivamente l'unica nazione che ha infranto la
legge internazionale sulla sovranità dell'Ucraina e ha inflitto crimini di
guerra", ha detto quando gli è stato chiesto dei rapporti che la Cina potrebbe
fornire armi alla Russia
09:04
Nato, sforzi Russia
stanno fallendo, restiamo con Ucraina
"Gli sforzi della
Russia per infrangere la determinazione del coraggioso popolo ucraino stanno
fallendo. Un anno dopo, gli ucraini stanno combattendo valorosamente per la
libertà e l'indipendenza. Siamo con loro".
Lo afferma il
Consiglio Nord Atlantico in una dichiarazione a un anno dall'inizio della guerra
in Ucraina.
09:09
Scholz, "Putin può
mettere fine alla guerra"
"La situazione è
nelle mani di Putin. Lui può mettere fine a questa guerra". Lo ha detto il
cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio video settimanale dedicato
all'anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina, pubblicato in rete
con i sottotitoli in ucraino. Non è la consegna delle armi occidentali a Kiev a
prolungare la guerra, ha continuato, "è vero il contrario: quanto prima il
presidente della Russia capisce che non raggiungerà i suoi obiettivi
imperialistici, tanto maggiore sarà la chance di una veloce conclusione della
guerra".
09:11
Macron, Francia
solidale con Kiev, "pace e vittoria"
Il presidente
francese Emmanuel Macron ha inviato un messaggio di solidarietà agli ucraini
dopo un anno di guerra, auspicando la "vittoria e la pace". "Ucraine, ucraini,
la Francia è al vostro fianco. Alla solidarietà, alla vittoria e alla pace", ha
scritto in un messaggio postato sul suo profilo Twitter in ucraino e inglese.
L'Eliseo ha invece pubblicato una foto notturna delle bandiere sventolanti e
illuminate davanti alla sede della presidenza francese, Faubourg St Honorè a
Parigi: al centro, fra il tricolore francese e la bandiera blu stellata
dell'Unione europea, quella ucraina bicolore giallo oro-blu. Emmanuel Macron era
stato invitato a Kiev in questi giorni dell'anniversario, come il presidente Usa
Joe Biden, l'italiana Giorgia Meloni e il premier spagnolo Pedro Sánchez, ma ha
preferito rinviare la visita a un momento meno simbolico e più sostanziale,
secondo quanto apprende la stampa francese dalle fonti diplomatiche.
09:15
Zelensky commemora
gli "eroi", un minuto di silenzio per le vittime
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky sta tenendo un discorso per celebrare un anno della
guerra, nella piazza Santa Sofia di Kiev, e ha chiesto un minuto di silenzio per
commemorare "gli eroi" che combattono per resistere all'invasione russa. "Gloria
a tutti quelli che stanno combattendo adesso", ha affermato. "Il vostro sforzo
rende più vicina la vittoria, e decide se l'Ucraina esisterà", ha detto.
09:19
Zelensky parla ai
soldati: "L'Ucraina è viva, orgogliosi di voi"
"Oggi dopo un anno
di guerra decisiva per l'indipendenza ucraina, oggi in questo posto valoroso",
"voglio dire a tutti voi, a tutti quelli che combattono per l'Ucraina e a chi
vive con l'Ucraina nel cuore, voglio dire che sono orgoglioso di voi, noi tutti
siamo orgogliosi di ognuno, tutti quanti siamo orgogliosi di voi e che questo
orgoglio vada per le strade e le trincee, si diffonda per le piazze e le città,
si diffonda per i cuori e i Paesi esteri, parli a tutti. L'Ucraina è viva". Così
il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti ai soldati a Kiev in
piazza Santa Sofia.
09:21
Medvedev:
"Vinceremo, avanti fino a confine Polonia"
La Russia vincerà in
Ucraina, arrivando se necessario "fino al confine con la Polonia". Lo ha scritto
l'ex primo ministro e vicepresidente del Comitato di sicurezza della Federazione
russa Dmitrij Medvedev sul suo profilo Telegram. "Dobbiamo spingere il più
lontano possibile i confini delle minacce al nostro Paese, anche se questi sono
i confini della Polonia", ha scritto in un lungo messaggio nel giorno
dell'anniversario dell'inizio dell'"operazione militare speciale" russa in
Ucraina.
09:24
Usa, "non vogliamo
un conflitto con la Russia"
"Non vogliamo un
conflitto con la Russia, vogliamo solo che la Russia lasci l'Ucraina". Lo ha
detto il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland in un'intervista
all'agenzia russa Tass, rispondendo a una domanda sulla possibilità di una Terza
guerra mondiale.
09:42
Polonia installa
barriere anticarro al confine
La Polonia ha
installato al confine con Ucraina e Bielorussia, a est, barriere anti carro, ha
annunciato il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak. Gli ostacoli rientrano
nella strategia di difesa e deterrenza nazionale, ha precisato. Le prime
barriere sono già state dispiegate al confine con l'enclave russa di
Kaliningrad, più a nord.
09:49
Medvedev:
"Trattative dureranno anni"
Al termine di
quella che la Russia ha definito ''operazione militare speciale'' in Ucraina
''ci saranno trattative difficili e nervose'' e dureranno ''mesi, anni''. Lo
ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale
russo Dmitry Medvedev nel primo anniversario della guerra di Mosca a Kiev.
Secondo il fedelissimo di Putin ''le decisioni per il regime di Kiev,
ovviamente, non saranno prese da una specie di Zelensky, se è ancora vivo, o
dalla sua cricca. La decisione sarà presa oltreoceano da coloro che hanno in
mano la fornitura di armi a Kiev e lo stanziamento di denaro per mantenere ciò
che resta dell'economia Ucraina''. Secondo Medvedev ''i principali nemici del
nostro Paese'' vogliono ''indebolire il più possibile la Russia, dissanguarci a
lungo. Pertanto, non sono interessati a porre fine al conflitto. Prima o poi,
secondo le leggi storiche, lo faranno. E ci sarà un accordo. Naturalmente, senza
accordi fondamentali su confini reali o su un nuovo Patto di Helsinki che
garantisca la sicurezza in Europa. Solo una specie di accordo''. Quindi,
prosegue, ''inizierà un periodo non meno difficile. Mesi e anni estenuanti di
confronti, capricci e maleducazione da parte di chi gestirà ciò che resta
dell'Ucraina''. Ma ''questo non può essere permesso'' ed è per questo che è
molto ''importante raggiungere tutti gli obiettivi dell'operazione militare
speciale''.
10:01
Zelensky: "24
Febbraio, giorno più duro della Storia Moderna"
''Il 24 febbraio è
stato il giorno più duro della storia moderna''. Lo ha detto il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky incontrando alcuni militari a piazza Sofia a Kiev ai
quali ha consegnato medaglie al merito. ''Il fatto che siamo qui ora, che
stiamo svolgendo una commemorazione all'aperto'' in centro a Kiev, dimostra che
''finché l'Occidente continuerà a sostenere l'Ucraina, l'Ucraina alla fine
prevarrà'', ha aggiunto Zelensky.
10:09
Usa, gli Abrams non
arriveranno quest'anno
I carri armati
americani Abrams che Washington ha promesso a Kiev potrebbero non arrivare in
Ucraina quest'anno. Lo ha detto ai giornalisti il segretario dell'esercito
americano Christine Wormuth, come ha riferito DefenseNews.
10:14
Nuland: "Non
vogliamo conflitto con la Russia, pronti a negoziare sul trattato Start"
"Non vogliamo un
conflitto con la Russia, vogliamo solo che la Russia lasci l'Ucraina". Lo ha
detto il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland in un'intervista
all'agenzia russa Tass. Nuland ha anche aggiunto che gli Usa sono pronti a
riprendere "domani" i negoziati con la Federazione Russa sull'applicazione del
trattato New Start. Qualche giorno fa il presidente russo Vladimir Putin ha
annunciato la sospensione del trattato sottoscritto da Usa e Russia per la
limitazione delle armi nucleari.
10:16
Stoltenberg: "La
libertà non è gratis, bisogna battersi"
La vostra storia è
un forte promemoria che non possiamo dare la nostra libertà per scontata. La
libertà non è gratuita, dobbiamo batterci ogni giorno per la libertà. Oggi è il
popolo ucraino che sta coraggiosamente combattendo per la sua libertà. E
nonostante l'anno di distruzione la loro determinazione prevarrà". Lo ha
dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza
stampa a Tallin con la premier estone, Kaja Kallas, e la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen.
10:18
Von der Leyen: "Voto
Onu mostra una Russia sempre più isolata"
"La Russia è sempre
più isolata, penso che parli molto chiaramente il voto di ieri all'Onu dove 141
Paesi hanno votato a favore della risoluzione che condanna la Russia. La Russia
sta regredendo verso un'economia autarchica, tagliata fuori dal mondo. Le nostre
sanzioni stanno mordendo fortemente la sua base economica, riducendo ogni
prospettiva di modernizzazione. Continueremo a porre la Russia sotto pressione e
su quanti la sostengono". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa con la premier estone,
Kaja Kallas, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in Estonia,
per celebrare l'anniversario della dichiarazione di indipendenza estone e a un
anno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
10:20
Scholz: "Putin ha
fallito, siamo più uniti che mai"
Il cancelliere
tedesco, Olaf Scholz, in occasione del primo anniversario dell'invasione russa
dell'Ucraina, ha dichiarato che il presidente russo, Vladimir Putin, ha fallito
nei suoi piani e ha elogiato la resilienza degli ucraini. "Chi da' uno sguardo
all'ultimo anno vede che il presidente russo ha fallito. Vladimir Putin ha
optato per la divisione e ha generato il contrario. L'Ucraina è più unita che
mai, l'Unione Europea è più unita che mai", ha detto in un messaggio video.
L'aggressione, dice Scholz, ha generato una serie di sfide, anche per la
Germania, che, secondo il cancelliere, sono state affrontate con successo, come
il raggiungimento dell'indipendenza energetica dalla Russia. "In pochi mesi
siamo diventati energeticamente indipendenti dalla Russia. Abbiamo abbastanza
gas e petrolio e l'economia non è in profonda recessione", ha detto. Inoltre, ha
aggiunto, la Germania è stata di supporto, ha accolto più di un milione di
rifugiati ucraini e ha fornito aiuti -finanziari, umanitari e militari- per un
valore di 14 miliardi di euro
10:21
Meloni: "Italia
dalla parte di Kiev"
"Un anno fa la
Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina, la Russia aveva già
in passato compiuto aggressioni verso i suoi vicini e non aveva mai spento le
rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva
immaginare un atto così grave". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un
messaggio in occasione dell'anniversario della guerra in Ucraina. "Il mondo
libero è debitore, l'Italia sta dalla parte di Kiev"
10:26
Il tweet di Biden:
"Putin credeva di spaccare la Nato, mai così forti"
Un anno fa il
presidente Putin ha creduto che avrebbe potuto prendere Kiev agilmente. Poi
conosciuto il coraggio dell'Ucraina e la volontà di ferro delle nazioni,
ovunque". Così in un tweet il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in
occasione del primo anniversario dall'inizio del conflitto russo-ucraino. Biden
ha aggiunto: "Il presidente Putin ha creduto che la Nato si sarebbe spaccata e
divisa. E invece la Nato è unita e forte come mai prima"
10:27
Nato, prossima
settimana Ungheria ratifica ok a ingresso di Svezia e Finlandia
"Vediamo progressi
riguardo alla storica adesione di Svezia e Finlandia alla Nato: 28 su 30 alleati
hanno già' ratificato i protocolli di adesione. Ho avuto una buona discussione
con il presidente Erdogan ad Ankara la settimana scorsa e abbiamo concordato di
riavviare i negoziati e di convocare un incontro tra Turchia, Svezia e Finlandia
al quartier generale della Nato a metà' marzo sotto la mia egida per discutere
l'attuazione dell'accordo e di come completare il processo di adesione. Ed è'
positivo che il Parlamento ungherese inizi la prossima settimana il processo di
ratifica". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg,
nella conferenza stampa con la premier estone, Kaja Kallas, e la presidente
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Estonia, per celebrare
l'anniversario della dichiarazione di indipendenza estone e a un anno
dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
10:39
Nato: "Se Cina
fornisce armi alla Russia sarà grave errore"
"Stiamo monitorando
da vicino quello che fa la Cina e abbiamo visto segnali che potrebbe considerare
e pianificare piccoli aiuti alla Russia. Sarebbe un grave errore e per questo
gli Stati Uniti e gli alleati lo stanno condannando". Lo ha dichiarato il
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha tuttavia precisato che
"al momento non ci sono prove che la Cina stia già fornendo aiuti alla Russia".
10:40
Macron: "Francia con
Ucraina fino alla vittoria"
"Ucraini, ucraine,
la Francia resta al vostro fianco. Alla solidarietà, alla vittoria e alla pace":
lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, a un anno
dall'invasione russa dall'Ucraina. Tra le tante manifestazioni di solidarietà
rivolte dalla Francia al Paese colpito dalla guerra di Vladimir Putin, la Tour
Eiffel - il monumento simbolo di Parigi - è illuminata in questi giorni con i
colori dell'Ucraina.
10:44
Portavoce
dell'aeronautica ucraina: "Oggi più che mai pronti a reagire a provocazioni"
L'esercito di Kiev è
''pronto a rispondere alle provocazioni russe'' e alle ''minacce di attacchi che
rimangono, ovvio'', ancor più in questa ''giornata che è diventa simbolica per
tutti, per il mondo intero''. Lo ha detto il portavoce dell'aeronautica
militare ucraina, Yurii Ihnat, in un discorso alla televisione di stato. "C'è
la minaccia che il nemico possa voler fare delle 'sorprese' per noi oggi. Ma
non c'è bisogno di aspettarsi'' attacchi, ha detto, spiegando che ''ci stiamo
preparando, comprendiamo la potenziale minaccia'', ha aggiunto.
10:54
Nato: "La Russia sta
fallendo"
In occasione del
primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, la Nato ha confermato il
sostegno a Kiev contro la Russia che sta "fallendo nei suoi sforzi per
infrangere la determinazione del coraggioso popolo ucraino". "Un anno dopo, gli
ucraini stanno combattendo valorosamente per la libertà' e l'indipendenza. Siamo
con loro", si legge in una dichiarazione del Consiglio Nord-atlantico.
10:55
Ambasciatore ucraino
in Italia: "Grazie Meloni per il sostegno"
"La recente visita
della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Ucraina ha confermato questa
linea continuativa di supporto che noi apprezziamo moltissimo. La battaglia non
è ancora finita e noi dobbiamo essere ancora più uniti per raggiungere la
vittoria". Lo ha detro l'Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, in
occasione dell'incontro davanti all'ambasciata Ucraina a Roma per ricordare il
primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. "Vorrei ringraziare il
viceministro degli affari esteri e tutto il governo italiano per tutto il
sostegno dimostrato all'Ucraina" ha aggiunto l'ambasciatore ucraino.
10:57
Michel:
"Anniversario buio, ma Ucraina prevarrà"
"Oggi è un
anniversario buio. Per l'Ucraina. Per l'Europa. E per il mondo. Per un anno la
Russia ha mosso guerra all'Ucraina. E per un anno l'Ucraina ha reagito con
coraggio. Un'Ucraina libera e indipendente è un'Europa libera e indipendente.
L'Ucraina prevarrà". E' quanto dichiara il presidente del Consiglio Ue Charles
Michel in un messaggio per l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina.
10:59
Zelensky alla
Germania: "Abbiamo forza per vincere"
Abbiamo la forza per
la vittoria. La Germania sarà con noi nel giorno della vittoria". Lo ha detto
il leader ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo con un messaggio video a
Berlino dove nel castello di Bellevue si tiene un evento per l'anniversario
dell'aggressione russa in Ucraina. Zelensky ha ringraziato del sostegno e ha
chiesto ulteriore impegno per vincere da parte della Germania.
11:04
G7: "Oggi lanceremo
un appello affinché nessuno sostenga militarmente Mosca"
Il G7 lancerà' oggi
un appello a tutti i Paesi perchè nessuno sostenga militarmente la Russia nella
guerra in Ucraina. Lo ha anticipato il premier giapponese Fumio Kishida,
presidente di turno dei 7 Grandi che oggi partecipano a una riunione virtuale
sull'anniversario dell'invasione russa. Parteciperà all'incontro anche il
presidente Volodymyr Zelensky
11:10
Johnson: "Subito più
armi all'Ucraina"
Più armi all'Ucraina
"al più presto" possibile. E' il messaggio lanciato nel primo anniversario della
guerra con la Russia dall'ex premier britannico conservatore Boris Johnson,
capofila dei leader occidentali considerati a Kiev fra gli "amici" più fidati
del presidente Volodymyr Zelensky. Parlando a Sky News ieri sera ha insistito
sulla necessità di fornire agli ucraini in particolare armi "a più lungo raggio"
e anche "aerei da combattimento" di standard Nato, per aiutarli a colpire "le
posizioni di artiglieria e i centri di comando e controllo" russi; e, pur
riconoscendo al suo successore Rishi Sunak di aver mantenuto il governo del
Regno in prima fila nel sostegno militare a Kiev, lo ha sollecitato ad
accelerare sulla fornitura di caccia Typhoon britannici.
11:12
Nel Regno Unito un
minuto di silenzio per Ucraina
Il Regno Unito
commemora oggi il primo anniversario della guerra in Ucraina con un momento di
silenzio nazionale alle 11 locali (le 12 italiane) e all'ombra di bandiere con i
colori ucraini innalzate un po' dovunque sull'isola, incluso nei palazzi simbolo
delle istituzioni e della monarchia. L'iniziativa, annunciata da Downing Street,
viene suggellata dalla presenza di fronte a Number 10 dell'ambasciatore di Kiev
a Londra e d'una rappresentanza di militari ucraini addestrati nel Regno, tutti
al fianco del primo ministro Rishi Sunak.
11:26
Stoltenberg:
"Rafforzare sistema difesa della Moldavia"
Se c'è "una lezione
che possiamo imparare dalla guerra in Ucraina è l'importanza di supportare
quei Paesi che sono vulnerabili all'aggressione russa il più presto possibile.
E questo vale anche per la Moldavia". Lo dice il segretario generale della Nato
Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Tallinn, in Estonia. Chisinau,
continua Stoltenberg, è "un partner stretto e altamente apprezzato della Nato.
Lavoriamo con loro da molti anni: ora abbiamo concordato di rafforzare la nostra
partnership e anche di aiutarli a costruire le loro capacità di difesa. Abbiamo
uno specifico accordo in vigore per rafforzare le loro varie istituzioni e per
aiutarli a rafforzare la loro resilienza", conclude.
11:29
Le Pen: "Francia
organizzi conferenza di pace"
A un anno
dall'invasione russa in Ucraina Marine Le Pen chiede che la Francia prenda
"l'iniziativa di una conferenza sulla pace" per ottenere una "uscita pacifica e
rapida dal conflitto". In una lettera ai connazionali trasmessa via Twitter, la
capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale di Parigi dice di
voler "continuare a portare instancabilmente il messaggio di indipendenza e di
pace che fece, credo, l'onore della nostra Patria". Negli ultimi giorni, il
partito francese di estrema destra ha fatto evolvere le sue posizioni passando
da un atteggiamento sostanzialmente morbido nei confronti di Mosca
all'ammissione di una "ingenuità collettiva" dinanzi alle "ambizioni
espansionistiche" di Vladimir Putin. Nella missiva, Le Pen invoca "una posizione
indipendente" della Francia rispetto al conflitto.
12:21
Ue: "Proposta di
pace cinese non distingue vittime da aggressori"
"Abbiamo preso nota
con attenzione della posizione di 12 punti presentata dalla Cina. E'
un'iniziativa politica, sottolinea alcuni principi della Carta delle Nazioni
unite, ma è selettiva e insufficiente riguardo alle loro implicazioni per la
guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. La posizione della Cina
basa l'attenzione sui cosiddetti legittimi interessi di sicurezza e
preoccupazioni delle parti che implicano una giustificazione per l'invasione
illegale della Russia e offusca i ruoli dell'aggressore e dell'aggredito". Lo ha
dichiarato la portavoce della Commissione europea per la Politica estera, Nabila
Massrali, rispondendo a una domanda sulla proposta di negoziati presenta dalla
Cina.
11:29
Re Carlo: "La Russia
sta provocando sofferenze inimmaginabili"
Re Carlo III ha
diffuso oggi un messaggio dai toni insolitamente duri ed espliciti in materia di
questioni internazionali per la casa reale britannica, denunciando - nel giorno
dell'anniversario della guerra in Ucraina - "l'attacco non provocato su larga
scala" iniziato dalla Russia il 24 febbraio 2022. Attacco che ha provocato
"sofferenze inimmaginabili" al popolo ucraino, si legge nel testo diffuso da
Buckingham Palace
11:32
Governatore di
Belgorod in ospedale: sospetto avvelenamento
Il governatore della
regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, è stato ricoverato in ospedale per
intossicazione alimentare e con il sospetto che sia stato avvelenato. Lo scrive
su Telegram il Canale 112 citando fonti mediche secondo le quali Gladkov non è
in pericolo di vita. Il governatore, le cui condizioni di salute sono state
giudicate moderate, resterà sotto osservazione medica per alcuni giorni.
11:43
Matterella:
"Aggressione mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale"
Oggi un giorno
particolare perchè si compie un lungo anno di guerra di aggressione della Russia
all'Ucraina: nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare
territori o per annetterlo dagli eventi drammatici della seconda guerra
mondiale". Lo afferma il presidente della Repubblica alla consegna dei premi
Alfieri della Repubblica
11:50
Cina: "Droni alla
Russia? Troppe falsità su di noi"
La Cina respinge le
accuse di vendita d'armi alla Russia, affermando che "negli ultimi tempi ci sono
state troppe falsità su di noi, moltissime". Il portavoce del ministero degli
Esteri Wang Wenbin, commentando quanto riportato da Der Spiegel, secondo cui
l'esercito russo è impegnato in trattative con la cinese Xi'an Bingo Intelligent
Aviation Technology per la produzione di massa di droni kamikaze destinati alle
sue forze armate, ha replicato di "non saperne nulla. La Cina ha sempre adottato
un approccio cauto e responsabile nei confronti dell'export militare, non vende
armi in zone di conflitto o parti coinvolte in guerre"
12:29
Ue: "Non ci sono
prove che la Cina fornisca armi alla Russia"
"Al momento non
abbiamo prove evidenti che la Cina fornisca sistemi di armi letali alla Russia,
ma chiediamo alla Cina di astenersi da qualsiasi forma di assistenza militare.
Una cosa è chiara: l'assistenza militare per aiutare l'Ucraina a difendersi
dall'aggressione russa è pienamente legittima ai sensi della Carta delle Nazioni
Unite, mentre armare l'aggressore sarebbe una chiara violazione". Lo ha detto la
portavoce della Commissione europea Nabila Massrali nel corso del briefing
quotidiano con la stampa dell'esecutivo europeo.
12:49
Podolyak: "Cessate
il fuoco congela la guerra ma non porta la pace"
'Qualsiasi 'piano di
pace' che prevede solo il cessate il fuoco e, di conseguenza, una nuova linea
di delimitazione'' oltre che a una ''continua occupazione del territorio
ucraino, non ha nulla a che vedere con la pace''. Ma si tratta, piuttosto, di
''congelare la guerra, di sconfitta dell'Ucraina e di portare avanti il
genocidio russo''. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, Mychajlo Podolyak, ribadendo che ''la posizione
dell'Ucraina è nota: serve il ritiro delle truppe russe entro i confini del
1991''.
13:35
Mosca: "Kiev ammassa
truppe al confine con la Transnistria"
Il ministero degli
Esteri russo ha affermato che gli ucraini stanno ammassando truppe al confine
con la Transnistria e schierano l'artiglieria in posizione di tiro. "Mettiamo in
guardia gli Usa, i Paesi della Nato e i reparti ucraini dal compiere nuovi passi
avventurosi", si aggiunge in un comunicato, citato dall'agenzia Ria Novosti,
affermando che ogni attacco a cittadini e soldati russi sarà considerato come
"un attacco alla Federazione Russa, secondo la legge internazionale".
13:40
Moldavia: "Nessuna
minaccia diretta dall'Ucraina alla Transnistria"
La Moldavia ha
negato l'esistenza di una "minaccia diretta" dall'Ucraina alla sua regione
separatista filo-russa della Transnistria, in risposta ai commenti della Russia,
che ha accusato Kiev di effettuare "preparara una invasione". "Il Dipartimento
della Difesa sta monitorando tutti gli eventi, le azioni e i cambiamenti in atto
nella regione... Affermiamo che attualmente non vi e' alcuna minaccia diretta
alla sicurezza militare dello Stato", si legge in una nota. "Le false
informazioni diffuse hanno lo scopo di seminare il panico", prosegue Chisinau
14:02
Sindaco di Kiev: "In
un anno 680 allarmi aerei nella capitale"
"Durante quest'anno
di guerra la capitale si è difesa, ha vissuto e ha lavorato. Noi stiamo facendo
di tutto per la vittoria e la liberazione del nostro Paese dall'aggressore
russo. Ringrazio tutte le persone di Kiev che sono state fianco a fianco nei
primi giorni e nelle prime settimane affinché Kiev sopravvivesse. Grazie ai
nostri soldati che combattono eroicamente per la libertà dell'Ucraina!". Lo
scrive sul suo canale Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko,
commemorando un anno dall'invasione che ha visto le forze russe il 24 febbraio
2022 arrivare fin nella capitale. Ma nel suo messaggio vuole anche celebrare la
vita e la vitalità di Kiev in questo anno, per questo fornisce numeri e cifre
che descrivono quella vitalità: "Dal 24 febbraio 2022 a Kiev: l'allarme aereo ha
suonato 680 volte. Oltre 700 edifici sono stati danneggiati.In particolare, 417
grattacieli e 109 edifici privati, oltre a 93 istituzioni educative "Kyiv Rescue
Service" ha effettuato 48 viaggi per eliminare le conseguenze degli attacchi
missilistici nella capitale", si legge tra l'altro. Ma anche: " Quasi 6.000
alberi sono stati piantati in città, 24.852 coppie si sono sposate. 2.688 coppie
divorziate. Sono nati 16.461 bambini:8.507 maschi e 7.954 femmine".
15:21
Usa, nuove sanzioni
contro intermediari europei di Mosca
Tra i nuovi
obiettivi del nuovo pacchetto di sanzioni Usa in sostegno all'Ucraina ci sono
anche "intermediari europei" che aiutano l'esercito di Mosca ad aggirare le
sanzioni. Lo riferisce la Casa Bianca.
15:23
Erdogan parla con
Zelensky: "Ogni contributo a soluzione pace"
Il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno del primo anniversario della guerra.
Secondo quanto riferito dalla direzione delle comunicazioni della presidenza
turca, Erdogan ha ribadito di "essere pronto a dare ogni contributo possibile
alla costruzione di una soluzione basata sul cessate il fuoco e i negoziati e
per la pace nella guerra russo-ucraina". Il presidente turco ha anche
ringraziato Zelensky per "la solidarietà" espressa ad Ankara dopo il devastante
terremoto del 6 febbraio scorso.
15:46
Blinken annuncia
nuove sanzioni, anche per Zaporizhzhia
Anche il
dipartimento di Stato Usa, dopo il Tesoro, ha annunciato nuove sanzioni per la
guerra in Ucraina, comprese alcune per il controllo illegittimo della Russia
sulla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Le ha illustrate il segretario
di Stato Antony Blinken in una nota.
16:03
Borrell boccia
documento cinese, "non è un piano di pace"
Quello cinese "non è
un piano di pace, è un documento di intenzioni, dove Pechino illustra tutte le
sue posizioni che sono note dall'inizio". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per
gli Affari Esteri dell'Ue, Josep Borrell, all'Onu. "Per essere un piano di pace
dovrebbe essere un testo che si può attuare", ha aggiunto, e "per essere
credibile deve essere condiviso con entrambe le parti: la Cina deve andare a
Kiev e parlare con Zelensky come ha parlato con Putin. Inoltre non può mettere
sullo stesso piano aggressore e aggredito".
16:12
Usa, nuove sanzioni
contro la Russia in coordinamento con il G7
Le
nuove sanzioni Usa contro la Russia sono state decise in coordinamento con i
partner del G7 e colpisco oltre 250 tra persone e aziende. Si tratta di aziende,
banche, produttori di armi e, in generale, tutte le organizzazioni che hanno
aiutato la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali dall'inizio della guerra
contro l'Ucraina. Per il dipartimento del Tesoro americano "è uno dei pacchetti
di sanzioni più significativi fino a oggi". "Le nostre misure hanno avuto un
impatto sia a breve che a lungo termine creando difficoltà alla Russia nel
rifornire le sue scorte di armi ed isolando la sua economia", ha dichiarato la
segretaria al Tesoro Janet Yellen sottolineando che "le nostre azioni di oggi
con i nostri partner del G7 dimostrano che sosterremo l'Ucraina per tutto il
tempo necessario".
16:24
Guterres apre Cds
Onu e attacca la Russia, "viola Carta"
"L'invasione russa
dell'Ucraina è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale". Lo ha ribadito il segretario generale Antonio
Guterres aprendo il Consiglio di Sicurezza. "Gli scopi e i principi della Carta
Onu non sono una questione di convenienza, non sono solo parole, ma sono al
centro di ciò che siamo e riflettono la missione guida delle Nazioni Unite", ha
aggiunto, ricordando che un anno fa aveva chiesto di dare una possibilità alla
pace, "ma la pace non ha avuto possibilità".
16:31
Berlino: altri 4
tank Leopard 2 a Kiev, 18 in tutto
Il "ministro tedesco
della Difesa Boris Pistorius, con la partecipazione dei suoi consiglieri
militari, ha deciso di consegnare all'Ucraina altri quattro carri armati Leopard
2 A6", provenienti dalle scorte dell'esercito tedesco. La Germania aumenterà
così il numero di panzer consegnati all'Ucraina da 14 a 18. Lo riporta una nota
del ministero.
16:34
Scintille a Cds Onu,
Russia lamenta che Kiev parli per prima
Prime scintille in
Consiglio di Sicurezza Onu per la riunione sull'Ucraina. L'ambasciatore
russo Vassily Nebenzia ha preso la parola criticando il fatto che il ministro
degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba abbia la parola subito dopo l'intervento del
segretario generale Guterres, prima dei membri del Consiglio. "Non abbiamo
niente in contrario a che l'Ucraina intervenga, ma dopo i membri del Consiglio
di sicurezza", ha aggiunto. La presidenza maltese ha spiegato che visto che
l'incontro è in occasione del primo anniversario della guerra in
Ucraina "abbiamo ritenuto giusto di dare la parola per prima" a Kiev.
16:47
Zelensky: "La
vittoria sarà nostra, spero entro quest'anno"
"Sono convinto che
raggiungeremo la vittoria, che la vittoria alla fine sarà nostra e spero che
questo possa succedere nel corso di quest'anno. Abbiamo tutte le condizioni
affinché questo avvenga". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky in conferenza stampa a Kiev. "Sicuramente ci saranno negoziati" e
"speriamo che ci possa essere un vertice di pace" a cui "partecipino quanti più
partner possibili", ha detto Zelensky aggiungendo che oggi "c'è più interesse a
conseguire una pace come la vogliamo noi. "Abbiamo dalla nostra parte la
comunità internazionale", ha sottolineato. "Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ma la Russia ha intrapreso solo azioni aggressive", ha tuttavia rilevato.
16:55
Zelensky vuole
America Latina, Africa, Cina e India nel piano di pace di Kiev
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di volere che i Paesi dell'America
Latina e dell'Africa, così come la Cina e l'India, si uniscano alla formula di
pace proposta da Kiev per porre fine alla guerra con la Russia. In una
conferenza stampa a Kiev, in occasione del primo anniversario dell'invasione da
parte di Mosca, Zelensky ha chiesto un vertice con i leader latino-americani e
ha affermato che Kiev dovrebbe adottare misure per costruire relazioni con i
Paesi africani.
17:10
Zelensky:
"Apprezziamo parole della Cina, aspettiamo fatti"
"La Cina ha iniziato
a parlare dell'Ucraina e questo non è un brutto segno. Ma bisogna capire, dopo
le parole, quali passi seguiranno". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in conferenza
stampa a Kiev rispondendo ad una domanda sul piano di pace di Pechino. "Nel
piano c'è il rispetto dell'integrità territoriale, anche se non è citata
esplicitamente l'Ucraina, e questo coincide con i nostri interessi. Così come le
questioni della sicurezza e del rispetto del diritto internazionale. Dobbiamo
lavorarci insieme alla Cina", ha aggiunto.
17:18
Zelensky: "Serve
aumentare rapidità in consegna armi"
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello affinchè i Paesi che
sostengono l'Ucraina "riducano i tempi necessari per la consegna di nuove
armi".
17:20
Zelensky: "I
negoziati ci saranno, serve un vertice di pace"
"Sicuramente ci
saranno negoziati" e "speriamo che ci possa essere un vertice di pace" a cui
"partecipino quanti più partner possibili". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in
conferenza stampa, aggiungendo che oggi "c'è più interesse a conseguire una pace
come la vogliamo noi. Abbiamo dalla nostra parte la comunità internazionale", ha
sottolineato. "Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma la Russia ha intrapreso
solo azioni aggressive", ha tuttavia rilevato.
17:31
Mosca, "apprezziamo
gli sforzi della Cina per la pace"
Mosca "apprezza
molto" gli sforzi della Cina di contribuire a una soluzione del conflitto in
Ucraina. Lo afferma il ministero degli Esteri citato dall'agenzia Ria Novosti.
17:40
Zelensky: "Bucha il
momento più difficile della guerra"
"Penso a Bucha, al
momento in cui abbiamo liberato Bucha, è stato orribile". Lo ha detto il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda in conferenza
stampa su quale sia stato il momento più difficile della guerra. A Bucha, come a
Irpin e Borodyanka, i russi sono accusati di aver commesso crimini di guerra.
17:54
Erdogan sente Putin,
in Ucraina serve una pace giusta
Si dovrebbe arrivare
a una "pace giusta" tra Russia e Ucraina senza ulteriori perdite di vite umane e
distruzione. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una
telefonata con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo rende noto Anadolu secondo
cui, durante la conversazione, Erdogan ha ringraziato il presidente russo per la
solidarietà espressa nei confronti della Turchia dopo il terremoto del 6
febbraio che ha provocato la morte di almeno 43mila persone.
17:43
Zelensky a Mosca,
"via da qui, smettetela di bombardarci"
"Rispettate il
nostro diritto di vivere sulla nostra terra, lasciate il nostro territorio,
smettetela di bombardarci". E' l'appello lanciato dal presidente
ucraino Zelensky direttamente alla Russia nel corso della conferenza stampa che
sta tenendo a Kiev nell'anniversario dello scoppio del conflitto.
17:48
Manifestazione fuori
dall'Onu, "Putin assassino"
Manifestazione di
protesta fuori dalle Nazioni Unite, a New York. Un gruppo di manifestanti,
secondo il New York Times, ha mostrato un'immagine del presidente russo Vladimir
Putin con le mani insanguinate e un cartello appeso al collo con scritto
"assassino". Vlad Spektor, conduttore radiofonico ucraino negli Stati Uniti per
un pubblico russofono, ha commentato: "E' dura pensare che sia passato già un
anno, così come vedere che la Russia mantiene ancora il suo posto al Consiglio
di sicurezza. E' incredibile".
18:08
Usa, Russia potrebbe
inviare a Iran jet da combattimento
Gli Stati Uniti
"hanno nuove prove" che il sostegno militare dell'Iran alla Russia per
continuare a portare avanti la sua guerra in Ucraina "si è ampliato" e in cambio
Mosca fornirà a Teheran "jet da combattimento". Lo ha detto il portavoce per la
sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un gruppo
ristretto di giornalisti precisando che "a novembre l'Iran ha inviato alle forze
di Vladimir Putin munizioni e carri armati".
18:19
G7, nostro sostegno
a Kiev è incrollabile
"Un anno dopo
l'inizio della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, noi, Capi
di Stato e di Governo del Gruppo del G7, ci siamo riuniti con il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky per riaffermare il nostro incrollabile sostegno
all'Ucraina per tutto il tempo necessario". Questo quanto si legge nella
dichiarazione del G7. "Rimaniamo impegnati a coordinare i nostri sforzi per
soddisfare le urgenti necessità di equipaggiamento militare e di difesa
dell'Ucraina, con un'attenzione prioritaria alle necessità di equipaggiamento
per la difesa, con particolare attenzione ai sistemi e alle capacità di difesa
aerea e alle munizioni e ai carri armati". E' quanto si legge nella
dichiarazione diffusa dopo la videconferenza dei leader.
18:35
G7, non
riconosceremo mai regioni annesse
Nel suo comunicato
finale il G7 afferma che "non riconoscerà mai" l'annessione delle regioni
orientali dell'Ucraina da parte della Russia. "Chiediamo a Paesi terzi e a
tutti gli attori
internazionali che cercano di aggirare le sanzioni fornendo sostegno materiale
alla Russia di smettere immediatamente o dovranno affrontare sanzioni
durissime", continuano i leader del G7 e gli Usa in una nota congiunta.
18:50
Zelensky, prevedo
incontro con presidente cinese Xi
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che intende incontrare il presidente
cinese Xi Jinping, ma non ha detto quando questo incontro potrebbe avvenire."Ho
intenzione di incontrare Xi Jinping e credo che questo sarà vantaggioso per i
nostri Paesi e per la sicurezza nel mondo", ha detto a una conferenza stampa a
Kiev nel primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. In precedenza
Zelenskiy aveva ribadito che non avrebbe avuto colloqui con il presidente russo
Vladimir Putin.
19:09
Tajani, "Luci e
ombre in piano Cina, punti in contraddizione"
"Luci e ombre" nel
piano di pace presentato dalla Cina. E' questo il giudizio espresso dal
vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo il bilaterale svolto
all'Onu con il segretario di Stato americano Antony Blinken. "E' positivo - ha
detto, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani - che la Cina si
schieri a favore della pace, che chieda di rispettare il diritto internazionale,
ma ci sono alcuni punti che sono in contraddizione". "Perchè - ha aggiunto -
quando la Cina dice che i due contendenti sono sullo stesso piano, sceglie una
posizione alternativa a quella votata dalla grande maggioranza dei Paesi del
mondo. C'è un aggressore e un aggredito, non si possono mettere sullo stesso
piano". Altro punto, ha continuato Tajani, "che non convince è che non si fa
menzione del ritiro delle truppe russe dai territori occupati con violenza. Noi
crediamo che la Russia possa fare delle scelte, condizionata dalle pressioni
cinesi. La Russia non sta facendo neanche i propri interessi, ci sono migliaia
di morti, la Cina può svolgere una moral suasion".
19:33
Ambasciatore russo
all'Onu : "Occidente vuole distruggere la Russia"
L'Occidente vuole
"distruggere" la Russia. Lo ha ribadito l'ambasciatore russo alle Nazioni
Unite, Vasily Nebensya, nel suo intervento davanti al consiglio di Sicurezza
all'Onu, denunciando quanto la parola "pace" sia usato in modo falso da Kiev e
da altri Paesi. "Ciò che intendono è una resa da parte della Russia,
infliggendole idealmente una sconfitta strategica, seguita dalla dissoluzione
del Paese e dalla riorganizzazione dei territori", ha accusato.
19:49
Farnesina illuminata
con colori bandiera ucraina
"Ad un anno dalla
drammatica invasione russa dell'Ucraina, la Farnesina si tinge dei colori della
bandiera ucraina per ribadire il continuo sostegno dell'Italia a fianco di
Kiev". Lo si legge in un tweet del ministero, che pubblica una foto
dell'edificio illuminato.
19:56
Londra, non
invieremo caccia a Kiev a breve
La Gran Bretagna
non ha intenzione di inviare i caccia Typhoon della Raf in Ucraina "a breve". Lo
ha riferito il ministro della Difesa britannico Ben Wallace in un'intervista
a Sky News rilanciata dal Guardian. "Non invieremo i nostri jet Typhoon a breve
termine in Ucraina", ha detto nell'intervista in occasione del primo
anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Wallace ha affermato che i Typhoon
sarebbero troppo complessi per l'Ucraina, ma ha aggiunto che potrebbero invece
fornire copertura aerea a quei Paesi del blocco orientale che volessero inviare
i loro MiG-29 e altri aerei dell'era sovietica a Kiev.
20:14
Arresti a Mosca e
San Pietroburgo per commemorazioni anniversario guerra
I tentativi di
commemorare l'anniversario della guerra russa in Ucraina sono stati rapidamente
bloccati dalle forze di sicurezza russa a Mosca e San Pietroburgo. Tre persone
sono state fermate a Mosca dopo che avevano deposto fiori ai piedi di un
monumento intitolato alla poetessa ucraina Lesya Ukrainka, secondo quanto
denunciato dal gruppo Ovd-Info. "Una di loro stava depositando i fiori ma al
contempo è stata presa dalle forze di sicurezza e il mazzo di fiori è stato
portato via". Altre 15 persone sono state detenute mentre deponevano dei fiori
sul monumento allo scrittore ucraino Taras Shevchenko a San Pietroburgo. Secondo
Ovd-Info oltre 4300 persone sono state arrestate in Russia durante le proteste
contro l'invasione lo scorso anno.
20:22
Palazzo Chigi
illuminato con i colori della bandiera ucraina
A partire dal
tramonto, e per tutta la serata di oggi, la facciata di Palazzo Chigi sarà
illuminata con i colori della bandiera ucraina. Un'iniziativa che rientra fra
quelle a sostegno dell'Ucraina ad un anno dall'invasione russa.
20:27
Zelensky, la domanda
sulla mia famiglia è la più difficile
E' "la più
difficile" l'ultima domanda che viene posta a Volodymyr Zelensky durante la
conferenza stampa a Kiev in occasione dell'anniversario dell'invasione russa. E'
lui stesso a definirla tale, quando gli viene chiesto come lui e la sua famiglia
stiano affrontando la realtà della guerra. "L'ultima domanda è la più
difficile", ha affermato Zelensky. "Li amo, ovviamente. Amo mia moglie, i miei
figli, sono le persone più importanti per me". "Non li vedo spesso. I miei
genitori - non li vedo affatto", ha detto, aggiungendo "sono tutti nel mio
cuore".
"L'importante è non
deluderli. L'importante è che i miei figli siano orgogliosi di me. E sono
contento che siano in Ucraina, che studino nelle scuole ucraine. È importante
per un presidente di un paese, ex o attuale, in tempo di guerra, è importante
avere i figli qui, perché il paese è qui, perché ragazzi e ragazze muoiono qui".
Zelensky ha aggiunto di essere "incredibilmente fortunato" con la sua famiglia e
il suo Paese.
20:48
Baerbock a Onu, pace
deve significare pace
"Pace deve
significare pace, non che ignoriamo chi è l'aggressore e chi la vittima. Non
nominare l'aggressore significherebbe accettare un mondo dove si bombardano le
scuole, dove si uccide gente mentre va in bicicletta". Lo ha detto in Consiglio
di Sicurezza la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. "Cosa significa
avere più Bucha, Mariupol, Bakhmut? - ha continuato - Non voglio immaginare un
mondo del genere".
21:09
Trudeau: "Manderemo
altri 4 Leopard 2"
Il premier
canadese Justin Trudeau ha confermato stasera che il paese consegnerà altri
quattro tank Leopard 2 all'Ucraina. Il Canada inoltre - ha aggiunto - invierà a
Kiev un veicolo corazzato e 5mila colpi di artiglieria. Nell'anniversario
dell'invasione russa dell'Ucraina Trudeau ha infine preannunciato un nuovo round
di sanzioni contro individui ed entità legati alla Russia. Tra i 129 individui e
63 entità individuati, vicepremier ed altri alti funzionari.
21:34
Poroshenko: "Putin
vuole cancellare l'Ucraina"
"Non fidatevi di
Putin...ha un solo obiettivo, cancellare l'Ucraina". A dichiararlo è stato l'ex
presidente ucraino Petro Poroshenko. "Putin dovrebbe essere in prigione", ha
dichiarato a Bfmtv. "I russi devono lasciare l'Ucraina, poi bisogna
deputinizzare il mondo", ha aggiunto Poroshenko, capo dello stato tra il 2014 e
il 2019.
21:46
Usa, "Piano Cina?
Dovrebbe fermarsi alle prime 2 righe"
"Il rispetto della
sovranità territoriale dell'Ucraina è fondamentale": lo ha ricordato la Casa
Bianca di fatto mostrandosi molto perplessa sul 'piano cinese' per la pace in
Ucraina La Casa Bianca ha fatto notare che la proposta di pace della Cina per
trovare una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina "avrebbe dovuto fermarsi
alle prime due righe, che invitano al rispetto della sovranità dei Paesi", ha
osservato il portavoce per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.
"Ma affinchè una pace sia fattibile -al di là della migliore e più improbabile
via d'uscita, che sarebbe che Putin ritiri le sue truppe- deve essere cercata
fin dall'inizio nell'inclusione della prospettiva ucraina, deve includere il
riconoscimento fondamentale di chi è l'aggressore, che è la Russia". Anche il
segretario di Stato, Antony Blinken, dinanzi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu,
si è mostrato tiepido sulla proposta cinese.
21:56
Kiev, "attacchi alla
periferia di Zaporizhzhia"
Le forze russe
stanno attaccando la periferia di Zaporizhzhia. Lo riporta Ukrainska
Pravda citando il segretario del consiglio comunale della città, Anatolii
Kurtiev. "Per quanto riguarda le esplosioni che hanno sentito i residenti di
alcune zone della città, il nemico ha attaccato la periferia di Zaporizhzhia" ha
detto Kurtiev, invitando i cittadini a "rimanere calmi e a non trascurare gli
allarmi antiaerei".
22:11
Kiev: "Non siamo
minaccia per la Transnistria"
Kiev ha respinto le
affermazioni russe secondo cui l'Ucraina starebbe progettando di invadere la
repubblica separatista della Transnistria, in Moldavia, al confine con
l'Ucraina. "Rispettiamo la sovranità della Moldavia", ha dichiarato il
presidente Volodymyr Zelensky, definendo infondate le accuse di Mosca. Anche la
Moldavia ha ripetutamente respinto le affermazioni di Mosca: non ci sono
"minacce alla sicurezza militare" della Transnistria, ha dichiarato il ministero
della Difesa della Moldavia. I leader politici moldavi hanno invece lanciato
recentemente l'allarme su possibili tentativi di colpo di stato in Moldavia da
parte della Russia.
22:15
Ue approva decimo
pacchetto di sanzioni
Fumata bianca in
extremis: gli Stati dell'Ue hanno dato il via libera al decimo pacchetto di
sanzioni contro la Russia, in tempo per poter dire di averlo fatto entro il
primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il pacchetto era stato
bloccato dalla Polonia che non condivideva alcuna esenzione all'embargo per
l'import dalla Russia della gomma sintetica. Il pacchetto comprende restrizioni
commerciali per un totale di 11 miliardi di euro così come colpisce l'export di
alcune tecnologie a duplice uso e l'Iran per la fornitura di droni.
22:40
Premier ucraino:
"Beni congelati ai russi per ricostruzione Paese"
"Chiediamo a tutti i
paesi di confiscare i beni russi e a trasferirli in Ucraina per la
ricostruzione, sarà il prezzo che l'aggressore dovrà pagare per tutte le
distruzioni e le violenze in Ucraina. Potrebbe essere anche un funzionamento di
sicurezza globale: ogni aggressore dovrebbe pagare il costo di un'aggressione
non provocata". Ad affermarlo ai microfoni del canale all news francese Lci è il
premier ucraino, Denys Chmyhal. "I beni russi congelati secondo gli esperti si
aggirano intorno ai 300-500 miliardi di dollari. Potrebbero essere la base per
la ricostruzione dell'Ucraina in modo, ad esempio, che i contribuenti francesi e
tedeschi non spendino le loro imposte per partecipare alla ricostruzione del
Paese. Sarebbe più giusto che a pagare fosse la Russia con i suoi beni
congelati", spiega il premier ucraino.
La Repubblica.
Punti chiave
22:06
Il G20 dei ministri
delle finanze in India si chiude con una spaccatura: Cina e Russia non votano
comunicato ufficiale
15:42
Zelensky, "Putin
sarà eliminato dal suo stesso entourage"
14:04
Biden: "Il piano
della Cina per la pace? Se piace a Putin non può essere buono"
12:27
Zelensky: "Bene le
sanzioni Ue, ora servono misure contro Rosatom e le banche"
11:52
Borrell: "Adottato
il decimo pacchetto di sanzioni Ue"
11:04
Macron andrà in Cina
a inizio aprile
10:14
Kiev: Mosca
raddoppia le navi nel Mar Nero, prepara un attacco
09:00
Kuleba: "Non
concordo con il piano di Pechino sulla fine delle sanzioni"
08:26
Bielorussia,
Lukashenko a Pechino da martedì: vedrà Xi
00:27
Biden, avvertii Xi
dei rischi in caso di aiuto alla Russia
Joe Biden ha
avvertito il presidente cinese Xi Jinping dei rischi che la Cina avrebbe corso
nel caso avesse deciso di aiutare la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina.
"Ho avuto con lui una lunga conversazione sull'argomento quest'estate", ha
rivelato il presidente americano ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca.
"Gli ho detto che
non era una minaccia ma un semplice dato di fatto: in Russia se ne sono andate
600 compagnie straniere dopo che hanno visto quello che era successo", ha detto
Biden sottolineando di aver avvertito Xi "di stare attento se è vero che il
futuro della Cina dipende dagli investimenti occidentali".
00:30
Biden, l'Ucraina per
ora non ha bisogno di F16
"L'Ucraina per ora
non ha bisogno dei jet F16". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista esclusiva a
Abc news. Rispondendo ad una domanda se questo significhi "mai", il presidente
americano ha risposto che "non è possibile stabilire esattamente di che cosa
avrà bisogno l'Ucraina per difendersi in futuro". "Ma al momento, secondo le
valutazioni del nostro esercito, non c'è nessuna ragione per inviare gli F16".
01:29
Biden, se Cina
fornisse armi a Russia Usa risponderebbero
Gli Stati Uniti
"risponderebbero" nel caso la Cina dovesse fornire alla Russia armi letali nella
guerra contro l'Ucraina. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista ad Abc News.
"Non l'abbiamo ancora visto, ma non prevedo una grande iniziativa da parte della
Cina nel fornire armi alla Russia", ha dichiarato. Biden ha poi fatto
riferimento alle sanzioni che altri paesi hanno ricevuto dopo aver sostenuto
Mosca. "Abbiamo imposto severe sanzioni a chiunque lo abbia fatto", ha
sottolineato.
08:26
Bielorussia,
Lukashenko a Pechino da martedì: vedrà Xi
Il presidente
bielorusso, Aleksandr Lukashenko, sarà in visita di Stato in Cina dal 28
febbraio al 2 marzo, secondo quanto riferito dal suo servizio stampa. Lo riporta
l'agenzia di stampa Belta, riferendo che è in programma un incontro con
l'omologo Xi Jinping. "Lukashenko e Xi", riferisce Minsk, "terranno colloqui in
formati ristretti ed estesi. L'attenzione sarà rivolta allo sviluppo della
cooperazione commerciale, economica, degli investimenti e umanitaria,
all'attuazione di progetti congiunti su ampia scala, all'interazione nella sfera
politica e alla risposta alle sfide più acute dell'attuale situazione
internazionale".
08:44
Ucraina: scattata
l'allerta aerea in tutto il Paese
È scattata l'allerta
anti-aerea in tutto il territorio dell'Ucraina, secondo quanto annunciato dalle
autorità competenti nel Paese. L'allarme è attualmente in vigore anche nelle
aree controllate da Kiev nelle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.
09:00
Kuleba: "Non
concordo con il piano di Pechino sulla fine delle sanzioni"
Il ministro degli
Esteri ucraino, Dmitri Kuleba, ritiene che nel documento di presa di posizione
sulla guerra in Ucraina presentato dalla Cina "ci sono vari elementi sui quali
siamo d'accordo, ma almeno un elemento su cui non siamo d'accordo, ed è la
richiesta della fine delle "sanzioni unilaterali". "Riteniamo - dice Kuleba,
citato da alcuni media, fra cui l'Ukrainska Pravda - che le sanzioni siano uno
strumento importante". Ma in generale, "questo documento (cinese) è importante.
Lo stiamo studiando, dobbiamo farlo dall'inizio alla fine e trarne poi le nostre
conclusioni", ha detto Kuleba. "Dobbiamo affermarlo chiaramente: 141 Paesi hanno
votato una risoluzione che definisce i principi e gli elementi chiave di come
questa guerra dovrebbe finire. E tutto ciò che viene proposto al di fuori di
questa risoluzione deve rispettare la risoluzione stessa", ha sottolineato il
capo della diplomazia di Kiev.
09:33
Difesa britannica:
"Mosca ha terminato le scorte di droni iraniani, cerca nuovi rifornimenti"
La Russia ha
esaurito le sue scorte di droni iraniani e sta cercando nuovi rifornimenti,
indica il ministero della Difesa britannico nel suo consueto aggiornamento
quotidiano della situazione in Ucraina. Dal 15 del mese non ci sono notizie di
attacchi con droni.
09:54
Medvedev:
"L'Occidente sta prolungando l'agonia dell'Ucraina"
"L'Occidente sta
solo prolungando l'agonia dell'Ucraina nella speranza di indebolire la Russia e
poi rottamarla" , ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza
russo, Dmitry Medvedev, in un articolo pubblicato su National Defence, citato
da Ria Novosti. "L'agonia dell'Ucraina viene prolungata artificialmente
dall'Occidente nella speranza che in questo modo possa logorare la Russia".
Secondo Medvedev gli Usa hanno speso 50 miliardi di dollari in aiuti militari
all'Ucraina. "L'industria della difesa russa sta lavorando, nessuna fornitura di
armi occidentali può dare un vantaggio a Kiev", ha aggiunto.
10:14
Kiev: Mosca
raddoppia le navi nel Mar Nero, prepara un attacco
L'esercito ucraino
ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate
attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione
per ulteriori attacchi missilistici. Lo riferisce il Guardian.
"Nel Mar Nero, la
flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto
navi", ha detto il comando militare nella regione meridionale in un
aggiornamento su Facebook, "ciò potrebbe indicare che sono in preparazione
attacchi missilistici e attacchi di droni", ha affermato. Una delle navi è una
fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud.
10:41
Kiev: "Piano di pace
cinese è irrealistico"
?Mykhailo Podolyak,
consigliere del Presidente Volodymir Zelensky, liquida il piano di pace
presentato dalla Cina come "irrealistico". Pechino, ha scritto, "non deve
puntare su un aggressore che ha violato il diritto internazionale e che perderà
la guerra. Non è lungimirante". Ieri Zelenzky aveva accolto il piano con toni
più positivi. "La Cina ha iniziato a parlare di Ucraina e questo non è
negativo", aveva detto. "Se sostenete di avere un ruolo globale, non offrite un
piano irrealistico. Chi pianifica per decenni, non deve impegnarsi in giochetti
di tre giorni. Cina, la finestra di opportunità non è senza fine", ha
sottolineato Podolyak.
11:04
Macron andrà in Cina
a inizio aprile
Il presidente
francese Emmanuel Macron ha annunciato che andrà in Cina a inizio aprile. Il
capo dell'Eliseo ha anche chiesto a Pechino di "aiutarci a fare pressione sulla
Russia per fermare l'aggressione e raggiungere la pace".
11:25
Kiev: distrutto un
deposito di munizioni a Mariupol occupata
Secondo il
consigliere del sindaco in esilio di Mariupol, Petro Andryushchenko, i difensori
ucraini hanno "distrutto" un altro deposito di munizioni russe: è scoppiato un
incendio nella zona di Novoselivka. Lo riporta Unian. L'Ucraina ha trovato un
modo per contrattaccare i russi, ha detto Andryushchenko, e ha pubblicato un
video che mostra l'esplosione del deposito ieri, 24 febbraio. Le forze armate
ucraine negli ultimi giorni hanno rivendicato attacchi su Mariupol,
precedentemente ritenuto al di fuori della portata effettiva dei missili
ucraini.
11:52
Borrell: "Adottato
il decimo pacchetto di sanzioni Ue"
"È stato adottato il
decimo pacchetto di sanzioni Ue". Lo annuncia sui social l'alto rappresentante
Ue Josep Borrell. "121 persone ed entità elencate, nuove e significative
restrizioni all'importazione/esportazione, divieto di diffusione della
propaganda russa. Rimaniamo uniti nella nostra determinazione a intaccare la
macchina da guerra della Russia", annuncia.
12:09
Capo 007 ucraino:
fallito attacco russo su sede intelligence a Kiev
L'esercito russo ha
cercato di colpire con un missile da crociera russo l'edificio della Direzione
principale dell'intelligence del Ministero della Difesa a Kiev. Lo ha rivelato
il capo del dipartimento Kyrylo Budanov, ma senza indicare la data dell'attacco,
commentando che gli dà "soddisfazione il fatto che i russi gli stiano dando la
caccia". Lo riporta Unian.
"È un
riconoscimento, dimostra che sto facendo bene il mio lavoro", ha affermato
Budanov, sottolineando che le minacce di Mosca e i tentativi di colpirlo non lo
spaventano: "Sono una persona religiosa e ho solo paura della punizione di Dio.
Non ho paura di nessuna Russia", ha concluso Budanov.
12:27
Zelensky: "Bene le
sanzioni Ue, ora servono misure contro Rosatom e le banche"
"Il decimo pacchetto
di sanzioni Ue prende di mira l'industria militare russa, la propaganda e il
sistema finanziario. La pressione sull'aggressore russo deve aumentare: ci
aspettiamo passi decisivi contro Rosatom e l'industria nucleare russa, più
pressione su militari e banche". Così su Twitter il presidente ucraino,
Volodymyr Zelensky, ha commentato l'adozione delle nuove sanzioni Ue.
13:03
Modi (India):
"Pronti a contribuire a sforzi di pace"
L'India "è disposta
a contribuire agli sforzi di pace in Ucraina". Lo ha assicurato il premier
Narendra Modi, dopo aver incontrato a Nuova Delhi il cancelliere tedesco Olaf
Scholz e all'indomani dell'appello di Volodymyr Zelensky per un vertice per la
pace con la presenza di Cina e India. "Dall'inizio del conflitto l'India ha
sottolineato la necessità di risolvere la crisi attraverso il dialogo e la
diplomazia", ha sottolineato Modi.
13:37
Kiev: bombardamenti
russi su Kherson, 3 feriti
Tre civili sono
stati feriti dai bombardamenti dell'artiglieria russa nella regione meridionale
ucraina di Kherson. Lo ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino,
Andriy Yermak su Telegram. "Oggi, a causa dei bombardamenti di artiglieria sulla
città di Kherson, tre residenti locali sono finiti in ospedale. I terroristi
russi stanno combattendo contro la popolazione civile", ha detto Yermak. Le
truppe russe sulla riva orientale del Dnipro hanno aperto il fuoco sulla regione
di Kherson 83 volte venerdì, colpendo un totale di 34 insediamenti, secondo
Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale.
14:04
Biden: "Il piano
della Cina per la pace? Se piace a Putin non può essere buono"
"Se a Putin piace,
come può essere un buon piano?". Così Joe Biden ha liquidato l'iniziativa per la
pace in Ucraina proposta dalla Cina. "Ci sono vantaggi solo per la Russia in
quel piano", ha aggiunto il presidente americano in un'intervista a Abc news
sottolineando che l'idea che la Cina "negozi l'esito di una guerra totalmente
ingiusta per l'Ucraina non è razionale".
14:28
Lukashenko: "Ieri ho
avuto una lunga conversazione con Putin"
Il presidente
bielorusso Alexander Lukashenko ha riferito di aver avuto una lunga
conversazione con il presidente russo Vladimir Putin ieri, giorno
dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina. "Lasciate che vi dica un
segreto, io e lui abbiamo avuto una lunga conversazione su molti argomenti ieri
sera", ha detto Lukashenko, citato da Interfax. "A Dio piacendo, i nostri
rapporti rimarranno così per sempre. E dopo di me, possano rimanere così", ha
aggiunto.
14:52
La Russia ha
tagliato tutte le forniture di petrolio alla Polonia
La Russia ha
tagliato tutte le forniture di petrolio alla Polonia. Lo ha denunciato la
principale azienda petrolifera polacca, Pkn Orlen, che ha smesso di ricevere i
flussi attraverso la pipeline Druzhba. Su Twitter, l'amministratore delegato,
Daniel Obajtek, ha scritto: "La Russia ha bloccato tutte le forniture",
circostanza per la quale "eravamo preparati". Il Ceo di Pkn Orlen ha spiegato
che le raffinerie verranno rifornite via mare e che non ci sarà alcuna
conseguenze per i consumatori.
L'oloedotto Druzhba,
che rifornisce Polonia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, era
stato escluso dalle sanzioni europee, per venire incontro ai Paesi che hanno
opzioni limitate per forniture alternative. Dopo la riduzione dei mesi scorsi,
la Polonia dipendeva solo per il 10% dalle forniture di petrolio russo.
15:23
Russia: "La Svizzera
non può fare da mediatrice dopo l'ok alle sanzioni"
La Svizzera non può
più svolgere un ruolo di mediazione nella crisi ucraina dopo che si è unita alle
sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli
Esteri russo Maria Zakharova. "La Svizzera che si è unita alle sanzioni
unilaterale e illegittime dell'Occidente contro la Russia non è più uno Stato
neutrale e non può svolgere alcun ruolo di mediazione nel contesto della crisi
dell'Ucraina", ha detto Zakharova rispondendo sul sito del ministero degli
Esteri russo alla proposta di mediazione del capo della diplomazia svizzera
Ignazio Cassis. A Ginevra, come ha riferito Cassis, sono anche iniziati
negoziati di pace "nella massima discrezione" tra russi e ucraini, anche se non
al livello più alto.
15:42
Zelensky, "Putin
sarà eliminato dal suo stesso entourage"
Zelensky, "Putin
sarà eliminato dal suo stesso entourage"
Il presidente
ucraino Voldymyr Zelensky si è detto convinto che Vladimir Putin prima o poi
verrà ucciso dal suo stesso entourage: "Ci sarà sicuramente un momento in cui la
fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno della Russia. I
predatori mangeranno il predatore. Troveranno un motivo per uccidere
l'assassino, ma avranno bisogno di una ragione", ha dichiarato Zelensky al
giornalista Dmytro Komarov che ha realizzato un documentario a un anno
dall'invasione russa dell'Ucraina.
15:44
Kiev, distrutto
deposito russo di munizioni a Mariupol
Un deposito russo di
munizioni a Mariupol è stato distrutto e 50 soldati russi sono rimasti uccisi o
gravemente feriti in un attacco delle forze ucraine. Lo ha riferito il
consigliere del sindaco in esilio della città nel sud del Paese, Petro
Andriushchenko, secondo cui nell'operazione della notte scorsa sarebbero stati
anche distrutti alcuni veicoli blindati russi.
16:01
Podolyak, bene nuove
sanzioni Ue ma bisogna essere più duri
"Il decimo pacchetto
di sanzioni dell'Ue inizia a funzionare... Fantastico, ma è necessario essere
più duri. Le sanzioni riguardano vero dolore economico, non la dichiarazione di
dolore. La Russia dovrebbe soffrire, non solo per pazzi propagandisti. Le
sanzioni contro Rosatom e l'industria nucleare russa funzionerebbero in modo più
efficace". Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo
Podolyak.
16:24
Ex comandante gruppo
Wagner arrestato di nuovo in Norvegia
L'ex comandante del
gruppo mercenario russo Wagner Andrey Medvedev, fuggito in Norvegia dove ha
chiesto asilo, è stato arrestato dopo aver presumibilmente aggredito un agente
di polizia fuori da un bar di Oslo, secondo i pubblici ministeri norvegesi.
L'uomo è stato arrestato nelle prime ore di mercoledì dopo una rissa fuori da un
bar della capitale norvegese. Le circostanze esatte della rissa non sono state
specificate ma, secondo gli atti del tribunale, Medvedev, ubriaco, ha resistito
all'arresto e poi ha aggredito fisicamente gli agenti di polizia una volta
arrivato alla stazione. Il processo è stato fissato per il 25 aprile.
16:58
Ucraina: incontro a
Bruxelles tra militari di Cina e Nato
I militari di Cina e
Nato si sono incontrati giovedì a Bruxelles riavviando "il dialogo e le
consultazioni istituzionali" per la prima volta dallo scoppio della guerra in
Ucraina e della pandemia del Covid. I colloqui, avvenuti un giorno prima che
Pechino pubblicasse il piano in 12 punti per risolvere la crisi ucraina e tra
gli avvertimenti alla Cina di Europa e Usa a non fornire armi alla Russia, "si
sono concentrati sullo sviluppo di relazioni bilaterali, sullo scambio di
commenti su questioni geopolitiche e di sicurezza di interesse reciproco e sul
miglioramento di comprensione e fiducia reciproche", secondo una nota di
Pechino.
17:14
Wagner, siamo a meno
di 2 km dal centro di Bakhmut
Alle forze russe
mancano meno di due chilometri per raggiungere il centro di Bakhmut. Ad
affermarlo è il comandante del plotone del gruppo di mercenari Wagner impegnato
alla conquista della città ucraina, parlando a Ria Novosti. "Al centro di
Bakhmut rimangono 1.740 metri dalle posizioni avanzate. Il nemico tiene la
difesa, ma perde ancora lo spirito. Comincia a ritirarsi", ha affermato. Secondo
il comandante dei mercenari, ora in città sono in corso feroci battaglie, e le
forze russe non stanno avanzando velocemente come vorrebbero, perché il comando
ucraino starebbe inviando nuove reclute nella battaglia per tenere la città.
17:22
La stanza del
presidente Zelensky dall'inizio della guerra
Il
presidente Volodymyr Zelensky per la prima volta ha mostrato dove vive
dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel suo documentario il
giornalista Dmytro Komarov ha fatto un giro del suo appartamento a Bankova e ha
mostrato un guardaroba militare e una foto sulla sua scrivania. Il sito web
ucraino Tablo Id, parte del gruppo Ukrayinska Pravda, ha pubblicato alcune foto
della stanza.
17:48
Media, Prigozhin
oscurato dai media ufficiali russi
Evgeny
Prigozhin sparisce dai media ufficiali russi: il capo dei mercenari Wagner
avrebbe pagato così il suo continuo dissenso nei confronti dei vertici militari
di Mosca riguardo alla conduzione della guerra in Ucraina. Lo rivela il media
indipendente russo Verstka, secondo cui diversi organi di stampa hanno ricevuto
l'ordine di oscurare lo "chef di Putin". Tuttavia sugli account risulta ancora
il suo nome. Da tempo Prigozhin denuncia i fallimenti dell'invasione ed ha
ingaggiato un duello diretto con il ministro della Difesa Shoigu, accusandolo
tra le altre cose di non fornire munizioni ai suoi miliziani impegnati in
Donbass. Ed ora Verstka fa sapere che i media di Stato sono stati istruiti a non
citare le sue dichiarazioni "su argomenti non neutrali". Secondo un'analisi del
media indipendente le agenzie di stampa controllate dal Cremlino hanno
effettivamente smesso di citare le dichiarazioni di Prigozhin nelle ultime
settimane, ad eccezione di quelle direttamente correlate all'attività sul campo
di battaglia della Wagner. Inoltre, secondo una fonte vicina al ministero della
Difesa russo, le autorità russe hanno preparato una "campagna" contro Prigozhin,
anche se hanno deciso di non lanciarla per il momento.
18:10
Kiev: attacco
missilistico russo su Kramatorsk, un ferito
Le truppe russe
hanno lanciato un attacco missilistico sulla città di Kramatorsk, nella regione
di Donetsk, provocando un ferito. Lo ha riferito Pavlo Kyrylenko, capo
dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, in un post su Facebook
riportato da Ukrinform. "Almeno una persona è rimasta ferita in un attacco
missilistico su Kramatorsk da parte delle forze di occupazione russe. I russi
hanno colpito un edificio residenziale con un missile. Hanno anche colpito e
distrutto una clinica ambulatoriale locale", ha detto Kyrylenko.
18:43
G20: Russia accusa,
Occidente destabilizza il summit
La Russia ha
accusato l'Occidente di aver "destabilizzato" il vertice finanziario del G20 in
India con un tentativo di "ricatto" sulla dichiarazione congiunta sull'Ucraina.
"Ci rammarichiamo che le attività del G20 continuino a essere destabilizzate
dall'Occidente e utilizzate in chiave anti-russa e puramente conflittuale", si
legge in una nota del ministero degli Esteri.
18:58
Ue vara sanzioni
contro mercenari Wagner, 'sono minaccia'
"Le attività
del Gruppo Wagner rappresentano una minaccia per le persone nei paesi in cui
operano e per l'Ue. Mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionale in
quanto non operano all'interno di alcun quadro legale. L'Ue è determinata a
continuare ad agire concretamente contro le violazioni del diritto
internazionale". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell in una nota
in cui annuncia la decisione del Consiglio di aggiungere negli elenchi delle
sanzioni 11 persone e 8 entità legate al gruppo della Wagner per la dimensione
internazionale e la gravità delle sue attività, dall'impatto destabilizzante.
19:18
Kiev: "Russi hanno
creato camera di tortura nella zona occupata dell'oblast di Zaporizhzhia"
Le forze russe hanno
allestito una "camera delle torture" nella città di Vasylivka, nella zona
occupata dell'oblast di Zaporizhzhia nell'Ucraina meridionale. Lo denuncia lo
Stato Maggiore dell'esercito di Kiev affermando che la Russia ha intensificato
la persecuzione dei civili nelle aree occupate. Secondo le forze armate ucraine,
quindi, i russi stanno facendo sempre più pressione sui civili e fanno irruzione
nelle loro case nelle parti occupate degli oblast di Kherson e Zaporizhzhia.
20:07
Russia Today e suo
direttore nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue
C'è anche il gruppo
mediatico Russia Today e il suo direttore esecutivo Kirill Vyshinsky nel nuovo
pacchetto di sanzioni, il decimo, approvato dall'Unione europea nei confronti
della Russia per l'invasione dell'Ucraina. La Ue ha motivato la scelta dicendo
che i media stanno "diffondendo disinformazione" su quella che Mosca definisce
l'operazione militare speciale russa in Ucraina. "Non c'è niente di
sorprendente. C'è una guerra ibrida in corso contro il nostro Paese, in questo
caso contro i media che lavorano nell'interesse del nostro Paese e che,
ovviamente, sono sotto attacco", ha detto Alexander Yushchenko, primo vice capo
del Comitato della Duma di Stato per la politica dell'Informazione, alla Ria
Novosti.
20:35
Poste ucraine
emettono francobollo con un'opera di Banksy
Le poste ucraine
hanno emesso un francobollo che riproduce un'opera dell'artista
britannico Banksy, in cui un giovane judoka abbatte un uomo adulto, un'allegoria
dell'Ucraina che sconfigge la Russia. Lo riporta Al Jazeera. L'opera
dell'artista evoca l'esercito ucraino che abbatte il presidente russo Vladimir
Putin, noto per essere cintura nera di judo. Era stata dipinta da Banksy su un
muro distrutto nella città di Borodianka, a nord-ovest di Kiev.
21:05
Ucraina: allarme
aereo nella regione di Kharkiv
Allarme aereo nella
regione di Kharkiv in Ucraina. Lo riportano i media di Kiev.
21:24
Zelensky, 1877
villaggi ancora nelle mani dei russi
Sono attualmente
1.877 le città e i villaggi ucraini nelle mani dei russi. Lo ha reso noto il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso ai partecipanti
all'evento del presidente federale della Germania dedicato alla solidarietà con
l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda. "L'occupante cerca di aumentare questo
numero e di aggiungere altri milioni di destini spezzati a quelli già infranti",
ha detto.
22:06
Il G20 dei ministri
delle finanze in India si chiude con una spaccatura: Cina e Russia non votano
comunicato ufficiale
Il G20 dei ministri
delle finanze e dei banchieri centrali in India si è chiuso con una spaccatura
sulla guerra in Ucraina, con la Cina e la Russia che non hanno votato il
comunicato ufficiale al termine dell'incontro, bloccandone così la
pubblicazione e costringendo l'India, presidente di turno, a rilasciare una
sintesi della presidenza. Il testo bocciato dai due Paesi ripeteva quanto
affermato al termine del G20 di Bali dello scorso novembre. La replica di Mosca:
"I nostri oppositori, rappresentati dagli Stati Uniti, dall'UE e dal G7,
continuano a non rallentare i loro tentativi paranoici di isolare la Russia, per
scaricare la colpa dei problemi provocati nel campo della sicurezza
internazionale e dell'economia mondiale".
22:26
Ue sanziona 7
aziende iraniane: "Forniscono droni a Russia"
Nel nuovo pacchetto
di sanzioni che l'Unione europea ha messo a punto in relazione alla guerra in
Ucraina ci sono anche sette aziende iraniane, ritenute colpevoli di aver
"fornito aerei senza pilota" alla Russia. Nel testo si legge che il Consiglio
europeo ritiene che queste aziende iraniane abbiano "fabbricato veicoli aerei
militari senza pilota che sono stati utilizzati dall'esercito russo in una
guerra di aggressione, anche contro le infrastrutture civili".
Le aziende
sanzionate sono: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (Dama), la forza
aerospazionale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i corpi di Ricerca dei
Pasdaran e l'organizzazione per il Jihad, Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado),
Paravar Pars Company, l'industria per l'aviazione di al-Qods, e l'industria
aviazione Shahed.
Estratto
dell’articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica” il 25 febbraio 2023.
[…] «Morta durante
i bombardamenti dei nazionalisti ucraini», recita il pannello della mostra
intitolata “Eroi e Atti eroici” allestita in Gogolevskij bul’var tra la
Cattedrale del Cristo Salvatore e la Vecchia Arbat. I passanti infagottati si
fermano e scorrono volti e storie. Giovani vite immolate sull’altare della folle
offensiva lanciata da Vladimir Putin contro l’Ucraina un anno fa. Dodici mesi
dopo i caduti non sono più un tabù. Anche se il loro numero è protetto dal
segreto di Stato, autorità e tv non fanno che glorificarne il sacrificio.
[…] La “propaganda
della morte”, come l’hanno battezzata i sociologi, non è che l’ultimo tassello
della “nuova normalità” imposta alla popolazione. Una normalità orwelliana dove
è normale morire per “difendersi” da qualcuno che non ti ha mai attaccato. È
normale essere condannati a 9 anni di carcere, come l’oppositore Ilja Jashin, in
base a una legge sulle “fake news” che punisce chi dice la “verità” sui crimini
commessi in Ucraina.
[…] È un cambiamento
che si fa fatica a cogliere in una capitale ricca come Mosca. Il conflitto è
qualcosa di lontano. Lo ricordano i sistemi anti- missilistici comparsi
settimane fa su alcuni tetti. Le sanzioni finora non hanno affossato l’economia.
I ristoranti traboccano e gli scaffali dei supermercati sono colmi benché molti
prodotti ora arrivino dall’Asia e i prezzi siano schizzati.
Le “importazioni
parallele” autorizzate per sopperire ai boicottaggi hanno avuto persino risvolti
inaspettati: l’atteso Samsung Galaxy S23 si trovava in vendita già prima del suo
debutto mondiale. «È frustrante. All’apparenza non è cambiato nulla. Sarebbe più
rasserenante se ci fossero chiari segnali di crisi economica o di una sorta di
reazione. Perché ogni mattina leggo le notizie e l’immagine del mondo che mi
arriva è totalmente diversa da quella che vedo per strada», ci ha confessato il
fotografo 42enne Aleksandr Gronskij.
Certo, la catena
russa “Vkusno i Tochka” ha preso il posto di McDonald’s, le auto cinesi Geely
hanno soppiantato le Bmw e le vetrine del lusso restano sbarrate. Nei cinema
ritornano le epopee sovietiche o si proiettano copie piratate dei film
hollywoodiani. Dalle librerie sono scomparsi i titoli di “agenti stranieri” come
Boris Akunin che si erano pronunciati per la pace. E nei musei e nelle strade si
susseguono mostre che rivisitano la storia per giustificare il presente.
La Piazza Rossa non
pullula più di turisti e nelle vetrine dei negozi di souvenir, matrioske e
samovar sono affiancate da t-shirt con la “Z”. Ma bisogna grattare a fondo la
scorza per trovare le vere cicatrici di questi passati 365 giorni.
La propaganda è
martellante. Pervade ogni ganglio dello spazio pubblico e privato. A scuola si
va a “lezione di patriottismo”. E la tv è un mondo alla rovescia. È una delle
ragioni per cui milioni di russi continuano a sostenere “il buon Zar” e la sua
aggressione: conoscono soltanto la realtà che autorità e media raccontano loro.
Censura e
repressione fanno il resto. Dopo quasi 20mila fermi persino per un foglio
bianco, nessuno protesta più in piazza. […]
(ANSA il 25 febbraio
2023) - Il presidente russo Vladimir Putin decise in segreto l'invasione
dell'Ucraina, parlando solo con pochi consiglieri super-fidati, tenendo
all'oscuro praticamente l'intera leadership di Mosca, tra cui il ministro degli
Esteri Sergei Lavrov.
Lo scrive il
Financial Times. "Intorno all'una del mattino del 24 febbraio, il ministro degli
Esteri russo Sergei Lavrov ricevette una telefonata inquietante. Dopo mesi
passati a preparare una forza di invasione da 100.000 uomini sui confini con
l'Ucraina, Vladimir Putin aveva dato il via libera all'invasione. La decisione
prese Lavrov totalmente di sorpresa", scrive l'Ft.
"Solo pochi giorni
prima, il presidente russo aveva sondato i membri del suo consiglio di sicurezza
sulla possibilità di riconoscere i due staterelli nel Donbass... durante una
cerimonia televisiva - ma non aveva comunicato loro le sue vere intenzioni",
scrive il giornale.
"Tutti gli alti
dirigenti del Cremlino seppero dell'invasione solo quando hanno visto Putin
dichiarare un''operazione militare speciale' in televisione quella mattina", si
legge. Durante una riunione quello stesso giorno con diversi oligarchi, "dove
tutti stavano perdendo la testa" perché sapevano che le sanzioni li avrebbero
colpiti duramente - racconta al giornale uno dei presenti - "uno degli oligarchi
chiese a Lavrov come Putin avesse potuto pianificare un'invasione così enorme
con una cerchia così ristretta, tanto che la maggior parte degli alti funzionari
del Cremlino, il gabinetto economico russo e la sua élite imprenditoriale non
credevano nemmeno che fosse possibile.
'Ha tre
consiglieri', rispose Lavrov. Ivan il Terribile. Pietro il Grande. E Caterina la
Grande'". "Secondo il piano di invasione di Putin, le truppe russe avrebbero
dovuto impadronirsi di Kiev nel giro di pochi giorni in una brillante e
relativamente incruenta guerra lampo. Invece, la guerra si è rivelata un pantano
di proporzioni storiche per la Russia", sottolinea il FT.
(ANSA il 25 febbraio
2023) - "La situazione è nelle mani di Putin. Lui può mettere fine a questa
guerra". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio video
settimanale dedicato all'anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina,
pubblicato in rete con i sottotitoli in ucraino. Non è la consegna delle armi
occidentali a Kiev a prolungare la guerra, ha continuato, "è vero il contrario:
quanto prima il presidente della Russia capisce che non raggiungerà i suoi
obiettivi imperialistici, tanto maggiore sarà la chance di una veloce
conclusione della guerra".
"Nonostante tutte
le sfide, che anche la Germania ha dovuto affrontare a causa dell'aggressione
della Russia all'Ucraina, siamo riusciti piuttosto bene a rimettere in sesto le
cose". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio video
settimanale dedicato all'anniversario dell'inizio della guerra. "Abbiamo
abbastanza gas e petrolio. E l'economia non è finita in una profonda recessione.
Abbiamo accolto oltre un milione di ucraini grazie alla grande disponibilità in
tutto il Paese", ha affermato il Bundeskanzler. (ANSA)
Estratto
dell’articolo di Jonathan Littell per il “Corriere della Sera” il 25 febbraio
2023.
[…] Olaf Scholz, il
cancelliere tedesco, è diventato un maestro sopraffino del giochetto della falsa
dimostrazione di forza, che ormai non trae in inganno più nessuno, a tal punto
che gli ucraini hanno coniato un nuovo verbo dal suo nome, scholzing , che si
traduce con: «Comunicare le proprie buone intenzioni e subito dopo
cercare/sfruttare/utilizzare tutte le ragioni possibili e immaginabili per
dilazionarle e/o impedire la loro realizzazione». […]
Estratto
dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa” il 25 febbraio 2023.
[…] Iryna Vereshchuk
[…] vicepremier e ministra per la Reintegrazione dei territori occupati. È
perentoria nel definire le condizioni di Kiev al negoziato: «Riprendere la
Crimea e tornare ai confini del 1991». Mentre liquida le affermazioni di Silvio
Berlusconi come quelle di un «maschio alfa modello Putin» ormai consegnato alla
storia.
[…] Un'Ucraina
sicura comprende la Crimea?
«Senza la Crimea non
ci sarà sicurezza né per l'Ucraina né per l'Europa. È nell'interesse
dell'Europa, della Gran Bretagna e degli Usa fare in modo che la Russia non
possa utilizzare la Crimea come il suo trampolino militare. È ormai un
fondamento della geopolitica mondiale».
Quali sono le
vostre condizioni per sedervi a un tavolo negoziale?
«Ristabilire i
confini ucraini del 1991 col riconoscimento della comunità internazionale».
[…] Un commento
sulle parole di Berlusconi?
«Berlusconi è un
prodotto del passato, di un'epoca dove si governava non in base ai valori ma con
altri strumenti politici. Non fa niente, non ci offendiamo, siamo comprensivi.
Anche noi eravamo sotto l'influenza di questo tipo di politica e di visioni del
mondo errate. Il futuro appartiene ad altri politici espressione di altri
valori, bisogna solo aspettare e non dare troppa importanza a episodi del
genere.
Berlusconi ricorda
Putin e la sua gente, maschi alfa che dimostrano disprezzo verso regole e i
principi, convinti che a loro tutto sia concesso. Per politici con un ego così
forte è difficile capire che un Paese grande come la Russia stia subendo colpi
da un Paese piccolo come l'Ucraina che mettono a nudo la loro debolezza».
[…] Si è chiesta
come mai gli alleati non hanno fornito subito determinati armamenti?
«Nel 2014 Putin ha
mostrato il suo vero volto annettendo la Crimea. E invece di fermarlo il mondo
ha iniziato a trattare con lui. Continuavano a permettere alla Russia di armarsi
militarmente e tecnologicamente.
Il Cremlino è
riuscito a convincere buona parte del establishment dell'Occidente che sarebbe
stato meglio per loro fare un passo indietro e concedergli una parte
dell'Ucraina, per tutelare i rapporti con Mosca e avere una relativa pace in
Europa.
Putin con la sua
aria di sfida, è riuscito ad impressionare gli altri leader, perciò quello che
succede ora è una specie di eco del 2014. Ma abbiamo avuto politici come Mario
Draghi, Andrzej Sebastian Duda, Boris Johnson, i leader di Lituania ed Estonia e
altri che non hanno esitato reagendo già nelle prime fasi dell'invasione. E
adesso gli altri si allineano. Le cose stanno cambiando». […]
Il ripensamento di
Sanremo vi ha turbato?
«No, il presidente
si rivolge e parla al mondo intero. Ha fatto talmente tanti discorsi da essere
sentito e capito in tantissimi consessi. Chi in qualche modo ha cercato di
limitarlo non limiterà l'energia che emana il popolo ucraino. Si è trattato di
un episodio specifico ma non così importante. Penso che gli italiani ci stiano
aiutando perché in qualche modo si rispecchiano in noi, in come eravate un
tempo. Il vostro popolo ha un grande cuore e una grande anima, questo è quello
che conta».
Mosca mette al
bando Prigozhin: i media di Stato ricevono l’ordine di oscurare la Wagner e il
suo fondatore.
Marco Imarisio su Il Corriere della Sera il 25 Febbraio 2023.
Da giorni, a Mosca,
le parole del fondatore del gruppo di mercenari Wagner sono «oscurate» dai media
ufficiali. E il governatore della regione di Sverdlovsk ora lo sbeffeggia:
«Torna a cucinare polpette e spaghetti»
All’arredamento
della propaganda manca ormai un pezzo importante. Fino a poco tempo fa, Evgenij
Prighozin era l’uomo forte che diceva le cose giuste. Era la figura da
contrapporre ai «burocrati ministeriali» che con i loro tentennamenti impedivano
una rapida avanzata in Ucraina. Le sue critiche rivolte soprattutto al titolare
della Difesa Sergey Shoigu e ai capi delle forze armate, risuonavano forti negli
studi televisivi ed erano commentate con favore anche sulla carta stampata
filogovernativa, in genere meno spericolata di quanto non lo siano i talk-show
serali.
Le ultime notizie
sulla guerra in Ucraina, in diretta
Dopo la ritirata
dell’Armata russa da Kherson, l’oligarca fondatore della Brigata Wagner era
diventato quasi un contropotere all’interno del potere stesso, un amico
personale di Vladimir Putin che criticava il modo «timido» con il quale veniva
condotta l’Operazione militare speciale . Poteva permetterselo, dato il
massiccio impiego dei suoi uomini al fronte, che costituiva un argine alla
controffensiva delle truppe di Kiev.
Adesso, l’ex cuoco
del presidente, in realtà ex titolare di una società di catering che riforniva
il Cremlino durante i ricevimenti ufficiali, è sparito dai media ufficiali. Non
appare più, non viene più citato. Eppure, parla. Con cadenza quotidiana,
continua a mandare messaggi attraverso i suoi social. Solo che non arrivano più
al grande pubblico della Russia profonda, quella che si nutre soltanto di
televisione e telegiornali, e cominciava a considerarlo un eroe del patriottismo
declinato in un ultranazionalismo sempre più estremo.
Prighozin ha
trascorso gli ultimi dieci giorni ad attaccare il ministero della Difesa, reo di
far mancare al suo gruppo mercenario le munizioni necessarie per combattere. I
media internazionali hanno dato ampio spazio alle sue lamentele. Lui ha anche
risposto a qualche domanda che gli proveniva dall’estero, sempre tramite i suoi
social. In Russia, non una parola. Niente. Neppure il lieto fine della storia,
con Prighozin che annuncia l’arrivo degli agognati rifornimenti, costretto a
ringraziare obtorto collo il «nemico» Shoigu. Come se non esistesse. Non può
essere un caso. E infatti non lo è.
Citando una fonte
interna, il sito di informazione indipendente Verstka racconta come molti organi
di informazione statali siano stati istruiti a non citare più le frasi di
Prighozin quando trattano «argomenti non neutri», quindi sempre. E aggiunge che
a sua volta il ministero della Difesa avrebbe pronta una campagna mediatica
contro di lui, nel caso ce ne fosse bisogno. L’unica certezza è la scomparsa
pubblica del signore della guerra russo. RIA Novosti, Tass e Interfax, le tre
principali agenzie di stampa, tutte controllate dal Cremlino, hanno smesso di
fare il suo nome, limitandosi a riportare i comunicati della Brigata Wagner
riguardanti l’attività sul campo di battaglia, come a operare una cesura tra il
fondatore e la sua creatura più importante. «Pensa agli affari tuoi, e torna a
cucinare polpette e spaghetti». Qualcosa è davvero cambiato, se il governatore
della regione di Sverdlovsk può permettersi di rispondere così alle critiche di
uno dei personaggi più temuti di Russia che lo accusava di non dare degna
sepoltura ai soldati della Wagner.
Un anno di
Operazione militare speciale lascia il segno anche in Russia, anche negli
equilibri sui quali si regge la verticale del potere putiniana. La crescente
popolarità di Prighozin, che quasi sempre parlava alle televisioni dal fronte, o
comunque in una situazione di combattimento, ponendosi anche a livello visivo
come uomo d’azione contrapposto ai «topi d’ufficio», così ebbe a definirli, che
siedono nei ministeri moscoviti, può diventare un problema. In una intervista
online di pochi giorni fa, il deputato di Russia Unita Oleg Matveychev ha
descritto gli ultranazionalisti, il partito della guerra, come «la più grande
minaccia interna nei confronti di Putin». I liberali sono tutti fuggiti,
spiegava. L’opposizione semi-ufficiale dei Comunisti agita la bandiera dei
salari e delle pensioni basse, che in tempo di guerra non esercita una gran
presa sull’elettorato. «I turbo-patrioti sono invece l’unico vero pericolo per
il nostro Stato». Le loro critiche all’establishment rischiano di compromettere
l’unità della Russia contro il nemico esterno, è il succo del ragionamento.
Matveychev faceva
anche i nomi dei due principali reprobi. Igor Girkin, l’ex comandante delle
Forze speciali nel Donbass ai tempi del primo conflitto ucraino, è una scheggia
impazzita della blogosfera russa, che ogni giorno accusa le autorità di
«negligenza criminale» senza aver più molto da perdere. Il secondo nome è quello
di Prighozin, che non ha mai fatto mistero di avere in animo la fondazione di un
proprio movimento super conservatore. Matveychev non è certo un moderato, anzi.
È un celebre blogger che fino a pochi mesi fa proponeva e sosteneva idee folli,
come quella di rinchiudere i membri dell’opposizione in piazza e di fucilarli
senza processo «per far crescere l’economia russa». Dopo l’inizio
dell’Operazione, militare speciale, aveva presentato una mozione alla Duma per
chiedere agli Usa la restituzione dell’Alaska e già che c’eravamo anche di Fort
Ross in California, «perché entrambe scoperte e fondate da russi». Ma lui ha
capito che l’aria si sta facendo sempre più spessa. E che la leva del
nazionalismo va lasciata in mano a chi ha il vero potere. Prighozin, invece no.
O almeno, non ancora.
La Repubblica.
Zelensky ricorda la caduta della Crimea: "Tornerà nostra"
Gli ultimi
aggiornamenti dalla crisi Russia-Ucraina. Lukashenko in Cina vedrà Xi Jinping.
Tajani: "Sull'invio delle armi alla Russia mi auguro che Pechino dica la verità"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky si è detto convinto che Vladimir Putin prima o poi
verrà ucciso dal suo stesso entourage: "Ci sarà sicuramente un momento in cui la
fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno della Russia. I
predatori mangeranno il predatore".
Il presidente
vladimir Putin, dal canto suo, ha detto che la Russia deve tenere conto del
potenziale nucleare non solo degli Stati Uniti, ma anche di tutti gli altri
paesi della Nato, poiché l'Alleanza considera la sconfitta strategica di Mosca
il suo obiettivo principale: "Nelle condizioni odierne, poiché tutti i
principali paesi della Nato hanno annunciato la nostra sconfitta strategica come
il loro obiettivo principale per far soffrire la nostra gente, come possiamo non
considerare il loro potenziale nucleare in queste condizioni?" ha detto.
Punti chiave
20:27
Zelensky, "Il
diritto internazionale prevarrà in Donbass e Crimea"
19:27
Kiev, in Crimea ci
sono 180 prigionieri politici detenuti
18:54
Ucraina, Shmyhal:
"Riconciliazione con la Russia impossibile nei prossimi 100 anni"
18:44
Ucraina, Zelensky
firma nuove sanzioni "contro coloro che aiutano la Russia a fare la guerra"
18:05
Ucraina, Berlino:
"Giudichiamo la Cina dai fatti non dalle parole"
17:41
Ucraina, Kirill: "Il
Donbass è un avamposto russo"
17:10
Ucraina, il ministro
della Difesa estone a Kiev annuncia aiuti militari
14:30
Usa: "Crimea è
Ucraina, non la riconosceremo mai come Russia"
12:15
Zelensky: "Nove
anni fa attacco Mosca a Crimea, tornerà nostra"
11:06
Putin: "La Russia
non può ignorare la capacità nucleare della Nato"
10:30
Putin: "Start
sospeso, Russia deve garantire sua sicurezza"
08:38
Putin: "Paesi Nato
complici dei crimini del regime di Kiev"
03:06
Zelensky, "Putin
sarà eliminato dal suo stesso entourage"
03:06
Zelensky, "Putin
sarà eliminato dal suo stesso entourage"
Il presidente
ucraino Voldymyr Zelensky si è detto convinto che Vladimir Putin prima o poi
verrà ucciso dal suo stesso entourage: "Ci sarà sicuramente un momento in cui la
fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno della Russia. I
predatori mangeranno il predatore. Troveranno un motivo per uccidere
l'assassino, ma avranno bisogno di una ragione", ha dichiarato Zelensky al
giornalista Dmytro Komarov che ha realizzato un documentario a un anno
dall'invasione russa dell'Ucraina.
05:35
Zelensky, 1877
villaggi ancora nelle mani dei russi
Sono attualmente
1.877 le città e i villaggi ucraini nelle mani dei russi. Lo ha reso noto il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso ai partecipanti
all'evento del presidente federale della Germania dedicato alla solidarietà con
l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda. "L'occupante cerca di aumentare questo
numero e di aggiungere altri milioni di destini spezzati a quelli già infranti",
ha detto.
05:36
Il G20 dei ministri
delle finanze in India si chiude con una spaccatura: Cina e Russia non votano
comunicato ufficiale
Il G20 dei ministri
delle finanze e dei banchieri centrali in India si è chiuso con una spaccatura
sulla guerra in Ucraina, con la Cina e la Russia che non hanno votato il
comunicato ufficiale al termine dell'incontro, bloccandone così la
pubblicazione e costringendo l'India, presidente di turno, a rilasciare una
sintesi della presidenza. Il testo bocciato dai due Paesi ripeteva quanto
affermato al termine del G20 di Bali dello scorso novembre. La replica di Mosca:
"I nostri oppositori, rappresentati dagli Stati Uniti, dall'UE e dal G7,
continuano a non rallentare i loro tentativi paranoici di isolare la Russia, per
scaricare la colpa dei problemi provocati nel campo della sicurezza
internazionale e dell'economia mondiale".
05:38
Biden boccia il
piano di pace messo a punto dalla Cina
Il presidente
americano Joe Biden boccia il piano di pace messo a punto dalla Cina. "Se a
Putin piace, come può essere un buon piano?" lo liquida osservando che "ci sono
vantaggi solo per la Russia in quel piano". Secondo il capo della Casa Bianca
"l'idea che la Cina "negozi l'esito di una guerra totalmente ingiusta per
l'Ucraina non è razionale".
08:37
Zelensky: "Pace non
basta, Ucraina si difenderà per 10 anni"
Se anche l'Ucraina
dovesse firmare il più stringente dei trattati di pace, il pericolo di
un'aggressione da parte della Russia potrebbe ripresentarsi. E' quindi
necessario costruire uno stato ucraino che in futuro sia in grado di difendersi:
parola del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in stralci di un'intervista
rilasciata ai media ucraini e riportati dal sito presidenziale ucraino.
08:38
Putin: "Paesi Nato
complici dei crimini del regime di Kiev"
"I Paesi della Nato,
seppur indirettamente, sono complici dei crimini del regime di Kiev, che, tra
l'altro, sta bombardando aree residenziali della Novorossia e di Donetsk". Lo ha
detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista a Russia 1.
09:25
Kiev: controffensiva
in primavera, liberiamo anche Crimea. Colpiremo depositi munizioni in territorio
russo, a Belgorod
L'esercito ucraino
sarà pronto a passare alla controffensiva in primavera: l'obiettivo è la
liberazione di tutti i territori occupati, compresa la Crimea: "Ci fermeremo
solo quando ripristineremo il Paese entro i limiti del 1991", ha affermato il
vice capo dell'intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur) Vadym
Skibitskyi, citato da Unian. Uno degli obiettivi sarà il tentativo di "inserire
un cuneo nel fronte russo a sud, tra la Crimea e la terraferma russa", ha
spiegato Skibitsky, "l'Ucraina colpirà i depositi di munizioni sul territorio
russo, compresa la regione di Belgorod, gli attacchi partono da lì".
09:55
Ucraina, "Putin" al
tappeto nel francobollo che riproduce l'opera di Banksy
Le poste ucraine
hanno emesso un francobollo che riproduce un'opera dell'artista
britannico Banksy, in cui un giovane judoka abbatte un uomo adulto, un'allegoria
dell'Ucraina che sconfigge la Russia. L'opera dell'artista evoca l'esercito
ucraino che abbatte il presidente russo Vladimir Putin, noto per essere cintura
nera di judo. Era stata dipinta da Banksy su un muro distrutto nella città
di Borodianka, a nord-ovest di Kiev.
10:02
Cnn, Zelensky ha
chiesto F-16 e missili a lungo raggio
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai parlamentari repubblicani di prendere
in considerazione un elenco di armi da fornire a Kiev, che includerà aerei da
combattimento F-16 e missili a lungo raggio. Lo riporta la Cnn. All'inizio di
febbraio, Zelensky ha incontrato una delegazione di repubblicani Usa, tra
cui Michael McCall, capo della commissione Esteri della Camera. "Abbiamo avuto
un incontro molto produttivo con il presidente Zelensky. Abbiamo parlato
principalmente di ciò di cui ha bisogno per vincere questa guerra. Zelensky
fornirà un elenco di armi di cui l'Ucraina ha bisogno per vincere", ha detto
McCall.
10:26
Kiev, sminamento in
corso nella regione di Kharkiv
Solo nell'ultima
giornata, sono stati disinnescati 46 ordigni esplosivi nell'intero oblast
ucraino di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleh Syniehubov, sottolineando
che le attività di sminamento continuano in tutta l'area. Lo scrive Kyiv
Independent. Secondo Syniehubov, il bombardamento russo della città di Kupiansk
nei giorni scorsi ha danneggiato almeno quattro abitazioni private e alcune
attività commerciali sono state distrutte. Una donna di 82 anni è stata curata
in seguito al forte stress subito. Nel vicino villaggio di Kupiansk-Vuzlovyi,
condomini di cinque piani sono stati danneggiati. Monachynivka, anch'essa
situata nel distretto di Kupiansk nell'oblast di Kharkiv, è stata bombardata
intorno alle 14 di ieri. Non ci sono state vittime.
10:30
Putin: "Start
sospeso, Russia deve garantire sua sicurezza"
La Russia ha bisogno
di garantire la propria sicurezza e stabilità strategica, ha dichiarato il
presidente russo, Vladimir Putin, commentando la decisione di sospendere la
partecipazione della Russia al Trattato Start (Trattato sulle armi nucleari) in
un'intervista a Rossiya-1. Lo riferisce Ria Novosti. Alla domanda su cosa gli
Usa debbano capire dopo la sospensione, Putin ha risposto: "Dipende da loro cosa
capire. Noi capiamo che cosa dobbiamo fare. E dobbiamo preservare il nostro
Paese, garantire la sicurezza, la stabilità strategica".
10:53
Esperti Isw:
"Lukashenko a Pechino per aiutare a eludere le sanzioni"
Il presidente
russo Vladimir Putin non mostra segni di volontà di scendere a compromessi sui
suoi obiettivi massimalisti dichiarati nella guerra, che includono la
"neutralità" e la "smilitarizzazione" dell'Ucraina, così come il cambio di
regime de facto a Kiev. Lo afferma il rapporto del think-tank americano
Institute for the Study of War (Isw), citato dall'agenzia ucraina Unian. Nel
frattempo, il dittatore bielorusso Oleksandr Lukashenko ha annunciato
l'intenzione di visitare la Cina dal 28 febbraio al 2 marzo per incontrare Xi
Jinping. "Lukashenko ha in programma di incontrare il leader cinese Xi Jinping
per aiutare la Russia e la Cina a eludere le sanzioni tra le notizie secondo cui
Pechino sta seriamente considerando di inviare aiuti letali a Mosca", affermano
gli analisti di Isw, citati da Unian.
11:06
Putin: "La Russia
non può ignorare la capacità nucleare della Nato"
"Nelle condizioni
attuali, con tutti i principali Paesi Nato che hanno dichiarato che il loro
obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro
popolo possa soffrire come dicono, come possiamo ignorare, in queste condizioni,
le loro capacità nucleari?". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista alla
televisione di Stato Rossiya, secondo quanto ripota la Tass. Il presidente russo
ha ribadito che l'Occidente vuole distruggere la Russia avendo "un solo
obiettivo: smembrare l'ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la
Federazione russa". Putin ha accusato i Paesi occidentali di essere complici dei
"crimini" che sarebbero stati commessi dall'Ucraina.
11:16
Direttore Cia: "La
Cina valuta invio armi a Mosca ma non ha deciso"
In un'intervista
esclusiva a Cbs News, il direttore della Cia Bill Burns ha confermato la
possibilità che la Cina possa inviare aiuti letali alla Russia nella sua guerra
contro l'Ucraina anche se Pechino non ha ancora preso una decisione. "Non
vediamo che sia stata ancora presa una decisione definitiva e non vediamo prove
di spedizioni effettive di attrezzature letali", ha affermato Burns, confermando
che l'obiettivo dell'amministrazione Usa - condividendo quello
dell'intelligence della Cia - è quello di dissuadere la Cina dal prendere la
decisione di trasferire aiuti a Mosca. E ha indicato che se questo venisse
deciso, per il presidente Xi Jinping "sarebbe una scommessa molto rischiosa e
imprudente". Burns ha poi osservato che l'invasione russa e la conseguente
risposta mondiale sono state di particolare interesse per Xi: "Non c'è nessun
leader straniero che abbia guardato più attentamente all'esperienza di Vladimir
Putin in Ucraina, l'evoluzione della guerra, di quanto abbia fatto Xi Jinping",
ha detto. "Penso che, in molti modi, sia stato turbato da ciò che ha visto", ha
aggiunto.
11:37
Blackout sospesi
oggi a Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk
Nella giornata di
oggi non sono previste interruzioni di elettricità nelle regioni
di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk. Lo riferiscono su Telegram le società locali
per l'erogazione di energia elettrica. "Oggi Ukrenergo non ha limitato il
consumo di elettricità . Questo ci consente di non spegnere le luci nelle
regioni di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk", si legge nel messaggio. Si sono
registrati comunque danni alle reti Ukrenergo in alcune centrali elettriche,
sono quindi possibili alcune interruzioni programmate.
12:15
Zelensky: "Nove
anni fa attacco Mosca a Crimea, tornerà nostra"
"Nove anni fa
iniziava l'aggressione russa in Crimea. Ripristineremo la pace nella Penisola",
ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky su Telegram. "Quella è la
nostra terra, il nostro popolo. Riporteremo la nostra bandiera in ogni angolo
dell'Ucraina", ha aggiunto.
12:47
L'accusa
dell'osservatore ucraino: "A gennaio il capo Wagner tentò di impossessarsi di
milioni di munizioni russe"
Una tentata "rapina"
per milioni di munizioni per artiglieria sembra emergere da alcuni documenti
postati su Twitter da Igor Sushko, osservatore ucraino con forti connessioni con
ambienti ufficiali russi "dissidenti". A tentare il colpo sarebbe stato Evgeny
Prigozhin, capo della milizia privata Wagner che dall'inizio dell'invasione
russa all'Ucraina ha affiancato le truppe di Mosca. In base a questi documenti,
che sarebbero stati messi in circolo dai servizi di sicurezza Fsb, nel quadro di
una faida in atto a Mosca, a inizio gennaio sarebbe stato deciso il
trasferimento di milioni di munizioni dai magazzini dell'esercito russo a due
unità operative, la 22ma brigata delle forze speciali e al 78mo Centro di
ricognizione: ma in realtà la destinazione sarebbero stati i reparti
di Prigozhin. A bloccare l'operazione - che sarebbe stata approvata da diversi
generali - il cambio della guardia ai vertici operativi delle operazioni in
Ucraina con la sostituzione di Sergei Surovikin: al suo posto il generale Valery
Gerasimov, considerato oppositore del capo del gruppo Wagner.
Dopo il mancato
'approvvigionamento' dai magazzini ufficiali, le cose per la milizia mercenaria
sono andate sempre peggio: non solo il Ministero della Difesa, su indicazione di
Gerasimov, sembra aver deciso di privare completamente la Wagner di qualsiasi
munizione (provocando pesanti proteste dello stesso Prigozhin, in video divenuti
virali) ma ha anche proibito al gruppo di reclutare dalle carceri russe altri
detenuti da mandare al fronte, dove il livello di perdite è elevatissimo. Di
pochi giorni fa, infine, le voci su un diktat del Cremlino per eliminare dai
media russi a qualsiasi riferimento a Prigozhin. Una censura che - secondo molti
- appare come una condanna a morte annunciata per la milizia privata.
13:00
Il ministro delle
Difesa tedesco: "Il piano della Cina? Giudichiamo Pechino dalle sue azioni, non
dalle sue parole"
Bisogna valutare "la
Cina dalle sue azioni non le sue parole". Lo ha detto il ministro della Difesa
tedesco, Boris Pistorius, esprimendo scetticismo sul piano di pace per l'Ucraina
presentato da Pechino. "Quando leggo le notizie, e non so se siano vere, secondo
le quali la Cina starebbe pianificando di fornire droni kamikaze alla Russia ed
allo stesso tempo sta presentando un piano di pace, io suggerisco di giudicare
la Cina dalle sue azioni e non dalle sue parole", ha detto all'emittente
pubblica tedesca Deutschlandfunk.
13:36
Russia, da Putin
auguri di compleanno al "caro amico" Erdogan
Il presidente
russo, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo
turco, Recep Tayyip Erdogan, a cui ha fatto gli auguri per il compleanno,
sottolineando "il suo grande contributo personale allo sviluppo delle relazioni
russo-turche". "Sono stati toccati alcuni temi di attualità nell'agenda
bilaterale", si legge nel messaggio pubblicato sul sito del Cremlino. Putin ha
anche inviato un telegramma di congratulazioni a Erdogan. "Lei gode giustamente
di un grande prestigio tra i suoi connazionali e all'estero. In questo momento
difficile, in una situazione così critica, in cui la Turchia sta superando le
tragiche conseguenze di devastanti terremoti, le sue migliori qualità di
statista e persona, coraggio, capacità di assumere misure equilibrate e
decisione necessaria", si legge nel telegramma pubblicato sul sito del Cremlino.
14:06
Media, da Zelensky
lista nuove armi a repubblicani Usa
Il presidente
dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky compilerà un elenco di armi e beni di prima
necessità di cui Kiev ha bisogno e lo sottoporrà all'esame di un gruppo di
rappresentanti della Camera dei rappresentanti Usa del Partito Repubblicano che
ha visitato l'Ucraina la settimana scorsa. Lo riferisce Unian. I membri del
Congresso hanno promesso di rivedere questo elenco, scrive la Cnn. Zelensky, che
ha incontrato il presidente della commissione per gli affari esteri della
Camera Michael McCaul e altri quattro membri del Congresso, avrebbe detto loro
che intende inviare un elenco di armi, compresi i caccia F-16, necessarie per
accelerare la fine della guerra con la Russia. Un alto comandante militare
statunitense ha ribadito a un gruppo di legislatori repubblicani che sarebbero
necessari aerei da combattimento F-16 e missili a lungo raggio per aiutare
l'Ucraina, ha riferito una fonte all'emittente americana.
14:25
Algeria riapre
ambasciata a Kiev a un anno da invasione russa
A un anno
dall'inizio dell'invasione russa l'Algeria annuncia la riapertura
dell'ambasciata a Kiev. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Algeri citato
dai media locali.
14:30
Usa: "Crimea è
Ucraina, non la riconosceremo mai come Russia"
"Nove anni fa, la
Russia ha invaso l'Ucraina e si è impadronita della Crimea, una chiara
violazione del diritto internazionale, della sovranità e integrità territoriale
dell'Ucraina". Lo dichiara il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned
Price, in una nota sottolineando che "gli Stati Uniti non riconoscono e non
riconosceranno mai la presunta annessione della penisola da parte della Russia.
La Crimea è Ucraina".
15:13
Ucraina, Tajani:
"Invio caccia in Ucraina? Per ora non è sul tavolo"
Per ora l'argomento
dell'invio di caccia dall'Italia all'Ucraina "non è sul tavolo". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Mezz'ora in più su Rai 3.
"Formare un pilota da caccia per aerei sofisticati", ha spiegato Tajani,
"richiede mesi di addestramento, bisogna formarli bene". "Noi siamo sempre stati
impegnati a inviare materiale per difendere il territorio ucraino", ha
proseguito il titolare della Farnesina, "stiamo inviando batterie anti-aeree
Sampt-T che realizziamo con la Francia, più materiale di altro tipo che serve
all'esercito ucraino".
15:20
Tajani, quello di
Zelensky "non era un attacco" a Berlusconi
Le critiche del
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al leader di Forza Italia, Silvio
Berlusconi, durante la conferenza stampa a Kiev con la premier Giorgia
Meloni sono state "molto montate". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, intervenendo a Mezz'ora in più su Rai 3. "E' stato molto montato, perchè
lo stesso Zelensky ha detto che secondo lui, Berlusconi non si rendeva conto di
quello che accadeva in Ucraina ma non era un attacco, basta ascoltare il suo
tono", ha dichiarato Tajani. "Credo che adesso si debba guardare avanti", ha
aggiunto, "penso non sia mai stato messo in dubbio che Berlusconi sia
filo-atlantico e un uomo di pace".
15:24
Tajani, "mi auguro
Cina abbia detto verità" su armi a Mosca
"Mi auguro che la
Cina abbia detto la verità che non invia e non intende inviare armi alla
Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo
a Mezz'ora in più su Rai 3. "La Cina può svolgere un ruolo importante", ha
ribadito il titolare della Farnesina, "è l'appello che ho lanciato anche al capo
della diplomazia cinese, Wang Yi, nei nostri recenti incontri: ho insisto
affinchè la Cina intervenisse presso la Russia per fermare Putin e farlo sedere
al tavolo di pace".
16:03
Kiev, russi ritirano
nave con missili Kalibr dal Mar Nero
Le forze russe hanno
ritirato dal Mar Nero l'unica nave con missili Kalibr presente sabato nel
bacino. Lo riferisce la Marina ucraina secondo quanto riportato da Ukrainska
Pravda. Secondo la Marina, ora sette navi di Mosca sono in servizio nel Mar
Nero, tra queste non ci sono portamissili. Nel Mar d'Azov è presente una nave
russa.
16:17
Ucraina: prima
visita ministro Esteri saudita a Kiev da Zelensky
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Kiev il ministro degli Esteri
saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud. Come riferito dallo stesso
Zelensky su Telegram, si tratta della prima visita ufficiale del capo della
diplomazia di Riad in Ucraina dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche.
"Mi aspetto che darà nuovo slancio all'intensificazione del nostro dialogo
reciprocamente vantaggioso", ha scritto il leader di Kiev, ringraziando l'Arabia
Saudita per "aver sostenuto la pace in Ucraina, la sua sovranità e integrità
territoriale".
17:08
Usa, Sullivan: "Armi
a Kiev per arrivare al negoziato"
Washington è
convinta che prima o poi il conflitto ucraino sarà risolto al tavolo dei
negoziati ed è convinta che le forniture di armi serva per rafforzare le
posizioni negoziali di Kiev. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza
nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Alla fine, vedremo che la soluzione
di questo conflitto andrà sul piano diplomatico. Il nostro compito è dare carte
vincenti agli ucraini sul campo di battaglia in modo che abbiano più argomenti
al tavolo dei negoziati", ha spiegato Sullivan in un'intervista alla Nbc.
17:10
Ucraina, il ministro
della Difesa estone a Kiev annuncia aiuti militari
Il ministro della
Difesa estone Hanno Pevkur ha incontrato a Kiev il suo omologo ucraino Oleks
Reznikov e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, che
questa volta consiste in armi e attrezzature donate alle forze per le operazioni
speciali. Lo riporta la radiotelevisione estone Err. Il pacchetto consegnato
oggi comprende fucili d'assalto, pistole, droni, termocamere, generatori e
caricabatterie.
17:14
Usa, Sullivan:
"Costi reali per la Cina se fornirà armi a Mosca"
Ci saranno "costi
reali" per la Cina se fornirà armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina. E'
il nuovo monito rivolto a Pechino dagli Stati Uniti. "Dalla nostra prospettiva,
in effetti, questa guerra rappresenta una vera complicazione per Pechino e
Pechino dovrà prendere le sue decisioni su come procedere, se fornire assistenza
militare - ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa
Bianca, Jake Sullivan - ma se sceglierà questa strada, questo comporterà costi
reali per la Cina".
17:41
Ucraina, Kirill: "Il
Donbass è un avamposto russo"
Il Donbass oggi è un
avamposto della Russia ed è importante che i giovani che vi abitano capiscano ne
siano consapevoli. Lo ha detto il patriarca di Mosca Kirill in un incontro con i
bambini del Donbass, come riporta Ria Novosti. "Il Donbass oggi è un avamposto
del mondo russo, un avamposto della Russia... È straordinario che la Russia si
sia battuta per la protezione degli interessi del Donbass e non abbia permesso
l'attuazione dei piani che i nostri avversari avevano... Il Donbass è una parte
organica inseparabile della Russia. Mi piacerebbe molto che i giovani del
Donbass, i bambini del Donbass capissero che quello che sta succedendo ora è
giusto per noi", ha detto rivolgendosi ai bambini il patriarca.
18:05
Ucraina, Berlino:
"Giudichiamo la Cina dai fatti non dalle parole"
Il ministro della
Difesa tedesco Boris Pistorius ha reagito con scetticismo ai piani della Cina su
come porre fine al conflitto ucraino. "Quando sento notizie - e non so se siano
vere - secondo cui la Cina potrebbe pianificare di fornire droni kamikaze alla
Russia presentando allo stesso tempo un piano di pace, allora suggerisco di
giudicare la Cina dalle sue azioni e non le sue parole", ha dichiarato in
un'intervista all'emittente pubblica tedesca citata dalla Cnn.
18:44
Ucraina, Zelensky
firma nuove sanzioni "contro coloro che aiutano la Russia a fare la guerra"
Il
presidente Volodymyr Zelensky ha firmato 3 decreti del Consiglio di sicurezza e
difesa nazionale con nuove sanzioni "contro coloro che sono coinvolti o aiutano
la Russia a fare la guerra e distruggere vite e persone", afferma nel consueto
discorso serale.
Le sanzioni sono
"contro quei russi coinvolti nel rapimento di bambini ucraini; contro quei
rappresentanti del settore sportivo russo che stanno cercando di mettere lo
sport al servizio dell'aggressione; contro coloro che aiutano a mantenere
strutture mercenarie in Russia per la guerra contro l'Ucraina e tutte le persone
libere". "La pressione dall'Ucraina continuerà. La pressione del mondo sullo
stato terrorista continuerà", aggiunge Zelensky.
18:54
Ucraina, Shmyhal:
"Riconciliazione con la Russia impossibile nei prossimi 100 anni"
"La riconciliazione
tra Russia e Ucraina non è possibile nei prossimi 100 anni". Lo ha dichiarato il
primo ministro ucraino, Denis Shmyhal, parlando ai media locali in un'intervista
rilanciato dalle agenzie russe. "Riconciliazione, cooperazione? Non sono
possibili almeno nei prossimi 100 anni", ha detto Shmyhal, "la Russia deve prima
cambiare, essere democratizzata, smilitarizzata e denuclearizzata". Shmyhal ha
poi avvertito che il congelamento del conflitto non può essere visto come
un'opzione per prevenire morti. "L'Ucraina non vede alcun compromesso riguardo
alla sua integrità territoriale", ha aggiunto il premier rispondendo alla
domanda sulla disponibilità di Kiev a fare concessioni territoriali a Mosca.
19:27
Kiev, in Crimea ci
sono 180 prigionieri politici detenuti
In Crimea ci sono
180 prigionieri politici detenuti. Lo ha affermato Dmytro Lubinets, commissario
per i diritti umani della Verkhovna Rada, il parlamento unicamerale ucraino,
citato dal Guardian. "A causa del costante timore della resistenza ucraina, la
Russia non ferma la dura repressione e la persecuzione dei nostri cittadini
nella Crimea temporaneamente occupata con perquisizioni illegali, casi penali
inventati, condanne inventate, in particolare, contro rappresentanti indigeni
della penisola: i tatari di Crimea", ha precisato Lubinets. Il funzionario
ucraino ha poi definito la recente morte nelle celle del Cremlino di due
prigionieri politici torturati una "flagrante violazione dei diritti umani
fondamentali e delle norme del diritto internazionale da parte della Russia"
20:27
Zelensky, "Il
diritto internazionale prevarrà in Donbass e Crimea"
"L'Ucraina non
abbandonerà nessuno, non lascerà nessuno al nemico. Restituiremo tutta la nostra
gente e tutto ciò che è nostro dalla prigionia russa. Nel 2014, l'aggressione
russa è iniziata con il sequestro della Crimea. È logico che liberando la
Crimea, porremo una fine storica a qualsiasi tentativo della Russia di rovinare
la vita degli ucraini e di tutti i popoli dell'Europa e dell'Asia che un tempo
il Cremlino affermava di conquistare. Il diritto internazionale prevarrà qui,
nelle terre dell'Ucraina: nel Donbass, nel Mar d'Azov, nella regione di Kherson
e in Crimea". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo
discorso serale riportato da Ukrinform.
Kyjiv chiama
Minsk. I bielorussi che combattono per la libertà a fianco degli ucraini.
Francesco Brusa su L’Inkiesta il 27 febbraio 2023.
I soldati del
reggimento Kalinoŭski, intitolato a uno scrittore rivoluzionario dell’Ottocento,
hanno partecipato all’Euromaidan e restano convinti che il destino dei due Paesi
sia legato: «Lukashenka mantiene il potere esclusivamente per il sostegno di
Putin»
Kyjiv. «Tornare a
casa, semplicemente tornare a casa»: per alcune delle persone che combattono
contro la Russia a fianco delle truppe di Kyjiv questo è l’obiettivo principale,
sia metaforico che concreto. Si tratta dei membri del reggimento Kastuś
Kalinoŭski, composto da cittadini e cittadine della Bielorussia e ufficialmente
formatosi pochi giorni dopo l’invasione del paese iniziata da Putin lo scorso 24
febbraio.
«Abbiamo deciso di
riporre tutte le nostre risorse e tutte le nostre forze in questa lotta nella
convinzione che dopo la vittoria dell’Ucraina, dopo l’affermazione dell’Ucraina
come nazione, ci sarà anche l’affermazione della Bielorussia», dicono due
combattenti del reggimento che abbiamo incontrato nel loro quartier generale.
«Perché tutti noi vogliamo far ritorno in patria».
Uno sforzo comune
A cavallo del nuovo
anno, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una possibile offensiva
russa che parta proprio dai territori della piccola repubblica retta da
Alexander Lukashenka (al potere dal 1994). Intanto, dopo l’importante
liberazione di Kherson da parte delle truppe ucraine a novembre, negli ultimi
giorni l’inerzia sul fronte di Bakhmut nel Donbas sembra invece spostarsi a
favore dell’esercito invasore, che ha conquistato il centro di Soledar.
Operazioni in cui
quasi sempre è stato coinvolto anche il reggimento Kalinoŭski – un’unità di
battaglia in cui all’inizio della guerra sono confluite circa quattrocento
persone, un numero piccolo ma significativo se si pensa che i bielorussi
all’interno del territorio ucraino dovrebbero essere meno di trecentomila e che
si tratta, secondo le stime, della seconda nazionalità per numero di persone
coinvolte nell’esercito, dopo quella georgiana.
«La situazione non è
semplice», ci spiegano i combattenti. «Il nostro compito è sostanzialmente
quello di aiutare le truppe ucraine a mantenere le proprie posizioni.
Recentemente (prima della presa di Soledar, ndr), ci sono stati quattro
tentativi di offensiva da parte dei russi, tutti e quattro respinti. Ma il
problema è che abbiamo a che fare con vere e proprie “orde”: non dobbiamo
dimenticarci che la Russia è un paese immenso e pieno di risorse e può contare
su un numero di persone elevatissimo da mandare in guerra».
Ciononostante, come
è stato evidenziato più volte dall’inizio del conflitto e come sottolineato
anche dalla forte presenza di truppe mercenarie nelle fila russe nonché di
coscritti provenienti dalle carceri, ben diverse sembrano essere le motivazioni
sui due fronti opposti. Proseguono infatti i membri del reggimento bielorusso:
«Da una parte si combatte per difendere la propria casa e il proprio futuro,
dall’altra si trovano uomini che sono andati in un altro Paese senza scopo
alcuno. Non c’è nessun dubbio per noi su chi vincerà».
Per chi si è
arruolato nell’unità Kalinoŭski, però, la questione della «vittoria» o comunque
delle conseguenze politiche che avrà il conflitto in corso assume una sfumatura
particolare, che riguarda appunto il futuro del Paese alleato de facto di Putin.
Che il destino di Ucraina e Bielorussia siano intrinsecamente legati è una
convinzione che, per tanti, precede l’invasione militare dello scorso anno.
Già nel 2013-14,
diversi attivisti bielorussi si unirono alle proteste di Euromaidan (Mykhailo
Zhyznevskyi, per esempio, un emigrato dalla regione di Gomel, fu fra i primi
caduti di quegli eventi e venne successivamente insignito del titolo di «eroe
dell’Ucraina») così come successivamente si arruolarono in alcuni battaglioni
militari attivi nella guerra del Donbas. Un piccolo monumento nelle strade di
Kyjiv ricorda questi scambi e queste vicende, con i due motti nazionali («Gloria
all’Ucraina» e «Lunga vita alla Bielorussia») a unire idealmente le due
comunità.
«Nel nostro
reggimento ci sono persone che sono contro il potere politico attualmente al
governo a Minsk», ci raccontano i membri del Kalinoŭski. «La maggior parte di
noi ha partecipato alle proteste del 2020 o, comunque, a manifestazioni e
contestazioni precedenti. Nessuno di noi, per questo motivo, può far rientro in
Bielorussia. In generale, i legami con i nostri compagni ucraini sono sempre
stati forti».
«Direi fin dalle
prime settimane successive all’indipendenza dei nostri paesi negli anni Novanta,
c’era chi veniva in Bielorussia dall’Ucraina per partecipare a proteste e
dimostrazioni e chi viceversa andava dalla Bielorussia all’Ucraina per gli
stessi motivi. Poi, però, il nostro paese ha iniziato ad avere un suo sviluppo
più specifico ed è diventato via via più “chiuso”: questo ha fatto sì che anche
le relazioni con la comunità ucraina si indebolissero e che non ci fosse
all’esterno una grande consapevolezza delle repressioni e delle difficoltà che
attraversavamo».
Una mancanza di
consapevolezza che – sempre secondo i membri del reggimento – rischia di
alimentare lo “stigma” negativo nei confronti della comunità bielorussa in
Ucraina e in generale della popolazione bielorussa.Come suggeriscono infatti
alcune indagini sociologiche dello scorso settembre, la percezione sociale verso
questi gruppi si è fortemente deteriorata in Ucraina in seguito all’invasione,
in maniera non dissimile da quanto è accaduto per cittadini e cittadine della
Russia.
«Ma si tratta di una
falsa equivalenza», affermano i membri del reggimento. «Quando si è trattato di
identificare un nemico, si è guardato non solo a Lukashenka ma a tutta la
Bielorussia. Invece non è così: la grande maggioranza delle persone che è
scappata dal Paese ma anche che è rimasta non appoggia le sue azioni e non
appoggia la decisione di lanciare una guerra».
Indipendenza dalla
Russia
Al contrario –
sostengono i combattenti bielorussi – ora il nemico comune è la Russia
imperialista di Putin. «Lukashenka riesce a mantenersi al potere esclusivamente
per il sostegno della vicina Federazione. Si tratta di un assunto che,
soprattutto dal 2020 in poi, è diventato consapevolezza comune per sempre più
persone. Ed è anche per questo che abbiamo deciso di venire a combattere: si è
capito che, sfortunatamente, le proteste pacifiche non hanno la possibilità di
intaccare l’attuale sistema di potere in Bielorussia».
Per chi milita nel
reggimento bielorusso le due questioni si trovano inevitabilmente intrecciate:
«Un tempo era l’Urss a essere una “prigione delle nazioni”, mentre adesso lo è
la Russia di Putin: un Paese ultranazionalista che umilia tutte le identità dei
popoli. Finché esiste in questa forma, nessuno può restare tranquillo».
In questo senso, il
nome adottato dall’unità militare è particolarmente significativo: Kastuś
Kalinoŭski fu infatti uno scrittore e rivoluzionario che si mise a capo
dell’insurrezione antizarista del 1863/64, in una chiave “rossa” e “socialista”,
con attenzione alla questione agraria e contadina, ma anche
patriottico-nazionalistica, di riscoperta e protezione dell’identità
linguistico-culturale del popolo bielorusso.
La sua figura è
tornata alla ribalta negli ultimi anni, sia perché nel 2019 i suoi resti sono
stati casualmente ritrovati in Lituania assieme a quelli di un’altra ventina di
partecipanti all’insurrezione, sia perché è diventato un simbolo sempre più
utilizzato durante le proteste anti-governative e dallo stesso Lukashenka
(mettendo in campo ovviamente diverse interpretazioni e diversi accenti, come
ben ricostruito da questa analisi).
Per chi combatte in
Ucraina è dunque un’immagine di autonomia e indipendenza dalla Russia così come
di radicale distanza dalle politiche del governatore bielorusso: «La propaganda
tenta di dipingerci come una giunta militare che vorrebbe sequestrare il potere
e che non riconosce alcun rappresentante della gente al di fuori di noi stessi»,
spiegano i membri del reggimento. «Al contrario, il fucile che imbracciamo oggi
non salirà al potere. Quello in cui speriamo è una Bielorussia con libere
elezioni e con un quadro di legalità, indipendente dalla dittatura attuale e da
quella russa».
Non stupisce che il
conflitto in Ucraina venga percepito come lo «scontro finale» in tal senso.
Soprattutto dal momento che – come affermano diverse testimonianze e nonostante
varie forme di sabotaggio e resistenza messe in atto dagli attivisti dopo il 24
febbraio – un qualsiasi cambiamento dall’interno del paese retto da Lukashenka
sembra attualmente impossibile, dato l’alto grado di repressione statale da un
lato e il forte scoramento della società civile dall’altro.
Per chi spera in un
futuro diverso, allora, combattere può sembrare una necessità più che una
scelta: «Il fatto è che qui, sostanzialmente, tutti sono contro il tuo nemico,
invece in Bielorussia nessuno è al tuo fianco se non te stesso e la tua cerchia
di conoscenze, mentre lo stato, la polizia e l’esercito sono contro di te»,
concludono i membri del reggimento Kalinoŭski. «Ci sentiamo più al sicuro qui in
Ucraina, mentre c’è una guerra, che nel nostro Paese».
La Repubblica.
Zelensky: "Situazione a Bakhmut sempre più complicata"
Nuove minacce di
escalation nucleare da parte russa. Kiev annuncia la controffensiva di
primavera. Washington: "Gravi conseguenze se Pechino fornirà armi a Mosca"
Mentre Mosca accusa
di nuovo l'Occidente di partecipare attivamente al conflitto, il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ricorda "l'aggressione russa in Crimea", nove anni
fa, e promette di riconquistare la penisola: "Quella è la nostra terra",
afferma. E da Washington arriva l'assicurazione che gli Usa non riconosceranno
mai la "presunta annessione russa".
Punti chiave
21:44
Zelensky, la
situazione a Bakhmut è sempre più complicata
11:00
Cremlino: "Per ora
non ci sono presupposti per soluzioni di pace. Ed è impossibile che la Crimea
torni all'Ucraina"
07:50
Kiev: massiccio
attacco russo con droni Shahed nell'Ovest
02:04
Medvedev parla di
nuovo del rischio di escalation nucleare
01:21
Zelensky ha silurato
il comandante delle forze in Donbass
00:32
Stoltenberg: la Nato
dovrà rafforzare la difesa dell'area baltica
Durante il summit di
Vilnius del prossimo luglio, la Nato dovrà "concentrarsi sul rafforzamento della
sua frontiera orientale" e, in particolare, della regione baltica. Lo ha
affermato il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in
un'intervista alla televisione lituana.
01:21
Zelensky ha silurato
il comandante delle forze in Donbass
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rimosso dal suo incarico il generale Eduard
Moskalev, comandante della Joint Forces Operation, ovvero dell'operazione nel
Donbass. Il decreto di licenziamento, n.113/2023, è stato pubblicato sul sito
web della presidenza ucraina. Moskalev era stato nominato comandante
dell'operazione delle forze congiunte nel marzo dello scorso anno.
02:04
Medvedev parla di
nuovo del rischio di escalation nucleare
L'ex presidente
russo Dmitry Medvedev, oggi numero due del consiglio di sicurezza nazionale,
torna ad agitare lo spettro della catastrofe nucleare avvertendo che se
l'Occidente continuerà ad armare Kiev il rischio sarà sempre più concreto.
"Certo, si può
continuare a pompare armi al regime neofascista di Kiev e bloccare ogni
possibilità di rilanciare i negoziati" ha dichiarato in un lungo articolo
a Izvestia. "I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire
che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale. Sconfitta per tutti.
Apocalisse. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a
quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni".
04:41
Kiev: dall'inizio
della guerra oltre 71.500 crimini di guerra russi
Dal giorno
dell'invasione, l'ufficio del procuratore generale ucraino ha registrato oltre
71.500 crimini di guerra russi e crimini di aggressione in Ucraina. Lo rende
noto Kyiv Independent.
La Statua della
Libertà decapitata da La Madre Patria chiama, l'ultimo video della propaganda
russa
05:44
Kiev: intercettati e
abbattuti tre droni
Il comando operativo
nord dell'Ucraina ha reso noto che l'esercito ha abbattuto un drone Shahed sopra
Chernihiv Oblast. Stando a Kyiv Independent, successivamente, il comando
operativo ha comunicato che altri due droni sono stati intercettati, senza
specificare in quale regione. L'allarme antiaereo è ancora attivo in molte aree.
Ieri la Russia - hanno fatto sapere le autorità ucraine - ha lanciato un attacco
utilizzando droni Shahed di fabbricazione iraniana.
07:50
Kiev: massiccio
attacco russo con droni Shahed nell'Ovest
Un massiccio
attacco è stato lanciato dall'esercito russo, con droni iraniani Shahed e razzi,
nella notte e fino a questa mattina contro la città dell'Ucraina occidentale
Khmelnytskyi: un civile è rimasto ucciso e altri quattro feriti. Lo riportano i
media ucraini.
"Un altro massiccio
attacco terroristico contro la comunità di Khmelnytskyi. Questa volta il nemico
ha usato droni. Finora sappiamo di un morto e 4 feriti", ha detto il sindaco di
Khmelnytskyi, spiegando che numerosi edifici residenziali sono stati colpiti e
sono scoppiati incendi. Le unità militari ucraine hanno abbattuto 11 droni.
08:34
Washington: "Gravi
conseguenze se Pechino fornirà armi a Mosca per combattere in Ucraina"
Gli Stati Uniti
hanno avvertito la Cina di gravi conseguenze in caso di fornitura di armi a
Mosca per sostenere l'invasione dell'Ucraina. Washington e i suoi alleati della
NATO temono che la leadership cinese stia prendendo in considerazione la
possibilità di fornire equipaggiamento letale, compresi i droni. "Pechino dovrà
prendere le proprie decisioni su come procedere, se fornire assistenza militare,
ma se percorrerà questa strada ci sarà un costo reale per la Cina", ha detto
il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan al
programma "State of the Union" della CNN.
Pechino ha rifiutato
di condannare l'attacco di Mosca contro l'Ucraina, da ultimo sabato in una
riunione del Gruppo dei Venti (G20) in India. Ha pubblicato una proposta di
cessate il fuoco venerdì, primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina,
ma l'offerta è stata accolta con scetticismo tra gli alleati occidentali
dell'Ucraina. "Quando sento rapporti - e non so se siano veri - secondo i quali
la Cina potrebbe pianificare di fornire droni kamikaze alla Russia presentando
allo stesso tempo un piano di pace, allora suggerisco di giudicare la Cina dalle
sue azioni e non dalle sue parole", ha detto domenica il ministro della Difesa
tedesco Boris Pistorius all'emittente pubblica tedesca Deutschlandfunk.
Anche il direttore
della CIA William Burns si è espresso sulla Cina in un'intervista andata in onda
domenica, affermando che l'agenzia di intelligence statunitense ritiene "che la
leadership cinese stia prendendo in considerazione la fornitura di
equipaggiamento letale".
09:55
Lavrov: "Abbiamo
contrastato i piani dell'Occidente per smembrare la Russia"
"La Russia è
riuscita a contrastare i piani dell'Occidente di smembrarla e isolarla", ha
detto il ministro degli Esteri Sergej Lavrov in un incontro con i capi degli
organi territoriali del ministero degli Esteri, secondo quanto riporta Ria
Novosti. "Il mondo è entrato in un'era di cambiamento radicale e irreversibile.
Siamo riusciti non solo a contrastare i piani dell'Occidente collettivo di
isolare e persino smembrare la Russia, ma anche a garantire una cooperazione
continua con la stragrande maggioranza dei membri della comunità
internazionale", ha detto il ministro.
"Mosca - ha aggiunto
- sta sviluppando legami sempre più stretti ed efficaci con la maggioranza dei
Paesi del mondo".
10:03
Prigozhin: "Gli
ucraini stanno usando agenti tossici"
Il fondatore del
gruppo di mercenari Wagner Evgenj Prigozhin torna a parlare sui social dopo
essere sparito dai media ufficiali russi presumibilmente per il suo continuo
dissenso nei confronti dei vertici militari di Mosca. Oggi Prigozhin si è
rifatto vivo su Telegram accusando l'esercito ucraino di usare diversi agenti
tossici contro le truppe russe nel Donbass, come riporta la Tass.
"Per quanto riguarda
la chimica, viene utilizzata attivamente dalle unità dell'esercito ucraino: vari
composti del fosforo e sostanze velenose in polvere e in forma gassosa. Le
lanciano con l'aiuto di munizioni, da veicoli aerei senza pilota e con altri
metodi", ha dichiarato l'ufficio stampa di Wagner. Un soldato ucraino catturato
ha anche raccontato "degli esperimenti che i gestori stranieri conducono sui
militari ucraini", ha detto Prigozhin. Questi esperimenti vengono condotti "per
ridurre la soglia del dolore e cercare di creare il cosiddetto soldato
universale con l'aiuto di un effetto indotto da farmaci", ha sottolineato.
10:13
Cina: "Canali di
comunicazione aperti con tutti, anche con Kiev"
La Cina ha fatto
sapere di avere canali di comunicazione aperti con tutti, "anche con Kiev".
Pechino ha protestato formalmente contro l'ultima tornata di sanzioni Usa alle
sue aziende sospettate di avere rapporti con l'esercito russo, esprimendo "ferma
opposizione" e promettendo adeguate contromisure. "Deploriamo e respingiamo la
mossa", ha affermato nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli
Esteri Mao Ning, esortando gli Stati Uniti a ritirare le sanzioni unilaterali.
"La Cina continuerà ad adottare le misure necessarie per salvaguardare con
fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi", ha aggiunto
Mao.
10:26
Ucraina, Cina
minaccia contromisure dopo le nuove sanzioni Usa
La Cina ha
protestato formalmente contro l'ultima tornata di sanzioni Usa alle sue aziende
sospettate di avere rapporti con l'esercito russo, esprimendo "ferma
opposizione" e promettendo adeguate contromisure. "Deploriamo e respingiamo la
mossa", ha affermato nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli
Esteri Mao Ning, esortando gli Stati Uniti a ritirare le sanzioni
unilaterali. "La Cina continuerà ad adottare le misure necessarie per
salvaguardare con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese
cinesi", ha aggiunto Mao.
10:43
Ministro della
Difesa tedesco: "Necessario aumentare le spese militari"
La Germania deve
necessariamente aumentare le spese militari. Lo ha detto il ministro della
Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un'intervista ieri sera all'emittende Ard.
Al momento la Bundeswehr può contare sui 100 miliardi del fondo speciale. "Poi
sarà chiaro che abbiamo bisogno di più", ha spiegato Pistorius. Per questo è
importante che "il bilancio del ministero della Difesa cresca, e cresca in modo
significativo, perché altrimenti non riusciremo a svolgere i compiti che non
riusciamo a svolgere da 30 anni", ha aggiunto. Pistorius ha sottolineato che
questo vale anche per il periodo successivo alla guerra russa in Ucraina.
11:00
Cremlino: "Per ora
non ci sono presupposti per soluzioni di pace. Ed è impossibile che la Crimea
torni all'Ucraina"
La Russia "per ora
non vede alcun presupposto affinchè la situazione in Ucraina vada in una
direzione pacifica e questo comporta il proseguimento dell'operazione speciale".
Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando con la
stampa la proposta di una soluzione pacifica del conflitto, avanzata dalla Cina
la settimana scorsa. Il ritorno della Crimea all'Ucraina "è impossibile" perché
è "una parte integrante della Russia".
11:17
Cremlino:
"preoccupati" per la situazione in Transnistria
Il Cremlino si è
detto "preoccupato" per la situazione in Transnistria, la regione separatista
della Moldavia, sottolineando che "è oggetto di massima attenzione" a Mosca. "La
situazione è turbolenta ed è provocata dall'esterno", ha denunciato il portavoce
Dmitri Peskov ai giornalisti. "Sappiamo come i nostri oppositori nel regime di
Kiev e nei Paesi europei siano capaci di vari tipi di provocazioni", ha aggiunto
il portavoce del Cremlino.
11:54
Peskov:
"Inimmaginabile che la Crimea torni sotto Kiev"
E' "inimmaginabile"
che la Crimea possa tornare a far parte dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il
portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Interfax.
La Crimea "è parte integrante della Federazione Russa", ha detto il portavoce
durante un punto stampa.
12:29
Podolyak: "La Crimea
non più questione separata, è sul tavolo del negoziato"
All'Ucraina "non
interessa" l'opinione della Russia sui piani di Kiev di liberare la Crimea e ora
la questione della liberazione della penisola occupata dai russi non è più un
caso separato da trattare in eventuali negoziati, ma rientra nella questione
della liberazione dell'Ucraina. È quanto ha detto in tv Mykhailo Podolyak,
consigliere della presidenza ucraina di Volodymyr Zelensky, secondo quanto
riporta Unian. "Fino alla metà della guerra, la Crimea era considerata come un
pacchetto separato, mentre ora la questione viene discussa in un unico pacchetto
come un territorio che deve essere liberato", ha detto Podolyak, aggiungendo che
è importante che i partner dell'Ucraina pongano correttamente l'accento sulla
questione della Crimea. "Non ci interessa quello che la Russia vorrà o non vorrà
accettare. Abbiamo un enorme debito con i tatari di Crimea", ha detto ancora.
13:04
Morto Pavlosky, ex
consigliere di Putin poi divenuto critico
E' morto a Mosca lo
scienziato politico Gleb Pavlosky, ex importante consigliere di Vladimir Putin,
poi estromesso nel 2011 e diventato un critico del Cremlino. La sua scomparsa
all'età di 71 anni, in seguito a grave malattia, è stata resa nota da Simon
Kordonsky dell'Alta scuola di economia di Mosca al quotidiano russo Vedomosti.
Nato a Odessa, Pavlosky aveva attivamente sostenuto i politici filorussi in
Ucraina, ricorda Ukrainska Pravda. Dissidente politico durante l'era sovietica,
Pavlosky era stato esiliato nella repubblica russa orientale di Komi negli anni
Ottanta. Alla fine degli anni Novanta diventò uno stretto consigliere di
Vladimir Putin, tramite la sua Fondazione per la politica efficace che gestì la
prima campagna elettorale del futuro leader russo. Ebbe poi un ruolo di primo
piano nello sviluppo della "democrazia gestita" grazie alla quale il leader del
Cremlino riuscì a far marginalizzare, esiliare o arrestare tutti i possibili
rivali politici, ricorda Moscow Times. Ma nel 2011 cadde in disgrazia,
probabilmente perché era favorevole ad un secondo mandato presidenziale
di Dmitry Medvedev invece del ritorno di Putin alla presidenza. Da allora
Pavlosky era diventato un critico del Cremlino, raccontando spesso gli intrighi
dietro le quinte. "Putin è stato fortunato. Questo è molto pericoloso per un
giocatore, perché gli fa credere di avere la fortuna dalla sua parte - aveva
detto Pavlosky al Financial Times dopo l'invasione dell'Ucraina- Quando giochi
alla roulette russa, pensi che Dio sia dalla tua parte fino a quando non parte
la pallottola". Ma anche se era diventato un critico del Cremlino, Pavlosky non
ha lasciato un buon ricordo in Ucraina. Ukrainska Pravda rievoca oggi il suo
ruolo per sostenere il candidato filorusso Viktor Yanukovych alle presidenziali
del 2004. Allora vinse Viktor Yushenko, malgrado un avvelenamento da diossina
che fu attribuito ai russi. La procura di Kiev riferì poi di un audio dei
servizi di Mosca nel quale si attribuiva a Pavlosky l'idea di avvelenare
Yushchenko. Pavlosky ha sempre negato.
13:31
Mosca: distrutto un
deposito di munizioni a Bakhmut e abbattuti 5 droni
Mosca ha rivendicato
la distruzione di un deposito di munizioni vicino a Bakhmut, città sotto assedio
dell'Ucraina orientale, e l'abbattimento di cinque droni in dotazione
all'esercito di Kiev. In una nota il ministero della Difesa russo ha anche reso
noto di aver intercettato e distrutto quattro missili Himars.
14:09
Appello di Baerbock
a Putin: "Torna ad aderire a New Start"
La ministra degli
Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha chiesto oggi al presidente russo Vladimir
Putin di tornare ad aderire al trattato 'New Start' sul controllo delle armi
nucleari. "Facciamo insieme un appello al presidente Putin perché torni al New
Start e riprenda il dialogo sul trattato con gli Stati Uniti", ha dichiarato a
margine della Conferenza sul disarmo a Ginevra.
La Russia sta
minando il sistema di controllo degli armamenti da cui dipendiamo tutti, ha
affermato Baerbock. E la sospensione del trattato "New Start" - ha aggiunto - è
stata "solo l'ultimo colpo che la Russia ha inferto alla nostra architettura di
controllo e al Trattato di non proliferazione".
14:34
Putin conferisce
l'Ordine dell'amicizia all'attore americano Steven Seagal
Il presidente russo,
Vladimir Putin, ha conferito l'Ordine dell'Amicizia all'attore americano Steven
Seagal. Lo riportano le agenzie russe, citando il relativo documento. Seagal -
che ha anche cittadinanza serba e russa - è da tempo un fan del leader del
Cremlino e dal 2018 è rappresentante speciale della Russia per le relazioni
umanitarie con gli Stati Uniti. L'estate scorsa si era recato in Donbass per
girare un documentario che mostrasse la guerra dal punto di vista russo.
14:54
Ucraina,
sottosegretario generale Onu: "La base di Brindisi impegnata dall'inizio"
"La base di
Brindisi ha fornito assistenza soprattutto a coloro i quali lavorano per le
Nazioni Unite affinché possano continuare a farlo in sicurezza nello scenario di
guerra". Così il sottosegretario generale Onu per il supporto operativo, Atul
Khare, a Brindisi, a margine della tavola rotonda a Brindisi dal titolo
'Supporting Peace with new alliances and skills: a focus on UN Centre in
Brindisi'. "Nei sette giorni successivi all'inizio del conflitto, dalla base
sono stati inviati circa 30 veicoli blindati che hanno aiutato e supportato il
personale Onu. Vorrei ringraziare il presidente della Regione Puglia e l'allora
prefetto", ha concluso.
15:05
Attivisti bielorussi
rivendicano la distruzione di un aereo russo
Partigiani
bielorussi contro la guerra in Ucraina hanno rivendicato di aver distrutto un
aereo militare russo in una base aerea vicino Minsk. "Questa è la diversione di
maggior successo dall'inizio del 2022. L'operazione è stata condotta da due
bielorussi. Hanno impiegato dei droni e hanno già lasciato il paese", ha
twittato Franak Viacorka, un consigliere della leader dell'opposizione in
esilio, Svetlana Tikhanovskaya.
L'attacco con due
droni alla base aerea di Machulishchy, a 12 chilometri da Minsk, è stato
rivendicato dall'organizzazione partigiana bielorussa Bypol, riferisce il
Guardian. Il bersaglio colpito è un aereo Beriev A-50, "uno dei nove Awacs delle
forze aeree russe dal valore di 330 milioni di dollari", sottolineano i
partigiani, usando la sigla per gli aerei con sofisticati sistemi di
ricognizione.
Non vi sono conferme
indipendenti al grave danneggiamento dell'aereo, ma blogger militari russi e
bielorussi hanno parlato ieri di esplosioni nella base aerea. Interrogato oggi
in merito dai giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto:
"non abbiamo nulla da dire a questo proposito".
15:24
Metsola: "L'Europa
può essere orgoliosa di quanto fatto. Ma deve fare di più"
"L'Europa può essere
orgogliosa delle scelte che ha fatto. Abbiamo resistito, abbiamo smentito i
cinici e ci siamo riuniti come mai prima d'ora. Ma dobbiamo ancora fare di più
per sostenere l'Ucraina e aiutare i nostri cittadini ad affrontare l'elevata
inflazione, i costosi prezzi dell'energia e il caro bollette". Lo ha
dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel discorso
in occasione della Settimana del Parlamento europeo.
15:46
Kiev: condannati due
soldati russi, hanno bombardato le città a Est
Un tribunale
ucraino ha condannato due soldati russi catturati per aver preso parte al
bombardamento delle aree residenziali nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito il
Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), secondo quanto riportato dal Guardian. Uno
dei soldati ha ricevuto una condanna a 10 anni e l'altro di nove, ha dichiarato
la Sbu in una nota. Entrambi "hanno preso parte attiva negli attacchi alle città
ucraine sul fronte orientale" e sono stati catturati l'anno scorso.
Secondo gli ucraini,
uno dei soldati aveva iniziato a combattere per i separatisti sostenuti dalla
Russia nell'Ucraina orientale nel 2014 e lo scorso anno ha combattuto per
l'esercito russo nella zona di Bakhmut nell'Ucraina orientale. L'altro era
responsabile delle truppe russe che bombardavano le città orientali di
Severodonetsk e Lysychansk, ed è stato catturato insieme ad alcuni dei suoi
subordinati.
"A seguito delle
indagini, sono state raccolte prove indiscutibili sulla colpa di altri due
militanti che si sono uniti ai ranghi dei gruppi di occupazione del Paese
aggressore all'inizio dell'invasione su vasta scala", si legge nella nota.
16:03
Russia: incriminato
due volte per discredito dei militari, il suo supermercato è un tazebao contro
la guerra
L'attivista russo
Dmitry Skurikhin, proprietario di un supermercato nella cittadina di
Russko-Vysotskoye, vicino a San Pietroburgo, in cui dal 2014 ha esibito più di
200 scritte con contenuti politici, e su cui, dall'inizio della guerra, ha
dipinto i nomi delle città ucraine maggiormente colpite, è stato arrestato con
l'accusa di discredito delle forze militari, ha reso noto Ovd-Info,
l'organizzazione indipendente che fornisce assistenza alle vittime di
persecuzioni in Russia.
È la seconda volta
che Skurikhin, che ha 47 anni, viene incriminato ai sensi della legge introdotta
subito dopo l'inizio della guerra, quindi il procedimento diventa penale. Il 24
febbraio giorno dell'anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina,
si è fatto fotografare dalla figlia Ulyana, di fronte al suo negozio, con un
cartello con la scritta "Ci perdoni, Ucraina".
La prima volta, gli
era stata comminata una sanzione di 45mila rubli dopo che, lo scorso settembre,
aveva scritto sulla facciata del negozio uno slogan contro la mobilitazione. Il
nuovo arresto è avvenuto sabato. Ieri un tribunale regionale lo ha condannato a
25 giorni di carcere.
16:21
Bielorussia, chiesta
condanna a 19 anni per Tsikhanouskaya e per l'ex ministro della Cultura Pavel
Latushko
La procura ha
chiesto una condanna a 19 anni di carcere per la leader dell'opposizione
bielorussa ed ex candidata alla presidenza Sviatlana Tsikhanouskaya e per l'ex
ministro della Cultura (2009-2012) Pavel Latushko, sotto processo in contumacia
con le accuse di cospirazione, estremismo e volontà di sovvertire il governo e
la sicurezza dello stato. Chiesta una condanna a 12 anni di carcere per gli
altri imputati, anche loro in esilio all'estero, Maria Moroz, Olga Kovalkova e
Sergey Dylevsky.
17:00
Fiori per Nemtsov in
molte città russe
Fiori in memoria
di Boris Nemtsov sono stati deposti in memoriali spontanei in diverse città
russe, in occasione dell'ottavo anniversario dell'assassinio dell'oppositore
russo, critico dell'occupazione della Crimea. Oltre a Mosca, dove la gente ha
deposto fiori sul luogo dell'omicidio, memoriali per Nemtsov sono apparsi a San
Pietroburgo, Novosibirsk, Yekaterinburg e Kazan, ma anche nelle località
siberiane di Tomsk e Barnaul, riferisce Moscow Times.
A Mosca, hanno
deposto fiori anche dei diplomatici, fra cui la numero due della rappresentanza
Ue, Ivana Norsic. Secondo RusNews, una persona è stata arrestata al memoriale a
Mosca.
Ex vice premier di
Boris Eltsin, il liberale Nemtsov era poi diventato uno dei principali
oppositori del leader russo Vladimir Putin. Fu ucciso da colpi d'arma da fuoco
il 27 febbraio 2015 mentre attraversava il ponte Bolsoj Moskvoreckij, vicino al
Cremlino. Nemtsov era a Mosca per organizzare una marcia di protesta che si
sarebbe dovuta svolgere il giorno dopo contro il governo di Putin e il suo
intervento militare in Ucraina, ad un anno dall'occupazione della Crimea. Per
l'assassinio di Nemtsov furono condannati cinque ceceni, ma non è mai stata
fatta chiarezza sui mandanti in quello che viene considerato un omicidio
politico.
17:14
Vescovi tedeschi:
dalle armi non viene la pace ma Kiev deve difendersi
"Sappiamo che le
armi non creano la pace. Questo è molto chiaro. Le armi fanno morire le persone
ogni giorno. D'altra parte, le consegne di armi sono l'unico modo per rafforzare
il diritto all'autodifesa di un Paese attaccato e sovrano". Lo ha detto
monsignor Georg Batzing, vescovo di Limburgo e presidente della Conferenza
episcopale tedesca, in un'intervista a Swr1. Batzing ha sottolineato il dilemma
etico della Chiesa cattolica in merito alla consegna delle armi all'Ucraina e la
necessità di ricercare la pace attraverso il dialogo. Un dilemma che
difficilmente può essere risolto. "A questo proposito, ci occuperemo ancora una
volta molto intensamente con i partner dell'Ucraina, con Caritas International e
Renovabis, di cercare una soluzione per rendere possibili le iniziative di
pace", ha aggiunto.
17:37
Segretaria al Tesoro
Usa Yellen a sorpresa a Kiev
La segretaria al
Tesoro Usa, Janet Yellen, è arrivata a Kiev per discutere del sostegno
finanziario all'Ucraina. Lo riferisce il Wall Street Journal.
17:59
La Ue proroga le
sanzioni alla Bielorussia per la repressione e l'aiuto a Mosca
Il Consiglio dell'Ue
ha deciso di prorogare per un altro anno, fino al 28 febbraio 2024, le misure
restrittive legate alla repressione interna in Bielorussia e al sostegno del
regime alla guerra contro l'Ucraina. "La decisione è stata presa sulla base
della revisione annuale e considerando la persistente gravità della situazione
interna del Paese e il continuo coinvolgimento della Bielorussia
nell'aggressione russa contro l'Ucraina", ha spiegato il Consiglio Ue. Le misure
restrittive consistono nel divieto di viaggiare nell'Ue e nel congelamento dei
beni per le 195 persone in elenco, tra cui il presidente Aleksandr Lukashenko, e
nel congelamento dei beni per 34 entità. Inoltre, alle persone e alle entità
dell'Ue è vietato mettere fondi a disposizione delle persone elencate,
direttamente o indirettamente. "La Bielorussia rimane inoltre soggetta a
sanzioni economiche mirate, tra cui restrizioni nel settore finanziario, del
commercio, dei beni a doppio uso, della tecnologia e delle telecomunicazioni,
dell'energia, dei trasporti e altro", ha puntualizzato il Consiglio.
18:24
Intelligence Kiev,
non ci sono segnali su invio armi Cina a Mosca
Il capo
dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, ha affermato in un'intervista a Voice
of America di "non condivido l'opinione che la Cina possa fornire armi alla
Russia. Per ora, non credo che la Cina acconsentirà al trasferimento di
armi alla Russia... Non vedo alcun segnale di queste cose", ha detto Budanov,
come riportano i media ucraini.
18:28
Kiev, diminuite
attività dei russi vicino a Vuhledar
Negli ultimi quattro
giorni, le truppe russe sono diventate meno attive nella direzione di Vuhledar.
A riferirlo è il capo del Centro stampa congiunto delle forze di difesa ucraine
nella direzione di Tavrian, Oleksii Dmytrashkivskyi, citato da Ukrinform. "Il
nemico è stato meno attivo per quattro giorni di fila. Nell'ultimo giorno sono
riusciti a portare a termine solo 15 azioni di assalto. Comparando coi dati
mensili, si registravano fino a 60 aggressioni al giorno. Forse, ciò è dovuto
alle condizioni meteorologiche che ora impediscono loro di utilizzare
attivamente l'attrezzatura. Inoltre, ci sono molti rapporti dei nostri ufficiali
dell'intelligence" secondo cui "ci sono rifiuti molto frequenti a partecipare
alle ostilità" tra i russi, ha detto Dmytrashkivskyi. Il funzionario ha riferito
che una nuova unità militare russa è arrivata in prima linea in direzione di
Donetsk, ovvero la 136a brigata che era stata creata per le guerre cecene.
18:47
Kiev, Mosca aumenta
le sue truppe nel Lugansk
"I principali sforzi
del nemico sono ora concentrati sulla conduzione di operazioni offensive nelle
direzioni Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtar , aumentando il numero
del personale. Secondo le informazioni disponibili, fino a 200 coscritti della
regione di Rostov sono stati trasferiti nel territorio temporaneamente occupato
della regione di Lugansk". Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate
ucraine su Facebook, citato da Ukrinform. "Durante la giornata, il nemico ha
lanciato 8 attacchi missilistici e 28 aerei, 12 dei quali con droni d'attacco
iraniani del tipo Shahed-136. Ha effettuato più di 55 attacchi da sistemi di
missili a salve. La minaccia di attacchi missilistici rimane alta per tutto il
tempo il territorio dell'Ucraina", ha spiegato lo stato maggiore. "Il nemico ha
effettuato diverse offensive infruttuose nelle direzioni Kupyansk e Lymansk",
mentre "in direzione di Bakhmut, insediamenti sono stati bombardati, in
particolare Zaliznyanske, Dubovo-Vasylivka, Berkhivka, Bakhmut, Ivanovske,
Stupochki, Klishchiivka e Ozaryanivka" della regione di Donetsk. Nella direzione
di Kherson, "più di 20 insediamenti situati sulla riva destra del fiume Dnipro
sono stati danneggiati dal fuoco dell'artiglieria delle forze di occupazione
russe".
18:52
Zelensky, importante
incontro con Yellen, rafforzare sanzioni
"Un importante
incontro con il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen. Gli Stati Uniti
ci hanno sostenuto con forza fin dai primi giorni di questa guerra non solo con
le armi, ma anche sul fronte finanziario. Lo apprezziamo molto". Lo scrive sul
suo profilo Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Grazie per le
misure sistematiche volte ad aumentare la pressione delle sanzioni sullo Stato
aggressore. È necessario rafforzare ulteriormente le sanzioni per privare la
Russia della capacità di finanziare la guerra", ha aggiunto Zelensky.
18:56
Dodik, pieno
appoggio al piano di pace cinese
Il leader
serbo-bosniaco Milorad Dodik ha espresso il suo pieno appoggio al piano di pace
cinese in 12 punti per porre fine al conflitto armato russo-ucraino. "Sono grato
al presidente cinese Xi Jinping per iniziative di importanza cruciale per
l'Europa e il mondo intero, e saluto e appoggio fermamente la proposta di pace
cinese in 12 punti", ha detto Dodik, citato dai media serbi. A suo dire si
tratta della prima proposta concreta di un piano di pace, in grado di fermare
una ulteriore escalation delle operazioni belliche. "Ritengo che l'Europa debba
essere grata alla Cina", ha affermato Dodik, che è presidente della Republika
Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. "Diamo una chance
alla pace! Diamo una chance all'avvio di negoziati nell'ambito del piano di pace
cinese", ha aggiunto il leader serbo-bosniaco, che ha elogiato al tempo stesso,
con riferimento alla Ue, la posizione dell'Ungheria, che" dal primo giorno del
conflitto lancia appelli a una soluzione diplomatica della crisi e a uno stop a
una ulteriore escalation".
19:08
Lukashenko, con
Mosca possiamo fabbricare qualsiasi arma
Nonostante le
sanzioni, la Bielorussia, di concerto con la Russia, può fabbricare qualsiasi
tipo di arma in qualsiasi quantità, ha affermato lunedì il presidente
bielorusso Alexander Lukashenko. "Nonostante la pressione delle sanzioni senza
precedenti, produciamo abbastanza armi e attrezzatura militare per l'esercito
bielorusso. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno, intendo armi e attrezzatura, lo
riceviamo dalla Russia. Per quanto riguarda la microelettronica, l'ottica, altre
cose, dobbiamo ringraziare coloro che hanno conservato le tecnologie che abbiamo
ereditato dall'Unione Sovietica. Quindi, insieme alla Russia, possiamo
fabbricare qualsiasi tipo di arma", ha detto Lukashenko, citato
dall'agenzia Belta. "Inoltre, possiamo permetterci di esportare questi prodotti
in 57 Paesi del mondo. E lo stiamo facendo. Stiamo sviluppando con successo armi
all'avanguardia non solo in quelle aree in cui abbiamo competenze di ricerca, ma
stiamo anche sviluppando nuovi promettenti aree: missili, proiettili di
artiglieria pesante", ha detto Lukashenko.
19:23
Wizz Air sospende
voli per Chisinau da 14/3, rischi spazio aereo
La compagnia aerea
Wizz Air ha annunciato che sospenderà i voli per la capitale della Moldavia ,
dal 14 marzo, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza del suo spazio
aereo. In un comunicato citato dal Guardian, la compagnia ha affermato di aver
preso la decisione "difficile ma responsabile" di sospendere i voli a causa del
rischio "alto, ma non imminente" nello spazio aereo della Moldavia. "Wizz Air ha
monitorato da vicino la situazione della sicurezza in Moldavia ed è stata
costantemente in contatto con varie autorità e agenzie locali e internazionali
per garantire il massimo livello di sicurezza e protezione delle operazioni",
scrive la compagnia. "La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio rimane la
priorità numero uno di Wizz Air e, a seguito dei recenti sviluppi in Moldavia e
del rischio elevato, ma non imminente, nello spazio aereo del Paese, Wizz Air ha
preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso
Chisinau a partire dal 14 marzo". Wizz Air ha detto che in sostituzione,
proporrà voli extra dalla città rumena di Iasi. All'inizio di questo mese, la
Moldavia ha temporaneamente chiuso il suo spazio aereo per diverse ore per
indagare sulle segnalazioni di un oggetto simile a un pallone nel cielo, il
giorno dopo aver accusato la Russia di complottare per far cadere il suo
governo.
19:46
Capo Cia: convinti
che la Cina valuti di dare armi alla Russia
Gli stati uniti sono
"convinti" che la Cina stia valutando la possibilità di fornire armi alla Russia
nella sua guerra in ucraina, anche se dicono che non è stata presa alcuna
decisione in tal senso, e che stanno aumentando la pressione su pechino,
avvertendola di non oltrepassare quella linea rossa. "Siamo convinti che la
leadership cinese stia valutando la possibilità di fornire materiale letale"
alla Russia, ha detto il capo della Cia William Burns, in un'intervista
alla Cbs andata in onda domenica. Ma, ha aggiunto il direttore dell'intelligence
americana, "non abbiamo constatato che sia stata presa una decisione definitiva"
e "non abbiamo visto prove che abbiano consegnato" armi alla Russia.
19:52
Usa: "A oggi ancora
nessuna sospensione New Start da parte di Mosca"
La sospensione
dell'adesione della Russia al Trattato per la riduzione degli armamenti
strategici New Start non è ancora entrata in vigore, ha affermato l'assistente
Segretaria per l'ufficio del controllo degli armamenti Usa, Mallory Stewart in
una conferenza alla Brooking Institution. "La sospensione non è stata ancora
intaccata nel senso che continuiamo a ricevere notifiche, anche oggi, secondo
quanto previsto dal Trattato, notifiche regolari", ha affermato.
20:02
Capo forze armate
Kiev: servono F16 per vincere
Il generale Valerii
Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha avuto un colloquio
con il capo degli Stati maggiori riuniti Usa, il generale Mark Milley, al quale
ha ribadito la richiesta di F16. "Ogni proiettile ricevuto, ogni pezzo di
materiale, significa la vita preservata dei soldati ucraini e dei civili.
Restiamo grazie al sostegno dei nostri partner e avremo sicuramente la meglio",
ha aggiunto Zaluzhnyi.
20:05
Meloni: "Non
togliamo nulla a italiani, invio armi per allontanare guerra"
"Noi non spendiamo
soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini, noi abbiamo già delle armi
che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare, quindi non c'è niente
che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe
riguardare anche gli italiani". Così la premier Giorgia Meloni intervistata
da Bruno Vespa nella trasmissione Cinque minuti che andrà in onda questa sera
su Rai1.
"Mi sono commossa"
a Bucha "per i peluche sotto la pioggia, ricordo di alcuni bambini, perché mia
figlia ne ha uno simile. Però ho pensato che gli italiani debbano essere molto
fieri di noi", aggiunge Meloni. "Molti si aspettavano il solito scenario
decantanto di una italietta spaghetti e mandolino - spiega la premier - che di
fronte alle difficoltà si gira sempre dall'altra parte e invece noi siamo stati
un'altra cosa, siamo un'altra cosa e questo non è solo un fatto di orgoglio ma è
un fatto di difesa dell'interesse nazionale perché quando tu sei autorevole e
credibile la tua voce è anche ascoltata quando la tua voce è ascoltata allora si
puoi ottenere risultato per il tuo interesse nazionale. Credo che questo debba
essere chiaro".
20:08
Meloni: "Italia non
cambia posizione da un giorno all'altro"
"Sono fiera anche
del fatto che quello che abbiamo fatto per gli ucraini riguarda anche la
popolazione civile, nessuno dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori
elettrici perché c'è gente che rischia di morire di freddo che non ha la luce,
bambini famiglie persone normali aggredite con missili che bombardano le
infrastrutture strategiche per piegare la popolazione, col freddo la fame il
buio. Sono fiera e credo che anche gli italiani dovrebbero esserlo di quello che
stiamo facendo per difendere queste famiglie e questi bambini. È l'Italia,
un'Italia orgogliosa che non cambia posizione da un giorno all'altro. Finché ci
sarò io al governo questa Italia voglio rappresentare". Così la premier Giorgia
Meloni intervistata da Bruno Vespa nella trasmissione 'Cinque minuti' che andrà
in onda questa sera su Rai1.
20:19
Moldavia: espulsi
due stranieri 'coinvolti in piano destabilizzazione'
L'agenzia di
intelligence moldava ha dichiarato oggi che due cittadini stranieri che si erano
finti turisti sono stati espulsi dal Paese. Alle due persone è stato vietato di
tornare per dieci anni, dopo essere stati sorpresi a compiere "azioni
sovversive" per destabilizzare la Moldavia. Il Servizio di Intelligence e
Sicurezza, Sis, ha dichiarato in un comunicato che la coppia è stata addestrata
alla raccolta di dati e informazioni "per l'attuazione di un piano per
destabilizzare la situazione interna del Paese" e per provocare quello che è
stato descritto come un "cambiamento violento" dell'ordine costituzionale
moldavo. Il Sis non ha specificato quando i cittadini stranieri fossero arrivati
in Moldavia, da quali Paesi provenissero o per chi stessero lavorando.
20:40
Ucraina: "Da Usa 10
miliardi di dollari a sostegno bilancio"
Gli Stati Uniti
forniranno dieci miliardi di dollari entro settembre per aiutare a coprire il
deficit di bilancio dell'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys
Shmyhal dopo i colloqui a Kiev con il segretario al Tesoro degli Stati
Uniti Janet Yellen, spiegando che il deficit di bilancio del paese quest'anno
dovrebbe ammontare a 38 miliardi di dollari. "Nel 2022 gli Stati Uniti hanno
fornito più tutti i paesi partner assistenza finanziaria fornita", ha affermato
Shmyhal, ricordando che da Washington sono stati forniti 13 miliardi di dollari
in sovvenzioni per il budget. "Questi fondi sono stati stanziati per programmi
di assistenza sanitaria, per l'istruzione, sociale e umanitaria", ha spiegato.
Quest'anno, ha aggiunto, "gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire
all'Ucraina più di 10 miliardi di dollari entro settembre. Inoltre, gli Stati
Uniti sostengono l'Ucraina nella sua rapida ripresa".
20:49
Casa Bianca, visita
ministro saudita a Kiev è passo positivo
Da un anno
"chiediamo a tutti i nostri partner di fare quello che possono" per aiutare
l'Ucraina e "l'iniziativa saudita è un passo positivo". Lo ha detto il portavoce
del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, commentando la visita
di domenica a Kiev del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud,
che ha annunciato 400 milioni di dollari di aiuti sul fronte energetico
all'Ucraina. "E' la prima visita ministeriale di uno Stato arabo dall'inizio
della guerra", ha sottolineato Kirby.
21:18
Zelensky: "L'Ucraina
può difendere i cieli solo se i partner eliminano il tabù dell'aviazione"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo Paese può difendere i propri
cieli solo se si pone fine a un "tabù dell'aviazione". "I nostri piloti, le
unità antiaeree e gli altri esperti delle nostre forze aeree stanno facendo un
ottimo lavoro", ha detto. "Ma saremo in grado di proteggere completamente i
nostri cieli quando il tabù dell'aviazione sarà completamente abolito nelle
relazioni con i nostri partner".
21:44
Zelensky, la
situazione a Bakhmut è sempre più complicata
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso nel suo consueto discorso serale che la
situazione per le truppe ucraine intorno a Bakhmut, nell'est del Paese, sta
diventando molto difficile. "La situazione sta diventando sempre più
complicata", ha detto. "Il nemico sta sistematicamente distruggendo tutto ciò
che può essere utilizzato per proteggere le nostre posizioni", ha aggiunto,
definendo i soldati ucraini impegnati nella battaglia "veri eroi". "Grazie a
tutti coloro che aiutano i nostri soldati e fanno di tutto per garantire che i
nostri difensori abbiano quante più armi possibili, armi a lungo raggio, armi
potenti".
21:55
Kiev, due droni
russi abbattuti stasera a Dnepropetrovsk
Nella regione di
Dnepropetrovsk due droni russi sono stati abbattuti stasera. Lo afferma il capo
dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Sergey Lysak spiegando
che "le esplosioni udite dagli abitanti della regione sono opera della difesa
aerea che ha distrutto 2 droni".
22:09
Blinken in
Kazakhstan e Uzbeskistan per rafforzare Usa
Il Segretario di
Stato americano Antony Blinken inizia domani la sua visita ufficiale in
Kazakhstan, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche in Uzbekistan e poi
in India per partecipare alla riunione ministeriale del G20 con l'obiettivo di
aumentare il ruolo degli Stati Uniti nell'Asia centrale. "E' la mia prima visita
come Segretario di Stato" Usa in questi Paesi, ha scritto Blinken su Twitter. Ad
Astana domani incontrerà il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e i ministri
degli Esteri delle cinque ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, ovvero
anche Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan. Mercoledì partirà per l'Uzbekistan.
Le cinque ex repubbliche sovietiche non hanno votato a sostegno
della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di condanna della
Russia per l'aggressione dell'Ucraina.
(ANSA il 27 febbraio
2023) - Il politologo russo ed ex consigliere del Cremlino Gleb Pavlovsky, che
negli ultimi anni aveva assunto posizioni critiche nei confronti del presidente
Vladimir Putin, è morto a Mosca all'età di 71 anni. Ne dà notizia il quotidiano
economico Vedomosti, citato dal Moscow Times.
Pavlovsky era stato
un personaggio influente durante i primi due mandati di presidenza di Putin, dal
2000 al 2008. Successivamente era stato licenziato dall'amministrazione
presidenziale, una decisione che secondo il Moscow Times è legata all'appoggio
dato a Dmitry Medvedev per una sua rielezione nelle presidenziali del 2012, che
invece segnarono il ritorno al vertice proprio di Putin.
Da allora l'ex
consigliere ha criticato più volte la politica di Putin, compresa la decisione
di lanciare la cosiddetta 'operazione militare speciale' in Ucraina un anno fa.
Nato a Odessa, Pavlovksy era stato un dissidente durante l'era sovietica e aveva
trascorso un periodo in esilio nella repubblica di Komi, nel nord della Russia.
La parabola di
Pavlovsky: da consigliere a detrattore dello Zar.
Storia di Roberto
Fabbri su Il Giornale il 28 febbraio 2023.
Gleb Pavlovsky,
morto ieri a 71 anni a Mosca dopo una grave malattia, era stato a modo suo una
voce libera in un Paese illiberale. Nell'arco di un mezzo secolo, aveva
attraversato un'articolata sequenza di posizioni politiche dapprima molto
scomode, per poi approdare al ruolo di consigliere politico dei nuovi leader
della Russia post sovietica e concludere la sua parabola da oppositore di quello
stesso Vladimir Putin il cui potere aveva contribuito a consolidare. Nelle
vicende di Pavlovsky, che era nato a Odessa in Ucraina nel 1952, non erano
mancati aspetti controversi. Impegnato già da universitario nella dissidenza,
era stato arrestato nel 1982 e condannato a tre anni di confino: al processo si
era dichiarato colpevole e aveva testimoniato contro alcuni colleghi, una scelta
che non gli era mai stata perdonata negli ambienti dell'opposizione. Tornato
libero a Mosca nel 1985, l'anno decisivo in cui Mikhail Gorbaciov prese il
timone dell'Unione Sovietica, Pavlovsky si schierò nel suo campo riformista.
Ormai attivo come consulente politico, dopo il collasso dell'Urss alla fine del
1991 collaborò con l'astro nascente Boris Eltsin e fu tra gli ispiratori della
campagna di rielezione che cinque anni dopo gli permise di mantenersi in sella.
Fu lo stesso Eltsin, d'intesa con l'ambizioso oligarca Boris Berezovsky, a
scegliere l'allora semisconosciuto Putin come suo successore alla presidenza
della Russia, e anche qui Pavlovsky svolse un ruolo importante nella sua
individuazione quale figura di garante degli interessi della famiglia Eltsin
nella fase di transizione del potere e per la sua vittoria elettorale del marzo
2000. Negli undici anni successivi, con Putin al Cremlino, Gleb Pavlovsky
mantenne il ruolo di suo consigliere politico e spin doctor. Fu lui a
contribuire a forgiare l'immagine di successo di Putin come uomo forte e anche a
tirar fuori dal cilindro il filosofo ultranazionalista Aleksandr Dugin e a
proporne le infauste idee a un presidente alla ricerca di una propria ideologia.
L'ex dissidente elaborò una nuova «dottrina per la sicurezza dell'informazione»
che permetteva di mettere nel mirino «agenti che rappresentavano una minaccia
agli interessi nazionali» come Berezovsky e Vladimir Gusinsky.
La parabola di
Pavlovsky si chiudeva cupamente, ma tutto questo non gli impedì di essere
estromesso, sembra per eccessiva vicinanza alle ambizioni di Dmitry Medvedev:
era il 2011, e dopo di allora si trasformò in una voce sempre più critica del
regime di Putin, fino a contestare la scelta di invadere l'Ucraina. Pavlovsky
salvò la vita, a differenza tra gli altri di Berezovsky e di Boris Nemtsov, di
cui oggi cade l'ottavo anniversario dell'assassinio a Mosca. Ieri coraggiosi
attivisti hanno portato fiori e candele ai piccoli memoriali che lo ricordano
non solo sul luogo del delitto, ma anche in altre città russe. Sono gesti di
resistenza sempre più rischiosi: ci sono stati diversi fermi, ma per ora solo un
arresto.
La Repubblica
Zelensky: "L'intensità degli scontri a Bakhmut non fa che aumentare".
Chiuso e poi
riaperto l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo: fonti di stampa hanno parlato
di un oggetto volante non identificato; i caccia in volo. Le autorità russe:
"Esercitazione aerea". Putin firma la sospensione del New Start. La missione
del segretario di Stato Usa nell'ex Urss
Improvvisa chiusura
dell'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo stamane a tutti i voli. Le autorità
non hanno fornito spiegazioni, ma fonti di stampa hanno parlato di un oggetto
volante non identificato, forse un drone. Caccia si sono levati in volo. Lo
scalo è stato poi riaperto senza ulteriori chiarimenti. Il segretario di Stato
Antony Blinken è in missione nei paesi dell'ex Urss e in India. Ad Astana parole
di sostegno al Kazakhstan. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato oggi
la legge che sospende la partecipazione al trattato New Start per la riduzione
delle armi strategiche.
Punti chiave
21:58
Zelensky:
"L'intensità dei combattimenti intorno a Bakhmut non fa che aumentare"
17:46
Il conduttore russo
Soloviov attacca l'Italia, "bastardi"
16:19
Putin promulga la
legge per la sospensione del New Start
15:33
Ucraina, Lukashenko
atterra a Pechino, al via visita
15:27
Russia, Tass:
"Precipita elicottero, 4 feriti"
15:15
Blinken alla Cina:
"Problema serio e conseguenze se fornisce armi alla russia"
14:45
Finlandia, al via la
costruzione del muro al confine con la Russia
06:14
Mosca: Usa preparano
una provocazione con agenti chimici in Ucraina
00:05
Sanchez: invio di
caccia a Kiev non è opzione sul tavolo
L'invio di caccia
militari in Ucraina "non è un'opzione attualmente sul tavolo" delle discussioni
tra i Paesi della Nato e dell'Ue che sostengono Kiev: è quanto affermato dal
premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista trasmessa in serata dal canale
tv Telecinco. "C'è invece l'opzione di fornire carri armati Leopard,
artiglieria, munizioni, risorse economiche per aiutare lo Stato ucraino stesso a
pagare insegnanti o personale sanitario, nei lavori di ricostruzione e per gli
aiuti umanitari". La settimana scorsa, Sanchez aveva detto dopo un incontro con
il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev che la richiesta dell'Ucraina di
ricevere militari da altri Paesi andava "studiata".
00:18
Cremlino: Putin
aperto a contatti, ma Francia e Germania non sono neutrali
Il presidente russo
Vladimir Putin "era e rimane aperto a qualsiasi contatto che possa aiutare la
Russia a raggiungere i propri obiettivi, preferibilmente con mezzi pacifici". Lo
ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al quotidiano
russo Izvestia. Peskov ha osservato che il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il
presidente francese Emmanuel Macron hanno ripetutamente affermato che avrebbero
cercato di avere contatti con il presidente russo ma, sostiene Peskov, "non ci
sono state richieste". E ha sottolineato che Francia e Germania partecipano
indirettamente alle ostilità a fianco dell'Ucraina, il che mette in discussione
il loro possibile ruolo di mediazione nei negoziati.
00:30
Usa: se la Cina
fornisce armi a Mosca ci saranno conseguenze
"Non è
nell'interesse della Cina" fornire armi alla Russia e gli Usa hanno "detto
chiaramente che ci sarebbero delle conseguenze". Lo afferma il portavoce del
Consiglio della Sicurezza nazionale John Kirby in un'intervista a Cnn
rispondendo a una domanda sulla possibile reazione americana nel caso in cui
Pechino fornisse armi alla Russia per la guerra in Ucraina.
02:47
Mosca non riattiverà
il trattato Start se gli Usa non ascolteranno le sue ragioni
La Russia non
tornerà ad attuare il trattato Start sulle armi nucleari fin quando gli Stati
Uniti non avranno preso in seria considerazione le posizioni di Mosca. Lo ha
dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
05:12
Il capo
dell'intelligence ucraina: nessun segnale di armi cinesi a Mosca
Il capo dei servizi
segreti ucraini, Kyrylo Budanov, non vede "nessun segno" che lo induca a credere
che la Cina consegnerà armi alla Russia. Lo ha detto in un'intervista trasmessa
ieri dalla radio Voice of America. "Non condivido questa opinione", ha detto
Budanov riferendosi alle accuse degli Stati Uniti - fermamente smentite da
Pechino - secondo cui la Cina sta valutando la possibilità di fornire armi alla
Russia per aiutarla nel suo offensiva contro l'Ucraina. "In questo momento, non
credo che la Cina accetterà di trasferire armi alla Russia... non vedo alcun
segno che queste cose vengano discusse", ha detto.
06:14
Mosca: Usa preparano
una provocazione con agenti chimici in Ucraina
Il ministero della
Difesa russo sostiene che gli americani stanno pianificando una provocazione con
agenti chimici in Ucraina
07:19
Zelensky:
"Situazione a Bakhmut sempre più difficile"
La situazione a
Bakhmut, località strategica della regione ucraina di Donetsk circondata dai
russi da diverse settimane, "è sempre più difficile". Lo ha ammesso il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il nemico distrugge costantemente tutto
ciò che può essere utilizzato per proteggere le nostre posizioni, per ottenere
un punto d'appoggio e garantire la difesa", ha detto Zelensky.
07:36
Giappone annuncia
nuove sanzioni a Mosca
Il governo
giapponese ha annunciato oggi nuove sanzioni contro la Russia, "con lo scopo di
contribuire agli sforzi internazionali per raggiungere la pace". Il ministro
degli Esteri di Tokyo ha fatto sapere che congelerà i beni di 39 personalità e
73 entità della Federazione russa, una banca e nove persone che si trovano nelle
aree occupate dell'est e del sud dell'Ucraina, per il loro coinvolgimento nelle
annessioni di queste regioni. Inoltre a 21 entità che potrebbero contribuire al
miglioramento delle capacità industriali russe è stato imposto un bando
all'export. Tra i sanzioni da Tokyo ci sono il vice ministro della Difesa,
Victor Goremikin e il principale azionista dell'azienda Kalashnikov, Alan
Lushnikov.
08:04
Kiev: "Le forze
russe cercano di sfondare le difese di Bakhmut"
La situazione
intorno alla città assediata di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è "estremamente
tesa": nonostante le perdite significative, "il nemico ha lanciato le unità
d'assalto più preparate del (Gruppo) Wagner, che stanno cercando di sfondare le
difese delle nostre truppe e di circondare la città". Lo ha reso noto
su Telegram, come riporta il Guardian, il comandante delle forze di terra
ucraine, generale Oleksandr Syrskyi.
08:41
Russia: "Usa
preparano provocazione con armi chimiche"
La Russia ha
accusato gli Stati Uniti e i suoi alleati di preparare una provocazione con
agenti chimici tossici in Ucraina e ha assicurato che una partita di queste
sostanze è arrivata il 10 febbraio a Kramatorsk, la principale roccaforte
ucraina nella regione di Donetsk, annessa da Mosca lo scorso 30 settembre.
Secondo il comandante delle forze di protezione chimica e biologica della Difesa
di Mosca, Igor Kirilov, i preparativi per questa provocazione "procedono a pieno
ritmo".
09:34
Blinken ad Astana:
"Gli Usa sostengono l'indipendenza e la sovranità del Kazakhstan"
"Come sapete bene,
gli Stati Uniti sostengono con forza la sovranità, l'indipendenza e l'integrità
territoriale del Kazakhstan". Lo ha assicurato il segretario di Stato americano,
Antony Blinken, in visita ad Astana, nell'ambito di un tour che lo porterà anche
in Uzbekistan e India con l'obiettivo di contrastare l'influenza russa. "Qualche
volta noi diciamo queste parole ma in realtà non hanno alcun significato e,
naturalmente, sappiamo che in questo particolare momento hanno ancora più
risonanza solito", ha sottolineato il capo della diplomazia americana, con un
riferimento alla guerra in Ucraina. Blinken ha poi ribadito "la determinazione"
degli Stati Uniti a rendere "più forte che mai" il rapporto con il Kazakhstan.
09:38
San Pietroburgo
chiude l'aeroporto Pulkovo a tutti i voli
L'aeroporto Pulkovo
di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza nello scalo,
senza fornire una motivazione. secondo canali di informazione russi, il motivo
sarebbe l'avvistament di un "velivolo non identificato", probabilmente un
drone. Lo riferisce l'amministrazione della città su Telegram. Lo spazio aereo
in un raggio di 200 chilometri intorno all'aeroporto dovrebbe restare chiuso
fino alle 13.20 ora locale, riferisce la Tass.
10:01
L'aeroporto di San
Pietroburgo riapre
L'aeroporto russo di
San Pietroburgo Pulkovo è stato riaperto ai voli. Il traffico era stato sospeso
senza spiegazioni uffuciali, ma i i canali di informazioni locali avevano
parlato della presenza di un oggetto volante non identificato.
10:03
Wagner all'attacco,
la situazione intorno a Bakhmut precipita
"La situazione
intorno a Bakhmut è estremamente tesa. Nonostante abbia subito perdite
significative, il nemico ha inviato le sue unità d'assalto del gruppo Wagner per
cercare di sfondare le difese delle nostre truppe e circondare la città", ha
dichiarato sui social il comandante delle forze di terra ucraine Oleksandr
Syrskyi. In precedenza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva
affermato che la situazione a Bakhmut è "sempre più difficile".
10:24
Esplosione in una
raffineria nella regione russa di Krasnodar. Avvistato un drone
Esplosioni sono
state udite la notte scorsa nella città russa di Tuapse, nella regione di
Krasnodar, seguite da un incendio in una locale raffineria del colosso
petrolifero controllato dal governo russo, Rosneft: lo riporta Ukrainska Pravda,
che cita alcuni canali Telegram del Paese. "C'è stata un'esplosione alla
raffineria di petrolio di Tuapse, poi una seconda, le finestre delle case vicine
sono saltate, non è chiaro cosa stia bruciando ma sembra si tratti di fusti di
petrolio", si legge in uno dei messaggi. Le autorità locali hanno confermato sul
social network VK che c'è stata un'esplosione nella raffineria, aggiungendo che
non c'è "alcun motivo di preoccupazione". Secondo l'agenzia di stampa RIA
Novosti, un drone sarebbe stato avvistato sull'area prima dell'incendio.
11:10
Mosca: "Su San
Pietroburgo esercitazione aerea"
Le forze russe del
distretto aereo occidentale, di cui fa parte San Pietroburgo, hanno compiuto
oggi un'esercitazione, facendo alzare in volo i caccia per identificare e
intercettare un obiettivo fittizio. Lo annuncia il ministero della Difesa,
citato dalle agenzie russe. Dovrebbe essere questo il motivo della chiusura
dello spazio aereo su San Pietroburgo, anche se il ministero non lo chiarisce.
11:15
Peskov: "Putin
pienamente informato sulla chiusura dell'aeroporto di San Pietroburgo"
Il presidente russo
Vladimir Putin è stato "pienamente" informato sulla chiusura dello spazio aereo
sopra San Pietroburgo e dell'aeroporto Pulkovo, che nel frattempo ha ripreso le
sue attività. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha
rifiutato di rispondere alle domande sulla cause che hanno portato alla chiusura
temporanea dello spazio aereo.
12:35
Un drone si schianta
a 100 chilometri da Mosca. "Vicino a una infrastruttura civile"
Un drone si è
schiantato nella regione di Kolomna, a poco più di 100 chilometri di Mosca. Lo
ha reso noto il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov nel suo
canale Telegram. Lo riporta Ria Novosti. "E' accaduto vicino al villaggio di
Gubastovo, l'obiettivo era probabilmente una struttura civile, non è stata
colpita. Non ci sono vittime o danni", ha spiegato.
12:37
Mosca: sono 2 i
droni "neutralizzati" nel Sud della Russia
Le forze armate
russe hanno rivendicato di aver abbattuto nella notte due droni ucraini che
avevano preso di mira infrastrutture civili nel sud della Russia. "Il regime di
Kiev ha tentato di attaccare con dei droni siti di infrastrutture civili nella
regione di Krasnodar e nella Repubblica di Adighezia", ha dichiarato il
ministero della Difesa russo in una nota. "I due droni sono stati neutralizzati"
senza provocare danni, si aggiunge.
12:46
La Russia: oltre che
nella zona di Mosca abbattuti droni in diverse regioni del sud
Le autorità russe
hanno specificato che gli attacchi con droni in territorio russo sono
molteplici. Uno nel villaggio di Gabastovo, distretto di Kolomna, nella regione
di Mosca, a 100 metri da una stazione di compressione del gas di proprietà di
Gazprom, come ha precisato il governatore locale. Il ministero della Difesa
russo ha poi annunciato l’abbattimento di droni ucraini che hanno attaccato il
Kuban e l'Adighezia, nel Sud. Un altro drone è stato abbattuto nella regione di
Brjansk. Inoltre, un drone è stato avvistato nell'area del deposito petrolifero
di Rosneft a Tuapse, dove di notte è scoppiato un incendio. Ieri erano stati
trovati anche frammenti di un oggetto non identificato a Belgorod su due strade
e un drone è volato su un condominio residenziale.
12:59
La relazione
dell'Intelligence italiana: "Mosca non smetterà di interferire con attacchi
cyber e disinformazione nei paesi Nato"
"Mosca non smetterà
di interferire nelle dinamiche politiche e nei processi decisionali interni ai
Paesi Nato, ricorrendo ancor più che in passato a metodi coercitivi e
manipolativi, quali attacchi cyber, disinformazione, ricatti e utilizzo di leve
come quella migratoria ed energetica, quest'ultima destinata a perdere di
rilevanza con l'impegno occidentale a trovare alternative alla dipendenza
energetica dalla Russia". Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence al
Parlamento presentata oggi.
13:55
Putin: "Fermare i
sabotatori"
Il presidente russo
Vladimir Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare
il confine con l'Ucraina per sventare le azioni di gruppi di sabotatori. Lo
riferisce l'agenzia Tass.
13:57
Putin ai Servizi:
"Neutralizzare le attività di chi cerca di dividere la Russia"
Il presidente russo
Vladimir Putin ha ordinato ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di "continuare
a neutralizzare le attività di chi cerca di dividere la Russia". Lo riferisce
l'agenzia Tass.
14:26
Putin: "Il regime di
Kiev usa metodi terroristici"
"Il regime di Kiev
utilizza metodi terroristici e la Russia ne è ben consapevole". Lo ha affermato
il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al consiglio dell'Fsb, il
Servizio per la sicurezza della Federazione Russa. "Nell'ultimo anno, il numero
di tali crimini è aumentato, è ovvio che ciò è collegato ai tentativi del regime
di Kiev di utilizzare metodi terroristici, ne siamo ben consapevoli, li usano da
molto tempo nel Donbass", ha spiegato. Putin ha osservato che l'Occidente
"aspira a rilanciare le cellule di estremisti e terroristi sul territorio della
Federazione Russa".
14:29
Putin ai Servizi:
"Vigilare sulla feccia neonazista"
I servizi di
sicurezza interni russi (Fsb) devono essere vigili per sventare i tentativi
della "feccia" che cerca di provocare divisioni interne usando le armi del
"separatismo, del nazionalismo, del neonazismo e della xenofobia". Lo ha
affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando i vertici dell'Fsb,
avvertendo che stanno aumentando in Russia i pericoli derivanti da questi
fenomeni. Lo riferisce l'agenzia Tass.
14:39
Putin: "Alcuni
membri dell'Fsb uccisi in Ucraina"
Il presidente
russo Vladimir Putin ha ammesso che alcuni membri del Servizio di sicurezza
federale (Fsb) russo sono stati uccisi in Ucraina. "Purtroppo ci sono perdite
tra le nostre file", ha detto Putin in una riunione del consiglio dell'Fsb,
senza specificare quante. "La leadership dell'Fsb deve fare di tutto per
sostenere ulteriormente le famiglie dei nostri compagni caduti.
Ricorderemo sempre
il loro eroismo e coraggio", ha detto Putin, secondo quanto riferito
dall'agenzia di stampa statale Ria Novosti.
"Le unità dell'Fsb
sono state coinvolte direttamente nell'operazione militare speciale. Hanno
risolto compiti operativi complessi e non standard, coprendo il confine di
Stato, combattendo attivamente il terrorismo, la criminalità organizzata, la
corruzione e l'estremismo", ha aggiunto Putin.
14:45
Finlandia, al via la
costruzione del muro al confine con la Russia
La Finlandia ha
iniziato oggi la costruzione di un muro al confine con la Russia presso il
valico di Imatra, nel sudest del Paese. La barriera, che dovrebbe essere
ultimata entro la fine di giugno, sarà lunga circa tre chilometri. Si tratta di
una prima "costruzione di prova" in vista di un ampliamento del percorso, lungo
il quale saranno installati sensori di movimento. A settembre, la Finlandia
aveva approvato la chiusura delle frontiere ai turisti russi, nel bel mezzo
dell'escalation migratoria derivante dalla parziale mobilitazione annunciata lo
stesso mese dal presidente Vladimir Putin, unendosi così alle restrizioni in tal
senso già adottate in precedenza dai Paesi baltici e dalla Polonia.
15:15
Blinken alla Cina:
"Problema serio e conseguenze se fornisce armi alla russia"
Gli Stati Uniti
"sono stati molto chiari con la Cina", circa le "implicazioni e conseguenze" di
un aiuto militare alla Russia, che rappresenterebbe "un problema serio" nelle
relazioni tra Washington e Pechino. Lo ha detto il Segretario di Stato
americano Antony Blinken nel corso di una conferenza stampa in Kazakistan, dove
ha spiegato che "non esiteremo, ad esempio, a prendere di mira aziende o
individui cinesi che violano le nostre sanzioni o sono comunque impegnati a
sostenere lo sforzo bellico russo". Blinken ha spiegato di aver sollevato la
questione "direttamente" con il capo della diplomazia cinese Wang Yi incontrato
a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco e lo stesso ha fatto il
presidente degli Stati Uniti Joe Biden con l'omologo cinese Xi Jinping in
Indonesia a novembre.
15:27
Russia, Tass:
"Precipita elicottero, 4 feriti"
Un elicottero
sarebbe precipitato in fase di atterraggio vicino a Murmansk, nel nord della
Russia: lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Tass citando i servizi di
emergenza. "Un elicottero si è schiantato durante l'atterraggio a tre chilometri
dall'aeroporto di Murmansk. A bordo c'erano otto persone, secondo le prime
informazioni quattro persone sono rimaste ferite", ha detto la fonte alla Tass.
Secondo l'agenzia russa, il ministero delle Emergenze locale afferma che a bordo
dell'elicottero c'erano nove persone, tra cui tre membri dell'equipaggio. "Non
ci sono vittime, i passeggeri vengono trasportati con motoslitte al villaggio di
Lovozero", ha spiegato il dicastero secondo la Tass.
15:33
Ucraina, Lukashenko
atterra a Pechino, al via visita
Il presidente
bielorusso, Aleksandr Lukashenko, è atterrato nella serata di oggi all'aeroporto
di Pechino, per una vista di tre giorni in Cina. La visita di Stato di
Lukashenko in Cina "sarà una continuazione della costruzione di relazioni
amichevoli di lungo termine e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la
Repubblica Popolare Cinese", riferisce l'agenzia Belta all'arrivo del leader
bielorusso nella capitale cinese. Lukashenko, alleato del presidente russo,
Vladimir Putin, è in Cina su invito del presidente cinese, Xi Jinping, e rimarrà
nel Paese fino al 2 marzo prossimo. La visita viene osservata con attenzione
dall'estero, soprattutto rispetto alla situazione della guerra in Ucraina: la
Cina ha proposto un piano in 12 punti per la soluzione politica della crisi,
accolto con scetticismo in Occidente, e lo scorso anno ha siglato una
partnership "senza limiti" con la Russia proprio poche settimane prima
dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina.
16:19
Putin promulga la
legge per la sospensione del New Start
Il presidente
Vladimir Putin ha firmato e promulgato oggi la legge che prevede la sospensione
da parte della Russia del New Start, l'ultimo trattato bilaterale con gli Usa
sulla limitazione delle armi nucleari. Lo riferiscono le agenzie russe. La legge
era stata approvata all'unanimità dalle due camere del Parlamento su proposta
dello stesso presidente.
16:42
Zelensky incontra a
Kiev procuratore Corte penale internazionale
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver incontrato a Kiev il
procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan. "Ci sentiamo
sostenuti dalla Corte penale internazionale nei nostri sforzi per ottenere
giustizia e consegnare alla giustizia tutti i responsabili dei crimini commessi
dagli occupanti russi in Ucraina", ha scritto su twitter.
16:47
Media, Putin vive
con ginnasta Kabaeva
Vladimir Putin vive
con l'ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, probabile madre dei suoi figli
più piccoli, nella lussuosa residenza di Valdai. Lo scrive Proekt, un sito
indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo, sottolineando che
la Kabaeva usa i fondi di Putin nella compagnia offshore di Cipro, Ermira
consultants. Il presidente russo ha divorziato nel 2013 dalla moglie Ludmilla e
da tempo si parla di una sua relazione con Kabaeva, anche se i due non si
mostrano mai assieme in pubblico. Varie fonti citate da Proekt confermano ora la
loro convivenza. Assistenti e famigliari della donna risiedono nella grande
residenza di Valdai, e una sorella possiede un appartamento nelle vicinanze.
All'interno del comprensorio di Valdai è stato costruito un terem di legno, la
tradizionale abitazione per le donne e i bambini, dove alloggiano la ginnasta e
i figli. Kabaeva avrebbe avuto due figli, nati nel 2015 e nel 2019, di cui non
si conosce il sesso. L'ex campionessa possiede anche un attico di lusso a Sochi
con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero, scrive il sito che
mostra diverse foto dell'interno dei lussuosi appartamenti della 'zarina'.
16:50
Foto satellitari
mostrano l'aereo russo attaccato ieri a Minsk
Immagini dell'aereo
russo, che ieri sarebbe stato attaccato dagli ucraini nell'aeroporto bielorusso
militare vicino Minsk, sono state pubblicate oggi dalla società di tecnologia
spaziale Maxar. Le foto satellitari mostrano che l'aereo non è stato distrutto e
al momento non è chiaro se ci sono danni.
17:23
Russia: 'multato per
critiche a guerra per errore', ora risarcito
Un tribunale di
Novgorod, in Russia nord-occidentale, ha ordinato al ministero dell'Interno
russo di pagare al capo della sezione locale del partito d'opposizione
Yabloko, Viktor Shalyakin, 20.000 rubli (circa 251 euro) a titolo di
risarcimento per una multa che gli era stata inflitta con l'accusa di
"discredito dell'esercito" per l'invasione dell'Ucraina. Lo riporta Radio
Liberty, secondo cui la multa, del maggio dell'anno scorso, era stata
successivamente cancellata dal tribunale. Shalyakin aveva pubblicato su internet
un video sulla guerra sovietico-afghana e sulla guerra in Georgia. La sentenza
del tribunale era stata quindi annullata dopo che i periti linguistici avevano
concluso che il post dell'oppositore non riguardava la guerra in Ucraina.
Shalyakin ha poi fatto causa al ministero. In Russia l'ultima legge "bavaglio"
prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni
sull'esercito che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità, vietando di
fatto di criticare la guerra in Ucraina.
17:46
Il conduttore russo
Soloviov attacca l'Italia, "bastardi"
L'anchorman della tv
russa Vladimir Soloviov, magnate e amico di Putin, ha rivolto un duro attacco
all'Italia in un video postato anche sul suo account Twitter in cui definisce
"bastardi" gli alleati dell'Ucraina. "Chissà se a Milano si ricordano come
baciavano le mani dei soldati russi", ha detto, senza mezzi termini, durante una
diretta tv. Il conduttore si riferiva alla campagna italiana di Suvorov nel nord
Italia tra l'aprile e il settembre 1799, quando il generale russo, a capo
dell'armata russo-austriaca, sconfisse l'esercito francese costringendolo a
lasciare Milano. "Se parliamo seriamente - ha detto - se capiamo davvero qual è
la posta in gioco, allora lasciateli tremare i bastardi. Poi ci sarà un'altra
traversata delle Alpi, se è necessario. Pensate al monumento a Suvorov, e chissà
se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi. Se fate i
maleducati con noi, voi bastardi, dovete tremare. I russi partono piano, ma poi
vanno veloce".
18:13
Processo a Zurigo
sulle tracce del denaro di Putin
Dipendenti della
filiale svizzera di Gazprombank saranno a processo mercoledì 8 marzo a Zurigo,
per depositi a nome del violoncellista russo Sergei Rodulgin, somme che in
realtà potrebbero essere collegate al presidente russo Vladimir Putin. La banca
ha nel frattempo cessato l'attività. Il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha
rinviato a giudizio il Ceo e altri tre dirigenti di Gazprombank Schweiz (Gpbs) e
ha intenzione di chiedere per ognuno una condanna a sette mesi di detenzione con
la condizionale. È quanto emerge dall'atto d'accusa di cui hanno riferito oggi
le testate online di Tamedia, visto anche da Keystone-ATS.
Il sospetto è che su
due conti aperti nel 2014 e gestiti fino al 2016 - quando cioè la Russia aveva
già annesso la Crimea - siano stati depositati, a nome del violoncellista e
direttore d'orchestra russo, circa 50 milioni di franchi che in realtà
provenivano dell'establishment russo. I quattro imputati respingono le accuse e
per loro si applica la presunzione d'innocenza. Nell'atto d'accusa viene fatto
esplicitamente il nome del presidente russo Vladimir Putin: "È noto che il
presidente russo Putin ufficialmente ha un reddito di soli 100.000 franchi e non
è ricco, ma in realtà ha un enorme patrimonio che viene gestito da persone a lui
vicine", scrivono gli inquirenti zurighesi.
18:26
Kiev, altre 2 camere
di tortura trovate nell'area di Kharkiv
Altre due camere di
tortura sono state scoperte nella regione di Kharkiv, dove le forze russe
tenevano prigionieri durante l'occupazione. Lo riferiscono i vertici della
Polizia locale citati da Ukrinform, secondo cui sono ad oggi 27 i luoghi simili
rinvenuti nella zona.
18:35
Russia vuole
criminalizzare la "russofobia"
La Russia potrebbe
varare una legge per rendere un reato la "russofobia". A chiederlo è Valery
Fadeyev, presidente del Consiglio russo per i diritti umani, un organismo
pubblico vicino al Cremlino. "Il nostro compito è arrivare ad una definizione
legale di russofobia, con una lista di articoli di legge penali applicabili", ha
detto Fadeyev, citato dal sito indipendente russo Meduza. Secondo Fadeyev, il
progetto di legge si accorda con la richiesta del presidente Vladimir Putin di
stabilire pene per chi discrimina i russi all'estero. Fadeyev ha tuttavia
ammesso che Mosca non ha i mezzi per perseguire stranieri all'estero per il
reato di russofobia, aggiungendo che è una questione su cui si dovrà "lavorare".
L'ufficio della procura russa ha intanto proposto che il reato di russofobia
possa essere classificato come una forma di estremismo. Le autorità di mosca
hanno più volte accusato l'Occidente di "russofobia" dopo l'invasione russa
dell'Ucraina.
18:40
Mosca, "drone
abbattuto voleva attaccare infrastrutture civili"
Il drone UJ-22 di
fabbricazione ucraina abbattuto vicino a Mosca "probabilmente era un tentativo
di prendere di mira le infrastrutture civili". A dirlo sul suo canale Telegram è
il governatore regionale Andrei Vorobyov, anche se l'Ucraina non ha rivendicato
la responsabilità degli attacchi all'interno della Russia. Il drone è caduto nei
pressi di Guabastovo, nella regione di Kolomna, a 100 chilometri da Mosca,
vicino a una sede di Gazprom, ma il gigante russo ha fatto sapere che le sue
operazioni nella regione non sono state interrotte. "Non ci sono vittime o danni
sul terreno", ha aggiunto Vorobyov: "L'Fsb (il servizio di sicurezza russo) e
altre autorità competenti stanno indagando".
19:16
Moldavia, filorussi
tentato irruzione nella sede del governo
La polizia moldava
si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che
cercavano di fare irruzione nella sede del governo. Diverse persone sono state
arrestate. Dopo gli scontri una parte del corteo si è diretta presso il
municipio di Chisinau, la capitale moldava. Qui il governatore della regione di
Orhei, Dinu Turcanu, del partito Sor, si è rivolto alla folla chiedendo che il
governo aiuti la popolazione di fronte alla crescita dei prezzi dell'energia. La
protesta, con manifestanti arrivati da tutto il paese, è stata organizzata dal
Movimento per il popolo, che riunisce diverse organizzazioni fra cui il partito
Sor. Il governo accusa il movimento, e in particolare il Sor, di voler
"destabilizzare" la Moldova.
20:03
Usa: "Mosca non ha
risorse per corsa al riarmo nucleare"
"Francamente, la
Russia non è nella posizione per una sfrenata corsa al riarmo nucleare". E'
quanto ha detto il sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, rispondendo
oggi, durante un'audizione al Congresso, a domande sulla recente decisione di
Mosca di sospendere la sua partecipazione al New Start. "Non hanno fondi,
specialmente considerata la pressione imposta sull'esercito dalla guerra, le
sanzioni, i controlli sulle esportazioni" ha continuato il funzionario del
Pentagono, aggiungendo di ritenere che Vladimir Putin abbia fatto questo
annuncio "per ottenere dei titoli retorici, ma non credo - ha detto ancora - che
abbia cambiato la situazione". Kahl infatti ha ricordato che la Russia, "usando
il Covid ed altre cose come scuse, già non rispettava il regime di ispezioni"
previsto dallo Start. "E' interessante che Putin abbia deciso di sospendere il
trattato, invece di lasciarlo - ha concluso il sottosegretario - credo che
questa sia effettivamente un'indicazione che non c'è una vera pressione su di
noi".
20:59
Usa, "nessuna prova"
Kiev faccia uso improprio aiuti
Non ci sono prove
che l'Ucraina stia facendo un uso improprio delle decine di miliardi di dollari
di aiuti che gli sono stati forniti per contrastare l'invasione russa. Lo ha
affermato il numero tre del Pentagono, Colin Kahl, di fronte alla commissione
Forze armate del Congresso americano. "Non c'è nessuna prova che gli ucraini li
stiano deviando verso il mercato nero", ha affermato Kahl. "Non è sorprendente
data l'intensità della lotta e il fatto che stanno chiaramente usando ciò che
noi e gli alleati stanno fornendo loro per ottenere il massimo effetto", ha
spiegato.
21:58
Zelensky:
"L'intensità dei combattimenti intorno a Bakhmut non fa che aumentare"
"L'intensità dei
combattimenti intorno alla città di Bakhmut non fa che aumentare", lo ha detto
il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale. "Stiamo
preparando il ritorno dei nostri soldati ad azioni attive per la liberazione
della nostra terra - ha aggiunto -. L'Ucraina sarà libera, tutta l'Ucraina".
Intanto lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che mentre la
Russia continua l'assalto a Bakhmut, si prepara all'offensiva negli oblast
meridionali di Kherson e Zaporizhia.
22:18
Aiea, preoccupano
bombardamenti vicino a centrale Zaporizhzhia
Il direttore
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael
Mariano Grossi, ha espresso preoccupazione per i nuovi bombardamenti di
artiglieria vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina e per la
temporanea perdita dell'unica linea elettrica di riserva rimasta. "Gli esperti
dell'Aiea che sono ora alla centrale dall'inizio di gennaio hanno riferito al
quartier generale che ieri pomeriggio si sono sentite circa 20 detonazioni,
apparentemente nelle vicinanze dell'impianto, che si trova in prima linea in
un'area di combattimento attiva", si legge nella nota dell'agenzia Onu.
La marcia
dell'opposizione a Chisinau. Alta tensione in Moldavia, filorussi in piazza
contro la presidente Sandu: manifestanti tentano di entrare nella sede del
governo.
Carmine Di Niro su Il Riformista il 28 Febbraio 2023
Il clima politico
in Moldavia si fa incandescente. L’opposizione filorussa ha sfilato per ore nel
pomeriggio di martedì per le strade della capitale Chisinau al grido di “Maia
Sandu vattene”, invocando dunque le dimissioni o comunque la cacciata dalla
presidente del Paese, europeista e filoatlantica.
Migliaia i
manifestanti in piazza guidati dai deputati del partito di opposizione
filo-russo Shor, tra cui la vicepresidente del movimento Marina Tauber,
nonostante gli sforzi della polizia moldava di impedire il procedere del corteo.
Momenti di tensione ci sono stati quando, secondo i media locali, alcuni
manifestanti hanno tentato di fare irruzione nella sede del governo: dopo essere
stati fermati dalla polizia, i dimostranti si sono diretti verso il municipio
della città e alcuni di loro sono stati arrestati dalle forze dell’ordine.
“Chiediamo elezioni
anticipate. Il governo deve pagare le bollette delle persone che sono aumentate
più volte per colpa delle autorità. Chiediamo anche che venga osservata la
neutralità, come è scritto nella costituzione, in modo che il nostro Paese non
sia trascinato in operazioni di guerra”, ha detto Vadim Fotescu, un parlamentare
di Shor presente in piazza, dove hanno sfilato per lo più contadini e anziani
che scandivano cori contro il governo e la presidente Sandu. Secondo il Partito
d’Azione e Solidarietà, al governo, le manifestazioni sono invece un tentativo
di “destabilizzare la situazione del Paese”.
Sullo sfondo ci sono
diverse questioni chiave per ‘leggere’ le proteste odierne: una è ovviamente
la guerra nella vicina Ucraina, che confina a est proprio con la Moldavia.
Quindi la questione dell’influenza russa sul piccolo Paese di due milioni di
abitanti (e dal Pil pro capite più basso d’Europa), aumentata da quando nel 2020
alla sua giuda sono arrivati governi filo-occidentali. La vittoria di Sandu
scorse presidenziali avevano provocato l’immediata reazione del Cremlino, che
si è ‘vendicato’ aumentando i prezzi delle forniture di gas, da cui era
dipendente al 100 per cento, e bloccando le importazioni del vino moldavo, il
principale prodotto del settore agroalimentare della Moldavia.
Proprio la
presidente nei giorni scorsi ha denunciato pubblicamente l’esistenza di un piano
russo per sovvertire dall’interno, con agenti stranieri sotto
copertura, l’attuale governo. Il 10 febbraio, pochi giorni prima l’allarme
lanciato da Sandu, la prima ministra Natalia Gavrilita si era dimessa dopo 18
mesi di governo ed era quasi immediatamente stata sostituita, su indicazioni
della presidente Sandu, da Dorin Recean, segretario del Consiglio di sicurezza
del paese e in passato ministro dell’Interno, come l’ex premier dalle solide
posizioni europeiste e filo-occidentali.
Quindi l’ultima
mossa del Cremlino dei giorni scorsi, con la revoca del decreto del 2012 che in
parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politiche sul
futuro della Transnistria, la regione separatista sostenuta da Mosca che confina
con l’ Ucraina e dove la Russia da anni ha stanziato circa 1500 soldati per una
presunta funzione di “peacekeeping”.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Un 6 gennaio
mancato. In Moldavia i filorussi hanno provato a fare irruzione nella sede del
governo.
Linkiesta il 28 Febbraio 2023
A Chișinău alcuni
manifestanti del partito filo putiniano "Sor" hanno provato a entrare nel
palazzo dell’esecutivo nel tentativo di destabilizzare l’esecutivo europeista
Alcuni manifestanti
del partito filorusso “Sor” hanno provato a entrare con la forza nella sede del
governo moldavo a Chișinău, ma sono stati fermati dalla polizia. Per ora. Una
dinamica che ricorda l’assalto a Capitol Hill fatto dai sostenitori di Donald
Trump il 6 gennaio 2021. Il tentativo di irruzione è l’apice di una protesta
organizzata nella capitale da Sor con il “Movimento per le persone” per chiedere
le dimissioni del governo europeista guidato dalla presidente Maia Sandu. Dopo
essere stati fermati dalla polizia, il gruppo di manifestanti si è diretto verso
il municipio.
Secondo il governo
questa manifestazione sarebbe un modo per destabilizzare il Paese che subito
dopo l’invasione russa in Ucraina ha presentato la domanda di adesione
all’Unione europea, ottenendo il 23 giugno del 2022 lo status di candidato.
La Moldavia, ex
paese dell’Unione sovietica, confina a ovest con la Romania e a est con
l’Ucraina ed è considerata da diversi analisti un possibile obiettivo militare
della Russia per creare un secondo fronte anti ucraino. All’interno della
Moldavia si è formata dal 2 settembre 1990 la Transinistria, un repubblica
autoproclamatasi indipendente, non riconosciuta dall’Onu e molto vicina al
Cremlino.
Guerra di numeri.
Ernesto Ferrante su L’Identità il 28 Febbraio 2023
Guerra di numeri tra
Mosca e Kiev. La Russia ha rivendicato la distruzione di un deposito di
munizioni vicino a Bakhmut, città dell’Ucraina orientale sotto assedio da mesi,
e di aver abbattuto cinque droni in dotazione all’esercito di Zelensky. In una
nota, il ministero della Difesa russo ha anche reso noto di aver neutralizzato
quattro missili Himars.
Le forze di difesa
aerea ucraine hanno annunciato di aver annientato, nella notte scorsa, 11 droni
lanciati da nord.
Le difficoltà
crescenti sul campo di battaglia potrebbero essere alla base della decisione del
presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rimuovere il comandante delle
Operazioni delle forze congiunge, il generale Eduard Mykhailovich Moskalov, che
guidava le truppe in Donbass.
Moskalov aveva
assunto l’incarico a marzo dello scorso anno con la contemporanea nomina del
generale Oleksandr Pavliuk a capo dell’amministrazione militare regionale di
Kiev. Non sono chiari i motivi alla base della sua destituzione. Il suo nome non
era tra quelli accostati ai recenti casi di corruzione.
Una formazione di
“partigiani bielorussi”, denominata “Bypol”, ha riferito di aver messo fuori uso
un aereo militare russo in una base aerea vicino Minsk. “Questa è la diversione
di maggior successo dall’inizio del 2022. L’operazione è stata condotta da due
bielorussi. Hanno impiegato dei droni e hanno già lasciato il paese”, ha
twittato Franak Viacorka, un consigliere della leader dell’opposizione in
esilio, Svetlana Tikhanovskaya.
Pechino accusa
Washington di doppiezza e “bullismo”. “Mentre gli Stati Uniti intensificano i
loro sforzi per inviare armi ad una delle parti in conflitto, con il risultato
di una guerra infinita, continuano a venir diffuse false informazioni su
fornitura di armi da parte della Cina alla Russia”. E’ quanto ha detto la
portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, rinfacciando agli Stati Uniti di
“cogliere l’opportunità di sanzionare società cinesi senza motivo: questo è
apertamente bullismo e doppio standard”.
Ning ha sottolineato
che le sanzioni Usa, definite “illegali”, “danneggiano seriamente gli interessi
della Cina” e per questo il suo Paese “le rifiuta e le deplora con forza, avendo
presentato proteste formali alla parte americana”.
Gli Stati Uniti
hanno sanzionato le società cinesi Changsha Tianyi Space Science e Technology
Research Institute, nota anche come Spacety China, per aver fornito immagini
satellitari dell’Ucraina al Wagner Group.
L’ex presidente
russo e attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry
Medvedev, è tornato ad evocare l’apocalisse. In un editoriale per il quotidiano
Izvestia, ha scritto testualmente: “Se si pone la questione dell’esistenza
stessa della Russia, non sarà decisa sul fronte ucraino ma insieme alla
questione dell’esistenza dell’intera civiltà umana. Non dovrebbero esserci
ambiguità qui: non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia”.
E ancora: “I nostri
nemici” potrebbero “continuare a pompare armi verso il regime neofascista di
Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati, non volendo capire
che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale. A una sconfitta per
tutti. A un Incidente. All’apocalisse. In cui ci si potrà scordare per secoli la
vita precedente, finché le macerie non cesseranno di emettere radiazioni”.
L'affondo del
fedelissimo dello Zar contro l'Italia.
Solovyev minaccia
l’Italia, il giornalista-oligarca amico di Putin al veleno: “Voi bastardi dovete
tremare”. Carmine Di Niro su Il Riformista il 28 Febbraio 2023
Nessun giro di
parole, nessuna perifrasi. Vladimir Solovyev, giornalista-oligarca della tv
russa Rossija 1 ma soprattutto amico personale del presidente Vladimir Putin,
che anche grazie al leader del Cremlino è diventato milionario, minaccia senza
mezzi termini l’Italia per il suo appoggio all’Ucraina.
Solovyev lancia i
suoi strali dalla sua trasmissione seguitissima in patria: “Chissà se a Milano
si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi”, dice l’uomo della
propaganda russa in riferimento a fatti storici molto in là nel tempo.
Solovyev torna
infatti al 1799, quando il generale russo Suvorov era a capo dell’armata
russo-austriaca destinata alla campagna in Italia contro i francesi. “Se
parliamo seriamente, se capiamo davvero qual è la posta in gioco, allora
lasciateli tremare i bastardi. Poi ci sarà un’altra traversata delle Alpi, se è
necessario. Pensate al monumento a Suvorov, e chissà se a Milano si ricordano
come baciavano le mani dei soldati russi. Se fate i maleducati con noi, voi
bastardi, dovete tremare. I russi partono piano, ma poi vanno veloce”, le
minacce di Solovyev.
Il giornalista russo
d’altronde è particolarmente legato al nostro Paese. In Italia possiede quattro
ville, due sul lago di Como del valore complessivo di 8 milioni di euro erano
state anche congelate all’oligarca 58enne in una operazione condotta nel marzo
del 2022 dalla Guardia di Finanza, pochi giorni dopo l’inizio dell’offensiva di
Mosca contro Kiev.
Parole che comunque
non sorprendono. Solovyev, più volte ospite di talk show italiani anche a
conflitto ormai iniziato, in particolare a ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti su
La7, aveva etichettato il nostro come un “paese fascista”. E che l’Italia nel
‘mirino’ del Cremlino lo dimostra anche il trattamento “speciale” riservatoci
dallo stesso Vladimir Putin nel corso del suo ultimo discorso sullo stato della
nazione all’Assemblea federale russa.
Putin in
quell’occasione aveva ricordato in particolare gli aiuti russi all’Italia
durante la prima fase della pandemia di Covid-19, la discussa operazione messa a
punto durante il governo Conte che secondo diverse ricostruzioni giornalistiche
nascondeva in realtà un tentativo da parte russa di infiltrare spie sul nostro
territorio.
“La Russia sa essere
amica e mantenere la parola data, non deluderà nessuno e sosterrà sempre i suoi
partner in situazioni difficili, lo dimostra il nostro aiuto ai Paesi europei,
come l’Italia, durante il momento più difficile della pandemia di Covid,
esattamente come stiamo andando in aiuto nelle zone del terremoto”, erano state
la parole di Putin il 21 febbraio scorso.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
La Repubblica.
Mosca: "Bloccato massiccio attacco con droni in Crimea"
Lukashenko in Cina,
segnala "pieno sostegno" al piano di pace di Pechino. L'intelligence britannica:
"Mosca ha esaurito le scorte di droni kamikaze"
Putin ha dato
seguito all'annuncio della settimana scorsa firmando la sospensione del trattato
New Start per la non proliferazione nucleare. Lo fa nel giorno in cui Mosca si
scopre vulnerabile: velivoli senza pilota vengono avvistati in varie regioni del
Sud e anche a 100 chilometri dalla capitale. Ma da Kiev oggi arriva una smentita
sul coinvolgimento: "L'Ucraina non colpisce il territorio russo", ha dichiarato
il consigliere di Zelensky Mikhailo Podolyak. Intanto sul territorio ucraino i
combattimenti infuriano soprattutto intorno a Bakhmut: un consigliere di
Zelensky intervistato dalla Cnn ammette che "la ritirata è un'opzione".
Punti chiave
15:14
Moldavia, Zakharova:
"Kiev prepara una provocazione con materiali radioattivi"
14:26
Ucraina, Olaf
Scholz: "In caso di attacco difenderemo ogni metro quadrato della Nato"
14:17
Ucraina, Mosca: "Non
esclusi contatti con rappresentanti Usa a Ginevra"
13:24
Xi: "In Ucraina
serve una soluzione politica, no alla mentalità della Guerra Fredda"
12:49
Ucraina, consigliere
Zelensky: "Kiev valuta di ritirare le truppe da Bakhmut"
12:18
Mosca: "Respinto
massiccio attacco di droni in Crimea"
11:25
Lukashenko a Xi:
"Pieno sostegno all'iniziativa cinese per la pace"
11:01
Podolyak smentisce
coinvolgimento di Kiev negli attacchi con droni: "L'Ucraina non colpisce in
territorio russo"
10:29
Nato, Stoltenberg
invita Zelensky al vertice a Vilnius
10:27
Ucraina,
intelligence Gb: "Minor numero di attacchi, Mosca ha esaurito lo stock di droni
kamikaze"
09:54
Ucraina, bombe russe
su Kherson: 5 morti
07:51
Media: esplosioni in
Crimea nella notte
03:15
Aiea: preoccupano i
bombardamenti vicino alla centrale di Zaporizhzhia
00:07
Allarme aereo a Kiev
e in altre regioni
00:07
Allarme aereo a Kiev
e in altre regioni
L'allarme aereo è
scattato in diverse regioni dell'Ucraina, anche a Kiev. Le sirene, scrive Unian,
hanno suonato nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Poltava,
Cherkasy, Kirovohrad e nel distretto di Nikopol, nella regione di
Dnipropetrovsk. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Poltava,
Dmytro Lunin, ha riferito su Telegram che un velivolo senza pilota russo è stato
abbattuto.
00:29
Kiev invia altre
truppe a Bakhmut
Il colonnello
generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze terrestri ucraine e del
comando operativo orientale, ha ordinato di inviare più truppe a Bakhmut dopo il
suo viaggio in prima linea il 25 febbraio. Lo riporta The Kyiv Independent.
00:50
Cnn: gli Usa hanno
addestrato più di 4.000 militari ucraini
Gli Stati Uniti
hanno già addestrato più di 1.000 soldati ucraini da gennaio e oltre 4.000
dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha riferito la Cnn. "L'addestramento
collettivo è in corso in tutta Europa" ha dichiarato il generale Douglas Sims
II, direttore delle operazioni del Joint Chief of Staff spiegando che "da
gennaio, l'esercito americano ha addestrato oltre 1.000 ucraini, portando il
totale dei soldati addestrati dagli Stati Uniti a poco più di 4.000".
01:12
A Kiev forte
minaccia di attacchi con droni kamikaze
Il sindaco di
Kremenchuk, Vitaly Maletskyi, ha riferito che in città si sono uditi suoni
simili a esplosioni. La polizia della regione di Kiev segnala un'alta minaccia
di attacco da parte di UAV iraniani "Shahed", noti come 'droni kamikaze'.
01:52
Kiev: cinque droni
russi abbattutti sull'oblast di Poltava
La difesa aerea
ucraina ha abbattuto cinque velivoli senza pilota (UAV) russi sopra l'oblast di
Poltava durante la notte. Lo ha riferito il governatore Dmytro Lunin citato da
'The Kyiv Independent'.
03:15
Aiea: preoccupano i
bombardamenti vicino alla centrale di Zaporizhzhia
Il direttore
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael
Mariano Grossi, ha espresso preoccupazione per i nuovi bombardamenti di
artiglieria vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e per la temporanea
perdita dell'unica linea elettrica di riserva rimasta.
07:14
Allarme aereo a
Mykolaiv
Un allarme antiaereo
è scattato questa mattina nella regione di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale:
lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Vitaly Kim, come
riporta il Guardian.
07:51
Media: esplosioni in
Crimea nella notte
Esplosioni nella
parte occidentale della Crimea occupata: lo riportano i media ucraini, che
citano canali Telegram locali. Le esplosioni sono avvenute a Yevpatoria, a circa
65 km a nord di Sebastopoli, e nel villaggio di Chornomorske.
"Sono state udite a
Chornomorske tutta la notte fino alle 5 del mattino... A Chornomorske, le
finestre hanno tremato per le esplosioni all'1:54, alle 2:55 e alle 4:20",
riferiscono fonti locali. Esplosioni sono state segnalate anche a Yevpatoria,
una delle quali nella parte settentrionale di Sebastopoli
08:14
Usa: "La Cina spende
miliardi in disinformazione pro russa"
La Cina ha speso
miliardi di dollari per fare disinformazione a livello globale, compresa quella
filo-russa rispetto alla guerra in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale
degli Stati Uniti James Rubin, coordinatore del Global Engagement Center, ente
del Dipartimento di Stato americano istituito per "smascherare e contrastare" la
propaganda straniera e la disinformazione. Giornalista ed ex funzionario
dell'amministrazione Clinton, Rubin ha anche sostenuto che l'Occidente è stato
troppo lento nel rispondere a questa disinformazione. Nella quale la Cina spende
molti più soldi che la Russia.
08:28
Kiev: "I russi
continuano a evacuare la Crimea occupata"
I russi continuano a
evacuare la penisola di Crimea occupata: lo riferisce lo stato maggiore
delle Forze Armate ucraine sulla sua pagina Facebook. "Ancora una volta, è stata
registrata l'evacuazione di alcune categorie di cittadini dalla Crimea occupata.
Recentemente, i militari delle forze di occupazione russe di stanza a Perevalny
(centro-est, ndr) hanno inviato le loro famiglie in Russia", si legge nel
rapporto dell'esercito. Allo stesso tempo, i russi stanno rafforzando le loro
difese nella penisola e stanno costruendo fortificazioni.
08:33
Ucraina,
intelligence Gb: "Mosca lancia droni da Briansk, aumenta minaccia per Kiev"
L'esercito russo ha
iniziato a lanciare i suoi droni kamikaze Shahed dalla regione di Briansk, in
Russia, una mossa che rappresenta una minaccia maggiore per Kiev: lo scrive il
ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di
intelligence. Nel suo rapporto pubblicato su Twitter, il ministero commenta che
probabilmente l'attacco con gli Shahed del 26 febbraio scorso è partito dalla
regione di Bryansk - che si trova a circa 200km dalla capitale ucraina - mentre
l'unico sito di lancio osservato da metà dicembre 2022 era quello della regione
di Krasnodar, al di là del Mar d'Azov. "Un secondo sito di lancio darebbe ai
russi un diverso asse di attacco, più vicino a Kiev", commentano gli esperti di
Londra.
09:54
Ucraina, bombe russe
su Kherson: 5 morti
Cinque persone sono
morte e altre sette sono rimaste ferite durante i bombardamenti russi di ieri
sulla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto
l'Amministrazione militare regionale, come riportano i media ucraini. La città e
l'omonima regione sono state colpite 86 volte nel corso della giornata. "Hanno
sparato da MLRS (sistemi missilistici a lancio multiplo, ndr), mortai,
artiglieria, carri armati, droni e aerei. Kherson è stata bombardata nove volte
dall'esercito russo: ancora una volta hanno colpito i quartieri residenziali
della città", afferma il rapporto sottolineando che è stata colpita anche l'area
di un'impresa statale oltre ad alcune case.
10:04
Russia, Duma al
voto: fino a 15 anni per chi scredita combattenti
La Duma, il
Parlamento russo, comincia oggi a votare emendamenti alla legge che rafforzano
ulteriormente le leggi sulla censura del Paese, prevedendo fino a 15 anni di
carcere per chi scredita le forze armate e le organizzazioni militari
volontarie come il gruppo Wagner. "Qualsiasi tipo di diffusione pubblica di
informazioni consapevolmente false e azioni pubbliche volte a screditare le
Forze armate russe, le unità di volontari è inammissibile", ha detto il
presidente della Duma Vyacheslav Volodin su Telegram, come riporta Interfax.
10:17
Nato, la presidente
ungherese: "Ratificare l'adesione di Svezia-Finlandia"
La presidente
ungherese, Katalin Novàk, ha esortato a ratificare l'ingresso della Finlandia e
della Svezia nella Nato "il prima possibile" mentre è iniziato in Parlamento il
dibattito sulle mozioni dopo mesi in cui i disegni di legge erano rimasti
bloccati. Lo riferisce il Guardian. "E' una decisione complessa, con gravi
conseguenze, quindi è necessaria un'attenta considerazione", ha detto Novak su
Facebook. "La mia posizione è netta: nella situazione attuale, l'adesione di
Svezia e Finlandia è giustificata. Confido che l'assemblea nazionale prenderà
una decisione saggia il prima possibile!", ha aggiunto la presidente. Ungheria e
Turchia sono i due membri della Nato che devono ancora ratificare l'ingresso di
Svezia e Finlandia.
10:27
Ucraina,
intelligence Gb: "Minor numero di attacchi, Mosca ha esaurito lo stock di droni
kamikaze"
Il minor numero di
attacchi con droni in Ucraina da parte della Russia indica un apparente
"esaurimento" dei suoi arsenali, un fatto che spingerà probabilmente Mosca a
cercare di rifornirsene. A scriverlo è nel suo rapporto quotidiano
l'intelligence britannica, secondo cui la Russia starebbe inoltre cercando di
utilizzare "un asse diverso" per eseguire questo tipo di attacchi, a partire da
punti più vicini alla capitale ucraina, Kiev.
10:29
Nato, Stoltenberg
invita Zelensky al vertice a Vilnius
Il segretario
generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky al vertice dell'Alleanza che si terrà a Vilnius, in Lituania,
a luglio: lo ha detto lo stesso Stoltenberg in un'intervista all'emittente
radiotv lituana LRT. "Ho invitato il presidente Zelensky a partecipare al
vertice della Nato a Vilnius. Credo fermamente che questo sarà un forte segno
della nostra solidarietà, del sostegno che gli alleati hanno per l'Ucraina, e
spero che il signor Zelensky possa partecipare.
Naturalmente, questo
dipenderà dalla situazione in Ucraina, che è ancora nel bel mezzo di una
guerra", ha detto.
11:01
Podolyak smentisce
coinvolgimento di Kiev negli attacchi con droni: "L'Ucraina non colpisce in
territorio russo"
Mikhailo Podolyak,
consigliere del capo dell'ufficio del presidente, ha affermato su Twitter che
l'Ucraina non colpisce il territorio della Russia, negando le accuse secondo cui
l'Ucraina avrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con droni.
"L'Ucraina sta conducendo una guerra difensiva per disoccupare tutti i suoi
territori" ha affermato Podolyak per il quale in Russia stanno crescendo
processi di panico e disintegrazione, "una manifestazione dei quali è un aumento
degli attacchi interni da parte di oggetti volanti non identificati contro
strutture infrastrutturali".
11:25
Lukashenko a Xi:
"Pieno sostegno all'iniziativa cinese per la pace"
La Bielorussia
"sostiene pienamente l'iniziativa" cinese sulle proposte per la pace e la
sicurezza internazionale, molte delle quali sono state riprese nel documento di
pace di 12 punti presentato da Pechino sulla crisi ucraina, respinto però da
Kiev, Usa ed Europa. E' quanto ha detto il presidente bielorusso Alexander
Lukashenko, stretto alleato del capo del Cremlino Vladimir Putin, nel colloquio
a Pechino con il presidente Xi Jinping, secondo il resoconto dell'agenzia
ufficiale di Minsk Belta.
12:18
Mosca: "Respinto
massiccio attacco di droni in Crimea"
"È stato evitato il
tentativo di un massiccio attacco con droni alla Crimea, sei droni sono stati
abbattuti, altri quattro disattivati". Lo ha detto il ministero della difesa
della federazione russa, come riporta Ria Novosti. Non si registrano vittime.
12:22
Russia, Peskov:
"Kiev nega l'invio di droni? Non gli crediamo"
La Russia non crede
a quanto detto dal consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak secondo
il quale l'Ucraina non attacca il territorio russo con i droni. "Non gli
crediamo", ha risposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una
domanda in proposito, come riferisce l'agenzia Ria Novosti.
12:49
Ucraina, consigliere
Zelensky: "Kiev valuta di ritirare le truppe da Bakhmut"
Le truppe ucraine
potrebbero "ritirarsi strategicamente" dalla roccaforte orientale strategica di
Bakhmut, se necessario. Lo ha detto un consigliere del presidente Volodymyr
Zelensky. Le forze russe continuano a fare progressi a Bakhmut, ha detto
riferito lo stato maggiore dell'esercito ucraino in un aggiornamento. La Russia
sta cercando di accerchiare Bakhmut e di usare le sue truppe "migliori", "più
ben addestrate e più esperte" del gruppo mercenario Wagner, ha detto alla Ccc il
consigliere economico ucraino Alexander Rodnyansky. "I nostri militari
ovviamente soppeseranno tutte le opzioni. Finora hanno tenuto la città, ma, se
necessario, si ritireranno strategicamente, perchè non sacrificheremo tutta la
nostra gente per niente", ha detto riferendosi ai 4.500 civili rimasti in città.
13:11
Kiev, difesa aerea
abbatte drone russo sulla capitale
La difesa aerea
ucraina ha abbattuto un drone russo nel cielo sopra la regione di Kiev. Lo
annuncia il colonnello Yuri Ignat, portavoce dell'Air Force, come
riporta Ukrainska Pravda.
13:24
Xi: "In Ucraina
serve una soluzione politica, no alla mentalità della Guerra Fredda"
La Cina promuove i
colloqui di pace e la soluzione politica della guerra in Ucraina e sollecita ad
abbandonare la "mentalità da Guerra Fredda" per risolvere la crisi. Lo ha
dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso dell'incontro con il
leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, giunto ieri a Pechino in visita di
Stato.
Citando per la prima
volta il documento in dodici punti per la pace in Ucraina, pubblicato la
settimana scorsa dal ministero degli Esteri di Pechino, Xi ha sottolineato che
"il fulcro della posizione della Cina è promuovere i colloqui di pace. Dobbiamo
attenerci alla direzione della soluzione politica e abbandonare ogni mentalità
da Guerra Fredda", ha aggiunto il presidente cinese, citato dall'emittente
televisiva statale Cctv.
Occorre, inoltre,
"rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i Paesi e
costruire un'architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e
sostenibile", ha detto Xi, aggiungendo che non si deve "politicizzare e
strumentalizzare l'economia mondiale" e che bisogna fare cose che servano a
"risolvere pacificamente la crisi".
13:40
Prigozhin: "Sempre
più spargimento di sangue a Bakhmut"
Le forze armate
ucraine stanno facendo convergere rinforzi verso Bakhmut, dove "decine di
migliaia di soldati" di Kiev stanno dando vita a una "resistenza accanita" e "lo
spargimento di sangue aumenta di giorno in giorno". Lo ha detto oggi in un
messaggio video Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, che svolge
un ruolo di primo piano nei tentativi russi di conquistare questa città del
Donbass ucraino.
14:17
Ucraina, Mosca: "Non
esclusi contatti con rappresentanti Usa a Ginevra"
Il vice ministro
degli Esteri russo Sergei Ryabkov "non ha escluso" contatti con rappresentanti
Usa a Ginevra. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov.
Lo riporta Ria Novosti. "Mosca è pronta a discutere con gli Usa eventuali
questioni di loro interesse - ha detto - ma questo non influenza l'attuale
situazione di partenza".
14:26
Ucraina, Olaf
Scholz: "In caso di attacco difenderemo ogni metro quadrato della Nato"
"Nel caso di un
attacco difenderemo insieme ogni metro quadrato della nostra Alleanza". Lo ha
detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una conferenza stampa bilaterale
col collega lettone, Arturs Krisjans Karins. Scholz ha spiegato che nella
bilaterale si è affrontato il capitolo della forza del fianco est della Nato.
"La nostra forza ci dà sicurezza", ha aggiunto.
15:01
Xi: "Cina e
Bielorussia, amicizia indissolubile"
Cina e Bielorussia
godono di un'amicizia "indissolubile" e, in un panorama di "incertezze" a
livello internazionale, devono promuovere lo sviluppo "sano e stabile" delle
relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante
l'incontro con il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, giunto ieri a Pechino
per una visita di tre giorni. "Di fronte a una situazione internazionale piena
di instabilità e incertezze, la Cina è disposta a collaborare con la Bielorussia
per promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali ad alto
livello", ha scandito il presidente cinese, citato dall'emittente televisiva
statale Cctv.
15:14
Moldavia, Zakharova:
"Kiev prepara una provocazione con materiali radioattivi"
La Russia si dice
preoccupata per le informazioni secondo cui una provocazione di Kiev con
l'utilizzo di materiali radioattivi potrebbe avvenire nei pressi della
Transnistria (regione moldava separatista filorussa) dove le tensioni stanno
aumentando, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri
russo Maria Zakharova, citata dalla Tass.
15:35
Lavrov, "rinnovo
accordo grano se garantiti produttori russi"
La Russia
acconsentirà a una nuova estensione per l'esportazione di grano dai porti
ucraini sul Mar Nero solo se ai produttori di cereali e fertilizzanti russi sarà
permesso di esportare sui mercati internazionali. Lo ha detto il ministro degli
Esteri Serghei Lavrov incontrando oggi a New Delhi il suo omologo turco Mevlut
Cavusoglu a margine di una riunione dei capi delle diplomazie dei Paesi del G20.
"La parte russa - si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca
- ha sottolineato che la continuazione dell'accordo sul grano è possibile solo
se verranno tenuti in considerazione gli interessi dei produttori russi di
derrate e di fertilizzanti in termini di libero accesso ai mercati mondiali".
L'accordo, mediato dalla Turchia e dall'Onu, è stato rinnovato per 120 giorni lo
scorso novembre e quindi arriverà a scadenza a metà marzo.
15:39
Moldavia, "menzogne
da Mosca su attacco Kiev"
Il governo moldavo
ha definito 'una menzogna' le dichiarazioni di oggi della portavoce del
ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secondo cui Kiev sarebbe
intenzionata ad usare materiale radioattivo vicino alla regione separatista
della Transnistria. "Le autorità statali stanno monitorando la situazione e non
confermano le informazioni diffuse dalla parte russa", si legge in un messaggio
pubblicato sul canale Telegram del governo moldavo. Le autorità hanno inoltre
invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le fonti ufficiali di
informazione in Moldavia.
16:12
Media moldavo, "il
leader ceceno Kadyrov è stato avvelenato"
Il leader
ceceno Ramzan Kadyrov, luogotenente di Vladimir Putin nel Paese, sarebbe stato
avvelenato e per questo motivo non sarebbe stato presente al discorso del
presidente russo sullo stato della nazione. Lo scrive il media moldavo Timpul ma
per ora non ci sono altre conferme. Kadyrov, 46 anni, secondo il giornalista
kazako Azamat Maitanov, al momento ha gravi problemi di salute, forse ai reni.
Secondo alcune fonti, il leader ceceno, che non si fida dei medici russi, si
sarebbe rivolto a un nefrolologo arrivato a Grozny dagli Emirati Arabi Uniti.
Nei giorni scorsi Kadyrov ha detto che il comandante delle forze cecene in
Ucraina Apty Alaudinov è stato avvelenato con una lettera impregnata da un
agente tossico.
16:23
Kiev, "Abbattuto
drone russo nei cieli sopra la capitale"
La difesa aerea
ucraina ha abbattuto un drone russo nel cielo sopra la regione di Kiev: lo ha
reso noto il colonnello Yuri Ignat, portavoce dell'Air Force ucraina parlando al
sito on-line locale, Ukrainska Pravda. Il portavoce ha aggiunto che il tipo di
drone non è stato individuato e che lo sarà non appena verranno trovati i resti.
16:39
Kiev, esplosione in
un sito dove russi tengono armi nel Lugansk
Il capo
dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Gaidai, in un
messaggio su Telegram riportato dall'Ukrainska Pravda, ha riferito
dell'esplosione nella fabbrica dove l'esercito russo ha nascosto le sue
munizioni nella cittadina occupata di Kadiivka. Una colonna di fumo si sta
alzando sopra il luogo dell'esplosione, scrive il sito ucraino postando un
video.
16:43
Germania aprirà
impianti olimpici ad allenamenti atleti ucraini
In preparazione
dei Giochi Olimpici e delle Paralimpiadi di Parigi del prossimo anno, la
Germania si sta preparando ad aprire i suoi impianti olimpici agli atleti
provenienti dall'Ucraina. Gli sportivi avranno così la possibilità di
allenarsi lontano dalla guerra. Lo ha detto la ministra tedesca dell'Interno e
responsabile dello sport, Nancy Faeser, citata da Dpa.
16:50
Kiev, nel mar Nero 5
portaerei russe di missili Kalibr
Nel Mar Nero sono
diventate cinque le portaerei russe con missili Kalibr per un totale di 32
missili. Lo riporta il centro stampa del Comando della Marina delle Forze
Armate, citato da Unian. "A partire dal 1 marzo, 17 navi nemiche sono in
servizio di combattimento nel Mar Nero, comprese cinque portaerei di missili da
crociera Kalibr, con un totale di 32 missili", si legge nel messaggio.
16:59
G20: Usa "fiduciosi"
che ci sarà condanna alla Russia
Gli Usa sono
fiduciosi che dal G20 Esteri di Nuova Delhi uscirà una condanna alla Russia e
all'invasione dell'Ucraina. Lo ha affermato il segretario di Stato, Antony
Blinken: "Penso che il linguaggio che verrà utilizzato rifletterà una
maggioranza, anche se non assoluta, del G20 contro la guerra della Russia", ha
affermato Blinken prima di partire per l'India.
17:28
Garland, Russia e
Wagner commettono crimini contro l'umanità
La Russia sta
commettendo crimini contro l'umanità e il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny
Prigozhin, è un criminale di guerra. Lo afferma il ministro della giustizia
americano, Merrick Garland.
17:33
Brasile, Lavrov in
visita da Lula ad aprile
Il governo del
presidente Lula ha informato che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov,
dovrebbe visitare il Brasile ad aprile. "Sergei Lavrov ha confermato la sua
intenzione di effettuare una visita di lavoro in Brasile ad aprile", rende noto
il ministero degli Esteri di Brasilia. La scorsa settimana Mosca ha riferito di
aver preso atto della proposta lanciata da Lula di creare un gruppo di Paesi per
facilitare i colloqui di pace in Ucraina. Intanto, il ministro degli Esteri
brasiliano, Mauro Vieira, oggi ha incontrato proprio Lavrov in India. Vieira è a
New Delhi, dove sta partecipando al vertice dei ministri degli Esteri del G20,
gruppo che il Brasile presiederà nel 2024.
17:59
Kiev saluta il primo
giorno di primavera: "Sconfitto terrore invernale di Putin"
Nella tradizione
ucraina, il primo marzo segna l'arrivo della primavera e molti hanno condiviso
sui social foto di gemme sugli alberi, congratulandosi per essere sopravvissuti
al "terrore invernale di Putin". "Il primo marzo 2023, Putin ha subito un'altra
forte sconfitta. Malgrado il freddo, il buio e gli attacchi missilistici,
L'Ucraina ha perseverato e sconfitto il terrore invernale. Inoltre l'Europa non
si è 'congelata' malgrado le previsioni e le ironie russe. Ringrazio i nostri
partner per essere al fianco dell'Ucraina", ha twittato oggi il ministro degli
Esteri Dmytro Kuleba. "Ci volevano congelare e gettare nel buio. Siamo
sopravvissuti", ha commentato su Twitter il ministro della Difesa Oleksii
Reznikov. "Felice primo giorno di primavera", si legge sull'account twitter
della polizia di confine, con la foto di un agente che mostra un mazzetto di
fiori bianchi nella neve.
Molti comuni ucraini
si sono aggiunti nel celebrare la primavera sui social, malgrado il tempo sia
ancora freddo e in alcune zone abbia nevicato. "Siamo sopravvissuti
all'inverno", ha twittato la giornalista ucraina di Politico, Nina Melkozerova.
Benvenuta alla "inarrestabile e inevitabile vittoriosa primavera ucraina", ha
scritto su Instagram il soldato Yuriy Syrotuk, condividendo le immagini di un
albero pieno di gemme. All'inizio dell'inverno, dopo i ripetuti attacchi
missilistici russi alle infrastrutture energetiche del paese molti esperti
internazionali avevano paventato il rischio di una catastrofe umanitaria con i
civili ucraini lasciati al buio e al freddo senza luce e riscaldamento.
18:14
Mosca, "sono in
corso discussioni con gli Usa sul New Start"
La Russia e gli Usa
hanno avuto colloqui negli ultimi giorni in merito al New Start, l'ultimo
accordo bilaterale per la limitazione delle armi nucleari ancora in vigore, che
Mosca ha deciso di sospendere con una legge firmata ieri dal presidente Vladimir
Putin. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato
dalla Tass. "Posso confermare che negli ultimi giorni abbiamo avuto discussioni
sulla questione del New Start attraverso canali riservati e queste discussioni
possono continuare", ha sottolineato Ryabkov. Il vice ministro ha precisato che
la parte americana è interessata ad alcuni dettagli relativi alla sospensione, e
in particolare "quando ci sarà una notifica ufficiale". Alla domanda se
rappresentanti russi e americani potranno incontrarsi a margine della conferenza
sul disarmo a Ginevra, Ryabkov ha risposto: "Niente da dichiarare a questo
riguardo".
18:32
Fonti, da Ue un
miliardo per munizioni da inviare a Kiev
L'Ue proporrà di
usare un miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace (Epf) per acquistare
munizioni di calibro 1.55 e anche di altri calibri da inviare all'Ucraina, come
richiesto dal presidente Volodymyr Zelensky. E' quanto si apprende da fonti
europee. I Paesi membri che vorranno acquistare munizioni per Kiev, secondo la
proposta, saranno rimborsati dall'Ue utilizzando il miliardo del Fondo. La
proposta sarà avanzata dal Servizio di Azione Esterna dell'Ue e arriverà sul
tavolo del Consiglio Affari Difesa il prossimo 7 marzo.
19:02
Kiev, allarme aereo
in varie regioni dell'Ucraina
Un allarme aereo è
stato dichiarato in varie regioni dell'Ucraina, Kiev compreso. Lo annunciano i
siti ucraini. Ukrinform scrive, citando i residenti, che esplosioni sono state
sentite nella regione di Poltava, nel distretto di Kremenchuk, al centro del
paese.
19:49
Premier Lettonia,
sostegno a Kiev è nell'interesse dell'Europa
"È nell'interesse
dell'Europa sostenere l'Ucraina. Cosa significherebbe per la sicurezza di altre
nazioni in Europa se la Russia avesse successo in Ucraina? Sarebbe un mondo
terribile". Lo ha detto l premier lettone Krisjanis Karins in occasione della
conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.
"Dobbiamo continuare ad agire con decisione. Sono convinto che l'Occidente sia
resiliente. Le autocrazie sottovalutano sempre la forza delle democrazie", ha
detto Karins.
"La sfida che
affrontiamo tutti insieme in Lettonia, in Germania, in Francia, nel Regno Unito,
negli Stati Uniti è assicurarci che le nostre società capiscano che questo non è
un evento a breve termine", ha affermato il premier lettone. "Non si tratta solo
della prossima primavera, possono volerci anni. Dobbiamo adattare la nostra
industria militare e della difesa per essere in grado di affrontare queste
grandi sfide", ha aggiunto.
20:11
Kiev, esplosioni in
alcuni insediamenti nel sud della Crimea
"Un'esplosione si è
verificata sul territorio della Crimea temporaneamente occupata dai russi, a
Bakhchisarai, vicino all'unità militare. Si sono sentite esplosioni anche a
Yalta, Gurzuf e altri insediamenti sulla costa meridionale della penisola". Lo
ha riferito il canale Crimean Wind Telegram, riporta Ukrinform.
20:29
Kiev contro le
aziende europee ancora in Russia: "Finanziano la guerra"
Kiev contro le
aziende europee ancora in Russia, "finanziano la guerra". L'accusa è arrivata
dal consigliere della presidenza ucraina, Mikhaylo Podolyak, che ha citato la
Raiffeisenbank, la filiale russa della banca austriaca Raiffeisen Banking Group,
la multinazionale tedesca Metro e il gruppo francese Auchan. "Pagando le tasse
in Russia, stanno di fatto finanziando la guerra. E sembra, per usare un
eufemismo, un pò strano. Quindi, ovviamente, ci sono molte più aziende per le
quali è necessario imporre sanzioni", ha detto Podolyak citato dall'agenzia di
stampa Ukrinform, denunciando ancora che in Europa ci sono "alcune forze" che,
"dopo tutto, vorrebbero che la Russia rimanesse un partner sul mercato". Il
consigliere della presidenza ucraina ha quindi ribadito che per porre fine alla
guerra in Ucraina è necessario non solo fornire armi, ma anche limitare il più
possibile il 'finanziamento' alla Russia: "È ovvio. Non si possono dare armi
all'Ucraina con una mano e con l'altra sostenere il finanziamento dell'esercito
russo attraverso il sistema fiscale. È necessario parlarne direttamente,
nominare chiaramente le aziende che pagano le tasse in Russia e imporre loro
sanzioni".
20:48
Bulgaria: nessun
invio in Ucraina di equipaggiamento nucleare
Sofia non invierà in
Ucraina alcun equipaggiamento destinato al progetto per la costruzione della
centrale nucleare di Belene sul Danubio, la seconda in Bulgaria. Lo ha
dichiarato oggi il ministro dell'Energia Rossen Hristov in un comunicato stampa
inviato ai media locali. A suo dire "le voci in merito sono solo delle
speculazioni" e "simili decisioni possono essere adottate solo dal parlamento".
Il ministro rileva che per un'operazione del genere è stato mostrato interesse
esclusivamente dalla parte ucraina. Le dichiarazioni di oggi di Hristov sono in
netto contrasto con le sue parole rese pubbliche ieri dopo il suo incontro a
Stoccolma, a margine della riunione del Consiglio informale dei ministri europei
dell'Energia e del Trasporti, con il ministro dell'Energia ucraino Herman
Halushchenko. In un comunicato stampa di ieri del dicastero di Sofia è detto che
"i due ministri hanno discusso della possibilità di cooperazione nel settore
dell'energia nucleare, compreso l'uso in Ucraina delle attrezzature russe per la
centrale nucleare bulgara di Belene. La questione sarà studiata in dettaglio, e
per questo la parte ucraina invierà una squadra tecnica in Bulgaria".
21:19
Zelensky: "Sotto
controllo tutti i fronti"
Le forze ucraine
stanno tenendo sotto controllo tutte le sezioni del fronte, ha dichiarato il
presidente Volodymyr Zelensky in un discorso video. Zelensky ha parlato poche
ore dopo che il comando militare ucraino ha dichiarato che le truppe russe
stavano avanzando vicino alla città chiave di Bakhmut, al centro di pesanti
attacchi da parte delle forze russe.
21:43
Estonia, avanti con
forniture munizioni a Kiev
"È importante
continuare a sostenere l'Ucraina per aiutarla a vincere la guerra e dare
esecuzione all'invio congiunto di munizioni da parte dell'Unione europea. Allo
stesso tempo, dobbiamo garantire l'applicazione delle sanzioni alla Russia e
isolarla a livello internazionale". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli
Esteri dell'Estonia, Urmas Reinsalu, al termine dell'incontro con il ministro
degli Affari Europei finlandese, Tytti Tuppurainen. Durante l'incontro - che ha
riguardato l'ulteriore sostegno all'Ucraina, l'adesione alla Nato di Finlandia e
Svezia e la garanzia che la Russia sia ritenuta legalmente responsabile dei
crimini commessi in Ucraina - i ministri hanno ribadito il loro fermo sostegno
all'Ucraina e l'intenzione dei rispettivi Paesi di continuare l'invio di
assistenza militare. Reinsalu e Tuppurainen hanno inoltre discusso delle
modalità per garantire che la Russia sia ritenuta legalmente responsabile dei
crimini commessi in Ucraina e del processo di istituzione di un tribunale
speciale per i crimini di aggressione.
21:52
Zelensky, superato
inverno molto difficile
"Questo inverno è
finito. È stato molto difficile, e ogni ucraino ha sentito questa difficoltà. Ma
siamo comunque riusciti a fornire all'Ucraina elettricità e riscaldamento.
Certo, la minaccia al sistema energetico rimane, ma stiamo continuando a
lavorare e a prepararci per la prossima stagione". Così il presidente
dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel consueto post serale pubblicato sui suoi
canali social. Oggi Zelensky ha incontrato "tutti i responsabili della stabilità
del nostro sistema energetico", in una riunione durata "oltre tre ore", ha
aggiunto il presidente ucraino.
22:15
Usa cercano sostegno
alleati a sanzioni Cina per Ucraina
Gli Stati Uniti
stanno cercando il sostegno degli alleati su possibili sanzioni alla Cina se
Pechino fornirà aiuti militari alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo
riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Le consultazioni sono
nelle fasi preliminari e puntano a ottenere il sostegno in particolare dei paesi
del G7.
Estratto
da repubblica.it l’1 marzo 2023.
Vladimir Putin e
l'ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, da anni additata come la sua
giovane amante, vivono insieme nella lussuosa residenza a Valdai. Lo rivela
un'inchiesta di Proekt, sito indipendente russo specializzato in giornalismo
investigativo.
Assistenti e
familiari della donna risiederebbero nella grande residenza di Valdai e una
sorella possiederebbe un appartamento nelle vicinanze. All'interno del
comprensorio è stato costruito un "terem" di legno, tradizionale abitazione per
le donne e i bambini, dove alloggiano la ginnasta e i due figli, nati nel 2015 e
nel 2019, che Kabaeva avrebbe avuto da Putin.
(...)
Nel 2003 il
presidente russo ha divorziato da Ljudmila dopo 30 anni di matrimonio. Putin ha
sempre negato i pettegolezzi sulla sua presunta relazione con l'ex campionessa
di ginnastica ritmica che ha 30 anni meno di lui. Nell'aprile dello scorso anno,
mentre tutti pensavano che fosse nascosta in Svizzera dall'inizio della guerra
in Ucraina, è comparsa a un evento a Mosca promosso dalla sua fondazione con un
anello alla mano destra. Il gioiello, indossato dove si porta la fede nei Paesi
ortodossi, non è passato inosservato tra i media: un possibile regalo da parte
del presidente russo per sugellare la loro relazione.
Nata in Uzbekistan,
è considerata una star nazionale, ha vinto 21 medaglie ai Campionati Europei, 14
ai Campionati mondiali e due medagli olimpiche, tra cui l'oro ad Atene 2004. Dal
2008, finita la sua carriera nella ginnastica ritmica, è entrata a far parte del
Consiglio di amministrazione del Gruppo mediatico nazionale che controlla tv e
radio filo-governative. Ed è finita nel mirino delle sanzioni di Usa, Ue e Regno
Unito lo scorso anno.
Estratto
dell'articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera” il 2 marzo 2023.
La vita privata di
Vladimir Putin è un «segreto con sette sigilli», come dicono da queste parti.
Negli ultimi due
giorni, l’inchiesta del gruppo proekt.media sulle finanze di Vladimir Putin e
soprattutto sugli immobili che condivide con la sua presunta compagna, l’ex
ginnasta olimpionica Alina Kabayeva, ha fatto il giro del mondo. Titoli su
titoli, commenti.
In Russia non c’è
stata notizia. Nel senso che proprio non è arrivata agli occhi e alle orecchie
di nessuno. […]
Ne hanno parlato
solo i siti di opposizione, gli «agenti stranieri» bloccati nel territorio del
Paese, consultabili solo con le reti private Vpn alle quali dà una caccia
serrata il Roskomnadzor, l’agenzia federale per le telecomunicazioni, mettendole
sempre più spesso fuori uso.
Le maglie della
censura si fanno più strette quando si parla della famiglia dello zar.
[...] Nel 2008, il
tabloid Moskovskij korrespondent osò pubblicare alcune indiscrezioni
sull’intenzione del presidente di sposare Kabayeva.
La testata venne
chiusa una settimana dopo.
Figurarsi oggi.
Secondo Proekt , la villa di Valdai, distante duecento chilometri da Mosca, e di
recente fornita di un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 per proteggerla, non è
solo la dimora preferita dal presidente. Ma è anche il luogo dove vive insieme a
Kabayeva, soprannominata «la regina senza corona», probabilmente con i loro due
figli, dei quali non sono mai stati svelati il sesso e i nomi. […] La dimora è
stata sistemata per ogni esigenza della donna.
Assistenti e suoi
familiari risiedono anch’essi in una casa nel parco. All’interno del
comprensorio, è stato costruito un terem di legno, una residenza separata sulla
scorta di quelle che, nella Russia degli zar, venivano riservate alle élite
aristocratiche femminili.
È quello il luogo
dove alloggerebbero l’ex campionessa olimpica e i figli.
La parte privata dà
più nell’occhio. Ma anche quella che riguarda le finanze della Kabayeva contiene
dettagli inediti. La donna sarebbe proprietaria anche di un vasto attico di
2.600 metri quadri con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero,
descritto come l’appartamento più grande del Paese, di altri appartamenti sul
Mar Nero, registrati a nome della nonna.
Il valore del suo
portafoglio immobiliare si aggirerebbe intorno ai 120 milioni di dollari.
Secondo Proekt , la presunta compagna di Putin avrebbe accesso ai fondi della
società offshore cipriota Ermira consultants, che altre inchieste avevano già
identificato come una delle casseforti private del presidente e del suo circolo
ristretto.
Ermira controlla
anche la società Real Invest, proprietaria del marchio di vodka Putinka, i cui
proventi tra il 2004 e il 2019 secondo un’altra recente indagine di Proekt
avrebbero fruttato al presidente un guadagno di cinquecento milioni di dollari.
[…] L’eco suscitato ovunque dall’inchiesta di Proekt è normale. Perché tutto
quel che riguarda Putin fa notizia. Tranne che nel suo Paese.
La Repubblica. Breve
dialogo tra Blinken e Lavrov a margine del G20
Raid russo su
Zaporizhzhia: 2 morti. Le forze di Mosca stringono il cerchio intorno a Bakhmut.
Il cancelliere Scholz: "Putin non è pronto a parlare di pace. Pechino non
fornisca armi a Mosca". Kiev: uccisi 150mila soldati russi. Secondo i media
russi, un gruppo di ucraini sarebbe entrato nella regione di Bryansk e avrebbe
ucciso due persone, ferito un bambino e preso quattro ostaggi. Mosca: "C'è il
rischio di uno scontro tra potenze nucleari"
Kiev nega di aver
attaccato territori della Federazione russa con droni, ma il Cremlino insiste e
sostiene inoltre che è stato bloccato un tentativo di colpire la Crimea. Il
Pentagono: "Nessun aiuto per colpire il territorio russo". Primo contatto tra il
segretario di Stato Usa Blinken e il ministro degli Esteri russo Lavrov: "Mosca
revochi lo stop al Trattato Start, consideri il piano di Zelensky e cessi una
guerra ingiusta", dice Washington. In serata segnalata un'esplosione a Kolomna,
120 chilometri a sud-est di Mosca.
Punti chiave
23:16
Esplosione a
Kolomna, a 120 chilometri da Mosca
16:00
Blinken: "A Lavrov
ho detto che serve la diplomazia per una pace giusta"
12:36
Usa-Russia,
Blinken-Lavrov dieci minuti a colloquio a margine del G20
11:59
La Sirenetta di
Copenaghen vandalizzata con i colori della bandiera russa
11:52
Kiev: "I sabotatori
di Bryansk? Una provocazione russa"
11:19
Mosca: "C'è rischio
di uno scontro diretto tra potenze nuclearì"
10:52
Media Mosca: i
"sabotatori ucraini" hanno preso in ostaggio a Bryansk 4 ostaggi, due adulti e
due bambini
10:24
Russia: presa
d'ostaggi in regione di Bryansk, vicino alla frontiera con l'Ucraina
07:34
G20. Mosca: incontro
Lavrov-Blinken non è avvenuto per posizione Usa
06:57
Kiev: a Zaporizhzhia
distrutto un palazzo di cinque piani, due morti
03:14
Kiev: raid su
Zaporozhzhia, colpito un palazzo di abitazioni
03:14
Kiev: raid su
Zaporozhzhia, colpito un palazzo di abitazioni
La Russia ha
condotto questa notte un attacco aereo su Zaporizhzhia, danneggiando gravemente
un edificio residenziale. Lo ha scritto su Telegram il sindaco ad interim
Anatoly Kurtev, citato dai media ucraini. L'amministrazione militare regionale
di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l'edificio è stato probabilmente un
missile russo S-300. L'attacco ha distrutto tre piani del palazzo. Informazioni
su eventuali vittime non sono ancora disponibili.
03:45
In calo il sostegno
degli americani agli aiuti a Kiev
Il sostegno degli
americani all'Ucraina è in calo. Secondo gli ultimi sondaggi, la percentuale dei
cittadini Usa favorevoli agli aiuti a Kiev è calata dal 60% di maggio al 48%
nell'ultimo mese, con il 26% degli americani convinti che gli Stati Uniti
abbiano già dato troppo all'Ucraina. Questa tendenza agita la Casa Bianca
soprattutto in vista della stagione elettorale. E la preoccupazione è talmente
palpabile, riporta il New York Times, che il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky sta cercando di instaurare un contatto diretto con lo speaker della
Camera americana Kevin McCarthy per chiedere l'appoggio del Congresso.
04:11
Slovacchia:
possibile fornitur di dieci Mig-29 a Kiev
La Slovacchia sta
valutando la possibilità di dare all'Ucraina 10 dei suoi 11 aerei Mig-29 di
fabbricazione sovietica, ha dichiarato il ministro della Difesa slovacco
Jaroslav Nad, citato dai media internazionali. A inizio febbraio, il quotidiano
slovacco Sme aveva riferito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha
chiesto a Bratislava aerei da combattimento e che il primo ministro slovacco
Eduard Heger ha detto che sarebbero iniziati i negoziati per la fornitura dei
Mig.
04:20
Media russi: radar
per difesa aerea vicino a stazione metrò di Mosca
Una stazione radar
mobile utilizzata in coordinamento con i sistemi di difesa aerea è stata
installata vicino alla stazione della metropolitana Salaryevo a Mosca, riferisce
il quotidiano indipendente russo The Insider. Si tratterebbe di un P-18-2 Prima,
un radar di sorveglianza e puntamento progettato per rilevare e tracciare
bersagli in arrivo per i sistemi di difesa aerea che si trovano nelle vicinanze,
riferisce la fonte citando un video apparso sul canale Telegram locale 'Sirena
russa'.
06:57
Kiev: a Zaporizhzhia
distrutto un palazzo di cinque piani, due morti
Due persone sono
state uccise questa mattina in un attacco missilistico lanciato dalle forze
armate russe su Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram il sindaco ad interim
di Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev, precisando che nell'attacco è stato "quasi
completamente distrutto un edificio residenziale di cinque piani" e che "diverse
sono sotto le macerie"
07:34
G20. Mosca: incontro
Lavrov-Blinken non è avvenuto per posizione Usa
L'incontro tra il
ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di Stato
Usa, Anthony Blinken, non ha potuto aver luogo a causa della posizione degli
Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria
Zakharova, a margine del G20 in India, citata da Interfax. "A mio avviso, la
posizione degli Stati Uniti è stata indicata in modo chiaro e molto tempo. Sono
a favore dell'escalation dei conflitti in tutto il mondo e la diplomazia,
purtroppo, è apparentemente relegata in secondo piano", ha detto Zakharova ai
giornalisti.
08:42
Kiev: oltre 150mila
soldati russi uccisi da inizio guerra
Sono oltre
150mila i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione delle forze
di Mosca: lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev in un
post su Facebook, come riportano i media nazionali.
Dal 24 febbraio 2022
i russi hanno perso sul campo di battaglia almeno 150.605 soldati, di cui 715
solo nella giornata di ieri. Dall'inizio della guerra, la Russia ha inoltre
perso 3.397 carri armati, 6.658 veicoli blindati da combattimento, 2.398 sistemi
di artiglieria, 300 aerei, 288 elicotteri, 2.058 droni, 873 missili da crociera
e 18 navi.
09:04
Zelenska, 'a
Zaporizhzhia colpiti i civili, non perdoneremo'
La first lady
ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter l'attacco notturno russo con
missili a Zaporizhia: "La città resiste coraggiosamente, (l'esercito russo) per
rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un
condomionio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti.
Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non
perdoneremo". Zelenska ha anche postato un'immagine dell'edificio colpito.
09:31
Scholz a Pechino:
non consegnate armi alla Russia
"È deludente che
all'ultimo G20 non ci fosse una chiara condanna dell'aggressione russa in
Ucraina" da parte della Cina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz,
parlando al Bundestag a un anno dalla "svolta epocale" annunciata il 27 febbraio
dell'anno scorso. "Il mio messaggio alla Cina è chiaro: usate la vostra
influenza su Mosca per far ritirare le truppe e non consegnate armi alla
Russia", ha scandito.
09:34
Scholz: Putin non è
pronto a parlare di pace
"Putin non è affatto
pronto a parlare di pace". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz,
parlando al Bundestag. Scholz ha anche confermato che ci sono colloqui in corso
con Kiev per "le garanzie di sicurezza per il futuro".
09:51
Lavrov: l'Occidente
seppellisce l'accordo sul grano
"L'Occidente
seppellisce spudoratamente l'accordo" sulle esportazioni di grano dall'Ucraina
mediato dall'Onu e dalla Turchia. Lo ha affermato il capo della diplomazia
russa, Sergei Lavrov, durante una riunione dei ministri degli Esteri del G20 in
India.
Secondo Lavrov,
citato dall'agenzia Ria Novosti, ci sono "ostacoli evidenti" all'esportazione di
prodotti agricoli russi in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che l'Ue
cerchi di "convincere tutti del contrario".
10:24
Russia: presa
d'ostaggi in regione di Bryansk, vicino alla frontiera con l'Ucraina
Alcune persone sono
tenute in ostaggio in un negozio nella regione russa di Bryansk, teatro stamane
di un blitz di un gruppo di "sabotatori" arrivato dall'Ucraina. Lo riporta
l'agenzia Tass, confermando che "due villaggi sono stati attaccati dai
sabotatori: Lyubechane e Sushany" e che sarebbe sei i civili tenuti in ostaggio
a Lyubechane. La Tass parla di "diverse decine di militanti armati" e di
"scontri" con le forze russe.
In particolare,
il gruppo di "sabotatori ucraini" avrebbe eseguito un blitz in territorio russo,
uccidendo una persona e un ferendo un bambino di 10 anni. Lo ha reso noto il
governatore della regione di Bryansk, situata al confine con l'Ucraina, sul suo
canale Telegram. "I sabotatori dall'Ucraina hanno sparato contro un'auto in
movimento nel villaggio di Lyubechane, nel territorio del distretto di
Klimovsky", ha dichiarato Alexander Bogomaz, secondo cui il bambino è stato
portato in ospedale e sta ricevendo l'assistenza necessaria. "Le forze armate
della Federazione Russa stanno adottando tutte le misure necessarie per
eliminare il gruppo di sabotatori", ha aggiunto il governatore. Inoltre, secondo
Bogomaz, il distretto di Klimovsky è stato attaccato dalle forze armate ucraine
con un drone, il cui "schianto" ha provocato un incendio in un edificio
residenziale nel villaggio di Sushany. "I servizi operativi e di emergenza
stanno lavorando sul posto", ha precisato.
10:41
Mosca: "Pronti a
distruggere sabotatori Kiev che hanno sconfinato"
"Nel distretto di
confine di Klimovsky della regione di Bryansk i Servizi di sicurezza della
Russia e le forze del ministero della Difesa stanno adottando misure per
distruggere i nazionalisti ucraini armati che hanno violato il confine di
stato". È quanto riporta una nota dell'Fsb. Lo dice la Tass.
10:51
Russia: "Saremo
costretti a rispondere ai test nucleari Usa"
La Russia sarà
costretta a rispondere ai test nucleari se gli Stati Uniti decideranno di
condurli. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov
riferendosi al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari
(Ctbt) e alle "crescenti preoccupazioni" in merito per "le azioni degli Stati
Uniti". Secondo il vice di Sergei Lavrov, "la situazione intorno al Ctbt desta
crescente preoccupazione. La responsabilità del fatto che il Trattato non sia
entrato in vigore da più di un quarto di secolo della sua esistenza ricade,
infatti, sugli Stati Uniti, che con aria di sfida si sono rifiutati di
ratificarlo e stanno mostrando un'evidente propensione a riprendere i
test". Intervenendo alla Conferenza sul disarmo a Ginevra, Ryabkov ha affermato
che "non possiamo rimanere indifferenti a quanto sta accadendo. Se gli Stati
Uniti decideranno comunque di fare un simile passo e di essere i primi a
condurre test nucleari, saremo costretti a rispondere adeguatamente".
10:52
Media Mosca: i
"sabotatori ucraini" hanno preso in ostaggio a Bryansk 4 ostaggi, due adulti e
due bambini
Un gruppo di
"sabotatori ucraini" entrato stamane nella regione russa di Bryansk ha preso in
ostaggio due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany, secondo testimoni
citati dall'agenzia russa Interfax. I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno
detto di essere all'opera per "distruggere i nazionalisti armati ucraini che
hanno violato i confini dello Stato".
11:07
G20, Mosca e Pechino
accusano l'Occidente: "Ricatti e minacce"
Russia e Cina hanno
accusato l'Occidente di usare "ricatti e minacce" contro altri Paesi. Lo ha
riferito Mosca, dopo l'incontro a New Delhi dei ministri degli Esteri dei due
Paesi, Sergei Lavrov e Qin Gang, a margine del G20. "È stato espresso un rifiuto
unanime dei tentativi di interferire negli affari interni di altri Paesi, di
imporre approcci unilaterali attraverso ricatti e minacce e di opporsi alla
democratizzazione delle relazioni internazionali", si legge nella nota.
11:19
Mosca: "C'è rischio
di uno scontro diretto tra potenze nuclearì"
Gli Usa e la Nato
stanno "fomentando ulteriormente il conflitto in Ucraina e attorno" a questo
Paese e il loro "crescente coinvolgimento" porta il rischio di "uno scontro
militare diretto tra potenze nucleari con conseguenze catastrofiche". Lo ha
detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov alla Conferenza sul
disarmo a Ginevra. Lo riferisce la Tass.
11:30
Germania, respinta
l'esplusione dalla Spd per l'ex cancelliere Schröder
L'ex cancelliere
tedesco Gerhard Schröder può rimanere nell'Spd. La domanda di espulsione dal
partito è stata respinta anche in secondo grado dalla commissione arbitrale
distrettuale di Hannover, come riporta Der Spiegel. La richiesta di espulsione
dall'Spd per Schröder era stata fatta da diversi membri del partito, a causa
delle sue controverse dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e delle sue attività
commerciali con alcune aziende russe. Diverse organizzazioni del partito
socialdemocratico avevano avviato nei suoi confronti un procedimento di
espulsione, inizialmente respinto dalla commissione arbitrale del sottodistretto
di Hannover. Ora il ricorso è stato ora integralmente rigettato.
11:50
Cremlino: "A Bryansk
è un attacco terroristico. Putin annulla il viaggio a Stavropol"
Contro la regione
russa di Bryansk è in corso "un attacco di terroristi" a seguito di
infiltrazioni di "sabotatori ucraini": le forze di sicurezza "stanno prendendo
le misure per eliminarli". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov,
che ha annunciato che a causa di questa vicenda il presidente russo Vladimir
Putin ha annullato il viaggio che aveva in programma a Stavropol.
11:52
Kiev: "I sabotatori
di Bryansk? Una provocazione russa"
"La storia del
gruppo di sabotaggio ucraino nella Federazione Russa è una classica provocazione
deliberata. La Federazione russa vuole spaventare la sua gente per giustificare
l'attacco a un altro Paese e la crescente povertà dopo un anno di guerra. Il
movimento partigiano nella Federazione russa sta diventando più forte e più
aggressivo. Temete i vostri partigiani...". Così il consigliere del presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, commenta su Twitter l'azione
condotta in territorio russo da un gruppo di "sabotatori" proveniente
dall'Ucraina, come sostenuto dalle autorità russe.
11:59
La Sirenetta di
Copenaghen vandalizzata con i colori della bandiera russa
La celebre Sirenetta
di Copenaghen è stata vandalizzata nella notte: la base è stata imbrattata con i
tre colori della bandiera russa, rosso, blu e bianco. La polizia ha riferito di
un "caso di vandalismo" sul quale sono in corso indagini. Il gesto sembra un
messaggio di sostegno nei confronti di Mosca nell'ambito dell'invasione
dell'Ucraina.
12:19
G20, Lavrov:
"Nessuna dichiarazione finale comune, a causa dell'Occidente"
Il ministro degli
Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che il documento comune finale della
riunione dei ministri degli Esteri del G20 non potrà essere concordato a causa
delle controversie sulla situazione in Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.
"Purtroppo non è stato possibile approvare la dichiarazione a nome di tutti i
ministri del G20 - ha spiegato - i nostri colleghi occidentali, proprio come un
anno fa sotto la presidenza indonesiana, hanno cercato con menzogne e
dichiarazioni retoriche di portare in primo piano il problema della situazione
in Ucraina, che ovviamente servono sotto la salsa dell' 'aggressione russa'", ha
dichiarato Lavrov.
12:36
Usa-Russia,
Blinken-Lavrov dieci minuti a colloquio a margine del G20
Il segretario di
Stato americano e il ministro degli Esteri russo si sono parlati al G20 in India
12:53
Usa-Russia,
Zakharova: Lavrov e Blinken hanno parlato "in movimento"
Sergey
Lavrov e Anthony Blinken hanno parlato "in movimento" alla seconda sessione
della riunione dei ministri degli Esteri del G20 in India, ha detto la portavoce
del ministero degli Esteri Maria Zakharova all'ageniza Tass chiarendo quella che
era sembrata una iniziale smentita di Lavrov dell'incontro con Blinken.
Non si è trattato di
un vero bilaterale ma ci sono stati contatti. Blinken ha chiesto un contatto con
Lavrov. Lungo la strada, nell'ambito della seconda sessione dei venti, ha
parlato Sergey Viktorovich. Non ci sono state trattative, riunioni e così via ",
ha detto.
13:14
Fonti Ue, vicini a
grande coalizione per munizioni a Kiev
"Siamo sul punto di
vedere una grande coalizione tra i Paesi Ue sugli appalti congiunti per fornire
munizioni all'Ucraina: si tratta di un cambiamento profondo di approccio e avrà
conseguenze importanti anche sulla difesa comune europea". Lo ha detto un alto
funzionario Ue che segue da vicino i negoziati.
"Sulle munizioni
sarà una questione di giorni o settimane, non di mesi", ha precisato. Ben 26
stati membri su 27 (manca solo la Danimarca) sono d'accordo nell'usare l'Agenzia
per la Difesa Europa (Eda) per "aggregare la domanda" e aumentare la produzione
di munizioni, così da rimpinguare i magazzini europei "con prodotti europei".
13:41
G20: summit India
finisce senza consenso su Ucraina
"Se avessimo avuto
un perfetto incontro di vedute su tutte le questioni, ci sarebbe stata una
dichiarazione collettiva", ha dichiarato il ministro degli Esteri
indiano Jaishankar, che ha aggiunto che i membri si sono trovati d'accordo sulla
maggior parte delle questioni che riguardano le preoccupazioni dei Paesi meno
sviluppati, "come il rafforzamento del multilateralismo, la promozione della
sicurezza alimentare ed energetica, il cambiamento climatico, le questioni di
genere e la lotta al terrorismo".
13:48
L'oligarca russo
Deripaska: Russia con le casse vuote nel 2024
La Russia potrebbe
trovarsi con le casse vuote già il prossimo anno e ha bisogno di investimenti da
paesi "amici" per spezzare la morsa delle sanzioni sull'economia. Lo ha detto
l'oligarca russo Oleg Deripaska intervenendo a un forum in Siberia, secondo
quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. "Già il prossimo anno non ci saranno
soldi. Avremo bisogno di investitori stranieri", ha spiegato Deripaska.
13:51
Russia: media,
esplosione in regione Tula, ipotesi drone
Un'esplosione è
avvenuta nella regione russa di Tula e fra le ipotesi è che possa essere stata
causata dalla caduta di un drone. Nella zona, che si trova a circa 170
chilometri a sud di Mosca, sono concentrate varie industrie per la produzione di
armi.
Secondo il
governatore della regione, citato dall'agenzia Ria Novosti, fra le spiegazioni
di quanto accaduto potrebbe essere la caduta di un drone.
14:15
Zelensky dopo il
raid di Zaporizhzhia: "Impediremo al male russo di dominare"
"Non daremo al male
russo la possibilità di dominare, né all'interno dell'Ucraina, né in alcuna
parte del mondo". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky commendando il raid russo compiuto nella notte su Zaporizhzhia nel
quale hanno perso la vita tre persone e altre sono rimaste ferite. "I terroristi
hanno colpito un edificio residenziale dove dormono i civili. Ci sono morti,
feriti, dispersi", ha denunciato Zelensky aggiungendo che "questo male non
eviterà la responsabilità dei crimini commessi".
14:44
Anche la Cina non
firma la dichiarazione del G20 sulla guerra
Anche la Cina, così
come la Russia, si è rifiutata di firmare la dichiarazione finale del G20 in
merito alla guerra in Ucraina. Lo rende noto l'emittente indiana Ndtv.
14:57
Mosca: gli attacchi
con droni di Kiev sono impossibili senza l'aiuto americano
"I tentativi
dell'Ucraina di attaccare le basi aeree strategiche russe? non sarebbero stati
possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti, inclusa la fornitura di intelligence.
Ne siamo consapevoli". Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergei
Ryabkov parlando alla Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo a Ginevra. Lo
riporta Ria Novosti. "Non è un segreto che qualche tempo fa Kiev abbia lanciato
attacchi con droni contro basi strategiche dell'aviazione russa nelle regioni di
Saratov e Ryazan. Sappiamo che questi attacchi non sarebbero stati possibili
senza una seria assistenza da parte degli Stati Uniti, compresa la selezione
degli obiettivi, la fornitura di intelligence e assistenza di altro tipo", ha
spiegato.
15:09
Le vittime di
Zaporizhzhia sono due, tra i feriti una donna incinta
Il capo
dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Yury Malashko ha
corretto le prime informazioni sul numero delle vittime nel condominio
bombardato nella notte: le vittime sono due e non quattro, come avevano detto le
autorità ucraine in precedenza. Malashko ha spiegato alla tv nazionale che i
missili russi hanno ucciso due uomini, sei persone sono rimaste ferite: tre
uomini e tre donne, una delle quali è incinta. Venti persone sono state
evacuate, undici sono state salvate.
15:40
Mosca: sale a due il
numero dei morti a Bryansk
Sale a due il numero
di civili morti nel villaggio di Lyubechane, distretto di Klimovsky, nella
regione di Bryansk, in Russia, a seguito di quello che, secondo Mosca, è un
attacco da parte di "sabotatori ucraini". Lo riporta Ria Novosti citando il
profilo Telegram del governatore della regione russa al confine con l'Ucraina,
Alexander Bogomaz. La seconda persona deceduta è "un uomo nato nel 1966".
15:19
007 russi: la
situazione a Bryansk è sotto controllo
L'Fsb ha dichiarato
che la situazione nel distretto di Klimovsky della regione russa di Bryansk è
"sotto il controllo delle forze dell'ordine" russe. I servizi di sicurezza di
Mosca sostengono che sarebbe "stato trovato un gran numero di ordigni esplosivi
di vario tipo" e sarebbe in corso "lo sminamento". Lo riporta la Tass.
16:00
Blinken: "A Lavrov
ho detto che serve la diplomazia per una pace giusta"
A Sergei Lavrov ho
detto che la Russia deve "impegnarsi in un'azione diplomatica significativa" che
possa produrre una "pace giusta". Lo ha affermato il segretario di Stato
Usa, Antony Blinken, riferendo in conferenza stampa del suo breve colloquio con
il ministro degli Esteri russo, a margine del G20 di New Delhi. Vladimir Putin,
ha aggiunto Blinken, ha però mostrato "zero interesse" per la pace: "E
ho chiesto alla Russia di invertire la sua decisione irresponsabile di
sospendere New Star e di rientrare nell'accordo".
16:21
Blinken minaccia la
Cina: "Possibili sanzioni se dà aiuto militare alla Russia"
L'assistenza
militare della Cina alla Federazione Russa comporterebbe conseguenze, comprese
sanzioni". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken,
nel corso di un punto stampa a Nuova Delhi. "Gli Stati Uniti hanno detto alla
Cina che l'assistenza militare di Pechino a Mosca sarebbe un problema serio per
le relazioni bilaterali", ha aggiunto.
16:37
Blinken: "Ho fatto
una proposta seria a Mosca per il rilascio di Whelan"
"Gli Stati Uniti
hanno fatto una proposta sera per il rilascio di Paul Whelan. Mosca dovrebbe
accettarla". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a New Delhi
riferendo del suo breve incontro con il ministro degli Esteri russo Serghei
Lavrov. "Gli ho parlato dell'ingiusta detenzione di Paul come ho fatto in altre
occasioni. Siamo determinati a riportare a casa lui e tutti i cittadini
americani ingiustamente detenuti nel mondo", ha detto il segretario di Stato. Ex
Marine, Whelan è stato arrestato in Russia nel dicembre 2018 con l'accusa di
spionaggio. Nel giugno del 2020 è stato condannato a 16 anni di carcere.
16:49
Kiev: attacco russo
sui civili in fila per gli aiuti a Kherson
Le forze russe hanno
attaccato con droni i civili in fila per ricevere aiuti umanitari nel distretto
di Beryslav nella regione di Kherson. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore
generale ucraino su Telegram. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui un
bambino.
"A seguito dei
bombardamenti, 9 civili sono rimasti feriti, compreso un minorenne. Ricevono
assistenza medica qualificata.
Il numero definitivo
delle vittime è in fase di chiarimento", continua il messaggio, aggiungendo che
infrastrutture civili sono state danneggiate nell'attacco.
17:11
Nato, l'Ungheria
rinvia di due settimane la decisione sulla ratifica per l'ingresso di Svezia e
Finlandia
Il Parlamento
ungherese ha rinviato di altre due settimane il dibattito e l'eventuale
voto sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Sebbene il dibattito
parlamentare fosse già iniziato il giorno prima e i media ipotizzassero che si
potesse votare la prossima settimana, il Parlamento ha fissato la settimana una
nuova data, dal 20 al 24 marzo, per completare il processo di ratifica.
Fidesz, il partito
che da tredici anni governa con la maggioranza assoluta, ritarda da mesi il voto
sull'ingresso di Svezia e Finlandia (mancano solo le ratifiche di Ungheria e
Turchia) sostenendo che le critiche di quei due Paesi sulla deriva democratica
di Budapest sono "ingiuste".
17:31
Mosca: "Nazionalisti
ucraini respinti oltre la frontiera"
I "nazionalisti
ucraini" che si erano infiltrati stamane nel territorio della regione russa
frontaliera di Bryansk, sono stati "respinti nel territorio ucraino", che è
stato colpito da un "massiccio bombardamento di artiglieria" russo. Lo affermano
i servizi di sicurezza interni russi (Fsb) citati dalle agenzie di Mosca.
18:22
Mosca contro
Blinken, sue parole su Lavrov "non professionali"
Mosca ha definito
auto-promozione le parole del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sul suo
incontro con l'omologo russo, Serghei Lavrov, in India. "Si tratta di self-pr,
pubblicità e mancanza di professionalità", ha dichiarato la portavoce del
ministero degli Esteri, Maria Zakharova, "gli Usa non hanno nulla da proporre".
18:41
Nuovo team Aiea
arriva a Zaporizhzhia
Un nuovo team di tre
esperti dell'Aiea è arrivato alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia,
prendendo il posto della squadra al lavoro dai primi di gennaio. Lo ha
annunciato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica, Rafael Grossi, sottolineando che la rotazione arriva con un mese di
ritardo rispetto a quanto previsto. Si conclude così "una impasse che ha
complicato gli sforzi dell'Aiea a sostegno della sicurezza nucleare durante il
conflitto", sottolinea il comunicato di Grossi. La squadra arrivata oggi è la
sesta da quando è stata istituita a settembre la missione di sostegno a
Zaporizhzhia (Isamz). "La presenza permanente dell'Isamz all'impianto di
Zaporizhzhia è indispensabile per aiutare a ridurre i rischi di un incidente
nucleare in questa guerra già devastante. I nostri coraggiosi esperti, lavorando
strettamente con lo staff dell'impianto, forniscono consigli tecnici e
monitorano la situazione in circostanze estremamente difficili", sottolinea
Grossi, ribadendo ancora una volta la necessità di creare una zona di sicurezza
attorno alla centrale di Zaporizhzhia.
18:56
Pentagono, fornire
F-16 a Kiev richiederebbe almeno 18 mesi
Fornire i caccia
F-16 a Kiev con relativo addestramento dei piloti richiederebbe tra i 18 e i 24
mesi. Lo ha riferito il sottosegretario al Pentagono, Colin Kahla, nel corso di
un'audizione davanti alla commissione Forze Armate della Camera dei
rappresentanti. Per Kahl, poiché la decisione sull'invio dei caccia non è ancora
stata presa, né dagli Usa né dai loro alleati, non ha senso al momento avviare
l'addestramento dei piloti ucraini. "A nostro giudizio non si risparmia
veramente tempo avviando subito l'addestramento. E poiché non abbiamo deciso
sulla fornitura degli F-16 e non lo hanno fatto nemmeno i nostri alleati e
partner, non ha senso addestrarli all'uso di un sistema che potrebbero non
ricevere mai", ha spiegato. In generale, Kahl ha riferito che l'invio dei nuovi
F-16 richiederebbe dai tre ai sei anni, mentre per le versioni precedenti si
tratterebbe di 18-24 mesi.
19:11
Ucraina: ordinata
evacuazione dei "vulnerabili" da Kupiansk
Le autorità ucraine
hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria dei cittadini ritenuti "vulnerabili"
da Kupiansk, centro abitato in prima linea sul fronte nord-est, poichè aumentano
i timori che la Russia riconquisti la città e lo snodo ferroviario.
"L'evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini e dei residenti con
mobilità ridotta è iniziata nella comunità di Kupiansk, a causa del costante
bombardamento del territorio della comunità da parte delle truppe russe", ha
affermato l'amministrazione militare della regione di Kharkiv.
19:40
Prigozhin pubblica
video, 'mercenari Wagner a Bakhmut'
Yevgeny Prigozhin,
il capo dei mercenari Wagner, ha condiviso un video su Telegram che secondo lui
mostrerebbe i suoi combattenti nella città di Bakhmut. Lo riporta la Cnn. Nelle
immagini si vedono uomini in uniforme sollevare una bandiera Wagner sulla cima
di un edificio gravemente danneggiato, con uno degli uomini che impugna una
chitarra, probabile riferimento al soprannome del gruppo, 'i musicisti'. Nel
post Prigozhin afferma che il video gli è stato portato stamattina "da Bakhmut,
praticamente il centro della città". La Cnn ha geolocalizzato il video a circa 2
km dal centro della città, dove il gruppo era già arrivato.
19:51
Usa, non abbiamo
aiutato Kiev negli attacchi con i droni
"Non siamo in guerra
con la Russia e le affermazioni che sostengono che abbiamo aiutato
l'Ucraina" negli attacchi con droni a basi aeree strategiche russe sono
"totalmente prive di senso". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il
generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa.
19:59
Medvedev, in attacco
Bryansk Occidente complice "terroristi"
Gli eventi nella
regione di Bryansk - dove quelli che Mosca considera "sabotatori" ucraini hanno
ucciso due civili in un attentato - "hanno dimostrato che Stati Uniti, Nato e Ue
appoggiano non il popolo ucraino amante della libertà, come dicono, ma una
marmaglia di terroristi". La denuncia è arrivata su Telegram dal vicepresidente
del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev. "Gli eventi di oggi
hanno dimostrato chi veramente è sostenuto negli Stati Uniti, nella Nato e
nell'Ue", ha scritto l'ex presidente russo, "non è il popolo ucraino amante
della libertà, ma solo dei bastardi nazisti, terroristi feccia, che attaccano i
civili". "Sono i vostri figli adottivi, signori Sunak, Macron, Scholz e Biden",
ha concluso Medvedev, "e il nostro atteggiamento nei vostri confronti ora sarà
lo stesso che nei loro: i vostri Paesi partecipano ad atti di terrorismo del
regime ucraino e siete complici diretti dei terroristi".
20:23
Servizi Kiev: "Fatti
Bryansk indicano inizio lotta russi contro Putin"
I servizi
d'intelligence militare ucraini ritengono che i fatti di oggi a Bryansk siano un
segnale dell'inizio della rivolta dei russi contro il regime di Vladimir Putin.
L'invasione
dell'Ucraina "ha aumentato i problemi all'interno della cosiddetta Federazione
Russa. La Russia è una entità instabile, con un gran numero di questioni
complesse irrisolte, contraddizioni e conflitti interregionali, interetnici,
religiosi, sociali e politici. E il fatto che oggi cittadini di una certa area
della Federazione russa si siano sollevati per rovesciare il regime di Putin è
uno sviluppo naturale dopo l'invasione dell'Ucraina", ha detto Andrii Yusov,
dell'intelligence militare ucraina, citato da Ukrainska pravda.
La Russia ha
denunciato oggi una infiltrazione di "sabotatori ucraini" che avrebbero preso
civili in ostaggio, sparato contro un'automobile e ferito un bambino. L'azione
di infiltrazione è stata poi rivendicata dal Corpo dei Volontari russi, una
unità di dissidenti russi che combatte a fianco dell'Ucraina. I volontari russi
hanno affermato di aver teso un'imboscata a due veicoli di fanteria nell'oblast
di Bryansk. Hanno negato di aver preso ostaggi e ferito un bambino. L'operazione
sarebbe stata compiuta da 45 uomini. Una guardia di confine sarebbe stata
ferita.
20:47
Kiev, respingiamo
attacchi a Bakhmut, russi assaltano città
Le forze russe
continuano a premere la loro offensiva nell'area di Bakhmut mentre le forze
ucraine cercano di respingere gli attacchi in corso vicino alla città orientale
e alle aree vicine nella regione di Donetsk. Lo ha riferito lo Stato Maggiore
dell'esercito ucraino in un aggiornamento serale. "Stanno assaltando la città di
Bakhmut", ha detto lo Stato Maggiore citato dalla Cnn, facendo eco a un
precedente aggiornamento che suggeriva la presenza russa all'interno della
città, e non solo in periferia.
Nelle ultime 24 ore,
le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici sulle città di Chasiv Yar,
nella regione di Donetsk - a soli cinque chilometri a ovest di Bakhmut - e su
Zaporizhzhia, ha sottolineato lo Stato Maggiore. "La minaccia di ulteriori
attacchi missilistici rimane alta in tutta l'Ucraina". Inoltre, ci sono stati
tentativi offensivi russi infruttuosi nelle direzioni Kupyansk e Lyman. Nelle
direzioni di Zaporizhzhia e Kherson, le forze russe continuano "a cercare di
creare le condizioni per un'offensiva" e hanno sparato con l'artiglieria in più
di 40 aree di insediamento. L'Ucraina ha effettuato 13 attacchi nell'ultimo
giorno, in aree in cui la Russia dispone di personale e attrezzature militari.
Le unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito un deposito di munizioni
russo.
21:14
Mosca, l'accordo sul
grano non sta funzionando
La Russia "è
costretta" a dichiarare che l'accordo sul grano non sta funzionando, poiché
l'Occidente sabota l'esecuzione della parte russa degli accordi. Lo ha affermato
il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. "Siamo costretti ad
affermare che il pacchetto di accordi proposto da Guterres e firmato a Istanbul
il 22 luglio 2022 non sta funzionando. Il problema principale è il sabotaggio da
parte dei Paesi occidentali del memorandum Russia-Onu", ha detto il ministero,
sottolineando che "la parte del leone dei cereali dell'Ucraina va all'Ue per
l'alimentazione animale a prezzi dumping, non ai Paesi più poveri" e che
l'Occidente "deve smettere di giocare la carta del cibo".
21:18
Telefonata tra
Zelensky e Lula
"Ho avuto una
telefonata con il presidente brasiliano Lula. L'ho ringraziato per aver
sostenuto la nostra risoluzione alle Nazioni Unite. Abbiamo sottolineato
l'importanza di sostenere il principio della sovranità e dell'integrità
territoriale degli Stati. Abbiamo anche discusso degli sforzi diplomatici per
riportare la pace in Ucraina e nel mondo". Lo scrive in un post su Telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
21:37
Usa, domani nuovo
pacchetto di armi all'Ucraina
"Domani gli Stati
Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina". Lo ha
detto il portavoce per il Consiglio della sicurezza nazionale americana, John
Kirby, precisando che si tratterà soprattutto di "artiglieria e munizioni per i
sistemi che le forze di Kiev hanno già".
21:55
Zelensky sostituisce
capo amministrazione militare città Kherson
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che nomina Roman Mrochko a capo
dell'amministrazione militare della città di Kherson, dopo aver
destituito Halyna Luhova dal suo incarico. Lo riporta Kyiv Independent. Mrochko
ha lavorato come procuratore dal 2011 e in precedenza ha ricoperto la carica di
procuratore militare nell'oblast di Lugansk. È anche un ex sostituto procuratore
militare del comando militare meridionale.
22:01
Russia: esplosione a
Kolomna, a 120 chilometri da Mosca
Un'esplosione si è
registrata a Kolomna, a 120 chilometri sud-est di Mosca. Lo riferisce
l'agenzia Ria Novosti che cita l'amministrazione comunale senza, però, fornire
dettagli. "I servizi di emergenza sono sul posto", si sono limitati a dire le
autorità locali.
22:10
Domani Putin
incontra Consiglio di sicurezza
Domani, il
presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro operativo con i membri
permanenti del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, secondo quanto
annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. L'incontro avverrà
all'indomani dell'attacco sferrato a Bryansk, vicino al confine ucraino, da
quelli che Mosca ritiene "sabotatori ucraini". Lo riporta Ria Novosti.
22:17
Usa, dopo
Blinken-Lavrov non previsti altri contatti con russi
Il segretario di
Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Serghei
Lavrov sono rimasti a parlare otto minuti, a margine della riunione ministeriale
del G20 in India, e non sono previsti ulteriori contatti di questo tipo con
Mosca, ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price. "E' stato un
contatto di otto minuti, piuttosto breve", ha detto ai giornalisti durante un
briefing. Secondo Price, gli Stati Uniti "non si fanno illusioni sul fatto che
una comunicazione così breve possa cambiare la posizione della Russia nel
prossimo futuro o in questo momento". Alla domanda dei giornalisti se siano ora
possibili ulteriori contatti con la Russia, Price ha affermato che "gli Stati
Uniti non si aspettano alcun contatto ad alto livello nel prossimo futuro". Allo
stesso tempo, ha aggiunto che Washington è "sempre aperta al dialogo".
23:16
Esplosione a
Kolomna, a 120 chilometri da Mosca
Un'esplosione si è
registrata a Kolomna, a 120 chilometri sud-est di Mosca. Lo riferisce l'agenzia
Ria Novosti che cita l'amministrazione comunale senza, però, fornire dettagli.
"I servizi di emergenza sono sul posto", si sono limitati a dire le autorità
locali.
23:35
Forse un drone
all'origine dell'esplosione di Kolomna
"L'esplosione di
Kolomna è avvenuta in aria. Con molta probabilità stiamo parlando di un drone.
Ma finora è impossibile dirlo con certezza, dal momento che non riescono a
trovare il relitto", hanno dichiarato le forze dell'ordine all'agenzia Tass. Un
portavoce dei servizi di emergenza ha riferito che "un certo numero di
potenziali strutture sono state controllate" e "non sono stati trovati segni di
esplosione".
Sirenetta di
Copenaghen imbrattata con i colori della bandiera russa.
Alcuni vandali hanno
dipinto la base della Sirenetta di Copenaghen con i colori della bandiera russa:
sulla vicenda indaga la polizia danese. Alessandro Ferro il 2 Marzo 2023 su Il
Giornale.
La statua
della Sirenetta più famosa al mondo, quella che si trova all'ingresso del porto
di Copenaghen, la scorsa notte ha subìto un atto vandalico: l'autore o gli
autori del gesto hanno dipinto la base della roccia con i colori bianco, blu e
rosso della bandiera della Russia. Il gesto potrebbe essere visto, in qualche
modo, come un sostegno a Mosca nella guerra contro l'Ucraina.
L'indagine della
polizia
Immediatamente dopo
la scoperta dello sfregio la base della statua è stata ripulita, anche se gli
scatti di giornalisti e turisti hanno già fatto il giro del mondo. Sulla vicenda
sta già indagando la polizia della capitale danese che ha parlato di "atto di
vandalismo". All'agenzia di stampa Ritzau è intervenuto Martin Kajberg, il capo
della polizia di Copenaghen: "Stiamo avviando un'indagine per scoprire chi è
stato, quando e come è successo, stiamo indagando". Alta 1,25 metri e pesante
175 chili, la statua ha compiuto 110 anni e celebra una delle più celebri fiabe
dello scrittore danese Hans Christian Andersen, in cui il personaggio della
Sirenetta prende vita diventando umana.
La storia
travagliata della Sirenetta
Inaugurata nel 1913,
non è la prima volta che la statua subisce atti vandalici: come avevamo visto
sul Giornale.it, dobbiamo tornare indietro di tre anni per vedere un episodio a
sfondo politico quando la statua fu imbrattata con alcune frasi che inneggiavano
ai moti di Hong Kong, manifestazioni che si verificarono tra il 2019 e il 2020.
Ma quello fu soltanto uno degli ultimi episodi che affondano radici profonde
agli anni '60: nel 1964 fu addiritura decapitata. Come riportano alcuni media
danesi, l'artista Jorgen Nash aveva dichiarato di conoscere gli autori del gesto
rifiutando però di rivelare la loro identità. Nel suo libro di memorie affermò
di aver gettato lui stesso la testa nell'area semi-naturale di Utterslev Mose,
sei km a nord della capitale, ma non fu mai ritrovata.
Venti anni più
tardi, nel 1984, alla Sirenetta fu segato il braccio su cui si appoggia,
fortunatamente ritrovato poco tempo dopo. Un'altra decapitazione avvenne nel
1998 quando, durante di notte, le tagliarono la testa con una pialla: fu
ritrovata pochi giorni dopo. Nel 2003 i vandali decisero di spostarla dalla sua
storica posizione sul porto di Copenaghen. Nel corso degli anni la statua è
stata mutilata e imbrattata di vernice numerose volte. Molte altre volte,
invece, è stata vestita con il cappello di Babbo Natale, un burka e addirittura
le maglie di calcio della Svezia e della Norvegia.
Bakhmut: il
simbolo dell'inutile strage ucraina.
Piccole Note
(putiniana) il 2 Marzo 2023 su Il Giornale.
Il fatto che Kiev
abbia inviato rinforzi a Bakhmut può voler dire che è intenzionata a difenderla
fino all’ultimo ucraino o che voglia far concentrare i russi nell’area per
attuare un’offensiva primaverile altrove. Oppure semplicemente che voglia
coprire le spalle al ritiro delle truppe.
Bakmuth: l’inutile
strage
Lo scrivono Matthew
Mpoke Bigg e Edward Wang in un articolo del New York Times. E a conferma di
quest’ultima ipotesi portano le parole di Zelenky, che ha dichiarato di non
voler difendere la città a “tutti i costi”; concetto ribadito in un’intervista
alla Cnn dal consigliere economico di Kiev Alexander Rodnyansky: “I nostri
militari ovviamente soppeseranno tutte le opzioni. Finora hanno tenuto la città
ma, se necessario, si ritireranno strategicamente. Perché non sacrificheremo
tutta la nostra gente per niente”.
Resta che da tempo
gli Stati Uniti avevano suggerito di ritirarsi dalla città indifendibile, cosa
che avrebbe limitato le enormi perdite. A spiegare quanto avvenuto è ancora il
Nyt. Consapevoli dell’importanza che Mosca ha accreditato alla conquista della
città, gli strateghi di Kiev hanno colto “l’opportunità di infliggere migliaia
di vittime [ai nemici], anche se a caro prezzo per i loro stessi combattenti”.
Insomma, l’obiettivo non era la difesa di una città chiave, ma cogliere
un’opportunità per fare una carneficina… tant’è.
Quanto alle
prospettive della guerra, appare interessante un altro articolo del Nyt,
stavolta a firma di Thomas Meaney, che spiega come i successi (veri o asseriti
tali) della resistenza ucraina e i deficit palesati dall’esercito russo
(asseriti o reali che siano) hanno “aumentato gli obiettivi dell’Ucraina” che,
se nei primi giorni di guerra erano bassi, ora sono massimi, cioè “la
riconquista di ogni centimetro del territorio occupato dai russi, compresa la
Crimea”.
“Il guaio è che
l’Ucraina ha un solo modo infallibile per realizzare questa impresa a breve
termine: il coinvolgimento diretto della NATO nella guerra. – scrive Meaney –
Solo il pieno dispiegamento di truppe e armamenti della NATO e degli Stati Uniti
in stile Desert Storm potrebbe portare a una vittoria completa dell’Ucraina […]
(non importa se un tale dispiegamento aumenterà le probabilità di una delle
prospettive più cupe della guerra: più la Russia perde, più è probabile che
ricorra alle armi nucleari)”. Parentesi indicativa.
Nessun motivo per
proseguire la guerra
Ma, come rileva
Meaney, “la vittoria completa è quasi impossibile“. E non solo perché gli
armamenti promessi dalla Nato non arriveranno come da aspettative. “Il problema
per Kiev è che, rassicurazioni pubbliche a parte, Washington non ha nessun
interesse a entrare direttamente in guerra. Il generale Mark Milley, a capo
degli Stati Maggiori congiunti, ha già espresso la sua opinione, cioè che
vittoria totale sia per la Russia che per l’Ucraina è irraggiungibile a breve”.
“Il presidente Biden
e il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, sono stati
irremovibili nell’impedire agli Stati Uniti di entrare direttamente nel
conflitto. E anche gli americani non hanno manifestato interesse per un
coinvolgimento diretto”.
“Gli Stati Uniti
potrebbero persino avere interesse al proseguimento delle ostilità, perché la
guerra riduce la capacità della Russia di agire altrove nel mondo, incrementa
l’export dell’energia americana [favorito dal sabotaggio del Nord Stream 2… ndr]
ed è un’ottima prova generale per il consolidamento e il coordinamento degli
alleati in vista della guerra economica contro Pechino”(… solo economica?).
Quindi il Nyt prende
in esame le esigenze reali dei duellanti. Mosca, secondo Meaney, sembra propensa
ad accontentarsi di controllare quanto conquistato, cioè “territori che anche
nella migliore delle circostanze è difficile che l’Ucraina possa riconquistare“.
D’altra parte,
invece, “il futuro economico dell’Ucraina appare sostenibile anche senza i
territori attualmente occupati dalla Russia”, dal momento che conserva lo sbocco
al Mare e tanto altro. Mentre “l’Ucraina rischierebbe di mettere a repentaglio
questa posizione in una controffensiva”. Non spiega l’enunciato, ma è ovvio: può
perdere.
Quindi la nota si
conclude discettando sul possibile ingresso di Kiev, nel dopoguerra, nella Nato
(ma gli Usa, spiega, sono contrari) o nella Ue. Temi di scarso interesse
attualmente. Quel che interessa è che la “completa vittoria” di Kiev è in realtà
uno slogan vuoto. Nessun leader d’Occidente ci crede.
Negoziati passati e
futuri
Così attualmente si
sta lottando, e stanno morendo a migliaia, per decidere se una o più cittadine
dell’attuale fronte, peraltro ridotte in macerie, in futuro saranno russe o
ucraine.
E per il destino di
qualche abitato fantasma si nega ogni possibilità all’apertura di finestre
negoziali e si continua a inondare Kiev di armi. Sull’inutile strage che si sta
consumando in ucraina appaiono interessanti le dichiarazioni di Fareed
Zakaria alla Cnn: “La guerra si sta svolgendo sul suolo ucraino, le sue città
sono bombardate e ridotte in macerie, così come le sue industrie, e la sua gente
è sempre più indigente. Se andrà avanti così, varrà la pena chiedersi: stiamo
lasciando che l’Ucraina venga distrutta per salvarla?“.
Così concludiamo con
quanto rileva Ted Snider in un articolo pubblicato su Consortium News, nel quale
annota come i leader d’Occidente pubblicamente sostengano la causa massimalista
ucraina, in privato dicono che il loro sostegno ha un limite e che tale
massimalismo non ha basi (e anche lui, come Meaney, reputa che l’ingresso di
Kiev nella Nato non è un’opzione realistica).
“L’orrore di tutto
ciò è che un’Ucraina, più piccola dei confini territoriali precedenti e armata
dall’Occidente, ma non nella NATO, è esattamente come sarebbe stata se i suoi
partner occidentali le avessero permesso di accettare gli accordi che aveva
dichiarato di essere disposta ad accogliere prima della guerra o ai quali aveva
provvisoriamente acconsentito nelle prime settimane di guerra, senza che fosse
costretta a subire i flagelli della guerra” (sulle interferenze d’Occidente
sull’apertura di negoziati vedi ad esempio la BBC o l’intervista dell’ex premier
israeliano Naftali Bennet).
C’era una volta
Narva. La città estone ai confini con la Russia dove è tornata la cortina di
ferro (tra le generazioni).
Luciana Grosso su
L’Inkiesta il 3 Marzo 2023.
È il terzo centro
della repubblica baltica per popolazione, che discende dai coloni inviati ai
tempi dell’Unione sovietica. Era un modello di convivenza con la gemella
Ivangorod, dall’altro lato del fiume, oggi è attraversata da una frattura
silenziosa tra gli abitanti
Narva è, per
popolazione, la terza città dell’Estonia: circa sessantamila persone. Però, se
ci si cammina per strada, in questo pezzo di Estonia, la lingua che si sente
parlare è il russo, i cartelli sono in russo, i piatti locali sono russi, le
televisioni che si sentono gracchiare dalle finestre sono russe, la musica è
russa, i libri nelle biblioteche sono russi. Le persone, in buona sostanza, sono
russe. L’espressione «in buona sostanza», però, indica una sintesi affrettata e
superficiale di una realtà complessa, che tutto richiede tranne fretta e
superficialità.
In Estonia, paese di
un milione e trecentomila abitanti, circa un quarto della popolazione appartiene
alla minoranza dei «russi etnici». Significa che ci sono trecentomila persone
nate in Russia, o discendenti da persone nate in Russia, che parlano russo e
hanno tradizioni russe.
La loro presenza
così alta è dovuta soprattutto alle massicce manovre di sostituzione etnica di
epoca sovietica, quando migliaia di estoni poco graditi al regime furono presi e
deportati in Siberia e altrettanti russi furono spediti in Estonia per
«russificare» la regione e renderla omogenea alla madre patria.
Oggi l’Unione
Sovietica non c’è più, e molti di quei «pionieri» sovietici spediti nel Baltico
sono o morti o molto anziani. Ci sono però i loro figli e i loro nipoti che, per
la quasi totalità (circa il settantacinque per cento) hanno cittadinanza estone,
si sentono estoni, sono estoni. Ma pur nel loro sentirsi ed essere estoni (e
quindi europei), hanno radici profonde al di là del confine.
Tutto questo ha
fatto sì che, fino a un anno fa, l’Estonia, e soprattutto la città di Narva,
fosse un esperimento riuscito di mescolanza, di convivenza, di contaminazione,
il posto in cui si erano chiusi i conti con l’Unione Sovietica.
Qui, in questa città
dove i palazzoni e le strade di epoca e stile sovietico si snodano attorno a un
castello del 1200, vivono persone che, per il novanta per cento, sono
madrelingua russa. Solo la metà di loro è cittadina estone, gli altri sono
cittadini russi o apolidi.
Fino a un anno fa,
gli abitanti di Narva che ne avevano la possibilità, se dovevano fare una spesa
ricercata o se avevano semplicemente voglia di fare un giro in una grande città,
attraversavano il confine con un permesso temporaneo e andavano a San
Pietroburgo, che è più vicina a casa loro di quanto non lo sia Tallinn.
Allo stesso modo,
sempre fino a un anno fa, gli abitanti di Ivangorod, la città gemella di Narva
che sorge sull’altra sponda del fiume che fa da confine naturale, si recavano a
Narva se volevano vedere un film non disponibile in Russia, o solo comprare al
supermercato qualche prodotto bloccato dall’embargo.
Adesso come è facile
intuire tutto è cambiato. Da Narva nessuno va più a San Pietroburgo, e da
Ivangorod nessuno va più a fare la spesa a Narva. I consolati dall’una e
dall’altra parte sono chiusi, e la mescolanza è andata a farsi benedire, insieme
con l’aver chiuso i conti con l’Unione Sovietica.
Al loro posto è
sorta una frattura silenziosa tra gli abitanti. Però, a stare sui lati opposti
di questa frattura non ci sono i russofoni e gli estonofoni (che da queste parti
quasi non esistono), ma i giovani e gli anziani.
I ragazzi sono
cresciuti in Estonia, si sentono europei a tutti gli effetti e soprattutto si
informano con i media europei e condannano senza esitare l’aggressione di
Vladimir Putin. I più anziani, invece, vengono raggiunti solo da notizie russe,
credono che Volodymyr Zelensky sia un nazistoide alcolizzato e che Putin sia
stato costretto a difendersi.
Non è vero, ovvio.
Ma gli ultimi anni ci hanno insegnato che le cose non devono essere vere per
radicarsi nella testa delle persone e per lacerare le comunità. E così oggi
Narva, che un tempo era il posto, la cicatrice dove la ferita dell’Unione
Sovietica in Europa sembrava rimarginata, è diventata il posto dove quella
stessa ferita ha ripreso a sanguinare.
La Repubblica.
Mosca: "Attacchi a Bryansk commessi con armi Nato".
Un'esplosione è
stata registrata a 120 km dalla capitale russa. Il boato è stato avvertito a
Kolomna, tra le ipotesi l'abbattimento di un drone penetrato da oltre
confine.Putin apre il Consiglio di Sicurezza: "Rinforzare le misure
antiterrorismo".
A New Delhi Russia e
Cina spaccano il G20: salta la dichiarazione congiunta sulla guerra, tensione
sull'accordo per il grano. A margine dell'incontro c'è stato un primo breve
contatto tra il segretario di Stato Usa Blinken e il ministro degli Esteri russo
Lavrov. Notizie confuse su presunti "sabotatori ucraini" arrivano dalla regione
russa di Brijansk. Putin prepara la rappresaglia.
Punti chiave
23:26
Metsola a Kiev, la
casa dei coraggiosi ucraini è l'Ue
17:47
Kiev: "Quasi 10mila
soldati russi hanno detto di volersi arrendere"
17:07
Intensi scontri a
Bakhmut: "Russi schierano truppe più esperte"
14:55
Ucraina, Zelensky
visita a Leopoli i militari ucraini feriti a Bakhmut
14:06
Russia, Putin dice
al consiglio di sicurezza di "rinforzare le misure antiterrorismo" dopo Bryansk
13:02
Mosca: "Kiev
continua a pianificare la conquista militare della Crimea"
12:42
Mosca: "Gli attacchi
di Bryansk commessi con armi Nato"
12:29
Ucraina, Sanchez:
"Accelerare arrivo aiuti militari"
10:16
Bielorussia, il
premio Nobel Bjaljatskij condannato a 10 anni di carcere
09:23
Il capo della
Wagner: "Bakhmut praticamente circondata, Zelensky ritiri i suoi soldati"
09:16
I russi fanno
saltare il ponte tra Bakhmut e Khromove. I Wagner: "L'abbiamo accerchiata"
00:06
Forte esplosione a
120 km da Mosca, forse un drone
00:06
Forte esplosione a
120 km da Mosca, forse un drone
Un'esplosione si è
registrata a Kolomna, a 120 chilometri sud-est di Mosca. "L'esplosione di
Kolomna è avvenuta in aria. Con molta probabilità stiamo parlando di un drone.
Ma finora è impossibile dirlo con certezza, dal momento che non è stato trovato
nessun frammento", hanno dichiarato le forze dell'ordine all'agenzia Tass. Un
portavoce dei servizi di emergenza ha riferito che "un certo numero di
potenziali strutture sono state controllate" e "non sono stati trovati segni di
esplosione".
00:26
Imminente nuovo
pacchetto di armi Usa a Kiev
Gli Stati Uniti
annunceranno a breve un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del
valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni.
Lo riferisce la Reuters citando fonti informate che confermano quanto
preannunciato dalla Casa Bianca nel briefing quotidiano. Il pacchetto, hanno
precisato le fonti, dovrebbe comprendere razzi per i sistemi di difesa
anti-aerea Himars, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli
gettaponte corazzati.
02:42
Incontro tra Biden e
Scholz alle 20 italiane alla Casa Bianca
È previsto alle 14
ora di Washington, le 20 in Italia, l'incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e
il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riferisce l'amministrazione Usa in una
nota. Non è prevista una conferenza stampa congiunta.
03:29
Kiev: oltre 170
esplosioni nell'area di Sumy
Nell'oblast di Sumy,
al confine con la Russia nel nord-est, sono state registrate oltre 170
esplosioni. Lo riferisce Kyiv Independent precisando che sono state prese di
mira dieci comunità e sono state danneggiate diverse case e infrastrutture. Non
si segnalano vittime.
08:40
Allerta aerea in
tutta l'Ucraina
Un'allerta antiaerea
è stata dichiarata in tutta l'Ucraina negli ultimi minuti: lo riportano i media
nazionali. Intanto, gruppi di monitoraggio segnalano il decollo di un MiG-31K
dell'aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal.
08:43
La Germania chiede
alla Svizzera di ri-vendergli alcuni tank Leopard per colmare i buchi negli
arsenali
La Germania ha
chiesto alla Svizzera di vendergli alcuni dei suoi carri armati Leopard II messi
fuori servizio, ha riferito venerdì il quotidiano svizzero Blick, un accordo che
potrebbe consentire a Berlino di aumentare i suoi aiuti militari all'Ucraina. La
Germania vuole che la Svizzera ri-venda alcuni dei carri armati alla
fabbrica Rheinmetall, afferma il giornale, il che consentirebbe alla società di
colmare le lacune negli armamenti dei membri dell'Unione Europea e della NATO.
Germania, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia sono tra i paesi che inviano
carri armati Leopard per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'attacco russo, ma
questo ha creato "buchi" negli arsenali dei membri dell'Alleanza.
Il ministro della
Difesa tedesco Boris Pistorius e il ministro dell'Economia Robert Habeck hanno
informato il ministro della Difesa svizzero Viola Amherd del progetto in una
lettera del 10 febbraio. 23, riferisce il giornale. Hanno chiesto alla loro
controparte svizzera di concordare la vendita, con assicurazioni che i carri
armati svizzeri non sarebbero stati trasferiti alla stessa Ucraina. In virtù
delle sue leggi sulla neutralità alla Svizzera è proibito inviare armi
direttamente all'Ucraina. Il ministero della Difesa svizzero ha dichiarato che
la richiesta della Germania è stata presa in considerazione.
09:16
I russi fanno
saltare il ponte tra Bakhmut e Khromove. I Wagner: "L'abbiamo accerchiata"
Le forze russe hanno
fatto saltare in aria durante la notte un ponte cruciale che collegava la città
assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove. Lo ha riferito la Cnn
citando la polizia della regione di Donetsk. Il ponte è un'arteria vitale per
l'evacuazione di civili e i rifornimento di munizioni. Secono le milizie Wagner
la città "è accerchiata".
09:23
Il capo della
Wagner: "Bakhmut praticamente circondata, Zelensky ritiri i suoi soldati"
La città strategica
ucraina di Bakhmut è "praticamente circondata" dalle forze russe. Lo ha
annunciato in un video il capo del gruppo di mercenari Wagner, vicino al
Cremlino, Yevgeny Prigozhin, aggiungendo che le forze ucraine hanno ora accesso
ad una sola via d'uscita. Nel video inoltre, Prigozhin ha invitato il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, a ritirare le sue forze dalla città.
09:27
Zelensky: "Risposta
militare e legale dopo l'attacco a Bakhmut"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una "risposta militare e legale"
all'attacco della Russia alla città orientale di Zaporizhzhia, che ieri ha
ucciso almeno quattro persone. "Il brutale attacco missilistico della Russia
su Zaporizhzhia dovrà affrontare la nostra risposta militare e legale.
L'occupante sentirà inevitabilmente la nostra forza", ha detto, prima di
aggiungere che le autorità russe conosceranno "la forza della giustizia in ogni
significato della parola".
09:31
Bakhmut, Progozhin:
"Zelensky evacui vecchi e bambini"
Secondo il fondatore
del gruppo di mercenari russi Wagner Evgeny Prigozhin le forze russe hanno
praticamente circondato la città dell'Ucraina orientale di Bakhmut (in russo
Artyomovsk): in un discorso video ha invitato il presidente ucraino Volodymir
Zelensky a evacuare anziani e bambini. Lo riportano i media russi. Secondo Ria
Novosti, ha invitato le autorità ucraine a dare alle forze armate ucraine
l'opportunità di lasciare la città. A Bakhmut da settimane infuria una
sanguinosa battaglia, condotta praticamente casa per casa.
09:37
Russia, Zakharova
smentisce Blinken: "Non ha parlato di Whelan con Lavrov"
Il segretario di
Stato americano Anthony Blinken, durante il colloquio con il ministro
degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine di una riunione dei ministri degli
Esteri del G20 a Nuova Delhi, non ha sollevato il tema della liberazione del
cittadino americano Paul Whelan, detenuto in Russia. Lo ha scritto la portavoce
del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram. "Il
segretario di Stato americano non ha nemmeno balbettato su questo punto. Tutto
ciò che il Dipartimento di Stato ha detto ieri sul fatto che Blinken ha espresso
preoccupazione sulla situazione del cittadino americano è una bugia.
Comportamento incredibile dell'amministrazione americana", afferma Zakharova,
citata da Tass.
09:54
Cnn: "Da Kiev ordine
di lasciare Bakhmut a unità di ricognizione"
Ad un'unità di
ricognizione di droni ucraini con base a Bakhmut è stato ordinato di lasciare la
città orientale assediata: lo ha riferito il suo comandante in un video
pubblicato su Telegram venerdì citato dalla Cnn. "Nel cuore della notte, l'unità
Madiar Birds ha ricevuto un ordine di combattimento per lasciare immediatamente
Bakhmut per un nuovo luogo di operazioni", ha detto il comandante Robert Brovdi.
09:57
Ucraina, Danilov:
"Le forze russe stanno avanzando a Bakhmut, ma non al ritmo che vorrebbero"
Le forze russe
stanno avanzando a Bakhmut, ma non al ritmo che vorrebbero: lo ha detto il
segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy
Danilov, in
un'intervista ai media del Paese. "Sono tutti presenti lì, ma non possono fare
nulla per molto tempo - ha detto l'alto funzionario riferendosi agli uomini del
Gruppo Wagner di Prigozhin, alle forze armate e alle truppe aviotrasportate
russe -. Sì, stanno avanzando, ma non al ritmo che vorrebbero".
10:02
Gas, Lavrov: "Non
permetteremo che l'Occidente faccia saltare altri ponti"
La Russia non
permetterà all'Occidente "di far saltare di nuovo gasdotti". Lo ha detto oggi
Sergei Lavrov intervenendo al convegno internazionale "Raisina Dialogue" a Nuova
Delhi. "La guerra che stiamo cercando di fermare e che è stata iniziata
dall'Occidente contro di noi usando gli ucraini, ovviamente, ha influenzato la
politica russa, compresa la politica energetica", ha detto ancora il ministro
degli Esteri russo.
10:16
Bielorussia, il
premio Nobel Bjaljatskij condannato a 10 anni di carcere
"Il premio Nobel per
la pace 2022, Ales Bjaljatskij, fondatore associazione Vesna (Primavera), è
stato condannato a 10 anni di carcere. Non è che l'ultima condanna esemplare.
Nel silenzio generale, Lukashenko continua a portare avanti la più dura
repressione costringendo molti a esiliare. In quasi tre anni dalla rivolta
dell'agosto 2020, sono almeno 1.400 i prigionieri politici, tra cui 32
giornalisti, e oltre 700 le organizzazioni della società civile che sono state
costrette a chiudere".
10:21
Usa, 2 americani
arrestati per aver venduto tecnologia a Russia
Il Dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato due uomini del Kansas con l'accusa di
aver esportato illegalmente tecnologia legata all'aviazione in Russia e di aver
fornito servizi di riparazione per l'attrezzatura. Cyril Gregory
Buyanovsky e Douglas Robertson sono accusati di cospirazione, esportazione di
merci controllate senza licenza, falsificazione e mancata presentazione di
informazioni elettroniche sull'esportazione e contrabbando di merci in
violazione della legge statunitense. Il Dipartimento di Giustizia afferma
che Buyanovsky e Robertson possedevano e gestivano l'azienda KanRus Trading Co.,
che avrebbe fornito elettronica per aerei a società russe, oltre a servizi di
riparazione per attrezzature utilizzate su aerei di fabbricazione russa.
10:41
Borrell: "Lavrov al
G20 è rimasto al tavolo, è un passo avanti"
"Questo G20 è stato
un passo avanti, a Bali Lavrov non era rimasto: ha parlato e se ne è andato. Qui
è rimasto e ha ascoltato gli altri. È importante avere forum dove almeno ci
ascoltiamo se non proprio parliamo. Non c'è stata una grande interazione ma
almeno ci ha ascoltato". Lo ha detto Josep Borrell intervenendo ai Raisina
Dialogue in India.
11:09
Dodici anni di
carcere al pilota russo che bombardò obiettivi civili a Kharkiv
Il pilota russo che
nel marzo di un anno fa ha bombardato obiettivi civili nella regione di Kharkiv,
inclusa la torre della televisione del capoluogo, è stato condannato a 12 anni
di carcere. Lo ha reso noto la procura generale ucraina, che ha dichiarato
l'uomo colpevole per aver violato le leggi e le usanze della guerra. "I pubblici
ministeri - afferma il rapporto della procura - hanno dimostrato in tribunale
che il condannato nel marzo 2022 ha ricevuto un ordine per distruggere obiettivi
civili sul territorio di Kharkiv mediante bombardamenti. Gli sono state fornite
le coordinate dell'obiettivo: la stazione di trasmissione radiotelevisiva di
Kharkiv". "Il condannato - prosegue la procura - rendendosi conto
dell'illegalità dell'ordine di combattimento, non ha rifiutato di eseguirlo e ha
bombardato la stazione televisiva di Kharkiv con otto bombe aeree FAB-500. A
seguito del bombardamento, la torre della televisione ha subito danni alla sua
struttura metallica, che ne hanno ridotto notevolmente la capacità portante e
reso impossibile un ulteriore funzionamento in sicurezza".
11:38
Con le sanzioni
dimezzata la quota di importazioni Russia-Ue
La quota della
Russia nelle importazioni extra-Ue è scesa dal 9,5% al 4,3% tra febbraio 2022 e
dicembre 2022. Nello stesso periodo, la quota della Russia nelle esportazioni
totali extra-Ue è scesa dal 4% al 2%. E' quanto segnala Eurostat sottolineando
che si tratta dell'effetto delle restrizioni legate alle sanzioni per la guerra
in Ucraina. Il deficit commerciale dell'Ue con la Russia ha raggiunto un picco
di 18,2 miliardi di euro a marzo 2022, per poi diminuire progressivamente fino a
6 miliardi di euro nel dicembre 2022.
11:49
Kuleba: colloquio
con Blinken su un tribunale per i crimini russi
Il ministro degli
Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha avuto un colloquio con il segretario di Stato
Usa, Antony Blinken. Come spiegato da Kuleba in un messaggio su Twitter, nel
colloquio si è discusso anche dei passi per l'organizzazione di un tribunale
speciale per i crimini di guerra russi. "Ho parlato con il segretario Blinken
che mi ha informato sulle sue discussioni al G20. Ho elaborato i nostri
ulteriori passi per creare un tribunale speciale per il crimine di aggressione
contro l'Ucraina: la nostra prossima grande impresa è garantire la
responsabilità della leadership russa. Gli sforzi coordinati sono fondamentali",
ha scritto Kuleba su Twitter.
12:05
Il ministro della
Difesa ucraino: fiduciosi sulla consegna di caccia da parte dell'Occidente
Il ministro della
Difesa ucraina, Oleksiy Reznikov, si è detto "fiducioso" sulla consegna di
caccia da combattimento a Kiev da parte dei Paesi occidentali. In un'intervista
a Bild, Reznikov ha detto di aspettarsi che la fornitura dei jet "sarà simile a
quanto avvenuto con i carri armati Leopard". Prima la Germania ha detto "no", ma
poi ha deciso per la consegna, ha affermato ancora Reznikov. Anche in questo
caso, secondo il ministro della Difesa ucraino, è possibile che si crei una
"coalizione" per la fornitura di diversi tipi di jet. "Sono sicuro che avremo da
due a tre tipi di jet da combattimento. Ci sarà un caccia principale. E
dipenderà da quale sia il migliore per l'Ucraina. Per i nostri aeroporti, per i
nostri ingegneri, per la manutenzione", ha aggiunto.
12:29
Ucraina, Sanchez:
"Accelerare arrivo aiuti militari"
Bisogna accelerare
l'arrivo "degli aiuti militari" all'Ucraina per difendersi dalla Russia, "la
prossima settimana in Consiglio europeo speriamo di arrivare a" un accordo
sull'"acquisto congiunto di munizioni e artiglieria per far sì che la fornitura"
a Kiev "sia più rapida". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in
conferenza stampa congiunta con l'omologa finlandese Sanna Marin da Helsinki,
commentando l'avanzata dei russi a Bakhmut.
12:42
Mosca: "Gli attacchi
di Bryansk commessi con armi Nato"
"Gli assassinii
avvenuti ieri nella regione russa di Bryansk sono stati commessi con armi della
Nato" e quindi è lecito chiedersi se i Paesi membri dell'Alleanza siano
"complici in questi crimini e sponsor del terrorismo". Lo afferma in un
comunicato il ministero degli Esteri di Mosca. "Questo crimine non resterà
impunito", si aggiunge nella nota.
12:44
Ucraina, Podolyak:
"Siamo estranei ai conflitti interni della Russia"
"Esplosioni in
strutture critiche, droni non identificati che attaccano le regioni russe,
scontri di bande, partigiani che attaccano aree popolate: tutte queste sono
conseguenze dirette della perdita di controllo all'interno della Federazione
Russa e della guerra". Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, sottolineando che "l'Ucraina non
è coinvolta in conflitti interni nella Federazione russa".
12:48
Mosca: "Usa e Nato
aiutano Kiev a individuare gli obiettivi da bombardare"
Gli Usa e la Nato
continuano nei loro "piani geopolitici di annientare la Russia" fornendo armi
all'Ucraina, addestrando le sue forze armate e "aiutando Kiev ad individuare gli
obiettivi da bombardare". Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri
di Mosca.
13:02
Mosca: "Kiev
continua a pianificare la conquista militare della Crimea"
Le autorità di Kiev
"continuano a pianificare la conquista militare della Crimea" e Washington le
incoraggia in questo sperando di guadagnare "punti in più dalla 'campagna di
Crimea' per le prossime elezioni". Lo afferma in un comunicato il ministero
degli Esteri di Mosca. "L'altro giorno - si sottolinea nella nota - il vice
segretario di Stato americano Nuland in un evento al Carnagie Center ha definito
le installazioni militari nella Crimea russa come 'obiettivi legittimi' per
l'Ucraina".
13:11
L' esercito di Kiev
esorta le famiglie a lasciare Kupiansk
Il comando militare
di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, ha esortato le famiglie e le persone "con
mobilità ridotta" di lasciare Kupiansk a causa dei "costanti" bombardamenti da
parte delle forze russe che stanno cercando di riconquistare la città liberata 5
mesi fa. Lo riporta la Bbc. Kupiansk è ritenuta dall'esercito del Cremlino un
importante snodo di approvvigionamento. L'amministrazione militare ha affermato
che l'ordine di evacuazione è dovuto alla "situazione di sicurezza instabile"
causata dal bombardamento russo della città e dei suoi dintorni. I militari
hanno detto che in città ci sono 812 bambini e oltre a 724 disabili.
13:22
Russia, Peskov:
"Inchiesta per evitare che si ripetano episodi come Bryansk"
"L'attacco
terroristico di ieri a Bryansk sarà indagato nei dettagli e adotteremo tutte le
misure necessarie per evitare che tali incidenti si ripetano in futuro", ha
affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri un commando di
ucraini si è infiltrato oltre il confine. Nell'attacco, hanno denunciato fonti
russe, sono state uccise due persone e un ragazzo di undici anni è stato ferito.
L'Fsb e il ministero della Difesa hanno condotto "azioni per distruggere i
nazionalisti ucraini armati che hanno violato il confine"
13:34
Ucraina, Zelensky
incontra a Leopoli il presidente lettone Levits
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, e la first lady Elena Zelenskaya hanno incontrato
a Leopoli il presidente della Lettonia, Egils Levits e sua moglie Andra Levite.
Lo riporta Ukrainska Pravda. Insieme i quattro hanno reso omaggio alla memoria
dei soldati ucraini caduti durante la guerra. Zelensky ha anche visitato uno
degli ospedali dove vengono curati i soldati ucraini feriti che hanno
combattuto, in particolare, nella direzione di Bakhmut.
13:36
Kiev: "Il video di
Prigozhin non è registrato a Bakhmut"
Il capo della
Wagner Yevgeny Prigozhin non ha registrato il video in cui annuncia che
Bakhmut è circondata nella cittadina del Donetsk al centro di feroci battaglie
ma "si trova nel villaggio di Paraskovievka, la cui cattura è stata annunciata
dal nemico il 20 febbraio". Lo afferma il Centro nazionale di resistenza di
Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. "Il terrorista Yevgeny Prigozhin ha
registrato un video in cui presumibilmente afferma che Bakhmut è circondata ma
il video stesso non è stato nemmeno registrato alla periferia della città,
poiché le sue guardie non lo lasciano andare lì", afferma il Centro che
definisce il video "una provocazione".
14:06
Russia, Putin dice
al consiglio di sicurezza di "rinforzare le misure antiterrorismo" dopo Bryansk
Il presidente russo
Vladimir Putin ha detto al Consiglio di sicurezza che è necessario discutere
ulteriori "misure antiterrorismo" per salvaguardare le strutture controllate
dalle forze dell'ordine. Putin ha detto giovedì che la Russia è stata colpita da
un "attacco terroristico" nella regione meridionale di Bryansk al confine con
l'Ucraina, e ha promesso di eliminare un gruppo di sabotaggio che aveva sparato
contro i civili. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver inscenato una falsa
"provocazione".
14:21
Ucraina, Blinken
sente Kuleba: "Parlato di colloquio con Lavrov"
Il Segretario di
Stato americano Antony J. Blinken ha parlato oggi con il Ministro degli Esteri
ucraino Dmytro Kuleba. E' quanto si legge in una nota. I due - viene spiegato -
"hanno discusso della recente breve conversazione del segretario con il ministro
degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine della riunione dei ministri degli
Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India" Blinken inoltre ha sottolineato a Kuleba
"il sostegno duraturo degli Stati Uniti all'Ucraina mentre si difende dai
brutali attacchi della Russia, compreso il continuo prendere di mira le
infrastrutture civili e le conseguenti vittime civili".
14:55
Ucraina, Zelensky
visita a Leopoli i militari ucraini feriti a Bakhmut
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato questa mattina l'ospedale militare di
Leopoli incontrando i soldati che sono rimasti feriti nella battaglia di
Bakhmut. "Abbiamo incontrato i nostri difensori, in particolare quelli che hanno
combattuto nella zona di Bakhmut", ha detto Zelensky sui social condividendo le
immagini della visita in ospedale, dove ha stretto le mani dei militari
ricoverati e ha "ringraziato i guerrieri per i servizi resi e per la difesa
eroica della nostra patria". Rivolgendosi ai medici, Zelensky li ha "ringraziati
per tutti i soldati che avete rimesso in piedi".
15:22
Kiev e Lettonia
firmano documento a sostegno ingresso in Ue e Nato
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky e quello lettone, Egils Levits, hanno firmato una
dichiarazione che ratifica il sostegno della Lettonia alla piena integrazione
europea ed euro-atlantica dell'Ucraina. Lo scrive Zelensky sul suo profilo
Telegram. "Sono grato al presidente e a tutto il popolo lettone per
l'incrollabile sostegno al nostro popolo in questo percorso di integrazione con
l'Unione europea e la Nato - dice Zelensky -, è solo con l'Ucraina al suo
interno che il progetto europeo diventerà veramente completo. È solo con
l'Ucraina al suo interno che la Nato diventerà un difensore veramente forte
delle nazioni europee e di tutti i nostri valori comuni".
15:29
Forze ucraine fanno
saltare ponte ferroviario a Bakhmut
Le forze ucraine
hanno fatto saltare i resti di un ponte ferroviario all'interno di Bakhmut, la
città che le forze russe cercano da mesi di conquistare. E' quanto hanno reso
noto le forze armate di Kiev e si vede in un video goelocalizzato dalla Cnn. Il
ponte era già stato parzialmente distrutto dagli ucraini ad agosto. Il video è
stato diffuso mentre vi sono notizie non confermate di un possibile ritiro
ucraino dalla città. Ma la 46esima brigata ucraina ha smentito questa
interpretazione: "il ponte che viene mostrato come prova che ci stiamo ritirando
era stato fatto saltare in aria da tempo. Chi si trova a Bakhmut lo sa. Non
diffondete il panico... il fiume si può attraversare anche senza il ponte".
Intanto la scorsa notte forze russe hanno fatto saltare in aria un altro ponte,
che collegava Bakhmut al vicino villaggio di Khromove.
15:36
Ucraina: von der
Leyen, presto forniamo 5.700 pannelli solari
"Ho promesso di
lavorare con l'Ucraina sulle fonti energetiche rinnovabili, importanti per la
sua sicurezza energetica. Ora manteniamo la promessa: un primo lotto di 5.700
pannelli solari sarà presto spedito in Ucraina". Lo ha annunciato la presidente
della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
15:49
Von der Leyen,
grazie a Enel per donazione pannelli solari all'Ucraina
"Dopo i miei annunci
a Kiev un mese fa, oggi possiamo annunciare che un primo lotto di pannelli
solari sarà presto consegnato all'Ucraina. Voglio ringraziare Enel che sta
donando 5.700 pannelli solari all'Ucraina. Questi pannelli solari sono prodotti
in Europa, a Catania, con il sostegno del Fondo Europeo per l'Innovazione.
Forniranno elettricità a scuole, ospedali e vigili del fuoco. Sono convinto che
altre aziende europee così come gli Stati membri saranno ispirati da questo
primo passo, in modo che l'Ucraina possa contare su elettricità pulita, prodotta
in casa". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in
una nota.
Lanciando oggi con
Enel il progetto "Raggio di speranza", la Commissione europea compie un primo
passo nell'ambito della più ampia iniziativa annunciata dalla Presidente von der
Leyen sulle donazioni di pannelli solari all'Ucraina durante la sua visita a
Kiev il 2 febbraio 2023. La commissaria per l'Energia, Kadri Simson,
l'Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, e il Ministro dell'Energia
ucraino, German Galushchenko, si sono incontrati oggi in formato ibrido per
salutare l'impegno di Enel a donare all'Ucraina 5.700 pannelli solari
fotovoltaici (PV) da 350 Watt ciascuno, per una potenza complessiva di circa 2
MW. I pannelli solari fotovoltaici donati copriranno fino a 11.400 metri
quadrati di tetti suddivisi tra diversi edifici pubblici in Ucraina. La consegna
è prevista per l'estate 2023.
15:58
Mosca, Blinken non
ha discusso di Whelan con Lavrov
Il segretario di
Stato americano Anthony Blinken "non ha sollevato" il tema dello scambio del
prigioniero statunitense Paul Whelan durante la sua conversazione con il
ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a margine della riunione dei ministri
degli Esteri del G20 a Nuova Delhi. Lo ha affermato la portavoce del ministero
degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram. "Oh, interessante. Ho fatto un
controllo con Serghei Viktorovich (Lavrov) per vedere se Blinken ha parlato di
Whelan ieri. Si scopre che il Segretario di Stato americano non l'ha nemmeno
sollevato. Tutto ciò che è stato detto ieri dal Dipartimento di Stato, che
Blinken ha espresso preoccupazione per la situazione intorno al cittadino
statunitense, era una bugia. Comportamento incredibile dell'amministrazione
statunitense", ha affermato Zakharova, citata dalla Tass.
16:05
Zelensky, munizioni
e proiettili a lungo raggio sono la priorità
"L'artiglieria è la
nostra necessità numero uno. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Munizioni,
proiettili a lungo raggio per fermare la Russia. Non per sparare sul territorio
della Russia, ma per buttarli fuori dal nostro territorio, il che è giusto". Lo
ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa dopo
aver incontrato l'omologo lettone Egils Levits, in visita in Ucraina. Il
presidente ha anche sottolineato che l'Ucraina ha bisogno di aerei militari e di
addestramento per gli equipaggi ucraini. Il presidente - riferisce una nota
della presidenza ucraina - ha anche sottolineato che Kiev ha bisogno di aerei
militari e di addestramento per gli equipaggi ucraini. "Oggi abbiamo parlato di
dove i nostri partner dalla Lettonia, così come dalla Lituania e dall'Estonia
possono aiutarci nelle missioni di addestramento. Abbiamo bisogno di aerei", ha
affermato il leader ucraino.
16:17
Bielorussia: Ue,
"processi farsa, esprimiamo ferma condanna"
"Oggi un tribunale
di Minsk ha condannato i membri del Centro per i diritti umani Viasna, tra cui
il suo presidente e premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, il
vicepresidente Valiantsin Stefanovic, Zmitser Salauyou (processato in
contumacia) e l'avvocato Uladzimir Labkovich, rispettivamente a dieci, nove,
otto e sette anni di carcere con accuse false e politicamente motivate. L'Unione
Europea condanna con la massima fermezza questi processi farsa, che
rappresentano un altro terribile esempio del tentativo del regime
di Lukashenko di mettere a tacere coloro che si battono in difesa dei diritti
umani e delle libertà fondamentali del popolo bielorusso. Lukashenko non ci
riuscirà. La loro richiesta di libertà è forte, anche dietro le sbarre". Lo
sostiene l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell in una
nota.
16:24
Kiev, abbattuto
caccia russo nei cieli del Donetsk occupato
L'aeronautica delle
forze armate dell'Ucraina ha rivendicato l'abbattimento di un cacciabombardiere
russo sui cieli di Yenakiyevo, nei territori occupati dai russi dell'oblast di
Donetsk. "Il 3 marzo 2023, nell'area di Yenakiyevo, intorno alle 13:30, i
cannonieri antiaerei del reggimento missilistico antiaereo Nikopol del comando
aereo Est hanno distrutto un cacciabombardiere russo Su-34. Uno dei piloti è
morto, il secondo si prepara a fargli compagnia", ha scritto l'aeronautica in un
messaggio su Telegram.
Citato dall'agenzia
russa Ria Novosti, il sindaco locale filorusso Roman Khramenkov ha confermato
l'abbattimento di un aereo militare sopra la città - che dista 50 km da Donetsk
- riferendo tuttavia che "due piloti espulsi sono stati visti coi paracadute".
"A terra... nessuno è rimasto ferito, perché in quel luogo c'è una fattoria", ha
affermato il sindaco.
16:44
Russia, a processo
vice presidente Duma della regione di Samara: "Contro Putin durante il suo
discorso"
Il vice presidente
della Duma della regione russa di Samara, l'esponente del Partito
comunista, Mikhail Abdalkin, sarà processato con l'accusa di aver screditato le
forze militari, per cui rischia una sanzione fino all'equivalente di 25mila
dollari, per aver preso in giro Vladimir Putin. Ha pubblicato su Youtube un
video in cui assiste al recente discorso sullo stato della Nazione del
presidente seduto alla scrivania di fronte a un computer, con spaghetti sulle
orecchie, in chiaro riferimento al celebre modo di dire russo "metter gli
spaghetti sulle orecchie di qualcuno" per dire "mentire a una persona", mentre
esprime "pieno sostegno" per la "grande performance" del presidente e annuisce
ripetutamente. Il processo a suo carico inizierà martedì presso il tribunale di
Novokuibyshevsk. Il Partito comunista russo ha preso le distanze da Abdalkin.
Nello spezzone di
video pubblicato da Abdalkin, Putin, che ha tenuto il suo discorso a tre giorni
dall'anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, denuncia che
l'Occidente "non ha onore, fiducia e decenza". "Nei lunghi secoli di
colonialismo, ordini ed egemonia, si sono abituati a poter fare qualsiasi cosa.
Si sono abituati a dividere il mondo intero. E prendono in giro anche i loro
cittadini parlando di pace e di rispetto delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell'Onu sul Donbass".
16:52
Telefonata
Blinken-Kuleba, focus su colloquio con Lavrov
Telefonata tra il
segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri
ucraino, Dmytro Kuleba. Nel colloquio, riferisce il portavoce del dipartimento
di Stato, Ned Price, Blinken ha riferito della sua breve conversazione col
ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine del G20 dei ministri degli
Esteri, a New Delhi. Il segretario di Stato ha ribadito al ministro ucraino il
continuo sostegno Usa per contrastare la brutale invasione russa.
17:01
Kiev, abbiamo
energia sufficiente per fabbisogno del Paese
L'Ucraina riesce a
generare tutta l'energia di cui ha bisogno nonostante i gravi danni causati
dagli attacchi russi alla sua rete energetica. Lo ha riferito il primo
ministro Denys Shmyhal, citato da Sky News. Shmyhal ha dichiarato in una
conferenza stampa che poco più di un anno dopo l'invasione della Russia, tra il
40% e il 50% del sistema energetico ucraino è stato danneggiato durante ondate
di missili e attacchi di droni nell'inverno. Anche se a volte milioni di persone
sono rimaste senza elettricità, l'Ucraina ha effettuato rapidamente riparazioni,
in parte con l'aiuto di attrezzature fornite dai suoi alleati. "L'Ucraina è per
ora dotata di capacità di generazione e di rete", ha detto il premier ucraino.
"Il prossimo passo è proteggere l'infrastruttura di rete per la prossima
stagione". Le misure includeranno la costruzione di rifugi in cemento e
sotterranei per proteggere gli impianti di generazione di energia e le reti di
distribuzione da potenziali nuovi attacchi.
17:07
Intensi scontri a
Bakhmut: "Russi schierano truppe più esperte"
"Intensi
combattimenti sono in corso dentro e fuori la città di Bakhmut", nel Donbass,
dove secondo le forze armate di Kiev "i russi stanno schierando le loro truppe
più esperte". Il comandante delle forze orientali, il colonnello
generale Oleksandr Syrskyi, ha detto che "gli occupanti russi hanno inviato le
unità più addestrate del gruppo Wagner e altre unità regolari dell'esercito
russo per catturare la città. Dentro e intorno alla città si stanno svolgendo
intensi combattimenti". Syrskyi "è stato informato sulle problematiche delle
nostre unità in prima linea". Secondo l'esercito ucraino la Russia continua a
premere nella speranza di "catturare Bakhmut e continua ad accumulare forze per
occupare la città".
17:14
Media, russo tenta
di nuotare fino a Odessa, condannato
Un russo accusato di
avere cercato di raggiungere Odessa dalla Crimea per arruolarsi nelle file
dell'esercito ucraino è stato condannato a sei anni di reclusione da una Corte
del territorio della penisola sul Mar Nero annessa nel 2014 da Mosca. Lo scrive
il sito della testata di opposizione russa Novaya Gazeta citando
l'agenzia Interfax.
L'uomo, un residente
di San Pietroburgo di 40 anni, è stato condannato per aver tentato di compiere
alto tradimento e per tentativo di espatrio illegale. Secondo i giudici, prima
di avventurarsi nella traversata a nuoto, nell'agosto dell'anno scorso, aveva
preso contatti con una unità di volontari ucraini. Dapprima intendeva
attraversare il confine dalla regione russa di Bryansk, ma poi ha cambiato idea
decidendo di tentare la traversata. A questo scopo aveva comprato una muta,
pinne, una bussola e una luce da usare sott'acqua. Ma la polizia di frontiera lo
ha fermato. Interfax sottolinea che la distanza tra Odessa e Olenivka, il punto
più occidentale della Crimea, è di 180 chilometri.
17:20
Nuovi aiuti Usa per
circa 400 milioni di dollari
Avrà un valore di
circa 400 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti americani all'Ucraina
che verrà annunciato oggi in occasione della visita del cancelliere tedesco Olaf
Scholz alla Casa Bianca. Il pacchetto includerà munizioni per lanciarazzi Himars
e diversi sistemi di artiglieria. Comprenderà anche per la prima volta veicoli
gettaponte corazzati, progettati per posare ponti o passerelle relativamente
piccoli attraverso fossati. Questi aiuti arriveranno dagli stock posti sotto la
Presidential Drawdown Authority (PDA), il che significa che le armi e le
attrezzature possono arrivare rapidamente in Ucraina. Con il pacchetto che verrà
annunciato oggi, gli Stati Uniti avranno impegnato più di 32 miliardi di dollari
in Ucraina dall'inizio della guerra più di un anno fa.
17:32
Caso Kara-Murza,
sanzioni Usa a magistrati russi
Gli Usa hanno
imposto sanzioni a tre magistrati russi accusati di gravi violazioni dei diritti
umani contro l'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, arrestato l'anno scorso
dopo che aveva parlato contro la guerra in Ucraina. Le misure del Dipartimento
del Tesoro colpiscono Elena Anatolievna Lenskaya, Andrei Andreevich
Zadachin e Danila Yurievich Mikheev per violazione della legge Magnitsky.
Kara-Murza, che ha cittadinanza britannica e russa, è stato stretto
collaboratore del leader dell'opposizione Boris Nemtsov, ucciso a colpi di arma
da fuoco a Mosca nel 2015.
17:47
Kiev: "Quasi 10mila
soldati russi hanno detto di volersi arrendere"
Sarebbero 9.836 i
soldati russi e dei territori occupati che hanno finora contattato la linea
telefonica messa a disposizione di Kiev per chi pensa di arrendersi. Lo afferma
il Quartier generale di coordinamento per i prigionieri di guerra, citato
da Ukrainska Pravda. Il progetto Hochu Zhit (Voglio vivere) è stato messo a
punto sei mesi fa dalle autorità ucraine. Da allora più di 14 milioni di persone
hanno visitato il sito web, malgrado i tentativi delle autorità russe di
bloccarne l'accesso. L'84% dei visitatori del sito provengono dalla Russia.
Oltre ai soldati, sono i famigliari a contattare la linea telefonica anche
perché ai militari viene spesso negato l'accesso ai Internet sui cellulari.
17:57
Lavrov, guerra
iniziata dall'Occidente. Platea scoppia a ridere
Non sono riusciti a
trattenere le risate, nonostante il contesto formale della conferenza Raisina
Dialogue in corso a Nuova Delhi. In un video diventato virale si vede il
ministro degli Esteri Sergei Lavrov attribuire la responsabilità del conflitto
in Ucraina all'Occidente, che "l'ha iniziata e sta usando gli ucraini contro di
noi". Prima che Lavrov finisse di parlare, la platea è scoppiata in una
fragorosa risata a cui si è aggiunto qualche urlo di dissenso, a sottolineare
l'assurdità dell'affermazione. Il ministro degli Esteri russo, comunque, non si
è scomposto e, dopo un secondo di interruzione, ha continuato il suo discorso.
18:18
"Nell'Ucraina
occupata costretti a registrare neonati come russi"
I genitori ucraini
nelle aree occupate dalle forze russe denunciano di essere stati costretti a
registrare i loro neonati come cittadini russi. Lo riporta il Guardian,
spiegando come i residenti che vivono in paesi e città nell'est e nel sud
dell'Ucraina hanno subito pressioni per accettare la cittadinanza russa per i
loro neonati, anche con la minaccia di vedersi negare la distribuzione gratuita
di pannolini e alimenti per bambini. "Abbiamo detto (ai russi) che il bambino è
nato in Ucraina ed è ucraino, non russo", ha detto Natalia Lukina, 42 anni della
città meridionale di Kherson. "Quando abbiamo chiesto i pannolini, i russi ci
hanno detto: 'Se vieni senza certificati di nascita russi, non ti daremo i
pannolini'". La maggior parte dei genitori di bambini piccoli, con scarso
reddito durante la guerra, ha accettato pannolini gratuiti dai russi, ha detto
il suo partner Oleksii Markelov. "Non avevamo un centesimo". Secondo Olena
Klimenko, capo dell'ufficio di registrazione regionale di Kherson, molti
genitori hanno rinviato le visite agli uffici del registro controllati dalla
Russia durante l'occupazione, e molti hanno registrato i loro bambini per la
cittadinanza ucraina una volta terminata l'occupazione. Non è chiaro quanti
bambini abbiano ricevuto la cittadinanza russa".
18:32
Russia, quasi tutti
morti i coscritti che si erano lamentati in video con Putin
Sono morti quasi
tutti i soldati mobilitati della regione siberiana di Irkutsk che a febbraio si
erano lamentati in video con il presidente russo Vladimir Putin di non aver
ricevuto un sufficiente addestramento e di essere stati messi agli ordini di
ufficiali dell'autoproclamata repubblica di Donetsk. Lo scrive il sito
russo Sibir. Realii. A quanto si legge, solo pochi membri del reggimento sono
rimasti in vita dopo che il primo marzo è stato loro ordinato di attaccare
un'area fortificata di Avdiivka, vicino Donetsk. I famigliari hanno riferito che
i pochi sopravvissuti sono feriti, mentre gli altri sono morti o dispersi. "Mio
marito mi ha chiamato, è stato ferito da una scheggia, è in ospedale. Dice che
del reggimento non è rimasto nessuno. Per ora si sa che sono sopravvissuti solo
due feriti, il resto è morto o è stato abbandonato sul posto in una situazione
molto difficile", ha raccontato la moglie di uno dei soldati a Sibir. Realii. Al
marito è stato detto che verrà rimandato al fronte fra una settimana, ha
aggiunto la donna. Il 27 febbraio gli uomini del 1439 reggimento avevano mandato
un terzo appello a Putin per denunciare le loro condizioni.
18:36
Serbia, non abbiamo
fornito armi né a Mosca né a Kiev
Il ministro degli
Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che dall'inizio della guerra in
Ucraina, la Serbia non ha esportato né concesso licenze per l'esportazione di
armi e materiale militare verso Kiev o verso Mosca. Lo riportano i media di
Belgrado.
19:02
Lavrov, Occidente
uguale su accordi Minsk e serbi del Kosovo
Per il ministro
degli esteri russo Lavrov, l'approccio che l'Occidente ha sul problema dei serbi
del Kosovo è identico a quello che l'Occidente ha mostrato sull'attuazione degli
accordi di Mnsk sull'Ucraina. "E' la stessa storia: un inganno dei serbi per ciò
che concerne la Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, e un inganno della
Russia riguardo agli accordi di Minsk", ha detto Lavrov, citato dai media serbi
che hanno riferito di un passaggio del suo intervento al Raisine Dialogue a New
Delhi. I Paesi occidentali, ha osservato il capo della diplomazia del Cremlino,
non hanno mai voluto attuare gli accordi di Minsk, e allo stesso modo non
intendono fare nulla per favorire l'attuazione degli accordi che riguardano i
serbi del Kosovo.
19:08
La Russia decide di
chiudere i gasdotti Nord Stream danneggiati
La Russia ha deciso
di chiudere i gasdotti Nord Stream che erano stati danneggiati negli scorsi
mesi. Secondo quanto riporta il sito di Reuters, nell'immediato non ci sono
piani per ripararli o riattivarli. Gazprom ha affermato che è tecnicamente
possibile rimettere in sesto le linee rotte, quindi la scelta di non intervenire
sarebbe politica.
A settembre diverse
esplosioni avevano colpito i due gasdotti, Nord Stream 1 e Nord Stream 2,
costruiti dalla società russa. A seguito di questi avvenimenti solo uno dei tubi
del Nord Stream 2 era rimasto intatto, mentre tutti gli altri erano rimasti
gravemente danneggiati. La Russia continua a sostenere che dietro il sabotaggio
ci siano gli Stati Uniti.
19:19
Ambasciatore russo
in Usa, Washington responsabile di attacco a Bryansk
L'ambasciatore russo
negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha affermato che le autorità americane "sono
responsabili" dell'attacco terroristico nella regione di Bryansk. Lo riporta Ria
Novosti. "I criminali di Kiev, ispirati dal sostegno degli Stati Uniti,
intraprendono azioni disumane, come l'attacco terroristico nella regione di
Bryansk. Washington è dietro le spalle di quelli che hanno sparato ai civili. Il
sangue delle vittime è già 'sulle mani' degli Stati Uniti", ha dichiarato.
19:36
Russia, l'oligarca
Deripaska: "Anno prossimo saremo senza soldi, servono investitori"
La Russia potrebbe
trovarsi "senza soldi già dal prossimo anno", tanto che "risulta necessario
avere investitori stranieri". Lo ha dichiarato l'oligarca russo Oleg Deripaska,
critico nei confronti della guerra decisa dal presidente russo Vladimir
Putin contro l'Ucraina. "Non ci saranno soldi già il prossimo anno, abbiamo
bisogno di investitori stranieri", ha detto in una conferenza in Siberia,
secondo quando riporta l’agenzia di stampa Tass. La produzione economica della
Russia è diminuita del 2,1% lo scorso anno, secondo una stima preliminare del
governo. La contrazione è stata più limitata di quanto inizialmente previsto da
molti economisti.
19:55
Zelensky, uniremo il
mondo per ripristinare la giustizia
"Abbiamo unito il
mondo per proteggere l'Ucraina, uniremo il mondo per ripristinare la giustizia.
Gli invasori russi saranno legalmente ed equamente tenuti a rendere conto di
tutti i crimini di guerra. Lo stato terrorista sarà tenuto a rendere conto del
crimine di aggressione". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su
Twitter. "Oggi a Lviv - prosegue - iniziano i lavori della conferenza United for
Justice, che ci aiuterà a creare una rete di forze legali per garantire che ogni
terrorista, assassino e torturatore russo ottenga una meritata condanna".
20:16
Russia, strangolato
scienziato russo che contribuì al vaccino Sputink
E' stato
"strangolato a morte con una cintura" Andrey Botikov, 47 anni, uno degli
scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo contro il Covid-19. Lo
riferisce l'agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è stato
"assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca". Botikov aveva
lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la
microbiologia sul vaccino Sputnik V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si
è dichiarato colpevole dell'omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue
l'agenzia di stampa, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite
domestica.
20:19
Scholz a
Biden,importante messaggio prosecuzione aiuto Kiev
E' molto importante
mandare il messaggio che gli alleati continueranno a sostenere l'Ucraina: lo ha
detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo incontro nello studio Ovale
con Joe Biden.
21:13
Kiev, i russi
cercano di circondare Bakhmut
"Il nemico non
abbandona i tentativi di circondare la città di Bakhmut". Lo scrive lo stato
maggiore ucraino nel suo aggiornamento serale. "Nel corso della giornata, i
nostri difensori hanno respinto numerosi attacchi nelle aree degli insediamenti
di Vasyukovka, Dubovo-Vasilyevka e Bakhmut nella regione di Donetsk", ha
riferito, citato da Ukrainska Pravda. Secondo i militari ucraini, le truppe
russe hanno lanciato 30 attacchi aerei e 6 missilistici, oltre a più di 20
attacchi da più sistemi lanciarazzi. Lo stato maggiore indica che i russi stanno
concentrando i loro sforzi principali in operazioni offensive nelle direzioni di
Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtar.
20:32
Ucraina: media, 12
anni a pilota russo, 'bombardò stazione tv'
Un tribunale ucraino
avrebbe condannato a 12 anni di reclusione un pilota militare russo preso
prigioniero accusandolo di aver preso parte a marzo a un attacco su Kharkiv. Lo
scrive la testata online Meduza. Secondo l'accusa ucraina, scrive il sito, il
pilota, di cui non viene fatto il nome, avrebbe sganciato otto bombe sulla
stazione radiotelevisiva della città. Meduza cita un rapporto della procura
generale ucraina in cui si sottolinea che le stazioni radiotelevisive sono
infrastrutture civili e si accusa il militare russo di aver violato le leggi di
guerra. Secondo la procura ucraina, il pilota sarebbe stato catturato dopo
l'abbattimento del suo velivolo.
20:54
Governatore
filo-russo di Zaporizhzhia decide nuovo assetto amministrativo
Il governatore
filo-russo di Zaporizhzhia, Eugeni Balitski, ha firmato oggi un decreto con il
quale la regione, situata nel sud dell'Ucraina e annessa dalla Russia a
settembre, è soggetta a rimodellamento amministrativo. Nel decreto si stabilisce
che Zaporizhzhia ha ora 16 unità amministrativo-territoriali e che la città di
Melitopol diventa capoluogo della regione, riferisce l'agenzia russa Interfax.
Pertanto, Zaporizhzhia avrà ora tre "città di importanza regionale" come
Melitopol, Berdiansk ed Energodar. Melitopol si estenderà geograficamente fino
alla costa del Mar d'Azov.
21:35
Casa Bianca, F-16
non sono parte fondamentale nell'incontro Biden-Scholz
I caccia F-16 non
sono una "parte fondamentale" dell'agenda dell'incontro di questo pomeriggio tra
il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma i due leader
parleranno ampiamente di quello di cui l'Ucraina avrà bisogno in primavera ed
estate per i combattimenti a venire. A dichiararlo è stato John Kirby, portavoce
del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, con riferimento ai
colloqui in corso nello Studio Ovale tra il presidente americano e il
cancelliere tedesco.
21:48
Usa, la Cina
potrebbe ancora compiere il passo di fornire amri alla Russia
La Cina potrebbe
ancora compiere il passo di fornire aiuti militari alla Russia, andando in
direzione di una escalation. A dichiararlo è stato il portavoce del Consiglio di
sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby. "Non crediamo che abbiano
rinunciato a questa opzione", ha detto Kirby alla CNN, osservando però che
l'amministrazione ancora non "crede che abbiano preso la decisione di andare
avanti".
22:33
Bbc: più di 16 mila
soldati russi uccisi dall'inizio della guerra
Secondo la Bbc, sono
16.071 i soldati russi morti nella guerra in Ucraina. Ma - si spiega - il numero
reale di perdite è decisamente ancora più alto, in quanto il dato riportato
riguarda solo le morti confermate. Le perdite totali della Russia - tra soldati
feriti, morti o dispersi - potrebbero ammontare a 144.500 persone.
22:38
Visita a sorpresa
del ministro della Giustizia Usa in Ucraina
Il ministro della
Giustizia Merrick Garland è arrivato a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato
il presidente Volodymyr Zelensky alla 'United for Justice Conference'. Lo
riporta Cnn. Garland ha visitato Leopoli su invito del procuratore generale
ucraino, ha reso noto un funzionario del Dipartimento di giustizia americano.
"Il procuratore generale ha tenuto diverse riunioni e ha ribadito la nostra
determinazione a ritenere la Russia responsabile dei crimini commessi nella sua
invasione ingiusta e non provocata contro il suo vicino sovrano", ha detto.
23:08
Attacco russo a
Zaporizhzhia, sale a 7 il numero dei morti
È salito a sette il
bilancio delle vittime dell'attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia,
lanciato dalle forze russe nella notte tra mercoledì e giovedì, che ha colpito
un condominio di cinque piani. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, le
unità del servizio di emergenza statale sono riuscite a salvare 11 persone e a
evacuarne altre 20.
23:26
Metsola a Kiev, la
casa dei coraggiosi ucraini è l'Ue
La presidente
dell'Eurocamera è arrivata, a sorpresa, in Ucraina. "È bello tornare in Ucraina.
Con quelle persone coraggiose che hanno ispirato il mondo. Con quegli eroi che
si rifiutano di arrendersi. Con coloro che hanno sacrificato tutto per i nostri
valori. Con gli europei la cui casa è la nostra Unione Europea", ha scritto in
un tweet pubblicando un'immagine che la ritrae, di sera, a Kiev.
Estratto
da affaritaliani.it il 3 marzo 2023.
Piero Fassino ha
espresso spesso le sue previsioni che si sono poi rivelate opposte alla realtà
dei fatti: da Beppe Grillo ("fondi il suo partito e vediamo quanti voti
prende"), a Chiara Appendino (sfidata a candidarsi a sindaca di Torino) al Pd
(che "non può fallire", alla vigilia della disfatta dei referendum 2016), fino
alla invasione dell'Ucraina.
(...)
Ecco perché non sono
sfuggite le dichiarazioni di Fassino a riguardo: "Non prevedo l'invasione
dell'Ucraina", disse poco prima che l'esercito di Putin entrasse nei confini
ucraini. Ora, però, Fassino si è espresso anche su qualcosa di ancor più
pericoloso e mondiale: il nucleare.
Il giornalista de
Il Piccolo, Mauro Manzin, in un'intervista al deputato Pd gli ha chiesto di dire
la sua sul possibile utilizzo di armi nucleari da parte della Russia: "No, non
credo che convenga, in primis, proprio a Putin: il mondo si può distruggere una
volta sola. È questo che vuole? Non penso". E i social sono esplosi: "È stato
bello conoscervi, addio", scrive un utente. "L'ha detto, siamo spacciati",
commenta un altro.
Russia, altra
morte sospetta: strangolato lo scienziato padre del vaccino Sputnik.
Il Tempo
il 03 marzo 2023
L’ennesimo decesso
in Russia che lascia più di qualche dubbio. È stato «strangolato a morte con una
cintura» Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a
creare il vaccino russo contro il Covid-19. A riferirlo è l’agenzia di stampa
Tass, che afferma anche che il ricercatore è stato «assassinato nel suo
appartamento nel nord-ovest di Mosca». Botikov aveva lavorato per il Centro
nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia sul vaccino Sputnik
V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole
dell’omicidio. Secondo gli investigatori l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito
di una lite domestica. Sputnik è un vaccino che non contiene l'agente patogeno,
ma utilizza come vettore alcune delle particelle di adenovirus umano.
La Repubblica. A
cura di Flavio Bini, Anna Lombardi, Ilaria Zaffino
Kharkiv 2000 morti,
100 bambini. Attacco aereo su Kiev. Nuovi negoziati nel weekend. Mosca blocca
Facebook e Twitter
Preso di mira
l'impianto per la produzione di energia atomica più grande d'Europa. L'Aeia:
"Ora è in sicurezza ma situazione fragile". L'offensiva delle forze russe avanza
verso le principali città e arriva a 25 chilometri dalla capitale. Zelensky:
"Sfiorata la fine dell'Europa". Conquistata la città di Mykolaiv. La Bbc ritira
i giornalisti dalla Russia. È previsto per sabato o domenica il terzo incontro
tra le due delegazioni
L'invasione russa si
spinge fino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa.
Sotto i colpi dei combattimenti per tutta la notte l'impianto passa nella mani
dell'esercito russo. Per qualche ora si teme un disastro molto più grave di
quello di Chernobyl, poi le autorità di Kiev fanno sapere che l'impianto è in
sicurezza. E anche l'Aiea rassicura: "Nessuna fuga di radiazioni". La città di
Kharkiv finora ha pagato il prezzo più alto dell'invasione russa, tra le vittime
ci sarebbero oltre 100 bambini. Con un messaggio su Twitter il presidente
ucraino Zelensky torna a rivolgersi all'Europa: "È l'unica che può fermare la
guerra". In una telefonata con il primo ministro tedesco Scholz, Putin conferma
i nuovi negoziati nel fine settimana. La Nato però avverte: "I giorni che
verranno probabilmente saranno peggiori, con più morti e più distruzione"
00.30 Facebook e i
siti di vari media inaccessibili in Russia
Facebook e diversi
siti di mezzi di informazione indipendenti sono parzialmente inaccessibili in
Russia. I giornalisti dell'AFP a Mosca non sono stati in grado di accedere a
Facebook, così come ai siti dei media Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL e al
servizio in lingua russa della Bbc.
00.56 "La centrale
di Zaporizhzhia è in fiamme"
La centrale nucleare
di Zaporizhzhia è in fiamme dopo un attacco russo. Lo ha riferito sul web Dmytro
Orlov, sindaco della città di Energodar. Nella giornata di ieri era stata
diffusa la notizia che l'impianto, il più grande di questo genere in Europa, era
stato conquistato dalle forze russe. Lo stesso Orlov aveva dato notizia di
combattimenti nei pressi della centrale. "Come risultato del continuo
bombardamento nemico di edifici e unità del complesso, l'impianto è in fiamme",
ha scritto sul suo canale Telegram parlando di una minaccia alla sicurezza
mondiale.
01.30 Ministro degli
Esteri: "Se esplode Zaporizhzhia, dieci volte peggio di Chernobyl"
Le forze russe
stanno "colpendo Zaporizhazhia, la maggiore centrale nucleare in Europa. Ci sono
già fiamme. Se dovesse esplodere, sarebbe dieci volte peggio di Chernobyl. La
Russia deve immediatamente cessare il fuoco, consentire ai pompieri" di
intervenire e "creare una zona di sicurezza". Lo twitta il ministro degli Esteri
ucraino Dmytro Kuleba.
01.50 Il portavoce
della centrale: "In fiamme un reattore al momento non operativo"
Il portavoce della
centrale, Andriy Tuz, ha detto alla tv ucraina che uno dei sei reattori
dell'impianto è in fiamme. Si tratta di un reattore al momento in manutenzione,
quindi non operativo. Ma all'interno c'è combustibile nucleare.
02.04 Pentagono: "I
russi stanno finendo carburante e cibo"
"I russi sono
frustrati, sono stati respinti, hanno trovato una dura resistenza. Stanno
affrontando problemi logistici e di sostentamento. Stanno finendo il carburante
e il cibo. Sono rimasti sorpresi da come gli ucraini stanno difendendo le loro
città". Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby lodando "il
coraggio degli ucraini".
02.10 Livelli alti
di radiazioni intorno alla centrale
Un funzionario
ucraino trinceratosi dietro l'anonimato ha detto all'Associated Press che
intorno alla centrale di Zaporizhzhia sono stati rilevati alti livelli di
radiazioni.
02.19 Zaporizhzhia,
pompieri sotto tiro non arrivano alle fiamme
I vigili del fuoco
non riescono a raggiungere le fiamme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia
perché sono sotto tiro da parte dei russi, secondo quanto afferma Andriy Tuz, il
portavoce della centrale, in un video postato su Telegram.
02.25 Aiea: stop ai
combattimenti intorno alla centrale nucleare
L'Agenzia
Internazionale per l'Energia Nucleare chiede la cessazione delle ostilità
intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e avverte che si corre un "grave
pericolo".
02.36 Colloquio
telefonico Biden-Zelensky
Il presidente degli
Stati Uniti ha parlato con quello ucraino dell'attacco alla centrale di
Zaporizhzhia, mentre il segretario di Stato americano Blinken ha discusso con il
collega Kuleba di ulteriori misure da adottare per sostenere l'Ucraina sul piano
della sicurezza e su quelli economico e umanitario.
02.53 "Incendio
scoppiato fuori dal perimetro della centrale"
Il Servizio statale
per le emergenze ucraino ha comunicato che l'incendio alla centrale nucleare di
Zaporizhzhia è scoppiato fuori dal perimetro dell'impianto.
02.57 "La centrale
di Zaporizhzhia messa in sicurezza"
Le autorità ucraine
hanno reso noto che la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia è ora
garantita, i vigili del fuoco hanno potuto raggiungere il luogo dell'incendio.
"Il direttore della centrale ha detto che è stata messa in sicurezza. Secondo i
responsabili dell'impianto le fiamme hanno interessato una struttura per la
formazione e un laboratorio", ha scritto su facebook Oleksandre Staroukh, capo
dell'amministrazione militare della regione.
03.03 Aiea: nessun
cambiamento nei livelli di radiazioni
"Le autorità di
controllo ucraine hanno informato l'Aiea che non è stato segnalato nessun
cambiamento nei livelli di radiazioni nel sito della centrale di Zaporizhzhia".
03.10 Zelensky:
"Mosca ricorre al terrore nucleare"
Il presidente
ucraino accusa Mosca di "ricorrere al terrore nucleare" e di voler "ripetere"
Chernobyl. "Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali
nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia
dell'umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare", ha
detto Zelensky in un video messaggio.
03.45 Johnson chiede
riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu
Il primo ministro
britannico ha denunciato le "azioni irresponsabili" di Putin che "minacciano
direttamente la sicurezza di tutta l'Europa". E dopo una telefonata con Zelensky
ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu
04.19 Aiea:
l'incendio a Zaporizhzha non ha interessato strutture essenziali
L'incendio alla
centrale nucleare di Zaporizhzhia non ha interessato strutture o attrezzature
"essenziali", il personale dell'impianto sta prendendo misure per la messa in
sicurezza: lo scrive su Twitter l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(Aiea) che è stata informata dalle autorità dell'Ucraina.
05.26 I pompieri
hanno fermato l'incendio
I vigili del fuoco
hanno arrestato la propagazione dell'incendio alla centrale nucleare di
Zaporizhzha. Lo ha reso noto il Servizio statale ucraino per le emergenze
06.03 Spento
l'incendio alla centrale nucleare
I soccorritori del
Servizio di emergenza dell'Ucraina hanno spento l'incendio divampato in un
edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Alle 6:20 ora locale,
l'incendio nella struttura di formazione della centrale nucleare di
Zaporizhzhia, nella città di Energodar, è stato spento. Non ci sono vittime o
feriti", ha comunicato il Servizio di emergenza statale in una dichiarazione su
Facebook.
06.55 Airbnb
sospende le sue attività in Russia
"Airbnb sospende
tutte le operazioni in Russia e Bielorussia". Lo scrive su twitter il ceo della
società Brian Chesky.
7:10 Zelensky: "Solo
l'Europa può fermare la Russia"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto "un'azione immediata da parte dell'Europa"
dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhya,
nel sud dell'Ucraina, causando un incendio. "Solo un'azione immediata da parte
dell'Europa può fermare le truppe russe", ha detto Zelensky su Twitter.
7.40 Aiea convoca
conferenza stampa
L'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha segnalato che "al momento non si
registrano cambiamenti nei livelli di radiazioni nell'impianto" nucleare di
Zaporizhzhia. Prevista per le 10 e 30 una conferenza stampa dell'Aiea, che nel
frattempo ha messo in allerta il suo Centro per le emergenze in modalità 24 ore
su 24, 7 giorni su 7.
08.00 Kiev, russi
hanno preso controllo centrale nucleare Zaporizhzhia
Le forze militari
russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della
città di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Lo
riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali. "Il personale
operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza", hanno affermato
sui social media, aggiungendo che gli sforzi compiuti sono stati in linea con i
requisiti di sicurezza.
08.19 Russia,
limitato accesso a siti di informazione tra cui Bbc
Roskomnadzor, il
servizio di controllo delle comunicazioni russo, ha limitato l'accesso a diversi
siti di informazione, tra cui Meduza, Radio Liberty e Bbc. Lo riporta Ria
Novosti.
08.22 Nessuna fuga
di radiazioni alla centrale
Le apparecchiature
essenziali della centrale nucleare di Zaporizhzhia non sono state danneggiate
dall'incendio provocato nella notte da un attacco russo, senza alcun cambiamento
nei livelli di radiazioni, ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA), citando le autorità di controllo dell'Ucraina. "L'autorità di
regolamentazione ucraina ha affermato che un incendio nel sito non ha colpito le
apparecchiature" essenziali "e il personale dell'impianto sta adottando misure
di mitigazione del rischio", si legge nella nota. "Non sono stati segnalati
cambiamenti nei livelli di radiazioni nell'impianto".
08.27 Google
sospende la pubblicità in Russia
Il motore di ricerca
Google e la collegata piattaforma video YouTube hanno sospeso la vendita di
spazi pubblicitari sul territorio russo come conseguenza del conflitto in
Ucraina. Lo scrive la Tass, citando una nota della compagnia Usa: "Alla luce di
queste circostanze straordinarie, abbiamo fermato gli spazi pubblicitari su
Google in Russia". Google ha aggiunto di star seguendo la situazione e che gli
utenti saranno tenuti informati sul suo evolversi.
08.52 Anche Airbnb
blocca i servizi in Russia
Airbnb ha annunciato
che sospenderà il servizio in Russia e Bielorussia. Lo riferisce la Bbc online
sottolineando che la società americana è l'ultima, in ordine di tempo, ad
annunciare tale decisione dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ciò è in linea
con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali su
molte parti dell'economia russa, come le banche, che hanno reso quasi
impossibile per le imprese globali operare in Russia.
09.01 I russi
sospendono lancio Soyuz con satelliti OneWeb
Nella base spaziale
russa di Baikonur è in corso la rimozione dalla rampa di lancio del razzo
Soyuz-2.1b, a bordo del quale sono 36 satelliti della costellazione OneWeb per
le connessioni internet. Lo rende noto l'agenzia spaziale russa Roscomos in un
tweet. Il lancio era previsto per oggi, ma nei gorni scorsi le relazioni fra
l'agenzia spaziale russa e l'azienda con base nel Regno Unito sono diventati
progressivamente più tesi, con la richiesta della Roscomos di garanzie sugli
scopi non militari e la conseguenta decisione della OneWeb di sospendere i lanci
dei suoi satelliti da Baikonur
09.13 Russia, nuove
misure contro "fake news su esercito". C'è anche il carcere
La Russia ha
approvato una legge che modifica il Codice penale per contenere la diffusione di
'fake news' sulle operazioni dell'esercito russo. Lo scrivono Tass e Interfax,
spiegando che questo è quello che prevede la legge appena approvata dalla Duma,
all'unanimità, che introduce una responsabilità criminale per la diffusione di
false informazioni sulle forze armate russe. In base alla gravità del reato sono
previste multe e anche la prigione (si rischiano fino a 15 anni di carcere).
09.16 Attacco hacker
a più grande agenzia spaziale russa
Un "massiccio
attacco" hacker ai server della più grande azienda spaziale russa, Energia, è
stato sferrato nella serata di ieri da siti esteri e ora la funzionalità del
sito è stata ripristinata. Lo rende noto su Twitter l'agenzia spaziale russa
Roscosmos. "Ieri sera - si legge nel tweet - gli specialisti di RSC Energia
hanno registrato un massiccio attacco DDoS al sito Web della società da vari
indirizzi IP dall'estero. Ora il sito funziona stabilmente, l'infrastruttura e
tutte le sezioni del sito sono sotto il controllo di specialisti
09.24 Kiev: "I russi
hanno subito perdite su tutti i fronti"
Nel nono giorno
dell'offensiva russa in Ucraina, le forze armate di Mosca "hanno subito perdite
su tutti i fronti". Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino. "Gli invasori
demotivati si stanno arrendendo e abbandonando l'equipaggiamento", si legge
nella nota, "questi trofei ci stanno aiutando a battere gli invasori russi. La
battaglia continua! La vittoria sarà nostra! Gloria all'Ucraina!".
09.32 Kiev: "Nessuna
vittima nell'incendio della centrale"
L'incendio alla
centrale nucleare di Zaporizhzhia, ora sotto controllo russo, è stato domato
alle 7:20 italiane e non ha causato alcuna vittima. Lo conferma una nato dello
Stato maggiore dell'esercito ucraino.
09.41 Mosca,
perquisizioni nella sede della ong Memorial
L'ong per la difesa
dei diritti umani Memorial Internazionale riferisce di perquisizioni nei suoi
uffici a Mosca: lo riporta l'agenzia Interfax. Memorial è stata recentemente
colpita da una sentenza di scioglimento emanata dalla Corte suprema russa in un
momento storico in cui le autorità russe stanno attuando un nuovo duro giro di
vite per soffocare il dissenso e la libertà di stampa
09.47 Nato:
"L'attacco alle centrali nucleari è segno di inscoscienza di questa guerra"
"L'attacco alle
centrali nucleari è la dimostrazione dell'incoscienza di questa guerra". Lo ha
dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al punto stampa
con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in merito all'attacco alla
centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.
09.56 Sirene di
allarme a Leopoli
A Leopoli hanno
risuonato poco fa le sirene di allarme anti bombardamento. La popolazione è
stata invitata a raggiungere un rifugio. Lo riferisce l'Ansa. La città è
protetta da almeno tre anelli di check point delle forze ucraine e cavalli di
frisia dove vengono controllati i documenti sia all'ingresso che all'uscita.
10.02 Kiev: "La
Russia ha perso 9166 soldati"
Sono finora 9.166 i
soldati russi caduti durante l'invasione dell'Ucraina. Lo riferiscono le forze
armate di Kiev.
10.12 Mosca: "Alla
centrale nucleare provocazione di Kiev"
Questa notte Kiev ha
tentato una provocazione sul territorio adiacente alla centrale nucleare di
Zaporizhzhia. Lo afferma il ministero della Difesa russo citato da Tass.
10.08 Borrell:
"Putin usa armi proibite dalla convenzione di Ginevra"
"Assistiamo a una
guerra guidata da Putin contro l'Ucraina, una guerra assolutamente
ingiustificabile che sta causando molto vittime con l'uso di armi severamente
vietate dalla Convenzione di Ginevra". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante
dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Nato.
10.11 Kiev: "Sale a
47 vittime il bilancio dei civili a Chernihiv"
Salgono ad almeno 47
i civili uccisi nell'attacco russo di ieri a Chernihiv, nel nord dell'Ucraina.
Lo riportano le
autorità regionali, citate dai media internazionali. Il bilancio di ieri era di
33 morti tra i civili. Ieri le operazioni di soccorso erano state sospese a
causa dei pesanti bombardamenti, secondo quanto riferito dal servizio di
emergenza locale.
10.15 Borrell (Ue):
"Tutte le misure sul tavolo"
"Questo è il momento
di far sentire la nostra voce e di alzarsi. Questo è il momento in cui l'unità
transatlantica è più importante che mai". Così l'Alto rappresentante Ue per la
politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla ministeriale Esteri della
Nato a Bruxelles. "Prenderemo in considerazione tutto. Una settimana fa vi dissi
che tutto era sul tavolo e avete potuto vedere che tutto era sul tavolo perché
abbiamo preso misure che nessuno poteva aspettarsi. Quindi tutto rimane sul
tavolo", ha aggiunto.
10.16 Borrell:
"Indagine sui crimini di guerra di Mosca"
La Russia sta
usando "armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra, ci sono numerose
perdite civili. E' importante attivare il meccanismo di Mosca e avviare una
missione per indagare su eventuali crimi di guerra commessi in Ucraina". Lo ha
detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell arrivando al
vertice dei ministri degli Esteri della Nato
10.22 Oltre 672mila
rifugiati già entrati in Polonia
Sono oltre 672mila i
rifugiati usciti dall'Ucraina che sono entrati in Polonia dall'inizio
dell'aggressione russa. Lo fa sapere la Guardia di frontiera polacca, secondo
quanto riportano i media internazionali
10.23 La marina
ucraina affonda nave ammiraglia per non farla prendere ai russi
Lo scrive il Kyiv
Independent. La fregata Hetman Sahaidachny era in riparazione nella città di
Mykolaiv. Al comandante è stato ordinato di affondarla, secondo quanto ha
riferito il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov
10.26 La situazione
sul campo secondo Kiev
Lo Stato maggiore
dell'esercito ucraino ha diffuso un bollettino dettagliato sullo stato delle
operazioni militari nel Paese, nel nono giorno dell'invasione russa. Le forze di
Kiev sostengono che i russi hanno perso finora oltre 9.100 uomini e molti
reparti si stiano arrendendo e stiano abbandonando le armi."Gli sforzi
principali delle forze di occupazione russe sono concentrati sull'accerchiamento
di Kiev e sull'indebolimento della resistenza negli insediamenti bloccati",
riferisce lo stato maggiore. "Allo stesso tempo è stato riferito che l'invasore
ha esaurito la maggior parte delle sue riserve operative e ha iniziato i
preparativi per trasferire forze e risorse aggiuntive dai distretti militari
meridionali e orientali. Il secondo livello e la maggior parte delle riserve
operative delle forze d'invasione sono state messe in funzione"
10.33 Appello del
vice sindaco di Mariupol: "Mandate truppe Nato"
"Non c'è modo di
fermare Putin finché la Nato non si sveglia e capisce che questo non è un
conflitto regionale ma una guerra contro la democrazia, la libertà e una delle
più grandi nazioni europee", ha detto Sergei Orlov alla Bbc. "Sembra che i
leader della Nato non capiscano che Putin non si fermerà".
10.38 Mosca accusa
Kiev: "Falsità sulla centrale nucleare"
Su Zaporizhzhya "c'è
stata una provocazione creata ad arte dal regime di Kiev con l'obiettivo di
accusare la Russia di causare un incidente nucleare". Lo dice il portavoce del
ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov precisando che il personale della
centrale "lavora come al solito e monitora i livelli di radiazione".
10.46 Due feriti
alla centrale nucleare di Zaporizhzhia
Lo ha detto il
direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi in conferenza stampa.
"Queste persone non sono operatori o tecnici della centrale ma fanno parte del
personale di sicurezza che lavora nella centrale", ha precisato. "Sono rimasti
feriti durante lo scontro a fuoco"
10.53 L'appello di
Zelensky agli abitanti di Kherson: "Fatevi sentire"
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto in un video rivolto agli abitanti di
Kherson di "far capire agli occupanti che possono stare a Kherson solo
temporaneamente". Secondo Zelensky, in questa città ucraina potrebbe presto
andare in scena una manifestazione a favore della Russia "alla quale
parteciperanno stranieri, con lo scopo di cercare traditori locali". E ha dunque
chiesto agli abitanti "Fimostrate che è la vostra citta. Fermate il piano
dell'invasore".
10.55 Aiea:
"Dall'Ucraina richiesta di assistenza immediata"
"L'Ucraina ha
inviato alla nostra agenzia una richiesta di assistenza immediata. Non la
lasceremo cadere nel vuoto". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, riferendo sugli
scontri avvenuti nella notte presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. "La
situazione è fragile e molto insanabile".
11.04 La propaganda
russa diffonde bufale da almeno 100 siti
E sono almeno dieci
le principali bufale diffuse. Lo dice un report del Centro di monitoraggio della
disinformazione sul conflitto Russia-Ucraina diffuso da NewsGuard che sta
monitorando 116 domini di propaganda e disinformazione filo-russa. "I tre siti
più influenti, finanziati e gestiti dal governo russo sono le fonti dei media
statali RT, TASS e Sputnik News, ma ci sono anche siti anonimi, gestiti con
finanziamenti non chiari, che potrebbero avere collegamenti non dichiarati con
il governo russo". Newsguard ha anche individuato le 10 principali bufale su cui
ha fatto fact-checking: i residenti di lingua russa del Donbas sono stati
vittime di un genocidio; sabotatori di lingua polacca hanno tentato di
bombardare un impianto di trattamento delle acque reflue nel Donbas; le forze
ucraine hanno bombardato un asilo nel Lugansk il 17 febbraio 2022; la Russia non
ha preso di mira infrastrutture civili in Ucraina; il nazismo è prevalente nella
politica e nella società ucraine; l'Occidente ha organizzato un colpo di stato
per rovesciare il governo ucraino filorusso nel 2014; gli Stati Uniti possiedono
una rete di laboratori di armi biologiche nell'Europa orientale; la Nato ha una
base militare a Odessa; la Crimea si è unita alla Russia legalmente; l'Ucraina
moderna è stata interamente creata dalla Russia comunista.
11.06 Aiea:
"Problemi tecnici nel monitoraggio delle radiazioni di Chernobyl"
Ma non si tratta di
"problemi enormi" e dai dati disponibili la situazione appare "nella
normalita'". Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi.
11.22 Zelensky:
"Sanzioni più severe dopo l'attacco alla centrale nucleare"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky chiede sanzioni occidentali più severe contro Mosca
dopo l'attacco russo alla prima centrale nucleare ucraina. "E' necessario un
inasprimento immediato delle sanzioni contro lo stato terrorista nucleare", ha
affermato in un discorso video, invitando anche i russi a "scendere in piazza"
per fermare gli attacchi russi ai siti nucleari in ucraina.
11.21 Kiev
accerchiata dalle forze russe
Lo conferma il
ministero della Difesa ucraina precisando che le truppe russe sono "bloccate e
fermate nell'area di Makarov" a circa 60 km dalla capitale ucraina. Secondo il
ministero, i militari hanno esaurito parte delle loro riserve operative e hanno
avviato "i preparativi per il trasferimento di forze e risorse aggiuntive dai
distretti militari meridionali e orientali". Ieri, il presidente russo Vladimir
Putin ha affermato che la guerra in ucraina "sta andando secondo i piani",
nonostante le valutazioni contrarie di altri Paesi. Secondo il ministero della
Difesa ucraino, le forze russe continuano a prepararsi per lo sbarco sulla costa
del Mar Nero.
11.25 Truppe russe
stanno entrando a Mykolaiv
Lo conferma il
sindaco, Oleksandr Senkevych. Mykolaiv, città dell'Ucraina meridionale non
distante da Kherson (il cui controllo è rivendicato dai russi), ha circa mezzo
milione di abitanti.
11.36 Lukashenko:
"Parlato con Putin, non partecipiamo all'invasione"
Il presidente
bielorusso Alexander Lukashenko ha riferito di un ''colloquio con il presidente
russo Vladimir Putin'' durante il quale ha confermato che ''i militari
bielorussi non parteciperanno all'invasione dell'Ucraina". La Russia ha però
utilizzato il territorio bielorusso per attaccare.
11.37 Zelensky: " A
Zaporizhzhia sfiorata la fine dell'Europa"
"Un disastro alla
centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe 6 volte peggiore di Chernobyl". Lo ha
detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo riporta il Kyiv
Independent. "Sarebbe potuta essere la fine della storia dell'Ucraina e
dell'Europa", ha detto, aggiungendo che i russi "sapevano cosa stavano colpendo,
hanno mirato al sito". Si è poi appellato ai russi: "Come è possibile. Abbiamo
combattuto insieme le conseguenze del disastro di Chernobyl del 1986. Ve lo
siete dimenticato? Se ve lo ricordate non potete stare in silenzio. Dite ai
vostri leader che volete vivere".
11.41 Kiev: "3
morti durante l'attacco alla centrale nucleare"
Sarebbero soldati
addetti alla sicurezza della centrale. Altri due sono stati feriti, uno è in
condizioni critiche
11.43 Borrell:
"Convocare il Consiglio di Sicurezza Onu dopo attacco alla centrale nucleare"
"Gli attacchi russi
nelle immediate vicinanze delle centrali nucleari ucraine possono avere
conseguenze catastrofiche. Devono fermarsi immediatamente. I bombardamenti e il
conseguente incendio alla Zaporizhzhya possono mettere in pericolo l'intera
Europa. Sostegno per una riunione di emergenza di Consiglio di sicurezza
dell'Onu". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica
estera, Josep Borrell.
11.52 Zhytomyr,
colpita una scuola. Non ci sono vittime
Le forze russe hanno
colpito una scuola a Zhytomyr, a ovest di Kiev, distruggendo l'edificio. Lo
rende noto il sindaco della città Serhiy Sukhomlyn su Facebook, citato dai media
ucraini. "Un razzo o una bomba sono stati appena lanciati contro la scuola n.25.
Metà dell'edificio è distrutto". Secondo le prime informazioni non ci sarebbero
vittime.
11.54 La ministra
degli Esteri britannica Truss: "Dobbiamo dare più sostegno militare"
Lo ha detto a
Bruxelles dove si trova per incontrare i colleghi dei Paesi alleati membri della
Nato: "Si deve stringere la morsa attorno alla macchina da guerra di Putin". E
deve avvenire in più modi: "Sanzioni sempre più forti sull'economia di Mosca e
invio di armamenti agli ucraini".
12.00 A Kharkiv 2000
morti, oltre 100 bambini
Lo ha detto Serhiy
Chernov, presidente del consiglio regionale di Kharkiv, in videocollegamento con
il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. "Il villaggio di Iakevo nella
ragione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quell'area", ha
spiegato. "Sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel
nostro centro regionale. Ci occupiamo di tutti i profughi dell'area consegnando
medicinali e cibo".
12.10 Bombe su
Chernihiv: 47 morti
Ieri sono morte 47
persone - 38 uomini e 9 donne - nei bombardamenti russi sulle aree residenziali
della città di Chernihiv, nel Nord dell'Ucraina. Lo riferisce il governo
ucraino. Altre 18 persone sono rimaste ferite
12.12 Zelensky:
"Oggi capiremo se l'accordo sui corridoi umanitari funziona"
Lo ha detto
riferendosi all'intesa raggiunta ieri nei colloqui tra le delegazioni russe ed
ucraini per creare corridoi umanitari che permettano ai civili di lasciare le
zone di combattimento. "La capitale Kiev rimane l'obiettivo principale degli
occupanti, ma non ci faremo piegare", ha poi aggiunto.
12.16 La presidente
della Commissione Europea Von der Leyen incontra il segretario di Stato Usa
Blinken
Si vedranno a
Bruxelles per discutere degli sviluppi della guerra in Ucraina. Domani sarà poi
in Spagna, per incontrare il premier spagnolo Pedro Sanchez. Lunedì riceverà a
Bruxelles il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Gli incontri
preludono al Consiglio Europeo informale del 10 e 11 marzo a Versailles.
12.18 Consiglio Onu
per i diritti umani approva risoluzione per commissione internazionale
d'inchiesta sulle violazioni
E' stata approvata a
grande maggioranza con 32 voti favorevoli, 2 contrari (Russia ed Eritrea) e 13
astensioni, compresi quelli di Venezuela, Cuba, Cina, India e Pakistan. E' la
prima volta che il Consiglio dell'Onu assume una risoluzione che riguarda
direttamente la Russia
12.25 Lukashenko
"non partecipiamo a invasione": Ma rafforza difesa
Il presidente
bielorusso ripete che le forze armate del suo Paese non prenderanno parte
"all'operazione militare speciale" in Ucraina, ma il colonnello Anatoly Bulavko
rende noto di aver rafforzato le forze di difesa aerea in servizio proprio su
richiesta dello stesso Lukashenko.
13.12 Kiev, in corso
colloquio Putin-Scholz su corridoi umanitari
"In questo momento,
il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta parlando con il presidente russo Vladimir
Putin dei corridoi umanitari". Lo ha scritto su Twitter il consigliere di
Zelensky Mykhailo Podoliak. "Il mondo ha finalmente realizzato l'intera
catastrofe organizzata dai russi", ha aggiunto il consigliere.
12.31 L'allarme del
ministro della Cultura ucraino: "patrimonio sotto attacco"
Il ministro della
Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, ha lanciato un appello stamani "per
chiudere i cieli sull'Ucraina in quanto gli aggressori russi stanno distruggendo
i nostri siti culturali. La maggior parte dei crimini di guerra di Putin in
Ucraina sono stati commessi dall'aria", ha detto. "Putin vuole cancellare il
patrimonio e la cultura dell'Europa dalla faccia della terra. Un dittatore pazzo
minaccia di distruggere la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, una chiesa
dell'Unesco costruita nell'XI secolo".
12.36 Putin a paesi
vicini: "Non inasprite le tensioni"
"La Russia non ha
cattive intenzioni nei confronti dei suoi vicini e li invita a normalizzare le
relazioni". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, partecipando in
collegamento video alla cerimonia dell'alzabandiera del traghetto Marshal
Rokossovsky. Rivolgendosi al governatore della regione di Kaliningrad, Anton
Andreyevich Alikhanov, gli ha detto "Vorrei sottolineare ancora una volta che
non abbiamo cattive intenzioni nei confronti dei vicini. Consiglierei loro di
non inasprire le tensioni e di non imporre alcuna restrizione. Stiamo onorando
tutti i nostri obblighi e continueremo a farlo"
12.49 I russi non
fanno "entrare né uscire dalla centrale nucleare colpita"
"Alcuni lavoratori
stanno dentro da 24 ore ma non possono andare via". Lo racconta Alexandra,
dipendente che lavora nell'impianto attaccato stanotte, al telefono col giornale
spagnolo El Pais. "Ieri i responsabili della centrale ci hanno detto che
avremmo potuto lavorare con normalità perché era sotto controllo dell'esercito
ucraino. E' arrivato il turno del mattino e dopo 24 ore loro sono ancora lì, non
li fanno uscire", ha aggiunto.
12.53 Unhcr, Verso
più grande crisi rifugiati in Europa in questo secolo
La decisione senza
precedenti dell'Ue di offrire protezione temporanea ai rifugiati in fuga
dall'Ucraina "fornirà protezione immediata nell'Ue agli ucraini e ai cittadini
di paesi terzi con status di rifugiato o di soggiorno permanente in Ucraina". Lo
rende noto l'Unhcr che esorta gli Stati della Ue ad attuare rapidamente la
direttiva poiché "questa sta rapidamente diventando la più grande crisi di
rifugiati in Europa di questo secolo".
13.36 Zelensky, mai
tanta crudeltà disumana da occupazione nazista
'Le città ucraine
non vedevano una simile crudeltà contro il nostro Paese dall'occupazione
nazista". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo
videomessaggio diffuso tramite Telegram. Zelensky ha quindi accusato la Russia
di aver colpito civili e in particolare ha confermato il bilancio dei 47 morti a
Chernihiv, un bombardamento nel quale hanno perso la vita "civili pacifici".
13.36 Cremlino,
sanzioni occidentali non cambieranno posizione russa
Le sanzioni imposte
dall'Occidente contro la Federazione russa e i suoi cittadini non hanno
possibilità di successo se il loro obiettivo è far cambiare posizione e
abbandonare il piano russo. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
13.50 Il Cremlino
chiama i russi "a unirsi intorno a Putin"
Il Cremlino chiama i
russi a stringersi intorno al presidente Vladimir Putin, al nono giorno
dell'invasione dell'Ucraina. "Non è il momento di dividersi, è il momento di
unirsi. E di unirsi attorno al nostro presidente" ha detto il portavoce del
Cremlino, Dmitri Peskov, nel corso di un incontro con la stampa.
13.56 Nato, prossimi
giorni andranno ancora peggio, con più morti
"Questa è la
peggiore aggressione militare da decenni, con città, scuole, ospedali, edifici
residenziali bombardati, attacchi alle centrali nucleale. I giorni che verranno
probabilmente saranno peggiori, con più morti e più distruzione". Lo dice il
segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza dopo il vertice
straordinario dei ministri degli Esteri Nato.
14.02 Stoltenberg,
'No aerei Nato né truppe su territorio'
"Gli Alleati danno
il loro supporto all'Ucraina, lo stiamo aumentando sotto differenti aspetti. E'
cruciale, è un momento critico per Kiev. La no fly zone è stata menzionata" nel
dibattito "ma non ci sono piani per operare nello spazio aereo ucraino o per
inviare nostre truppe". Lo dice il segretario generale della Nato Jens
Stoltenberg in conferenza stampa aggiungendo che i prossimi giorni saranno
peggio "con più morti, più sofferenza e più distruzione".
14.08 Onu, oggi
riunione d'emergenza Consiglio Sicurezza
Il Consiglio di
sicurezza dell'Onu terrà oggi una riunione d'emergenza sulla guerra in Ucraina.
Lo riferiscono fonti diplomatiche
14.28 Usa, attacco
centrale nucleare è crimine guerra
Attaccare una
centrale nucleare costituisce un crimine di guerra: lo twitta l'ambasciata Usa a
Kiev dopo il blitz russo contro l'impianto ucraino di Zaporizhzhia. "E' un
crimine di guerra attaccare una centrale nucleare. Il bombardamento da parte di
Putin della più grande centrale nucleare europea porta il suo regno del terrore
un passo più avanti"
14.29 Mosca,
'Zelensky ha lasciato l'Ucraina, ora è in Polonia'. Ma Kiev non conferma
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky "ha lasciato l'Ucraina ed è andato in Polonia". Lo
sostiene il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale
Telegram, secondo quanto riferisce la Tass. Non c'è nessuna conferma da parte
ucraina.
14.35 Stoltenberg,
'Usate bombe a grappolo e armi in violazione diritto internazionalè
"Abbiamo visto
l'uso di bombe a grappolo e ci sono state notizie dell'uso di altro tipo di armi
che sarebbero in violazione del diritto internazionale". Lo ha detto il
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, esprimendo il suo
apprezzamento per l'avvio dell'inchiesta da parte del tribunale penale
internazionale. "Putin deve rispondere delle sue responsabilità", ha detto.
14.36 Kuleba alla
Nato, agite ora o sarà troppo tardi
"Agite ora o sarà
troppo tardi". Questo il messaggio del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro
Kuleba, durante il meeting della Nato con gli omologhi degli altri Paesi
dell'Alleanza. "Non lasciate che Putin trasformi l'Ucraina nella Siria - scrive
su Twitter -. Siamo pronti a combattere. Continueremo a combattere. Ma abbiamo
bisogno dell'aiuto concreto e risoluto dei nostri partner, ora".
15.29 Putin a
Scholz: "Nuovo round di colloqui nel fine settimana"
Il presidente russo
Vladimir Putin "ha informato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che Russia e
Ucraina hanno programmato un terzo round di colloqui per questo fine settimana".
Lo ha riferito in una nota il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit
al termine del colloquio telefonico tra Putin e Scholz.
15.49 Kiev: "Fake
news da Mosca, Zelensky è qui"
"Gli occupanti hanno
diffuso un altro falso dicendo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lasciato
il Paese. Non è vero, il presidente è Kiev con la sua gente". Lo scrive sul
proprio canale Telegram la 'Rada', il canale televisivo ufficiale del parlamento
ucraino
15.59 Borrell: "I
russi bombardano scuole e ospedali"
"I russi stanno
bombardando qualsiasi cosa: ospedali, case scuole con molte vittime civili. E'
un modo barbaro di fare la guerra". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante
dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio esteri
insieme con il segretario di Stato americano, Antony Blinken. "Il Consiglio
dell'Onu per i diritti umani manderà presto una missione per esminare le
violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo in Ucraina.
Questa è la guerra
di Putin. E Putin la deve fermare. Noi resteremo uniti nel chiedere che questa
guerra si fermi e si eviti di uccidere persone innocenti", ha aggiunto il capo
della diplomazia Ue.
16.02 Scholz:
"Chiesto a Putin di fermare i combattimenti"
Il cancelliere
tedesco Olaf Scholz ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin e lo ha
esortato "ad interrompere immediatamente tutte le operazioni di combattimento e
a consentire l'accesso umanitario alle aree contese". A renderlo noto è stato il
portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit precisando che il
cancelliere ha espresso forte preoccupazione durante il colloquio con Putin,
durato un'ora.
16.18 Kiev:
"Tribunale speciale per Putin"
I paesi occidentali
devono approvare la creazione di un tribunale speciale per punire Vladimir Putin
per la sua invasione dell'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri
ucraino, stando a Politico.eu. Parlando a un evento online tenuto oggi dal think
tank di politica estera di Chatham House, il ministro Dmytro Kuleba ha affermato
che la Russia ha commesso un "crimine di aggressione" contro l'Ucraina e alla
fine sarà "ritenuta responsabile delle sue azioni". "Lo scopo di questa
iniziativa non è sostituire la Corte penale internazionale o qualsiasi altra
giurisdizione, ma colmare il vuoto esistente nel diritto internazionale e
utilizzare l'esperienza della comunità internazionale e del diritto
internazionale a beneficio delle persone e dell'ordine mondiale", ha detto.
Gli esperti di
diritto internazionale sostengono che è necessario un nuovo tribunale perché la
Cpi ha giurisdizione solo su tre crimini - crimini di guerra, crimini contro
l'umanità e genocidio - ma non sui cosiddetti crimini di aggressione nel caso
della Russia, precisa Politico.eu.. Questo perché Mosca non ha sottoscritto uno
statuto specifico della Cpi in base al quale i paesi si impegnano a non
commettere tali crimini. "Il ricorso alla guerra in Ucraina equivale a un
crimine di aggressione", ha affermato Philippe Sands, professore di diritto
all'University College di Londra.
16.20 Irlanda:
"Prossima settimana nuovo round di sanzioni"
"E' il terzo
consiglio Affari esteri dell'Ue che abbiamo in una settimana e probabilmente ce
ne sarà un altro nei prossimi giorni. Oggi non concorderemo un nuovo pacchetto
di sanzioni ma è chiaramente in arrivo, mi aspetto venga approvato nei primi
giorni della prossima settimana". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri
irlandese, Simon Coveney, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles.
16.22 Kiev:
"Numerosi casi di donne stuprate, serve tribunale"
"Purtroppo abbiamo
numerosi casi di donne stuprate dai soldati russi nelle città ucraine": lo ha
detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un birefing a Londra,
nella sede del think-tank Chatham House.
Kuleba si è quindi
detto favorevole alla proposta di un tribunale speciale avanzata dall'ex premier
britannico Gordon Brown, osservando che "stiamo lottando contro un nemico che è
molto più forte di noi".
16.24 Zelensky:
"Continua dialogo con Michel. Nostro obiettivo è proteggere gli impianti
nucleari"
"Continua il dialogo
con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il nostro compito comune
è proteggere gli impianti nucleari, la produzione e le infrastrutture critiche.
Abbiamo discusso i modi per implementare questa protezione nonché l'aumento
delle sanzioni contro la Russia. Sollevata anche la questione dell'adesione
dell'Ucraina all'Ue". Lo ha twittato poco fa il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky, senza alcun riferimento alle accuse russe di aver lasciato il Paese.
16.43 Milioni
bambini rischiano di rimanere intrappolati in violenze
"A causa
dell'intensificarsi del conflitto 500mila bambini sono stati costretti a
lasciare le proprie case in soli 7 giorni. È una cosa senza precedenti in
termini di portata e velocità. E se le violenze, le munizioni esplosive non si
arresteranno, molti di più lasceranno il paese in tempi molto brevi. E temiamo
che molti altri saranno uccisi". Lo dice James Elder, portavoce Unicef alla
conferenza stampa di oggi al Palazzo delle Nazioni a Ginevra. "Dobbiamo
ricordare - aggiunge - anche coloro che non possono sfuggire ai bombardamenti
che colpiscono l'Ucraina. Decine di migliaia di bambini sono in istituti per
l'infanzia, molti vivono con disabilità. Ci sono poi i bambini malati. Bambini
feriti negli ospedali a Kiev. La loro fuga è molto più complicata e pericolosa".
16.44 Svizzera
amplia sanzioni alla Russia, bloccati conti oligarchi
La Svizzera adotterà
ulteriori sanzioni contro la Russia adeguandole alle ultime misure dell'Unione
europea e congelerà i conti di diversi oligarchi russi. È vietata l'esportazione
di beni che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della
Russia o allo sviluppo del settore di difesa e sicurezza. Inoltre, le
transazioni con la Banca centrale russa non sono più consentite.
16.49 Mosca, Usa e
Gb inviano combattenti stranieri
Gli 007 di diversi
Paesi Nato, tra cui Usa e Regno Unito, stanno utilizzando da settimane come
"base logistica la Polonia" per "trasferire" in Ucraina "armi e combattenti
terroristi stranieri, compresi alcuni dal Medio Oriente". A lanciare l'accusa
sono i servizi di intelligence internazionali russi (Svr), citati dalle agenzie
di Mosca, affermando inoltre che "molti" di questi presunti combattenti sono
stati uccisi.
16.54 Sindaco Kiev,
aiuti stanno arrivando, siete grandi
"Stiamo ricevendo
cibo, pacchi, medicinali. Siete grandi". Lo dichiara in un video postato su
Twitter il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, riprendendo qualcosa come 15
bancali di merce: "Amici di tutto il mondo, vediamo voi e il vostro supporto.
Siete meravigliosi. Continuate ad aiutarci".
16.54 Stoltenberg,
Polonia non pianifica di fornire aerei a Kiev
La Polonia "non sta
pianificando" di fornire aeroplani a Kiev per sostenerla nella guerra contro
Mosca. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in
conferenza stampa, a differenza di quanto si era appreso erroneamente in un
primo momento.
16.58 Usa, "Forze
russe sono a 25 km da centro di Kiev"
Le forze russe sono
a circa 25 chilometri dal centro di Kiev nel nord e rimangono a 10 chilometri
dai centri delle città di Chernihiv e Kharkiv nel nord in Ucraina. Lo rende noto
un alto funzionario della difesa Usa, stando alla Cnn.
17.03 Putin, accuse
bombardamenti città sono "propaganda"
"Nel corso della sua
operazione speciale, l'esercito russo sta adottando tutte le misure possibili
per salvare la vita dei civili e le notizie di presunti bombardamenti di Kiev e
di altre grandi città sono grossolani falsi di propaganda". Lo ha detto il
presidente russo Vladimir Putin nella conversazione telefonica col cancelliere
tedesco, Olaf Scholz, secondo quanto riportato dal Cremlino in una nota.
17.03 Sindaco
Mariupol, siamo senza acqua e sta finendo cibo serve corridoio umanitario
Mariupol è rimasta
senz'acqua, riscaldamento, elettricità e sta finendo anche il cibo dopo cinque
giorni di attacchi russi. Lo denuncia il sindaco della città portuale nel
sud-est dell'Ucraina in televisione, facendo un appello all'apertura di un
corridoio umanitario per evacuare i civili. "Siamo semplicemente distrutti", ha
detto Vadym Boychenko, aggiungendo di aver chiesto un corridoio umanitario per
far uscire i civili dall'area.
17.09 Zelensky a Von
der Leyen, discusse altre sanzioni
"Ho parlato con la
presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, e l'ho informata del
terrorismo nucleare dell'aggressore. Prevenire è il nostro compito comune": così
il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet. Con Von der Leyen,
aggiunge Zelensky, "abbiamo discusso di un rafforzamento delle sanzioni contro
la Russia. All'ordine del giorno c'era anche la questione dell'adesione
dell'Ucraina all'Ue".
17.11 Putin, con
Kiev mercenari da ex Jugoslavia e Siria
In Ucraina, "stiamo
assistendo sempre più alla comparsa di mercenari da Paesi terzi, tra cui Albania
e Croazia, militanti del Kosovo e persino jihadisti con esperienza di operazioni
militari in Siria". Lo ha denunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel
suo colloquio con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz,
17.15 Arrivati in
Italia 9.058 profughi da inizio conflitto
Sono 9.058 i
cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto, lo fa sapere in
una nota il Viminale.
17.17 Save the
Children, 100 bambini uccisi in 24 ore un'onta
"100 bambini uccisi
a Kharkiv in 24 ore sono un'onta per le coscienze di tutto il mondo". A dirlo è
Save The Children. "Ancora una volta sono i più piccoli a pagare il prezzo più
alto della guerra".
17.29 Bbc ritira
giornalisti dalla Russia
La Bbc ha sospeso
temporaneamente il lavoro di tutti i suoi giornalisti e del personale in Russia
dopo che le autorità di Mosca hanno approvato una nuova legge che rende la
diffusione di informazioni "false" un reato punibile con multe o pene detentive
fino a 15 anni di carcere.
17.53 Media, attacco
aereo vicino Kiev, almeno 7 morti
Almeno sette persone
sono morte in un attacco aereo nella regione di Kiev, a Markhalivka. Lo riporta
Sky News. La polizia ucraina ha detto che tra le vittime ci sono anche due
bambini.
18.08 Blinken,
"Guerra potrebbe non finire presto"
"Sappiamo che
purtroppo, tragicamente, questa guerra potrebbe non essere finita presto. Gli
sforzi che stiamo facendo insieme devono essere sostenuti nel tempo". Lo
sottolinea il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a fianco della presidente
Ursula von der Leyen a Bruxelles.
18.10 Bbc, "Molti
russi fuggono dalla Russia in Finlandia"
Molti cittadini
russi stanno lasciando il loro Paese per rifugiarsi in Finlandia, per la paura
di nuove strette del governo di Mosca, compresa la legge marziale, in seguito
alla crisi ucraina. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un flusso costante di
macchine e autobus russi è segnalato alla frontiera di Vaalimaa, circa 200
chilometri a est da Helsinki.
18.25 Kiev, 100
persone potrebbero essere sotto macerie a Borodyanka
Sotto le macerie
delle case a Borodyanka, nella regione di Kiev, potrebbero esserci circa 100
persone. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statali ucraini (Ses). I
soccorritori hanno cercato di raggiungere il luogo dell'incidente, ma sono stati
colpiti dalle truppe russe, ha detto la portavoce del Ses nella regione di Kiev,
Victoria Ruban. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone sotto le
macerie. La cittadina, a pochi chilometri da Kiev, è stata devastata dai
bombardamenti russi anche se l'esercito ucraino è riuscito a respingere
l'avanzata russa.
18.45 G7, subito
corridoi, stop attacchi a centrali nucleari
Una "rapida"
realizzazione di nuovi corridoi umanitari per i profughi in fuga dall'Ucraina,ì
e lo stop agli attacchi da parte della Russia "nelle vicinanze immediate di
centrali nucleari ucraine". E' quanto chiede il G7 nel comunicato finale al
termine della riunione dei suoi ministri degli Esteri.
18.53 Blinken, Usa e
Ue devono mantenere la Russia sotto pressione
Gli Stati Uniti e
l'Unione Europea devono mantenere la pressione sulla russia per porre fine alla
guerra in ucraina, ha affermato a Bruxelles il segretario di stato americano
Antony Blinken.
18.54 G7, crimini
di guerra saranno perseguiti
"Chiederemo conto
ai responsabili dei crimini di guerra, compreso l'utilizzo indiscriminato di
armi contro i civili, e sosteniamo le inchieste e la raccolta di prove, in
particolare da parte del procuratore del Tribunale penale internazionale". Lo
scrivono, a proposito dell'invasione russa dell'ucraina, i ministri degli Esteri
del G7 in una nota congiunta dopo la riunione di oggi a Bruxelles.
19.09 Media, Russia
blocca Facebook
L'Autorità russa per
le comunicazioni ha annunciato il blocco di Facebook in Russia accusando il
social network di "discriminare" i media russi. Lo riporta l'agenzia russa
Interfax.
19.16 Borrell,
possiamo estendere banche escluse da Swift
"Stiamo valutando
quale potrebbe essere un nuovo pacchetto di sanzioni nei prossimi giorni,
potremmo ad esempio allargare il numero di banche escluse dal sistema Swift.
Vedremo, i nostri tecnici ci stanno lavorando". Lo ha dichiarato l'Alto
rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del
Consiglio Affari esteri.
19.48 Borrell, no
fly zone sarebbe uso forza, competenza Nato
"Non spetta al
Consiglio Esteri dell'Ue prendere questo tipo di decisioni, è una questione
della Nato. Quando hai deciso ciò significa che sei pronto a usare la forza con
l'invio di voli per impedire a tutti di volare". Così l'Alto rappresentante Ue
per la politica estera, Josep Borrell, ha risposto a una domanda sull'ipotesi
della 'no fly zonè sul cielo ucraino, nella conferenza stampa al termine del
Consiglio Affari esteri Ue straordinario.
20.04 Sirene suonano
a Kiev: "Andate nei rifugi"
Sirene antiaereo
stanno risuonando in questo momento a Kiev. Lo annuncia sul proprio profilo
Telegram la municipalità della stessa capitale ucraina invitando i cittadini ad
andare nei rifugi.
20.05 Borrell, mondo
è da parte giusta storia, voto Onu lo dimostra
"Il mondo sta con
l'Ucraina, sta dalla parte giusta della storia. Questo voto ha mandato un
segnale chiaro. Oggi il Consiglio diritti umani ha votato di nuovo e stabilito
una commissione indipendente di inchiesta sulla situazione umanitaria e il
risultato è stato molto chiaro: 32 voti a favore, 2 contro, 3 astensioni". Lo ha
affermato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella
conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri Ue straordinario.
"Spero che (le sanzioni) mineranno la macchina da guerra russa. Il presidente
Putin voleva dividerci ma ha raggiunto l'opposto. Siamo più uniti che mai e la
Russia è completamente isolata dalla comunità internazionale come il voto
all'Assemblea generale ha mostrato chiaramente", ha aggiunto.
20.08 Gb lancia
stretta anti Putin, "più poteri per sanzioni"
Il premier
britannico Boris Johnson, come promesso nei giorni scorsi dopo l'invasione russa
dell'Ucraina, lancia una decisa stretta contro il "regime di Vladimir Putin" con
modifiche alla legislazione del Regno Unito al fine di introdurre "nuovi poteri
nel nostro arsenale" per colpire Mosca con le sanzioni. "Il Regno Unito ha
aperto la strada con il pacchetto più duro di sanzioni contro il regime di Putin
e lo stiamo ulteriormente rafforzando", ha detto il primo ministro.
20.24 Blinken,
stabilità Europa a rischio, avanti con sanzioni ma non cerchiamo scontro
"La stabilità
dell'Europa è in bilico, la pace è stata messa in pericolo dall'invasione
russa", Usa e Ue continueranno con le sanzioni ad "alzare il costo" per Mosca
dell'invasione dell'Ucraina ma non "cercheranno mai il conflitto con la Russia".
Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando a
Bruxelles dopo un incontro Nato.
20.29 Attacco aereo
nella regione di Kiev
Ci sarebbero 5 morti
di cui 3 bambini nell'attacco aereo nella regione di Kiev.
20.32 Blinken: Nato
non può attuare no fly zone
"Abbiamo la
responsabilità che la guerra non vada oltre l'Ucraina. La Nato non può attuare
una no fly zone sull'Ucraina perché ciò significherebbe che la Nato dovrà
abbattere gli aerei russi. E il presidente Biden ha detto che non faremo la
guerra con la Russia". Così il segretario di Stato Usa Antony Blinken in
conferenza stampa dopo il Consiglio Esteri straordinario che si è tenuto oggi a
Bruxelles.
20.38 Casa Bianca,
Biden-Putin? non è momento, serve de-escalation
Joe Biden "non
intende avere un coinvolgimento diretto con il presidente russo Vladimir Putin,
non è il momento, serve una de-escalation": lo ha ribadito la portavoce della
Casa Bianca Jen Psaki.
20.43 Macron,
"Garantire sicurezza centrali nucleari"
Il presidente
francese Emmanuel Macron "condanna fermamente qualsiasi attacco all'integrità
delle installazioni nucleari civili ucraine causato dalle forze russe nel corso
della loro aggressione militare contro l'Ucraina. È imperativo garantire la loro
sicurezza e protezione". Lo si legge in un comunicato dell'Eliseo in cui si
ribadisce la "estrema preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare.
20.51 Dopo Facebook,
la Russia blocca anche Twitter
Dopo quello di
Facebook, l'ente regolatore delle Telecomunicazioni in Russia, Roskomnadzor, ha
ordinato anche il blocco di Twitter.
21.15 Casa Bianca,
l'attacco alla centrale nucleare è l'apice dell'irresponsabilità
L'attacco dei russi
a una centrale nucleare in Ucraina ha rappresentato "l'apice
dell'irresponsabilità", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca,
Jen Psaki. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, stanno valutando se la Russia ha
commesso crimini di guerra, ma non sono ancora state tratte conclusioni.
21.33 Di Maio:
"Nato, Ue e G7 lavorano per una soluzione diplomatica"
"Nato, Ue e G7
lavorano per una soluzione diplomatica e pacifica a questa crisi", ha detto il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Tg2 Post. "Oggi si è preso una decisione
importante: non si istituirà la cosiddetta no-fly zone della Nato. L'Ucraina ci
sta chiedendo di far intervenire i nostri aerei e i nostri armamenti per
bloccare i bombardamenti dei russi. Questo da un punto di vista delle loro
richieste è legittimo, ma significherebbe portare in guerra i Paesi alleati,
inclusa l'Italia. E questo non ce lo possiamo permettere perché poi si rischia
veramente una guerra mondiale", ha detto Di Maio. Il ministro ha ricordato che
con le sanzioni "la borsa di Mosca è chiusa da 5 giorni" e questo "è l'unico
modo per convincere Putin a ragionare". L'Italia farà la sua parte e "si
appresta a procedere con la confisca di beni degli oligarchi russi" vicini al
Cremlino "per un valore di 140 milioni di euro".
21.38 Cnn, per il
Pentagono il 92% delle forze russe è in Ucraina
Il 92% delle forze
di combattimento russo preparate per l'invasione sono ora in Ucraina: lo
riferisce la Cnn citando un alto dirigente del Pentagono.
21.47 Gli Stati
Uniti valutano il divieto per l'importazione di petrolio russo
L'amministrazione
Biden sta "cercando dei modi per ridurre l'importazione di petrolio russo", ha
detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Stiamo esaminando le opzioni
che potremmo adottare in questo momento per ridurre il consumo statunitense di
energia russa, ma siamo molto concentrati sulla riduzione al minimo dell'impatto
sulle famiglie", ha dichiarato Psaki ai giornalisti. "Quello che è veramente più
importante è che manteniamo una fornitura costante di energia globale", ha
spiegato.
22.12 Zelensky in
video agli europei: "Sostenete l'Ucraina"
"Non tacete,
scendete in piazza e sostenete l'Ucraina", perché "se l'Ucraina non
sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà". Lo ha detto il presidente
Volodymyr Zelensky in un videomessaggio trasmesso questa sera sugli schermi
nelle piazze di città europee dove si sono svolte manifestazioni contro
l'invasione russa, tra cui Francoforte, Praga, Lione, Tbilisi, Vienna,
Bratislava e Vilnius. "Sostieni l'Ucraina - ha detto Zelensky, citato
dall'agenzia Unian. "Sostieni la nostra libertà. Questa è una vittoria non solo
sull'esercito russo, ma della luce sulle tenebre, del bene sul male".
22.32 Kamala Harris
vola in Polonia e Romania per dimostrare il sostegno Usa
Anche la
vicepresidente Kamala Harris - dopo il segretario di stato Usa Antony Blinken -
vola in Europa, dove visiterà Varsavia e Bucarest dal 9 all'11 marzo, "per
dimostrare la forza e l'unità della Nato e il sostegno degli Usa agli alleati
del fianco orientale di fronte all'aggressione russa", nonché per "evidenziare
lo sforzo collettivo per supportare il popolo ucraino", lo rende noto la Casa
Bianca. Blinken, oggi a Bruxelles, visiterà sino al 9 marzo Polonia, Moldavia e
paesi Baltici.
22.45 Borrell: "Le
sanzioni non puntano a un cambio di regime"
Le sanzioni imposte
alla Russia dalla Ue non mirano ad un cambio di regime a Mosca. Lo ha assicurato
l'Alto rappresentante per la politica estera comune dell'Unione, Josep Borrell,
citato da Cnn. "Le sanzioni non puntano ad un cambio di regime - ha sottolineato
-. Lo scopo è di indebolire l'economia russa, di fare in modo che senta il peso
delle conseguenze della guerra e di rafforzare la posizione degli ucraini ai
prossimi negoziati".
22.52 Zelensky
contro la Nato per il rifiuto della no-fly zone
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato la decisione della Nato di non
istituire una no-fly zone in Ucraina. "Oggi la leadership dell'Alleanza ha dato
luce verde all'ulteriore bombardamento di città e villaggi ucraini, rifiutandosi
di stabilire una no-fly zone", ha denunciato, secondo quanto riporta il
portale Kyiv Independent.
23.01 La Cnn
interrompe le trasmissioni in Russia
"La Cnn smetterà di
trasmettere in Russia, continuiamo a valutare la situazione e i nostri prossimi
passi", ha detto un portavoce dell'emittente statunitense.
23.06 Casa
Bianca: "Assassinare Putin? Non è la nostra posizione"
La Casa Bianca ha
respinto l'appello del senatore repubblicano Lindsey Graham per assassinare
Vladimir Putin. "Questa non è la posizione del governo degli Stati Uniti e
certamente non è una dichiarazione che sentirete arrivare dalla bocca di
qualsiasi persona che lavora in questa amministrazione", ha spiegato la
portavoce Jen Psaki, quando i reporter le hanno chiesto un commento sulle parole
di Graham.
23.16 Bloomberg
sospende l'attività dei suoi giornalisti in Russia
Dopo la Bbc e la
Cnn, anche Bloomberg News ha annunciato la sospensione del lavoro dei suoi
giornalisti in Russia. "Il cambiamento del codice penale, che sembra progettato
per trasformare qualsiasi reporter indipendente in un criminale, rende
impossibile continuare qualsiasi parvenza di giornalismo normale all'interno del
Paese", ha detto il caporedattore di Bloomberg , John Micklethwait,
riferendosi a una nuova legge che rende la diffusione di informazioni "false" un
reato punibile con multe o pene detentive fino a 15 anni di carcere.
(AGI il 4 marzo
2023) - "Stiamo cercando di fermare la guerra che è stata scatenata contro di
noi usando il popolo ucraino". Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov,
ripete la narrativa ufficiale del Cremlino sul conflitto in Ucraina e la sala
scoppia a ridere. E' successo alla conferenza Raisina Dialogue in India, che ha
avuto luogo dopo la riunione ministeriale del G20 a New Delhi.
Lavrov è stato
costretto a interrompere, e poi ripetuto tre volte: la guerra "ha influenzato,
influenzato, influenzato" la politica russa. Il video è stato pubblicato dal
Moscow Times e rilanciato dalla testata indipendente Meduza.
La Repubblica.
Kiev: "Ci vorranno 70 anni per sminare l'Ucraina"
Le truppe di Kiev
sarebbero sul punto di ritirarsi dalla città. La popolazione cerca di scappare.
Il capo del gruppo Wagner avverte: "Indietreggiare farebbe cadere sui mercenari
il peso della sconfitta"
A Bakhmut si
combatte nelle strade: le forze russe accerchiano la città su tre lati, mentre i
civili cercano di fuggire, con l'aiuto dei militari ucraini che starebbero
preparando la ritirata. Secondo la Nato, dall'inizio del conflitto sono
stati uccisi 200mila soldati di Mosca.
00:34
Kiev: dal giorno
dell'invasione 171 casi di violenza sessuale da parte dei russi
In Ucraina sono
stati registrati 171 casi di violenza sessuale dall'inizio del conflitto. Lo
scrive Kyiv Independent citando le parole di Olena Zelenska alla conferenza
United for Justice di Leopoli. Secondo la first lady ucraina il numero di atti
di violenza sessuale da parte delle truppe russe nel Paese indica che tali
crimini sono una politica deliberata dell'esercito di Mosca in territorio
ucraino.
01:16
Trump: "Metterò
fine alla guerra in un giorno"
"Metterò fine
alla guerra in Ucraina in un giorno, andrò d'accordo con Putin": così Donald
Trump alla Cpac, la conferenza dei conservatori alle porte di Washington. "Siamo
nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra
mondiale ma io la eviterò", ha promesso il tycoon, respingendo le accuse di
essere stato troppo soft con Putin durante la sua presidenza.
07:35
Due piloti
ucraini negli Usa: test per addestramento con i caccia
Due piloti
ucraini sono negli Stati Uniti perché le forze armate statunitensi possano
valutare le loro capacità in vista di un possibile addestramento con i caccia
occidentali, tra cui gli aerei da combattimenti F-16. Lo rende noto l'emittente
statunitense Nbc citando due fonti del Congresso e un alto funzionario
dell'amministrazione. Secondo queste fonti, il Pentagono conduce questi test di
addestramento su simulatori in una base militare a Tucson, in Arizona; nei
prossimi giorni arriveranno negli Usa altri otto piloti. I test puntano a capire
quanto tempo sia necessario per eventualmente addestrarli.
08:16
Sale a 13 il
bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia
È salito a 13 il
bilancio dei morti dell'attacco missilistico russo lanciato nella notte tra
mercoledì e giovedì scorsi sulla città di Zaporizhzhia, che ha colpito un
condominio di cinque piani: lo annuncia su Facebook il Servizio di emergenza
statale, come riportano i media nazionali, ricordando che tra le vittime c'è
anche una bambina di otto mesi.
08:17
Media: russi
usano superbomba da 1.500 kg per la prima volta
I russi hanno
usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di
1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una
distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale:
lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della
bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019.
L'ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel
nord dell'Ucraina. Non si conosce quale sia stato l'obiettivo. Lunga 5,05 metri
con un diametro di 40cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di
un'altitudine.
09:42
Kiev: "I russi
perdono 500 uomini al giorno a Bakhmut"
Il ministro della
Difesa ucraino, Oleksi Reznikov, ha assicurato che l'esercito russo sta perdendo
fino a "500 soldati al giorno" nella sua offensiva contro la città di Bakhmut.
"Le perdite dei russi ammontano a 500, tra morti e feriti, ogni giorno", ha
assicurato il ministro ucraino al domenicale del quotidiano tedesco Bild.
Reznikov ha anche aggiunto che Mosca considera i suoi militari "carne da
macello".
La battaglia per
Bakhmut è la più sanguinosa dall'inizio dell'inizio dell'invasione da parte
dell'esercito di Mosca. Le forze russe cercano di conquistarla dal maggio 2022
senza riuscirci. Nelle ultime settimane hanno intensificato gli attacchi,
aiutati anche dagli uomini del gruppo di mercenari Wagner; e la città, da cui
arrivano sporadicamente racconti di disperazione sui civili rimasti e immagini
raccapriccianti, sembra da giorni sul punto di cadere ma ancora resiste.
10:23
Tajani:
"Scongiurare ogni rischio di uso di armi nucleari"
Sull'Ucraina si
deve "cercare di convincere la Russia a venire a più miti consigli e sedersi ad
una tavolo per trattare una soluzione pacifica della crisi in Ucraina.
Naturalmente la pace, per quanto ci riguarda, significa una pace che preveda non
la sconfitta dell'Ucraina, ma il ritiro delle truppe russe". Lo ha detto il
ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tgcom24. "Tutti quanti lavoriamo per
raggiungere l'obiettivo della pace - ha aggiunto -. Vogliamo scongiurare
assolutamente qualsiasi rischio, anche ipotetico, di utilizzo di armi nucleari,
seppur tattiche, quindi limitate ad alcune zone, perché sarebbe una sciagura".
11:40
L'intelligence
britannica: in ucraina i russi combattono anche con le pale
Il comando russo
continua a insistere su azioni offensive, che portano a combattimenti
ravvicinati con la partecipazione della fanteria di Mosca scarsamente
equipaggiata: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo
aggiornamento quotidiano di intelligence.
In particolare,
si legge nel rapporto pubblicato su Twitter, alla fine del mese scorso i
riservisti russi mobilitati hanno dichiarato di aver ricevuto l'ordine di
prendere d'assalto una roccaforte in cemento ucraina armati solo di "armi da
fuoco e pale". Molto probabilmente, commenta il ministero, si tratta di
strumenti di scavo utilizzati dai soldati russi anche per il combattimento corpo
a corpo. La letalità dell'attrezzo da trincea MPL-50 (una pala lunga 50cm, ndr)
in dotazione è particolarmente mitizzata in Russia, ricordano gli esperti di
Londra aggiungendo che questo attrezzo ha subito solo poche modifiche dalla sua
progettazione nel 1869 e il suo continuo utilizzo come arma evidenzia i
combattimenti brutali e la bassa tecnologia che hanno caratterizzato gran parte
del conflitto. I dati recenti suggeriscono un aumento dei combattimenti
ravvicinati in Ucraina, conclude il rapporto osservando che questo deriva
probabilmente dal fatto che il comando russo continua a insistere su un'azione
offensiva composta in gran parte da fanteria a piedi, con un minore supporto di
fuoco di artiglieria perché Mosca è a corto di munizioni.
12:03
Difesa
britannica: "Russi senza munizioni combattono corpo a corpo con le pale
Aumentano in
Ucraina "combattimenti ravvicinati" a causa della scarsità di munizioni a
disposizione delle forze di Mosca, rende noto il ministero della Difesa
britannico, nel suo consueto briefing sull'andamento della guerra. Ai
riservisti russi mobilitati viene imposto di assalire le postazioni ucraine
"armati solo con fucili e pale". Probabilmente pale da fanteria Mpl-50 datate,
oggetti progettati sulla base di un modello non troppo diverdso da quello
introdotto per le forze russe nel 1869. Il loro impiego evidenzia "la natura
brutale e low tech dei combattimenti" che ha caratterizzato gran parte della
guerra. Nei giorni scorsi il capo della Wagner, Evgheny Prigozhin, aveva
denunciato che i suoi mercenari, impegnati in particolare a Bakhmut, non
avevano munizioni.
12:24
Zelensky: "Uniti
per la giustizia"
"Ricorda: cosa
ci permette esattamente di essere uniti ora, uniti per la giustizia. Ogni
persona è importante. Cioè, ogni persona è importante, ogni vita è importante.
Gloria a tutti coloro che proteggono l'Ucraina e l'ordine internazionale sul
fronte legale! Gloria a tutti coloro che ora stanno combattendo per l'Ucraina!":
lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
13:05
Papa Francesco:
"Dio doni la pace a Ucraina martoriata"
Il Papa
all'Angelus ha salutato la comunità ucraina di Milano. "Lodo il vostro impegno
per accogliere i vostri connazionali fuggiti dalla guerra. Il Signore", ha
pregato il Papa, "doni la pace al martoriato popolo ucraino" è tornato a
ripetere.
13:11
Due piloti
ucraini in Arizona per addestramento
Due piloti
ucraini sono in Arizona per addestrarsi con i simulatori di volo, hanno reso
noto fonti militari americane citate dal Guardian, dopo che Kiev ha più volte
chiesto caccia ai Paesi alleati che ancora non hanno risposto. E' il primo
addestramento di questo tipo per i piloti ucraini.
13:24
Il capo del
gruppo Wagner Prigozhin: "Se ci ritiriamo da Bakhmut perdiamo la guerra"
Il capo del
Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è sicuro che un'eventuale ritirata delle sue
truppe dalla città assediata di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, porterebbe al
crollo dell'intero fronte e scatenerebbe l'ira di Mosca, che incolperebbe i suoi
mercenari per la sconfitta contro l'Ucraina: lo afferma lo stesso Prigozhin in
un videomessaggio. "Se PMK Wagner si ritira da Bakhmut, l'intero fronte
crollerà", afferma Prigozhin. Il numero uno di Wagner dice che le autorità
russe incolperebbero i suoi mercenari per le sconfitte nella guerra, dal momento
che una ritirata da Bakhmut "provocherebbe un 'effetto primavera' e le forze
ucraine irromperebbero da tutte le parti nel territorio della cosiddetta
Repubblica Popolare di Lugansk, spazzerebbero via Lugansk, la vicina Sorokyne ed
entrerebbero nel territorio della Russia". La Crimea sarebbe liberata
dall'occupazione russa e si lamenta perché il ministero della Difesa di Mosca
non fornisce al gruppo altre munizioni e detenuti da mandare al fronte.
13:37
Una donna e due
bambini morti in un attacco a Kherson
Le autorita'
ucraine affermano che tre civili sono morti nella regione di Kherson, nel Sud
del Paese, a seguito di un attacco dei russi a colpi di mortaio contro
un'abitazione. "Il villaggio di Poniativka nella regione di Kherson e' stato
colpito da colpi di mortaio", scrive sul suo canale Telegram il capo
dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, denunciando che "i terroristi russi
continuano a uccidere civili". Le vittime sono una donna e due bambini. Per
tutto il giorno, ieri, le forze russe hanno attaccato con la loro artiglieria il
territorio della regione di Kherson in 78 raid
14:25
Ucraina, la
guerra ha già portato alla perdita di 505 infrastrutture culturali
A causa
dell'invasione su vasta scala della Russia, in Ucraina sono già stati distrutte
505 infrastrutture culturali. Lo ha riferito su Telegram il ministero della
Cultura ucraino, citato da Ukrinform. "Un totale di 1.322 elementi di
infrastrutture culturali sono già stati danneggiati a causa dell'aggressione
russa in Ucraina.Quasi un terzo di essi - 505 oggetti - è stato distrutto", ha
affermato. Le infrastrutture culturali hanno subito le maggiori perdite e
danni nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Kherson, Mykolaiv e Lugansk.
Secondo quanto riferito, 101 infrastrutture giovanili sono state distrutte in
Ucraina a seguito dell'invasione.
15:06
I mercenari della
Wagner lanciano il "Club dei patrioti"
Il gruppo
mercenario russo Wagner ha lanciato un club giovanile volto a promuovere il
patriottismo e preparare i giovani russi al servizio militare. Si chiama
Wagneryonok ("piccoli Wagner") e ha sede presso il Wagner Center, quartier
generale con facciata in vetro del gruppo e centro tecnologico, aperto a San
Pietroburgo a novembre.
A guidarlo, il
neolaureato Aleksander Tronin, ex membro del parlamento giovanile di San
Pietroburgo. Attualmente ha 60 membri. Le attività includono l'organizzazione di
eventi patriottici e l'assistenza alle famiglie dei combattenti volontari in
Ucraina. È aperto a ragazzi e ragazze e l'età media di adesione è 18 anni. Il
primo incontro si è svolto il 29 gennaio
15:38
Turchia:
"Lavoriamo per prorogare l'accordo sul grano"
La Turchia sta
lavorando duramente per il rinnovo dell'accordo sul grano del Mar Nero. Lo ha
dichiarato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. L'iniziativa, mediata
dalle Nazioni Unite e dalla Turchia lo scorso luglio, ha consentito
l'esportazione di grano da tre porti ucraini. L'accordo è stato prorogato a
novembre e scadrà il 18 marzo, a meno che non venga concordata una proroga.
"Stiamo lavorando duramente per una corretta attuazione e un'ulteriore
estensione dell'accordo sui cereali del Mar Nero", ha dichiarato Cavusoglu.
All'inizio di questa settimana, la Russia ha dichiarato che accetterà di
estendere l'accordo sul grano solo se si terrà conto degli interessi dei propri
produttori agricoli.
16:07
Ucraina: "I
colloqui per sbloccare la centrale di Zaporizhzhia sono bloccati"
Lo ha dichiarato
il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko, secondo quanto riportato
da Ukrinform. "Attualmente la situazione è bloccata. La nostra posizione, che
stiamo esprimendo su tutte le piattaforme internazionali, è che qualsiasi
negoziato riguardante la centrale nucleare di Zaporizhzhia dovrebbe basarsi su
quanto segue: primo, la smilitarizzazione dell'impianto; secondo, l'uscita dei
lavoratori di Rosatom dalla centrale; terzo, al personale ucraino dovrebbe
essere data l'opportunità di far funzionare l'impianto nucleare senza pressioni.
Ma, in risposta a ciò, abbiamo ricevuto un decreto senza valore da Putin che
dichiara la centrale nucleare di Zaporizhzhia una proprietà federale russa", ha
affermato Galushchenko.
Secondo il
ministro, l'Ucraina sta ricevendo segnali di allarme dalla missione dell'Aiea
presso la centrale nucleare secondo cui i russi si stanno comportando in modo
estremamente poco professionale nell'impianto, e le condizioni delle
attrezzature e delle strutture dell'impianto si stanno notevolmente
deteriorando. "C'è la sensazione che uno degli obiettivi degli invasori sia
lasciarlo a noi in condizioni non operative dopo che l'avremo liberata", ha
aggiunto Galushchenko.
16:13
Vicesindaco
Bakhmut: "Ormai riescono a fuggire in pochi"
Ormai solo
cinque-dieci persone al giorno riescono a lasciare Bakhmut, la città del Donbass
assediata da mesi dalle forze russe in cui vivono ancora in 4500, con solo 5
fra medici e paramedici. Al culmine dell'operazione per l'evacuazione dei
civili, erano 600 ogni giorno a lasciare le case, ha raccontato il vice sindaco
della città, Oleksandr Marchenko a Cnn. "Il nemico fa saltare tutto in aria,
colpisce gli edifici a più piani e i quartieri residenziali. Colpiscono la
città con tutto quello di cui dispongono. Non riusciamo a entrare", ha
spiegato.
16:34
Kiev:
"Controlliamo ancora l'autostrada chiave per Bakhmut"
Le forze ucraine
mantengono il controllo di un'autostrada considerata chiave nella città contesa
di Bakhmut, secondo un vice comandante della Guardia nazionale ucraina, citato
da Cnn. "Le forze armate dell'Ucraina controllano l'autostrada
Bakhmut-Kostiantynivka, è abbastanza stabile", ha detto Volodymyr Nazarenko, del
battaglione Svoboda.
"La situazione
intorno a Bakhmut e alla sua periferia è simile all'inferno, come lo è su tutto
il fronte orientale". L'autostrada Bakhmut-Kostiantynivka è considerata un
percorso cruciale per l'approvvigionamento in città. Secondo Nazarenko, non ci
sono stati "cambiamenti tattici" da parte ucraina: "Stiamo mantenendo la difesa,
il nemico sta cercando punti deboli" ma sta fallendo".
17:05
Kiev, Mosca non
più in grado di sostenere la guerra dopo la primavera
L'economia russa
non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione in Ucraina dopo i
prossimi tre mesi. Lo riporta Ukrinform, citando il capo dell'intelligence
militare ucraina, Kyrylo Budanov: "La Russia ha sprecato enormi quantità di
risorse umane, armamenti e materiali, e la sua economia e la sua produzione non
sono in grado di coprire queste perdite".
Inoltre, aggiunge
Budanov, Mosca "ha cambiato la sua catena di comando militare: se l'esercito
russo fallirà nei suoi obiettivi questa primavera, esaurirà i suoi strumenti di
guerra".
17:26
Ucraina: Mosca,
pronti a rinnovare l'accordo sul grano se equo
La Russia
prolungherà la sua partecipazione all'accordo per l'esportazione di grano
ucraino dal Mar Nero, se tutte le parti coinvolte rispettano i loro obblighi, ha
detto domenica la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
"Se l'accordo è
uguale per tutti, abbiamo sempre adempiuto alla nostra parte e lo faremo", ha
detto Zakharova intervistata dalla tv pubblica. Allo stesso tempo, ha avvertito
che se si tratta di una "truffa" per ottenere "ciò di cui alcuni hanno bisogno e
dimenticare il resto", allora la Russia non parteciperà.
Il capo della
diplomazia russa, Serghei Lavrov, questa settimana ha discusso del futuro
dell'accordo sul grano e del suo collegamento con l'esportazione di prodotti
agricoli russi con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.
18:21
Kiev, ci vorranno
fino a 70 anni per sminare l'Ucraina
Ci vorranno fino
a 70 anni per liberare completamente l'Ucraina dalle mine piazzate per la
guerra. Lo ha riferito il ministero dell'Economia ucraino citato da Ukrinform.
"Lo sminamento
durerà 70 anni con le risorse attualmente disponibili in Ucraina. Pertanto, per
risolvere questo problema nel più breve tempo possibile, è necessario un forte
sostegno da parte dei partner internazionali: finanziario, tecnologico e
organizzativo", si legge in un comunicato.
Secondo la
vicepremier e ministra dell'Economia Yulia Svyrydenko, è necessario creare un
analogo del formato Ramstein per sincronizzare e coordinare gli sforzi per
liberare i territori da mine e ordigni inesplosi.
18:27
Kiev conferma
l'uso della superbomba da parte dei russi
Il portavoce
dell'aeronautica ucraina Yuriy Ihnat ha confermato che la Russia ha utilizzato
per la prima volta nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate sul Paese,
sottolineando che è fondamentale che l'Ucraina riceva i caccia occidentali per
"contrastare questa minaccia".
Lo
riporta Ukrainska Pravda. L'uso della bomba è stato segnalato dal sito
ucraino Defense Express che, citando proprie fonti, aveva riferito che alcune
settimane fa le truppe russe hanno sganciato l'UPAB-1500B nella regione di
Chernihiv, nel nord dell'Ucraina.
19:54
Zelensky, la
battaglia per il Donbass dolorosa e difficile
"Oggi menzionerò
in particolare il coraggio, la forza e l'indomabilità dei soldati che combattono
nel Donbass. Una delle battaglie più dure. Dolorosa e difficile". Lo ha
dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.
"Grazie a tutti i soldati e alle guardie di frontiera che proteggono il nostro
Paese nelle aree di Bakhmut, Vuhledar, Avdiivka, Siver, Svatove, Lyman e
Zaporizhzhia", ha aggiunto.
20:44
Kiev, 'distrutta
torre di osservazione in Russia a Bryansk'
L'unità speciale
"Kraken", che fa parte dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, ha
affermato di aver distrutto la torre di osservazione autonoma "Grenadier", nella
regione russa di Bryansk, con l'aiuto di un drone kamikaze. Lo riporta Ukrainska
Pravda. Bryansk era stata al centro di un'incursione del Corpo dei volontari
russi, un gruppo paramilitare vicino all'esercito di Kiev.
22:14
Scholz:
conseguenze se la Cina invia armi alla Russia
Il cancelliere
tedesco Olaf Scholz ha avvertito che ci saranno "conseguenze" se la Cina invierà
armi alla Russia per la guerra di Mosca in Ucraina.
Alla domanda
della Cnn se immaginava sanzioni alla Cina in caso di aiuti militari alla
Russia, Scholz ha risposto: "Penso che ci sarebbero delle conseguenze, ma ora
siamo in una fase in cui stiamo chiarendo che ciò non dovrebbe accadere, e sono
relativamente ottimista che avremo successo con la nostra richiesta, dobbiamo
essere molto, molto cauti".
22:19
Schlein: "Invio
armi necessario, ma l'ambizione è costruire la pace"
"L'invio di armi
in Ucraina è necessario? Credo sia necessario sostenere il popolo ucraino
rispetto a un'invasione criminale avanzata dalla Russia di Putin, quello che
però ho sempre aggiunto è che non ci può essere sinistra senza l'ambizione di
costruire un futuro di pace, su quel conflitto e chiaramente anche sugli altri
più di 170 conflitti che sono aperti". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del
Pd, ospite di 'Che tempo che fa', su Rai 3. "Non possiamo rinunciare all'idea
che alla fine i conflitti non si risolvono solo con le armi", "vorrei un
protagonismo forte dell'Unione europea, un ruolo diplomatico e politico forte",
ha aggiunto Schlein.
22:33
Kiev: "Distrutte
due basi militari russe a Melitopol"
Le forze armate
ucraine hanno distrutto due basi militari russe a Melitopol, nella regione di
Zaporizhzhia. Ne dà notizia il sindaco della città, Ivan Fedorov, citato da
Ukrinform. Secondo quanto riporta l'agenzia stampa ucraina, sarebbero rimasti
uccisi centinaia di soldati russi.
Cirillo, il
patriarca di Mosca, di tutte le Russie (e di Putin).
Pietro Emanueli il 5
Marzo 2023 su Inside Oveer.
Ogni re ha bisogno
di tre figure: un consigliere, cioè un’eminenza grigia alla Richelieu, un
confessore, ovvero un chierico a metà tra il confidente e lo stratega, e un
vescovo. Vladimir Putin, lo “zar” della nuova Russia, non fa eccezione alla
regola ed è, infatti, circondato da consiglieri e popi ortodossi. Se dei
consiglieri di Putin si scrive di più, dei suoi confessori e vescovi si sa di
meno. E scrivere di questi ultimi equivale a parlare, tra gli altri, di padre
Tichon, del metropolita Hilarion e del patriarca Cirillo.
La lunga ascesa del
Papa russo
Cirillo, al
secolo Vladimir Michajlovič Gundjaev, nasce nella fu Leningrado, l’odierna San
Pietroburgo, il 20 novembre 1946. Cresciuto in una famiglia molto devota e
legata formalmente alla Chiesa ortodossa, da generazioni, Gundjaev è figlio di
un reverendo, fratello minore di un arcivescovo e nipote di un chierico, Vasilij
Gundjaev, che fu imprigionato nel gulag di Soloveckij durante l’era staliniana
per via dell’attivismo a favore della libertà religiosa e contro la
chiesa-fantoccio dell’Ortodossia rinnovata (обновленческая
церковь).
Nonostante
l’ispirazione in casa, in quanto figlio, fratello e discendente di chierici,
Gundjaev ha inizialmente altri piani e lavora come cartografo presso un ente
geologico di Leningrado per tre anni, dal 1962 al 1965, prima di essere
folgorato sulla via di Damasco. L’illuminazione
è accecante: nel
1966, ventenne, Gundjaev abbandona l’esordiente carriera nella geologia per il
Seminario di Leningrado. Da lì, più tardi, l’approdo nell’Accademia teologica di
Leningrado, dalla quale si licenzierà con lode nel 1970.
Nel 1969, alla
vigilia della fine degli studi, Gundjaev viene ufficialmente tonsurato nella
Chiesa ortodossa russa col nome di Cirillo, in memoria di Cirillo il Filosofo, e
ordinato prima ierodiacono e poi ieromonaco. Carismatico, preparato e ortodosso,
nel senso letterale del termine, il giovane Cirillo è la scommessa dell’alta
gerarchia. Lo dimostra il fatto che nel 1971, bruciando le tappe e stupefacendo
i parigrado, viene elevato ad archimandrita in concomitanza con l’assunzione del
ruolo di rappresentante della Chiesa ortodossa russa presso il Consiglio
ecumenico delle chiese.
Tichon, il
confessore di Putin
La scalata ai
vertici della Chiesa ortodossa russa è inarrestabile. Nel 1977 diventa
arcivescovo. Nel 1989 consolida la posizione di portavoce nel mondo della
Chiesa, in quanto nominato presidente del Dipartimento per le relazioni esterne
e membro permanente del Santo sinodo. Nel 1991 viene elevato a metropolita. Nel
1994, segno dell’influenza esercitata e della fiducia in lui riposta dai
superiori, gli viene consentito di inaugurare un proprio programma
televisivo, La parola del pastore, sul popolare Canale uno.
La scalata ai
vertici della Chiesa ortodossa è rapida. Troppo rapida. Gli invidiosi lo
accusano di ruffianeria. I maliziosi, un po’ più lungimiranti, pensano che sia
in odore di complicità con gli apparati securitari, che possa essere un agente
sotto copertura del KGB. La verità, forse, sta nel mezzo: Cirillo avrebbe fatto
carriera perché ritenuto ossequioso dalla gerarchia e perché assoldato dal KGB,
per conto del quale avrebbe operato come agente di influenza nel Consiglio
ecumenico delle chiese – stando a documenti dell’Archivio federale svizzero.
Il patriarca di
Putin?
Nel 2009, alla
morte di Alessio II – anch’egli, a suo tempo, accusato di essere stato al soldo
del KGB –, Cirillo è considerato dagli osservatori il candidato più papabile
all’intronizzazione sul soglio del Patriarcato di Mosca e di tutte le Russie. Un
pronostico profetico: l’insediamento al trono avviene con la benedizione di 508
votanti su 700.
Cirillo si rivela
uno stacanovista. Trascorre il primo anno di pontificato a supervisionare una
riforma della macchina amministrativa della Chiesa ortodossa russa, improntata
sul binomio efficacia-efficienza, che sarebbe stata propedeutica alla
trasformazione delle parrocchie in erogatori di welfare e alla successiva
adozione di una strategia di internazionalizzazione.
La parola
d’ordine dei primi anni di papato è riorganizzazione. Dopo la riforma
strutturale degli organi amministrativi, è il turno del ritorno del Patriarcato
di Mosca nello spazio postsovietico, dall’Ucraina all’Asia centrale, che avviene
di pari passo con il consolidamento dell’intesa con il Cremlino. Cirillo,
per Vladimir Putin, è colui che può riportare la Russia all’antico ruolo di
Terza Roma. E Vladimir Putin, per Cirillo, è un “miracolo di Dio”.
Putinismo, ovvero
la Russia
Tra Cirillo e
Putin, più che un rapporto di mera subordinazione, è un do ut des frequentemente
vantaggioso per entrambi. Putin accontenta il redivivo Patriarcato di Mosca
attraverso l’implementazione di politiche conservatrici, come la legge sulla
propaganda gay, e l’erogazione generosa di danari agli istituti caritatevoli
ortodossi e alle chiese, quando ricostruite e quando rinnovate. Cirillo appoggia
le agende-chiave del Cremlino, dalla lotta all’inverno demografico alla politica
estera, investendole di sacralità e fatalismo.
Più che il “papa
di Putin”, come viene erroneamente (e dispregiativamente) ribattezzato da certa
stampa, Cirillo è un patriarca politico. Nella consapevolezza di essere il
pastore di una “chiesa a sovranità limitata”, come ognuno dei suoi predecessori,
ha fatto della massimizzazione del profitto derivante dall’asse col Cremlino un
obiettivo esistenziale. Memore di cosa è capace un potere ostile – le periodiche
strette anticlericali durante lo Zarato, le persecuzioni durante l’età sovietica
–, che ha preferito riverire anche nei momenti in cui avrebbe potuto/dovuto
essere sfidato. E con orizzonte il Duemila inoltrato – la cristallizzazione del
ritorno alla religiosità dei russi.
Nel 2022,
all’indomani dell’invasione militare dell’Ucraina, la dispensazione di supporto
ideologico al Cremlino, sotto forma di sermoni bellicistici, gli è valsa
l’inserimento nell’elenco dei cittadini russi sanzionati da Canada e Regno
Unito. Una campagna di sanzionamento alla quale avrebbe dovuto partecipare anche
l’Eurocommissione, secondo indiscrezioni circolate nel maggio 2022, in seguito
saltata a causa del veto del governo ungherese.
La visione di
Cirillo
Erroneamente
accusato dalla grande stampa occidentale di essere un ventriloquo e/o un
propagandista del Cremlino, quando invece è il patriarca di una fede millenaria
dotata di un corpo specifico di valori, convinzioni e dogmi, Cirillo ha, molto
più semplicemente, una visione del mondo – e del ruolo che l’Ortodossia russa è
chiamata a giocare – che combacia spesso, ma non sempre, con gli interessi della
classe dirigente.
Estimatore di
Putin, ma lo fu anche Benedetto XVI – che al presidente russo dedicò diverse
righe, con tono simpatetico, nel libro-intervista Ultime conversazioni. Se la
Russia è grande, la Chiesa ortodossa prospera. Se la Russia è vinta, la Chiesa
ortodossa è moritura. Perciò Cirillo ha accettato di (ri)fare del Patriarcato di
Mosca l’instrumentum regni del Cremlino, intravedendo nelle aspirazioni di
grandezza del “miracolo di Dio” l’opportunità di ricristianizzare le masse russe
e di trasformare l’Ortodossia russa in una forza diplomatica di rilievo globale.
Russia Unita, tra
Putin e putinismo
Forte
dell’appoggio di Mosca, bisognosa di un corpo diplomatico parallelo al quale
delegare una parte del faldone della Transizione multipolare, Cirillo ha
potenziato considerevolmente il Dipartimento per le relazioni esterne della
Chiesa, i cui diplomatici in abito talare sono stati inviati in teatri-chiave
per gli interessi nazionali, come Cina, Corea del Nord, Iran, Siria, Vaticano e
Venezuela. Nel nome dell’evangelizzazione al verbo del multipolarismo.
Cirillo verrà
ricordato come un patriarca divisivo, circondato da ombre e al centro di
scandali, ma anche come colui che ha saputo capitalizzare le convergenze
parallele con Putin, non a caso definito un “miracolo di Dio”, facendo di
necessità virtù ovunque e comunque fosse possibile. L’Intesa cordiale tra Mosca
e Pechino trasformata in un’occasione per intavolare un dialogo, anche con
Pyongyang, sulla concessione di maggiori libertà agli ortodossi russi. Il patto
tra Mosca e Vescovato di Roma utilizzato per ravvicinare ortodossi russi e
cattolici, come rammentato da L’Avana 2016, nella speranza di fare fronte comune
contro degli stessi nemici: dalla secolarizzazione al terrorismo. Il
conservatorismo sociale di Russia Unita come mezzo per un fine: il
disseppellimento del mito della Terza Roma.
La Repubblica.
Video shock di un soldato ucraino disarmato e trucidato
Nella notte,
bombe russe hanno colpito edifici residenziali a Kramatorsk. In mattinata,
allarme aereo a Kiev e nel centro del Paese. Uccisi 18 sabotatori russi nella
zona di Kherson
Le forze militari
ucraine hanno distrutto due basi militari russe a Melitopol, uccidendo centinaia
di soldati occupanti. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Ivan Fedorov.
Nelle ultime 24 ore, inoltre, l'esercito di Kiev avrebbe ucciso 18 membri del
gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate russe, che si muovevano
su barche a motore vicino a Kherson.
In Georgia ci
sono stati scontri in parlamento durante la discussione della legge sugli
"agenti stranieri", una normativa di stampo russo. Per le strade migliaia di
manifestanti protestano contro la legge e a favore dell'Europa.
Punti chiave
17:32
Kuleba, atroce
video soldato ucciso, Cpi indaghi crimine guerra
15:13
Kiev: "Uccisi 18
sabotatori russi nella zona di Kherson"
12:19
Georgia, proteste
a Tibilisi contro il progetto di legge di stampo russo sugli agenti stranieri
12:03
Ucraina, Semen
Kryvonos è il nuovo responsabile anticorruzione
12:00
Austin: "La
caduta di Bakhmut non cambia le sorti della guerra"
11:53
Russia, Fsb:
"Sventato un attentato contro l'oligarca Malofeev". È l'editore dei Dugin
10:28
Estonia,
l'europeista Kaja Kallas vince le elezioni
09:43
Ucraina,
Intelligence Gb: "I russi mandano al fronte tank obsoleti"
09:37
Ucraina, il
ministro della Difesa russo Shoigu in visita a Mariupol
09:32
Allarme aereo a
Kiev e nelle regioni centrali dell'Ucraina
09:30
Ucraina, media:
"Bombe russe su Kramatorsk, danneggiati edifici residenziali"
00:58
Kiev, distrutta
torre guardia russa nell'Oblast Bryansk
Il gruppo Kraken,
l'unità delle forze speciali ucraine, ha riferito di aver distrutto una torre di
guardia militare russa nell'Oblast di Bryansk con un drone kamikaze. E' quanto
riporta Kyiv Independent spiegando che la torre di guardia era utilizzata dalle
guardie di frontiera russe per monitorare parte del confine ucraino.
01:38
Scholz a Cnn,
conseguenze se Cina aiuta Russia
Ci sarebbero
"conseguenze" se la Cina inviasse armi alla Russia per la guerra in Ucraina: lo
ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista alla Cnn,
dicendosi però abbastanza ottimista sul fatto che Pechino si asterrà dal farlo.
Alla domanda se potesse immaginare di sanzionare la Cina nel caso aiutasse
Mosca, Scholz ha risposto: "Penso che avrebbe delle conseguenze, ma ora siamo in
una fase in cui stiamo mettendo in chiaro che ciò non deve accadere e sono
relativamente ottimista che avremo successo con la nostra richiesta, ma dovremo
verificare".
09:30
Ucraina, media:
"Bombe russe su Kramatorsk, danneggiati edifici residenziali"
Le forze russe
hanno lanciato la notte scorsa un attacco missilistico sulla città di
Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, distruggendo una scuola: lo riporta
l'emittente statale ucraina Suspilne. Nell'attacco sono stati danneggiati anche
15 edifici residenziali. Per ora non si hanno notizie di feriti o vittime.
09:32
Allarme aereo a
Kiev e nelle regioni centrali dell'Ucraina
Un allarme aereo
a Kiev e nelle regioni centrali dell'Ucraina è stato annunciato questa mattina
dalle autorità, successivamente le sirene hanno risuonato in tutto il Paese,
come riporta l'Ukrainska Pravda citando il monitoraggio del gruppo Belarusian
Gayun su Telegram. Secondo i dati a disposizione, un MiG-31K delle forze russe è
decollato dall'aeroporto bielorusso di Machulishchi
09:34
Ucraina: Kiev:
"Distrutte due basi russe a Melitopol"
Le forze armate
ucraine hanno distrutto due basi militari russe a Melitopol, città ucraina
attualmente sotto il controllo delle forze di Mosca. Lo riporta Ukrinform
citando il sindaco ucraino Ivan Fedorov. "Due potenti esplosioni sono state
udite nei quartieri settentrionali della città. Abbiamo informazioni che due
basi, dove erano di stanza i russi, sono state distrutte", ha dichiarato.
09:37
Ucraina, il
ministro della Difesa russo Shoigu in visita a Mariupol
Il ministro
della Difesa russo Sergei Shoigu, nell'ambito di un viaggio nel Donbass, si è
recato a Mariupol. Lo riporta Ria Novosti. Shoigu - spiega il ministero della
Difesa - ha verificato "lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri degli
edifici e delle strutture in costruzione".
09:43
Ucraina,
Intelligence Gb: "I russi mandano al fronte tank obsoleti"
Per far fronte
alla perdita di veicoli corazzati pesanti, l'esercito russo sta
spostando attrezzature obsolete in Ucraina, in particolare i T-62, cari armati
che hanno 60 anni e che presentano molte vulnerabilità sul campo di battaglia
moderno. E' quanto fa sapere, nel consueto aggiornamento sulla situazione sul
campo, l'intelligence militare britannica. "C'è una reale possibilità che anche
le unità della 1a armata di carri armati della Guardia, considerata la
principale formazione di carri armati della Russia, vengano riequipaggiate con i
T-62 per compensare le perdite".
09:51
Ucraina, Metsola:
"Sono orgogliosa delle nostre scelte, uniti più che mai"
"Sono orgogliosa
delle scelte che abbiamo fatto. Ci siamo uniti come mai prima d'ora". Così la
presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, parla della posizione
europea sull'Ucraina nel suo videomessaggio inviato alla 14/ma riunione plenaria
del network europeo del Corpo della Guardia di Finanza in corso a Roma. "Tutti
abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte", ha sottolineato.
09:59
Kiev: "Nella
notte abbattuti 13 droni russi su 15"
Le forze di Kiev
hanno abbattuto la notte scorsa 13 droni kamikaze Shahed su un totale di 15
lanciati dalle forze russe sull'Ucraina: lo ha reso noto il portavoce
dell'Aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, come riporta Ukrainska Pravda. "I droni
sono stati lanciati dalla direzione nord. Erano droni kamikaze del tipo
Shahed-136 di produzione iraniana. Ne sono stati lanciati 15 e 13 sono stati
distrutti dalla difesa antiaerea e da vari mezzi di fuoco", ha detto Ignat
definendo il lavoro delle forze di difesa "abbastanza buono".
10:14
Mosca: "Tre
missili ucraini su Belgorod, un ferito"
Almeno una
persona è rimasta ferita la notte scorsa in Russia, quando le difese aeree del
Paese hanno abbattuto tre missili sulla regione meridionale di Belgorod, vicino
al confine con l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della
regione, Vyacheslav Gladkov, come riporta la Cnn. "Il nostro sistema di difesa
aerea è entrato in funzione a Novy Oskol. Tre missili sono stati abbattuti. Si
sta chiarendo l'entità dei danni", ha scritto Gladkov. "C'è un ferito: un uomo
che ha riportato ferite da schegge al braccio. Un'ambulanza è già sul posto.
Diverse facciate di edifici e linee elettriche in diversi villaggi del distretto
di Novooskolsky hanno subito danni. Le squadre di soccorso e i servizi di
emergenza sono sul posto", ha aggiunto.
10:28
Estonia,
l'europeista Kaja Kallas vince le elezioni
La premier
estone Kaja Kallas alla guida del Partito riformatore (Er) ha vinto le elezioni
parlamentari nella repubblica baltica con il 31,5% dei voti e si prepara a
formare una nuova coalizione filo-europea per il suo secondo mandato. Una
notizia accolta con soddisfazione dai vertici Ue, con sia il presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, che la presidente dell'Europarlamento,
Roberta Metsola, che si sono congratulati con la premier.
10:44
Ucraina,
filorussi: "10.000 soldati ucraini rimasti a difendere Bakhmut"
Sono 10.000 i
soldati ucraini rimasti a difendere la città di Bakhmut dall'assalto delle
truppe russe. Lo ha detto Ian Gagin, consigliere del capo della autoproclamata
Repubblica filorussa di Donetsk, Denis Pushilin. Lo riferisce l'agenzia Ria
Novosti.
10:51
Cremlino,
Nordstream: "Il destino del gasdotto sarà deciso dagli azionisti"
L'addetto stampa
del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la decisione relativa al futuro del
gasdotto Nord Stream "dovrebbe essere presa collettivamente da tutti gli
azionisti di questo progetto internazionale" a partire da Gazprom. Lo riporta
Ria Novosti.
11:12
Ucraina, i leader
socialdemocratici tedeschi dell'SPD in visita a Kiev
Il leader del
partito tedesco Spd, Lars Klingbeil, e il capo gruppo al Bundestag, Rolf
Muetzenich, sono giunti a Kiev per colloqui con i rappresentanti del governo e
del parlamento ucraini. Lo riportano i media tedeschi.
11:29
Ucraina, Bild:
"Scontro tra Zelensky e Zaluzhny sulla gestione del conflitto a Bakhmut"
E' scontro aperto
tra il presidente Volodymyr Zelensky e il comandante in capo delle forze armate,
il generale Valery Zaluzhny sulle decisioni da prendere su Bakhmut, la città del
Donetsk dove da mesi infuriano sanguinose battaglie. Lo riporta la Bild. Secondo
informazioni provenienti da diverse fonti della leadership politica ucraina,
Zaluzhny qualche settimana fa ha raccomandato di considerare la possibilità di
lasciare Bakhmut per ragioni tattiche. Il capo dello Stato su Bakhmut ha
un'opinione completamente diversa, hanno riferito le fonti alla Bild.
11:53
Russia, Fsb:
"Sventato un attentato contro l'oligarca Malofeev". È l'editore dei Dugin
È sopravvissuto,
illeso, a un attentato contro di lui sventato dai servizi di sicurezza dell'Fsb,
che non ha fatto altre vittime, l'oligarca ultraortodosso e conservatore
russo Konstantin Malofeev, editore della rete tv Tsargrad per cui lavorava la
commentatrice ultranazionalista Darya Dugina uccisa in un attentato lo scorso
agosto, e il padre, l'ideologo dell'euroasismo Aleksandr Dugin che
dell'emittente era stato direttore. La minaccia di azioni di terrorismo non
cambierà le mie idee patriottiche, ha affermato Malofeev, citato dall'agenzia
Tass. "Spero che chi ha organizzato l'assassinio di Dugina sarà scoperto e
arrestato", ha aggiunto il 48enne, inserito nell'elenco delle persone colpite da
sanzioni nell'Unione europea sin dal 2014 per il suo ruolo in sostegno dei
separatisti russi in azione nel Donbass.
12:00
Austin: "La
caduta di Bakhmut non cambia le sorti della guerra"
Bakhmut ha
un'importanza piùsimbolica che operativa e una sua eventuale caduta non darebbe
necessariamente uno slancio allo sforzo bellico di Mosca in Ucraina: lo ha detto
il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, durante la sua visita in
Giordania. "Penso che abbia più un valore simbolico che strategico e operativo",
ha affermato Austin riferendosi alla città assediata. Austin non ha fatto
previsioni su quando - né se - verrà conquistata dalle forze russe, ma ha
aggiunto: "La caduta di Bakhmut non significherà necessariamente che i russi
avranno cambiato le sorti di questa battaglia".
12:03
Ucraina, Semen
Kryvonos è il nuovo responsabile anticorruzione
Il governo
ucraino ha nominato oggi un nuovo responsabile dell'ufficio nazionale per
l'anticorruzione (Nabu), lo riferiscono i media locali. Si tratta di Semen
Kryvonos, in passato a capo della sovrintendenza all' urbanistica. La mossa
rientra negli sforzi di Kiev di mostrate particolare impegno nella lotta alla
corruzione, priorità quest'ultima espressa dall'Ue per l'Ucraina che ambisce
all'adesione.
12:09
Putin sente Raisi
al telefono: "Discussi progetti congiunti"
Il presidente
russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con quello
iraniano Ibrahim Raisi, con il quale ha condiviso un "giudizio positivo" sul
livello e lo sviluppo delle relazioni bilaterali e discusso "la realizzazione di
progetti infrastrutturali congiunti". Lo riferisce il servizio stampa del
Cremlino citato dall'agenzia Interfax.
12:19
Georgia, proteste
a Tibilisi contro il progetto di legge di stampo russo sugli agenti stranieri
Proseguono le
proteste di piazza aTbilisi contro il progetto di legge di stampo russo
sostenuta dal partito al potere Sogno Georgiano in discussione in questi giorni
in Parlamento per l'introduzione di un registro delle organizzazioni considerata
come 'agente di influenza straniera'. Il provvedimento prevede che le
organizzazioni non governative che ricevono finanziamenti dall'estero per oltre
il 20 per cento del loro budget siano inserite nel registro. La Presidente
Salome Zurabishvili ha anticipato che porrà il veto sulla legge, se il
Parlamento la approverà. Critiche al provvedimento sono già arrivate sia dagli
Usa che dall'Ue.
12:51
Dugin sul tentato
attentato a Malofeev: "I terroristi Nato vogliono eliminare gli ideologi del
Rinascimento russo"
Dietro lo
sventato attentato all'oligarca ortodosso, Konstantin Malofeev ci sono "i
terroristi della Nato e i nazisti di Kiev, che vogliono eliminare i principali
ideologi del Rinascimento russo". Così il filosofo russo, Aleksandr Dugin, ha
commentato la notizia che i servizi segreti russi (Fsb) hanno sventato il piano
per uccidere il miliardario a capo del canale ultraconservatore Tsargrad e anche
finanziatore delle milizie filo-russe in Donbass. "La logica dei terroristi
della Nato e dei loro mercenari diretti, i nazisti di Kiev, è comprensibile: la
distruzione dei principali ideologi del Rinascimento russo", ha scritto su
Telegram Dugin, che è stato anche caporedattore a Tsargrad e l'estate scorsa ha
perso la figlia Daria in un attentato vicino Mosca. "Il nostro nemico è astuto,
spietato. Capisce (anche meglio di noi stessi) quanto sia importante il
pensiero", ha sottolineato, "ma la cosa più importante in questa Guerra Santa è
la battaglia delle idee".
13:01
Zakharova: "Il
silenzio degli occidentali sul tentato attentato a Malofeev significherà il loro
tacito consenso"
Il silenzio dei
regimi occidentali sull'attentato al fondatore del canale televisivo Tsargrad,
Konstantin Malofeev, dimostrerà il loro tacito coinvolgimento nel sostenere tali
crimini, ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria
Zakharova. "Il silenzio dei regimi occidentali - di solito iperattivi in ogni
occasione di violenza sui giornalisti - in relazione all'attentato alla vita del
fondatore del canale televisivo Tsargrad Konstantin Malofeev significherà il
loro tacito coinvolgimento nel sostenere tali crimini, così come l'ideologia
delle azioni estremiste dei banditi di Kiev", ha scritto Zakharova sul suo
canale Telegram.
13:20
La Bielorussia
condana Svetlana Tikhanovskaja a 15 anni
Un tribunale di
Minsk ha condannato in contumacia l'ex candidata alle presidenziali e leader
dell'opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaja. La sentenza ha stabilito 15
anni di carcere. Lo riporta l'agenzia ufficiale BelTa.
13:35
Ucraina, Kiev:
"L'esercito rinforzerà le sue posizioni a Bakhmut"
L'esercito
ucraino "rafforzerà" le sue posizioni a Bakhmut, epicentro dei combattimenti con
le truppe russe nell'est del Paese, lo ha dichiarato oggi la presidenza ucraina,
mentre circolano voci secondo cui le forze di Kiev potrebbero ritirarsi dalla
città. I comandanti in capo delle forze armate ucraine "si sono espressi a
favore del proseguimento dell'operazione difensiva e del rafforzamento delle
nostre posizioni a Bakhmut" durante un incontro con il capo di Stato Volodymyr
Zelensky, ha dichiarato la presidenza in un comunicato.
13:48
Ucraina, Kiev non
crede che la Cina fornirà le armi alla Russia
Il ministro della
Difesa ucraino, Oleksi Reznikov, si è dichiarato 'ottimista' quanto al temuto
sostegno militare cinese alla Russia. "Personalmente sono ancora ottimista sul
fatto che non lo facciano", ha dichiarato in un'intervista al portale di notizie
Liga.net, commentando le recenti accuse americane a Pechino. Reznikov ha quindi
ricordato che il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che "la guerra non è
il modo per risolvere i problemi tra stati".
14:26
Prigozhin:
"Wagner non sarà a eventi 8 marzo a San Pietroburgo"
"Per quanto
riguarda l'8 marzo, voglio attirare la tua attenzione sul fatto che si tratta di
un puro falso. Pmc "Wagner" non parteciperà ad alcun evento l'8 marzo a San
Pietroburgo". Lo ha scritto su Telegram il comandante del gruppo
paramilitare Yevgeny Prigozhin, rispondendo a una domanda nella quale gli si
chiedeva conto della possibile presenza della milizia Wagner alle celebrazioni
della ricorrenza. "La questione delle mie ambizioni politiche è stata
ripetutamente discussa", ha aggiunto Prigozhin, "non ho ambizioni politiche, il
nostro compito è combattere e proteggere gli interessi della Federazione Russa".
14:37
Esercitazioni nel
Mar Giappone: un missile russo centra un obiettivo a 1.000 km
Un sottomarino
russo ha lanciato venerdì un missile da crociera Kalibr dal Mar del Giappone: si
trattava di un'esercitazione e il missile ha colpito un bersaglio terrestre a
più di mille chilometri di distanza. Il Ministero della Difesa russo, che
venerdì aveva annunciato le esercitazioni, ha pubblicato un video -riferisce la
Reuters- in cui si vede il missile uscire dall'acqua e poi colpire un bersaglio
in un'area di addestramento nella regione orientale di Khabarovsk in Russia.
15:13
Kiev: "Uccisi 18
sabotatori russi nella zona di Kherson"
Nelle ultime 24
ore, l'esercito di Kiev ha ucciso 18 membri del gruppo di sabotaggio e
ricognizione delle forze armate russe, che si muovevano su barche a motore
vicino a Kherson. Lo riporta Ukrainska Pravda, aggiungendo che secondo il
rapporto del Comando operativo Sud sono stati distrutti anche tre sistemi
missilistici antiaerei, due unità di equipaggiamento ingegneristico, due posti
di osservazione e un deposito di munizioni.
15:41
Video
shock,"russi uccidono prigioniero ucraino disarmato"
L'Ukrainska
Pravda ha diffuso un video shock che mostra l'esecuzione a sangue freddo di un
prigioniero ucraino disarmato da parte delle truppe russe che hanno ripreso la
scena mentre lo insultavano. Le immagini mostrano l'uomo che dice qualche
parola, fa un ultimo tiro di sigaretta e viene crivellato di colpi. Secondo
quanto riporta il quotidiano online ucraino, prima di essere freddato dai
soldati russi, la vittima ha esclamato: "Gloria all'Ucraina".
15:56
Russia,
minacciava di far esplodere ufficio militare vicino Mosca: arrestato
Un uomo in tuta
mimetica è stato arrestato alla periferia di Mosca dopo aver minacciato di far
esplodere un ufficio di reclutamento militare con una bomba a mano. Lo riferisce
il sito indipendente Meduza, citando i canali Telegram dei media Baza e Mash.
Altri media scrivono che l'uomo era fuggito da una base militare. L'arresto è
avvenuto nella cittadina suburbana di Domodedovo. Secondo Mash, la bomba a mano
non sarebbe stata vera.
16:06
Kiev su
prigioniero ucciso, "puniremo ogni crimine di guerra"
Andriy Yermak,
capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha scritto sul suo
canale Telegram che i crimini di guerra sono coltivati in Russia e mascherati
dalla loro propaganda e dai miti "nazisti". "L'omicidio di una persona che è
stata fatta prigioniera ne è un altro esempio", ha commentato Yermak riferendosi
al video shock in cui soldati russi uccidono a sangue freddo un prigioniero
ucraino che lui stesso ha pubblicato su Telegram. "E' anche un esempio della
loro insignificanza e debolezza nazionale. Ogni crimine di guerra sarà punito.
Nessuno schiverà la giustizia. Li troveremo tutti", ha aggiunto.
16:17
Ucraina:
dirigenza Spd tedesca in visita a Kiev
Visita a Kiev per
il co-leader della Spd tedesca Lars Klingbeil e il capogruppo parlamentare dei
socialdemocratici Rolf Mützenich. Durante un incontro questa mattina con il
sindaco di Kiev Vitali Klitschko, Klingbeil ha promesso ulteriori e continui
aiuti all'Ucraina. Lo riporta Tagesschau. Klitschko ha definito la visita un
"segnale incredibilmente importante". I due politici tedeschi incontreranno oggi
ancora rappresentanti del governo e del parlamento ucraini, tra cui il ministro
degli Esteri Dmytro Kuleba. Il vice-ministro ucraino degli Esteri ed ex
ambasciatore in Germania, Andrij Melnyk, ha detto in un'intervista a Dpa di
sperare che i due socialdemocratici si convinceranno della necessità di inviare
caccia da combattimento in Ucraina.
16:20
Tikhanovskaya:
"Mio lavoro per democrazia ripagato con 15 anni di prigione"
"Quindici anni di
prigione. Questo è il modo in cui il regime ha 'ripagato' il mio lavoro per i
cambiamenti democratici in Bielorussa". E' la reazione della leader
dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya alla sentenza di
condanna in contumacia pronunciata oggi da un tribunale di Minsk. "Ma oggi - ha
continuato in un tweet - non penso solo alla mia di sentenza. Penso alle
migliaia di innocenti, detenuti e condannati a vere pene detentive. Non mi
fermerò fino a che ognuno di loro non sarà rilasciato".
16:25
Russia,
preparativi in corso per riunione con ministri Esteri Iran, Turchia e Siria
È in preparazione
un incontro tra i ministri degli Esteri di Russia, Turchia, Siria, Iran. Lo ha
annunciato il rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per
il Medio Oriente e l'Africa, il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov. "Ci
stiamo lavorando", ha detto rispondendo a una domanda dell'agenzia Tass sulla
data e il luogo del prossimo incontro quadripartito. Il vice ministro non ha
rivelato i dettagli dei colloqui. "Posso dirvi che abbiamo concordato di non
rivelare dettagli: questa è una condizione per il lavoro e il successo"
dell'incontro, ha dichiarato.
16:32
Capo Wagner evoca
tradimento, Mosca non ci manda munizioni
Il capo del
gruppo russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, denuncia che non sta ricevendo da Mosca
le munizioni necessarie mentre porta avanti la battaglia per il controllo di
Bakhmut. Potrebbe essere "ordinaria burocrazia o tradimento", è la denuncia di
Prigozhin, di cui riferisce la Bbc. I rapporti tra Wagner e Mosca sembrano
sempre più tesi. Il gruppo, che ha decine di migliaia di soldati in Ucraina, è
diventato una parte fondamentale nella guerra di Mosca. Domenica Prigozhin aveva
riferito che il 22 febbraio erano stati firmati i documenti e le munizioni
dovevano essere inviate a Bakhmut il giorno dopo, ma ha aggiunto che la maggior
parte non era stata spedita e ha poi suggerito che potrebbe trattarsi di una
mossa deliberata.
16:53
Financial Times:
Russia-Iran cauti su missili, timori ripercussioni
La Russia esita
ad acquistare missili balistici dall'Iran per paura che gli alleati dell'Ucraina
a loro volta forniscano a Kiev missili a lungo raggio. Lo scrive il Financial
Times, riportando le valutazioni di alcuni funzionari occidentali. L'Iran ha
inviato centinaia di droni armati in Russia che sono stati utilizzati per
attaccare le infrastrutture civili in Ucraina. Le capitali occidentali ritengono
che Teheran sia aperta a un'ulteriore cooperazione militare con Mosca. Ma
nonostante la necessità di aumentare le proprie forniture, Mosca si è trattenuta
dall'acquisto di missili balistici a lungo raggio dell'Iran, in grado anche di
portare carichi di esplosivo maggiore. Un fattore significativo, secondo le
valutazioni nei Paesi Nato, è stata la minaccia degli Stati Uniti di fornire a
Kiev il sistema missilistico Atacms, la cui gittata di 300 chilometri potrebbe
raggiungere in profondità il territorio controllato dalla Russia. Washington ha
respinto le richieste di Kiev per l'invio di Atacms: il sistema ha quasi quattro
volte la portata dei sistemi missilistici Himars forniti dagli Usa e che
l'Ucraina ha utilizzato con effetti devastanti contro le forze russe. Teheran e
Mosca hanno esplorato la possibilità di uno scambio di armi russe moderne con
missili balistici, ma i colloqui si sono bloccati, hanno detto funzionari e
analisti occidentali, in parte a causa delle potenziali ripercussioni di un
simile accordo per entrambe le parti.
17:06
Condannato
giornalista russo per "fake news" su guerra
Un tribunale
russo ha condannato il giornalista indipendente Andrei Novashov a otto mesi di
servizio sociale per aver diffuso "falsità" sull'esercito russo. Come riferisce
il canale televisivo russo indipendente Dozhd, Novashov - reporter freelance
della regione di Kemerovo, nella Siberia sudoccidentale - è stato il primo
giornalista ad essere perseguito per aver violato la rigida legge russa sulla
censura in tempo di guerra, introdotta poco dopo l'inizio dell'invasione
dell'Ucraina lo scorso anno e che punisce chi "discredita" le Forze armate o
diffonde fake news. Secondo l'accusa, Novashov ha infranto la legge, ripostando
un articolo sull'assedio di Mariupol scritto dalla giornalista russa Victoria
Ivleva sul social media russo VKontakte. "Mi rifiuto di etichettare il nero come
bianco. Fin dall'inizio della cosiddetta operazione militare speciale l'ho
considerata un crimine contro il popolo ucraino", ha detto Novashov nella sua
dichiarazione conclusiva in aula. "Tutto ciò che viene detto nei post di cui
sono accusato di pubblicare è vero", ha aggiunto. Il tribunale ha anche vietato
a Novashov di pubblicare materiale online per un anno intero.
17:15
Ucraina: "Russia
presidente Consiglio di sicurezza Onu ad aprile, bisogna fermarlo"
L'Ucraina vuole
impedire che la Russia assuma in aprile la presidenza di turno del Consiglio di
sicurezza dell'Onu, come da calendario previsto. "La notte dell'invasione russa
(il segretario generale dell'Onu) Antonio Guterres parlò del 'giorno più triste
del suo mandato'; ma il giorno più triste sarà il primo aprile 2023 quando, a
meno che non prevalga la giustizia, la Russia assumerà la presidenza del
Consiglio di Sicurezza. Basta violentare la giustizia e calpestare la Carta Onu!
Devono renderne conto!", ha twittato l'ambasciatore ucraino presso l'Onu, Sergiy
Kyslytsya.
Il diplomatico si
dice consapevole del fatto che la decisione sulla presidenza del Consiglio Onu
non competa a Guterres e si appella ai membri del Consiglio perché intervengano,
in modo che la Russia subisca "le conseguenze dell'aggressione". Kyslytsya ha
allegato al suo tweet una immagine del documento con la lista dei prossimi
presidenti di turno, dove il nome della Russia e la foto del suo
ambasciatore Vassily Nebenzya appaiono macchiati di sangue.
17:32
Kuleba, atroce
video soldato ucciso, Cpi indaghi crimine guerra
"Il video
orribile che mostra un prigioniero di guerra ucraino disarmato che viene
giustiziato dalle forze russe semplicemente per aver detto 'Gloria all'Ucrainà è
l'ennesima prova che questa guerra è un genocidio". Lo ha scritto su
Twitter Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, precisando che "è
imperativo che il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan avvii
un'immediata indagine su questo atroce crimine di guerra. I colpevoli siano
assicurati alla giustizia".
17:38
Russia,
Transparency International dichiarata "indesiderata"
In Russia il
gruppo globale anticorruzione Transparency International è stato bollato come
"indesiderato" dalla procura generale, vietando di fatto all'organizzazione di
operare nel Paese. Mentre "agisce formalmente come un'organizzazione che
combatte la corruzione in tutto il mondo, interferisce negli affari interni
della Federazione Russa, il che rappresenta una minaccia per le fondamenta
dell'ordine costituzionale e la sicurezza della Federazione Russa", afferma la
procura. Il gruppo, con sede a Berlino conosciuto soprattutto per l'indice
annuale che classifica i Paesi, compresa la Russia, in base al loro grado di
corruzione.
18:01
Premier Kiev
ringrazia leader Spd e chiede invio altre armi
"Felice di aver
dato il benvenuto ai leader dell'Spd, Lars Klingbeil e Rolf Mützenich, a Kiev.
Li ho ringraziati per il supporto della Germania all'Ucraina. Ho sottolineato la
necessità di ulteriori consegne di armi che accelereranno la nostra vittoria e
la fine della guerra. Oggi il sostegno all'Ucraina è un investimento per la
sicurezza dell'Europa". Così su Twitter il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.
18:25
Ucraina,
comandante forze di terra in visita a Bakhmut
Il comandante
delle forze di terra ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi si è recato ieri in
visita a Bakhmut dove ha visitato i militari impegnati nella resistenza
all'offensiva russa da agosto alla periferia della città, ha reso noto il
ministero della difesa. "I combattimenti hanno raggiunto i livelli più elevati
di intensità. Il nemico ha fatto arrivare altri mercenari Wagner. I nostri
soldati stanno coraggiosamente difendendo le loro posizioni a nord, cercando di
evitare che la città sia circondata", ha spiegato.
18:46
"Via Tchaikovsky
da Conservatorio", polemica a Kiev
Lasciarlo o
rimuoverlo? Questa è la domanda che ha scatenato un acceso dibattito in Ucraina
sull'uomo a cui è intitolato il Conservatorio di Kiev: il compositore
russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Come riporta Radio Free Europe, sulla scia
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli studenti dell'Accademia
nazionale di musica Tchaikovsky, precedentemente nota come Conservatorio di
Kiev, da mesi chiedono, senza successo, la rimozione del nome del compositore
russo dall'istituzione. Mentre la proposta degli studenti ha ricevuto il
sostegno del governo ucraino, che vede anche Tchaikovsky come uno degli
strumenti del progetto imperialista del Cremlino, i dirigenti del Conservatorio
hanno bocciato la mozione e deciso di mantenere il nome. Il dibattito si colloca
sullo sfondo delle misure per "de-russificare" l'Ucraina, dopo l'invasione
ordinata da Vladimir Putin, un anno fa.
19:17
Nato, a Bakhmut
morti 5 soldati russi ogni ucraino
Le forze armate
russe hanno perso cinque uomini ogni soldato ucraino ucciso a Bakhmut. E' la
stima dell'intelligence della Nato stima che per ogni soldato ucraino ucciso
difendendo Bakhmut, come ha detto alla Cnn un funzionario militare dell'Alleanza
a condizione di anonimato. L'Ucraina ha tuttavia registrato perdite
significative nella difesa della città, riferisce la Nato.
19:41
Cambio ai vertici
dei servizi, Zelensky licenzia vicepresidente
Volodymyr
Zelensky ha licenziato Oleksandr Yakushev, vicepresidente dei servizi segreti
di Kiev (Sbu). Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, tra i vertici
silurati dal presidente ucraino ci sarebbero anche due capi dei dipartimenti dei
servizi speciali e i capi dei servizi di sicurezza di due regioni. In
particolare, sono stati licenziati il capo del dipartimento per la protezione
dei segreti di Stato della Sbu, Igor Nosok, e il capo del dipartimento per il
sostegno economico, Alexander Provotorov. Oleg Khramov è già stato nominato al
posto di Nosok. Zelensky ha anche licenziato due capi di dipartimento: Boris
Bezrukiy, nella regione di Zaporizhzhia, ed Eduard Fedorov, nella regione di
Sumy.
20:03
Kiev, militari
d'accordo, continuare difesa Bakhmut
C'è "consenso"
all'interno dell'esercito ucraino, sulla volontà di continuare a difendere la
città contesa di Bakhmut: lo ha detto il portavoce della presidenza Mykhaylo
Podolyak. "C'è consenso fra i militari sulla necessità di continuare a difendere
la città "C'è un consenso tra i militari sulla necessità di continuare a
difendere la città e a perseguire il logoramento delle forze nemiche, mentre si
costruiscono... nuove linee di difesa nel caso in cui la situazione cambi".
20:09
Mosca, Usa
rifiutano visti per nostra delegazione all'Onu
Mosca denuncia il
rifiuto degli Stati Uniti a concedere i visti per l'ingresso di una delegazione
russa che avrebbe dovuto partecipare a una sessione dell'Onu sulla tecnologia
del'informazione. "Gli Stati Uniti - ha accusato la rappresentante russa alle
Nazioni Unite, Irina Tiazhlova - ancora una volta, senza fondamento, in aperta
sfida, hanno negato la concessioni dei visti a membri di una delegazione russa.
Questa è una violazione grave da parte di Washington dei suoi obblighi di
garantire il lavoro delle istituzioni internazionali centrali dell'Onu",
ospitate dagli Stati Uniti. Tiazhlova si è detta fiduciosa nella capacità della
comunità internazionale di distinguere tra chi sta "politicizzando" il foro
sulle tecnologie dell'informazione e chi è "realmente impegnato a sviluppare
soluzione universali". La rappresentante russa, citata dalla Tass, ha fatto
sapere di essersi messa in contatto con il segretario generale dell'Onu per
chiedergli di "prendere misure per fermare queste pratiche".
20:15
Casa Bianca,
fornitura F-16 non è sul tavolo
La questione
della fornitura dei caccia F-16 all'Ucraina "non è sul tavolo". Lo ha ribadito
la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.
20:45
Zelensky: "Gloria
all'eroe!Gloria all'Ucraina!"
"Gloria all'eroe!
Gloria agli eroi! Gloria all'Ucraina!". Così su Twitter il presidente
dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, una scritta bianca su sfondo nero. Un post che
sembra una risposta al video shock che circola sui social media e che mostra
quella che appare essere l'esecuzione di un prigioniero ucraino da parte di
soldati russi.
21:22
Tajani, condanna
Tikhanovskaya ennesimo atto ingiustizia
"La condanna a 15
anni in contumacia a Svetlana Tikhanovskaya è l'ennesimo atto di ingiustizia
perpetrato dal regime in Bielorussia. Siamo al fianco di Tikhanovskaya e del
popolo bielorusso nella battaglia di libertà e democrazia, a tutela dei diritti
civili e politici". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio
Tajani.
21:51
Podolyak: "A
Bakhmut obiettivo raggiunto, successo strategico"
A Bakhmut l'esercito ucraino ha "raggiunto i suoi obiettivi al mille per mille",
è stato "un grande successo strategico". Lo ha detto il consigliere del
presidente ucraino Volodymyr Zelensky Mykhailo Podolyak, dicendo che nel
difendere Bakmut Kiev vuole guadagnare tempo per ricostituire le sue forze e
infliggere pesanti perdite agli eserciti russi. "Per quanto riguarda la difesa
di Bakhmut, ha raggiunto i suoi obiettivi del 1000%. I militari hanno attuato il
piano per distruggere il principale gruppo nemico pronto al combattimento da un
lato e hanno consentito l'addestramento di decine di migliaia di truppe ucraine
per prepararsi a un contrattacco dall'altro", ha affermato Podolyak. "Anche se
la leadership militare a un certo punto decidesse di ritirarsi in posizioni più
favorevoli, la difesa di Bakhmut sarà un grande successo strategico per le forze
armate ucraine come base per la vittoria futura", ha aggiunto.
Guerra in
Ucraina, russi senza munizioni all’assalto con le pale: a Kiev scontro tra
Zelensky e il capo delle forze armate.
Carmine Di
Niro su Il Riformista il 6 Marzo 2023
Avanzano verso la
conquista di Bakhmut con un costo in vite umane sempre più alto, ma per Mosca
quello dei morti sul campo non è l’unico problema. Il conflitto in corso da
oltre un anno in Ucraina sta costando carissimo al Cremlino e all’economia
russa, stritolata dalle sanzioni in particolare proprio nel settore della difesa
e delle armi, e in quello tecnologico.
Così, come
evidenzia un report dell’intelligence britannica, i combattenti russi in prima
linea sul fronte del Donbass devono fare i conti con un numero sempre più esiguo
di armamenti adeguati. Una circostanza che da settimane è al centro degli
scontri tra il capo della milizia Wagner Evgeniy Prigozhin contro i vertici
della Difesa russi, in particolare il ministro Shoigu, accusato di aver lasciato
i suoi mercenari senza munizioni.
Alle ‘bordate’ di
Prigozhin seguono ulteriori conferme, questa volta da Londra. A causa delle
perdite di veicoli corazzati nel corso della “operazione militare speciale” in
corso ormai da oltre un anno, l’esercito russo è costretto ad utilizzare carri
armati e veicoli blindati sempre più obsoleti.
In particolare,
si parla dei carri armati T-62, prodotti negli anni Sessanta, in epoca
sovietica, di cui circa 800 sono stati rimossi dai magazzini dal 2022 e alcuni
dei quali sono stati modernizzati con nuovi sistemi di puntamento che potrebbero
aumentarne l’efficacia durante la notte. Sui campi di battaglia ucraini sono
stati avvistati inoltre per la prima volta anche i veicoli blindati russi BT-50,
un “reperto archeologico” militare fabbricato nel 1954.
Anche la 1a
Armata corazzata di guardia russa, considerata la principale unità corazzata
dell’esercito russo, potrebbe ricevere T-62 come sostituti per le perdite
subite. Il piano originale del Cremlino e del ministero della Difesa russo era
di fornire a questa unità i nuovi carri T-14 “Armata”, progetto per ora
accantonato.
Sempre
l’intelligence di Londra in un suo aggiornamento sul conflitto di domenica ha
riferito anche di un episodio che ha del clamoroso. Gli 007 britannici
sostengono infatti che alcuni riservisti russi lamentano di essere stati mandati
all’assalto di un bunker ucraino con l’ordine di combattere soltanto “con armi
da fuoco e pale”, un ulteriore segnale delle difficoltà di Mosca nel reperire
munizioni per i soldati impegnati sul fronte.
Lo scontro a Kiev
Ma difficoltà
sono evidente anche sull’altro fronte, quello ucraino. La questione chiave, da
settimane a questa parte, è la strenua difesa di Bakhmut, ormai più per ragioni
simboliche che per la sua reale importanza strategica per un eventuale
rovesciamento dell’esito della guerra.
Proprio sulla
città del Donbass sarebbe in corso uno scontro tra il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky e il comandante in capo delle forze armate, il
generale Valery Zaluzhny. Oggetto del contendere appunto le decisioni da
prendere sulla difesa di Bakhmut: la Bild, che cita informazioni provenienti da
diverse fonti della leadership politica ucraina, scrive oggi che Zaluzhny
qualche settimana fa ha raccomandato di considerare la possibilità di lasciare
Bakhmut per ragioni tattiche.
Di tutt’altra
opinione invece il presidente Zelensky, che sulla difesa di Bakhmut ha
un’opinione completamente diversa. Quasi in ‘risposta’ all’indiscrezione
filtrata sulla Bild, la presidenza ucraina con un comunicato pubblicato sul
proprio sito web ha invece sottolineato che in una riunione tra Zelensky,
Zaluzhny e il comandante del gruppo di truppe operativo-strategico Khortytsia,
Oleksandr Syrsky tutti si sono espressi a favore del proseguimento della difesa
di Bakhmut.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
(ANSA il 7 marzo
2023) Se gli Stati Uniti non "frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci
saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche
conseguenze?" E' il monito del ministro degli Esteri cinese Qin Gang, per il
quale "contenimento e repressione non renderanno grande l'America e non
fermeranno il rinnovamento della Cina". Qin, in un briefing, è ritornato sul
pallone aerostatico transitato di recente sul territorio americano (come
"incidente inaspettato") e abbattuto. Gli Usa "hanno agito con una presunzione
di colpa, reagito in modo eccessivo, abusato della forza e drammatizzato
l'incidente", ha aggiunto.
(ANSA il 7 marzo
2023) Pechino "non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto
ucraino. La Cina non è l'artefice della crisi, né una parte direttamente
interessata. Perché minacciare allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente
accettabile". Il neoministro degli Esteri, Qin Gang, nel suo primo briefing con
i media a margine dei lavori parlamentari annuali, ha accennato a "una mano
invisibile" che sembra sostenere una crisi prolungata. "E' una tragedia che
poteva essere evitata: la Cina sceglie la pace sulla guerra, il dialogo sulle
sanzioni" e la de-escalation all'escalation", ha notato ancora Qin sul conflitto
tra Russia e Ucraina.
La questione di
Taiwan "è il fulcro degli interessi centrali della Cina, il fondamento politico
nelle relazioni Cina-Usa e la prima linea rossa che non deve essere superata".
Il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, nel suo primo briefing a margine
della sessione annuale del parlamento, ha assicurato che. "continueremo a
lavorare per la riunificazione pacifica, ma ci riserviamo il diritto di prendere
tutte le misure necessarie. Nessuno dovrebbe mai sottovalutare la ferma
determinazione, la forte volontà e la grande capacità del governo e del popolo
cinesi di salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale".
Il rapporto tra
Cina e Russia si basa sui principi "di non alleanza, non confronto e non presa
di mira di terze parti". Il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, nella sua
prima conferenza stampa a margine della sessione annuale del parlamento, ha
osservato che se i due Paesi "lavorano insieme, il mondo avrà una forza
trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni
internazionali", mentre "l'equilibrio strategico globale e la stabilità saranno
meglio garantiti". Una relazione che, proprio perché "non minaccia alcun Paese,
non è soggetta ad alcuna interferenza o discordia seminata da terzi". (ANSA)
La Cina minaccia
gli Usa: “Cambino linea o ripercussioni catastrofiche”.
Martina Melli su
L’Identità l’8 Marzo 2023
Dopo l’incidente
diplomatico dei palloni aerostatici abbattuti dai caccia americani, sale ancora
la temperatura tra Pechino e Washington.
Il nuovo Ministro
degli Esteri, Qin Gang, che fino a tre mesi fa era ambasciatore della Cina negli
States e dunque punto di convergenza tra diplomazia asiatica e americana,
durante la sua prima conferenza ufficiale ha usato parole particolarmente
aggressive nei confronti della controparte occidentale. “Se gli Usa non si
fermano e vanno avanti su questa rotta, ci saranno sicuramente conflitti e
scontri”, ha tuonato il ministro riferendosi alla crescita economica e
all’affermazione della Cina in quanto superpotenza mondiale. “Chi ne pagherà le
catastrofiche conseguenze?”.
Non solo minacce:
Qin Gang ha delineato l’agenda di politica estera per i prossimi anni,
presentando la Cina e le sue relazioni con la Russia come un faro di forza e
stabilità, e gli Stati Uniti e i loro alleati come fonte di tensione e
conflitto.
Qin ha difeso la
vicinanza tra Cina e Russia, una relazione costantemente monitorata
dall’Occidente alla luce della guerra in Ucraina. “Più il mondo diventa
instabile, più è imperativo per Cina e Russia far progredire le proprie
relazioni”.
Secondo il Ministro,
gli Usa vogliono surclassare la Cina, non attraverso un conflitto diretto “ma
attraverso il contenimento e la soppressione a tutto campo, un gioco al massacro
in cui tu muori e io vivo”. Una politica che, però, “non renderà grande
l’America e non fermerà il rinnovamento della Cina”.
Le dichiarazioni di
Qin sono in linea con un recente discorso di Xi Jinping ai delegati, in cui il
leader ha denunciato la cosiddetta “soppressione”guidata dagli Stati Uniti. I
rapporti col Congresso si sono deteriorati bruscamente negli ultimi anni e gli
sforzi per ripararli sono deragliati all’inizio di quest’anno, quando il
Pentagono ha dato l’ordine di abbattere il presunto pallone spia che volava nel
loro spazio aereo. La Cina insiste si sia trattato di un incidente e punta il
dito contro la reazione bellicosa ed eccessiva degli americani. Qin insomma,
ritiene gli Usa responsabili di aver incrinato i rapporti, in particolare con la
vicenda del pallone, le tensioni su Taiwan, gli equilibri nell’Indo-Pacifico, la
guerra commerciale e la guerra in Ucraina. Per il Ministro, infatti, la guerra
in Ucraina sembra essere stata guidata da “una mano invisibile, una mano che
l’ha usata per servire agende geopolitiche più alte”, avallando il protrarsi e
l’escalation del conflitto.
La Cina si è
inizialmente presentata come pacificatrice nello scontro, ma ha, in pratica,
sempre sostenuto la Russia. Qin non ha risparmiato alcuna critica, alludendo
anche al fatto che gli Stati Uniti, strenuamente “a difesa” della sovranità e
dell’integrità territoriale dell’Ucraina, stanno in realtà agendo con grande
ipocrisia. Esempio: quando accusavano la Cina di prendere in considerazione
l’armamento della Russia mentre loro già armavano Taiwan. “La questione di
Taiwan è il fondamento delle basi politiche delle relazioni USA-Cina e la prima
linea rossa che non deve essere attraversata nei rapporti diplomatici”, ha
affermato.
La conferenza stampa
di Qin ha infine esposto i piani di politica estera rispetto al nuovo mandato
politico quinquennale, iniziato con la riconferma di Xi come leader del Partito
comunista cinese nell’ottobre dello scorso anno, e con nuove nomine governative
che saranno annunciate questa settimana. Qin ha evidenziato il ruolo della Cina
come polo di stabilità e prosperità globale, ispirando la modernizzazione, in
particolare nel sud del mondo. Ha detto che i risultati della Cina “sfatano il
mito che la modernizzazione è occidentalizzazione”. Ha concluso dicendo che la
Repubblica Popolare potrebbe offrire soluzioni ai grandi temi e alle grandi
sfide, se solo non fossero sempre gli stessi a “monopolizzare il microfono”.
La «mossa delle
super stampanti»: così è partito l’embargo tecnologico di Europa e Usa contro la
Cina di Xi.
Federico Rampini su Il Corriere della Sera il 9 Marzo 2023.
L’Olanda ha
annunciato lo stop all’export delle stampanti per la produzione di chip in Cina:
insieme a Usa e Giappone, che già hanno aderito al piano, è l’unico Paese a
produrle. Che cosa c’è dietro il tentativo di ridurre Xi Jinping alla «dieta
paleo»
Si capisce perché Xi
Jinping da tempo alza i toni contro un’America che lui accusa di voler
«contenere e schiacciare l’ascesa della Cina».
Joe Biden,
sfruttando anche madornali errori di Pechino (ultimo l’appoggio a Putin in
Ucraina) sta riuscendo in un’impresa che sembrava impossibile pochi anni
fa: compattare l’Occidente per stendere un cordone sanitario attorno alla Cina
nelle tecnologie avanzate.
Gli europei si
stanno allineando sempre più sulla strategia di Washington.
Due novità di questi
giorni, in Olanda e in Germania, confermano un dato che per Xi è una
sconfitta: la «perdita dell’Europa», con la quale lui sperava di mantenere dei
buoni rapporti a prescindere dal deterioramento con gli Stati Uniti.
Dividere l’Unione
europea dagli Stati Uniti era un suo imperativo strategico, che ora sembra
allontanarsi.
Anche il Giappone si
sta muovendo in stretta sintonia con il blocco occidentale, ed è un altro
partner fondamentale per la stretta sulle forniture di tecnologie avanzate.
L’Olanda ha appena
deciso di varare una serie di restrizioni sull’export hi-tech alla Cina. La
mossa del governo dell’Aia era prevista da tempo, ma la sua conferma ufficiale è
una vittoria sostanziale per Washington. I Paesi Bassi sono la sede della
società Asml, una delle sole tre aziende mondiali che fabbricano «stampanti per
micro-chip» di tipo molto avanzato.
Un altro produttore
è il Giappone, che sta aderendo alla stessa strategia americana.
Questo significa
che l’industria cinese dei semiconduttori si vede privata dei macchinari di
nuova generazione, indispensabili per adeguare la qualità e la potenza dei
microchip che sforna dalle sue «fabs» (così si chiamano in gergo gli impianti di
produzione dei semiconduttori, le memorie e circuiti integrati che rappresentano
il sistema nervoso di ogni apparecchio elettronico e digitale).
L’adesione di Olanda
e Giappone è decisiva perché l’embargo americano sia davvero efficace nel
rallentare e ritardare l’avanzata cinese nei settori di punta. Si aggiunge alle
politiche industriali (i sussidi statali del Chips Act) con cui
l’Amministrazione Biden sta riportando sul proprio territorio una parte della
produzione di semiconduttori. Tra coloro che si sono fatti attrarre dal mix di
aiuti pubblici e pressioni politiche c’è il numero uno mondiale di questo
settore, la taiwanese Tsmc che sta investendo 40 miliardi di dollari nella
costruzione di un nuovo stabilimento in Arizona.
L’altra vittoria
strategica di Biden che sta maturando in questi giorni viene dalla Germania. Il
cancelliere Olaf Scholz starebbe per costringere i grandi operatori telefonici
tedeschi (Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica) a disfarsi delle
infrastrutture «made in China» che avevano comprato da Huawei e Zte per
prepararsi al passaggio verso il 5G, la linea telefonica-Internet di quinta
generazione. Il passo è drastico, perché il 59% delle reti 5G installate in
Germania sono di provenienza cinese.
Questo significa che
Scholz si è convinto della giustezza degli allarmi americani, sul rischio che il
5G diventi il cavallo di Troia per un sistematico spionaggio cinese in Europa.
Che cosa sta
spingendo gli europei verso l’allineamento con gli Stati Uniti? Un mix di
ragioni, analizzate anche dal sito Politico (un sito che nacque negli Usa ma
adesso è di proprietà tedesca e sta diventando una fonte sempre più preziosa di
notizie sull’Europa).
In primo luogo ci
metterei un sincero convincimento sulla strategia antagonista della Cina. Così
come gli americani iniziarono ad aprire gli occhi sul finire della presidenza
Obama e durante l’Amministrazione Trump, ora anche gli europei sono diventati
più pessimisti sulla pericolosità di Xi Jinping. La pandemia e l’Ucraina non
hanno fatto del bene all’immagine del governo cinese: tra bugie sanitarie e
appoggio a Putin, gli atti di Pechino hanno spinto l’Unione europea nelle
braccia di Washington. In generale questo allineamento di Olanda e Germania con
gli Stati Uniti su dossier strategici per le relazioni con la Cina s’inserisce
nel contesto di una ritrovata coesione dell’Occidente, uno dei «frutti
avvelenati» che la coppia Putin-Xi raccoglie dalla guerra in Ucraina.
L’altra
interpretazione che avanza Politico riguarda invece i do-ut-des che vengono
negoziati tra le due sponde dell’Atlantico. Gli europei sono preoccupati per la
politica industriale di Biden racchiusa nei due contenitori dell’Inflation
Reduction Act e del Chips Act.
Il primo è una
manovra di sussidi soprattutto in campo energetico, con un forte accento sulla
sostenibilità, ed anche per la ri-localizzazione in Nordamerica di produzioni
come le batterie per auto elettriche. Vale 370 miliardi di dollari e ha un
impatto protezionista perché per incassare quei sussidi bisogna andare a
fabbricare dentro il mercato unico Usa-Canada-Messico. La recente decisione di
Volkswagen di costruire batterie elettriche in America è una conferma che molte
multinazionali europee sono attratte dagli aiuti di Biden.
L’altra manovra, il
Chips Act, all’interno di un budget di 280 miliardi per la ricerca e
l’innovazione dedica 52 miliardi a finanziare la costruzione di nuove «fabs» di
semiconduttori. I governi europei temono un deflusso di imprese, investimenti,
posti di lavoro, e una perdita di ruolo nelle tecnologie avanzate.
Per la verità
esistono delle politiche industriali europee non meno generose di quella
americana – per esempio attraverso il Next Generation EU – però quei fondi
vengono dispersi in mille rivoli, spesso in una logica di orticelli nazionali,
mentre l’America riesce a convogliare i suoi aiuti federali su pochi grandi
progetti. A sua volta l’Unione europea mette in campo la «carbon border tax», il
progetto di un dazio verde che tasserebbe le importazioni in base alla quantità
di CO2 emessa per fabbricarle. Oltre a quella cinese o indiana, anche
l’industria americana si considera un possibile bersaglio di questo
«protezionismo ambientalista».
Biden e gli europei
(in particolare la coppia Scholz-Macron) hanno già cominciato a spingere verso
dei compromessi.
Cedere alla Casa
Bianca sull’embargo tecnologico contro la Cina può servire a spuntare
delle contropartite americane per evitare una escalation nella potenziale guerra
transatlantica dei sussidi e dei protezionismi.
Se si conferma
l’ulteriore compattamento dell’asse transatlantico, anche sul cordone sanitario
da stendere attorno a Pechino nelle tecnologie avanzate, un effetto sarà senza
dubbio quello di contenere e ritardare gli obiettivi di Xi Jinping: che già agli
albori della sua ascesa al potere un decennio fa, nel celebre piano «Made in
China 2025» si prefiggeva di raggiungere il primato mondiale in tutti i settori
di punta, compresi i supercomputer e l’intelligenza artificiale.
Di sicuro la sua
Cina aveva già fatto grandi passi verso un semi-monopolio planetario per le
tecnologie verdi. Ora Politico definisce ironicamente la strategia occidentale
come un tentativo di sottoporre la Cina alla «dieta paleo», la dieta alimentare
praticata dai cavernicoli.
(ANSA il 9 marzo
2023) La società russa Rosatom sta fornendo uranio altamente arricchito alla
Cina. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, John
Plumb, in un'audizione alla Camera americana. "Siamo molto preoccupati per la
cooperazione tra Mosca e Pechino in questo ambito", ha aggiunto il funzionario
del Pentagono sottolineando che "la Cina è impegnata in una rapida espansione e
diversificazione delle sue capacità nucleari". L'uranio ufficialmente è stato
inviato per rifornire i reattori nucleari autofertilizzanti che usano il
plutonio e, precisa Plumb, "il plutonio si usa per fabbricare armi nucleari".
(ANSA il 10 marzo
2023) Gli Stati Federati di Micronesia hanno tenuto colloqui con Taiwan a
febbraio per un possibile ribaltone delle relazioni diplomatiche da Pechino a
Taipei a fronte di 50 milioni di dollari in assistenza dopo la frustrazione
maturata verso la Cina. In una lettera ai leader statali - ha riferito The
Diplomat - il presidente uscente della nazione insulare del Pacifico, David
Panuelo, ha accusato la Cina di pressioni, intimidazioni e corruzione nel Paese,
dimostrando "un'acuta capacità di minare la nostra sovranità, di respingere i
nostri valori e di utilizzare i nostri funzionari eletti e di alto livello per i
loro scopi".
Volare alto.
Quali aerei caccia servono all’Ucraina e quali (non) potrà fornire l’Occidente.
Elio Calcagno e Michelangelo Freyrie su L’Inkiesta il 7
Marzo 2023.
Kyjiv ha bisogno
di un aiuto aeronautico per non soccombere a Mosca nel controllo dei cieli. Ma
la donazione da parte dei Paesi europei (e degli Stati Uniti) potrà funzionare
solo se c’è uno sforzo collettivo: nessuno Stato da solo potrà fare da solo una
grande differenza
Tutto è
cominciato nei cieli del Donbas; è quindi scontato che qualcuno creda che li
tutto possa finire. Quasi dieci anni fa il tentativo russo (e separatista) di
imporre il proprio controllo su parte dello spazio aereo ucraino si concluse con
l’abbattimento accidentale del volo di linea MH-17. La dimensione politica di
quell’evento riecheggia oggi nella richiesta ucraina di una fornitura di caccia
di produzione occidentale, una questione militare ma con un grande valore
simbolico. L’ipotesi di una donazione jet multiruolo è per ora stata accolta in
Occidente con un certo scetticismo, anche in Italia: il sottosegretario alla
Difesa Matteo Perego di Cremnago e il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli
hanno per ora escluso una fuga in avanti dell’Italia sul tema, additando la
difficoltà di fornire sistemi aerei e spiegando che Roma agirà solo in concerto
con gli alleati.
Come sta andando
la guerra aerea
Eppure, l’urgenza
ucraina non sembra ingiustificata. Ovviamente, è difficile giudicare i progressi
fatti da Russia e Ucraina per quel che riguarda la guerra nei cieli. Raccogliere
informazioni sugli avvenimenti sul campo è già di per sé complicato; farlo in un
dominio come quello aereo, dove i dati pur parziali fruibili dai contenuti
caricati sui social sono pochissimi, è ancora più complicato. Sappiamo però che
l’ultimo anno ha visto una certa evoluzione nel modo con cui invasori e
difensori hanno gestito la questione.
I russi non sono
riusciti nella prima fase della campagna a distruggere a terra i caccia ucraini
e sopprimere radar, basi e difese aeree ucraine, grazie anche a un efficace
piano di evacuazione delle forze aeree di Kyjiv. Nonostante questo,
l’aeronautica russa ha dalla propria parte la superiorità dei numeri di sistemi
impiegati. La Russia dispone di aerei anche tecnologicamente più avanzati di
quelli di era sovietica impiegati dall’aeronautica ucraina. È però massiccio uso
di sistemi antiaerei a corto e medio raggio da entrambe le parti limita però
fortemente la libertà di movimento dei rispettivi velivoli.
La vita di un
pilota da caccia in Ucraina è oggi particolarmente pericolosa. La proliferazione
di sistemi antiaerei, fra cui gli S-400 e i BUK M-2 da lato russo e i (pochi)
Aspide e NASAMS da lato ucraino, impone agli aerei particolare cautela. Essendo
costretti a volare molto bassi per non farsi individuare dai radar avversari, il
supporto alle truppe di terra può avvenire solo tramite standoff (quindi il
lancio di missili a distanza, da dietro le proprie linee piuttosto che un
attacco frontale ravvicinato sopra le posizioni nemiche) e, in generale,
restringe le missioni possibili.
Un logoramento a
favore della Russia?
Senza la
possibilità di ottenere un grado di superiorità aerea sul nemico, entrambe le
parti si trovano a dover assumere un approccio piuttosto passivo; per gli
ucraini però ciò vuol dire ovviamente anche intercettare missili, droni e
bombardieri russi impegnati nella campagna aerea contro le infrastrutture
critiche di Kyjiv.
Al netto di ciò,
l’aeronautica russa può scommettere sul progressivo consumo dei propri nemici.
Le difese antiaeree russe possono minacciare gli aerei ucraini fino a 100km
dietro la linea del fronte, mentre gli aiuti occidentali si sono finora
concentrati soprattutto sulla fornitura di sistemi più a corto raggio capaci di
tutelare di obiettivi strategici.
Il risultato è
che i caccia russi possono comunque pattugliare da altitudini superiori di
quelli ucraini lo spazio aereo sopra il territorio occupato, anche se come i
difensori costretti a voli rasoterra quando operano a portata dei sistemi
antiaerei nemici. Nel medio periodo, questa asimmetria potrebbe permettere a
Mosca di imporre una superiorità aerea almeno in alcuni settori del fronte per
il tempo sufficiente per lanciare offensive locali.
Richieste ucraine
e necessità occidentali
Insomma, le
richieste ucraine sono dettate da precisi sviluppi in atto sul fronte. Come per
altri domini, un impegno credibile alla difesa dell’Ucraina richiederebbe un
progressivo passaggio a sistemi alla cui manutenzione e riparazione possono
contribuire i paesi Nato. Ciò vorrebbe dire quindi la sostituzione con jet
ancora in produzione e ampiamente diffusi, come l’F-16, l’Eurofighter Typhoon e
il JAS 39 Gripen.
Tuttavia,
ciascuna di queste opzioni va esaminata attentamente, tenendo conto di un
groviglio di elementi che includono sia i requisiti identificati dagli ucraini
che le capacità e la disponibilità degli aerei in questione e dei relativi
sistemi d’arma e pezzi di ricambio. Altra considerazione fondamentale è la
facilità di utilizzo, che determina anche le tempistiche di addestramento dei
piloti, ma anche del personale incaricato della manutenzione a terra.
L’ultima
variabile è rappresentata dall’effettiva capacità dei Paesi occidentali di
fornire sistemi in buone condizioni senza impattare l’efficacia delle proprie
aeronautiche e lasciare dei vuoti nei propri apparati di difesa aerea.
Esaminiamo quindi
i tre principali modelli di caccia considerati per un’eventuale donazione
all’Ucraina.
L’Eurofighter
L’Eurofighter, in
dotazione a cinque aeronautiche europee, incluse quelle di Italia, Spagna, Regno
Unito e Germania, è il risultato di un grande programma di cooperazione fra
questi Paesi e a oggi uno dei caccia da superiorità aerea più diffusi sul
continente. Si tratta di un sistema avanzato e molto capace, in grado di dare
del filo da torcere anche alle più avanzate fra le controparti russe. Era anche
il sospettato principale quando a febbraio il Primo ministro britannico Rishi
Sunak aveva incaricato il suo Ministro della difesa, Ben Wallace, di esaminare
quali aerei da combattimento Londra potesse fornire all’Ucraina. Gli Eurofighter
sono sistemi meno complessi del ben più costoso F-35 e sarebbero l’unica opzione
realisticamente sul tavolo per un’ipotetica fornitura da parte di Londra.
L’Eurofighter
rimane tuttavia un aereo complicato da manutenere e richiederebbe con ogni
probabilità una presenza di contractor occidentali per assistenza in loco. Lo
stesso Wallace ha già cercato di rimediare alle prime dichiarazioni provenienti
da Downing Street spiegando che, visti i requisiti ucraini, l’opzione più
pragmatica nel breve termine sarebbe la fornitura di missili a lungo raggio e
droni – utili per garantire supporto aereo alle truppe di terra e facilmente
impiegabili. Secondo il ministro, infatti, la fornitura di aerei da
combattimento sarebbe un prospetto realistico soltanto in un’ottica di lungo
termine e dunque di deterrenza dopo la fine del conflitto.
F-16 e Gripen
L’F-16, sistema
americano progettato inizialmente negli anni ’80 e utilizzato anche da diverse
aeronautiche europee, è fra i candidati principali per un trasferimento agli
ucraini anche perché molto più diffuso di qualsiasi equivalente europeo. Una
maggiore diffusione porta chiari vantaggi rispetto alla disponibilità dei pezzi
di ricambio e componenti, indispensabili per poter garantire l’operatività degli
aerei.
Tuttavia,
qualsiasi mossa europea a riguardo necessiterebbe di un’autorizzazione da parte
di Washington che, almeno nell’immediato, sembra distante. Anche gli Stati Uniti
restano infatti riluttanti rispetto alla fornitura di caccia. Come praticamente
tutti i Paesi Nato, farebbero fatica a privare le proprie forze aeree di mezzi
indispensabili per la sicurezza nazionale in un clima di riarmo post-Guerra
fredda – specialmente nel breve periodo.
Sulla carta, il
terzo candidato potrebbe essere il più adatto a rispondere ai requisiti
dell’aeronautica ucraina: il Gripen, prodotto dalla svedese Saab. Questo caccia
è stato progettato per operare non da poche, grandi basi aeree come quelle delle
potenze militari della Nato, ma da una rete di piccole basi distribuite sul
territorio.
Di conseguenza,
tutti gli equipaggiamenti necessari per il supporto a terra e la manutenzione e
riparazione sono adatti a una dottrina sviluppata dagli svedesi per contrastare
la superiorità numerica dei russi in caso di conflitto. Il Gripen, inoltre, è
compatibile con i missili aria-aria europei Meteor a lungo raggio, ideali per
ingaggiare i caccia russi da posizioni arretrate rispetto alle difese aeree
russe. Eppure la Svezia, spaventata dalla deriva russa al punto da porre fine a
una politica di neutralità durata due secoli, sembra non essere nella posizione
di privarsi anche di un piccolo numero di Gripen nel breve termine, a
prescindere dalle carenze di piloti e personale specializzato.
L’imperativo:
agire insieme
La ricerca di una
soluzione praticabile alle richieste di Kyjiv deve evitare di cadere nella
tentazione di vedere ogni opzione come un singolo aereo con le relative
prestazioni. Bisogna invece parlare di veri e propri ecosistemi che includono sì
le prestazioni del singolo aereo, ma anche le caratteristiche dei relativi
sistemi d’arma come anche la reperibilità degli stessi, oltre che delle
strumentazioni e componenti necessarie per manutenere tutto l’insieme in maniera
sostenibile.
In definitiva, la
posizione del governo italiano ha del vero: un aiuto aeronautico non potrà che
essere orchestrato con gli alleati. Le preoccupazioni della Difesa britannica
sono verosimilmente simili a quelle che esprimerebbe Via XX Settembre, e anche
il nostro Paese è soggetto a vincoli tecnici simili. Una donazione di aerei può
funzionare solo se c’è uno sforzo collettivo: nessun Paese si trova attualmente
in grado di fare da solo una grande differenza. Ma nulla vieta alle capitali
europee, Roma compresa, di elaborare un piano preciso, con un orizzonte più a
lungo termine rispetto all’immediato, che potrebbe dare qualche frutto.
L’imperativo, in ogni caso, è che gli alleati si muovano insieme.
La Repubblica. New
York Times: "Un gruppo pro-ucraino all'origine del sabotaggio del Nord Stream"
Il leader ucraino:
"Ho chiesto allo Stato maggiore di trovare le forze appropriate per aiutare la
difesa della città, nessuna parte dell'Ucraina può essere abbandonata". Regno
Unito: "La difesa della città si è probabilmente stabilizzata". Intanto Kiev
evacua i bambini dalla città contesa
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato rinforzi per Bakhmut. "Ho chiesto allo
Stato maggiore di trovare le forze appropriate per aiutare la difesa di Bakhmut,
nessuna parte dell'Ucraina può essere abbandonata", ha detto nel consueto
messaggio serale al Paese. Zelensky ha spiegato di aver discusso di Bakhmut con
alti generali, sottolineando che la loro posizione non era quella di ritirarsi
bensì di rafforzare le difese: "Il comando ha sostenuto all'unanimità questa
posizione. Non c'erano altre posizioni. Ho detto al comandante in capo di
trovare le forze appropriate per aiutare i nostri ragazzi a Bakhmut", ha detto
Zelensky.
Punti chiave
16:59
New York Times: "Un
gruppo pro-ucraino all'origine del sabotaggio del Nord Stream"
16:44
Kiev: evacuazione
obbligatoria dei bambini da Bakhmut
14:42
Lukashenko accusa
Zelensky di sabotaggio: "È un bastardo"
14:15
Prigozhin:
"Smettiamola di dire che abbiamo preso Bakhmut. Servono munizioni"
13:54
Il segretario
generale dell'Onu Guterres verso Kiev, incontrerà Zelensky
12:47
L'Ucraina ha
identificato il soldato giustiziato in video-shock
11:14
Mosca: "La conquista
di Bakhmut permetterà di continuare l'avanzata"
11:02
Cremlino: "Bene gli
sforzi della Cina, ma non ci sono le condizioni per la pace. Gli Usa fanno di
tutto per continuare il conflitto"
02:08
Rappresentante
Ucraina all'Onu: no a presidenza russa in consiglio di Sicurezza
Il rappresentante
permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha esortato
l'organizzazione a non consentire la presidenza di turno di un mese della
Russia, a partire da aprile, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "La
notte dell'invasione Antonio Guterres l'ha definito 'il giorno piu' triste del
suo mandatò; di fatto il più triste nella storia delle Nazioni Unite fino al 1
aprile 2023 quando, a meno che non prevalga la giustizia, la Russia assumerà la
presidenza del Consiglio di sicurezza", ha sottolineato Kyslytsya in un tweet. A
marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è presieduto dal Mozambico.
Da aprile, secondo il programma delle Nazioni Unite, la Russia dovrebbe assumere
la presidenza.
04:28
Cina, crisi a punto
critico, colloqui prima possibile
La crisi ucraina è
giunta a un punto critico e il conflitto e le sanzioni non risolveranno il
problema. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. "Gli
sforzi per i colloqui di pace sono stati danneggiati ripetutamente", ha scandito
il ministro degli Esteri di Pechino, ricordando il piano in dodici punti
presentato dalla Cina il 24 febbraio scorso, nel primo anniversario dall'inizio
del conflitto, per risolvere pacificamente la crisi. La crisi ucraina è giunta
"a un punto critico", ha detto e "i colloqui di pace devono cominciare il prima
possibile".
05:04
Cina, mai fornito
armi alle parti in conflitto
Pechino "non ha
fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto ucraino. La Cina non è
l'artefice della crisi, né una parte direttamente interessata. Perché minacciare
allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente accettabile". Il neoministro
degli Esteri, Qin Gang, nel suo primo briefing con i media a margine dei lavori
parlamentari annuali, ha accennato a "una mano invisibile" che sembra sostenere
una crisi prolungata. "E' una tragedia che poteva essere evitata: la Cina
sceglie la pace sulla guerra, il dialogo sulle sanzioni" e la de-escalation
all'escalation", ha notato ancora Qin sul conflitto tra Russia e Ucraina.
08:42
Kiev: ieri uccisi
1.060 soldati di Mosca
Le forze armate
ucraine hanno ucciso ieri 1.060 soldati russi, un bilancio che porta il totale
delle forze di Mosca eliminate nel Paese dall'inizio dell'invasione a 154.830:
lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev nel suo aggiornamento
quotidiano della situazione al fronte, come riporta Ukrinform. L'esercito
ucraino non specifica quanti uomini russi abbiano perso la vita ieri nella città
assediata di Bakhmut, ma nei giorni scorsi il ministro della Difesa ucraino
Oleksiy Reznikov aveva detto che le perdite russe ammontano fino a 500 soldati
al giorno nella battaglia per la conquista della città strategica nell'est del
Paese. Il rapporto dello Stato Maggiore indica inoltre che dall'inizio della
guerra la Russia ha perso 303 caccia, 289 elicotteri e 2.095 droni. Le forze di
Kiev affermano di aver distrutto anche 3.432 carri armati russi, 2.456 sistemi
di artiglieria, 488 sistemi di razzi a lancio multiplo, 253 sistemi di difesa
aerea, 873 missili da crociera e 18 navi.
08:47
L'Isw: "Le forze
russe controllano il 40% di Bakhmut"
Le forze russe
controllano il 40% della città assediata di Bakhmut, nell'Ucraina orientale: è
quanto si evince da una mappa interattiva pubblicata su Internet dall'Istituto
per lo studio della guerra (Isw). La mappa del centro studi statunitense, che
mostra i movimenti di terra dei soldati di Mosca aggiornati a ieri, indica che
la zona controllata dai russi si estende - dal lato orientale - quasi fino al
centro della città. Nel consueto messaggio serale al paese il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver dato direttive all'Esercito per trovare
"tutte le forze" per difendere Bakhmut. "Ho chiesto allo Stato maggiore di
trovare le forze appropriate per aiutare la difesa di Bakhmut, nessuna parte
dell'Ucraina può essere abbandonata", ha detto.
09:31
Media: allerta
antiaerea in tutta l'Ucraina
Un'allerta antiaerea è stata dichiarata in tutta l'Ucraina: lo riporta
il Guardian.
10:04
Difesa
britannica: probabilmente stabilizzata la difesa di Bakhmut
Le forze ucraine
hanno "probabilmente stabilizzato" il loro perimetro difensivo a Bakhmut in
seguito agli sforzi russi di invadere il nord della città, secondo
l'aggiornamento quotidiano dell'intelligence del ministero della Difesa
britannico. Entrambe le parti stanno subendo pesanti perdite dentro e intorno a
Bakhmut.
Il rapporto arriva
il giorno dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha detto in un discorso agli
ucraini che c'era consenso tra lui e la massima leadership militare ucraina sul
fatto che le forze ucraine dovrebbero continuare a tenere la città.
Si ritiene che le
perdite della Russia nella battaglia per Bakhmut siano significativamente più
alte di quelle dell'Ucraina, ma cresce la preoccupazione per il logoramento
subito dalle brigate ucraine incaricate di difendere la città quasi accerchiata.
10:21
Kiev: respinti 37
attacchi nell'area di Bakhmut
Le forze russe hanno
effettuato 50 attacchi aerei e cinque missilistici durante la notte e le forze
ucraine hanno respinto 37 attacchi nella zona intorno a Bakhmut, secondo
l'ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine, ripreso
dal Guardian. Le forze di Kiev hanno effettuato 15 attacchi aerei contro le
forze russe, compreso un attacco a un sistema antiaereo e hanno dichiarato di
aver abbattuto un aereo SU-25, nove droni Shaheed e altri otto droni.
10:42
Filorussi:
"Conquistata quasi la metà di Bakhmut"
Le forze russe
controllano "quasi la metà" della città di Bakhmut, secondo quanto annunciato da
Jan Gagin, consigliere del capo dell'autoproclamata repubblica filorussa di
Donetsk, Denis Pusilin. "Le nostre truppe e la nostra artiglieria sono già in
città e ne controllano quasi la metà", ha detto Gagin, citato dall'agenzia Ria
Novosti, aggiungendo che è in atto "un ritiro caotico di vari piccoli gruppi" di
soldati ucraini, alcuni dei quali si arrendono.
11:02
Cremlino: "Bene gli
sforzi della Cina, ma non ci sono le condizioni per la pace. Gli Usa fanno di
tutto per continuare il conflitto"
La Russia presta
"grande attenzione" all'iniziativa di pace della Cina per l'Ucraina, ma ora "non
ci sono le condizioni perché la situazione si avvii su un percorso pacifico" e
quindi Mosca cerca di raggiungere i suoi obiettivi "continuando l'operazione
militare". Lo ha detto, citato dall'agenzia Ria Novosti, il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui "Washington non vuole porre fine al
conflitto in Ucraina e sta facendo di tutto per continuarla". La Cina oggi ha
detto che la guerra in Ucraina è guidata da una "mano invisibile", e per Peskov
"quella mano appartiene agli Usa".
11:14
Mosca: "La conquista
di Bakhmut permetterà di continuare l'avanzata"
"La liberazione di
Bakhmut continua". Lo ha detto il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu,
aggiungendo che la città nel Donbass ucraino rappresenta una fondamentale linea
difensiva per le truppe ucraine e la sua conquista permetterà ai russi di
"continuare l'avanzata in profondità nelle difese ucraine". Lo riferisce
l'agenzia Tass.
11:29
Mosca: "11mila
soldati ucraini uccisi a febbraio, il 40% in più di gennaio"
Sono più di
undicimila i soldati ucraini uccisi a febbraio nel conflitto contro la Russia.
È la stima che viene fornita dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu,
secondo il quale le perdite dell'esercito di Kiev sono aumentate di oltre il 40
per cento rispetto a gennaio, quando sarebbero 6.500 i soldati ucraini morti in
battaglia.
In una
videoconferenza con la leadership delle forze armate, il ministro russo afferma
che i paesi occidentali stanno aumentando la fornitura di armi e attrezzature
militari all'Ucraina, ampliando i programmi di addestramento per il personale
dell'esercito ucraino. Ma, afferma il ministro, il sostegno della Nato al regime
di Kiev "non porta al successo delle truppe ucraine sul campo di battaglia. Al
contrario, c'è stato un aumento significativo delle perdite tra il personale
delle forze armate ucraine".
11:49
Ucraina, le autorità
di Kherson ai civili: "Lasciate la città"
Le autorità di
Kherson invitano gli abitanti a lasciare la città utilizzando i bus per
l'evacuazione. "I nemici hanno iniziato un bombardamento sistematico e
massiccio. La gran parte dei proiettili finisce sulle aree residenziali, vi
invitiamo a usare i mezzi di evacuazione per non mettere in pericolo la vostra
vita e quella dei vostri cari", recita un avviso del consiglio municipale
pubblicato su Telegram.
12:04
Mosca: "1.100 donne
russe in campo in Ucraina"
Sono circa 1.100 le
donne soldato russe impegnate in Ucraina a combattere e un terzo di loro ha
ricevuto riconoscimenti speciali. Lo ha detto il ministro della Difesa russo
Sergei Shoigu intervenendo in videoconferenza in un incontro con la leadership
delle forze armate alla vigilia della Festa internazionale della donna. "Oggi,
millecento donne militari stanno prendendo parte a un'operazione militare
speciale, un terzo di loro ha ricevuto riconoscimenti statali", ha detto Shoigu
esprimendo gratitudine a tutte le donne dell'esercito russo per il loro servizio
e l'approccio professionale e responsabile al lavoro assegnato. Shoigu ha anche
augurato loro "buona salute, umore primaverile e benessere familiare".
Il ministro della
Difesa russo ha anche espresso "sincera gratitudine alle nostre care donne per
la loro cura, gentilezza e calore". In campo professionale, ha aggiunto in vista
dell'8 marzo, le donne "realizzano pienamente le proprie capacità, partecipano
attivamente alla vita sociale e politica del Paese".
12:08
Il Cremlino non
conferma che Xi Jinping sarà a Mosca 21 marzo
Il portavoce del
Cremlino, Dmitry Peskov, non ha confermato le indiscrezioni secondo cui l'attesa
visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Mosca sarà il 21 marzo. "Non c'è
nulla da rendere noto", ha detto rispondendo a una domanda, "tutti gli ospiti
stranieri in Russia sono annunciati per tempo". Lo riferisce l'agenzia russa Ria
Novosti.
12:34
Lukashenko:
"Arrestato un agente ucraino per il sabotaggio dell'aereo russo in Bielorussia"
C'è anche un agente
dei servizi segreti ucraini, entrato in Bielorussia attraverso la Polonia, tra
gli oltre 20 arrestati per il sabotaggio di un aereo russo da ricognizione A-50.
Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato dall'agenzia
Belta. Secondo Lukashenko, l'azione "non può essere stata compiuta senza
l'assenso" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
12:47
L'Ucraina ha
identificato il soldato giustiziato in video-shock
L'Ucraina annuncia
di aver identificato un soldato ripreso mentre veniva ucciso in un video che è
circolato ampiamente sui social media, scatenando l'indignazione e spingendo i
funzionari a chiedere un'indagine. Il filmato mostra quello che sembra essere un
combattente ucraino detenuto in piedi in una trincea poco profonda, mentre fuma
e viene fucilato dopo aver detto "Gloria all'Ucraina".
La frase pronunciata
dal presunto soldato ucraino prigioniero ieri ha fatto tendenza sui social media
e gli alti funzionari di Kiev hanno accusato le forze russe e chiesto giustizia
per quello che a tutti gli effetti è uncrimine di guerra: uccidere un
prigioniero inerme. "Secondo i dati preliminari, il deceduto è un militare della
30a brigata meccanizzata separata, Tymofiy Mykolayovych Shadura", scrive
l'esercito ucraino su Telegram. Il soldato era scomparso dal 3 febbraio durante
i combattimenti nei pressi della città ucraina orientale di Bakhmut. "La
conferma definitiva della sua identità potrà essere stabilita dopo il ritorno
del corpo", ha aggiunto. Kiev ha detto che i resti del soldato ucciso si
trovavano in un territorio attualmente controllato dalle forze russe. L'Afp non
è stata in grado di verificare in modo indipendente dove o quando il filmato sia
stato girato o se mostri - come suggerito da funzionari ucraini e utenti dei
social media - un prigioniero di guerra ucraino.
13:00
Russia: 8 anni a
blogger per le sue critiche sull'invasione dell'Ucraina
Un tribunale di
Mosca ha condannato a otto anni e mezzo di reclusione il blogger Dmitry
Ivanov per aver criticato l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe:
lo riporta Novaya Gazeta citando a sua volta la testata MediaZona. Ivanov, che
cura un canale su Telegram chiamato "Protestniy Mgu", è uno studente di
matematica e informatica dell'università Lomonosov di Mosca e ha 23 anni. Le
autorità lo hanno incriminato sulla base della nuova legge bavaglio che prevede
fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che
dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe.
13:25
La Polonia invia in
Ucraina altri dieci carri armati Leopard 2
La Polonia
invierà altri carri armati in Ucraina questa settimana: lo ha detto oggi il
ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, come ripota
il Guardian. "Quattro (carri armati) sono già in Ucraina, altri dieci andranno
in Ucraina questa settimana", ha affermato Blaszczak in una conferenza stampa.
La Polonia aveva promesso di inviare a Kiev 14 carri armati Leopard 2.
13:54
Il segretario
generale dell'Onu Guterres verso Kiev, incontrerà Zelensky
Il segretario
generale dell'Onu, Antonio Guterres, è in viaggio verso Kiev dalla Polonia, per
incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Al centro del colloquio
l'accordo sull'esportazione dei cereali. È il terzo viaggio di Guterres in
Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.
14:15
Prigozhin:
"Smettiamola di dire che abbiamo preso Bakhmut. Servono munizioni"
"Ho un'enorme
richiesta a tutti i giornalisti rispettabili. Smettiamo di correre davanti alla
locomotiva e dire che abbiamo preso Bakhmut e cosa succederà dopo". Lo ha
scritto su Telegram Yevgeniy Prigozhin, capo del Gruppo Wagner. Prigozhin ha
aggiunto una metafora: "In una triste storia su un orso non ucciso, si dice che
non condivideremo la pelle, ma nessuno parla delle conseguenze del tentativo di
rimuovere questa pelle da un orso ancora vivo. Uccidiamo con calma questo orso.
Credetemi, stiamo facendo di tutto per questo, anche se non ci vengono ancora
fornite munizioni, equipaggiamento militare, armi e veicoli".
14:42
Lukashenko accusa
Zelensky di sabotaggio: "È un bastardo"
l presidente
bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dato oggi del "bastardo" a Volodymyr
Zelensky, accusando l'omologo ucraino del "sabotaggio" di un aereo da
ricognizione russo A-50, colpito da droni in una base aerea in Bielorussia. "C'è
solo una conclusione. Pensavo che l'Ucraina avesse bisogno di pace e che
Zelensky facesse il tifo per il suo popolo. Ma Zelensky è solo un bastardo.
Queste operazioni non possono essere portate avanti senza l'approvazione del
leader del Paese", ha detto Lukashenko nel lungo discorso in cui ha annunciato
la cattura del presunto responsabile dell'attacco del 26 febbraio contro un A-50
russo nella base aerea di Machulishchy, vicino Minsk. L'azione era stata
rivendicata dal gruppo partigiano bielorusso Bypol.
15:14
Media: oltre 20mila
perdite tra i soldati russi a Bakhmut
La Russia ha subito
da 20 mila a 30 mila perdite nel tentativo di prendere la città di Bakhmut. Lo
riporta il Guardian, citando funzionari occidentali che hanno parlato a
condizione di anonimato.
15:35
Berlino: "Se il
video dell'uccisione del soldato ucraino è autentico è un crimine di guerra"
Il governo tedesco
ha definito "scioccante" il video della presunta uccisione di un prigioniero di
guerra ucraino, che Kiev avrebbe identificato nel soldato della 30esima brigata
meccanizzata separata, Tymofiy Mykolayovych Shadura. "Se questo è autentico,
allora sarebbe un crimine di guerra", ha sottolineato un portavoce del ministero
degli Esteri tedesco, come riporta Tagesschau. Su Internet è circolato un video
in cui un uomo in uniforme ucraina viene ucciso a colpi di arma da fuoco da
sospetti soldati russi.
15:52
Russia: rimpatriati
90 militari russi che erano prigionieri di Kiev
Novanta prigionieri
russi sono stati liberati dalle autorità di Kiev e sono rientrati in Russia. Lo
ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca spiegando che "a seguito del
processo di negoziazione, 90 militari russi sono stati rimpatriati dal
territorio controllato dal regime di Kiev", soldati che "erano in pericolo di
vita durante la prigionia". Il ministero ha aggiunto che "a tutti coloro che
sono stati rilasciati viene fornita la necessaria assistenza medica e
psicologica".
16:08
Prigozhin: "A Bakhmut l'esercito di Kiev non scappa"
A Bakhmut ci sono
"battaglie pesanti sia di giorno che di notte, ma gli ucraini non stanno
scappando da nessuna parte". Lo ha detto il capo del gruppo Wagner, Evgenij
Prigozhin, come riporta il battaglione sul proprio canale Telegram. "Zelensky
non sta esaurendo le persone, altre migliaia vengono gettate nel 'tritacarne'",
ha aggiunto Prigozhin.
16:27
Kiev: rimpatriati
130 soldati dopo lo scambio di prigionieri
In un nuovo scambio
di prigionieri l'Ucraina ha riportato a casa 130 soldati catturati dai russi. Lo
riferisce il capo dell'Ufficio di presidenza ucraino Andriy Yermak in un
messaggio su Telegram. "Tra loro ci sono 87 difensori di Mariupol, 71 dei quali
sono di Azovstal", si legge nel messaggio, "la maggior parte delle persone che
ci stanno restituendo oggi ha ferite gravi. Come dice il presidente Volodymyr
Zelensky, lo Stato deve prendersi cura di ciascuno di loro".
16:44
Kiev: evacuazione
obbligatoria dei bambini da Bakhmut
Il consiglio dei
ministri ucraino ha approvato l'evacuazione obbligatoria dei bambini dalle zone
di combattimento: al momento solo Bakhmut rientra nei criteri per l'applicazione
della norma. Lo riferisce l'Ukrainska Pravda. I minorenni dovranno essere
accompagnati da uno dei genitori, una persona che li sostituisca o un altro
rappresentante legale. Non è consentito il rifiuto di genitori o tutori di
evacuare il bambino."Il dovere dello Stato è proteggere la vita e la salute del
bambino", ha detto il vice primo ministro Irina Vereshchuk.
16:59
New York Times: "Un
gruppo pro-ucraino all'origine del sabotaggio del Nord Stream"
Sarebbe stato un
gruppo pro-ucraino, secondo le fonti di intelligence citate dal New York Times,
ad avere ordito il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. È quanto si legge sul
quotidiano Usa che cita un "nuovo rapporto di intelligence".
Il nuovo rapporto,
secondo il Nyt, è la "prima pista significativa sui responsabili dell'attacco ai
gasdotti Nord Stream" sui quali viaggia il gas naturale dalla Russia al Nord
Europa, avvenuto l'anno scorso. I funzionari statunitensi citati dal giornale
hanno dichiarato di non avere alcuna prova che il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky o i suoi principali luogotenenti fossero coinvolti nell'operazione, o
che gli autori agissero sotto la direzione di funzionari del governo ucraino.
L'attacco ai gasdotti naturali che collegano la Russia all'Europa ha alimentato
le speculazioni sulle responsabilità: da Mosca a Kiev, da Londra a Washington si
sono rimbalzate le ipotesi, ma quello dei sabotaggi al gasdotto è rimasto uno
dei più importanti misteri irrisolti della guerra della Russia in Ucraina.
L'Ucraina e i suoi
alleati sono considerati in questo rapporto come i potenziali attentatori più
verosimili. Da anni si oppongono al progetto, definendolo una minaccia per la
sicurezza nazionale perchè permetterebbe alla Russia di vendere più facilmente
gas all'Europa. I funzionari del governo ucraino e dell'intelligence militare
affermano di non aver avuto alcun ruolo nell'attacco e di non sapere chi lo
abbia compiuto.
17:25
Kiev, non siamo
coinvolti in sabotaggio aereo russo
L'Ucraina ha
ribadito di non essere coinvolta nel tentativo di sabotaggio dell'aereo russo
A-50 nell'aeroporto bielorusso di Machulishchi. Le accuse mosse dal presidente
bielorusso Aleksandr Lukashenko sono "un altro tentativo di creare una minaccia
artificiale dall'Ucraina per giustificare il sostegno bielorusso all'aggressione
della Russia". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri
ucraino Oleg Nikolenko, come riporta il Guardian.
17:36
Fonti occidentali:
"20-30mila fra morti e feriti russi a Bakhmut"
Fra morti e feriti,
i russi avrebbero perso 20-30mila uomini nel tentativo finora vano di
conquistare Bakhmut. E' quanto emerge da un briefing con funzionari occidentali,
citato dal Guardian. Secondo queste fonti, le perdite ucraine, che non sono
state quantificate, sono "significativamente minori". Gran parte di queste
perdite, dicono le fonti, sono probabilmente detenuti arruolati dalla compagnia
di mercenari Wagner, e la maggior parte di loro sono morti. "Il tasso di morti
della Wagner è significativamente più alto che nelle forze armate russe", viene
spiegato, ricordando che nelle forze regolari di Mosca vi sono in media un morto
ogni tre feriti. Nel riportare le stime, il Guardian ricorda che in 20 anni di
operazioni militare in Afghanistan, gli americani hanno avuto poco meno di
21mila soldati morti e feriti.
18:11
Usa, su incidente a
Nord Stream aspettiamo fine indagini
"Sull'incidente
al Nord Stream ci sono tre inchieste in corso, ancora non si è arrivati ad una
conclusione, aspettiamo la fine delle indagini". Lo ha detto il portavoce per la
sicurezza nazionale americana, John Kirby, a proposito della notizia del New
York Times che sarebbe stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare il gasdotto l'anno
scorso. "A quanto ne sappiamo, come ha detto già il presidente Biden, è stato un
sabotaggio", ha aggiunto.
18:40
Dissidenti Bypol,
abbiamo sabotato noi aereo russo, Kiev non c'entra
La guerriglia di
dissidenti bielorussi che si oppongono al governo di Aleksandr Lukashenko, noti
come Bypol, hanno smentito la sua versione dei fatti sul tentativo di sabotaggio
dell'aereo russo A-50 nell'aeroporto di Machulishchi. "Non conosciamo la persona
di cui ha parlato Lukashenko", ha detto il leader di Bypol Aliaksandr Azarau,
parlando dell'uomo che secondo Lukashenko sarebbe il sabotatore addestrato
dall'intelligence di Kiev. "Non c'è stato alcun coordinamento con gli ucraini
durante questa operazione", ha detto Azarau in un'intervista ad Associated
Press. Bypol aveva rivendicato la responsabilità dell'attacco settimana scorsa.
"Le persone coinvolte nell'attacco sono cittadini bielorussi", ha aggiunto,
"sono tutti partiti all'estero e sono al sicuro". Secondo Azarau, "Lukashenko ha
qualcosa da temere".
18:46
Nord Stream:
Berlino, indagini su sabotaggio ancora in corso
Una portavoce del
governo tedesco ha affermato che Berlino ha "preso atto" di quanto riferito
dal New York Times in merito al sabotaggio del gasdotto Nord Stream,
sottolineando che le indagini sulle esplosioni sono ancora in corso. Secondo i
servizi di intelligence statunitensi, un gruppo filo-ucraino potrebbe essere
responsabile dell'attacco dello scorso anno, ha riportato il Nyt. "Il
procuratore generale sta indagando sul caso dall'inizio di ottobre 2022. E' lui
ad avere il controllo del processo. Inoltre, le indagini sulle esplosioni sono
in corso in Svezia e in Danimarca, ciascuna sotto l'egida delle autorità
nazionali", ha spiegato la portavoce, come riporta Tagesschau. "Inoltre, sono in
corso indagini sulle esplosioni in Svezia e Danimarca, ciascuna sotto la guida
delle autorità nazionali locali", ha aggiunto. Pochi giorni fa, Svezia,
Danimarca e Germania hanno informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite che le indagini sono in corso e che non ci sono ancora dei risultati.
18:59
Russia: rapporto del
New York Times su Nord Stream giustifica la spinta per un'inchiesta
internazionale
Il vice inviato
russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy, ha dichiarato che un rapporto
del New York Times sui possibili responsabili degli attacchi ai gasdotti Nord
Stream dello scorso anno "dimostra solo che la nostra iniziativa di lanciare
un'indagine internazionale sotto gli auspici del Segretario generale delle
Nazioni Unite è molto tempestiva". La Russia ha in programma di chiedere un voto
al Consiglio di Sicurezza dell'Onu entro la fine di marzo sulla sua bozza di
risoluzione che chiede al Segretario Generale Antonio Guterres di istituire
un'inchiesta di questo tipo, ha dichiarato alla Reuters Polyanskiy.
19:11
Zelensky, se cade
Bakhmut apriamo la strada a Mosca
Le forze russe
avranno la "strada aperta" verso città chiave dell'Ucraina orientale se
prenderanno il controllo di Bakhmut. Lo ha sottolineato il presidente Volodymyr
Zelensky in un'intervista alla Cnn, difendendo così la sua decisione di
mantenere le forze ucraine nella città assediata. "Questo è tattico per noi", ha
detto Zelensky, insistendo sul fatto che i vertici militari di Kiev sono uniti
nel concordare di prolungare la difesa della città dopo settimane di furiosa
battaglia.
19:17
Kiev, assolutamente
non coinvolti in sabotaggio Nord Stream
Il consigliere del
presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha assicurato che Kiev "non è
stata assolutamente coinvolta" negli attacchi dello scorso anno ai gasdotti Nord
Stream e non ha informazioni su quanto accaduto. Il commento arriva dopo che
il New York Times, citando funzionari Usa, che ha rivelato che il responsabile
fosse un gruppo filo-ucraino.
19:33
Georgia, primo sì
alla legge sugli "agenti stranieri"
Il parlamento
georgiano ha approvato in prima lettura le due bozze del progetto di legge che
mira a introdurre nuove norme per il controllo dei cosiddetti 'agenti
stranieri', principalmente pensata per i media. La legge, sostenuta dal partito
di governo Sogno Georgiano, ricalca quella già in vigore in Russia ed è vista
dalle opposizioni come un tentativo di mettere il bavaglio all'informazione.
Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, hanno votato a favore 76 deputati,
mentre 13 parlamentari si sono espressi contro. Inizialmente la discussione era
prevista per il 9 marzo. Il disegno di legge sarà ora inviato alla Commissione
di Venezia del Consiglio d'Europa per un parere. Successivamente, questi
progetti di legge saranno ascoltati e possibilmente approvati in seconda e terza
lettura dal parlamento georgiano, secondo quanto riportato da Interfax.
La polizia
antisommossa è stata immediatamente schierata non appena i disegni di legge sono
stati approvati. Fuori dal parlamento, infatti, centinaia di persone si sono
riunite per protestare contro la legge. Su di loro sono stati usati cannoni ad
acqua e spray. L'ambasciata degli Stati Uniti ha definito questi eventi "un
giorno nero per la democrazia georgiana". La proposta di adottare anche in
Georgia una legge sugli 'agenti stranieri' è stata presentata dal partito
filogovernativo Potere del Popolo e ha incontrato le proteste di organizzazioni
non governative e media. La legge prevede che società non commerciali che
ricevono oltre il 20% dei propri finanziamenti da fonti straniere siano appunto
registrate come agenti stranieri, con possibili limitazioni alle loro attività.
19:41
Mosca: "Occidente
risponda a nostre richieste su Nord Stream"
Invece di
organizzare "fughe di notizie" dall'indagine sul Nord Stream, "l'Occidente deve
rispondere alle richieste ufficiali della Federazione Russa". Lo ha dichiarato
la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo che un articolo
del New York Times, citando fonti Usa, sostiene che sia stato un gruppo
pro-Ucraina a portare a termine l'attacco contro il gasdotto Nord Stream lo
scorso anno.
20:00
Nord Stream:
Stoltenberg, aspettare fine delle indagini in corso
"Gli attacchi ai
gasdotti Nord Stream hanno mostrato la vulnerabilità delle nostre infrastrutture
critiche ma ci sono delle indagini in corso e sarebbe sbagliato speculare sui
responsabili sino a che non si sono concluse". Lo ha detto il segretario
generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso della sua conferenza stampa a
Stoccolma con il primo ministro svedese Ulf Kristerssen. "La Nato dopo gli
attacchi ha raddoppiato la sua presenza militare nel mar Baltico e nel mare del
Nord", ha ricordato.
20:16
Georgia: ddl agenti
stranieri scatena protesta,scontri a Tbilisi
La polizia georgiana
ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad'acqua per disperdere i manifestanti
radunatasi in serata nel centro di Tbilisi, dopo che il Parlamento ha approvato,
in prima lettura, un progetto di legge sugli "agenti stranieri" che secondo gli
attivisti per i diritti umani rappresenta una svolta autoritaria del Paese. La
legge, sostenuta dal partito al potere 'Sogno georgiano', richiederebbe a tutte
le Ong che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero di
registrarsi come "agenti stranieri", pena multe salate. I detrattori
dell'iniziativa la paragonano alla legge russa del 2012, che da allora viene
usata da Mosca per reprimere il dissenso.
La televisione
georgiana ha mostrato i manifestanti che protestavano con rabbia davanti al
Parlamento mentre la polizia armata di scudi antisommossa lancia gas lacrimogeni
e aziona i cannoni ad'acqua. Alcuni dei manifestanti scesi in piazza
sventolavano la bandiera dell'Unione europea e degli Stati Uniti e gridavano:
"No alla legge russa".
20:25
Zelensky: "Russia
vuole mettere solo una bandierina a Bakhmut"
Ucraini e russi
hanno motivazioni "diverse" riguardo al controllo di Bakhmut, con Mosca che "ha
bisogno di almeno una vittoria - una piccola vittoria - anche distruggendo
tutto, anche uccidendo ogni civile lì". Lo ha dichiarato il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn. Se la Russia riuscisse a
"mettere la sua bandierina" in cima a Bakhmut, ciò aiuterebbe "a mobilitare la
loro società per creare l'idea che sono un esercito potente".
20:41
Von der Leyen,
obiettivo addestrare 30.000 soldati ucraini entro l'anno
L'obiettivo "è
addestrare 30.000 soldati ucraini entro l'anno". Lo ha detto il presidente della
commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della sua missione in Canada
durante la quale ha incontrato il premier Justin Trudeau. "I due leader hanno
riaffermati il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale
dell'Ucraina", si legge nella dichiarazione congiunta.
21:01
Ucraina, Zelensky
raddoppia la difesa di Bakhmut
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha raddoppiato la difesa di Bakhmut nonostante le
voci di un imminente ritiro dalla città assediata che ha subito un assalto di
nove mesi. Durante il suo discorso serale Zelensky ha detto di aver incontrato
alti generali dove che hanno indicato il loro sostegno per continuare la difesa.
"Ho detto al capo di stato maggiore di trovare le forze adeguate per aiutare i
ragazzi a Bakhmut.Non c'è parte dell'ucraina di cui si possa dire che possa
essere abbandonata". Dopo una serie di incontri con Zelenskiy, Valerii Zaluzhnyi
, comandante in capo delle forze armate, e Oleksandr Syrskyi , comandante delle
forze di terra ucraine, "si sono espressi a favore della continuazione
dell'operazione difensiva e dell'ulteriore rafforzamento delle posizioni
[ucraine] a Bakhmut ", ha detto l'ufficio di Zelenskiy.
21:17
Zelensky, morto al
fronte "Da Vinci", giovane eroe ucraino
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in serata la morte al fronte di "Dmytro
Kotsyubailo, un combattente di 27 anni, deceduto nella battaglia vicino
a Bakhmut, nella battaglia per l'Ucraina". Per il leader ucraino - citato
da Ukrainska Pravda -, il giovane era a capo di un battaglione meccanizzato
separato detto "Lupi di Da Vinci" e pertanto era stato soprannominato Da Vinci.
"Da Vinci è un eroe dell'Ucraina, un volontario, un uomo-simbolo, un
uomo-coraggio, ed è morto oggi nella battaglia al fronte", ha detto Zelensky,
ricordando che "dal 2014 questo eroe, tra i più giovani dell'Ucraina, difende la
nostra indipendenza e la dignità del nostro popolo. E uno di quelli la cui
storia personale, il carattere, il coraggio sono diventati la storia, il
carattere e il coraggio dell'Ucraina".
21:19
Usa valutano missili
aria-aria per i MiG Kiev
Gli Stati Uniti
stanno valutando se è possibile integrare gli avanzati missili aria-aria
occidentali sui jet ucraini dell'era sovietica. Lo riporta Politico citando
alcune fonti, secondo le quali l'ipotesi è quella di verificare se i missili
avanzati a medio raggio aria-aria AIM-20, progettati per essere lanciati da jet
come gli F-16, possono essere montati sugli esistenti MiG. Se le verifiche
avranno successo, gli Stati Uniti potrebbero rafforzare le difese aeree di Kiev.
21:59
Georgia: a Tbilisi,
manifestanti tentano irruzione Parlamento
I manifestanti che a
Tbilisi, in Georgia, sono scesi in piazza per protestare contro la proposta
di legge sugli "agenti stranieri" hanno sfondato le barriere poste dalle forze
dell'ordine e stanno cercando di irrompere nell'edificio del Parlamento dove
oggi il testo è stato approvato in prima lettura. Lo riportano i media locali
che stanno diffondendo immagini delle proteste, che la polizia ha già cercato di
disperdere con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.
22:15
Capo esercito:
"Situazione a Bakhmut discussa con generali Nato e Usa"
Il comandante in
capo delle forze armate ucraine, il generale Valerii Zaluzhnyi, ha annunciato su
Telegram di aver discusso della situazione a Bakhmut con i generali degli Stati
Uniti e dei Paesi Nato. "Prima di tutto, li ho informati della situazione sul
campo di battaglia. Mi sono concentrato sulla direzione orientale nel modo più
dettagliato. In particolare, sulla situazione a Bakhmut", ha dichiarato il
comandante in capo. "Abbiamo discusso della fornitura di aiuti militari,
comprese armi e munizioni, in modo non meno dettagliato. Le questioni relative
al rafforzamento della difesa aerea e alla fornitura di armi a lungo raggio
rimangono cruciali", ha aggiunto.
22:33
8 marzo: auguri
Putin a militari donna, "svolgete missione alta"
Il leader del
Cremlino, Vladimir Putin, ha inviato i suoi auguri alle donne in occasione
dell'8 marzo, che in Russia è un giorno festivo. Per noi è una giornata, ha
detto in un video messaggio, "sempre piena di calore e significato speciali,
perchè il rispetto della donna e la maternità sono per un noi un valore
assoluto, tramandato di generazione in generazione". Mentre la guerra in Ucraina
è entrata nel suo secondo anno, il presidente russo si è rivolto in particolare
alle "donne militari, che hanno scelto per se stesse la missione più alta: la
difesa della patria". "Il vostro coraggio e la vostra determinazione stupiscono
anche i combattenti più esperti", ha sottolineato Putin, "nei momenti difficili,
la sensibilità e la reattività del cuore femminile si trasformano sempre in una
forza potente che indica la linea di condotta più corretta, giusta e necessaria.
E' così sta accandendo ora".
(ANSA-AFP il 7 marzo
2023) - Il prigioniero ucraino ucciso a sangue freddo dalle forze armate di
Mosca è stato identificato. Secondo quanto riportato dall'esercito ucraino su
Telegram, "la vittima è Tymofiy Mykolayovych Shadura, un soldato della 30a
brigata", che ha preso parte ai combattimenti nei pressi di Bakhmut, considerato
disperso dal 3 febbraio. Secondo alcuni media l'uomo aveva 40 anni.
Sulla pagina
ufficiale della 30esima Brigata separata meccanizzata, di cui farebbe parte il
soldato ucciso nel video shock diffuso ieri in rete, i commilitoni di Tymofiy
Mykolayovych Shadura lo ricordano con un post: "Il comando della trentesima
brigata e i fratelli dell'eroe esprimono sincere condoglianze alla sua famiglia
e ai suoi cari.
La vendetta sarà
inevitabile". La brigata aggiunge che il corpo del soldato al momento si trova
"nel territorio temporaneamente occupato" e che "la conferma finale della
persona sarà stabilita dopo il rientro e dopo gli esami pertinenti". Nel
pomeriggio di ieri anche il presidente ucraino aveva commentato la notizia:
"L'Ucraina non dimenticherà mai l'impresa di tutti coloro che hanno dato la vita
per la libertà dell'Ucraina".
Estratto
dell'articolo di Anna Zafesova per “La Stampa” il 7 marzo 2023.
«Se non veniamo
aiutati qui finisce in c... a tutti». Evgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo
Wagner, ormai non ha remore nel presentarsi come l'unico in grado di conquistare
per il Cremlino la «fortezza Bakhmut», e nell'accusare gli stessi militari russi
di remargli contro.
Vladimir Putin
vuole questa città, ormai quasi rasa al suolo dalla sua artiglieria, come primo
trofeo da mostrare ai russi dopo più di sette mesi in cui non è riuscito a far
avanzare bandierine sulla mappa dei combattimenti. E di conseguenza, Bakhmut
diventa il premio che si contendono i due eserciti di Putin, quello «pubblico»,
ufficiale, che risponde al ministero della Difesa, e quello privato, il gruppo
Wagner di Evgeny Prigozhin [...]
Ieri ha accusato di
nuovo il ministero della Difesa di non consegnare ai suoi uomini le munizioni
richieste. Ha sostenuto che «tutti i documenti erano stati firmati», ma i suoi
mercenari sono stati costretti a ingaggiare dei combattimenti corpo a corpo con
le truppe ucraine, utilizzando come armi le vanghe. «Stiamo ancora cercando di
capire se è semplice burocrazia o tradimento», ha aggiunto minacciosamente
[...]
Il capo di Wagner
aveva rivendicato il merito esclusivo di aver preso Soledar, e proclamato
diverse volte la caduta imminente di Bakhmut (ieri invece è stato molto più
prudente, ammettendo che «l'accerchiamento della città non è ancora concluso e
potrebbe non esserlo mai»). Il risultato di questa campagna di autopromozione
molto aggressiva è stato il boicottaggio dei Wagner da parte dei militari.
Secondo alcuni
esperti militari russi, Prigozhin è finito nella trappola delle sue stesse
ambizioni: i generali hanno mandato i suoi mercenari all'attacco per dissanguare
i ranghi dell'«orchestra», inclusi i circa 40 mila detenuti che il «cuoco di
Putin» ha avuto il permesso di arruolare dalle carceri con la promessa della
grazia (prerogativa del presidente) ai sopravvissuti dopo sei mesi.
Ma resta anche il
dubbio che gli spietati Wagner siano stati molto più efficienti delle truppe
regolari, seppure a prezzo di perdite terribili: la Cnn ieri parlava di un
rapporto di 5 caduti russi per ogni ucraino.
Ora è il ministero
della Difesa ad arruolare i detenuti, e Prigozhin si rende conto di stare
sfidando il sistema, e rilancia con l'accusa che i generali preferiscono perdere
Bakhmut pur di distruggere i Wagner. Una denuncia che chiaramente è diretta
verso il Cremlino, che però potrebbe non gradire più un personaggio che sta
sconfinando pesantemente in territori proibiti.
[…] La brutale
aggressività di Prigozhin piace a molti russi delusi dalla noia corrotta
dell'establishment putiniano, e un comandante che dice pane al pane mentre
divide il pane con i suoi soldati – a differenza di Putin che sempre più spesso
appare anche alle cerimonie in remoto, un ologramma su uno schermo. Prigozhin si
sporca le mani, dice parolacce, paga i funerali ai suoi soldati-detenuti e si
propone come un «uomo d'onore», forte dei suoi trascorsi criminali che lo
rendono molto più credibile agli occhi dei suoi mercenari rispetto al
presidente, che spesso si atteggia a «duro», ma in fondo si è laureato in legge
all'università di Pietroburgo.
La Repubblica.
Borrell: "Piano da 2 miliardi per armi Ue a Kiev"
La richiesta del
ministro della Difesa alla Ue. Gli Stati Uniti, secondo Politico, stanno
valutando se è possibile integrare gli avanzati missili aria-aria occidentali
sui jet ucraini dell'era sovietica. Il Gruppo Wagner rivendica la conquista
della parte Est della cittadina contesa
"Potenti esplosioni
sono state sentite questa sera a Melitopol, città ucraina del sud, nel luogo in
cui si stavano radunando gli occupanti russi". Lo ha reso noto il sindaco Ivan
Fedorov, in esilio, su Telegram. Gli Stati Uniti intanto, secondo quanto riporta
Politico, stanno valutando se è possibile integrare gli avanzati missili
aria-aria occidentali sui jet ucraini dell'era sovietica.
Punti chiave
11:27
Zelensky: "Se i
russi prendono Bakhmut avranno la strada aperta"
11:03
NordStream, procura
tedesca: c'era un'imbarcazione sospetta
10:45
Cremlino: "Gruppo
pro-ucraino dietro attacco a NordStream? È tentativo di depistaggio"
00:56
Usa valutano missili
aria-aria per i MiG Kiev
Gli Stati Uniti
stanno valutando se è possibile integrare gli avanzati missili aria-aria
occidentali sui jet ucraini dell'era sovietica. Lo riporta Politico citando
alcune fonti, secondo le quali l'ipotesi è quella di verificare se i missili
avanzati a medio raggio aria-aria AIM-20, progettati per essere lanciati da jet
come gli F-16, possono essere montati sugli esistenti MiG. Se le verifiche
avranno successo, gli Stati Uniti potrebbero rafforzare le difese aeree di Kiev.
03:21
Presidente Svizzera
Berset all'Onu, restiamo neutrali
Di fronte al
conflitto ucraino, la Svizzera intende preservare la sua neutralità prevista
dalla Costituzione e rimane quindi per il momento contraria al trasferimento di
armi in questo Paese in guerra. Lo ha detto il presidente della Confederazione
elvetica Alain Berset, in visita all'Onu. "Il dibattito sulle esportazioni di
armi, finchè abbiamo questo quadro giuridico in Svizzera, non è possibile farlo"
ha detto Berset ai giornalisti a margine delle riunioni delle Nazioni Unite sui
diritti delle donne. D'altra parte, il suo governo rimane inflessibile sulla
neutralità storica del Paese. Nonostante le pressioni di Kiev e dei suoi alleati
per consentire la riesportazione di armi e munizioni svizzere a Kiev, Berna ha
finora respinto le richieste di Germania, Spagna e Danimarca. Diverse iniziative
sono in corso nel Parlamento svizzero per allentare queste regole, ma non è
prevista alcuna decisione per diversi mesi. Berset ha incontrato a New York il
segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.
04:50
Slovenia, no a
dichiarare Russia sponsor terrorismo
La commissione per
la Politica estera della Camera bassa del Parlamento sloveno ha respinto la
proposta di designare la Russia come "uno Stato sponsor del terrorismo", riporta
l'Agenzia di stampa della Slovenia (Sta). La proposta era stata avanzata dal
Partito democratico sloveno (Sds) e dal suo leader, l'ex primo ministro Janez
Jansa. Il 23 novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che
menziona la Russia come uno Stato sponsor del terrorismo.
05:49
Capo forze armate
vede comandanti Usa, Uk e Polonia
Il comandante in
capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi ha riferito di aver incontrato
quattro leader militari di paesi occidentali.
Zaluzhnyi ha
spiegato su Telegram di aver visto ieri il generale americano Christopher
Cavoli, comandante del Comando alleato Nato supremo in Europa (Saceur);
l'ammiraglio britannico Tony Radakin, capo di Stato maggiore della difesa del
Regno Unito; il generale polacco Rajmund Andrzejczak, capo di Stato maggiore
delle forze armate della Polonia; il tenente generale americano Antonio Aguto,
comandante del Gruppo assistenza e sicurezza Ucraina. Il comandante in capo
delle forze armate ucraine ha affermato di averli informati della situazione sul
campo di battaglia, in particolare a Bakhmut. E' stata anche discussa - ha
scritto Zaluzhnyi - la fornitura di aiuti militari all'Ucraina, comprese armi e
munizioni.
06:38
Wagner, preso
completo controllo parte est Bakhmut
Le forze russe hanno
preso il pieno controllo della parte orientale della città ucraina di Bakhmut,
ha comunicato oggi la Wagner. "Tutto a est del fiume Bakhmutka è completamente
sotto il controllo della Wagner", ha affermato sul suo canale Telegram il
fondatore del gruppo mercenario Evgeny Prigozhin.
08:29
La Difesa ucraina:
"Non c'entriamo con il sabotaggio di NordStream"
"Non c'entriamo
nulla con l'operazione di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream: sarebbe
un bel complimento per i nostri servizi speciali, ma quando si concluderanno le
indagini si vedrà che l'Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò". Lo ha
detto Oleksii Reznikov, Ministro della Difesa ucraino arrivando al consiglio
difesa informale di Stoccolma.
08:59
8 Marzo, Putin loda
il coraggio delle donne-soldato
Il presidente russo
Vladimir Putin ha rivolto un messaggio alle donne soldato impegnate nella guerra
in Ucraina in occasione della Giornata internazionale della donna. "Nei momenti
difficili, nei momenti di prova, la reattività del cuore femminile si trasforma
sempre in una forza potente che indica la linea di condotta più corretta, giusta
e necessaria. Questo sta accadendo ora", ha detto Putin congratulandosi -
riporta la Ria Novosti - con "le donne soldato che hanno difeso la loro patria,
medici, paramedici e infermiere che hanno soccorso i feriti. Il loro coraggio
impressiona anche i combattenti esperti".
09:17
Von der Leyen:
"Onore alle donne che combattono per l'Ucraina e a Zelenska"
"Nella Giornata
internazionale della donna rendo onore alle donne che sono un'ispirazione per
tutti noi. Le donne dell'Ucraina. Coloro che, arruolandosi nell'esercito, hanno
infranto un soffitto di vetro sopra la testa degli invasori russi, E quelle che
sono diventate forze indistruttibili per il bene, come Zelenska". Così la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.
09:29
Kiev: "Abbiamo
bisogno di un milione di munizioni"
"Ci servono un
milione di munizioni da 155, 90-100 mila al mese per poterci difendere e
rilanciare la nostra controffensiva". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa
ucraino, Oleksii Reznikov, al suo arrivo alla riunione informale degli omologhi
Ue a Stoccolma. "Condividiamo il piano estone che stima servano 4 miliardi di
euro per consegnare il milione di munizioni", ha spiegato. Reznikov ha inoltre
chiesto "difesa anti-aerea, blindati e carri armati" per respingere l'attacco
russo.
10:04
Commissario Ue
Breton: "Serve economia di guerra per mandare armi a Kiev"
"Siamo arrivati a un
momento cruciale del nostro sostegno per l'Ucraina, è assolutamente obbligatorio
che ci si muova in una sorta di economia di guerra per l'industria della difesa,
dobbiamo fare 'whatever it takes' per fornire l'Ucraina di munizioni. Ecco
perché oggi presentiamo il nostro piano in tre fasi". Lo ha detto Thierry
Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, arrivando al consiglio
informale Difesa a Stoccolma.
10:25
Kiev: distrutti due
droni kamikaze russi
Le forze di difesa
dell'Ucraina nella notte hanno distrutto due droni kamikaze del tipo
Shahed-131/136 lanciati dai russi. Lo ha riferito l'aeronautica militare
ucraina, come riporta Ukrinform. "A mezzanotte dell'8 marzo, la difesa antiaerea
ha distrutto due droni kamikaze iraniani Shahed-131/136, che gli invasori hanno
utilizzato per attaccare l'Ucraina da nord", si legge nel messaggio su Telegram.
10:45
Cremlino: "Gruppo
pro-ucraino dietro attacco a NordStream? È tentativo di depistaggio"
Il Cremlino ha
respinto le indiscrezioni di stampa secondo le quali un "gruppo pro-ucraino"
sarebbe all'origine del sabotaggio dell'anno scorso ai gasdotti russi NordStream
1 e 2, considerando che si è trattato di un tentativo di "distogliere
l'attenzione". Sulla base di informazioni ottenute dall'intelligence Usa, il
quotidiano New York Times ha attribuito la responsabilità del sabotaggio a un
gruppo pro-ucraino, ma senza che il presidente Volodymyr Zelensky risulti
coinvolto. "È chiaro che gli autori dell'attacco vogliono distogliere
l'attenzione - ha detto il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri
Peskov - È chiaro che si tratta di un colpo mediatico concordato: questa vicenda
non è solo strana, assomiglia a un crimine mostruoso".
Peskov ha chiesto
quindi una "inchiesta trasparente urgente" e ha insistito che anche la Russia
sia coinvolta nell'inchiesta internazionale sul sabotaggio dei due importanti
gasdotti. "Continuiamo a non essere autorizzati a partecipare all'inchiesta.
Appena qualche giorno fa, abbiamo ricevuto indicazioni su questo da Danimarca e
Svezia". Quanto all'Ucraina, oggi il ministro ucraino della Difesa, Oleksyi
Reznikov, ha assicurato che Kiev non è coinvolta nelle esplosioni che alla fine
dello scorso settembre hanno danneggiato i gasdotti.
11:03
NordStream, procura
tedesca: c'era un'imbarcazione sospetta
Nel corso delle
indagini sulle esplosioni dei gasdotti NordStream 1 e 2, la Procura federale
generale tedesca conferma di aver individuato un'imbarcazione sospetta e di
averla fatta perquisire lo scorso gennaio.
L'imbarcazione
potrebbe essere stata utilizzata per trasportare gli esplosivi. Lo riporta Dpa.
Non sono stati comunicati ulteriori dettagli su possibili autori o moventi.
11:27
Zelensky: "Se i
russi prendono Bakhmut avranno la strada aperta"
Le truppe russe
avranno "strada aperta" per conquistare città chiave nell'Ucraina orientale se
prenderanno il controllo di Bakhmut. Lo ha detto il presidente Volodymyr
Zelensky in un'intervista alla Cnn, difendendo la sua decisione di mantenere le
forze ucraine nella città assediata. "Per noi è una questione tattica", ha detto
Zelensky, insistendo sul fatto che i vertici militari di Kiev sono uniti nel
prolungare la difesa della città dopo che settimane di attacchi russi l'hanno
lasciata sul punto di cadere sotto le truppe di Mosca. "Capiamo che dopo Bakhmut
potrebbero andare oltre. Potrebbero andare a Kramatorsk, a Sloviansk, sarebbe
una strada aperta per i russi dopo Bakhmut verso altre città in ucraina, in
direzione di Donetsk", ha detto alla Cnn in un'intervista esclusiva da Kiev:
"Ecco perché i nostri ragazzi sono lì".
Zelensky ha detto
che le motivazioni per mantenere la città sono "molto diverse" dagli obiettivi
della Russia: "Capiamo cosa vuole ottenere la Russia. La Russia ha bisogno
almeno di una vittoria - una piccola vittoria - anche rovinando tutto a Bakhmut,
uccidendo ogni civile", ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che se la
Russia riuscisse a "mettere la propria bandierina" in cima a Bakhmut, aiuterebbe
a "mobilitare la società per creare l'idea di essere un esercito così potente".
11:56
Berlino: a marzo 21
carri armati Leopard 2 a Kiev
L'Ucraina riceverà
entro questo mese 21 carri armati Leopard 2A6, 18 dalla Germania e tre dal
Portogallo. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius da
Stoccolma, dove è in corso la riunione informale dei ministri della Difesa Ue.
12:14
NordStream, Mosca:
"Ci diranno che è stato un delfino"
"Non sarei sorpresa
se, dopo una presunta inchiesta, gli occidentali e i loro giornali stabilissero
che il Nord Stream è stato distrutto da un delfino-attentatore fuggito dalla
Crimea in Ucraina". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo,
Maria Zakharova, commentando l'articolo del New York Times secondo il quale,
stando a fonti americane, l'attacco sarebbe stato compiuto da un non meglio
precisato gruppo pro-ucraino. Washington e Londra, aggiunge Zakharova sul suo
canale Telegram, stanno solo "utilizzando indiscrezioni controllate" per
sostenere i loro interessi. "Mi chiedo - scrive ancora la portavoce - chi
autorizza tali indiscrezioni. E la risposta è che sono coloro che non vogliono
condurre un'inchiesta legale, e vogliono distogliere l'attenzione del pubblico
dai fatti in ogni modo possibile". Invece di far uscire indiscrezioni, conclude
Zakharova, "i regimi occidentali coinvolti nell'accaduto devono rispondere alle
richieste ufficiali della parte russa (per un'inchiesta) e, come minimo,
prendere in considerazione l'inchiesta giornalistica di Seymour Hersh". Cioè il
giornalista americano Premio Pulitzer secondo il quale l'attacco è stato
compiuto dagli Usa con la complicità della Norvegia.
12:39
Stoltenberg: "Non
escludiamo che Bakhmut cada a breve"
"Non possiamo
escludere che Bakhmut possa cadere nei prossimi giorni, questo non sarà
necessariamente una svolta nella guerra ma evidenzia solo che non dobbiamo
sottovalutare la Russia e dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina". Lo ha
detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg arrivando al consiglio
informale difesa a Stoccolma.
13:04
La Ue pronta ad
estendere al 2025 la protezione temporanea per i profughi ucraini
"L'Unione europea è
pronta a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. La protezione è già
stata prorogata fino al marzo 2024 e può essere ulteriormente prorogata fino al
2025. la Commissione è pronta ad adottare le misure necessarie per un'ulteriore
proroga, se necessario". Lo ha annunciato la Commissione europea presentando il
primo rapporto annuale sull'applicazione della direttiva per la protezione
temporanea concessa agli ucraini in fuga dal Paese in seguito all'invasione
russa. "Allo stesso tempo l'Ue perseguirà un solido approccio coordinato a
livello europeo per garantire una transizione agevole verso status giuridici
alternativi che consentano l'accesso ai diritti oltre la durata massima della
protezione temporanea, nonchè un sostegno mirato per le persone che, fuggite
dall'Ucraina, desiderano ritornare a casa", spiega l'esecutivo europeo.
La direttiva è stata
attivata per la prima volta il 4 marzo 2022. Da allora circa 4 milioni di
persone hanno ottenuto una protezione immediata nell'Ue, di cui oltre 3 milioni
nella prima metà del 2022. A tutte le persone registrate è stato accordato il
diritto di accedere al mercato del lavoro, all'istruzione, all'assistenza
sanitaria e all'alloggio.
13:20
Mosca: "Intense
operazioni militari in Donetsk"
Le forze russe hanno
condotto intense operazioni nelle ultime 24 ore nel Donetsk con bombardamenti
aerei e di artiglieria. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa,
Igor Konashenkov, aggiungendo che "oltre 180 soldati ucraini sono stati
eliminati".
13:42
Stoltenberg: ancora
non sappiamo chi ha colpito il NordStream
"Ciò che sappiamo è
che c'è stato un attacco contro i gasdotti del NordStream ma non siamo stati in
grado di determinare chi fosse dietro" l'attacco. A dichiararlo è stato il
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Stoccolma. "Vi sono in corso
indagini nazionali e credo che sia giusto attendere che siano concluse prima di
dire altro su chi ci sia dietro" l'attacco, ha aggiunto.
14:24
Guterres a Kiev:
incontrerà Zelensky per parlare dell'accordo sul grano
Il segretario
generale delle nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Kiev, in Ucraina,
dove ha in programma di discutere l'estensione dell'accordo sul grano nel Mar
Nero: lo ha confermato un portavoce del leader Onu.
"Il segretario
generale è a Kiev. Più tardi in giornata incontrerà Zelensky per discutere la
continuazione della black sea grain initiative in tutti i suoi aspetti, così
come altre questioni pertinenti", si legge in un messaggio su twitter.
15:00
Ucraina: Sky, Iran
ha fornito a Russia milioni di munizioni e artiglieria
L'Iran ha
fornito segretamente alla Russia grandi quantità di proiettili, razzi e
proiettili da mortaio e avrebbe intenzione di inviarne altri. Lo rivela Sky
News citando una fonte della sicurezza. La fonte ha affermato che due navi da
carico battenti bandiera russa sono partite da un porto iraniano a gennaio
dirette in Russia attraverso il Mar Caspio, trasportando circa 100 milioni di
proiettili e circa 300.000 munizioni. Nella spedizione, sempre secondo la fonte,
sarebbero state incluse munizioni per lanciarazzi, mortai e mitragliatrici. La
Russia avrebbe pagato il tutto in contanti.
15:11
Grano: Guterres a
Kiev, fondamentale estensione accordo
Il segretario
generale dell'Onu Antonio Guterres in visita a Kiev ha affermato che è
"fondamentale" che venga esteso l'accordo con Mosca sull'esportazione di grano
dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo riporta il Guardian. L'accordo di 120
giorni, inizialmente mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia a luglio e
prorogato a novembre, sarà rinnovato il 18 marzo se nessuna delle parti si
oppone. Dopo il colloquio con Guterres anche il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky ha sottolineato che l'accordo è necessario non solo per l'Ucraina, ma
per il mondo intero.
15:21
Ucraina: Borrell,
per arrivare a pace Kiev deve vincere
"Per ottenere la
pace, l'Ucraina deve vincere la guerra". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante
dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine della riunione
informale dei ministri della Difesa Ue a Stoccolma.
15:36
Borrell: "Piano da
due miliardi per mandare munizioni a Kiev"
"Ho presentato un
piano da due miliardi di euro per fornire più munizioni all'Ucraina e spero che
i ministri della Difesa e degli Esteri che si riuniranno il 20 marzo lo possano
approvare definitivamente". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per
la Politica estera, Josep Borrell, al termine della riunione informale dei
ministri della Difesa Ue a Stoccolma. "Il piano si basa su tre binari, un
miliardo per la fornitura di munizioni 155 e 152 mm; un miliardo per nuovi
acquisti aggiunti e per ricostituire le scorte degli Stati e un piano a lungo
termine per l'industria della difesa", ha spiegato il capo della diplomazia
europea.
"La situazione
militare sul terreno rimane molto difficile. In particolare a Bakhmut", ha detto
Borrell che ha anche comunicato il numero di soldati ucraini addestrati dall'Ue:
più di 11mila ed "entro la fine dell'anno prevediamo di addestrare 30.000
soldati".
16:00
Corte Ue annulla
sanzioni contro madre Prigozhin
La Corte Ue ha
annullato le sanzioni imposte alla madre del proprietario del gruppo
Wagner, Prigozhin, perché si basavano esclusivamente sul fatto che i due sono
imparentati. Violetta Prigozhina era stata inserita nella lista delle sanzioni
dell'Unione Europea perché considerata proprietaria della Concord Management and
Consulting LLC, parte del gruppo fondato e posseduto fino al 2019 dal figlio. Ma
il Tribunale di Lussemburgo ha dichiarato di voler ritirare le sanzioni perché
la donna ha smesso di essere proprietaria della società nel 2017, anche se ha
mantenuto alcune azioni della stessa.
16:06
Georgia: migliaia a
nuova manifestazione davanti Parlamento
Migliaia di
manifestanti sono tornati a radunarsi oggi pomeriggio sulla piazza antistante il
Parlamento a Tbilisi per protestare contro la legge sugli 'agenti stranieri'
approvata ieri dall'assemblea in prima lettura. Lo riferisce l'agenzia
russa Interfax. Prendendo la parola, Levan Khabeishvili, leader del partito di
opposizione georgiano Movimento unito nazionale, ha fatto un appello per tenere
manifestazioni quotidiane fino alla revoca della normativa e ha bruciato
pubblicamente dei fogli su cui ha detto che era stampato il testo della legge.
16:42
Zelensky,
Zaporizhzhia deve tornare sotto controllo ucraino
Il Presidente
ucraino Volodymyr Zelensky e il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio
Guterres hanno discusso la questione della fine del 'ricatto nucleare' della
Russia e del ripristino della sicurezza delle centrali nucleari ucraine. Lo
riporta Ukrinform. "Oggi abbiamo discusso su come fermare il ricatto nucleare
della Russia e ripristinare la sicurezza di tutte le centrali nucleari ucraine,
che è stata violata dalla Russia, in particolare la sicurezza della centrale
nucleare di Zaporizhzhia. La centrale nucleare di Zaporizhzhia deve tornare
sotto il pieno controllo dell'Ucraina: è una questione di sicurezza globale, non
solo di sicurezza ucraina", ha dichiarato Zelensky nel corso della conferenza
stampa con Guterres.
16:49
Capo 007 Usa, Putin
pensa ancora di poter battere Kiev
I controlli imposti
alle esportazioni stanno ostacolando gli sforzi della Russia nella guerra
all'Ucraina. Lo afferma la direttrice della National Intelligence
americana Avril Haines, secondo la quale - riporta l'agenzia Bloomberg - il
presidente russo Vladimir Putin probabilmente ritiene ancora di poter battere
Kiev.
17:12
Zelensky invita
McCarthy a Kiev, deve vedere quello che succede
Volodymyr Zelensky
ha invitato lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, a visitare l'Ucraina
per vedere di persona la situazione sul campo. "Deve venire qui per vedere
quello che la guerra ha causato, le persone che stanno combattendo e cosa è
successo. Soltanto dopo potrà fare le sue valutazioni", ha detto il leader
ucraino in un'intervista alla Cnn riferendosi alle dichiarazioni del
repubblicano che, in passato, ha detto di non voler più "staccare assegni in
bianco" all'Ucraina. "Quando i democratici e i repubblicani vengono in visita
qui, possono vedere dove è andato a finire ogni aiuto, ogni proiettile, ogni
dollaro", ha detto ancora Zelensky ringraziando il Congresso americano per il
supporto bipartisan. Alla domanda se sia preoccupato che il sostegno possa
essere ridotto se non addirittura interrotto per volere dei repubblicani il
presidente ucraino ha risposto di aver avuto diversi incontro con deputati e
senatori del Grand old party che gli hanno assicurato "che vogliono sostenerci,
come i democratici". "Non ci interessa da che parte arrivi il sostegno finché è
forte e costante".
17:33
Capo Wagner,
sanzioni Ue contro di me "ragionevoli"
Il capo del gruppo
mercenario russo Wagner, Evgheni Prigozhin, ha dichiarato che le sanzioni
europee contro di lui e la società di contractor da lui fondata sono
giustificate e non ha intenzione di contestarle in tribunale. "Per quanto
riguarda la contestazione delle sanzioni contro di me e contro la compagnia Pmc
Wagner, non le contesterò e credo che al momento siano imposte in modo
abbastanza ragionevole", ha affermato in una nota.
18:21
Rutte: "Diamo
messaggio unico, in Europa uniti per la vittoria di Kiev"
"Noi diamo messaggio
unito, unico, che in Europa siamo uniti contro la Russia: l'Ucraina deve vincere
e la Russia deve perdere, anche per la nostra sicurezza", ha affermato il
Premier olandese, Mark Rutte, a Roma, dopo aver incontrato Giorgia Meloni per
cui ha espresso "grande ammirazione, per la responsabilità che fa vedere
l'Italia nel suo sostegno all'Ucraina, ora ma anche a lungo termine. Anche la
visita della presidente del Consiglio Meloni in Ucraina qualche settimana fa è
importante", ha aggiunto.
18:54
Russia, per disegno
contro guerra 12enne trasferita in orfanotrofio senza contatti con casa
Non potrà ricevere
visite o contattare il padre al telefono la 12enne russa Maria
Moskalova trasferita in un orfanotrofio dopo la condanna di Aleksei Moskalev, il
padre, agli arresti domiciliari per discredito dei militari, in un procedimento
aperto per un disegno contro la guerra fatto dalla figlia a scuola, denuncia Ovd
Info.
19:03
Wagner, entrati in
villaggio a nord di Bakhmut
"Le truppe Wagner
sono entrate nel villaggio di Dubovo-Vasilyevka a nord di Bakhmut. Sono in corso
pesanti combattimenti". Lo scrive la milizia stessa sul proprio canale Telegram.
19:31
007 Usa, improbabile
che Russia conquisti ulteriore territorio
"È improbabile che
la Russia quest'anno conquisti ulteriore territorio in Ucraina". È quanto
afferma la direttrice dell'intelligence degli Stati Uniti Avril Haines, come
riporta il Guardian. Durante un'udienza al Senato, Haines ha affermato che i
soldati russi non saranno in grado di portare avanti il loro attuale livello di
combattimento, anche se dovessero riuscire a conquistare Bakhmut. Dopo
importanti battute d'arresto e grandi perdite sul campo di battaglia, "non
prevediamo che quest'anno l'esercito russo si riprenderà abbastanza per ottenere
importanti conquiste territoriali", ha aggiunto Haines.
19:48
Svizzera: tesoro
Putin, al via processo collegato al prestanome
E' cominciato, in un
tribunale a Zurigo, il processo contro quattro ex dipendenti della filiale
svizzera della banca Gazprombank: sono tre russi e uno svizzero accusati di aver
aiutato Sergei Roldugin, violoncellista russo molto vicino a Vladimir Putin, a
riciclare fondi sospettati di appartenere al presidente russo. Roldugin, così
vicino a Putin al punto si dice che sia il padrino di una delle figlie, è
sospettato di aver portato all'estero parte della fortuna del capo del Cremlino.
L'accusa chiede sette mesi di reclusione con la condizionale per mancanza di
'due diligence' nella gestione finanziaria. Si calcola che Roldugin abbia
trasferito circa 30 milioni di franchi svizzeri (30 milioni di euro) da società
intestate al musicista con sedi a Panama e Cipro senza che i responsabili di
Gazprombank effettuassero le necessarie verifiche e senza che lui desse alcuna
spiegazione credibile sulla provenienza del denaro (all'epoca si presentava come
un violoncellista dal reddito modesto). Roldugin è attualmente nell'elenco dei
cittadini russi soggetti a sanzioni da parte del governo svizzero e, secondo
l'accusa, tutti gli indizi indicano che non fosse il vero proprietario dei beni
nei suoi precedenti conti in Gazprombank, che sono stati chiusi nel 2016. La
legge svizzera obbliga le banche a porre fine a una relazione d'affari in caso
di dubbio sull'identità del cliente; e il processo viene considerato un pò una
cartina di tornasole di quanto rigorosamente la Svizzera applichi le sue leggi
sul riciclaggio di denaro, leggi che, almeno sulla carta, sono piuttosto severe.
19:59
Nord Stream:
Spiegel, per agguato usata barca a vela da 15 metri
I presunti
responsabili dell'agguato ai gasdotti Nord Stream avrebbero utilizzato per la
loro azione una barca a vela di oltre 15 metri con un motore diesel. È quello
che scrive der Spiegel, in un'anticipazione del prossimo numero in edicola nel
weekend. L'imbarcazione, prosegue il settimanale, è una di quelle offerte da
un'impresa del Land tedesco del Meclemburgo Pomerania Anteriore. A bordo può
ospitare massimo 11 persone e ha 5 cabine. Noleggiarla per una settimana a
settembre costa 3000 euro. L'azienda che le produce non ha voluto rilasciare
dichiarazioni.
20:18
Georgia: idranti per
disperdere proteste dinanzi Parlamento
A Tblisi, la polizia
ha utilizzato cannoni ad acqua per cercare di disperdere i numerosi manifestanti
riuniti vicino al Parlamento, che protestavano per la legge sugli "agenti
stranieri", ritenuta uno strumento per contrastare il dissenso, sul modello di
una simile legge già in vigore in Russia dal 2012. Alcuni manifestanti hanno
cercato di entrare nell'edificio, ma sono stati respinti.
21:01
Presidente Polonia,
necessario addestrare ucraini a usare F-16
"L'addestramento dei
piloti ucraini per far funzionare i caccia F-16 è "necessario". Lo ha detto il
presidente della Polonia Andrzej Duda alla Cnn, ritenendo che le forze armate
ucraine vogliano essere "all'altezza degli standard Nato" e quindi vorranno
utilizzare aerei da combattimento F-16. "L'addestramento dei piloti dell'Ucraina
è importante ed è abbastanza necessario", ha aggiunto.
21:07
Razzi su Nikopol, 6
feriti tra cui 2 bambini
"Il nemico ha
colpito il distretto di Nikopol della regione di Dnipropetrovsk con missili Grad
e artiglieria pesante. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini". Lo
ha scritto su Telegram il capo del comando militare regionale di
Dnipropetrovsk Serhiy Lysak, aggiungendo che "i russi hanno diretto il loro
attacco contro le comunità di Marganetska, Chervonogrihorivska e Nikopol". 24
case private sono state danneggiate in città. Una di loro ha preso fuoco. I
vigili del fuoco hanno già spento l'incendio. 7 annessi sono stati parzialmente
distrutti. 20 pannelli solari, 4 linee elettriche e 2 fornaci a gas sono stati
danneggiate.
21:12
Georgia: Zelensky
auspica il "successo democratico"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha auspicato un "successo democratico" in
Georgia, dove migliaia di manifestanti si sono radunati contro una controversa
legge sugli "agenti stranieri" che ricorda la legislazione russa utilizzata per
mettere a tacere i critici. "Non c'è ucraino che non auguri il successo alla
nostra amica Georgia. Successo democratico. Successo europeo", ha detto Zelensky
nel suo discorso serale alla nazione.
21:20
Zelensky, la Georgia
e la Moldavia entrino in Ue, come l'Ucraina
"Vogliamo essere
nell'Unione europea e lo saremo. Vogliamo che anche la Georgia entri nell'Unione
europea, e sono sicuro che ci sarà. Ma vogliamo anche la Moldavia nell'Ue, e ci
sarà. Tutti i popoli liberi d'Europa se lo meritano". Lo ha detto il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Lo scrive Unian.
21:32
Duda: "Pronti a
fornire Mig-29 a Kiev"
La Polonia è pronta
a consegnare i suoi aerei da combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica
all'Ucraina. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej Duda, precisando che
"siamo pronti a consegnare questi velivoli e sono sicuro che l'Ucraina sarebbe
pronta a usarli immediatamente". "Per il futuro - ha aggiunto Duda parlando in
occasione della sua visita ad Abu Dhabi - sarebbe importante addestrare più
piloti ucraini sui caccia F-16 statunitensi". La discussione sui MiG-29 polacchi
è già sorta lo scorso anno poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Secondo gli
esperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul
fianco orientale della Nato.
21:35
Berlino, aumenteremo
sostegno a Kiev se armi da Cina a Russia
La Germania
"aumenterà il sostegno all'Ucraina se la Cina fornirà armi alla Russia". Lo ha
detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, alla
radio Deutschlandfunk.
21:44
Usa a Tbilisi,
rispettare "manifestazioni pacifiche"
Gli Stati Uniti
hanno invitato le autorità georgiane a "rispettare le manifestazioni pacifiche",
affermando di essere "solidali con il popolo georgiano" che sta protestando
contro una legge che minaccia i media e le ONG e che i critici paragonano a una
legge russa sulla libertà di riunione. "Chiediamo al governo della Georgia di
rispettare la libertà di riunione e di protesta pacifica", ha dichiarato il
portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, ribadendo la
"preoccupazione" degli Stati Uniti per la legge.
21:59
Zelensky, battaglia
per Bakhmut e per il Donbass è la priorità
"Ho tenuto un
incontro con i militari e l'intelligence. La linea del fronte, la battaglia
per Bakhmut e per l'intero Donbass è la nostra priorità". Lo ha detto il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale. Lo
riporta Ukrinform. "Stiamo facendo di tutto per garantire che le nostre scelte
tattici contribuiscano a questo obiettivo strategico e sono grato a ciascuno dei
nostri combattenti", ha aggiunto.
22:53
Ucraina, Nyt:
"Pentagono frena Biden su prove atrocità russe"
Il Pentagono sta
bloccando l'amministrazione Biden dal fornire prove sulle atrocità russe alla
Corte Internazionale dell'Aja. Lo riporta il New York Times che cita fonti
dell'amministrazione. I vertici della Difesa americana temono che questo
meccanismo potrebbe costituire un precedente e che in futuro potrebbe spingere
altri Paesi, a cominciare dalla stessa Russia, a mettere sotto inchiesta gli
Stati Uniti. Il presidente Joe Biden, secondo il quotidiano newyorkese, non ha
ancora deciso cosa fare.
L'inchiesta a cui
Washington sta collaborando, fornendo prove, riguarda le atrocità commesse dai
russi in Ucraina e di cui si sta occupando Karim Khan, a capo della procura
della Corte penale internazionale.
l ricatto di
Vladimir Putin alla Moldova: se vuoi sopravvivere non guardare all’Europa.
La
piccola repubblica teme l’offensiva per la sua posizione strategica. La Russia
ha già gettato un ponte verso la Transnistria e il Paese dipende ancora troppo
dal gas di Mosca. Mario Bonito su L’Espresso il 7 marzo 2023.
Un vento gelido
sferza il mercato centrale di Chişinău, la capitale della Moldova, nell’ora di
punta il luogo più affollato della città. Nessuno ha voglia di parlarne ma la
paura è che, a più di un anno dall’inizio della guerra, un allargamento del
conflitto possa coinvolgere questa repubblica di appena due milioni e mezzo di
abitanti.
Le notizie che
arrivano da Mosca non sono incoraggianti. Il presidente russo Vladimir Putin,
infatti, ha cancellato un decreto firmato nel 2012 che in parte sosteneva la
sovranità della Moldova nel risolvere la questione territoriale della
Transnistria, autoproclamata repubblica che nessuno riconosce. Incastonata tra
Ucraina e Moldova, la sua capitale è Tiraspol dove, accanto alla bandiera
transnistriana, sventola quella della Federazione russa. Una città pulita,
ordinata e apparentemente efficiente che sembra ferma ai primi anni Novanta.
Il decreto del 2012
è stato annullato – si legge nel documento pubblicato sul sito del Cremlino –
per «garantire gli interessi nazionali della Russia in relazione ai profondi
cambiamenti in atto nelle relazioni internazionali».
Moldova, le tensioni
con il Cremlino
La decisione fa
parte di una serie di misure anti-occidentali e preoccupa il governo di
Chişinău, che spinge per entrare nell’Unione Europea. «È una mossa che non ci
aspettavamo, Mosca sta cercando di manipolarci e di intimidirci. Ma nessuno
vuole la guerra, tantomeno le autorità della Transnistria con cui stiamo
migliorando i rapporti», dice a L’Espresso la ministra dell’Interno moldava Ana
Revenco. Che non nasconde le preoccupazioni del rischio di un golpe nel Paese da
parte di «sabotatori vicini al Cremlino». «È già successo in passato – spiega –.
Utilizzano la crisi energetica per dividere la società e destabilizzare il
Paese». Stessa cosa per il vicepresidente del Parlamento Mihail Popșoi, del
Partito azione e solidarietà della presidente Maia Sandu: «Vogliono rovesciare
il governo democraticamente eletto e creare qui un polo per sostenere gli sforzi
militari in Ucraina. Ma non succederà».
La Moldova, però, è
in difficoltà: la maggior parte del gas arriva ancora dalla Russia,
l’elettricità dalla Transnistria e dall’Ucraina, che, ovviamente, quel poco che
ha lo tiene per sé. Le bollette, insieme al malcontento della popolazione
alimentato da una pesante propaganda, aumentano bruciando i pochi risparmi dei
cittadini. «La guerra ha accelerato i nostri sforzi di diversificazione
energetica, ma ci vorranno almeno un paio d’anni», spiega sempre Popșoi. Per
questo gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare 300 milioni di dollari per
aiutare Chişinău a liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia. Un piano
di aiuti necessari alla Moldova «per affrontare i bisogni urgenti creati dalla
guerra del presidente russo Putin, ma anche a costruire una resilienza
energetica a lungo termine e a rafforzare le interconnessioni con l’Europa», si
legge nel documento visionato da Reuters. E che Putin potrebbe utilizzare come
pretesto per attaccare il Paese, forse nella sempre più esile speranza di creare
una continuità territoriale tra Donbass, Crimea e Transnistria.
«È veramente
difficile capire cosa passa nella mente di Putin. L’unica cosa che ho compreso
negli ultimi vent’anni della storia moldava è che è proprio lui ad averci spinto
vicino all’Unione europea», il commento di Veaceslav Ioniță, ex parlamentare e
analista politico. E ancora: «Noi ovviamente eravamo molto legati alla Russia,
ma tutte le sue scelte ci hanno fatto capire che l’Ue è importante:
politicamente, socialmente ed economicamente. Solo il gas resta un grande
problema». Secondo Ioniță anche la Transnistria non avrebbe alcuna intenzione di
appoggiare la Russia. «A Tiraspol ci sono persone leali al Cremlino – dice – ma
non tante come dieci anni fa, non tante come credono i russi».
Sul campo però la
situazione resta tesa. Dal 1992 vicino a Cobasna, nel nord della Transnistria,
si trovano circa 1.500 soldati russi, formalmente in missione di peacekeeping, e
un grande deposito di munizioni. Da qui l’allarme su un possibile attacco di
Mosca. Il ministero della Difesa russo nega, anzi accusa l’Ucraina di «preparare
un’azione militare in Transinistria» sotto falsa bandiera. In uniformi militari
russe, insomma, gli ucraini starebbero architettando una scusa per attaccare
questa piccola lingua di terra al di là del fiume Nistro. Accuse smentite dalle
autorità moldave.
Come in Russia, il
23 febbraio a Tiraspol si è celebrato il Giorno dei difensori della patria. In
mattinata qualcuno ha posato dei fiori freschi davanti al monumento ai soldati
caduti nella guerra del 1992. Un conflitto che ha sugellato la sua indipendenza
dalla Moldova, che qui si ricordano bene. E che non vorrebbero ripetere. Così
almeno per Dmitriy. «Non abbiamo bisogno della guerra, non ce la aspettiamo e
non ci prepariamo nemmeno. Non abbiamo armi, solo due carri armati arrugginiti»,
dice mentre gioca a biliardo e fuma una sigaretta dietro l’altra in una bisca
vicino alla stazione degli autobus. «Qui vivono bulgari, ucraini, gagauzi, russi
e moldavi. Non litighiamo, ci rallegriamo quando c’è il sole e siamo felici di
vedere degli italiani nel nostro Paese». Se dovesse scoppiare una guerra, però,
Dmitriy non avrebbe dubbi: «La colpa sarebbe della Moldova, della presidente
Maia Sandu che vuole combattere».
Georgia, idranti
e gas contro i manifestanti pro Europa e anti Russia La donna simbolo della
protesta.
Marta Serafini su Il Corriere della Sera l’8 marzo 2023.
Oltre 65 arresti per
gli scontri scoppiati dopo che il Parlamento ha approvato in prima lettura la
legge anti-agenti stranieri. Il presidente del partito di governo: dibattito
riprenderà «tra alcuni mesi»
Una donna sventola
la bandiera europea mentre gli idranti della polizia sparano senza sosta contro
di lei. E’ la foto simbolo che da ieri gira in rete e che arriva da Tiblisi.
Sale la tensione in
Georgia, stato in bilico sia geograficamente che politicamente tra Mosca e
l’Occidente. Sessantasei manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di
poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste nella capitale Tbilisi.
Ieri sera i
manifestanti hanno sfondato le barriere all’ingresso del Parlamento, tentando di
entrare nel cortile del palazzo. Bombe molotov e pietre sono state lanciate
contro la polizia negli scontri durante la notte mente alcuni manifestanti
cadono a terra tossendo, colpiti da idranti e gas mentre sventolavano bandiere
dell’Unione europea e della Georgia, come mostrano i video circolati in queste
ore. Gli scontri sono iniziati dopo che il Parlamento ha dato il suo sostegno
iniziale a un progetto di legge sugli «agenti stranieri» che, secondo i critici,
mina le speranze di adesione all’Ue del Paese del Caucaso meridionale. La
polizia antisommossa ha usato cannoni ad acqua e spray al peperoncino per
disperdere la folla fuori dall’edificio del parlamento.
Il disegno di legge
richiederebbe alle organizzazioni non governative (ONG) e ai media indipendenti
che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero di dichiararsi
agenti stranieri. L’opposizione l’ha descritta come una legge in stile russo che
stigmatizzerebbe e reprimerebbe la vivace società civile e i media indipendenti
della Georgia. Storicamente il termine “agente” in Russia e Georgia ha il
significato di “spia” e “traditore”, con una connotazione negativa al lavoro
svolto dalla società civile. Se approvata questa legge di fatto ricalcherebbe
quella in vigore in Russia del 2012 e sancirebbe lo sbilanciamento di Tbilisi
verso Mosca.
Con l’approvazione,
la Georgia entrerebbe di fatto a far parte di un elenco di stati post-sovietici
antidemocratici e autoritari come la Bielorussia, il Tagikistan e l’Azerbaigian.
Il tutto proprio mentre Bruxelles sta esaminando la domanda della Georgia per lo
status di candidato. Il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha già
avvertito che il disegno di legge è «incompatibile con i valori e gli standard
europei». Anche il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha
affermato che il progetto di legge rappresenterebbe un enorme passo indietro e
«colpirebbe alcuni degli stessi diritti che sono fondamentali per le aspirazioni
del popolo georgiano».
Che in Georgia stia
succedendo qualcosa di molto simile a quanto successo in Ucraina con Euromaidan
è plausibile. Che l’invasione russa abbia riacceso vecchie tensioni sociali è un
dato, che Tibilisi, ancora più di Chisinau, guardi più a Ovest che a Est, anche.
Ora si tratta di capire quanto i georgiani siano in grado di fare fronte ai
tentativi dello Zar di rafforzarsi verso il Mar Nero. Intanto, per oggi, sono
previste nuove manifestazioni e il presidente del partito governativo Sogno
Georgiano, Irakli Kobakhidze, citato dall’agenzia russa Interfax ha fatto sapere
che il parlamento georgiano riprenderà il dibattito della legge solo tra «alcuni
mesi», quando avrà ottenuto il parere della Commissione di Venezia del Consiglio
d’Europa, a cui ha inviato la normativa.
Le proteste buone
in Georgia e quelle cattive in Moldavia: il doppio standard occidentale.
Giorgia
Audiello su L'Indipendente il 9 marzo 2023.
In Georgia si sono
verificate negli ultimi giorni animate manifestazioni contro la cosiddetta legge
sugli “agenti stranieri” che impone alle società non commerciali, quali
associazioni, media e ong, che ricevono oltre il 20% dei loro finanziamenti
dall’estero, di registrarsi presso un registro detto degli “agenti stranieri”.
Quest’ultimo consentirebbe alle autorità di accedere alle informazioni personali
dei membri delle organizzazioni interessate e dei terzi coinvolti nelle loro
attività, nonché imporrebbe di fornire a scadenza regolare una serie di
informazioni sulla natura dei fondi ricevuti e sul modo in cui vengono spesi. La
legge è sostenuta dal partito di maggioranza “Sogno georgiano”, guidato dal
premier Irakli Garibashvili, ed è stata interpretata come una manovra contro le
opposizioni in un contesto politico che – a detta della stampa europea e filo
Nato – starebbe scivolando verso un regime autoritario vicino a Mosca, tanto che
la legge è stata etichettata come “legge russa”. In realtà, il governo in
carica, pur cercando di mantenere relazioni costruttive con Mosca, aspira
anch’esso all’ingresso nell’Ue e nell’Alleanza atlantica. Nonostante ciò,
l’informazione occidentale è tornata ad agitare lo spettro di una presunta nuova
“Maidan” – la rivolta di piazza verificatasi in Ucraina nel 2014 che ha portato
al cambio di governo con la destituzione dell’allora presidente Viktor
Yanukovich – elevando i manifestanti filoeuropei a simboli di democrazia contro
il presunto autoritarismo dei sostenitori di Mosca. Per questo, secondo alcuni
organi di stampa occidentale, sui social sarebbe diventato virale il video di
una donna che sventola la bandiera europea mentre viene colpita dagli idranti
della polizia.
Accetta Funzionali cookie per visualizzare il contenuto.
Le manifestazioni
georgiane possono essere considerate il corrispettivo, al rovescio, di quanto
accaduto in Moldavia nelle scorse settimane, dove folle probabilmente anche più
numerose, si sono riversate davanti al palazzo di governo per protestare contro
l’amministrazione filoeuropea e a sostegno di Mosca. La differenza è che mentre
in quel caso le proteste erano accusate di essere eterodirette dal Cremlino e,
dunque, ritenute “cattive”, quelle filoeuropee di Tbilisi sono sostenute e
incoraggiate da tutto il mondo istituzionale e mediatico europeo e americano,
senza che venga minimamente preso in considerazione il sospetto che possano
essere sobillate da forze extra nazionali. Si tratta di un doppio standard nella
valutazione delle espressioni popolari che mostra come per l’Occidente le
manifestazioni e le proteste “buone” siano sempre e solo quelle filo-Nato e
filoeuropee.
Accetta Funzionali cookie per visualizzare il contenuto.
Secondo il ministero
dell’Interno, sessantasei manifestanti sono stati fermati durante gli incidenti
nella notte quando la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti al
lancio di bottiglie incendiarie e pietre contro il Parlamento, che una parte dei
dimostranti ha cercato di prendere d’assalto. Negli scontri sono rimasti feriti
anche cinquanta persone tra agenti e civili, ha aggiunto il ministero. Il leader
del partito di opposizione Strategia Aghmashenebeli, Giorgi Vashadze, ha
denunciato «un uso sproporzionato della forza contro una dimostrazione pacifica»
e ha detto che tra gli arrestati figura Zurab Japaridze, capo di un altro
partito di opposizione, il Girchi. Il capo dell’altro partito di opposizione
“Movimento unito nazionale”, Levan Khabeishvili, ha invece fatto un appello a
continuare le proteste quotidianamente fino alla revoca della normativa.
In seguito alla dura
reazione della popolazione verso la legge, il presidente del partito di
maggioranza, Garibashvili, ha dapprima detto che il dibattito per il voto in
seconda e terza lettura della legge non sarebbe avvenuto prima di giugno con il
parere del Consiglio d’Europa, mentre, successivamente, ha direttamente ritirato
la legge. In una nota pubblicata sul sito georgiano Rustavi 2, si legge che «In
quanto responsabili nei confronti di ogni membro della società abbiamo deciso
di ritirare incondizionatamente il disegno di legge che abbiamo sostenuto senza
alcuna riserva». Secondo “Sogno georgiano”, la legge sarebbe stata posta in
cattiva luce affibbiandogli l’etichetta di “legge russa”: «Le è stata affibbiata
un’etichetta falsa di “legge russa”, e la sua approvazione in prima lettura è
stata vista da parte dell’opinione pubblica come un allontanamento dal corso
europeo. Inoltre, alcune forze radicali sono state in grado di coinvolgere parte
dei giovani in attività illegali”, prosegue il comunicato. Il governo ha fatto
comunque sapere che «quando si attenuerà l’emotività, faremo capire alla
popolazione a cosa serviva». Questa mattina si è appreso che il Parlamento
georgiano ha già ritirato la legge.
Da parte sua, Mosca
ha ribadito la sua totale estraneità alla legge per mezzo del portavoce del
Cremlino, Dmitry Peskov: «Il Cremlino non ha ispirato nulla e non ha
assolutamente nulla a che fare con questo», ha affermato il diplomatico.
Sarcastico, invece, il commento della portavoce del ministero degli Esteri,
Maria Zakharova: «ora è chiaro perché gli Stati Uniti non sono ancora
nell’Unione europea, da loro questa legge è in vigore dal 1938», ha affermato in
riferimento al Foreign Agents Registration Act sugli “agenti stranieri” in
vigore appunto da 85 anni.
Piena soddisfazione
per il ritiro della legge si è avuta, invece, da parte della delegazione in
Georgia dell’Unione europea: «Accogliamo con favore la dichiarazione del partito
al governo sul richiamo del disegno di legge sull’“influenza straniera”» e
«Chiediamo a tutti i leader politici della Georgia di rinnovare le riforme a
sostegno dell’UE, in modo inclusivo e costruttivo, e di raggiungere lo status di
candidato della Georgia in conformità con le 12 priorità», si legge in una
dichiarazione.
Le proteste
georgiane sono, dunque, riuscite quasi immediatamente a bloccare la proposta di
legge, anche grazie all’appoggio dell’Ue. Al contrario, le proteste della
popolazione moldava e la richiesta al governo di dimettersi restano inascoltate
da mesi sia dall’amministrazione moldava che dalle istituzioni occidentali in
quanto accusate di essere influenzate dal Cremlino e, tutto ciò, nonostante la
situazione socioeconomica di Chisinau sia oggettivamente drammatica da anni e
ormai insostenibile a causa del peggioramento dovuto alle congiunture
geopolitiche internazionali. [di Giorgia Audiello]
I russi che
combattono con le pale e le altre bufale del mainstream sulla guerra.
Enrica
Perucchietti su L'Indipendente il 9 marzo 2023.
«Da Tassagart a
Clonmore scorre un fiume di sangue sassone». Follow me up to Carlow è un canto
popolare dell’epopea ribellistica irlandese che celebra la sconfitta di un
esercito di 3.000 soldati inglesi, guidato da Lord Grey de Wilton, da parte di
Fiach McHugh O’Byrne nella battaglia di Glenmalure, avvenuta nel 1580, durante
la seconda rivolta dei Desmond. Circa 800 soldati inglesi furono massacrati
durante un’imboscata, straziati a colpi di spade, lance, pale e asce. Uno
scenario simile a quello che emerge, almeno nell’ultimo rapporto
dell’intelligence ucraina, secondo cui i riservisti russi sarebbero costretti a
combattere con le pale. Il documento parla di un attacco a un avamposto nel
quale i militari di Mosca avrebbero ricevuto l’ordine di assaltare le forze di
Kiev usando «armi da fuoco e pale».
Come sgusciati da un
racconto di battaglie epiche o da una puntata di Vikings, questa sarebbe,
infatti, la surreale situazione dell’esercito russo, costretto per la mancanza
di munizioni a usare armi a dir poco vetuste. La pala in questione, di carattere
più “mitologico” che moderno, già in voga durante il periodo sovietico, è lunga
circa 50 centimetri, e ai lati della parte metallica viene affilata per essere
usata come ascia.
Nello specifico, si
tratta di un modello noto come MPL-50: progettata nel 1869, secondo il ministero
della Difesa ucraino, si tratta di uno strumento che in Russia viene
considerato, come si può ben immaginare, “superato”. Questo è forse l’unico
punto del documento su cui si può concordare senza sorridere. Il report
puntualizza come il conflitto sia diventato sempre di più una guerra di
contatto per la quale i riservisti russi non sarebbero pronti «né fisicamente né
psicologicamente». Sebbene sia redatto da una fonte istituzionale, ben lungi dal
potersi considerare affidabile, la Bbc fa sapere di non essere riuscita a
verificare il contenuto del rapporto, che non specifica dove e quando i russi
avrebbero ricevuto l’ordine di usare le pale.
Il report, però, è
stato ripreso avidamente dai quotidiani italiani, anche da coloro che guidano le
armate dei moderni Inquisitori digitali, l’onnipresente Open di Mentana, il
giorno stesso in cui la Russia ha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da
1,5 tonnellate contro l’Ucraina. Una notizia confermata da Kiev attraverso il
portavoce dell’Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda. Lo
stesso Ignat ha spiegato ai media che l’Ucraina ha bisogno «degli F-16 o di
altri aerei», proprio per difendersi dai missili a distanza e dalle bombe russe.
Perché se l’esercito fosse davvero a corto di munizioni e fosse costretto a
combattere come cinque secoli or sono, non ci sarebbe bisogno di continuare a
mandare armamenti a supporto delle truppe di Kiev…
Ora, al di là
dell’evidente assurdità della ricostruzione dal sapore propagandistico, è bene
ricostruire come i media mainstream ripetano a spron battuto da un anno esatto a
questa parte che la Russia non è più in grado di sostenere la guerra. Dal marzo
2022, infatti, la stampa occidentale ha più volte insistito sulla narrazione
secondo la quale la Russia sarebbe senza risorse (e ora senza armi né
munizioni), incapace di continuare a sostenere il conflitto.
A ripeterlo è ancora
oggi Ukrinform che, citando il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo
Budanov si dice convinto che «l’esercito russo fallirà nei suoi obiettivi questa
primavera, esaurirà i suoi strumenti di guerra». Ma questa litania viene
promossa e ripetuta dagli organi di stampa, da un anno esatto e, soprattutto, è
stata smentita nei mesi, dai fatti.
Il 4 marzo del 2022,
già La Stampa sosteneva questa versione: secondo l’economista Vladimir Mirov –
collaboratore di Navalny – Putin aveva finito le risorse e la guerra in Ucraina
si sarebbe fermata entro 2-3 settimane al massimo: «Non hanno ancora capito che
la Russia è piombata in una crisi economica che sarà peggio di quella del 1991.
Diamogli altre due-tre settimane per comprendere la realtà: non ha le risorse
per proseguire la guerra».
L’intervista era
stata ripresa da Open e altri colleghi, con scarse doti di lungimiranza.
A prefigurare
l’imminente collasso del Cremlino era anche il Wall Street Journal che, sempre a
marzo di un anno fa, sosteneva che “Putin potrebbe temere più il default che la
sconfitta in Ucraina”.
[La versione del WSJ
sul conflitto Ucraino prima (a sinistra) e dopo (a destra).]Oggi il WSJ, invece,
scrive che la lotta mortale minaccia la capacità di Kiev di organizzare
un’offensiva: le migliori brigate ucraine sarebbero morte in una feroce
battaglia con i mercenari della Wagner, durante la battaglia per Bakhmut.
Eppure, esattamente un anno fa, il quotidiano sosteneva che il conflitto sarebbe
durato al massimo due settimane. [di Enrica Perucchietti]
Cresce la
tensione. La Moldavia si infiamma, la Transnistria filorussa accusa Kiev:
“Sventato attentato degli 007 ucraini al nostro presidente”.
Carmine Di Niro su
Il Riformista il 9 Marzo 2023
Non solo la Georgia.
La tensione torna a farsi altissima anche in una seconda ex Repubblica
sovietica, la Moldavia, e nella ‘sua’ regione separatista filo-russa
della Transnistria, la Repubblica autoproclamatasi indipendente dal 2 settembre
1990 dopo il crollo dell’Unione Sovietica.
Il ministero per la
Sicurezza dello Stato di Tiraspol ha denunciato questa mattina un attentato ai
danni del presidente della regione separatista, Vadim Krasnoselsky, sventato
delle forze di sicurezza locali. Ministero e procuratore della Transnistria
hanno accusato senza mezzi termini i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) di aver
organizzato il presunto attentato ai danni del leader del Paese, non
riconosciuto dalla comunità internazionale e dove da anni è presente un
distaccamento di forze militare russi in funzione di “peacekeeping” dopo il
cessate il fuoco tra Tiraspol e la Moldavia a seguito della guerra tra i due
‘Paesi’ del 1992.
Secondo fonti
locali, alcune persone che dovevano compiere l’attacco “su istruzione dei
servizi segreti ucraini” sarebbero state arrestate e “hanno confessato“.
Stando al ministero
della Sicurezza statale transnistriano, lo Sbu avrebbe preparato tentativi di
assassinio contro diversi funzionari, non solo Krasnoselsky: il metodo
utilizzato dagli 007 di Kiev secondo il procuratore della Transnistria
era un’autobomba nel centro di Tiraspol, davanti al Parlamento locale.
In risposta
all’attentato la Transnistria considera vari tipi di risposta in caso di un
attacco dall’Ucraina, che dipenderebbero “dallo scenario”, ha minacciato il
ministro degli Esteri dell’entità separatista sul territorio moldavo, Vitaly
Ignatyev.
Non si è fatta
attendere la reazione di Kiev. I servizi di sicurezza ucraini hanno denunciato
come una “provocazione orchestrata dal Cremlino” le affermazioni di un
coinvolgimento ucraino nel presunto attentato sventato nella capitale della
regione separatista moldava. “Qualsiasi dichiarazione della presunta Repubblica
Popolare di Transnistria sul coinvolgimento dell’Sbu nella preparazione di un
attacco terroristico deve essere considerata esclusivamente come una
provocazione orchestrata dal Cremlino“, hanno dichiarato i servizi ucraini su
Telegram.
E anche nella vicina
capitale moldava Chisinau, che dista 60 km da Tiraspol e che nelle scorse
settimane è stata al centro delle attenzioni di Mosca tra proteste
dell’opposizione filorussa e un presunto piano per realizzare un golpe e
rimuovere il governo europeista, si invita alla cautela.
Il governo ha
annunciato che sta “indagando” sulle accuse delle autorità della Transnistria.
“Le autorità competenti stanno indagando su questa informazione“, ha reagito il
governo su Facebook, mentre il primo ministro, Dorin Recean, ha affermato di
“non avere conferme” e si è detto pronto a “rispondere a qualsiasi
provocazione“.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Moldavia,
sventato "complotto russo": agenti infiltrati dietro alla rivolta.
Il
Tempo il
Situazione
esplosiva in Moldavia, la repubblica confinante con l'Ucraina che sarebbe nelle
mire della Russia e dove da settimane si registrano manifestazioni e
instabilità. La polizia moldava ha dichiarato oggi di aver sventato un complotto
da parte di gruppi sostenuti dalla Russia che erano stati appositamente
addestrati per provocare disordini di massa. Il capo della polizia locale,
Viorel Cernauteanu, ha dichiarato in una conferenza stampa che un agente sotto
copertura si era infiltrato in gruppi di cittadini russi, a cui erano stati
promessi 10.000 dollari per organizzare "disordini di massa" per destabilizzare
la Moldavia durante una protesta nella capitale, Chisinau. Sette persone sono
state arrestate, ha detto Cernauteanu.
Dopo
perquisizioni ieri notte, 25 uomini sono stati interrogati e sette di loro sono
stati arrestati, ha detto ai media il capo della polizia. Un agente è riuscito a
infiltrarsi nel gruppo guidato da un uomo di nazionalità moldava e russa, ha
aggiunto, indicando 10 ore di registrazione video come prova. "Le persone sono
arrivate dalla Russia con un ruolo di addestramento molto specifico", ha
aggiunto il funzionario. Le autorità moldave hanno affermato di aver agito dopo
aver "ricevuto informazioni sull’organizzazione da parte dei servizi speciali
russi di azioni destabilizzanti sul nostro territorio tramite manifestazioni".
Il partito
dell’oligarca filo-russo in fuga, Ilhan Shor, si è nuovamente mobilitato nelle
ultime settimane contro il governo filo-europeo, tra le crescenti tensioni tra
Mosca e Chisinau, organizzando diverse manifestazioni, secondo il governo
pagando i partecipanti.
L’opposizione
filo-russa è scesa in piazza anche oggi nel centro di Chisinau e la polizia ha
formato un cordone per bloccare migliaia di manifestanti che volevano
raggiungere la piazza centrale e il palazzo del governo. Secondo la Ria Novosti,
alcuni manifestanti sarebbero riusciti a sfondarlo. I manifestanti, secondo la
Tass, scandiscono slogan come "Abbasso la dittatura", "Abbasso il presidente
Maia Sandu". Sempre secondo le agenzia russe, l’opposizione manifesta a causa
degli alti prezzi del gas, che hanno provocato un aumento del prezzo
dell’elettricità, del riscaldamento domestico, dei servizi e dei prodotti.
"Piano russo per
controllare la Moldavia": l'ultima minaccia da Mosca.
Media internazionali
svelano un presunto piano della Russia per infiltrare la Moldavia fino al 2030.
Che pare però già essere in ritardo. Andrea Muratore il 15 Marzo 2023 su Il
Giornale
Tabella dei
contenuti
Il contenuto del
piano della Russia per controllare la Moldavia
I contatti del
Cremlino
La Russia ha un
piano per destabilizzare e controllare la Moldavia entro il 2030 con una vera e
propria "guerra ibrida"? Questa la clamorosa rivelazione lanciata da un gruppo
di testate che dichiara di aver avuto accesso a un rapporto interno del governo
russo avente l'obiettivo di delineare una strategia per la destabilizzazione di
Chisinau e il suo graduale inserimento nell'orbita russa. Il documento si
intitolerebbe "Obiettivi strategici della Federazione Russa nella Repubblica di
Moldova" e risalirebbe a fine 2020 con un orizzonte temporale decennale.
Il piano è stato
ottenuto da una testata investigativa dedicata alle nazioni del Gruppo di
Visegrád, VSquare, insieme a diversi partner internazionali: Delfi Estonia, il
quotidiano svedese Expressen, il Dossier Centre for Investigative Journalism, il
quotidiano ucraino Kyiv Independent, la testata moldava Rise Moldova, i
tedeschi Süddeutsche Zeitung e Westdeutscher Rundfunk e il canale
statunitense Yahoo News.
Putin revoca
il decreto: ora si rischia una nuova invasione
Il contenuto del
piano della Russia per controllare la Moldavia
L'agenda rivelerebbe
un vero e proprio cronoprogramma per portare Chisinau sempre più nell'orbita di
Mosca. Ma mostrerebbe anche che buona parte degli obiettivi pensati come di
breve periodo non sono, ad oggi, stati portati a compimento da Mosca. Il piano
del governo russo avrebbe implicato nel breve periodo lo stop alle iniziative
della Repubblica di Moldova volte ad eliminare la presenza militare russa in
Transnistria. La presidenza europeista di Maia Sandu e il governo del suo
Partito d'Azione e Sviluppo stanno accelerando nel disconoscere
l'eredità post-1992, e la stessa Russia ha dovuto ridurre il suo sostegno
all'integrità territoriale della Moldavia con apposito decreto.
Un secondo punto
segnato è l'apertura di un consolato a Comrat, capitale della Gagauzia, entro il
2022, ipotesi che però non si è materializzata. Più successo avrebbe avuto il
piano di "neutralizzazione dei tentativi di limitare le attività dei media russi
e filo-russi in Moldavia": le manifestazioni del 9 maggio scorso e la
spontaneità del sentimento dei membri della cittadinanza più legati a Mosca,
oltre alle recenti proteste anti-governative dopo la controversa legge sulla
lingua, hanno mostrato che i sentimenti anti-russi non albergano nella
popolazione.
I contatti del
Cremlino
Per il 2025 e il
2030, invece, Mosca si presupporrebbe rispettivamente di ampliare la base
elettorale ai socialisti di Igor Dodon e alle altre forze pro-Russia nel Paese e
di minare la cooperazione di Chisinau con la Nato. L'obiettivo ultimo alla fine
del decennio sarebbe estremamente ambizioso, leggendo le bozze di piano: la
"creazione di gruppi di influenza filo-russi stabili nelle élite politiche ed
economiche moldave, la formazione di un atteggiamento negativo nei confronti
della Nato nella società moldava e il sostegno alla Chiesa ortodossa russa nella
difesa degli interessi dell'Ortodossia canonica nella Repubblica di
Moldavia". Vaste programme, guardando come l'avvicinamento della Moldavia
all'Europa e agli Stati Uniti sia mese dopo mese e anno dopo anno in via di
consolidamento.
Ad occhio, il piano
appare una grande dichiarazione di intenti che non necessariamente è sostanziato
da una postura strategica volto a concretizzarla, ammesso che la Russia l'abbia
effettivamente iniziato a mettere in pratica. Come nota VSquare, del resto,
molti nodi sulle influenze russe in Moldavia stanno venendo al pettine: "Venerdì
scorso, la Casa Bianca ha emesso un avvertimento ufficiale che la Russia sta
cercando di destabilizzare il governo filo-occidentale della Moldavia e vuole
installare una nuova leadership nel paese. Due giorni dopo, la polizia moldava
ha arrestato diversi manifestanti, sostenendo che erano stati inviati e pagati
dalla Russia per destabilizzare il paese. Le guardie di frontiera moldave hanno
arrestato un presunto mercenario del gruppo russo Wagner al confine".
Insomma, per Mosca
lo spazio di manovra nella piccola Repubblica contesa appare sempre più
ristretto. E da qui al 2030 il vero tema sarà capire se ci sarà ancora uno
scampolo di influenza russa in Moldavia
L'ex
presidente georgiano è stato trasferito nell'ospedale del carcere in cui è
detenuto. Ha risposto per lettera alle domande di Sky News.
La Repubblica il
12 marzo 2023.
L'ex presidente
della Georgia Mikheil Saakashvili ha detto a Sky News di essere "vicino alla
morte" nell'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere. L'ex leader sostiene
di essere stato avvelenato in prigione, tesi negata dall'attuale governo
georgiano, secondo cui le condizioni di salute di Saakashvili sarebbero dovute
al fatto che non si è nutrito a sufficienza. "Inizialmente pesavo 120
chilogrammi, ora ne ho 64, se scendo sotto ai 60 i medici prevedono
insufficienze multiorgano", ha detto Saakashvili alla domanda su quanto fosse
vicino alla morte.
A Sky News è
stato negato l'accesso all'ospedale, Il canale ha però trasmesso le domande
a Saakashvili tramite il suo avvocato e ha ricevuto le risposte scritte a mano.
Per quanto riguarda la sua salute, l'ex presidente georgiano ha detto di essere
"sempre a letto. Le mie ossa si stanno disintegrando e mi danno un dolore
lancinante".
Il suo
avvocato Shalva Khachapuridze ha detto che le condizioni del suo cliente
peggiorano ogni giorno. "È una scena orribile", ha detto Khachapuridze a Sky
News. "Sembra un prigioniero in un campo di concentramento nella Germania
nazista".
Nell'intervista, Saakashvili ha inviato un messaggio alle migliaia di
manifestanti che sono scesi in piazza per protestare contro le proposte di nuove
leggi criticate come filo-russe: "Restate molto vigili, siate pronti a
mobilitarvi con breve preavviso, a causa dello stato d'animo vendicativo del
regime degli oligarchi", ha scritto.
Il governo ha ora
ritirato il controverso disegno di legge sugli agenti stranieri, ma l'Occidente
osserva da vicino ciò che accade a Saakashvili, per comprendere se l'orizzonte
politico del Paese guardi alla Russia o al contrario all'Europa.
Egemonia
erosa. L’instabilità in Georgia arriva al momento sbagliato per Mosca (quindi
quello giusto per l’Occidente).
Michelangelo Freyrie
Linkiesta il 10 Marzo 2023.
Pur rimanendo la
maggiore potenza della regione, l’improvvisa debolezza militare impedisce alla
Russia di distrarre risorse dall’Ucraina. Putin premerà sulla classe dirigente
affinché il Paese rimanga istituzionalmente compatibile con gli strumenti della
sua politica estera: oligarchico, corrotto e autoritario
Sono quasi quindici
anni che la Russia tratta la Georgia come una provincia del proprio impero.
Tbilisi si è piegata alle esigenze russe grazie a una politica del bastone
(l’occupazione del venti per cento del Paese nei territori separatisti
dell’Abkhazia e Ossezia del Sud) e della carota (una forte dipendenza economica
e il supporto alla parte più corrotta della classe politica, incarnata dal
partito Sogno Georgiano e dall’oligarca Bidizina Ivanishvili). Mosca sfrutta
sapientemente le divisioni interne al piccolo Paese montano e la sua dipendenza
economica dal gigante russo: basti pensare che la metà dei 4,4 miliardi di
dollari mandati a casa da lavoratori e lavoratrici georgiane all’estero proviene
dalla Russia.
Popolo filoeuropeo,
governo corrotto
Complice anche una
politica europea a volte assente e priva di strumenti con i quali spingere
vigorosamente per il rientro della Georgia sulla traiettoria di
democratizzazione, Tbilisi è rimasta alla mercé delle politiche di influenza
russe, palesi o corruttrici che esse siano. Lo shock della guerra del 2008, al
netto degli errori commessi dalla leadership georgiana e la scelta comprensibile
dell’Occidente di evitare un’escalation, ha fatto sfumare per la Georgia la
prospettiva di qualsivoglia protezione europea nel caso di uno scontro politico
con Mosca. Tutto ciò, paradossalmente, avviene nonostante il forte sentimento
filoeuropeo del popolo georgiano.
Ciò ha fatto
scivolare il Paese verso il tipo di palude politica perfetta per gli strumenti
meno coercitivi nell’armamentario politico russo. Mosca interloquisce
direttamente con Ivanishivili, eminenza grigia del governo, tramite canali
ufficiosi come oligarchi e affaristi. In più, l’autoritarismo del governo e la
fortissima polarizzazione fra società civile e classe politica ostacolano la
nascita di qualsiasi visione di politica alternativa allo status quo.
Anche se sulla carta
la Georgia rimane impegnata nel processo di integrazione europea, de facto è da
anni che il governo si spende per un riavvicinamento alla Russia: Ivanishivili
stesso si è impegnato in prima persona in colloqui bilaterali a Ginevra fra i
due stati, che tecnicamente non intrattengono rapporti diplomatici dal 2008.
Questo sviluppo è
parecchio apprezzato dalla Russia, che vede in Tbilisi un pilastro fondamentale
della propria politica regionale. Dal 24 febbraio 2022, la quantità di cargo in
partenza dalla Georgia per la Federazione Russa è aumentata di circa un terzo, e
la tirannia della geografia impone che la maggior parte del commercio
proveniente dalla Turchia (che non ha adottato le sanzioni) transiti da qui.
Un’altra importante
novità nel rapporto è la presenza di centinaia di migliaia di esuli fuggiti
dalla Russia per evitare il reclutamento. Secondo la politica di centrodestra
Nona Mamulashvili, quasi l’otto per cento di chi attualmente vive in Georgia è
un cittadino russo arrivato dopo il 24 febbraio: un numero enorme che ha già
avuto pesanti effetti sul mercato del lavoro e degli affitti. In più, Mosca non
può essere assente da una zona geografica così importante per i rapporti
Est-Ovest: basti pensare alla ferrovia Baku-Tbilisi-Kars o al corridoio
energetico meridionale, che partendo dall’Azerbaigian sfocia nel Tap in Puglia.
Riassestamento delle
sfere d’influenza
Ma qualcosa è
cambiato in Georgia e nella regione. Nella visione del mondo russa, il Caucaso
rappresenta uno spazio geopolitico nel quale il Cremlino si aspetta una totale
assenza di rivali. La Federazione Russa si vede come arbitro regionale che si
riserva il diritto di intervenire nelle questioni che infiammano il Caucaso
quando ne va delle priorità fondamentali della politica estera russa. Per anni
ciò ha significato gettare benzina sul fuoco e provocare (o
tollerare) escalation che richiedessero un intervento russo, rendendo la Russia
un «attore indispensabile».
Con l’affacciarsi di
nuove potenze come l’Iran e la Turchia, questa funzione insostituibile è
tuttavia venuta meno. Nel conflitto fra Armenia e Azerbaigian, Mosca ha avuto un
ruolo ben minore rispetto al passato nei negoziati fra i due Stati. È notevole
anche che Tbilisi abbia votato a favore della risoluzione Onu che condanna
l’invasione del 24 febbraio (una scelta diplomatica che verosimilmente appariva
inevitabile perfino agli occhi di Mosca) ma che abbia disertato le risoluzioni
sulle violenze in Iran.
L’incapacità (o
mancanza di volontà) da parte di Mosca di investire in soluzioni politiche
durature nella regione si sta tramutando in una evidente debolezza, e l’egemonia
russa è erosa al punto da non garantire più un supporto sine die per la politica
del Cremlino. L’improvvisa debolezza militare russa poi non aiuta: pur rimanendo
la maggiore potenza della regione, Mosca non può attualmente permettersi di
distrarre risorse convenzionali dall’Ucraina.
Un futuro diverso
Queste dinamiche
sono emerse con particolare virulenza di Georgia. L’accelerazione (relativa) del
processo di adesione all’Ue per Moldavia e Ucraina, unita alla solidarietà
popolare nei confronti di Kyjiv e i disagi causati dai profughi russi, hanno
riacceso la speranza per un futuro diverso e lontano dall’ombra della Russia.
Questa instabilità arriva al momento sbagliato per Mosca, che si trova
all’improvviso a dover gestire una crisi profonda per la quale non ha
necessariamente gli strumenti.
Quello che Mosca può
fare a questo punto è raddoppiare il proprio investimento nelle parti di classe
dirigente a lei più congeniale, e spingere affinché la Georgia rimanga un Paese
istituzionalmente compatibile con gli strumenti della politica estera russa:
oligarchico, corrotto e autoritario. L’offerta di rilanciare rapporti
diplomatici diretti e di restituire voli diretti fra i due Stati sono modi con
cui la Russia spera di poter cementare la propria presenza informale,
rafforzando la mano della coalizione di governo nella dialettica interna alla
Georgia.
La legge sugli
“agenti stranieri” passata da Sogno Georgiano, e ritirata dopo le proteste di
questi giorni, va vista in questa ottica: rappresentava un ostacolo artificiale
posto del governo per allontanare definitivamente il Paese dal percorso dello
status di candidato all’Unione europea, con la quale gli alleati della Russia a
Tbilisi cercano di garantire la propria permanenza nella sfera di influenza di
Mosca.
L’obiettivo ultimo,
sia per il Cremlino che per i suoi accoliti, è insomma quella di preservare
l’attuale status quo e mantenere l’attuale politica di appeasement nonostante le
pressioni della piazza. Quanto Ivanishvili e i suoi sostenitori siano
effettivamente agenti del governo russo, o se si tratta di una semplice
convergenza di interessi fra Mosca e i cleptocrati al potere in Georgia, rimane
un punto di domanda significativo.
Una variabile sarà
la capacità di Unione europea e Stati Uniti di sostenere politicamente le
opposizioni democratiche. Il rischio è che con la fine del rapporto imperiale
fra Russia e Georgia, Mosca decida che l’alternativa migliore a una Georgia
completamente assoggettata sia una Georgia politicamente instabile ed
economicamente al palo.
Capire prima,
capire meglio. La Georgia ci ricorda a cosa serve l’Europa (e a chi servono i
populisti).
Francesco Cundari su Linkiesta il 10 Marzo 2023.
Sono proprio i
manifestanti che tengono alta la bandiera blu a Tbilisi, e che nei talk show
italiani saranno certo definiti pupazzi degli americani da chi continua a
ripetere le solite geofregnacce sulla «guerra per procura», ad aver compreso il
senso e il valore dell’Ue
Se fossi stato meno
distratto, meno ignorante e meno fesso, la prima volta in cui ho sentito uno dei
tanti osservatori Putin-comprensivi che affollano quotidiani, settimanali,
bimestrali, librerie e talk show italiani ripetere la teoria dei nazisti
ucraini intenti a perseguitare la minoranza russofona nel Donbas, mi sarei
ricordato della Georgia. Perché anche in Georgia, nel 2008, è successo qualcosa
di molto simile a quello che è accaduto in Ucraina, e cioè che Vladimir Putin ha
prima sostenuto e fomentato i separatisti nelle cosiddette repubbliche
indipendenti e poi li ha usati come pretesto per intervenire militarmente.
Se fossi stato meno
distratto, meno ignorante e meno fesso, sentendo tanti intellettuali, politologi
e geopolitologi ripetere il solito copione sulle manovre della Nato, degli Stati
Uniti e dell’Unione europea, invece di tanti altri inutili discorsi, avrei
formulato una semplice domanda: e la Georgia? (e potremmo pure continuare,
cambiando il pochissimo che c’è da cambiare, ad esempio con la Moldavia: perché
pure lì ovviamente c’è una minoranza filorussa perseguitata, ma assai ben
armata, che invoca l’aiuto fraterno di Mosca).
Siccome da oggi
voglio essere un po’ meno distratto, meno ignorante e meno fesso, dopo aver
guardato le splendide immagini delle manifestazioni di Tbilisi, con quella donna
che sventola la bandiera dell’Unione europea contro gli idranti della polizia,
alcune cose voglio ricordarle, e penso che dovreste farlo anche voi, ogni
giorno, con chiunque vi capiti di parlare.
La prima è che è
proprio così che è cominciata, davvero, la crisi russo-ucraina: con le
manifestazioni di protesta contro il tentativo del governo filoputiniano di
allontanare il paese dall’Unione europea, per riportarlo definitivamente sotto
il controllo di Mosca. Manifestazioni represse brutalmente, con centinaia di
morti in piazza, che sfociarono nella rivolta e nella cacciata del presidente
Viktor Yanukovich, cui Putin rispose con l’occupazione della Crimea e la guerra
sporca nel Donbas.
La seconda cosa che
voglio ricordare è che allora, dalla parte della Russia di Putin, c’era l’intero
schieramento populista e antieuropeista italiano, dal Movimento 5 stelle alla
Lega, Fratelli d’Italia compresi. Una simmetria che almeno oggi, con il senno
del poi e senza la fesseria del prima, dovrebbe dirci qualcosa: le stesse forze
politiche più impegnate in quegli anni – tra 2014 e 2016 – nel chiedere l’uscita
dall’euro, nell’entusiasmarsi per la Brexit e per la vittoria di Donald Trump,
erano anche le più convinte nel chiedere di rimuovere le sanzioni contro la
Russia. Ma guarda un po’.
La terza cosa che
voglio ricordare è che nel frattempo Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia si
sono scambiati di posto, l’uno è tornato all’opposizione, l’altro è andato al
governo. Sarà un’altra coincidenza, ma giusto in prossimità di questa
ricollocazione il Movimento 5 stelle è rifluito su posizioni sostanzialmente
filoputiniane, mentre Fratelli d’Italia, dal giorno dopo l’invasione del 24
febbraio 2021, ha fatto il percorso inverso. Motivo per cui suggerirei di
moderare sempre l’entusiasmo per certe evoluzioni, maturazioni, conversioni
improvvise, soprattutto quando non accompagnate da alcuna seria autocritica (non
per una questione di principio, ma per una ragione pratica: perché in tal modo,
come dimostra l’esempio grillino, le nuove posizioni restano sempre
reversibili).
La quarta cosa che
voglio ricordare è che la legge sugli «agenti stranieri» contro cui sono scesi
in piazza i georgiani (pare, per ora, con successo, se è vero che il governo
vorrebbe ritirarla) non è solo ricalcata su quella russa, alla base della
definitiva chiusura di ogni spazio di libertà di espressione in quel paese, non
ha solo un forte retrogusto anni trenta (il lessico è inconfondibile), ma è
anche tragicamente simile ad analoghi provvedimenti già adottati nell’Ungheria
di Viktor Orbán, in nome della crociata contro George Soros, la dittatura di
Bruxelles e la congiura delle élite globaliste e delle ong.
Serve un ripassino
pure su questo, e in particolare su chi e come, in questi anni, ha condiviso e
diffuso la stessa paccottiglia anche in Italia? I protagonisti, ovviamente, sono
sempre gli stessi.
Perché ho ricordato
tutte queste cose? Perché è alla luce di tutte queste cose che si vede con
chiarezza l’estremo paradosso della nostra epoca: che ad avere capito prima e
meglio di tutti cosa significhi e a cosa serva l’Unione europea sono ucraini e
georgiani, che non ne fanno parte. Sono quella donna in piazza e quegli uomini
che la aiutano a tenere alta la bandiera blu, che nei talk show italiani saranno
immancabilmente definiti pupazzi degli americani da chi continua a ripetere le
solite geofregnacce sulla «guerra per procura» e «l’accerchiamento della Nato».
Mentre la verità è che gli unici a essere davvero accerchiati, come si vede,
siamo proprio noi italiani, circondati da almeno dieci anni da un manipolo di
farabutti e da un immenso esercito di mentecatti.
La Repubblica.
Attacco russo da tre mari
Le forze russe hanno
preso di mira infrastrutture critiche, ha riferito il governatore regionale Oleh
Syniehubov. Lanciati anche missili ipersonici. Transnistria: "Sventato attacco
terroristico ucraino"
Bombardamenti russi
hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Kharkiv e di Odessa, secondo
quanto riportano i media locali. Le forze russe hanno attaccato l'oblast di
Kharkiv prendendo di mira infrastrutture critiche, ha riferito il governatore
regionale Oleh Syniehubov su Telegram specificando che una residenza privata è
stata danneggiata. Nell'oblast di Odessa sono state prese di mira invece
infrastrutture energetiche, secondo il governatore Maksym Marchenko. La
fornitura di elettricità è stata parzialmente interrotta.
Punti chiave
16:15
Esercito Kiev, Mosca
ha lanciato missili da tre mari
12:15
Mosca, missili su
Ucraina per rappresaglia attacco Bryansk
11:51
Aiea: "A
Zaporizhzhia stiamo giocando con il fuoco"
11:14
Ucraina, Simson: "A
Zaporizhzhia enorme rischio nucleare"
10:23
Transnistria:
"Sventato attacco terroristico ucraino"
10:08
Zelensky: "Notte
difficile, attaccate dieci regioni"
06:53
Centrale Zaporizhzia
senza energia dopo attacco russo
02:12
Kiev, attacchi russi
su regioni di Kharkiv e Odessa
Alcuni attacchi
hanno preso di mira la regione orientale ucraina di Kharkiv e la regione
meridionale di Odesa: lo hanno reso noto funzionari locali. "Il nemico ha
effettuato circa 15 attacchi contro la città e la regione. Gli occupanti hanno
ancora una volta preso di mira le infrastrutture critiche", ha dichiarato il
governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, sui social media. Nella
regione di Odessa, il governatore Maksym Marchneko ha affermato che "i missili
hanno colpito l'infrastruttura energetica della regione e danneggiato gli
edifici residenziali" a seguito di un "massiccio attacco missilistico".
04:14
Allarme antiaereo in
tutte le regioni
Esplosioni sono
state segnalate nella notte nelle città ucraine di Dnipro e di Kirovohrad e
nella regione di Mykolaiv. Lo riportano i media locali aggiungendo che l'allarme
antiaereo è stato attivato in tutti gli oblast ucraini. L'amministrazione
militare della regione di Kiev ha avvertito i residenti di possibili minacce
aeree e ha affermato che la difesa aerea è pronta a proteggere la regione. Hanno
anche esortato i residenti a rimanere nei rifugi.
05:44
Forte esplosione a
Kiev
Una forte esplosione
è stata udita a Kiev questa mattina presto, riportano i media locali. In
precedenza l'amministrazione militare dell'oblast della capitale ucraina aveva
riferito che le difese aeree della regione erano operative.
05:47
Sindaco Kiev,
esplosioni nella capitale
Il sindaco di
Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di esplosioni nella capitale ucraina, mentre
un'ondata di bombardamenti russi sta colpendo diverse parti del Paese.
"Esplosioni nel quartiere Holosiivskyi della capitale. Tutti i servizi si stanno
recando sul posto", ha dichiarato Klitschko sui social media, riferendosi a
un'area meridionale della città.
06:38
Bombe su Kiev,
almeno due feriti
Altre esplosioni si
sono verificate stamattina a Kiev nel distretto occidentale di Sviatoshynskyi.
Lo ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko su Telegram.
Due persone sono rimaste ferite e sono state curate sul luogo dell'attacco, ha
specificato Klitschko aggiungendo che alcune auto sono andate in fiamme nel
cortile di un edificio residenziale dopo il raid russo.
06:53
Centrale Zaporizhzia
senza energia dopo attacco russo
La centrale nucleare
ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza energia elettrica a seguito di un
attacco russo. Attualmente funziona con generatori diesel. Lo afferma il gestore
dell'energia nucleare del Paese. "L'ultima linea di comunicazione tra la
centrale nucleare di Zaporizhzhia e il sistema elettrico ucraino è stata
interrotta a causa di attacchi missilistici", dichiara Energoatom in un
comunicato.
07:22
Colpito impianto
energia a Kiev, 40% senza riscaldamento
Una delle esplosioni
udite questa mattina a Kiev è stata un attacco a un impianto energetico e il 40%
degli abitanti della capitale è ora senza riscaldamento: lo ha scritto
su Telegram il sindaco, Vitali Klitschko, come riporta il Guardian. "Dopo
l'attacco missilistico, a causa dell'interruzione di emergenza dell'energia
elettrica, il 40% dei consumatori della capitale è attualmente senza
riscaldamento. L'erogazione dell'acqua funziona normalmente", ha dichiarato il
sindaco. Attualmente la temperatura nella città è di 4 gradi.
07:25
Zelensky: "Non
incontrerò Putin, nessuna fiducia in lui"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky esclude al momento di immaginare una situazione nella
quale potrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin. "Non abbiamo
alcuna circostanza per parlare con il presidente della Federazione Russa perché
non mantiene la parola data", ha detto Zelensky in un'intervista alla Cnn. "Non
abbiamo alcuna fiducia in lui", ha affermato, ribadendo che "la Russia dovrebbe
lasciare il nostro territorio. Dopo di che, saremo felici di unirci agli
strumenti diplomatici. Per farlo, possiamo trovare qualsiasi formato con i
nostri partner".
07:41
4 morti a Leopoli
dopo raid russo, una vittima a Dnipropetrovsk
Le autorità ucraine
affermano che almeno cinque persone sono state uccise in un massiccio attacco
missilistico e molte altre sono rimaste ferite. Il governatore della regione
occidentale di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha dichiarato che quattro persone sono
state uccise dopo che un missile ha colpito un'area residenziale nel distretto
di Zolochivskyi. I soccorritori stanno setacciando le macerie, sotto le quali
potrebbero essere rimaste intrappolate altre persone. Una persona è stata uccisa
nella regione di Dnipropetrovsk, ha riferito il governatore Serhii Lysak,
aggiungendo che altre due sono rimaste ferite in diversi attacchi nella regione.
Il sindaco di Kiev ha riferito di danni in due distretti, mentre i governatori
di Kharkiv e Odesa hanno dichiarato che sono stati colpiti edifici residenziali.
07:51
Georgia: Parlamento
revoca legge su agenti stranieri
Il Parlamento
georgiano ha revocato la legge sugli agenti stranieri. Lo riferisce Sputnik
Georgia
07:54
Energoatom: "Russi
spingono mondo verso catastrofe nucleare"
"I russi stanno
mettendo il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. E questo avviene il
giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della ZNPP
(la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ndr)": lo ha afferma in un comunicato
l'operatore ucraino per il nucleare Energoatom, come riporta il Guardian.
08:14
Kiev dopo gli
attacchi a Zaporizhzhia: i russi mettono il mondo sull'orlo di una catastrofe
nucleare
"A seguito dei
bombardamenti, l'ultima linea che alimentava la centrale nucleare di
Zaporizhzhia è stata danneggiata. I russi stanno mettendo il mondo sull'orlo di
una catastrofe nucleare. E questo avviene il giorno dopo i negoziati con le
Nazioni Unite sulla smilitarizzazione di Zaporizhzhia". È quanto afferma il
ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko, come riporta via Telegram la
società energetica ucraina Energoatom.
08:53
Kiev: abbattuti 34
misssili da crociera russi
"Dei 48 missili da
crociera Kh-101/Kh-555 lanciati dai russi, le forze di difesa aerea Calibre
dell'Ucraina ne hanno distrutti 34". Lo riferisce il comandante capo delle forze
armate ucraine, Valery Zaluzhnyi, come riporta Unian. In tutto, durante la
notte, i russi hanno sparato 81 missili.
10:08
Zelensky: "Notte
difficile, attaccate dieci regioni"
"E' stata una notte
difficile. Abbiamo avuto un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese.
Sono state attaccate le regioni di Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv,
Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e Vinnytsia". Lo ha affermato
su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sono stati attaccati
edifici residenziali e infrastrutture essenziali. Purtroppo ci sono feriti e
morti. Le mie condoglianze alle famiglie", ha aggiunto Zelensky.
09:49
Kuleba: "Nella notte
massiccio attacco russo su obiettivi civili. E' una barbarie"
"La Russia ha
lanciato nella notte un massiccio attacco con missili e droni contro l'Ucraina,
causando la perdita di vite umane e danneggiando le infrastrutture civili.
Nessun obiettivo militare, solo la barbarie russa". È quanto scrive in un tweet
il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Verrà il giorno in cui Putin e
i suoi collaboratori saranno chiamati a rispondere delle loro azioni da un
Tribunale speciale", aggiunge Kuleba.
09:51
Il sindaco di
Kharkiv: "La città senza acqua, riscaldamento e luce dopo gli attacchi"
I 15 missili
lanciati nella notte su Kharkiv hanno lasciato la città senza acqua, senza
elettricità e e senza riscaldamento. Lo riferisce il sindaco della città, Igor
Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda. "Sono state colpite e danneggiate
infrastrutture critiche", fa sapere Terekhov, "non c'è elettricità in tutta la
città, quindi siamo passati ai generatori". "Stiamo lavorando per ripristinare
il riscaldamento, mentre l'approvvigionamento idrico è stato interrotto",
aggiunge.
10:12
Kiev: "Nella notte
solo la barbarie russa"
"La Russia ha
lanciato nella notte un massiccio attacco con missili e droni contro l'Ucraina,
causando la perdita di vite umane e danneggiando le infrastrutture civili.
Nessun obiettivo militare, solo la barbarie russa. Verrà il giorno in cui Putin
e i suoi collaboratori saranno chiamati a rispondere delle loro azioni da un
Tribunale speciale": lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri
ucraino, Dmytro Kuleba.
10:23
Transnistria:
"Sventato attacco terroristico ucraino"
I separatisti
filo-russi della Transnistria, in Moldavia, hanno annunciato di aver sventato un
attentato terroristico dei servizi segreti ucraini (Sbu) contro il loro
leader, Vadim Krasnoselsky. Secondo quanto riferito dal ministero della
Sicurezza della Transnistria, l'attentato doveva colpire "diversi funzionari"
della regione separatista. I sospetti coinvolti nel piano sono stati arrestati.
Secondo le ricostruzioni, gli aggressori contavano di causare "un gran numero di
vittime", perché l'attacco era stato pianificato al centro di Tiraspol.
10:31
Bombe russe
sull'Ucraina, i morti sono almeno 8
E' salito ad almeno
otto il bilancio dei morti in Ucraina provocati dai bombardamenti russi la notte
scorsa: lo hanno reso noto funzionari del Paese. Il totale include 5 morti nella
regione di Leopoli (tre uomini e due donne), nell'ovest del Paese, e altri tre a
Kherson, nell'Ucraina meridionale.
11:01
Nord Stream,
Cremlino: "Opera di un servizio statale"
Il Cremlino non
crede che dietro all'attacco al Nord Stream ci sia "un Dottor Male pro-ucraino"
ed è convinto che un'operazione di tale difficoltà possa essere stata compiuto
solo da "un servizio speciale statale ben organizzato come ce ne sono pochi nel
mondo". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. Il Cremlino
chiede inoltre una "inchiesta veloce e trasparente sull'attacco terroristico al
Nord Stream" e che Mosca "vi possa partecipare".
11:07
Kiev: "Sei degli 81
missili russi erano ipersonici"
Sei degli 81 missili
lanciati dalle forze russe la notte scorsa contro l'Ucraina erano gli ipersonici
Kinzhal, che la forza aerea di Kiev non è in grado di intercettare: lo ha reso
noto su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine, il
generale Valery Zaloujny.
11:14
Ucraina, Simson: "A
Zaporizhzhia enorme rischio nucleare"
"L'impianto
nucleare di Zaporizhzhia è occupato dalle forze militari, in violazione della
convenzione internazionale, con rischi enormi di incidenti nucleari. Gli esperti
nucleari, i tecnici, gli ingegneri rischiano la vita ogni giorno e in questo
istante stanno cercando di sostituire l'infrastruttura danneggiata. Qualsiasi
sistema energetico si sarebbe ritrovato in ginocchio, ma l'Ucraina non ha
ceduto, ha resistito all'invasione e l'Europa ha sostenuto l'Ucraina in ogni
passo". Lo ha dichiarato la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, in
audizione alla commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo,
insieme al direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, Fatih
Birol.
11:27
Almeno 15 missili
russi s-300 su Kharkiv: due donne ferite
Le forze russe hanno
lanciato nelle ultime ore "un massiccio attacco missilistico su kharkiv e la sua
regione" con "almeno 15 missili s-300". Lo ha spiegato questa mattina il
governatore Oleh Synyehubov, in un messaggio su Telegram. "Oggetti
dell'infrastruttura critica sono stati colpiti. Inoltre, un obiettivo di
un'infrastruttura civile è stato danneggiato nella città di Kharkiv", ha
aggiunto. Synyehubov ha detto che due donne di circa 70 anni sono rimaste ferite
a pisochyn: una di loro è stata ricoverata in ospedale. Una struttura agricola,
inoltre, è stata danneggiata a slobozhanske.
11:51
Aiea: "A
Zaporizhzhia stiamo giocando con il fuoco"
Il direttore
generale della Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael
Grossi, ha rilanciato l'allarme sulla sicurezza della centrale di Zaporizhzhia,
in Ucraina meridionale, dopo l'ultimo attacco russo che ha comportato
l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto. "Ogni volta è come giocare con
il fuoco, ma se permettiamo a questa situazione di estendersi, un giorno la
nostra fortuna finirà", ha avvertito Grossi davanti al consiglio dei governatori
dell'organismo delle Nazioni Unite a Vienna. Il capo dell'Aiea ha poi invitato
"tutti a impegnarsi per garantire la sicurezza" della centrale.
12:03
Nuova sirena di
allarme a Kiev
E' in corso a Kiev
un nuovo allarme aereo, la sirena che lo segnala sta risuonando in città.
12:15
Mosca, missili su
Ucraina per rappresaglia attacco Bryansk
I nuovi attacchi
missilistici russi sull'Ucraina sono stati una "massiccia rappresaglia"
per "l'attacco terroristico" nella regione frontaliera di Bryansk da parte di un
commando infiltrato dall'Ucraina. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca
citato dalle agenzie russe. Il ministero conferma che sono stati utilizzati
anche missili ipersonici Kinzhal.
12:19
Aiea: "Centrale
Zaporizhzhia autosufficiente per 15 giorni"
Nella centrale
nucleare di Zaporizhzhia c'è abbastanza diesel per garantire il funzionamento
dell'impianto con i generatori "per 15 giorni": lo ha detto il direttore
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael
Grossi, nella sua relazione al Consiglio dei governatori dell'organizzazione
sulla situazione dopo i bombardamenti russi. Grossi ha pubblicato sul suo
account Twitter il video del suo intervento. Questa mattina l'operatore ucraino
per il nucleare, Energoatom, aveva stimato che il carburante per i generatori
diesel che sono stati accesi per soddisfare il fabbisogno della centrale "durerà
10 giorni".
12:23
Polonia: "Già
consegnati altri 10 Leopard 2"
Il ministro della
Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha annunciato che la Polonia ha "già"
consegnato all'Ucraina i 10 carri armati Leopard 2A4 aggiuntivi promessi.
"Stiamo parlando di un battaglione di carri armati pesanti che, nel caso della
Polonia, sono già stati consegnati e, nel caso dei nostri alleati, saranno
consegnati all'Ucraina molto presto", ha dichiarato Blaszczak ai giornalisti. La
Polonia aveva promesso a fine gennaio di inviare a Kiev un totale di 14 carri
armati Lepoard 2 e i primi quattro erano stati consegnati il 24 febbraio,
anniversario dell'invasione russa.
12:32
Mosca: "Attacchi
odierni rappresaglia per Bryansk, colpiti obiettivi militari"
"Armi di alta
precisione a lungo raggio lanciate dall'aria, dal mare e da terra, compresi i
missili ipersonici Kinzhal, hanno colpito obiettivi cruciali delle
infrastrutture militari, imprese del complesso militare-industriale e strutture
energetiche che le alimentano" in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della
Difesa russo, citato dall'agenzia Ria Novosti.
Il portavoce del
ministero, Igor Konashenkov, ha spiegato che gli attacchi missilistici di questa
notte contro l'Ucraina sono una "rappresaglia" per "gli atti terroristici
organizzati dal regime di Kiev nella regione di Bryansk il 2 marzo".
13:09
Ucraina: Ue, a
Zaporizhzhia situazione molto pericolosa
La Commissione
europea "sostiene tutte le iniziative per mettere in
sicurezza" Zaporizhzhia "perché occupare una centrale civile è contro tutti gli
accordi internazionali e crea una situazione molto pericolosa". Così la
commissaria Ue all'Energia Kadri Simson rispondendo alle domande dei giornalisti
a Bruxelles.
La commissaria ha
riferito di essere "in contatto" con il ministro ucraino dell'Energia German
Galushchenko "per sostenere il sistema energetico dell'Ucraina". I due nel
pomeriggio avranno un colloquio in videochiamata
13:28
Polonia consegna
ultimi 10 carri armati Leopard
Il ministro della
Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha confermato la consegna all'Ucraina degli
ultimi dieci carri armati Leopard 2, dopo l'invio di un primo lotto di tank la
scorsa settimana, in concomitanza con la visita a Kiev del primo
ministro Mateusz Morawiecki.
Blaszczak, che aveva
già anticipato all'inizio della settimana che la seconda consegna era imminente,
ha dichiarato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Pap, che anche il
lavoro di addestramento per l'esercito ucraino che deve gestire questi nuovi
carri armati è terminato.
13:39
Bombe russe
sull'Ucraina, i morti sono almeno 11
Sono almeno 11 le
vittime e 22 i feriti provocati dai bombardamenti russi in Ucraina durante la
notte e le prime ore del mattino: lo affermano le autorità regionali citate
dalle Cnn. Ottantuno missili sono stati lanciati in diverse regioni del Paese,
tra cui la capitale.
14:00
Ucraina: Zelensky
riunisce forze sicurezza: nonostante gli attacchi vinceremo
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione con i vertici dei servizi di
sicurezza dopo l'ultimo massiccio raid russo. "I bombardamenti di oggi hanno
interessato le regioni di Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Kirovohrad, Kharkiv, Sumy,
Vinnytsia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Odessa, Zaporizhzhia e la città di Kiev",
ha scritto su Telegram. "Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il
loro duro lavoro, per proteggere la nostra gente. Dobbiamo garantire la
protezione delle infrastrutture energetiche dal fuoco nemico e garantire il
rapido ripristino dell'approvvigionamento energetico nelle aree colpite", ha
aggiunto. "Nonostante migliaia di attacchi russi, garantiremo tutti insieme
l'invincibilità dell'Ucraina. Stiamo lavorando e vinceremo", ha concluso.
14:38
L'intelligence
lituana: Mosca ha risorse militari per combattere altri due anni
La Russia ha risorse
militari sufficienti per portare avanti la guerra in Ucraina per altri due anni.
Lo ha detto il capo dell'intelligence lituana Elegijus Paulavicius nel corso di
una conferenza stampa a Vilnius. "Le risorse che la Russia ha in questo momento
sarebbero sufficienti per continuare la guerra all'attuale intensità per due
anni", ha detto Paulavicius. "Per quanto tempo la Russia sarà in grado di
condurre la guerra dipenderà anche dal sostegno all'esercito russo da parte di
Stati come l'Iran e la Corea del Nord. Ma se si guarda a ciò che la Russia ha
oggi, come la riserva strategica, l'equipaggiamento, le munizioni, gli
armamenti, può combattere all'attuale intensità per due anni", ha aggiunto.
15:06
Riparte la corrente
nella centrale di Zaporizhzhia dopo attacchi
L'energia elettrica
è stata ripristinata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia interrotta
dagli attacchi missilistici russi della notte scorsa.
"Gli specialisti di
Ukrenergo hanno ripristinato l'alimentazione della centrale nucleare di
Zaporizhzhia, che era stata interrotta dagli attacchi missilistici russi", ha
dichiarato l'operatore Ukrenergo in una nota.
La centrale di
Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è attualmente occupata dalle truppe del
Cremlino.
15:32
Russia, hacker
violano radio e tv: annunciano attacco nucleare
"E' stato condotto
un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di
iodio". Questo il messaggio trasmesso da tv e radio di alcune regioni dalla
Russia, in quello che le autorità hanno successivamente rivelato essere il
risultato di un attacco hacker. Secondo Ukrinform, l'allarme è stato diffuso a
Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk. Successivamente il ministero russo
per le Situazioni di emergenza ha annunciato che i server radiofonici e
televisivi erano stati violati. Altri media precisano che l'avviso è arrivato
anche sulle tv della regione di Mosca. Sul web circolando le immagini delle
televisioni russe che trasmettono il messaggio di allarme.
15:38
Mosca, consultazioni
su accordo grano lunedì a Ginevra
Consultazioni tra
una delegazione russa e rappresentanti dell'Onu per l'estensione
dell'accordo sull'esportazione di grano ucraino dai porti sul Mar Nero, in
scadenza il 17 marzo, si svolgeranno lunedì 13 marzo a Ginevra. Lo ha annunciato
il ministero degli Esteri di Mosca.
16:03
Esercito Kiev, "dai
russi attacchi così mai visti prima"
"Per la prima volta
la Russia ha utilizzato nei raid diversi tipi di missili. Sono stati utilizzati
ben sei Kinzhal (arma ipersonica a capacità nucleare): è un attacco che non
ricordo di aver mai visto prima", ha dichiarato alla televisione ucraina Yurii
Ihnat, portavoce del Comando delle forze aeree dell'Ucraina, citato dalla Cnn.
"Finora non abbiamo la capacità di contrastare queste armi", ha aggiunto,
riferendosi ai Kinzhal e ai missili da crociera X-22 lanciati sull'Ucraina
durante la notte e al mattino. Mosca ha usato il missile Kinzhal a capacità
nucleare in alcune occasioni nelle prime settimane dell'invasione.
16:15
Esercito Kiev, Mosca
ha lanciato missili da tre mari
"Gli attacchi delle
unità militari russe all'Ucraina della notte sono partiti da tre mari: il Mar
Nero, il Mar d'Azov, il Mar Caspio. Hanno usato tutti i tipi di missili che
hanno, anche per distrarre la contraerea", ha detto alla tv statale il portavoce
del Comando delle forze aeree ucraine Yurii Ignat. Ignat ha spiegato che oltre
ad utilizzare gli S-300, che i russi lanciano praticamente tutti i giorni,
durante i raid sono stati usati anche i distruttivi Kh-22, con una testata da
950 chili, poi missili anti-radar che non perdono la direzione, X-31 e X-59.
16:46
Lettonia invia a
Kiev auto confiscate a guidatori ubriachi
Le auto confiscate
ai conducenti ubriachi in Lettonia verranno inviate in Ucraina nell'ambito di un
nuovo programma approvato dal parlamento lettone per sostenere Kiev nella guerra
con la Russia. Come riporta Ntv, il primo convoglio composto da otto veicoli
sequestrati ha lasciato un deposito di Riga oggi e dovrebbe attraversare presto
il confine. Le auto sono destinate all'esercito e agli ospedali ucraini.
17:23
Sindaco Kiev,
ripristinata fornitura elettricità in città
"La fornitura di
elettricità ai consumatori di Kiev è stata completamente ripristinata". Lo ha
scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko.
"Proseguono i lavori per il ripristino della fornitura di calore. Attualmente il
30% delle abitazioni è senza riscaldamento", ha aggiunto. L'obiettivo è di
tornare a regime "entro un giorno". I lavoratori delle utility pianificano di
ripristinare completamente il calore entro un giorno.
17:40
Media, raid russi
costati a Mosca 581 milioni di dollari
Secondo un'inchiesta
giornalistica pubblicata sul canale Telegram The Price of the State, i raid
russi della notte scorsa sull'Ucraina sono costati da 438 milioni a 581 milioni
di dollari per i diversi tipi di missili utilizzati. Nella notte del 9 marzo, le
truppe russe hanno lanciato 81 missili da diverse basi. Negli ultimi 5 mesi, le
unità militari del Cremlino hanno sparato 821 missili contro l'Ucraina, per un
costo totale di circa 7,5 miliardi di dollari. Secondo gli autori del report,
gli attacchi lanciati tra la notte e le prime ore del mattino, sono
"probabilmente di una vendetta nei confronti degli ucraini per il fatto che il 7
marzo è scoppiata una tubatura a Vladivostok, lasciando 30.000 persone senza
riscaldamento e acqua".
17:43
Presidente Georgia,
'revoca legge è vittoria del popolo'
La presidente
georgiana, Salomè Zurabishvili, ha accolto con favore la decisione del
Parlamento di revocare la contestata legge sugli 'agenti stranieri' salutandola
come una vittoria del popolo. "Mi congratulo con l'intera società per questa
vittoria, accolgo con favore la giusta decisione di revocare la legge, presa in
considerazione del vero potere del popolo", ha detto Zurabishvili, citata
dall'agenzia russa Tass.
17:55
Capo forze di terra:
"Tenere Bakhmut diventa sempre più importante"
Reggere l'urto
dell'offensiva russa a Bakhmut diventa per l'esercito ucraino giorno dopo giorno
"sempre più importante" perché consente di intaccare le capacità offensive delle
forze di Mosca. Lo ha dichiarato il comandante delle forze di terra
ucraine, Oleksandr Syrskyi, sottolineando che "l'importanza di tenere Bakhmut è
in costante crescita. Ogni giorno di difesa della città ci consente di
guadagnare tempo per prepararci per future operazioni offensive", ha dichiarato
in una nota il generale. Nella battaglia per Bakhmut, "il nemico perde la truppe
più addestrate e pronte al combattimento del suo esercito, le unità d'assalto
Wagner", ha detto Syrskyi, che è il secondo generale più alto in grado
dell'Ucraina.
18:20
Mosca adotta
sanzioni contro 144 cittadini Stati baltici
Mosca ha annunciato
di avere adottato sanzioni contro 144 cittadini di Lettonia, Lituania ed
Estonia, compresi ministri, parlamentari, personaggi pubblici e giornalisti, per
la loro politica ostile nei confronti della Russia. La decisione, afferma il
ministero degli Esteri in una nota citata dalla Tass, è stata presa per
rappresaglia contro "l'attività di lobbying degli Stati baltici per sanzioni e
altre misure contro la Russia, l'interferenza negli affari interni russi e per
il fatto di fomentare sentimenti russofobi". I personaggi colpiti dalle sanzioni
di Mosca sono inoltre coinvolti in una "campagna barbara intrapresa dalle
autorità di questi Stati per la demolizione di monumenti ai soldati liberatori
sovietici, la persecuzione della popolazione russofona, la riscrittura della
Storia, la glorificazione del nazismo e la continuazione della politica
criminale per provocare una escalation del conflitto ucraino e rifornire di armi
il regime di Kiev".
18:57
Ucraina: Usa,
attacco Russia brutale e ingiustificato
Gli ultimi attacchi
missilistici della Russia contro l'Ucraina sono "brutali e ingiustificati". Lo
ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, in un briefing con
la stampa sull'Air Force One che sta portando Joe Biden a Filadelfia.
19:11
Von der Leyen a
Zelensky, 'attacchi russi crimini guerra'
"Oggi ho parlato con
Zelensky in seguito agli attacchi missilistici indiscriminati sull'Ucraina la
scorsa notte. L'attacco deliberato della Russia contro i civili e la rete
energetica è un crimine di guerra. Ciò rafforza la nostra comune determinazione
a continuare a progredire negli sforzi di riforma dell'Ucraina nel percorso di
adesione in Ue". Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der
Leyen su twitter dopo aver avuto una conversazione telefonica con il
presidente Volodymyr Zelensky.
19:37
Scholz, non vedo
volontà Putin di negoziare
Il cancelliere
tedesco Olaf Scholz ha ribadito la sua sensazione riguardo alla mancanza di
volontà da parte del presidente russo Vladimir Putin per un'apertura a negoziati
di pace con l'Ucraina. "Purtroppo al momento non vedo alcuna volontà di farlo",
ha detto Scholz in un'intervista a Südwest Presse. Scholz ha quindi ribadito il
sostegno all'Ucraina, ma anche l'intenzione di rimanere "in contatto con la
Russia". "Ho deliberatamente tenuto contatti telefonici con Putin. Naturalmente,
i nostri punti di vista molto diversi diventano evidenti. Ma deve arrivare un
momento in cui Putin riconosce che non sta raggiungendo i suoi obiettivi
imperialisti, che il prezzo è troppo alto", ha aggiunto Scholz, "le autorità
ucraine hanno da tempo dichiarato di essere pronte per la pace. Ma non deve
essere una pace dettata. Non puoi negoziare con una pistola puntata alla
tempia".
19:57
Finlandia, Biden
incontra presidente Niinstö: "Adesione a Nato prima possibile"
Il presidente
americano Joe Biden ha incontrato formalmente alla Casa Bianca il presidente
della Finlandia, Sauli Niinistö, mentre questi era riunito con il Consigliere
per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Biden ha ribadito "il deciso sostegno
degli Usa per l'adesione il prima possibile di Svezia e Finlandia alla Nato"
20:42
007 Vilnius, Mosca
ha risorse per altri 2 anni guerra
La Russia ha risorse
sufficienti per altri due anni di guerra in Ucraina. Lo riferisce l'intelligence
lituana, spiegando che Mosca "ha accumulato armi e attrezzature durante i lunghi
anni della Guerra Fredda". "Stimiamo - ha detto il direttore Elegijus
Paulaviciusche - che le risorse di Mosca dureranno per altri due anni di guerra
della stessa intensità di oggi".
21:38
Georgia:Usa,bene
revoca legge agenti stranieri, ora ritiro
Gli Stati Uniti
apprezzano la decisione del parlamento della Georgia di revocare la controversa
legge sugli agenti stranieri. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato
americano, Ned Price, in un briefing con la stampa sottolineando che adesso
Washington auspica "il ritiro totale" della misura.
21:50
Lukashenko firma
legge pena di morte per funzionari traditori
Il presidente
bielorusso Alexsandr Lukashenko ha firmato una legge che prevede la pena di
morte per funzionari e soldati rei di "tradimento". Lo riferisce Ukrainska
Pravda, citando il canale Telegram Pul Pervogo, vicino a Lukashenko.
22:26
Blinken chiama
ministra francese Colonna, sostegno a Ucraina
Il Segretario di
Stato americano Antony J. Blinken ha parlato oggi al telefono con la ministra
degli Esteri francese Catherine Colonna con la quale ha discusso del sostegno
all'Ucraina contro la guerra non provocata e brutale della Russia. Lo riferisce
una nota del dipartimento di Stato Usa. Il segretario ha inoltre rilevato
l'importanza di una stretta cooperazione tra Francia e Stati Uniti per
promuoveregli obiettivi "condivisi di pace, stabilità e prosperità
nell'Indo-Pacifico e altrove.
Stessa
'illusione' usata dalle truppe speciali Usa nella IIWW contro Hitler.
La guerra
fantasma in Ucraina, carri armati e missili gonfiabili: le esche di Kiev per le
munizioni di Putin. Riccardo Annibali su Il Riformista il 9 Marzo 2023
Questa volta c’è il
trucco e c’è anche l’inganno (a danno dei russi). L’esercito ucraino ha
‘schierato’ imponenti colonne di carri armati e lanciamissili Himars pronti a
colpire con la massima potenza di fuoco l’esercito russo. Però sono soltanto
delle esche gonfiabili, posizionate sul campo di battaglia per confondere il
nemico. Tra i vari stratagemmi utilizzati da Kiev per fronteggiare le forze del
Cremlino troviamo anche la carta dei falsi veicoli militari dei sistemi di
difesa. Basta piazzarli sulla linea del fronte e aspettare che gli uomini
di Vladimir Putin li colpiscano sprecando così munizioni.
Nel frattempo che
all’Ucraina arrivino le armi, i mezzi e i veicoli promessi, l’esercito
di Zelensky ha deciso che la tattica da intraprendere è quella di far sprecare
quante più munizioni possibili al nemico. Niente di nuovo sul fronte
orientale. Il precedente storico è quello dell’Esercito Fantasma statunitense
che combatté durante la Seconda guerra mondiale. Era composto da oltre mille
uomini e aveva l’unico obiettivo di ingannare l’esercito nazista e depistare i
loro alti comandi, inscenando quello che gli storici hanno poi definito uno
‘show itinerante’ di finte campagne militari.
Il nome ufficiale
del loro reparto era 23rd Headquarters Special Troops, un corpo di élite
specializzato nell’ingannare i nemici e formato da artisti, attori,
pubblicitari, i quali tra il 1944 e il 1945 riuscirono a organizzare più di
venti finti campi di battaglia al confine tra Francia, Germania e Lussemburgo.
Per farlo utilizzarono carri armati e aeroplani gonfiabili, altoparlanti molto
potenti che diffondevano suoni di esplosioni e di artiglieria, e finte
comunicazioni radio.
Cercarono di dare
l’impressione che l’esercito fosse ovunque. Impersonarono soldati di altre unità
che si trovavano da tutt’altra parte, si cucivano i costumi da soli e
applicavano emblemi sempre diversi sui veicoli, a seconda delle esigenze, per
far sembrare che ci fosse un gran movimento di mezzi. Tra le altre cose si
travestivano anche da alti ufficiali e si facevano vedere in pubblico in vari
villaggi, per dare adito a pettegolezzi sulle presunte importanti operazioni in
corso. Tutto questo faceva parte di “un’atmosfera” che contribuiva a creare
“l’illusione”, per usare le parole degli stessi membri dell’Esercito fantasma.
Oggi anche
l’esercito ucraino, da un anno impegnato in un’estenuante guerra, si sta
affidando a copie gonfiabili dei mezzi richiesti dal loro comandante in capo.
Con questa tecnica la perdita di un carro armato e dei sistemi missilistici di
artiglieria made in Usa può essere considerata irrisoria se i bersagli fatti
‘scoppiare’ dai russi sono soltanto esche a buon mercato per ingannare gli
uomini del Cremlino.
Come riportato
da Reuters, Inflatech Decoys, un produttore ceco di falso equipaggiamento
militare, ha visto i suoi guadagni schizzare alle stelle. L’azienda ha un
catalogo di oltre trenta differenti esche gonfiabili, di dimensioni reali, che
vende a clienti di tutto il mondo. Adesso si è aggiunto il 31esimo “modello”:
quello degli Himars.
Le esche non sono
semplici palloncini, anzi. Sono fatte sì di materiali leggeri e, oltre a
fuorviare visivamente l’avversario, hanno anche un’impronta termica.
Quindi appaiono sui radar nemici. Ciascun modello viene impacchettato in sacchi
che possono essere trasportati da due soldati che possono facilmente gonfiarli
in 10 minuti.
I costi sono
variabili: oscillano tra i 10mila e i 100mila dollari. Un costo ‘ammortizzato’
se si pensa che si costringe il nemico a concentrare il fuoco su queste sagome
sprecando risorse preziose sparate con equipaggiamenti che costano dalle quattro
alle 20 volte di più contro un falso bersaglio. Riccardo Annibali
DAGONEWS il 9 marzo
2023.
L’oligarca russo che
ha venduto a Harry e Meghan la loro casa a Montecito per 12 milioni di sterline
è morto a Mosca a 56 anni.
Sergey Grishin, noto
come "l'oligarca Scarface", è deceduto lunedì in un ospedale di Mosca dopo una
“grave malattia”: pare abbia avuto problemi al cervello che hanno portato a una
sepsi.
In passato aveva
criticato Putin tanto da aver chiesto all’allora presidente Donald Trump di
concedergli un passaporto americano: «Voglio essere al sicuro. In questo momento
sono un po' preso di mira dal mondo criminale russo e anche dagli alti
funzionari del governo russo». Tuttavia, era rimasto in Russia, dopo aver
venduto la sua villa americana al duca e alla duchessa del Sussex.
Grishin aveva
acquistato la villa - conosciuta come il castello di Riven Rock - nel 2009.
Era soprannominato
Scarface perché possedeva un'altra villa dove è stato girato il film con Al
Pacino del 1983.
Il magnate russo era
l'ex comproprietario di RosEvroBank e una volta si vantava di aver messo in
ginocchio il sistema bancario russo negli anni '90 commettendo una frode da 60
miliardi di dollari. Lo aveva definito "il più grande schema di frode bancaria
di sempre".
Un'altra delle sue
truffe prevedeva l'uso di inchiostro invisibile sugli assegni. Ora la morte che
rimane un mistero.
Il Caso Biot.
Walter Biot, i giudici militari lo condannano a 30 anni. “Commercio di atti
segreti”.
Il Tempo il 09 marzo 2023
La Procura militare
aveva chiesto l'ergastolo, i giudici hanno deciso per trent’anni di carcere.
Questa la condanna del Tribunale militare di Roma per Walter Biot, il capitano
di fregata arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l’accusa di
spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio
di cinquemila euro. "Biot ha fatto commercio di atti segreti ed è stato colto in
flagranza" ha sottolineato il sostituto procuratore militare nel corso della
requisitoria.
La procura militare,
guidata da Antonio Sabino, contesta a Biot le accuse di rivelazione di segreti
militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di
spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e
rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di
notizie non segrete né riservate. Nel procedimento sono parti civili la
presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministro della Difesa. Nei confronti
del capitano di fregata procede anche la procura di Roma che, nell’inchiesta
della pm Gianfederica Dito coordinata dal procuratore aggiunto Michele
Prestipino, contesta le accuse di spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e
corruzione. Biot per queste accuse è sotto processo davanti alla Corte di Assise
di
L'uomo era
stato arresto la sera del 30 marzo 2021 mentre incontrava il funzionario russo
Dmitry Ostroukhov. in un parcheggio, nel quartiere di Spinaceto, per
consegnargli i materiali raccolti e ricevere in cambio il denaro.
Spionaggio con i
“servizi” russi: Biot condannato a 30 anni dal Tribunale militare.
Redazione
CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 9 Marzo 2023.
Le immagini di due
telecamere nascoste nell’ufficio di Biot, dalle quali si vede l’ufficiale alla
sua scrivania prendere una scatoletta da cui estrae un cellulare, inserire al
suo interno una scheda Sd e fotografare lo schermo del pc e dei documenti
cartacei riservati. L'ufficiale della Marina venne pedinato nei giorni
successivi 24 ore su 24, ed il 30 marzo 2021 venne arrestato nel parcheggio di
in un centro commerciale subito dopo aver incontrato un funzionario russo
Trent’anni di
carcere. Questa la condanna del Tribunale militare di Roma nei confronti del
capitano di fregata della Marina Militare Walter Biot , arrestato dai
carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver
passato documenti segreti a Dmitry Ostroukhov un funzionario dei “servizi” russi
in cambio di cinquemila euro. Nei confronti del capitano di fregata procede
anche la procura di Roma che, nell’inchiesta della pm Gianfederica
Dito coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse
di spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. Biot è sotto
processo per queste accuse davanti alla Corte di Assise di Roma.
“Biot ha fatto
commercio di atti segreti ed è stato colto in flagranza” ha sottolineato il
sostituto procuratore militare nel corso della sua requisitoria. La procura
militare, guidata da Antonio Sabino, contesta a Biot le accuse di rivelazione di
segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a
scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio,
procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni
all’estero di notizie non segrete né riservate.
“Walter Biot
maneggiava quotidianamente documentazione riservata “e questo è stato attestato
e confermato da colleghi e funzionari. Ad esempio il colonnello Pasquale
Tirone lo ha dichiarato a ottobre 2022 durante il dibattimento: “La sezione
analisi strategica dove lavorava Biot si occupava di
operazioni delicatissime, operazioni Nato ad esempio”. La stanza 248 dove
lavorava Biot prevede due postazioni hanno spiegano i testimoni in questo
processo. Il capitano di fregata maneggiava indiscutibilmente materiale
riservato, ed essendo addirittura un supervisore aveva “un controllo su questa
documentazione” ha spiegato la pm che ha rappresentato l’accusa, che ha aggiunto
“Biot curava il regolamento di sicurezza fra le altre cose ma era anche
responsabile di chi aveva titolo a maneggiare i documenti riservati. Secondo
l’ufficiale Mannino Biot era la sua longa manus“.
Durante l’udienza
del Tribunale Militare, il rappresentante dell’accusa ha ricordato le
testimonianze e le immagini di due telecamere nell’ufficio di Biot, dalle quali
si vede l’ufficiale alla sua scrivania prendere una scatoletta da cui estrae un
cellulare, inserire al suo interno una scheda Sd e fotografare lo schermo del pc
e dei documenti cartacei riservati. Dopodichè Biot inserisce la Sd in una
scatola di medicine, nascosta nel ‘bugiardino’ ed infila tutto nel suo zaino.
L’ufficiale della Marina venne pedinato nei giorni successivi 24 ore su 24, ed
il 30 marzo 2021 venne arrestato dagli uomini del ROS dei Carabinieri nel
parcheggio di in un centro commerciale subito dopo aver incontrato un
funzionario russo. “Biot ha fatto commercio di atti segreti ed è stato colto in
flagranza” ha sottolineato il sostituto procuratore militare.
“Biot non ha avuto
possibilità di difendersi. In questo paradosso tra segreto istruttorio e segreto
Nato viene calpestato l’imputato. – ha affermato l’avvocato difensore durante
l’arringa – Chi è quell’imputato che senza poter vedere gli elementi di prova si
sottopone a un esame? Biot non ha avuto la possibilità di confrontarsi
concretamente con l’accusa mossa. Se il segreto e’ prevalente non si butta
all’ergastolo il singolo. Adesso con uno slancio di coraggio dovremmo pensare
che la decisione che verrà adottata ha una rilevanza che va oltre questo
tribunale. C’è stata una competizione di severità – ha sottolineato il penalista
– un crescendo di severità e di gravità di giudizio su fatti, non provati.
Continueremo questa battaglia fino a quando Walter Biot non verrà reintegrato
con onore nella Marina Militare”.
Secondo quanto
riferito da testimoni nel corso del dibattimento, come ricordato dall’accusa in
aula, i documenti in questione riguardavano alcuni la lotta all’Isis mentre
altri mostravano debolezze e criticità dell’Alleanza Nato, specie dal punto di
vista navale e marittimo. ‘Falle’ che sarebbero poi emerse proprio durante la
crisi in Ucraina e l’invasione russa. “Tra i 19 documenti fotografati da Biot ce
ne erano alcuni Nato secret, riservatissimi, e uno Top secret” ha spiegato in
aula l’accusa.
La procura militare
aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Biot, che ha assistito in aula alla
lettura della sentenza. Nel procedimento si sono costituite come parti civili la
presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero della Difesa. “Trent’anni
non sono l’ergastolo. Le questioni poste sono un monolite che porteremo in
Appello. Questa è la prima tappa di un percorso che alla fine darà ragione
a Walter Biot”. Così l’avvocato Roberto De Vita difensore del capitano di
fregata condannato a trent’anni. “Il tema è la prevalenza dello stato di diritto
sulla ragion di Stato e le condanne, come i processi, basate su prove segrete
non trovano ospizio nell’ordinamento costituzionale italiano”, ha sostenuto il
penalista dopo la sentenza. Ribaltarla non sarà facile, anche perchè Biot dovrà
affrontare anche il secondo processo, prima di approdare in Corte di appello.
Redazione CdG 1947
La sentenza del
Tribunale militare di Roma. Walter Biot condannato a 30 anni: il militare
accusato di aver venduto segreti ai russi.
Redazione su Il
Riformista il 9 Marzo 2023
Il tribunale
militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot. L’ufficiale di Marina era
accusato di accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio,
procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di
fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di
carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete né
riservate. Biot era stato arrestato due anni fa in un parcheggio alla periferia
sud di Roma, nel quartiere di Spinaceto, mentre cedeva secondo l’accusa
documenti top secret al funzionario russo Dmitry Ostroukhov in cambio di una
mazzetta di banconote. La Procura militare aveva chiesto l’ergastolo per il
capitano di Fregata.
“Fu infedele e
astuto: condannatelo all’ergastolo”, aveva argomentato l’accusa. “Maneggiava
quotidianamente documentazione riservata e questo è attestato da colleghi e
funzionari”. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Biot ha
risposto di “procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio”,
“procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato”, “esecuzione di
fotografie a scopo di spionaggio” e “comunicazione all’estero di notizie non
segrete nè riservate”. Secondo chi indaga, Biot si sarebbe procurato notizie
che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, dovevano rimanere segrete, per
poi passarle al funzionario russo. Tra i 19 documenti fotografati ce ne erano
alcuni, della Nato, “riservatissimi”, e uno “Top secret”, ha evidenziato
l’accusa durante la requisitoria.
L’ufficiale era
stato incastrato da alcuni video in cui sarebbe stato ripreso mentre fotografava
documenti riservati ai quali aveva accesso grazie all’impiego presso lo Stato
maggiore della difesa. L’accusa ha citato in udienza un video in cui
l’ufficiale, seduto alla sua scrivania, avrebbe preso una scatoletta dalla quale
estraeva il cellulare, inseriva la scheda sd e fotografava lo schermo del pc e
alcuni fogli prima di nascondere la scheda in una scatola di medicine e di
mettere tutto nello zaino.
Perché sono stati
espulsi 30 diplomatici russi dall’Italia, erano spie?
Per il
rappresentante dell’accusa “Biot ha fatto commercio di documenti segreti” e ha
dimostrato “elevato grado infedeltà e la capacità criminale, ma anche il triste
tornaconto venale. L’astuzia con la quale voleva dissimulare la sua azione.
Quella del 30 marzo del 2021 è stata solo quella scoperta, ma possono essercene
state altre”. Quei documenti avrebbero avuto un valore pari a una somma di
cinquemila euro. Nei confronti del capitano di fregata procede anche la procura
di Roma che, nell’inchiesta della pm Gianfederica Dito coordinata dal
procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di spionaggio,
rivelazione di segreto di Stato e corruzione. Biot per queste accuse è sotto
processo davanti alla Corte di Assise di Roma. La difesa ha annunciato ricorso
in Appello.
La Repubblica.
Consigliere Zelensky: "In difficoltà contro missili
I sistemi di difesa
aerea dell'ucraina "non resistono abbastanza bene" ai missili ipersonici russi
Un allarme aereo è
stato lanciato nella notte nelle regioni di Poltava, Kharkiv e Dnipropetrovsk.
Difese ucraine in difficoltà come conferma anche un consigliere del presidente
Zelensky: "I sistemi di difesa non resistono abbastanza bene ai missili
ipersonici russi".
Punti chiave
17:55
Turchia sospende
transito beni verso la Russia
15:44
Immagini satellitari
Maxar mostrano la distruzione a Bakhmut
12:02
Lavrov: "Gli eventi
in Georgia ricordano Euromaidan a Kiev"
10:56
Bloccarono difese
aeroporto Kiev: arrestati capi Antonov
10:16
Isw: "A Bakhmut
pausa tattica del gruppo Wagner"
08:35
Wagner, Prigozhin
contro Mosca: "Ci ha tagliati fuori"
04:29
Consigliere
Zelensky: difesa aerea in difficoltà con missili kinzhal
01:30
Zelensky, al lavoro
per ripristino linee elettriche
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un bilancio del massiccio attacco russo
avvenuto la notte scorsa, assicurando che per tutta la giornata si è lavorato
per ripristinare le linee elettriche danneggiate. "E' stato un nuovo tentativo
da parte dello stato terrorista di combattere la civilgà con un massiccio
attacco contro le nostre infrastrutture. Ci sono state interruzioni temporanee
di elettricità, calore e acqua in alcune delle nostre regioni e città. E sei
ucraini hanno perso la vita: le mie condoglianze vanno alle loro famiglie". Le
zone più colpite sono quelle di Kharkiv, Zhytomyr, Odessa, Dnipropetrovsk, Kiev,
Zaporizhzhia, ha detto ancora il capo di stato nel suo discorso serale.
"RIngrazio tutti quelli che stanno lavorando per ripristinare gli
approvvigionamenti elettrici: continuiamo a dimostrare di cosa è capace
l'Ucraina".
02:32
Cnn: Putin si sta
preparando per una lunga guerra convenzionale
Il presidente
russo Vladimir Putin ha Cambiato i suoi piani sull'operazione speciale e si è
preparato ad una lunga guerra convenzionale in ucraina, e non è successo da poco
tempo. Lo rivela un lungo reportage della Cnn, che ha ha raccolto anche la
testimonianza di un ex giornalista investigativo russo. Dall'estate scorsa Putin
ha trasferito il controllo del conflitto dall'agenzia di intelligence interna
del paese, il servizio federale per la sicurezza della federazione russa, noto
con la sigla Fsb, e lo ha messo nelle mani dell'intelligence militare, il gru
(direttorato generale per le informazioni militari).
"Dall'estate scorsa
i generali dell'intelligence militare hanno assunto un ruolo più importante
quando putin si è reso conto che non si trattava più di un'operazione speciale,
ma di una guerra convenzionale", ha detto alla cnn andrei soldatov, giornalista
investigativo russo ed esperto di intelligence ora in esilio a londra. E
"sfortunatamente, significa che putin sta preparando il paese per una lunga
guerra convenzionale".
04:29
Consigliere
Zelensky: difesa aerea in difficoltà con missili kinzhal
I sistemi di difesa
aerea dell'ucraina "Non resistono abbastanza bene" ai missili ipersonici russi,
lo ha rivelato un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo
quanto riportato dalla Cnn. I sistemi di difesa aerea dell'ucraina non sono
riusciti ad abbattere alcuni dei missili Kinzhal lanciati nell'ultimo
attacco della Russia di giovedì. Un totale di 84 missili sono stati lanciati
contro le infrastrutture ucraine, inclusi sei missili balistici kinzhal che
hanno possono riuscire a eludere le difese aeree di kiev, come ha ammesso
l'esercito ucraino. "Stanno usando missili ipersonici. Stanno usando nuovi tipi
di armi e stanno mettendo alla prova anche i nostri sistemi di difesa aerea ",
ha detto Alexander Rodnyansky, consigliere economico di Zelensky, aggiungendo
che "non stanno resistendo abbastanza bene."
06:05
Isw, attacco aereo
del 9 marzo solo per propaganda
Il bombardamento del
9 marzo sull'Ucraina - il più grande attacco aereo della Federazione Russa nel
2023 - non ha portato alcun vantaggio sul campo di battaglia e fa parte di
un'azione di propaganda. Lo sostengono gli analisti dell'American Institute for
the Study of War (Isw) sottolineando che "il Cremlino ha probabilmente lanciato
deliberatamente missili che il sistema di difesa aerea ucraino non può
intercettare per ottenere risultati nello spazio informativo russo, nonostante
la riduzione delle scorte di tali missili". In dettaglio si tratterebbe di una
"vendetta" per gli attacchi terroristici avvenuti nella regione di Bryansk, in
territorio russo, il 2 marzo scorso. Il 9 marzo sono stati lanciati dalla Russia
84 missili su varie città dell'Ucraina, provocando almeno 11 morti e 22 feriti.
08:35
Wagner, Prigozhin
contro Mosca: "Ci ha tagliati fuori"
Il capo della
compagnia Wagner Yevgeny Prigozhin ha detto di essere stato tagliato fuori dalle
comunicazioni speciali con le autorità russe a causa delle sue richieste di
fornire munizioni: siamo stati "tagliati fuori" da Putin. Lo riporta il servizio
stampa dello stesso Prigozhin, citato dalla Cnn. "Per farmi smettere di chiedere
munizioni, mi sono stati spenti tutti i telefoni speciali in tutti gli uffici e
anche bloccati tutti i passaggi ai dipartimenti responsabili delle decisioni",
ha dichiarato sul canale Telegram del suo ufficio stampa, aggiungendo che
chiederà le forniture di proiettili attraverso i media.
09:32
Hacker alla tv russa
annunciano un falso allarme nucleare
Hacker irrompono
nella Tv russa con un falso allarme nucleare: “C'è un attacco andate nei rifugi
”
10:08
Gb, la Russia ha
bisogno di stoccare nuovi missili
L'intervallo tra le
ondate di attacchi dell'esercito russo all'Ucraina sta probabilmente aumentando
perché la Russia ha ora bisogno di stoccare una massa di missili di nuova
produzione direttamente dall'industria prima di poter effettuare dei raid
abbastanza massicci contro le difese aeree ucraine. Lo scrive l'intelligence del
ministero della Difesa britannico su Twitter. Quella di ieri è stata la prima
grande ondata di attacchi a lungo raggio dal 16 febbraio 2023 e probabilmente
una delle più grandi dal dicembre 2022.
10:16
Isw: "A Bakhmut
pausa tattica del gruppo Wagner"
"Sembra che
il gruppo mercenario privato Wagner si stia prendendo una 'pausa tattica' a
Bakhmut". Lo ha scritto su Twitter l'Istituto per lo studio della guerra. Il
think tank statunitense ritiene che Wagner stia aspettando "l'arrivo di rinforzi
sufficienti di truppe russe convenzionali prima di proseguire con la battaglia".
10:48
Georgia, Mosca vede
"mani" Usa dietro "sentimenti antirussi"
Il Cremlino vede "le
mani" degli Stati Uniti dietro "il sentimento antirusso" che ha animato le
proteste degli ultimi giorni a Tbilisi, proteste contro una legge sulla stampa
che è stata poi ritirata dal governo. Lo ha detto il portavoce del
Cremlino, Dmitry Peskov: "La mano di qualcuno sta cercando diligentemente di
aggiungere elementi anti-russi. Stiamo attentamente, con preoccupazione,
osservando le provocazioni".
10:56
Bloccarono difese
aeroporto Kiev: arrestati capi Antonov
L'ex direttore
generale dell'azienda statale Antonov, il suo vice e il capo dell'unità di
sicurezza dell'aviazione sono stati arrestati dai servizi ucraini per aver
impedito all'esercito di Kiev di mettere in sicurezza l'aeroporto di Gostomel (a
10 chilometri dalla capitale) alla vigilia dell'invasione russa. Lo riferiscono
i media del Paese.
I tre, secondo
l'accusa, proibirono intenzionalmente all'esercito ucraino di costruire
fortificazioni intorno all'aeroporto. Il loro ostacolo ha portato le forze russe
a prendere il controllo dell'aeroporto oltre che alla distruzione
dell'aereo Antonov 225 Mriya, il più grande del mondo.
11:42
Cremlino: "Rischi
possibili provocazioni in Sud Ossezia e Abkhazia"
Il Cremlino denuncia
rischi di provocazioni in Sud Ossezia e Abkhazia, le due regioni della
Georgia di cui Mosca ha riconosciuto la sovranità. Il portavoce Dmitry Peskov,
ha spiegato che Mosca sta seguendo la situazione "con preoccupazione".
12:02
Lavrov: "Gli eventi
in Georgia ricordano Euromaidan a Kiev"
Gli eventi di questi
giorni in Georgia ricordano quelli di Euromaidan a Kiev che nel 2014 portarono
al rovesciamento del presidente filorusso Viktor Yanukovich. Lo ha detto il
ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Tass. La Russia
considera il rovesciamento di Yanukovich come un "colpo di Stato" sostenuto
dall'Occidente.
12:44
Nord Stream, Mosca:
"È chiaro che colpevoli sono gli Usa"
"Per noi è chiaro
che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Lo
ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia
Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul Nord Stream.
Ryabkov ha aggiunto che le presunte indiscrezioni fatte trapelare da fonti
americane e pubblicate dal New York Times secondo le quali l'attacco sarebbe
stato compiuto da "un gruppo pro-ucraino" sono "un tentativo da poco per sviare
l'opinione pubblica internazionale".
12:57
La premier
finlandese Marin è arrivata a Kiev
La premier
finlandese Sanna Marin è arrivata a Kiev. Lo riportano i media ucraini. La
leader di Helsinki ha in programma un incontro con il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky.
14:27
Arrivata in Ucraina
la prima batteria di Patriot
"L'Ucraina ha
ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e
Germania, ma non è ancora operativo. L'Ucraina è inoltre in attesa di alcuni
lanciatori Patriot dai Paesi Bassi". Lo scrive il Financial Times in un articolo
in cui ricorda come "il Patriot sia il sistema di difesa aerea a medio raggio
più avanzato che l'Occidente possa offrire, ma non è stato testato contro i
Kinzhal. Anche un sistema simile, il Samp-T, promesso da Francia e Italia, non è
ancora arrivato".
15:21
Wagner apre centri
reclutamento in 42 città russe
Yevgeny Prigozhin,
capo del gruppo mercenario russo Wagner, coinvolto in una lotta di potere con il
ministero della Difesa, ha annunciato l'apertura di centri di reclutamento in 42
città della Russia. "Nonostante la colossale resistenza delle forze armate
ucraine, andremo avanti", ha detto.
15:44
Immagini satellitari
Maxar mostrano la distruzione a Bakhmut
Questa
settimana Maxar Technologies,ha raccolto nuove immagini satellitari ad alta
risoluzione di Bakhmut, in Ucraina, e della battaglia in corso per la città tra
le forze russe e ucraine. Le immagini sono state raccolte nella zona il 6 marzo
2023, e aiutano a mostrare l'estensione della distruzione in tutta la città, i
ponti danneggiati sul fiume Bakhmutovka vicino alla prima linea di combattimento
e diverse immagini che evidenziano i recenti impatti dell'artiglieria nelle aree
residenziali.
16:01
Tajani a G7,
conferenza ricostruzione Ucraina il 26 aprile
"Oggi in
collegamento con i ministri degli Esteri G7 ho annunciato che il governo
organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con
il contributo delle imprese italiane. Prosegue il nostro impegno in favore della
pace e della libertà per il popolo ucraino". Lo scrive su Twitter il ministro
degli Esteri Antonio Tajani.
16:20
Usa, la Russia sta
tentando di destabilizzare la Moldova
"Non ci sono minacce
militari dirette da parte della Russia contro la Moldavia, ma abbiamo
informazioni di tentativi di destabilizzazione del Paese da parte di Mosca". Lo
ha detto il portavoce della sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing
con un ristretto gruppo di giornalisti precisando che "gli Stati Uniti
sostengono l'integrità e sovranità della Moldavia".
16:59
Kiev, situazione
tesa a Bakhmut, nemico continua ad attaccare
"Per riassumere
brevemente i rapporti pubblicati, la situazione a Bakhmut è La situazione a
Bakhmut è tesa, il nemico continua ad attaccare e cerca di superare le difese
delle nostre truppe". Lo ha detto la viceministra della Difesa ucraina Hanna
Malyar via Telegram, come riporta Ukrinform.
16:38
Putin si congratula
con Xi Jinping per rielezione a presidente Cina
Il presidente
russo Vladimir Putin si è congratulato oggi con Xi Jinping per la sua rielezione
a uno storico terzo mandato da presidente della Cina, affermando che Mosca
apprezza molto il suo contributo al rafforzamento del partenariato tra gli
stati. Lo ha riferito oggi il Cremlino. "Caro signor Xi Jinping, caro amico,
accetti le mie più sentite congratulazioni per la sua rielezione a presidente
della Cina. La Russia apprezza molto il suo contributo personale al
rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra i
nostri stati", ha detto Putin. Putin ha anche augurato al leader cinese buona
salute e prosperità.
16:47
Kiev, un morto nei
bombardamenti russi a Kherson
Un uomo di 35 anni è
morto nel microdistretto di Tauride, a Kherson, a seguito del bombardamento
dell'artiglieria russa. Lo riporta Ukrainska Pravda secondo cui la casa della
vittima avrebbe preso fuoco a causa di un proiettile nemico e l'uomo sarebbe
rimasto ucciso sul colpo. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco.
17:18
Isw, Wagner in pausa
tattica a Bakhmut, attendono rinforzi
"L'operazione
offensiva del Gruppo Wagner nell'est di Bakhmut sembra essere entrata in una
temporanea pausa tattica e non è chiaro se i combattenti manterranno la loro
predominanza operativa nelle future offensive russe nella città". A sostenerlo è
il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw) nel suo
aggiornamento quotidiano. "Non ci sono state segnalazioni di combattenti Wagner
che conducono operazioni offensive da Bakhmut orientale nelle parti centrali
della città da quando le forze russe hanno catturato tutto il Bakhmut orientale,
situato a est del fiume Bakhmutka, il 7 marzo", scrive l'Isw, suggerendo che i
mercenari "potrebbero condurre una pausa tattica temporanea per attendere
rinforzi russi convenzionali e rifornirsi in preparazione di costose operazioni
nella Bakhmut centrale".
17:55
Turchia sospende
transito beni verso la Russia
La Turchia ha
interrotto il transito verso la Russia di beni soggetti alle sanzioni decise in
seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Alla base della decisione di Ankara,
presa il primo marzo ma operativa da oggi, le pressioni di Usa e Unione Europea.
La decisione della Turchia di non applicare le sanzioni nei confronti di Mosca
dopo l'inizio della guerra, ha permesso ad aziende e uomini d'affari russi di
spostare an Istanbul e Ankara il centro dei propri interessi e affari, eludendo
le sanzioni. Nel 2022 è stato anche significativo il volume di scambio tra i due
Paesi, con la Turchia che ha esportato per 9.3 miliardi di dollari contro i 5.8
dell'anno precedente l'invasione dell'Ucraina. La nuova posizione presa dal
governo turco è riconducibile alla decisione dell'Unione Europea di estendere le
sanzioni nei confronti di Mosca.
18:03
Tblisi, "seguaci ex
presidente vogliono rivoluzione come a Kiev"
Un gruppo di
sostenitori dell'ex presidente Mikhail Saakashvili, che ha combattuto in Ucraina
a fianco delle forze armate ucraine, è arrivato in Georgia per incarnare uno
"scenario rivoluzionario", ha detto il vicepresidente del parlamento
georgiano Gia Volsky citato da Ria Novosti. "Si può dire con certezza che un
gruppo di sostenitori del Movimento nazionale e di Saakashvili (suo fondatore,
ndr) è arrivato dall'Ucraina. Questi sono combattenti che cercheranno, usando
questa energia giovanile, di non interrompere questo processo rivoluzionario
dall'agenda in modo che tutto si sviluppi in guerra civile, fuga precipitosa,
confronto", ha detto il rappresentante di 'Sogno georgiano', partito al potere a
Tblisi.
18:22
Wagner, "Kiev sta
organizzando la controffensiva a Bakhmut"
L'esercito ucraino
starebbe organizzando i preparativi per una controffensiva nell'area di
Artyomovsk (il nome russo di Bakhmut), secondo quanto ha scritto su
Telegram Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner. "Sì, è noto che il
nemico sta preparando una controffensiva. Ovviamente stiamo facendo tutto il
possibile per evitare che ciò accada", ha detto Prigozhin.
18:44
Orbán, Occidente
vicino a valutazione invio truppe
Secondo il premier
ungherese, Viktor Orbán, l'Occidente è "molto vicino" al discutere seriamente la
prospettiva di inviare le sue truppe in Ucraina. "Penso che siamo molto vicini
al valutare seriamente l'invio in Ucraina di truppe dei Paesi alleati", ha
dichiarato in un'intervista televisiva, rilanciata su Twitter dal portavoce del
governo ungherese Zoltan Kovacs. Il leader di Budapest ha ricordato che "la
Germania aveva iniziato inviando elmetti e ora manda a Kiev carri armati". "Il
mondo non è mai stato così vicino al trasformare una guerra locale in una guerra
mondiale", ha aggiunto.
19:06
Kiev, ex presidente
ucraino verrà processato in contumacia
La giustizia ucraina
processerà in contumacia l'ex presidente Viktor Yanukovych per reati legati alla
diserzione e all'attraversamento illegale del confine con la Russia, dove è in
esilio. "L'adozione di questa decisione da parte del tribunale consente di
condurre un processo e prendere una decisione definitiva sulle accuse mosse
senza la partecipazione dell'imputato", ha affermato in una nota l'ufficio del
procuratore generale ucraino. L'ex presidente, contro il quale è stato emanato
un mandato di arresto a febbraio a seguito di una petizione del tribunale
distrettuale Pechersky della capitale ucraina, Kiev, è indagato per aver
attraversato illegalmente il confine ucraino e aver portato almeno 20 persone in
territorio russo. Fuggito in Russia dopo essere stato destituito dal Parlamento
nel quadro delle massicce proteste di Euromaidan, l'ex presidente è anche
sospettato di aver incitato alla diserzione i soldati del dipartimento di
sicurezza ucraino.
19:23
Zelensky, Kiev non è
coinvolta nel sabotaggio a Nord Stream
L'Ucraina non è
coinvolta nelle esplosioni al gasdotto Nord Stream. Lo ha detto il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con la premier
finlandese Sanna Marin a Kiev. "Gli ucraini sicuramente non l'hanno fatto. E
questa è la cosa più importante", ha affermato, citato dalla tv ucraina pubblica
Suspilne. Secondo il presidente ucraino, le informazioni sul presunto
collegamento tra Kiev con gli attacchi del Nord Stream vengono diffuse per
rallentare gli aiuti occidentali all'Ucraina. "Penso che sia molto pericoloso
che alcuni media indipendenti, che ho sempre trattato con grande rispetto,
prendano tali misure. Penso che sia sbagliato, fa solo il gioco della Russia",
ha dichiarato Zelensky.
19:39
Mosca chiede
riunione Consiglio sicurezza Onu per 14 marzo
"Oggi abbiamo
chiesto una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
martedì 14 marzo sulla russofobia come ostacolo alla ricerca di soluzioni a
lungo termine e sostenibili alla crisi ucraina". Lo riferisce via
Telegram Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della
Federazione Russa presso l'Organizzazione mondiale, come riporta l'agenzia Tass.
"Naturalmente, parleremo anche della russofobia sia in Ucraina che in
Occidente", ha precisato Polyansky, "i nomi dei nostri relatori saranno resi
noti alla vigilia, in modo da non subire le pressioni dei nostri nemici, come
spesso accade".
21:04
Von der Leyen a
Biden, Ue liberata da gas russo con aiuto Usa
La presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ringraziato gli Stati Uniti per
"aver aiutato" l'Europa a liberarsi dalla dipendenza dal combustibile fossile
russo. "Ci avete aiutato - ha detto nel corso dell'incontro con il
presidente Joe Biden - ad affrontare la crisi energetica". "Noi - ha aggiunto -
siamo uniti nel sostenere l'Ucraina che combatte per la libertà e per
l'indipendenza. Faremo in modo che la Russia paghi per la sua atroce guerra.
Siamo fortemente allineati nel difendere i nostri valori". La presidente della
Commissione europea ha inoltre applaudito la decisione dell'amministrazione
americana di investire nelle nuove tecnologie pulite.
21:13
Zelensky, con
Norvegia discutiamo addestramento dei piloti
"Stiamo iniziando a
comunicare con la Norvegia sulle possibilità di una missione di addestramento
per i nostri piloti". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky nel suo discorso serale, riferendo dell'incontro con il ministro della
Difesa norvegese Bjorn Arild Gram a Kiev. "Abbiamo raggiunto un rapporto
estremamente forte con la Norvegia in molte aree. Ciò riguarda anche le armi:
grazie alla Norvegia, abbiamo rafforzato la nostra difesa aerea, l'artiglieria e
altri tipi di truppe. La Norvegia ha inoltre lanciato un programma di sostegno
al bilancio a lungo termine per l'Ucraina - 7 miliardi di dollari per cinque
anni - che può e deve diventare un esempio per gli altri nostri partner", ha
sottolineato Zelensky. "Abbiamo discusso ulteriori passi che possiamo
intraprendere insieme alla Norvegia per rendere questa primavera un successo sia
per la difesa ucraina che per le prospettive di sicurezza paneuropea". Dopo
l'incontro tra Zelensky e Gram, il governo norvegese ha annunciato una nuova
fornitura a Kiev di due unità di lancio del sistema missilistico Nasams, in
aggiunta alle due unità già fornite dagli Stati Uniti lo scorso autunno.
21:19
Zelensky,sconfitta
Russia significa non combattere più in Europa
"Sconfiggere la
Russia sul campo di battaglia in Ucraina significa non combattere da
nessun'altra parte in Europa e lungo i confini russi". Lo ha detto il presidente
dell'Ucraina Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai partecipanti all'American
Enterprise Institute World Forum. "Tutti gli aiuti che attualmente vengono
forniti all'Ucraina sono, infatti, un investimento nella pace globale, in una
vera architettura di sicurezza per la libertà", ha detto Zelensky, citato
da Ukrinform. "Il Cremlino non ha mai voluto fermarsi conquistando solo
l'Ucraina. Mai! Altri stati europei, i popoli dell'Asia sono obiettivi per la
Russia tanto quanto l'Ucraina", ha detto Zelensky. "E' ragionevole sconfiggere
la Russia ora. Per liberare l'Ucraina. Per garantire la sicurezza dell'Europa.
Per salvare da questo male genocida russo qualsiasi altra nazione che potrebbe
essere minacciata dal male", ha sottolineato il presidente.
21:34
Mosca chiede
riunione del Consiglio di sicurezza Onu il 14 marzo
La Russia ha chiesto
una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo. Ne dà
notizia l'agenzia russa Tass, citando Dmitry Polyansky, primo vice
rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Organizzazione
mondiale e precisando che la riunione dovrà secondo Mosca essere incentrata
sulla russofobia come fattore che ostacola la risoluzione della crisi ucraina.
"Oggi abbiamo
richiesto per martedì 14 marzo una riunione aperta del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite sulla russofobia come fattore che ostacola la ricerca di
soluzioni a lungo termine e sostenibili alla crisi ucraina", ha osservato il
diplomatico sul suo canale Telegram. Esamineremo la russofobia sia in Ucraina
che in Occidente. I nomi dei nostri relatori saranno annunciati il giorno prima
in modo che non siano soggetti alle pressioni dei nostri nemici, come spesso
accade". L'incontro è richiesto per le 17 ora di Mosca.
21:57
Auchan rafforza la
sua presenza in Russia con un nuovo negozio
Aumenta la
partecipazione di Auchan in Russia. Secondo quanto riportato dal sito
di Reuters, il rivenditore francese prevede di aprire un nuovo negozio e di
raddoppiare in futuro la sua presenza nel Paese. Auchan Retail Russia ha
affermato che il nuovo negozio "My Auchan" offrirà un assortimento di circa 900
articoli, il 90% dei quali saranno prodotti alimentari con i marchi del
produttore. La catena era stata al centro delle polemiche per la scelta di non
lasciare il territorio russo, come hanno fatto invece altri grandi marchi, e
dall'Ucraina era arrivata la richiesta di boicottaggio. Inoltre, la parte russa
di Auchan avrebbe fornito merci all'esercito russo nei territori ucraini
occupati, con il pretesto di aiuti umanitari ai civili, secondo quanto riportato
da un'inchiesta congiunta di The Insider, Le Monde e Bellingcat.
22:13
Biden e von der
Leyen, sostegno a Kiev fino a quando sarà necessario
Gli Stati Uniti e
l'Unione europea "stanno lavorando per garantire che l'Ucraina abbia il sostegno
militare, economico e umanitario di cui ha bisogno per tutto il tempo
necessario". E' quanto affermano il presidente Usa Joe Biden e la presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen nella dichiarazione congiunta
diffusa dopo il loro incontro bilaterale alla Casa Bianca. Inoltre, Usa e Ue
"rimangono impegnati nel fornire e mobilitare il sostegno internazionale, anche
da parte del settore privato, per la stabilità economica e finanziaria
dell'Ucraina" e sostengono il Fondo monetario internazionale nella
realizzazione di "un programma ambizioso entro la fine di marzo 2023 per fornire
il necessario sostegno di bilancio all'Ucraina per tutto il 2023 e oltre".
Bakhmut,
adrenalina e fango: «Si spara poi via veloci: 6 minuti prima che arrivino i
razzi russi».
Lorenzo Cremonesi su Il Corriere della Sera il 10 marzo 2023.
Una giornata con i
soldati della Decima Brigata da montagna Edelweiss: «La porta del Donbass non
può cadere». Vietato parlare del numero di morti e feriti
Quando irrompe il
rombo della deflagrazione misto al flash dei razzi che partono verso il cielo è
impossibile non sobbalzare. È un fracasso che offende i timpani e lascia
nell’aria l’odore acre della dinamite.
Si fa presto a
urlare ogogn — gli artiglieri ucraini usano il termine russo per dire «fuoco» —
ma mettersi in salvo prende molto più impegno perché, una volta sparata la salva
dei sei missili montati sul camion, poi si deve scappare il più rapidamente
possibile. «Via, via veloci. Abbiamo sei o sette minuti prima che i russi
individuino la nostra posizione e cerchino di colpirci. Se poi hanno già in aria
i droni kamikaze Lancet, allora il tempo a nostra disposizione si riduce a meno
della metà», gridano correndo come forsennati soldati e ufficiali della Decima
Brigata da Montagna Edelweiss. Militari incalliti, abituati al rumore esasperato
e al caos minaccioso della battaglia, molti di loro combattono nel Donbass sin
dal 2014 e restano quasi indifferenti al continuo tambureggiare di colpi
d’artiglieria da 152 millimetri e al sibilo dei missili Grad che arrivano dalla
collina scura incombente all’orizzonte, sei chilometri davanti a noi.
Battaglia nel
pantano
Ma se l’adrenalina
aiuta ad accelerare i movimenti, il fango li rallenta in modo
esasperante. Correre nella mota è faticosissimo, gli scarponi sembrano come
imprigionati nell’impasto vischioso, scuro di pioggia, s’affonda e s’inciampa
nelle tracce dei mezzi pesanti profonde quasi come trincee. Salire sul cassone
scivoloso del camion lanciamissili può essere quasi un’impresa, mentre gli
autisti imprecano fissando preoccupati il cielo grigio e intanto premono la
frizione tenendo al massimo i giri del motore, che stride sbuffando fitte volute
di fumo oleoso. Un soldato cade e quello dietro lo alza di peso per fare più in
fretta. «I camion carichi sfiorano gli ottanta all’ora, ma in questo pantano
raggiungono a malapena i dieci», dice il puntatore, che vorrebbe essere già
oltre il prossimo filare.
Siamo rimasti con
loro una giornata intera tra le colline marcate da campi coltivati e macchie di
boscaglia, che caratterizzano l’area settentrionale tra la cittadina assediata
di Bakhmut e quelle contese di Siversk (in mano ucraina) e Soledar (presa dai
russi) appena più a nord. «Questi mezzi lanciarazzi sono stati donati dalla
Repubblica Ceca, li chiamano Vampire, costruiti sul modello dei Grad russi con
un raggio compreso, a seconda dei tipi di missili, tra i 20 e 40 chilometri. Noi
siamo qui da oltre due mesi. Il nostro compito è fermare i russi che cercano
di accerchiare Bakhmut da nord per poi raggiungere Kramatorsk e mirare alla
conquista dell’intero Donbass», spiega il 24enne tenente-maggiore Vladislav, che
è soldato da 7 anni, ha frequentato l’accademia militare e adesso comanda i
plotoni lanciamissili.
Lui e i suoi uomini
stanno accampati in piccole buche scavate nella terra e coperte da tronchi. Tra
gli alberi vicini sono visibili alcuni cannoni semoventi di fabbricazione
polacca coperti da teli mimetici, ci mostrano anche un’area dove sono
posizionati gli ormai celebri Himars lanciamissili a lunga gittata americani, ma
fotografarli è assolutamente vietato. Come pure non possiamo riprendere le
«tane» dei più recenti M-270 made in Usa, anche loro ormai parte integrante del
duello a distanza con l’artiglieria russa: troppo preziosi per metterli a
rischio. Sparano meno degli altri e spesso li fanno arretrare in luoghi più
sicuri.
Freddo e morte
Nelle trincee
l’umido è sovrano, loro provano a scaldarsi con piccole stufe a legna molto
rudimentali, ma durante le giornate limpide ogni fuoco è vietato per non
rivelare le posizioni. «I russi bombardano tanto, specie con l’artiglieria da
152 millimetri, dispongono almeno del triplo dei nostri proiettili. Ma sono
altamente inaccurati, in realtà in questo settore non ci hanno quasi mai
colpiti», dice l’ufficiale, senza però rivelare le loro perdite. Un agente
dell’intelligence che ci scorta in prima linea vieta qualsiasi domanda sul
numero di morti o feriti. È top secret. I comandi ucraini sono ben contenti di
enfatizzare le perdite russe qui nel «tritacarne» di Bakhmut, si parla di circa
800 tra morti e feriti quotidiani, da giugno i mercenari della milizia privata
Wagner avrebbero subito oltre 30.000 morti, in massima parte prigionieri comuni
reclutati dalle carceri russe in cambio del condono della pena. Però anche gli
ucraini si dissanguano, con perdite che sembra superino ai 200 tra morti e
feriti gravi ogni giorno. E comunque questi soldati al fronte non sono per nulla
disposti a sottovalutare il nemico. «I russi mandano anche soldati esperti, non
solo carne da cannone. Gente che sa combattere, si muovono anche di notte,
piccole ondate di 20 o 30 uomini, muniti di visori notturni, coraggiosi,
s’infiltrano nelle retrovie, sono una minaccia costante», spiegano.
Sino a una decina di
giorni fa sembrava che Kiev volesse ritirarsi da Bakhmut, ma poi ha deciso di
restare nella speranza di eliminare il massimo numeri di nemici in vista dalle
prossime offensive. La sfida resta aperta. «Disponiamo di munizioni a
sufficienza per difenderci. Siamo certi che di qua i russi non potranno passare.
Però non bastano per sostenere una nostra offensiva. Attendiamo che arrivino
rinforzi dagli alleati: munizioni, cannoni, missili. E soprattutto ci servono
droni di ogni tipo, sia per osservare che per sparare. I russi hanno nuovi
modelli molto efficienti e riescono adesso ad abbattere facilmente i nostri, che
non sappiamo come rimpiazzare. Ormai un esercito senza droni è come un cavaliere
cieco», aggiunge il comandante.
Con lui e tre dei
suoi uomini marciamo su tratturi di fango e campi aperti per circa cinque
chilometri in direzione della strada asfaltata. Più indietro ci sono gruppi di
casupole coi tetti scoperchiati. «Lasciate una distanza minima di 5 metri da chi
vi precede e in caso di attacco disperdetevi subito», ordinano mostrando i
crateri più recenti contornati dai rottami dei razzi russi. Tra le piante si
vedono i resti inceneriti di un grosso cannone semovente. «Lo hanno colpito una
settimana fa», ammettono, ma di più non vogliono dire.
La Repubblica.
Kirill al Papa: "Impedire le espulsioni dal monastero a Kiev"
Von der Leyen:
"Sanzioni a Cina? Già punito chi aiuta la Russia". Kiev: "Oltre 500 russi morti
e feriti oggi a Bakhmut"
"Abbiamo già
sanzionato paesi terzi che hanno fornito armi alla Russia nella guerra contro
l'Ucraina, ad esempio l'Iran". Lo ha detto la presidente della commissione
europea Ursula von der Leyen rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla
Casa Bianca sul rischio che la Cina possa fornire armi a Mosca. La leader
europea ha spiegato di aver discusso con Joe Biden del pericolo che Pechino
"possa fornire sostegno militare" alle forze di Vladimir Putin.
Punti chiave
19:06
Kirill a Papa,
impedire espulsioni dal monastero a Kiev
13:21
La Russia dichiara
il Wwf "agente straniero"
08:27
Difesa
britannica: ai russi il controllo di Bakhmut Est, Kiev resiste a Ovest
02:41
Georgia: consigliere
sicurezza Usa vede presidente Zourabichvili
Il consigliere per
la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan ha incontrato oggi la
presidente della Georgia Salome Zourabichvili. Lo riferisce la Casa Bianca in
una nota. Al centro dei colloqui l'integrazione euro-atlantica del Paese e delle
riforme necessarie per far avanzare la candidatura della Georgia all'adesione
all'Unione europea. Sullivan e la presidente hanno anche discusso del
controverso disegno di legge sugli "agenti stranieri" che ha provocato proteste
nel Paese, esprimendo la comune preoccupazione che la misura possa ostacolare
l'importante lavoro di centinaia di Ong georgiane. Infine, è stato affrontato il
tema delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e oltre 30 alleati contro la
Russia, sottolineando la necessità che Vladimir Putin paghi per la guerra in
Ucraina.
03:55
Kiev, danni
ambientali per oltre 50 miliardi euro
A seguito
dell'invasione russa in Ucraina sono stati causati danni all'ambiente per circa
50 miliardi di euro. E' quanto emerso - come riporta Ukrinform -
a Kharkiv durante una riunione del Comitato della Verkhovna Rada per la politica
ambientale e la gestione della natura.
"Contiamo ogni
albero distrutto. E ogni grivna che la Federazione Russa ci pagherà per quello
che hanno fatto. Ogni giorno continuiamo a registrare nuovi danni e distruzione.
Secondo stime
preliminari, il danno totale all'ambiente è già di oltre 2 trilioni di grivne:
include l'inquinamento del suolo, l'inquinamento atmosferico, le foreste
bruciate e gli edifici distrutti. La Russia sta provocando una crisi climatica,
una crisi nucleare, una crisi umanitaria", ha affermato il primo viceministro
dell'Ambiente e delle risorse naturali ucraino, Ruslan Grechanyk. Oleksandr
Filchakov, capo dell'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, ha aggiunto:
"Registriamo e analizziamo tutti i crimini nel campo dell'ecologia, attacchi a
strutture industriali, depositi di petrolio".
07:57
Kiev: respinti più
di cento attacchi in un giorno
Le forze ucraine
durante l'ultimo giorno respinto più di cento attacchi russi nelle direzioni
Lyman, Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. Lo riferisce lo Stato maggiore delle
forze armate ucraine su Facebook, citato da Ukrinform.
08:27
Difesa
britannica: ai russi il controllo di Bakhmut Est, Kiev resiste a Ovest
Le forze del gruppo
Wagner controllano la maggior parte della parte Est della città di Bakhmut,
mentre gli ucraini continuano a resistere a Est e la linea del fronte, sul fiume
omonimo che attraversa la città, è molto difficile da superare per i
russi. È quanto si legge nell'analisi diffusa oggi dall'intelligence della
Difesa britannica. "Negli ultimi 4 giorni, le forze del gruppo Wagner hanno
preso il controllo della maggior parte della parte orientale" della città
contesa del Donbass. In centro, "il fiume Bakhmut segna ora la linea del fronte.
Le forze ucraine tengono la parte occidentale della città e hanno demolito i
ponti più importanti sul fiume, che attraversa in direzione nord-sud una
striscia di terreno aperto larga fra i 200 e gli 800 metri, tra le aree
edificate". Poiché le unità ucraine possono sparare dagli edifici fortificati
sulla sponda ovest del fiume, "quest'area è diventata una zona di morte,
rendendo molto difficile per le forze Wagner continuare il loro assalto frontale
verso occidente".
08:59
Kiev: due morti nel
Donetsk
Due persone sono
rimaste uccise ieri nel villaggio di Krasnohorivka nel Donetsk, la regione
dell'Ucraina orientale teatro dei combattimenti più intensi tra le forze di
Mosca e quelle di Kiev. Lo riferisce il governatore dell'oblast di Donetsk,
Pavlo Kyrylenko, citato da Kyiv Independent. Secondo il governatore, 14 persone
sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore.
09:19
Kiev sanziona 120
persone, anche società scommesse sportive
L'Ucraina ha
imposto sanzioni contro 120 persone, principalmente cittadini russi,
provvedimento entrato in vigore con la firma del relativo decreto da parte del
presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce Kyiv Independent. L'elenco include
anche alcuni cittadini di Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Turchia e Cipro.
Sanzionate anche 287 entità giuridiche, tra queste una serie di società di
scommesse sportive.
L'elenco comprende
persone presumibilmente coinvolte nel rapimento di bambini ucraini, coloro che
aiutano a sostenere i mercenari che combattono contro l'Ucraina, atleti russi e
altri rappresentanti sportivi che hanno mostrato sostegno pubblico alla guerra,
sottolinea Kyiv Independent.
09:50
Difesa britannica: a
Bakhmut gli ucraini fanno il "tiro a bersaglio" sui Wagner
Le difficoltà
incontrate dalla milizia russa Wagner nell'avanzare su Bakhmut sono dovute al
fatto che gli ucraini, dopo aver minato i ponti sul fiume Bakhmutka, da
postazioni rinforzate fanno un micidiale "tiro al bersaglio" sui mercenari
russi, causando altissime perdite: è quanto sostiene il ministero della Difesa
britannico, da fonti di intelligence, citato dal Guardian. Secondo i militari
britannici, il fiume Bahmutka costituisce ora di fatto la linea del fronte,
sebbene i Wagner siano risusciti a occupare quasi tutta la parte orientale della
città. Sebbene dagli edifici alti gli ucraini che difendono Bakhmut diano filo
da torcere ai russi, secondo Londra restano tuttavia potenzialmente vulnerabili
da attacchi da nord e sud.
10:18
Londra scrive agli
sponsor olimpici: premete per l'esclusione degli atleti russi e bielorussi
Il governo
britannico esorta i grandi sponsor olimpici a premere in favore della decisione
di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni. "Sappiamo che lo
sport e la politica sono strettamente intrecciati in Russia e Bielorussia e
siamo risoluti nella nostra determinazione a non lasciare che i regimi in Russia
e Bielorussia siano autorizzati ad utilizzare lo sport per i loro scopi di
propaganda", ha scritto il ministro dello sport Lucy Frazer in una lettera
indirizzata ai vertici di Coca-Cola, Intel, Samsung e Visa in Gran Bretagna, tra
gli altri.
Un gruppo di 35
paesi ha chiesto qualche settimana fa che gli atleti russi e bielorussi fossero
esclusi dai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Attualmente Russia e Bielorussia
sono escluse da molte competizioni sportive internazionali. Il Cio punta a far
competere gli atleti di entrambi i paesi sotto bandiere neutrali, a condizione
che si impegnino chiaramente a rispettare la Carta olimpica e non sostengano
attivamente la guerra in Ucraina.
10:36
Kiev: Mosca ha perso
circa 158mila soldati
La Russia ha perso
circa 158mila soldati in Ucraina. A dichiararlo su Facebook è lo stato maggiore
delle forze armate di Kiev, citato da Ukrinform. Tra il 24 febbraio 2022 e l'11
marzo 2023, tra le perdite subite in combattimento dai russi figuravano anche -
secondo la stessa fonte - 3.458 carri armati, 6.762 veicoli corazzati da
combattimento, 2.483 sistemi di artiglieria, 493 razzi antiaerei a lancio
multiplo, 257 sistemi antiaerei, 304 velivoli, 289 elicotteri, 5.344 automezzi e
serbatoi carburante, 18 navi/navi da guerra, 2.108 droni. Inoltre sono stati
abbattuti 907 missili da crociera.
10:50
Kiev, colpi di
artiglieria nella zone del confine di Sumy
Questa mattina le
forze russe hanno bombardato con l'artiglieria il confine della regione di Sumy,
scrive Ukrinform citando un post su Facebook del comando operativo 'Nord'
ucraino. Nell'area del villaggio di Rozhkovichi dalle 8:10 alle 8:35 sono stati
registrati 23 colpi, probabilmente di artiglieria e nella zona del villaggio di
Sytne dalle 8:50 alle 8:55 i colpi registrati sono stati due. In entrambi i casi
non si sono verificate perdite di personale e mezzi. Non ci sono state
segnalazioni di vittime tra la popolazione locale o danni alle infrastrutture
civili.
11:12
Ucraina: sindaco,
udite oltre 10 esplosioni a Melitopol
Oltre 10 esplosioni
sono state udite in Ucraina nella zona nord della città di Melitopol, nella
regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce il sindaco Ivan Fedorov sul suo account
Telegram. "I residenti riferiscono di più di 10 forti esplosioni nella parte
settentrionale della città. Le informazioni sono in corso di aggiornamento", ha
scritto.
11:40
Zelensky, "cambiamo
il nome della Russia in Moscovia"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelesnky sta valutando la possibilità di cambiare il nome
della Russia, trasformandolo in '"Moscovia", secondo quanto riportato
da Ukrainska Pravda. L'idea arriva da una petizione online che ha già raggiunto
25 mila firme e che spiega come "questo nome era usato nelle lingue europee e in
alcune lingue asiatiche", aggiungendo che "molte mappe storiche dei secoli
XVI-XIX, realizzate in Europa prima e dopo la ridenominazione del regno di Mosca
nell'Impero panrusso, presentavano anche questo nome".
"La questione
sollevata nella petizione richiede un'attenta considerazione sia sul piano del
contesto storico e culturale, sia tenendo conto delle possibili conseguenze
legali internazionali", ha aggiunto Zelensky che ha incaricato il primo
ministro Denys Shmygal di seguire il caso. A stretto giro è arrivata la risposta
di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, che su Telegram ha
parlato di ennesima dimostrazione della campagna 'anti-russa' in atto in
Ucraina. Secondo Ria Novosti, anche il vicepresidente della Duma di Stato
russa, Boris Chernyshov, ha commentato la petizione sostenendo che "iniziative
del genere possono essere trattate solo con un sorriso".
11:57
Kiev, 3 morti in
bombardamento russo su Kherson
È di 3 morti in
Ucraina il bilancio di un raid russo che ha colpito stamattina la città
di Kherson. Lo riferisce il presidente dell'amministrazione regionale di
Kherson, Alexander Prokudin, citato da Ukrainska Pravda.
12:13
Papa: " Disposto ad
andare a Kiev, ma a condizione di andare anche a Mosca"
"Sono disposto ad
andare a Kiev. Voglio andare a Kiev. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in
entrambi i posti o in nessuno dei due". Lo ha ribadito il Papa in una intervista
a La Nacion aggiungendo che il viaggio a Mosca, a suo avviso, "non è
impossibile". "Occhio, non c'è nessuna promessa. Niente. Non ho chiuso quella
porta", ha precisato Bergoglio. Ma Putin la chiude o no? "Ma è lì che si
distrae e la apre, non lo so". "La guerra mi fa male - ha ribadito - voglio
dirlo, mi fa male".
Bergoglio, in
un'altra intervista, aveva definito il leader del Cremlino Putin un uomo
"colto". "E' colto - ha ribadito - . E' venuto a trovarmi qui tre volte come
capo di Stato e puoi avere una conversazione di alto livello con lui. Abbiamo
parlato di letteratura una volta. Una cultura è qualcosa che si acquisisce non è
una professione morale. Sono due cose differenti". Bergoglio ha poi detto che
non esiste un piano di pace Vaticano ma ha detto che esiste un "servizio di
pace" per cui il Vaticano sta lavorando per porre fine alla invasione russa
dell'Ucraina. Alla domanda se siamo davanti a un genocidio, Francesco ha detto:
"Non so se questo è genocidio o no, devono studiarlo, la gente deve definirlo
bene ma non è certo un'etica della guerra a cui siamo abituati".
12:54
Russia a Kiev, se
noi Moscovia voi 'sporco Reich di Bandera'
In risposta al fatto
che "il supremo nazista di Kiev (il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ndr)
ha ordinato di risolvere la questione della ridenominazione della Russia in
Moscovia", il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev,
ha proposto la sua versione per il cambio di nome dell'Ucraina. "Non Hochlandia
(dispregiativo rivolto all'Ucraina che può essere tradotto come 'terra
inferiore', ndr) e ancor meno Piccola Russia", dice Medvedev, "solo sporco Reich
di Bandera"
13:16
Moldavia, trovati 2
droni nel bagaglio di un passeggero ucraino
Un cittadino ucraino
di 30 anni è stato fermato all'aeroporto di Chisinau e, durante un controllo,
nel suo bagaglio sono stati trovati due droni che non aveva dichiarato.
Secondo Ukrainska Pravda, si trattava di un volo Istanbul-Chisinau e i droni
erano del modello Dji Mavic 3. Nelle ultime settimane si sono intensificati i
controlli sugli arrivi in Moldavia in relazione alla minaccia della Russia, che
cerca di destabilizzare la situazione nel Paese.
13:21
La Russia dichiara
il Wwf "agente straniero"
Il governo russo ha
dichiarato il Wwf, il World Wide Fund for Nature, 'agente straniero' accusandolo
di utilizzare le proprie rivendicazioni ecologiste per influenzare la politica
nazionale. "Con il pretesto dello svolgimento di attività volte alla tutela
della natura, i rappresentanti del fondo hanno cercato di influenzare le
decisioni delle autorità esecutive e legislative della Russia, ostacolando
l'attuazione di progetti industriali e infrastrutturali", ha dichiarato il
ministero della Giustizia russo citato dalla catena Rbc. Il fondo inoltre, ha
aggiunto, "ha divulgato informazioni negative sulle decisioni assunte da
organismi statali e sulle sue politiche".
Fonti della filiale
russa della Ong hanno confermato all'agenzia Dpa di voler presentare ricorso
contro tale decisione. In un'altra nota, l'agenzia ricorda di operare da più di
trent'anni nel paese e che tutti i suoi membri nel consiglio direttivo sono
cittadini russi. "Il fondo lavora a beneficio della natura in Russia dal 1994,
in parte grazie al sostegno di oltre 1,5 milioni di persone che ci appoggiano
nel paese. A loro vanno i nostri ringraziamenti e la nostra richiesta di
continuare al nostro fianco in questi tempi difficili", ha spiegato la Ong.
13:24
Danimarca, primi
Leopard 1 a Kiev in primavera
Il primo lotto di
carri armati Leopard 1 forniti dalla cooperazione tra Danimarca, Germania e
Olanda, sarà consegnato in Ucraina in primavera. Lo ha annunciato il ministro
della Difesa ad Interim danese Troels Lund Poulsen, in visita all'azienda
tedesca Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, impegnata nella preparazione di
carri armati Leopard 1 da trasferire in Ucraina. Lo riporta Ukrinform. Il
ministro ha ricordato che il governo danese ha avviato una cooperazione con
Germania e Olanda con l'obiettivo di trasferire almeno 100 carri armati Leopard
1 in Ucraina.
13:50
Capo Wagner, siamo a
poco più di 1 km dal centro di Bakhmut
Il capo del gruppo
mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che le forze filorusse sono a
1,2km dal centro di Bakhmut. Lo ha detto in un video pubblicato dal servizio
stampa del gruppo, come riporta l'agenzia Tass. Nel video mostra un edificio in
lontananza. "Si tratta di un edificio di cinque piani da cui proviene il fumo:
l'edificio dell'amministrazione comunale, il centro amministrativo della città.
È a 1 km e 200 metri di distanza", afferma Prigozhin.
14:21
Analista Uk,"30 mila
russi morti per conquistare Bakhmut"
Sarebbero più di 30
mila i soldati russi morti nel tentativo di prendere Bakhmut secondo Philip
Ingram, ex colonnello dell'intelligence militare britannica e ora analista
militare, intervistato da Sky News Uk. Ingram ha aggiunto che Bakhmut è un
"piccola e insignificante" città su un fronte di 1.200 chilometri. "I russi lo
vedono come un trampolino di lancio per andare in altre città, Kramatorsk e
Sloviansk, e quindi avanzare per cercare di prendere il resto del Donbass" ha
aggiunto l'ex colonnello.
15:29
Kiev, "la Russia sta
esaurendo le scorte di armi"
La Russia starebbe
esaurendo le scorte di armi preparate in vista della guerra e accumulate per
anni. Lo ribadisce il segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino, Alexei
Danilov, citato da Ukrainska Pravda. "I calcoli prevedevano una blitzkrieg
(guerra lampo ndr), non un 'utilizzo lampo'. L'economia corrotta non è in grado
di fornire una copertura, l'assistenza esterna alla Russia terrorista è una
questione di fondamentale importanza" ha concluso Danilov.
15:56
Moldavia, Kiev scava
trincee al confine contro attraversamenti illegali
Le guardie di
frontiera ucraine stanno scavando trincee al confine con la Moldavia. È quanto
afferma l'addetta stampa della polizia di frontiera moldava, Raisa Novitski,
citata da Ria Novosti. "I colleghi del servizio di frontiera statale
dell'Ucraina hanno riferito che tale lavoro viene svolto al fine di impedire
l'attraversamento illegale del confine di Stato, nonché il contrabbando
dall'Ucraina alla Moldavia", ha affermato Novitski.
16:22
Iran: accordo con la
rusia per acquisto caccia Su-35
L'Iran ha
finalizzato un accordo per l'acquisto di caccia multiruolo di quarta generazione
avanzata Sukhoi Su-35 dalla Russia, secondo quanto riferito dai media statali,
nell'ambito dell'approfondimento della cooperazione nel settore della difesa tra
i due Paesi. L'aeronautica militare iraniana, colpita dalle sanzioni, ha una
flotta di aerei che sta invecchiando e fatica ad acquistare pezzi di ricambio
per mantenere in volo i suoi velivoli da guerra. In una dichiarazione alle
Nazioni Unite, Teheran ha detto di aver iniziato ad avvicinare "Paesi per
l'acquisto di jet da combattimento" per rifornire la sua flotta sulla scia della
guerra Iran-Iraq del 1980-88.
"La Russia ha
annunciato di essere pronta a venderli" dopo la scadenza, nell'ottobre 2020,
delle restrizioni all'acquisto di armi convenzionali da parte dell'Iran in base
alla risoluzione 2231 delle Nazioni Unite, si legge nella dichiarazione diffusa
dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. "I caccia Sukhoi 35 sono tecnicamente
accettabili per l'Iran", ha aggiunto. Nell'ultimo anno Teheran ha stretto forti
legami con Mosca in vari settori, compreso quello militare.
16:29
Kuleba, esclusione
discorso Zelensky dagli Oscar è ipocrita
La decisione di non
invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a tenere un discorso durante
la cerimonia degli Oscar è "ipocrita". Lo ha detto il ministro degli Esteri
ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista alla Bild. "Penso che se 'Niente di nuovo
sul fronte occidentale' ricevesse un Oscar come miglior film in lingua
straniera, mentre al presidente Zelensky, che è in guerra, guidando un Paese che
combatte nella più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale, non è
permesso di parlare alla cerimonia degli Oscar, non si troverebbe un esempio
migliore dell'ipocrisia dei massimi dirigenti e produttori dell'industria
cinematografica", ha detto Kuleba. "La parola ridicolo non è sufficiente per
descrivere questa ipocrisia. Io non metto in dubbio la qualità del film, sto
solo dicendo: gente, quando state per premiare un film sulla guerra e non vi
rendete conto che mentre bevete champagne e indossate bei vestiti e diamanti,
qualcuno non vuole ascoltare una vera storia di guerra che sta accadendo qui e
ora, allora c'è qualcosa che non va", ha affermato il ministro. Quest'anno per
la seconda volta consecutiva l'Academy of Motion Pictures ha respinto la
richiesta di Zelensky di apparire in video durante la notte degli Oscar.
16:41
Kiev, "da febbraio
28 mila volontari hanno fatto domanda"
Sarebbero 28.000 i
volontari che hanno presentato domanda da febbraio per entrare a far parte della
Guardia d'assalto ucraina, con quasi tutte le unità già formate. Lo ha detto il
ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko alla televisione ucraina,
secondo Ukrinform. "Abbiamo già accettato 28.000 domande di combattenti
volontari. Naturalmente, non tutti entrano in queste unità, perché il processo
di selezione è abbastanza duro", ha affermato Klymenko che ha detto anche che
l'addestramento sarebbe durato il tempo necessario per ottenere unità pronte al
combattimento. "Le unità sono state per lo più formate e oggi stiamo reclutando
ulteriori combattenti volontari in modo da avere una riserva per il futuro", ha
concluso il ministro dell'Interno ucraino.
16:55
Ministro difesa
Norvegia Gram in visita a Kiev
Il ministro della
Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha accolto sabato a Kiev il suo omologo
norvegese Bjørn Arild Gram. Durante la visita Gram ha annunciato la decisione di
stanziare 7,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per armi e altri
aiuti all'Ucraina. Secondo un resoconto dell'incontro pubblicato dal ministero
della Difesa ucraino, Gram ha affermato che le armi che la Norvegia intende
inviare comprendono lanciamissili e munizioni per i sistemi antiaerei NASAMS.
Reznikov ha detto che le truppe ucraine hanno utilizzato con successo proprio
alcuni dei sistemi NASAMS per abbattere i droni e i missili che la Russia ha
fatto piovere sull'Ucraina giovedì. "Sappiamo con certezza che ogni 10 utilizzi
del sistema NASAMS", sono le parole di Reznikov, "significa abbattere 10 missili
dell'aggressore, salvare 10 edifici e strutture infrastrutturali, oltre a
centinaia di vite umane".
17:09
Ucraina, colpite
infrastrutture della città di Zaporizhzhia
Bombardamenti russi
hanno colpito "infrastrutture vitali" della città di Zaporizhzhia. Lo ha reso
noto l'ammministarzione militare dell'oblast di Zaporizhzhia, citata dai media
ucraini. Nell'attacco sarebbero stati usati missili russi S-300. A quanto
riferisce Anatolii Kurtiev, del consiglio comunale cittadino, "a causa
dell'attacco missilistico si è sviluppato un incendio in uno dei distretti
cittadini".
17:16
Kiev, attacco russo
su aree residenziali Donetsk: un morto
"Le forze armate
russe hanno sparato con cannoni d'artiglieria e lanciarazzi multipli Uragan
contro la città di Konstantinivuts. Konstantinivuts, i villaggi di Mykolayivka,
distretto di Kramatorsk, e Maksymilianivka, distretto di Pokrovsk. Un uomo di 52
anni è morto a causa dei colpi inferti alle aree residenziali. Quattro cittadini
hanno riportato ferite di varia gravità. Uno dei feriti è in condizioni
critiche". Lo afferma l'Ufficio del procuratore ucraino in un messaggio via
Telegram.
17:26
Prigozhin,
combattiamo per evitare la disgrazia della Russia
I mercenari
Wagner hanno un "semplice" obiettivo: non permettere la "disgrazia" della Russia
nelle mani dei governi occidentali. A sostenerlo è Yevgeny Prigozhin, il capo
del gruppo di combattenti russi, in un video pubblicato oggi su Telegram e
citato dalla Cnn. "Qual è il nostro obiettivo? Perché stiamo combattendo?
L'obiettivo è semplice. Perché non ci sia la disgrazia delle armi russe, perché
non ci sia la disgrazia della Russia", ha detto Prigozhin. "Per non portare la
Russia al punto di crollare". "Molto probabilmente questo è l'obiettivo dei
servizi segreti americani e britannici, che lavorano per distruggere la Russia",
ha aggiunto.
17:59
Prigozhin, "mi
candiderò presidente contro Zelensky"
Il capo del gruppo
di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che si candiderà alle
elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Ma non in Russia, come qualcuno
potrebbe supporre, bensì "in Ucraina". "L'importante annuncio" è arrivato in un
messaggio video, registrato mentre sullo sfondo si sentono colpi d'arma da
fuoco, presumibilmente dal fronte di Bakhmut. Prigozhin, 61 anni, dichiara che
si candiderà contro l'attuale presidente Volodymyr Zelensky e il suo
predecessore Petro Poroshenko.
18:03
Prigozhin: "A
Bakhmut servono 10mila tonnellate di munizioni al mese"
Il capo dei
mercenari russi della Wagner, Yevgeny Prigozhin, chiede 10mila tonnellate di
munizioni per poter continuare a combattere a Bakhmut. la richiesta arriva in un
video, dove Prigozhin si mostra in piedi sul tetto di una casa distrutta che si
troverebbe a 1,2 km dal centro di Bakhmut. "Vinceremo", dichiara il capo dei
mercenari, aggiungendo che a Mosca nessuno deve temere che lui abbia ambizioni
politiche. Quello che chiede è l'invio di munizioni. Serve mezzo milioni di
dollari al mese, afferma, e potrebbero pagarli gli oligarchi russi.
18:49
Mosca, incendio nel
palazzo della televisione Spas
A Mosca è scoppiato
un incendio nell'edificio dove si trova la redazione del canale Spas,
l'emittente russa collegata alla Chiesa ortodossa russa. Secondo quanto
riportato dalla Tass, il rogo è divampato al primo piano di un edificio di nove
piani in via Akademika Korolev 13 ed è stato in seguito domato: tutte le persone
sono state evacuate e non ci sono state vittime. Spas è un canale televisivo
federale russo associato alla Chiesa ortodossa russa. Ha iniziato a trasmettere
in Russia il 28 luglio 2005.
19:06
Kirill a Papa,
impedire espulsioni dal monastero a Kiev
Il patriarca di
Mosca Kirill lancia un appello a papa Francesco, al segretario generale
dell'Onu Antonio Guterres e alla comunità internazionale per impedire
l'espulsione dei religiosi della Chiesa ortodossa ucraina rimasti fedeli a Mosca
dal conteso Monastero delle Grotte di Kiev. Lo riferisce la Tass.
19:52
Praga, dopo la
manifestazione antigovernativa scontri tra manifestanti e polizia: "Il governo
si preoccupa più degli ucraini che dei cittadini cechi"
Migliaia di persone
hanno manifestato oggi in piazza San Venceslao a Praga contro il governo del
premier Petr Fiala, contro la Nato e l'Ue e contro l'aiuto che la Repubblica
ceca concede all'Ucraina aggredita dalla Russia. Dopo la fine della protesta
antigovernativa un gruppo di manifestanti si è diretto verso il Museo
nazionale dove un gruppo di sostenitori dell'Ucraina e dell'Ue aveva manifestato
in precedenza. Gli attivisti volevano strappare la bandiera ucraina dalla
facciata del museo e alcuni di loro sono penetrati nell'edificio. È intervenuta
la polizia antisommossa che ha creato un cordone davanti all'entrata ed ha
successivamente arrestato quindici manifestanti. Secondo il ministro
dell'interno ceco Vit Rakusan un agente di polizia è rimasto ferito. Il Paese,
che conta 10,5 milioni di abitanti, è membro dell'Ue e della Nato, ha inviato
ingenti aiuti militari e umanitari all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa
nel febbraio 2022. E gli oppositori del governo di Petr Fiala affermano che
quest'ultimo si preoccupa più degli ucraini che del suo stesso popolo. I
manifestanti hanno invitato il premier di centrodestra e il suo esecutivo a
dimettersi, mentre Rajchl ha affermato di voler un governo che "si preoccupi
prima degli interessi dei cittadini cechi".
21:42
Kiev, oltre 500
russi morti e feriti oggi a Bakhmut
Oggi le forze russe
hanno perso più di 500 soldati, tra morti e feriti, nella battaglia per
conquistare Bakhmut. Lo ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del
raggruppamento orientale delle forze armate dell'Ucraina, citato da Ukrainska
Pravda. "Durante i combattimenti, 221 nemici sono stati uccisi e 314 feriti", ha
affermato.
Il portavoce ha
dichiarato che nella giornata ci sono stati 53 ingaggi nell'area, di cui 23
all'interno della città devastata, aggiungendo che le forze russe hanno
bombardato il fronte di Bakhmut 157 volte.
21:45
Ucraina, Zelensky:
"Russia è sinonimo di terrorismo"
Volodymyr
Zelensky contro la Russia per i nuovi "brutali attacchi terroristici" contro le
città ucraina. "Missili ed artiglieria, droni e mortai: questo stato malvagio
usa una varietà di armi con l'obiettivo unico di distruggere la vita e non
lasciare nulla di umano", ha detto il presidente ucraino nel discorso trasmesso
questa sera da Kiev. "Rovine, macerie, crateri dove i missili hanno colpito sono
l'autoritratto che la Russia dipinge dove esisteva la vita" continua Zelensky
affermando che la Russia è "diventata sinonimo di terrorismo e sarà un esempio
di sconfitta e giusta punizione per i suoi attacchi terroristici. Il Cremlino -
ha concluso - non può bloccare la sua punizione".
Dalla Russia
all’Iran: così Teheran potrebbe decodificare armi Usa e Nato.
Federico Giuliani
l’11 Marzo 2023 su Inside Over.
La Russia ha messo
le mani su alcune delle armi fornite dagli Stati Uniti e dalla Nato all’esercito
ucraino e le ha inviate in Iran, dove Washington teme che Teheran possa provare
a decodificarne i sistemi. Nello specifico, il materiale ottenuto dai russi
consisterebbe in una parte degli aiuti militari spediti che il blocco
occidentale ha mandato sul fronte, e che le forze di Kiev sono state costrette
ad abbandonare sul campo di battaglia in seguito a non meglio specificate
sconfitte locali.
La notizia è stata
diffusa dalla Cnn, che ha citato quattro fonti anonime informate sui fatti. Nel
corso dell’ultimo anno, hanno spiegato le stesse fonti, gli Usa, l’Alleanza
Atlantica e altri funzionari occidentali hanno assistito a diversi episodi in
cui gli uomini di Vladimir Putin sono riusciti a recuperare attrezzature per
armi più piccole, a spalla, tra cui sistemi anticarro Javelin e sistemi
antiaerei Stinger.
Pare che in molti di
questi casi la Russia abbia inviato l’attrezzatura in Iran per smantellare e
analizzare ogni singola arma, probabilmente per consentire agli iraniani di
creare la propria versione di quelle armi. Mosca riterrebbe inoltre che
continuare a fornire armi occidentali catturate all’Iran sarebbe un valido
incentivo per convincere Teheran a mantenere alto il suo sostegno alle
operazioni militari della Russia in Ucraina.
Dalla Russia
all’Iran
Da quanto emerso,
gli Stati Uniti non credono che l’invio di armi occidentali all’Iran da parte
dei russi sia sistematico o diffuso. Come se non bastasse, dall’inizio della
guerra l’esercito ucraino è solito riferire al Pentagono qualsiasi perdita di
equipaggiamento ricevuto. Allo stesso tempo, però, è difficile monitorare
l’intera situazione in modo tale da esser sicuri che nessun arma possa arrivare
a Teheran.
Non è chiaro se gli
iraniani siano riusciti a decodificare le ipotetiche attrezzature fin qui
ricevute ma gli ingegneri e scienziati iraniani si sono fin qui dimostrati
abilissimi nello sviluppare sistemi di arma basati su attrezzature statunitensi
sequestrate in passato.
Del resto, un’arma
chiave nell’arsenale dell’Iran è il missile guidato anticarro Toophan, un’arma
decodificata con successo dal missile americano BGM-71 TOW negli anni ’70. Un
altro esempio? Nel 2011 Teheran ha intercettato un drone fabbricato dagli Stati
Uniti, il Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Lo hanno decodificato, ancora con
successo, per creare un nuovo drone che, nel 2018, ha attraversato lo spazio
aereo israeliano prima di essere abbattuto.
Un rischio da
evitare
Che cosa potrebbe
succedere nel caso in cui armi occidentali impiegate dall’esercito ucraino
dovessero essere decodificate dall’Iran? Basta ascoltare Jonathan Lord, senior
fellow e director del Middle East security program presso il Center for a New
American Security.
“(Gli iraniani ndr)
hanno decodificato il missile guidato anticarro TOW, creando una replica quasi
perfetta che hanno chiamato Toophan, e da allora l’hanno diffuso tra
gli Houthi e gli Hezbollah. L’Iran potrebbe fare lo stesso con uno Stinger, che
potrebbe minacciare l’aviazione civile e militare in tutta la regione. Un
Javelin retroingegnerizzato potrebbe essere usato da Hamas o Hezbollah per
minacciare un carro armato israeliano Merkava. Nelle mani dei delegati
dell’Iran, queste armi rappresentano una vera minaccia per le forze militari
convenzionali di Israele”, ha spiegato Lord.
Ricordiamo che
nell’ultimo anno la cooperazione militare della Russia con l’Iran si è
approfondita. La Casa Bianca ritiene che il Cremlino abbia chiesto e ricevuto
centinaia di droni dall’Iran, oltre a proiettili di artiglieria e carri armati;
in cambio, Teheran avrebbe chiesto a Mosca attrezzature militari per un valore
di miliardi di dollari, tra cui aerei da combattimento, sistemi radar ed
elicotteri. Il nuovo filone delle armi occidentali inviate dai russi in Iran
apre un nuovo, preoccupante, filone. FEDERICO GIULIANI
GUERRA DI
ANNUNCI.
Ernesto Ferrante su L’Identità l’11 Marzo 2023
La battaglia per il
controllo del bastione difensivo ucraino di Bakhmut si sta combattendo anche a
livello dialettico. Secondo Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, le truppe di Kiev dovrebbero logorare i russi per
scompaginarne l’offensiva e concentrare le loro energie altrove, per la
controffensiva di primavera.
Scambio di colpi
anche sulle cifre. Podolyak ha parlato di perdite di soldati per Mosca superiori
di 5-7 volte rispetto alle loro, con circa 40mila tra morti e feriti in sette
mesi nella città del Donbass, evidenziando un presunto “disaccordo strategico
tra il leader Wagner Prigozhin e il generale di Putin Gerasimov, a cui si è
unito il ministro della Difesa Shoigu”.
“Sembra che il
gruppo mercenario privato Wagner si stia prendendo una ‘pausa tattica’ a
Bakhmut”, ha scritto su Twitter l’Istituto per lo studio della guerra. Il think
tank statunitense ritiene che gli uomini di Prigozhin stiano aspettando
“l’arrivo di rinforzi sufficienti di truppe russe convenzionali prima di
proseguire con la battaglia”.
L’intelligence del
Ministero della Difesa britannico, nel suo bollettino quotidiano su Twitter,
ritiene invece che “l’intervallo tra le ondate di attacchi missilistici russi
sta aumentando, perché la Russia probabilmente ha bisogno di accumulare missili
di nuova produzione affinché ogni raid sia abbastanza potente da colpire
efficacemente la difesa aerea ucraina”.
Gli 007 di Londra
hanno evidenziato il fatto che nella sola giornata di giovedì i russi hanno
effettuato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche ucraine durante i
quali ha utilizzato missili da crociera, missili antiaerei, droni iraniani,
nonché un numero insolitamente elevato di missili balistici ipersonici lanciati
dall’aria.
Voglia di Patriot.
“Quando i sistemi missilistici antiaerei Patriot arriveranno in Ucraina, gli
ucraini lo scopriranno: ci saranno informazioni sul primo aereo nemico
abbattuto”, ha dichiarato Yuriy Ignat, portavoce del comando dell’aeronautica
delle forze armate ucraine.
“Non c’è ancora, non
l’ho visto. Quando ci sarà, lo saprete, quando il primo aereo nemico verrà
abbattuto”, ha detto Ignat parlando durante la maratona informativa nazionale.
La premier
finlandese Sanna Marin ha incontrato a Kiev Volodymyr Zelensky. Insieme a lui ha
onorato la memoria di Dmytro Kotsyubail, partecipando alla funzione
commemorativa nella cattedrale di San Michele.
Zelensky ha definito
“molto pericolose” le ultime informazioni pubblicate dal New York Times sulla
presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto
Nord Stream, sostenendo che questa notizia “faccia il gioco della Russia”.
Durante una
conferenza stampa nella capitale insieme al primo ministro finlandese, l’ex
comico ha respinto ancora una volta tutte le accuse: “Non abbiamo niente a che
vedere con queste. Non lo hanno fatto gli ucraini”.
Il presidente
ucraino si è rammaricato dei vantaggi che certe ricostruzioni, sempre più
convergenti, porterebbero ai russi. “Stiamo combattendo contro un nemico: la
Russia. E stiamo combattendo anche contro quelle persone che, a parte i soldi,
non vedono altro che se stesse”, ha aggiunto Zelensky, accusando alcuni leader
internazionali, “anche membri della Ue o della Nato”, di aver continuato a “fare
affari” con Putin.
Il crollo
demografico in Russia rappresenta un impoverimento enorme, ma anche una grande
speranza.
Federico Rampini / CorriereTv su Il Corriere della Sera il 10
Marzo 2023
C’è un incubo
russo che bisogna sperare si trasformi in un sogno di una nuova Russia: è
il crollo demografico della Russia, che ha proporzioni quasi inimmaginabili.
Nella Russia, negli ultimi 3 anni, la Russia ha perso circa 2 milioni di
abitanti. Non è solo il risultato della guerra (dove la Russia dovrebbe aver
avuto circa 200mila tra morti e feriti), ma prima ancora il Covid e il ritorno
di problemi antichi come l’alcolismo. La speranza di vita media di un maschio
adulto è crollata agli stessi libelli di Haiti. A tutto questo bisogna
aggiungere il mezzo milione di maschi russi che sono scappati all’estero per non
andare al fronte contro l’Ucraina.
E’ un Paese che si
sta assottigliando: questo nel breve termine non altera le proporzioni
demografiche che favoriscono le forze armate russe rispetto a quelle ucraine, ma
la perdita di abitanti - soprattutto maschi adulti giovani - è un impoverimento
enorme.
Dove questo potrebbe
trasformarsi in un sogno? Forse all’estero: bisogna riflettere su cosa significa
questa diaspora. Molto spesso quelli che sono riusciti a scappare all’estero
sono le forze migliori del Paese: informatici, tecnici, matematici, scienziati,
ricercatori, imprenditori. Ma nella storia le diaspore hanno creato anche
una storia alternativa: se all’interno di questa emigrazione,
nascessero movimenti per disegnare una Russia diversa, sarebbe una meravigliosa
speranza.
La Repubblica.
Kiev: cadaveri di civili per le strade di Bakhmut. Zakharova a Kuleba: "Gli
italiani non hanno mandato tank in Piemonte come gli ucraini nel Donbass"
La portavoce di
Lavrov risponde al ministro degli Esteri ucraino, che aveva paragonato
l'eventuale cessione di regioni del Sud a quella, per lui altrettanto
impossibile, del Piemonte da parte di Roma. Kiev: "Morti oltre 159mila russi,
più di mille nelle ultime 24 ore". L'appello delle madri e delle mogli russe a
Putin: "Non mandare i nostri uomini al macello"
Continua lo
stallo sulla conquista della città di Bakhmut, città dell'Ucraina orientale che
le forze russe stanno cercando di conquistare dall'estate a costo di pesanti
perdite. Gli ucraini starebbero preparando una controffensiva che, secondo loro,
non dovrebbe durare a lungo. L'esercito russo continua contemporaneamente i suoi
attacchi in altre regioni: le autorità hanno annunciato che un attacco in
mattinata ha provocato almeno tre morti e due feriti a Kherson. Per il
bollettino giornaliero dello stato maggiore di Kiev sarebbero 159.090 i soldati
di Mosca uccisi dall'inizio dell'invasione.
Punti chiave
18:48
Georgia,
Saakashvili a Sky News: sono vicino alla morte
17:51
Forze ucraine:
cadaveri di civili nelle strade di Bakhmut
17:17
Zakharova a
Kuleba: "Gli italiani non hanno mandato tank in Piemonte come gli ucraini nel
Donbass"
16:35
Moldavia,
polizia: "Sventato complotto di Mosca, arrestato un cittadino russo"
15:08
Moldavia, polizia
smantella rete sovversiva orchestrata da Mosca
12:19
Ucraina, Isw:
"Zakharova ammette scontri interni nelle èlite"
01:16
Capo polizia,
presa di mira la città di Ochakiv
La città di
Ochakiv, situata a 60 chilometri a sud-ovest di Mykolaiv, è stata presa di mira
durante la notte. Lo ha riferito il capo della polizia di Mykolaiv Serhii
Shaikhet su Telegram, secondo quanto riporta The Kyiv Independent.
02:30
Razzi russi su
città a sud-ovest di Mykolaiv
Razzi russi
nella notte sulla città di Ochakiv (20.000 abitanti), situata a 60 chilometri a
sud-ovest di Mykolaiv. Lo riferisce su Telegram - come riportato dal Kyiv
Independent - il capo della polizia di Mykolaiv, Serhii Shaikhet. Le forze russe
hanno utilizzato vari lanciarazzi per colpire la città. I proiettili hanno
incendiato alcune auto ma non sono segnalate vittime. I servizi di emergenza
stanno lavorando sul luogo dell'attacco.
03:47
Kiev prepara
controffensiva nei pressi di Bakhmout
Gli ucraini si
stanno preparando a una controffensiva che, secondo loro, non dovrebbe durare a
lungo nella regione di Bakhmout, una città dell'Ucraina orientale che le forze
russe stanno cercando di conquistare dall'estate a costo di pesanti perdite.
L'esercito russo continua contemporaneamente i suoi attacchi in altre regioni:
le autorità hanno annunciato che un attacco in mattinata ha provocato almeno tre
morti e due feriti a Kherson, città del sud liberata dall'esercito di Kiev a
novembre dopo diversi mesi di occupazione. A Bakhmout, attuale epicentro del
conflitto, Evguèni Prigojine, il capo del gruppo paramilitare Wagner, ha
rivendicato una nuova progressione dei suoi uomini che stanno combattendo lì in
prima linea. Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato sabato che le forze
ucraine il giorno prima avevano "respinto più di 100 attacchi nemici" nelle
principali zone di combattimento.
04:01
Zelensky, oltre
40 missili su Kharkiv da inizio 2023
"Oltre 40 missili
hanno colpito Kharkiv dall'inizio del 2023". Nel suo discorso notturno il
presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che più di 40 missili hanno colpito
la città nord-orientale di Kharkiv dall'inizio dell'anno.
04:33
Due bambini
trovano granata e la portano a casa, entrambi feriti
Due bambini sono
rimasti feriti nella regione di Zaporizhia a causa dello scoppio di una granata
anticarro che avevano trovato per strada e portato a casa. Lo riferisce
l'agenzia Unian citando fonti della polizia locale. I bambini, nati nel 2012 e
nel 2019, sono rimasti feriti in una abitazione del villaggio di Novoivanivka.
Poco prima avevano portato a casa un oggetto cilindrico allungato sconosciuto,
trovato per strada, che è esploso mentre giocavano. "Dopo aver ispezionato la
scena e i resti dell'oggetto esplosivo, le forze dell'ordine hanno
preliminarmente determinato che si tratta dell'impugnatura di una granata
anticarro Rkg-3", si legge nel rapporto. I due bambini hanno riportato lesioni
di varia gravità e sono stati portati in ospedale: il più piccolo è stato
dimesso mentre il più grande è stato ricoverato.
09:05
Kuleba: "La
carenza delle munizioni è il primo problema. Berlino acceleri consegne"
L'Occidente e in
particolare la Germania dovrebbero iniziare ad addestrare i piloti ucraini a
pilotare moderni aerei da combattimento, anche se la consegna di jet avanzati
occidentali non è imminente: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri
dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, in un'intervista al tabloid domenicale
tedesco Bild, nella quale ha anche sollecitato i produttori tedeschi ad
accelerare la consegna di munizioni all'esercito di Kiev, perché, ha detto, la
scarsità di munizioni è al momento il "problema numero uno" nella difesa
dall'invasione russa. Kuleba ha detto che alla Conferenza sulla Sicurezza di
Monaco di febbraio i produttori di armi tedeschi lo hanno rassicurato che le
consegne erano pronte, in attesa della firma dei contratti da parte del governo.
09:37
Tajani: "Il 26
aprile faremo evento per ricostruzione Ucraina"
"Il 26 aprile
organizzeremo come ministero degli Esteri un grande evento per parlare della
partecipazione italiana alla ricostruzione ucraina, puntiamo ai settori di alta
tecnologia, infrastrutture, elettrico, il nostro saper fare potrà esser utile
all'Ucraina". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Il
caffè della domenica" su Radio24, assicurando che "l'Italia vuole essere
protagonista della ricostruzione dell'Ucraina".
09:40
Kuleba:
"Continueremo a difendere Bakhmut"
"Se ci
ritirassimo da Bakhmut, cosa cambierebbe? La Russia prenderebbe Bakhmut e poi
continuerebbe la sua offensiva contro Chasiv Yar, quindi ogni città dietro
Bakhmut potrebbe subire la stessa sorte": lo ha detto il ministro degli Esteri
ucraino, Dmytro Kuleba, affermando che Kiev intende continuare a difendere la
città, ritenuta nodo strategico dell'avanzata russa. Lo riporta il Guardian.
Alla domanda 'per quanto tempo le forze ucraine potrebbero resistere?', Kuleba
ha paragonato la difesa della città a quella di una casa contro un intruso che
cerca di ucciderne gli abitanti e di sottrarre loro tutto ciò che possiedono.
10:55
Kiev: "Morti
oltre 159mila russi, più di mille nelle ultime 24 ore"
Nella sola
giornata di ieri sarebbero stati uccisi 1090 soldati russi, portando a 159.090
il totale dei morti dall'inizio dell'invasione. Lo afferma il bollettino
giornaliero dello stato maggiore di Kiev, aggiungendo che ieri sono stati
distrutti 8 tank, 7 veicoli corazzati e 4 sistemi d'artiglieria dell'esercito
russo.
12:19
Ucraina, Isw:
"Zakharova ammette scontri interni nelle èlite"
La portavoce del
ministero degli Esteri russo Maria Zacharova ha di fatto "confermato che vi sono
lotte intestine nei circoli del Cremlino, che il Cremlino ha ceduto il controllo
dello spazio informativo russo e che il presidente russo Vladimir Putin
apparentemente non riesce a risolvere tutto ciò". E' quanto si legge nel
bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War
(Isw). L'analisi prende spunto da un intervento di Zacharova ad un forum ieri a
Mosca durante il quale la portavoce degli Esteri ha detto che il Cremlino non
può riproporre l'appoccio stalinista di controllo centrale dell'informazione
interna russa a causa di non meglio specificate lotte fra le "èlite" del
Cremlino. Secondo Isw queste dichiarazioni sostengono alcune valutazioni dello
stesso think tank sul deterioramento del regime russo e le dinamiche del
controllo dello spazio informativo. Ovvero che vi siano "lotte intestine fra
membri chiave del circolo ristretto di Putin; che Putin abbia ceduto lo spazio
informativo ad una varietà di attori quasi indipendenti; che Putin sia
apparentemente incapace di intraprendere un'azione decisiva per riprendere il
controllo dello spazio informativo".
12:46
Mosca: "Su export
grano ancora nessun colloquio con noi"
Mosca ha fatto
sapere che i rappresentanti russi non hanno ancora preso parte ai negoziati
sull'estensione dell'accordo sull'esportazione del grano ucraino attraverso il
Mar Nero. "Non ci sono stati negoziati su questo argomento, soprattutto con la
partecipazione di rappresentanti russi", ha affermato la portavoce del ministero
degli Esteri, Maria Zakharova, precisando che il prossimo round di colloqui si
terrà domani a Ginevra tra la delegazione russa e l'alto rappresentante
Onu, Rebeca Grynspan.
13:01
L'appello delle
madri e delle mogli russe a Putin: "Non mandare nostri uomini al macello"
Diverse mogli e
madri russe si sono unite per chiedere al presidente Vladimir Putin di smettere
di mandare i loro mariti e figli "al massacro" costringendoli a unirsi a gruppi
d'assalto senza un addestramento o rifornimenti adeguati. Lo scrive Cnn online
citando un video condiviso dal canale indipendente russo Telegram Sota, in cui
le donne affermano che i loro figli o mariti sono stati "costretti a unirsi a
gruppi d'assalto" all'inizio di marzo dopo appena quattro giorni di
addestramento. Il video mostra le donne con in mano un cartello con scritto in
russo "580 Separate Howitzer Artillery Division", datato 11 marzo 2023. "Mio
marito si trova sulla linea di contatto con il nemico", dice una donna nella
registrazione, aggiungendo che "i nostri mobilitati vengono inviati come agnelli
al macello per assaltare le aree fortificate, cinque alla volta, contro 100
uomini nemici pesantemente armati", pertanto "vi chiediamo di ritirare i nostri
uomini dalla linea di contatto e di fornire agli artiglieri armi e munizioni",
riferisce ancora la Cnn, precisando di non aver potuto verificare in modo
indipendente le affermazioni fatte dal gruppo di donne nel video.
13:15
Moldavia, nuove
manifestazioni anti-governative a Chisinau
Ci sarebbero
stati delle tensioni tra la polizia e i manifestanti dell'opposizione
filo-russa nel centro di Chisinau, capitale della Moldavia. Secondo le agenzie
di stampa russe la polizia ha formato un cordone per bloccare migliaia di
manifestanti che volevano raggiungere la piazza centrale e il palazzo del
governo. Secondo la Ria Novosti, alcuni manifestanti sarebbero riusciti a
sfondarlo. I manifestanti, secondo la Tass, scandiscono slogan come "Abbasso la
dittatura", "Abbasso la presidente Maia Sandu".
Sempre secondo le
agenzia russe, l'opposizione manifesta a causa degli alti prezzi del gas, che
hanno provocato un aumento del prezzo dell'elettricità, del riscaldamento
domestico, dei servizi e dei prodotti.
14:23
Zakharova
smentisce affermazioni su lotte intestine élite
La portavoce del
ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "false" le notizie
secondo cui avrebbe parlato della "lotte intestine tra le elite" in Russia. Lo
riferisce la Tass.
14:51
Mosca: "Tre
civili uccisi e 9 feriti in bombardamento ucraino"
Tre civili sono
stati uccisi e nove sono rimasti feriti a causa del bombardamento ucraino di una
stazione degli autobus a Perevalsk, nella regione del Lugansk. Lo riporta Ria
Novosti citando l'ufficio di rappresentanza presso il Centro congiunto per il
controllo e il coordinamento (Jccc) delle questioni relative ai crimini di
guerra dell'Ucraina. "Secondo le informazioni preliminari, a seguito del
bombardamento della stazione degli autobus Alchevsk AS-1 nella città di
Perevalsk, tre civili sono stati uccisi e nove persone sono rimaste coinvolte
con ferite di varia entità", ha concluso l'ufficio di rappresentanza.
15:08
Moldavia, polizia
smantella rete sovversiva orchestrata da Mosca
La polizia
moldava ha annunciato di aver smantellato una rete sovversiva "orchestrata da
Mosca". Dopo le perquisizioni, ieri notte 25 uomini sono stati interrogati e
sette di loro sono stati arrestati, ha detto ai media il capo della
polizia Viorel Cernauteanu. Un agente è riuscito a infiltrarsi nel gruppo
guidato da un uomo di nazionalità moldava-russa, ha aggiunto, indicando 10 ore
di registrazione video come prova. "Le persone sono arrivate dalla Russia con un
ruolo di addestramento molto specifico", ha aggiunto il funzionario. Le autorità
moldave hanno affermato di aver agito dopo aver "ricevuto informazioni
sull'organizzazione da parte dei servizi speciali russi di azioni
destabilizzanti sul nostro territorio tramite manifestazioni". Il partito
dell'oligarca filo-russo in fuga, Ilhan Shor, si è nuovamente mobilitato nelle
ultime settimane contro il governo filo-europeo, tra le crescenti tensioni tra
Mosca e Chisinau, organizzando diverse manifestazioni, secondo il governo
pagando i partecipanti.
15:43
Kiev: "28.000
nuovi volontari per la prossima controffensiva"
Circa 28.000
volontari ucraini hanno chiesto di entrare nelle nuove brigate d'assalto
che Kiev sta preparando in vista di una controffensiva contro le truppe russe
che occupano il suo territorio. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno
ucraino, Ihor Klymenko. "Abbiamo già accettato 28 mila domande di volontari", ha
spiegato Klymenko in un comunicato in cui spiega che non tutti saranno accettati
in queste brigate che agiranno sotto il comando del ministero dell'Interno. "Le
unità sono praticamente formate", ha aggiunto il ministro, spiegando che il
reclutamento di volontari continua affinchè queste unità abbiano personale di
riserva.
16:19
Ucraina, Kiev:
"48 attacchi russi in 24 ore sui civili nel Donetsk"
Soltanto nelle
ultime 24 ore la Russia ha lanciato 48 attacchi contro civili nella regione del
Donetsk, secondo la polizia nazionale ucraina. Lo riporta Ukrinform. Stando a
quanto sostiene il Kyiv Independent, la polizia ha detto che sono state
attaccate 15 città, tra cui Bakhmut, Kostjantynivka e Avdiivka. Da Mosca
avrebbero utilizzato missili S-300, aerei, lanciarazzi multipli Grad e Uragan,
artiglieria, mortai e carri armati. Il governatore della regione di
Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato nel suo briefing quotidiano che due
civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti nell'ultimo giorno.
16:28
Ucraina, Kiev:
"Le vie di rifornimento a Bakhmut sono ancora funzionanti"
Le rotte
logistiche in entrata e in uscita da Bakhmut sono ancora funzionanti, il che
significa che "la fornitura di munizioni" alla città assediata è possibile. A
riferirlo è un comandante dell'esercito ucraino citato dalla Cnn. "Il meteo
impone le sue restrizioni. Ma al momento le rotte logistiche funzionano. La
fornitura di munizioni è possibile, sebbene sia difficile. L'evacuazione dei
feriti è possibile. È possibile anche la fornitura di rinforzi", ha detto alla
televisione locale Mykola Volokhov, capo dell'unità di ricognizione aerea
"Terra" dell'Ucraina. Bakhmut ha importanti collegamenti stradali con altre
parti della regione di Donetsk; a est fino al confine con Lugansk, a nord-ovest
fino a Sloviansk ea sud-ovest fino a Kostiantynivka. Tuttavia una conquista
russa avrebbe un significato più simbolico che militare.
16:35
Moldavia,
polizia: "Sventato complotto di Mosca, arrestato un cittadino russo"
La polizia
moldava ha annunciato di aver sventato un complotto di Mosca per destabilizzare
il paese. Lo riferisce il sito NewsMaker. Un cittadino russo entrato nel paese
il 9 marzo è stato arrestato, ha detto il capo della polizia Viorel Cernauteanu.
Il complotto è stato scoperto da un agente moldavo sotto copertura. L'uomo
arrestato, che era già venuto diverse volte in Moldavia, era incaricato
dell'addestramento. Gli organizzatori avevano formato dieci gruppi di dieci
persone per azioni di destabilizzazione. A tutti i reclutatori, sette dei quali
sono stati arrestati, erano stati promessi 10mila dollari per l'organizzazione
di rivolte anti governative. Il canale Telegram della polizia moldava ha diffuso
anche un video dell'addestramento, registrato con una telecamera nascosta.
16:42
Mosca: "L'accordo
del grano deve garantire anche l'export russo"
La parte
dell'accordo sul grano che permette le esportazioni del cereale dai porti
ucraini è stata finora applicata, mentre continua ad essere bloccata quella
relativa alle esportazioni russe, come risultato delle sanzioni occidentali. Lo
ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova,
confermando che domani a Ginevra è in programma un incontro tra una delegazione
russa e responsabili dell'Onu su una possibile estensione dell'accordo, che
scade il 18 marzo. "La nostra posizione - ha sottolineato la portavoce, citata
dall'agenzia Tass - è nota e non cambia". Vale a dire che l'accordo per
l'esportazione del grano dai porto ucraini e un memorandum tra Russia e Onu per
la normalizzazione delle esportazioni agricole russe "devono essere applicati
insieme per risolvere il compito umanitario di mettere fine alla crisi
alimentare ed aiutare i Paesi bisognosi in Africa, Asia e America Latina".
16:48
Oltre 50 fermati
in Moldavia durante le manifestazioni contro il governo
Oltre 50 persone
sono state fermate oggi dalla polizia a Chisinau durante scontri tra la polizia
e migliaia di manifestanti anti-governativi che gridavano slogan per le
dimissioni della presidente filo-occidentale Maia Sandu. Lo riferisce sul suo
canale Telegram la polizia moldava, citata dalle agenzie russe. Marina Tauber,
vice capo del partito di opposizione Sor, ha detto che tra i fermati vi è il
presidente onorario del partito, Valery Klimenko.
17:17
Zakharova a
Kuleba: "Gli italiani non hanno mandato tank in Piemonte come gli ucraini nel
Donbass"
La portavoce del
ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha attaccato oggi il ministro
degli Esteri Dmytro Kuleba per dichiarazioni riportate nei giorni scorsi da La
Repubblica e La Stampa in cui ha criticato gli italiani che chiedono una fine
negoziata del conflitto con la cessione di territori ucraini.
In particolare,
Zakharova sottolinea una frase in cui Kuleba chiede se gli italiani sarebbero
pronti a cedere la Calabria, la Sardegna, il Piemonte o l'Alto Adige. "È un
peccato - scrive la portavoce russa sul suo canale Telegram - che il
rappresentante del comico (il presidente Volodymyr Zelensky, ndr) non precisi
che gli italiani non hanno messo in ginocchio le legittime autorità di quelle
regioni, non abbiano mandato carri armati in Piemonte e in Alto Adige e non
abbiano espulso dalle loro terre gli abitanti di Sardegna e Calabria".
17:34
La Svizzera
rivendica la sua neutralità e dice no alla riesportazione di armi verso Kiev
Il presidente
federale svizzero Alain Berset difende la neutralità del paese in merito alla
guerra in Ucraina e sottolinea che non significa indifferenza. "Oggi sento
questa frenesia bellica in certi ambienti. E sono molto preoccupato per questo.
Perché questa sensazione si basa su una visione a breve termine", ha detto
Berset al quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, "cerchiamo di essere
presenti ovunque possiamo dare un contributo alla mediazione e alla pace". A
proposito della richiesta tedesca di riesportazione delle armi, "la posizione
del Consiglio federale è chiara", afferma, "corrisponde anche al mio
atteggiamento personale. Le armi svizzere non devono essere utilizzate nelle
guerre".
17:51
Forze ucraine:
cadaveri di civili nelle strade di Bakhmut
I combattenti
ucraini affermano che corpi dei civili giacciono per le strade di Bakhmut, non
potendo recuperarli a causa dell'intensità della battaglia che infuria nella
città. Parlando a Sky News, Khalid Makiazho, parte di un battaglione ceceno che
sostiene l'Ucraina, ha descritto un paesaggio di totale devastazione, continue
raffiche di artiglieria e "bombardamenti caotici".
Secondo Makiazho,
i civili rimasti si rifugiano negli scantinati. "Ci sono ancora persone in
città, alcune sono molto anziane, ci sono anche cadaveri di civili, stiamo
cercando di recuperare i corpi ma non c'è modo di raggiungerli".
18:48
Georgia,
Saakashvili a Sky News: sono vicino alla morte
L'ex presidente
della Georgia Mikheil Saakashvili ha detto a Sky News di essere "vicino alla
morte" nell'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere. L'ex leader sostiene
di essere stato avvelenato in prigione, tesi negata dall'attuale governo
georgiano, secondo cui le condizioni di salute di Saakashvili sarebbero dovute
al fatto che non si è nutrito a sufficienza. "Inizialmente pesavo 120
chilogrammi, ora ne ho 64, se scendo sotto ai 60 i medici prevedono
insufficienze multiorgano", ha detto Saakashvili alla domanda su quanto fosse
vicino alla morte.
Estratto
dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero” il 12 marzo 2023.
[…] i soldati russi
non capiscono per che cosa vanno a morire e disertano in numero sempre maggiore.
Dopo l'ultimo arruolamento forzato di 300.000 unità deciso dal Cremlino, […] Da
qualche settimana gli strateghi ucraini hanno dato vita al programma "Voglio
vivere", istituendo una linea calda che i nemici possono chiamare se decidono di
abbandonare i combattimenti. La gestiscono in tutto dieci persone, uomini e
donne che hanno studiato psicologia e parlano bene il russo. […]
I dieci operatori
della linea calda rispondono da una base segreta superprotetta, perché le
diserzioni sono ormai così tante che Putin li considera un obiettivo strategico
da eliminare al più presto. Hanno un portavoce, il tenente Vitaly Matvienko, il
quale parla pochissimo e quando fa ascoltare una registrazione altera la voce
del soldato perché non possa essere riconosciuta.
[…] Gli operatori
assicurano a chi chiama che nei loro documenti si scriverà che sono stati
catturati e non che si sono arresi volontariamente. Questo è indispensabile nel
caso in cui vogliano poi essere mandati a casa in uno scambio di prigionieri.
La possibilità di
utilizzare la linea "Voglio vivere" è stata resa nota attraverso i social, e il
sito web del programma ha attirato decine di milioni di visite da tutto il
territorio russo. Sul fronte la notizia dell'esistenza della linea calda è stata
diffusa con il passaparola o con bigliettini scritti a mano che si possono
facilmente ingoiare se si avvicina un ufficiale. Sui social è stato raccomandato
ai soldati russi di portare con sé e usare per la chiamata un "flip phone", la
versione base di un telefonino, facile da nascondere e non tracciabile come uno
smartphone. […]
Da “la
Repubblica”
il 12 marzo 2023.
La guerra tra
Russia e Ucraina diventa anche guerra dei nomi con il presidente Zelensky che
incarica il primo ministro Denys Shmygal di studiare la fattibilità della
petizione, firmata da 25mila persone, che chiede il cambio del nome Russia in
Moscovia, come il granducato medievale con sede nell’attuale capitale che
precedette la nascita dell’impero. Si ridimensionerebbe così lo status della
Russia da potenza internazionale a piccola entità periferica.
«La Russia esiste
solo da 301 anni, dal 22 ottobre 1721, quando lo zar Pietro I di Mosca proclamò
il regno di Mosca “Impero russo”», si legge nella petizione. Dura la risposta
dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev: «Se lo faranno l’Ucraina verrà
chiamata “Il sudicio Reich di Bandera», ovvero il nazionalista ucraino
anti-russo che durante l’invasione nazista dell’Urss si alleò con Hitler. Per
Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, è «un’altra prova
del tentativo di fare dell’Ucraina una anti-Russia».
Da corriere.it il 12
marzo 2023.
Stando al bollettino
giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War (Isw), Maria
Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri, avrebbe di fatto confermato che
all’interno dei circoli del Cremlino esistono «lotte intestine». che «il
Cremlino ha ceduto il controllo dello spazio informativo russo» e che «Putin
apparentemente non riesce a risolvere tutto ciò».
La portavoce degli
Esteri, in occasione di un forum tenutosi a Mosca, avrebbe detto che il Cremlino
non può riproporre l’approccio stalinista di controllo centrale
dell’informazione interna russa a causa di non meglio specificate lotte fra le
«elite» del Cremlino.
Secondo Isw queste
dichiarazioni sostengono alcune valutazioni dello stesso think tank sul
deterioramento del regime russo e le dinamiche del controllo dello spazio
informativo. Ovvero che vi siano «lotte intestine fra membri chiave del circolo
ristretto di Putin; che Putin abbia ceduto lo spazio informativo ad una varietà
di attori quasi indipendenti; che Putin sia apparentemente incapace di
intraprendere un’azione decisiva per riprendere il controllo dello spazio
informativo».
Secondo l’Isw, non
è chiaro perché Zacharova si sia spinta a fare queste affermazioni, ma è
possibile che abbia voluto «ridurre le aspettative dei blogger militari
nazionalisti sulle capacità del Cremlino di dare coerenza ad una narrativa unica
e forse anche una politica unificata».
L’agenzia Tass
riferisce che Maria Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri, avrebbe
provato a smentire le voci che la vedrebbero responsabile di aver raccontato di
«lotte intestine» ai vertici del Cremlino. La Isw aveva parlato di un resoconto
di Zacharova a margine di un evento a Mosca nel quale la portavoce si era
sbilanciata spiegando che Putin non riuscirebbe a risolvere i conflitti tra i
vertici del suo cerchio magico.
Cremlino tra
faide e veleni. "Lotte nel cerchio di Putin".
Matteo Basile il
13 Marzo 2023 su Il Giornale.
Il think tank
Usa: Zakharova ammette divisioni. Lei: "Falso". Moldavia, caos e arresti:
sventato golpe russo
Che qualcosa
stesse pesantemente scricchiolando all'interno dell'establishment russo è cosa
nota da tempo, al di là delle smentite di facciata. Non solo il palese scontro
tra il generale Gerasimov e Prigozhin per il controllo dell'esercito,
impossibile da negare. Ma al netto delle purghe e dei giri di vite che dalle
parti del Cremlino non mancano mai, sono in molti nel cerchio magico putiniano a
non essere d'accordo con la linea ufficiale. E ora l'istituto americano per lo
studio della guerra racconta che anche la portavoce del ministero degli Esteri
russo Maria Zakharova ha di fatto confermato che vi sono lotte intestine nei
circoli del Cremlino, che il Cremlino ha ceduto il controllo dello spazio
informativo russo e che il presidente russo Vladimir Putin apparentemente non
riesce a risolvere la situazione.
Ovviamente la
Zakharova ha definito «false» le notizie del think tank ma il personaggio si
conosce. Sempre in prima linea nell'accusare chiunque, nell'attaccare tutti, da
leader a interi governi, con toni polemici e spesso violenti. Pronta a difendere
l'indifendibile e a negare anche la realtà più palese in nome della (sua) ragion
di Stato. Ma proprio lei avrebbe detto «che il Cremlino non può riproporre
l'approccio stalinista di controllo centrale dell'informazione», a causa di non
meglio specificate «lotte fra le èlite». Ennesima conferma di un caos interno
difficile da gestire, anche a causa di un conflitto che in pochissimi volevano
realmente portare avanti. Non solo ai piani alti del Cremlino ma anche, e forse
soprattutto, tra la popolazione civile.
Dopo le fughe
dalla Russia di migliaia di uomini per sfuggire all'arruolamento, ieri numerose
mogli e madri russe si sono unite per chiedere a Putin di smettere di mandare i
loro mariti e figli «al massacro», obbligandoli a unirsi all'esercito senza un
addestramento o rifornimenti adeguati. In un video, una delle donne racconta che
suo marito si trova in prima linea e accusa: «I nostri mobilitati vengono
inviati come agnelli al macello per assaltare le aree fortificate, cinque alla
volta, contro 100 uomini», chiedendo che gli uomini vengano ritirati dal fronte
o quantomeno equipaggiati a dovere. Scarso, quasi nullo, il gradimento per la
Russia anche oltre confine, specialmente in Georgia e Moldavia dove ieri ci sono
stati ancora momenti di tensioni in piazza tra la polizia e manifestanti
filo-russi nel centro di Chisinau con più di 50 persone fermate. Da tempo
agitatori vicini a Mosca stanno mettendo sotto pressione il governo, tanto che
proprio ieri la polizia ha comunicato di aver smantellato una rete sovversiva
«orchestrata da Mosca».
Un uomo arrivato
dalla Russia, accusato di essere un addestratore di manifestanti, è stato
arrestato. Altri 25 sono stati interrogati e sette di loro sono finiti in
manette grazie al lavoro di un agente infiltrato. Le autorità hanno riferito di
aver ricevuto informazioni dettagliate sul gruppo che voleva creare «azioni
destabilizzanti sul nostro territorio tramite manifestazioni». Intanto prosegue
senza sosta la battaglia di Bakhmut, con la città spezzata in due tra i
mercenari della Wagner e la resistenza ucraina che denuncia numerosi cadaveri di
civili nelle strade. «Se ci ritirassimo la Russia prenderebbe Bakhmut e poi
continuerebbe la sua offensiva», ha detto il ministro degli Esteri ucraino
Dmytro Kuleba, tornando a chiedere all'Occidente di accelerare il rifornimento
di armi e munizioni per continuare la difesa del territorio.
(ANSA il 12 marzo
2023) Diverse mogli e madri russe si sono unite per chiedere al presidente
Vladimir Putin di smettere di mandare i loro mariti e figli "al massacro"
costringendoli a unirsi a gruppi d'assalto senza un addestramento o rifornimenti
adeguati. Lo scrive Cnn online citando un video condiviso dal canale
indipendente russo Telegram SOTA, in cui le donne affermano che i loro figli o
mariti sono stati "costretti a unirsi a gruppi d'assalto" all'inizio di marzo
dopo appena quattro giorni di addestramento.
Il video mostra le
donne con in mano un cartello con scritto in russo "580 Separate Howitzer
Artillery Division", datato 11 marzo 2023. "Mio marito... si trova sulla linea
di contatto con il nemico", dice una donna nella registrazione, aggiungendo che
"i nostri mobilitati vengono inviati come agnelli al macello per assaltare le
aree fortificate, cinque alla volta, contro 100 uomini nemici pesantemente
armati", pertanto "vi chiediamo di ritirare i nostri uomini dalla linea di
contatto e di fornire agli artiglieri armi e munizioni", riferisce ancora la
Cnn, precisando di non aver potuto verificare in modo indipendente le
affermazioni fatte dal gruppo di donne nel video.
La Repubblica.
Media: Xi vede Putin, poi parlerà con Zelensky. Tajani. "Molti migranti da zone
controllate da Wagner". Mosca, estensione accordo sul grano per 60 giorni
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che le forze russe hanno subito più di 1.100
morti negli ultimi giorni. Lukashenko oggi a Teheran. Kirill al Papa: "Il
dialogo religioso può dare buoni risultati"
Continua a infuriare
la battaglia a Bakhmut, dove i corpi di molti civili giacciono nelle strade e
non possono essere recuperati dai combattenti ucraini. Le forze ucraine
controllano la parte occidentale della città in rovina e quasi deserta, mentre
il gruppo russo Wagner controlla la maggior parte della zona est - riferiscono
fonti dell'intelligence britannica riportate dai media locali - con la linea del
fronte sul fiume Bakhmutka che taglia in due la città. Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che le forze russe hanno subito più di 1.100
morti negli ultimi giorni combattendo lungo la sezione di Bakhmut della linea
del fronte. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno
ucciso più di 220 militari ucraini nelle ultime 24 ore.
Punti chiave
19:20
Prigozhin insulta
Crosetto, "non ci occupiamo di migranti"
17:10
Mosca, estensione
accordo sul grano solo per 60 giorni
15:45
Tajani, molti
migranti da zone controllate da Wagner
13:10
Iniziato a Ginevra
l'incontro Russia-Onu per il rinnovo dell'accordo sul grano in Ucraina
12:41
Wall Street Journal:
Xi vuole avere incontro online con Zelensky dopo la visita a Mosca
12:00
Il Cremlino non
conferma che il presidente cinese Xi visiterà Mosca la prossima settimana: "Vi
faremo sapere"
09:45
Kiev e Wagner:
"Scontri per il controllo del centro di Bakhmut"
08:41
Xi Jinping visiterà
Mosca la prossima settimana
08:32
Russia, Patrushev:
"Dubbi che gruppi pro ucraini abbiano fatto saltare Nord Stream 2"
08:08
Lukashenko in visita
ufficiale in Iran. Oggi incontri con Raisi e Khamenei
23:59
Confermata
l'identità del soldato ucciso nel video
I servizi di
sicurezza ucraini hanno confermato l'identità del soldato la cui fucilazione è
stata ripresa in un video diventato virale, dopo che diverse fonti ufficiali
avevano fornito due nomi diversi. "Gli investigatori (SBU) hanno stabilito che
il soldato ucraino colpito era un cecchino del 163 battaglione della 119
brigata di difesa territoriale della regione di Chernihiv, Oleksander Igorovich
Matsievskiy", hanno annunciato gli investigatori in un comunicato.
00:18
Parigi 2024:
Lituania, stop a russi a Giochi a livello mondiale
Il parlamento della
Lituania (Seimas), dopo aver votato all'unanimità di chiedere al Comitato
Olimpico Internazionale (Cio) di bandire gli atleti russi e bielorussi dalle
Olimpiadi di Parigi 2024 fino al termine della guerra in Ucraina, attraverso la
sua presidente Viktoria Cmilyte-Nielsen si è rivolto al resto del mondo.
"Chiediamo ai
parlamenti di tutti i Paesi del mondo di esprimere la loro chiara e forte
opposizione a qualsiasi proposta, iniziativa, progetto o qualsiasi altra azione
volta a consentire agli atleti e ai funzionari sportivi russi e bielorussi di
partecipare ai Giochi olimpici o a qualsiasi altro evento internazionale
competizioni sotto una bandiera neutrale", ha affermato Cmilyte-Nielsen. A
Praga, il Senato della Repubblica Ceca con una risicata maggioranza (67 a 63) ha
indirizzato il Comitato olimpico nazionale, qualora interpellato dal Cio, di non
consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di
Parigi.
"È impensabile che
un Paese che ha provocato una guerra promuova il suo regime attraverso i suoi
atleti", ha detto il vicepresidente del Senato, Jirì Ruzcka. Il Comitato
Olimpico Internazionale sta completando una serie di "esplorazioni" atte a
trovare una soluzione nella totale neutralità e senza alcun inno, bandiera o
colore della Nazione, di far partecipare gli atleti con passaporto russo e
bielorusso alle qualificazioni per i Giochi olimpici del 2024 nella capitale
francese.
00:31
Rapporto Sipri: con
guerra Ucraina raddoppiate importazioni armi in Ue nel 2022
Secondo un
rapporto dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma
(Sipri) le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate nel 2022,
grazie alle massicce forniture all'Ucraina, che è diventata la terza
destinazione mondiale.
Con un'impennata del
93% rispetto all'anno precedente, le importazioni sono aumentate anche a causa
dell'aumento della spesa militare da parte di diversi Stati europei come la
Polonia e la Norvegia, che si prevede accelererà ulteriormente, secondo lo
studio di riferimento.
"L'invasione ha
davvero causato un'impennata significativa della domanda di armi in Europa, che
non ha ancora mostrato tutta la sua forza e che con ogni probabilità porterà a
un ulteriore aumento delle importazioni", ha dichiarato Pieter Wezeman,
co-autore del rapporto annuale da oltre tre decenni.
06:38
Isw, Putin a caccia
di capri espiatori
Il presidente
Vladimir Putin è alla ricerca di capri espiatori per i fallimenti della Russia
nel conflitto in Ucraina: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw)
nel suo aggiornamento quotidiano. Lo riporta Rbc.
Secondo gli analisti
del centro studi statunitense, Putin sta usando le pesanti perdite del Gruppo
Wagner, oltre alle notizie sul basso morale delle truppe e sui crimini di
guerra, per distrarre il pubblico da problemi forse maggiori nell'esercito del
Paese
07:14
Quattro missili
abbattuti su oblast russo di Belgorod, un ferito
Le forze russe hanno
abbattuto quattro missili sulla regione russa di di Belgorod, si conta almeno
una persona ferita. "Ci sono anche danni da detriti di razzi in due edifici
residenziali", ha dichiarato su Telegram il governatore dell'oblast Vyacheslav
Gladkov. Sul luogo dell'attacco - riferisce il Kiev Independent - sono già
arrivati i servizi di emergenza. Il governatore non ha fornito ulteriori
informazioni né chiarito se i missili fossero di origine ucraina o armi russe
che avevano deviato dalla traiettoria. Belgorod confina con l'oblast di
Kharkiv in Ucraina ed è stata spesso presa di mira dall'inizio dell'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia.
08:08
Lukashenko in visita
ufficiale in Iran. Oggi incontri con Raisi e Khamenei
Il presidente
bielorusso Alexander Lukashenko è arrivato ieri sera a Teheran per la sua terza
visita di Stato nel Paese: lo ha reso noto il suo servizio stampa, come
riportano i media internazionali. Lukashenko incontrerà il presidente
iraniano Ebrahim Raisi, con il quale discuterà l'attuazione di progetti nei
settori dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti e della logistica.
Durante la sua visita, Lukashenko incontrerà anche la Guida suprema dell'Iran
Ali Khamenei e alcuni alti funzionari governativi e parlamentari. I colloqui
verteranno sulla cooperazione commerciale ed economica e dovrebbero portare alla
definizione di una roadmap di cooperazione tra i due Paesi.
08:32
Russia, Patrushev:
"Dubbi che gruppi pro ucraini abbiano fatto saltare Nord Stream 2"
Il segretario del
Consiglio di Sicurezza della Federazione russa Nicolaj Patrushev ha detto in
dichiarazioni riportate da Interfax che la Russia dubita che siano stati gruppi
"pro-ucraini" a sabotare il gasdotto Nord Stream 2, come suggerisce un'inchiesta
del New York Times. Patrushev ha aggiunto che la Russia al momento non sa chi
siano i responsabili.
08:41
Xi Jinping visiterà
Mosca la prossima settimana
Fonti locali
confermano a Reuters che il presidente cinese Xi Jinping intende visitare la
capitale Russa la prossima settimana per incontrare il presidente Vladimir
Putin. Xi ha concluso oggi i lavori dell'Assemblea Nazionale con un dicorso
incentrato sulla sicurezza e la potenza dell'esercito.
09:23
Nazionalista Girkin:
"I russi hanno fallito campagna invernale"
"I russi hanno
fallito la campagna invernale in Ucraina. I successi rimangono a livello
tattico. Lo ha detto l'ex ministro della Difesa dell'autoproclamata Repubblica
del Donetsk (Dpr) Igor Girkin, soprannominato "Strelkov-il fuciliere o
sparatutto", commentando la situazione al fronte, citato dai media
ucraini. A Bakhmut, l'avanzamento delle unità Wagner è insignificante, "durante
la campagna invernale, le forze armate russe non sono state in grado di ottenere
alcun successo al di là della tattica", ha osservato Girkin. E si è detto sicuro
che la "controffensiva" delle forze ucraine a Bakhmut non avverrà.
09:45
Kiev e Wagner:
"Scontri per il controllo del centro di Bakhmut"
Si combatte
duramente per il controllo del centro di Bakhmut, la cittadina nel settore
orientale dell'Ucraina in posizione strategica e dove si combatte da mesi. La
recrudescenza degli scontri per il controllo della città è confermata
dall'esercito ucraino ("I russi avanzano da varie direzioni" verso "i quartieri
centrali"). Anche Yevgeny Prigozhin, il capo e fondatore del gruppo di mercenari
russi Wagner, in mattinata aveva detto che la situazione a Bakhmut "è molto
difficile". "Tanto più ci avviciniamo al centro, tanto più duri sono gli
scontri". Entrambi le parti considerano la conquista di Bakhmut determinante per
il futuro della battaglia nel Donbass.
09:54
Il premier polacco
accusa l'intelligence russa: "Ha corrotto il Parlamento europeo"
Non solo Qatar e
Marocco. Anche la Russia avrebbe cercato di influenzare le decisioni del
Parlamento Europeo, corrompendone alcuni dei suoi membri. Lo rivela il primo
ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista al portale i.pl e ripresa
dall'agenzia di stampa polacca Pap. Il ministero dell'Interno polacco "rivelerà
presto documenti" che mostrano come "i servizi segreti russi abbiano corrotto
membri del Parlamento europeo", ha detto il premier, aggiungendo che le
informazioni riguardavano diversi eurodeputati, ma nessuno di nazionalità
polacca.
10:26
Kirill al Papa: "Il
dialogo religioso può dare buoni risultati"
Il Patriarca della
Chiesa ortodossa russa, Kirill, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i
leader religiosi nelle sue congratulazioni a Papa Francesco per il decimo
anniversario del suo pontificato. "In questi tempi difficili, il dialogo tra i
leader religiosi può portare buoni risultati e unire le persone di buona volontà
per 'guarire le ferite'", si legge nelle congratulazioni pubblicate sul sito
della Chiesa ortodossa russa. Il capo della Chiesa russa ha assicurato che,
nelle circostanze attuali, Papa Francesco dà un contributo "significativo" come
predicatore del Vangelo e promuove l'interazione interreligiosa. "Il patriarca
Kirill - conclude la nota - ha augurato a Papa Francesco buona salute, pace
spirituale e l'aiuto interminabile di Gesù Cristo nella sua opera".
10:31
Ankara: "Ottimisti
sul rinnovo dell'accordo del grano"
C'è ottimismo ad
Ankara sulla possibilità che Russia e Ucraina estendano l'accordo che consente
il passaggio sicuro di grano ucraino attraverso il Mar Nero. E' previsto infatti
per oggi un incontro a Ginevra tra rappresentanti di Russia e Nazioni Unite.
Proprio l'Onu ha sottolineato l'importanza del dialogo, da cui dipende "il
destino di milioni di persone". Sull'incontro è intervenuto il ministro della
Difesa turco, Hulusi Akar, uno degli artefici del primo accordo siglato lo
scorso luglio, dicendosi ottimista rispetto all'eventualità di un'estensione
11:12
Cremlino, Putin
potrebbe andare a vertice G20 a New Delhi
Il presidente
russo Vladimir Putin "non esclude" di partecipare al vertice del G20 a New Delhi
in settembre, "ma la decisione non è stata ancora presa". Lo ha detto il
portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.
11:24
Cremlino: "Il Papa a
Mosca? Aspettiamo le dichiarazione del Vaticano"
"Dobbiamo aspettare
una dichiarazione del Vaticano". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov sulla possibilità di un viaggio di Papa Francesco a Mosca. Lo riferisce
l'agenzia Ria Novosti. Sabato il Pontefice aveva ribadito di essere pronto ad
"andare a Kiev, ma a "condizione di andare a Mosca". "Vado in entrambi i posti o
in nessuno dei due", aveva detto Francesco.
11:39
Cremlino: Putin
potrebbe andare al G20 in India
Il Cremlino non
esclude che il presidente russo, Vladimir Putin, possa recarsi in India per il
summit del G20 in programma a Nuova Delhi per il 9 e 10 settembre. Lo riporta
l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Non può essere escluso. La Russia
continua a partecipare a pieno titolo al formato del G20 e intende continuare a
farlo. Ma non è stata ancora presa alcuna decisione", ha detto il portavoce del
Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla partecipazione di Putin
al summit.
12:00
Il Cremlino non
conferma che il presidente cinese Xi visiterà Mosca la prossima settimana: "Vi
faremo sapere"
Il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov non ha confermato la visita del presidente cinese Xi
Jinping a Mosca la prossima settimana, aggiungendo che "al momento non ho nulla
da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ufficiali
all'estero sono coordinati simultaneamente e di comune accordo tra le parti. Vi
faremo sapere".
12:18
Cremlino sull'Oscar
al documentario "Navalny": "A Hollywood c'è politicizzazione"
"Non posso giudicare
le qualità di questo documentario perché non l'ho visto, ma mi permetto di
pensare che ci sia una certa dose di politicizzazione" nella scelta della
giuria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov,
sull'assegnazione dell'Oscar al documentario Navalny del regista canadese Daniel
Roher, dedicato all'oppositore russo. "Anche Hollywood a volte non esclude
l'elemento della politicizzazione nel suo lavoro, succede", ha sottolineato
Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.
12:41
Wall Street Journal:
Xi vuole avere incontro online con Zelensky dopo la visita a Mosca
Il presidente cinese
Xi Jinping intende avere un incontro online con il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina più di un anno
fa. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate e confermando
l'intenzione di Xi di recarsi a Mosca la prossima settimana per incontrare il
leader del Cremlino Vladimir Putin. Il colloquio online tra Xi e Zelensky
dovrebbe avvenire, scrive il Wsj, "presumibilmente dopo" la visita del
presidente cinese in Russia.
13:10
Iniziato a Ginevra
l'incontro Russia-Onu per il rinnovo dell'accordo sul grano in Ucraina
Incontro oggi a
Ginevra di alti funzionari russi e delle Nazioni Unite per discutere il rinnovo
dell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino, che scade il 18 marzo. I
colloqui si svolgono presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra e la
delegazione russa è guidata dal vice ministro degli Esteri Sergei Verchinin. Ai
colloqui dovrebbe partecipare anche il Segretario generale della Conferenza
delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), Rebeca Grynspan. La
rappresentanza russa alle Nazioni Unite ha confermato l'inizio dell'incontro
poco dopo l'arrivo di Griffiths.
La scorsa settimana,
il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov ha definito "complicati" i
negoziati per estendere l'accordo che ha permesso la ripresa delle esportazioni
di grano ucraino nonostante l'invasione del Paese. L'accordo, vitale per le
forniture alimentari globali, ha finora permesso l'esportazione di oltre 24
milioni di tonnellate di grano dai porti ucraini, secondo le Nazioni Unite.
La scorsa settimana
l'Ucraina ha chiesto sforzi internazionali per mantenere aperte le rotte del Mar
Nero utilizzate per il trasporto del grano e il Segretario di Stato americano
Antony Blinken ha dichiarato al G20 di inizio marzo che la Russia dovrebbe
rinnovare l'accordo. La Russia, da parte sua, sostiene che la parte dell'accordo
che avrebbe dovuto consentirle di esportare fertilizzanti senza sanzioni
occidentali non viene pienamente rispettata.
13:44
Il regista Lisovsky
ha lasciato la Russia dopo due arresti
Il regista teatrale
e drammaturgo Vsevolod Lisovsky ha lasciato la Russia dopo essere stato
arrestato due volte per 15 giorni con l'accusa di "mancato rispetto di ordini
della polizia": lo ha riferito la figlia Eva alla testata online Meduza. A
maggio e a settembre, Lisovsky era stato fermato due volte durante uno
spettacolo basato sull'opera teatrale "Terrore e miseria del terzo Reich" di
Bertolt Brecht. Al regista, che ha vinto due volte il premio del teatro russo
"Maschera dorata", a novembre era stata inoltre inflitta una multa di
50mila rubli (circa 600 euro) con l'accusa di "discredito" delle forze armate
per una pubblicazione su internet contro la guerra in Ucraina.
14:18
L'ex colonnello
russo Igor Girkin: "L'avanzata russa a Bakhmut è insignificante"
"L'avanzata delle
unità Wagner e delle forze russe a Bakhmut è stata insignificante". È quanto
scrive sul proprio canale Telegram l'ex colonnello russo in pensione Igor
Girkin, commentando la situazione al fronte. Lo riporta Unian. "Per quanto
riguarda il 'contrattacco' ampiamente pubblicizzato dalle forze armate ucraine
vicino alla città", aggiunge Girkin, "sono praticamente certo che si tratti di
una 'bufala', altrimenti non sarebbe stata annunciata al mondo dai comandanti
militari ucraini". Secondo Girkin, una controffensiva è inutile per l'Ucraina,
che ha "già saldamente in mano metà di Bakhmut" e la loro è stata una riuscita
"battaglia di logoramento e di guadagno di tempo".
14:44
Kiev: razzi contro
scuola, morta una donna nel Donetsk
Le forze russe hanno
lanciato razzi contro una scuola ad Avdiivka, nel Donetsk, e una residente
locale è stata uccisa. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'ufficio del
Presidente, Andriy Yermak, scrive Ukrinform. "I russi hanno sparato due razzi
contro la scuola di Avdiivka. Una donna del posto è morta", ha scritto Yermak.
15:09
Russia: verso
l'aumento dell'età del servizio di leva fino a 30 anni
Alla Duma - il ramo
basso del Parlamento russo - è stato presentato un disegno di legge che prevede
di spostare l'età della chiamata al servizio di leva dalla fascia 18-27 anni a
quella 21-30 anni. Ma mentre l'età massima verrebbe portata subito a 30 anni,
quella minima verrebbe fatta salire solo gradualmente dai 18 ai 21. Di
conseguenza, stando a una griglia pubblicata da Novaya Gazeta Europa, nel 2024
potrebbero essere chiamati alle armi uomini dai 19 ai 30 anni, nel 2025 dai 20
ai 30 anni e solo nel 2026 dai 21 ai 30 anni. Nei due anni di transizione in
pratica sarebbero chiamabili più classi di leva del consueto. In ogni caso,
stando alla proposta di legge, i cittadini maggiorenni che volessero prestare
servizio prima dei 21 anni potranno farlo. Gli autori del disegno di legge
affermano di voler "garantire che i cittadini ricevano sia un'istruzione
secondaria generale che un'istruzione secondaria professionale o superiore".
15:31
Ucraina: Onu
conferma 8 mila civili morti e 14 mila feriti
Il numero confermato
di vittime civili della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina, tra morti e
feriti, è di 21.965, lo ha dichiarato oggi l'Ufficio delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani. Il numero di civili uccisi è di 8.231, mentre il numero di feriti
tra la popolazione non militare è di 13.734, anche se ancora una volta è stato
sottolineato che queste cifre sono conservative e includono solo i casi che sono
stati documentati utilizzando la rigorosa metodologia utilizzata dalle Nazioni
Unite in situazioni di questo tipo. L'agenzia, che segue le vittime civili
dall'inizio dell'invasione russa, ha indicato che la maggior parte delle vittime
(6.372) è stata registrata nelle aree controllate dal governo ucraino, dove
11.247 persone sono rimaste ferite negli attacchi. Nel frattempo, 4.346 persone
(1.859 morti e 2.487 feriti) sono state vittime della guerra nelle regioni
ucraine occupate dai russi. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, marzo
2022 è stato il mese in cui sono stati uccisi più civili in questa guerra, e da
allora la tendenza è in calo. La principale causa di morte è la detonazione di
armi esplosive ad ampio raggio, seguita da mine e residuati bellici.
15:39
Russia: iniziato il
processo contro l'oppositore Kara-Murza
E' iniziato in
Russia il processo a porte chiuse contro l'oppositore Vladimir Kara-Murza,
accusato di "alto tradimento" e di altri reati in un procedimento penale
ritenuto di palese matrice politica: lo riporta l'Afp. Secondo Radio Liberty,
Kara-Murza, figura di spicco dell'opposizione, rischia fino a 24 anni di
reclusione. Il 41enne dallo scorso aprile si trova in carcere perché accusato di
diffusione di "informazioni false" sull'esercito russo sulla base di una nuova
legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni
sulle forze armate che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità.
15:45
Tajani, molti
migranti da zone controllate da Wagner
"La questione
immigrazione non può essere soltanto un tema italiano": lo ha detto il ministro
degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro con il premier Benjamin
Netanyahu a Gerusalemme. "Ho trovato - ha aggiunto - grande comprensione per
quello che sta accadendo in Italia riguardo all'immigrazione da parte di
Netanyahu". Il ministro ha poi sottolineato "la preoccupazione" sul fatto che
"molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci
fosse un tentativo di spingere migranti verso l'Italia".
15:50
Putin vede
Kadyrov,"grazie per contributo tuoi soldati"
Il presidente
russo, Vladimir Putin, ha ricevuto al Cremlino il leader ceceno, Ramzan Kadyrov,
lodando l'operato dei suoi soldati in Ucraina. "Vedo come i tuoi uomini stanno
combattendo nella zona dell'operazione militare speciale. A loro vanno le nostre
parole migliori, grazie mille da parte nostra", ha detto Putin. Da parte sua
Kadyrov ha assicurato a Putin che i soldati ceceni non lo deluderanno. "Non ho
dubbi", ha risposto il leader russo.
16:26
Sindaco Melitopol,
Wagner recluta residenti per battaglia a Bakhmut
Il gruppo mercenario
Wagner ha iniziato a reclutare i residenti di Melitopol, nella regione di
Zaporizhzhia, per combattere a Bakhmut. Lo afferma il sindaco ucraino Ivan
Fedorov, alla tv nazionale ucraina, come riporta il Kyiv Indipendent. Fedorov,
che si trova nel territorio controllato dall'Ucraina e riferisce in base a fonti
in città, ha detto che le truppe russe stanno offrendo ai residenti di Melitopol
200mila rubli (circa 2.480 euro) al mese per combattere per Mosca a Bakhmut.
16:45
Mosca, "due donne
uccise in bombardamento ucraino nel Donetsk"
Due donne sono
rimaste uccise e una ragazza di 14 anni ferita in un bombardamento ucraino
avvenuto oggi pomeriggio nella regione di Donetsk. Lo riferisce l'agenzia
russa Ria Novosti citando il locale Comitato investigativo russo. Alcuni razzi
lanciati dalle forze ucraine, precisa la fonte, si sono abbattuti su Volnovakha,
un centro situato una cinquantina di chilometri a sud del capoluogo Donetsk,
considerata strategica perché qui passano la strada principale e la ferrovia che
dalla stessa Donetsk portano verso Mariupol, sulla Costa del Mar d'Azov. Un
giornalista della Ria Novosti sul posto ha detto che è stato colpito anche un
edificio dove si trova un supermercato.
16:47
Consiglio Ue
proroga sanzioni alla Russia
Il Consiglio Ue ha
deciso oggi di prorogare per altri sei mesi, fino al 15 settembre 2023, le
misure restrittive nei confronti dei responsabili di aver minato o minacciato
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure
esistenti prevedono restrizioni di viaggio per le persone fisiche, il
congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o altre risorse economiche a
disposizione delle persone ed entità elencate. Le sanzioni continueranno ad
essere applicate a 1.473 persone fisiche e 205 entità, molte delle quali sono
state prese di mira in risposta all'aggressione militare ingiustificata e non
provocata della Russia contro l'Ucraina.
17:07
Russia: "tentò
incendiare centro reclute", 8 anni reclusione
Un tribunale
militare russo ha condannato a otto anni di reclusione un abitante di Uglich -
città di 35.000 abitanti nella regione di Yaroslavl - con l'accusa di aver
tentato di incendiare un centro di reclutamento: lo scrive il quotidiano
Kommersant citando l'ufficio stampa dei servizi di sicurezza russi (Fsb).
Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato arrestato lo scorso luglio
vicino a un centro di reclutamento con diverse bottiglie molotov. Due settimane
fa un tribunale militare russo ha condannato a sette anni di reclusione un
giovane di 21 anni di Vladivostok, nell'estremo oriente russo, con l'accusa di
aver incendiato a giugno un ufficio di reclutamento.
17:10
Mosca, estensione
accordo sul grano solo per 60 giorni
Mosca è favorevole a
prolungare l'accordo per l'esportazione del grano dai porti ucraini sul Mar Nero
ma "solo per 60 giorni". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Vershinin,
che ha guidato la delegazione russa ai colloqui a Ginevra con rappresentanti
dell'Onu. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Un'estensione di più lungo
periodo,
ha aggiunto
Vershinin, potrà essere presa in considerazione da Mosca se verranno tolti gli
ostacoli alla sua esportazione di prodotti agricoli. Fino ad oggi, ha
sottolineato il vice ministro, la revoca delle sanzioni su questi prodotti
annunciata dagli Usa, dalla Ue e dalla Gran Bretagna, non sta funzionando.
17:44
Media, Cpi pronta a
mandati d'arresto per crimini guerra
La Corte penale
internazionale sta programmando la richiesta di arresto di funzionari russi per
la deportazione forzata di bambini dall'Ucraina e per aver preso di mira le
infrastrutture civili, in quelli che sarebbero i primi casi di crimini di guerra
derivanti dall'invasione di Mosca. Lo riporta il sito di Reuters citando una non
precisata fonte.
La fonte ha
affermato che i mandati di arresto potrebbero includere il reato di genocidio e
dovrebbero arrivare a "breve termine" se approvati da un giudice delle indagini
preliminari presso il tribunale dell'Aja
18:15
Gruppo Wagner,
vicini a interrompere forniture Kiev a Bakhmut
Le forze russe
a Bakhmut sono a tre chilometri dalla ferrovia che porta rifornimenti alle
truppe ucraine. Lo afferma un combattente del battaglione Wagner, come
riporta Ria Novosti. Le forze si stanno avvicinando alla ferrovia e presto
riusciranno a interrompere le forniture che dall'esterno arrivano ai soldati
ucraini. Il combattente ha aggiunto che le forze russe stanno avanzando a
nord-ovest della cittadina.
18:28
Russia: iniziato
processo a Kara-Murza, oppositore si dichiara innocente
E' iniziato oggi in
un tribunale di Mosca il processo all'oppositore Vladimir Kara-Murza. L'uomo
rischia una condanna fino a 20 anni di carcere per "tradimento" e "diffusione di
notizie false sull'esercito". Kara-Murza, come spiegato dalla sua legale Maria
Eismont a Ria Novosti, si è dichiarato non colpevole. La prossima udienza si
terrà il 16 marzo.
18:37
Germania, completato
addestramento soldati ucraini su Leopard
Dopo diverse
settimane di addestramento intensivo in Germania, i soldati ucraini sono ora
pronti a usare i carri armati Leopard 2 in combattimento. Come riportano i media
tedeschi, alla fine del loro corso, gli equipaggi si sono esercitati in manovre
di attacco e ripiegamento, con munizioni vere, nell'area di addestramento
militare di Bergen in Bassa Sassonia. Dopo l'addestramento, gli esercizi sul
simulatore, l'addestramento al combattimento sul campo e il tiro al bersaglio,
gli equipaggi sono ora pronti per condurre scontri a fuoco in modo indipendente
con il moderno sistema d'arma, ha spiegato il generale di brigata Björn Schulz,
comandante della scuola di truppe di carri armati a Munster, in Bassa Sassonia.
19:20
Prigozhin insulta
Crosetto, "non ci occupiamo di migranti"
"Crosetto dovrebbe
guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi problemi, che
probabilmente non è riuscito a risolvere. Noi non siamo al corrente di ciò che
sta succedendo con la crisi migratoria, non ce ne occupiamo, abbiamo un sacco di
problemi nostri di cui occuparci". Lo afferma il capo della Wagner Yevgeny
Prigozhin, rispondendo al ministro della Difesa, che ha accusato la compagnia
privata russa di attuare una 'guerra ibrida' favorendo la migrazione dai Paesi
africani dove è presente. Prigozhin definisce Crosetto 'mudak', un termine che
in russo corrisponde a un pesante insulto.
19:38
Casa Bianca, abbiamo
incoraggiato Xi a contattare Zelensky
Gli Usa hanno
incoraggiato il leader cinese Xi Jinping a contattare il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza
nazionale Jake Sullivan ai reporter al seguito di Joe Biden.
20:19
Kiev: "Decisione
russa su export grano contraddice accordo"
Il ministro ucraino
delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, ha criticato la decisione annunciata
dal governo russo di prorogare l'accordo sull'export di grano solo per 60
giorni, sostenendo che sia contraria ai termini dell'intesa. "L'accordo prevede
almeno 120 giorni di estensione, quindi la posizione della Russia di prorogare
l'accordo solo per 60 giorni contraddice il documento firmato dalla Turchia e
dalle Nazioni Unite", ha dichiarato su Twitter Kubrakov, aggiungendo che "stiamo
aspettando la posizione ufficiale delle Nazioni Unite e della Turchia in quanto
garanti dell'iniziativa".
20:49
Ucraina: potranno
rimanere negli Usa rifugiati arrivati un anno fa
L'Amministrazione
Biden consentirà alle migliaia di rifugiati ucraini, che hanno lasciato il Paese
all'indomani dell'invasione russa, di rimanere negli Stati Uniti. Lo ha
annunciato il dipartimento per la Sicurezza interna, in vista della scadenza dei
permessi accordati un anno fa, all'inizio della guerra. L'estensione del
permesso si rivolge ai cittadini ucraini e ai loro famigliari più stretti che
fecero ingresso negli Usa prima dell'avvio del programma 'Uniting for Ukraine',
che invece garantisce un permesso di due anni. L'ingresso dei primi rifugiati
ucraini, all'indomani dell'invasione, venne invece accordato in base a un
provvedimento di emergenza, il cosiddetto 'humanitarian parole', che garantisce
la permanenza negli Usa solamente per un anno e che è già stato impiegato in
passato per altre emergenze umanitarie.
21:03
Zelensky, a Bakhmut
e nell'est si sta decidendo il nostro futuro
"Come sempre oggi
sono stato in contatto con i nostri comandanti. E' molto duro a est, molto
doloroso. Dobbiamo distruggere il potere militare del nemico e lo distruggeremo.
Belogorivka e Maryinka, Avdiivka e Bakhmut, Vugledar e Kamianka e tutti gli
altri luoghi in cui ora si sta decidendo quale sarà il nostro futuro. Dove si
combatte per il nostro futuro". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky nel suo consueto messaggio serale. "Ringrazio tutti coloro che
attualmente stanno combattendo! Grazie a tutti coloro che difendono le loro
posizioni e combattono per l'Ucraina e i loro fratelli! Grazie a tutti coloro
che non deludono mai qualcuno in una posizione! Oggi vorrei menzionare in
particolare i combattenti della 92a brigata meccanizzata separata per le loro
azioni di successo nell'area di Bakhmut. Grazie ragazzi! Gloria a tutti i
soldati ucraini! Gloria al nostro popolo indomabile e bello! Gloria
all'Ucraina!", aggiunge Zelensky.
21:13
Ucraina: telefonata
Austin-Reznikov, focus su nuovo Gruppo contatto
Il segretario alla
Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo
ucraino, Oleksii Reznikov, riguardante le priorità per il Gruppo di contatto per
l'Ucraina del 15 marzo. Austin, riferisce il Pentagono, ha fornito un
aggiornamento sugli aiuti militari Usa a Kiev, mentre il ministro Reznikov ha
fornito dettagli sui recenti sviluppi sul terreno in Ucraina.
21:46
Sullivan: "Biden
avrà colloquio con Xi"
Il presidente degli
Stati Uniti Joe Biden "avrà una conversazione" con il leader cinese Xi
Jinping nel prossimo periodo. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza
nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Non posso darvi una data. Perché
non c'è una data fissata, ma il presidente Biden ha indicato la sua
disponibilità ad avere un colloquio telefonico con il presidente Xi", ha detto
Sullivan.
21:52
Zelensky, 170mila
chilometri quadrati Paese coperti da mine
"Oggi abbiamo
parlato anche di sminamento, cosa di vitale importanza, in senso letterale. Ad
oggi, più di 170mila chilometri quadrati del nostro territorio rimangono
pericolosi a causa di mine nemiche e proiettili inesplosi. Una parte
significativa di questo territorio è la terra dei nostri contadini, la terra che
veniva coltivata. Quindi oggi abbiamo discusso su come intensificare questo
lavoro: accelerare lo sminamento e aumentare la cooperazione pertinente con i
partner". Lo afferma il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, nel suo consueto
discorso serale.
Punire le atrocità. Il
tribunale dell’Aia è pronto a condannare la Russia per i crimini di guerra.
Linkiesta il
13 marzo 2023.
Secondo le fonti del New York
Times, il Cremlino dovrà presto rispondere degli attacchi deliberati alle
infrastrutture civili e delle migliaia di bimbi e ragazzi deportati nei campi di
“rieducazione”
L’imputazione è crimini di
guerra. Il Tribunale penale internazionale è (finalmente) pronto ad aprire due
casi contro i russi coinvolti nelle atrocità commesse in Ucraina. Per i
responsabili sarà spiccato un mandato d’arresto. Il Cremlino dovrà rispondere
delle deportazioni di bambini e adolescenti, costretti alla «rieducazione», e di
aver deliberatamente bombardato le infrastrutture civili dell’Ucraina. Lo rivela
il New York Times, da fonti interne alla Corte con sede all’Aia, in Olanda.
La svolta arriva dopo mesi di
lavoro sul campo da parte di una squadra investigativa speciale, incaricata di
raccogliere le prove. Se quanto scrive il giornale americano sarà confermato, il
procuratore capo Karim Khan dovrà prima sottoporre le accuse ai magistrati in
una sorta di udienza preliminare, che verificherà ci siano le basi per emettere
gli ordini di cattura. Alla richiesta di una conferma, l’ufficio del magistrato
ha risposto così al Times: «Non discutiamo pubblicamente i dettagli sulle
indagini in corso».
Un’ipotesi è che venga
incriminato il mandante dell’invasione, Vladimir Putin. La Corte, infatti, non
riconosce l’immunità ai capi di Stato nei casi su crimini di guerra, contro
l’umanità o genocidio. La possibilità e i tempi di un processo restano però
un’incognita, perché il tribunale richiede la presenza dell’imputato e non è
verosimile che la Russia consegni i suoi comandanti e ufficiali.
Da mesi, le indagini
internazionali e quelle ucraina hanno documentato i crimini di guerra delle
truppe della Federazione. Solo Kyjiv, attraverso il magistrato Andriy Kostin, ne
ha denunciati più di sessantacinquemila dall’inizio del conflitto. Per la prima
accusa, la rieducazione coatta, sono state le stesse autorità russe ad ammettere
l’esistenza del programma, che spacciano per una missione umanitaria. È
accertato il trasferimento illegale di più di seimila minorenni in quarantatré
strutture, ma secondo gli ucraini in totale i rapiti sarebbero oltre sedicimila.
Anche nel secondo caso, è la
cronaca degli scorsi mesi a inchiodare i comandi militari. La scriteriata guerra
totale contro la popolazione ucraina ha colpito acquedotti e centrali
elettriche, che non sono considerati – né considerabili – obiettivi bellici
leciti. In particolare, l’amministrazione americana disporrebbe di materiale
secretato, ma non è ancora certo se o quando la Casa Bianca accetterà di
trasmetterlo ai giudici (per non aprire un precedente, pare, per le presunte
violazioni degli Stati Uniti nei teatri di guerra dell’ultimo trentennio).
In passato, ci sono voluti
mesi prima che la revisione delle accuse si traducesse nei mandati d’arresto.
Kyjiv non fa (ancora) parte del Tribunale, ma le è riconosciuta giurisdizione
sul suo territorio. Più di quaranta Paesi hanno chiesto all’Aja di intervenire.
La situazione in Ucraina, dove centinaia di cittadini della nazione in armi
continuano a morire per respingere gli attacchi brutali e ostentatamente
irrispettosi del diritto internazionale della Russia, dovrebbe essere un
incentivo a sveltire le lungaggini burocratiche.
Le difficoltà della Corte
penale internazionale nel perseguire i crimini di guerra in Ucraina.
YOUSSEF HASSAN
HOLGADO su Il Domani il 14 marzo 2023
Il procuratore capo della
Corte penale internazionale, Karim Khan, chiederà ai giudici preliminari di
approvare i mandati di arresto nei confronti di diversi soldati ucraini. Ma non
sarà facile dato che la Russia non li consegnerà all’Aja e i processi non
possono essere celebrati in contumacia
A poco più di un anno
dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la Corte penale internazionale ha
deciso formalmente di incriminare una serie di soldati russi accusati di essere
i responsabili di rapimenti di massa e deportazioni di bambini ucraini.
Oltre della deportazione dei
minori i soldati russi sono accusati anche di aver attaccato deliberatamente le
infrastrutture civili come ospedali, cliniche sanitarie, scuole, asili,
università e musei.
Non è conosciuta l’identità
dei soldati russi accusati dei crimini. Il procuratore capo della Corte penale
internazionale, Karim Khan, chiederà ai giudici preliminari di approvare i
mandati di arresto sulla base delle prove raccolte finora e in caso positivo si
tratterebbe delle prime misure cautelari emanate contro membri dell’esercito
russo dall’inizio della guerra iniziata il 24 febbraio del 2022.
LE DIFFICOLTÀ
Tuttavia, non sarà semplice
per la Corte penale internazionale processare i responsabili. Ci sono due
ostacoli principali: primo fra tutti il fatto che la Russia (così come
l’Ucraina) non aderisce allo statuto della Corte. Non ne fa parte e quindi non
consegnerà i suoi soldati ai giudici dell’Aja. In caso di processo e di
condanna, per la Russia equivarrebbe ammettere di essersi macchiata di crimini
di guerra, accuse che finora sono state sempre respinte.
La seconda difficoltà deriva
invece dal fatto che la Corte non esegue processi in contumacia e quindi senza
la presenza in aula degli imputati, non possono essere celebrati.
LE ACCUSE DI DEPORTAZIONI
Accuse di deportazioni sono
state formulate da più indagini indipendenti. Il mese scorso un report
preliminare, risultato di un’indagine condotta dall’Humanitarian research lab
della Yale School of public health, ha denunciato la creazione di un sistema di
rieducazione che coinvolge migliaia di minori ucraini. Attraverso una rete di 43
strutture – situate nei territori ucraini occupati e in Siberia – il governo
russo starebbe procedendo alla rieducazione politica di almeno 6mila bambini
ucraini di età compresa tra 4 mesi e 17 anni.
La maggior parte delle
famiglie ha pochissime informazioni sullo stato e l’ubicazione dei propri figli,
in alcuni casi sottoposti anche a pratiche simili all’addestramento militare,
specie nei campi della Crimea occupata e della Cecenia. D’altronde, è stata la
stessa commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini, Maria
Lvova-Belova, ad ammettere che 350 bambini sono stati adottati da famiglie russe
e oltre mille sono in attesa di sistemazione.
L’INIZIO DELL’INDAGINE DELLA
CPI
Lo scorso 2 marzo 2022 la
Corte penale internazionale ha deciso di aprire un’indagine per crimini di
guerra in Ucraina. La decisione è stata presa dal procuratore capo Khan dopo il
suo viaggio nei luoghi in cui sono stati perpetrati crimini di guerra di massa
come Bucha, frazione a nord di Kiev, dove dopo la liberazione dei soldati
ucraini dall’occupazione russa sono state trovate fosse comuni e corpi di civili
deceduti per strada con le mani legate dietro la schiena. Per gli ucraini si
tratta di esecuzioni a sangue freddo in violazione del diritto internazionale.
Nell’ultimo anno Khan si è
recato in Ucraina almeno tre volte per discutere con la procura locale su come
aiutare gli inquirenti a raccogliere materiale probatorio per poter incriminare
i soldati rei di aver commesso crimini di guerra. Diversi stati tra cui Italia,
Francia, Regno Unito hanno inviato squadre della polizia scientifica a supporto
delle autorità ucraine. Anche il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite
ha avviato una sua indagine sul territorio.
Si cerca di capire quale sia
il ruolo dell’amministrazione americana di Joe Biden, divisa sulla possibilità
di inviare propri documenti all’Aja per evitare di creare un precedente su
un’indagine nei confronti di uno stato che non faccia parte dello statuto. La
paura è che anche i soldati americani possano essere perseguiti per i crimini
condotti in medio oriente.
In totale, la procura generale
ucraina ha affermato di aver raccolto prove riguardanti circa 70mila casi di
violazioni. Anche diverse Ong europee stanno assistendo le autorità di Kiev,
soprattutto per catalogare e conservare il materiale raccolto all’interno degli
archivi digitali. Qui, la difficoltà maggiore è prevedere i progressi
tecnologici che potrebbero influenzare l’accesso ai documenti in futuro.
YOUSSEF HASSAN HOLGADO.
Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di
Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso.
Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e
questioni sociali.
I migranti ce li manda la
Russia. Crosetto accusa la Wagner: “Guerra ibrida”.
Pietro De Leo su Il Tempo il
14 marzo 2023
C’è una leva geopolitica a
muovere l’enorme afflusso di migranti verso l’Italia. Rischi tangibili circa il
movimento indotto di masse umane verso l’Europa come elemento destabilizzante
erano già stato prefigurati all’inizio dell’invasione in Ucraina. La Russia,
infatti, è uno dei «nuovi attori» egemonici nel continente africano, che divide
il primato del protagonismo con la Cina. La Wagner, società privata paramilitare
russa guidata da un imprenditore tra i più vicini a Putin, Evgenij Prigozhin,
oltre ad essere attiva nell’Ucraina Orientale ha avuto un ruolo anche nei
rivolgimenti politici nella fascia del Sahel. E dunque, di fronte a nuovi,
drammatici numeri sugli arrivi in Italia (dal primo gennaio alla giornata di
ieri, dati del Viminale, è stata toccata quota 20.017, oltre tre volte gli
arrivi dello scorso anno, 6.152 nel periodo omologo). Di un collegamento tra gli
sbarchi e l’eventualità di una iniziativa russa per propiziarli si parla
esplicitamente anche nel governo al termine della riunione a Palazzo Chigi tra
il premier Meloni, i vertici dell’Intelligence e i ministri Crosetto,
Piantedosi, Tajani e Salvini, questi ultimi due in videocollegamento. Il
ministro degli Esteri sottolinea che «molti migranti arrivano da aree
controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingerli
verso l’Italia». Posizione analoga esprime il titolare della Difesa Guido
Crosetto: «Mi sembra che oramai si possa affermare che l’aumento esponenziale
del fenomeno migratorio, che parte dalle coste africane sia anche, in misura non
indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione
Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso
rilevante in alcuni Paesi africani».
E sposta, Crosetto,
l’attenzione su Alleanza Atlantica e Ue: «Ue, Nato e Occidente sarebbe opportuno
capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più
pericoloso. Dovrebbero prendere atto che l’immigrazione incontrollata e
continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i
Paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e
nette». Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, risponde con un audio su Telegram:
«Non abbiamo idea di cosa stia accadendo in merito alla crisi dei migranti, ma
noi non ce ne occupiamo», ha detto Prigozhin, utilizzando poi per l’esponente
del governo italiano il termine russo «Mudak», un pesante insulto. La
disperazione come arma. Espediente cinico già visto, purtroppo. Dalla Turchia di
Erdogan alla Bielorussia di Lukashenko fino alla Cirenaica di Haftar. Alzare il
prezzo con moneta umana.
Che l’Africa sia al centro di
tutto questo lo ha confermato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:
«In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia
coscienza è a posto. Forse sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia -
ha detto presentando il libro di Padre Antonio Spadaro - lasciare che siano dei
mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi, lasciare che arrivi da noi solo chi
ha soldi per pagare quei mafiosi, lasciare che in Africa continuino a prendere
piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti». Alla riunione di ieri a
Palazzo Chigi si è parlato anche di un coordinamento maggiore per la
sorveglianza marittima per individuare i barconi che trasportano i migranti in
acque extraterritoriali. Coinvolgendo, dunque, la Marina Militare.
Guerra Ucraina, Yevgeny
Prigozhin insulta Crosetto: non ci occupiamo di migranti. Il Tempo il 13
marzo 2023
Botta e risposta tra Guido
Crosetto e Yevgeny Prigozhin. I migranti scatenano il putiferio tra il governo
italiano e la Brigata Wagner. Il nostro ministro della Difesa ha accusato i
mercenari russi di favorire le migrazioni dalle zone controllate verso l'Italia.
Accuse che sono state rispedite al mittente da Yevgeny Prigozhin in malo modo.
Con tanto di insulti. Il capo del gruppo Wagner ha risposto con un audio su
Telegram al ministro Crosetto che aveva parlato dell’aumento del fenomeno
migratorio dalle coste africane come parte di una «strategia di guerra ibrida»
messa in atto dalla stessa Wagner, presente in vari Paesi dell’Africa. «Non
abbiamo idea di cosa stia accadendo in merito alla crisi dei migranti, ma noi
non ce ne occupiamo», ha detto Prigozhin, utilizzando poi per l’esponente del
governo italiano il termine russo "Mudak", un pesante insulto.
Ma qual è la situazione delle
migrazioni dal nord Africa verso l'Europa? Libia, Sudan, Mozambico, Repubblica
centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Mali: sono tutti i Paesi dove
si è fatta più forte ed estesa la presenza dei mercenari del gruppo Wagner, che
il Cremlino usa «per eliminare l’influenza occidentale dal continente africano».
E «per raggiungere i suoi obiettivi senza fare grandi investimenti, continuando
a negare la sua presenza», spiega all’Adnkronos Brian Jenkins, esperto del think
tank americano Rand Corporation. Nella Repubblica centrafricana, ricca di
depositi di oro e diamanti, si contano poco meno di duemila mercenari russi,
schierati con il governo nella guerra civile in corso. In Libia si parla di
1-2mila miliziani, schierati a sostegno dell’uomo forte della Cirenaica, Khalifa
Haftar. Il loro numero che si è ridotto negli ultimi mesi dopo che Mosca ha
richiamato buona parte dei mercenari per ridispiegarli in Ucraina. In Mali, dove
la giunta ha costretto i francesi a lasciare il Paese, si conterebbero centinaia
di combattenti del gruppo fondato da Eveghny Prigozhin, oligarca vicino a
Vladimir Putin. In Sudan, Wagner si è assicurato il business delle concessioni
delle miniere di diamanti, in Mozambico, un mese prima del dispiegamento dei
miliziani nel settembre del 2019, la Russia ha firmato accordo sulle risorse
minerarie, l’energia e la difesa. Il gruppo è arrivato fino in Burkina Faso,
dove, secondo le accuse del presidente del Ghana Nana Akufo-Addo, «una miniera
sarebbe stata concessa al gruppo come forma di pagamento per i loro servizi».
Nella Repubblica democratica del Congo, nella crisi tra Kinshasa e il gruppo
filoruandese M23 i mercenari russi sarebbero schierati con l’esercito congolese,
che ha invece negato la loro presenza.
Profondo russo. Putin manda
a morire a Bakhmut i mercenari della Wagner per indebolire Prigozhin.
Linkiesta il 13
marzo 2023.
Secondo una analisi
dell’Institute for Study of War, il ministero della difesa russo sta
risparmiando i soldati regolari nella più dura battaglia di logoramento della
guerra per indebolire le mire del suo fondatore, considerato un possibile
successore del dittattore
Siccome non riesce a vincere
la guerra, Vladimir Putin manda al massacro i soldati del suo possibile
successore per evitare un colpo di stato. Stando a una analisi dell’Institute
for Study of War, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e il capo di
stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov stanno inviando senza sosta i
mercenari del gruppo Wagner a Bakhmut, città del Donetsk dove finora sono morti
circa mille soldati russi in una sola settimana.
Secondo l’ISW, l’invio dei
mercenari Wagner sarebbe un modo per indebolire le mire del suo fondatore
Yevgeny Prigozhin, l’ex “cuoco” di Putin, che dall’inizio della guerra cerca di
ritagliarsi la figura dell’uomo forte e possibile successore del dittatore
russo. Nelle ultime settimane il ministero della Difesa ha limitato la capacità
di Prigozhin di reclutare detenuti e procurarsi munizioni, costringendo il capo
della Wagner a riconoscere pubblicamente la sua dipendenza dal governo.
Lo stesso Prigozhin ha
minacciato di ritirare le forze della Wagner da Bakhmut e ha insinuato che il
ministero della Difesa russo abbia utilizzato il suo esercito di mercenari per
risparmiare l’esercito regolare nella battagglia di logoramento ad alta
intensità per impadronirsi della città ucraina. Questa minaccia, secondo l’ISW
indicano che Prigozhin è consapevole della gravità del suo conflitto con il
ministero della Difesa.
Prigozhin probabilmente
prevedeva che le forze ucraine si sarebbero ritirate completamente da Bakhmut
per paura di un imminente accerchiamento e sperava che il suo impegno con le
forze d’élite di Wagner sarebbe stato sufficiente a generare quell’effetto. Ma
così non è stato e la città è ancora contesa.
Lo Stato Maggiore
dell’esercito ucraino ha comunicato che Kyjiv ha respinto 102 attacchi delle
forze armate russe non solo a Bakhmut, ma anche Avdiivka, Limansk, Maryinka e
Shakhtarsk.
La Repubblica. Jet
russo colpisce drone Usa sul Mar Nero. Mosca: "Caduto da solo per manovra
brusca". Putin: "Uno Stato dietro gli attacchi al Nord Stream"
Il Pentagono: "Atto
pericoloso dei russi". Il Cremlino: "Non riconosciamo la Corte penale
internazionale". La Duma estende il reato di discredito delle forze armate anche
ai mercenari della Wagner
"Dobbiamo
distruggere il potere militare del nemico e lo distruggeremo. A Belogorivka,
Maryinka, Avdiivka, Bakhmut, Vuhledar e Kamianka si sta decidendo quale sarà il
nostro futuro. Qui si combatte per il nostro futuro". Così ha parlato il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto che "al momento, più di
170mila chilometri quadrati del territorio dell'Ucraina rimangono pericolosi a
causa delle mine e dei proiettili nemici che non sono esplosi".
Il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov ha commentato questa mattina le indiscrezioni su
possibili mandati di cattura della Corte penale internazionale contro esponenti
russi, dicendo che il Paese "non riconosce" la corte dell'Aia.
Punti chiave
20:10
Pentagono: "Il jet
russo probabilmente danneggiato nella collissione"
19:57
Comando americano in
Europa: "Il drone non è stato recuperato"
19:45
Russia: "Drone
americano si stava avvicinando al nostro confine, ma è caduto da solo per
manovra brusca"
19:41
Usa convocano
ambasciatore russo per incidente drone
18:15
Putin, gli attacchi
al Nord Stream condotti da uno Stato
18:11
Ucraina: jet russo
si scontra con drone Usa sul Mar Nero
18:10
Pentagono, il jet
russo ha colpito l'elica del drone Usa
17:30
Media, "incidente"
per drone occidentale sul Mar Nero
14:57
Putin: "Combattiamo
per la sopravvivenza dello Stato russo"
12:09
Georgia:
anti-europeisti tolgono da Parlamento bandiera Ue
11:49
La Duma estende il
reato di discredito delle forze armate anche alla Wagner
10:16
Lavrov critica
l'accordo Aukus: "Gli anglosassoni tramano anni di scontri in Asia"
09:49
Ucraina, un civile
ucciso a Kramatorsk nel corso di un raid russo
09:46
Ucraina, Berlino: "I
caccia sul fianco est della Nato sono stati dispiegati 27 volte da Agosto"
09:19
Russia, Peskov: "Non
riconosciamo la giurisdizione della Corte Penale Internazionale"
23:41
Parolin: "Santa Sede
sta dando fondo a sua creatività diplomatica"
"La Chiesa ha un
approccio diverso da quello dei singoli stati, ha una visione universalistica e
vuole lavorare concretamente per la pace. Stiamo dando fondo a tutta la nostra
creatività per trovare una via ma il primo passo deve essere il cessate il
fuoco". Così il Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin a
margine del colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sede
della rivista La Civiltà Cattolica a Roma. "Il Papa vuole andare in entrambe le
capitali. Lo ha detto fin dall'inizio. Ritiene che il servizio alla pace può
essere fatto solo se incontrerà il presidente Putin e il presidente Zelensky",
ha aggiunto.
00:04
Zelensky: "Futuro
dipende da esito battaglie nell'Est"
Il futuro
dell'Ucraina dipende dall'esito delle battaglie cruciali in corso nell'Est del
Paese.
Lo ha affermato il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo tradizionale discorso serale. "È
molto dura a est, molto dolorosa. Dobbiamo distruggere il potere militare del
nemico. E lo distruggeremo".
00:04
Inaugurato 'Peace
village' a Brovary, donato da aziende italiane
Si è tenuta in
Piazza della Libertà nella città di Brovary, vicino Kiev, l'inaugurazione del
'Peace Village', uno spazio multinazionale e rifugio climatico a servizio della
popolazione civile, progettato dall'architetto Mario Cuccinella e donato a
Brovary dal Movimento Europeo Azione Nonviolenta (Mean) insieme con un pool di
imprese italiane. Da parte ucraina, il progetto è stato curato dalla Fondazione
di beneficenza internazionale di Serhii Malyk 'Free Spirit of Ukraine' e Kyiv
Municipal Motor Car Club con il sostegno dell'Amministrazione statale del
distretto di Brovary della regione di Kiev e del Consiglio comunale di Brovary.
All'evento di inaugurazione sono stati invitati Volodymyr Maibozhenko, capo
della Brovary Rda della regione di Kiev, Ihor Sapozhko, sindaco di Brovary, e
rappresentanti del Mean e delle aziende italiane che hanno finanziato questo
progetto.
Cinquanta attivisti
del Mean, con l'intenzione di operare concretamente per la cultura della pace ed
il sostegno umano e non violento alla popolazione aggredita, stanno tornando in
Ucraina per un nuovo importante appuntamento: l'inaugurazione del 'Villaggio
della Pace' a Brovary.
01:24
Macron e Orban
cercano arginare divergenze, "uniti" su Ucraina
Il presidente
francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro ungherese, Viktor Orban, hanno
messo da parte le loro diverse visioni di politica internazionale, soprattutto
nel rapporto con la Russia e sul futuro dell'Ue, e hanno scelto a Parigi di dare
un'immagine di unità riaffermando il sostegno all'Ucraina. L'Eliseo, al termine
della cena tra i due, ha diffuso una nota che ha voluto ribadirlo: "Durante
l'incontro, entrambi hanno avuto l'opportunità di riaffermare la necessità di
unità dei Paesi europei nel loro sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione
russa, soprattutto applicando sanzioni severe contro Mosca".
Orban è stato il
leader europeo più critico sull'ondata di sanzioni Occidentali e recentemente ha
proposto che Stati Uniti e Russia aprano negoziati per porre fine al conflitto
ucraino, un atteggiamento che ha creato irritazione a Kiev, che si vede esclusa
dall'iniziativa. Senza entrare nei dettagli, la presidenza francese ha indicato
che l'incontro di Parigi - a più di un anno dal loro ultimo bilaterale nel
dicembre 2021 a Budapest- è servito anche per affrontare il tema della ratifica
della richiesta di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia che il Parlamento
ungherese sta discutendo in queste settimane.
Orban si è detto
pubblicamente favorevole all'ingresso dei due Paesi nordici nella Nato, ma ha
aggiunto che tra i deputati del suo partito, Fidesz, ci sono diversi contrari
per via delle critiche di Stoccolma ed Helsinki all'attuale governo ungherese,
considerato autoritario e ultranazionalista. Dei 30 membri dell'Alleanza
atlantica, solo Turchia e Ungheria devono ancora ratificare le due nuove
candidature presentate sull'onda della guerra in Ucraina. Una fonte diplomatica
francese ha dichiarato di essere "abbastanza fiducioso" riguardo al processo
parlamentare avviato a Budapest.
Il comunicato
dell'Eliseo non fa cenno al contenzioso relativo all'applicazione dello stato di
diritto in Ungheria: è un tema sensibile a Bruxelles, che ha sanzionato
finanziariamente e congelato i fondi a Budapest per non aver rispettato le
regole democratiche richieste dall'Unione.
La presidenza
francese cita però punti di "convergenza" tra Macron e Orban, come la promozione
di un sistema di difesa europeo e l'aumento dell'energia nucleare nel
continente.
06:44
Nyt: "I russi
ottengono 'guadagni minimi' a Est"
Le forze russe
stanno attaccando lungo un arco di 160 miglia (256 km) nell'Ucraina orientale
"per ottenere un vantaggio tattico prima di possibili offensive primaverili", ma
i loro "guadagni sono minimi e hanno un costo spaventoso per entrambe le parti":
lo scrive il New York Times (Nyt) in un articolo pubblicato sul suo sito.
"Da Kupiansk, nel
nord, ad Avdiivka, nel sud, passando per Bakhmut, Lyman e decine di città
intermedie, le forze russe stanno attaccando lungo un arco di 160 miglia
nell'Ucraina orientale", scrive il quotidiano. Il Nyt osserva che "con poche
persone o edifici rimasti intatti, i luoghi più contesi hanno poco da offrire
oltre al controllo di strade e ferrovie che il Cremlino considera importanti per
il suo obiettivo di conquistare l'intera regione orientale... Gli assalti
possono anche fornire un miglior posizionamento per il prossimo attacco,
informazioni sulle posizioni della controparte e valore propagandistico".
Tuttavia, "i
guadagni russi sono minimi e hanno un costo spaventoso per entrambe le parti.
09:13
Cina: "Patto Aukus è
frutto di una mentalità da guerra fredda"
Il
programma Aukus sui sottomarini "è nato sotto una tipica mentalità da Guerra
Fredda, che stimolerà solo una corsa agli armamenti, saboterà il sistema
internazionale di non proliferazione nucleare e danneggerà la pace e la
stabilità regionali". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri
cinese Wang Wenbin, sull'ampio programma sulla sicurezza annunciato ieri da Usa,
Gb e Australia.
09:16
Ucraina, sirene
antiaeree risuonano a Kiev e in altre regioni
Sono appena
risuonate le sirene a Kiev per indicare l'allarme di attacco aereo. Dalle mappe
interattive risulta inoltre che l'allarme è stato diramato anche in altre
regioni del Paese.
09:19
Russia, Peskov: "Non
riconosciamo la giurisdizione della Corte Penale Internazionale"
Il Cremlino ha
dichiarato di non riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale
dell'Aia, ha riferito l'agenzia di stampa TASS, citando il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov. Peskov è stato interrogato sui rapporti che la Corte
penale internazionale (ICC) avrebbe dovuto chiedere a breve i suoi primi mandati
di arresto contro individui russi in relazione al conflitto in Ucraina.
09:34
Ucraina, Kiev: "Tre
civili feriti e sei edifici danneggiati a Kramatorsk"
Almeno tre civili
sono rimasti feriti e sei edifici sono stati danneggiati nel bombardamento di
questa mattina a Kramatorsk, nella regione del Donetsk nell'Ucraina orientale.
Lo riferisce il governatore regionale, Pavlo Kyrylenko, citato dai media locali.
09:37
Russia, Peskov: "Non
è ancora possibile una soluzione pacifica a questo conflitto"
"Apprezziamo molto
gli sforzi di quei Paesi che hanno già compiuto sforzi considerevoli per portare
la soluzione a questo conflitto in una direzione pacifica, ma ancora una volta,
questo non è ancora possibile. Finora, questo conflitto è stato risolto con
mezzi militari". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come
riporta l'agenzia Tass. "Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora è
possibile solo con mezzi militari", ha aggiunto Peskov.
09:46
Ucraina, Berlino: "I
caccia sul fianco est della Nato sono stati dispiegati 27 volte da Agosto"
I caccia tedeschi di
stanza lungo il fianco orientale della Nato sono stati dispiegati 27 volte dal
mese di agosto scorso a seguito di allerte riguardanti aerei sconosciuti nella
regione baltica. Lo riporta la Dpa, citando l'aeronautica tedesca, Luftwaffe.
Durante i dispiegamenti, le forze tedesche hanno identificato aerei militari
russi sopra il Mar Baltico, ha reso noto un portavoce a Berlino. Gli Eurofighter
Typhoon della Luftwaffe tedesca vengono allertati quando velivoli non conosciuti
si avvicinano allo spazio aereo baltico senza transponder o contatto radio.
09:49
Ucraina, un civile
ucciso a Kramatorsk nel corso di un raid russo
C'è anche un civile
ucciso questa mattina nel centro di Kramatorsk colpito da un razzo lanciato
dalle forze russe, altri tre civili sono rimasti feriti: lo scrive il capo
dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko in un
aggiornamento su Telegram citato da Ukrinform.
10:05
Kiev, uccisi 700
soldati russi in ultime 24 ore
Nelle ultime 24 ore
l'esercito ucraino ha ucciso 700 soldati russi. Lo afferma il ministero della
Difesa di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano su Twitter.
10:13
Zelensky, "Ogni
attacco che toglie la vita sarà punito"
"Lo Stato malvagio
continua a combattere contro la popolazione civile. A distruggere la vita e non
lasciare nulla di umano. Ogni attacco che priva di una vita innocente deve
sfociare in una sentenza giusta che punisca l'omicidio. Sarà sicuramente così".
Lo sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, confermando
che a Kramatorsk colpita oggi da un razzo russo si è registrata una vittima
civile e tre feriti.
10:16
Lavrov critica
l'accordo Aukus: "Gli anglosassoni tramano anni di scontri in Asia"
La Russia accusato
Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna di orchestrare "anni di scontri" in Asia
con il lancio dell'alleanza di sottomarini nucleari Aukus. "Il mondo
anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come l'Aukus, facendo avanzare
l'infrastruttura della Nato in Asia e scommettendo seriamente su anni di
scontri", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un
discorso a Mosca.
10:42
Ucraina, Kiev:
"Attacco su Kharkiv, morta una donna di 55 anni"
"Il nemico continua
a bombardare i civili e le infrastrutture civili di Vovchansk nella regione di
Kharkiv. Lo afferma Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione militare regionale
via Telegram, come riporta Ukrinform. "Oggi, durante il bombardamento contro
un'unità dei vigili del fuoco e dei soccorsi della città, un proiettile nemico
ha colpito un'auto civile. Una donna di 55 anni che era a bordo è morta sul
colpo", ha scritto Sinegubov.
10:50
Ucraina, vasto
incendio a Simferopoli in Crimea
Nelle prime ore del
mattino un vasto incendio è scoppiato a Simferopoli, in Crimea. Gli
amministratori russi hanno detto che le fiamme sono state circoscritte e non ci
sono state vittime. Lo riportano i media ucraini. Il rogo si è esteso sull'area
di un magazzino di mille metri quadrati. Nelle scorse settimane un altro grave
incendio in Crimea, a Sebastopoli, aveva provocato sei morti.
11:02
Russia, Alexey
Volin: "Attacchi costanti ai segnali dei nostri satelliti"
La Russia subisce
"attacchi costanti" da territori di "Paesi vicini" per oscurare i segnali dei
suoi satelliti. Lo ha detto Alexey Volin, direttore generale della Compagnia
statale per le comunicazioni satellitari. Mosca, ha sottolineato Volin, citato
dall'agenzia Tass, sta sviluppando un sistema di difesa per individuare attacchi
ai suoi satelliti. Una cosa diventata necessaria in particolare negli ultimi
tempi, ha aggiunto, "perché osserviamo attacchi costanti ai satelliti russi dai
territori vicini".
11:06
Ucraina, Lituania:
"Serve un tribunale ad hoc per i crimini russi"
"Siamo favorevoli a
più sanzioni" contro la Russia e "all'idea di creare un apposito tribunale per
l'Ucraina e per la confisca dei beni di chi ha commesso crimini di guerra". Lo
ha detto il presidente della Lituania Gitanas Nauseda parlando alla Plenaria
dell'Eurocamera. "La comunità europea, nata come progetto di pace, è sottoposta
a pressioni crescenti. L'esperienza ci dice che il modo migliore per espandere
l'idea di pace è l'allargamento dell'Ue ed ecco perché anche oggi, se vogliamo
rafforzare l'Ue, dobbiamo accogliere nuovi membri. l'Ucraina ha già dimostrato
di intraprendere il cammino delle riforme necessarie, la rinascita dell'Ucraina
deve concludersi in un'Europa: ecco perché attendo il giorno in cui i
parlamentari ucraini siederanno in quest'Aula", ha aggiunto Nauseda.
11:11
Ucraina, la Wagner:
"Siamo nell'impianto Azom di Bakhmut"
Mercenari del
gruppo Wagner hanno postato sui social immagini che li mostrano dentro
l'impianto industriale Azom di Bakhmut. Le foto sono state pubblicate sul
canale del gruppo paramilitare fondato da Yevgeny Prigozhin. Intanto l'agenzia
statale russa Ria Novosti scrive che le unità russe hanno preso il controllo di
una parte dell'impianto di lavorazione di metalli nel centro della città e dove
a dicembre Volodymyr Zelensky ha consegnato medaglie ai difensori di Bakhmut. Il
sito ha una rete di tunnel sotterranei, i combattimenti tra russi e ucraini si
stanno svolgendo anche sottoterra.
11:38
Cremlino chiede
chiarimenti su sottomarini Usa a Australia
Il piano degli Usa
per vendere all'Australia cinque sottomarini nucleari "solleva molte domande
legate alla non proliferazione", occorre "trasparenza" ed è necessario
"rispondere a tali domande". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov citato dalle agenzie russe.
11:49
La Duma estende il
reato di discredito delle forze armate anche alla Wagner
La camera bassa del
parlamento russo, la Duma di Stato, ha votato martedì per approvare un
emendamento che punisce i colpevoli di aver screditato i gruppi di "volontari"
che combattono in Ucraina, estendendo così la legge che censura le critiche alle
forze armate russe. L'emendamento è visto come una mossa per "proteggere" i
combattenti che lavorano per il gruppo privato Wagner.
11:53
Nordstream, media:
"Barca Andromeda usata da misterioso equipaggio"
La rivista
tedesca Der Spiegel ha identificato l'imbarcazione perquisita dalle autorità in
relazione alle esplosioni che hanno messo fuori uso il gasdotto Nord Stream 2 a
settembre. Secondo Der Spiegel, l'equipaggio non identificato di sei persone che
ha navigato verso verso l'area dell'esplosione nel Mar Baltico era sulla
"Andromeda", imbarcazione che è stata perquisita a gennaio. La scorsa settimana
la Procura generale tedesca aveva dichiarato di aver perquisito un'imbarcazione
senza fornire il nome o altri dettagli. Secondo i siti web marittimi
vesselfinder.com e marinetraffic.com, l"Andromedà batte bandiera tedesca e
misura 13 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza. La Cnn ha contattato la
società che noleggia l'Andromeda", ma senza ottenere commenti.
12:09
Georgia:
anti-europeisti tolgono da Parlamento bandiera Ue
Manifestanti
anti-europeisti a Tbilisi hanno ammainato la bandiera della Ue che era stata
posta sul Parlamento e le hanno dato fuoco. Ci sono stati anche tafferugli con
la polizia. I manifestanti, del Movimento conservatore, chiedono che venga
indetto un referendum sulla legge relativa agli "agenti stranieri", che il
partito governativo Sogno Georgiano aveva revocato nei giorni scorsi dopo
manifestazioni europeiste nella capitale che avevano portato a incidenti con
decine di feriti.
12:40
Shoigu: "Raddoppiare
la produzione di armi di precisione"
Il ministro della
Difesa russo Sergey Shoigu ha ordinato di raddoppiare la produzione di "armi di
precisione" in Russia: lo riferisce il ministero, ripreso dalla Tass. Secondo il
ministero della Difesa di Mosca, Shoigu ha emesso l'ordine durante una visita
alla "Tactical Missiles Corporation" russa. "Il ministro della Difesa russo
Sergey Shoigu - afferma il dicastero - ha sottolineato che la Tactical Missiles
Corporation soddisfa degnamente il piano di approvvigionamento della difesa.
Tuttavia, tenendo conto dell'aumento della produzione di quest'anno, ha emesso
un ordine per raddoppiare la produzione di armi di precisione".
13:15
Kiev: "Cecchini
russi violarono bambina di 4 anni e sua madre"
Nuove, gravissime
accuse sull'esercito russo. Secondo quanto riporta il sito di Reuters, l'Ucraina
attribuisce a due cecchini russi della guarnigione di Samara l'aggressione
sessuale di una bambina di quattro anni e lo stupro di gruppo della madre. Le
violenze sarebbero avvenute davanti al padre della piccola, minacciato con le
armi. I due soldati sospettati sarebbero un anonimo russo di 32 anni e il 28enne
Yevgeny Chornoknyzhny che, insieme ad altri uomini appartenenti all'esercito,
sono coinvolti in una delle più vaste indagini sulle violenze sessuali commesse
in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Il materiale arriverebbe dall'ufficio del
procuratore ucraino . I soldati sospettati fanno parte della 15a brigata
separata di fucili a motore. Il caso delle violenza sulla bambina di 4 anni e
sulla madre farebbero parte di una serie di crimini sessuali commessi dai russi
nel distretto di Brovary nella regione di Kiev lo scorso marzo. La maggior parte
delle atrocità sarebbe avvenuta il 13 marzo.
13:35
Polonia: "Potremmo a
fornire Mig a Kiev in poche settimane"
La Polonia "potrebbe
fornire all'Ucraina aerei da combattimento MiG in poche settimane": lo afferma
il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per il quale il suo Paese
potrebbe fornire all'Ucraina aerei da combattimento MIG nelle prossime 4-6
settimane. Lo riporta il Guardian. I Paesi occidentali che hanno fornito armi
all'Ucraina hanno finora rifiutato di inviare aerei da combattimento. La Polonia
ha detto che sarebbe disposta a inviare aerei da guerra in una coalizione di
paesi. L'impegno di Varsavia a Kiev è stato importante per convincere gli
alleati europei a donare armi pesanti all'Ucraina, compresi i carri armati.
13:50
Ucraina, combattente
Wagner: "Ucraini usano tutti i tipi di armi"
Secondo i
combattenti del gruppo Wagner, che stanno avanzando in direzione di Chasov Yar
vicino a Bakhmut, l'aviazione ucraina, i veicoli corazzati e tutti i tipi di
armi nemiche stanno operando intensamente, ha detto un combattente del gruppo
a Ria Novosti. "Usano l'aviazione per noi, gli elicotteri decollano sette o otto
volte durante le ore diurne. Elicotteri e aerei non funzionano su veicoli
blindati, ma lavorano sulla forza lavoro, cioè su di noi, nelle trincee e
piantagioni forestali", ha detto il combattente. L'interlocutore dell'agenzia ha
parlato anche della tattica dei carri armati usati dal nemico - il cosiddetto
"carosello di carri armati".
14:31
Putin: "Le pressioni
su di noi cominciate con caduta Urss"
Le pressioni sulla
Russia sono cominciate dopo il collasso dell'Unione Sovietica. Lo ha detto il
presidente Vladimir Putin, sottolineando che gli avversari hanno usato contro il
suo Paese anche il terrorismo. Ora, ha aggiunto, gli interessi geopolitici
dell'Occidente sono diventati "molto più importanti per loro di quanto non
fossero i contrasti ideologici con l'Urss". Lo riferiscono le agenzie russe. Gli
attuali problemi internazionali, ha detto Putin, "sono iniziati dopo il crollo
dell'Unione Sovietica", perché esso ha fatto venir meno un ordine mondiale
creato dopo la Seconda guerra mondiale dai Paesi che l'avevano vinta, prima di
tutto gli Usa e l'Urss. Putin ha fatto queste considerazioni durante la sua
visita a Ulan-Ude, nell'Estremo Oriente, rispondendo alla domanda di un
dipendente della locale fabbrica aeronautica.
14:57
Putin: "Combattiamo
per la sopravvivenza dello Stato russo"
Quella che la Russia
sta conducendo, ovvero quella che Mosca definisce l'operazione militare speciale
in corso in Ucraina, è una "lotta per la sopravvivenza dello Stato" e per
"creare le condizioni per lo sviluppo del Paese e per il futuro dei nostri
figli". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una visita a
una fabbrica dell'aviazione nella regione orientale della Buriazia. "Molti di
noi, e ancora di più i Paesi occidentali, hanno scoperto che le basi della
stabilità della Russia sono molto più forti di quanto si pensasse prima", ha
aggiunto Putin citato dalla Ria Novosti.
15:50
Media, "Kiev valuta
di dichiarare la Russia fascista"
Il parlamento
ucraino potrebbe approvare una dichiarazione in cui si definisce 'ruscism' (una
crasi tra le parole 'russian' e 'fascism') il sistema attualmente in vigore
in Russia. Secondo quanto sostiene il quotidiano russo Meduza, una bozza è stata
inviata alla Verchovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino, per essere
valutata. Nella dichiarazione è riportata anche la condanna verso i suoi
"fondamenti ideologici e pratiche sociali", definite come "totalitarie e
odiose". La dichiarazione inviterebbe anche la comunità internazionale a
riconoscere il regime al potere della Russia come criminale.
16:01
Lituania dichiara
gruppo Wagner organizzazione terroristica
Il parlamento
lituano ha votato all'unanimità per designare il gruppo mercenario russo
Wagner come "organizzazione terroristica", accusandolo di "gravi e sistematici
crimini di aggressione" in Ucraina. Lo riferisce una nota del Seimas, il
parlamento nazionale della Lituania, come riporta Ukrinform.
16:16
Ue: Wagner tema
accessorio, lavorare a cause vere
"Wagner o non
Wagner, questo è un fattore accessorio, la causa alla radice della migrazione è
che la gente si sposta per avere una vita migliore, scappare dalla guerra e
dalle persecuzioni. Dobbiamo lavorare sia con i Paesi d'origine che con quelli
di transito". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione
europea, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda sul
potenziale coinvolgimento della milizia russa Wagner nell'aumento dei flussi
migratori attraverso il Mediterraneo. "Perdere tempo su ragioni accessorie alle
cause alla radice" della migrazione "non credo ci serva molto", ha aggiunto
Schinas minimizzando l'impatto di fattori come la presenza del gruppo Wagner nei
Paesi d'origine.
16:40
Prigozhin, "oltre
10.000 ucraini uccisi ogni mese a Bakhmut"
"Tra i 10.000 e gli
11.000 soldati ucraini sono stati uccisi" ogni mese nella difesa di Bakhmut,
secondo quanto afferma Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata russa
Wagner, in prima linea nell'offensiva per la conquista di questa città del
Donbass. Lo riferisce l'agenzia statale russa Ria Novosti. Secondo le ultime
notizie, aggiunge l'agenzia, le forze russe hanno ormai preso il controllo o
tengono sotto il tiro della loro artiglieria tutte le strade asfaltate, e il
fango che comincia a prodursi con il disgelo sta rendendo molto difficile il
rifornimento di munizioni e l'afflusso di rinforzi alle truppe di Kiev
16:56
Zelensky: un morto e
tre feriti in bombardamento Kramatorsk
Si contano un morto
e tre feriti nel bombardamento di Kramatorsk nella regione diDdonetsk, lo ha
confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sul suo canale
telegram. "Un missile russo ha colpito il centro della città. Sei grattacieli
sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Una persona è
morta" e "le operazioni di soccorso sono ancora in corso". "Ogni colpo che
strappa una vita innocente deve portare a una sentenza legittima e giusta che
punisca l'omicidio", ha aggiunto il capo di stato ucraino.
17:09
Zelensky riunisce
Stato Maggiore su Bakhmut: "Continuare difesa città"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha riunito lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev
per discutere della situazione a Bakhmut e dei combattimenti in corso in prima
linea. "Dopo aver valutato i progressi dell'operazione di difesa nell'area di
Bakhmut, tutti hanno concordato sulla necessita di portare avanti un ulteriore
controllo e difesa della città di Bakhmut" nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina
orientale, ha scritto l'ufficio del presidente Zelensky in una nota. Si è anche
parlato della fornitura di armi e munizioni alle forze armate ucraine impegnate
in prima linea. All'incontro hanno partecipato il capo dello staff di
Zelensky, Andrii Yermak, il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa
nazionale Oleksii Danilov,, il comandante in capo delle forze armate
ucraine Valerii Zaluzhny, il capo dell'intelligence Kyrylo Budanov e il primo
ministro Denys Shmyhal.
17:30
Media, "incidente"
per drone occidentale sul Mar Nero
Un incidente che
coinvolge un drone Reaper di fabbricazione americana di proprietà sconosciuta si
è verificato sul Mar Nero. Lo hanno riferito due fonti militari occidentali. "E'
successo qualcosa ma non abbiamo conferme che il drone sia stato abbattuto, è in
corso un'indagine", ha detto una delle fonti contattate da Afp.
17:38
Netanyahu convoca
riunione per valutare opportunità di inviare aiuti militari a Kiev
Il primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione per valutare
l'opportunità di inviare aiuti militari all'Ucraina per affrontare l'invasione
russa.
Lo scrive il Times
of Israel sottolineando che si tratta della prima volta che Netanyahu affronta
il tema da quando è tornato premier. Alla riunione erano presenti tra gli altri
anche il ministro della Difesa Yoav Gallant, il ministro degli Esteri Eli Cohen,
il capo del Mossad David Barnea, il capo di stato maggiore dell'IDF Herzi
Halevi, il segretario militare di Netanyahu Avi Gil. Al momento non sono state
prese decisioni in merito e seguiranno altre consultazioni, spiegano i media.
17:47
Kiev, sale a 9 il
numero di civili feriti a Kramatorsk
Nove persone sono
rimaste ferite nel bombardamento di questa mattina a Kramatorsk, nella regione
del Donetsk nell'Ucraina orientale. Lo riferisce Oleksandr Goncharenko, capo
dell'amministrazione militare della città di Kramatorsk, citato dai media
locali. Sale anche il bilancio delle case danneggiate, arrivato a 25.
17:49
Filorussi, auto
esplode a Melitopol, 'è terrorismo ucraino'
E' di due morti e
due feriti il bilancio dell'esplosione di un'autobomba oggi a Melitopol,
cittadina controllata dai russi nella provincia ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha
reso noto Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione regionale filorussa,
citato dall'agenzia Ria Novosti. I servizi di emergenza della regione di
Zaporizhzhia occupata dai russi hanno riferito che è stata fatta saltare in aria
nel cortile di un edificio a Melitopol. Secondo quanto riportato da Ria Novosti,
Rogov ha definito l'incidente "un attacco terroristico" organizzato
dall'Ucraina.
18:06
Russia: legale,
poeti anti-guerra accusati di minaccia allo Stato
Tre poeti russi,
arrestati a settembre a Mosca dopo aver preso parte a una lettura contro la
guerra in Ucraina in piazza Majakovskij, sono stati accusati di "inviti pubblici
a commettere attività contro la sicurezza dello Stato" e "istigazione all'odio"
in un "gruppo organizzato": lo ha detto all'Afp l'avvocato Leonid Solovyov,
legale di uno dei poeti, precisando che i tre artisti - Artiom Kamardin, Yegor
Shtovba e Nikolai Daineko - rischiano fino a dieci anni di reclusione.
Inizialmente i tre poeti erano stati accusati solo di "istigazione all'odio",
punibile con sei anni di reclusione. Ora rischiano altri quattro anni.
L'avvocato Leonid Solovyov ha detto che è la prima volta che sa di cittadini
russi accusati di "inviti pubblici a commettere attività contro la sicurezza
dello Stato": un reato introdotto nel codice penale a luglio. La polizia russa è
accusata di aver usato violenza a uno dei poeti, Artyom Kamardin.
18:10
Pentagono, il jet
russo ha colpito l'elica del drone Usa
Un jet da
combattimento russo ha colpito l'elica di un drone militare Usa 'Reaper',
costringendo gli Usa a farlo cadere nel Mar Nero: lo rende noto il Pentagono.
18:11
Ucraina: jet russo
si scontra con drone Usa sul Mar Nero
Un jet russo ha
costretto un drone MQ-9 Reaper dell'aeronautica Usa ad un atterraggio forzato,
dopo averne danneggiato l'elica. L'incidente, secondo quanto riferiscono fonti
militari Usa citate dalla Cnn, è avvenuto sulle acque internazionali del Mar
Nero e ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi. Uno dei due jet ha scaricato
del carburante davanti al drone, mentre l'altro ne ha danneggiato l'elica,
montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far
scendere il drone in acqua.
18:12
Biden informato
dell'incidente tra jet russo e drone Usa
Joe Biden è stato
informato dal consigliere per la sicurezza nazionale dell'incidente tra un jet
russo e un drone Usa sul Mar Nero: lo ha detto il portavoce del consiglio per la
sicurezza nazionale John Kirby.
18:15
Putin, gli attacchi
al Nord Stream condotti da uno Stato
Gli atti
terroristici compiuti contro il Nord Stream sono stati commessi da uno Stato. Lo
ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che gli Stati
Uniti erano interessati a far esplodere le condotte del gasdotto. Lo riporta
la Tass. Secondo Putin, la versione del coinvolgimento di attivisti ucraini
nelle esplosioni lungo il gasdotto Nord Stream "è una totale sciocchezza".
18:23
Usa, drone in azione
di routine in spazio aereo internazionale
Il drone Usa colpito
da un jet russo sul Mar Nero stava conducendo un'operazione di routine nello
spazio aereo internazionale quando due caccia russi hanno cercato di
intercettarlo: lo ha riferito il Pentagono. Il dipartimento di Stato intende
contattare le autorità russe per esprimere la "preoccupazione" degli Stati Uniti
per l'incidente avvenuto tra un jet russo e un drone Usa sul Mar Nero. Lo ha
riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.
18:30
Casa Bianca,
l'attacco al drone Usa unico nel suo genere
Se la Russia intende
"impedire" agli Stati Uniti di volare sul Mar Nero, "questo on accadrà" e
"continueremo a volare". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza
nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.
Secondo Kirby, si tratta di una situazione unica nel suo genere: "Ci sono state
altre intercettazioni simili ma questa è degna di nota perché è stata pericolosa
e poco professionale" e ha causato l'abbattimento di un velivolo statunitense,
"quindi è unica al riguardo".
18:33
Nord Stream: Putin,
Gazprom potrebbe aver trovato altro ordigno su gasdotto
Una nave della
Gazprom ha trovato prove della possibile presenza di un altro ordigno esplosivo
sul tubo del Nord Stream, a 30 km dal luogo del precedente attacco terroristico.
Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Russia 1.
Lo riporta la Tass. Putin ha ricordato che Gazprom aveva precedentemente
ricevuto il permesso dalle autorità danesi di indagare sul luogo dell'esplosione
sul Nord Stream, ma non si è fermata qui e la nave noleggiata dalla compagnia è
andata oltre lungo il gasdotto. "E a una distanza di circa 30 km dal luogo
dell'esplosione - ha spiegato - gli specialisti ritengono che potrebbe essere
un'antenna per ricevere un segnale per far scattare un ordigno esplosivo, che
potrebbe essere posto sotto il sistema di condutture", ha sottolineato.
18:39
Putin, se europei
rinsaviscono Nord Stream ha un futuro
I gasdotti Nord
Stream hanno un futuro se i Paesi europei ripristineranno l'interesse nazionale.
Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Penso che (un futuro) ci sia",
ha detto in un'intervista al canale televisivo Russia 1, rispondendo a una
domanda in tal senso. "Se i nostri partner europei sono interessati e se hanno
ancora questo istinto di interesse nazionale, allora, ovviamente, avranno un
futuro", ha dichiarato il leader del Cremlino. "A volte mi sembra che qualunque
cosa venga loro detta da Oltreoceano, loro la fanno", ha detto riferendosi ai
leader europei.
18:43
Nato: "Alleati
informati del drone Usa abbattuto"
Il comandante
militare della Nato, il generale Christopher Cavoli, ha informato tutti e trenta
gli Stati che fanno parte dell'Alleanza Atlantica dell'abbattimento di un drone
americano MQ-9 Reaper da parte di un caccia russo Su-27. Lo rende noto un
funzionario della Nato.
18:46
Casa Bianca, se
messaggio russi è non volare su Mar Nero fallirà
"Non sappiamo quale
fosse l'intenzione dei russi ma se il messaggio era quello di esercitare
deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar
Nero, o la nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato
a fallire": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza
nazionale John Kirby in un briefing telefonico rispondendo ad una
domanda sull'incidente tra un jet russo e un drone Usa sul Mar Nero.
18:48
Presidente siriano
arrivato a Mosca, previsto colloquio con Putin
Il presidente
siriano, Bashar al Assad, è arrivato in visita ufficiale a Mosca, dove dovrebbe
incontrare l'omologo russo, Vladimir Putin. Lo riferisce l'ufficio della
presidenza siriana, come riporta Ria Novosti.
18:56
Putin, ha perso gene
sovranità e indipendenza
Gli Europei "hanno
perso il gene dell'indipendenza, della sovranità e dell'interesse nazionale". Lo
ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista a Russia
1. Lo riporta Ria Novosti. "Più li colpiscono sul naso o sulla sommità della
testa, più si piegano e sorridono", ha aggiunto.
19:04
Ucraina, allerta
aerea in tutto il Paese
Un'allerta aerea è
stata dichiarata in tutta l'Ucraina, per la quarta volta oggi. Lo ha reso noto
il ministero della Trasformazione digitale. Il primo allarme è stato lanciato
per la capitale Kiev e poi ha interessato l'intera Ucraina. I precedenti
avvertimenti erano stati alle 13.00, 14.30 e 16.25 ora di Kiev.
19:41
Usa convocano
ambasciatore russo per incidente drone
Gli Stati
Uniti hanno convocato l'ambasciatore russo a Washington per protestare contro lo
schianto di un drone americano sul Mar Nero dopo che un aereo da guerra russo si
è scontrato con esso. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato
Ned Price.
19:45
Russia: "Drone
americano si stava avvicinando al nostro confine, ma è caduto da solo per
manovra brusca"
Il drone americano
MQ-9 Reaper precipitato nel Mar Nero "stava violando le norme di utilizzo dello
spazio aereo" e per questo "i caccia russi si sono alzati in volo". Ma "non c'è
stato alcjn contatto tra il drone americano e i caccia russi" che "non hanno
utilizzato armi". E' quanto sostiene il ministero della Difesa russo in una nota
rilanciata dall'agenzia di stampa Ria Novosti. "Il drone americano, in seguito a
una brusca manovra, ha perso il controllo in volo, ha avuto una perdita di quota
ed è precipitato in acqua", sostiene il ministero.
"Il drone stava
volando in direzione del confine della Federazione russa", aggiunge la nota,
affermando che il velivolo aveva "i transponder spenti". Il ministero afferma
inoltre che "dopo essere stato rilevato il drone, i caccia delle forze armate
russe in servizio si sono alzati in volo".
19:57
Comando americano in
Europa: "Il drone non è stato recuperato"
Il drone Usa
Reaper abbattuto da un caccia russo sul Mar Nero non è stato recuperato. Lo
riporta un portavoce del comando Usa in Europa.
20:03
Il Pentagono non
fornisce dettagli sui danni al drone
Il Pentagono non ha
voluto fornire dettagli su come e dove è stato colpito il drone, abbattuto sul
Mar Nero dopo un confronto con un jet russo. Nel corso del briefing con i
giornalisti, il portavoce della Difesa ha detto più volte di non poter fornire
dettagli, ma si è limitato a dire che era stato danneggiato, senza indicare
dove.
20:10
Pentagono: "Il jet
russo probabilmente danneggiato nella collissione"
Il jet da
combattimento russo Su-27 "probabilmente è stato danneggiato" nella collisione
con il drone statunitense MQ-9 nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero.
Lo ha affermato il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, nel corso di una
conferenza stampa. "Ciò che abbiamo visto sono stati aerei da combattimento che
scaricavano carburante davanti a questo drone e poi si sono avvicinati così
tanto all'aereo da danneggiare l'elica dell'MQ-9. Stimiamo che probabilmente
anche l'aereo russo abbia subito qualche danno", ha detto.
20:25
Pentagono:
"Costretti a far precipitare il drone dopo la collisione"
Le forze armate
americane sono state costrette a far precipitare nel Mar Nero il drone Mq-9 dopo
che il velivolo era stato danneggiato in seguito a una collisione con un caccia
russo Su-27. Lo ha chiarito in conferenza stampa il generale Pat Ryder al
Pentagono. "A causa dei danni, abbiamo dovuto farlo precipitare nel Mar Nero",
ha aggiunto, spiegando che il drone non poteva più volare dopo la collisione.
20:38
Pentagono: il jet
russo ha volato 30-40 minuti vicino al drone americano
Il caccia russo ha
affiancato il drone Usa per circa 30-40 minuti prima della collisione. Lo ha
detto il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder. "Basato sulle
informazioni in nostro possesso - ha detto, durante il briefing con i
giornalisti - sembra che (il jet russo, ndr) abbia volato da 30 a 40 minuti
nelle vicinanze dell'Mq-9". La collisione avrebbe reso il drone impossibilitato
a volare e spinto gli Stati Uniti ad abbatterlo.
20:54
Cnn: dal jet russo
carburante sul drone per danneggiarlo
Un jet russo avrebbe
"deliberatamente" e "numerose volte" rilasciato carburante lungo la rotta del
drone americano Mq-9 per danneggiare le eliche posteriori del velivolo,
rendendolo così impossibilitato a volare. Lo riporta la Cnn, che cita fonti
dell'amministrazione Usa.
21:44
L'ambasciatore russo
al Dipartimento di Stato Usa
L'ambasciatore
russo Anatoly Antonov è arrivato al Dipartimento di Stato americano, dove è
stato convocato in seguito alla collisione tra un drone americano e un caccia
russo sul Mar Nero. Lo riferisce la Cnn, spiegando che il diplomatico non ha
risposto alla richiesta di commenti.
Antonov dovrebbe
incontrare il vice Segretario di Stato per gli affari europei Karen Donfried, ha
detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Antonov è stato convocato
per "trasmettere le nostre forti obiezioni", ha detto il portavoce del
Dipartimento di Stato Ned Price. L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia
Lynne Tracy "ha trasmesso un messaggio forte al ministero degli Affari esteri
russo", ha affermato Price.
22:15
Ambasciatore russo a
Washington: "Nessuna arma usata contro il drone americano"
I caccia russi non
hanno usato le loro armi contro il drone americano in missione di ricognizione
sul Mar Nero. Lo ha ribadito l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly
Antonov, dopo essere stato convocato al Dipartimento di Stato per rendere conto
dell'incidente. "Voglio sottolineare che i piloti russi hanno agito in modo
molto professionale, non c'è stato alcun contatto e non c'è stato alcun uso di
armi", ha dichiarato. Lo riporta la Tass.
22:30
Ambasciatore Mosca:
"La Russia non cerca lo scontro con gli Usa"
"La Russia non sta
cercando lo scontro con gli Stati Uniti". Lo ha detto l'ambasciatore di Mosca a
Washington, Anatoly Antonov, che oggi è stato convocato al Dipartimento di Stato
americano dopo la collisione tra un drone americano e un caccia russo sul Mar
Nero. Antonov ha detto di aver incontrato l'assistente del Segretario di Stato
americano Antony Blinken, Karen Donfrid.
Estratto da wired.it
il 14 marzo 2023.
L'interesse recente
dell'opinione pubblica verso l'intelligenza artificiale si è concentrato
soprattutto sugli aspetti ricreativi, ma la nuova tecnologia ha un'applicazione
molto più seria e preoccupante che riguarda le guerre.
L'Ai viene già
utilizzata in Ucraina: il conflitto ha di fatto anticipato l'uso
dell'intelligenza artificiale in guerra, portando sul campo di battaglia
strumenti e programmi ancora da perfezionare. Ora l'innovazione è nell'agenda
dei leader militari e politici di tutto il mondo; per questo si è svolto il
primo vertice internazionale sull'uso militare responsabile dell'Ai che ha
stimolato una discussione etica e le principali preoccupazioni riguardanti
l'arrivo dell'Ai nei conflitti.
Ha avuto luogo a
L'Aia, in Olanda, il Reaim Summit, manifestazione organizzata dal governo
olandese per posizionare il tema dell'Ai nel mondo militare più in alto
nell'agenda politica internazionale.
All'evento hanno
partecipato delegati di 50 Paesi, fra cui Stati Uniti e Cina, ma i Paesi Bassi e
la Corea del Sud co-organizzatrice non hanno invitato la Russia. Erano presenti
anche aziende private: l'amministratore delegato di Palantir, compagnia
statunitense specializzata nelle nuove tecnologie e nell'analisi di big data,
non ha nascosto il coinvolgimento della propria azienda nel conflitto in
Ucraina.
“Siamo responsabili
della maggior parte degli attacchi” ha detto Alex Karp di Palantir. La sua
impresa sfrutta l'intelligenza artificiale per colpire obiettivi russi ed è
quindi a supporto della nazione di Kiev. Fra i servizi di Palantir la
possibilità di analizzare i movimenti satellitari e i feed dei social media per
aiutare a visualizzare la posizione di un nemico […]. L'Ai riesce ad analizzare
una grande quantità di dati in poco tempo, velocizzando gli attacchi e favorendo
un approccio ostile in minor tempo.
"[…] Sul fatto che
l'Ai in guerra sia una realtà non ci sono dubbi: i governi devono esaminare
quale parte dei loro budget per la difesa sarà destinata ai progressi della
tecnologia, soprattutto perché la conversazione è cambiata negli ultimi sei
mesi.
L'intelligenza
artificiale offre un importante vantaggio strategico nei contesti di guerra, in
quanto favorisce la possibilità di automatizzare compiti ripetitivi e consente
una maggiore accuratezza e precisione nelle operazioni di combattimento. […]
I sistemi di imaging
basati sull'intelligenza artificiale possono fornire un'immagine precisa di ciò
che sta accadendo in una situazione di combattimento, consentendo colpi più
precisi e meno danni collaterali.
Inoltre, i sistemi
di posizionamento basati sull'intelligenza artificiale consentono una maggiore
precisione nel puntamento di munizioni esplosive e nella navigazione di aerei da
combattimento e altre unità di combattimento. Il software e gli algoritmi basati
sull'intelligenza artificiale offrono la possibilità di elaborare grandi
quantità di dati in modo rapido e accurato per ottenere informazioni preziose.
[…]
Jet russo
colpisce un drone Usa, scontro nei cieli del Mar Nero: ecco cosa è successo. Andrea
Marinelli, Guido Olimpio e Lorenzo Cremonesi, inviato a Kramatorsk, su Il
Corriere della Sera il 15 Marzo 2023.
Un jet russo si è
scontrato nel cielo del Mar Nero con un drone da ricognizione americano poco
dopo le 7 del mattino di ieri, costringendo i piloti che lo manovravano a farlo
precipitare in acque internazionali. Secondo un funzionario statunitense citato
dalla Cnn, il drone Reaper MQ-9 e i due Su-27 Flanker stavano operando sul Mar
Nero quando uno dei jet russi è volato intenzionalmente davanti al velivolo
senza pilota e ha scaricato carburante. Un jet ha poi danneggiato l’elica sul
retro del Reaper, costringendo gli Usa ad abbattere il drone, che non è stato
recuperato.
In serata è arrivata
anche la ricostruzione russa. Il drone sarebbe stato localizzato «vicino alla
penisola di Crimea, in direzione del confine della Federazione Russa», ha
dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. «Il velivolo volava con i
transponder spenti. A quel punto i caccia dell’aeronautica hanno provato a
identificare l’intruso, ma non hanno usato armi e non sono entrati in contatto
con il drone americano, che ha perso controllo e quota ed è finito in acqua al
termine di una brusca manovra».
Dopo l’incidente il
comandante militare della Nato, il generale Christopher Cavoli, ha subito
informato i trenta Stati che fanno parte dell’Alleanza Atlantica. «Questo
incidente segue uno schema di azioni pericolose da parte di piloti russi che
interagiscono con velivoli statunitensi e alleati nello spazio aereo
internazionale», ha scritto in una nota lo Us Eucom, il comando Usa per
l’Europa. «Queste azioni aggressive da parte dell’equipaggio russo sono
pericolose e potrebbero portare a calcoli errati e a un’escalation
involontaria».
Incidenti simili
sono frequenti, ha notato la ricercatrice della Rand Corporation Dara Massicot,
che ha analizzato decine di casi e ritiene che lo scontro fra il jet russo e il
drone americano faccia parte dei «segnali coercitivi» che Mosca invia agli
alleati, e che ne replichi le modalità. Quello di ieri è però il primo confronto
diretto fra Stati Uniti e Russia dall’inizio del conflitto, anche se nei cieli
del Mar Nero i velivoli alleati — che monitorano il conflitto — e quelli russi
hanno costanti interazioni.
Ci sono stati altri
intercettamenti, ha precisato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale
John Kirby, ma questo è degno di nota perché è stato «pericoloso e non
professionale. Per questo è stato unico. Non sappiamo quale fosse l’intenzione
dei russi», ha aggiunto, «ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza
contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero, o la
nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire».
Il presidente degli
Stati Uniti Joe Biden è stato immediatamente informato dell’incidente, ha
affermato Kirby, mentre l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov è
stato convocato nel pomeriggio di martedì e la rappresentante americana a Mosca
Lynne Tracy ha presentato una formale protesta al ministero degli Esteri russo.
Intanto ieri
Vladimir Putin, sottolineando il cambiamento di priorità, ha spiegato che
quella in Ucraina si è trasformata da operazione minore per «liberare il Paese
dai nazisti» a conflitto vitale per «garantire la stessa esistenza dello Stato
Russo». «Nel Donbass lottiamo per la nostra sopravvivenza. Questo non un è
conflitto geopolitico, ma una missione per garantire il futuro della Russia che
permetta lo sviluppo del Paese e dei nostri figli», ha esclamato.
A conferma del
prevalere della logica della forza militare sono i duri scontri nel Donbass
attorno alla cittadina contesa di Bakhmut (dove la lotta è adesso incentrata tra
i capannoni della ditta metallurgica Azom con immagini che ricordano la sfida
per la Azovstal di Mariupol la primavera scorsa) e nei settori adiacenti come
Kreminna, Avdiivka e Lyman. I comandi ucraini insistono sull’importanza «vitale»
di Bakhmut, ma c’è il sospetto che serva da puro diversivo per attirare il
grosso delle forze russe, mentre Kiev pianifica la sua prossima controffensiva
nel sud. I proiettili russi hanno anche colpito ieri mattina la città di
Kramatorsk, causando un morto e tre feriti tra i civili.
La guerra della
Russia a Bakhmut e quella con Prighozin.
Stefano Piazza su
Panorama il 14 Marzo 2023
Questa mattina il
Cremlino attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato all'agenzia di
stampa Tass di non riconoscere la giurisdizione d Corte penale internazionale
dell'Aia. Nemmeno il tempo di registrare l’ennesima rottura di Mosca con le
organizzazioni internazionali che il portavoce del ministero degli Esteri cinese
Wang Wenbin ha fatto la stessa cosa parlando il programma Aukus annunciato ieri
da Usa, Gran Bretagna Australia sui sottomarini che secondo Pechino «è nato
sotto una tipica mentalità da Guerra Fredda, che stimolerà solo una corsa agli
armamenti saboterà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e
danne la pace e la stabilità regionali». Di questo ha parlato il ministro degli
Ester russo Sergei Lavrov che in un discorso a Mosca ha detto: «Il mondo
anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come l'Aukus, facendo avanzare
l'infrastruttura della Nato in Asia e scommettendo seriamente s anni di
scontri». Evidente come russi e cinesi perseguano gli stessi obbiettivi che
mirano a destabilizzare l’Occidente in modo da avere le mani libere nei loro
progetto di espansione, come accade in Ucraina da parte russa (con un occhio a
Moldo in Georgia) e come vedremo prossimamente a Taiwan da parte cinese. A loro
aggiungono l’Iran che fornisce armi alla Russia, la Bielorussia prossima
all’unificazione forzata con Mosca, la Cecenia di Razman Kadyrov che partecipa
al conflitto ucraino con le sue truppe e la Corea del Nord che è anche luogo di
riciclaggio di denaro sporco per russi, cinesi e iraniani che acquistano anche
armi. Gli attacchi russi alle organizzazioni internazionale servono anche a
distrarre l’opinione pubblica russa e quella internazionale dagli scontri
quotidiani all’interno del gruppo di potere di Mosca che seco alcuni Vladimir
Putin fatica sempre più a gestire. Ieri è stata la volta del politologo russo
Aleksey Mukhin, che contribuisce al forum Valdai Discus Club e ai media statali
russi, che ha commentato l'annuncio sarcastico di Yevgeny Prigozhin dell'11
marzo secondo cui si candiderà alle elezioni presidenziali ucraine del 2024.
Mukhin sul suo canale Telegram ha chiesto in maniera ironica «se Prigozhin
avesse informato il presidente russo Vladim Putin delle sue ambizioni
presidenziali» inoltre il politologo scrive che che Prigozhin « si definisce
comandante della compagnia militare privata Wagner influenza direttamente la
pianificazione e la gestione delle opera di combattimento delle squadre
d'assalto». Poi Aleksey Mukhin che non è certo un personaggio minore, ha
aggiunto che il leader del Gruppo Wagne un potenziale politico che cerca capri
espiatori da incolpare per le elevate perdite di personale di Wagner. Tutti
sanno che il governo russo paga per forze di Prigozhin e le loro munizioni e il
fallimento di Prigozhin nel riconoscere il sostegno delle forze russe
convenzionali lo ha alienato dai comandanti russi sul campo di battaglia.
Prigozhin ha messo i combattenti Wagner in pericolo di accerchiamento durante
l'atteso contrattacco ucraini in seguito delle sue azioni. Prigozhin ora chiede
che le forze convenzionali r coprano i 'suoi fianchi' e che le forze russe
potrebbero aver bisogno di me da parte il loro disgusto per Prigozhin per
prevenire ulteriori perdite di W a Bakhmut». Un attacco durissimo quello a
Yevgeny Prigozhin che sta diventando sempre di più un problema per Putin del
quale aveva parlato l'Institute for the Study of War (ISW) nel suo report del 12
marzo secondo ministero della Difesa russo potrebbe deliberatamente sacrificare
le forze Wagner a Bakhmut in parte per far deragliare le aspirazioni politiche
di Prigozhin. Le pesanti accuse di Mukhin supportano anche la valutazione
dell’ISW secondo cui il Cremlino e il Ministero della Difesa russo stanno
tentando d’incolpare Prigozhin per il ritmo rallentato dell'avanzata a Bakhmut e
per elevate perdite tra i mercenari Wagner. Prigozhin si è difeso affermando c
15/03/23, 07:41 La guerra della Russia a Bakhmut e quella con Prighozin -
Panorama
https://www.panorama.it/news/dal-mondo/guerra-bakhmut-prighozin-wagner 4/8
«la situazione a Bakhmut rimane davvero difficile» e che «i miei 550 tenta di
procurare munizioni per Wagner sono stati ignorati. Non vi è alcun con tra i
combattenti di Wagner e i combattenti del ministero della Difesa russi sono
fiducioso che Wagner continuerà a ricevere tali donazioni grazie alle relazioni
amichevoli con queste unità». Mentre scriviamo i mercenari del gruppo Wagner
stanno pubblicando sui loro sui social network immagini mostrano dentro
l'impianto industriale Azom di Bakhmut.
Da blitzquotidiano.it
il 14 marzo 2023.
[…] Un uomo ha
portato il suo carro armato a fare un giro sulla neve prima di fare il pieno di
benzina a una stazione di servizio. Il protagonista è un 35enne di
Stoke-on-Trent, nel Regno Unito, conosciuto come “The Beast” che nel 2017 è
stato incoronato come World’s Strongest Man.
[…] Il costo del
pieno del carro armato al distributore è stato però molto salato: circa mille
sterline.
Un carro armato che
può circolare in strada
Lo scorso anno il
protagonista della vicenda ha comprato il mezzo militare e ha voluto subito
personalizzarlo. Questo perché il suo fiammante carro armato è omologato per la
circolazione su strada, con un limite massimo di velocità di 20 miglia all’ora
(circa 32 km/h).
È andato anche a
prendere il figlio a scuola
Come ogni buon padre
è andato persino a prendere suo figlio a scuola. […]
La Repubblica. Kiev:
Wagner mette taglia su Crosetto. Colloquio telefonico tra ministri della Difesa
Washington-Mosca. Usa, incidente drone sembra non intenzionale
L'Ambasciata Russia
a Washington: "Il volo del drone Usa è una provocazione". Mosca: "Usa smettano
attività militari ai nostri confini". Allarme aereo in tutte le regioni,
esplosioni a Kharkiv. Entro maggio la Turchia potrebbe dire sì all'ingresso
della Finlandia nella Nato. Media russi: "Reclutamento di 400mila militari da
aprile". Ma il Cremlino smentisce. Mosca: "ordigni esplosivi" su oleodotto a
confine
Cresce la tensione
tra Usa e Mosca dopo la che un jet russo si è scontrato con un drone Usa che
stava conducendo una missione di ricognizione sul Mar Nero. Per l'ambasciatore
russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, l'episodio "è una provocazione".
"Questo dispositivo
stava volando con i transponder spenti ed è entrato nella zona di un'operazione
militare speciale - ha spiegato alla Tass. E ancora: "La Russia chiede agli Usa
di mettere fine alle inaccettabili attività militari vicino ai confini russi".
Intanto secondo la Bbc aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e
dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo
spazio aereo dell'Estonia, che è stato scortato fuori.
Punti chiave
20:24
Dipartimento di
Stato Usa, incidente drone sembra non intenzionale
19:12
Colloquio telefonico
tra ministri della Difesa Usa-Russia
16:43
La Wagner ha messo
una taglia sul ministro Crosetto
12:57
Putin: "La
situazione nelle nuove regioni rimane difficile"
11:59
Russia: Transneft,
"ordigni esplosivi" su oleodotto a confine
11:47
Wagner, conquistata
un'altra località vicino a Bakhmut
07:44
Caccia Gb e tedeschi
intercettano aereo russo sull'Estonia
00:00
La Lituania proroga
lo stato di emergenza al confine russo
Il parlamento
lituano (Seimas) ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza nelle aree di
frontiera con la Federazione russa e la Bielorussia. La misura era stata
adottata per limitare l'immigrazione clandestina favorita dalla polizia
bielorussa e iniziata nell'estate del 2021.
00:10
Usa: "Adottate
misure per evitare che drone finisca in mani sbagliate"
La Casa Bianca ha
adottato le misure necessarie per evitare che il drone abbattuto nel Mare Nero
"finisca nelle mani sbagliate". Lo ha riferito il coordinatore del Consiglio di
sicurezza nazionale, John Kirby, alla Cnn. "Senza entrare troppo nei dettagli,
quello che posso dire è che abbiamo adottato misure per proteggere le nostre
azioni rispetto a quel particolare drone. Ed è proprietà degli Stati Uniti.
Ovviamente non vogliamo vedere nessuno metterci le mani sopra al di là di noi",
ha spiegato.
00:28
Nyt: "Drone caduto
in mar Nero non aveva armi"
Il drone americano
caduto nel mar Nero dopo un incontro ravvicinato con un caccia russo non aveva
armi. Lo riporta il New York Times citando un funzionario militare statunitense.
Il velivolo - viene spiegato - era decollato da una base in Romania per una
missione di ricognizione regolarmente programmata, che in genere dura dalle nove
alle dieci ore.
00:45
Media: usate
munizioni fosforo nei pressi di Bakhmout
I militari russi
hanno sparato almeno due munizioni al fosforo bianco nel pomeriggio di ieri in
una zona disabitata a Chassiv Iar, nei pressi di Bakhmout, nell'Ucraina
orientale. Lo riportano i giornalisti di Afp presenti sul posto.
00:49
Zelensky,
"Rafforzeremo la difesa di Bakhmut"
In merito
a Bakhmut "c'è una posizione chiara e congiunta: rafforzare le difese per
distruggere l'occupante il più possibile". Lo ha detto il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale. Lo riporta Unian.
01:02
Ambasciatore russo:
"Non vogliamo scontro con Usa"
La Russia non vuole
lo "scontro" con gli Stati Uniti: lo ha detto ai reporter l'ambasciatore russo a
Washington Anatoly Antonov, dopo essere stato convocato al Dipartimento di Stato
americano per l'incidente tra un jet di Mosca e un drone Usa. Il diplomatico
tuttavia ha osservato che "per come la vediamo, gli aerei americani non
dovrebbero trovarsi vicino al confine russo". "Potete immaginare se un drone del
genere apparisse improvvisamente vicino a New York o San Francisco?", ha
chiesto, anche se l'incidente è avvenuto nello spazio aereo internazionale.
06:19
Governatore
Belgorod: "Abbattuti 3 missili sopra la regione"
Il governatore della
regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha affermato che la difesa aerea
russa ha abbattuto tre missili sopra la regione. Lo riporta il Kyiv
Independent secondo cui il governatore Vyacheslav Gladkov non ha fornito
dettagli sulla provenienza dei missili. Non sono stati segnalati feriti.
06:47
Isw: "Incidente
drone non causerà conflitto diretto Usa-Russia"
L'incidente con il
drone americano MQ-9 Reaper nel Mar Nero non causerà un conflitto diretto tra
Stati Uniti e Russia. È quanto affermano gli analisti dell'Istituto per lo
studio della guerra, come riporta Ukrainska Pravda. "Le truppe russe hanno usato
per decenni tattiche intimidatorie contro aerei e navi americani e alleati in
numerosi teatri, il che non ha mai portato a conflitti", hanno osservato gli
esperti dell'istituto
06:49
Kiev, quattro feriti
in attacco russo a Kherson
Due civili e due
ufficiali del servizio di emergenza statale ucraino sono rimasti feriti in un
bombardamento russo nella regione di Kherson. Lo riferisce il comando militare
ucraino che opera nel sud del Paese, come riporta il Kyiv Indipendent.
07:44
Caccia Gb e tedeschi
intercettano aereo russo sull'Estonia
Aerei da caccia
della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno
intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia, scrive
la Bbc in un tweet, che non cita fonti. L'aereo russo, un quadrimotore da
trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, volava fra l'enclave
russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazio aereo
estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di
Tallinn. I due aerei che l'hanno intercettato, due Typhoon decollati per
l'occasione, appunto uno tedesco e l'altro britannico, hanno scortato l'Il-78
fuori dallo spazio estone.
07:59
Mosca: "Usa smettano
attività militari ai nostri confini"
La Russia chiede
agli Usa di mettere fine a quelle che chiama le "inaccettabili attività militari
vicino ai confini russi" dopo l'incidente che ieri ha coinvolto un jet di
Mosca e un drone americano. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti,
Anatoly Antonov, citato dall'agenzia Ria Novosti.
08:22
Media russi:
"Reclutamento di 400mila militari da aprile"
A partire dal primo
aprile, la Russia inizierà un nuovo reclutamento di militari a contratto, il
ministero della Difesa ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di
persone che dovranno firmare: i media regionali russi hanno scritto che un
totale di 400.000 militari a contratto dovranno aggiungersi all'esercito,
secondo i piani del ministero della Difesa della Federazione. Lo riporta il sito
di Radio Svoboda. Secondo il quotidiano Vyrstka gli uffici di registrazione e
arruolamento stanno cercando di compensare le perdite dell'esercito russo.
09:20
Kiev: "Tredici navi
russe nel Mar Nero con 28 missili cruise Kalibr"
Al momento la Russia
ha dislocato 13 navi militari in servizio di combattimento nel Mar Nero, tra cui
quattro unità lanciamissili con un totale di 28 missili da crociera Kalibr a
bordo: lo scrive il comando navale ucraino su Facebook, citato
dall'agenzia Ukrinform. "Al 15 marzo 2023, ci sono 13 navi nemiche in servizio
di combattimento nel Mar Nero, incluse 4 portaerei di missili da crociera Kalibr
con una salva totale fino a 28 missili", si legge nel messaggio.
09:25
Michel: "Da Russia
nessuna volontà di arrivare a pace"
"Vogliamo
un'escalation verso la pace, ma la Russia ha invece aumentato l'escalation della
guerra" e "non vediamo alcun segnale dal Cremlino nella direzione giusta". Lo ha
dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo
intervento al Parlamento europeo a Strasburgo.
09:43
Ucraina: allarme
aereo in tutte le regioni, esplosioni a Kharkiv
Allarme aereo questa
mattina in tutte le regioni ucraine, compresa la capitale. Esplosioni sono state
segnalate a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, come riferisce il capo
dell'amministrazione regionale militare, Oleg Sinegubov, citato da Unian.
Secondo il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun, un MiG-31K russo 'Dagger
carrier' è decollato dal territorio della Bielorussia. "Gli aerei MiG-31K sono
potenziali portatori di missili Dagger. Attualmente l'Ucraina non dispone di
difese aeree in grado di abbattere questi missili", ha detto Sinegubov.
10:11
Ingresso nella Nato,
presidente della Finlandia da domani in Turchia per colloqui con Erdogan
Il presidente
finlandese Sauli Niinisto si recherà domani e dopodomani in Turchia per
incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdoagn. Al centro dei colloqui
l'adesione alla Nato della Finlandia, come ha dichiarato l'ufficio del
presidente finlandese.
10:31
Kiev: gli Usa hanno
già rimpiazzato il drone abbattuto
Il drone Usa caduto
ieri nel Mar Nero dopo un incidente con un caccia russo è già stato sostituito
da un altro velivolo, lo afferma il portavoce delle forze aeree ucraine,
colonnello Yuriy Ignat. "L'aviazione statunitense nel Mar Nero è permanente. Il
Mar Nero non è un mare interno della Russia", ha dichiarato Ignat a un programma
di informazione congiunto trasmesso dalle stazioni televisive ucraine e
riportato da Ukrainska Pravda.
Il portavoce
militare ha aggiunto che gli Stati Uniti "valuteranno l'incidente" che ha
coinvolto il drone da ricognizione MQ-9 Reaper, che ha anche capacità di
combattimento, e il caccia russo Su-27, ma ha detto che "un altro drone sta già
operando nel sito del ricognitore abbattuto".
10:47
Usa, gruppo
bipartisan di senatori spinge per l'invio di jet F-16 all'Ucraina
Un gruppo di
senatori statunitensi bipartisan sta facendo pressioni sul Pentagono per inviare
jet F-16 in Ucraina. In una lettera al Segretario alla Difesa Lloyd Austin,
ottenuta dal giornale statunitense Politico, otto senatori hanno scritto che il
conflitto tra Russia e Ucraina è "ora in un momento critico", sostenendo che i
caccia F-16 potrebbero dare a Kiev un vantaggio mentre l'invasione a tutto campo
di Mosca entra nel secondo anno. "Dopo aver parlato alla Conferenza sulla
sicurezza di Monaco il mese scorso con i leader statunitensi, ucraini e
stranieri che lavorano per sostenere l'Ucraina - affermano i senatori -
riteniamo che gli Stati Uniti debbano attentamente prendere in considerazione la
fornitura di aerei F-16. Questa dotazione potrebbe rivelarsi un punto di svolta
sul campo di battaglia".
10:57
Nato: è vicino il
via libera della Turchia alla Finlandia
La Turchia intende
approvare la richiesta di adesione della Finlandia alla Nato - indipendentemente
da quella della Svezia - prima delle elezioni parlamentari e presidenziali che
si terranno il 14 maggio, lo hanno detto a Reuters due funzionari turchi.
È molto probabile
che il Parlamento turco ratifichi l'adesione della Finlandia alla Nato prima che
si chiuda a metà aprile per le elezioni, hanno detto le fonti.
11:19
Mosca, esercitazione
di 10 jet russi sopra Kaliningrad
Oltre dieci jet
militari russi della flotta del Mar Baltico, tra Su-27 e Su-30SM, hanno condotto
oggi un'esercitazione nel cielo sopra Kaliningrad per simulare l'intercettazione
e la distruzione di obiettivi nemici convenzionali. Lo ha reso noto il servizio
stampa della flotta citato dall'agenzia Tass.
11:36
Kiev, abbattuto un
aereo russo vicino Bakhmut
Le forze ucraine
hanno abbattuto un aereo militare russo vicino Bakhmut. Lo riferisce via
Telegram il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak,
scrive Ukrinform.
11:47
Wagner, conquistata
un'altra località vicino a Bakhmut
Le forze russe hanno
conquistato un'altra località nei pressi di Bakhmut, quella di Zaliznyanskoye.
Lo afferma Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, citato
dall'agenzia Ria Novosti.
11:49
Regno Unito: jet
russo intercettato era fuori dallo spazio aereo estone
Era fuori dallo
spazio aereo dell'Estonia, seppure nelle vicinanze dei confini, l'aereo militare
russo da rifornimento Il-78 Midas in volo tra San Pietroburgo e l'enclave russa
di Kaliningrad intercettato nelle scorse ore congiuntamente da due caccia Nato,
uno della Raf britannica e da uno dell'aviazione tedesca, nella "prima
operazione condotta insieme dai 2 Paesi". Lo precisa la Bbc citando fonti del
ministero della Difesa di Londra, secondo cui il blitz e avvenuto "vicino" ai
cieli estoni. La motivazione addotta per l'intercettamento è che l'equipaggio
dell'Il-78 avrebbe "ignorato di comunicare con il controllo aereo" di Tallinn.
11:59
Russia: Transneft,
"ordigni esplosivi" su oleodotto a confine
Ordigni esplosivi,
probabilmente sganciati da droni, sono stati trovati presso la stazione di
pompaggio del petrolio di Novozybkovo dell'oleodotto russo Druzhba nella regione
di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato la compagnia Transneft,
operatore dell'infrastruttura.
Secondo la
compagnia, scopo dell'attacco era uccidere persone. Attualmente, ha specificato
Transneft, la stazione non sta pompando petrolio. I media russi riferiscono che
non ci sono feriti e sull'accaduto sono state aperte indagini.
12:12
Cremlino: nessun
contatto di alto livello con gli Usa sul drone
Non ci sono stati
contatti ad alto livello tra la Russia e gli Stati Uniti sull'incidente avvenuto
ieri nei cieli sul Mar Nero che ha portato alla distruzione di un drone
americano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia russa Ria Novosti.
12:24
Cremlino smentisce:
nuovi arruolamenti non sono in discussione
In Russia "non è in
discussione" un'eventuale nuova ondata di arruolamenti nell'ambito della
mobilitazione militare parziale introdotta nel settembre scorso. Lo ha detto il
portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che un sito russo, Ura.ru, ha
scritto che a partire dal primo aprile comincerà una campagna di arruolamenti di
400mila professionisti da integrare nelle forze russe, secondo i piani già
previsti.
12:40
Nato, Erdogan
rassicura la Finlandia: "Manterremo la parola data"
Il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan rassicura la Finlandia, aspirante membro Nato, rispetto al
fondamentale via libera della Turchia all'allargamento. "Faremo tutto quello che
ci tocca. Manterremo la parola data", ha detto Erdogan oggi, alla vigilia della
visita in Turchia del presidente finlandese Sauli Niniisto.
12:57
Putin: "La
situazione nelle nuove regioni rimane difficile"
La situazione nelle
nuove regioni russe (quelle ucraine annesse con referendum, ndr) "rimane
difficile, è necessario rafforzare le autorità locali". Lo ha dichiarato il
presidente russo, Vladimir Putin, riferendosi alle quattro regioni ucraine
annesse da Mosca con un referendum non riconosciuto dalla comunità
internazionale. Putin sta parlando a una riunione del collegio della procura
generale.
13:12
Media: il drone Usa
colpito dai russi è partito dalla Romania
Il drone Usa MQ-9
Reaper è partito dalla Romania e volava a un'altitudine di circa 7.500 metri sul
Mar Nero quando è stato intercettato dai jet russi. Lo riportano diversi media,
tra cui New York Times e Abc News, che cita un funzionario dell'Air Force
americana. Droni di questo genere solitamente decollano dalla basi Nato di
Câmpia Turzii (Romania), Larissa (Grecia) e Signonella (Italia).
13:25
Casa Bianca: "Il
drone americano potrebbe non essere mai recuperato"
Il drone di
sorveglianza americano MQ-9 che si è schiantato nel Mar Nero non è stato
recuperato e potrebbe non essere mai recuperato, ha detto alla Cnn il portavoce
della Casa Bianca John Kirby. "Non è stato recuperato. Non sono sicuro che
riusciremo a recuperarlo. Dove è caduto nel Mar Nero ci sono acque molto
profonde. Quindi stiamo ancora valutando se ci possa essere qualche tipo di
sforzo di recupero. E potrebbe non esserci", ha detto Kirby. E ha aggiunto:
"Abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre al minimo qualsiasi valore di
intelligence che potrebbe derivare se qualcun altro mette le mani su quel
drone".
13:53
Russia, Senato
approva ddl contro critiche a miliziani Wagner in Ucraina
Il Consiglio della
Federazione - la camera alta del Parlamento russo - ha approvato un ddl che mira
a estendere la censura sul conflitto in Ucraina. La legge, che prevede fino a 15
anni di reclusione per la diffusione di notizie sull'esercito che le autorità
russe dovessero ritenere "false" e fino a 7 anni per diffamazione dei militari,
verrebbe infatti estesa anche a informazioni riguardanti gruppi di volontari e
miliziani che combattono in Ucraina dalla parte delle forze del Cremlino, e
quindi pure al Gruppo Wagner, i cui mercenari sono accusati di crimini di
guerra. Per diventare legge, il ddl deve essere ora firmato da Putin.
14:19
Usa: 9 Paesi
intendono inviare 150 tank Leopard all'Ucraina
Nove paesi intendono
trasferire più di 150 carri armati Leopard in Ucraina. Lo ha dichiarato il
ministro della Difesa statunitense Lloyd Austin, aprendo la decima riunione del
Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (il cosiddetto 'formato
Ramstein'), che si svolge in videoconferenza.
"Solo negli ultimi
tre mesi, i membri di questo gruppo di contatto hanno dimostrato una leadership
eccezionale nel costruire le capacità di cui l'Ucraina ha bisogno per difendere
la propria sovranità e per costruire lo slancio sul campo di battaglia", ha
affermato Austin.
"La coalizione di
Paesi che forniscono all'Ucraina carri armati Leopard continua a crescere. Ora 9
Paesi si sono impegnati a fornire più di 150 carri armati Leopard", ha aggiunto
Austin. Probabilmente il riferimento è sia ai Leopard 1 che 2.
14:39
Kiev, abbattuto
aereo russi Su-24 vicino Bakhmut
I soldati della
93sima brigata meccanizzata separata hanno abbattuto un bombardiere tattico
supersonico russo Su-24 vicino a Bakhmut nell'oblast di Donetsk. Lo ha detto la
portavoce della brigata Iryna Rybakova, come riporta Kiev Independent.
Il capo dell'ufficio
presidenziale ucraino Andrii Yermak ha pubblicato in precedenza un video su
Telegram con l'abbattimento dell'aereo. Il filmato mostra che il pilota
dell'aereo è riuscito a espellersi con un paracadute. Lo stato maggiore delle
forze armate ucraine ha riferito che la Russia ha perso 304 aerei e 289
elicotteri dall'inizio della guerra.
15:03
Russia: 'incendiò
centro reclute', condannato a 13 anni
Un tribunale
militare russo ha condannato a 13 anni di reclusione, di cui 10 in "regime
severo", un uomo di 22 anni accusato di aver incendiato un ufficio di
reclutamento a Lukhovitsy, nella regione di Mosca: lo riporta la Tass.
Secondo l'agenzia di
stampa statale russa, l'uomo, identificato come Kirill Butylin, è stato accusato
di "vandalismo", "terrorismo" e "inviti pubblici a effettuare attività
terroristiche". Secondo la Tass, si tratta del primo caso di incendio di un
centro di reclutamento russo dall'inizio della guerra in Ucraina.
Stando agli
investigatori, Butylin avrebbe lanciato delle molotov contro l'ufficio di
reclutamento il 28 febbraio dell'anno scorso e sarebbe poi andato in
Bielorussia.
15:10
Ucraina: Mosca,
cercheremo di recuperare resti drone Usa
"Ci sono le
possibilità tecniche per recuperare i resti del drone americano precipitato ieri
e studiarlo. Lo ha affermato il direttore del Russian Foreign Intelligence
Service, Serghei Naryshkin, citato da Ria Novosti.
"Mi sembra che ci
siano tali possibilità tecniche", ha spiegato.
15:19
Iniziato l'incontro
Putin-Assad a Mosca
E' iniziato a Mosca
l'incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo
siriano, Bashar al Assad: lo riporta l'Afp citando la tv di Stato russa.
15:28
Austin, nove Paesi
pronti a inviare 150 Leopard
"La coalizione è
unita e resta impegnata ad aiutare l'Ucraina finché necessario": lo ha detto il
capo del Pentagono Lloyd Austin aprendo la decima riunione in formato virtuale
del gruppo di contatto sull'Ucraina, dove ha annunciato che nove Paesi intendono
trasferire più di 150 carri armati Leopard in Ucraina. "La coalizione di Paesi
che forniscono all'Ucraina carri armati Leopard continua a crescere", ha
proseguito, ringraziando poi vari Paesi per i loro differenti contribuiti,
compresa l'Italia.
15:43
Patrushev:
"Proveremo a recuperare relitto drone Usa"
La Russia proverà a
recuperare il relitto del drone americano MQ-9 caduto ieri nel Mar Nero per
studiarlo. Lo ha sottolineato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di
sicurezza della Federazione Russa, in un'intervista sul canale
televisivo Rossiya-1. "Non so se saremo in grado di recuperarlo o meno, ma è
quello che dobbiamo fare e ce ne occuperemo", ha detto Patrushev, rispondendo
alla domanda se la Russia possa trovare il velivolo senza pilota. "Spero,
ovviamente, in un successo", ha aggiunto.
16:03
Assad, "Siria
sostiene operazione militare speciale russa"
La Siria sostiene la
decisione della Russia di condurre la cosiddetta operazione militare speciale in
Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente siriano Bashar al-Assad in un incontro
con il suo omologo russo Vladimir Putin a Mosca. "Voglio cogliere l'occasione,
perché questa è la mia prima visita dopo l'operazione speciale, per ribadire la
posizione siriana a sostegno dell'operazione speciale", ha detto il presidente
siriano. Come riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, Assad ha anche affermato
che "la situazione nel mondo deve essere stabilizzata".
16:19
Media, piano russo
per controllare la Moldavia entro il 2030
Mosca ha elaborato
una strategia per destabilizzare la Moldavia, prenderla sotto il suo controllo
politico e allontanarla dai partner occidentali entro il 2030. Lo rivela un
documento di strategia interna dall'amministrazione presidenziale di Putin
ottenuto da un consorzio di media, tra cui Suddeutsche Zeitung e Yahoo News. Il
testo, elaborato nel 2021, proviene dalla stessa 'Direzione presidenziale per la
cooperazione transfrontaliera' che ha prodotto una strategia simile sulla
Bielorussia. L'obiettivo finale entro il 2030 è la "creazione di gruppi di
influenza filo-russi stabili nelle élite politiche ed economiche moldave".
16:39
Finlandia, Ankara ha
preso decisione su nostra adesione a Nato
La Turchia ha preso
la sua decisione sull'adesione di Helsinki alla Nato, che sarà annunciata
ufficialmente venerdì in occasione della visita del presidente finlandese Sauli
Niinisto. Lo ha fatto sapere la Finlandia stessa. Il presidente turco Recep
Tayyip Erdogan ha già fatto intendere che risponderà positivamente alla
richiesta di adesione di Helsinki. Discorso diverso invece per la Svezia: la
Turchia ha sospeso i negoziati con Stoccolma dopo le proteste di gennaio contro
Ankara, i colloqui sono tuttavia ripresi a Bruxelles il 9 marzo.
16:43
La Wagner ha messo
una taglia sul ministro Crosetto
Il gruppo della
brigata russa Wagner ha istituito una taglia sul ministro della Difesa Guido
Crosetto. È quanto comunicato allo stesso ministro una decina di giorni fa, dopo
una segnalazione dei servizi di intelligence italiani. A quanto si apprende, non
sarebbe stata aumentata la sua scorta. Secondo quanto scrive il Foglio, che ha
anticipato la notizia, la taglia sarebbe di circa 15 milioni di dollari.
17:13
Kiev, volontari
cercano corpi di russi da scambiare con ucraini
Si fanno chiamare il
'Tulipano nero' e sono un gruppo di volontari ucraini che, dall'inizio della
guerra, raccoglie corpi di soldati russi da scambiare con quelli di Kiev. Nella
storia, raccontata dal Guardian, viene spiegato che un soldato non può essere
dichiarato morto dallo Stato finché non c'è un corpo. I volontari agiscono
soprattutto a Krasnopillia, nel Donetsk, ma la zona è molto pericolosa essendo
stata teatro di diverse battaglie e avendo sul suo terreno ancora molte mine
antiuomo disseminate. Dall'inizio dell'invasione il 'Tulipano nero' ha affermato
di aver dissotterrato i corpi di 311 soldati russi.
Lo scambio di corpi
tra Russia e Ucraina è un processo segreto e il totale delle operazioni non è
stato reso noto da nessuna delle due parti. Questi avvengono al confine tra i
due Paesi e vengono supervisionati dai due eserciti. In alcuni casi alle
operazioni ha preso parte anche il Comitato internazionale della Croce Rossa che
si impegna affinché i soldati possano essere identificati e restituiti alle loro
famiglie. Alle volte questo passaggio è complicato. Come hanno spiegato i
volontari, infatti, i cadaveri russi vengono occasionalmente trovati bruciati, a
volte dalla popolazione locale per motivi igienici, ma spesso anche
dall'esercito russo, nel tentativo di nascondere le perdite. Secondo i servizi
di sicurezza ucraini sarebbero migliaia i russi eliminati in modo informale
poiché il Cremlino li registra come "dispersi in azione".
17:45
Klitschko all'Ansa,
"Kiev è ancora viva, Mosca ha fallito"
"Abbiamo lavorato
notte e giorno, abbiamo dovuto calcolare e prevedere qualsiasi situazione, anche
gli scenari peggiori. Un paio di mesi sono stati particolarmente difficili. Ma
abbiamo tenuto tutto sotto controllo e i russi non ce l'hanno fatta, nonostante
abbiano lanciato oltre 800 razzi verso la nostra città". Lo dice il sindaco
di Kiev, Vitali Klitschko, ricordando in una conversazione con l'Ansa l'ultimo
anno vissuto nella capitale ucraina.
18:03
Usa hanno cancellato
software drone
Gli americani hanno
cancellato da remoto il software del drone Mq-9 Reaper prima che cadesse nel mar
Nero, in modo da impedire ai russi di raccogliere informazioni riservate nel
case riescano a ripescarlo. Lo riferisce la Cnn, citando due funzionari
americani, a proposito della collisione di ieri fra il drone e un aereo militare
russo.
18:35
Lavrov, Usa ignorano
limitazioni per aerei in Mar Nero
"Gli Stati Uniti
ignorano completamente il fatto che dopo l'inizio di un'operazione militare
speciale i nostri militari hanno dichiarato le aree rilevanti del Mar Nero come
aree con uno status limitato per l'uso di qualsiasi aereo". Lo ha detto il
ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, intervistato dalla televisione
russa, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti. "Un'ignoranza così
provocatoria di questo fatto oggettivo suggerisce che la parte americana cerca
costantemente una sorta di provocazione per intensificare i suoi approcci
conflittuali", ha aggiunto Lavrov. "Questo è un male perchè (gli americani, ndr)
hanno costantemente dichiarato di essere un potere responsabile, interessato
alla stabilità strategica. Ma le parole sono in contrasto con i fatti", ha
concluso Lavrov.
18:52
Lavrov, Usa cercano
continuamente provocazioni
Gli Stati Uniti
ignorano completamente il fatto che alcune aree al largo della costa del Mar
Nero dopo l'inizio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina
hanno uno status limitato per i voli e cercano costantemente provocazioni. E' la
lettura del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dell'abbattimento di un
drone statunitense sui cieli del mar Nero. "(Gli Stati Uniti) ignorano
completamente il fatto che dopo l'inizio dell'operazione militare speciale, i
nostri militari hanno dichiarato le aree del Mar Nero adiacenti alla costa come
zone limitate all'utilizzo da parte di qualsiasi aereo. Gli americani ignorano
provocatoriamente questo fatto oggettivo e cercano costantemente provocazioni
per intensificare il loro approccio conflittuale", ha detto Lavrov, intervistato
dalla televisione russa. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti.
19:12
Colloquio telefonico
tra ministri della Difesa Usa-Russia
Il ministro della
Difesa russo Sergei Shoigu ha tenuto conversazioni telefoniche con il suo
omologo americano Lloyd Austin. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo,
specificando che il colloquio è avvenuto su iniziativa della parte americana.
"Il 15 marzo 2023, su iniziativa della parte americana, si sono svolte
conversazioni telefoniche tra il ministro della Difesa della Federazione Russa
Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America, Lloyd
Austin", riferisce il ministero citato dalla Tass.
19:22
Moldavia, filorussi
bloccano ancora le strade del Paese
Continuano le
tensioni in Moldavia, fomentate dal Movimento per il popolo, che ha alle spalle
il partito filorusso Sor. Secondo quanto riporta il sito moldavo Newsmaker, oggi
i manifestanti sono tornati a bloccare le strade del Paese con dei flash mob che
hanno avuto luogo sia sulle vie cittadine che su quelle provinciali. Gli slogan
sono sempre gli stessi, contro Maia Sandu e il caro-bollette. Secondo le
informazioni diffuse, le azioni si stanno svolgendo a Glodeni, Briceni,
Cimislia, Floresti, Soldanesti, Calarasi, Balti e in altre parti del Paese
insediamenti. Domani si prevede un'altra giornata di tensioni. Il Movimento per
il popolo ha infatti annunciato che si troverà nuovamente davanti al parlamento,
alle 11, per chiedere che il governo soddisfi "l'iniziativa legislativa firmata
da oltre 713.000 cittadini che hanno firmato la proposta del Movimento per il
popolo di far pagare integralmente le bollette" al Pas, il Partito di azione e
solidarietà al governo.
19:47
Austin conferma
telefonata con Shoigu, continueremo a volare dove consentito
Il segretario alla
Difesa Usa, Lloyd Austin, ha confermato il colloquio telefonico col ministro
della Difesa russo Shoigu. "Come ho ripetuto più volte, è importante che le
grandi potenze siano un modello di trasparenza e comunicazione e gli Stati Uniti
continueranno a volare e operare ovunque le leggi internazionali lo consentono",
ha detto il capo del Pentagono in un briefing, riferendo dei contenuti della
telefonata.
20:24
Dipartimento di
Stato Usa, incidente drone sembra non intenzionale
"Penso che la
migliore valutazione in questo momento sia che probabilmente non è stato
intenzionale. Probabilmente è stato il risultato di una profonda incompetenza da
parte di uno di questi piloti russi": così il portavoce del dipartimento di
stato Usa Ned Price in un'intervista a Msnbc.
20:43
Usa, drone caduto
nel Mar Nero "non ha più valore di intelligence"
Il drone caduto ieri
nel Mar Nero dopo essere entrato in collisione con due caccia russi "non ha più
valore" di intelligence. Lo ha detto il capo degli Stati maggiori riuniti
americano, il generale Mark Milley, in un briefing con i giornalisti.
"Probabilmente si è rotto, probabilmente non c'è molto da recuperare,
francamente - ha sottolineato - Per quanto riguarda la perdita di informazioni
sensibili, come di consueto prenderemo - e abbiamo preso - delle misure di
attenuazione. Quindi siamo abbastanza fiduciosi che tutto ciò che era di valore
non lo sia più". Milley ha detto che l'intelligence sa dove è finito il drone
nel Mar Nero e che probabilmente si trova a quattro o cinquemila piedi (tra i
1.300 ed i 1.600 metri) sotto la superficie, il che renderebbe le operazioni di
recupero "molto difficili" per chiunque. Tra l'altro, ha riferito il generale,
gli Stati Uniti "non hanno navi lì, ma abbiamo molti alleati e amici nell'area".
21:15
Shoigu ad Austin,
l'incidente del drone per violazione Usa
L'incidente con il
drone è stato causato dal mancato rispetto da parte degli Stati Uniti delle
restrizioni ai voli che la Russia ha stabilito per alcune zone. Lo ha detto il
ministro della Difesa russo Sergei Shoigu al suo omologo statunitense Lloyd
Austin nel colloquio telefonico di oggi, secondo quanto riferito dal ministero
della Difesa russo citato dalla Tass.
21:51
Russia "reagirà
proporzionatamente" a provocazioni
La Russia reagirà
"in maniera proporzionata" a qualsiasi futura "provocazione" statunitense. Lo fa
sapere in una nota il ministero della Difesa russa, all'indomani dello schianto
di un drone americano precipitato nel Mar Nero. "I voli di veicoli aerei senza
pilota strategici americani al largo della costa della Crimea sono di natura
provocatoria, il che crea i presupposti per un'escalation della situazione nella
zona del Mar Nero", si legge nel comunicato. "La Russia non è interessata a un
tale sviluppo di eventi, ma continuerà a rispondere in maniera proporzionale a
tutte le provocazioni".
22:17
Ucraina: colloquio
fra capi di Stato maggiore Russia e Usa
Conversazione
telefonica fra i capi di Stato maggiore russo e americano, Valery
Gerasimov e Mark Milley. Lo riporta la Tass citando una nota del ministero della
Difesa russo.
Dalla guerra
ibrida al gruppo Wagner: il dossier che svela le mire russe.
Il Copasir nel 2022
indicava nelle attività di Wagner in Africa uno strumento di "guerra ibrida"
russo. Andrea Muratore il 15 Marzo 2023 su Il Giornale
Le dichiarazioni del
ministro della Difesa Guido Crosetto sul ruolo presunto dei mercenari russi
del Gruppo Wagner nel sostegno all'immigrazione clandestina hanno suscitato
scalpore e fatto discutere molto la politica e i media negli ultimi giorni.
Tanto da portare alla piccata risposta del capo della Wagner, Yevgeny Prighozin,
che ha seccamente negato il ruolo dei suoi uomini nello scatenamento della corsa
all'immigrazione che caratterizza l'Africa del Nord.
Quale che sia la
realtà, è indubbio che la Russia abbia delle mire sull'Africa tutt'altro che
indifferenti. E che al contempo le mosse di Mosca nel Maghreb e nel Sahel siano
da tempo nel mirino degli apparati di sicurezza, politici, militari e
d'intelligence, a disposizione del sistema-Paese.
Cosa contiene il
dossier del Copasir
Una prova di questo
fatto è la relazione sulle attività svolte nel 2021 dal Comitato Parlamentare
per la Sicurezza per la Repubblica, pubblicata nel febbraio 2022, poche
settimane prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Il dossier è stato presentato
da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia ai tempi presidente del Copasir e
oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata del 9 febbraio
2022. Al suo interno il Copasir indicò nell'assertività della Russia sul
continente africano una potenziale causa di destabilizzazione di sistema.
Nella corposa
relazione di 120 pagine il Copasir, a pagina 52, scrive esplicitamente: "La
Russia, considerata la principale minaccia verso Est, ha intrapreso ormai da
qualche anno diverse iniziative assertive da Sud: una presenza con forze navali
nel Mediterraneo; una presenza con truppe e l’occupazione di basi in Siria;
interventi in Libia, Repubblica Centrafricana e Mali di forze militari proprie o
ad esse collegate, come la compagnia Wagner", di cui già ai tempi si iniziava a
intuire la proiezione internazionale. Il Copasir non metteva in correlazione
diretta la presenza della Wagner in diversi teatri bellici e la questione
dell'immigrazione clandestina. Tuttavia, poneva in essere delle questioni di
merito riguardanti la minaccia indiretta imposta dalla presenza
russa nell'Africa settentrionale e sub-sahariana.
La relazione sulle
attività svolte nel 2021 dal Copasir
Per il Copasir gli
interventi russi nella regione del Sahel "hanno l’obiettivo di contrastare e
porsi come alternativa alle operazioni dei Paesi occidentali in un’area
delicatissima, considerata come il confine meridionale d’Europa, da cui
originano alcune grandi minacce quali l’enorme instabilità degli Stati
saheliani, il terrorismo di stampo jihadista e l’immigrazione clandestina".
Tutte minacce di sistema legate al buco nero geopolitico della Libia, del Sahel
e delle regioni circostanti in cui gli interventi militari di Europa e Usa e
l'insorgenza jihadista hanno creato sfiducia nelle classi dirigenti locali e nei
rapporti con l'Occidente, oltre a trasformare molti di questi Paesi in stati
falliti.
I rischi della
guerra ibrida
La relazione Copasir
non fa riferimento a episodi specifici ma il comitato di Palazzo San Macuto
sottolinea che "tali elementi entrano a far parte della guerra ibrida che
minaccia l’Unione europea e la sua coesione". Ancor prima della Libia, il
Paese-chiave per la sicurezza regionale del quadrante mediterraneo e africano è
indicato il Mali, epicentro della penetrazione di Wagner, ove il ritiro delle
forze armate francesi ivi presenti ha lasciato spazio ai russi di dettare legge:
"Questo scenario problematico – a fronte di una situazione caratterizzata dalla
presenza di gruppi jihadisti che operano travalicando le frontiere, anche
sfruttando le crisi politiche presenti nei Paesi saheliani – potrebbe infatti
provocare un effetto domino sugli Stati vicini con conseguenze anche sui flussi
migratori e sui traffici illegali", fa notare la relazione del comitato di
controllo e garanzia sui servizi segreti italiani (a pagina 64).
In quest'ottica, va
aggiunto che l'attuale Relazione annuale del Dipartimento per le Informazioni
della Sicurezza (Dis) che coordina i servizi segreti italiani indica anche nel
Sudan un quarto Paese africano di riferimento degli interventi militari
all'estero. Non c'è, né nella relazione Copasir né in quella Dis, tra i Paesi di
riferimento della Wagner in Africa la maggiore fonte di incremento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, la Tunisia, per quanto entrambi i
rapporti si focalizzino sulla necessità di una sua stabilità e sui problemi che
un crollo politico a Tunisi potrebbe rappresentare per l'Italia.
Per il Copasir, in
particolare, "flussi migratori dal Paese, principalmente verso l’Italia, non
possono non risentire della complessa situazione interna e sono in continuo
aumento". Ma nonostante tutto, gli obiettivi della Russia in Africa sono noti e
in via di perseguimento alla luce del sole da tempo. E l'Italia, Paese
interessato alla stabilità del nord del continente, fa bene a tenere gli occhi
opportunamente aperti sulle tensioni regionali, specie se di derivazione
esterna.
La guerra dai mille volti.
Nei giorni scorsi,
di fronte al moltiplicarsi degli sbarchi, i ministri Antonio Tajani e Guido
Crosetto hanno ipotizzato che dietro il fenomeno ci sia una ben precisa
strategia dei mercenari della "Wagner". Augusto Minzolini il 15 Marzo 2023 su Il
Giornale
Nei giorni scorsi,
di fronte al moltiplicarsi degli sbarchi di immigrati clandestini provenienti
dall'Africa, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa,
Guido Crosetto (che non rilasciava interviste dal 26 gennaio, a dimostrazione
del fatto che è stata un'uscita meditata), hanno ipotizzato che dietro il
fenomeno ci sia una ben precisa strategia dei mercenari della «Wagner», cioè del
Cremlino.
L'analisi non è
peregrina perché nel continente africano le brigate filo-russe (con le loro
alleanze) sono ben presenti, controllano Stati dalla Cirenaica al Mali. Facile
intravvedere l'obiettivo: destabilizzare l'Italia e l'Europa nell'ottica del
conflitto in Ucraina. Né tantomeno bisogna meravigliarsi del cinismo: gli «scudi
umani» sono un portato spietato delle ultime guerre dove il senso dell'onore è
venuto meno, figurarsi se oggi qualcuno a Mosca si fa scrupoli ad usare un nuovo
strumento nella guerra ibrida.
L'analisi
preoccupata dei due ministri non è campata in aria: non ci sono prove evidenti,
ma parte da basi logiche. Anche i nostri servizi segreti ne sono convinti. Solo
che se le parole hanno un senso, se davvero i mercenari della Wagner o chi per
loro hanno il potere di aprire e chiudere i rubinetti dell'immigrazione
clandestina, bisogna essere conseguenti. E, contro un'azione che risponde ad una
logica di guerra, è necessario usare strumenti di difesa di un certo livello.
Non ci vuole molto ad immaginare che l'organizzazione più adatta sia la stessa
che sta garantendo l'Ucraina, cioè la Nato. Anche perché la destabilizzazione di
un Paese come il nostro può avere ripercussioni per tutta l'Alleanza. Senza
contare che un'ondata di 600-800mila immigrati si propagherà nel Vecchio
continente e tra loro - è il sospetto degli 007 - potrebbero mischiarsi anche
terroristi. Per cui o il fenomeno è gestito (e non basta l'impegno della sola
Italia), o crea problemi a tutti.
Siamo di fronte ad
un salto di qualità del problema immigrazione ed è evidente che un intervento
della Nato può avere effetti più efficaci di quello della nostra Marina: sia per
il salvataggio in mare, sia per l'eliminazione dei barconi sulle coste del
Nord-Africa (basta pensare all'uso dei droni). Inoltre la Nato avrebbe
l'autorità per chiedere ad uno Stato membro come la Turchia di intervenire per
bloccare la partenza degli scafisti dalle sue coste o da quelle che controlla in
Libia e, magari, organizzare corridoi umanitari per i rifugiati.
L'Africa è una
polveriera. Il fronte meridionale dell'Alleanza, quello che ci riguarda
direttamente, è vulnerabile. Per cui c'è bisogno di un maggiore impegno: la Nato
non può occuparsi solo del conflitto russo-ucraino. Nell'epoca delle guerre
asimmetriche, quel conflitto si combatte anche in Africa. In tanti modi,
appunto. E in quel continente l'Occidente ha perso molto terreno, in favore di
Russia e Cina. Per errori (il caso Gheddafi) o per disinteresse. Ora deve
riconquistarlo per non scoprire a sue spese che la guerra da quelle parti ha
mille volti.
Il drone
abbattuto e l'aereo russo in Estonia, incidenti di percorso che possono far
esplodere tutto (General Atomics).
Sergio Barlocchetti
su Panorama il 15 Marzo 2023.
Il drone abbattuto e
l'aereo russo in Estoni incidenti di percorso che possono far esplodere tutto
16/03/23, 07:02 Il drone abbattuto e l'aereo russo in Estonia, incidenti di
percorso che possono far esplodere tutto - Panorama
https://www.panorama.it/Tecnologia/difesa-aerospazio/drone-abbattuto-russia-usa-estonia
2/8
La vicenda del drone americano abbattuto dall’aviazione russa si può
interpretare come una scaramuccia inevitabile in tempi come questi, soprattutto
in un’area geografica come quella del Mar Nero, stretta tra la Turchia, dove gli
Usa hanno basi militari attive, l’Europa dell’Est e i territori contesi da russi
e ucraini. Già la ricostruzione dei fatti è complessa, poiché c’è chi sostiene
che lo M Reaper americano sia stato abbattuto, e chi riferisce che la coppia di
Sukh che l’ha avvicinato l’avrebbe semplicemente danneggiato, costringendo i
piloti Usa ad abbatterlo per evitare una perdita di controllo pericolosa e,
soprattutto, che i resti potessero finire in mani russe. Perché il fatto
determinante è che fosse un drone per intelligence, ovvero per la raccolta
informazioni, fossero esse di tipo fisico come il riscontro della posizione
unità navali o altro, oppure elettromagnetico, cioè emissioni che dimostrare la
presenza di radar o altri sistemi di trasmissione. Il tutto, probabilmente
fornire a Kiev un altro vantaggio. Sta di fatto che nella prima mattinata di un
caccia Sukhoi Su-27 russo sarebbe entrato volontariamente in collisione con il
Reaper mentre questo era in volo sul Mar Nero seppure rimanendo n spazio aereo
internazionale, anche se a soli sessanta chilometri dalla base navale russa di
Sebastopoli. Una distanza enorme per qualsiasi congegno ottico, ma praticamente
nulla per le emissioni radio, facili da rilevare. Sulla dinamica dell’incidente
la narrazione varia da quanto riferito dai russi che parlano di avaria
indipendente dalla loro presenza, fino alla versione secondo la quale uno dei
piloti avrebbe scaricato carburante davanti al drone poi danneggiato la sua
elica, di fatto abbattendolo. Secondo il generale Pa Ryder, addetto stampa del
Pentagono, la coppia di velivoli militari russi avrebbero volato intorno al
drone almeno per 40 minuti prima che avvenisse la collisione. Non è certamente
una novità che piloti di aerei mi affianchino grandi droni per osservarli,
quello che rende questa storia div è la “provocazione” russa, che tuttavia non
può di per sé costituire un valido motivo per una escalation militare tra le due
potenze nucleari. Ma, semmai distogliere l’attenzione occidentale da quanto
avviene in Donbass e sul fronte della guerra. Il generale James Hecker, a capo
dell’aviazione Usa in Europa, ha dichiara “Il nostro MQ-9 stava conducendo
operazioni di routine nello spazio aere internazionale quando è stato
intercettato e colpito, provocando un incidente la completa perdita del mezzo,
poiché a causa dei danni subiti abbiamo do farlo precipitare nel Mar Nero”. Il
ministero della Difesa russo ha invece negato di essere entrato in contatto con
il drone, affermando che i due Su probabilmente decollati da una base della
Crimea, “si sono affrettati a intercettare e identificare l’intruso” dopo averlo
rilevato mentre sorvolava il Mar Nero con i sistemi di identificazione spenti,
violando i confini dello s aereo temporaneamente segregato dalla Difesa russa
perché teatro opera dell’operazione militare speciale”. Infine, Mosca ha
confermato che il pil coinvolto nell’incidente è atterrato senza danni, anche se
non è stato detto dove. Gli americani hanno sempre giustificato la presenza dei
droni nello spazio aereo dell’area con la necessità di aiutare le forze aeree
romene (e non sol quelle, anche quelle di Estonia, Polonia e Grecia), a
mantenere il miglior controllo possibile dello spazio aereo circostante. Ma
certo questo potrebbe valere per la costa ovest, raggiunta spesso da MQ-9 in
decollo dalla base da Sigonella, in Sicilia, non certo per la parte centrale
del mare dove l’incidente avvenuto, circa 500 chilometri più a est. Perché
dunque gli Usa fanno vola questi droni così lontano dal fronte e dai territori
alleati? La risposta è che momento è perfetto per venderli, dimostrando ai
potenziali clienti la loro efficacia, e al contempo – ma non si può dimostrare –
per aiutare con informative puntuali le forze ucraine dando loro grande
vantaggio. Ora però è necessario recuperare il relitto, poiché a bordo ci sono
sistemi elettronici con tecnologia classificata e certo lo sforzo americano per
riuscire non sarà di poco conto, stante che i russi ben difficilmente daranno
l’asse unità navali Usa per entrare in quelle acque. Di fatto, seppure il
Dipartimento di Stato abbia convocato l’ambasciatore russo per riferire
sull’episodio, il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin non ne ha
ovviamente anco potuto discutere con il suo omologo russo Sergei Shoigu. Ma la
posizione americana è ferma su un punto: per loro l’area segregata
dell’Operazione Speciale non esiste e l’Usaf continuerà a volare in quello che
viene definito spazio aereo internazionale. Non è certo il primo drone che gli
Usa perdono: nel 2019 uno RQ-4 Global Hawk (più grande di quello caduto nel Mar
Nero) mentre volava per dimostrazione sopra lo stretto di Hormuz, forse per mano
iraniana, spinge il presidente Donald Trump a minacciare una ritorsione militare
che tutta non avvenne mai: gli Usa dissero che fu per evitare vittime civili,
gli iraniani negarono di aver provocato l’incidente. Intanto questa mattina una
pattuglia formata da velivoli Eurofighter Typh del Regno Unito e della Germania
ha intercettato un velivolo russo che decollato da San Pietroburgo per
Kaliningrad ha “tagliato” la sua rotta se avvertire il controllo aereo Estone. I
Typhoon occidentali hanno identifica velivolo come uno Iliushin 78 Midas, ovvero
un velivolo per trasporto mil e rifornimento, che volava senza alcuna scorta e
che è poi rientrato in spa aereo russo, mentre un altro “scramble” si rendeva
necessario per identificare uno Antonov 148 che stava per ripetere lo stesso
errore.
Le sanzioni sono
per sempre. Perché l’Europa dovrebbe fermare lo smercio di diamanti che finanzia
il Cremlino.
Matteo Fabbri su L’Inkiesta il 16 Marzo 2023.
Regno Unito e
America hanno già colpito il settore delle pietre preziose, tra i cinque
prodotti che generano maggiori entrate per la Russia. La svolta è attesa al
vertice G20 a maggio. Il Belgio, che ad Anversa ospita il principale mercato del
continente, insiste nel chiedere un tracciamento completo
«Date le entrate
significative che la Russia ricava dall’esportazione di diamanti, ci impegneremo
collettivamente su ulteriori misure sui diamanti russi, compresi quelli grezzi e
lucidati, lavorando a stretto contatto per coinvolgere i partner chiave». I
leader del G7 lo hanno esplicitato nella nota a margine dell’incontro del 24
febbraio mandando un segnale chiaro che, pur non indicando tempi precisi, lascia
presagire che il prossimo incontro delle sette potenze in Giappone nel mese di
maggio, possa essere quello decisivo per estendere le sanzioni anche ai diamanti
russi.
Di fatto, però, i
Paesi del G7 stanno aspettando Bruxelles, visto che Regno Unito e Stati Uniti
hanno già sanzionato il settore, mentre l’Unione europea continua a
tergiversare. Il tema è delicato: l’Europa ha ad Anversa, nel nord del Belgio,
il più grande hub dei diamanti al mondo, attivo dal quindicesimo secolo.
A pochi passi dalla
meravigliosa stazione dei treni della città fiamminga sorge il Diamond District,
una zona relativamente piccola – circa un chilometro quadrato – nella quale
transita l’ottantasei per cento di tutti i diamanti grezzi al mondo e le società
registrate che lavorano e commerciano il minerale sono circa millesettecento. Il
mercato dei diamanti genera scambi per quaranta miliardi di euro, un impatto
economico importante per il Paese sede delle istituzioni europee. Nel 2021
Anversa ha importato dalla Russia diamanti per quasi due miliardi di euro.
Mosca è il primo
esportatore al mondo e il commercio fuori dai confini vale circa quattro
miliardi. Una somma che colloca il minerale tra i primi cinque prodotti che
generano entrate per il Paese, staccato da gas e petrolio, ma con una fetta di
mercato comunque significativa. La russa Alrosa è la più grande compagnia di
estrazione di diamanti al mondo, anche grazie alle ricche miniere siberiane
nella repubblica russa della Jacuzia.
Ovviamente è sotto
il controllo Cremlino. L’amministratore delegato Sergei Ivanov viene considerato
molto vicino a Putin ed è stato uno dei primi oligarchi a essere sanzionato
dagli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Ucraina. In passato Alrosa avrebbe
addirittura finanziato un sottomarino da combattimento che porta il nome della
compagnia.
Il governo belga ha
sempre affermato di non essersi mai opposto esplicitamente a restrizioni sui
diamanti ma viene naturale pensare che se l’Europa sia in ritardo da questo
punto di vista rispetto a Stati Uniti e Gran Bretagna, il Paese che ospita il
più grande hub dei diamanti al mondo possa averci messo lo zampino.
Le osservazioni
sollevate dall’Awdc, il Centro mondiale dei diamanti di Anversa, insistono sul
fatto che imponendo sanzioni al settore non si farebbe altro che spostare il
mercato dall’Europa verso Israele, India ed Emirati Arabi. Paesi dove le pietre
verrebbero lavorate per poi essere rimesse in commercio nei mercati occidentali
non arrecando, di fatto, danni sensibili a Vladimir Putin.
Il Belgio sembra
aver sposato questa linea e insiste nel chiedere che venga eseguito un
tracciamento completo del minerale per poter garantire maggiore trasparenza e
rendere al contempo maggiormente efficaci le sanzioni nei confronti di Mosca. In
effetti questa situazione potrebbe essere l’occasione per stabilire nuovi
standard globali a lungo termine che possano contribuire a riorganizzare il
mercato garantendo un tracciamento sicuro.
Questa è la
soluzione individuata dal Governo belga guidato da Alexander De Croo, che
impedirebbe allo stesso tempo di aggirare le sanzioni. Ancora una volta però si
è preferito rimandare di qualche mese e dei diamanti russi nel decimo pacchetto
non c’è traccia. Anche all’interno dello stesso esecutivo di Bruxelles c’è chi
avrebbe voluto un intervento più tempestivo.
I socialisti
fiamminghi di Vooruit hanno sottolineato più volte come una maggiore
tracciabilità a livello internazionale si rivelerebbe efficace solo se
accompagnata da sanzioni immediate a livello europeo che vadano a colpire
direttamente Alrosa riducendo i flussi economici verso la Russia. Difficile però
pensare che la questione porti alla rottura degli equilibri all’interno della
maggioranza di governo.
Dopo gli enormi
sforzi del blocco dei ventisette per rendersi indipendenti da buona parte delle
fonti energetiche russe (non tutte, fa eccezione ad esempio il settore
nucleare), era lecito aspettarsi più coraggio da parte dell’Unione. Soprattutto
rispetto ad un settore come quello del minerale più prezioso che pur avendo un
forte impatto sull’economia di uno dei ventisette Stati membri, rappresenta un
bene di lusso non paragonabile alle fonti energetiche.
Il fatto che la nota
del G7 abbia citato esplicitamente i diamanti lascia presagire che la pressione
su Bruxelles aumenterà e la prossima riunione delle sette potenze globali in
Giappone potrebbe essere un orizzonte verosimile per estendere le sanzioni anche
ad Alrosa e alle miniere del Cremlino. Sembra che a maggio quindi si arriverà ad
una decisione. Ma nel frattempo i mesi passano e Putin continua a fare affari.
La Repubblica.
Polonia trasferirà 4 MiG-29 nei prossimi giorni. Usa: "Non cambiamo idea su
F-16". Media Usa, dalla Cina armi a Mosca
Gli Usa
pubblicano il video dell'incidente del drone sul Mar Nero. Secondo la Cnn la
marina russa sarebbe in procinto di recuperare i pezzi del drone distrutto
nell'incidente di martedì. Putin agli industriali: "Siamo in una guerra di
sanzioni". Rapporto Onu: la Russia ha commesso crimini di guerra
La tensione nei
cieli d'Europa non si allenta. Dopo l'incidente che ha portato alla distruzione
di un drone americano sul Mar Nero, velivoli russi e della Nato si sono
incrociati anche oggi. Due caccia, uno britannico e uno tedesco, hanno
intercettato un aereo militare russo da rifornimento che volava vicino
all'Estonia. In mattinata il Comando Usa di stanza in Europa ha pubblicato il
video dell'incidente, accusando Mosca di operazione "poco professionale".
Il presidente
russo Vladimir Putin si è rivolto agli industriali del Paese per la prima volta
dopo l'inizio della guerra e ha detto che la Russia si è rivolta a paesi in
crescita per compensare il contraccolpo delle sanzioni.
Punti chiave
17:53
Polonia
trasferirà 4 MiG-29 nei prossimi giorni
15:26
Pechino a Kiev:
"Riprendere colloqui di pace Ucraina-Russia"
14:14
Ucraina, rapporto
Onu: la Russia ha commesso crimini di guerra
13:37
Mosca annuncia un
prelievo una tantum alle imprese a sostegno delle casse dello Stato
13:21
Russia, Putin:
"Abbiamo sviluppato relazioni con Stati in crescita, e compensato così le
chiusure dei mercati occidentali"
12:40
Putin parla per
la prima volta agli imprenditori da Febbraio 2022: "La Russia affronta una
guerra di sanzioni"
11:44
Il Comando Usa in
Europa: "Operazione russa pericolosa e poco professionale"
11:23
Gli Usa
pubblicano il video dell'incidente tra drone americano e jet russo sul Mar Nero
10:10
Ucraina,
l'istituto Isw: "L'offensiva della Wagner a Bakhmut è agli sgoccioli"
09:46
Ucraina, Kiev:
"20 navi russe nel Mar Nero, attività atipica"
09:39
Zelensky ricorda
le vittime dell'attacco al teatro
09:34
Cnn: forze russe
hanno raggiunto il luogo dell'incidente del drone Usa
07:40
Cnn: abbattuto
nell'Est Ucraina un drone civile cinese "riadattato e armato"
23:59
Media: "Israele
approva licenze per vendita sistemi antidrone a Kiev"
Israele avrebbe
approvato le licenze di esportazione per la possibile vendita di sistemi di
disturbo dei droni che potrebbero aiutare l'Ucraina a contrastare i droni
iraniani utilizzati dalla Russia nel conflitto. Lo riporta Ukrainska
Pravda citando il portale di notizie Axios che spiega di aver avuto conferma
della notizia da funzionari israeliani e ucraini. Secondo Axios l'approvazione
delle licenze di esportazione da parte del segretario alla Difesa Yoav Gallan e
del ministro degli Esteri Eli Cohen sarebbe arrivata a metà febbraio, ma una
decisione finale non sarebbe ancora stata presa. In ogni caso - secondo i
funzionari israeliani - non si tratterebbe di un cambiamento di politica perché
i sistemi sono di natura difensiva.
01:17
Assad riconosce
nuovi confini Russia con territori annessi
"Damasco
riconosce i nuovi confini della Russia con i territori che si sono uniti in
seguito ai risultati dei referendum". Lo ha detto il presidente siriano Bashar
al-Assad in un'intervista a Ria Novosti in merito alle autoproclamate
repubbliche di Donetsk e Luhansk e alle regioni ucraine di Kherson e
Zaporizhzhia.
"Questi sono
territori russi, e anche se la guerra non fosse avvenuta, questi sono
storicamente territori russi", ha dichiarato.
07:40
Cnn: abbattuto
nell'Est Ucraina un drone civile cinese "riadattato e armato"
Un drone per uso
civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è stato
abbattuto dall'esercito di Kiev nell'Ucraina orientale nella notte fra venerdì e
sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del
velivolo senza pilota colpito da armi automatiche A-47. Il drone era un Mugin-5,
un uav commerciale realizzato da un produttore cinese con sede nella città
portuale di Xiamen, sulla costa orientale della Cina. Alcuni blogger tecnologici
affermano che le macchine sono conosciute come "droni Alibaba" in quanto erano
disponibili per la vendita a un prezzo di circa 15.000 dollari sui siti web del
mercato cinese tra cui Alibaba e Taobao. Mugin Limited ha confermato alla Cnn
che si trattava di un loro prodotto, definendo l'incidente "profondamente
sfortunato". È l'ultimo esempio di un drone civile che è stato adattato e
trasformato in arma dall'invasione russa dell'Ucraina.
08:14
Isw: Wagner non
riesce a sfondare a Bakhmut, offensiva agli sgoccioli
Il numero di
attacchi del gruppo Wagner a Bakhmut è notevolmente diminuito in particolare
negli ultimi giorni. Lo rileva l'Istituto per lo studio della guerra nel suo
ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. Il finanziere del gruppo
Wagner Yevgeny Prigozhin ha recentemente sottolineato il prezzo che una
segnalata mancanza di munizioni ha sulla capacità della milizia di perseguire
offensive su Bakhmut e ha dichiarato che a causa della carenza di munizioni e
dei pesanti combattimenti, Wagner ha dovuto allentare il suo accerchiamento
della città.
Prigozhin,
tuttavia, afferma il think thank Usa, ha dichiarato che Wagner ha preso
Zalizianske, un minuscolo insediamento rurale situato a circa nove chilometri a
nord-ovest di Bakhmut, il che indica che "le forze di Wagner stanno
probabilmente conducendo attacchi localizzati opportunistici contro insediamenti
più a nord di Bakhmut che sono piccoli e relativamente più facili da
conquistare".
I recenti
successi di Wagner a nord di Bakhmut suggeriscono che le perdite di manodopera,
artiglieria e equipaggiamento nei combattimenti per Bakhmut probabilmente
limiteranno la sua capacità di completare uno stretto accerchiamento della
città. "È improbabile - sottolinea l'Isw - che la cattura di Zalizianske e di
altre piccole città a nord di Bakhmut aumenti la capacità di Wagner di catturare
Bakhmut stessa o di ottenere altri successi operativamente significativi. È
quindi probabile che l'offensiva di Wagner su Bakhmut sia sempre più vicina al
culmine".
08:57
Bombe russe su
Belopol, nella regione di Sumy
La località di
Belopol, nella regione di Sumy nell'Ucraina orientale, è stata attaccata questa
mattina dalle forze russe con artiglieria e lanciagranate: lo ha reso noto
l'amministrazione militare regionale, come riportano i media locali.
"Questa mattina
sono stati registrati tre bombardamenti nemici (due con artiglieria e uno con
lanciagranate) della comunità di Belopol", si legge in un comunicato.
Nel complesso
sono stati registrati 23 colpi di artiglieria e 110 di lanciagranate AGS. Non ci
sono state vittime o danni.
09:20
Mosca: Kiev non
riconquisterà mai la Crimea
L'Ucraina non ha
alcuna possibilità di riconquistare la Crimea a causa della fortificazione della
regione: lo ha detto all'agenzia di stampa russa Tass il governatore della
penisola annessa da Mosca nel 2014, Sergey Aksyonov, come riporta il Guardian.
"Hanno capito che non hanno alcuna possibilità di riprendere la Crimea, tenendo
conto delle misure che vengono attuate per conto del presidente (Vladimir Putin,
ndr) - ha detto Aksyonov -. In questa zona nulla minaccia la Crimea e i crimeani
possono dormire tranquilli. Le misure sono state prese al 100% e la loro
attuazione permetterà di minimizzare il più possibile i possibili
danni". Aksyonov ha poi accusato Kiev di utilizzare droni acquistati
dall'Occidente per cercare di sondare le difese russe in Crimea.
09:34
Cnn: forze russe
hanno raggiunto il luogo dell'incidente del drone Usa
I russi hanno
raggiunto il luogo dell'incidente tra il jet russo e il drone MQ-9 statunitense
nel Mar Nero: lo riporta la Cnn che cita due funzionari statunitensi. La Marina
russa ha diverse navi nel Mar Nero, comprese unità con base nei porti della
Crimea, il che le ha poste in una posizione vantaggiosa per tentare di
recuperare il drone statunitense MQ-9 Reaper dopo la collisione con i caccia
russi. Il drone è caduto in acque internazionali a circa 70 miglia a sud-ovest
della Crimea, ha detto uno dei funzionari. Non è chiaro se la Russia sia stata
in grado di recuperare i rottami del drone.
09:39
Zelensky ricorda
le vittime dell'attacco al teatro
"Passo dopo
passo, ci stiamo muovendo per garantire la piena responsabilità dello Stato
terrorista per ciò che ha fatto contro il nostro Paese, il nostro popolo": lo
scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nell'anniversario
del bombardamento da parte delle forze russe del teatro di Mariupol, dove si
nascondevano centinaia di persone, inclusi bambini.
"Un anno fa, la
Russia ha sganciato deliberatamente e brutalmente una potente bomba sul teatro
drammatico nel centro di Mariupol. C'era la scritta 'Bambini' accanto
all'edificio, che era impossibile non notare. Centinaia di persone si
nascondevano lì dai bombardamenti", ha ricordato Zelensky. "Non perdoneremo agli
occupanti alcun destino rovinato - ha concluso -. Ricordiamo tutti coloro le cui
vite sono state prese dal terrore russo". Secondo il consiglio comunale di
Mariupol nell'attacco al teatro morirono circa 300 persone, mentre secondo altre
fonti le vittime furono tra 600 e 1.200, incluse quelle che si trovano negli
edifici vicini.
09:43
Ucraina, Scholz:
"Ci assicureremo che Kiev riceva munizioni"
"L'Ucraina sarà
sostenuta fino a quando sarà necessario. Insieme ai partner Ue ci assicureremo
che Kiev riceva munizioni". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel
suo discorso al Bundestag in vista del prossimo Consiglio europeo. Scholz ha
spiegato che il Consiglio europeo discuterà anche di come ottenere una
"fornitura continua e migliore", di munizioni per l'Ucraina. L'Ue dovrebbe anche
discutere di come aiutare ulteriormente Kiev, e garantire che le sanzioni contro
la Russia non possano essere aggirate da Paesi terzi, ha detto ancora il
cancelliere tedesco.
09:46
Ucraina, Kiev:
"20 navi russe nel Mar Nero, attività atipica"
L'esercito
ucraino sta registrando "attività atipiche" della marina russa nel Mar Nero
contando 20 navi di cui 4 portamissili: lo ha detto Natalya Humenyuk, portavoce
delle forze sud, come riporta Unian. Secondo la portavoce, la presenza di navi
russe è collegata alla disponibilità a lanciare attacchi missilistici
sull'Ucraina e all'incidente dell'abbattimento di un drone americano da parte di
caccia russi in acque internazionali.
09:53
Ucraina,
filorussi: "Le forze di Kiev non si ritireranno da Bakhmut"
Le forze armate
ucraine non ritireranno le loro unità da Bakhmut, non ci sono i presupposti per
farlo. Lo ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della Reppubblica di
Donetsk al canale televisivo Russia-24, come riporta l'agenzia Tass. Pushilin ha
aggiunto che resta però molto complicata la fornitura di munizioni, cibo e
rinforzi ai soldati ucraini, ora che l'unica strada della cittadina "è sotto il
controllo del fuoco della Wagner".
09:57
Ucraina, bombe
russe su 7 regioni, 1 morto
Una persona è
morta e altre 14 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi nelle ultime
24 ore, che hanno colpito sette regioni ucraine: lo hanno reso noto le autorità
locali, come riporta il Kyiv Independent. Le regioni colpite
sono Donetsk, Kherson, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia e Lugansk,
nell'Ucraina orientale, meridionale e settentrionale. La vittima si trovava a
Bakhmut, ha riferito il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko,
dove sono state danneggiate oltre 25 case, cinque condomini, due scuole e alcune
auto.
10:02
Polonia:
"Smantellata una rete di spionaggio russo"
"La Polonia ha
smantellato una rete di spionaggio russo". Lo ha detto oggi a Varsavia il
ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, citato dalla radio Pr1.
10:10
Ucraina,
l'istituto Isw: "L'offensiva della Wagner a Bakhmut è agli sgoccioli"
Gli esperti
dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw) ritengono che le truppe russe
abbiano rallentato le loro operazioni al fronte in Ucraina rispetto alle
settimane precedenti. E sostengono che l'attacco del
gruppo Wagner a Bakhmut sembra avvicinarsi agli sgoccioli per una serie di
difficoltà tanto che, osserva l'istituto statunitense, "le forze russe
dovrebbero probabilmente impegnare riserve significative" per sostenere
l'accerchiamento di Wagner.
10:31
Il Regno Unito
aumenta i fondi a Moldavia e Georgia contro minaccia russa
Il Regno Unito
aumenta il suo sostegno finanziario a Moldavia e Georgia contro la minaccia
della Russia cresciuta dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di
Mosca. E' quanto si legge in un comunicato del Foreign Office sulla visita oggi
e domani nei due Paesi del ministro degli Esteri James Cleverly che deve
annunciare 10 milioni di sterline in aiuti per favorire le riforme economiche e
di gestione amministrativa in Moldavia e nuovi finanziamenti per 500 mila
sterline al fine di rafforzare la sicurezza delle elezioni del prossimo anno in
Georgia rispetto a possibili "interferenze esterne". "Poche società comprendono
le tattiche subdole dell'attività maligna russa meglio della Moldavia e della
Georgia", ha affermato Cleverly. E ha aggiunto: "Il Regno Unito non starà a
guardare mentre Mosca mina palesemente la loro democrazia, sovranità e integrità
territoriale".
10:47
Mosca: "Rammarico
per Svezia e Finlandia nella Nato"
Il Cremlino
esprime "rammarico" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato,
perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il
portavoce Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.
11:14
Russia, incendio
nella sede delle guardie di frontiera a Rostov
Un incendio è
scoppiato oggi nella sede delle guardie di frontiera a Rostov, capoluogo
dell'omonima provincia russa confinante con l'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia
Ria Novosti. Alcuni testimoni citati da canali Telegram hanno detto di avere
udito un'esplosione prima che le fiamme si sprigionassero.
11:23
Gli Usa
pubblicano il video dell'incidente tra drone americano e jet russo sul Mar Nero
Washington ha
finalmente deciso di pubblicare il video dell'incidente tra il drone Reaper
americano e il jet russo avvenuto martedì nei cieli sopra il Mar Nero.
L'incidente, descritto come "involontario" dagli Usa, ha causato l'innalzamento
delle tensioni tra le due potenze.
11:44
Il Comando Usa in
Europa: "Operazione russa pericolosa e poco professionale"
"Due Su-27 russi
hanno condotto un'intercettazione non sicura e poco professionale
senza intelligence, sorveglianza e ricognizione contro un MQ-9 senza pilota
operante nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero il 14 marzo", con
queste parole il Comando Usa in Europa ha commentato la pubblicazione del video
dell'incidente di pochi giorni fa che ha fatto salire la tensione tra Usa e
Russia.
11:53
Russia, Shojgu:
"Rischio escalation dai voli dei droni Usa"
Il ministro
della Difesa russo Sergei Shojgu ha dichiarato, durante la telefonata con il
segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, che i voli dei veicoli aerei
strategici senza pilota statunitensi al largo delle coste della
Crimea potrebbero portare a un'escalation della situazione nella regione del Mar
Nero. "È stato notato che i voli dei veicoli aerei strategici senza pilota
americani al largo delle coste della Crimea sono di natura provocatoria, il che
crea i presupposti per un'escalation della situazione nell'area del Mar Nero",
ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. "La Federazione Russa non è
interessata a tali sviluppi, ma in futuro reagirà di conseguenza a tutte le
provocazioni".
12:11
Ucraina, Erdogan:
"Riportare Mosca e Kiev al tavolo negoziale"
La Turchia
continuerà la sua mediazione affinché Russia e Ucraina tornino a negoziare.
"Fino alla fine continueremo con i nostri sforzi per riportare le parti al
tavolo negoziale", ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come
riporta Anadolu.
12:14
Russia, arrestato
l'oppositore Roizman, ex sindaco di Yekaterinburg
È stato fermato
l'oppositore russo Yevgeny Roizman, ex sindaco di Yekaterinburg: lo riportano le
agenzie russe. L'avvocato Idamzhapov - sentito dalla Tass - afferma che il
motivo sia la condivisione di un post su VKontakte ma che il dissidente non
sarebbe in realtà coinvolto nel caso "perché non ha mai avuto una propria pagina
sul social". Secondo alcuni media, il post condiviso era della fondazione di
Navalny. Roizman era stato fermato in estate e poi rilasciato in attesa di
giudizio e rischia diversi anni di reclusione per "discredito" dell'esercito per
una nuova legge bavaglio che vieta di fatto di criticare la guerra in Ucraina.
12:16
Incendio nella
sede dell'Fsb a Rostov: un morto e due feriti
È di un morto e
due feriti il bilancio di un incendio avvenuto oggi nella sede delle guardie di
frontiera dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Rostov, capoluogo dell'omonima
regione confinante con l'Ucraina. Lo riferiscono i servizi d'emergenza, secondo
i quali le fiamme si sono sprigionate dopo un'esplosione. Lo scrive l'agenzia
Tass.
12:40
Putin parla per
la prima volta agli imprenditori da Febbraio 2022: "La Russia affronta una
guerra di sanzioni"
Il presidente
russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì che la Russia sta affrontando una
"guerra di sanzioni" nel suo primo importante discorso all'élite imprenditoriale
del paese dal giorno in cui ha ordinato l'ingresso di decine di migliaia di
truppe in Ucraina lo scorso anno. Putin ha affermato che la Russia sta
rapidamente riorientando la sua economia verso paesi che non hanno colpito la
Russia con sanzioni e ha ringraziato i leader aziendali per aver lavorato per
aiutare lo stato russo.
12:50
Putin, "notevole
crescita del Pil attesa in secondo trimestre"
"Vediamo tendenze
positive nell'economia russa, e ci aspettiamo una notevole crescita del Pil nel
secondo trimestre dell'anno rispetto al 2022". Lo ha detto il presidente
Vladimir Putin parlando al congresso dell'Unione russa degli industriali e
imprenditori. Lo riferisce l'agenzia Tass.
13:21
Russia, Putin:
"Abbiamo sviluppato relazioni con Stati in crescita, e compensato così le
chiusure dei mercati occidentali"
La Russia è
riuscita a "compensare la chiusura dei mercati occidentali" sviluppando le
relazioni economiche con gli Stati "di regioni del mondo in rapida crescita". Lo
ha detto il presidente Vladimir Putin intervenendo al Congresso dell'Unione
degli industriali e imprenditori russi. Lo riferisce l'agenzia Tass.
13:59
Russia, soldato
confessa crimini di guerra e viene condannato a 5 anni per fake news
Un soldato russo
è stato condannato a cinque anni di carcere da un tribunale militare di
Khabarovsk, nella Russia orientale, perché riconosciuto colpevole di aver
diffuso "informazioni false" dopo aver confessato di aver commesso crimini di
guerra in Ucraina. Lo rende noto Ovd-Info. In Russia diffamare l'immagine
dell'esercito è considerato un reato penale. Mosca nega che i suoi uomini
abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina. Il soldato condannato aveva detto
al portale indipendente Vashnye Istorii (Storie Importanti) di aver sparato e
ucciso un civile vicino a Kiev circa un anno fa, all'inizio della guerra.
Tornato a casa, aveva accusato i suoi superiori di avergli ordinato di uccidere
e saccheggiare in Ucraina.
13:27
Russia, Mosca:
"Incendio a Rostov frutto di un cortocircuito"
L'incendio
nell'edificio della guardia di frontiera russa è stato causato da un
cortocircuito. Successivamente, a causa delle fiamme, sono esplosi alcuni
contenitori con carburante e lubrificanti. Lo riferisce il governatore della
regione di Rostov, Vasily Golubev, come riporta l'agenzia Tass. L'incendio è
scoppiato al secondo piano dell'edificio al numero 20 di Sievers Avenue, in cui
si trova il magazzino della guardia di frontiera. Due muri sono crollati, l'area
in cui sono divampate le fiamme ha raggiunto gli 880 metri quadrati. Gli
abitanti delle case che si trovano accanto alla palazzina andata in fiamme sono
stati evacuati.
13:37
Mosca annuncia un
prelievo una tantum alle imprese a sostegno delle casse dello Stato
Ammonta a 300
miliardi di rubli (circa 3,8 miliardi di euro) il totale di un prelievo una
tantum sulle imprese deciso dal governo russo a sostegno del bilancio statale.
Lo ha precisato oggi il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, intervenendo al
congresso dell'Unione degli industriali e imprenditori. Secondo Siluanov, citato
dall'agenzia Ria Novosti, i finanziamenti così ottenuti saranno spesi per lo
sviluppo di infrastrutture e per interventi sociali.
13:39
Varsavia
consegnerà 4 Mig-29 all'Ucraina fra pochi giorni
Varsavia
trasferirà all'Ucraina 4 caccia Mig-29 nei prossimi giorni. Lo ha affermato il
premier polacco Mateusz Morawiecki, secondo quanto riporta la Pap. Si tratta, ha
fatto sapere Varsavia, di "quattro aerei pienamente operativi".
14:14
Ucraina, rapporto
Onu: la Russia ha commesso crimini di guerra
La Russia ha
commesso crimini di guerra in Ucraina e possibili crimini contro l'umanità che
necessitano ulteriori indagini. Lo denuncia la Commissione internazionale
indipendente d'inchiesta sull'Ucraina in un nuovo rapporto reso noto oggi a
Ginevra. Le autorità russe - afferma la Commissione - hanno commesso una vasta
gamma di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto
internazionale umanitario in varie regioni dell'Ucraina, molte delle quali
costituiscono crimini di guerra. Questi includono attacchi contro civili e
infrastrutture legate all'energia, tortura e trasferimenti illegali e
deportazioni di bambini. La Commissione, guidata dal norvegese Erik Møse, ha
inoltre riscontrato numerosi casi di stupro e violenza sessuale e di genere. Gli
esperti della Commissione, che ha visitato 56 località e intervistato 348 donne
e 247 uomini, ha inoltre stabilito un modello di diffusa detenzione illegale
nelle aree controllate dalle forze armate russe.
14:42
Russia: spento
l'incendio nella sede dell'Fsb a Rostov
È stato estinto
l'incendio che si era sprigionato stamane nella sede delle guardie di frontiera
dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Rostov, capoluogo dell'omonima provincia
russa confinante con l'Ucraina. Lo hanno detto i servizi d'emergenza citati
dall'agenzia Tass. In precedenza la stessa fonte aveva detto che una persona era
morta e due erano rimaste ferite nell'incendio, accompagnato da un'esplosione.
Secondo lo stesso
Fsb, l'esplosione è avvenuta quando le fiamme hanno investito un deposito di
carburante e lubrificanti nel garage dell'edificio. Il governatore della
provincia, Vasily Golubev, ha affermato che l'incendio è avvenuto a causa di un
cortocircuito.
15:12
Incendio
nell'edificio dell'Fsb a Rostov, Kiev: "Prova di divisioni interne"
"Qualsiasi
edificio dell'Fsb che brucia o che esplode in Russia, in particolare nella
regione di Rostov, indica chiaramente una manifestazione di panico,
indebolimento del controllo del potere e transizione verso un grave conflitto
interno". Lo ha scritto il consigliere del presidente ucraino Volodymyr
Zelensky, Podolyak, su Twitter. "L'Ucraina non interferisce, ma guarda con
piacere", ha aggiunto.
15:26
Pechino a Kiev:
"Riprendere colloqui di pace Ucraina-Russia"
Il ministro degli
Esteri cinese Qin Gang ha avuto oggi un colloquio telefonico con la sua
controparte ucraina Dmytro Kuleba. Lo riferiscono i media ufficiali di Pechino,
secondo cui Qin ha invitato Russia e Ucraina a far ripartire i colloqui "il
prima possibile".
15:45
Ucraina, Kuleba a
Blinken: "Accelerare sulle munizioni"
Il ministro
degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha chiesto al segretario di Stato
americano, Antony Blinken, di "accelerare" sulle forniture di munizioni
all'esercito di Kiev. Riferendo su Twitter il contenuto del colloquio telefonico
avuto con Blinken, Kuleba ha spiegato di aver discusso con il suo omologo della
"formula di pace" proposta da Kiev per porre fine al conflitto e della consegna
di munizioni per l'artiglieria. "Stiamo lavorando con gli Stati Uniti e gli
altri alleati 24 ore su 24 per garantire che l'Ucraina riceva tutte le munizioni
di cui ha bisogno per le sue operazioni di difesa e controffensiva", ha
affermato.
15:49
Ucraina, Tajani:
"Per dialogo iniziare da grano e Zaporizhzhia"
"Non è facile il
dialogo tra Russia e Ucraina ma ci sono 2 temi che potrebbero vedere le due
parti sedute: i corridoi verdi per l'export di grano e l'altro aspetto per me
fondamentale è il nucleare. Bisogna mettere in sicurezza la centrale di
Zaporizhzhia perché si rischia un disastro peggio di Chernobyl. Sono cose
concrete che possono portare Mosca e Kiev intorno ad un tavolo". Lo ha detto il
vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum ANSA-Pe.
16:23
Kiev, con Cina
discusso significato integrità territoriale
"Durante la mia
telefonata odierna con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri
cinese Qin Gang, abbiamo discusso del significato del principio dell'integrità
territoriale. Ho sottolineato l'importanza della Formula di Pace del
presidente Volodymyr Zelensky per porre fine all'aggressione e ripristinare la
giusta pace in Ucraina". Lo ha scritto su twitter il ministro degli Esteri
ucraino Dmytro Kuleba.
16:45
Mosca,
"importante mantenere linee comunicazione con gli Usa"
Mosca ritiene che
sia importante mantenere aperte le linee di comunicazione con Washington, alla
luce dell'incidente che ha portato alla distruzione di un drone americano sul
Mar Nero. "Pensiamo che sia importante lasciare aperte le linee di
comunicazione, e ciò è quello che stiamo facendo", ha sottolineato la portavoce
del ministero degli Esteri Maria Zakharova in una conferenza stampa. Lo
riferisce la Tass.
16:59
Putin, "ho ancora
amici tedeschi. Rimaniamo in contatto"
Vladimir Putin ha
ancora "molti amici in Germania", con i quali mantiene rapporti e scambia
battute. Lo ha detto lo stesso presidente russo parlando al
congresso dell'Unione degli industriali e imprenditori. "Tutte queste amicizie
sono durate, i miei veri amici tedeschi sono rimasti con me, scherziamo e ci
scambiamo battute", ha detto Putin, che parla il tedesco e negli anni '80 era in
servizio a Dresda, nell'allora Germania Est, come ufficiale del Kgb. Tra le
battute il presidente russo, citato dalla Tass, ne ha ricordata una sugli
scarafaggi. "Noi li chiamiamo 'prussiani', sapete, quelli grandi, rossi", ha
detto, mostrandone con la mano alla platea le dimensioni. "In Germania invece li
chiamano 'russen', russi. Vedete?". E poi si è messo a ridere.
17:20
Zelensky sente
Sunak, risultati concreti in aumento difesa
"Una bella
chiacchierata con il primo ministro Rishi Sunak. L'ho informato della situazione
al fronte, difesa di Bakhmut. Scambio di opinioni sui recenti avvenimenti
internazionali. Come sempre, abbiamo risultati concreti nell'aumentare la difesa
e il sostegno economico per l'Ucraina. Apprezzo la posizione incrollabile del
Regno Unito". È quanto scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un
tweet.
17:47
Casa Bianca,
video sul drone dimostra la nostra versione
Il video del
drone Usa caduto nel Mar Nero dopo le manovre del jet russo "dimostra al mondo
la nostra versione" con " prove chiare e convincenti" e rivela le "menzogne"
della Russia: lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John
Kirby in un briefing telefonico.
17:53
Polonia
trasferirà 4 MiG-29 nei prossimi giorni
"Nei prossimi
giorni per primi trasferiremo quattro aerei pienamente operativi in Ucraina, se
ricordo bene". Lo ha annunciato il presidente polacco Andrzej Duda, precisando
che "altri aerei sono attualmente in preparazione, in manutenzione e
probabilmente verranno trasferiti successivamente". "Questi MiG sono ancora in
servizio nell'aeronautica polacca. Sono nei loro ultimi anni di attività, ma
sono ancora per la maggior parte perfettamente funzionanti", ha assicurato
Duda. Da parte sua, il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak ha precisato che
Varsavia intende operare "nel quadro di una più ampia coalizione di Paesi", a
cominciare dalla Repubblica slovacca, ma "ovviamente siamo aperti ad altri". I
caccia inviati all'Ucraina saranno sostituiti in Polonia con aerei FA-50
sudcoreani, e poi da F-35 americani.
17:58
Usa, Mig da
Polonia a Kiev? Non cambiamo idea su F-16
La mossa della
Polonia di diventare il primo paese a inviare aerei da guerra MiG-29 in Ucraina
"non cambia" la decisione degli Stati Uniti di non inviare i propri caccia a
Kiev. Lo ha riferito la Casa Bianca.
18:17
Casa Bianca
auspica colloquio Xi-Zelensky
Un colloquio tra
il presidente cinese, Xi Jinping, e quello ucraino, Volodymy Zelensky, sarebbe
"una buona cosa". Lo ha dichiarato il John Kirby, portavoce del Consiglio di
Sicurezza nazionale della Casa Bianca.
18:59
Kuleba, 33 Paesi
a favore tribunale speciale per crimini russi
"Sono grato
all'Austria per essersi unita alla coalizione di paesi che lavorano per
istituire il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro
l'Ucraina. 33 Stati fanno già parte del gruppo principale. Con l'aumentare del
numero, cresce anche la fiducia che la leadership russa sarà ritenuta
responsabile". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro
Kuleba.
19:18
Kiev, dopo drone
"attività atipica" russa in Mar Nero
L'Ucraina ha
registrato una "attività atipica" della Russia nel Mar Nero, in coincidenza con
gli sforzi per recuperare i resti del drone statunitense contro cui si è
schiantato un caccia russo. La portavoce del Comando Sud dell'Ucraina, Nataliya
Humenyuk, ha sottolineato che i movimenti russi sono legati ai preparativi per
un nuovo attacco missilistico russo contro l'Ucraina e con "i recenti
avvenimenti col drone americano" precipitato martedì a circa 100 chilometri a
sud-ovest della Crimea, secondo quanto riporta l'agenzia Unian. Humenyuk ha
spiegato che attualmente ci sono "molte unità della flotta ausiliaria" e 20 navi
russe nel Mar Nero.
19:43
Politico, 'da
società cinesi fucili d'assalto alla Russia'
"Compagnie
cinesi, inclusa una collegata al governo di Pechino, hanno inviato alle entità
russe 1.000 fucili d'assalto e altre attrezzature che potrebbero essere
utilizzate per scopi militari, comprese parti di droni e giubbotti
antiproiettile". Lo scrive Politico, citando dati commerciali e doganali. Le
spedizioni sono avvenute tra giugno e dicembre 2022, secondo i dati forniti da
ImportGenius, aggregatore di dati doganali.
19:52
Ucraina: Casa
Bianca, risorse sufficienti sino a settembre
La Casa Bianca
ritiene che gli Usa abbiano sufficienti risorse per sostenere l'Ucraina sino
alla fine di questo anno fiscale, che scade a fine settembre. Lo ha detto la
portavoce della presidenza Karine Jean-Pierre.
20:28
Lituania,
proposta legge per interrompere procedure cittadinanza per russi
Il Parlamento
lituano (Seimas) discuterà una proposta di legge per sospendere l'accettazione
delle richieste e l'assegnazione della cittadinanza lituana ai cittadini della
Federazione russa e della Bielorussia. Firmatari della proposta sono il ministro
degli Interni lituano e il Presidente della Commissione parlamentare per la
sicurezza e la difesa nazionale.
20:35
Kiev, in corso
negoziati per colloquio Zelensky-Xi
I negoziati per
una possibile conversazione tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il
leader cinese, Xi Jinping, sono in corso, ma è troppo presto per dire se questa
avrà effettivamente luogo. Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere
presidenziale ucraino. "Non possiamo dirlo con certezza, perchè i negoziati sono
in corso", ha dichiarato parlando alla televisione nazionale. Il presidente
ucraino è aperto alle conversazioni anche con altri leader, non solo con Xi,
"per spiegare la natura della guerra e dire perchè, senza tener conto della
posizione dell'Ucraina, questa guerra non può essere conclusa", ha spiegato
Podolyak. "Perchè, ad esempio, sostenere solo la parte russa in primo luogo non
porterà alla conclusione della guerra e, in secondo luogo, non aggiungerà punti
alla Cina come attore globale che comprende la natura della guerra e capisce
come porvi fine", ha aggiunto.
21:10
Russia, arrestato
ex sindaco di Ekaterinburg, critico del Cremlino
La polizia russa
ha arrestato uno dei principali critici del Cremlino ed ex sindaco della città
di Ekaterinburg, Yevgeny Roizman. Lo ha annunciato la moglie, Yulia Kruteyeva,
spiegando che roizman è stato accusato di avere ripubblicato un commento del
leader dell'opposizione incarcerato Alexey Navalny sul social network russo
Vkontakte. Kruteyeva ha precisato però che Roizman non ha un account su
Vkontakte, e che il repost del commento di Navalny sarebbe stato fatto in un
gruppo a lui intitolato con cui "non ha nulla a che fare".
21:47
Scholz,
importante fornire rapidamente munizioni all'Ucraina
Il cancelliere
tedesco Olaf Scholz ha avvertito che è fondamentale fornire all'Ucraina il prima
possibile munizioni fresche per resistere all'invasione della Russia. "E' molto
importante fornire rapidamente all'Ucraina le munizioni necessarie", ha detto
alla Camera bassa del Parlamento, promettendo un'azione in occasione del vertice
dell'UE della prossima settimana.
Estratto
dell’articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera” il 16 marzo 2023.
«È solo un privato
cittadino, che non rappresenta lo Stato». Vladimir Putin era in modalità
sorniona. Quel giorno del luglio 2018 a Helsinki, dopo il primo incontro con
Donald Trump, aveva molte ragioni per essere di buon umore. Così, lo Zar nominò
per la prima volta in pubblico tale Evgenij Prigozhin, ex cuoco e ristoratore,
accusato di gestire a San Pietroburgo una squadra di troll che aveva lavorato
sodo per denigrare Hillary Clinton.
Cinque anni dopo,
siamo ancora a quella espressione tipica del Kgb quando voleva negare qualunque
coinvolgimento del Cremlino. Prigozhin è tornato a essere un privato cittadino.
La sua creatura, la milizia mercenaria del Gruppo Wagner, ha sempre avuto un
piede nelle istituzioni e un altro fuori.
[…] Quando muoiono,
i mercenari sono figli di nessuno.
Ma l’Operazione
militare speciale e l’inattesa resistenza ucraina hanno travolto queste
finzioni. Prigozhin e i Wagner si sono ritrovati in una posizione difficile. A
livello ufficiale non esistono. Ma, al tempo stesso, i suoi uomini stanno
reggendo lo stallo al fronte, con malumori sempre più evidenti.
Prigozhin non è un
politico, che sa quando tacere. Lui viene dalla strada. Era appena ventenne
quando fu condannato a 13 anni di carcere nella allora Leningrado. Dopo averne
scontati nove, nel 1990 mise su assieme al patrigno un chiosco di hot dog col
quale fece i primi rubli. Poi entrò nei casinò, e finalmente aprì i primi
ristoranti. Putin ci portò il presidente francese Chirac e George Bush. Da
quella frequentazione nasce il seguito della storia, con il gruppo Wagner
impiegato per azioni «sporche» in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana e
Ucraina. Un personaggio del genere, più a suo agio in mimetica che in blazer, è
difficile da tenere a bada.
[…] ogni giorno un
attacco ai vertici delle Forze armate e al ministro delle Difesa Sergei Shoigu.
Incompetenti, burocrati, incapaci. Colpevoli di alto tradimento perché non
mandano munizioni a sufficienza.
[…] Lo scorso 24
novembre, in risposta alla richiesta del Parlamento Ue di includere il gruppo
Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche, ha mostrato un martello
sporco di sangue da «regalare» ai deputati europei. Presumibilmente, l’arma con
la quale era stato massacrato un disertore, esecuzione mostrata in un video che
ha suscitato orrore in tutto il mondo.
Proprio questi
eccessi, e la figura ingombrante del fondatore, sembrano essere all’origine del
declino della Wagner. La parabola di Prigozhin sta prendendo una china
discendente, e il suo prossimo ruolo potrebbe essere quello del capro
espiatorio. Ma lui non sembra voler cambiare spartito.
[…] Proprio questa
sovraesposizione mediatica racconta delle sue difficoltà. E del suo probabile
destino. Prigozhin andava bene quando c’era ma sembrava che non esistesse.
Adesso è un problema. Il Cremlino ci convive, per i suoi meriti acquisiti sul
campo. Ma il ghiaccio sul quale cammina l’ex privato cittadino del Gruppo Wagner
sembra essere sempre più sottile.
Da corriere.it il 16
marzo 2023.
Il Pentagono ha
diffuso un breve video dello scontro tra il caccia russo e il drone americano
sul Mar Nero avvenuto il 14 marzo, un filmato che sembra confermare l’accusa di
un’azione aggressiva, ripetuta.
Questa la sequenza
secondo la versione americana.
Inizio clip: il
caccia Su 27 si avvicina al Reaper
00.05: il caccia
inizia a “rilasciare” il carburante
00.09: il Su-27
oltrepassa il drone e continua a rilasciare il carburante provocando un disturbo
alle trasmissioni
00.22: secondo
passaggio del caccia verso il drone
00.27: nuovo
rilascio di carburante, il caccia passa molto vicino al velivolo statunitense
00.29: il Su 27
tocca il drone e la telecamera del Reaper smette temporaneamente di funzionare
00.39: la
telecamera del drone è di nuovo attiva, si vede l’elica, possibile
danneggiamento.
In base alle ultime
informazioni alcune unità russe avrebbero raggiunto il punto dell’impatto, il
relitto però si troverebbe in acque profonde. Dobbiamo provarci — ha promesso
Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo — non
so se ne saremo capaci.
Più cauti gli
americani che non escludono sia rimasto poco. Per gli Usa è comunque difficile
un intervento visto che i rottami si trovano in un’area in apparenza sotto
controllo di Mosca
La Repubblica. La
Cpi emette un mandato di arresto contro Putin. Procuratore Khan: "Centinaia
bambini deportati da orfanotrofi". Kiev: "Decisione storica"
Il capo del
gruppo Wagner Prigozhin sulle voci di un complotto del presidente russo Putin e
del Segretario del Consiglio di Sicurezza Patrushev per "neutralizzare" la sua
compagnia: "Non ne so nulla". Ue, "bene il mandato contro Putin, è solo
l'inizio"
La corte penale
internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti del presidente
russo Vladimir Putin per la presunta deportazione illegale di bambini ucraini in
Russia.
La tensione nei
cieli europei non si allenta dopo la distruzione di un drone americano sul Mar
Nero. Gli Stati Uniti stanno effettuando una valutazione su come ridurre il
rischio di uno scontro con i russi, che fanno volare regolarmente aerei da
combattimento dentro e fuori lo spazio aereo della Crimea.
Previsto per
lunedì e martedì il vertice a Mosca tra Xi jinping e Vladimir Putin. Intanto
Peskov avverte gli Alleati: "L'invio di jet da Polonia e Slovacchia indica un
maggiore coinvolgimento della Nato"
Punti chiave
22:29
Casa Bianca su
Cpi per Putin, sosteniamo responsabilità per crimini guerra
18:08
Cpi: "Centinaia
di bambini presi dagli orfanotrofi e dati in adozione in Russia"
16:49
Cpi, esecuzione
arresto dipende da collaborazione internazionale
16:43
Ucraina, Kiev:
"Mandato di arresto per Putin è una decisione storica"
16:34
Russia, mandato
di arresto della Corte penale internazionale anche per Maria Lvova-Belova
16:21
Il mandato di
arresto di Putin della Cpi è per "la detenzione illegale di bambini"
16:14
Ucraina, la Corte
penale internazionale emette il mandato d'arresto per Putin
15:55
Nato, Erdogan:
"Sì all'adesione della Finlandia. Quella della Svezia dipenderà dalle azioni del
governo"
15:49
Ucraina, Putin:
"Faremo di tutto per difendere la Crimea"
15:21
Ucraina, Madrid:
"Non invieremo aerei da guerra a Kiev"
15:20
Ucraina, Ue
valuta nuovo aumento fondo armi per 3,5 miliardi di euro
14:49
Media: esplosione
in Crimea, vicino sito difesa flotta russa
12:35
Norvegia:
"Abbiamo 8 mila km gasdotti; serve sicurezza Nato"
11:27
Russia, Peskov:
"Invio jet segna maggiore coinvolgimento della Nato"
11:14
Mosca: i jet di
Polonia e Slovacchia saranno distrutti
11:05
Kuleba: "Chi non
ha aiutato l'Ucraina nel momento più buio pagherà un prezzo"
10:37
Mosca premia i
piloti che hanno abbattuto il drone Usa
23:59
Zelensky:
"Ucraina è sempre stata Europa, bombe russe non cambieranno realtà"
"L'Ucraina è
sempre stata Europa. Le bombe russe non cambieranno la realtà oggettiva. La
realtà che gli ucraini difendono". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr
Zelensky, nel suo consueto discorso serale su Telegram.
00:00
Gop: "Confisca
beni russi per ripagare drone abbattuto"
L'amministrazione
Biden dovrebbe sequestrare beni russi negli Stati Uniti come risarcimento per i
32 milioni di dollari persi con il drone americano, abbattuto sul Mar Nero, dopo
il contatto con jet russi. È la proposta fatta dal rappresentante repubblicano
della Camera, Nick LaLota, membro della commissione Servizi armati del
Congresso.
03:24
Bombe russe sul
Donetsk, almeno un morto e 7 feriti
Le forze russe
hanno bombardato Kostiantynivka e Toretsk nell'oblast di Donetsk uccidendo una
persona e ferendone altre sette, ha riferito l'ufficio del procuratore generale
ucraino citato dai media locali.
Sono stati
colpiti i villaggi di Pivnichne e Pivdenne a Toretsk: una donna di 50 anni è
stata uccisa e un uomo di 40 anni è rimasto ferito. A Kostyantynivka sei civili,
tra cui un cittadino polacco, sono rimasti feriti. Frammenti di proiettili russi
hanno danneggiato oltre 30 case, condotte del gas, automobili e fabbricati
agricoli
08:18
Xi Jinping in
visita in Russia dal 20 al 22 marzo
Il presidente Xi
Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo
riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. Si tratta della prima
visita in Russia di Xi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte dei
soldati di Mosca.
09:16
Voci di un
complotto Putin-Patrushev contro Wagner. Prigozhin: non ne so nulla
Un complotto
guidato dal presidente russo Vladimir Putin e dal Segretario del Consiglio di
Sicurezza Nikolai Patrushev per "neutralizzare" il Gruppo Wagner: indiscrezioni
in questo senso sarebbero circolate di recente sui canali Telegram russi e
ucraini e il quotidiano russo Nezavisimaya Gazeta ha chiesto al fondatore del
gruppo Yevgeny Prigozhin se fosse a conoscenza dei presunti piani di Mosca e ne
avrebbe avuto un "Non ne so nulla" come risposta. Secondo quanto riporta
l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano, è
stato lo stesso servizio stampa del patron del gruppo di mercenari a rendere
pubblica ieri in un post la richiesta del giornale russo. Le indiscrezioni
parlano di presunti colloqui sul futuro del Gruppo Wagner tra Putin e Patrushev,
il quale avrebbe detto al presidente russo che non rimarrà "nulla" di Wagner tra
"un mese e mezzo o due". Il centro studi statunitense sottolinea che non ha
osservato "alcuna informazione che suggerisca che queste discussioni siano
avvenute". Da parte sua, Nezavisimaya Gazeta non ha pubblicato la richiesta di
un commento a Prigozhin, di cui non c'è traccia se non nel post del servizio
stampa del Gruppo Wagner. Tuttavia, sempre secondo questo post, Patrushev
avrebbe suggerito che - dopo la distruzione del Gruppo Wagner in Ucraina -
Prigozhin cercherà di "unire gli ex combattenti di Wagner e quelli rimasti
attivi con un pretesto inverosimile", li armerà e "li invierà nel territorio
russo per prendere il potere nelle regioni confinanti con l'Ucraina, con una
possibile avanzata verso l'interno". Per questo, Patrushev avrebbe già ordinato
di controllare i movimenti degli ex combattenti di Wagner e Putin avrebbe
riferito di essere d'accordo con questa iniziativa e lo avrebbe ringraziato dei
suoi sforzi per "neutralizzare Wagner in generale e Yevgeny Prigozhin in
particolare".
09:59
Il governo
slovacco dà l'ok all'invio di aerei da combattimento Mig-29 a Kiev
Il governo
slovacco ha approvato l'invio di aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina. Lo ha
affermato il primo ministro Eduard Heger, all'indomani dell'annuncio simile
della Polonia. Secondo la Reuters, la flotta slovacca di 11 aerei MiG-29 è stata
ritirata la scorsa estate e la maggior parte di essi non è in condizioni
operative.
10:37
Mosca premia i
piloti che hanno abbattuto il drone Usa
I piloti russi
che martedì scorso hanno abbattuto il drone americano sul Mar Nero riceveranno
un riconoscimento statale dal governo russo: lo ha reso noto il ministero della
Difesa di Mosca, come riporta la Tass. "Il ministro della Difesa russo, il
generale dell'esercito Sergey Shoigu, ha emesso un ordine per conferire
riconoscimenti statali ai piloti degli aerei Su-27 che non hanno consentito al
velivolo senza pilota statunitense MQ-9 di violare lo spazio aereo limitato
all'uso durante l'operazione militare speciale", ha affermato il ministero in
un comunicato. Il ministero ha ricordato che i confini dello spazio aereo in
questione erano stati comunicati a tutti gli utenti dello spazio aereo
internazionale e pubblicati in conformità con le norme internazionali.
11:05
Kuleba: "Chi non
ha aiutato l'Ucraina nel momento più buio pagherà un prezzo"
In una intervista
alla Bbc, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che i Paesi
che non hanno sostenuto l'Ucraina, che l'hanno "maltrattata" saranno chiamati a
risponderne dopo la fine della guerra, "pagheranno un prezzo in futuro". "La
guerra è un momento in cui bisogna fare una scelta. E ogni scelta è stata
registrata. L'Ucraina potrebbe dipendere dagli aiuti e dal sostegno militare
dell'Occidente nel medio-lungo termine e quindi la sua disapprovazione
diplomatica potrebbe non preoccupare alcuni Paesi. Ma in tempo di pace, le
enormi esportazioni di cereali dell'Ucraina le conferiscono una notevole
influenza economica, in particolare in alcune parti del mondo in via di
sviluppo", ha affermato Kuleba. "Se qualcuno nel mondo pensa che il modo in cui
questo o quel Paese si è comportato - o ha trattato l'Ucraina nel momento più
buio della sua storia - non sarà preso in considerazione nella costruzione di
relazioni future, queste persone non sanno come funziona la diplomazia", ha
detto. Sulle consegne di armi da parte dei Paesi occidentali, il ministro degli
Esteri ha dichiarato che Kiev vorrebbe che i partner agissero "più velocemente.
11:14
Mosca: i jet di
Polonia e Slovacchia saranno distrutti
Gli aerei da
combattimento che Polonia e Slovacchia forniranno all'Ucraina saranno
"distrutti". E' l'avvertimento lanciato dal portavoce del Cremlino, Dmitri
Peskov, dopo l'annuncio delle forniture di aerei da combattimento da parte di
Varsavia e Bratislava a Kiev.
11:27
Russia, Peskov:
"Invio jet segna maggiore coinvolgimento della Nato"
L'annuncio di
Polonia e Slovacchia di voler fornire all'Ucraina aerei da combattimento sono
"un esempio di come un certo numero di Paesi, membri della Nato, aumentano il
loro diretto coinvolgimento nel conflitto". Lo ha sottolineato il portavoce del
Cremlino, Dmitri Peskov, sostenendo che l'invio di questi aiuti militari "non
può influenzare l'esito dell'operazione militare speciale, ma può portare
ulteriori disgrazie all'Ucraina e al popolo ucraino".
11:31
Von der Leyen in
Norvegia con Stoltenberg, focus su forniture gas
Oggi la
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è in visita alla
piattaforma Troll A al largo della costa occidentale della Norvegia, insieme al
primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, al segretario generale della Nato,
Jens Stoltenberg. Discuteranno della protezione e della resilienza delle
infrastrutture critiche e delle forniture di gas all'Europa. "È bello rivederti,
Jonas Gahr Store. Insieme, la Norvegia e l'Ue sostengono con forza l'Ucraina.
Accolgo con favore il vostro impegno a contribuire alla ricostruzione
dell'Ucraina. Siamo partner stretti su tutta la linea, dall'assicurare forniture
energetiche affidabili alla lotta al cambiamento climatico", ha scritto von der
Leyen su Twitter.
11:41
Ucraina, Kiev:
"Dal 26 marzo il coprifuoco sarà ridotto nella capitale"
Il coprifuoco a
Kiev sarà ridotto dal 26 marzo: lo ha annunciato l'amministrazione militare
della capitale spiegando che durerà da mezzanotte alle 5 del mattino tutti i
giorni, ossia un'ora in meno rispetto ad ora. "Il nuovo periodo di coprifuoco
allungherà il tempo dei trasporti pubblici, e contribuirà anche a ridurre le
tensioni sociali, aumentare la produzione e creare nuovi posti di lavoro", è
stato spiegato, ma "esistono ancora minacce alla capitale, quindi le misure di
sicurezza possono essere rafforzate se ce ne sarà bisogno".
11:49
Ucraina, il
Cremlino: "Kiev attacca ingiustamente la chiesa ortodossa che fa capo a Mosca"
Il Cremlino ha
detto venerdì che l'Ucraina sta "attaccando illegalmente" la Chiesa ortodossa
ucraina (UOC) - che fino a poco tempo fa ha accettato l'autorità del patriarca
di Mosca - aggiungendo che ciò conferma la necessità della sua "operazione
militare speciale". Funzionari ucraini la scorsa settimana hanno ordinato
all'UOC di lasciare il complesso del monastero di Kiev dove ha sede, suscitando
una feroce condanna da parte di Mosca. "Con questi attacchi illegali alla
chiesa, il regime di Kiev dimostra ancora una volta il suo carattere, proprio il
personaggio che stiamo combattendo, proprio il personaggio che dobbiamo fermare
attraverso l'operazione (militare) in corso", ha detto ai giornalisti il
??portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
12:19
Norvegia:
"Forniremo 30-40% gas a Ue per prossimi 4-5 anni"
"Abbiamo una
intensa cooperazione con l'Ue. La Norvegia ha potuto incrementare le forniture
di gas per l'Ue quest'anno, ed è nostra ambiziosa mantenere alto questo livello
per i prossimi 4-5 anni. Forniremo il 30-40% di gas all'Ue e solo in questa
piattaforma viene prodotto il 10% del gas consumato". Lo ha detto il primo
ministro norvegese Jonas Gahr Store in un punto stampa con Ursula von der Leyen
e Jens Stoltenberg dalla piattaforma offshore Troll A. "Non è nostro interesse
che i prezzi del gas si alzino, sia per le nostre partnership sia per i
consumatori norvegesi", ha aggiunto il primo ministro di Oslo.
12:32
Pechino: "Armi a
Mosca? Da sempre teniamo un approccio responsabile"
La Cina ha
"sempre avuto" un "approccio responsabile" sulle esportazioni militari. Si è
espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin,
in dichiarazioni riportate dal South China Morning Post dopo le accuse al
gigante asiatico che proprio poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina aveva
consolidato con la Russia una partnership "senza limiti". La Cina, ha affermato,
"ha sempre controllato l'esportazione di prodotti a duplice uso nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti".
"La posizione e
le pratiche della Cina - ha rivendicato - sono coerenti sulla questione della
vendita di armi, in netto contrasto con i due pesi e le due misure di alcuni
Paesi che infiammano la crisi ucraina".
12:35
Norvegia:
"Abbiamo 8 mila km gasdotti; serve sicurezza Nato"
"Io e il
cancelliere tedesco abbiamo preso un'iniziativa per chiedere alla Nato di
Coordinare le azioni per la sicurezza delle nostre strutture energetiche. La
Norvegia ha circa 90 strutture off-shore e 8 mila chilometri di gasdotti. È un
segnale molto importante che la Nato intervenga per coordinare per la sicurezza
sia con l'industria che con i governi". Lo ha dichiarato il primo ministro
norvegese, Jonas Gahr Store, in una conferenza stampa su una piattaforma di
estrazione di gas nei pressi di Bergen, in Norvegia, con la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, il segretario generale della Nato,
Jens Stoltenberg, e l'amministratore delegato di Equinor, Anders Opedal.
13:44
La moglie di
Navalny: "L'aggressione all'Ucraina noin può essere perdonata. Mio marito
ostaggio personale di Putin"
"L'aggressione
all'Ucraina non può essere perdonata". È quello che dice Julia Navalny, moglie
del dissidente russo Alexei, tuttora in prigione in Russia, in un'intervista
allo Spiegel, anticipata oggi. "Putin non ha paura di nulla, pur di rimanere al
potere. È addirittura arrivato a minacciare il mondo con le armi atomiche". Per
lei e suo marito è chiaro da tempo che "più a lungo Putin resta, peggio è".
La Navalny
replica poi ai rumors su un suo eventuale impegno politico al posto del marito:
"Non penso di volermi confrontare con questa idea. Se una persona vuole farsi
eleggere, se vuole essere un politico, deve farlo perché lo vuole in prima
persona, non in sostituzione di qualcun altro". A proposito delle condizioni di
Alexei, sopravvissuto ad un avvelenamento grazie alle cure in Germania, la donna
dice: i russi "fanno di tutto per rendergli la situazione insostenibile".
Trascorre la maggior parte del tempo in isolamento e senza accesso alle giuste
cure mediche, racconta. "E quando uno in queste condizioni ha problemi di
salute, la situazione non migliora di certo, ma diventa sempre peggio". Bisogna
ricordare che è nelle mani di chi lo ha avvelenato, incalza, "Putin lo considera
un suo prigioniero personale".
14:04
Ucraina: Londra,
Xi a Mosca incoraggi Putin a ritirarsi
Il presidente
cinese, Xi Jinping, dovrebbe sfruttare il viaggio della prossima settimana a
Mosca per incoraggiare Vladimir Putin a ritirare le truppe dall'Ucraina. Lo ha
detto il portavoce del premier britannico, Rishi Sunak, dopo l'annuncio della
missione del leader cinese al Cremlino.
"Se la Cina vuole
svolgere un ruolo autentico nel restituire la sovranità all'Ucraina, ovviamente
lo accoglieremmo con favore", ha detto il portavoce di Downing Street.
Xi sarà in Russia
da lunedì a mercoledì, in un'apparente dimostrazione di sostegno alla Russia. Il
portavoce del governo britannico, citato da Sky News, ha dichiarato: "È chiaro
che qualsiasi accordo di pace che non sia basato sulla sovranità e
l'autodeterminazione dell'Ucraina non è affatto un accordo di pace".
14:10
Mosca, tra Putin
e Xi intesa per 'nuova era' partnership
Durante la visita
della prossima settimana a Mosca, il presidente cinese Xi Jinping firmerà con
quello russo Vladimir Putin un documento su una "nuova era" della "partnership e
delle relazioni strategiche" tra i due Paesi. Lo ha detto il consigliere del
Cremlino Yuri Ushakov citato dalla Tass. Un altro documento riguarderà lo
sviluppo della cooperazione economica "fino al 2030".
14:32
Ucraina, Kuleba:
"Ci rincresce che il Papa non sia potuto ancora venire"
"Ci rincresce
profondamente che il Papa non abbia trovato l'occasione di venire in visita in
Ucraina dall'inizio della guerra". Ad affermarlo, in un'intervista alla Bbc, è
il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.
"Ci rincresce
profondamente che il Papa non abbia trovato l'occasione di venire in visita in
Ucraina dall'inizio della guerra". Ad affermarlo, in un'intervista alla Bbc, è
il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.
14:49
Media: esplosione
in Crimea, vicino sito difesa flotta russa
Un'esplosione è
avvenuta fuori dal villaggio di Perevalne, nel distretto di Simferopoli,
in Crimea, dove è di stanza la Brigata di difesa costiera della Flotta russa del
Mar Nero. Lo riporta il canale Telegram Crimean Wind, citato da Ukrinform.
15:20
Ucraina, Ue
valuta nuovo aumento fondo armi per 3,5 miliardi di euro
L'Unione europea
proporrà ai ministri degli Esteri e della Difesa di destinare al Fondo europeo
per la pace (Epf), lo strumento che finora ha permesso di fornire all'Ucraina
3,6 miliardi di euro di armi. "C'è stato già un aumento di due miliardi di euro
che saranno destinati alla fornitura di munizioni 155 mm all'Ucraina, un
miliardo per quelle già pronte e un altro miliardo per le nuove produzione", ha
spiegato un alto funzionario dell'Ue. "L'obiettivo ora è ottenere la prossima
settimana il via libera per avviare il percorso per un nuovo aumento di fondi
per 3,5 miliardi di euro", ha evidenziato. "Ovviamente richiederà diverse
discussioni tecniche perchè non parliamo di una somma modesta ma vorremmo
ottenere l'ok politico", ha precisato.
15:21
Ucraina, Madrid:
"Non invieremo aerei da guerra a Kiev"
La Spagna è
"totalmente impegnata" al fianco dell'Ucraina e "rispetta" le decisioni di tutti
i Paesi suoi alleati, ma "non parteciperà" all'invio a Kiev di "aerei da
combattimento": lo ha affermato a cronisti la ministra della Difesa, Margarita
Robles. "La Spagna non è in possesso degli aerei che chiede l'Ucraina", ha
aggiunto.
15:24
Casa Bianca: "La
tregua ora sarebbe la ratifica delle conquiste russe"
La Casa Bianca ha
espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a
Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano
in un'unica direzione. Il portavoce del consiglio per la sicurezza
nazionale John Kirby ha detto che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace
cinese non porterebbe ad "una pace giusta e durevole" ma sarebbe "la
ratificazione della conquista russa".
15:27
Usa: "Non ci sono
prove che armi cinesi siano state consegnate a Kiev"
Gli Stati Uniti
ritengono che Pechino "non abbia ancora escluso" la possibilità di fornire armi
alla Russia, ma non ci sono prove al momento che la Cina abbia deciso in questo
senso o che abbia fornito armi a Mosca. Lo ha riferito il portavoce del
Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.
15:30
Zelensky
ringrazia il primo ministro slovacco per gli aiuti alla difesa aerea
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky in una telefonata con il primo ministro slovacco
Eduard Heger lo ha ringraziato per il significativo pacchetto per la difesa
aerea annunciato a favore dell'Ucraina. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.
"I nostri accordi a Bruxelles stanno funzionando! Durante una telefonata, ho
ringraziato il primo ministro slovacco Eduard Heger per un consistente pacchetto
di armi per la difesa aerea, compresi gli aerei MiG. Apprezzo il suo ruolo
personale nel sostenere l'Ucraina. Non vedo l'ora di continuare il nostro
dialogo a Kiev", ha scritto Zelensky.
15:49
Ucraina, Putin:
"Faremo di tutto per difendere la Crimea"
La Russia farà
"tutto per fermare ogni minaccia" alla Crimea e Sebastopoli. Lo ha detto il
presidente Vladimir Putin alla vigilia del nono anniversario dell'annessione
della penisola alla Federazione Russa. Il presidente, citato dall'agenzia
Interfax, ha aggiunto che il governo realizzerà tutti i piani previsti per lo
sviluppo economico della Crimea, compresi gli investimenti nel settore
industriale e turistico.
15:55
Nato, Erdogan:
"Sì all'adesione della Finlandia. Quella della Svezia dipenderà dalle azioni del
governo"
Il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che il parlamento turco inizierà i
lavori per la ratifica dell'ingresso della Finlandia nella Nato. "Iniziamo con
la procedura di ratifica presso il parlamento. Gli incontri che abbiamo avuto
con i rappresentati della Finlandia hanno avuto esito positivo", ha detto il
presidente turco alla presenza del collega finlandese Sauli Niinisto, giunto
oggi nella capitale turca Ankara. "Dal momento che non ci danno i terroristi non
è possibile avere un approccio favorevole verso la Svezia", ha aggiunto Erdogan.
16:14
Ucraina, la Corte
penale internazionale emette il mandato d'arresto per Putin
La Corte penale
internazionale (Cpi) ha emesso venerdì un mandato di cattura contro il
presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di essere responsabile di crimini
di guerra commessi in Ucraina. Mosca ha ripetutamente negato le accuse di
atrocità durante la sua invasione di un anno del suo vicino
16:21
Il mandato di
arresto di Putin della Cpi è per "la detenzione illegale di bambini"
La Corte penale
internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Putin per
crimini di guerra a causa del suo presunto coinvolgimento in rapimenti di
bambini dall'Ucraina. La corte ha affermato in una dichiarazione che Putin "è
presumibilmente responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di
popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle
aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa". Venerdì ha anche emesso un
mandato di arresto per Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Commissario per i diritti
dei bambini presso l'Ufficio del Presidente della Federazione Russa con accuse
simili.
16:28
Mosca: "Di
Crosetto non importa nulla a nessuno"
"Non ci si deve
sopravvalutare. Di lui non importa nulla a nessuno". Così Oleg Osipov,
assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev,
ha commentato le notizie sulla taglia istituita dai mercenari Wagner sul
ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo riporta Ria Novosti, citata dai media
russi.
16:34
Russia, mandato
di arresto della Corte penale internazionale anche per Maria Lvova-Belova
Oggi la corte ha
emesso un mandato di arresto anche per Maria Alekseyevna Lvova-Belova,
Commissaria per i diritti dei bambini presso l'Ufficio del Presidente della
Federazione Russa, per accuse simili.
16:41
Russia,
Zakharova: "Per noi le decisioni della Corte penale internazionale non hanno
alcun significato"
"Le decisioni
della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro
Paese, nemmeno dal punto divista legale". Lo ha detto la portavoce del ministero
degli Esteri russo Maria Zakharova dopo la notizia del mandato d'arresto contro
il presidente Vladimir Putin.
16:43
Ucraina, Kiev:
"Mandato di arresto per Putin è una decisione storica"
"Una decisione
storica". Così il procuratore generale dell'Ucraina, Andrij Kostin, ha
commentato su Twitter il mandato d'arresto emanato dalla Corte penale
internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin. "Sono personalmente
grato al procuratore della Cpi Karim Khan per questa storica decisione.
Continuiamo la stretta collaborazione con la Cpi nei casi di deportazione
forzata di bambini ucraini. Oltre 40 volumi di fascicoli, più di 1000 pagine di
prove già condivise con la Corte", ha scritto su Twitter.
16:49
Cpi, esecuzione
arresto dipende da collaborazione internazionale
I giudici della
Corte penale internazionale hanno esaminato i documenti e le prove raccolte dal
procuratore e hanno stabilito che c'erano accuse credibili contro queste due
persone", Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova. "La Cpi sta facendo
la sua parte di lavoro, i giudici hanno emesso i mandati d'arresto. La loro
esecuzione dipende dalla collaborazione internazionale". Lo ha dichiarato in un
video il presidente della Cpi, giudice Piotr Hofma?ski annunciando la decisione
odierna della II Camera preliminare.
17:00
Medvedev:
"Mandato d'arresto contro Putin è carta igienica"
"La Corte penale
internazionale ha emesso un mandato d'arresto contro Vladimir Putin. Non c'è
bisogno di spiegare 'dove' dovrebbe essere usato questo documento". Lo scrive su
Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev,
aggiungendo un emoji della carta igienica.
17:25
Ucraina: Kuleba,
bene Cpi su Putin, la giustizia si muove
"La giustizia
sta facendo il suo corso: plaudo alla decisione della Corte penale
internazionale di emettere mandati d'arresto per Vladimir Putin e Maria
Lvova-Belova per il trasferimento forzato di bambini ucraini". Lo ha scritto su
Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "I criminali
internazionali saranno perseguiti per il rapimento di bambini e per altri
crimini internazionali", ha aggiunto.
17:33
Commissaria russa
diritti bambini, continuiamo a lavorare
"Continuiamo a
lavorare". Lo ha dichiarato Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i
diritti dei bambini presso il Cremlino, commentando il mandato d'arresto della
Corte penale internazionale nei suoi confronti con l'accusa di trasferimento
forzato di bambini ucraini. Lo riporta la Tass.
17:49
Cremlino,
mandato arresto Cpi oltraggioso e privo di effetti
Il Cremlino ha
definito oltraggiosa l'emissione di un mandato di arresto per Vladimir Putin da
parte della Corte penale internazionale e nulla dal punto di vista legale.
"Consideriamo la formulazione stessa della questione oltraggiosa e
inaccettabile", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti,
"la Russia, come un certo numero di altri stati, non riconosce la giurisdizione
di questa corte. Di conseguenza, qualsiasi decisione di questo tipo è nulla e
priva di effetto per la Federazione Russa dal punto di vista giuridico", ha
sottolineato.
17:59
Medvedev:
"Mandato d'arresto contro Putin? Come carta igienica"
"La Corte Penale
Internazionale ha emesso un mandato d'arresto contro Vladimir Putin. Non c'è
bisogno di spiegare dove dovrebbe essere usata questa carta". Lo scrive su
Twitter il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev.
18:08
Cpi: "Centinaia
di bambini presi dagli orfanotrofi e dati in adozione in Russia"
"Gli incidenti
identificati dal mio Ufficio includono la deportazione di almeno centinaia di
bambini prelevati da orfanotrofi e case di accoglienza per bambini. Molti di
questi bambini, secondo noi, sono stati dati in adozione nella Federazione
Russa". E' quanto dichiara in uno statement il procuratore della Cpi Karim Khan.
"La legge è stata modificata nella Federazione Russa, attraverso decreti
presidenziali emanati dal presidente Putin, per accelerare il conferimento della
cittadinanza russa, rendendo più facile l'adozione da parte di famiglie russe.
Il mio Ufficio sostiene che questi atti, tra gli altri, dimostrano l'intenzione
di allontanare definitivamente questi bambini dal loro Paese. Al momento di
queste deportazioni, i bambini ucraini erano persone protette dalla Quarta
Convenzione di Ginevra", spiega Khan aggiungendo: "Nella nostra richiesta
abbiamo anche sottolineato che la maggior parte degli atti di questo schema di
deportazione sono stati effettuati nel contesto degli atti di aggressione
commessi dalle forze militari russe contro la sovranità e l'integrità
territoriale dell'Ucraina, iniziati nel 2014".
18:14
Ue, "bene il
mandato contro Putin, è solo l'inizio"
"Con il mandato
di arresto contro Vladimir Putin ci troviamo di fronte a un'importante decisione
di giustizia internazionale e per il popolo ucraino: abbiamo sempre detto
nell'Unione Europea che gli autori dei crimini in Ucraina dovranno essere
ritenuti responsabili: questo è solo l'inizio del processo". Lo ha detto l'alto
rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. "L'Ue sostiene il lavoro
della Corte Penale Internazionale, non può esserci impunità", ha aggiunto.
18:33
Regno Unito,
"bene il mandato contro Putin, le indagini continuino"
Il Regno Unito ha
accolto con favore la decisione della Corte penale internazionale di emettere un
mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che le
indagini sui presunti crimini di guerra in Ucraina devono continuare. E' quanto
si legge in un tweet del ministro degli Esteri britannico James Cleverly,
secondo cui "i responsabili di orribili crimini di guerra in Ucraina devono
essere assicurati alla giustizia".
18:44
Kiev, camera di
tortura russa a Energodar
L'esercito russo
ha realizzato una camera di tortura per i cittadini filo-ucraini nella città
occupata di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia. Lo rende noto lo Stato
maggiore delle forze armate di Kiev. Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo i
militari di Kiev, "le persone con opinioni filo-ucraine e coloro che non
soddisfano i requisiti degli occupanti sono sottoposte a gravi torture".
18:56
Filorussi
Donetsk, 70% Bakhmut sotto controllo militari Mosca
"Le unità russe
hanno preso il controllo di circa il 70% del territorio di Bakhmut". Lo ha
dichiarato Jan Gagin, consigliere del capo ad interim dell'autoproclamata
repubblica di Donetsk, sul canale televisivo Rossiya 24. "Se parliamo di Bakhmut
le nostre forze ora controllano circa il 60%, forse anche di più, fino al 70%
della città stessa", ha detto.
19:17
Casa Bianca:
"Bene avvio ratifica Turchia adesione Finlandia, lo faccia anche per Svezia"
"Gli Stati Uniti
salutano l'annuncio del presidente Erdogan dell'invio al Parlamento turco i
protocolli di adesione alla Nato della Finlandia e aspettiamo con ansia una
veloce conclusione del processo". Lo dichiara il consigliere per la Sicurezza
Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan che poi aggiunge: "incoraggiamo la
Turchia a ratificare velocemente anche l'adesione della Svezia". "Inoltre
esortiamo l'Ungheria a concludere senza ritardi il processo di ratifica per
Svezia e Finlandia", afferma ancora Sullivan che definisce i due Paesi "partner
forti e capaci che condividono i valori Nato e rafforzeranno l'Alleanza e
contribuiranno alla sicurezza Europea". "Gli Stati Uniti credono che entrambi i
Paesi debbano diventare membri della Nato al più presto possibile" conclude la
dichiarazione.
19:25
Deportazione
bambini? Mosca, si chiama "salvezza"
La portavoce del
ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "salvezza" la
deportazione dei bambini ucraini nei territori russi, giudicato invece un
crimine di guerra dalla Corte penale internazionale che per questo ha spiccato
un mandato di arresto per Vladimir Putin. "Chi avrebbe pensato, 15 anni fa, che
in Occidente prendersi cura dei bambini, salvarli e curarli sarebbe diventato un
reato penale", ha scritto su Telegram la portavoce. "Tutto però ci stava
portando verso questo", ha continuato, "gli esperimenti dell'Occidente
illuminato sulla riassegnazione di genere ai bambini, la persecuzione dei medici
che credono che ci siano solo due sessi, la sostituzione di 'madre' e 'padre'
con 'genitore A' e 'genitore B'". "Non si trattava di sfortunati episodi, ma di
una politica di vasta scala dei Paesi Nato", ha denunciato Zakharova.
19:35
Zelensky,
deportazioni "impossibili" senza ok Putin
"Sarebbe
impossibile portare a termine un'operazione così criminale" come la deportazione
di migliaia di bambini ucraini in territorio russo, "senza l'ordine del massimo
leader di questo Stato terrorista". Così il presidente ucraino, Volodymyr
Zelensky, ha commentato la notizia del mandato di arresto emesso dalla Corta
penale internazionale contro Vladimir Putin per "crimini di guerra". "Separare i
bambini dalle loro famiglie, privarli di ogni possibilità di contattare i loro
parenti, nasconderli in territorio russo e disperderli in regioni remote: tutto
questo è ovviamente una politica statale, una decisione statale, malvagità
statale che inizia proprio con il funzionario più alto in grado di questo
Stato", ha detto Zelensky in un video messaggio su Telegram.
19:52
Fonti Nato, 1.500
morti o feriti russi al giorno
Nell'attuale
offensiva in Ucraina, concentrata per lo più a Bakhmut, ogni giorno restano
uccisi o feriti circa 1.500 soldati russi. Lo rivela una fonte della Nato citata
dal Guardian, secondo cui non è chiaro quanto durerà la battaglia per Bakhmut. I
combattimenti sono intensi e cruenti sulla linea del fronte, lungo il fiume, che
è diventata una "zona di morte".
20:14
Berlino, "Putin
ha ordito la guerra, risponda in tribunale"
"Chi come Putin
ha ordito una guerra sanguinosa, dovrebbe risponderne in tribunale". Lo ha detto
il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, parlando a Rnd. ll mandato
d'arresto per crimini di guerra che è stato emesso contro il presidente russo
dalla Corte penale internazionale "è un importante segnale di determinazione" e
la soluzione migliore è che si possa presentare un'accusa della Corte, ha
commentato Buschmann, che è membro dei Liberali Fdp. Inoltre, è importante
continuare a pensare ad altri modelli su "cui possiamo implementare un'azione
penale coerente, per esempio con un tribunale speciale per perseguire il crimine
della guerra di aggressione", ha continuato il ministro tedesco.
20:28
Usa, Xi parli con
Zelensky mentre è a Mosca
Gli Stati Uniti
sollecitano il presidente cinese Xi Jinping, che da lunedì sarà in visita a
Mosca, a parlare anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre
sarà in missione in Russia. "Speriamo anche che il presidente Xi contatti
direttamente il presidente Zelensky, perché continuiamo a credere che sia molto
importante che senta anche la parte ucraina e non solo Putin", ha detto il
portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby.
21:08
Ucraina: "Mandato
arresto a Putin rende difficile visita Kiev"
Il mandato
d'arresto della Corte Penale Internazionale (Cpi) contro Vladimir
Putin complica la visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping. A dirlo
è Oleksy Danilov, segretario del Consiglio ucraino di difesa e sicurezza
nazionale. "A proposito dell'annunciata vista del leader cinese a Mosca: penso
che la situazione sarà ora difficile per la Cina. E' difficile incontrare una
persona che è sospettata dalla Corte penale internazionale di reati contro i
bambini ucraini. Anche se la Cina non aderisce allo Statuto di Roma della Cpi,
sarà comunque un compito difficile per la Cina e i suoi diplomatici", ha detto
Danilov, citato da Interfax Ukraine.
21:37
Allerta aerea a
Kiev
Allerta aerea
questa sera a Kiev. L'autorità militare ha diffuso l'allerta per possibili
attacchi di droni kamikaze, invitando la popolazione a raggiungere i rifugi.
21:48
Zelensky: "Oltre
16mila bambini deportati, solo 300 restituiti"
Sono "oltre
16mila" i casi registrati di bambini ucraini deportati in Russia, ma i veri
numeri potrebbero essere "molto più alti". E le autorità ucraine sono riuscite a
riportarne a casa solo 300. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky nel suo discorso serale, dopo che la Corte penale internazionale ha
emesso oggi un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin e
un'alta funzionaria russa per il reato di deportazione dei bambini ucraini.
22:11
Procuratore Cpi,
possibile Putin venga processato un giorno
Non è impossibile
che il presidente russo Vladimir Putin possa un giorno essere processato dalla
Corte penale internazionale. Lo ha detto il procuratore capo dell'Cpi, Karim
Khan. Lo riporta la Cnn. "Quelli che pensano sia impossibile non capiscono la
storia - ha aggiunto - i principali criminali di guerra nazisti, l'ex presidente
jugoslavo Slobodan Miloüevic, l'ex politico serbo-bosniaco Radovan Karad, l'ex
ufficiale militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, l'ex presidente
liberiano Charles Taylor, l'ex primo ministro Jean Kambanda del Ruanda, Hissène
Habré, l'ex presidente del Ciad, erano tutti individui potenti e potenti, eppure
si sono trovati in un'aula di tribunale davanti a giudici indipendenti", ha
detto Khan.
22:29
Casa Bianca su
Cpi per Putin, sosteniamo responsabilità per crimini guerra
La Casa Bianca
"sostiene la responsabilità" per quanti hanno commesso "crimini di guerra" in
Ucraina. Lo ha affermato alla Cnn John Kirby, portavoce del Consiglio per la
Sicurezza nazionale. "Vogliamo vedere i perpetratori di crimini di guerra
davanti alla giustizia" e continuiamo a sostenere l'indagine internazionale", ha
detto Kirby.
22:44
Onu, tutto il
possibile perché iniziativa grano continui
"In questo
momento le Nazioni Unite, sotto la guida del segretario generale Guterres,
stanno facendo tutto il possibile per garantire che l'Iniziativa per i cereali
del Mar Nero possa continuare". Lo ha detto il capo degli affari umanitari
dell'Onu Martin Griffiths a una riunione del Consiglio di Sicurezza
sull'Ucraina. "Continuiamo a impegnarci a stretto contatto con tutte le parti -
ha aggiunto - Questa settimana, i prodotti alimentari hanno continuato ad essere
trasportati fuori dall'Ucraina attraverso il corridoio umanitario marittimo,
sotto la supervisione del Centro comune di coordinamento". L'accordo scade
domani, la Russia insiste su un rinnovo di 60 giorni mentre l'Onu chiede di
attenersi ai 120 giorni previsti.
(askanews il 17 marzo 2023) -
Il mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del
presidente russo Vladimir Putin "non ha alcun significato legale" per Mosca: lo
ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
La portavoce ha spiegato che
la Russia non ha sottoscritto il Trattato di Roma, che ha dato vita alla Cpi, e
dunque non ha alcun obbligo legale nei confronti delle sue decisioni.
L’Aia vuole
arrestare Putin: «Ha deportato i bambini». Fiorenza
Sarzanini su Il Corriere della Sera
il 18 marzo 2023.
Lo zar ora è
ufficialmente ricercato dalla Corte penale internazionale. Kiev
esulta:«Decisione storica». Mosca: «Carta igienica»
Putin e la
commissaria Maria Lvova-Belova
Il mandato di
cattura internazionale è stato firmato ieri alle 16 dai giudici della Corte
penale dell’Aia. E adesso il presidente Vladimir Putin è ufficialmente ricercato
con l’accusa di crimini di guerra «per aver deportato bambini e adolescenti
ucraini in Russia». Provvedimento analogo contro Maria Lvova-Belova, la
commissaria di Mosca per i diritti dei bambini, che ha curato personalmente i
trasferimenti e l’organizzazione dell’accoglienza negli orfanatrofi e presso
nuove famiglie . Arriva dunque la clamorosa svolta nell’indagine avviata poche
settimane dopo l’invasione rendendo di nuovo altissima la tensione con Mosca che
definisce «carta igienica» gli atti giudiziari, mentre da Kiev il presidente
Volodymyr Zelensky esulta «è una decisione storica, l’inizio della fine» e l’Ue
avvisa: «Non ci può essere impunità, ora si prosegue».
A firmare
l’ordine di cattura sono tre giudici: l’italiano Rosario Aitala, la giapponese
Tomoko Akane e il costaricano Sergio Ugalde. La conseguenza è immediata, se
Putin e la sua fidata collaboratrice dovessero uscire dai confini potrebbero
essere arrestati da qualsiasi forza di polizia di uno dei 123 Stati che hanno
firmato la convenzione.
I 600 fascicoli
«Noi continuiamo
a lavorare», commenta Lvova-Belova lasciando intendere che i trasferimenti non
si fermeranno. Kiev sostiene che sono oltre 16 mila i minori portati in
Russia , i rapporti internazionali accreditano almeno seimila deportazioni.
Nell’ordine di cattura sono elencati i casi già accertati attraverso le
testimonianze dei genitori, dei familiari, degli stessi ragazzi che sono
riusciti a ritornare in Ucraina. L’indagine si è concentrata su chi è stato
strappato alle famiglie, ma anche sugli orfani che sono stati chiusi nelle
strutture russe per essere «educati». La maggior parte proviene dal Donbass, poi
c’è chi è stato preso a Mariupol, nel Donetsk. Le verifiche proseguono perché
secondo le norme internazionali si può contestare questo tipo di reato soltanto
se commesso nei territori occupati e dunque è indispensabile ricostruire la
storia di ogni bambino e adolescente costretto a vivere lontano dal proprio
Paese e dai propri familiari.
Le chat di
Telegram
Nelle migliaia di
pagine raccolte dalla procura coordinata dal britannico Karim Ahmad Khan e dagli
stessi giudici che hanno poi ordinato l’arresto, ci sono anche i documenti
trasmessi dal procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin. Oltre
ai verbali, ai video che mostrano l’arrivo dei bimbi e dei ragazzi in
Russia, documentano i rastrellamenti dei soldati e gli ingressi in alcuni
edifici ucraini, i successivi viaggi, ci sono le chat intercettate sul canale
Telegram. Proprio lì — in alcuni gruppi segreti appositamente creati, ma anche
nei post pubblici — la commissaria Lvova-Belova e i suoi collaboratori
comunicano i vari trasferimenti e danno indicazioni su dove portare i minori.
Spesso ricevendo il plauso dello stesso Putin che nel maggio 2022 ha firmato un
decreto per snellire e rendere subito operative le procedure per far ottenere
agli ucraini la cittadinanza russa. Il mandato di cattura internazionale è stato
emesso perché ai capi di Stato non viene riconosciuta l’immunità nei casi che
coinvolgono crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio.
«Bottino di
guerra»
Investigatori e
magistrati che indagano sui crimini compiuti durante il conflitto spiegano che
questo filone di indagine ha sempre avuto la priorità perché «bambini e
adolescenti non possono essere trattati come bottino di guerra». La commissione
d’inchiesta dell’Onu ha trasmesso le proprie conclusioni alla Corte confermando
la contestazione di crimini contro l’umanità. Secondo un rapporto pubblicato da
un centro di ricerca dell’università di Yale nel febbraio 2023 e intitolato «Il
sistematico programma della Russia per la rieducazione e l’adozione dei minori
ucraini», «tra febbraio 2022 fino a gennaio 2023 sono stati trasferiti più di
6.000 giovani di età compresa fra 4 mesi di età e 17 anni».
Strutture di
detenzione
I ricercatori
hanno individuato «43 strutture di detenzione e rieducazione, di cui 12 attorno
al mar Nero, 7 nella Crimea occupata, 10 attorno alle città di Mosca, Kazan ed
Ekaterinburg, mentre gli altri nelle regioni dell’estremo oriente russo, di cui
2 in Siberia». Nel dossier si specifica che «i genitori sono stati costretti,
ingannati con la promessa di un trasferimento temporaneo o non interpellati del
tutto e i moduli di affido compilati con firme false. In ogni caso, la capacità
dei genitori di fornire un consenso effettivo viene considerata dubbia, perché
«lo stato di guerra e la minaccia implicita delle forze di occupazione
rappresentano una forma di costrizione costante».
Chi è Rosario
Aitala, l’italiano tra i giudici dell’Aja che accusano Putin di crimini di
Guerra.
Fiorenza Sarzanini su Il
Corriere della Sera
il 17 marzo 2023.
Rosario Salvatore
Aitala è entrato in magistratura nel 1997. Prima di approdare all’Aja è stato
consigliere nelle aree di crisi e criminalità internazionale di diversi Paesi
«Il diritto
internazionale penale è un modo di guardare il mondo. Chiunque legga le pagine
della storia delle atrocità di massa, anche se molto distanti nel tempo e nello
spazio, diventa testimone di crimini che invocano giustizia». Lo ha scritto nel
suo ultimo libro Rosario Salvatore Aitala, il giudice italiano che con altri due
giudici - la giapponese Tomoko Akane e il costaricano Sergio Ugalde - ha accolto
le richieste di Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale
internazionale dell’Aja, che aveva avviato un’indagine sui crimini di guerra e
contro l’umanità commessi da i militari russi e Vladimir Putin in Ucraina. Il
verdetto è arrivato: mandato di arresto internazionale per crimini di guerra. Il
presidente russo è accusato di aver deportato migliaia di bambini ucraini in
Russia, insieme alla commissaria russa per i diritti dei bambini Maria
Lvova-Belova.
Professore di
diritto internazionale penale alla LUISS, 55 anni, Aitala è stato fino al 1992
funzionario di polizia e nel 1997 è entrato in magistratura. Ha lavorato a
Milano, Trapani, Roma ma è stato molto all’estero. Prima di arrivare all’Aja è
stato consigliere per le aree di crisi e la criminalità internazionale del
ministero degli Esteri in Albania, Afghanistan, Balcani e America Latina e
consigliere per gli affari internazionali del presidente del Senato Piero
Grasso.
È componente
della commissione sui crimini di guerra istituita dall’allora ministra della
Giustizia Marta Cartabia. Nel suo libro ha scritto: «È nel secolo più violento
di sempre, il Ventesimo, che il male smisurato si afferma come meditata
strategia politica giocata sulla pelle di milioni di persone inermi. Dunque non
mera malvagità: piuttosto grammatica del potere».
Il mandato di
arresto contro Putin e i bambini ucraini.
Piccole Note (filo
Putin) il 21 marzo 2023 su Il Giornale.
Il mandato di
arresto contro Putin della Corte dell’Aja presenta diverse criticità. Una di
queste, poco indagata, riguarda l’estrema vulnerabilità dei bambini ucraini. I
bambini del Donbass erano a rischio a causa delle bombe, ché tante ne cadono,
lanciate dagli ucraini, nel territorio controllato dai russi (peraltro
bombardato per anni anche prima dell’invasione; in tale temperie, come
registrava l’Unicef, sono stati uccisi 152 bambini e 146 sono rimasti feriti,
mentre 66.491 hanno “sofferto a causa della guerra”). Ma i bimbi ucraini
risultano esposti anche ad altri pericoli, perché tanti sono i predatori che si
aggirano per il Paese.
Riprendiamo
dal Corriere della Sera del 20 maggio 2020: “l’Ucraina è diventata un negozio
online internazionale per la vendita di neonati”. A denunciare tale situazione
era stata Mykola Kuleba, difensore civico dei bambini del governo Zelensky.
Un grido di dolore
lanciato dopo la tragica scoperta di un centinaio di bambini, nati attraverso la
pratica dell’utero in affitto, stipati in una stanza d’albergo perché, a causa
dei lockdown pandemici, i genitori a distanza non avevano potuto prelevarli.
Sul punto
l’Associated Press del 10 giugno 2020 rilevava: “L’Ucraina ha una fiorente
industria della maternità surrogata ed è uno dei pochi paesi che consente agli
stranieri di partecipare a tale pratica. Circa 50 cliniche offrono servizi di
maternità surrogata nel paese, dove le ristrettezze economiche spingono molte
donne ucraine a diventare madri surrogate”. Di oggi un articolo di Libero che
spiega come tale industria sia ancora fiorente. Pratica legale, ma a rischio di
incidenti di percorso e non sempre curata da persone affidabili, come rivela la
scoperta alla quale abbiamo accennato.
Il fenomeno della
sparizione di bambini
Più inquietante
quanto denunciava anni fa l’European Centre for Law and Justice, secondo il
quale l’Ucraina registrava una massiva sparizione di bambini, a volte usati
anche per alimentare il traffico di organi. “È difficile guardare i minuscoli
cadaveri dissotterrati dal cimitero vicino all’ospedale n. 6 – si legge in un
rapporto dell’ECLJ -. Le fotografie forensi mostrano corpi che sembrano esser
stati mutilati prima di essere gettati in una fossa comune a Kharkiv, una città
Ucraina”.
“In una foto si vede
un uomo con guanti chirurgici che mette insieme diversi pezzi di carne,
disponendo i frammenti in modo da far intravedere il corpo di un bambino prima
che fosse smembrato”. Nel rapporto si parla di madri alle quali, dopo il parto,
sono stati sottratti i figli, adducendo la scusa che erano deceduti subito dopo
la nascita. Madri che hanno provato a trovare una risposta alle loro domande,
sbattendo però sempre la “testa contro un muro”.
“Ancora più
inquietante, ha affermato la signora Vermot-Mangold [una delle madri in
questione], è l’evidenza che i bambini sono trattati in modo tanto disinvolto in
Ucraina, così è probabile che il numero reale di bambini scomparsi nel paese
resti sconosciuto”.
E ancora, il 2
giugno 2015 l’Huffington Post pubblicava un articolo di Laurie Ahern, presidente
di Disability Rights International, dal titolo: “Ucraina, gli orfanotrofi
alimentano il traffico di bambini”. Vi si legge che “i bambini poveri e
disabili, ospitati [negli orfanotrofi], lontani dal controllo delle famiglie e
delle loro comunità, sono bersaglio facile per trafficanti e pedofili. E il
personale addetto è spesso il nefasto beneficiario di transazioni perverse delle
quali i bambini prigionieri sono la merce”.
“La mia
organizzazione, Disability Rights International (DRI), ha recentemente
pubblicato un rapporto — “No Way Home: The Exploitation and Abuse of Children in
Ukraine’s Orphanages” — a seguito di un’indagine durata tre anni sulla
condizione dei bambini che vivono in istituti”.
“DRI ha scoperto che
i bambini sono a rischio di diventare preda di traffici a scopo sessuale, di
essere usati come manodopera, nella pornografia e nel traffico di organi, in un
paese noto per essere un hub per il traffico di esseri umani”.
“Si dice che circa
82.000 bambini vivano in queste strutture, anche se nessuno sembra saperlo con
certezza. Alcuni attivisti ucraini reputano che il numero si aggiri attorno ai
200.000”.
Il Dipartimento di
Stato Usa: Kiev non contrasta la tratta
Si tratta di anni
anche molto precedenti la guerra, ma non sembra che le cose siano molto cambiate
negli anni successivi. Infatti, nel 2021 il Dipartimento di Stato Usa denunciava
che “il governo dell’Ucraina non soddisfa pienamente gli standard minimi per
l’eliminazione della tratta” di esseri umani.
“L’impegno delle
forze dell’ordine per scoraggiare la tratta è stato inadeguato. Continuano le
segnalazioni di funzionari pubblici implicati nella tratta di esseri umani,
compresi funzionari della polizia anti-tratta. Sebbene il governo, nel periodo a
cui facciamo riferimento, abbia fatto delle indagini penali e accusato diversi
funzionari, presumibilmente complici [di tale traffico], per il quarto anno
consecutivo non si è registrata nessuna condanna“. Il Dipartimento di Stato non
parla specificamente di tratta di bambini, ma le reti che operano in tale
settore hanno maglie molto larghe.
Il conflitto ha
acuito i rischi. Sulla situazione successiva alla guerra, un rapporto
dell’Unicef nel quale si legge: “I bambini costituiscono la metà dei rifugiati
della guerra ucraina, secondo l’UNICEF e l’UNHCR. Più di 1,1 milioni di bambini
sono arrivati in Polonia e centinaia di migliaia in Romania, Moldavia,
Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca”.
“L’UNICEF continua
ad avvertire sul rischio che possano essere vittime della tratta di esseri umani
e dello sfruttamento. Per cercare di ridurre i rischi che i bambini e i giovani
devono affrontare, l’UNICEF, l’UNHCR e i partner del governo e della società
civile stanno aumentando i ‘punti blu’ nei paesi che ospitano i rifugiati […],
spazi sicuri per fornire informazioni alle famiglie in viaggio, aiutare a
identificare i minori non accompagnati e isolati e garantire loro protezione
dallo sfruttamento”.
Come si può notare,
bambini senza genitori sono arrivati nell’Europa dell’Est in maniera caotica,
tanto che l’Unicef è dovuto intervenire per ridurre i rischi, mentre la Russia
ha organizzato un piano di evacuazione strutturato, spostando i bambini a
rischio o isolati nel proprio territorio, al sicuro dalle bombe e da altro.
Dal momento che la
Russia è un Paese nemico dell’Ucraina, si è parlato di deportazione, perché Kiev
non ha consentito a tale operazione. Era meglio lasciarli in balia dei
trafficanti e delle bombe? Domanda che lasciamo in sospeso.
I veterani Usa e i
bambini ucraini
Di interesse
osservare come anche gli Stati Uniti si siano adoperati per salvare i bambini a
rischio. Così la BBC: “Una squadra di veterani militari statunitensi sta
aiutando a organizzare un passaggio sicuro per i circa 200.000 bambini ospiti
degli orfanotrofi e delle famiglie ucraine affidatarie”.
“Ma dicono che
migliaia sono dispersi e temono che alcuni possano essere già caduti preda dei
trafficanti di esseri umani”. Martin Kvernbekk, un volontario che si è prodigato
in tale operazione, ha raccontato alla BBC che “ha sentito parlare di bambini
scomparsi da una serie di fonti diverse e di rapporti di trafficanti di persone
che indossano giubbotti catarifrangenti e fingono di appartenere a
organizzazioni che aiutano i soccorsi”.
“Le organizzazioni
sono molto forti – sono reti grandi e ben finanziate, che fanno questo per
vivere. Sono brave a far questo in tempo di pace”, dice. “Ora c’è la guerra, il
caos, e stanno sfruttando il disordine per poter rapire più donne e bambini
possibile”.
Insomma, ucraini e
americani hanno fatto la stessa cosa dei russi. Solo che quanto fatto dai primi,
che hanno portato i bambini al sicuro nella zona occidentale del Paese o nei
Paesi dell’Est, è opera meritoria; mentre i russi, avendoli portati nel loro
Paese, li hanno deportati…
Peraltro, gli sforzi
di Kiev e dei veterani Usa hanno solo limitato i danni. Infatti, “il governo non
ha la capacità di affrontare il problema”, ha detto alla BBC Jeremy Locke, a
capo del team che si è prodigato per salvare i fanciulli. Tanto che, in una
riunione, le autorità si sono accorte come “5.000 bambini fossero scomparsi dai
loro registri”, ha aggiunto.
“Nessuno sa cosa gli
sia successo. O sono vittime di guerra o sono scappati dal paese oppure sono
stati portati oltreconfine da contrabbandieri o da persone che lavorano in modo
errato'”, ha commentato Locke.
Pedofili in missione
Interessante anche
un articolo dell’Indipendent, anch’esso successivo all’inizio della guerra. Ne
riportiamo l’incipit: “Diversi pedofili britannici si sono recati
in Polonia dichiarando di voler prestare ‘assistenza umanitaria’ ai rifugiati in
fuga dall’Ucraina, tra cui migliaia di bambini non accompagnati“.
“La National Crime
Agency (NCA) ha affermato che 10 noti pedofili si sono recati nel paese nelle
sei settimane successive all’invasione russa. A tutti e 10 è stato chiesto di
lasciare la Polonia dopo un colloquio con gli agenti dell’immigrazione e le
forze dell’ordine e ora le autorità britanniche stanno lavorando per dissuadere
altri dall’intraprende simili viaggi”.
I dieci loschi
figuri sono stati identificati per la la loro fedina penale sporca. Ma siamo
pronti a scommettere che altri con analoga fedina penale hanno portato a termine
la loro nefasta missione, eludendo i controlli o corrompendo qualcuno; e altri,
con la fedina penale pulita, si sono prestati a operazioni analoghe senza essere
scoperti.
Ed è presumibile che
tale attività non ha visto all’opera solo predatori britannici e non abbia avuto
come obiettivo solo i bambini ucraini rifugiati in Polonia, ma anche quelli che
hanno trovato riparo negli altri Paesi dell’Est e nella stessa Ucraina. Quanto
emerso, cioè, è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che sarebbe tutto da
indagare, ma che non è stato indagato né lo sarà.
Lo denota l’altra
cosa sconcertante dell’articolo: una volta scoperti, i dieci figuri, invece di
essere arrestati e di indagare se facessero parte di una rete, come probabile
che fosse, sono stati invitati a lasciare la Polonia. E possiamo scommettere che
anche al loro ritorno in patria non hanno avuto alcun problema con le autorità,
altrimenti l’articolo ne avrebbe accennato.
Invece, si rileva
solo come le autorità britanniche hanno tentato di “dissuadere altri”
dall’intraprendere analoghi viaggi, non sappiamo se attraverso una campagna
pubblicitaria o altro e altrettanto aleatorio (un’inchiesta sarebbe stata forse
più incisiva…).
Insomma, l’Ucraina
non sembra essere un Paese nel quale i bambini hanno vita facile, per usare un
eufemismo, e la guerra ha aumentato la loro vulnerabilità. Dato tutto ciò, il
mandato di arresto contro Putin, colpevole di aver sottratto i fanciulli del
Donbass alle bombe e ai tanti pericoli che incombevano su di essi (nel Paese
confinante e altrove), lascia ancora più perplessi.
Operazione Babylift
Da ultimo, ci
permettiamo di citare un articolo di Kurt Nimmo riportato dal Ron Paul
Institute, che rammenta l’operazione Babylift, autorizzata dal presidente Gerald
Ford alla fine della guerra del Vietnam, quando 3300 bambini vietnamiti furono
prelevati dall’Us Army perché venissero adottati in “America, Australia,
Germania ovest e Francia”.
“I bambini
vietnamiti rapiti senza permesso furono identificati come ‘orfani’ nonostante il
fatto che molti di essi avessero genitori e parenti” in patria, scrive Nimmo.
“Un crimine” contro il quale fu intentata una causa collettiva che mirava “a
fermare il procedimento di adozione fino a quando non fosse stato accertato che
i genitori o i parenti in Vietnam erano consenzienti […] o che non avessero più
genitori o parenti […]. Nella denuncia si dichiarava che molti degli orfani
vietnamiti portati negli Stati Uniti durante l’operazione Babylift affermavano
di non essere affatto orfani e di voler tornare in Vietnam”.
Solo per accennare
da che pulpiti provengano certe prediche.
Nota a margine. La
portavoce del Cremlino Marija Zacharova ha rivelato che il fratello di Karim
Khan, il procuratore della Corte che ha spiccato il mandato d’arresto contro
Putin, era un pedofilo e ha scontato solo metà della pena inflitta. Tutto vero,
vedi il relativo articolo della BBC sull’ex parlamentare britannico Imran Ahmad
Khan, espulso dal partito conservatore dopo la brutta vicenda. Le colpe e i
reati non sono trasmissibili, ma la cosa desta curiosità.
Mandato di
arresto per Putin, «I bambini ucraini portati in Crimea non si trovano più».
Lorenzo Cremonesi su Il Corriere
della Sera il 17
marzo 2023.
I centri di
smistamento e i 600 casi documentati. Il sospetto che Mosca abbia avviato un
progetto di ingegneria civile per la crescita demografica russa
«Ce ne andiamo
anche perché non vogliamo registrare i nostri figli nelle scuole controllate dai
russi. Quelli dei nostri vicini sono stati portati in un campo estivo in Crimea
e adesso non li trovano più», ci dicevano l’estate scorsa alcuni genitori tra
i nuclei famigliari in fuga dalla regione di Kherson ancora occupata. I più
spaventati erano coloro che erano disposti a trascorrere anche più di una
settimana chiusi in auto, fermi ai posti di blocco con i figli piccoli, tra afa,
sporcizia e zanzare, pur di lasciare al più presto la zona di Mariupol e
raggiungere i militari ucraini a Zaporizhzhia. Non fuggivano solo dai disagi
della loro città ridotta in macerie.
«Il peggio capita
ai filtration camp», raccontavano, citando i famigerati centri di censimento e
controllo, dove non era affatto raro che i soldati russi separassero i genitori
dai figli. I maschi più grandicelli rischiavano forte. I soldati se la
prendevano in particolare contro coloro che rifiutavano la deportazione in
Russia, o in Crimea, chiedendo di essere messi in aree di transito con la
speranza di poter poi evacuare nelle zone controllate dagli ucraini.
Le ultime notizie
sulla guerra in Ucraina, in diretta
Tra i profughi
giravano le informazioni su dove fossero i ceceni o i buriati da evitare ad ogni
costo e dove invece fosse possibile corrompere con poche grivne o, ancora, fosse
al comando un ufficiale meno burbero degli altri e propenso a lasciare passare
senza troppi problemi. «Il nostro destino è nelle mani di gente che non ha
alcuna idea di cosa siano i diritti civili», diceva una madre nei tendoni del
centro accoglienza di Zaporizhzhia, esausta dopo tante incertezze, ma felice di
avere ancora con sé il figlio e la figlia che voleva iscrivere ai licei ucraini.
Le autorità di
Kiev furono molto rapide nel cominciare a documentare i crimini di
guerra commessi dalle truppe russe sin dai primi giorni dell’invasione. Già di
fronte ai morti civili a Bucha, ai bombardamenti indiscriminati di Irpin,
ascoltando le testimonianze degli sfollati in fuga dalle prime regioni occupate,
gli ufficiali inviati dal procuratore generale ucraino iniziarono a registrare
le testimonianze, preparare i dossier e spedirli sia al Tribunale internazionale
dell’Aia che agli uffici competenti all’Onu.
E, sin dai passi
iniziali di questa inchiesta condotta sotto le bombe e tra le paure della guerra
guerreggiata, il tema del rapimento dei minori divenne prominente. Oggi si parla
di numeri compresi tra 6.000 e 13.000 casi, ma quelli documentati concretamente
pare siano circa 600. Del resto, il tema non è nuovo, aveva già caratterizzato
le accuse di Kiev contro le «violazioni dei diritti umani fondamentali» commesse
nel 2014 dai soldati russi sia occupando la Crimea che sostenendo i separatisti
di Lugansk e Donetsk nel Donbass. Già allora Kiev imputava al regime di Mosca il
piano di sequestrare i minorenni, anche orfani piccolissimi, per portarli tra
gli orfanotrofi in patria o per farli adottati a famiglie di provata lealtà allo
Stato con il piano di cancellare le loro identità ucraine e indottrinarli alla
fedeltà per la «madre Russia».
Nel 2022 la cosa
divenne ancora più evidente. Un grande progetto di ingegneria sociale con tre
effetti positivi per i suoi fautori: contribuire alla crescita demografica
nazionale, provocare un danno all’Ucraina e fiaccare la volontà di resistenza
della sua popolazione. Tanto importante fu documentarlo correttamente che il 1°
giugno il parlamento ucraino sfiduciava e rimuoveva dal suo incarico la
commissaria per i diritti umani, Lyudmila Denisova, che aveva gonfiato i numeri
e distorto all’eccesso le violenze russe. Le accuse a Putin dovevano essere
serie e circostanziate, si rischiava altrimenti di perdere di credibilità.
Mandato di
arresto internazionale per Putin: è accusato di deportazione illegale di bambini
ucraini.
Per la Corte penale
internazionale il presidente russo è responsabile di crimini di guerra: “Ha
trasferito illegalmente bambini dalle aree occupate dell’Ucraina alla
Federazione Russa”. Il Dubbio il
17 marzo 2023.
È un passaggio
traumatico e di importanza quasi storica, che allontana ancora di più la Russia
di Vladimir Putin dalla comunità internazionale e che è stato accolto dal
Cremlino con malcelata rabbia.
La Corte penale
internazionale ha infatti emesso un mandato di arresto per il presidente russo
ritenuto responsabile dei crimini di guerra commessi dall’esercito di Mosca in
Ucraina. Putin, si legge in un comunicato della Cpi, è accusato del "crimini di
guerra di deportazione della popolazione" e di "trasferimento illegale della
popolazione", in particolare bambini dalle aree occupate dalle truppe di Mosca
in Ucraina dall'inizio della guerra.
«Ci sono fondate
ragioni», si legge ancora nel comunicato dall'Aja, «per ritenere che Putin abbia
responsabilità penali individuali per i crimini sopra menzionati». I giudici
della Corte hanno spiccato un mandato di arresto anche per la commissaria russa
per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, accusata degli stessi crimini del
suo presidente. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Kiev stima che siano
oltre 16 mila i bambini trasferiti forzatamente in Russia o nelle zone occupate
dall’esercito russo.
In precedenza,
gli inquirenti delle Nazioni Unite avevano stabilito che la deportazione forzata
di bambini ucraini equivaleva a un crimine di guerra. La Commissione d'inchiesta
delle Nazioni Unite sull'Ucraina ha affermato che vi sono prove del
trasferimento illegale di centinaia di bambini ucraini in Russia. Molto
dettagliata la spiegazione del procuratore della Cpi Karim Khan. «Attraverso
decreti presidenziali emanati dal presidente Putin ha accelerato il conferimento
della cittadinanza russa, rendendo più facile l'adozione da parte di famiglie
russe. Il mio Ufficio sostiene che questi atti, tra gli altri, dimostrano
l'intenzione di allontanare definitivamente questi bambini dal loro Paese. I
bambini ucraini erano persone protette dalla Quarta Convenzione di Ginevra». Il
rapporto della Commissione afferma che la Russia ha commesso anche altri crimini
di guerra in Ucraina, tra cui attacchi a ospedali, torture, stupri e omicidi
volontari.
La Russia dal
canto ha ripetutamente negato di aver commesso crimini nel corso di quella che
fin dal 24 febbraio del 2022 chiama "operazione militare speciale", rifiutandosi
di definirla una guerra.
Da Mosca la
reazione è furiosa e sprezzante allo stesso tempo: "Le decisioni della Corte
penale internazionale non hanno alcun significato per la Russia e dal punto di
vista legale sono nulle", ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri
russo Maria Zakharova, sottolineando che la Russia ha ritirato la sua firma
dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e non ha obblighi ai
sensi di esso. «Non collaboriamo con questo organismo» e i possibili mandati di
arresto provenienti dalla Corte internazionale «saranno legalmente
insignificanti per noi».
Esultanza invece
dai palazzi di Kiev. La presidenza ucraina ha definito "storica" la decisione
della Corte penale internazionale e lo ha definito "solo un primo passo" per
fare giustizia dopo l'invasione dell'Ucraina. "Questo è solo l'inizio", ha
aggiunto sui social il responsabile dello staff presidenziale ucraino Andriy
Yermak.
Anche l’Alto
rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, saluta la
decisione della Cpi: «Si tratta di un’importante decisione della giustizia
internazionale e per il popolo ucraino. Noi abbiamo sempre detto che i
responsabili dell’aggressione illegale contro l’Ucraina devono essere portati
alla giustizia. E questo mandato è solo l’inizio nel processo contro i leader
russi per i crimini e le atrocità commessi in Ucraina. L’Ueapprezza e sostiene
il lavoro della Corte penale internazionale e le sue inchieste. Non ci può
essere impunità».
Criminale di
Guerra. La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto per Vladimir
Putin.
Linkiesta
il 17 marzo 2023.
Il tribunale
dell’Aia ritiene il presidente russo responsabile, insieme alla sua commissaria
ai Diritti dei bambini, della deportazione di migliaia di minorenni ucraini
La Corte penale
internazionale dell’Aia ha emesso un mandato d’arresto internazionale per il
presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato la Corte, che ha sede nella
città olandese. La settimana si era aperta con un’indiscrezione del New York
Times, secondo cui i giudici erano ormai pronti ad aprire formalmente due
processi per i crimini commessi dalla Federazione Russa.
Il Cremlino deve
rispondere della deportazione di migliaia di bambini e ragazzi ucraini nei campi
di “rieducazione”, a partire dal 24 febbraio 2022. «Ci sono ragionevoli ragioni
per credere che Putin abbia responsabilità penali individuali per i crimini»,
scrive il Tribunale nel mandato d’arresto. Un analogo ordine di cattura è stato
spiccato anche per Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i Diritti dei
bambini della Russia, a sua volta coinvolta nei trasferimenti illegali.
È accertato il
trasferimento illegale di più di seimila minorenni in quarantatré strutture, ma
il bilancio totale potrebbe essere più alto (secondo fonti ucraine, oltre
sedicimila). I giudici incaricati, in sede preliminare, che ci fossero le basi
giuridiche per procedere contro i responsabili, le hanno riscontrate. Mosca non
riconosce l’autorità del Tribunale, ha detto in questi giorni il portavoce del
Cremlino, Dmitry Peskov.
Un secondo caso
potrebbe presto aprirsi per i bombardamenti indiscriminati alle infrastrutture
civili ucraine.
La Corte non
riconosce l’immunità ai capi di Stato in casi – come questo – di crimini di
guerra, contro l’umanità o genocidio. Nonostante il mandato d’arresto, però, il
tribunale non ha il potere di arrestare gli imputati: può esercitare la sua
giurisdizione solo sui Paesi che hanno sottoscritto lo Statuto di Roma del 1998.
Tra questi, non c’è la Russia.
«Le decisioni
della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro
Paese, anche da un punto di vista legale», ha infatti ribadito la portavoce del
ministero della Difesa russo, Maria Zakharova. «È solo l’inizio», commenta
invece il capo di gabinetto del governo ucraino, Andriy Yermak.
BRUCIA
L’INTELLIGENCE.
Ernesto Ferrante
su L’Identità il 17 Marzo 2023
È di un morto e
due feriti il bilancio dell’incendio che si è sviluppato in un edificio del
servizio di intelligence interna (Fsb) a Rostov, nel sud della Russia. A
causarlo sarebbe stato un cortocircuito. “E’ stato accertato che la causa
dell’incendio è un cortocircuito nell’impianto elettrico all’interno
dell’edificio. Il propagarsi dell’incendio ha provocato l’esplosione di
contenitori con carburante e lubrificanti”, ha scritto il governatore regionale
Vasily Golubev sul suo canale Telegram.
Golubev ha
aggiunto che i residenti delle case vicine al luogo dell’incidente sono stati
evacuati per motivi di sicurezza. “E’ in corso un’indagine”, ha riferito il
governatore.
Per gli ucraini è
la prova di un “conflitto interno”. “Qualsiasi edificio dell’Fsb che brucia o
che esplode in Russia, in particolare nella regione di Rostov, indica
chiaramente una manifestazione di panico, indebolimento del controllo del potere
e transizione verso un grave conflitto interno”, ha twittato il consigliere del
presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Podolyak. “L’Ucraina non interferisce, ma
guarda con piacere”, ha commentato sarcasticamente.
Le forze russe
stanno conducendo offensive contro Lyman, Avdeevka, Mariinka e Shakhtarsk
nell’oblast di Donetsk. La Wagner ha espugnato Zaliznyanskoye, un piccolo
insediamento situato a circa nove chilometri a nord-ovest di Bakhmut.
L’accerchiamento della città diventa ogni giorno più asfissiante.
La Polonia nei
prossimi giorni trasferirà quattro Mig-29 a Zelensky. Ad annunciarlo è stato il
presidente Andrzej Duda nel corso di una conferenza stampa. Altri aerei di
fabbricazione sovietica dello stesso tipo saranno inviati dopo essere stati
riadattati.
Di aiuti militari
ha parlato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Particolarmente importante
è fornire rapidamente all’Ucraina le munizioni necessarie. Nel corso del
Consiglio Europeo decideremo su altre misure assieme ai nostri soci della Ue per
garantire forniture migliori e più continue”, ha detto il cancelliere
intervenendo al Bundestag in vista del vertice dei capi di stato e di governo
dei 27 della prossima settimana.
Il ministro degli
Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è tornato a battere cassa con il segretario di
Stato americano, Antony Blinken. Rivelando su Twitter il contenuto del colloquio
telefonico avuto con lui, Kuleba ha spiegato di aver discusso della “formula di
pace” proposta da Kiev per porre fine al conflitto e della consegna di munizioni
per l’artiglieria.
Il capo della
diplomazia ucraina ha anche sentito il suo omologo cinese Qin Gang, con il quale
ha affrontato il delicato tema del “principio di integrità territoriale”,
sottolineando “l’importanza della iniziativa di pace di Zelensky per mettere
fine all’aggressione e riportare la pace in Ucraina”.
La Russia avrebbe
ritirato 20 navi e molte unità della sua flotta ausiliaria nel Mar Nero. Lo ha
reso noto la portavoce del comando meridionale ucraino, Natalia Humeniuk,
definendo quella dei nemici “un’attività atipica”. Le unità navali russe
attualmente di stanza nel Mar Nero includono quattro vettori missilistici, ha
precisato Humeniuk alla televisione nazionale.
Secondo il
comando sud, il ritiro potrebbe essere spiegato con il loro utilizzo nella
ricerca del relitto del drone americano recentemente abbattuto da un jet russo.
Putin
ricercato per crimini di Guerra.
Stefano Piazza su Panorama il 17 Marzo 2023 s Il Tribunale dell'Aja lo vuole
processare accusandolo di deportazione illegale di bambini dall'Ucraina. La
Russia non riconosce la Corte internazionale ma l'annuncio arriva alla vigilia
dell'incontro con Xi Jinping
Alla vigilia
dell’incontro tra il leader cinese Xi Jinping e Vladimir Putin che si terrà a a
Mosca il prossimo 20 marzo, il Tribunale penale internazionale dell'Aia ha
emesso mandati di arresto nei confronti del presidente della Federazione russa
Vladimir Putin e della sua commissaria per i diritti dei bambini Maria
Alekseyevna Lvova-Belova «per deportazione illegale di bambini ucraini». I
giudici istruttori della corte hanno valutato che vi siano «ragionevoli motivi
per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di
deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione
dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini
ucraini». Se avessero voluto i giudici avrebbero potuto optare per l'emissione
di mandati di arresto segreti, ma hanno deciso di renderli pubblici in modo da
«contribuire a prevenire l'ulteriore commissione di reati». Mosca ha
ripetutamente negato le accuse secondo cui le sue forze hanno commesso atrocità
durante l'invasione in Ucraina. Non appena si si è diffusa la notizia la
portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha così commentato
l'emissione di un mandato d'arresto per Putin da parte della Corte penale
internazionale dell'Aia: «Le decisioni della Corte penale internazionale non
hanno alcun significato per il nostro Paese, anche dal punto di vista giuridico.
La Russia non partecipa allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e
non ha alcun obbligo ai sensi di esso. La Russia non sta collaborando con questo
organismo e le eventuali prescrizioni di arresto provenienti dalla Corte
internazionale di giustizia saranno legalmente nulle per noi».
Nonostante il
mandato nei confronti di Putin e Lvova-Belova, la Corte penale internazionale
non ha il potere di arrestare i sospetti e può esercitare la giurisdizione solo
all'interno dei paesi che hanno firmato l'accordo che ha istituito il tribunale.
La Russia non è firmataria di tale accordo, quindi è improbabile che che
Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova vengano arrestati. Per il
procuratore generale dell'Ucraina, Andrij Kostin si tratta di una decisione
storica «Sono personalmente grato al procuratore della Cpi Karim Khan per questa
storica decisione. Continuiamo la stretta collaborazione con la Cpi nei casi di
deportazione forzata di bambini ucraini. Oltre 40 volumi di fascicoli, più di
1000 pagine di prove già condivise con la Corte» Ecco la dichiarazione ufficiale
della Corte Penale Internazionale di oggi: Oggi, 17 marzo 2023, la Camera
preliminare II della Corte penale internazionale ("CPI" o "la Corte") ha emesso
mandati di arresto per due persone nel contesto della situazione in Ucraina: il
sig. Vladimir Vladimirovich Putin e la sig.ra Maria Alekseyevna Leopoli-Belov.
Vladimir Vladimirovich Putin, nato il 7 ottobre 1952, Presidente della
Federazione Russa, sarebbe responsabile del crimine di guerra di deportazione
illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione
(bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia Federazione (ai sensi
degli articoli 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma). I crimini
sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24
febbraio 2022. Vi sono fondati motivi per ritenere che Putin abbia la
responsabilità penale individuale per i suddetti crimini, (i) per aver commesso
gli atti direttamente, insieme ad altri e/o per interposta persona (articolo
25(3)(a) dello Statuto di Roma), e (ii) per il suo mancato controllo sui
subordinati civili e militari che hanno commesso gli atti. La sig.ra Maria
Alekseyevna Lvova-Belova, nata il 25 ottobre 1984, Commissario per i diritti dei
bambini presso l'Ufficio del Presidente della Federazione Russa, sarebbe
responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione
(bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone
occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa (ai sensi degli articoli
8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma). I reati sarebbero stati
commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022.
Vi sono fondati motivi per ritenere che la sig.ra Lvova-Belova abbia la
responsabilità penale individuale per i predetti reati, per aver commesso gli
atti direttamente, insieme ad altri e/o tramite altri (articolo 25(3)(a) dello
Statuto di Roma). La Camera preliminare II ha ritenuto, sulla base delle istanze
dell'accusa del 22 febbraio 2023, che vi siano fondati motivi per ritenere che
ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione
illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree
occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, in pregiudizio dei bambini
ucraini. La Camera ha ritenuto che i mandati fossero segreti al fine di
proteggere vittime e testimoni e anche per salvaguardare le indagini. Tuttavia,
consapevole che le condotte contestate nella fattispecie sarebbero in corso, e
che la conoscenza pubblica dei mandati può contribuire a prevenire l'ulteriore
commissione di reati, la Camera ha ritenuto che sia nell'interesse della
giustizia autorizzare la Cancelleria rendere pubblica l'esistenza dei mandati,
il nome degli indagati, i reati per i quali i mandati sono stati emessi e le
modalità di responsabilità stabilite dalla Camera.
Estratto
dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera” il 18 marzo
2023.
Vladimir Putin
sempre più costretto nell’angolo […]: il mandato d’arresto del Tribunale
Internazionale dell’Aia per crimini di guerra relativi al suo presunto
coinvolgimento nella deportazione di bambini ucraini in Russia sarà quasi
sicuramente impossibile da perseguire, almeno in questa fase, ma rappresenta un
colpo molto grave per il suo status internazionale e comporta nella pratica
ripercussioni indubitabili sulla sua stessa libertà di movimento.
In teoria adesso
tutte le polizie dei 123 Stati firmatari del Trattato di Roma, che nel 1998
istituì il Tribunale, potrebbero arrestarlo se dovesse entrare nel loro
territorio. Il precedente tra i più noti che viene immediatamente alla memoria è
quello di Slobodan Milosevic, l’ex presidente serbo morto in carcere all’Aia
durante il processo nel marzo 2006. [...]
Estratto dal
libro “La cortina di vetro”, di Micol Flammini (ed. Mondadori – Strade Blu)
I paesi dei Balcani
[…] hanno […] la convinzione di essere un romanzo già scritto per capire il
futuro dell’Ucraina. Va letto, va studiato in profondità, per evitare gli
errori, per comprendere che la ricostruzione è importante, ma non basta a curare
tutto, che l’amnesia è una delle ferite più profonde che si possano infliggere a
un popolo massacrato.
L’ho sentito con
chiarezza nella voce dello scrittore bosniaco Faruk Šehic, che ancora prima
delle sue parole esprime una sofferenza mai lenita per una guerra già
dimenticata. Abbiamo parlato per telefono, mentre lui era a Berlino e mi
spiegava i continui e tormentosi rimandi tra la guerra in Ucraina e quella in
Bosnia.
[…] Quando la
Russia ha invaso l’Ucraina, Šehic sapeva quello che sarebbe successo, gli
sembrava di rivedere tutto, ma in grande. «Gli inizi erano stati gli stessi.
Putin aveva detto che l’Ucraina non esisteva, lo stesso aveva detto Miloševic
della Bosnia. Il riconoscimento delle repubbliche di Donec’k e Luhans’k altro
non era che quello che avevamo visto fare nei Balcani. Una situazione identica,
riconoscevo la manovra, tutto era già successo.»
Putin è un nemico
più potente di Miloševic, ha un arsenale nucleare e questa guerra spaventa il
mondo. «La nostra, in un certo senso, era una prova. La chiamo la smallish war,
la guerra piccola, in preparazione di un evento più grande.» Le guerre finiscono
davvero quando ci sono vincitori e vinti; per Šehic, in Bosnia non ce ne sono
stati e questo ha pesato sugli accordi di pace e anche sull’amministrazione
della giustizia, in cui l’Ucraina si è già portata avanti raccogliendo le prove
dei crimini di guerra. […]
[…] Rimarranno
anche i conti in sospeso, la necessità di istituire una forma di giustizia per
punire i crimini che sono stati commessi, e anche in questo i Balcani sono una
strada, da seguire o da evitare. Uno dei principi che il Tribunale
internazionale dell’Aja per l’ex Iugoslavia scelse fu quello di incriminare le
persone e non gli Stati, cosa che si riteneva fosse fondamentale per non
fomentare future tensioni in popoli che prima della guerra avevano vissuto
fianco a fianco, parlato la stessa lingua, formato famiglie miste e visto i
confini come una linea in mezzo al nulla, disegnata per dovere formale e non per
identificare luoghi da temere.
Per Šehic fu una
scelta sbagliata, fu come coprire i crimini, nascondere che i leader della
Republika srpska, la Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina, non avrebbero
potuto fare una guerra senza il sostegno di Belgrado. Secondo i serbi, invece,
molte delle condanne emesse dal Tribunale internazionale non sono attendibili e,
anzi, la giustizia si è macchiata di un pregiudizio antiserbo.
Da quando Vucic è
stato eletto presidente, i criminali di guerra che tornano in patria vengono
accolti, intervistati da televisioni e giornali, spesso coinvolti nella vita
politica. La giustizia nei Balcani non è riuscita a far andare avanti il tempo,
a mettere fine al passato.
Ci sono paesi che
hanno deciso di rimanere intrappolati nei lacci della storia, come la Russia o
la Serbia, e altri che sono riusciti ad andare oltre, come la Germania, che dopo
il nazismo, la seconda guerra mondiale e l’Olocausto ha ammesso le proprie colpe
attraverso uno sforzo che ha consentito a tutta l’Europa di ricominciare a
fidarsi di Berlino e al paese di ricostruirsi.
Superare il passato
vuol dire anche assumersene la responsabilità e abbattere la cortina di
risentimenti, paure, rivendicazioni e nostalgie, che era di ferro, si è fatta di
vetro e ora sembra d’acciaio.
“Putin noi non lo
arrestiamo”: Orban sfida l’Europa.
Libero Quotidiano il
23 marzo 2023
"Non
arresteremo Vladimir Putin se entrasse nel nostro Paese". L'Ungheria ha
platealmente detto al mondo che intende ignorare il mandato di arresto
europeo emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente
russo accusato di crimini di guerra per aver deportato illegalmente centinaia di
bambini dall'Ucraina. Il primo ministro Viktor Orban, per voce del suo
capostaff Gergely Gulyas, ha spiegato che l'arresto di Putin non ha basi legali.
Lo Statuto di Roma che ha creato la Corte Penale internazionale, infatti, non è
stato integrato nel sistema legale ungherese poiché "contrario alla
Costituzione". "Possiamo fare riferimento alla legge ungherese e sulla base di
essa non possiamo arrestare il presidente russo", poiché lo statuto della Corte
penale internazionale "non è stato promulgato in Ungheria", ha spiegato Gulyas.
Un portavoce della
Corte Penale internazionale, però, all'Ansa ha confermato che l'Ungheria ha
"ratificato il trattato nel 2001" e dunque ha "l'obbligo di cooperare con la
Corte nel quadro dello Statuto di Roma". Ma questo è solo l'ultimo di una serie
di distinguo di cui si è resa protagonista l'Ungheria di Orban. Come ha
riportato Bloomberg, ad esempio, Budapest ha bloccato la pubblicazione di
una dichiarazione congiunta dei Paesi membri dell'Ue sul mandato d'arresto
spiccato dalla Cpi nei confronti del presidente russo. Al termine del Consiglio
Affari esteri e difesa, svoltosi nei giorni scorsi a Bruxelles, l'Alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha
pubblicato tale dichiarazione a suo nome, e non intestandola a tutti i 27 Paesi
membri come auspicato durante la riunione. In precedenza, i ministri della
Giustizia di 26 paesi dell'Ue avevano rilasciato una dichiarazione a sostegno
dell'indagine della Corte penale internazionale: anche in quel caso, l'Ungheria
non ha siglato il documento. E poi ancora l'ingresso di Svezia e Finlandia sotto
l'ombrello protettrice della Nato per il quale il governo ungherese deve ancora
dare il suo via libera. E infine lo sblocco dei fondi europei: da Bruxelles
ripetono che, prima di procedere con la loro erogazione, Budapest è chiamata ad
effettuate le riforme previste dal Pnrr ungherese. Da parte sua Viktor Orban
tira dritto per la sua strada e su Twitter scrive: "Il Consiglio europeo è in
corso. La posizione ungherese è chiara e semplice: no all'immigrazione, no al
gender, no alla guerra!".
CPI contro Putin:
il fallimento annunciato dell’uso politico della legge internazionale.
Valeria
Casolaro su L'Indipendente il 18 Marzo 2023
La Corte Penale
Internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto nei confronti del
presidente russo Vladimir Putin. L’accusa: l’aver commesso un crimine di guerra,
ovvero aver deportato bambini ucraini in Russia. Un altro mandato di arresto è
stato emesso nei confronti della commissaria per i diritti dei bambini al
Cremlino, Maria Alekseyevna Lvova-Balova. Come sottolineato dalla portavoce del
ministro degli Esteri russo Maria Zacharova, tuttavia, la CPI non ha
giurisdizione in Russia, non avendo questa mai ratificato lo Statuto sul quale
si basa la CPI (come nemmeno l’Ucraina). Di fatto, la Corte starebbe procedendo
per crimini commessi da uno Stato non membro sul territorio di un altro Stato
non membro, cosa che rende difficile pensare che l’iniziativa si possa tradurre
in un risultato davvero concreto.
L’ipotesi di
un’indagine su possibili crimini di guerra commessi da Mosca era stata
aperta all’incirca un anno fa: da allora, il presidente della Corte Karim Khan
ha effettuato tre viaggi in Ucraina, per visitare i luoghi dove sarebbero stati
commessi i crimini. Secondo quanto rilevato, Putin
sarebbe ritenuto “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di
popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle
zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. L’arresto di Putin è di fatto
imprescindibile affinché possa essere ipotizzato un qualsiasi ruolo della CPI,
la quale non può avviare processi in contumacia.
La Corte Penale
Internazionale ha sede a l’Aja, nei Paesi Bassi. Il suo ruolo è occuparsi di
alcune fattispecie di crimini che riguardano la comunità internazionale, ovvero
i crimini contro l’umanità, il crimine di aggressione, i crimini di guerra e il
genocidio. La Corte – la quale può avviare processi contro i singoli individui,
ma non contro interi Stati – ha base giuridica nello Statuto di Roma, che ad
oggi è stato ratificato da 123 Paesi in tutto il mondo. Tra i grandi assenti
dalla ratifica vi sono Stati Uniti, Russia, Cina, Israele: tutti Paesi, insomma,
con una mira imperialistica di qualche tipo, che sia esercitata
nell’insospettabile forma del riportare la democrazia in un certo Paese o in
maniera più subdola. Nemmeno l’Ucraina ha mai ratificato lo Statuto. La
Corte esercita i propri poteri sul territorio degli Stati firmatari ma, grazie
ad apposite procedure, questi possono essere estesi al territorio di uno Stato
non facente parte che lo richieda (come ha fatto l’Ucraina nel 2014). Si tratta
quindi di uno strumento potenzialmente molto utile per punire chi si macchi di
reati contro l’umanità di particolare gravità, non fosse per il fatto che,
spesso, il suo utilizzo sembra più assecondare determinati equilibri
geopolitici che la ricerca di un più alto criterio di giustizia.
Nelle zone teatro di
alcuni dei più sanguinosi conflitti del nostro tempo i crimini di guerra sono
stati tollerati, se non del tutto ignorati, dalla comunità internazionale
(ovvero dalle forze politiche occidentali) perché in larga parte adducibili a
una superpotenza: gli Stati Uniti. Quando la Corte ha mostrato l’intenzione di
indagare su presunti crimini di guerra e abusi di altro genere commessi dai
militari americani in Afghanistan o altrove (in particolare “atti di tortura,
trattamento crudele, offese alla dignità personale, stupro e violenza sessuale
contro detenuti in relazione al conflitto in Afghanistan e altre violazioni,
principalmente nel periodo 2003-2004”), gli USA hanno replicato di
fatto minacciando il personale della CPI di revocare o negare i visti di
ingresso nel Paese. Inoltre, l’ex Segretario di Stato americano Mike Pompeo
aveva dichiarato che si sarebbero riservati di fare lo stesso con chi avesse
tentato azioni analoghe contro Israele. «Siamo determinati a proteggere il
personale militare e civile Americano e alleato dal vivere nel timore di essere
ingiustamente perseguiti per azioni intraprese per difendere la nostra grande
nazione» aveva dichiarato. Le pressioni furono tali che, nel dicembre 2021, la
CPI annunciò ufficialmente di aver sospeso le indagini a carico dei soldati
statunitensi.
Altro esempio: nel
2006 la CPI ricevette centinaia di segnalazioni (240 in tutto) da parte di ONG e
attori della società civile che denunciavano le uccisioni di massa dei civili
che stavano avendo luogo in Iraq a seguito delle operazioni del Regno Unito
(Paese firmatario dello Statuto di Roma). In quell’occasione il procuratore
giustificò l’impossibilità ad intervenire con il fatto che l’Iraq si trovasse al
di fuori della giurisdizione della Corte e che altri Stati membri non avevano
segnalato la necessità di procedere con accertamenti. “L’uccisione di civili non
costituisce di per sé un crimine di guerra” aveva ricordato, aggiungendo che
“dopo aver analizzato tutte le informazioni disponibili, si è giunti alla
conclusione che esistesse una base ragionevole per ritenere che fossero stati
commessi crimini di competenza della Corte, ovvero uccisioni volontarie e
trattamenti inumani. Le informazioni disponibili al momento supportano una base
ragionevole per una stima tra le 4 e le 12 vittime di omicidio intenzionale e un
numero limitato di trattamenti inumani, per un totale di meno di 20 persone”.
La fattibilità delle
operazioni avanzate dalla CPI è quindi tutta ancora da verificare: certo si è
tentati di pensare che l’Occidente stia utilizzando qualsiasi strumento a
disposizione per soffiare sul fuoco di un conflitto dagli equilibri al momento
altamente incerti. [di Valeria Casolaro]
Estratto
dell'articolo di Fiorenza Sarzanini per il “Corriere della Sera” il 19 marzo
2023.
C’ è un video
ufficiale che mostra Maria Lvova-Belova mentre ringrazia il presidente Vladimir
Putin perché le ha consentito di adottare un bambino ucraino. Quel filmato,
rilanciato dalla propaganda del Cremlino, si è trasformato in uno degli elementi
d’accusa contro lo stesso presidente russo e la commissaria per i diritti dei
minori di Mosca, accusati dalla Corte penale internazionale dell’Aia di crimini
di guerra per la deportazione dei minori ucraini.
Il mandato di
arresto firmato due giorni fa dai giudici Rosario Aitala, Tomoko Akane e Sergio
Ugalde ricostruisce il piano per il trasferimento di bimbi e ragazzi, i viaggi a
bordo degli aerei militari, i rastrellamenti in scuole e orfanotrofi, la
falsificazione dei documenti. Un progetto criminale che — evidenziano i giudici
— prende forma nel maggio scorso, poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina,
con la firma di Putin sul decreto che prevede procedure semplificate per
riconoscere d’urgenza la cittadinanza russa ai minori strappati alle proprie
famiglie dopo l’invasione.
[…] Sono stati
proprio gli investigatori coordinati da Khan a ricostruire decine e decine di
voli effettuati dai militari russi per trasferire bimbi e ragazzi dai territori
occupati del Donbass e farli arrivare in Russia. Il resto lo hanno fatto le
verifiche dei giudici. […]
Il mandato firmato
due giorni fa è solo il primo atto di un’indagine che potrebbe portare a nuovi
provvedimenti. Nei casi in cui i testimoni erano a rischio sparizione Aitala e i
suoi colleghi hanno disposto incidenti probatori segreti proprio per validare le
loro dichiarazioni.
[…] Le testimonianze
dei genitori e i racconti di chi è riuscito a tornare in Ucraina, soprattutto
grazie all’impegno delle organizzazioni umanitarie, fanno ben comprendere che il
piano di Mosca è tuttora in atto. Una donna ascoltata nel corso delle indagini
racconta di essere andata a prendere il figlio a scuola e di non averlo più
trovato. «Ho sbagliato, non avrei dovuto mandarlo. Ho scoperto che cosa era
successo quando l’ho riconosciuto in un video della propaganda russa. Era
disperato, non smetteva di piangere».
È uno dei bimbi
portati via con gli aerei militari e la donna non sa dove sia adesso. Non è
l’unica. La tv russa, ma anche i social della propaganda di Mosca mostrano
frequentemente le immagini di piccoli all’interno delle nuove scuole, esposti
come trofei, oppure affidati a nuove famiglie. Sono moltissimi gli ucraini che
hanno riconosciuto i propri figli in quei filmati, ma non sono riusciti a
riportarli a casa.
A molti è stato
raccontato che i genitori erano morti, altri invece non capiscono il russo e non
comprendono che cosa sia accaduto.
[…] Secondo il
rapporto dell’Onu sono almeno seimila i minori deportati, le autorità di Kiev
denunciano la sparizione di oltre 16 mila. I giudici dell’Aja hanno raccolto
prove per circa 600 casi ed evidenziano nel mandato di cattura che soltanto un
minore su cento è riuscito a tornare a casa. Negli atti si parla in maniera
esplicita di «persone trattate come un bottino di guerra».
Il riferimento è
alle trattative concluse grazie all’intervento dei servizi di intelligence
ucraini per scambiarli con i soldati russi fatti prigioni Non sono stato
maltrattato, ma quando piangevo e chiedevo della mia mamma e del mio papà loro
mi dicevano che erano morti. Ora sei russo e avrai un’altra mamma e un altro
papà eri. Tra i verbali raccolti dai giudici della Corte c’è quello di un
bambino restituito ai genitori.
«Non sono stato
maltrattato, ma quando piangevo e chiedevo della mia mamma e del mio papà loro
mi dicevano che erano morti. Ora sei russo e avrai un’altra mamma e un altro
papà», ha raccontato. […] È stato accertato che in alcuni casi i bambini sono
stati dati in premio dal regime di Mosca, «sono diventati il regalo per gli
ufficiali più fedeli». Proprio come accadeva in Argentina durante la dittatura
di Jorge Videla.
Olena: «Mio
figlio Andrii deportato in Russia dopo un bombardamento: gli hanno detto che ero
morta». Greta
Privitera su Il Corriere della Sera il 18 marzo 2023.
Dopo l’ordine di
cattura dell’Aia contro Putin accusato di «crimini di guerra» per la
deportazione di bambini ucraini in territorio russo, la storia di una famiglia
di Izium, che è riuscita a riportare il figlio a casa
Il mandato di
cattura internazionale emesso dalla Corte penale dell’Aia contro Vladimir Putin,
a Olena non fa nessun effetto. «Non mi importa di Putin, penso ai miei figli»,
ci dice su Telegram. Non le importa, ma quello che è successo al suo Andrii è il
motivo per cui la Corte internazionale accusa lo zar di «crimini di guerra» per
la deportazione di bambini e adolescenti ucraini in territorio russo.
Olena è
un’infermiera, madre di sette figli. «Prima di rifugiarci in Svizzera, lavoravo
in un ospedale di Izium, a Kharkiv». Il 30 aprile, sua mamma e suo figlio
adolescente l’hanno raggiunta al lavoro per ricaricare il cellulare perché, come
spesso accadeva, a casa mancava l’elettricità. «Proprio in quei minuti i russi
ci hanno bombardato. Mia madre è morta, mio figlio è rimasto gravemente ferito».
L’ospedale era stato colpito da una bomba a grappolo, Andrii aveva bisogno di
essere operato. La diagnosi era atroce: lesione spinale e lesioni multiple di
organi interni.
«Ero riuscita a
vederlo su un lettino, mi avevano detto che lo avrebbero portato in sala
operatoria e che poi sarei potuta stare con lui. Ma non è andata così. Dopo il
bombardamento, i russi sono entrati e hanno portato via alcune persone, tra cui
Andrii. Per un mese e mezzo non ho saputo niente di lui, nemmeno se fosse vivo o
morto. Scrivevo a chiunque per avere informazioni, sapevo che cosa poteva
succedere ai nostri bambini e ragazzi. Dalla Russia non ci dicevano niente».
Andrii era finito in
un ospedale di Mosca dove è stato operato alla schiena. I medici gli dissero
che sua madre era morta e che quindi lui era stato inserito in un programma di
adozione. Gli avrebbero trovato una famiglia russa. Non avrebbe più visto i suoi
fratelli. «Stava male, era angosciato, era disperato per aver perso la mamma e
perché non camminava più».
Anche Olena, a 850
chilometri di distanza da suo figlio, pensava che non ci fosse più niente da
fare. Poi, dice lei, il miracolo: «Un giorno, degli amici mi hanno mandato uno
screenshot di una foto che stava circolando su Viber (un sistema di
messaggistica, ndr.). Era la foto della carta d’identità di Andrii. A postarla è
stata una nostra concittadina, deportata anche lei dalla regione di Kharkiv».
L’immagine è diventata virale e Olena si è affidata a un’associazione che le ha
organizzato il viaggio in Russia per andare a recuperare suo figlio,
paralizzato.
«Non è stato facile
arrivare a Mosca, sono stati giorni molto difficili, per motivi di sicurezza non
posso raccontare l’itinerario. Una volta arrivata nell’ospedale che mi avevano
segnalato ho visto mio figlio sdraiato su un letto, poteva muovere solo il collo
e le braccia. Ci siamo stretti e abbracciati. Lui non si aspettava di vedermi,
non riusciva a smettere di piangere».
Olena e Andrii sono
rimasti in Russia quasi tre mesi, l’associazione li ha aiutati a organizzare il
viaggio di ritorno e la nuova vita in Svizzera. C’erano dei medici che non
volevano farlo andare via, «ma hanno capito che mai lo avrei lasciato lì. In
quell’ospedale ho visto altri bambini deportati. Una bambina era già stata data
in adozione. Ho cercato di aiutare suo padre, ma poi sono dovuta partire e non
ho più saputo niente».
Oggi Andrii soffre
di depressione ed è in sedia a rotella, ma Olena è sicura che riuscirà a
rimetterlo in piedi: «Sono sua madre e sono un’infermiera», dice. Quando Andrii
sente un aereo passare si spaventa e a volte piange. Così come quando scoppia un
palloncino. Entrambi di notte sognano i bombardamenti. E se incontrasse Putin,
che cosa gli direbbe, chiediamo a Olena: «Voglio che mi restituisca mia madre, e
il futuro dei miei figli».
Estratto
dell’articolo di Giovanni Pigni per “La Stampa” il 19 marzo 2023.
Gleb Bogush è un
esperto russo di diritto internazionale penale e ricercatore all'università di
Copenhagen.
Che conseguenza
avrà il mandato di arresto emesso nei confronti del presidente russo Vladimir
Putin e della commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino, Maria
Lvova-Belova?
«La Russia non ha
l'obbligo giuridico di collaborare con la Corte penale internazionale, dunque è
irrealistico pensare che queste persone verranno processate, almeno per il
momento».
Vladimir Putin può
essere definito ora un "criminale di guerra"?
«No, esiste la
presunzione di innocenza. Fino a quando la sentenza non verrà emessa dalla
Corte, non è corretto giuridicamente definirlo un "criminale di guerra"».
Quanto è probabile
che Putin venga arrestato nel caso si trovi a visitare un Paese che riconosce
l'autorità della Corte?
«Formalmente e
giuridicamente è possibile ma in pratica poco probabile. In primo luogo, Putin
non visita i paesi firmatari dello Statuto di Roma […]. E, in secondo luogo,
Putin gode dell'immunità presidenziale che rende il suo arresto complicato per
molti Stati».
La Russia è
sospettata di svariati crimini di guerra in Ucraina. Perché la corte di
giustizia ha deciso di focalizzarsi proprio sul tema della deportazione dei
bambini?
«Si tratta di un
tema sul quale ci sono molte informazioni disponibili. Gli stessi Putin e
Lvova-Belova hanno già raccontato molto al riguardo. Inoltre la difesa dei
bambini è una delle principali priorità della Corte».
[…] Qual è l'impatto
della decisione della Corte sul piano simbolico e politico?
«Si tratta di un
gesto dal valore simbolico enorme, anche al di là della guerra in Ucraina […] Si
tratta anche di un passo importante verso la delegittimazione del regime russo e
di Putin personalmente. Si tratta di un lungo processo ma è ovvio che renderà
ancora più difficile per la Russia normalizzare i propri rapporti
internazionali. Inoltre è importante dimostrare che dietro a questi crimini ci
sono dei colpevoli concreti».
Sì, i comunisti
mangiavano bambini (ucraini).
In "Raccolto di
dolore", Conquest narra la carestia voluta da Stalin. Alessandro Gnocchi il 18
Marzo 2023 su Il Giornale.
La sinistra
recentemente ha scoperto, con trent'anni di ritardo, i danni del politicamente
corretto e della cultura (si fa per dire) della cancellazione. È giunto il
momento di fare un altro passo e ammettere che il socialismo non era una buona
idea realizzata male, ma una pessima idea realizzata, purtroppo, bene.
L'uguaglianza imposta, la redistribuzione forzata, i prezzi fissati per decreto,
la produzione suddivisa in quote, l'economia regolata da piani quinquennali, il
partito unico, il controllo poliziesco, la repressione del dissenso, la
distruzione di intere classi sociali, la censura, lo schiavismo, le purghe, il
culto del leader. Tutto questo non era una degenerazione, era l'essenza di una
ideologia nella quale lo Stato, coincidente col Partito comunista, era tutto e
l'individuo era niente.
Chi volesse
avventurarsi nella lettura di Raccolto di dolore, il capolavoro dello storico
inglese Robert Conquest, potrebbe addirittura accertarsi della verità di alcune
cose negate pervicacemente dagli eredi del Partito comunista. Ad esempio, Stalin
ordinò dei pogrom selvaggi in Ucraina, battendo sul tempo Adolf Hitler: fatto
che concorre a spiegare come mai Urss e Germania nazista, inizialmente, avessero
firmato il patto Ribbentrop-Molotov. Soprattutto: i comunisti forse non
mangiavano i bambini ma costrinsero gli ucraini al cannibalismo, come dimostra
inoppugnabilmente il saggio di Conquest.
Raccolto di dolore
spezzava la congiura del silenzio sull'Holodomor, ovvero la apocalisse inflitta
da Stalin alla Ucraina per ottenere un triplice risultato: piegare
definitivamente i kulaki, i contadini agiati e proprietari delle terre; piegare
definitivamente l'Ucraina, che non sopportava la dominazione dei bolscevichi;
avere un capro espiatorio al quale attribuire la colpa dei disastrosi risultati
in campo agro-alimentare. Così fu deciso a tavolino che una carestia avrebbe
messo le cose sul binario desiderato. I raccolti furono espropriati, furono
fissati obiettivi palesemente irraggiungibili, fu impedita la fuga dei profughi
affamati, fu negata ogni forma di aiuto da parte delle altre regioni della
Russia sovietica.
Tra il 1929 e il
1932, milioni di cittadini ucraini morirono di fame. I paesi si ridussero a
lazzaretti popolati solo da famiglie malnutrite e in attesa della fine. Nelle
campagne si arrivò al cannibalismo. Conquest raccolse un'ampia documentazione e
in particolare numerose testimonianze dirette.
Quando Raccolto di
dolore fu pubblicato, nel 1986, suscitò polemiche furibonde e la reazione dei
comunisti di mezzo mondo. Conquest fu accusato di essere una mezza tacca della
ricerca e di essersi affidato unicamente alle parole dei sopravvissuti, nemici
giurati dell'Urss. Gli fu anche rinfacciata la mancanza di carte ufficiali
sovietiche, ancora rinchiuse in archivi inaccessibili. Accidenti, poveri
comunisti, che sfortuna. Caduta l'Unione sovietica, tre anni dopo, gli archivi
per un breve periodo furono aperti e, maledizione, Conquest trovò proprio gli
ordini diretti di Stalin. Il dittatore esprimeva, senza mezzi termini, la
volontà di infliggere all'Ucraina una lezione durissima.
Nel 2008, il
Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che definisce l'Holodomor uno
«spaventoso crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità». Il Parlamento
europeo è stato netto ma in fondo prudente. Per gli Stati Uniti, la Germania, la
Città del Vaticano e molti altri Paesi, l'Holodomor è un genocidio.
In Italia, Raccolto
di dolore fu pubblicato soltanto nel 2004, grazie alla Fondazione Liberal che
andò a colmare una lacuna intollerabile. Suscitò reazioni scomposte, apologie di
Stalin, saggi sulla leggenda nera del dittatore georgiano e altra robaccia. Oggi
arriva la prima edizione per un grande editore, Rizzoli (prefazione di Marco
Clementi; postfazione di Federico Argentieri, pp. 540, euro 25). In origine il
libro era stato comprato da Garzanti e tradotto da Sergio Minucci ma fu gettato
in un cassetto ove rimase per diciotto anni. Chissà come mai, potrebbe chiedersi
un ingenuo...
La Polonia prima
decimata poi prigioniera e arruolata.
In "La terra
inumana" Józef Czapski racconta (da vittima) il calvario di un intero popolo.
Stenio Solinas il 18 Marzo 2023 su Il Giornale.
«La Polonia - disse
il presidente americano F.D. Roosevelt quando la Seconda guerra mondale si
avviava alla conclusione - è l'ispirazione delle nazioni». Il conflitto era
cominciato per difenderla dall'invasione tedesca e dal totalitarismo nazista e
quindi nella sua fine era insito il concetto che quella nazione sarebbe tornata
a essere libera e indipendente. Era la promessa delle democrazie ed era in nome
di quella promessa che i polacchi avevano resistito, si erano sacrificati, in
esilio avevano dato vita a un esercito e con esso contribuito alla vittoria
finale. Come scrive Józef Czapski nel suo dolente La terra inumana (Adelphi,
pagg. 459, euro 28, traduzione di Andrea Ceccherelli e Tullia Villanova,
postfazione e cura di Andrea Ceccherelli), ancora nel settembre del 1942 lui
stesso non aveva idea «di dove - se in Iran, in Palestina o in Egitto - si
sarebbe formata l'armata polacca, né se la nostra strada di ritorno verso la
Polonia sarebbe passata dal Caucaso o dai Balcani. Non mi sarebbe mai passato
per la testa che il nostro sentiero di guerra dovesse portare in Italia, a
Montecassino, Ancona, Bologna, e che alla fine di tutto ciò ci aspettasse ancora
l'esilio».
Il fatto è che
quella promessa si basava su un non detto iniziale, frutto di calcolo, di
cinismo, di pressapochismo, di ingenuità politica e/o di cecità ideologica. In
quel 1939 in cui la Polonia si era ritrovata invasa, gli invasori erano stati
due, la Germania da occidente e l'Urss da oriente, spartendosi in pratica il
Paese. Lo avevano fatto sulla base di un patto di reciproca non aggressione e
nel nome di un'identica spietatezza, razziale in un caso, di classe nell'altro.
Hitler e Stalin, insomma, erano le due facce della stessa medaglia totalitaria.
Fino all'estate del
1941, un anno e mezzo di guerra all'incirca, il patto era rimasto inalterato,
poi l'invasione nazista dell'Unione sovietica aveva ribaltato la situazione,
spingendo quest'ultima a un'alleanza militare con l'Inghilterra e economica con
gli Stati Uniti che di lì a pochi mesi, con l'entrata in guerra di quest'ultimi,
avrebbe assunto anche risvolti bellici. Di fatto, insomma, la Russia di Stalin
si ritrovava nel campo delle democrazie, pur non avendoci nulla a che fare.
Combattevano sì un nemico comune, ma con fini e motivazioni differenti. La
conferenza di Yalta prima, quella di Potsdam poi, sanciranno il nuovo ordine
europeo che consegnava all'Urss quell'Europa centro-orientale di cui la Polonia
faceva parte, una Polonia che aveva già sperimentato il totalitarismo sovietico
in quella guerra appena finita: un milione e mezzo di deportati, quindicimila
tra ufficiali e soldati fatti prigionieri e poi eliminati con esecuzioni di
massa, colpi alla nuca, annegamenti, marce forzate e gulag. In pochi anni,
scrive Czapski, l'Urss «aveva sterminato più polacchi che nel corso di tutta la
storia passata».
La terra inumana,
insomma, ci mette di fronte a quella che la retorica sulla Seconda guerra
mondiale, ovvero la vittoria delle democrazie, la sconfitta dei totalitarismi,
il contributo sovietico alla causa della libertà e dell'indipendenza ha
insabbiato e che nemmeno la successiva «guerra fredda» ha poi modificato e/o
messo in discussione. Farlo, significava metterne in crisi la legittimità e
quindi era preferibile continuare nella rappresentazione, come dire, di una
Russia sovietica a due dimensioni: la prima genuinamente democratica, eroica e
patriottica nella sua lotta a fianco dell'Occidente libero e nella sua sete di
giustizia sociale; la seconda, venuta su però solo dopo la fine del conflitto,
ostile e chiusa all'interno della sua «cortina di ferro». Così, nella prima non
rientravano né l'universo concentrazionario, né lo stato di polizia, né la
ferocia delle repressioni e delle punizioni esemplari, né il più assoluto
disprezzo per la vita umana, per la dignità dell'essere umano, mentre intorno
alla seconda ci si poteva lamentare, proclamando sì la superiorità del mondo
libero, ma stando però ben attenti a non commettere invasioni di campo
geopolitiche...
È emblematico, sotto
questo punto di vista, quanto scrive Józef Czapski a proposito del famoso
eccidio di Katyn' perpetrato dai russi ancora nella primavera del 1940 e venuto
alla luce solo nel 1943: «Tutta la stampa inglese, salvo rare eccezioni, troppo
a lungo ha taciuto sulle fosse di Katyn'! Non si poteva certo imputare un simile
crimine ai russi, allora considerati l'incarnazione della democrazia e della
giustizia (). Pareva si dovesse stendere un velo di silenzio sull'intera
faccenda». Quello russo, dunque era un totalitarismo buono, un ossimoro e
insieme un falso che grondava letteralmente sangue. Il problema, nota infatti
Czapski, è che «un eccidio come quello di Katyn' non rappresenta un'eccezione.
Non è avvenuto durante una rivoluzione, quando la lava è ancora liquida. Katyn'
faceva parte di un piano più vasto, attuato a freddo». Infine, «non c'è forse
Paese in Europa dove l'aratro sovietico abbia schiacciato e annientato più gente
che in questa terra, gente del tutto innocente».
Per inciso, Czapski
era un testimone di prima mano: da ufficiale polacco prigioniero si era fatto
«ventitré mesi di filo spinato», poi in qualità di addetto alle ricerche dei
militari suoi connazionali scomparsi si era scontrato con il «negazionismo» dei
vertici politico-militari del Gulag e dell'Nkvd, la polizia segreta.
La retorica sulla
Seconda guerra mondiale si nutre del resto di quelle tecniche linguistiche di
cui George Orwell darà poi magistralmente conto nel suo 1984, ma che nel
totalitarismo comunista erano state già ampiamente sperimentate. All'indomani
dell'invasione tedesca dell'Urss, quest'ultima si ritrova sull'orlo del
collasso: «Nell'autunno del 1941 chiunque di noi avesse la possibilità di venire
in contatto con gli strati bassi della popolazione, rimaneva impressionato
dall'ondata di rancore, di odio contro il regime, di ostilità alla guerra».
Stalin rispolvera allora non solo la «guerra patriottica» e la Santa Russia, i
pope, le chiese e le icone, ma per la proprietà transitiva delle alleanze firma
un accordo con quel governo polacco che ha contribuito con Hitler a mandare in
esilio a Londra e intanto ne ha massacrato la popolazione in patria. L'accordo
prevede la costituzione sul suolo sovietico di un'armata polacca composta dai
soldati fatti prigionieri dai sovietici e sopravvissuti alla mattanza già prima
descritta. Al rilascio dei militari deportati viene dato il nome di «amnistia»,
come se fosse stato un crimine l'aver difeso la propria patria, così come, del
resto, l'invasione dei territori orientali nel 1939 era stata definita
«liberazione»... I polacchi accettano questo ribaltone perché si fidano: non dei
russi, naturalmente, ma degli inglesi e degli americani. «Non saremo trattati
come una pedina nella partita con i sovietici» pensano. Si illudono.
La prima edizione di
La terra inumana uscì in Francia nel 1949, in Inghilterra nel 1951, in Germania
nel 1967, in Polonia, ma clandestinamente, nel 1982 e poi liberamente solo dopo
la caduta del Muro di Berlino. Czapski, come ben racconta Andrea Ceccherelli
nella sua postfazione, fu nel secondo dopoguerra una figura di spicco
dell'emigrazione intellettuale polacca, scrittore e pittore di talento. La sua
testimonianza sull'universo concentrazionario sovietico anticipa
cronologicamente Salamov e lo stesso Solzenycin e la «eccezionalità» della sua
figura è data proprio «dal ruolo di testimone che suo malgrado la storia gli
cucì addosso, e che egli assunse con straordinario rigore morale, slancio umano
e assenza di animosità».
Resta da chiedersi
come mai, e nonostante la presenza del 2º corpo polacco nella campagna d'Italia
1944-45, La terra inumana veda da noi la luce soltanto adesso, anche se una
riflessione sul peso e sul ruolo pluridecennale del Partito comunista italiano,
fratello di quello sovietico nella comune retorica della lotta di liberazione
antinazista, e la coda di paglia dei sostenitori democratici di un «socialismo
dal volto umano», ci fa capire l'ingenuità di quell'interrogativo.
Mossa
disperata. Putin chiede aiuto agli oligarchi per impedire il tracollo economico
della Russia.
Maurizio Stefanini su L’Inkiesta
il 18 marzo
2023.
Con enormi buchi
nel bilancio, il boss del Cremlino sta cercando di riallacciare i rapporti con
le aziende che non si sono ritirate dal Paese, promettendo sostegno «alle
imprese responsabili, a coloro che sono pronti a battersi per la causa»
Alle prese con
una emergenza economica in arrivo, Vladimir Putin mette in sordina la recente
retorica anti-oligarchi e chiede invece loro aiuto «per impedire la distruzione
dell’economia».
Meno di un mese
fa, nel suo discorso sullo Stato della Nazione Putin aveva rivolto ai «Paperoni»
russi una durissima bordata. «Nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per
coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero». Anche lì,
però, aveva rivolto un invito. «Non supplicate per riavere i vostri soldi. Non
investite all’estero, ma in Russia. A quel punto lo Stato e la società vi
sosterranno». All’avvertimento-richiesta dà un evidente spessore la lunghissima
lista di oligarchi, scienziati e generali russi che dall’inizio del 2022 sono
stati vittime di morti misteriose, ormai arrivata a quota trentanove.
Ma alla
narrazione di Putin secondo cui l’economia russa va a gonfie vele malgrado le
sanzioni e senza bisogno degli oligarchi aveva risposto subito Oleg Deripaska,
il magnate dell’alluminio fondatore del gruppo industriale Basic Element e
titolare di un patrimonio stimato da Forbes 2,9 miliardi di dollari.
«Sono molto
preoccupato per tutto il tempo che lo Stato e le imprese siano costantemente
messi l’uno contro l’altro», aveva detto al Forum economico di Krasnoyarsk in
Siberia, avvertendo che «già il prossimo anno non ci saranno soldi, avremo
bisogno di investitori stranieri. I nostri problemi non finiranno nemmeno nel
2025, che per me è il punto più vicino possibile a una diminuzione di intensità
dell’attuale conflitto. Per questo il governo sta facendo appello a noi
imprenditori», aveva spiegato. Ma aveva avvertito Putin: «La Russia dovrebbe
continuare a sviluppare l’economia di mercato». Sottolineando le «gravi»
conseguenze delle sanzioni internazionali in corso contro il Paese, che hanno
colpito in particolare settori chiave come quello dell’energia, ma anche della
difesa, della tecnologia oltre alle istituzioni finanziarie, aveva ammonito che
«il capitalismo di Stato non è un’opzione».
Giovedì Putin è
appunto intervenuto al Congresso dell’Unione russa degli industriali e
imprenditori (Rspp), il cosiddetto «sindacato degli oligarchi» fondato nel
giugno 1990. Era la seconda volta che incontrava l’élite economica del Paese
dall’inizio del conflitto ucraino, e il primo incontro, ripreso e mandato in
onda da tutte le tv, era avvenuto proprio il 24 febbraio 2022 ad appena poche
ore dall’annuncio dell’attacco. Insomma, non si vedevano da oltre un anno.
Nell’occasione il presidente russo ha ripetuto che l’economia, tenendo conto
della situazione, starebbe andando che meglio non potrebbe.
«I Paesi
dell’euro parlano di collasso della nostra economia ma la loro inflazione è più
alta», ha detto. Poi ha spiegato che «è in corso un riorientamento graduale per
raggiungere i mercati in via di sviluppo, che il processo era stato avviato
prima ancora «dell’operazione militare speciale», e che la Russia in questo modo
è riuscita a compensare la chiusura dei mercati occidentali. Insomma, sua
citazione di Mark Twain, «le notizie della mia morte sono enormemente
esagerate». Secondo lui, la domanda interna in Russia cresce bene e continuerà a
farlo in modo sostenibile e stabile.
In effetti,
l’affidabilità di molti dati economici resi noti dalle autorità russe è messa in
dubbio da osservatori che le rubricano come parte di una «guerra informativa».
«Non fidatevi dei numeri russi» dice letteralmente su Foreign Policy Agathe
Demarais, global forecasting director alla Economist Intelligence Unit. La
stessa Unione europea spiega che le sanzioni sono come un «veleno a lento
effetto» destinato a colpire un po’ per volta. Docente di Economia alla
University of California, Los Angeles, l’economista russo-statunitense Oleg
Itskhoki descrive la tenuta della economia russa sotto sanzioni come un
paradosso: «L’anno scorso ha segnato la prima volta nella storia in cui sono
state imposte sanzioni internazionali a un’economia grande come quella russa. I
risultati sono stati notevoli. Se valutato in termini di differenza tra crescita
attesa e contrazione effettiva del Pil, tale effetto negativo arriva a circa il
sei per cento. Tuttavia, questo non è neanche lontanamente vicino al calo
previsto dell’8-12 per cento, previsto dal ministero delle Finanze russo e dalla
Banca centrale. Perché l’economia russa non è crollata nel 2022?».
La sua risposta è
che da una parte gli enormi surplus di bilancio precedenti grazie alti prezzi
delle esportazioni di energia, dall’altra il fatto che l’economia russa stava
attraversando la «de-dollarizzazione» hanno ammortizzato la botta.
Ma, d’accordo con
la valutazione dell’Unione europea, l’esito è comunque quello di «un declino»,
ancorché «piuttosto graduale. Una crisi acuta è stata sostituita da uno scenario
macroeconomico inerziale, con graduale contrazione e stagnazione dell’economia».
Ma «la situazione macroeconomica nel 2023 sarà fondamentalmente diversa da
quella del 2022. Il 2022 è stato l’anno delle sanzioni all’importazione, della
distruzione o dell’adeguamento delle catene di approvvigionamento esistenti e
della costruzione di catene alternative a fronte di finanziamenti in eccesso e
afflussi di entrate in valuta estera. Il 2023, invece, sarà un anno di catene di
approvvigionamento relativamente adeguate, ma sarà anche un anno di calo delle
entrate da esportazione e di un afflusso di finanziamenti in valuta estera a
fronte di persistenti deficit di bilancio. In questo senso, il 2023 assomiglierà
più da vicino a una tipica crisi internazionale (quello che chiamiamo “arresto
improvviso”), con un calo degli afflussi di capitali, pressioni di svalutazione
e crescenti problemi con il finanziamento dell’intera economia – sia in termini
bancari che produttivi».
In proposito, è
significativo che, in contemporanea con il discorso di Putin agli oligarchi, sia
arrivata la notizia che nel 2022 gli utili netti di Gazprom si sono ridotti del
72,2 per cento: da duemilasettecento miliardi di rubli del 2021 a 743,3 del
2022, 9,8 milioni di dollari. Ciò benché le entrate di Gazprom nel 2022 siano
state di ottomila miliardi di rubli, ovvero il venticinque per cento in più
rispetto ai seimilaquattrocento miliardi entrate del 2021 di 6,4 trilioni. La
stessa produzione di petrolio della Russia si è contratta dell’11,8 per cento
nel 2022, nel contesto del crollo delle esportazioni verso l’Europa. Intanto, il
buco del bilancio statale è arrivato a trentaquattro miliardi di dollari.
Anche Oleg
Deripaska era presente all’incontro, assieme ad altri personaggi come Vladimir
Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov,
Andrei Melnichenko e Dmitry Mazepin i cui interessi spaziano dai metalli alle
banche e ai fertilizzanti.
Molti di loro
russi sono stati sottoposti a sanzioni occidentali, ma Putin ha spiegato di non
aver avuto altra scelta se non quella di procedere con la cosiddetta operazione
militare speciale in Ucraina. La Russia, ha proseguito, sta affrontando una
«guerra di sanzioni», ma sta rapidamente riorientando la sua economia verso
«Paesi amici».
La Russia deve
«risolvere questioni sistemiche, logistiche, tecnologiche e finanziarie, a
favore dell’economia» ha riconosciuto, pur assicurando: «Il declino
dell’economia russa questa estate è stato determinato dalle sanzioni, ma da
luglio l’economia è tornata a crescere». Ha quindi ringraziato le aziende che
non si sono ritirate dal Paese dicendo che «chi è rimasto in Russia si è
dimostrato più intelligente rispetto a chi ha dato ascolto ai consigli di chi ci
vuole distruggere». Ha promesso «sostegno del governo in tutti i modi alle
imprese responsabili, a coloro che sono pronti a battersi per la loro causa, per
il benessere del loro gruppo, delle persone che lavorano per loro, per il
benessere di tutti i russi». Ma, appunto, ha pure confessato loro che se non
portano risorse i quantità e al più presto la Russia rischia la «distruzione».
Putin teme che
il gruppo Wagner possa "invadere" la Russia, complotto per neutralizzarlo.
Il Tempo il 17 marzo 2023
L'esercito
privato del "cuoco di Putin" Yevgeny Prigozhin nella seconda fase della guerra è
diventato, insieme ai miliziani ceceni di Ramzan Kadyrov, una sorta di braccio
armato personale dello Zar. Ma secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano su
numerosi canali Telegram russi e ucraini, il famigerato Gruppo Wagner sarebbe
ora inviso a Vladimir Putin. Il presidente russo, secondo questi retroscena
impossibili da verificare, avrebbe messo in atto una sorta di complotto
orchestrato insieme al segretario del consiglio di Sicurezza, Nikolai Patrushev,
al fine di "neutralizzare" la brigata.
Voci che seguono
i segnali di insofferenza dello stesso Prigozhin, imprenditore della
ristorazione (da qui il soprannome di "cuoco di Putin") divenuto negli anni uno
dei consiglieri più fidati del presidente. Dalla brigata Wagner si erano levate
anche accuse di alto tradimento rivolte contro Mosca per il mancato invio di
sufficienti munizioni al fronte, ricorda il Giornale che dà conto degli ultimi
retroscena in cui il confine tra insider e propaganda è difficile da
individuare.
La situazione
rischia di diventare un boomerang per Putin. "Il rischio, ha sottolineato il
think tank Institute for the Study of War (Isw), è che Prigozhin e i suoi
uomini, dopo un'eventuale battuta d'arresto in Ucraina, dove sono attualmente
impegnati, possano convergere nel territorio russo per prendere il potere nelle
regioni confinanti con l'Ucraina, con una possibile avanzata verso l'interno",
si legge nell'articolo. Insomma, se fatti fuori in Ucraina, i mercenari di
Wagner sono pronti a "invadere" parti di Russia.
La voce gira, lo
stesso Prigozhin ha riferito di aver ricevuto una domanda da un'agenzia di
stampa russa su eventuali discussioni al Cremlino per neutralizzare
Wagner. Patrushev, uomo di Putin, avrebbe detto al presidente russo che tra "un
mese e mezzo o due" non sarebbe rimasto niente del gruppo Wagner. Ma anche qui
la ricostruzione è impossibile da verificare, come riporta lo stesso ISW che
sospetta che dietro all'affermazione ci sia lo stesso capo di Wagner. Ma in cosa
consisterebbe il "complotto"?. Per evitare che Prigozhin spedisca i suoi
mercenari in armi contro la Russia. "Patrushev avrebbe già ordinato di
controllare i movimenti degli ex combattenti di Wagner. Putin avrebbe riferito
di essere d'accordo con questa iniziativa e lo avrebbe ringraziato dei suoi
sforzi" per "neutralizzare Wagner in generale e Yevgeny Prigozhin in
particolare", sui legge nel retroscena.
Estratto dell'articolo di
Letizia Tortello per “la Stampa” il 17 marzo 2023.
[…]Più che uno slogan, quello
del Battaglione georgiano che combatte in Ucraina, è una promessa di vendetta.
«Non dimentichiamo. Non perdoniamo. Ti aspetteremo ovunque», ripete ad alta voce
Mamuka Mamulashvili in un parcheggio di Kostantinivka, appena rientrato
dall'inferno di fuoco di Bakhmut. La Madre di tutti i nemici, fin da quando lui
aveva 14 anni e con il padre combatteva in Abkhazia, è la Russia liberticida e
totalitaria.
«Ero adolescente, mi hanno
catturato e in prigione mi hanno spezzato le ossa, russian style, non lo
dimenticherò», […] Oggi Mamulashvili comanda la legione georgiana, […]Guida 2000
soldati professionisti della guerra, un terzo di loro è straniero, sei sono
italiani. «Lottiamo tutti per la democrazia, anche i vostri connazionali –
spiega. Questa è anche la nostra guerra, parlo da georgiano. Se cade Kiev, la
prossima sarà Tbilisi. Io a Bakhmut proteggo anche la mia gente, i georgiani non
vogliono finire nelle braccia di Putin».
[…] Lo stato maggiore ucraino
continua a sperare che, con le elevate perdite russe e l'arrivo di ulteriori
forze da altre sezioni del fronte, la tenuta di Bakhmut indebolisca l'intera
offensiva del nemico. […] Descrive con orgoglio il pantano in cui si sarebbe
ficcato, a suo dire, il capo dei mercenari, Evgenij Prigozin con i suoi uomini:
«Hanno problemi di logistica, di morale ovviamente perché non si aspettavano una
controffensiva così tenace. Usano i soldati come carne da cannone e noi li
aspettiamo perché siamo più veloci». […]
[…] I lupi georgiani sparano
coi mortai verso l'orizzonte, usano armi piccole e anche cannoni sotto i 20
millimetri, sistemi di radio locazione. Si muovono tra le sterpaglie dopo ogni
colpo, si rannicchiano dietro gli alberi, esultano. […]La violenza terribile
dell'odio per il nemico, che è anche lotta per la sopravvivenza.Dei singoli
soldati, di un'intera nazione.
«Difendiamo la democrazia,
contro la dittatura di Putin», aggiunge Mamulashvili, […] «Quando l'Unione
Sovietica è crollata – spiega –, le repubbliche indipendenti hanno cercato di
conquistare alleati stabili e affidabili nel nuovo mondo post-bipolare.
L'Ucraina ci ha aiutato durante l'invasione, nel 2008. E ora siamo qua a
restituirle il favore. Sappiamo bene di cosa è capace Mosca, è sempre lo stesso
copione».
[…] ITALIANI SCELTI
[…] Con lui combattono anche
sei italiani scelti, che non vogliono farsi intervistare. Hanno tra i 40 e i 50
anni. Hanno preferito il battaglione georgiano, perché è più preparato di quello
internazionale. «Nelle mie vene scorre il sangue della vendetta. Bakhmut non
cadrà - spiega Mamulashvili -. La Russia si ricordi: andrò a prenderli sempre,
uno ad uno. Anche in Giappone. Abbiamo tanti ragazzi giapponesi valorosi che
combattono con noi».
Ecco la vera
storia delle “minacce” dei mercenari Wagner al ministro della Difesa Crosetto.
EMILIANO FITTIPALDI su Il Domani il 18 marzo 2023
L’ex ministro
grillina Trenta ha mandato un alert su WhatsApp avvertendo della presunta taglia
da 15 milioni di dollari messa dai mercenari russi. Messaggio in mano anche ai
vertici dei servizi
L’informazione
veniva da una fonte straniera considerata poco attendibile, e non è stato dunque
dato seguito. Ma perché la smentita di Mantovano non ha comunque dato conto
degli sms di Trenta?
Alta tensione nel
governo verso il Dis: l’ipotesi del rapporto tra Wagner e il boom degli sbarchi
è stata lanciata dalla Belloni. E poi cavalcata dal governo. Ma non esistono
report con prove certe
La vicenda della
presunta taglia da 15 milioni di dollari che i russi del Gruppo Wagner avrebbero
messo sul ministro della Difesa Guido Crosetto è assai istruttiva. Perché la
notizia del Foglio - che mercoledì ha scritto che «la segnalazione è arrivata al
governo da parte della nostra intelligence» - è stata inizialmente ripresa da
testate di mezzo mondo, e data per buona anche dal titolare della Farnesina
Antonio Tajani. Salvo, un giorno dopo, essere smentita da Alfredo Mantovano,
compagno di partito di Crosetto e sottosegretario con delega ai servizi segreti.
Mantovano ha
detto, in una lettera al comitato parlamentare che vigila sull’intelligence
(Copasir) che chiedeva spiegazioni, che «non risulta alcuna evidenza di
intelligence riguardanti concrete minacce nei confronti del ministro». Il Foglio
ha ribadito lo scoop, senza fare marcia indietro nemmeno dopo il tweet dello
stesso Crosetto che ha negato di aver mai ricevuto alcuna informazione, dai
servizi, di minacce.
Siamo di fronte a
una fake news montata da un giornale e usata poi da esponenti del governo Meloni
per fare propaganda “vittimista”?
Se la notizia di
«un allerta dei servizi italiani» sulla taglia contro Crosetto è – ha
ricostruito Domani – fasulla, i retroscena della vicenda sono complessi.
ARRIVA LA
GRILLINA
La genesi della
storia è legata ad alcuni messaggi Whatsapp di Elisabetta Trenta, grillina ed ex
ministra della Difesa, e di una sua presunta fonte nei servizi turchi. Messaggi
che a inizio marzo arrivano a vari soggetti, tra cui lo stesso Crosetto, due
altri ministri e ai vertici dell’Aisi, il servizio segreto interno.
Trenta scrive al
ministro della Difesa: «La fonte “H” dice che Medvedev ha dato ordine alla
Wagner di colpire te e la tua famiglia e ha messo a disposizione una taglia di
15 milioni di dollari. Mi ha detto che Medvedev ha cominciato a parlare di te
circa un mese o un mese e mezzo fa, quando tu hai fatto una dichiarazione contro
di loro. La Wagner avrebbe incaricato il suo gruppo albanese ed estone, ed un
gruppo di circa 8-9 persone dovrebbe venire in Italia per questo dai due paesi.
Dice che sono pronti al suicidio. Posso chiamarti?».
La stessa fonte
di Trenta, sedicente agente che secondo qualificate fonti sarebbe «un mezzo
mitomane», ha mandato sms dello stesso tenore, spiegando che la Wagner ha messo
in piedi contro Crosetto e la sua famiglia «un gruppo di otto o nove mercenari.
Non so se Aise e Aisi hanno dato informazioni al ministro. Tuttavia, potrebbero
non dare informazioni complete».
L'alert parte da
Trenta e dalla sua fonte “H”, non dai nostri servizi, ai quali però i messaggi
sono arrivati: con ogni probabilità li hanno valutati subito come inattendibili
e non hanno dato alcun seguito. Non esistono né informative né segnalazioni che
l'Aise di Gianni Caravelli e l'Aisi di Mario Parente hanno mandato al dal Dis
guidato da Elisabetta Belloni.
Ma perché
Mantovano, nella smentita fatta tramite Ansa che correttamente nega l'esistenza
di pericoli reali per Crosetto o «evidenze di intelligence», non ha dato anche
conto dell'alert informale di Trenta, non una passante ma una che è stata nel
2018 e 2019 il nostro titolare della Difesa?
La sconfessione
di Palazzo Chigi ha creato qualche imbarazzo a chi ha dato per assodata la
minaccia. Ma soprattutto è stata sfruttata sui social da chi crede che il
ministro della Difesa abbia usato l'articolo del Foglio per farsi
auto-propaganda. Anche se Crosetto, in realtà, lo aveva subito minimizzato,
dichiarando che lui «per non alimentare un ulteriore, inutile motivo di scontro»
non si sente «minacciato, e sono certo che non ci siano taglie o altro su di me.
Se ci fossero stati rischi o minacce di tale gravità, ne sarei stato certamente
informato, e non è mai accaduto».
Se la Trenta,
contattata da Domani, non smentisce aggiungendo che comunque a suo parere «la
vicenda è stata gestita malissimo», da Palazzo Chigi spiegano a Domani che
«Mantovano non ha certo voluto fare uno sgarbo a Crosetto: probabilmente non ha
saputo nulla del messaggio della Trenta». Vorrebbe dire che dentro il comparto
nessuno ha informato il sottosegretario con delega all'intelligence. Poco
probabile.
LA BUFALA WAGNER
La ricostruzione
serve a capire come, talvolta, informazioni non verificate possono creare
tempeste in un bicchier d'acqua. E diventare armi di propaganda da una parte o
un'altra, creando confusione su temi sensibili. Cosa accaduta anche per l'altra
notizia di settimana che aveva al centro la Wagner. Quella cioè dell'utilizzo
che il gruppo di mercenari fondato dal “cuoco” di Putin di Evgeny Prigozhin
farebbe dell'immigrazione clandestina da qualche mese a questa parte.
I traffici di
esseri umani – hanno detto prima Crosetto e poi Tajani – sarebbero parte della
guerra ibrida di Putin per destabilizzare i paesi occidentali. Un disegno reso
possibile dal fatto che i miliziani Wagner sono attivi in alcune regioni da cui
partono i disperati, come Libia, Sudan e Mali.
Sarebbero i
mercenari russi e non l'incapacità del governo, insomma, in colpevoli
dell'aumento degli sbarchi sulle coste italiane. Fenomeno che sta creando
problemi mediatici e politici alla destra che ha promesso in campagna elettorale
porti chiusi e impossibili blocchi navali.
Le responsabilità
della Wagner sul boom dei barconi è per molti esperti una panzana. Smentita dal
fatto che nelle ultime ondate migratorie i migranti partono da Tunisia o da
paesi orientali, dove l'influenza del gruppo è inesistente. È dall'evidenza che
i paramilitari russi sono presenti in Cirenaica (Libia) con pochissimi
effettivi, non in grado di regolare a loro piacimento flussi di decine o
centinaia di migliaia di persone. «Crosetto è un testa di c., noi non siamo al
corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria, abbiamo un sacco di
altri problemi», ha replicato Prigozhin alle accuse.
Il ruolo del Dis
Ma come è nato
questo nuovo “fattoide” cavalcato dal governo Meloni dopo la disastrosa gestione
della tragedia di Cutro? I ministri hanno esternato subito dopo un vertice a
sette tra Meloni, Crosetto, Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e i tre
vertici delle nostre agenzie di sicurezza.
Qualsiasi analisi
geopolitica definisce da mesi la presenza della Wagner in Africa come un
elemento di destabilizzazione, ma a Domani risulta che né Aise né Aisi abbiano
mai fatto alcuna relazione su rapporto diretto tra Wagner e l'immigrazione
clandestina. E che sia stata invece il capo del Dis, Elisabetta Belloni, a
parlare ai ministri presenti alla riunione del 13 marzo di questa ipotesi, poi
divulgata da Crosetto, Tajani ed esponenti leghisti.
Che prove
concrete sui presunti traffici umani dei soldati di Putin ce ne fossero poche
s'è capito quando Tajani è andato a Porta a Porta. Il ministro degli Esteri non
ha citato relazioni della nostra intelligence, ma ha solamente sventolato un
articolo di Repubblica dello scorso luglio, in cui una generica «fonte
qualificata dei nostri apparati di sicurezza» ipotizzava come «Wagner usasse i
migranti come arma sul voto italiano». Nessun altra evidenza.
Altri ministri
hanno invece ricordato che in passato il Copasir aveva lanciato stesso allarme.
In realtà era stato il membro della commissione Enrico Borghi, del Pd, a
rilasciare un'intervista in cui commentava il medesimo articolo di Repubblica.
«Nessuna puntuale relazione di intelligence sul binomio Wagner-migranti in
Africa è conservata dentro i cassetti del Copasir, anche perché dall'Aise e
dall'Aisi nulla ci è mai arrivato», spiega a Domani un attuale membro
dell'organismo.
«Nel 2021 la
nostra relazione annuale in un rigo ha dato conto della presenza della Wagner
nel Sahel. Regione dove, si legge, “originano alcuni grandi minacce come
l'instabilità degli stati, il terrorismo Jihadista e l'immigrazione
clandestina”. Nulla di più».
PROPAGANDA
L'assenza di
relazioni dell’intelligence ha fatto assai arrabbiare lo stesso Tajani, che ha
capito di essere stato spedito a combattere in tv senza equipaggiamento
adeguato. Se ne è lamentato direttamente con Meloni.
Il ministro del
Made in Italy Adolfo Urso, ex presidente del Copasir, per dare copertura alla
congettura ha pure tirato in ballo «il famoso ponte aereo» a novembre 2021 «che
portò in Bielorussia decine di migliaia di profughi e migranti siriani,
iracheni, afgani che poi furono indirizzati alla frontiera d’Europa per far
entrare in crisi l’Europa, alimentandone anche le divisioni interne su come
gestire il fenomeno migratorio».
Una vicenda che
nulla c'entra con eventuali responsabilità della milizia Wagner sui flussi
migratori: la storia dei voli di migranti che arrivavano con normali aerei di
linea da Turchia e Iran fino a Minsk fu pubblicata dal giornale Deutsche Welle,
che evidenziò (usando un'anonima «fonte interna all'ambasciata bielorussa di
Erbil») come gli uomini del dittatore Lukashenko stavano concedendo il visto
turistico a «decine di migliaia di migranti» che poi venivano “spinti” verso la
frontiera della Polonia.
Non è chiaro se
il governo abbia forzato la narrazione per suoi interessi o se il Dis abbia dato
informazioni parziali. Senz'altro però Meloni dovrebbe maneggiare dossier così
delicati con maggiore attenzione: siamo in guerra, la migrazione è un fenomeno
epocale, e giustificare incapacità di Palazzo Chigi tirando in ballo i mercenari
del cuoco di Putin senza prove certe sembra un'arma di distrazione di massa.
EMILIANO
FITTIPALDI. Nato nel 1974, è vicedirettore di Domani. Giornalista investigativo,
ha lavorato all'Espresso firmando inchieste su politica, economia e criminalità.
Per Feltrinelli ha scritto "Avarizia" e "Lussuria" sulla corruzione in Vaticano
e altri saggi sul potere.
Guido Crosetto,
cosa c'è dietro la "taglia di Wagner". Spunta il primo sms.
Valentina Bertoli su
Il Tempo il 18 marzo 2023
La guerra
sotterranea di propaganda è inarrestabile. La notizia che la brigata Wagner,
composta dai mercenari russi capeggiati dall’oligarca Evgenij Prigozhin, avesse
istituito una taglia di 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido
Crosetto, inizialmente ricondotta a una decina di giorni fa e associata al
vaglio dei Servizi di intelligence italiani, ha destato non poca preoccupazione
e creato alta tensione tra il governo e il Dis. Arrivano le prime ricostruzioni
e, dopo la smentita di Alfredo Mantovano, spunta una nuova versione dei fatti:
secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, tutto è nato da un messaggio
WhatsApp della grillina Elisabetta Trenta.
L’esercito guidato
dal generale russo Evgenij Prigozhin avrebbe istituito una taglia di 15 milioni
di dollari sulla testa di Guido Crosetto, il ministro della Difesa. Se fino a
qualche giorno fa, in base a quanto riportato da Il Foglio, si pensava che la
minaccia della brigata di mercenari che fiancheggia la Russia nella guerra
contro l’Ucraina fosse stata comunicata al ministro dai Servizi di intelligence
italiani circa dieci giorni fa, ora la prospettiva cambia. Ad aggiungere un
tassello alla vicenda è il quotidiano Domani. Ripercorrendo le tappe
dell’itinerario servito alla notizia per mandare in allarme governo e Dis, è
bene ricordare che la notizia de Il Foglio, che mercoledì ha scritto che “la
segnalazione è arrivata al governo da parte della nostra intelligence”, è stata
inizialmente data per certa non solo dalle testate giornalistiche, ma anche dal
titolare della Farnesina Antonio Tajani. Poi Alfredo Mantovano, sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha fatto chiarezza e, in
una lettera al Copasir, ha detto: “Non risulta alcuna evidenza di intelligence
riguardante concrete minacce nei confronti del ministro”.
È Domani ad
inserirsi in questo complesso scontro di ipotesi. Per il quotidiano di Stefano
Feltri, la genesi della minaccia è legata ad alcuni messaggi WhatsApp di
Elisabetta Trenta, grillina ed ex ministra della Difesa, e ad una sua presunta
fonte nei servizi turchi. Sembrerebbe, infatti, che questi messaggi siano
arrivati a inizio marzo a vari soggetti, tra cui lo stesso Crosetto, due altri
ministri e i vertici dell’Aisi, il servizio segreto interno. L’ “alert” sarebbe
partito da Trenta e dalla sua fonte “H”, quindi. Scrive la grillina al ministro
della Difesa: “La fonte “H” dice che Medvedev ha dato ordine alla Wagner di
colpire te e la tua famiglia e ha messo a disposizione una taglia di 15 milioni
di dollari. Mi ha detto che Medvedev ha cominciato a parlare di te circa un mese
o un mese e mezzo fa, quando tu hai fatto una dichiarazione contro di loro. La
Wagner avrebbe incaricato il suo gruppo albanese ed estone ed un gruppo di circa
8-9 persone dovrebbe venire in Italia per questo dai due paesi. Dice che sono
pronti al suicidio. Posso chiamarti?”.
La storia dietro
la presunta "taglia" sul ministro. La “taglia” della Wagner su Crosetto e il
ruolo dell’ex ministro Trenta nell’allarme-bufala: per i nostri 007 la sua fonte
“è un mitomane”.
Carmine Di Niro su Il Riformista il 18 Marzo 2023
La
fantomatica taglia da 15 milioni di dollari messa sulla testa del ministro della
Difesa Guido Crosetto da parte del gruppo Wagner, i mercenari russi al soldo
dell’ex “chef” di Putin, Evgeny Prigozhin? A fornire alla nostra “intelligence”
la pluvi-smentita informazione sarebbe stata l’ex ministra della Difesa, l’ex
grillina Elisabetta Trenta.
A scriverlo oggi
è Domani in una contro-inchiesta di Emiliano Fittipaldi sul caso fatto scoppiare
pochi giorni fa da un articolo de Il Foglio che lanciava l’allarme sulla taglia
sul ministro e cofondatore di Fratelli d’Italia, citando a sostegno
dell’articolo fonti dei servizi segreti.
Una questione,
quella della taglia, smentita sia dal diretto interessato, ovvero Crosetto, che
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che di
fronte alle richieste del Copasir ha evidenziato che “non risulta alcuna
evidenza di intelligence riguardanti concrete minacce nei confronti del
ministro”.
Il Foglio ha
ribadito la sua notizia, senza fare marcia indietro neanche di fronte alla
smentita dello stesso Crosetto, che su Twitter aveva sottolineato dopo le
polemiche e anche le ironie di non sentirsi minacciato “e sono certo che non ci
siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di
tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto”.
Ora sulla questione
delle “fonti” è il quotidiano di Stefano Feltri a tentare di fare chiarezza. Al
netto delle smentite, una segnalazione ai nostri servizi segreti sarebbe
effettivamente arrivata. A inviarla l’ex ministro della Difesa Elisabetta
Trenta: i suoi messaggi arrivano a vari soggetti, ricostruire Domani, tra cui lo
stesso Crosetto, altri ministri e ai vertici dell’Aisi, il servizio segreto
interno.
La fonte della
Trenta sarebbe un uomo dei servizi segreti turchi. Quest’ultimo, che secondo
fonti qualificate ascoltate dal Domani sarebbe “un mezzo mitomane”, scriveva a
sua volta che la milizia Wagner aveva messo in piedi contro Crosetto e i suoi
familiari “un gruppo di otto o nove mercenari”.
Trenta gira l’alert
in un messaggio che il quotidiano riporta così: “La fonte “H” dice che Medvedev
ha dato ordine alla Wagner di colpire te e la tua famiglia e ha messo a
disposizione una taglia di 15 milioni di dollari. Mi ha detto che Medvedev ha
cominciato a parlare di te circa un mese o un mese e mezzo fa, quando tu hai
fatto una dichiarazione contro di loro. La Wagner avrebbe incaricato il suo
gruppo albanese ed estone, ed un gruppo di circa 8-9 persone dovrebbe venire in
Italia per questo dai due paesi. Dice che sono pronti al suicidio. Posso
chiamarti?”.
Al Domani la Trenta
non smentisce la storia, limitandosi a spiegare che a suo modo di vedere “la
vicenda è stata gestita malissimo”.
Gli stessi servizi
nostrani avrebbero valutato come inattendibili le presunte minacce del gruppo
Wagner su ‘ordine’ di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza
russo e sodale di Putin. Non a caso, aggiunge Domani, “non esistono informative
né segnalazioni che l’Aise di Gianni Caravelli e l’Aisi di Mario Parente hanno
mandato al Dis guidato da Elisabetta Belloni”.
In tutto ciò, non si
capisce perchè Mantovano nello smentire le minacce russe e l’esistenza di
pericoli reali per Crosetto, non ha dato conto dell’alert informale di Trenta.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
La Repubblica.
Putin a sorpresa in Crimea, visita un centro per bambini. Cpi: "Può essere
processato come nazisti e Milosevic"
Biden: "Mandato
d'arresto per Putin è giustificato, ha commesso crimini di guerra di cui
rispondere". Zelensky, liberazione territori occupati è in vista. Crimea, forte
esplosione a Sebastopoli
Il presidente
russo, Vladimir Putin, si è recato a sorpresa in visita in Crimea in occasione
del nono anniversario dell'annessione della regione alla Russia. Le immagini
mostrano Putin, vestito informalmente con un cardigan blu e pantaloni scuri,
visitare il centro per bambini 'Korsun', a Sebastopoli. Nella città della Crimea
occupata dai russi questa mattina c'è stata una forte esplosione.
Il viaggio in Crimea
arriva all'indomani della condanna da parte della Corte penale internazionale
che ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Gli
Stati uniti non hanno dubbi: la Russia sta commettendo crimini di guerra e
atrocità in Ucraina. Lo ha sostenuto la portavoce del Consiglio di sicurezza
americano, Adrienne Watson.
Punti chiave
15:05
Kiev, accordo grano
esteso per 120 giorni
14:43
Putin visita centro
per bambini a Sebastopoli in Crimea
12:43
Cpi, Putin si può
processare, come nazisti e Milosevic
10:24
Gb, Mosca si prepara
ad ampliare l'arruolamento militare
09:33
Allarme aereo a Kiev
e in tutta l'Ucraina per partenza jet dalla Bielorussia
23:59
Vertici militari Usa
sentono omologhi Kiev e Zelensky
Il Consigliere per
la Sicurezza Nazionale anericano Jake Sullivan, il Segretario alla Difesa Lloyd
J. Austin III e il capo di Stato maggiore Mark A. Milley hanno parlato oggi con
il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, il ministro della
Difesa Oleksii Reznikov e il Comandante in capo delle forze armate ucraine, il
generale Valerii Zaluzhnyi, per discutere del fermo sostegno degli Stati Uniti
alle forze armate ucraine mentre si difendono dalla brutale invasione della
Russia. È quanto si legge in una nota. I funzionari ucraini hanno fornito un
aggiornamento sulle condizioni del campo di battaglia e hanno espresso
apprezzamento per la continua fornitura di assistenza alla sicurezza degli Stati
Uniti. I funzionari statunitensi hanno ribadito il fermo sostegno degli Stati
Uniti all'Ucraina in quanto difende la sua sovranità e integrità territoriale.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è unito alla chiamata alla
conclusione, viene spiegato.
00:00
Usa: "Russia
commette crimini di guerra di cui rispondere"
"Non c'è dubbio che
la Russia stia commettendo crimini di guerra e atrocità in Ucraina, e siamo
stati chiari sul fatto che i responsabili devono essere chiamati a risponderne":
lo ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa Adrienne
Watson, dopo che il mandato d'arresto per Putin emesso dalla Cpi. "Il
procuratore della Cpi è un attore indipendente e prende le proprie decisioni
giudiziarie sulla base delle prove di cui dispone", ha affermato Watson, senza
esprimere esplicito sostegno all'iniziativa: gli Stati Uniti, così come la
Russia, non hanno aderito a trattato istitutivo dell'organismo.
00:34
Biden: "Mandato
d'arresto per Putin giustificato"
Vladimir Putin ha
chiaramente commesso dei crimini di guerra: il mandato di arresto della Corte
penale internazionale nei suoi confronti è giustificato.
Lo afferma il
presidente americano Joe Biden.
02:54
Difesa aerea ucraina
abbatte 11 dei 16 droni lanciati da Russia
La difesa aerea
ucraina ha abbattuto 11 dei 16 droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati
dalla Russia contro l'Ucraina il 17 marzo. Lo rende noto il quotidiano Kiyv
Independent.
Secondo
l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha attaccato il Paese da due
direzioni. lancinado i droni Shahed dall'Oblast di Bryansk e dalla costa
orientale del Mar d'Azov.
In precedenza, il
governatore dell'Oblast di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha dichiarato che il
Comando orientale dell'Ucraina ha intercettato tre droni sopra l'Oblast di
Dnipropetrovsk, ma altri due droni hanno colpito una struttura infrastrutturale
critica a Novomoskovsk.
Le forze di difesa
aerea hanno abbattuto tutti i droni sopra Kiev, ha dichiarato Serhii Popko, capo
dell'amministrazione militare dell'Oblast di Kiev.
Nella tarda serata
di ieri, la Russia ha lanciato un attacco con i droni contro l'Ucraina.
Esplosioni sono state segnalate negli Oblast di Dnipropetrovsk, Kyiv e Zhytomyr.
03:00
Truppe russe verso
Bakhmut ma subiscono gravi perdite
La Russia ha
utilizzato tutte le sue forze a Bakhmut nel tentativo di circondare
completamente la città, ha dichiarato il colonnello generale Oleksandr Syrskyi,
comandante delle forze di terra dell'Ucraina. Secondo Syrskyi, sono in corso
aspri combattimenti a Kreminna, Torske, Bilohorivka e Spirne negli oblast di
Luhansk e Donetsk.
Tuttavia, Bakhmut
rimane l'epicentro della guerra. I combattimenti - rende noto il quotidiano Kiyv
Independent - sono in corso a nord, est e sud di Bakhmut, ha detto Syrskyi. Le
truppe russe stanno subendo pesanti perdite e, in alcuni casi, si stanno
ritirando senza aver ottenuto guadagni significativi.
La battaglia di
Bakhmut infuria da sette mesi e, nonostante i pesanti combattimenti, l'Ucraina
continua a mantenere la città.
Il governatore
dell'Oblast' di Donetst, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato due giorni fa che sono
rimasti meno di 3.000 abitanti della città industriale di prima della guerra,
tra cui 33 bambini. Le truppe russe stanno inoltre tentando senza successo di
sfondare le difese ucraine nelle direzioni di Lyman, nell'Oblast di Donetsk, e
di Kupiansk, nell'Oblast di Kharkiv, secondo l'aggiornamento notturno dello
Stato Maggiore ucraino.
Secondo lo Stato
Maggiore, la Russia ha lanciato 19 attacchi aerei nell'ultimo giorno e ha
effettuato 26 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo. L'aeronautica
ucraina ha effettuato sei attacchi aerei su aree di concentrazione di personale
militare e armi russe, ha reso noto lo Stato Maggiore.
08:02
Nella notte attacco
russo contro Zaporizhzhia
Le forze russe
hanno colpito la notte scorsa la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina
meridionale: lo ha reso noto il sindaco, Anatolii Kurtiev, aggiungendo che
nell'attacco è stato distrutto un ristorante e l'onda d'urto ha danneggiato
alcuni condominii. Secondo l'Amministrazione militare della regione, sono stati
usati missili S-300, come riporta il Kyiv Independent. Per ora non si registrano
vittime o feriti.
08:47
L'amministrazione
Biden non concede più asilo ai russi che chiedono rifugio negli Stati Uniti
L'Amministrazione
Biden non fa più eccezioni e i russi fuggiti negli Stati Uniti dopo l'invasione
dell'Ucraina vengono espulsi e rispediti in patria. Lo scrive il Guardian
parlando di un rapporto esclusivo e di un'inversione di tendenza rispetto a un
anno fa, quando le espulsioni erano state sospese per tutelare chi contestava la
linea adottata dal presidente russo Vladimir Putin e che per questo rischiava
di essere perseguito a Mosca. I numerosi richiedenti asilo russi, molti dei
quali si sono recati negli Stati Uniti nell'ultimo anno, ora sono terrorizzati
dal fatto che il governo degli Stati Uniti li possa far rientrare in Russia
dove rischiano il carcere o di essere inviati a combattere in prima linea in
Ucraina.
09:33
Allarme aereo a Kiev
e in tutta l'Ucraina per partenza jet dalla Bielorussia
Un allarme antiaereo
è stato dichiarato a Kiev e nel giro di pochi minuti si è diffuso a tutta
l'Ucraina per il timore di nuovi attacchi russi. Lo ha reso noto il ministero
della Trasformazione digitale ucraino diffondendo la mappa dei possibili
rischi. L'allerta in seguito alla partenza di jet da comabttimento MiG-31K
dalla Bielorussia. La partenza degli aerei è stata segnalata dagli attivisti
bielorussi di Gayun, come riportano Ukrinform e Ukrainska Pravda.
09:51
Droni Usa tornano a
sorvolare il Mar Nero
Gli Stati Uniti
hanno ripreso a volare sul Mar Nero dopo quanto accaduto martedì, quando un
drone americano Mq-9 è stato fatto precipitare in acque internazionali in
seguito a una collisione con un caccia russo Su-27. Lo riferisce FlightRadar24
spiegando che un drone Usa da ricognizione, un Rg-Global Hawk, è entrato nei
cieli sopra il Mar Nero dalla Romania e si è posizionato nello spazio aereo
internazionale a sud est della Crimea e a ovest della città costiera russa di
Sochi. Il Pentagono ha affermato più volte che l'abbattimento dell'Mq-9 non
avrebbe impedito ulteriori sorvoli del Mar Nero
10:24
Gb, Mosca si prepara
ad ampliare l'arruolamento militare
È probabile che le
autorità russe si stiano preparando a facilitare un più ampio arruolamento
nell'esercito per soddisfare le esigenze militari del Paese: lo scrive il
ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di
intelligence. Lunedì scorso, ricorda il rapporto pubblicato su Twitter, i
deputati della Duma - la Camera bassa del Parlamento russo - hanno presentato un
disegno di legge che prevede di spostare l'età della chiamata al servizio di
leva dall'attuale fascia di 18-27 anni a 21-30 anni. Ed è probabile che la legge
venga approvata ed entri in vigore nel gennaio 2024. "Molti uomini di età
compresa tra i 18 e i 21 anni attualmente chiedono di essere esentati dal
servizio di leva perché frequentano l'istruzione superiore. È molto probabile
che le autorità cambino la fascia d'età per aumentare il numero delle truppe,
assicurandosi che gli studenti siano alla fine costretti a prestare servizio",
concludono gli esperti di Londra.
10:52
Putin firma legge
che punisce chi critica anche i mercenari
Il presidente
russo, Vladimir Putin, ha firmato la legge che prevede la responsabilità penale
e amministrativa, con pene da cinque a sette anni di carcere, fino a 15 per i
casi più "gravi", per chi compie "azioni pubbliche volte a screditare qualsiasi
partecipante all'operazione militare speciale (come Mosca chiama l'invasione
dell'Ucraina, ndr), comprese le unità di volontari, organizzazioni o persone che
assistono" le forze armate regolari russe. Per quanto riguarda la parte
amministrativa, il provvedimento prevede per lo stesso reato multe a persone o
enti che possono arrivare fino a 500.000 rubli (circa 6.000 euro). Lo scrive
la Tass. Nel caso della "consapevole diffusione di notizie false", la pena
arriva a cinque anni, ma se il reato dovesse avere "gravi conseguenze" e causare
la morte di qualcuno o gravi danni, la pena può essere estesa fino a 15 anni di
reclusione e a 1,5 milioni di rubli. L'agenzia di stampa russa ricorda che
finora il codice penale prevedeva - dopo l'approvazione dell'apposita legge
quasi un anno fa - pene fino a un massimo di 15 anni solo per chi screditava le
forze armate. Di fatto la censura viene quindi estesa ora anche alle milizie
mercenarie che operano sul teatro ucraino, compreso il Gruppo Wagner.
11:12
Kiev, in Lugansk
'esercitazioni' russe per coprire mobilitazione
Le autorità russe
nella regione di Lugansk, nell'Ucraina orientale, hanno annunciato l'inizio di
"esercitazioni militari" su larga scala che coinvolgono tutti gli uomini in età
militare: lo rende noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev sulla sua
pagina Facebook, come riporta Unian. Secondo l'esercito, in questo modo i russi
cercano di nascondere la mobilitazione totale in alcuni villaggi della regione.
"La cosiddetta" autorità "locale nei territori temporaneamente occupati della
regione di Lugansk ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari su larga
scala che coinvolgono l'intera popolazione maschile (in età) di leva a
Starobelsk, Shchastia, Novy Aidar, Novopskov e Nyzhneteply", scrive lo Stato
Maggiore.
11:21
Zelensky,
liberazione dei territori occupati è all'orizzonte
"La guerra in
Ucraina è uno dei più grandi conflitti armati dalla seconda guerra mondiale. La
prima linea del fronte attiva raggiunge i 1.500 km. Le battaglie si svolgono nei
campi, nelle foreste, sull'acqua, nel cielo e nelle città. Continuiamo a
combattere per la nostra terra natale. La liberazione di tutti i territori
occupati è all'orizzonte. E l'Ucraina ce la farà sicuramente": lo scrive oggi il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo account Telegram.
11:31
Crimea, forte
esplosione a Sebastopoli
Una forte esplosione
ha scosso questa mattina Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi. "E' stato
forte oggi a Sebastopoli. C'è panico fra la popolazione", si legge sul canale
Telegram del Centro risorse tatare in Crimea, secondo quanto riferisce il
sito Ukrinform. Altri canali locali di Telegram riferiscono di esplosioni in
vari distretti della città. Ukrinform scrive anche di una esplosione a
Perevalne, un villaggio del distretto di Simferopol in Crimea, dove è dispiegata
una brigata di difesa costiera della flotta russa del mar Nero.
11:49
Kiev, uccisi altri
880 soldati russi nella giornata di ieri
Lo stato maggiore
ucraino ha riferito che altri 880 soldati russi sono stati uccisi nella giornata
di ieri. Con questo dato, sempre secondo le fonti delle forze armate ucraine,
sono più di 164.000 i membri del personale di servizio russo che sono stati
uccisi dall'inizio della guerra nel febbraio dello scorso anno.
12:15
Zelensky sente
Austin, Sullivan e Milley
Alti funzionari
ucraini e americani hanno avuto questa mattina un incontro video per discutere
di ulteriore assistenza da parte di Washington per la fornitura di armi e
munizioni. Vi hanno partecipato da parte americana il capo del Pentagono, Lloyd
Austin, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan e il capo di
Stato maggiore, Mark Milley. Per gli ucraini c'erano il ministro della
Difesa Oleksiy Reznikov, e il vice capo dell'ufficio presidenziale, Roman
Mashovets. Al termine dell'incontro si è aggiunto anche il presidente Volodymyr
Zelensky, ha riferito su Telegram il capo del suo ufficio Andriy Yermak. Il
leader ucraino, ha riferito Yermak, ha parlato di come le sue forze intendono
liberare i territori occupati dai russi. "Abbiamo ringraziato le autorità e il
popolo americano per l'ampio e potente sostegno al nostro paese nella lotta per
la libertà e il ripristino della pace in Europa", ha aggiunto.
12:20
Scholz su mandato
arresto Putin, nessuno al di sopra legge
Il cancelliere
tedesco Olaf Scholz ha accolto con favore il mandato di arresto emesso dalla
Corte penale internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin. "La Corte
penale internazionale è l'istituzione giusta per indagare sui crimini di
guerra", ha affermato Scholz durante la sua visita a Tokyo, come riportano i
media tedeschi. "Nessuno è al di sopra della legge", ha affermato Scholz,
ricordando che il governo tedesco ha sempre fatto in modo che alla Corte penale
internazionale fosse data l'importanza che merita.
12:33
Russia, per
estensione accordo sul grano via restrizioni su export
La Russia sta
legando la propria approvazione all'estensione dell'accordo sul grano con
l'Ucraina alla richiesta della rimozione delle restrizioni occidentali
all'esportazione dei propri prodotti agricoli. "Se Washington, Bruxelles e
Londra sono davvero interessate a continuare l'esportazione di cibo dall'Ucraina
via mare, hanno due mesi di tempo, con l'aiuto delle Nazioni Unite, per
rimuovere dall'ambito delle sanzioni l'intera catena di operazioni relative alle
esportazioni agricole russe prendere", ha detto il rappresentante delle Nazioni
Unite di Mosca Vasily Nebensja a New York, come riportano i media tedeschi. In
caso contrario, Nebensja ha affermato di dubitare che possa esserci una nuova
proroga dell'accordo.
12:43
Cpi, Putin si può
processare, come nazisti e Milosevic
Il procuratore capo
della Corte penale internazionale Karim Khan ha detto alla Cnn di ritenere che
il presidente russo Vladimir Putin possa essere processato per presunti crimini
di guerra nonostante Mosca sostenga di non essere soggetta alle decisioni della
Corte. Khan ha ricordato i processi storici contro i criminali di guerra
nazisti, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e l'ex leader
liberiano Charles Taylor, come esempi di figure apparentemente intoccabili che
hanno dovuto affrontare la giustizia: "Erano tutti individui potenti, eppure si
sono ritrovati nelle aule di tribunale", ha affermato.
12:51
Kiev, manovre nei
corridoi del Cremlino per sostituire Putin
L'atmosfera a Mosca
si è fatta più cupa dopo la decisione della Corte penale internazionale (Cpi) di
emettere un mandato d'arresto per il presidente Vladimir Putin e al Cremlino
stanno già cercando un suo successore: tuttavia non è più Putin che lo cerca. Lo
ha detto in tv il rappresentante dell'intelligence militare ucraina, Andrey
Yusov, come riportano i media nazionali. Yusov ha sottolineato che la cerchia di
Putin si sta restringendo, sta diventando sempre più tossica sia per il mondo
esterno sia per l'interno del Paese. "Nelle torri del Cremlino, in particolare,
cresce l'insoddisfazione per quanto sta accadendo - ha aggiunto -. C'è una
crescente consapevolezza delle prospettive, ovvero della catastrofe geopolitica
del regime di Putin. E sì, si parla già di trovare un successore a Putin e non è
più Putin a cercare un successore".
13:14
Mosca, aperti a
proposte serie su crisi ma non a ultimatum
Mosca è aperta a
proposte serie per risolvere la crisi ucraina, ma non accetterà ultimatum: lo ha
detto oggi la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come
riporta la Tass. "Abbiamo ripetutamente dichiarato di essere aperti a proposte
veramente serie da parte dell'Occidente e dell'Ucraina per trovare una soluzione
politica e diplomatica alla crisi, ma non accetteremo il linguaggio degli
ultimatum", ha affermato Zakharova commentando le dichiarazioni del ministro
degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba sull'importanza della 'formula di pace'
proposta dal presidente Volodymyr Zelensky.
13:35
Mosca, per pace
serve smilitarizzazione e denazificazione Kiev
Per raggiungere una
pace sostenibile tra Russia e Ucraina, è necessario ottenere la
"smilitarizzazione e la denazificazione" di Kiev. Lo ha detto la portavoce del
ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Tass. Per Zakharova
la pace sostenibile deve passare attraverso la cessazione della fornitura di
armi e mercenari all'Ucraina, la fine delle ostilità, il ritorno dell'Ucraina a
uno status neutrale non di blocco e il riconoscimento internazionale delle nuove
realtà territoriali emerse a seguito della realizzazione del diritto dei popoli
all'autodeterminazione. "Devono essere effettuate la smilitarizzazione e la
denazificazione dell'Ucraina ed eliminate tutte le minacce provenienti dal suo
territorio", ha affermato ancora Zakharova, aggiungendo che devono essere anche
abolite "tutte le sanzioni e le azioni illegali contro la Russia nei tribunali
internazionali". Zakharova ha poi raccomandato a tutti i paesi che vogliono
contribuire alla normalizzazione della situazione di rivolgere i loro appelli
per la pace a Kiev e ai suoi "burattinai occidentali, che stanno sempre più
trascinando l'Ucraina nel pericoloso imbuto del confronto globale".
13:41
Zelensky sanziona
presidente siriano Assad
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni nei confronti del presidente
siriano Bashar al-Assad. Lo riporta il Kiev Independent spiegando che oggi
ielensky ha firmato un decreto che impone sanzioni a 141 persone giuridiche e
300 persone fisiche, tra cui il presidente siriano Assad. Nei giorni scorsi
Assad si era recato in visita a Mosca dal leader del Cremlino Vladimir Putin e
aveva manifestato il proprio sostegno alla guerra russa contro l'Ucraina,
affermato che il mondo sarebbe stato più sicuro dopo la vittoria di Mosca su
Kiev.
13:44
Domani riunione in
Ue, si punta a intesa su munizioni a Kiev
Nuova riunione dei
Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue prevista per domani pomeriggio.
L'incontro del Coreper II è stato convocato sia per portare avanti i lavori
preparatori per il Consiglio europeo di giovedì e venerdì sia per avvicinarsi
all'intesa sull'invio delle munizioni all'Ucraina. Quest'ultimo dossier sarà sul
tavolo del Consiglio Affari Esteri di lunedì e i vertici comunitari puntano ad
un accordo politico tra i ministri dei 27 Paesi membri. L'intesa non è lontana
ma, in queste ore, gli sherpa saranno impegnati ad un'ulteriore limatura,
soprattutto per quanto riguarda l'irrobustimento dell'industria della difesa
europea. La Francia vuole allegare il capitolo, senza rinvii, all'accordo sulle
modalità per inviare e acquistare munizioni per l'Ucraina.
14:00
Putin a sorpresa in
visita in Crimea
dalla nostra inviata
Brunella Giovara
Il giorno dopo
l'incriminazione della Corte penale internazionale, a sorpresa il presidente
russo Vladimir Putin fa una visita ufficiale in Crimea. Le immagini del
principale canale televisivo russo Russia1 mostrano Putin mentre passeggia
accompagnato dal governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, tra gli altri
funzionari. Il presidente russo ha visitato anche una scuola d'arte e un centro
per bambini a Sebastopoli. Oggi è l'anniversario dell'occupazione della Crimea
avvenuta nel 2014. Questa visita suona come una risposta alle accuse che gli
vengono rivolte dal mondo occidentale.
14:38
Gruppo Wagner pronto
a reclutare 30.000 combattenti
Yevgeny Prigozhin,
il capo del gruppo di mercenari Wagner, ha annunciato di voler reclutare circa
30.000 nuovi combattenti entro metà maggio. Come riporta Cnn, Prigozhin ha anche
affermato che Wagner recluta in media da 500 a 800 persone al giorno e talvolta
fino a 1.200 al giorno. "È possibile che questo numero di reclute diminuisca nel
tempo. Tuttavia, entro la metà di maggio, prevediamo che il numero di
combattenti dell'unità aumenterà di circa 30.000 unità", ha detto Prigozhin in
un messaggio audio pubblicato su Telegram.
14:43
Putin visita centro
per bambini a Sebastopoli in Crimea
Il presidente
russo Vladimir Putin è arrivato, alla guida di un'auto, per una visita a
sorpresa a Sebastopoli, il porto dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero
in Crimea. Il presidente russo ha visitato il centro per bambini 'Korsun'. Ieri
la Cpi ha emesso un mandato di arresto contro di lui ritenendolo "responsabile
del crimine di guerra di deportazione illegale bambini dalle zone occupate
dell'Ucraina alla Russia". Putin, vestito informalmente con un cardigan blu e
pantaloni scuri, ha visitato anche una scuola d'arte accompagnato dal
governatore Mikhail Razvojaev, come mostra un video rilanciato da Ria Novosti.
Putin sarebbe
arrivato in Crimea guidando la sua automobile, come ha sottolineato con toni
entusiastici il governatore di Sebastopoli. "Il nostro presidente sa come
sorprenderci, in senso buono - ha scritto su Telegram - Oggi dovevamo inaugurare
una scuola d'arte per bambini. Tutto era pronto per una video conferenza e un
collegamento speciale con il presidente. Ma alla fine il presidente è venuto
personalmente. In macchina. Era lui stesso al volante. In questo giorno storico,
il presidente è sempre con Sebastopoli e il suo popolo. Il nostro paese ha un
leader incredibile".
15:05
Kiev, accordo grano
esteso per 120 giorni
Il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l'estensione dell'accordo sul grano
ucraino che scade stanotte a mezzanotte. Il presidente turco non ha specificato
il periodo di tempo, ma da Kiev il ministro delle Infrastrutture Oleksandr
Kubrakov fa sapere che l'accordo è stato prorogato per 120 giorni. Su twitter,
Kubrakov ha ringraziato Erdogan, Antonio Guterres e tutti i 'nostri partner':
"Grazie ai nostri sforzi congiunti, 25 milioni di tonnellate di grano ucraino
sono state consegnate ai mercati mondiali".
15:43
Mosca, 'accordo di
pace deve cancellare cause legali a Mosca'
Un eventuale accordo
per l'Ucraina deve comprendere "la cancellazione delle sanzioni e di tutte le
cause legali contro la Russia nelle Corti internazionali". Lo ha detto la
portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Ria
Novosti. Per arrivare alla pace, ha aggiunto la portavoce in una dichiarazione
postata sul sito del ministero degli Esteri, è inoltre necessario che "cessino i
rifornimenti di armi e mercenari all'Ucraina" e il ritorno dell'Ucraina a uno
status neutrale, oltre al "riconoscimento internazionale delle nuove realtà
territoriali".
16:07
Zakharova, "fratello
Karim Khan pedofilo rilasciato in anticipo"
E' "un pedofilo"
rilasciato in anticipo il fratello di Karim Khan, il procuratore della Corte
penale internazionale (Cpi) che ieri ha emesso un mandato d'arresto per il
presidente russo Vladimir Putin accusandolo della deportazione di bambini
dall'Ucraina in Russia. Lo afferma sul suo canale Telegram la portavoce del
ministero degli Esteri Maria Zakharova, aggiungendo che il fratello del
procuratore, Imran Ahmad Khan, ex deputato conservatore dimessosi in seguito
all'episodio, è stato rilasciato il 23 febbraio da una prigione in Gran Bretagna
dopo avere scontato soltanto la metà di una condanna a 18 mesi di reclusione per
avere molestato un ragazzo minorenne.
"Il 17 marzo, tre
settimane dopo il rilascio del fratello pedofilo - afferma ancora Zakharova -
Karim Khan emette un ordine d'arresto non solo per Putin, ma anche Maria
Llova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini in Russia, cioè una persona
che protegge i bambini da gente come il fratello del procuratore. Non si
vergognano più di niente".
La portavoce fa
capire di ritenere che vi sia un legame tra il rilascio anticipato del fratello
di Karim Khan e il mandato d'arresto contro Putin, affermando che "è uno
scandalo". "Dopo tutto - aggiunge - non esistono simili coincidenze. Il 'sistema
giudiziario' britannico ha già premiato un procuratore britannico della Cpi
rilasciando in anticipo suo fratello pedofilo. Naturalmente, ora è chiaro il
perché. I giudici della Cpi hanno fatto un salto fuori dalle loro toghe per
prendere una decisione così evidentemente idiota e illegale".
16:33
A Kiev nuovo
rimpasto governo,a Industrie l'eroico capo delle Fs
Il premier
ucraino Denys Shmyhal ha annunciato un rimpasto di governo per la prossima
settimana, quando dovrebbero dare le dimissioni il ministro delle industrie
strategiche Pavel Ryabikin e il titolare dell'istruzione e della Scienza Serhiy
Shkarlet. Alle industrie strategiche potrebbe essere nominato Oleksandr
Kamyshin, già presidente delle ferrovie Ukrzaliznytsia, simbolo della
resistenza ucraina che con i suoi treni è riuscito a far evacuare quasi due
milioni e mezzo di cittadini lontano dalle zone del Paese più colpite dalla
guerra. E per questo non proprio amato a Mosca.
16:48
Russia estende
accordo grano per 60 giorni
La Russia ha
notificato alle parti coinvolte che l'accordo sul grano è stato prorogato di 60
giorni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.
In precedenza, la Turchia e le Nazioni Unite avevano dichiarato che l'accordo
era stato prorogato, ma non avevano specificato per quanto tempo. Un ministro
del governo ucraino ha dichiarato che la proroga era di 120 giorni.
16:59
Kiev, 'bombe a
grappolo su Kramatorsk,almeno 2 morti e 5 feriti'
Almeno due persone
sono rimaste uccise a seguito del bombardamento russo di oggi su Kramatorsk. Lo
riporta Ukrainska Pravda citando il presidente dell'amministrazione di
Donetsk Pavel Kirilenko. Kirilenko ha parlato di utilizzo di bombe a grappolo
che hanno ferito anche cinque persone, oltre ad aver danneggiato una decina di
case e diverse macchine. "Stanno colpendo intenzionalmente la città, cercando di
uccidere il maggior numero possibile di civili", ha concluso il presidente
dell'amministrazione di Donetsk.
17:58
Guardian, ripresi i
rimpatri forzati dei russi richiedenti asilo
Gli Stati Uniti
hanno ripreso a rimpatriare con la forza i cittadini russi nel Paese. Lo rivela
il Guardian. I rimpatri erano stati sospesi con l'invasione dell'Ucraina da
parte di Mosca. Sono numerosi i richiedenti asilo che fuggono dalla Russia, dove
rischiano il carcere o la mobilitazione. "L'Us Immigration and Customs
Enforcement (Ice) rimane impegnato a far rispettare le leggi sull'immigrazione
in modo umano, efficace e professionale. L'Ice facilita il trasferimento e
l'allontanamento di non cittadini tramite compagnie aeree commerciali e voli
charter a sostegno dei requisiti della missione", ha affermato questa settimana
l'agenzia federale, secondo quanto riporta sempre il Guardian, e aggiunge:
"L'Ice conduce gli spostamenti verso Paesi, inclusa la Russia, in conformità con
le linee guida sull'allontanamento dei Paesi".
18:09
Medvedev, 'volevano
arrestare qualcuno, arrestano Trump'
Il vicepresidente
del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato la dichiarazione
dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si aspetta di essere
arrestato martedì invitando gli americani a distruggere la tirannia di
Washington. Lo riporta Ria Novosti. "Gli idioti in Europa volevano arrestare
qualcun altro (facendo riferimento al mandato d'arresto della Cpi per il
presidente Putin, ndr) e il 21 marzo arresteranno qualcuno in America.
Riprendetevi il vostro Paese, americani. Combattete. Distruggete la tirannia di
Washington. Mandate la cricca corrotta di padre e figlio Biden nella puzzolente
pattumiera della storia. Maga (acronimo trumpiano di Make America Great
Again)!", ha scritto Medvedev su Telegram citato da Ria Novosti, mettendo alla
fine del messaggio tre faccine di clown.
18:23
Mosca, estensione
accordo grano solo con promozione fertilizzanti russi
Mosca prenderà in
considerazione la possibilità di estendere l'accordo sul grano oltre i 60 giorni
solo se con la "promozione di cibo e fertilizzanti russi sui mercati globali".
Lo scrive Vasily Nebenzya, rappresentante russo permanente presso le Nazioni
Unite, in una lettera destinata a Martin Griffiths, vice segretario generale del
organizzazione, e a Rebecca Greenspan, a capo della Conferenza delle Nazioni
Unite sul commercio e lo sviluppo. Lo riporta Ria Novosti, che è entrata in
possesso del documento.
18:24
Kiev, "respinti
attacchi russi a nord di Bakhmut"
Le forze ucraine
hanno respinto gli attacchi sferrati oggi dai soldati russi nella zona
settentrionale di Bakhmut. Lo riporta Ukrainska Pravda citando lo stato maggiore
delle forze armate dell'Ucraina. La città rimane comunque epicentro delle
ostilità.
18:32
Esercito Kiev ha
attaccato 13 aree di concentramento russe nel Donbass
L'esercito ucraino
ha colpito oggi 13 aree di concentramento dell'esercito russo nel Donbass. Lo ha
reso noto lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina. Nel suo
aggiornamento serale, l'esercito di Kiev precisa che "la Federazione Russa
continua a condurre operazioni offensive nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiiv,
Marin e Shakhtar. Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità. Senza il risultato
desiderato sul campo di battaglia, la Federazione Russa usa tattiche
terroristiche contro la popolazione civile. Sta bombardando città e villaggi,
così come strutture infrastrutturali critiche, ignorando le norme del diritto
internazionale umanitario". Secondo i militari ucraini, l'esercito russo ha
lanciato cinque attacchi missilistici, quattro dei quali hanno colpito le
infrastrutture civili nella città di Zaporizhzhia. Inoltre, l'esercito russo ha
effettuato 12 attacchi aerei e ha effettuato più di 20 attacchi missilistici.
19:05
Jet Nato
intercettano velivoli russi vicino spazio aereo estone
Caccia britannici e
tedeschi hanno intercettato per la seconda volta in una settimana aerei russi
che volavano vicino allo spazio aereo estone. Lo rende noto la Royal Air Force
(Raf) britannica, come riporta la Cnn. I due jet Typhoon hanno intercettato "un
aereo passeggeri militare russo Tu-134, noto con il nome Nato Crusty, che era
scortato da due caccia Sukhoi Su-27 Flanker e da un aereo da trasporto militare
AN-12 Cub", ha detto la Raf. La Raf ha descritto l'operazione come una
rassicurazione sul fatto che il Regno Unito, la Germania e altri paesi della
Nato "stanno dalla parte del loro alleato estone in questo momento di tensione".
La Repubblica. Putin
visita Mariupol
Il presidente
promette di "ampliare i quartieri residenziali" della città occupata. Il
ministero della Difesa di Kiev: "E' arrivato di notte come un ladro"
Il blitz del
presidente russo nella città ucraina occupata il giorno dopo la visita in Crimea
per il nono anniversario dall'annessione. Il presidente ucraino Zelensky:
"Chiunque produca armi per il terrore contro l'Ucraina, chi aiuta la Russia a
fomentare l'aggressione, chi sostiene la distruzione del diritto internazionale
da parte della Russia, non può che essere emarginato dal mondo". Una inchiesta
dell'agenzia Bloomberg racconta come una flotta-ombra di petroliere aiuti Mosca
a trasportare il suo petrolio nel mondo nonostante le sanzioni.
00:00
Zelensky: "Chiunque
aiuti la Russia deve essere emarginato"
L'Ucraina ha emesso
sanzioni contro "più di 400 persone e aziende". Lo scrive su Telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le misure si rivolgono soprattutto contro
i russi, "si tratta del complesso militare-industriale dello Stato terrorista",
ma ci sono anche ripercussioni verso "individui iraniani e siriani, che aiutano
il terrorismo". "Valutiamo attentamente ogni nostra misura sanzionatoria" ha
aggiunto Zelensky, concludendo che "chiunque produca armi per il terrore contro
l'Ucraina, chi aiuta la Russia a fomentare l'aggressione, chi sostiene la
distruzione del diritto internazionale da parte della Russia, non può che essere
emarginato dal mondo".
04:20
Putin visita
Mariupol
Il presidente russo,
Vladimir Putin, ha fatto un "viaggio di lavoro" a Mariupol. Lo ha riferito il
servizio stampa del Cremlino secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti.
"Il capo dello stato
- scrive l'agenzia russa - ha ispezionato una serie di luoghi della città e ha
anche parlato con i residenti. Secondo il Cremlino è volato a Mariupol in
elicottero. Su un'automobile ha percorso diversi quartieri della città, facendo
soste. Il vice primo ministro Marat Khusnullin ha riferito in modo dettagliato
al presidente sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione e restauro
della città e dei suoi dintorni. In particolare, fa sapere il servizio stampa
del Cremlino, Putin e Khusnullin hanno discusso della costruzione di nuovi
microdistretti residenziali, nuove strutture sociali ed educative,
infrastrutture per alloggi e servizi comunali e istituzioni mediche" "Nel
microdistretto di Nevsky, il presidente Putin ha parlato con i residenti della
città e su invito di una famiglia è entrato dentro casa. Il capo dello Stato -
precisa il servizio stampa del Cremlino - ha anche esaminato la costa di
Mariupol nell'area dello yacht club, dell'edificio del teatro, luoghi memorabili
della città". Ieri Putin si trovava in Crimea per una visita a sorpresa nel nono
anniversario dell'annessione
04:41
Putin a Rostov sul
Don per riunione con militari
Il presidente
russo, Vladimir Putin, è andato a Rostov sul Don, in territorio russo, vicino al
confine con l'Ucraina, dove ha tenuto una riunione al posto di comando della
cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha riferito il servizio
stampa del Cremlino, secondo quanto riporta Ria Novosti.
"Il capo dello stato
ha ascoltato i rapporti del capo di stato maggiore delle forze armate, Valery
Gerasimov, e di un certo numero di capi militari", ha precisato il Cremlino.
05:44
Kramatorsk, bilancio
sale a due morti e 10 feriti
È salito a due
morti e dieci feriti il bilancio del bombardamento russo effettuato ieri sulla
città ucraina di Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Lo rendono noto le
autorità locali, citate dai media di Kiev.
Secondo il
governatore Pavlo Kyrylenko le forze russe hanno usato munizioni a grappolo
prendendo di mira il Parco Bernatsky, danneggiando una decina di edifici
residenziali e diverse auto.
10:16
Una flotta ombra di
petroliere per aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni
Almeno due compagnie
stanno aiutando la Russia ad eludere le sanzioni sul petrolio imposte
dall'Occidente, con l'aiuto di una flotta ombra di petroliere. Lo riporta
l'agenzia di stampa Bloomberg. Si tratta della Fractal Shipping di Dubai, negli
Emirati Arabi Uniti, e dell'indiana Gatik Ship Management basata a Mumbai, che
insieme possiedono petroliere per un valore di 2 miliardi di dollari. "In meno
di un anno hanno assemblato flotte che ora trasportano milioni di barili di
petrolio russo in tutto il mondo", riferisce l'agenzia sottolineando che gli
uffici di entrambe le società sono registrati in edifici abbandonati. La Fractal
e la Gatik fanno parte di una rete tentacolare di attività marittime emersa
subito dopo l'invasione dell'Ucraina, che aiuta la Russia ad esportare il suo
petrolio nonostante le sanzioni dell'Occidente, scrive Bloomberg. "È questa
nuova generazione di operatori del mercato delle petroliere che ha aiutato il
petrolio russo a continuare a circolare nel mondo", ha detto Rebecca
Galanopoulos Jones, analista di VesselsValue, una società che monitora i prezzi
di migliaia di navi mercantili. "Le sanzioni sul petrolio russo sembrano aver
avuto un impatto minimo sui livelli complessivi di esportazione", ha aggiunto.
10:54
Pushilin: "Felici di
avere Putin in visita. Siamo un'unica famiglia con la Russia"
Denis Pushilin, il
capo dell'amministrazione filo-russa di Donetsk, ha definito "simbolica" la
visita del presidente russo Vladimir Putin a Mariupol. Nel suo canale Telegram,
Pushilin ha scritto che "non è un caso che il presidente della Federazione Russa
Vladimir Putin ha visitato la Repubblica popolare di Donetsk nell'anniversario
della riunificazione della Crimea con la Russia. Il ritorno della Crimea e del
Donbass sono anelli della stessa catena. In tutti questi anni abbiamo sostenuto
che il nostro viaggio verso casa è più lungo e ora noi, insieme alla Crimea,
siamo un'unica famiglia dei popoli della Russia. E, naturalmente, siamo molto
felici di vedere il nostro presidente nel Donbass".
11:19
Il deputato ucraino
Honcharenko: "Putin è venuto a Mariupol a vedere il genocidio commesso?"
"Il criminale di
guerra è venuto a vedere con i suoi occhi il genocidio che ha commesso a
Mariupol? Perché di notte? Ha paura?". Così Oleksii Honcharenko, deputato
ucraino e membro della delegazione ucraina all'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa (Apce), ha criticato la decisione del presidente russo
Vladimir Putin di recarsi in visita a Mariupol.
11:43
Putin: "Gli ucraini
hanno minato l'ospedale di Mariupol. Queste sono cose da nazisti"
"Le persone normali
non lo fanno": è il commento del presidente russo Vladimir Putin nei confronti
dei soldati ucraini che - come riporta la Tass - avrebbero minato le strutture
ospedaliere di Mariupol. Putin, che ha visitato la città accompagnato dal vice
primo ministro Marat Khusnullin, ha ispezionato nuove aree residenziali.
Khusnullin ha detto di aver visitato l'ospedale e di aver visto con i suoi occhi
come vivevano i rifugiati nelle stanze vicine, c'erano i pazienti e venivano
eseguite le operazioni. "Tutti i dispositivi e le attrezzature mediche - tutto è
stato minato", ha sottolineato. "Bene, questi sono i cosiddetti nazisti. Le
persone normali non lo fanno, le persone di Bandera lo fanno", ha commentato
Putin.
11:53
Putin in visita a
Mariupol: "Amplieremo i quartieri residenziali"
Vladimir Putin ha
promesso che Mosca costruirà altri quartieri residenziali a Mariupol,
nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Secondo quanto riporta
l'agenzia di stampa Tass, durante la sua visita nella città dell'Ucraina
orientale Putin ha parlato con un residente locale, che ha definito il luogo "un
piccolo angolo di paradiso". E il presidente russo ha detto: "Lo amplieremo".
12:33
Vucic: "Il mandato
di arresto per Putin allontana la pace"
Il mandato di
arresto della Cpi per Vladimir Putin avrà conseguenze negative sugli sforzi di
pace nel conflitto armato in Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente serbo
Aleksandar Vucic. "Penso che il mandato di arresto per Putin avrà conseguenze
politiche negative, e dimostra che vi è una grande indisponibilità a parlare di
pace e di un cessate il fuoco", ha detto Vucic in una conferenza stampa a
Belgrado.
13:17
Kiev: "Putin a
Mariupol di notte come un ladro"
"Come si addice a un
ladro, Putin ha visitato l'ucraina Mariupol, sotto la copertura della notte.
Innanzitutto, è più
sicuro. Inoltre, l'oscurità gli permette di evidenziare ciò che vuole mostrare,
e tenere al riparo da occhi indiscreti la città completamente distrutta dal suo
esercito e i suoi pochi abitanti sopravvissuti". Lo ha scritto il ministero
ucraino della Difesa sul suo account Twitter.
13:44
Putin a Mariupol:
"Dobbiamo conoscerci meglio"
Le autorità russe
hanno rilasciato filmati della visita di Vladimir Putin a Mariupol, città
ucraina conquistata dai russi a maggio. Il presidente russo incontrando alcuni
residenti, sorpresi di vederlo, ha detto: "Dobbiamo iniziare a conoscerci
meglio", riporta la Cnn. In un video Putin, seduto al posto di guida insieme al
vice primo ministro Marat Khusnullin, parla dei piani di ricostruzione della
città rasa al suolo dalla Russia. I due discutono dei piani per costruire un
nuovo ospedale a Mariupol, dove nel marzo dello scorso anno, la Russia ha
bombardato un reparto maternità, mentre dentro c'erano donne incinta e personale
medico. "Ci sarà un'ambulanza e ci saranno tutti i laboratori più moderni", dice
Khusnullin. "Andrà tutto bene", risponde Putin.
13:59
Peskov: "I droni Usa
sul Mar Nero provano il coinvolgimento americano nel conflitto contro la Russia"
I droni statunitensi
sul mar Nero non sono utilizzati per la sicurezza delle navi e, di fatto,
provano il coinvolgimento di Washington nel conflitto contro la Russia. Lo ha
detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale tv
Rossiya-1. Rispondendo a una domanda sul drone Usa che si è inabissato nelle
acque internazionali del Mar Nero il 14 marzo scorso dopo lo scontro con un jet
russo, il portavoce del Cremlino ha definito incidenti di questo tipo
"certamente estremamente pericolosi", aggiungendo che "è abbastanza ovvio cosa
stanno facendo questi droni". "La loro missione non è affatto una missione
pacifica per garantire la sicurezza della navigazione in acque internazionali.
Ne siamo ben consapevoli. E, infatti, stiamo parlando del coinvolgimento diretto
degli operatori di questi droni nel conflitto, e contro di noi", le parole di
Peskov riportate da Tass.
14:31
Il governatore di
Kramatorsk accusa Mosca: "Usate bombe a grappolo"
Negli attacchi che
ieri sera hanno ucciso due persone a Kramatorsk, nel Donetsk, i russi hanno
utilizzato le bombe a grappolo vietate dalla convenzione Onu del 2008. Lo ha
detto il governatore regionale Pavlo Kyrylenko. Obiettivo dell'attacco, ha
spiegato, sono stati "un parco e una dozzina di edifici residenziali".
15:08
Putin: "Aumentare le
nostre forze? Nel 2014 non avevamo le armi ipersoniche, ora sì"
La Russia nel 2014
non aveva armi ipersoniche mentre ora ne ha e il fatto di non usarle non
significa che non esistano. A dirlo è Vladimir Putin in un'intervista al canale
tv televisivo Rossiya-1 riportata da Tass. Rispondendo a una domanda sulla
necessità di implementare le forze di terra, Putin ha sottolineato che "nel 2014
non avevamo armi ipersoniche ma ora sì. Certo, non le usiamo ma esistono".
15:59
Kiev: i russi non
sono in grado di catturare Bakhmut
I russi non sono
tatticamente in grado di completare l'operazione per catturare Bakhmut e stanno
subendo enormi perdite durante i combattimenti: lo ha assicurato Sergei
Cherevaty, rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina,
come riporta Ukrainska Pravda."Ora non sono tatticamente in grado di completare
l'operazione per catturare il centro regionale ucraino di Bakhmut. Sì, ci sono
battaglie molto attive, continuano ancora a effettuare diverse dozzine di
attacchi per inerzia, ma subiscono enormi perdite. Il nostro comando e il nostro
stato maggiore pianificano correttamente la loro difesa", ha affermato
Cherevaty.
17:02
Kiev: "Evacuati
tutti i bambini dalla zona di Chasiv Yar"
L'amministrazione
militare ucraina ha evacuato tutti i bambini dalla città di Chasiv Yar, nella
regione del Donetsk. Lo riporta Ukrinform. "Gli ultimi bambini li abbiamo
portati via l'altro ieri" ha spiegato Sehiy Chaus, capo dell'amministrazione
militare. Chaus spiega che questo è stato fatto "con gli sforzi congiunti
dell'amministrazione, della polizia, degli Angeli Bianchi (l'unità di polizia
locale ndr). È stato difficile, doloroso, ma ce l'abbiamo fatta"
17:24
Gli ucraini
respingono quattro attacchi russi a Bakhmut
Le unità della
guardia di frontiera dispiegate a Bakhmut, nella regione di Donetsk, hanno
respinto quattro attacchi russi domenica, eliminando cinque invasori e ferendone
nove. È quanto riferisce Ukrinform, citando l'ufficio stampa del Servizio
statale delle guardie di frontiera. Le unità del Gruppo Wagner volevano
avvicinarsi senza farsi notare per sfondare la linea di difesa dell'Ucraina,
spiegano i militari ucraini, ma "si sono trovati di fronte al fuoco massiccio
dei nostri difensori: cinque di loro non saranno più in grado di correre da
nessuna parte, mentre altri nove sono rimasti feriti".
17:59
Bombe russe sulle
case vicino a Zaporizhzhia, tre morti e due feriti
Almeno tre persone
sono morte a seguito del bombardamento da parte dei russi di un edificio
residenziale nel villaggio di Kamenskoe, nella regione di Zaporizhzhia. Lo
riporta Ukrainska Pravda citando l'amministrazione regionale. Nell'attacco
sarebbero rimaste ferite almeno due persone.
18:22
Consiglio comunale
di Mariupol (in esilio): "Visita del criminale Putin"
Il Consiglio
comunale di Mariupol, che ora opera dal territorio controllato dall'Ucraina, ha
condannato la visita di oggi del presidente russo Vladimir Putin nella città
occupata dai russi. "Il criminale internazionale Putin ha visitato la Mariupol
occupata - ha dichiarato il consiglio in un post su Telegram - Ha assistito
alla 'ricostruzione della città'... di notte. Dopotutto, al buio, non si può
vedere quante case distrutte ci sono e dove è stato lasciato un mucchio di
pietre al posto dei grattacieli". "Ha anche visitato la Filarmonica di Mariupol,
un edificio che ha resistito. Dove i civili si nascondevano durante i massicci
bombardamenti - ha scritto ancora il Consiglio - Si dice che i criminali siano
attratti dal luogo dei loro crimini. Mariupol è un errore fatale di un dittatore
sanguinario. Ha mostrato il vero volto del “mondo russo”, che è il terrore e
l'atrocità russa".
18:54
Ambasciatore polacco
in Francia: "O Ucraina riesce a difendersi o entriamo in guerra"
"O l'Ucraina
difenderà la sua indipendenza o, in caso contrario, saremo costretti a unirci a
questo conflitto, perché sono in gioco i nostri valori fondamentali, che sono il
fondamento della nostra civiltà, quindi non avremo scelta". Lo ha detto
l'ambasciatore polacco in Francia, Jan Emeryk Rociszewski, intervistato dalla
televisione Lci. La risposta è arrivata mentre si parlava del trasferimento di
caccia Mig-29 dalla Polonia e dalla Slovacchia all'Ucraina e si discuteva della
possibile escalation del conflitto. Come riportato dal quotidiano polacco Fakt,
l'ambasciatore Jan Emeryk Rociszewski ha spiegato che "non è la Nato, non la
Polonia, non la Francia o la Slovacchia ad aumentare la tensione, ma è la Russia
che ha attaccato l'Ucraina, è la Russia che invade, uccide persone, rapisce
bambini ucraini". Un attimo dopo, ha chiarito che la Polonia potrebbe svolgere
un ruolo ancora più significativo in questa guerra.
17:39
Usa: "Inaccettabile
eventuale richiesta di tregua dopo incontro Putin Xi"
"Vedremo cosa
emergerà da questo meeting" fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse
emergere la richiesta di una tregua in Ucraina sarà "inaccettabile perché
l'unica cosa" che significherebbe a "ratificare le conquiste fatte fino a oggi
dalla Russia" e "concedere più tempo a Putin". Lo ribadisce il portavoce della
Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, a Fox
20:26
Moldavia: "Misure
restrittive contro 25 perone coinvolte nell'invasione ucraina"
Le autorità moldave
introdurranno misure restrittive contro 25 persone coinvolte nell'invasione
ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando il ministero degli esteri di Chisinau,
Nicu Popescu, che ha annunciato la presenza di russi tra coloro che verranno
colpiti, "circa la metà" del totale. "Si tratta principalmente del divieto di
ingresso in Moldavia, del blocco dei conti bancari o dei beni di coloro che sono
coinvolti nell'aggressione all'ucraina", ha dichiarato Popescu. Secondo il
ministro, la decisione è già stata presa, ma ci vorrà tempo per completare
"tutti i passaggi legali". I nomi delle persone coinvolte non sono ancora stati
divulgati.
20:56
Zelensky: "Il
mandato di arresto di Putin è una svolta"
Per il presidente
Volodymyr Zelensky il mandato di arresto da parte della Corte penale
internazionale per il presidente russo Vladimir Putin è un punto di svolta. ha
definito un punto di svolta. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il discorso
serale del presidente ucraino. "Questa settimana ha finalmente portato un
risultato legale internazionale davvero significativo per l'Ucraina - ha detto
Zelesnky -, c'è un mandato della Corte penale internazionale per l'arresto del
leader della Russia, e questo è un punto di svolta". Per il presidente ucraino
grazie a questo strumento, quando finirà l'invasione, si dimostrerà tutta la
responsabilità di Mosca: "Per ogni attacco contro l'Ucraina, per ogni vita
distrutta, per ogni bambino ucraino deportato. E, naturalmente, per ogni
manifestazione di destabilizzazione mondiale derivante dall'aggressione russa".
21:34
Arriva Xi Jinping a
Mosca e Putin scrive sul sito del Cremlino: "La nostra partnership è speciale"
Arriva Xi Jinping a
Mosca e Putin scrive sul sito del Cremlino: "Xi è un buon vecchio amico. La
nostra partnership è speciale. Ci aspettiamo un importante implemento delle
nostre relazioni, che sono già a un punto altissimo. Parleremo di tutti: non ci
sono limiti o argomenti proibiti". Non solo. Il presidente russo ha scritto pure
che "i nostri rapporti commerciali si amplieranno. Il giro d'affari varrà più di
200 miliardi di dollari". Per quel che riguarda la politica estera, poi:
"Combatteremo insieme le minacce comuni". Aggiungendo pure che "la volontà
cinese di giocare un ruolo decisivo nel risolvere la questione ucraina è la
benvenuta".
23:37
Xi Jinping: "Via
d'uscita dalla crisi possibile se garantiamo sicurezza comune"
"Siamo convinti che
una via d'uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace
duratura e la sicurezza universale nel mondo saranno trovati se tutti saranno
guidati dal concetto di sicurezza comune, integrata, congiunta e sostenibile,
continuando il dialogo e le consultazioni in modo equo, prudente e pragmatico".
Ad affermarlo è il presidente cinese, Xi Jinping in un articolo pubblicato da
'Rossijskaja Gazeta'.
La Repubblica.
Colloquio Putin-Xi di 4 ore e mezzo. Il presidente cinese arriva da Putin
preceduto da una serie di articoli in cui si propone per un ruolo di mediazione:
"Nessun Paese ha diritto di dettare l'ordine mondiale, serve l'idea di sicurezza
collettiva". La Cpi a Putin: "Rimpatri i bambini"
È il giorno di Xi a
Mosca. Il presidente cinese si fa precedere da articoli sulla stampa russa in
cui invoca la sicurezza collettiva e avverte che nessun Paese può dettare
l'ordine mondiale. Putin, da parte sua, dichiara che Mosca e Pechino "stanno
combattendo minacce comuni". L'incontro tra il presidente cinese e quello di
Mosca avviene all'indomani del viaggio di Putin a Mariupol, il primo nel
Donbass. Una visita che ha provocato l'ira di Kiev: "Cinico e senza rimorso".
Zelensky, intanto, preferisce concentrarsi sul mandato di arresto per il leader
russo: "È un punto di svolta". Mentre Varsavia avverte: "Se l'Ucraina non
riuscirà a difendere la propria indipendenza, entreremo nel conflitto".
Intanto a Bruxelles,
il piano europeo per dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è stato
approvato dal Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportano fonti
diplomatiche. Il Consiglio ha dato l'ok politico ma per i dettagli si continuerà
a discutere in altri "gruppi di lavoro".
Continua lo scambio
di accuse tra Occidente e Russia sulla decisione della Cpi di spiccare un
mandato di arresto contro Putin. Il vicepresidente ìdel consiglio di sicurezza
di Mosca, Dmitry Medvedev prevede "conseguenze mostruose per il diritto penale
internazionale".
Punti chiave
19:31
Concluso il
colloquio Putin-Xi: è durato 4 ore e mezzo
16:11
La Cpi a Putin: "Se
c'è verità rimpatri i bambini"
16:04
Ucraina: "Grati
all'Ue per fornitura munizioni d'artiglieria"
15:28
Xi a Putin: "Con te
alle prossime presidenziali"
15:24
Ucraina, la Casa
Bianca: "Un appello per un cessate il fuoco non farebbe che ratificare
l'occupazione russa"
15:15
Putin chiama Xi
"caro amico" e si congratula
14:59
Xi: "Putin caro
amico, nostri paesi abbiano rapporti stretti"
14:51
Russia, Putin:
"Guardiamo con interesse alle proposte della cina per risolvere la crisi in
Ucraina"
12:42
Russia apre
procedimento penale contro Cpi
11:47
Ucraina, Zelensky:
"La difesa dell'Ucraina garantirà la pace"
11:42
Xi, "la Cina e la
Russia sono partner affidabili"
11:23
Xi scende dall'aereo
a Mosca: "La Cina è pronta ad essere salvaguardare l'ordine mondiale insieme
alla Russia"
10:33
Russia, Peskov: "Il
Cremlino è tranquillo rispetto al mandato di cattura della Cpi"
10:23
Russia, Xi atterra a
Mosca. Peskov: "Putin lo informerà personalmente sulla posizione della russia
sulla guerra in Ucraina"
10:13
Vertice a Mosca, il
Ft: "Xi chiamerà Zelensky dopo aver parlato con Putin"
09:34
Russia, la garante
per l'infanzia Lvova-Belova: "Nessun bimbo separato dai genitori"
09:26
Russia, Medvedev:
"Si potrebbe tirare un missile sulla Corte penale internazionale"
09:23
Ucraina, Gb: "Di
recente progressi russi intorno ad Avdiivka"
08:56
La Cina ai giudici
dell'Aia: "Evitare i doppi standard"
08:53
Ucraina, L'Isw:
"Kiev ha buone possibilità per lanciare una controffensiva"
08:47
Russia, Medvedev:
"La decisione della Cpi su mandato di arresto a Putin avrà conseguenze mostruose
per diritto internazionale"
08:40
Zelensky: "Il
mandato di arresto per Putin è un puntodi svolta"
08:32
Pechino sul mandato
di arresto contro Putin: "La cina continuerà ad avere un ruolo oggettivo e
giusto sulla guerra in Ucraina"
04:29
Putin: "Noi e la
Cina combattiamo minacce comuni"
01:39
Xi: "Nessun Paese ha
il diritto di dettare l'ordine mondiale"
00:00
Zelensky: "Il
mandato di arresto per Putin è una svolta"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale, ha definito il mando
d'arresto per Putin - da parte della Corte penale internazionale - una
"decisione storica". Queste le sue parole: "È chiaro che alla fine di questa
aggressione la Russia dovrà assumersi le sue responsabilità. Responsabilità per
ogni colpo all'Ucraina, per ogni vita rovinata, per ogni bambino ucraino
deportato... E, naturalmente, per ogni manifestazione della destabilizzazione
del mondo, che è stata il risultato dell'aggressione russa".
00:09
Xi: "Dialogo
paritario verso la pace"
L'arrivo di Xi
Jinping a Mosca è preceduto da un articolo apparso su Ria Novosti e Rossiyskaya
Gazeta. "I problemi complessi non hanno soluzioni semplici - dice il presidente
cinese - siamo convinti che si troverà una via d'uscita razionale dalla crisi
ucraina e la strada verso una pace duratura e una sicurezza globale nel mondo se
tutti saranno guidati dal concetto di comune, globale, congiunto e sostenibile
sicurezza". E chiede di continuare il dialogo e le consultazioni in modo
paritario, prudente e pragmatico".
01:00
Xi: la guerra finirà
solo con un'idea di sicurezza collettiva
"La risoluzione del
conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del
concetto di sicurezza collettiva". E' uno dei passaggi del messaggio di Xi
Jinping sulla Rossiyskaya Gazeta prima del suo incontro con Vladimir Putin (e un
articolo 'parallelo' è stato pubblicato sul Quotidiano del popolo cinese). Per
Xi, il cui articolo è citato dalla Tass, "la comunità internazionale ha capito
che nessuna potenza globale è superiore a tutte le altre".
01:39
Xi: "Nessun Paese ha
il diritto di dettare l'ordine mondiale"
Nell'intervista al
quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta ripresa dall'agenzia Tass, Xi dice che
"nessun paese nell'arena globale ha il diritto di avere l'ultima parola nel
determinare l'ordine mondiale esistente".
03:48
Nuovi fondi per
finanziare la Cpi
Oggi, in una
conferenza internazionale dei ministri della Giustizia che si terrà a Londra,
diversi Paesi dovrebbero annunciare la mobilitazione di risorse aggiuntive per
sostenere le indagini della Corte penale internazionale (Cpi) sui presunti
crimini di guerra in Ucraina. Più di 40 i Paesi invitati. Londra ha già
annunciato un finanziamento aggiuntivo di quasi 400.000 sterline (452.000 euro),
portando il suo sostegno totale a 1 milione di sterline (1,13 milioni di euro)
dallo scorso anno.
04:29
Putin: "Noi e la
Cina combattiamo minacce comuni"
Il presidente
Vladimir Putin, nel giorno dell'arrivo a Mosca del suo omologo Xi Jinping, ha
scritto un articolo per il Quotidiano del Popolo, definendo la missione di Xi un
"evento storico" che "riafferma la natura speciale del partenariato
Russia-Cina". Per Putin, Russia e Cina stanno combattendo "minacce comuni", il
loro rapporto diventa "costantemente più forte" ed è al "livello più alto della
loro storia".
06:32
Il presidente ceco
Pavel: "Kiev lanci la controffensiva o sarà tardi"
L'Ucraina deve
lanciare la sua controffensiva entro i prossimi mesi, ha detto il presidente
ceco Petr Pavel in un'intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita ripresa
dai media di Kiev. "La finestra di opportunità è aperta quest'anno. Dopo il
prossimo inverno sarà estremamente difficile mantenere l'attuale livello di
assistenza - ha detto Pavel -. La fatica della guerra non è solo l'esaurimento
delle risorse umane e delle attrezzature e la distruzione delle infrastrutture
in Ucraina, ma anche la stanchezza nei paesi che forniscono aiuti". Parole che
suonano come un avvertimento.
07:41
Kiev: "Mosca vuole
impadronirsi di nuovi territori"
La Russia punta ad
impadronirsi di nuovi territori in Ucraina per creare zone cuscinetto a
protezione delle aree occupate: lo ha detto il comandante delle forze congiunte
delle forze armate ucraine, Sergiy Naev, in un'intervista a RBC-Ucraina. "In
futuro, l'aggressore vuole impadronirsi di nuovi territori per creare zone
cuscinetto al fine di garantire 'sicurezza' ai territori occupati dell'Ucraina
già 'inclusi nella Federazione Russa'", ha aggiunto Naev.
08:32
Pechino sul mandato
di arresto contro Putin: "La cina continuerà ad avere un ruolo oggettivo e
giusto sulla guerra in Ucraina"
"La Cina continuerà
ad avere un ruolo corretto e oggettivo sulla guerra in Ucraina", il ministero
degli Esteri cinese ha reagito con queste parole al mandato di arresto
internazionale della Corte dell'Aia contro il presidente russo Vladimir Putin.
La presa di posizione laconica è stata pronunciata mentre il presidente Xi è
atteso a Mosca per una storica visita destinata a sancire l'alleanza tra le due
potenze.
08:40
Zelensky: "Il
mandato di arresto per Putin è un puntodi svolta"
Il mandato di
arresto per il Presidente russo Vladimir Putin, emesso dalla corte penale
internazionale dell'aia, è un "risultato giuridico internazionale veramente
significativo" e "un punto di svolta". Lo ha detto il presidente ucraino
Voldymyr Zelensky nel suo messaggio ieri notte.
08:47
Russia, Medvedev:
"La decisione della Cpi su mandato di arresto a Putin avrà conseguenze mostruose
per diritto internazionale"
Medvedev ha
nuovamente attaccato la decisione della Corte penale internazionale (Cpi) di
spiccare un mandato di arresto internazionale per il presidente Vladimir Putin
per crimini di guerra con l'accusa di aver fatto deportare bambini ucraini nella
Federazione. "Hanno deciso di processare un presidente di una potenza nucleare
che non partecipa alla Cpi per gli stessi motivi degli Stati Uniti e di altri
Paesi. Le conseguenze per il diritto internazionale saranno mostruose.
Dopotutto, questo è il crollo delle fondamenta, dei principi del diritto", ha
scritto l'attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.
08:53
Ucraina, L'Isw:
"Kiev ha buone possibilità per lanciare una controffensiva"
L'offensiva della
Russia nel Donbass potrebbe avvicinarsi al suo apice e l'Ucraina "ha buone
possibilitò per riprendere l'iniziativa e lanciare una controffensiva". Gli
analisti dell'American Institute for the Study of War (ISW) sono giunti a questa
conclusione. Secondo le loro stime, il ritmo delle operazioni offensive delle
forze russe è rallentato nelle ultime settimane, e questo indica che l'offensiva
di primavera della Russia nel Donbas potrebbe avvicinarsi al culmine. Nel
frattempo, rileva il think thank Usa, le forze armate ucraine hanno
probabilmente condotto un contrattacco locale a sud-ovest di Bakhmut, vicino
all'insediamento di Ivanivske, allargando così il corridoio tra Bakhmut e altri
territori controllati da Kiev nella regione di Donetsk. Inoltre, significative
perdite di truppe russe nell'area di Vugledar indeboliscono seriamente il
potenziale offensivo di Mosca nella regione di Donetsk.
08:56
La Cina ai giudici
dell'Aia: "Evitare i doppi standard"
Pechino ha
esortato i giudici della Corte penale internazionale (Cpi) a non applicare "due
pesi e due misure", dopo il mandato di arresto internazionale spiccato nei
confronti del presidente russo Vladimir Putin, accusato di crimini di guerra per
la deportazione di bambini ucraini.
09:17
Ucraina, Kiev:
"Uccisi oltre 165mila soldati russi da inizio conflitto"
Lo stato maggiore
delle forze armate di Kiev ha riferito che la Russia ha perso 165.610 soldati in
Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala il 24 febbraio dello
scorso anno. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 700. La Russia ha perso
anche 3.537 carri armati, 6.869 veicoli corazzati da combattimento, 5.416
veicoli e serbatoi di carburante, 2.577 sistemi di artiglieria, 507 sistemi di
razzi a lancio multiplo, 270 sistemi di difesa aerea, 305 aeroplani, 290
elicotteri, 2.160 droni e 18 imbarcazioni.
09:23
Ucraina, Gb: "Di
recente progressi russi intorno ad Avdiivka"
La situazione per le
forze ucraine a difesa di Avdiivka, a un centinaio di km da Bakhmut, è sempre
più difficile: "Nelle ultime tre settimane, le forze russe hanno ottenuto
progressi intorno alla città del Donbass" che "è ora in gran parte distrutta".
Lo riporta il bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sul conflitto
in Ucraina, sottolineando che "le linee di rifornimento verso ovest" dei soldati
ucraini "sono sempre più minacciate dall'operazione di accerchiamento russo".
09:26
Russia, Medvedev:
"Si potrebbe tirare un missile sulla Corte penale internazionale"
"È del tutto
possibile immaginare l'uso mirato di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una
nave russa verso il tribunale dell'Aia". E' l'ultima provocazione lanciata su
Telegram dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev,
dopo il mandato di arresto chiesto per Vladimir Putin dalla Corte penale
internazionale dell'Aia. "Il tribunale è solo una miserabile organizzazione
internazionale, non la popolazione di un paese della Nato", aggiunge
sottolineando che, a suo dire, in questo scenario la guerra "non inizierebbe".
09:34
Russia, la garante
per l'infanzia Lvova-Belova: "Nessun bimbo separato dai genitori"
"Ad oggi, 380
orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso
famiglie russe. Erano in istituti di assistenza. Nessuno è stato separato dai
genitori". Lo ha dichiarato parlando a Soloviev, in diretta, Maria Lvova-Belova,
la Garante per l'infanzia russa per la quale la Corte internazionale penale ha
emesso un mandato di arresto (insieme con il presidente Putin) con l'accusa di
deportazione di minori ucraini. "Se ci sono rappresentanti legali, faremo il
possibile per riunire le famiglie", ha aggiunto spiegando che oggi 15 bambini
evacuati in Russia si sono riuniti ai parenti ucraini.
10:10
Ucraina, Kiev:
"Avdiivka e Kramatorsk sotto il fuoco russo"
Le forze russe hanno
bombardato questa mattina la città ucraina di Avdiivka, nel Donetsk (est), dopo
aver attaccato la notte scorsa la città di Kramatorsk, a un centinaio di
chilometri a nord: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione
militare regionale, Pavel Kirilenko, che ha parlato di danni alle case e
nell'area dove sorge l'impianto chimico Avdiivka Coke and Chemical Plant (AKHZ).
"Nel cuore della notte, i russi hanno lanciato un attacco missilistico
su Kramatorsk, ci sono case danneggiate, ma secondo le informazioni preliminari,
nessuna vittima", ha scritto Kirilenko aggiungendo che Avdiivka è stata colpita
questa mattina dall'artiglieria e dai sistemi a lancio multiplo Grad di Mosca.
"Ci sono danni su due strade e sul territorio dell'AKHZ", ha aggiunto il
governatore. Si registrano, inoltre, attacchi russi a Bakhmut e Konstantinovka,
dove una persona è rimasta ferita.
10:13
Vertice a Mosca, il
Ft: "Xi chiamerà Zelensky dopo aver parlato con Putin"
Il presidente cinese
Xi Jinping potrebbe chiamare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky dopo i
colloqui a Mosca con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo scrive il
Financial Times citando fonti ben informate secondo le quali "è probabile che il
leader cinese chiami il presidente ucraino". E "Zelensky senza dubbio risponderà
a quella chiamata", prosegue la fonte, sottolineando che "Xi ha un'enorme
influenza su Putin". "Dopo un viaggio a Mosca, Xi potrebbe chiamare Zelensky",
ha scritto il giornale citando una fonte a condizione di anonimato.
10:23
Russia, Xi atterra a
Mosca. Peskov: "Putin lo informerà personalmente sulla posizione della Russia
sulla guerra in Ucraina"
Il presidente cinese
Xi Jinping è atterrato a Mosca. Il portavoce presidenziale Peskov ha garantito
che Putin "in prima persona" darà a Xi Jinping una spiegazione della posizione
della Federazione Russa sull'Ucraina.
10:33
Russia, Peskov: "Il
Cremlino è tranquillo rispetto al mandato di cattura della Cpi"
Il Cremlino è
tranquillo rispetto al mandato d'arresto internazionale spiccato dalla Corte
penale internazionale (Cpi) contro il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha
affermato il portavoce Dmitri Peskov, sottolineando che "il presidente continua
a lavorare". Mosca, ha aggiunto, "registra attentamente" simili "manifestazioni
ostili contro il nostro Paese e il nostro presidente".
10:36
Ucraina, Borrell:
"Senza accordo sulle munizioni saremo in difficoltà"
"Nel pomeriggio
avremo la riunione jumbo, insieme ai ministri della Difesa. I ministri degli
Affari esteri e della Difesa insieme spero che arrivino alla conclusione
dell'accordo per fornire munizioni all'Ucraina. Ci sono tre percorsi per fornire
munizioni per circa 2 miliardi di euro, per permettere agli ucraini di
difendersi. Spero che i ministri si impegnino in una discussione finale e
raggiungano l'accordo, su quella che è una decisione molto importante, per
questo pomeriggio. Altrimenti ci troveremo in difficoltà nel continuare a dare
armi all'Ucraina". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la politica
estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
10:40
L'aereo di Xi
atterra a Mosca: più di 100.000 persone hanno seguito la rotta su Flightradar
L'aereo del
presidente cinese Xi Jinping sarebbe atterrato a Mosca. Lo riporta Ria Novosti.
Quello del leader cinese era al primo posto tra i voli più monitorati al mondo
sul sito Flightradar. Più di 100mila persone hanno seguito il Boeing 747 di Air
China.
10:44
Ucraina, Borrell:
"La decisione dell'Aja su Putin è una svolta"
"La decisione della
Corte Penale internazionale è una svolta: so che le autorità russe stanno
diminuendo l'importanza, poiché la Russia non partecipa allo statuto di Roma. Ma
vediamo le conseguenze pratiche: se Vladimir Putin viaggia in in uno degli oltre
130 Paesi firmatari, dovrebbe essere subito arrestato. Possiamo negoziare quel
che si vuole ma questa decisione resta valida". Lo ha detto l'alto
rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al consiglio
affari esteri-difesa.
11:04
Russia, Peskov: "Gli
Usa impediscono la riduzione delle ostilità"
Il Cremlino ha
accusato gli Stati Uniti di alimentare il conflitto in Ucraina nel giorno della
visita di Stato a Mosca del presidente cinese, Xi Jinping. "Gli Stati Uniti
restano sulle loro posizioni di continuare a provocare il conflitto, di
ostacolare una riduzione dell'intensità delle ostilità e di continuare a
inondare l'Ucraina di armi", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry
Peskov, durante un punto stampa.
11:23
Xi scende dall'aereo
a Mosca: "La Cina è pronta ad essere salvaguardare l'ordine mondiale insieme
alla Russia"
"La Cina è pronta a
salvaguardare l'ordine mondiale insieme alla Russia", con queste parole il
leader cinese Xi Jinping ha inaugurato la sua attesa visita ufficiale a Mosca
poco fa. Xi si è detto "fiducioso" che la visita sarà fruttuosa.
11:29
Ucraina, Francia:
"Mosca attacca i civili, fornire munizioni a Kiev"
"La Russia continua
la sua campagna di attacchi indiscriminati contro obiettivi civili e dunque
dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi" e perciò "discuteremo
della proposta dell'Alto rappresentante per l'utilizzo dell'European peace
facility per accelerare la fornitura di munizioni all'Ucraina, consentire gli
acquisti congiunti e rinforzare la capacità di produzione dell'Unione europea".
Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, al suo
arrivo al Consiglio Ue Esteri.
11:42
Xi, "la Cina e la
Russia sono partner affidabili"
"La Cina e la
Russia sono buoni vicini e partner affidabili". Lo ha detto il presidente cinese
Xi Jinping al sul arrivo a Mosca, citato dall'agenzia Ria Novosti.
11:46
Xi, 'A Mosca per
sviluppare interazione strategica'
Il presidente cinese
Xi Jinping ha detto che durante la sua visita a Mosca sarà varato un piano "per
lo sviluppo dell'interazione strategica e la cooperazione pratica" con la
Russia. Lo riferisce Ria Novosti.
11:47
Ucraina, Zelensky:
"La difesa dell'Ucraina garantirà la pace"
"Quando il popolo
ucraino si difende, quando la forza della Carta delle Nazioni Unite e la forza
della giustizia sono ripristinate sulla nostra terra, ciò garantirà la pace
anche per molte altre parti del mondo". E' il messaggio postato su Telegram dal
presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre a Mosca è arrivato il presidente
cinese Xi Jinping per colloqui con il leader russo Vladimir Putin.
11:59
Xi, "con Russia
pronti a salvaguardare ordine mondiale"
"La Cina è pronta,
insieme con la Russia, a salvaguardare l'ordine mondiale basato sul diritto
internazionale". Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, arrivando a
Mosca per una visita ufficiale che durerà fino a mercoledì. "La Cina e la Russia
hanno relazioni di buon vicinato e sono reciprocamente partner affidabili", ha
aggiunto Xi, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. La Cina, ha proseguito Xi,
"è Cina è pronta con la Russia a sostenere risolutamente il sistema
internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, a difendere l'ordine mondiale
basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni
internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni
Unite, a sostenere il vero multilateralismo, promuovere il multipolarismo nel
mondo e democratizzare le relazioni internazionali, promuovere lo sviluppo della
governance globale in una direzione più giusta e razionale". "Sono molto lieto
di tornare, su invito del presidente Vladimir Putin, nella terra del nostro
vicino per una visita di Stato. A nome del governo e del popolo cinese, esprimo
sinceri saluti e auguri al governo e al popolo della Russia", ha aggiunto Xi,
secondo quanto si legge sul sito dell'agenzia Tass.
12:26
Cina: "Armi a Mosca?
Usa smettano di soffiare sul fuoco"
"Gli Stati Uniti
dovrebbero smettere soffiare sul fuoco" e "svolgere un ruolo costruttivo sulla
crisi in Ucraina, non il contrario". Si è espresso così il portavoce del
ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, nel giorno della visita del
leader cinese Xi Jinping in Russia. "Non è la Cina, ma sono gli Usa - ha
affermato secondo le dichiarazioni riportate dal Global Times - a fornire armi
sul campo di battaglia del conflitto tra Russia e Ucraina".
12:42
Russia apre
procedimento penale contro Cpi
La Russia ha avviato
un procedimento penale contro il procuratore e i giudici della Corte penale
internazionale, dopo che è stato emanato il mandato d'arresto nei confronti del
presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, la commissaria per
l'infanzia del governo russo.
12:56
Mosca, senza
progressi stop intesa grano a maggio
Se non ci saranno
progressi nell'attuazione dell'accordo per l'export del grano ucraino attraverso
il Mar Nero, Mosca lo sospenderà il 18 maggio, allo scadere dei due mesi di
estensione. E' l'avvertimento lanciato dal ministero degli Esteri russo. In
particolare, nella nota, tra i temi sui quali le autorità russe vogliono vedere
un avanzamento ci sono "la riconnessione di Rosselkhozbank al sistema Swift, la
ripresa delle spedizioni e manutenzioni di macchine agricole e ricambi,
l'abolizione dei vincoli assicurativi e riassicurativi nonchè la revoca del
divieto di accesso ai porti, la ripresa dell'operatività del gasdotto
Togliatti-Odessa e lo sblocco delle attività e conti esteri di società russe
relative alla produzione e al trasporto di generi alimentari e fertilizzanti".
12:59
Putin, oggi Russia
deve produrre quello che comprava ieri
L'obiettivo
principale del nemico è scuotere dall'interno la società russa. Lo ha detto il
presidente Vladimir Putin parlando a una riunione al ministero dell'Interno.
Putin ha affermato che "le provocazioni, le manifestazioni di strada illegali o
ogni altro tentativo di creare sconvolgimento nella società deve essere
represso". "La nostra economia deve affrontare molte sfide, inclusa la
sostituzione delle importazioni. Lo facciamo ogni giorno. Quello che potevamo
ancora comprare ieri, oggi dobbiamo produrlo da soli", ha detto Putin, secondo
quanto riporta Ria Novosti.
13:08
Xi accolto a Mosca
da vicepremier, ai colloqui anche Medvedev e Nabiullina
Da Dmitry
Medvedev a Elvira Nabiullina, il Cremlino rende noto chi parteciperà agli
incontri tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi
Jinping. Il presidente cinese è arrivato stamani a Mosca, accolto all'aeroporto
Vnukovo dal vicepremier Dmitry Chernyshenko, come evidenzia la Cnn. Intanto il
Cremlino ha diffuso un elenco delle personalità russe che saranno presenti agli
incontri di domani tra Putin e Xi, stando a quanto riporta l'agenzia Ria
Novosti che cita il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. Tra i
nomi - oltre a quelli del vice presidente del Consiglio di sicurezza della
Federazione Russa e della governatrice della Banca centrale - ci sono quelli dei
ministri di Esteri e Difesa, Sergei Lavrov e Sergei Shoigu, dello stesso
vicepremier Chernyshenko, del capo dell'agenzia spaziale Roscosmos, Yuri
Borisov, e del direttore del Servizio federale per la cooperazione
tecnico-militare, Dmitry Shugaev. Ai colloqui "in formato allargato", stando
alla Ria Novosti, parteciperanno "anche sei vice premier", il consigliere
presidenziale Maxim Oreshkin, i ministri per lo Sviluppo economico, Maxim
Reshetnikov, dei Trasporti, Vitaly Savelyev, e delle Finanze, Anton Siluanov, e
il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev.
13:13
Putin: "Se non
estendiamo accordo grano, lo invieremo gratuitamente all'Africa"
Il presidente
russo, Vladimir Putin, ha detto che se non estenderanno l'accordo sul grano la
Russia lo invierà gratuitamente all'Africa. "La Russia sta aiutando i paesi
africani con cibo ed energia", ha detto il presidente russo.
13:24
"Non è vero", il
grido sullo sfondo del video di Putin a Mariupol
"Non è vero! è tutto
uno show". Il grido, con una voce di donna, si sente sullo sfondo del video
propagandistico della visita del presidente russo Vladimir Putin ieri a
Mariupol, diffuso dal servizio stampa del Cremlino e l'agenzia Ria Novosti. A
farlo notare sono diversi canali Telegram russi e ucraini, racconta oggi il sito
indipendente russo Meduza. Le parole della donna, che si sentono in lontananza,
non sono chiarissime. Ma dopo il suo grido si vedono distintamente gli uomini
della sicurezza che si guardano intorno e parlottano fra loro. Intanto Putin
continua a parlare con un gruppetto di presunti abitanti. Secondo quanto scrive
su Twitter Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, una
delle agenzie stampa russe ha tagliato la scena, ma l'altra no.
13:28
Kiev esorta Xi a
usare influenza per fermare guerra
Kiev ha esortato il
presidente cinese Xi Jinping, a Mosca per colloqui con il leader russo Vladimir
Putin, a usare la sua l'influenza per fermare la guerra. "L'Ucraina sta seguendo
da vicino la visita del presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino
usi la sua influenza su Mosca per porre fine alla guerra aggressiva contro
l'Ucraina", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg
Nikolenko.
13:46
Putin: se accordo su
grano non rinnovato, invieremo cereali gratis in Africa
Il presidente
russo Vladimir Putin ha promesso lunedì di consegnare gratuitamente cereali
all'Africa se l'accordo sulle esportazioni ucraine non sarà rinnovato entro due
mesi, dopo la proroga annunciata sabato dal suo omologo turco Recep Tayyip
Erdogan. "Se alla fine decidiamo di non prorogare questo accordo entro 60
giorni, allora siamo pronti a consegnare gratuitamente dalla Russia tutto il
volume che è stato destinato ultimamente ai Paesi più bisognosi dell'Africa", ha
detto durante un discorso a Mosca ai funzionari africani.
13:53
Fonti, approvato il
piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev
Il piano europeo per
dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è stato approvato dal Consiglio
Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportano fonti diplomatiche. Il
Consiglio ha dato l'ok politico ma per i dettagli si continuerà a discutere in
altri "gruppi di lavoro".
14:22
Putin, relazioni con
Africa una priorità
Il raffrorzamento
delle relazioni tra la Russia e l'Africa è un obiettivo chiave per il Cremlino.
Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin. "Consentitemi di sottolineare
che il nostro Paese ha sempre dato - e continuerà a dare - priorità alla
cooperazione con gli stati africani", ha detto Putin in un discorso televisivo
durante una conferenza sulle relazioni russo-africane. La Russia è uno dei
principali esportatori di armi in Africa.
14:33
Xi a Mosca: Casa
Bianca, seguiamo visita molto da vicino
La Casa Bianca sta
seguendo l'incontro a Mosca fra Vladimir Putin e Xi Jinping "molto, molto da
vicino".
Lo ha detto
alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby,
sottolineando che "un appello al cessate il fuoco in Ucraina in questo momento
fondamentalmente ratificherebbe solo la conquista della Russia e darebbe a Putin
più tempo per attrezzarsi, riqualificarsi e riavviare le operazioni in un
momento e in un luogo di sua scelta".
14:36
Xi Jinping arrivato
al Cremlino
Il leader cinese Xi
Jinping è arrivato al Cremlino per l'incontro informale con Putin
14:39
Estonia, 1 milione
di munizioni da 155mm a Kiev entro 1 anno
"L'Ucraina ha
bisogno di avere un milione di proiettili di artiglieria da 155mm entro un anno.
L'accordo politico di oggi dimostra che se c'è la volontà si trova un modo. Ora
tocca ai funzionari mettere a punto i dettagli, per noi è importante che
l'Ucraina riceva aiuto il prima possibile". Lo ha detto Hanno Pevkur, Ministro
della Difesa estone.
14:43
Xi-Putin, al via
l'incontro
È cominciato al
Cremlino un incontro informale faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir
Putin e cinese Xi Jinping. Lo rende noto l'agenzia Ria Novosti. I colloqui
continueranno durante una cena di lavoro.
14:45
Putin a Xi: la Cina
ha fatto un grande balzo in avanti
"Siamo leggermente
invidiosi del rapido sviluppo della Cina", ha detto il presidente russo Putin
accogliendo il suo omologo cinese Xi Jinping al Cremlino. "In Cina sei riuscito
a rendere più forte lo Stato. La Cina ha fatt un grande salto in avanti".
14:51
Russia, Putin:
"Guardiamo con interesse alle proposte della cina per risolvere la crisi in
Ucraina"
"Guardiamo con
interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina": lo ha
detto il presidente russo Vladimir Putin a quello cinese Xi Jinping all'inizio
del loro incontro al Cremlino.
14:59
Xi: "Putin caro
amico, nostri paesi abbiano rapporti stretti"
Il presidente
cinese Xi Jinping ha definito nell'incontro al Cremlino il presidente russo
Putin "un caro amico". "I nostri paesi devono avere stretti rapporti", ha
affermato Xi, come riporta Ria Novosti.
15:02
Putin a Xi: "Piano
cinese fondato su principi di giustizia e diritto internazionali"
Nell'incontro con Xi
Jinping oggi al Cremlino, Vladimir Putin ha affermato di aver letto attentamente
le proposte della Cina per il superamento della crisi in Ucraina. "Sappiamo che
procedi dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del
diritto internazionale", ha detto Putin, secondo quanto ha riportato Ria
Novosti.
15:15
Putin chiama Xi
"caro amico" e si congratula
"Caro signor
presidente, caro amico, benvenuto in Russia, a Mosca. Sono lieto di avere
l'opportunità di congratularmi personalmente per la rielezione a capo dello
Stato cinese". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, all'inizio
dell'incontro informale con il presidente cinese Xi Jinping al Cremlino, a
Mosca, come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. I due avranno poi un
incontro formale domani.
15:24
Ucraina, la Casa
Bianca: "Un appello per un cessate il fuoco non farebbe che ratificare
l'occupazione russa"
"Un appello per un
cessate il fuoco in questo momento non farebbe che ratificare l'occupazione
della Russia e darebbe a Putin più tempo per equipaggiarsi, prepararsi e
ricominciare le operazioni in un momento e un luogo a sua scelta". Lo ha detto
alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa
Bianca John Kirby nel primo giorno della visita del leader cinese Xi Jinping a
Mosca, un viaggio che l'Amministrazione Biden "segue molto, molto attentamente".
Gli Stati Uniti, ha detto, "respingerebbero" qualsiasi appello a un cessate il
fuoco che possa scaturire dalla visita di Xi a Mosca. E, ha insistito, i
rapporti tra Russia e Cina sono "un matrimonio d'interesse".
15:26
Russia, Xi: "Pronti
a salvaguardare ordine globale"
"La Cina è pronta,
insieme con la Russia, a salvaguardare l'ordine mondiale basato sul diritto
internazionale". Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, arrivando a
Mosca per una visita ufficiale che durerà fino a mercoledì. "La Cina e la Russia
hanno relazioni di buon vicinato e sono reciprocamente partner affidabili", ha
aggiunto Xi, secondo quanto riporta l'agenzia Tass
15:28
Xi a Putin: "Con te
alle prossime presidenziali"
Nel corso del
colloquio con Valdimir Putin a Mosca, il presidente cinese, Xi Jinping, si è
detto "sicuro" che il popolo russo sosterrà il leader del Cremlino alle elezioni
presidenziali del prossimo anno. "So che l'anno prossimo ci sarà un'altra
elezione presidenziale nel tuo Paese. Grazie alla sua forte leadership, negli
ultimi anni la Russia ha compiuto progressi significativi nel raggiungere la
prosperità", ha detto Xi.
15:29
Usa, Casa Bianca:
"Xi dovrebbe parlare al telefono con Zelensky"
"Se vai a Mosca e ti
siedi per tre giorni allo stesso tavolo del presidente Putin e ascolti il suo
punto di vista su una guerra che ha iniziato e che potrebbe finire oggi,
dovresti come minimo alzare il telefono e parlare anche con il presidente
Zelensky per avere il suo punto di vista", ha detto alla Cnn il portavoce del
Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, assicurando che la Casa Bianca sta
seguendo l'incontro a Mosca fra Xi e Vladimir Putin "molto, molto da vicino".
15:47
Ucraina, la russia
cessa la rottamazione di armi sovietiche
La Russia ha smesso
la rottamazione di vecchie armi sovietiche dopo l'inizio dell'invasione in
Ucraina nel febbraio 2024. Lo scrive Moscow Times, basandosi sull'esame dei
contratti firmati dal ministero della difesa russa. Secondo fonti del sito,
molte di queste vecchie armi vengono ora mandate al fronte, per sopperire alla
mancanza di armamenti. Fra il 2024 e il 2022, il ministero ha speso 4,7 miliardi
di rubli oltre 100 milioni di dollari) per smantellare armi e munizioni
obsolete, compresi vecchi missili. Ma l'ultimo contratto, per la dismissione di
proiettili d'artiglieria, risale al gennaio 2022, un mese prima dell'invasione.
16:04
Ucraina: "Grati
all'Ue per fornitura munizioni d'artiglieria"
L'Ucraina ha
salutato lo stanziamento di 2 miliardi di euro da parte dell'Ue per l'acquisto e
la consegna di munizioni di artiglieria alle forze di Kiev come una "forte
misura per la sicurezza europea". "Siamo grati all'Ue. Questa è una misura molto
forte per proteggere la sicurezza europea", ha dichiarato su Twitter il capo
dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andrey Yermak.
16:07
Il leader della
Wagner Progozhin: "La Wagner non sia esclusa dal coordinamento dell'esercito"
Il capo mercenario
russo Yevgeny Prigozhin ha detto al ministro della Difesa Sergei Shoigu in una
lettera pubblicata lunedì che l'esercito ucraino stava pianificando un'offensiva
volta a tagliare le sue forze Wagner dal grosso delle truppe russe nell'Ucraina
orientale. Nella lettera pubblicata dal suo servizio stampa, Prigozhin afferma
che l'offensiva è prevista per la fine di marzo o l'inizio di aprile. Nel
documento Prigozhin invita il ministro della Difesa a prendere tutte le misure
necessarie affinchè la Wagner non sia tagliata fuori dall'esercito, perchè le
conseguenze sarebbero gravi.
16:11
La Cpi a Putin: "Se
c'è verità rimpatri i bambini"
"Se c'è un minimo
di apparenza di verità" nell'argomentazione di Mosca secondo cui il
trasferimento di bambini dall'Ucraina in Russia dall'inizio della guerra sarebbe
stato deciso a loro tutela, allora quei bimbi adesso devono "essere rimpatriati,
non dotati d'un passaporto straniero". È l'appello lanciato dal procuratore
della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan alla conferenza di Londra fra
i ministri della Giustizia dei circa 40 Paesi impegnati a sostenere le indagini
della Cpi sui crimini imputati ai russi. Khan ha precisato che il mandato di
arresto appena emesso contro Vladimir Putin non si prescriverà.
16:21
Ucraina, l'Ungheria
non parteciperà all'invio delle munizioni
L'Ungheria non
parteciperà alla fornitura di munizioni all'Ucraina, ma non si opporrà al piano
dell'Ue. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjrtó ,
in conferenza stampa a margine della riunione con i suoi omologhi dell'Ue. "Non
forniamo munizioni all'Ucraina, ma non impediremo ad altri di fare ciò che
vogliono in questo senso", ha spiegato il ministro, citato in un tweet da Zoltan
Kovacs, portavoce del premier magiaro, Viktor Orban.
16:28
Ucraina, Von der
Leyen: "Bene accordo su munizioni, aumentare la produzione"
"I soldati ucraini
stanno dimostrando grande coraggio e tenacia ma hanno bisogno di munizioni.
Accolgo con favore l'accordo odierno volto a consegnare 1 milione di munizioni
nei prossimi 12 mesi. Lavoreremo con gli Stati membri per aumentare la
produzione industriale della difesa nell'Unione europea da consegnare". Così la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.
16:31
Blinken, altri 350
milioni di aiuti militari a Kiev
Gli Stati Uniti
stanno autorizzando un altro pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del
valore di 350 milioni di dollari: lo ha annunciato il segretario di Stato
americano Antony Blinken. "Questo pacchetto di assistenza militare include altre
munizioni per gli Himars e Howitzers forniti dagli Stati Uniti che l'Ucraina sta
usando per difendersi, così come munizioni per i veicoli di fanteria da
combattimento Bradley, missili Harm, armi anticarro, imbarcazioni fluviali e
altre attrezzature", ha spiegato.
16:41
Wagner, controlliamo
il 70% di Bakhmut
Il capo del gruppo
russo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha assicurato che le sue forze
controllano il 70% della città orientale ucraina di Bakhmut. "Al momento, le
unità Wagner controllano circa il 70% della città di Bakhmut e stanno
continuando le operazioni per completare la liberazione della città", ha scritto
Prigozhin in una lettera aperta al ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu.
17:00
Borrell: "Daremo un
milione di munizioni a Kiev, accordo storico"
Il capo della
politica estera Ue saluta come "storico" l'accordo raggiunto oggi a Bruxelles
per la fornitura di un milioni di munizioni a Kiev, deciso al consiglio Ue dei
ministri degli Esteri. Si tratta di un piano da due miliardi. "Una decisione
storica. In seguito alla mia proposta, gli Stati membri hanno convenuto di
fornire un milione di munizioni d'artiglieria nei prossimi 12 mesi. Abbiamo un
approccio in tre fasi: 1) un miliardo di euro per la consegna immediata. 2) un
miliardo per un approvigionamento comune 2) la commissione aumenterà la capacità
di produzione", ha twittato Borrell.
17:02
Blinken, visita Xi a
Mosca ignora la decisione della Cpi
La visita di Xi
Jinping a Mosca dopo il mandato d'arresto della corte penale internazionale
dell'Aja suggerisce che la Cina non pensa che il Cremlino debba rispondere delle
sue responsabilità per le atrocità in Ucraina: lo ha detto il segretario di
stato Usa Antony Blinken.
17:15
Tajani, "dare
munizioni a Kiev, Parlamento sarà informato"
"Il tema è
consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha
l'autorizzazione del Parlamento a dare materiale militare fino alla fine
dell'anno e qualora si dovesse decidere di dare altro materiale bellico il
Parlamento sarà informato attraverso il Copasir". Lo ha detto il ministro degli
Esteri Antonio Tajani a Bruxelles.
17:43
Rapporto Usa, Mosca
ha commesso atrocità e crimini di guerra
Il rapporto sui
diritti umani realizzato quest'anno dal Dipartimento di Stato evidenzia i
crimini di guerra e altre atrocità commesse dalla Russia in Ucraina che hanno
provocato "massicce morti e distruzioni". E' quanto scrive il segretario di
Stato americano Antony Blinken nella prefazione del documento. "Ci sono state
segnalazioni credibili di esecuzioni sommarie, torture, stupri, attacchi
indiscriminati e attacchi deliberati contro civili e infrastrutture civili da
parte delle forze russe in Ucraina, che costituiscono tutti crimini di guerra.
Il governo russo si è impegnato nella deportazione forzata di civili
dall'Ucraina alla Russia, spesso a seguito di un processo di 'filtrazione' duro
e abusivo, e ci sono state numerose segnalazioni di deportazioni forzate e
adozioni di bambini dall'Ucraina", afferma il rapporto. Il documento viene
pubblicato pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un
mandato contro il presidente russo Vladimir Putin per un presunto piano di
deportazione di "migliaia" di bambini ucraini in Russia. Il sistema politico
autoritario della Russia è "dominato dal presidente Vladimir Putin", afferma il
documento del dipartimento di Stato, che però non traccia collegamenti specifici
tra Putin e i crimini di guerra commessi in Ucraina.
17:51
Norvegia consegna 8
Leopard
Le Norvegia ha
consegnato a Kiev otto tank Leopard 2, assieme a quattro veicoli di supporto. Lo
ha annunciato il ministro norvegese dalla Difesa, citato da Ukarainska pravda. I
tank sono stati portati con un aereo da trasporto An-124. La consegna è avvenuta
mentre è ancora in corso il relativo addestramento dei carristi in Polonia. Oslo
ha fornito anche fondi per l'acquisto di munizioni e parti di ricambio.
18:00
Ue, in settimana via
a nuovi aiuti per Kiev da 1,5 mld
L'Unione europea è
pronta ad erogare "questa settimana" una nuova tranche di aiuti da "1,5 miliardi
di euro" per Kiev come parte del pacchetto di assistenza macrofinanziaria per il
2023 concordato a dicembre. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione
Ue Valdis Dombrovskis in audizione al Parlamento europeo. Una prima tranche da 3
miliardi di euro era stata versata a gennaio. Tra i Paesi membri c'è "forte
consenso sulla necessità di continuare a sostenere l'Ucraina anche attraverso
l'assistenza macrofinanziaria", ha evidenziato Dombrovskis, ricordando che gli
aiuti erogati lo scorso anno a Kiev ammontano a 7,5 miliardi.
18:19
Prigozhin scrive a
Shoigu: "Kiev prepara l'offensiva, l'esercito ci aiuti"
Il capo dei
mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin ha scritto al ministro della Difesa russo
Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, ma anche per
chiedere aiuto in vista dell'offensiva su vasta scala che stanno preparando gli
ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche
dalla Tass.
"Attualmente, le
unità della Wagner controllano circa il 70% di Bakhmut e continuano l'offensiva
fino alla sua totale liberazione", scrive Prigozhin. "Secondo le informazioni
disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico prevede di iniziare una
offensiva su vasta scala", con il rischio che il gruppo Wagner venga separato
dall'esercito russo, continua Prigozhin, chiedendo a Shoigu d prendere le misure
necessarie impedire che ciò avvenga perché tale separazione avrebbe "conseguenze
negative per l'operazione militare speciale".
18:40
Sostegno dei Paesi
Ue alle indagini Cpi, l'Ungheria non firma
Ventisei Stati
membri dell'Ue, con l'unica firma mancante dell'Ungheria, in una dichiarazione
congiunta diffusa dalla presidenza svedese hanno espresso "supporto alla Corte
Penale Internazionale e alle indagini sulla situazione in Ucraina" in occasione
della conferenza dei ministri della Giustizia di circa 40 Paesi tenutasi a
Londra sul dossier. "Gli Stati membri dell'Ue hanno annunciato un ulteriore
sostegno finanziario e risorse umane aggiuntive per rafforzare il lavoro della
Cpi e continueranno ad adoperarsi per garantire la responsabilità per i
principali crimini internazionali commessi in Ucraina", si legge nel testo.
19:01
Cremlino: per Xi è
pronto il gelato, ne va ghiotto
Il presidente russo
Vladimir Putin tiene sempre pronto del gelato russo per il presidente cinese Xi
Jinping. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a chi gli
chiedeva se nella cena con fra Putin e Xi verrà offerto al leader cinese del
gelato. "Sicuramente", è stata la risposta, come riporta l'agenzia di stampa
russa Tass. "Il gelato è sempre pronto, visto che Xi Jinping lo ama molto", ha
detto Peskov. Parlando del menu della cena di Stato, il portavoce del Cremlino
ha promesso "cucina tradizionale russa".
19:13
Borrell: "Nessuna
prova che la Cina fornisca armi a Mosca"
"Non ho abbastanza
informazioni per commentare ciò che è stato deciso all'incontro" tra il
presidente cinese, Xi Jinping e il presidente russo, Vladimir Putin, "ma quello
che posso dire è che non ho nessuna prova del fatto che la Cina abbia fornito
armi alla Russia. E non ho nessuna prova che pensi di farlo". Lo ha dichiarato
l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine
del Consiglio Esteri. "Certo non possiamo indovinare quello che succederà
domani. Però non ci sono prove. Se avesse fornito armi lo sapremmo perché le
armi si usano. Non ci sono prove di sostegno militare né di piani per un
sostegno", ha ribadito il capo della diplomazia Ue.
19:31
Concluso il
colloquio Putin-Xi: è durato 4 ore e mezzo
È durato quattro ore
e mezzo il colloquio nel pomeriggio a Mosca tra il presidente russo Vladimir
Putin e Xi Jinping, nella prima giornata di visita del presidente cinese a
Mosca. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'incontro
era iniziato alle 16:36 ora di Mosca. Putin e Xi si sono incontrati al Cremlino
per colloqui - definiti dall'agenzia russa Ria Novosti "informali e
tete-a-tete". I due leader dovrebbero continuare parlare anche a cena. Ma la
giornata-clou della visita di Xi sarà domani.
19:47
Casa Bianca: Putin
vede in Xi una risorsa vitale perché la guerra va male
Vladimir Putin vede
in Xi Jinping una "risorsa vitale" perché la guerra in Ucraina "sta andando
male". È il giudizio del portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa,
John Kirby, per il quale Mosca e Pechino hanno inoltre un interesse comune a
"sfidare" l'ordine internazionale sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E
tuttavia, ha aggiunto, Russia e Cina "non hanno alle spalle decenni di reciproca
collaborazione e fiducia". Il loro, ha aggiunto è un "matrimonio di
convenienza".
20:01
Casa Bianca, Putin a
Mariupol? Speriamo abbia visto distruzione
Mariupol è lontana
dai combattimenti e dalla linea del fronte, ma "speriamo" che Vladimir Putin
"abbia visto la distruzione causata dal suo esercito". Lo ha detto il portavoce
del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, commentando la visita
del presidente russo nella città ucraina occupata. Gli "unici combattimenti
attivi" attualmente sono attorno a Bakhmut e gli ucraini "non mollano", ha
sottolineato Kirby rilevando che la guerra per la Russia "sta andando male".
20:28
Intelligence Kiev,
nessuna prova che Cina invii armi a Mosca
Al momento non ci
sono prove che la Cina stia fornendo armi alla Russia. Lo ha detto Andriy Yusov,
un rappresentante dell'intelligence della difesa ucraina, citato dalla Cnn.
"Ci sono casi in cui
il regime di Putin, la Federazione Russa, acquista droni, beni civili da fonti
aperte e utilizza microchip da tali beni. Tuttavia, non è stata registrata
alcuna prova di consegne di armi. L'Ucraina sta monitorando attentamente", ha
detto Yusov. Secondo gli Stati Uniti e i loro alleati, la Cina starebbe
valutando la possibilità di inviare armi alla Russia per il suo sforzo bellico
in Ucraina, ma Pechino ha negato.
21:02
Caccia russi
intercettano un B-52 a Kaliningrad
Ancora tensione nei
cieli nelle zone del conflitto. Un B-52 ha sorvolato le zone sul confine di
Kaliningrad, come già accade da giorni, ma stavolta è stato affiancato da caccia
Sukhoi 35 russi, in una manovra di identificazione. I bombardieri sono già
rientrati a Moron, in Spagna, non sembrano quindi esserci stati incidenti. Ma
l'episodio rileva un momento di particolare gravità.
Putin, la donna
lo contesta: "Tutto falso". Che fine ha fatto?
Libero Quotidiano il
20 marzo 2023
Durante la visita
di Vladimir Putin a Mariupol non è andato tutto liscio. Nel video ufficiale del
viaggio del presidente russo si notano delle urla di una donna del posto, che
poi sono state tagliate in un secondo momento. Mentre Putin conversava con
alcuni residenti locali, una donna ha preso il coraggio in mano e si è fatta
sentire chiaramente: “È tutto falso, è tutto uno spettacolo”.
Ad oggi nessuno sa
che fine abbia fatto questa persona, di certo c’è che gli agenti del Fso si sono
subito girati per vedere chi fosse la contestatrice. Se un episodio del genere
fosse accaduto a Mosca, la donna sarebbe stata come minimo arrestata
all’istante. Stando a quanto riporta Ukrainska Pravda, il video incriminato è
stato pubblicato anche sul sito del Cremlino, che ha poi rimediato all’errore
eliminando la parte in cui si sentiva la donna urlare contro Putin.
A proposito del
viaggio a Mariupol, dagli Stati Uniti è intervenuto il portavoce del Consiglio
di sicurezza nazionale, John Kirby: “Putin era lontano dalle prime linee dei
combattimenti. È stata una comoda scusa per lui per andare prima della visita di
Xi Jinping per dimostrare che è ancora il comandante in capo, che è ancora al
comando e che i suoi militari hanno ancora in mano i territori occupati
all'interno dell’Ucraina. Non c'è dubbio che possa vedere di persona quanto male
stiano effettivamente facendo i suoi militari, lì dove si stanno effettivamente
svolgendo i combattimenti".
Putin, il
racconto di quest'uomo: "È entrato in casa mia. E mi ha detto..."
Daniele
Dell'Orco su Libero Quotidiano il 20 marzo 2023
Vista l’ora, la
piccola tavola del trilocale al piano terra del microdistretto Nevsky, uno di
quelli nuovi di zecca che stanno cambiando il volto della città martire di
Mariupol, è imbandita del necessario per una cena frugale tra due settantenni:
Nikolai e sua moglie. Di spazio per aggiungere un posto però ce ne sarebbe,
specie se l’inviato improvvisato si chiama Vladimir Putin. Sabato, intorno alle
7, il presidente russo si è palesato in città, per la prima volta in assoluto
nella zona di quella che il Cremlino chiama ancora “operazione militare
speciale”. Senza il solito mega codazzo di auto al seguito (la delegazione era
di “sole” sei), senza sirene spiegate e soprattutto senza essere annunciato
(«l’incontro non era in programma», ha detto il portavoce Dmitry Peskov), Putin
di ritorno dalla Crimea in occasione dell’anniversario dall’annessione
unilaterale alla Russia è atterrato in elicottero in Donbass e si è messo alla
guida di un suv girando per la città come un cittadino comune.
Insieme al vice
primo ministro Marat Khusnullin, Putin ha visitato il Palazzo della Filarmonica
restaurato, l’aeroporto che nei piani russi dovrà diventare internazionale nel
giro di due anni, la zona dello yatch club, alcuni hotspot divenuti tristemente
noti durante la battaglia per la città come il Teatro d’arte drammatica (ancora
ignoto il conto esatto dei civili che hanno perso la vita al suo interno a
seguito di quello che l’Ucraina e alcune organizzazioni umanitarie ritengono
essere stato un bombardamento aereo russo mentre i russi dicono si sia trattato
di una esplosione di materiale bellico), infine il microdistretto composto da
decine di nuovi palazzi che ospitano circa 2500 tra le persone rimaste senza un
tetto (i posti letto totali sono almemo il triplo, in via di assegnazione man
mano che le persone tornano a ripopolare la città che ora conta 230mila
abitanti, molti rispetto a pochi mesi fa ma comunque la metà del pre-24
febbraio). Qui, ha incontrato alcuni increduli residenti. Una donna tiene le
mani giunte come stesse assistendo ad una apparizione mariana. Un uomo gli
stringe la mano dicendo: «Questa sì che è una sorpresa». Un anziano si presenta:
«L’ho sempre vista solo in tv». Putin risponde: «Dobbiamo iniziare a conoscerci
meglio allora».
LE ACCUSE
L’anziano è Nikolai.
Libero l’ha incontrato. Quando gli chiediamo quale fosse stata la prima cosa
detta a Putin, risponde: «Che abbiamo la stessa età, 70 anni, ma che io ho perso
tutto». E lui? «Mi ha detto “ora hai tutto ciò che occorre”». Nel video
circolato sul web che qualcuno sostiene non sia mai stato girato per davvero,
Nikolai invita Putin ad entrare in casa per vedere l’appartamento costruito
dalle imprese russe e “donato” alla Repubblica di Donetsk: «Ci espanderemo»,
chiosa Putin. Mariupol, nell’ottica del Cremlino, dovrà diventare un gioiello
sul Mar d’Azov. I cantieri sono centinaia. Dopo sei mesi almeno 300 tra gli
edifici più devastati sono stati demoliti e microdistretti come quello di
Nikolai stanno sorgendo a poca distanza l’uno dall’altro. Molti altri stabili
vengono invece sistemati senza bisogno della demolizione. La vecchia abitazione
di Nikolai non è stata tra le fortunate.
Prima di mostrarci
l’enorme cratere rimasto al suo posto, a pochi passi dell’acciaieria Ilycha dove
ha lavorato per tutta la vita, viene ammonito da sua moglie: «Stai parlando
troppo, non sai dove andranno a finire questi video». In un certo senso, la
carrambata di un Putin in versione Papa Francesco (che poi ha proseguito il suo
viaggio in elicottero verso Rostov dove ha incontrato Gerasimov, Surovikin e gli
altri vertici militari) non è stata una benedizione per tutti. Una delle donne
presenti si nasconde perché ha ricevuto una valanga di insulti dai suoi ex
vicini fuggiti nel resto dell’Ucraina. Lo stesso Nikolai è stato accusato di
essere un “venduto”, alcuni parenti sono stati minacciati da abitanti di
Mariupol che ora vivono in Polonia: «Ma io non ho fatto niente di male dice -
Sono nato quando Donetsk si chiamava ancora Stalino [la ribattezzò Khrushchev
nel 1961 durante la destalinizzazione, NdR], quest’odio non è nato per volontà
mia. Mi hanno dato un tetto sulla testa, cosa avrei dovuto fare? Non ho niente
di cui aver paura». Mariupol si sta rivestendo a festa con i miliardi russi, ma
le sue ferite non si rimargineranno tanto presto.
Una Tari
anti-drone. La propaganda del Cremlino porta i sistemi difensivi dentro le città
(ma ai russi non piace).
Michelangelo Freyrie
il 22 Marzo 2023 su L’Inkiesta.
Per convincere il
Paese a sopportare un conflitto a oltranza, Putin deve presentare la guerra come
una minaccia esistenziale. Ma la decisione di installare gli S-400 sui tetti
degli edifici ha generato soprattutto irritazione: un segnale che l’invasione
sta erodendo la già debole impalcatura sociale
È strano che in un
Paese nei cui cimiteri sono sorte decine di migliaia di croci la gente si
arrabbi per l’installazione di poche decine di sistemi antiaerei. È infatti da
qualche mese a Mosca e altre grandi città sono spuntate discrete postazioni per
la difesa dello spazio aereo, e spesso queste nuove apparizioni sono
accompagnate da malumori e timide proteste sui social.
Eppure, la cosa non
dovrebbe essere poi chissà quanto sconvolgente. Si tratta soprattutto di missili
a lunga gittata S-400 e sistemi per la difesa ravvicinata Pantsir S-1,
posizionati in cima a edifici governativi e in spazi abbandonati. Non si tratta
certo di un fatto inconsueto per un Paese in guerra, soprattutto considerato che
le forze di Kyjiv riescono regolarmente a colpire obiettivi militari sul
territorio russo.
Quello che però
colpisce è quanto scalpore abbia generato l’apparizione di questi sistemi,
seppur con la cautela necessaria e con la consapevolezza di quanto si rischi a
criticare le forze armate. A gennaio, il Moscow Times ha intervistato diversi
cittadini della capitale preoccupati per la mancanza di comunicazioni ufficiali
da parte del governo e snervati dal fatto che una guerra in teoria lontana e
compulsivamente ignorata nel quotidiano si sia manifestata sotto gli occhi di
tutti.
Una Tari anti-drone
L’apoteosi della
polemica è stata però raggiunta a Bryansk, a centoventi chilometri dal confine
russo-ucraino. Qui un politico locale ha addirittura suggerito di «normalizzare»
la presenza di sistemi, mettendo sul proprio sito la proposta di finanziare la
manutenzione dei sistemi antiaerei tramite una tassa regionale. Il servizio
stampa del consiglio regionale ha smentito, sostenendo che la pubblicazione è
stata frutto di un attacco hacker: fatto sta che l’idea di una Tari antiaerea è
stata brevemente ritenuta un’iniziativa credibile.
Tralasciando gli
atteggiamenti più grotteschi della classe politica russa, ciò che sorprende è
quanto il Cremlino si sia mostrato cauto nel pubblicizzare l’installazione dei
S-400 e Pantsir in giro per il Paese. La leadership russa sembra indecisa fra
due registri da adottare.
Innanzitutto, è
oggettivo che le forze ucraine siano riuscite a penetrare uno spazio aereo
precedentemente ritenuto inviolabile. Un obiettivo privilegiato è l’oblast di
Belgorod che, come tutte le regioni al confine con l’Ucraina, ospita molte basi
logistiche e caserme dove le truppe di invasione si riorganizzano e addestrano
le nuove reclute. Tuttavia, questo inverno gli ucraini sono riusciti a colpire
anche gli aeroporti militari di Ryzan e Saratov, a seicento chilometri dalla
frontiera. Anche in altre città della Federazione Russa sono avvenuti atti di
sabotaggio, si pensa utilizzando droni lanciati da piccoli commandos infiltrati
nel territorio russo.
Paura o
indifferenza?
Tutto ciò ovviamente
non fa onore a una sedicente superpotenza militare. D’altro canto, le autorità
sembrano fare di tutto per amplificare singoli episodi e segnalare con
allarmismo eventi in realtà piuttosto ambigui. Va infatti notato che molte delle
esplosioni e incendi avvenuti in depositi di munizioni sparsi per la Russia,
spesso ricondotti a una presunta campagna di sabotaggio ucraina, sia
verosimilmente frutto di incidenti e incuria da parte delle stesse truppe. Si
tratterebbe di un problema riconducibile più alla negligenza degli ufficiali
della logistica e alla mancanza di manutenzione delle basi che ad atti ostili. I
dubbi abbondano anche per quel che riguarda le accuse mosse dal governatore
della regione di Mosca e dal ministero della Difesa contro Kyjiv, che
recentemente sarebbe addirittura riuscita a operare droni da combattimento nei
pressi della capitale russa.
Combinando questo
alla retorica di Vladimir Putin, che parla dell’Ucraina come di uno Stato che
rappresenta una «minaccia esistenziale» per la Russia, la domanda sorge
spontanea: quale emozione devono provare i cittadini russi, paura o
indifferenza? Ha senso evocare uno spirito da “Grande guerra patriottica”, nel
quale tutti i russi sono coinvolti in un conflitto senza quartiere che arriva
fino a dentro le città? E soprattutto, è pensabile quando si parla ancora di una
“operazione speciale” sostenuta da una mobilitazione solamente parziale?
Grande guerra
patriottica soft
In un contesto come
quello russo, dove il flusso di informazioni è accuratamente sorvegliato dal
regime ma nel quale diversi potentati competono per far prevalere una narrativa
a loro più congeniale, queste sono domande a cui è difficile rispondere. Gli
ultranazionalisti, i parvenus come Evgenij Prigozhin, Ramzan Kadyrov, le forze
armate, i tecnocrati dei ministeri, i governatori, i leader aziendali, la Duma:
ognuno parla della guerra, e quindi del proprio ruolo all’interno di essa, con
una narrazione compatibile con i propri interessi politici.
Nel complesso,
l’immagine che ne esce è di un Paese nel quale la guerra è diventata una sorta
di nuova routine, un principio organizzativo della vita pubblica che fonda il
proprio nuovo contratto sociale sullo sforzo bellico. Ciò è diverso
dall’approccio inizialmente adottato dal Cremlino, che dipingeva “l’operazione
speciale” come qualcosa di lontano, un equivalente russo di quello che la guerra
in Afghanistan o in Iraq è stato per l’Occidente: un tema importante, ma che in
ultima analisi non tocca la quotidianità domestica.
Che la guerra in
Ucraina abbia assunto una dimensione più totalizzante nella retorica governativa
non significa però che il regime abbia adottato la linea del «lacrime e sangue»,
di un eroico scontro nel quale ognuno è chiamato a fare sacrifici. Il tono è
piuttosto quello di una Guerra patriottica soft, con tutta la sua enfasi
retorica ma nessuno dei suoi aspetti più drammatici. Non a caso, Putin è molto
attento a sottolineare iniziative come un welfare espanso per gli operai delle
fabbriche costrette a lavorare su tre turni.
Apatia e guerra
totale
In generale,
l’intera classe politica tende a rappresentare la guerra come un grande progetto
politico nazionale che non avrà né costi per la collettività, né richiederà una
presa di coscienza da parte del popolo (l’eccezione sono i rappresentati locali,
che effettivamente si trovano a toccare con mano le conseguenze delle decisioni
di Mosca). Decenni di apatia ideologica indotta dalle autorità per impedire la
formazione di una base politica opposta a Putin non si possono cancellare in
pochi mesi. Non esiste ad oggi un collante valoriale, sociale, partitico che
permetterebbe di sostenere i contraccolpi di una guerra pesantemente sentita
anche sul fronte domestico.
L’unico modo con cui
il Cremlino può manovrare il pubblico in un conflitto a oltranza senza che il
corpo sociale si sfaldi è presentare la guerra come un fatto esterno, come può
essere una catastrofe naturale o una pandemia: qualcosa di astratto, sottaciuto
nel quotidiano e confinato a una politica che il russo medio percepisce
solamente come uno dei tanti spettacoli televisivi in onda in prima serata.
Presumibilmente, è
per questo è che l’apparizione di sistemi antiaerei nelle città sia stato
accolto con tanta irritazione. Sono dimostrazioni tangibili che il conflitto è
qualcosa di concreto, che ormai pervade la vita pubblica del Paese e che
lentamente ne avvelena la società. È possibile che questo impedirà alla Russia
di prendere decisioni improvvise per quel che riguarda la mobilitazione, al
netto di eventi catastrofici come la liberazione di Kharkiv l’anno scorso. Il
governo continuerà ad alzare gradualmente la temperatura dell’acqua nel quale
languisce la società russa, dissolvendo progressivamente la pace civile fino al
giorno in cui la Russia si sveglierà nell’acqua bollente di una guerra totale.
La Repubblica.
Accordo Ucraina-Fmi su piano aiuti da 15,6 miliardi
La visita del
presidente cinese a Mosca prosegue. Il premier giapponese nella capitale
ucraina. Missili di Mosca distrutti in Crimea. Fonti Kiev: "Si lavora per
organizzare una telefonata Zelensky-Xi. Ma nulla è programmato"
La visita di Xi a
Mosca - che durerà ancora oggi e domani - non sembra destinata a segnare una
svolta per l'Ucraina. Gli Usa restano scettici sul ruolo di Xi Jinping come
'peacemaker'. Se la Cina lancerà un appello per un cessate il fuoco, Kiev
dovrebbe respingerlo perché "ratificherebbe ciò che i russi sono stati in grado
di conquistare", è la posizione di Washington. Intanto ancora tensione nei
cieli tra Russia e Stati Uniti. Mosca annuncia di aver inviato un
cacciabombardiere Su-35 nella regione del Mar Baltico dopo aver rilevato due
bombardieri strategici americani B-52H in grado di trasportare bombe nucleari.
Mentre Kiev parla della distruzione di missili russi in Crimea. Sul fronte
diplomatico, viaggio a Kiev del primo ministro giapponese Fumio Kishida.
Punti chiave
20:33
Casa Bianca,
Cina-Russia vorrebbero mondo con loro regole
16:47
Putin, piano Cina
per Ucraina può essere base accordo pace
16:37
Conclusi colloqui
Putin-Xi, accordo cooperazione economica
12:31
Ucraina, l'Ue ha
versato nuovi aiuti per 1,5 miliardi
11:46
Ucraina, Kiev:
"Respinto tentativo delle truppe ruse di raggiungere il centro di Bakhmut"
11:32
Ucraina, Cina: "Mai
fornite armi alle parti in conflitto"
11:22
Xi invita Putin in
Cina
10:20
Cina: la Russia è
aperta a colloqui di pace
10:05
Mosca: intercettati
2 bombardieri Usa sul Mar Baltico
04:10
Viaggio a Kiev del
premier giapponese Kishida
00:39
Kiev: "Distrutti
missili russi in Crimea"
00:00
Caccia russi
intercettano un B-52 a Kaliningrad
00:00
Caccia russi
intercettano un B-52 a Kaliningrad
Ancora tensione nei
cieli nelle zone del conflitto. Un B-52 ha sorvolato le zone sul confine di
Kaliningrad, come già accade da giorni, ma stavolta è stato affiancato da caccia
Sukhoi 35 russi, in una manovra di identificazione. I bombardieri sono già
rientrati a Moron, in Spagna, non sembrano quindi esserci stati incidenti. Ma
l'episodio rileva un momento di particolare gravità.
00:09
Zelensky: "Il piano
Ue sulle munizioni ci dà fiducia"
"Il piano dell'Ue
che accelera la fornitura di munizioni all'Ucraina ci dà fiducia". Lo ha detto
nel suo consueto discorso serale il presidente Volodymyr Zelensky: "La decisione
vale due miliardi di euro. Prevede sia la consegna immediata che la produzione
di munizioni. È una mossa strategica. Ci dà fiducia nella nostra unità,
nell'immutabilità dei progressi verso la vittoria. Sono grato a tutti i nostri
partner in Europa. A tutti coloro che sono veramente impegnati a rendere
l'Europa forte e libera".
00:39
Kiev: "Distrutti
missili russi in Crimea"
Il ministero della
Difesa ucraino ha dichiarato, su Telegram, che un'esplosione nella città
di Dzhankoi, nel nord della Crimea, ha portato alla distruzione di missili da
crociera russi destinati alla flotta russa nel Mar Nero. "Un'esplosione nella
città di Dzhankoi, nel nord della Crimea temporaneamente occupata - si legge -
ha distrutto i missili da crociera russi Kalibr mentre venivano trasportati su
treni a rotaia". I missili, progettati per essere lanciati dalle navi della
flotta russa del Mar Nero, hanno una gittata operativa di oltre 2.500 chilometri
(1.550 miglia) sulla terraferma e di circa 375 chilometri in mare.
02:15
Attacco russo
nell'oblast di Sumy
Le forze armate
russe hanno lanciato attacchi contro tre centri nell'oblast di Sumy. A
riportarlo è l'amministrazione regionale. Non ci sono ancora notizie sulle
vittime.
04:10
Viaggio a Kiev del
premier giapponese Kishida
Il primo ministro
del Giappone, Fumio Kishida, visiterà oggi l'Ucraina. "È raro" sottolinea in
particolare Kyodo News "che un leader giapponese compia un viaggio di questa
rilevanza, senza preavviso, in un Paese straniero". L'emittente pubblica
giapponese NHK ha mostrato Kishida a bordo di un treno proveniente dalla Polonia
e diretto a Kiev. Il viaggio a sorpresa del leader nipponico arriva poche ore
dopo l'incontro con l'omologo indiano, Narendra Modi, a Nuova Delhi. Kishida era
l'unico leader del G7 a non aver ancora visitato l'Ucraina.
06:17
Kiev non rivendica
la distruzione dei missili in Crimea
Il ministero della
Difesa ucraino ha dato la notizia dei missili da crociera russi destinati alla
flotta moscovita del Mar Nero distrutti in Crimea ma non ha rivendicato
l'azione. Se confermata, l'esplosione potrebbe rappresentare un raro attacco
delle forze ucraine nel cuore di un territorio annesso illegalmente alla Russia
nel 2014. Vicino a Dzhankoi si trova una base aerea militare russa e funzionari
ucraini hanno a lungo affermato che si tratta della più grande base militare
russa in Crimea.
08:51
Olaf Scholz: "La
guerra sarà ancora lunga"
Il cancelliere
tedesco, Olaf Scholz, ritiene che la guerra in Ucraina potrebbe durare a lungo.
Lo ha detto lui stesso a un evento organizzato dal Rheinische Post che si è
tenuto a Duesseldorf lunedì sera. "Dobbiamo essere pronti a pensare che può
durare a lungo. Anche quando la guerra sarà finita, non sarà tutto subito
normale. Ma non dobbiamo nemmeno smettere di impegnarci per garantire la fine
della guerra", ha dichiarato Scholz, come riferisce lo stesso Rheinische Post.
"Dovremmo renderci conto che questa terribile guerra di aggressione e le sue
conseguenze ci occuperanno per molto tempo ancora", ha ribadito Scholz.Per
Scholz, condizione preliminare per una pace giusta è che la Russia inizi a
ritirare le truppe. Il cancelliere, prosegue il Rheinisce Post, ha insistito
sulla necessità di ripristinare un ordine di pace e sicurezza funzionante,
evidenziando come principio centrale che "i confini non si spostano con la
forza".
09:19
Mosca vuole una
riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla situiazione dei bambini ucraini
portati in Russia
La Russia prevede di
tenere una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite all'inizio di aprile su quella che dice essere "la reale situazione" dei
bambini ucraini portati in Russia. Lo riporta l'Associated Press. La vicenda è
al centro dell'attenzione in seguito all'emissione di un mandato di arresto
della Corte penale internazionale nei confronti del presidente russo Vladimir
Putin per crimini di guerra legati al trasferimento dei piccoli. L'ambasciatore
russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha dichiarato in una conferenza
stampa che la Russia ha pianificato la riunione del Consiglio di Sicurezza molto
prima dell'annuncio di venerdì da parte della Corte penale internazionale. La
Russia avrà la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza ad aprile. La
Corte penale internazionale ha detto che chiede l'arresto di Putin perchè "è
presumibilmente responsabile del crimine di guerra della deportazione illegale
di (bambini) e del trasferimento illegale di (bambini) dalle aree occupate
dell'Ucraina alla Federazione Russa".
09:56
Xi Jinping: "La Cina
e la Russia partner strategici"
Il presidente cinese
Xi Jinping nel secondo giorno di visita a Mosca ha detto che la "Cina e la
Russia sono partner strategici e grandi potenze vicine".
Il corteo delle auto
della delegazione cinese lascia il Soluxe Hotel a Mosca per portare Xi Jinping
al secondo giorno di incontri nella capitale russa (ansa)
10:05
Mosca: intercettati
2 bombardieri Usa sul Mar Baltico
Il ministero della
Difesa di Mosca ha reso noto che ieri un suo caccia Su-35 ha intercettato sul
Mar Baltico due bombardieri strategici B-52H Usa che volavano in direzione del
confine russo: il jet è rientrato dopo che i bombardieri si sono allontanati. Lo
riporta Interfax. L'episodio segue l'abbattimento il 14 marzo di un drone Usa
nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da caccia russi. Mosca ha dichiarato
che il volo del Su-35 è stato rigorosamente in linea con le regole
internazionali sull'uso dello spazio aereo. "Non è stata consentita alcuna
violazione" del confine di Stato della Russia, ha sottolineato.
10:17
Cina: "Premier
giapponese a Kiev? Aiuti a raffreddare non a infiammare"
La Cina esprime la
speranza che il viaggio del premier giapponese Fumio Kishida a Kiev serva a
"raffreddare la situazione" e "non al contrario". Lo ha detto il portavoce degli
Esteri cinese, Wang Wenbin, aggiungendo che la comunità internazionale deve
"mantenersi nella direzione giusta per la ricerca della pace" e deve "promuovere
dialoghi che creino le condizioni necessarie per una soluzione politica alla
crisi in Ucraina".
10:20
Cina: la Russia è
aperta a colloqui di pace
I contatti di
Pechino con la Russia contribuiranno a portare pace. È quanto ha detto a
Pechino Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese. "La Russia ha
studiato attentamente il documento di posizione della Cina sulla soluzione
politica della questione ucraina ed è aperta a colloqui di pace", ha detto il
portavoce, aggiungendo che "il presidente Putin ha dichiarato che la Russia
apprezza la posizione coerente della Cina di sostenere l'equità, l'obiettività e
l'equilibrio sulle principali questioni internazionali".
10:35
Xi: "La nostra
partnership con la Russia resta la priorità"
Il presidente
cinese, Xi Jinping, nel corso del suo incontro con il premier russo Mikhail
Mishustin, ha assicurato che il nuovo premier cinese Li Qiang "continuerà a dare
priorità alla partnership strategica a tutto tondo fra Cina e Russia". Lo
riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Darà priorità anche a stabilire
contatti di lavoro stretti" con il premier russo, ha aggiunto Xi, chiedendo di
proseguire con la tradizione di incontri regolari tra i capi di governo dei due
Paesi.
10:55
Cina: "Manteniamo
comunicazione con tutte le parti"
La Cina dichiara di
mantenere la comunicazione con tutte le parti sulla guerra in Ucraina. In
risposta a una serie di domande sul conflitto, il portavoce del ministero degli
Esteri, Wang Wenbin, ha sottolineato che la Cina "continuerà a mantenere una
posizione obiettiva ed equa e collaborerà con la comunità internazionale per
svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi ucraina".
La Cina ha una
posizione "sempre chiara" sulla crisi ucraina, e "mantiene la comunicazione con
tutte le parti", ha aggiunto il portavoce, senza citare direttamente un
possibile colloquio tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il 11:12
Cremlino: Putin e Xi
parleranno ai media ma senza domande
Il presidente russo
Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping parleranno ai media dopo il loro nuovo
colloquio oggi pomeriggio e dopo avere firmato alcuni accordi, ma non
risponderanno ad alcuna domanda. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov citato dall'agenzia Interfax.
Successivamente è in
programma una cena di Stato in onore del presidente cinese, che sarà seguita in
tarda serata da alcune riunioni interne dello stesso Putin con suoi
collaboratori.
presidente ucraino,
Volodymyr Zelensky, che sarebbe il primo dall'inizio del conflitto.
11:22
Xi invita Putin in
Cina
Secondo i media di
Stato cinesi, il presidente Xi Jinping ha invitato il leader russo Vladimir
Putin in Cina per il terzo forum sulla Nuova via della Seta
11:32
Ucraina, Cina: "Mai
fornite armi alle parti in conflitto"
La Cina "non è né
creatrice né parte della crisi in Ucraina, né ha fornito armi ad alcuna delle
due parti in conflitto". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin,
rispondendo alle critiche del segretario di Stato americano Antony Blinken sulla
copertura diplomatica data da Pechino a Mosca, ha detto che "gli Usa non sono
qualificati per puntare il dito contro la Cina, figuriamoci incolparla".
Inoltre, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "dicono di voler mantenere la
pace, ma la gente non vede alcun passo effettivo", mentre "quello che vedono
tutti è che gli Usa continuano a fornire armi al campo di battaglia".
11:46
Ucraina, Kiev:
"Respinto tentativo delle truppe ruse di raggiungere il centro di Bakhmut"
Le forze ucraine
hanno respinto i tentativi russi di avanzare nel centro della piccola città
orientale di Bakhmut, ha detto martedì un alto generale ucraino. La battaglia
che dura da mesi per Bakhmut è diventata una delle più sanguinose della guerra
russa in Ucraina. "I gruppi d'assalto del nemico stanno cercando di avanzare
dalla periferia al centro della città, ma le nostre forze di difesa lavorano e
li distruggono 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha scritto Oleksandr Syrskyi, il
comandante delle forze di terra ucraine, su Telegram.
11:51
Il premier
giapponese Kishida arriva a Kiev
Il primo ministro
giapponese Fumio Kishida è arrivato a Kiev in treno dalla Polonia. Secondo un
video trasmesso dalla televisione pubblica giapponese, il primo ministro
giapponese è stato accolto al terminal ferroviario di Kiev dal primo vice
ministro degli Esteri ucraino Emine Japarova.
12:10
Ucraina, Cina: "La
Russia è aperta a colloqui di pace"
Dopo la visita del
presidente cinese Xi Jinping in Russia, i contatti di Pechino con Mosca
contribuiranno a portare la pace. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang
Wenbin, nel briefing quotidiano, ha detto che "la Russia ha studiato con
attenzione il documento di posizione della Cina sulla soluzione politica della
crisi in Ucraina ed è aperta a colloqui di pace". Il presidente Vladimir Putin
ha riferito che "la Russia apprezza la posizione coerente della Cina di
sostenere equità, obiettività ed equilibrio sulle principali questioni
internazionali. La Cina continuerà a fare delle relazioni sino-russe una
priorità"
12:17
Ucraina, il
rappresentante italiano all'Onu: "Pieno appoggio di Roma a indagini del Cpi"
L'Italia ha espresso
oggi pieno appoggio alle indagini del Procuratore della Corte Penale
Internazionale, della Commissione d'Inchiesta dell'Onu e alle altre iniziative
per l'accertamento delle responsabilità delle violazioni dei diritti umani, del
diritto umanitario internazionale e sui crimini ad esse correlati in Ucraina,
dopo l'aggressione russa. Lo ha detto oggi a Ginevra il Rappresentante
Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni
Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi.
12:31
Ucraina, l'Ue ha
versato nuovi aiuti per 1,5 miliardi
La Commissione
europea ha versato oggi all'Ucraina una seconda rata di 1,5 miliardi di euro
nell'ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria fino a 18 miliardi di
euro. Il sostegno, ricorda in una nota, aiuterà l'Ucraina a continuare a pagare
stipendi e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali,
come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Consentirà poi
all'Ucraina di garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le
infrastrutture critiche distrutte, come quelle energetiche, i sistemi idrici, le
reti di trasporto, le strade e i ponti.
12:45
Russia, Mosca:
"Attacco droni ucraini a una stazione di petrolio a Bryansk"
Le forze ucraine
hanno attaccato con droni una stazione di pompaggio del petrolio nella regione
russa di Bryansk, vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto sul suo
canale Telegram il governatore della regione, aggiungendo che non sono segnalate
vittime.
12:50
Muratov, "Arresti
durante visita Xi. Spero che Mosca e Pechino non collaborino su diritti umani"
"Un attivista per i
diritti umani è stato arrestato poco fa nel centro di Mosca" in uno stabile "a
tre minuti da dove si trova il segretario generale del Partito comunista cinese,
Xi Jinping", e questa "è la mia risposta a chi mi chiede cosa significa per la
Russia la visita del leader cinese". Lo ha dichiarato il giornalista Dmitrij
Muratov, direttore di Novaja Gazeta e Premio Nobel per la pace 2021, nel suo
intervento alla commissione speciale del Parlamento europeo sulle Ingerenze
straniere. "Spero che Russia e Cina non stiano cooperando in materia di diritti
umani", ha aggiunto Muratov con sarcasmo.
12:55
Ucraina, Onu:
"Almeno 8.317 civili uccisi in tutta l'Ucraina dall'inizio della guerra"
Almeno 8.317 civili
sono stati uccisi e almeno altri 13.892 sono rimasti feriti in tutta l'Ucraina
dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. Lo afferma in una nota
l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr).
Il numero più alto di morti e feriti è stato registrato nelle regioni di Donetsk
e Lugansk, precisa l'Ohchr. I numeri si basano sulle informazioni raccolte fino
al 19 marzo 2023. Nel territorio controllato dall'Ucraina sono stati registrati
6.446 morti e 11.374 feriti e nei territori controllati dalla Russia sono stati
rilevati 1.871 morti e 2.518 feriti. L'Ohchr ha infine sottolineato che i
rapporti da alcune località sono in ritardo e molti sono ancora in attesa di
conferma e quindi "i numeri effettivi sono notevolmente più alti".
13:13
Gruppo anti-Putin
rivendica incendio a sede Fsb a Rostov
Un gruppo russo
anti-Cremlino chiamato Chyorny Most (Ponte Nero) ha rivendicato la sua
responsabilità nell'incendio avvenuto la scorsa settimana in una sede del
Servizio di sicurezza federale (Fsb) russo nella città di Rostov vicino al
confine ucraino, che ha ucciso almeno quattro persone e ferite cinque. Lo
riporta Radio Free Europe. Il gruppo ha dichiarato su Telegram di essere
"coautore" dell'incidente, contribuendo ai suoi preparativi e alla sua
attuazione, ma non ha nominato nessun altro coinvolto.
Chyorny Most si
posiziona come un movimento di guerriglia che combatte contro il presidente
Putin e l'invasione dell'Ucraina.
13:37
Xi arrivato al
Cremlino
Il presidente cinese
Xi Jinping è arrivato al Cremlino per la seconda giornata di incontri con
Vladimir Putin a Mosca. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali nel grande salone
del Palazzo di Stato del Cremlino, i due leader si sono ritirati per un nuovo
incontro faccia a faccia, dopo il colloquio di ieri durato quattro ore e mezza.
Soltanto in un secondo momento a loro si uniranno le delegazioni. Lo riferisce
l'agenzia Interfax.
13:49
Cremlino, via ai
colloqui ristretti tra le delegazioni di Xi e Putin
I colloqui tra i due
presidenti si tengono nella Sala di Caterina del Palazzo del Gran Cremlino in
formato ristretto con la sola partecipazione delle delegazioni. Lo riporta
l'agenzia Tass. Da parte russa sono presenti il vicepresidente del Consiglio di
sicurezza Dmitry Medvedev, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, gli aiutanti
presidenziali Maxim Oreshkin e Yuri Ushakov, l'ambasciatore in Cina Igor
Morgulov, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, la capa della Banca centrale
Elvira Nabiullina, il direttore del Servizio federale per cooperazione militare
e tecnica Dmitry Shugaev e il capo di Roscosmos Yury Borisov.
14:10
Mosca, raid della
polizia nelle case di membri dell'organizzazione premio Nobel Memorial
La polizia di Mosca
ha effettuato questa mattina un'ampia serie di perquisizioni nelle case di
membri dell'organizzazione della società civile Memorial, una dei tre vincitori
del premio Nobel per la Pace 2022. Lo denuncia la stessa organizzazione sul suo
canale Telegram, secondo quanto riferiscono Meduza e Moscow Times. I raid
appaiono legati alla recente accusa di "riabilitazione del nazismo" emessa
contro il gruppo. Almeno otto membri di Memorial, uno dei loro familiari, e due
uffici sono stati presi di mira dal raid, condotto da agenti del Comitato
Investigativo e dell'unità anti estremismo del ministero dell'Interno. Alcuni
membri di Memorial sono stati fermati per essere interrogati.
Gli avvocati di
Memorial riferiscono di non aver potuto contattare i loro assistiti.
Fondata nel 1998,
Memorial è la principale organizzazione russa di documentazione dei crimini
dello stalinismo.
Nel 2021, la Corte
Suprema russa ha ordinato lo scioglimento del gruppo. Il 7 ottobre 2022, il
giorno in cui è stato annunciato il conferimento del premio Nobel, la polizia ha
sequestrato gli uffici dell'organizzazione. Memorial ha un archivio con i dati
di tre milioni di vittime della repressione stalinista, fra cui figurano alcune
persone accusate di aver collaborato con i nazisti. Su questa base le autorità
russe hanno aperto una inchiesta contro il gruppo per "riabilitazione del
nazismo" nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione dell'Ucraina. L'avvocato
di Memorial, Arseniy Levinson, ha detto a Novaya Gazeta, che sono state
perquisite le case dei dipendenti di Memorial Oleg Orlov, Nikita Petrov, Yan
Rachinsky, Alexandra Polivanova, e della madre di quest'ultima, Marina
Polivanova. Altre fonti riportano perquisizioni nelle case di Galina
Iordanskaya, Alena Kozlovaya, Irina Ostrovskaya, e Alexander Guryanov.
14:18
Fonti di Kiev:
"Nulla di programmato per la telefonata Xi-Zelensky, ma si lavora per
organizzarla"
Per quanto riguarda
la telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky "non è stato programmato nulla di concreto". Lo afferma un
alto funzionario ucraino, citato dalla Cnn. Ma lo stesso funzionario ha poi
aggiunto che "si lavora per organizzarla". Se la conversazione dovesse avvenire,
sarebbe la prima tra i due leader.
14:35
Il Pentagono
accelera sulla consegna dei tank Abrams a Kiev. Saranno modelli vecchi rinnovati
Il Pentagono sta
accelerando la consegna dei carri armati Abrams all'Ucraina, optando per l'invio
di un vecchio modello rinnovato che può essere pronto più velocemente. Lo hanno
reso noto funzionari statunitensi parlando in condizioni di anonimato perché il
piano non è stato ancora annunciato pubblicamente. Il progetto originale era
quello di inviare 31 dei nuovi M1A2 Abrams, ma i funzionari hanno fatto sapere
che è stata presa la decisione di utilizzare la vecchia versione M1A1, che può
essere prelevata dalle scorte dell'esercito e sarebbe più facile da utilizzare
da parte delle forze ucraine. L'obiettivo è quello di portarli nelle zone di
guerra in 8-10 mesi.
14:38
Il New York Times:
da Pechino a Mosca droni per 12 milioni di dollari
Il New York Times
riferisce che la Cina ha fornito alla Russia di droni per un valore di 12
milioni di dollari. L'inchiesta si basa sull'analisi dei dati doganali ufficiali
russi forniti da una società terza.
Secondo il
quotidiano, la Cina ha fornito alla Russia un mix di prodotti della Dji, società
tecnologica cinese leader nella realizzazione di droni, e di una serie di
aziende più piccole, spesso tramite piccoli intermediari ed esportatori.
Le vendite
ufficiali, secondo il Nyt, sono probabilmente solo una parte di un flusso più
ampio di tecnologie attraverso canali non ufficiali che arriva in Russia
attraverso nazioni "amiche" come Kazakhstan, Pakistan e Bielorussia. Il secondo
marchio più venduto di droni, dopo Dji, è stato Autel, un produttore cinese con
filiali negli Stati Uniti, in Germania e Italia. Sono stati venduti quasi 2
milioni di dollari di droni di questo marchio, con l'ultima spedizione risalente
al mese scorso.
15:12
Xi: pronti a
espandere la collaborazione con Mosca
La Cina è pronta ad
espandere la sua cooperazione con la Russia nei settori del commercio, degli
investimenti, della catena degli approvvigionamenti, dei mega progetti,
dell'energia e dell'alta tecnologia. E' quanto ha detto il presidente cinese Xi
Jinping nell'incontro avuto con il premier russo Mikhail Mishustin, osservando
che i due Paesi sono "partner strategici completi con pieno coordinamento".
Mantenere lo "sviluppo sano e stabile dei legami è conforme alla logica storica
dei rapporti bilaterali e agli interessi fondamentali dei rispettivi popoli", ha
aggiunto Xi nel resoconto diffuso in serata dalla Xinhua.
15:27
Putin, "con Xi
scambio di vedute franco e sostanzioso"
Tra il presidente
russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping c'è stato "uno scambio di
opinioni franco e sostanzioso". Lo ha detto lo stesso Putin, citato
dall'agenzia Ria Novosti, dopo due ore di colloqui a porte chiuse al Cremlino, a
cui ora sta seguendo una sessione pubblica alla presenza delle delegazioni
allargate.
15:41
Putin, "concordati
parametri per gasdotto Forza Siberia 2"
Tra Russia e Cina
sono stati concordati "praticamente tutti i parametri" per la costruzione del
gasdotto Forza della Siberia 2 per l'esportazione di gas russo in Cina, che si
aggiungerà al Forza della Siberia 1 già funzionante. Lo ha detto il presidente
russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe.
15:46
Putin a Xi, possiamo
ambire a leadership mondiale in AI
Russia e Cina
possono diventare leader mondiali nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Lo ha
detto il presidente russo, Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe, nel corso
del suo incontro con l'omologo cinese, Xi Jinping.
15:57
Putin, promuoveremo
i pagamenti in yuan con Paesi terzi
La Russia vuole
"utilizzare lo yuan cinese nei pagamenti con Paesi dell'Asia, dell'Africa e
dell'America Latina". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin durante
l'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. "Sono sicuro - ha sottolineato Putin
- che queste forme di pagamento saranno sviluppate tra la Russia e i partner e
colleghi di Paesi terzi", riporta l'agenzia Ria Novosti.
16:11
Kishida a Bucha,
"massimo sostegno a Kiev per la pace"
Tappa a Bucha per il
premier giapponese Fumio Kishida, arrivato in visita a sorpresa in Ucraina per
colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky mentre il leader cinese Xi Jinping
è in Russia dal capo del Cremlino Vladimir Putin. Il Giappone "continuerà con il
massimo impegno per sostenere l'Ucraina per ripristinare la pace", ha detto
Kishida da Bucha, come riporta l'agenzia Kyodo.
16:19
Cremlino,
improbabile colloquio Xi-Zelensky oggi o domani
E' improbabile che
un'eventuale conversazione telefonica tra il presidente cinese Xi Jinping e
quello ucraino Vladimir Zelensky avvenga tra oggi e domani. Lo ha dichiarato ai
giornalisti il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, ricordando che il
leader cinese è ora impegnato nella sua visita a Mosca. "Non credo che oggi o
domani ci sarà alcuna conversazione con Kiev", ha detto Ushakov. Alla domanda se
una possibile conversazione telefonica tra Xi e Zelensky sia importante per la
Russia per una soluzione della crisi ucraina, Ushakov ha risposto: "In questo
contesto, una tale conversazione è del tutto irrilevante. Non so nemmeno se la
parte cinese abbia confermato o meno una tale possibilità". In precedenza,
il Financial Times, citando una fonte a conoscenza dei fatti, aveva affermato
che Xi potrebbe chiamare Zelensky dopo la sua missione a Mosca.
16:26
Cremlino, Putin
potrebbe andare a Pechino quest'anno
La visita del
presidente russo, Vladimir Putin, in Cina è possibile entro quest'anno, ma non
ci sono ancora delle date. Lo ha detto ai giornalisti Yury Ushakov, consigliere
diplomatico del Cremlino. "Se ne è discusso e penso che ci sia la possibilità di
un viaggio a Pechino quest'anno", ha detto Ushakov dopo che il leader cinese Xi
Jinping, in visita a Mosca, ha invitato Putin in Cina. Xi è fino a domani in
visita di Stato a Mosca. Si è trattato del suo primo viaggio all'estero da
quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di Stato. Ieri, il
presidente cinese ha avuto un incontro informale e una cena con Putin a cui oggi
sono seguiti i colloqui ufficiali.
16:37
Conclusi colloqui
Putin-Xi, accordo cooperazione economica
Si sono conclusi
dopo tre ore, con la firma di un accordo per lo sviluppo economico fino al 2030,
i colloqui al Cremlino tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi
Jinping. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
16:42
Regno Unito rivela,
forniamo bombe con uranio impoverito
Il Regno Unito
intende fornire all'Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto
potenziale contenenti uranio impoverito. La rivelazione è stata fatta ieri dalla
baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi
Sunak, durante un'audizione di secondaria importanza alla Camera non elettiva
dei Lord, passata del tutto sotto silenzio sull'isola, fino a che oggi non è
rimbalzata dai media ucraini.
16:47
Putin, piano Cina
per Ucraina può essere base accordo pace
"Il piano di pace
della Cina può essere preso come la base per un accordo di pace sull'Ucraina,
quando Occidente e Kiev saranno pronti a farlo". Lo ha detto il presidente
russo Vladimir Putin nella dichiarazione alla stampa, seguita all'incontro con
l'omologo cinese, Xi Jinping.
16:52
Lavrov,con armi a
uranio impoverito finirà male per Londra
Se la Gran Bretagna
dovesse fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina, "non c'è dubbio che
finirà male" per Londra. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei
Lavrov in un'intervista alla tv Rossiya-1. "Non sarei sorpreso da questo
sviluppo, se questa (consegna) avvenisse effettivamente, ma non c'è dubbio che
finirà male per loro", ha detto Lavrov. Di queste forniture "non ne ho sentito
parlare, ma non sarei sorpreso da nulla, perché hanno completamente perso il
senso dell'orientamento riguardo alle loro azioni e al modo in cui minano la
stabilità strategica in tutto il mondo", ha affermato.
16:56
Putin, la Russia
dovrà reagire all'uso di armi con uranio
"L'Occidente ha
deciso di combattere la Russia fino a ultimo ucraino non a parole ma nei fatti.
Se l'Occidente collettivo inizierà a usare armi con componenti nucleari, la
Russia sarà costretta a reagire". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir
Putin, parlando davanti alla stampa dopo i suoi colloqui con il collega
cinese, Xi Jinping.
Il riferimento è
alle dichiarazioni arrivate da Londra, secondo cui la Gran Bretagna potrebbe
inviare a Kiev munizioni all'uranio impoverito.
17:01
Xi, con Russia
impegnati in rispetto e difesa Carta Onu
La Cina e la Russia,
in qualità di membri del Consiglio di Sicurezza Onu difenderanno ulteriormente
le norme delle relazioni internazionali, basate sulla Carta delle Nazioni Unite.
Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nelle dichiarazioni alla
stampa dopo i colloqui al Cremlino con l'omologo russo, Vladimir Putin.
17:13
Shoigu, con
decisione Gb scontro nucleare a pochi passi
Dopo le
dichiarazioni della Gran Bretagna sulle forniture di munizioni
all'uranio impoverito all'Ucraina, lo scontro nucleare è "a pochi passi". Lo ha
dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dalla Tass.
17:17
Putin, Kiev non
vuole attuare il piano di pace cinese
Il presidente
russo Vladimir Putin ha detto di non vedere la "volontà" delle autorità ucraine
di trovare una soluzione al conflitto, sulla base del piano di pace proposto
dalla Cina. "Crediamo che molti punti del piano di pace proposto dalla
Cina possano servire come base per una soluzione pacifica, quando saranno pronti
in Occidente e a Kiev. Tuttavia, al momento non vediamo una tale disposizione da
parte loro", ha detto Putin dopo i colloqui con il suo omologo cinese Xi
Jinping al Cremlino.
17:34
Cina
"imparziale",dice Xi dopo colloqui "amichevoli" con Putin
Il presidente
cinese, Xi Jinping, ha assicurato che Pechino ha una "posizione imparziale" sul
conflitto in Ucraina. Lo ha detto durante le dichiarazioni congiunte date alla
stampa, al termine del colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin,
secondo quando riportano i media russi. Xi, che parlava attraverso un
traduttore, ha aggiunto che i colloqui con Putin sono stati "aperti e
amichevoli". Secondo i media cinesi, i russi hanno ribadito l'impegno a
riprendere i colloqui di pace il prima possibile; e le due parti hanno
sottolineato che per risolvere la crisi ucraina devono essere rispettate le
"legittime preoccupazioni di sicurezza" di tutti i Paesi.
17:48
Putin-Xi, non ci
sono vincitori in una guerra nucleare
Russia e Cina
credono che non possano esserci vincitori in una guerra nucleare e quindi un
conflitto di questo tipo non deve essere mai scatenato. Lo si legge nella
dichiarazione congiunta firmata al Cremlino dai presidenti Xi Jinping e Vladimir
Putin, in cui Russia e Cina tra l'altro si dicono "preoccupate per i rischi
derivanti dal piano Aukus per la costruzione di sottomarini nucleari" tra Usa,
Gran Bretagna e Australia. Lo riporta la Tass.
17:58
Xi-Putin, fermare
tensioni per evitare che crisi peggiori
Il presidente
cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin "hanno chiesto di fermare
tutte le mosse che portano a tensioni e al protrarsi dei combattimenti per
evitare che la crisi peggiori o addirittura vada fuori controllo". Lo scrive in
un tweet la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. I due
leader "si oppongono a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", si legge ancora nel tweet.
18:06
Media, Usa
accelerano invio Patriot a Kiev
Gli Stati Uniti
invieranno sistemi missilistici Patriot in Ucraina più velocemente di quanto
inizialmente previsto. Lo riporta la Cnn, citando funzionari della Difesa
americana.
I sistemi di difesa
missilistica Patriot saranno schierati in Ucraina più velocemente di quanto
inizialmente previsto e un gruppo di 65 soldati ucraini completerà il suo
addestramento sui sistemi a Fort Sill, in Oklahoma, nei prossimi giorni, hanno
detto i funzionari statunitensi. Le truppe si sposteranno quindi in Europa per
ulteriore addestramento sui due sistemi Patriot, uno americano e uno costruito
da tedeschi e olandesi, che saranno schierati in Ucraina nelle prossime
settimane, hanno detto i funzionari ai giornalisti a Fort Sill.
18:33
Zelensky ha
"invitato" Xi a dialogo,attende risposta
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver "invitato" la Cina al dialogo e
di "aspettare una risposta". Lo ha fatto sapere mentre il presidente cinese Xi
Jinping è a Mosca per suggellare la sua alleanza con Vladimir Putin. "Abbiamo
offerto alla Cina" di collaborare alla ricerca di una soluzione del conflitto in
Ucraina, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa. "Vi invitiamo al
dialogo, attendiamo una vostra risposta". Il presidente ucraino ha aggiunto di
aver "ricevuto segnali, ma niente di concreto". In precedenza la presidenza
ucraina aveva fatto sapere che sono in corso contatti perchè ci sia una
telefonata tra Xi e Zelensky ma che ancora non c'è nulla di concreto.
18:51
Zelensky parteciperà
in collegamento a vertice Hiroshima
Il presidente
ucraino Voldymyr Zelensky parteciperà in collegamento al G7 che si terrà a
maggio a Hiroshima, in Giappone. "Ho accettato l'invito del primo ministro
giapponese e parteciperò al vertice in formato online", ha detto Zelensky. Lo
riporta Ukrainska Pravda.
19:21
Pentagono, drone
caduto nel Mar Nero non è stato recuperato
Il drone Usa MQ-9
caduto nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da due caccia russi "non è
stato recuperato". Lo ha riferito il portavoce del Pentagono, il generale Pat
Ryder, sottolineando che il velivolo era caduto in acque molto profonde.
19:31
Pentagono conferma
accelerazione su Abrams e Patriot
Il portavoce del
Pentagono Pat Ryder ha confermato in una conferenza stampa le anticipazioni di
stampa sull'intenzione degli Usa di accelerare il più possibile la fornitura
della versione più vecchia degli Abrams e di missili Patriot a Kiev.
19:40
Zelensky-Kishida
firmano dichiarazione su partnership speciale
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro giapponese Fumio Kishida hanno
firmato oggi a Kiev una dichiarazione congiunta sulla partnership speciale
globale fra i due paesi. Lo riferisce Ukrinform. "Il documento riflette i nostri
valori, che intendiamo difendere assieme, e le nostre aspirazioni, che dobbiamo
realizzare. Abbiamo raggiunto i più significativi rapporti in più di 30 anni, ma
sono solo le fondamenta di quanto possiamo ottenere in futuro", ha detto
Zelensky.
20:05
Zelensky, "nessuna
conferma telefonata con Xi"
Niente di specifico
(è stato deciso). Non abbiamo ancora una conferma". Così il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva
di una sua possibile telefonata con il presidente cinese Xi Jinping. Lo
riferiscono i media ucraini. "Abbiamo trasmesso la nostra formula di pace alla
Cina sia pubblicamente che tramite canali diplomatici e l'abbiamo invitata a
prendere parte alla sua realizzazione. Aspettiamo la risposta", ha detto ancora
Zelensky, mentre Xi si trova a Mosca dove ha incontrato il presidente
russo Vladimir Putin.
20:28
Casa Bianca, Cina
non ha posizione imparziale sulla guerra
La Cina non ha una
posizione imparziale sulla guerra in Ucraina e se vuole giocare un ruolo
costruttivo dovrebbe sollecitare la Russia a mettere fine al conflitto: lo ha
detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby,
aggiungendo che rispettare la carta Onu significa che Mosca deve ritirarsi da
tutta l'Ucraina.
20:33
Casa Bianca,
Cina-Russia vorrebbero mondo con loro regole
La Cina e la
Russia vorrebbero vedere il mondo giocare con le loro regole: lo ha detto il
portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, aggiungendo
che non definirebbe la relazione tra i due Paesi come un'alleanza. Ieri l'aveva
definita "un matrimonio di interessi".
20:35
Casa Bianca, da
società cinesi materiale dual use a Mosca
Alcune società
cinesi hanno fornito materiale ad uso duale (militare e civile) alla Russia: lo
ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby.
20:41
Kiev, missile russo
sulla regione di Odessa: ci sono feriti
Le forze russe hanno
lanciato un attacco missilistico sulla regione di Odessa. Lo ha riferito
l'amministrazione militare del distretto, spiegando che un edificio residenziale
è stato danneggiato e ci sarebbero feriti. "Grazie all'efficace prestazione
delle nostre forze di difesa aerea, alcuni missili sono stati abbattuti, ma uno
è caduto e un edificio residenziale è stato parzialmente danneggiato. Ci sono
vittime, ma nessuno è rimasto ucciso", si legge in una nota.
Secondo le autorità
ucraine, i missili sono stati lanciati da caccia Su-35 dal mare.
20:55
Casa Bianca, Putin
ha carenze belliche, tregua lo aiuterebbe
Putin "ha difficoltà
di risorse belliche, un cessare il fuoco congelerebbe la linea del fronte
dandogli tempo e modo di riorganizzarsi": lo ha ribadito il portavoce del
consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby.
21:27
Iran: pronti a
rafforzare la cooperazione energetica con mosca
L'Iran è pronto a
rafforzare la cooperazione con la Russia nel settore energetico. Lo ha detto il
ministro dell'Economia iraniano, Ehsan Khandouzi, in un'intervista rilasciata
all'agenzia di stampa russa Ria. "La prospettiva di una cooperazione nel settore
delle nuove energie e delle fonti energetiche rinnovabili, così come nell'ambito
di altri tipi di energia, compresa l'energia nucleare pacifica, suscita
certamente grande interesse e motivazione per rafforzare le relazioni economiche
con la Russia", ha affermato Khandouzi. Come ricorda la ria, la Russia è oggi
impegnata nella costruzione della seconda unità della centrale nucleare di
bushehr, nel sud-est dell'Iran, dopo aver completato la prima unità, collegata
alla rete elettrica iraniana nel settembre 2011. Ed è già stato firmato un
contratto per la costruzione della terza unità.
21:48
Zelensky, serve
rapidità nelle sanzioni contro Mosca
Il
presidente Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa odierna in
Ucraina con il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è detto convinto che
le nuove sanzioni contro la Russia "dovrebbero essere introdotte più rapidamente
rispetto alla velocità con la quale la Russia si adegua a tali restrizioni". Lo
ha riferito un corrispondente di Ukrinform. Zelensky ha ringraziato il Giappone
per aver sostenuto gli sforzi per creare un tribunale speciale per il crimine di
aggressione russa, nonché per la sua disponibilità a cooperare nell'attuazione
dei punti della formula di pace ucraina.
21:59
Accordo Ucraina-Fmi
su piano aiuti da 15,6 miliardi
Lo staff del Fondo
Monetario Internazionale ha raggiunto un accordo con l'Ucraina per un piano di
aiuti da 15,6miliardi di dollari. L'intesa deve essere ora approvata dal board
del Fmi che dovrebbe esaminarla nelle prossime settimane
22:34
Zelensky: "Vinceremo
nel Donbass e riprenderemo la Crimea"
Il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo paese "vincerà l'eroica
battaglia per il Donbass, il confronto nel sud e riprenderà la Crimea". Lo
riporta Unian, precisando che il leader ucraino nel suo videomessaggio serale ha
sottolineato che dalla penisola della Crimea è già iniziata la migrazione dei
"topi più lungimiranti dello Stato terrorista" russo.
La Wagner arruola
ex soldati dell’esercito afghano per farli combattere in Ucraina.
Mauro Indelicato
il 21 marzo 2023 su Inside Over
Immagini da un
passato recente che tornano sullo sfondo di un presente sempre più tribolato.
Quei video dove migliaia di afghani, nell’agosto del 2021, assaltavano
letteralmente gli aerei per fuggire da Kabul durante l’avanzata talebana oggi
potrebbero tornare di attualità. Ed entrare anche nello scacchiere ucraino. Tra
chi provava a fuggire infatti, c’erano soldati dell’ex esercito
afghano, dissoltosi con il ritorno al potere degli studenti coranici. Adesso
molti di quei soldati potrebbero essere impiegati tra le posizioni russe in
Ucraina, agli ordini della Wagner.
Dall’Afghanistan
alle trincee nel Donbass
L’arrivo di ex
soldati afghani in Ucraina è stata resa nota nelle scorse ore da AgenziaNova. A
rivelarlo alcune fonti afghane che hanno spiegato cosa è avvenuto nel Paese dopo
l’avvento dei talebani. In particolare, mentre i vertici del dissolto esercito
afghano sono riusciti a trovare protezione negli Usa o nei Paesi Nato, gli
stessi che dal 2001 al 2021 hanno sostenuto con soldi, armi e addestramento le
truppe di Kabul, soldati semplici e quadri intermedi invece non hanno trovato
molte vie di scampo.
E così, per evitare
di finire nel mirino dei talebani, in molti hanno deciso di scappare nei Paesi
più vicini. In primis, nel confinante Iran. Secondo le fonti sentite da
AgenziaNova, tra i ventimila e i trentamila soldati dell’ex esercito afghano
hanno trovato rifugio in territorio iraniano. E ora potrebbero rappresentare una
preziosa risorsa per l’agenzia di contractors russi della Wagner.
La società di Evgeny
Prigozhin si starebbe muovendo infatti per reclutare quanti più ex soldati
afghani possibile. “Anche se ancora non si è ai livelli di un reclutamento di
massa – hanno fatto sapere le fonti afghane – presto però questa eventualità
potrebbe concretizzarsi”. Già oggi alcuni ex militari di Kabul sarebbero tra le
trincee scavate dai russi nel Donbass. Pronti a combattere contro gli ucraini.
Il ruolo dell’Iran
A Teheran sarebbero
ben consapevoli di questa situazione. E, anzi, i vertici della Repubblica
Islamica starebbero favorendo l’afflusso di ex combattenti afghani verso le
posizioni russe. Il tutto favorito dalla necessità dei membri del dissolto
esercito di Kabul di tornare ad avere mezzi di sostentamento per le proprie
famiglie. Una volta fuggiti dall’Afghanistan, molti di loro hanno iniziato a
vivere in clandestinità in Iran. Oppure lavorando per pochi Dollari al mese, con
poche prospettive e con molte difficoltà a pagare anche un piccolo alloggio.
La Wagner invece
assicurerebbe stipendi da 1.500 o duemila dollari al mese. A livello economico,
una vera e propria svolta per molti ex soldati. I quali quindi preferiscono
tornare a indossare una divisa piuttosto che rimanere in Iran. Dal canto suo, il
governo di Teheran in questo modo può assicurare un ulteriore appoggio alla
Russia. Del resto, il Paese ha già fornito a Mosca droni in grado di penetrare
nelle difese ucraine anche se i vertici militari affermano che quei mezzi, di
cui il Cremlino ha avuto disperatamente bisogno, sono stati venduti prima della
guerra.
Perché i russi
reclutano tra gli afghani
Se la situazione
così prospettata fosse confermata, per la Wagner e per la Russia il reclutamento
di afghani avrebbe un doppio vantaggio. Sotto il profilo economico, la compagnia
di mercenari potrebbe fare affidamento a soldati già addestrati pagandoli molto
meno di combattenti reclutati in patria. Ma è un altro l’aspetto da
sottolineare: gli ex militari afghani sono stati per due decenni addestrati
dalla Nato e hanno quindi dimestichezza con molte armi girate dall’Alleanza
Atlantica agli ucraini. Dal 2001 al 2021, gli Stati Uniti e altri Paesi della
Nato hanno contribuito a formare l’esercito afghano. Poi la fine della missione
nella primavera del 2021 e l’avanzata talebana, hanno comportato il definitivo
abbandono del Paese nell’estate di due anni fa.
Mezzi, razzi e
missili statunitensi e occidentali catturati dai russi sul campo di battaglia,
possono adesso essere facilmente messi in mano agli afghani. Per Kiev, così come
per Washington, si tratta di un dettaglio non indifferente. E che potrebbe far
storcere ulteriormente il naso tra chi, all’interno del Pentagono e della Casa
Bianca, già nell’agosto del 2021 ha valutato come superficiale e negativa la
gestione del ritiro degli Usa dall’Afghanistan. MAURO INDELICATO
Dagospia il 21 marzo
2023.
L’EX PRESIDENTE
UCRAINO PETRO POROSHENKO IN UN INTERVENTO SU “FORMICHE” SUGGERISCE ALCUNE MOSSE
PER SCONFIGGERE LA RUSSIA DI PUTIN: BLOCCARE LE PETROLIERE FANTASMA DEL REGIME,
INTERVENIRE SUL CANALE DI SUEZ E SULL’OLEODOTTO DRUZHBA – “IL PRESIDENTE RUSSO
STA PORTANDO LA GUERRA PIÙ VICINO ALLE SUE ELEZIONI DEL 2024, PER PRESENTARSI
COME IL DIFENSORE DELLA RUSSIA CONTRO L’AGGRESSIVO OCCIDENTE…”
Petro Poroshenko
per formiche.net il 21 marzo 2023.
L’inverno se n’è
andato portando con sé la “horror story” preferita dal Cremlino, ovvero che
l’Unione europea sarebbe morta di freddo senza il gas della Siberia. La nuova
era glaciale non è arrivata. Grazie a sforzi ben mirati, i governi sono riusciti
a liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia. I moscoviti hanno perso
l’enorme mercato europeo – un flusso costante di denaro nel bilancio per decenni
che alimenta la gerontocrazia di Putin e le sue aspirazioni neo-imperialistiche.
Alla fine della
stagione invernale il prezzo del gas ha raggiunto un minimo storico. Per la
prima volta dall’agosto 2021 è sceso sotto i 450 dollari per mille metri cubi.
In seguito al forte calo del consumo di gas russo, l’introduzione di un tetto
massimo di prezzo, prima per il greggio poi per i derivati del petrolio, si è
dimostrata una misura molto efficace. Di conseguenza, i ricavi da petrolio e gas
si sono quasi dimezzati nel periodo gennaio-febbraio rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Il deficit del bilancio russo per i due mesi in
corso è quasi pari al deficit previsto per un anno. Pertanto, i russi hanno già
coperto l’88% del piano annuale per questo indicatore.
Colpito dalle
sanzioni, il Cremlino ha intensificato la sua campagna di disinformazione per
convincere il mondo che “le sanzioni non funzionano” e “tutto va secondo i
piani”. Ecco come si presenta il bluff del Cremlino. Il Cremlino ha spaventato
il mondo con la natura prolungata del conflitto, cercando di ridurre il sostegno
pubblico alle sanzioni nelle società occidentali e di influenzare gli elettori
nei Paesi democratici. L’anno prossimo si terranno importanti elezioni negli
Stati Uniti e nell’Unione europea. Putin sta portando la guerra più vicino alle
sue elezioni del 2024, per presentarsi come il difensore della Russia contro
l’aggressivo Occidente. La guerra è stata trasformata nella sua bandiera
elettorale e quello che considera il suo asso nella manica dovrebbe essergli
tolto dalle mani quest’anno.
Se scorriamo il
lungo elenco di centinaia di sanzioni nel corso dell’anno, è chiaro che ci sono
tre blocchi principali che hanno portato sofferenze e problemi al Cremlino. Tra
queste, il congelamento dei beni statali russi per un valore di oltre 300
miliardi di dollari e dei beni dei russi presenti nella lista di Forbes;
l’esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift; le misure restrittive
contro il settore energetico russo, che un tempo forniva la metà delle entrate
del bilancio russo. Tutto indica dove colpire per infliggere il massimo danno
alla macchina da guerra dell’aggressore.
In primo luogo, è
tempo di escludere le banche russe rimanenti dal sistema Swift e di congelare
tutti i pagamenti internazionali del Paese aggressore e della cerchia di Putin.
La prospettiva della deswiftizzazione riguarderà tutti quei Paesi che sostengono
la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Così come tutti gli istituti
bancari di qualsiasi Paese che aiuti deliberatamente il regime di Putin ad
aggirare le sanzioni e a sponsorizzare il genocidio degli ucraini.
In secondo luogo,
tutti i beni congelati della Federazione Russa e degli oligarchi russi
dovrebbero essere concentrati in un fondo trasparente sotto le indicazioni degli
Stati Uniti e dell’Unione europea, per garantire la trasparenza e impedire che
finiscano nelle mani di funzionari corrotti. Questo fondo dovrebbe essere
interamente dedicato al sostegno dell’Ucraina.
In terzo luogo,
dovremmo liberarci del petrolio e del gas russo in tutte le sue forme, prezzi,
modalità e vie di consegna. Il ricatto della Russia non dovrebbe essere preso in
considerazione. Si tratta di una quota pari al 7% del mercato petrolifero
globale, che può essere sostituita dagli Emirati Arabi Uniti, dall’Arabia
Saudita, per esempio. Per quanto riguarda i derivati del petrolio, circa il 30%
della capacità di raffinazione globale rimane libera. Il mercato globale si sta
adattando alle sanzioni contro la Russia senza alcuno shock per gli operatori.
A seguito del
congelamento degli asset, la liquidità delle riserve valutarie russe è di soli
120 miliardi di dollari (contro i 650 miliardi di dollari di prima della
guerra). E anche questo saldo potrebbe esaurirsi già a novembre-dicembre, se
l’attuale tendenza alla riduzione delle riserve dovesse continuare.
Ovviamente, con una
grave carenza di denaro, Putin darà priorità alle spese per la sua “guerra
santa” e chiederà ai pensionati e ad altre categorie che dipendono dal bilancio
di essere pazienti e di tirare la cinghia. È importante che Putin appaia ai suoi
connazionali come un leader incapace di rispettare il suo contratto sociale, che
è alla base del sostegno pubblico in Russia all’aggressione contro l’Ucraina e
al confronto con il mondo democratico.
Tuttavia, non
bisogna aspettarsi che le truppe ucraine “brucino Mosca”. Il Cremlino deve
cadere a causa delle turbolenze interne alla Russia stessa, dovute all’emorragia
dei ricavi delle esportazioni di energia, al picco delle importazioni, all’alta
inflazione e al crollo del prodotto interno lordo. Il mostro della guerra,
scatenato da Putin, deve divorare il suo regime.
Come possiamo
raggiungere questo obiettivo?
Primo. Il tetto
massimo dei prezzi del greggio e dei prodotti derivati deve essere ridotto
costantemente.
Secondo. Occorre
fissare una quota di fornitura e un tetto massimo di prezzo per i progetti russi
di gas naturale liquefatto, che sono diventati una miniera d’oro per finanziare
l’esercito di Putin e le sue tasche private.
In terzo luogo, il
Canale di Suez dovrebbe essere chiuso ai carichi di petrolio e raffinerie di
origine russa. Il percorso intorno all’Africa è più lungo, il trasporto è più
costoso, il numero di petroliere è maggiore, i costi logistici sono più alti e i
profitti sono più bassi.
Quarto. Il ramo sud
dell’oleodotto Druzhba, che ancora arricchisce la Russia di 4 miliardi di
dollari all’anno, deve essere interrotto. Si potrebbero sviluppare alternative
per l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Per esempio, può essere un
percorso attraverso la Croazia per coprire il loro fabbisogno.
Quinto. Proponiamo
di imporre sanzioni non solo all’enorme flotta di petroliere ombra russe, ma
anche di imporre sanzioni secondarie a coloro che acquistano il petrolio
trasportato da queste navi. Allo stesso tempo, queste navi dovrebbero essere
identificate come russe non solo dalla loro bandiera, ma anche dai loro reali
proprietari effettivi finali. La lotta contro la flotta di petroliere ombra è
importante anche perché, oltre a violare il regime di sanzioni, genera miliardi
di dollari di entrate illecite per tangenti e finanziamenti occulti, comprese le
spese militari per l’aggressione all’Ucraina e all’intero mondo civilizzato.
Ecco qualcosa da fare anche per il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.
Le nostre Forze
Armate hanno esortato sia gli ucraini sia i decisori occidentali a fornirci
sempre più armi. La priorità assoluta è rappresentata da proiettili e altre
munizioni, artiglieria, carri armati, jet da combattimento e missili a lungo
raggio. Le decisioni fondamentali vengono prese sul campo di battaglia a costo
di perdite umane, ed è importante che i partner occidentali aumentino la
fornitura di armi all’Ucraina. Ma per salvare il maggior numero possibile di
vite umane, dobbiamo adottare misure per dissanguare economicamente la Russia e
tagliare i finanziamenti alla sua macchina da guerra.
Tank russi in
Ucraina: Mosca manda i vecchi T-54 verso il fronte?
Paolo Mauri il 23
marzo 2023 su Inside Over.
Nella giornata di
mercoledì 22 marzo, sono apparse online immagini di carri armati
russi T-54 e T-55 caricati su treni che potrebbero essere diretti verso il
fronte ucraino. Nella fattispecie, si tratta di due versioni del T-54: la 3 (del
1951) e la B (del 1959). A tal proposito è singolare che, nelle riprese, il
fondo sia stato oscurato, come a voler impedire qualsiasi tipo di
geolocalizzazione da parte di esperti di Osint (Open Source Intelligence).
Attualmente non
possiamo sapere se i tank siano in viaggio verso l’Ucraina oppure in movimento
per raggiungere la Uralvagonzavod, la principale fabbrica russa (situata nella
zona degli Urali) che produce gli Mbt (Main Battle Tank) per l’esercito di
Mosca, o sue affiliate, per effettuare lavori di modernizzazione.
La storia del T-54
Il T-54 entra a far
parte dell’Armata Rossa a partire dal 1949 e ha un disegno originale che risale
al 1944. Ne sono state costruite alcune varianti in numerosissimi esemplari: in
totale circa 35 mila T-54 sono usciti dalle fabbriche sovietiche per
equipaggiare gli eserciti del Patto di Varsavia e di altri alleati e partner
dell’Urss sparsi per il mondo. In particolare la versione nota come T-54-3
risale al 1950 entrata in servizio l’anno successivo. La torretta, in questo
carro armato, è stata rimodellata dandole la caratteristica forma a cupola e
dotata di un nuovo mirino telescopico, ma il pezzo principale è rimasto
il cannone da 100 millimetri della serie D-10, con le rispettive munizioni
stoccate in torretta, come classicamente avviene per i carri sovietici/russi, e
nello scafo.
L’armamento
secondario è costituito da una mitragliatrice antiaerea da 12,7 millimetri e una
coassiale rispetto al cannone da 7,62. Anche qui l’equipaggio è di quattro
uomini (capocarro, artigliere, servente e pilota) e il motore è rappresentato da
un diesel V12 raffreddato a liquido da 520 cavalli di potenza. Il peso
complessivo in assetto di combattimento si aggira intorno alle 38 tonnellate per
una velocità su strada di 55 Km/h e un’autonomia di 340/400 chilometri. La
produzione totale per questo modello si è estesa dal 1952 al 1955.
Il T-54B viene
ideato nel 1957 ed entra in servizio due anni più tardi. L’innovazione
principale, in questo carro armato, risiede in un sistema di stabilizzazione del
tiro su due assi che però non risolve i problemi di precisione della serie “54”,
il cui pezzo principale (sempre da 100 millimetri) è molto impreciso durante il
tiro in movimento. Nel 1959, ai T-54B viene fornito un sistema a infrarossi per
la visione notturna ed è stato prodotto sino a tutto il 1958.
A metà degli anni
Cinquanta un’ulteriore modernizzazione del T-54 dà vita al T-55: questo carro
armato possiede un nuovo propulsore (il V-55 da 581 cavalli), una corazzatura
più spessa e un sistema di protezione NBC (Nuclear Biological Chemical) di base
per l’equipaggio. Si stima che ne siano usciti 27 mila esemplari dalle fabbriche
sovietiche complessivamente, quindi per tutti i Paesi utilizzatori, e forse
rappresenta il carro più longevo per quanto riguarda la produzione, che è
terminata solo nel 1981.
Entrambi i carri
armati possono usare munizionamento He (High Explosive) e il T-55 anche l’Heat
(High Explosive Anti Tank). I carri hanno una spessa corazzatura ma non sono
dotati di protezione reattiva, quindi risultano vulnerabili ai colpi Ap (Armour
Piercing) e a un certo tipo di munizionamento a carica cava. Innumerevoli le
guerre e i conflitti a cui hanno partecipato: dai più sconosciuti sino alla
Prima guerra del Golfo del 1991, dove peraltro hanno dimostrato tutti i loro
limiti in combattimento insieme ai T-62 trovandosi ad affrontare carri moderni
come gli statunitensi M1A1 Abrams.
Tank obsoleti e
inadeguati?
Sia i T-54/55 sia i
T-62 hanno poche chance di sopravvivere anche a uno scontro coi più moderni
T-72, utilizzanti munizionamento HEAT e APFSDS (Armour Piercing Fin Stabilized
Discarding Sabot) in più i T-54/55 non potendo utilizzare la stessa tipologia di
colpi (eccezion fatta per gli HEAT) sono quasi del tutto inutili in un confronto
tra carri armati.
I T-62 sono già
presenti da tempo sul campo da battaglia ucraino: a fine maggio vi avevamo
raccontato dell’arrivo di questi tank al fronte. I T-62 sono stati tenuti in
servizio attivo fino all’inizio degli anni 2010, pertanto rimangono il tipo di
Mbt che ha la prontezza operativa più alta nei depositi di carri armati russi.
Negli anni ’80, sul finire della Guerra fredda, i T-62 erano stati ritirati
dalle divisioni sovietiche di prima linea e vennero assegnati a unità di seconda
e terza linea: in quegli anni questi carri erano in servizio nei distretti
militari della parte asiatica dell’Urss, lasciando quindi quelli più moderni a
occidente.
La Russia, grazie
alla filosofia di immagazzinamento dei propri veicoli corazzati e blindati, può
contare su immensi depositi ereditati dall’Unione Sovietica che li ospita in tre
diversi livelli di prontezza. Pertanto è ragionevole pensare che, qualora i
T-54/55 siano diretti verso l’Ucraina, l’esercito russo abbia già provveduto da
mesi al loro ricondizionamento per poter essere impiegati in battaglia.
Come detto, questi
carri armati non sono molto utili per affrontare gli Mbt avversari, infatti la
Russia in questo conflitto sta usando i T-62 principalmente come “pezzi di
artiglieria campale mobili”, ovvero come i normali obici e cannoni trainati.
Questo, se da un
lato permette di ammassare un notevole volume di fuoco in breve tempo, a
discapito di penetrazione (che per truppe e ricoveri improvvisati non serve) e
precisione (quest’ultima però ovviata dalla concentrazione di fuoco stesso),
dall’altro accorcia rapidamente la vita utile delle canne. Il pezzo principale
di un carro armato non è concepito per un volume di fuoco sostenuto, come la
canna di un obice ad esempio, quindi la sua anima si consuma più velocemente e
necessita di essere cambiata con più frequenza obbligando a far rientrare il
carro in fabbrica (o centro logistico principale), ove si procede al
sollevamento della torretta e alla sostituzione del pezzo. Risulta pertanto
probabile che anche i T-54/55 verranno impiegati, se vedranno il fronte, allo
stesso modo. PAOLO MAURI
Droni sulla regione
di Kiev. Zelensky visita le truppe a Bakhmut. Lorenzo Cremonesi, inviato, Paola
Caruso, Paolo Foschi e Redazione Online su Il Corriere della Sera il 22 Marzo
2023
Le notizie sulla
guerra di mercoledì 22 marzo, in diretta. Colpito un edificio residenziale a
Rzhyshchiv: almeno 8 i morti. Xi Jinping è tornato in Cina. Il presidente
ucraino al fronte: «Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale»
19:45
I militari russi
lamentano ritardi nel pagamento dei salari, alcuni non lo avrebbero mai ricevuto
I soldati russi in
Ucraina lamentano ritardi nel pagamento dei salari, con alcuni che non sono mai
stati pagati.
Lo riferisce
l’outlet indipendente Verstka, rilanciato da Moscow Times. I ritardi vengono
segnalati da familiari di soldati in tutte le 52 regioni russe e la Crimea,
scrive Verstka, basandosi sull’esame di chat e pagine tematiche del social russo
Vkontakte. Le lamentele provengono dai soldati professionisti, volontari che si
sono arruolati, così come da quanti sono stati mobilitati a settembre.
19:59
L’avvertimento di
Stoltenberg: «Prepariamoci a sostenere Kiev in una lunga guerra»
L’Occidente deve
prepararsi a sostenere Kiev per molto tempo a venire. L’avvertimento arriva dal
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista rilasciata al
Guardian.
Secondo il numero
uno dell’alleanza, Putin è impegnato in «una guerra di logoramento» e la
battaglia attorno a Bakhmut, nella quale molti russi stanno morendo, dimostra
che Mosca è disposta «a lanciare migliaia e migliaia di truppe in più, a subire
molte perdite per guadagni minimi».
Per sostenere Kiev,
dunque, Stoltenberg si augura che i membri della Nato accettino di spendere
almeno il 2% del Pil per la difesa al prossimo vertice dell’alleanza, che avrà
luogo a Vilnius, la capitale della Lituania. «Il presidente Putin non pianifica
la pace, sta pianificando altra guerra», ha continuato Stoltenberg, aggiungendo
che la Russia sta aumentando la produzione industriale militare e «si rivolge a
regimi autoritari come l’Iran o la Corea del Nord e altri per cercare di
ottenere più armi». Di conseguenza, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia,
la Germania e altri Stati occidentali devono essere pronti a sostenere l’Ucraina
con armi, munizioni e pezzi di ricambio per lungo tempo.
20:38
Medvedev: «Armi
straniere all’Ucraina avvicinano l’apocalisse nucleare»
«La minaccia del
conflitto nucleare non è passata, ma sta crescendo». A dirlo è il vice capo del
Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, secondo quanto riporta Ria
Novosti. «La fornitura di armi straniere all’Ucraina avvicina all’apocalisse
nucleare», ha poi aggiunto.
20:46
Usa: «Ridicolo e
offensivo il premio di Putin ai piloti russi coinvolti nell’incidente del drone»
«Ridicola e
offensiva». Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John
Kirby, ha definito così la decisione di Vladimir Putin di decorare come eroi i
piloti dei due jet russi che hanno costretto il drone spia americano a
schiantarsi nel Mar Nero.
21:04
Si aggrava il
bilancio dell’attacco russo nella regione di Kiev: «Almeno 8 morti»
Sono almeno otto le
persone uccise nel corso di un attacco di droni russi nella regione di Kiev. A
renderlo noto è il servizio di emergenza statale ucraino. Si contano anche sette
feriti ed «è probabile che quattro persone siano sotto le macerie».
Questa mattina, i
droni russi hanno colpito un edificio residenziale nella città di Rzhyshchiv,
che si trova a circa 85 chilometri a sud-est della capitale.
21:20
Erdogan: «Tra 2-3
giorni avrò un’altra telefonata con Putin»
«Nei prossimi due o
tre giorni ho intenzione di avere un’altra conversazione con Putin». Lo ha detto
il presidente turco Erdogan all’emittente Ntv. Il presidente turco ha aggiunto
di aver discusso attivamente con Putin dell’attuazione del cosiddetto accordo
sul grano e della possibilità di lavorare il grano russo nei mulini turchi per
poi inviarlo ai paesi africani più poveri.
21:36
Le Figaro: «Piloti
ucraini addestrati in Francia». Ma Kiev smentisce
Oggi pomeriggio il
quotidiano Le Figaro ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui la Francia
starebbe addestrando da un mese e mezzo una trentina di piloti ucraini a usare i
caccia multiruolo Mirage 2000. Le operazioni avrebbero luogo, secondo il
giornale transalpino, nelle basi aeree di Mont-de-Marsan e Nancy.
La notizia è stata
però smentita dal portavoce dell’aviazione ucraina, Yurii Ihnat: «Voglio
smentirla immediatamente perché non vi sia distorsione dei fatti», ha affermato,
citato da Ukrainska Pravda. Inhat ha poi aggiunto che diversi stati hanno
offerto loro siti per «possibili, potenziali e futuri addestramenti di questo
tipo, che verranno scelti collettivamente in consultazione con i nostri
partner. In Francia sono stati addestrati osservatori aerei e vi sono stati
corsi di sopravvivenza per aviatori, ma non parliamo di addestramento di
equipaggi di volo», ha sottolineato.
21:46
Kirby: «Washington
non fornisce munizioni all’uranio impoverito all’Ucraina»
Gli Stati Uniti non
forniscono all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito e non commentano la
«decisione sovrana» di Londra. A dirlo è il portavoce del Consiglio per la
Sicurezza nazionale statunitense John Kirby, precisando tuttavia che si tratta
di un tipo di munizioni «comuni», utilizzate per le loro capacità perforanti, ed
escludendo che costituiscano una «minaccia radioattiva».
21:52
Il Canada estende il
termine per il visto d’emergenza: i rifugiati ucraini potranno fare domanda fino
al 15 luglio 2023
I rifugiati ucraini
avranno tempo fino al 15 luglio 2023 per richiedere il CUAET, il visto
d’emergenza per raggiungere il Canada. L’estensione del termine ultimo per
presentare le domande è stata annunciata oggi dal ministro dell’Immigrazione
Sean Fraser.
«Mentre la Russia
continua la sua illecita e ingiustificata invasione dell’Ucraina - si legge in
un comunicato del governo di Ottawa -, il Canada rimarrà determinato ne l
supportare chi è costretto a fuggire. Questo include aiutare queste persone a
trovare un rifugio sicuro temporaneo in Canada».
22:06
Lituania: «La Cina è
un intermediario inaffidabile per la pace in Ucraina»
«La proposta della
Cina di fare da intermediario per arrivare alla pace in Ucraina non è sincero. È
improbabile che l’Ucraina si fidi di un tale intermediario che sta considerando
molto seriamente la possibilità di fornire armi alla Russia». Lo ha affermato
questa sera il presidente lituano Gitanas Nauséda durante un intervento
televisivo.
Il capo di Stato ha
osservato che la visita di Xi Jinping a Mosca rappresenta «un segnale che viene
inviato proprio nel momento in cui la Corte penale internazionale ha deciso di
emettere un mandato di arresto per Putin. Si tratta di un segnale davvero
preoccupante e inaccettabile».
22:54
Ron DeSantis: «Putin
è un criminale di guerra»
Vladimir Putin è un
«criminale di guerra» e va «processato» per l’invasione dell’Ucraina. Lo avrebbe
affermato Ron DeSantis, probabile candidato per la nomination repubblicana 2024,
ospite del programma “Piers Morgan Uncensored” in onda domani su Fox Nation. A
far trapelare l’anticipazione è stato il New York Post.
Per il governatore
della Florida si tratterebbe di un deciso cambio di registro rispetto ai recenti
commenti nei quali aveva definito il conflitto in Ucraina una «disputa
territoriale» tra Mosca e Kiev, in cui gli Usa non dovrebbero lasciarsi più
coinvolgere. Per quei giudizi, DeSantis era stato criticato anche da alcuni suoi
colleghi di partito, come i senatori Marc Rubio e Lindsay Graham.
23:09
Pechino: «Con la
Russia rapporti di buon vicinato e fiducia. Certi paesi ostacolano negoziati di
pace in nome dei loro interessi»
I rapporti tra Cina
e Russia potrebbero rivelarsi ancora più importanti in virtù
«dell’unilateralismo e dell’egemonismo imperanti». Lo ha detto il ministro degli
Esteri cinese, Qin Gang, ripreso dalla CNN.
«Certi
paesi ostacolano deliberatamente i negoziati di pace in nome dei loro
interessi geopolitici, e inventano ogni sorta di voci e falsità per attaccare e
screditare la Cina», ha affermato.
Qin Gang ha poi
elogiato la visita di Xi Jinping a Mosca, definendola una mossa politica presa
dopo attenta riflessione, e ha affermato che Cina e Russia continueranno a
mantenere «rapporti di buon vicinato e fiducia reciproca».
Guerra Ucraina -
Russia, le news del 22 marzo.
La Repubblica. L' Aiea, dopo l'attacco a Zaporizhzhia: "Sicurezza della centrale
è precaria"
Nessun progresso,
sul fronte diplomatico, dalla visita di Xi al Cremlino. Mentre si rischia
un'escalation sul fronte militare: ira di Mosca per le munizioni Gb con uranio
impoverito. Il Pentagono accelera sugli Abrams e i Patriot
La visita a Mosca
di Xi Jinping è terminata. Il presidente cinese è ripartito stamattina e da
Washington arriva una secca bocciatura del suo ruolo di peacemaker. Mentre la
stampa Usa parla di forniture - da parte di Pechino alla Russia - di materiale a
uso duale: militare e civile.
A rendere ancora più
tesa la crisi c'è la notizia dei proiettili all'uranio che Londra invierà a
Kiev. Scatenando l'ira di Mosca: "Avvicinano lo scontro nucleare". Anche il
Pentagono accelera: gli Abrams saranno consegnati all'Ucraina entro l'autunno.
Intanto Mosca afferma di aver respinto un attacco con i droni a Sebastopoli.
Punti chiave
12:42
Zelensky a Bakhmut
ringrazia i soldati: "Proteggete sovranità dell'Ucraina"
09:15
Zelensky: "Raid
criminali nella notte con i droni iraniani assassini"
06:19
Mosca: "Respinto
attacco a Sebastopoli"
04:15
Patriot, soldati
ucraini stanno ultimando la preparazione
00:00
Pentagono: gli
Abrams a Kiev entro l'autunno
00:00
Pentagono: gli
Abrams a Kiev entro l'autunno
Il Pentagono ha
annunciato che l'Ucraina riceverà i carri armati Abrams in "tempi accelerati".
Comunque entro l'autunno. Sarà fornita la versione M1-A1, meno aggiornata
rispetto agli M1-A2. I tank daranno all'Ucraina - ha spiegato il portavoce Pat
Ryder - "una capacità molto simile agli M1A2" che sarebbero stati disponibili
solo nel 2024.
00:36
Zelensky: "Vinceremo
nel Donbass e riprenderemo la Crimea"
Dal presidente
ucraino Volodymyr Zelensky arrivano proclami riferiti al fronte militare. Nel
suo discorso serale, ha affermato che il suo paese "vincerà l'eroica battaglia
per il Donbass, il confronto nel sud e riprenderà la Crimea". Ed ha aggiunto che
dalla Crimea è "già iniziata la migrazione dei topi più lungimiranti dello Stato
terrorista" russo.
00:47
Xi: "Cina obiettiva
e imparziale"
Xi replica alle
critiche che arrivano da Washington. Sul conflitto in Ucraina, la Cina è guidata
dai principi della Carta delle Nazioni Unite e ha un atteggiamento imparziale,
ha detto ai giornalisti il presidente cinese Xi Jinping dopo i colloqui con il
presidente russo Vladimir Putin.
04:15
Patriot, soldati
ucraini stanno ultimando la preparazione
Secondo l'Ap, un
gruppo di 65 soldati ucraini sta ultimando la preparazione per l'utilizzo dei
missili Patriot. Le esercitazioni avvengono in Oklahoma, nel Fort Sill army
post. Il colonnello Martin O'Donnel ha annunciato che i militari ucraini
torneranno in Europa nei prossimi giorni.
06:19
Mosca: "Respinto
attacco a Sebastopoli"
La Marina russa
afferma di aver respinto un attacco di droni su Sebastopoli. Lo ha annunciato il
governatore Mikhail Razvozhaiev su Telegram. "La nostra flotta ha respinto un
attacco di droni di superficie stamattina presto. Tre droni sono stati
distrutti. I droni hanno tentato l'ingresso nella baia, ma la Marina ha sparato.
Sono state allertate anche le difese aeree".
06:58
Xi ha lasciato Mosca
Gli aerei del
presidente cinese Xi Jinping e della delegazione che lo accompagna sono
decollati dall'aeroporto Vnukovo di Mosca. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
Il leader cinese è stato salutato da una guardia d'onore .
07:44
Tre morti in un
attacco di droni nella regione di Kiev
Tre persone sono
morte e altre sette sono rimaste ferite in seguito ad un attacco con droni
lanciato la notte scorsa dalle forze russe nella regione di Kiev: lo ha reso
noto su Telegram l'amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform.
08:13
Proiettili
all'uranio impoverito da Londra, la reazione della Duma: "Una tragedia globale
che colpirà principalmente l'Europa"
"Provocherà una
tragedia globale che colpirà principalmente l'Europa" l'eventuale fornitura di
proiettili con uranio impoverito annunciata dal Regno Unito all'Ucraina. È il
pensiero espresso dal presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin,
sul suo canale Telegram. Volodin ha ricordato che Washington "ha usato
proiettili simili in Jugoslavia e Iraq, che hanno portato alla contaminazione
dell'area, nonché a un forte aumento del cancro tra le persone".
08:19
Ucraina: Kiev
ottiene dall'Fmi pacchetto aiuti da 15,6 mld dlr
Il Fondo monetario
internazionale (Fmi) ha fatto sapere di aver raggiunto una prima intesa con
l'Ucraina per un pacchetto di aiuti quadriennale del valore di circa 15,6
miliardi di dollari. L'accordo, che deve ancora essere ratificato dal board
dell'Fmi, tiene in considerazione il percorso del Paese verso l'adesione all'Ue.
Il 'via libera' definitivo, ha fatto sapere il Fondo, dovrebbe arrivare già
nelle prossime settimane.
09:14
Mosca, 'Usa non
mettano a prova nostra pazienza con droni'
Mosca mette in
guardia gli Stati Uniti dal "mettere alla prova la pazienza" della Russia
continuando i sorvoli di droni sul Mar Nero. Lo ha detto il vice ministro degli
Esteri Serghei Ryabkov. Il diplomatico, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha
affermato che gli Usa "negano cinicamente" il divieto imposto dalla Russia ai
sorvoli un'area del Mar Nero in seguito al conflitto in corso in Ucraina.
09:15
Zelensky: "Raid
criminali nella notte con i droni iraniani assassini"
"Più di 20 droni
iraniani assassini, oltre a missili e numerosi bombardamenti. E questo solo
nell'ultima notte di terrore russo contro l'Ucraina. Ogni volta che qualcuno
cerca di sentire la parola 'pace' a Mosca, lì viene dato un altro ordine per
questi raid criminali". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr
Zelensky, commentando l'ultima tornata di attacchi russi.
"Il successo delle
forze di terra, di cielo e di mare dell'Ucraina avvicina davvero la pace - ha
aggiunto - Il pieno rispetto del regime di sanzioni contro la Russia ripristina
la forza della Carta delle Nazioni Unite. L'unità globale può ripristinare la
stabilità globale".
09:43
Ucraina: Gb conferma
uranio impoverito, procedura "standard"
Il ministero della
Difesa britannico ha confermato che i proiettili perforanti che invierà in
Ucraina contengono uranio impoverito, ma aggiunge che si tratta di una procedura
"standard" e che la utilizza "da decenni".
"È una componente
standard che non ha nulla a che fare con armi o potenziale nucleare", si legge
in una nota del ministero diffusa da Sky News britannica. "La Russia lo sa, ma
sta deliberatamente cercando di disinformare". Tra l'altro, continua la nota,
"uno studio indipendente condotto da scienziati di gruppi come la Royal Society
ha valutato che qualsiasi impatto sulla salute e sull'ambiente derivante
dall'uso di munizioni all'uranio impoverito sarà probabilmente basso".
10:01
Intelligence
britannica: "L'offensiva russa su Bakhmut si sta indebolendo"
"C'è una possibilità
realistica che l'offensiva russa su Bakhmut si stia indebolendo, anche a causa
del ridispiegamento delle forze russe in altri settori". Lo scrive su Twitter il
ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento sulla guerra fra Russia
e Ucraina.
"Nei giorni scorsi
le truppe ucraine hanno lanciato un contrattacco a ovest della città di Bakhmut
- prosegue l'intelligence di Londra - che probabilmente allenterà la pressione
sulla via di rifornimento. I combattimenti continuano nel centro della città, la
difesa ucraina rimane minacciata dal nord e dal sud".
10:20
Papa: "Non
dimentichiamo l'Ucraina, è martoriata, soffre tanto"
"Non dimentichiamo
la martoriata Ucraina che soffre tanto". Lo ha ammonito ancora una volta il
Papa al termine dell'udienza generale nel ricordare che sabato prossimo si
celebra la solennità dell'annunciazione del Signore.
"Il pensiero va al
25 marzo dello scorso anno quando in unione voi Vescovi del mondo si sono
consacrare la Chiesa e l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina al cuore
immacolato di Maria. Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla
Regina della pace".
Bergoglio ha quindi
invitato "ciascun credente, specialmente i gruppi di preghiera a rinnovare ogni
25 marzo l'atto di consacrazione alla Madonna perché è madre e può custodirci
tutti nell'unità e nella pace. In questi giorni non dimentichiamo la martoriata
Ucraina che soffre tanto".
10:32
Filorussi Donetsk:
le forze di Mosca hanno bloccato Bakhmut
L'esercito russo ha
praticamente bloccato Bakhmut. Lo ha affermato Jan Gagin, consigliere del capo
ad interim dell'autoproclamata repubblica di Donetsk. Lo riporta Ria Novosti. Le
truppe russe avrebbero preso il controllo del fuoco di tutte le strade asfaltate
mentre il fango starebbe sta complicando seriamente la consegna di munizioni e
il rifornimento per le forze armate dell'Ucraina.
10:44
Ucraina: Mosca, se
estradato da Italia, Uss in scambio prigionieri con USA
Il vice ministro
degli Esteri russo Sergei Ryabkov non ha escluso la possibilità di includere
l'imprenditore Artem Uss, figlio del governatore della regione di
Krasnoyarsk Alexander Uss, detenuto in Italia su mandato internazionale, nelle
liste degli scambi di prigionieri tra Mosca e Washington in caso di sua
estradizione negli Stati Uniti. Lo riporta la Tass.
"Non so quale sarà
il destino del signor Uss. Spero che tornerà a casa in un modo o nell'altro - ha
detto - abbiamo sempre combattuto e continueremo a combattere per ogni cittadino
della Federazione Russa, fornendo assistenza consolare, proteggendo i suoi
interessi con tutti i mezzi disponibili. Questo, ovviamente, vale per il signor
Uss".
10:49
Cremlino,
dall'Occidente reazione 'ostile' a visita Xi
La Russia critica la
reazione "ostile" dell'Occidente alla visita a Mosca del presidente cinese Xi
Jinping, ma quello che conta per Mosca è "il suo risultato". Lo ha detto il
portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Ria Novosti.
10:50
Droni su regione
Kiev, il bilancio dei morti sale a 4
È salito a quattro
il bilancio delle vittime dell'attacco russo con droni lanciato la notte scorsa
nella città di Rzhyshchiv, a sud-est di Kiev: lo ha reso noto il capo del
dipartimento di polizia della regione della capitale, Andrey Nebitov, come
riporta Unian.
Intanto, il bilancio
dei dispersi à sceso a quattro, dopo che i soccorsi hanno estratto dalle macerie
una persona, ha annunciato su Telegram il servizio di emergenza statale citato
dal Guardian.
11:19
Kiev, la città di
Zaporizhzhia è sotto attacco
La città di
Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, è sotto attacco da parte delle forze
russe: lo ha annunciato su Twitter il capo dell'ufficio del presidente
ucraino, Andriy Yermak.
"I russi stanno
bombardando Zaporizhzhia.Gli edifici residenziali e l'isola di Khortytsia sono
sotto il fuoco nemico", ha scritto Yermak sul suo account.
11:35
Mosca, un morto in
bombardamento ucraino in territorio russo
Una persona è stata
uccisa oggi nella regione russa di Belgorod, confinante con l'Ucraina, in un
bombardamento delle forze di Kiev. Lo ha detto il governatore, Vyacheslav
Gladkov, sul suo canale Telegram. L'artiglieria ucraina, ha precisato Gladkov,
citato dall'agenzia Tass, ha colpito il villaggio di Boriskovka e la maggior
parte degli obici d'artiglieria sono piovuti su una fattoria.
11:48
Lukashenko, "Russia
può darci proiettili con uranio"
La Russia è in grado
di fornire alla Bielorussia "munizioni con vero uranio" se il Regno Unito
trasferirà proiettili con uranio impoverito all'Ucraina: lo ha detto il
presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, stretto alleato di Mosca. "Se loro
(i Paesi Occidentali) sono pazzi, allora si metterà in moto questo processo".
Lukashenko ha avvertito che l'uso di proiettili all'uranio impoverito da parte
delle forze armate ucraine non rimarrà impunito. Lo riporta l'agenzia russa Ria
Novosti.
11:52
Peskov, Putin e Xi
non hanno parlato "piano Zelensky"
Il presidente
russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping non hanno discusso della
formula di pace proposta dal presidente ucraino Volodimir Zelensky. Lo ha detto
il portavoce della presidenza russa Dmitri Peskov nel consueto briefing con la
stampa. "No, il piano di pace ucraino non è stato discusso. C'è stato uno
scambio di opinioni sulle clausole del piano di pace cinese". Secondo Peskov, il
"piano Zelensky" è una questione che devono affrontare Cina e Ucraina.
12:06
Shoigu, "sarà
ammodernata la difesa missilistica di Mosca"
Entro quest'anno la
Russia "completerà l'ammodernamento del sistema di difesa missilistico della
città di Mosca". Lo ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu, citato
dall'agenzia Ria Novosti. "Una delle priorità nello sviluppo delle forze
aerospaziali - ha sottolineato Shoigu - è equipaggiare le truppe con sistemi di
difesa aerea e missilistica".
12:13
Zelensky,
Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale
"Zaporizhzhia. In
questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia
sta bombardando la città con ferocia bestiale. Si spara contro aree residenziali
in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato
terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra
gente". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Voldymyr Zelensky.
12:29
Zelensky visita
fronte orientale vicino a Bakhmut
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, è andato a sorpresa a visitare il fronte orientale
vicino a Bakhmut dove da tempo truppe ucraine e russe si scontrano duramente per
il controllo della città. Lo ha riferito l'ufficio presidenziale di Kiev.
12:42
Zelensky a Bakhmut
ringrazia i soldati: "Proteggete sovranità dell'Ucraina"
"Sono onorato di
essere qui oggi, nell'est del Paese, nel Donbass, e di premiare i nostri eroi,
di ringraziarvi, di stringere le vostre mani. Grazie perché proteggete lo stato,
la sovranità e l'est dell'Ucraina". E' quello che il presidente Volodymyr
Zelensky ha detto ai militari in occasione di una visita a sorpresa alla linea
del fronte nei pressi di Bakhmut.
12:56
Londra, proiettili
con uranio non sono armi nucleari
I proiettili
all'uranio impoverito che Londra vuole inviare all'Ucraina "non sono munizioni
nucleari, sono munizioni puramente convenzionali". Lo afferma il ministro degli
Esteri britannico James Cleverley, come riporta il Guardian. "Quindi non c'è
escalation nucleare. L'unico paese al mondo che parla di questioni nucleari è la
Russia", ha aggiunto Cleverley.
13:09
Mosca, proiettili
uranio impoverito a Kiev passo verso escalation
"La fornitura di
proiettili all'uranio impoverito da Londra a Kiev sarà un ulteriore passo verso
l'escalation". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Lo
riporta la Tass. Secondo Lavrov la fornitura di proiettili con uranio impoverito
a Kiev "ridurrà la capacità dell'Ucraina di produrre cibo di qualità". Inoltre
Mosca "sarà costretta a rispondere tenendo conto della dottrina militare della
Federazione Russa".
13:16
Ucraina: attacco
russo su Zaporizhzhia, un morto e 25 feriti
Il bombardamento
russo di un edificio residenziale nella città di Zaporizhzhia ha fatto un morto
e 25 feriti, tra cui bambini. Lo ha riferito il sindaco Anatoliy Kurtiev,
precisando che i feriti sono stati trasportati in ospedale.
13:34
Kiev, a Zaporizhzhia
2 razzi su palazzo, non target militare
Il condominio di
Zaporizhzhia attaccato oggi dalle forze russe è stato colpito da 2 missili: lo
ha reso noto su Telegram il servizio stampa dell'amministrazione militare della
regione, come riporta Ukrinform. "Nessun obiettivo militare! Due razzi russi
hanno colpito un grattacielo residenziale, un obiettivo strategico per le truppe
di uno Stato terrorista. Un altro crimine di guerra è stato commesso nel bel
mezzo della giornata in una zona di una città con migliaia di persone", si legge
nel messaggio.
13:51
Zaporizhzhia: Aiea,
sicurezza centrale rimane precaria
"La sicurezza
nucleare alla centrale di Zaporizhzhia rimane in uno stato precario. Chiedo
ancora una volta un impegno da tutte le parti per garantire la sicurezza
nucleare e la protezione della centrale". Lo ha detto in una nota il Direttore
generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. L'Agenzia ha anche reso noto che
questa settimana verrà completata la prevista rotazione del personale presso gli
altri quattro impianti nucleari ucraini, le centrali nucleari di Khmelnitsky,
Rivne e dell'Ucraina meridionale, nonché il sito di Chernobyl. Quanto a
Zaporizhzhia invece "i ridotti livelli di personale, combinati con lo stress
psicologico dovuto al conflitto militare in corso, stanno avendo un impatto
sulla sicurezza nucleare e sulla protezione dell'impianto".
14:02
Lavrov, Cpi fa
interessi Occidente e ignora crimini guerra Usa
Il ministro degli
Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato la Corte penale internazionale (Cpi),
che ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo, Vladimir Putin, di
servire gli interessi occidentali e di ignorare i crimini di guerra commessi
dagli Stati Uniti e dalla Nato. "Ora la Cpi è guidata da un procuratore
anglosassone naturalizzato che soddisfa le richieste dei suoi proprietari, che
vietano a questo corpo di giustizia di indagare sui crimini dei Paesi della
Nato", ha detto Lavrov in conferenza stampa a Sochi con il suo omologo
eritreo, Osman Saleh Mohammed.
14:25
Ucraina: salgono a 7
i morti in attacco droni russi su regione Kiev
Salgono a 7 i morti
nell'attacco di droni lanciato dall'esercito russo sulla regione di Kiev. I
soccorritori hanno recuperato i corpi di altre 3 persone da sotto le macerie di
un dormitorio nella città di Rzhishchev, portando così il bilancio a 7. Lo
riporta l'Ukrainska Pravda, citando la portavoce del servizio di emergenza
statale, Victoria Ruban.
14:37
Zelensky fa riunione
sulla sicurezza nella regione di Donetsk
Il presidente
ucraino Voldymyr Zelensky dopo aver visitato il fronte nella linea di Bakhmut ha
svolto un incontro sulla situazione sociale e di sicurezza nella regione di
Donetsk. "Ho ascoltato il rapporto del comando militare sullo stato della
situazione operativa nella zona di responsabilità del gruppo operativo-tattico
Lyman - racconta Zelensky su Telegram - e ho discusso separatamente del
ripristino dell'infrastruttura distrutta, garantendo una fornitura ininterrotta
di acqua ed elettricità".
15:12
Melnyk, chiedere
pace e stop alle armi è fare gioco Russia
"Sono consapevole
che per alcuni politici in Italia e per i loro eletti il tema della fornitura di
armi sta diventato sempre più sensibile.La pace è possibile esclusivamente sulla
base dei principi di diritto internazionale e della carta Onu. Tutte le altre
mezze soluzioni non saranno in grado di garantire una pace vera. E per arrivare
ai negoziati di pace servono le armi. Chiedere la pace in Ucraina e lo stop
all'invio degli aiuti militari significa fare il gioco solo di una parte, la
Russia. Significa chiedere la resa dell'Ucraina". Così l'ambasciatore ucraino in
Italia, Yaroslav Melnyk,in audizione alle commissioni riunite Esteri.
15:32
Mosca, "gli Usa
stanno giocando con il fuoco"
Gli Usa "giocano con
il fuoco" continuando le loro azioni ostili contro la Russia, "non solo in
Ucraina". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri di Mosca Serghei Ryabkov,
aggiungendo che la probabilità di un conflitto nucleare oggi "è più alta di
quanto si è visto negli ultimi decenni". Lo riporta l'agenzia Tass.
15:38
Banca Mondiale, per
ricostruire l'Ucraina servono 411 mld
Per la ripresa e la
ricostruzione dell'Ucraina sono necessari 411 miliardi di dollari. E' una stima
pubblicata oggi dalla Banca Mondiale (BM), dalle Nazioni Unite, dall'Unione
Europea e dal governo ucraino. Mentre i combattimenti continuano, queste
organizzazioni e istituzioni prevedono un bisogno immediato di 14 miliardi di
dollari quest'anno per effettuare "investimenti critici e prioritari" per
avviare la ricostruzione.
15:47
Drone Usa
precipitato, Russia assegna onorificenza ai piloti
Il ministro della
Difesa russo Sergei Shoigu ha assegnato un'onorificenza al merito, 'l'Ordine del
coraggio, ai piloti del caccia Su-27 che si sono confrontati con il drone
americano Mq-9 costringendolo a precipitare nel Mar Nero. Questi piloti russi,
si legge nella motivazione del ministero della Difesa russo, "hanno impedito la
violazione dei confini dell'area delle operazioni militari speciali da parte del
drone americano Mq-9".
16:04
Blinken,Cina non ha
varcato la linea di armi letali a Mosca
"Finora non abbiamo
ancora visto la Cina superare la linea" delle forniture di armi letali alla
Russia per la guerra in Ucraina: lo ha detto il segretario di stato Antony
Blinken in una audizione al Senato. La Cina sta guardando al conflitto in
Ucraina "molto attentamente" e trarrà lezioni da come il mondo si oppone
all'invasione russa, ha continuato Blinken sottolineando che la posta in gioco
nel conflitto in corso va ben oltre l'Ucraina, con un profondo impatto in Asia.
16:21
Fonti Ue, sul piano
munizioni domani non serve l'unanimità
Al Consiglio Europeo
di domani i leader saranno chiamati a dare l'ok politico definitivo al
piano munizioni per l'Ucraina, in modo che poi si possa passare agli atti
legislativi. "Non abbiamo bisogno dell'unanimità, semmai che nessun Paese
blocchi l'iniziativa", spiega un alto funzionario europeo. L'idea è di superare
le possibili incertezze con il metodo "dell'astensione costruttiva".
16:35
Media Cina, Xi
rientrato a Pechino dopo la visita in Russia
Il presidente
cinese Xi Jinping è rientrato direttamente a Pechino dopo aver concluso la sua
visita di Stato di tre giorni nella Federazione Russa, su invito del suo
omologo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Xinhua, ricordando che a bordo
dell'aereo presidenziale c'erano tra gli altri Cai Qi (n.5 del Partito
comunista, membro del Comitato permanente del Politburo e direttore dell'Ufficio
generale del Comitato centrale), Wang Yi (componente del Politburo e capo della
diplomazia del partito) e il ministro degli Esteri Qin Gang.
16:38
Kiev, saliti a 32 i
feriti nell'attacco a Zaporizhzhia
Almeno una persona è
rimasta uccisa e altre 32 sono rimaste ferite per gli attacchi missilistici di
oggi a Zaporizhzhia. Lo riferisce il servizio di emergenza statale ucraino
citato dalla Cnn. "Fino ad ora, 32 persone sono rimaste ferite a seguito di un
attacco missilistico nemico tra due edifici di nove piani: 27 persone sono state
ricoverate in ospedale, tra cui 3 bambini", ha dichiarato. "Cinque persone sono
state curate sul posto. Una persona è morta". Secondo l'ufficio del procuratore
ucraino, le forze russe hanno sparato almeno sei missili contro Zaporizhzhia. Il
tipo di missile è "attualmente in fase di definizione", ha affermato l'ufficio
del procuratore in una nota, spiegando che gli attacchi hanno causato danni
significativi alle infrastrutture civili e alcune persone risultano ancora
disperse.
16:43
Tornano a Kiev 15
ragazzi e ragazze dai campi della Crimea
L'organizzazione
ucraina Save Ukraine ha "soccorso" 17 ragazzi e riportato a casa da uno dei
campi in Crimea dove erano arrivati tutti a fine estate dalle loro case nelle
regioni di Kherson e Kharkiv pensando di rimanerci soltanto qualche settimana e
ritrovandosi invece in quelli che l'organizzazione sottolinea essere veri e
propri "campi di rieducazione" gestiti dalle autorità russe. Save Ukraine - che
opera interamente con fondi privati - tiene a spiegare che le loro sono
"missioni di soccorso": "Perchè soccorriamo i ragazzi" dal tentativo della
Russia di "rieducarli, di fare loro il lavaggio di cervello". In questo caso
vengono tutti dalla Crimea e in 15 sono arrivati a Kiev nel pomeriggio (uno è
rimasto in Polonia con la sua famiglia e un altro è in arrivo), quasi tutti
accompagnati dalle madri che hanno percorso migliaia di chilometri e
attraversato diverse frontiere per recuperarli. E sono 15 storie diverse: quella
di Artem, che fra pochi giorni compie 16 anni, e non guarda nelle telecamere,
non parla molto, si morde le labbra.
16:54
Russia utilizza
vecchi tank anni cinquanta
L'esercito russo ha
iniziato a prelevare dai depositi vecchi tank T-54/55 costruiti negli anni
quaranta e cinquanta, per poi mandarli al fronte in Ucraina. Lo riferisce il
sito investigativo russo indipendente Conflict Intelligence Team (Cit),
rilanciato da Ukrainska Pravda. Cit riferisce di aver ottenuto immagini del
trasporto via treno di tank provenienti dall'estremo oriente russo."Abbiamo
stabilito che il treno filmato è recentemente partito dalla città di Arsenyev,
nella regione di Primorsky, dove si trova la 129esima base di stoccaggio e
riparazione dei tank", viene precisato.
17:13
Nato: parlamento
Svezia vota a favore di adesione
Il parlamento
svedese ha votato a stragrande maggioranza mercoledì a favore dell'ingresso
della Svezia nella Nato. Il Parlamento, con 349 seggi, ha autorizzato l'adesione
della Svezia alla Nato con un voto di 269 a 37, con 43 parlamentari assenti. Si
è trattato dell'ultimo ostacolo interno richiesto per l'ingresso del Paese
nell'alleanza militare occidentale. Sei degli otto partiti rappresentati in
parlamento erano favorevoli all'adesione e il voto, che si è tenuto dopo un
dibattito di quasi sette ore, è stato considerato una formalità. "L'adesione
alla Nato è il modo migliore per salvaguardare la sicurezza della Svezia", ha
dichiarato il ministro degli Esteri Tobias Billström durante le deliberazioni,
definendo il voto "un evento storico" e "una delle più importanti decisioni di
politica di sicurezza mai prese dal nostro Paese".
17:16
La Cpi respinge
'minacce' dopo mandato d'arresto per Putin
La presidenza
dell'Assemblea degli Stati parti dello Statuto di Roma - ramo legislativo della
Corte penale internazionale - ha respinto le "minacce" contro la Cpi e "le
misure annunciate contro i suoi procuratori e giudici coinvolti nell'emissione
di mandati d'arresto sulla situazione ucraina. La Presidenza dell'Assemblea si
rammarica di questi tentativi di ostacolare gli sforzi internazionali per
garantire la responsabilità per atti vietati dal diritto internazionale
generale". "La Corte, i suoi funzionari eletti e il suo personale hanno il forte
sostegno dell'Assemblea degli Stati parti dello Statuto di Roma", si legge in
una nota. "Riaffermiamo la sua piena fiducia nella Corte come istituzione
giudiziaria indipendente e imparziale e ribadiamo il nostro forte impegno a
sostenere e difendere i principi e i valori sanciti dallo Statuto di Roma e a
preservarne l'integrità imperterrita da qualsiasi minaccia". La Cpi "incarna il
nostro impegno collettivo a combattere l'impunità per i più gravi crimini
internazionali. In quanto istituzione di ultima istanza, la Corte è
complementare alle giurisdizioni nazionali. Chiediamo a tutti gli Stati di
rispettare la sua indipendenza giudiziaria", conclude la nota.
17:26
Russia, possibile
scambio di prigionieri con Usa
Il vice ministro
degli Esteri russo Sergey Ryabkov non esclude la possibilità che l'uomo
d'affari Artyom Uss, fermato a Milano su mandato internazionale, possa essere
compreso in uno scambio di prigionieri fra Russia e Stati Uniti. "Tutto è
possibile, ma il fatto è che durante le prime fasi delle discussioni su queste
questioni, per quanto ne so, gli americani non mostrano interesse nel rimpatrio
di alcuni dei loro cittadini", ha detto Ryabkov, rispondendo alle domande dei
giornalisti, secondo quanto riferisce la Tass.
Figlio del
governatore del territorio russo di Krasnoyarsk in Siberia, Uss è stato fermato
all'aeroporto milanese di Malpensa il 17 ottobre su mandato internazionale
dell'autorità giudiziaria di New York. La Corte d'appello di Milano ha dato ieri
via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti per le accuse di contrabbando
di petrolio del Venezuela verso Cina e Russia con elusione di sanzioni e frode
bancaria. In attesa del ricorso in cassazione, Uss rimane agli arresti
domiciliari.
17:41
Mosca esclude
Usa-Gb-Germania-Francia dagli eventuali colloqui
Per Mosca, Usa,
Regno Unito, Germania e Francia non potranno partecipare ai colloqui di pace
sull'Ucraina. Lo riporta Newsweek sottolineando che il ministero degli Esteri
russo ha respinto la proposta secondo cui "i più potenti partner occidentali
dell'Ucraina dovrebbero essere coinvolti in eventuali negoziati per porre fine
all'invasione russa". Nei giorni scorsi - riporta il media americano - il
ministero degli Esteri russo ha dichiarato a Ria Novosti che Stati Uniti, Regno
Unito, Germania e Francia non possono essere considerati mediatori affidabili in
alcun negoziato di pace dato il loro coinvolgimento nel conflitto.
"Ufficialmente non sappiamo nulla di questa iniziativa", ha precisato la fonte
del ministero russo riferendosi alla recente proposta del diplomatico
tedesco Wolfgang Ischinger affinché Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania
formino il "nucleo" di un gruppo di mediazione occidentale. "Tutti e quattro i
Paesi citati - ha riferito il ministero russo, secondo Newsweek - sono loro
stessi parti del conflitto: sostengono le iniziative di pseudo-pace di Zelensky,
che sono requisiti ultimatum per la resa del nostro Paese. Con tali approcci,
Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania non possono pretendere di essere
mediatori neutrali nell'avvio del processo di pace. Non sono interessati a
risolvere la crisi e stanno facendo di tutto per massimizzare il confronto".
18:00
Cimitero di missili
a Kharkiv, servirà per provare crimini di guerra
Oltre mille pezzi di
missili ed esplosivi sono raccolti in un'area recintata grande come mezzo campo
da calcio in un distretto industriale di Kharkiv, seconda città dell'Ucraina. A
raccontare oggi la storia del "cimitero dei missili" è il Guardian, spiegando
che gli ucraini sperano di utilizzare i resti come prove di crimini di guerra.
Nei primi mesi di guerra, quando Kharkiv fu massicciamente bombardata, i resti
dei missili rimasero spesso nelle case colpite. Poi i funzionari della procura
hanno iniziato a raccoglierli e catalogarli.
Le autorità locali
pensano che il "cimitero dei missili" possa un giorno servire per la
realizzazione di un museo delle atrocità dell'invasione russa. Ma prima ancora
la procura intende usare i resti per documentare i crimini di guerra. "Questo
posto è stato creato per raccogliere le prove dei crimini. Tutti questi ordigni
sono stati recuperati a Kharkiv, ma è soltanto la metà di quello che ci hanno
sparato addosso. Sono prove che speriamo vengano usate dalla Corte penale
internazionale", spiega Dmytro Chubenko, portavoce della procura di Kharkiv.
Circa il 95% degli ordini recuperati sono parti di sistemi lancia missili
multipli, compreso il sistema Smerch che può sparare le bombe a grappolo,
proibite internazionalmente nel 2008, e usate dai russi per colpire aree civili.
18:16
Colloqui tra
ministri Difesa russo e turco, focus su accordo grano
Il ministro della
Difesa russo Sergei Shoighu ha avuto un colloquio con l'omologo turco Hulusi
Akar, su iniziativa di Ankara. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo
in una nota spiegando che al centro dei colloqui c'è stato l'accordo per
l'esportazione del grano dai porti dell'Ucraina che si affacciano sul Mar Nero.
Accordo raggiunto lo scorso luglio a Istanbul tra Kiev e Mosca con la mediazione
di Ankara e delle Nazioni Unite. Durante la conversazione, si legge sulla Ria
Novosti, i due ministri hanno anche parlato della situazione in Siria e di altre
questioni internazionali.
18:34
Il principe William
in Polonia incontra le trubbe britanniche e polacche coinvolte nel sostegno
all'Ucraina
Il principe
William si è recato in Polonia per ringraziare le truppe britanniche e polacche
coinvolte nel sostegno all'Ucraina, poi ha incontrato i rifugiati fuggiti dal
conflitto. L'erede al trono si è recato a Rzeszow, nel sud-est della Polonia,
dove ha incontrato il ministro della Difesa del Paese, Mariusz Blaszczak, e ha
parlato con i membri delle forze di difesa polacche e delle truppe britanniche
di stanza in Polonia. Il dispiegamento britannico in Polonia fa parte di un
rafforzamento della Nato sul suo fianco orientale dopo l'invasione russa
dell'Ucraina. Dopo gli impegni militari, il Principe di Galles si recherà a
Varsavia per visitare un centro di accoglienza per circa 300 donne e bambini
ucraini fuggiti dalla guerra. "Domani, quando incontrerò il presidente Duda,
ribadirò il solido rapporto condiviso dalle nostre due nazioni e sottolineerò il
mio continuo sostegno e la mia gratitudine al popolo polacco", ha dichiarato.
18:52
Mosca, probabilità
più alta da decenni di conflitto nucleare
"Non voglio
addentrarmi in una discussione sul fatto che la probabilità di un conflitto
nucleare sia alta oggi, ma è in ogni caso più alta di qualsiasi cosa abbiamo
avuto negli ultimi decenni, mettiamola così". Lo afferma il viceministro degli
Esteri, Sergei Ryabkov, durante il dibattito 'Un mondo senza Start: cosa c'è
dopo?'. Lo riporta l'agenzia Tass.
18:59
Le Figaro, Francia
forma piloti Kiev per usare Mirage
Da circa un mese e
mezzo la Francia sta formando una trentina di piloti ucraini per pilotare i
caccia Mirage 2000 dell'Aeronautica francese. Lo riporta Le Figaro precisando
che l'addestramento si svolge nelle basi aeree di Mont-de-Marsan e Nancy e che
la decisione è stata presa prima della visita di Volodymyr Zelensky a Parigi,
l'8 febbraio scorso. La Francia, osserva il quotidiano , si è così unita agli
Usa, che formano i piloti ucraini con gli F-16. "Ma mentre la Casa Bianca ha
ribadito la settimana scorsa che una eventuale consegna di aerei da
combattimento non è ancora sul tavolo, Parigi potrebbe fornire una decina di
velivoli a Kiev, a tempo debito", si legge nell'articolo.
19:02
Zelensky visita a
sorpresa anche Kharkiv
Dopo aver incontrato
i militari ucraini al fronte vicino Bakhmut, il presidente Volodymyr Zelensky è
arrivato a sorpresa anche a Kharkiv. Lo riporta Ukrainska Pravda. Zelensky ha
consegnato un premio onorario al sindaco Igor Terekhov e ha postato il discorso
in un video su Telegram. "Grazie agli abitanti di questa bellissima città, che
difende la nostra indipendenza fianco a fianco con altre città del nostro Stato"
ha detto il presidente ucraino. La visita di Zelensky è servita anche per fare
il punto sulla situazione nella regione, a cominciare dalla sistemazione delle
fortificazioni e dal ripristino delle infrastrutture. Zelensky ha consegnato al
sindaco Igor Terekhov il premio onorario "Città eroe dell'Ucraina".
19:08
Mosca, Usa giocano
col fuoco su trattato Start
Gli Stati Uniti
"devono in qualche modo rinsavire e scuotersi, togliersi i paraocchi e accettare
la realtà così com'è. Continuano a giocare con il fuoco". Lo ha detto il
vicemninistro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, parlando di un possibile
ritorno al dialogo con Washington sul trattato Start. "La condizione per tornare
alla discussione sul contenuto del trattato è un cambiamento nella rotta ostile
degli Stati Uniti nei confronti della Russia", ha detto Ryabkov. Lo riporta Ria
Novosti.
19:18
Zelensky,
risponderemo a tutti gli attacchi russi
"Risponderemo
sicuramente all'occupante per ogni attacco alle nostre città... Gli attacchi
russi di oggi a Zaporizhzhia, l'attacco notturno alla regione di Kiev... Tutti
gli attacchi russi riceveranno una risposta militare, politica e legale. La
Russia perderà questa guerra". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su
Telegram. "Nel Donbass, nella regione di Kharkiv, ovunque sia arrivato il male
russo, è ovvio che lo stato terrorista non può essere fermato da nient'altro che
da una cosa: la nostra vittoria. La garantiremo" e "faremo di tutto per
restituire una vita normale a tutta la nostra terra, da Donetsk al confine".
19:35
Kiev, abbattuto un
drone russo nel nord
Le forze armate
ucraine hanno abbattuto un drone russo nel nord del Paese. Lo ha riferito il
Comando Operativo Nord su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "I
soldati delle forze di difesa nell'area di Sivershchyna hanno abbattuto un Uav
nemico, presumibilmente un Orlan-10", ha dichiarato il comando. Nella notte tra
ieri e oggi, i russi hanno lanciato contro il Paese un attacco con droni che ha
colpito anche la regione di Kiev, provocando sette morti.
19:50
Stoltenberg,
"prepararsi a sostenere Kiev in una lunga guerra"
Il
presidente Vladimir Putin nell'immediato non ha intenzione di portare avanti
piani per la pace, quindi l'Occidente deve prepararsi a sostenere Kiev per molto
tempo. L'avvertimento arriva dal segretario generale della Nato, Jens
Stoltenberg, in un'intervista rilasciata al Guardian. Secondo il numero uno
dell'alleanza, Putin è impegnato in "una guerra di logoramento" e la battaglia
attorno a Bakhmut, nella quale molti russi stanno morendo, dimostra che Mosca è
disposta "a lanciare migliaia e migliaia di truppe in più, a subire molte
perdite per guadagni minimi". Per sostenere Kiev, dunque, Stoltenberg si augura
che i membri della Nato accettino di spendere almeno il 2% del Pil per la difesa
al prossimo vertice dell'alleanza, che avrà luogo a Vilnius, la capitale della
Lituania. "Il presidente Putin non pianifica la pace, sta pianificando altra
guerra", ha continuato Stoltenberg, aggiungendo che la Russia sta aumentando la
produzione industriale militare e "si rivolge a regimi autoritari come l'Iran o
la Corea del Nord e altri per cercare di ottenere più armi". Di conseguenza, gli
Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e altri Stati occidentali
devono essere pronti a sostenere l'Ucraina con armi, munizioni e pezzi di
ricambio per lungo tempo.
21:33
Kiev smentisce
l'addestramento dei piloti in Francia
Il portavoce
dell'aviazione ucraina, Yurii Ihnat, ha smentito la notizia pubblicata da Le
Figaro che piloti di Kiev si stiano addestrando da un mese e mezzo
in Francia all'uso dei caccia Mirage. "Voglio smentirla immediatamente perché
non vi sia distorsione dei fatti", ha affermato, citato da Ukrainska Pravda.
Vari stati hanno offerto loro siti per "possibili, potenziali e futuri
addestramenti di questo tipo che verranno scelti collettivamente in
consultazione con i nostri partner", ha aggiunto il portavoce. "In Francia sono
stati addestrati osservatori aerei e vi sono stati corsi di sopravvivenza per
aviatori, ma non parliamo di addestramento di equipaggi di volo", ha
sottolineato.
20:45
Medvedev: "La
minaccia del conflitto nucleare non è passata, è aumentata"
"La minaccia del
conflitto nucleare non è passata, ma sta crescendo". Lo ha detto il vice capo
del Consiglio per la sicurezza nazionale Dmitry Medvedev. Lo riporta Ria
Novosti. "La fornitura di armi straniere all'Ucraina avvicina all'apocalisse
nucleare", ha poi avvertito.
21:38
Sono 8 i morti
nell'attacco russo con i droni nella regione di Kiev
E' salito a 8 il
numero delle vittime nell'attacco con droni notturno dei russi alla città di
Rzhishchev, nella regione di Kiev. Lo rendono noto i servizi di soccorso
ucraini. Nell'attacco è stato colpito un dormitorio.
21:54
Ryabkov: "Ipotesi
conflitto nucleare oggi è più alta che in qualsiasi momento degli ultimi
decenni"
Il rischio di un
conflitto nucleare è ora al suo livello più alto da decenni. Lo ha detto il vice
ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, secondo quanto riporta l'agenzia di
stampa Tass. "Non vorrei entrare in una discussione se la probabilità di un
conflitto nucleare sia alta oggi, ma certamente è più alta che in qualsiasi
momento degli ultimi decenni, mettiamola così", ha detto Ryabkov intervenendo a
un evento del club Valdai. Poco prima il vicepresidente del Consiglio di
sicurezza, Dmitry Medvedev, in un'intervista ai principali media russi ha
avvertito che le consegne di armi straniere all'Ucraina ci avvicinano a un
conflitto nucleare.
23:37
Xi a Mosca: Blinken,
fra Russia e Cina matrimonio convenienza
Il riavvicinamento
russo-cinese è "un matrimonio di convenienza" piuttosto che di "convinzione": lo
ha detto il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, secondo il quale
Pechino non ha ancora consegnato armi letali a Mosca in piena guerra in Ucraina.
"Avendo una visione
del mondo molto diversa dalla nostra, hanno contratto un matrimonio di
convenienza", ha detto il segretario di Stato alla commissione Affari Esteri del
Senato americano. "La Russia è chiaramente il partner minore in questa
relazione", ha aggiunto.
Il presidente cinese
Xi Jinping ha fatto una visita di tre giorni in Russia, incentrata sul
rafforzamento dei legami bilaterali.
La Repubblica.
Zelensky al vertice Ue: "Ecco i ritardi nella consegna di armi che allungano la
guerra"
È salito a 8 il
bilancio dei morti negli attacchi vicino a Kiev. Vittime anche a Zaporizhzhia
dove l'Aiea lancia l'allarme per la possibile disconnessione della centrale
dalla linea elettrica esterna
Il livello dello
scontro sull'Ucraina sale di intensità, con Mosca che evoca di continuo
l'Apocalisse nucleare dopo la notizia dei proiettili all'uranio
impoverito destinati da Londra a Kiev. L'ultimo ad agitare lo spettro
dell'Armageddon è l'ambasciatore russo negli Stati Uniti", Anatoly Antonov. Ma
intanto, sul campo, si continua a morire. Anche tra i civili. Come è successo
nelle ultime ore nella zona di Kiev. Con un bilancio salito ad almeno 8
morti. Vittime anche a Zaporizhzhia dove l'Aiea lancia l'allarme sulla possibile
disconnessione della centrale dalla linea elettrica esterna. La Banca
mondiale intanto stima i costi della ricostruzione: sono necessari 411 miliardi
di dollari.
Punti chiave
04:57
L'ambasciatore russo
negli Usa: "L'Occidente ci porta all'Armageddon"
00:48
Blinken: "Tra Russia
e Cina matrimonio di convenienza"
Il riavvicinamento
russo-cinese è "un matrimonio di convenienza" piuttosto che di "convinzione". Lo
ha detto il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, secondo il quale
Pechino non ha ancora consegnato armi letali a Mosca in piena guerra in
Ucraina."La Russia è chiaramente il partner minore in questa relazione", ha
aggiunto.
02:19
De Santis: "Putin
criminale di guerra, non vincerà"
Il governatore della
Florida, Ron DeSantis ha definito il presidente russo Vladimir Putin un
"criminale di guerra" e ha chiesto che venga "ritenuto responsabile" per
l'invasione dell'Ucraina.
In un'intervista con
l'anchorman britannco Piers Morgan, DeSantis ha dunque usato toni più duri
rispetto alle parole pronunciate la scorsa settimana, che sembravano liquidare
la guerra come una "disputa territoriale". Ma soprattutto toni assai più duri,
verso Mosca, rispetto al suo probabile avversario alle primarie repubblicane:
Donald Trump.
03:29
Mosca: "Eliminato
l'equipaggio dei droni ucraini"
Le truppe russe
hanno individuato e ucciso, utilizzando armamenti APC-82, un equipaggio di
operatori di droni ucraini che cercava rifugio in una casa unifamiliare vicino a
Donetsk. Lo ha detto alla Tass Ivan Bigma, portavoce del gruppo tattico Sud.
04:57
L'ambasciatore russo
negli Usa: "L'Occidente ci porta all'Armageddon"
"I Paesi occidentali
guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un
Armageddon nucleare". Sono le parole, riportate dalla Tass, dell'ambasciatore
russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. Il diplomatico rispondeva alle
dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni
all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero
alcun rischio elevato. "Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile.
Le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro
dichiarazioni irresponsabili", ha detto Antonov.
06:04
Medvedev:
"L'Occidente vuole solo destabilizzare la Russia"
Nuove dichiarazioni
bellicose da parte del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry
Medvedev. "Il desiderio dell'Occidente è molto semplice: destabilizzare la
situazione politica, dividere il Paese in parti, abbastanza grandi, negoziare
con ognuna di queste parti, denuclearizzarla e smilitarizzarla. Capiscono solo
il linguaggio della forza".
07:52
Intelligence: "Mosca
a corto di tank, pensa a mezzi anni '50"
L'esercito russo
potrebbe schierare al fronte carri armati risalenti agli anni '50 per compensare
le enormi perdite di mezzi corazzati subite dall'inizio dell'invasione
dell'Ucraina: lo scrive il Conflict Intelligence Team, un'organizzazione open
source con sede a Tbilisi, come riporta il Kyiv Independent. Il centro studi ha
reso noto che le forze russe hanno trasportato un carico di carri armati T-54/55
da un deposito di Primorye, nell'estremo sud-est del Paese, verso la Russia
occidentale e si ipotizza che potrebbero dispiegare questi mezzi in Ucraina.
Secondo Oryx, un'altra organizzazione di intelligence open-source che documenta
le perdite russe in Ucraina, Mosca ha perso dall'inizio della guerra circa 1.871
carri armati.
08:49
L'intelligence
britannica: "Mosca mira conquistare la città di Kupyansk"
Le forze russe
mirano presumibilmente a riconquistare la città di Kupyansk, nella regione di
Kharkiv (est), che è anche un hub logistico: lo scrive il ministero della Difesa
britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Dall'inizio di
questo mese sono continuati pesanti combattimenti in alcune parti del
settore Svatove-Kreminna della linea del fronte nel nord della regione di
Lugansk, osserva il ministero nel suo rapporto pubblicato su Twitter. La Russia
ha parzialmente ripreso il controllo delle immediate vicinanze della città di
Kreminna, proseguono gli esperti di Londra, sottolineando che in alcuni punti le
truppe di Mosca hanno "guadagnato fino a diversi chilometri".
A questo punto, "i
comandanti russi stanno probabilmente cercando di espandere una zona di
sicurezza a ovest delle linee di difesa preparate lungo le alture, integrando
l'ostacolo naturale del fiume Oskil. È probabile che cerchino di riconquistare
Kupiansk, un nodo logistico". Dal punto di vista operativo, conclude il
rapporto, l'obiettivo della Russia nel nord-est "rimane probabilmente difensivo:
i comandanti probabilmente temono che questo sia uno dei settori in cui
l'Ucraina potrebbe tentare importanti operazioni offensive".
09:19
Medvedev: "Ogni
tentativo di arresto di Putin sarebbe una dichiarazione di guerra alla Russia"
Un arresto di
Vladimir Putin da parte di un paese straniero a seguito del mandato d'arresto
emesso la scorsa settimana dalla Corte penale internazionale equivarrebbe a
"dichiarare guerra" a Mosca. Lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medvedev.
"Immaginiamo la cosa (...): il capo di Stato di una potenza nucleare va a dire,
ad esempio, la Germania e viene arrestato. Cos'è questa? Una dichiarazione di
guerra alla Russia", ha dichiarato Medvedev, attuale numero 2 del Consiglio di
sicurezza russo - Se ciò accade, allora "tutte le nostre capacità, missili e
altro, ricadranno sul Bundestag, sull'ufficio del cancelliere e così via".
L'avvertimento arriva dopo che la scorsa settimana la CPI con sede all'Aia ha
emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per il crimine di guerra di
"deportazione" di bambini ucraini come parte dell'offensiva di Mosca contro
l'Ucraina. Mercoledì la CPI ha denunciato le "minacce" che provengono da Mosca
nei suoi confronti, dopo che la giustizia russa ha annunciato di aprire
un'indagine penale contro diversi suoi giudici e il suo procuratore, Karim Khan.
All'inizio di questa settimana, Medvedev aveva già minacciato la Corte penale
internazionale con un attacco missilistico, invitando i suoi magistrati a
"guardare attentamente il cielo". La Russia, che non riconosce la giurisdizione
della Corte penale internazionale, ha descritto il mandato di arresto nei
confronti di Putin come "nullo e non valido".
09:44
Kiev: attacco
missilistico russo ad Adviivka, due morti
Due persone sono
morte la notte scorsa durante un attacco missilistico russo contro la città di
Avdiivka, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su
Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come
riporta Ukrinform. "Nel cuore della notte, i russi hanno bombardato Kramatorsk e
la periferia della città - ha scritto Kyrylenko - Nella direzione di Donetsk,
due persone sono morte ad Avdiivka. La città è stata colpita da un missile: tre
missili puntavano sul territorio dell'AKHZ", ha aggiunto il governatore
riferendosi all'impianto chimico Avdiivka Coke and Chemical Plant.
10:14
Borrell: "Putin
parla di pace con Xi, ma continua a compiere crimini di guerra"
"L'Ucraina è stata
nuovamente attaccata dalla Russia con droni iraniani. Sono state prese di mira
strutture educative; un attacco missilistico è stato lanciato contro un edificio
residenziale a Zaporizhzhia. Proprio quando Putin ha espresso la necessità di
una "soluzione pacifica" al presidente Xi, la Russia commette nuovamente crimini
di guerra". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica
estera, Josep Borrell.
10:49
Ucraina: missili
russi su Avdiivka nella notte, 2 morti
Due persone sono
morte la notte scorsa durante un attacco missilistico russo contro la città di
Avdiivka, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su
Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come
riporta Ukrinform.
"Nel cuore della
notte, i russi hanno bombardato Kramatorsk e la periferia della città - ha
scritto Kyrylenko -. Nella direzione di Donetsk, due persone sono morte ad
Avdiivka. La città è stata colpita da un missile: tre missili puntavano sul
territorio dell'AKHZ", ha aggiunto il governatore riferendosi all'impianto
chimico Avdiivka Coke and Chemical Plant.
11:05
Media: in Crimea
sventola una bandiera ucraina
Una bandiera ucraina
che sventola su una torre di comunicazione nella Crimea annessa alla Russia: è
quanto mostra un video pubblicato su Twitter dal giornalista della New Voice of
Ukraine, Euan MacDonald, come riporta il Guardian.
"Una bandiera
ucraina sventola da una torre di comunicazione vicino al villaggio di Hrushivka,
a circa 18 chilometri a nord della città di Sudak, nella Crimea occupata dai
russi. Anche dopo nove anni di occupazione militare russa, alcuni crimeani
sembrano ancora pronti a rischiare per dimostrare il proprio patriottismo",
scrive il giornalista.
11:09
Ucraina: Estonia,
con Guterres parleremo di tribunale per aggressione
"Oggi avremo un
incontro con il segretario generale dell'Onu Guterres e parleremo di un
tribunale per il crimine di aggressione perché il mandato d'arresto della Corte
penale internazionale (Cpi) è un buon segno che nessun leader è immune, ma loro
non possono perseguire il crimine di aggressione, questo deve venire dall'Onu".
Lo ha detto la premier dell'Estonia, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio
europeo a Bruxelles.
11:39
Il capo delle forze
di terra ucraine: presto controffensiva a Bakhmut
Le forze armate
ucraine lanceranno presto una controffensiva nei confronti dell'esercito russo.
Parola del comandante delle forze di terra di Kiev Oleksandr Syrsky, secondo il
quale le forze russe "stanno perdendo forza in modo considerevole e si stanno
esaurendo" nella battaglia per Bakhmut. "Molto presto approfitteremo di questa
opportunità, come abbiamo fatto in passato vicino a Kiev, Kharkiv, Balakliya e
Kupiansk", ha detto Syrsky, elencando le controffensive ucraine dell'anno scorso
che si sono rivelate punti di svolta nella guerra.
Funzionari ucraini e
gli analisti occidentali hanno affermato che l'offensiva russa attorno a Bakhmut
sembra essere entrata in una fase di stallo. Dopo mesi di combattimento i
militari russi non sono ancora riusciti a conquistare la città del Donbass
nonostante l'ingente impiego di uomini e armi.
11:46
Ucraina: Borrell,
per ora la Cina non sta aiutando la Russia
"Per il momento la
Cina non sta aiutando la Russia". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per
la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo. "Parlerò
ai leader dell'accordo per fornire munizioni all'Ucraina, discusso all'ultimo
Consiglio europeo", ha aggiunto Borrell, riferendosi all'intesa "per un milione
di munizioni in dodici mesi per due miliardi di euro".
11:58
Sanchez in Cina da
Xi: "Gli dirò che spetta a Kiev stabilire le condizioni per la pace"
"Credo che l'invito
di Xi Jinping dimostri l'importanza e il peso internazionale della Spagna e
della sua diplomazia. È importante che si sviluppino le relazioni bilaterali. È
anche importante conoscere in prima persona le posizioni della Cina sull'Ucraina
e trasmettere il messaggio che siano gli ucraini che debbano stabilire le
condizioni per il negoziato di pace. Va rispettato un ordine internazionale
garantito dall'Onu e che prevede la tutela di una sovranità violata dal
presidente Putin". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al
Consiglio europeo e soffermandosi sulla missione in Cina del prossimo 30 e 31
marzo.
12:52
Ucraina: Zelensky
visita regione Kherson
Il presidente
dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è in visita a una delle strutture energetiche
della regione di Kherson, per discutere delle forniture di elettricità agli
insediamenti della regione di Kherson, del ripristino nei territori tornati
sotto il controllo ucraino e del recupero delle attrezzature danneggiate dai
bombardamenti russi. Lo ha scritto lo stesso presidente sul suo profilo
Telegram. "Riunione di coordinamento sulla situazione nella regione di Kherson -
si legge - L'attuale situazione della sicurezza, il ripristino delle
infrastrutture danneggiate della regione, lo sminamento dei territori
de-occupati, il ripristino delle reti elettriche: teniamo sotto controllo tutte
queste importanti questioni", ha aggiunto Zelensky.
12:56
Ucraina: il ministro
Urso, 'è diventata una guerra di sterminio' da parte russa
"Mia moglie è nata
in Siberia, dove tuttora vive suo padre da una famiglia russa e russofona, metà
russa e metà russofona di Lugansk, dove poi loro hanno vissuto in realtà. Sono
quindi anche consapevole più di altri di quello che è il dramma di quei popoli
però le scelte che ho fatto fin dall'inizio sono scelte che riguardano
l'interesse nazionale del nostro Paese". Lo racconta il ministro delle Imprese e
del made in Italy, Adolfo Urso, al podcast di Libero Terraverso.
"Gli ucraini di
lingua russa sono diventati i più acerrimi avversari di Putin, proprio quelli
che lui avrebbe dovuto liberare perché quella liberazione è diventata non solo
un'occupazione ma una guerra di sterminio", osserva il ministro.
13:03
Kiev, 'possiamo
liberare da russi 30 km su riva sinistra Dnipro'
Le forze armate
ucraine che operano nel Sud del Paese stanno cercando di liberare dai russi una
zona di 20-30 km sulla riva sinistra del Dnipro, quindi sul versante orientale
dell'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando Natalya Gumenyuk, capo
dell'ufficio stampa delle forze di stanza nel sud dell'Ucraina.
"È un lavoro
piuttosto difficile" ha detto Gumenyuk, aggiungendo che "è complicato dal fatto
che il nemico ha iniziato a nascondersi dietro i civili, cercando di nascondere
le loro unità e il loro dispiegamento di attrezzature nei cortili dei residenti
locali, dietro gli edifici residenziali".
Nonostante questo,
spiega il capo ufficio stampa, il lavoro degli ucraini è abbastanza efficace e
ciò si può notare dal fatto che "i bombardamenti dalla direzione del Kinburn
Spit sono notevolmente diminuiti, poiché abbiamo raggiunto un punto di
rifornimento e un deposito di munizioni".
13:20
Papa: "La guerra è
il fallimento della politica, non può essere soluzione dei conflitti"
"La guerra è un
fallimento della politica e dell'umanità. Questo dobbiamo ripeterlo ai
politici". Lo ha ammonito il Papa parlando ai partecipanti alla plenaria della
Comece. "Si può parlare ormai di una terza guerra mondiale", ha ribadito
Bergoglio, nel sottolineare che la guerra in Ucraina "ha scosso la pace
europea".
"La guerra - ha
soggiunto - non può e non deve più essere considerata come una soluzione dei
conflitti. Se i Paesi dell'Europa di oggi non condividono questo principio
etico-politico, allora vuol dire che si sono allontanati dal sogno originario.
Se invece lo condividono, devono impegnarsi ad attuarlo, con tutta la fatica e
la complessità che la situazione storica richiede. Perché la guerra è un
fallimento della politica e dell'umanità. Questo dobbiamo ripeterlo ai
politici".
13:57
Ungheria: Non
arresteremo Putin se verrà nel nostro Paese
L'Ungheria non
arresterà il presidente russo, Vladimir Putin, se dovesse entrare nel Paese. Lo
ha assicurato il capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, malgrado
l'Ungheria abbia firmato e ratificato lo Statuto di Roma che ha istituito la
Corte penale internazionale (Cpi). Venerdì lo stesso tribunale ha emesso
un mandato di arresto contro Putin accusandolo di crimine di guerra per aver
deportato illegalmente centinaia di bambini dall'Ucraina.
14:12
Cina: fonti Ue,
Guterres ai leader; isolarla presenta rischi
"L'isolamento della
Cina da parte dell'Europa pone dei rischi". Lo ha affermato - a quanto riferisce
una fonte Ue - il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo
discorso ai capi di Stato e di Governo dell'Unione riuniti a Bruxelles.
Guterres, che si è
detto molto pessimista sulla situazione globale attuale, ha invitato l'Ue anche
a valutare il proprio impatto nell'agevolare la soluzione della crisi
alimentare. Il segretario generale delle Nazioni unite ha mostrato poco
ottimismo anche nei confronti dell'accordo per l'export del grano dall'Ucraina.
"La discussione sull'interpretazione della durata della proroga dimostra che non
siamo sulla strada giusta", ha evidenziato Guterres.
14:45
La Slovacchia
consegna i primi Mig all'Ucraina
I primi quattro
caccia Mig-29 donati dalla Slovacchia all'Ucraina sono partiti oggi dal
territorio slovacco. Lo ha reso noto il ministero della Difesa slovacco. La
Slovacchia intende donare all'Ucraina in totale 13 caccia di questo tipo.
"Ringrazio tutte le forze coinvolte per il fantastico lavoro professionale. La
Slovacchia è dalla parte giusta e con questo gesto, noi come Paese, ci siamo
iscritti a caratteri cubitali nella storia del mondo moderno, che parla di
assistenza tempestiva, solidarietà sincera e grandezza della nazione", ha
commentato il ministro della Difesa Jaroslav Nad.
15:37
Zelensky al vertice
Ue: "Ecco i ritardi che allungano la guerra"
Il presidente
ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video-collegamento con il vertice Ue in
corso a Bruxelles ha citato cinque ritardi che prorogano la guerra: "I ritardi
nella consegna dei missili a lungo raggio, degli aerei moderni, nell'adozione di
un nuovo pacchetto di sanzioni, nel piano di pace formulato da Kiev e nel
percorso di adesione all'Ue".
15:55
Mosca, se la
Moldavia si unirà alle sanzioni Ue reagiremo
La Russia adotterà
le misure appropriate se la Moldavia dovesse unirsi alle sanzioni anti-Mosca
dell'Unione europea. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri
russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia stampa russa Tass. "Come sapete,
tali misure da parte dell'Ue non sono state fatte senza una risposta da parte
nostra. Se e quando Chisinau si unirà ufficialmente a queste sanzioni, saremo
costretti ad adottare adeguate misure di ritorsione. Vorrei sottolineare che
questa non sarà una nostra scelta, ma piuttosto una risposta ad azioni ostili",
ha detto Zakharova. In precedenza, il ministro degli Esteri della Moldavia, Nicu
Popescu, aveva affermato che Chisinau intendeva aderire alle misure restrittive
imposte dall'Ue nei confronti di alcuni cittadini russi. Secondo Zakharova, è
difficile non notare come "le autorità moldave continuino a mostrare particolare
zelo nel mettere a punto la loro agenda russofoba, non solo limitandosi ad
aderire all'Ue anti-russa". La portavoce ha ricordato che il 22 marzo il
servizio di informazione e sicurezza moldavo ha emesso l'ordine di bloccare
altri cinque siti web dell'agenzia di stampa russa Sputnik.
16:04
Mosca, con Mig da
Slovacchia "passo distruttivo"
La Federazione russa
considera il trasferimento di quattro caccia da combattimento Mig-29
dalla Slovacchia all'Ucraina come "un passo distruttivo che contraddice la
retorica dell'Unione europea sulal ricerca di soluzioni pacifiche" al conflitto.
Lo ha denunciato il viceministro degli Esteri di Mosca, Aleksandr Grushko, come
riporta l'agenzia Tass.
16:08
Bloomberg, "la
Wagner pronta al disimpegno in Ucraina"
Il Gruppo
Wagner sarebbe pronto a disimpegnarsi dalla zona del Donbass, in Ucraina, per
spostare le sue forze in Africa a seguito della scelta dei capi militari russi
di tagliare le forniture di uomini e munizioni. A riportare la notizia è
la Bloomberg, che cita fonti che "hanno familiarità con la questione".
16:20
Russia, ferrovia
ponte Crimea in funzione in estate
Il tratto
ferroviario del Ponte di Crimea tornerà a funzionare entro il primo luglio per
consentire l'aumento del traffico di merci dalla Russia alle regioni occupate
dell'Ucraina, ha spiegato il vice premier russo, Marat Khusnullin in una
intervista a Rossiya-24. Il Presidente Putin ha anche approvato la ripresa del
traffico dei camion, ma non ancora dei tir, dati i rischi posti dall'operazione
militare speciale, dopo l'esplosione che aveva provocato la morte di tre
persone.
16:36
Prigozhin, nessun
ritiro della Wagner dall'Ucraina
"Sembra che
la Bloomberg sappia meglio di noi quello che faremo. Fino a quando il nostro
Paese ha bisogno di noi, rimarremo a combattere in Ucraina". Lo ha detto su
Telegram il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, smentendo quanto scritto
dall'agenzia americana, secondo la quale la compagnia privata russa sarebbe in
procinto di ritirare le proprie forze dall'Ucraina per spostarle in Africa.
17:02
Intelligence Kiev,
russi incapaci di un'offensiva su larga scala
Da diversi mesi la
propaganda russa annuncia una "offensiva su larga scala" dell'esercito russo in
Ucraina, ma Mosca "si è trovata di fronte all'incapacità di condurre
un'offensiva in più direzioni". A sostenerlo è Vadym Skibitskyi, rappresentante
della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino,
in un'intervista a RBC-Ucraina rilanciata da Ukrinform. Secondo Skibitskyi, "la
spavalderia generale degli invasori era più basata sulla disinformazione e su
una generale sopravvalutazione delle proprie capacità. In realtà, si sono
trovati di fronte all'incapacità di condurre un'offensiva contemporaneamente in
più direzioni". L'esercito russo "ha l'unico obiettivo: raggiungere i confini
amministrativi delle regioni di Donetsk e Lugansk. Tuttavia, non hanno
particolarmente successo, perché richiede la pianificazione e la conduzione di
operazioni strategiche su larga scala"."Attualmente, gli occupanti sono più
attivi nelle direzioni Bakhmut, Avdiivka, Lyman, Kupiansk e Shakhtarsk", ha
spiegato Skibitskyi.
17:34
Kiev, presto
controffensiva a Bakhmut
Il comandante delle
forze di terra dell'esercito ucraino, il colonnello Oleksandr Syrskyi, ha
affermato che l'esercito russo "sta esaurendo i suoi tentativi di
catturare Bakhmut" e le forze armate ucraine "ne trarranno presto vantaggio".
"Le principali forze della Federazione russa in questa direzione sono i
rappresentanti di Wagner - le parole di Syrskyi riportate da Radio Svoboda -,
stanno perdendo forze in maniera significativa e presto approfitteremo di questa
opportunità, come abbiamo fatto in passato vicino a Kiev, Kharkiv, Balaklia e
Kupyansk".
17:38
Leader Ue, ok
acquisti congiunti anche per missili
I capi di Stato e di
Governo dell'Unione europea hanno "accolto con favore, tenendo conto degli
interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri", l'accordo in seno al
Consiglio di "fornire urgentemente all'Ucraina munizioni terra-terra e di
artiglieria e, se richiesto, missili, anche attraverso appalti congiunti e la
mobilitazione di finanziamenti adeguati anche attraverso lo strumento europeo
per la pace, con l'obiettivo di fornire un milione di munizioni di artiglieria
entro i prossimi dodici mesi". E' quanto si legge nelle conclusioni del
Consiglio europeo appena approvate dai leader. "L'Unione europea sostiene
fermamente e pienamente l'Ucraina e continuerà a fornire un forte sostegno
politico, economico, militare, finanziario e umanitario all'Ucraina e al suo
popolo per tutto il tempo necessario. L'Unione europea e gli Stati membri stanno
intensificando gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze
militari e di difesa" del Paese, si legge ancora.
17:53
Mosca contro la
Finlandia: "Decisione sbilanciata e controproducente"
Mosca torna a
criticare la Finlandia dopo che il presidente Sauli Niinisto ha firmato la legge
sull'adesione del Paese alla Nato. "Difficilmente la decisione della Finlandia
di aderire alla Nato può essere considerata equilibrata", ha detto la portavoce
del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che in dichiarazioni
riportate dall'agenzia Ria Novosti ha parlato anche di una decisione
controproducente. Per Mosca si tratta di una decisione presa "sotto l'influenza
di una campagna mediatica anti-russa senza precedenti" e Zakharova ha puntato il
dito contro gli Usa e "alcuni loro alleati", accusati di essere "dietro questa
campagna politica".
18:05
Auto con ministro
Esteri estone si incendia a Kiev
E' scoppiato un
incendio sull'auto blindata che ha trasportato il ministro degli Esteri
estone, Urmas Reinsalu, durante la sua recente visita a Kiev. Lo ha rivelato lo
stesso Reinsalu durante una conferenza stampa a Tallinn. "Ero seduto con
(l'ambasciatore estone, ndr) Kaimo Kuusk sul sedile posteriore e all'improvviso
Kaimo ha detto di sentire un odore. Poi sono divampate delle fiamme dietro di
noi", ha affermato il ministro. "Per fortuna le porte posteriori alla fine si
sono aperte, perché l'auto si sarebbe trasformata in una camera a gas in pochi
secondi", ha aggiunto. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente avvenuto martedì
sera. Reinsalu non ha fornito dettagli sulla possibile causa dell'incendio, che
ha bruciato il veicolo. Ora un team di esperti si occuperà di esaminare il
relitto dell'auto.
18:16
Ucraina: russi
ritirati da città Novaya Kakhovka in regione Kherson
Le unità
dell'esercito russo hanno lasciato la città di Novaya Kakhovka, nella regione di
Kherson. Lo riporta Unian, citando le forze armate di Kiev. Prima di andarsene,
viene spiegato, "i russi hanno confiscato alla popolazione civile grandi
quantità di elettrodomestici, gioielli, capi di abbigliamento e telefoni
cellulari".
18:47
Blinken, pronti a
diplomazia costruttiva con Mosca
Gli Stati Uniti sono
aperti a una diplomazia costruttiva con la Russia per porre fine al conflitto
ucraino se Mosca mostra volontà di impegnarsi. Lo ha detto il segretario di
Stato americano, Anthony Blinken. "Se vediamo qualche segno di una Russia
impegnata in una diplomazia costruttiva e pronta a porre fine a questa
aggressione, coglieremo questa opportunità", ha detto Blinken durante
un'audizione alla commissione Affari esteri della Camera Usa. Ora Washington, ha
sottolineato Blinken, non vede segnali da Mosca di disponibilità a mettere fine
al conflitto.
18:59
Filorussi, nessun
ritiro da Nova Kakhovka
Le truppe russe
rimangono a Nova Kakhovka. Lo dicono le autorità filorusse della regione di
Kherson, smentendo quanto affermato dallo stato maggiore di Kiev che ha
annunciato il ritiro russo dalla città. "Dichiaro ufficialmente che tutti i
militari russi a Nova Kakhovka, così come in altri luoghi di schieramento sulla
riva sinistra del Dnepr, rimangono al loro posto", ha detto il governatore
filorusso di Kherson, Vladimir Saldo. "I propagandisti ucraini hanno lanciato
un'altra disinformazione" sul ritiro da Nova Kakhovka. Naturalmente si tratta di
una bugia", ha detto il capo filorusso del distretto della città, Vladimir
Leontiev.
19:09
Zelensky a Ue,
organizzare summit su piano di pace di Kiev
Nel suo intervento
al Consiglio europeo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha espresso
l'intenzione di organizzare un vertice sul piano di pace proposto da lui. Lo
riferiscono fonti diplomatiche europee, aggiungendo che il capo di Stato ucraino
avrebbe voluto che si tenesse a Kiev, ma per ragioni di sicurezza, ha chiesto
che il summit si svolgesse in una delle capitali europee.
19:30
Kiev ammette, errore
annuncio ritiro russo da Nova Kakhovka
L'esercito ucraino
ha ammesso di aver erroneamente annunciato il ritiro delle forze russe dalla
città meridionale di Nova Kakhovka nella regione di Kherson.
Gli invasori sono
ancora temporaneamente a Nova Kakhovka. Le informazioni sul presunto ritiro del
nemico da questo insediamento sono state rese pubbliche a causa dell'uso
scorretto dei dati disponibili", ha precisato lo stato maggiore su Telegram.
20:12
Ucraina, morto il
soldato neozalendese Kane Te Tai
L'ultimo post su
Instagram l'aveva postato appena cinque giorni fa, dopo essere stato
intervistato dall'unità stampa militare dell'esercito di Kiev. Kane Te Tai, ex
soldato neozelandese di 38 anni, è stato ucciso in combattimento. Lo ha
annunciato il ministero degli esteri di Wellington, citando fonti del governo
ucraino: si tratta del terzo neozelandese morto in questo guerra. Come riporta
il Guardian, Te Tai combatteva nella legione internazionale e sui social
raccontava ogni volta che poteva la vita al fronte. Una settimana fa aveva
iniziato una raccolta fondi per comprare una macchina per l'esercito
20:36
Russia, Lavrov
incontra suo omologo iraniano a Mosca il 29 marzo
Il ministro degli
Esteri russo Sergei Lavrov incontrerà il ministro degli Esteri iraniano Hossein
Amir Abdollahian a Mosca mercoledì 29 marzo. Lo ha detto la portavoce del
ministero degli Esteri russo Maria Zakharova specificando che i due
"continueranno uno scambio di opinioni su questioni internazionali di
attualità", compresa "la situazione intorno al piano d'azione congiunto globale
sul programma nucleare iraniano, lo stato delle cose in Siria, Afghanistan,
Transcaucaso e, naturalmente, il problema del Mar Caspio", ha detto Zakharova
durante un briefing.
Ufficialmente nessun
riferimento a forniture di armi. "Il miglioramento della situazione nella
regione del Medio Oriente sarà preso in considerazione alla luce dell'annunciato
ripristino delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita... Si prevede una notevole
attenzione per una revisione completa dell'agenda bilaterale con un'enfasi sulla
componente commerciale ed economica, compresa l'attuazione di progetti
infrastrutturali congiunti nel settore dei trasporti e dell'energia", ha
aggiunto Zakharova.
20:54
Zelensky, passi da
partner Ue ma ancora ritardi verso vittoria
"Ho preso atto dei
forti passi compiuti dai partner" europei "ma ho notato cose che, purtroppo, non
ci permettono di accelerare la liberazione dei territori, non ci permettono di
accelerare la fine della guerra". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky nel suo discorso serale, riferendo della sua partecipazione online alla
riunione del Consiglio europeo, durante la quale ha affermato che ogni ritardo
nello sforzo di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungamento
della guerra. "Sono certo che i partner abbiano ascoltato la posizione
dell'Ucraina", ha aggiunto.
21:19
La Bulgaria non darà
armi né munizioni all'Ucraina
"La Bulgaria non
sostiene e non fa parte della decisione Ue per la consegna congiunta di
munizioni di artiglieria destinate all'Ucraina. Sosterremo soltanto sforzi
diplomatici europei per ristabilire la pace", ha dichiarato oggi ai giornalisti
il presidente Rumen Radev, a margine dei lavori del Consiglio europeo a
Bruxelles. "La Bulgaria non fornirà all'Ucraina né i suoi caccia da
combattimento, né i suoi carri armati né i suoi sistemi antimissile", ha
precisato in modo categorico Radev. "La Bulgaria è tra i dieci paesi Ue che non
partecipano all'ordine congiunto di munizioni d'artiglieria per l'Ucraina, anche
in calibro 155 mm", ha aggiunto. Nello stesso tempo il presidente bulgaro ha
detto che Sofia "si impegna a produrre proiettili d'artiglieria su eventuale
richiesta di paesi partner, a condizione che poi non vengano esportati verso
l'Ucraina".
21:30
Credit Suisse e Ubs
in mirino Usa su sanzioni alla Russia
Credit Suisse e Ubs
sono fra le banche sulle quali il Dipartimento di Giustizia americano starebbe
indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le
sanzioni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali
le due banche sarebbero nella recente ondata di richieste di informazioni
inviate dalle autorità americane. Richieste inviate prima delle loro nozze.
21:42
Zelensky, aprirà in
Ucraina un ufficio rappresentanza Cpi
"Oggi abbiamo
ottenuto un risultato per il quale lavoriamo da tempo. È stato firmato un
accordo per aprire un ufficio di rappresentanza della Corte penale
internazionale in Ucraina. Questo passo consentirà alla giustizia internazionale
di diventare ancora più attiva nelle indagini sui crimini di l'esercito russo
sul nostro suolo ucraino". Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky nel suo videomessaggio serale, ringraziando la Cpi, l'ufficio del
procuratore generale e tutti i partner dell'Ucraina che aiutano nelle indagini
sui crimini russi contro l'Ucraina e gli ucraini.
21:57
Von der Leyen, Mosca
ha rapito 16mila bambini ucraini
"Sull'Ucraina
abbiamo avuto un dibattito intenso, anche con il segretario generale
dell'Onu Antonio Guterres. Un punto che mi è caro è quello dei bambini ucraini
rapiti dalla Russia, che ci ricorda i momenti bui di un nostro oscuro
passato: ben 16.200 bambini sono stati rapiti. È un crimine di guerra e
giustifica pienamente il mandato d'arresto spiccato dall'Aja". Lo ha detto la
presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine della prima
giornata del Consiglio Europeo.
22:01
Von der Leyen,
riportare a casa bambini deportati
"Il rapimento di
bambini ucraini è un orribile promemoria dei momenti più bui della storia"
nonchè "un crimine di guerra" e "su 16.200 bambini deportati, solo 300 hanno
fatto ritorno". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, nella conferenza stampa al termine della prima giornata di
Consiglio europeo. "In partnership con gli ucraini, io e il primo ministro
Morawiecki abbiamo lanciato un'iniziativa per riportare indietro questi bambini
portati in Russia" e "organizzeremo una conferenza per aumentare la pressione
internazionale" sul tema, ha aggiunto.
22:03
Kiev contro Orban
sulla Cpi, sostenete il cadavere russo
"La Federazione
russa è un paese criminale innegabile che si dirige vergognosamente verso il
fondo della storia... Ma l'Ungheria ha ripetutamente danneggiato la sua
reputazione sostenendo direttamente il cadavere russo. Rifiutando anche la sua
firma dello Statuto di Roma... Per che cosa?". Lo afferma in un tweet il
consigliere presidenziale ucraino, Mikhail Podolyak, facendo riferimento alla
decisione di Budapest che ha annunciato di non volere arrestare il presidente
russo Vladimir Putin se mettesse piede sul suo territorio, poiché, sebbene
l'Ungheria abbia aderito alla Corte Penale Internazionale (Cpi), il trattato
"non è stato ancora promulgato" poiché "contrario alla Costituzione".
Lo Stato Maggiore
della Difesa avverte: il sostegno all’Ucraina ci sta lasciando senza scorte di
armi.
Il Riformista il 23 Marzo 2023
Altro che Russia
senza scorte di armi. L’esercito di Mosca si ritrova effettivamente impelagato
in un conflitto che doveva essere “lampo”, per prendere Kiev in pochi giorni e
sostituire il presidente Volodymyr Zelensky con un uomo di fiducia del Cremlino,
invece i militari russi si trovano dopo 13 mesi a battagliare nel Donbass già in
parte controllato sin dallo scoppiare della guerra civile del 2014.
Eppure, nonostante
le sanzioni internazionali che stanno mettendo a durissima prova l’economia
russa e che col passare dei mesi avranno effetti sempre più dirompenti in
particolare su alcuni settori chiave, per ora sono i partner occidentali
dell’Ucraina a soffrire, almeno per quanto riguarda lo sforzo bellico.
Lo dice senza mezzi
termini il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone,
in audizione alla Commissione Difesa ed Esteri del Senato. “Il sostegno
all’Ucraina ha creato problemi un po’ a tutti: quando mi sono trovato nei vari
consessi con le nazioni alle alleate o con quelle che fanno parte con altri del
gruppo di contatto per l’Ucraina, sono stati tutti fortemente coinvolti
e preoccupati per l’abbassamento del livello delle scorte, che non si è
abbassato oltre il livello di allarme ma tutti quanti ci siamo avvicinati a quel
limite e ci siamo resi conto che non abbiamo un supporto adeguato in questi
casi”, ha spiegato Cavo Dragone durante l’audizione.
Secondo il capo di
Stato maggiore della Difesa il tema dei tempi sull’approvvigionamento di armi
“andrà affrontato anche a livello di Unione europea“. “Abbiamo vissuto – ha
spiegato Cavo Dragone – gli ultimi venti anni pensando di fare lotta al
terrorismo, guerre asimmetriche e peacekeeping, ma un’attività così massiva come
si è manifestata nel teatro ucraino-russo non era tra le priorità. Non possiamo
permetterci di prenotare sistemi d’armi, di munizionamento o di missili e averli
tra venti mesi, perché tra venti mesi non possiamo sapere chi sono i buoni e
cattivi”.
Un problema che in
realtà era già stato posto alcuni mesi fa dal ministro della Difesa, Guido
Crosetto, con l’obiettivo di rilanciare sull’obiettivo di raggiungere per le
spese militari italiane il 2% rispetto al Pil, come chiesto dalla NATO, per
“ripristinare le scorte che servono per la Difesa nazionale”.
Solo tre giorni,
ricorda l’Ansa, fa l’Unione europea ha approvato una proposta sul piano
munizioni europeo per aiutare Kiev e per rimpinguare i magazzini degli Stati
membri. Ma l’accordo per ora è soltanto politico e l’unico obiettivo messo nero
un bianco è di dare un milione di munizioni a Kiev entro un anno. Lo svuotamento
dei hangar dei eserciti non è però l’unica conseguenza del conflitto. “Dopo lo
scoppio della guerra c’è stato uno tsunami sulla tanto discussa Difesa europea,
un’accelerazione notevole. Tutti i capi di Stato maggiore delle forze armate
dell’Unione hanno detto che c’è necessità e a quanto pare dovremmo arrivarci
anche a breve. Non dico che si palerà già di militarizzazione, ma il primo step
sarà di operazionalizzare la struttura di comando e controllo dell’ipotetico
strumento della Difesa dell’Unione europea – ha annunciato ancora Cavo Dragone
in Commissione al Senato – . Questo è solo il primo step ma è lo scheletro
intorno al quale poi costruire tutte le diramazioni, le specializzazioni e le
necessità a cui bisogna mettere attenzione per avere un esercito europeo“.
Estratto
dell’articolo di Domenico Quirico per “la Stampa” il 23 marzo 2023.
Lenin lo definiva
l'imperialismo dei pezzenti. Perfetto. Sono coloro che non hanno i mezzi ma
vorrebbero, quelli che fanno la voce grossa con slogan brodosi e di facile
impegno ma hanno arsenali e borsellino vuoti, i bluffatori, i rospi della
politica internazionale che si gonfiano per sembrare più grossi. […] Gli
imperialisti veri, quelli di zecca, quelli con la Roba, sono silenziosi,
colpiscono, occupano, distruggono. Putin per esempio. Come gli invadenti
americani: lo potrebbero testimoniare popoli interi, a partire dai messicani nel
1846 […]
Nella orribile
mischia ucraina […] spuntano rospetti da un anno impegnati a gonfiarsi a
dismisura. Purtroppo contribuendo […] a far ascendere il conflitto verso
orizzonti sempre più vasti e foschi. Perché gli imperialismi di riporto, di
modesta pecunia, sono convinti che soltanto se la guerra si fa grossa, al riparo
di una potenza vera, loro avranno spazio e diritto a ritagliarsi sciacalleschi
bocconcini della vittoria.
Devo a Boris Johnson
[…] una doverosa riparazione. Pensavo che il fervore bellicista […] fosse tutta
opera sua. […] Se qualcuno nella Nato esitava il micro Churchill dell'era del
tweet inveiva, fulminava la pavidità degli indecisi […] Ho pensato fosse solo il
bluff di uno sgangherato Falstaff bellicista […] Infatti gli stessi inglesi lo
hanno licenziato bruscamente, sepolto da un cumulo di bugie e incompetenza.
E invece mi
sbagliavo. Due primi ministri dopo, Londra guida sempre l'avanguardia della
guerra contro la Russia a tutti i costi, con tutti i mezzi, in ogni luogo, non
hanno affatto smarrito il lessico di Boris. Munizioni contraerea missili obici
anticarro siluri carrarmati istruttori: non basta? No! É il momento dei
proiettili insaporiti all'uranio, per nuocer di più e lasciar tracce velenose e
su tutti, buoni e cattivi.
Gli europei stanno
entrando in guerra camminando all'indietro […] Facendo finta di non sapere che
la pace su questa via è possibile solo se si chiama resa senza condizioni del
nemico. E quella bisogna ottenerla, accettando di pagare un prezzo diretto e non
solo versando cambiali agli altri. Il Regno Unito no: della pace non vuol sentir
parlare, coniuga la parola solo se si traduce con vittoria. Sono sempre un passo
avanti, gli inglesi, incitano, eccitano, soffiano e quando la brace sembra meno
vispa trovano i modo per ravvivarla provocando e aumentando la posta. Come
accade gettando sul campo i proiettili all'uranio.
Un tempo operavano
in proprio, dalle guerre dell'oppio alla strage degli zulu alla più domestica
Irlanda. […] nel 1952 in Malesia, messi alle strette dalla guerriglia comunista,
irrorarono le selve con l'acido. Gli americano vi trassero proficua ispirazione
per ammansire con i defolianti i Vietcong. L'ultima impresa imperiale autonoma
fu Suez, 1956. Una figuraccia, una umiliazione per di più proprio per mano
americana che voleva sfilare all'Impero agonizzante il vicino oriente. In quel
momento i politici inglesi compresero che il mondo era diventato troppo grande
per un made in England lillipuziano, decrepito e fatiscente e hanno scelto le
meste attrattive della subordinazione istituzionale e sistemica agli americani.
Sì. erano loro ad
aver bisogno degli americani per contare ancora qualcosa nel groviglio polimorfo
del mondo nuovo e non il contrario. Tutti i premier inglesi, laburisti e
conservatori, hanno fatto a gara a chi era il maggiordomo più efficiente e
laborioso di Washington. Erano passati nel palazzo imperialista dal piano nobile
alla soffitta della servitù. Poco male, l'importante era restare nel palazzo,
raccogliere mance e briciole dalla potenza dei nuovi padroni di casa. […] La
perfezione ancillare fu raggiunta con Blair, inventore della formula
dell'imperialismo postmoderno, diceva lui, informale e filantropico. Una bugia
come quelle, assai formali, che pronunciò per appoggiare l'invasione americana
dell'Iraq. […]
Le munizioni di
Londra all'Ucraina. Cosa sono le munizioni all’uranio impoverito e perché sono
pericolose: fanno strage di amici e nemici.
Paolo Comi su Il
Riformista il 23 Marzo 2023
L’uranio
impoverito, contenuto soprattutto nei missili anticarro, ha provocato solo fra
i militari italiani circa 300 morti di tumore e oltre 8000 ammalati gravi. Il
nesso di causalità fra l’esposizione all’uranio impoverito e le patologie
tumorali è ormai provato da più di 300 sentenze emesse da decine di tribunali.
In Serbia, un tempo uno dei paesi più salubri al mondo, i casi di tumore fra la
popolazione, dopo il conflitto nei Balcani in cui la Nato utilizzò in maniera
massiccia i proiettili con l’uranio impoverito, crescono di 40mila all’anno. Non
sono disponibili i dati per l’Iraq e per l’Afghanistan, gli altri due paesi dove
si è fatto in questi anni impiego su larga scala di tale munizionamento. Una
strage silenziosa, di cui nessuno parla, destinata a numeri ancora più elevati
se la Nato decidesse di voler bombardare le truppe russe in Ucraina con i
missili all’uranio impoverito.
Uno dei massimi
esperti di questa materia è l’avvocato romano Angelo Fiore Tartaglia che da
oltre 20 anni segue le cause risarcitorie dei soldati italiani che, dopo essere
stati in missione all’estero dove erano state utilizzate queste armi micidiali,
tornando in patria hanno scoperto di avere un tumore. I primi casi risalgono
alla fine del 1999 e riguardarono i soldati che avevano prestato in servizio
in Kosovo. Poi, appunto, in Iraq ed Afghanistan. Emblematico fu il caso
della caserma Tito Barak di Sarajevo, ex sede dell’Accademia militare
bosniaca, uno degli obiettivi maggiormente colpiti dal munizionamento all’uranio
impoverito della Nato. Proprio tra i militari delle forze alleate (la maggior
parte erano italiani) che alloggiarono alla Tito Barak fu riscontrata la più
alta concentrazione di malattie e di decessi causati da linfomi. In particolare
il linfoma di Hodgkin. La prima vittima di quella che verrà chiamata
la “sindrome dei Balcani” sarà il caporale maggiore Salvatore
Vacca della Brigata Sassari.
All’inizio la
Cassazione vietava di fare cause per risarcimento del danno ai militari che si
erano ammalati, ritenendo che la decisione di impiegare le truppe all’estero
fosse “insindacabile”. La giurisprudenza, poi, ha cambiato indirizzo ritenendo
responsabile il datore di lavoro del militare, quindi il Ministero della
Difesa. Ma perchè si utilizzano i proiettili all’uranio impoverito? Il motivo è
molto semplice: sono molto efficaci. Quando impattano sull’obiettivo sprigionano
temperature fino a 3000 gradi che sciolgono come il burro anche le corazze
dei carri armati più sofisticati. Il problema è che “polverizzano”, con la
conseguente dispersione di micro e nano particelle che sono classificate a
rischio oncologico uno, il rischio massimo. Gli arsenali della Nato, Stati
Uniti in testa, sono pieni di questi proiettili che, comunque, vengono impiegati
da tutti gli eserciti i cui paesi dispongono di centrali nucleari.
L’uranio
impoverito è, infatti, lo scarto della produzione energetica e il modo più
rapido per smaltirlo è utilizzarlo per i fini bellici. Nei Balcani i proiettili
di questo genere utilizzati hanno provocato radiazioni e dispersioni di
particelle superiori di 300 volte alle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Tornando
alle vittime fra i militari italiani, la maggior parte appartengono all’Esercito
e all’Arma dei Carabinieri, inizialmente impiegati sui teatri di guerra senza
alcuna protezione. Eppure già negli anni Novanta esistevano documenti Nato in
cui era segnalato che inalare polveri derivanti dall’esplosione di questi
proiettili provocava il tumore. Per anni, però, il Ministero della difesa non ha
fatto nulla, non informando dei rischi il personale inviato in missione
all’Estero. L’uranio impoverito, comunque, non provoca solo tumori: studi
recenti hanno dimostrato che è in grado di interferire sul sistema nervoso
centrale, causando malattie come la sclerosi multipla. La storia dovrebbe aver
insegnato qualcosa. Paolo Comi
Proiettili
all’uranio all’Ucraina, l’ira della Russia: «Avvicinano lo scontro nucleare».
Lorenzo Cremonesi su Il Corriere della Sera il 22 Marzo 2023
La Gran Bretagna
annuncia che fornirà a Kiev carri armati con proiettili all’uranio impoverito.
La risposta di Mosca: «Avvicinano lo scontro nucleare, reagiremo». E i droni
ucraini colpiscono una bse in Crimea
Settimana dopo
settimana, addirittura giorno dopo giorno, i segnali dell’approssimarsi della
già annunciata «controffensiva ucraina di primavera» si fanno più evidenti. E
sono ormai talmente predominanti che hanno praticamente soppiantato quelli della
tanto sbandierata «offensiva russa», che comunque tra dicembre e febbraio scorsi
dominava le cronache della guerra. Vista da Kiev, e facendo la tara
all’inevitabile nebbia della propaganda, la spiegazione più evidente è quella
per cui i russi ci hanno già provato, ma non sono andati da nessuna parte. «I
comandi di Mosca hanno perso centinaia di tank e blindati nelle campagne di
Vuhledar ai primi di febbraio. Poi la loro fanteria non è riuscita ad avanzare
da Kreminna verso Kharkiv e adesso sia i mercenari della Wagner che il meglio
delle ultime unità d’assalto dell’esercito regolare continuano a dissanguarsi
per serrare l’assedio attorno alla cittadina di Bakhmut, senza peraltro ottenere
grandi risultati», ci spiegava l’altro giorno un alto ufficiale
dell’intelligence ucraina nel Donbass. Sembra invece che il capo di Stato
maggiore ucraino, Valery Zaluzhny, stia ancora una volta muovendosi con grande
discrezione, cercando di rivelare molto poco sulle sue prossime mosse.
Le ultime notizie
sulla guerra in Ucraina, in diretta
Uno dei segnali che
i commentatori locali seguono con attenzione è stato l’annuncio una settimana fa
di chiudere la zona di Kherson alla stampa. Voci non confermate parlano di unità
speciali che si muoverebbero nelle aree liberate a novembre con pontoni mobili
per attraversare il Dnipro, dove forse i russi meno se lo aspettano.
Un’altra mossa
rilevante è stata lunedì sera colpire con nuovi modelli di droni ad alta
autonomia le difese dell’aeroporto militare di Dzhankoi e soprattutto il suo
scalo ferroviario, dove erano fermi alcuni vagoni carichi di Kalibr, i missili a
lunga gittata che montati sulle navi della Flotta del Mar Nero causano caos e
terrore in tutta l’Ucraina. L’importanza strategica di Dzhankoi è ben nota: si
tratta della base militare russa più rilevante della Crimea settentrionale, da
cui partono i convogli verso le zone occupate di Kherson e Melitopol. Come
sempre avviene per i blitz sia in Crimea che nel territorio russo, anche ieri
gli ucraini non hanno rivendicato la paternità del raid, ma per una volta il
ministero della Difesa a Kiev ha sottolineato che sono stati distrutti i Kalibr.
Ad alimentare le
aspettative per la controffensiva è il continuo flusso di armi e munizioni del
fronte alleato, che di recente ha visto una notevole accelerata. Nelle ultime
ore l’annuncio del ministero della Difesa britannico di voler inviare proiettili
all’uranio impoverito ha provocato la reazione rabbiosa di Mosca, che denuncia
Londra di «avvicinare lo scontro nucleare». «Se l’Occidente iniziasse ad usare
armi con componenti nucleari, la Russia sarebbe costretta a reagire», ha
minacciato in serata lo stesso Putin. Intanto, ancora Londra raddoppia a una
trentina i tank Challenger per Kiev. Gli americani promettono di mandare al più
presto i loro Abrams ultrasofisticati (si credeva dovessero arrivare a fine
estate) e lo stesso fanno gli europei con il sistema antimissile Patriot. Sembra
siano, nel frattempo, già arrivati ben oltre cento carri armati Leopard di
fabbricazione tedesca, ma inviati dagli arsenali soprattutto polacchi, cechi e
dei Paesi baltici.
Estratto
dell’articolo di Gianluca Di Feo per repubblica.it il 22 marzo 2023.
[…] I proiettili a
uranio impoverito uniscono il sinistro futuro delle guerre nucleari agli antichi
calcoli balistici dell'artiglieria, concependo una munizione presentata come la
pallottola d'argento dei fumetti horror: l'unica in grado di sfondare qualsiasi
corazza.
Anche la sua
origine ha una doppia motivazione. Sfrutta infatti gli scarti della produzione
del combustile per le centrali atomiche e delle testate per le bombe
dell'Apocalisse: un enorme quantità di materiale a bassa radioattività ma che
pone comunque problemi di stoccaggio. Ed ecco l'idea nata al Pentagono negli
anni Settanta: poiché ha una densità altissima e basso prezzo, perché non
trasformarlo nel dardo per crivellare i tank sovietici? Le prove hanno
dimostrato che era più efficace del tungsteno e meno costoso. E così si
risolveva pure lo smaltimento delle scorie...
Nel tramonto della
Guerra Fredda si è cominciato a trasformarlo in proiettili, destinati a un
numero selezionato di cannoni. In particolare, a quelli dei carri armati Abrams
e agli Avenger - Vendicatore - ossia le micidiali armi a canne rotanti degli
aerei A-10. […]
L'esordio è
avvenuto nella campagna per la liberazione del Kuwait, con i tank di Saddam
Hussein trapassati da queste munizioni, sparate a migliaia da terra e cielo. Poi
i reduci hanno cominciato ad ammalarsi e sono iniziati gli interrogativi: non
sarà colpa dell'uranio impoverito?
Il dubbio è stato
riproposto dopo le operazioni nei Balcani, quando sindromi misteriose e
devastanti hanno colpito pure i militari italiani mandati nelle zone dove gli
A-10 statunitensi avevano distrutto i blindati serbi. […] Un fantasma velenoso,
invisibile ma persistente intorno alle carcasse delle battaglie della Bosnia e
del Kosovo. Che, come già in Iraq, è sospettato di avere trasmesso patologie
alla popolazione.
Molti studi hanno
negato un legame tra i proiettili e le malattie. Una ricerca del Commissario Ue
alla Salute pubblicata nel 2010 sostiene che i livelli di contaminazione
riscontrati in Kosovo sono "molto al di sotto della soglia di pericolo" […].
L'aspetto forse più
raccapricciante è che non sono mai state messe al bando, neppure quando le
missioni contro il terrorismo jihadista le hanno rese inutili, e colossi come
General Dynamics le offrono ancora in catalogo. […]
Nemmeno il governo
britannico, stando alle dichiarazioni, si è liberato delle munizioni - chiamate
Jericho - costruite per i tank Challenger, e oggi starebbe per consegnarle
all'Ucraina. Una scelta che apre tantissimi interrogativi. E che potrebbe non
essere l'unica. Negli ultimi mesi è stata ventilata più volte la possibilità che
gli Stati Uniti donino a Kiev i caccia A-10: aerei che impiegano esclusivamente
i proiettili tossici.
Kishida a Kiev, i
proiettili all'uranio impoverito: si gioca con la guerra globale.
Piccole Note
(filo – Putin) il 22 marzo 2023 su Il Giornale.
La Gran Bretagna ha
portato il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale. Infatti, non poteva
restare senza conseguenze l’annuncio che avrebbe inviato a Kiev proiettili
all’uranio impoverito, intenzione espressa dal vice ministro della Difesa
britannico Annabelle Goldie.
La visita di Xi in
Russia e l’escalation
Putin
ha dichiarato ufficialmente che “se ciò dovesse avverarsi, la Russia
sarà costretta a reagire“. A declinare la possibile reazione, politici e
analisti russi e filorussi, dal presidente bielorusso Lukaschenko, che ha
parlato di una risposta che “servirà da lezione al mondo intero” alla più
contenuta, ma non meno disastrosa, prospettiva immaginata dell’analista per la
Difesa di Ria novosti, secondo il quale l’esercito russo potrebbe iniziare a
usare le armi nucleari tattiche.
I proiettili
all’uranio, atti a distruggere i carri armati, causano una contaminazione
radioattiva che si propaga per decine di chilometri e che persiste per gli anni
a venire. Inutile specificare i danni causati dalle radiazioni, sia sui soldati,
russi e ucraini, sia sui civili che andranno ad abitare quelle regioni nel
dopoguerra (sul punto vedi The Intercept).
L’idea di utilizzare
tali proiettili, dati i danni che causeranno anche agli ucraini, dà la misura di
quanto gli sponsor di Zelensky abbiano a cuore il popolo che dicono di voler
aiutare… tant’è.
L’annuncio della
signora Goldie non è voce dal sen fuggita, dal momento che da tempo i neocon e i
loro adepti stanno facendo pressioni in tal senso. E a gennaio la Casa Bianca,
interpellata sulla questione, non ha escluso che gli Usa potessero compiere tale
disastroso passo.
Non riuscendo a
forzare la mano all’amministrazione Usa, i neocon hanno deciso di ricorrere
all’ancella d’oltreatlantico, già usata al tempo dell’invasione irachena grazie
a Tony Blair.
L’annuncio è giunto
durante il summit tra Putin e Xi Jinping, come risposta a questo. L’incontro tra
i due leader aveva suscitato qualche flebile speranza per la pace in Ucraina. La
risposta è stata un’ulteriore escalation, che si approssima a una delle linee
“rosse nucleari” di Mosca (Military watch).
Incenerire le
speranze di un negoziato
A dare l’idea che
potesse aprirsi uno spiraglio per i negoziati non erano state solo le aperture
di Putin al piano di pace cinese, ma soprattutto quelle più sorprendenti del
ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il quale aveva espresso la speranza
che la mediazione di Pechino potesse aprire spazi per un “cessate il fuoco”.
La sola idea che
qualcosa si potesse muovere in tal senso ha letteralmente fatto impazzire
l’amministrazione Usa, che ha avuto reazioni che possono definirsi isteriche sia
contro la visita di Xi in Russia che contro la prospettiva di una mediazione
cinese sul conflitto ucraino.
Negli Stati Uniti,
infatti, si è registrata una vera e propria escalation di dichiarazioni contro
il piano di pace cinese, e specificatamente contro il cessate il fuoco,
prendendo evidentemente sul serio le parole di Kuleba. Un nervosismo rivelatore.
Evidentemente non si
fidavano di Kiev. Avevano paura che le élite ucraine forzassero Zelensky a fare
un passo in tale direzione. Infatti, nonostante Zelensky si proponga come l’uomo
solo al comando, esiste all’interno della leadership ucraina un’opposizione
tacita al suo egotismo, che si è rafforzata dopo la sua decisione di difendere a
tutti i costi Bakhmut, che parte delle élite reputava
saggio abbandonare evitando la macelleria che vi si sta consumando (ipotesi che,
peraltro, aveva il sostegno americano, che da tempo ha suggerito il ritiro).
La mission di
Kishida
Così, a rafforzare
la posizione di Zelensky, e per evitare possibili tentennamenti di Kiev, Fumio
Kishida è volato improvvisamente in Ucraina. Una visita furtiva quella del
presidente giapponese, che ha tutta l’apparenza di una missione approntata in
fretta e furia, come se gli fosse stato affidato un incarico urgente di cui si è
fatto parte diligente.
Diverse la anomalie
del viaggio registrate dai media giapponesi. Anzitutto, come annota Kyodo News,
la visita non ha avuto l’approvazione previa del Parlamento giapponese, come da
prassi istituzionale.
Terminata la visita
di Stato in India, dopo la quale Kishida sarebbe dovuto tornare in Giappone,
senza avvertire nessuno, ha deciso di partire per la “Polonia utilizzando un
aereo noleggiato segretamente invece dell’usuale aereo governativo”. Quindi,
dalla Polonia, ha preso un treno per Kiev.
Il Japan
Times aggiunge che l’aereo noleggiato per l’occasione era lo stesso “usato dalla
star del baseball giapponese Shohei Ohtani quando è tornato in Giappone dagli
Stati Uniti all’inizio di questo mese”.
Kishida come Johnson
Tali anomalie sono
state motivate come dettate da ragioni di sicurezza, ma è davvero arduo
immaginare che Putin si metta a tirar giù gli aerei su cui viaggiano i capi di
Stato dei Paesi a lui ostili… tant’è.
Nel suo incontro con
Zelensky, dopo la visita di rito a Bucha, necessaria ad alimentare
la narrazione dei crimini russi, Kishida ha recitato il credo iper-atlantista,
ribadendo il sostegno “incrollabile” del Giappone all’Ucraina e sostenendo che
difenderla serve a preservare l’ordine internazionale basato sulle regole
(affermazione che suona bizzarra data la ricorrenza dei venti anni
dall’invasione dell’Iraq).
A nessuno è sfuggito
che la visita serviva a lanciare ufficialmente una sfida a Xi, ma essa serviva
anzitutto a incenerire sul nascere le possibilità aperte dal piano di pace
cinese. La visita improvvisata di Kishida sembra così aver ricalcato le orme
dell’altrettanto improvvisa visita di Boris Johnson, il quale ad aprile dello
scorso anno si precipitò a Kiev per impedire che l’Ucraina raggiungesse un
accordo con Mosca.
Non solo. Il
ministero degli Esteri cinese aveva dichiarato che il Giappone dovrebbe “aiutare
a ridurre la tensione invece di fare il contrario” (New York Times).
Evidentemente sapeva di cosa parlava, perché l’escalation si è materializzata,
sia con l’annuncio dei proiettili all’uranio britannici, sia con la decisione
degli Stati Uniti di accelerare i tempi per la consegna dei carri armati Abrams.
Il momento dei
kamikaze globali
Infine, sulla visita
a Kiev c’è da registrare quanto scrive Michael MacArthur Bosak, consigliere del
governo nipponico per l’Indo-pacifico, sul Japan Times, il quale, oltre ad
annotare il guanto di sfida lanciato da Kishida alla Cina, spiega che è la prima
volta che un leader nipponico si “reca in una zona di guerra da oltre mezzo
secolo”, iniziativa che apre la strada a una politica estera muscolare del
Giappone (lo scrive in termini più soft, ovviamente).
Inoltre, essendo il
primo leader di un Paese non occidentale a volare a Kiev, Kishida ha rotto lo
schema dello scontro tra Oriente e Occidente, evidenziando che si tratta di un
conflitto globale e, “con questa visita, il governo giapponese ha dimostrato che
non intende assistere a tale competizione da bordo campo”.
Dati i precedenti
del militarismo nipponico, non tranquillizza. Anche considerando che sono stati
loro a inventare i kamikaze (tornati di attualità con il Terrore
internazionale). Ricordo di nefasto auspicio, soprattutto in un momento in cui
si gioca con la Terza guerra mondiale, un gioco in stile kamikaze su scala
globale.
L'escalation del
conflitto. Cosa sono le armi all’uranio impoverito che Londra ha promesso a
Kiev.
Redazione su Il Riformista il 22 Marzo 2023
La Gran
Bretagna fornirà all’Ucraina proiettili con uranio impoverito da utilizzare
nella guerra con la Russia. Lo ha detto la viceministra britannica della
Difesa, Annabel Goldie. Citata dal Guardian, ha indicato che oltre a fornire
i carri armati Challenger 2, il Paese invierà “munizioni, compresi proiettili
perforanti contenenti uranio impoverito”. Questo tipo di proiettili, ha
aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati.
Se le munizioni
speciali verranno fornite a Kiev e utilizzate, la Russia sarà costretta a
reagire, ha detto il presidente russo Vladimir Putin nelle dichiarazioni alla
stampa al termine dei colloqui con il presidente cinese Xi
Jinping a Mosca, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. Immediata è
arrivata anche la replica della portavoce del ministero degli Esteri russo,
Maria Zakharova, che ha accusato il governo britannico di voler creare
uno “scenario jugoslavo”. “Questi materiali non solo uccidono, ma avvelenano
anche l’ambiente e provocano il cancro nelle persone che abitano queste terre”,
ha affermato in un messaggio sul suo account Telegram. “È un po’ ingenuo pensare
che queste armi causeranno vittime solo tra coloro contro i quali vengono
utilizzate. In Jugoslavia, i militari Nato, soprattutto italiani, sono stati i
primi a pagarne le conseguenze”, ha sottolineato.
Intanto un alto
funzionario ucraino ha dichiarato alla Cnn che sono in corso discussioni con
la Cina per organizzare una chiamata tra il leader cinese Xi Jinping e il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere della proposta
di Pechino per un piano di pace per l’Ucraina. Tuttavia, «non è stato
programmato nulla di concreto», ha precisato il funzionario. “L’Ucraina è
contraria ad un cessate il fuoco perché ciò significherebbe protrarre il
conflitto”, precisa il portavoce di Zelensky, Podolyak, nel corso del summit
tra Putin e Xi.
I proiettili
all’uranio impoverito causano tumori e contaminazione: ora li manderanno a Kiev.
Salvatore Toscano su L'Indipendente il 22 Marzo 2023
La baronessa Annabel
Goldie, viceministra della Difesa nel governo di Rishi Sunak, ha dichiarato il
Regno Unito fornirà all’Ucraina munizioni anticarro perforanti ad alto
potenziale contenenti uranio impoverito. La rivelazione, avvenuta il 20 marzo
durante un’audizione alla Camera dei Lord, è passata in sordina nei media locali
fino a che non è stata rilanciata il giorno dopo dai giornali ucraini. Il tutto
mentre a circa 2500km da Westminster si svolgeva a Mosca l’incontro tra il
presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping. Replicando alla
preoccupazione di alcuni parlamentari presenti in Aula, Annabel Goldie ha
cercato di ridimensionare la portata della notizia: «Assieme a uno squadrone di
carri armati pesanti da combattimento Challenger 2 manderemo anche le relative
munizioni, inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito poiché
altamente efficaci per neutralizzare tank e blindati moderni russi». La
baronessa ha però dimenticato che l’impatto delle pallottole genera la
diffusione di microparticelle di uranio che, anche se “impoverito”, continua a
emettere radiazioni a danno delle persone e del territorio circostanti.
Nel proprio
arsenale, il Regno Unito conta almeno due tipi di proiettili all’uranio
impoverito: Charm 1 e Charm 3, sviluppati negli anni ’90. Entrambi possono
essere utilizzati come munizioni per i Challenger 2, tank pesanti da
combattimento di standard NATO che il governo Sunak ha promesso all’Ucraina.
Alla rivelazione del governo britannico ha fatto seguito la risposta di Putin,
impegnato nell’incontro a Mosca con Xi Jinping, che ha dichiarato: «la Russia
sarà costretta a reagire alle forniture occidentali di munizioni all’uranio».
Dal Cremlino il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha rilanciato,
definendo lo scontro nucleare ormai «a pochi passi». In poche ore si è passati
dunque dall’apertura nei confronti dei colloqui di pace, partendo dal
progetto presentato da Pechino, all’ennesima escalation tra le parti. La
tensione era già aumentata qualche ora prima dell’arrivo di Xi Jinping a Mosca,
quando il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca,
John Kirby, ha dichiarato: «la richiesta di una tregua in Ucraina è
inaccettabile perché significherebbe ratificare le conquiste fatte fino a oggi
dalla Russia e concedere più tempo a Putin».
Il dibattito
all’interno della comunità internazionale sull’utilizzo delle armi all’uranio
impoverito non si è ancora concluso, dal momento in cui questa tipologia di
proiettili non è stata definitivamente messa al bando. Diversi Paesi, tra cui
proprio il Regno Unito, continuano a utilizzare queste “armi non convenzionali”.
Si sminuisce così il loro impatto sulla salute e sull’ambiente giustificando la
scelta alla luce di studi che negano il legame diretto tra proiettili e malattie
o dell’assenza di trattati restrittivi in merito. Allo stesso tempo non vengono
prese in considerazione ricerche, sentenze e testimonianze dirette che procedono
invece nella direzione opposta. I proiettili all’uranio impoverito sono stati
utilizzati in modo massiccio dagli eserciti occidentali in Iraq, Kuwait e
nei Balcani. Nel 2001, l’allora procuratrice capo del tribunale penale
internazionale per l’ex Jugoslavia Carla del Ponte affermò che l’utilizzo delle
armi all’uranio impoverito da parte della NATO fosse assimilabile a un crimine
di guerra. Tale fattispecie di reato, appartenente alla categoria dei “4 crimini
internazionali”, è definito dettagliatamente dall’articolo 8 dello Statuto di
Roma. Comprende anche “la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte
della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale
territorio”; reato per cui la Corte Penale Internazionale dell’Aia ha di recente
emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin.
L’Osservatorio
Nazionale Amianto (ONA) ha censito circa 8.000 militari italiani che, di ritorno
dalle missioni nei Balcani, sono stati colpiti da diverse malattie. Le più
comuni sono state i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin e la leucemia. Il
presidente ONA Ezio Bonanni ha più volte denunciato i rischi dell’esposizione
all’uranio impoverito, ricordando come la sostanzia abbia «provocato almeno 400
decessi solo per tumori emolinfopoietici tra tutti coloro che sono stati
impiegati nelle missioni all’estero». Nel 1995 e nel 1999 la Bosnia Erzegovina e
il Kosovo vennero colpiti dalla NATO con proiettili all’uranio impoverito. Una
sentenza del 2013, emessa dalla Corte dei Conti della Regione Lazio, ha accolto
il ricorso presentato da un militare ammalatosi di tumore, al quale il ministero
della Difesa aveva rigettato la richiesta di pensione privilegiata. La sentenza
ha sottolineato la correlazione tra la malattia e le condizioni ambientali in
cui il militare aveva prestato servizio (Kosovo). Diverse perizie medico legali
nominate dalla Corte hanno confermato la presenza, nei tessuti neoplastici del
soldato, svariate nano-particelle “estranee al tessuto biologico, che quindi
testimoniano un’esposizione a contaminazione ambientale”. Dagli atti risulta,
inoltre, che “tutti gli alimenti distribuiti alla mensa e allo spaccio della
base ove prestava servizio il ricorrente, compresa l’acqua utilizzata sia per
l’alimentazione sia per l’igiene personale, erano oggetto di approvvigionamento
in loco” e quindi inquinati dall’uranio impoverito e dalle sue micro polveri.
Un’informazione che assume ancor più rilevanza se si considera che la zona del
Kosovo posta sotto protezione del contingente italiano fu la più bombardata
dalla NATO nel 1999: 50 siti per un totale di 17.237 proiettili. [di Salvatore
Toscano]
Munizioni
all'uranio impoverito: come funzionano, cosa provocano.
Sergio Barlocchetti su Panorama il 22 Marzo 2023.
Londra le fornirà
all'Ucraina, torna lo spettro della "Sindrome dei Balcani". La Russia minaccia
un'escalation bellica e il rischio è che venga contaminato quello che è ritenuto
il granaio d'Europa Munizioni all'uranio impoverito: come funzionano, cosa
provocano
La notizia secondo
la quale Londra fornirà a Kiev munizioni anticarro perforanti all'uranio
impoverito ha visto una rapida e severa reazione di Mosca, il cui ministro della
Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato: “lo scontro nucleare è ormai a un passo". Si
parla però delle munizioni Charm 1 e Charm 3 utilizzate nei cannoni da 120
millimetri di alcuni carri armati, principalmente con funzioni anticarro. Le
vicende legate all’uso di Uranio impoverito per scopi militari balzarono alla
cronaca dopo le denunce da parte di militari che si ammalarono dopo le campagne
in Kosovo, dove si stima che furono sparati circa 32000 colpi pari a disperdere
circa 15 tonnellate di materiale radioattivo. Si parlò quindi di “Sindrome dei
Balcani” per intendere le malattie che colpirono i militari italiani dopo il
loro rientro dalle missioni internazionali di pace. I soldati svilupparono
proprio linfomi di Hodgkin e leucemia.
Dal punto di vista
del trasporto, dello stoccaggio e della movimentazione, queste munizioni non
sono più pericolose di quelle tradizionali; tuttavia, nel momento in cui
esplodono perforando le corazze, proprio in virtù dell’alto rapporto tra peso e
volume, bruciando a migliaia di gradi, creano un pulviscolo riconosciuto come
altamente cancerogeno. Il materiale “impoverito” si ricava come sottoprodotto
del procedimento di arricchimento dell’uranio per scopi energetici, e serve sia
per scopi civili (tipicamente medicali e aerospaziali), sia militari. In
pratica, grazie all’altissima densità, piccole quantità di materiale in termini
di dimensioni hanno grande peso, e questo per esempio fa dell’uranio depleto (si
chiama anche così), un buon materiale per costruire masse di bilanciamento negli
aeroplani e non soltanto. Per lo stesso motivo e dopo un processo di indurimento
e drogaggio (si aggiungono altri elementi in piccole percentuali e lo si
sottopone a trattamento termico), acquisisce proprietà meccaniche tali da essere
usato per i proiettili, ovvero diventa duro come un acciaio, pur costando meno
di altri materiali come il tungsteno, permettendo di realizzare proiettili di
ridotto calibro ma molto efficaci. In campo medico il processo di indurimento
non occorre, ma vengono sfruttate le sue proprietà duttili e la capacità di
assorbire radiazioni, che lo rende ottimo per realizzare elementi di
schermatura. Il suo peso è utile anche per farne anche attrezzature per la
perforazione in campo energetico. Gli studi per l’uso dell’uranio impoverito per
scopi bellici risale alla fine degli anni Cinquanta, ma ufficialmente è stato
usato durante la prima guerra del Golfo, in Kosovo e in altri teatri, non è
pericoloso da maneggiare ma lo diventa nel momento in cui, esplodendo la carica
associata, vaporizza bruciando, producendo schegge e un pulviscolo che viene
respirato dagli esseri viventi. Questo pericolo rimane in sospensione nell’aria,
viene trasportato dal vento e si deposita sull’ambiente, conservando la
radioattività per un tempo piuttosto lungo. Dunque se anche un soldato
sopravvive a uno scontro nel quale sono state usate queste munizioni, la
permanenza sul teatro delle operazioni diventa un rischio molto alto per il solo
fatto di respirarlo e farlo depositare nei polmoni, con un effetto peggiore di
ciò che provocano i metalli pesanti in genere, poiché l’uranio impoverito arriva
a viaggiare all’’interno degli organismi fino a raggiungere organi come stomaco,
intestino (ingerendolo e bevendo acqua contaminata), pancreas, reni, centri
vitali, sperma e geni, causando morti e malformazioni, lo sviluppo di linfomi di
Hodgkin e diverse forme di leucemia. In caso di sospetta esposizione è proprio
dalle urine che è possibile determinare se i reni e il fisico sono stati invasi,
ma le tracce devono essere cercate appositamente e non si rivelano con un esame
generico di controllo. In genere quando si scopre la contaminazione è già troppo
tardi. C'è da chiedersi, a guerra finita, quali conseguenze si avranno sul grano
coltivato in Ucraina ed esportato in mezzo mondo
La pace di Xi sul
tavolo di Putin: «Eterna amicizia tramandata di generazione in generazione». Guido
Santevecchi su Il Corriere della Sera il 21 Marzo 2023.
I due leader fianco
a fianco, a rimarcare la «vicinanza» tra i rispettivi Paesi Lo zar «pronto a
negoziare». Il Nuovo Timoniere: «Stessi obiettivi»
Da quando ha
scatenato l’aggressione all’Ucraina, lo zar ha preso le distanze da tutto e da
tutti, confinando visitatori e collaboratori all’altro capo di un tavolone ovale
lungo sei metri. La regola non poteva valere per «il caro amico» venuto da
Pechino proprio per rompere l’isolamento del leader russo.
Putin ha subito
ringraziato dicendo di essere «sempre pronto a negoziare», di avere «rispetto»
per la proposta di soluzione elaborata da Pechino, di volerla studiare con Xi e
di essere disposto a fornire «chiarimenti». Per mostrarsi ancora più grato della
visita, ha aggiunto che «la Russia è un po’ invidiosa» per il rapido sviluppo
della Cina negli ultimi decenni. Su questo punto è stato probabilmente sincero:
Mosca ormai è considerata la sorella povera di Pechino.
Nel minuetto
diplomatico Xi ha firmato un editoriale sulla Rossiyskaya Gazeta dove
chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi ucraina (che evita sempre di
chiamare invasione) e ripresenta la proposta di «soluzione politica» in 12 punti
come un tentativo di «rappresentare per quanto è possibile le vedute unitarie
della comunità mondiale». Xi conclude che i problemi complessi non hanno facili
soluzioni e inneggia alla «eterna amicizia tra Cina e Russia tramandata di
generazione in generazione» (in realtà i due imperi sono stati storicamente più
divisi e sospettosi l’uno dell’altro che vicini fraterni).
Contemporaneamente
il Renmin Ribao (Quotidiano del Popolo) di Pechino ha pubblicato un intervento
di Putin «grato per la linea equilibrata della Cina sugli eventi in corso in
Ucraina e per la sua comprensione delle cause reali». Lo zar accomuna Russia e
Cina come vittime del «doppio contenimento da parte degli Stati Uniti». Anche Xi
si è lamentato in pubblico dell’accerchiamento americano e ieri ha detto che «è
vero che le nostre due nazioni condividono obiettivi uguali e alcuni simili».
Da Pechino, il
portavoce degli Esteri critica l’incriminazione di Putin da parte della Corte
penale internazionale: «Il tribunale dell’Aia deve rispettare l’immunità dei
capi di Stato, senza usare due pesi e due misure». Ha esternato sul tema anche
Dmitry Medvedev, pretoriano di Putin, consigliando su Telegram ai giudici
dell’Aia di «guardare sempre il cielo, perché un missile ipersonico può sempre
arrivare». Non va liquidata solo come boutade incendiaria: vista la fine
violenta di numerosi avversari del Cremlino all’estero suona come
un’intimidazione.
Oggi Xi e Putin
trattano di cooperazione politica ed economica. L’interscambio commerciale è
salito a 185 miliardi di dollari e Putin già prevede che quest’anno arriverà a
200. Le transazioni su gas e petrolio russo vengono ormai regolate
principalmente in yuan: gli analisti osservano che la Banca centrale di Mosca si
lega a una moneta strettamente controllata da Pechino.
Quello che volevano
comunicare al mondo è stato detto ed esibito intorno al tavolino. Putin mostra
di non essere solo. Xi ha più messaggi: si veste da statista globale; copre la
sua solidarietà verso Mosca con i 12 punti che vanno dal cessate il fuoco alla
ricostruzione dell’Ucraina devastata; cerca di convincere della propria buona
volontà pacificatrice gli europei; infine dice a Joe Biden che la Cina può
sempre rivolgersi alla Russia per spezzare l’accerchiamento sul fronte asiatico.
Si spera in un
vertice (almeno telefonico) con Volodymyr Zelensky, ma qui Xi dovrà essere più
cauto, perché il presidente ucraino è un grande comunicatore e potrebbe svelare
la vera posizione emersa da un colloquio.
Il politologo cinese
Wang Huyao chiede di dare una chance a una mediazione di Pechino. Spiega che «è
credibile perché fermando la guerra Xi eviterebbe l’ulteriore indebolimento del
partner russo e rilancerebbe il dialogo economico con l’Europa».
Pechino fa filtrare
anche vecchi rancori: «Per le alleanze con la Russia la Cina ha spesso pagato un
prezzo alto», ha detto lo storico Feng Yujun in una conferenza. Xi e Putin sono
quasi coetanei, il leader cinese è nato nel 1953, il russo nel 1952. È noto che
Xi ammira il collega per il suo decisionismo (i cinesi sui social lo chiamano
«Pu da di», «grande imperatore Pu»). Ma c’è una grossa differenza nelle
biografie dei due leader: «Xi da uomo maturo ha vissuto una storia di successo
con la crescita della Cina e vuole proseguire la marcia in avanti; nella
percezione di Putin il passato della Russia era migliore del presente», ha
osservato subito dopo l’inizio dell’avventura in Ucraina Sergey Aleksashenko,
vicegovernatore della Banca centrale russa negli Anni 90.
Uno degli infiniti
modi di dire cinesi recita: «Vanno a letto insieme, ma fanno sogni diversi».
Sembra perfetto per i due «grandi amici» Xi e Putin. Si può aggiungere che
condividono un incubo: l’accerchiamento da parte dell’Occidente
Estratto
dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera” il 21 marzo
2023.
[…] Xi ha firmato un
editoriale sulla Rossiyskaya Gazeta dove chiede «una via razionale» per uscire
dalla crisi ucraina (che evita sempre di chiamare invasione) e ripresenta la
proposta di «soluzione politica» in 12 punti come un tentativo di «rappresentare
per quanto è possibile le vedute unitarie della comunità mondiale». Xi conclude
che i problemi complessi non hanno facili soluzioni e inneggia alla «eterna
amicizia tra Cina e Russia tramandata di generazione in generazione» (in realtà
i due imperi sono stati storicamente più divisi e sospettosi l’uno dell’altro
che vicini fraterni).
Contemporaneamente
il Renmin Ribao (Quotidiano del Popolo) di Pechino ha pubblicato un intervento
di Putin «grato per la linea equilibrata della Cina sugli eventi in corso in
Ucraina e per la sua comprensione delle cause reali». Lo zar accomuna Russia e
Cina come vittime del «doppio contenimento da parte degli Stati Uniti». Anche Xi
si è lamentato in pubblico dell’accerchiamento americano e ieri ha detto che «è
vero che le nostre due nazioni condividono obiettivi uguali e alcuni simili».
[…] Oggi Xi e Putin
trattano di cooperazione politica ed economica. L’interscambio commerciale è
salito a 185 miliardi di dollari e Putin già prevede che quest’anno arriverà a
200. Le transazioni su gas e petrolio russo vengono ormai regolate
principalmente in yuan: gli analisti osservano che la Banca centrale di Mosca si
lega a una moneta strettamente controllata da Pechino. Quello che volevano
comunicare al mondo è stato detto ed esibito intorno al tavolino.
Putin mostra di non
essere solo. Xi ha più messaggi: si veste da statista globale; copre la sua
solidarietà verso Mosca con i 12 punti che vanno dal cessate il fuoco alla
ricostruzione dell’Ucraina devastata; cerca di convincere della propria buona
volontà pacificatrice gli europei; infine dice a Joe Biden che la Cina può
sempre rivolgersi alla Russia per spezzare l’accerchiamento sul fronte asiatico.
Si spera in un vertice (almeno telefonico) con Volodymyr Zelensky, ma qui Xi
dovrà essere più cauto, perché il presidente ucraino è un grande comunicatore e
potrebbe svelare la vera posizione emersa da un colloquio.
[…] Pechino fa
filtrare anche vecchi rancori: «Per le alleanze con la Russia la Cina ha spesso
pagato un prezzo alto», ha detto lo storico Feng Yujun in una conferenza. Xi e
Putin sono quasi coetanei, il leader cinese è nato nel 1953, il russo nel 1952.
È noto che Xi ammira il collega per il suo decisionismo (i cinesi sui social lo
chiamano «Pu da di», «grande imperatore Pu»).
Ma c’è una grossa
differenza nelle biografie dei due leader: «Xi da uomo maturo ha vissuto una
storia di successo con la crescita della Cina e vuole proseguire la marcia in
avanti; nella percezione di Putin il passato della Russia era migliore del
presente», ha osservato subito dopo l’inizio dell’avventura in Ucraina Sergey
Aleksashenko, vicegovernatore della Banca centrale russa negli Anni 90. Uno
degli infiniti modi di dire cinesi recita: «Vanno a letto insieme, ma fanno
sogni diversi». Sembra perfetto per i due «grandi amici» Xi e Putin. Si può
aggiungere che condividono un incubo: l’accerchiamento da parte dell’Occidente.
Grande madre
Ruxia.
Adolfo Spezzaferro su L’Identità il 21 Marzo 2023
La Russia accoglie
il piano di pace proposto dalla Cina, l’Occidente a guida Usa lo respinge. In
sintesi è questa l’ennesima contrapposizione scaturita dall’incontro di ieri a
Mosca tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin.
Il dragone si propone ancora una volta come mediatore per una soluzione
negoziale del conflitto russo-ucraino ma ancora una volta da Washington arriva
lo stop: nessun cessate il fuoco, la guerra deve continuare. “Il loro è solo un
inganno” è l’accusa della Casa Bianca contro Putin e Xi. Accusa ripetuta dalla
Ue, che anzi alza il tiro, stanziando due miliardi di euro in munizioni per
Kiev. “Quanto al piano di pace della Cina, serve un sforzo intellettuale molto
grande per considerarlo un piano di pace. È una considerazione della Cina
riguardo alla situazione”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica
estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio
Esteri-Difesa. La guerra non si ferma, dunque.
“Caro signor
presidente, caro amico, benvenuto in Russia, a Mosca. Sono lieto di avere
l’opportunità di congratularmi personalmente per la rielezione a capo dello
Stato cinese”. Lo ha detto il presidente russo all’inizio dell’incontro
informale con il presidente cinese al Cremlino, a Mosca. Xi dal canto suo ha
usato toni identici: “Caro presidente Putin, ti chiamo sempre mio caro amico.
Sono molto lieto del tuo invito a compiere un’altra visita di Stato in Russia,
soprattutto subito dopo la mia rielezione a Presidente della Repubblica popolare
cinese, e ho scelto la Russia come mia prima visita all’estero. Mi hai appena
ricordato che esattamente dieci anni fa, quando sono diventato per la prima
volta Presidente della Repubblica popolare cinese, ho scelto la Russia come
Paese per la mia prima visita all’estero. Me lo hai ricordato e fino ad oggi
quelle immagini rimangono nel mio cuore. So che l’anno prossimo il tuo Paese
avrà un’altra elezione presidenziale. Grazie alla tua forte leadership negli
ultimi anni, la Russia ha ottenuto grandi risultati diventando un Paese di
successo e prospero. Sono fiducioso che il popolo russo ti sosterrà fortemente
nelle tue buone azioni”.
È durato quattro ore
e mezzo il colloquio tra i due leader nel pomeriggio a Mosca. Lo ha fatto sapere
il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin e Xi si sono incontrati al
Cremlino per colloqui “informali e tête-à-tête”, come riporta l’agenzia russa
Ria Novosti. La giornata-clou della visita del presidente cinese sarà oggi, con
dichiarazioni ufficiali. Secondo l’agenzia, Putin e Xi hanno discusso sia della
cooperazione bilaterale che della situazione sulla Ucraina e del piano proposto
da Pechino per risolvere la crisi.
“Guardiamo con
interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina”, ha
dichiarato il leader russo. Il piano di pace della Cina, che prevede il rispetto
della “sovranità di tutti i Paesi” e la fine di eventuali sanzioni, è
“costruttivo” e promuove una “soluzione politica”, ha affermato Xi, per il quale
“i problemi complessi non hanno soluzioni semplici”. “Sono fiducioso che la
visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle
relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una
nuova era”, ha sottolineato il leader cinese, secondo il quale Russia e la Cina
intendono lavorare insieme per promuovere il “multilateralismo” e la “governance
globale in una direzione più giusta e razionale”, sulla base dei principi delle
Nazioni Unite.
Sull’altro fronte,
quello che non vuole accettare un mondo multipolare ma difende la visione
dell’Occidente a trazione Usa come unico polo a difesa della democrazia sua
scala mondiale, troviamo l’amministrazione Biden che va ancora una volta
all’attacco dell’asse sino-russo. Il segretario di Stato Antony Blinken ha
avvertito che il mondo “non deve lasciarsi ingannare” dal piano di pace della
Cina, spiegando che un cessate il fuoco ora che non includa un completo ritiro
dall’Ucraina da parte delle forze russe sarebbe effettivamente una resa.
“Chiedere un cessate il fuoco che non includa la rimozione delle forze russe dal
territorio ucraino sosterrebbe effettivamente la ratifica della conquista
russa”, ha affermato Blinken. “Un cessate il fuoco ora senza una soluzione
duratura consentirebbe al presidente Putin di riposare e riorganizzare le sue
truppe e quindi ricominciare la guerra in un momento più vantaggioso per la
Russia”. Ancora, “il mondo non dovrebbe lasciarsi ingannare da alcuna mossa
tattica della Russia sostenuta dalla Cina, o da qualsiasi altro Paese, per
congelare la guerra alle sue condizioni”. “La visita di Xi a seguito del mandato
di arresto della Corte penale internazionale per Putin suggerisce che Pechino
non pensa che il Cremlino debba essere ritenuto responsabile delle sue atrocità
in Ucraina”, ha concluso Blinken.
Ma i fatti parlano
chiaro. La guerra prosegue non per volontà della Cina. Anzi, il Cremlino ha
accusato gli Stati Uniti di alimentare il conflitto e “di ostacolare una
riduzione dell’intensità delle ostilità e di continuare a inondare l’Ucraina di
armi”, ha dichiarato Peskov. Lo stesso dicasi per la Ue, che di pace non vuole
proprio sentire parlare, per adesso.
Xi-Putin, gli Usa
duri: «Il loro è solo un inganno». E inviano nuove armi per la controffensiva
ucraina.
diGiuseppe Sarcina su Il Corriere della Sera il 20 Marzo 2023.
L’amministrazione
Biden ritiene che il vertice sia una manfrina per mascherare il reale stato
delle cose. I servizi Usa temono che la Cina sia pronta ad aumentare il supporto
militare a Mosca. E la corsa contro il tempo si fa sempre più affannosa
A Washington, il
Segretario di Stato Antony Blinken si è presentato davanti ai giornalisti,
mentre a Mosca era in corso il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi
Jinping : «Il mondo non si faccia ingannare dalla mossa di Russia e Cina».
Il messaggio è
chiaro. Per l’Amministrazione Biden i colloqui di oggi, lunedì 20 marzo, tra Xi
e Putin sono solo una manfrina per mascherare il reale stato delle cose. Da una
parte il presidente russo non ha alcuna intenzione di fermare l’aggressione;
dall’altra il leader cinese cerca di mascherare l’appoggio sostanziale ai russi
con un piano di pace non credibile.
Già nella mattinata
di oggi, John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, era stato
molto netto in un’intervista con la Cnn: «Noi non accetteremmo la proposta di un
cessate il fuoco avanzata in questo momento. Credo che non lo farebbe neanche
Kiev. Fermarsi ora significherebbe ratificare la conquista del territorio
ucraino in mano ai russi. Inoltre Putin avrebbe il tempo per equipaggiare di
nuovo il suo esercito e riprendere l’attacco in un momento e in un luogo a sua
scelta».
E il ruolo della
Cina? L’intelligence Usa ritiene che Pechino stia già vendendo ai russi droni
per uso civile, fucili, giubbotti anti proiettili e altro materiale adattabile
per le esigenze della guerra. I servizi segreti americani, però, sospettano
che i cinesi stiano studiando le coperture per alzare il livello delle armi
consegnate.
Prima Kirby e poi
Blinken hanno avvertito ancora una volta Xi Jinping: «Non è nel suo interesse
armare Putin». È in atto, quindi, una controffensiva mediatica per stroncare sul
nascere le speranze, o le «illusioni» secondo gli americani, che quel vertice
possa aprire uno spiraglio per i negoziati. Blinken non solo ha escluso questa
possibilità, ma ha rilanciato su due fronti. Innanzitutto ha presentato un
rapporto compilato dal Dipartimento di Stato sui «crimini di guerra commessi dai
russi». Poi ha rilanciato l’impegno militare Usa, annunciando l’invio del «34°
pacchetto di armi e di equipaggiamenti» all’esercito ucraino. Nel
dettaglio: munizioni per le batterie di missili Himars e Horowitzer, per i
veicoli blindati Bradley, per le postazioni anti carro e altro ancora. Valore:
350 milioni di dollari che si aggiungono agli oltre 30 miliardi già stanziati
dall’inizio della guerra.
Anche l’Unione
europea si muove sulla traccia degli americani. Sempre oggi i ministri degli
Esteri Ue hanno dato il via libera alla consegna a Zelensky di munizioni per un
valore di 2 miliardi di euro. La metà della somma servirà per rimborsare, fino
al 90% delle uscite, i governi che stanno già attingendo ai propri arsenali; il
resto sarà utilizzato per ordinare soprattutto altri proiettili da 155 mm
destinati all’artiglieria. L’accordo sarà ratificato dai Capi di Stato e di
governo, nel Consiglio europeo di giovedì 23 e di venerdì 24 marzo.
Il fattore tempo
resta cruciale. Gli analisti europei stimano che i russi siano in grado di
sparare dai 20 mila ai 50 mila colpi di cannone al giorno; gli ucraini
rispondono con 4-7 mila esplosioni. Kiev ha chiesto agli europei di metterli in
condizioni di arrivare fino a 12 mila. L’Unione si prepara a farlo, con una
decisione che, naturalmente, ha un’importante valenza politica. Come gli
americani, anche i leader europei sono pronti a sostenere la resistenza ucraina
e un possibile contrattacco.
Putin-Xi, il
primo duetto. MICHELE
FARINA su Il Corriere della Sera il 20 Marzo 2023.
L’arrivo di Xi
Jinping a Mosca (ricordando quello di Mao tanti anni fa): oggi la newletter è
fatta di tanti viaggi, nel tempo e nello spazio. Dalla missione segreta che
(forse) cambiò la storia degli Stati Uniti alle miniere del Centrafrica (dove
nove cinesi sono stati uccisi nel «regno» dei miliziani russi), dai percorsi
misteriosi di Guido Olimpio nel Sud-Ovest degli Stati Uniti alla missione di
Assad nel Golfo, dall’Iraq vent’anni dopo la caduta di Saddam Hussein al
monastero ortodosso che fa litigare Kiev e il Vaticano. In fondo, un promemoria:
oggi che è il giorno della Felicità, che ne pensate di una passeggiata tra gli
alberi?
Putin-Xi, primo
minuetto.
GUIDO SANTEVECCHI su Il Corriere della Sera il 20 Marzo 2023.
Il preludio al
grande spettacolo del summit tra Vladimir Putin e Xi Jinping è stato un minuetto
ballato sui giornali. Sulla Rossiyskaya Gazeta il presidente cinese ha firmato
un editoriale dove chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi ucraina
(che ovviamente evita ancora di chiamare invasione) e ripresenta la proposta di
soluzione politica in 12 punti come un tentativo di «rappresentare per quanto è
possibile le vedute unitarie della comunità mondiale». Xi conclude che i
problemi complessi non hanno facili soluzioni e inneggia alla «eterna amicizia
tra Cina e Russia tramandata di generazione in generazione» (in realtà i due
imperi sono stati storicamente più divisi e sospettosi l’uno dell’altro che
compagni fraterni).
In un locale di San
Pietroburgo le immagini dell’arrivo di Xi Jinping a Mosca
Non ci si poteva
aspettare di più da un articolo scritto per far piacere al padrone di casa.
Contemporaneamente il Renmin Ribao (Quotidiano del Popolo) di Pechino ha
pubblicato un intervento di Putin «grato per la linea equilibrata della
Cina sugli eventi in corso in Ucraina e per la sua comprensione delle cause
reali». Il presidente russo dà il «benvenuto alla disponibilità cinese di
svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione della crisi» e poi spara a zero
sull’«Occidente collettivo che si aggrappa disperatamente a dogmi arcaici di
dominio». Lo zar accomuna Russia e Cina come vittime del «doppio contenimento da
parte degli Stati Uniti». Anche Xi si è lamentato in pubblico
dell’accerchiamento americano.
Mao-Stalin, il lungo
corteggiamento (a parti invertite). FABRIZIO DRAGOSEI su Il Corriere della Sera
il 20 Marzo 2023.
Anche il primo
storico incontro tra i capi supremi di Cina e Russia si era aperto con l’impegno
di entrambi a favorire la pace. E subito dopo Stalin, che riceveva Mao a Mosca
nel dicembre del 1949, si premurava di rassicurare il suo ospite: «Gli Stati
Uniti hanno paura della guerra. Gli americani chiedono agli altri di combattere
per loro…».
Gli stessi concetti
che Putin e i suoi vanno ripetendo in continuazione a proposito dell’Ucraina. Ma
mentre oggi Vladimir Vladimirovich spera che l’«amico» Xi possa aiutare il suo
Paese, sia economicamente che militarmente, allora il rapporto tra i due
campioni del comunismo era completamente invertito.
Il leader cinese si
trattenne a Mosca per due mesi, nella speranza di ottenere dal dittatore
sovietico un contributo fondamentale per la crescita della neonata Repubblica
popolare. Mao Zedong chiedeva a Stalin equipaggiamenti industriali, sostegno per
la Marina e l’aviazione, un intervento specifico per «liberare» Formosa,
l’attuale Taiwan. Il Piccolo padre fu decisamente evasivo. Generoso solo nel
dispensare consigli e promesse.
«Alcuni dei nostri
generali — spiegò Mao — sostengono che dovremmo richiedere l’assistenza
dell’Unione Sovietica, che potrebbe mandare piloti volontari o distaccamenti
militari segreti per accelerare la conquista di Formosa». Stalin rispose che la
cosa principale era «non dare agli americani un pretesto per
intervenire. Sarebbe la terza guerra mondiale». Poi il consiglio: «Selezionate
una compagnia di forze da sbarco, istruitele sulla propaganda, mandatele a
Formosa e per loro tramite organizzate una rivolta sull’isola».
I cinesi avevano
bisogno di tutto, e Stalin si impegnava. «Potremo creare corridoi aerei che
attraversino lo Xinjiang e la Mongolia… quadri della Marina cinese si potrebbero
addestrare a Port Arthur. Voi ci mandate gli uomini e noi vi diamo le navi».
Dalle varie conversazioni, traspare chiarissimo il desiderio del dittatore
russo di non inimicarsi i cinesi ma, soprattutto, di non far nascere nuovi
attriti con le potenze occidentali. Con l’accordo di Yalta, Mosca aveva
riconosciuto la Cina e il governo nazionalista che ora era il grande avversario
di Mao. Quindi grande cautela.
Una posizione non
troppo dissimile da quella dell’attuale leader di Pechino che promette eterna
amicizia a Putin ma non può assolutamente entrare in conflitto diretto con Stati
Uniti ed Europa, i due grandi mercati che assicurano la prosperità della sua
economia.
I 20 anni della guerra in Iraq: cosa resta dell’invasione Usa
Mauro Indelicato
il 19 Marzo 2023 su Inside Over.
Anche in Iraq la
guerra è iniziata nel cuore della notte. In quella compresa tra il 19 e il 20
marzo 2003 gli inviati a Baghdad, poco prima dell’alba, hanno segnalato il
rumore delle prime esplosioni subito dopo l’attivazione degli allarmi aerei.
Negli Stati Uniti mancavano poche ore a mezzanotte e le televisioni hanno
improvvisamente interrotto le trasmissioni per trasmettere il discorso del
presidente George W. Bush. Dallo studio ovale della Casa Bianca, Bush ha
annunciato l’avvio delle operazioni contro l’Iraq di Saddam Hussein.
Quest’ultimo parlerà poco dopo: in uno studio con lo sfondo blu, il rais ha
denunciato l’aggressione Usa e ha chiamato a raccolta tutti gli iracheni.
É stato quello il
momento spartiacque della storia recente del Medio Oriente. Una fase arrivata al
culmine di tensioni iniziate pochi mesi prima, con la denuncia di Washington di
possibili piani di Saddam per la costruzione di armi di distruzione di massa. La
storia dirà che di quelle armi per la verità non c’è mai stata traccia. Ma il 20
marzo 2003 la macchina bellica si è messa in moto. Il 9 aprile le truppe Usa
saranno già a Baghdad, ponendo fine a 24 anni di regno di Saddam Hussein e del
suo partito Baath. Da allora, sono passati esattamente 20 anni. Due decadi
scivolate via velocemente. Non tanto però da non far risultare attuali le
conseguenze degli eventi di quei drammatici giorni.
L’anniversario
della guerra visto dall’occidente
John Harris
sul Guardian nei giorni scorsi ha riportato come, alla vigilia del ventesimo
anniversario, della guerra del 2003 in occidente sono rimaste ben poche tracce.
Un’opinione espressa in primo luogo anche da diversi editorialisti del Financial
Times. I motivi possono essere diversi. A partire dal fatto che quel conflitto
non ha mai avuto molta popolarità. Se nel 1991, anno del primo braccio di ferro
tra Washington e Saddam, c’era di mezzo la necessità di ridare sovranità al
Kuwait, nel 2003 in pochi hanno capito i reali motivi della guerra. Il mancato
ritrovamento delle armi di distruzione di massa ha contribuito a rendere poco
comprensibile le operazioni belliche contro Baghdad. E quindi, di riflesso, a
far scivolare il conflitto nei meandri periferici della memoria.
La guerra poi non
è rimasta costantemente nelle prime pagine nemmeno durante i combattimenti. Il
20 marzo 2003 i telegiornali hanno trasmesso a più riprese le prime immagini dei
bombardamenti Usa, ma a fine mese si parlava già d’altro. I riflettori sono
stati puntati sulla Cina, lì dove stavano emergendo drammatiche notizie
sull’epidemia di Sars. E poi sul Canada, Paese nordamericano più colpito dal
virus. In occidente, in poche parole, in quei giorni si temeva maggiormente il
primo coronavirus nocivo per l’uomo che non le conseguenze di un conflitto mai
realmente compreso.
Le tracce più
significative, a 20 anni di distanza, sono quelle legate al dopoguerra. In Gran
Bretagna ad esempio, l’azione contro Saddam è rimasta come macchia indelebile
dell’operato di Tony Blair, premier e principale fautore insieme a Bush
dell’avventura militare del 2003. In Italia si ricordano i soldati morti nelle
operazioni di peacekeeping e i rapimenti fatali per alcuni nostri concittadini.
Ma della guerra in sé, a distanza di due decadi, i ricordi appaiono molto
sbiaditi e lontani.
Come in Iraq si
ricorda il conflitto
Dove ovviamente
il conflitto ha lasciato molte tracce e molte ferite è ovviamente in Iraq. Anche
se quanto accaduto venti anni fa è ricordato sotto diverse sfaccettature, a
seconda della generazione o della regione a cui si appartiene. I giovani non
hanno vivi ricordi. Circostanza quest’ultima da non sottovalutare: a vent’anni
dal conflitto, c’è una parte di Iraq che non ha vissuto l’era di Saddam e che è
nata in un’epoca del Paese postuma a quella del rais. Per loro forse la guerra è
ancora più lontana e la mente è più proiettata alle attuali difficoltà da
affrontare nella vita quotidiana.
A Baghdad invece
gli adulti ricordano molto bene il conflitto. Nel giorno dell’anniversario, il
pensiero di molte famiglie è rivolto alla corsa per l’accaparramento degli
alimenti fatta a poche ore dai bombardamenti, alla paura suscitata dagli allarmi
aerei, ai timori di ritrovarsi in una città nel pieno dei combattimenti. Ricordi
di sofferenza quindi, a cui si aggiungono quelli relativi a un dopoguerra
costellato di attentati, ribellioni e instabilità. La capitale irachena non
sembra rimpiangere il rais, ma non appare nemmeno così convinta di aver
imboccato la giusta strada dopo la guerra del 2003. Le ferite di allora sono
ancora aperte, in diverse zone i danni causati dal conflitto non sono ancora
stati riparati. La Baghdad “in pace” di oggi non è così diversa da quella in
guerra di venti anni fa.
Diverso il
contesto invece nel sud dell’Iraq. Qui vive la maggioranza sciita della
popolazione, la quale ha sempre visto nel sunnita Saddam Hussein un nemico.
Da Najaf a Bassora, il ricordo della guerra passa anche dal ricordo delle
aspettative di quei giorni. Aspettative spesso disattese, ma vissute all’epoca
in modo più forte rispetto a Baghdad. Un po’ come avvenuto nel Kurdistan
iracheno. Venti anni fa la guerra è durata poco in una regione dove i peshmerga
hanno subito approfittato dell’arrivo degli Usa per sbarazzarsi delle forze di
Saddam. Per i curdi il conflitto ha significato la possibilità di avere una
regione autonoma tutta loro. Anche qui però molte speranze sono state disattese
e oggi la crisi economica è tornata a mordere e a innescare nuove tensioni con
il governo centrale.
A Mosul invece il
ricordo della guerra del 2003 è destinato ad andare in secondo piano. Qui i
ricordi più vivi riguardano un altro conflitto, ben più duro e più
recente. Quello cioè combattuto contro l’Isis. Il passaggio del califfato da
queste parti, tra il 2014 e il 2017, ha lasciato cicatrici ancora più profonde e
a oggi ben lontane dall’essere anche minimamente rimarginate.
Che fine hanno
fatto i gerarchi di Saddam
Con l’arrivo
degli statunitensi a Baghdad, non è stata decretata soltanto la fine del lungo
regno personale di Saddam Hussein. Gli Usa hanno proceduto
alla liquidazione dello Stato iracheno precedente. Un vero e proprio processo di
“de baathizzazione“, come chiamato in seguito con riferimento alla caccia data a
tutti i rappresentanti principali del partito del rais. Con il senno del poi,
probabilmente una scelta non molto saggia da parte di Washington. Molti ex
fedelissimi di Saddam, dopo la guerra hanno alimentato la guerriglia islamista.
Nonostante una profonda differenza ideologica tra il laico Baath e i gruppi
jihadisti, nella ribellione sunnita ex membri del partito hanno visto la
possibilità di una resa dei conti contro le forze Usa.
Lo dimostrano le
parole dell’unico importante gerarca del rais mai catturato dai militari
statunitensi, Izzat Ibrahim al-Douri. Vice di Saddam, nel 2016 ha parlato di
“eroi” riferendosi ai combattenti dell’Isis in quel momento dilaganti nel nord
dell’Iraq. Al Douri è morto in latitanza nel 2020. Tutti gli altri membri di
spicco del Baath sono stati catturati poco dopo il conflitto. A partire
da Barzan Ibrahim Al Tikriti, fratellastro del rais ed ex capo dei servizi di
sicurezza. Preso nell’aprile 2003, Barzan è stato condannato a morte nel 2007.
Sorte toccata anche ad Ali Hassan Al Majid, soprannominato “Alì il chimico” per
il bombardamento contro il villaggio curdo di Halabja negli anni ’80.
Catturato nel
2003 anche il volto forse più popolare in occidente della gerarchia di Saddam,
ossia l’ex ministro degli Esteri Tareq Aziz. Rappresentante cristiano nel
governo di Baghdad, Aziz è stato l’esponente principale della diplomazia del
Baath ed è morto in un carcere di Nassiriya nel 2015. Sarebbe ancora vivo
invece Muhammad Saeed al-Sahhaf. Secondo gli Usa non era tra gli elementi di
spicco del regime iracheno, ma era ministro dell’Informazione durante la guerra.
Il suo volto è diventato popolare per le conferenze stampa convocate a Baghdad
in cui sosteneva, a poche ore dalla deposizione di Saddam, la non presenza di
americani in città. Per questo motivo è stato poi soprannominato “Alì il
Comico”. Incarcerato per breve tempo, oggi vivrebbe negli Emirati Arabi Uniti.
Cosa resta della
famiglia Hussein
Il destino del
rais è ben noto ai più. Saddam Hussein è stato arrestato nella sua Tikrit, a
nord di Baghdad, nel dicembre del 2003 e condannato a morte tre anni più tardi.
I suoi figli, Uday e Qusay, sono stati uccisi il 22 luglio durante il blitz nel
loro ultimo covo individuato a Mosul. La prima moglie del rais, Sajida Talfah, è
andata via da Baghdad già prima della guerra e oggi vivrebbe in Qatar. La coppia
ha avuto anche tre figlie: Raghad, Rana e Hala.
Particolarmente
significativa è la posizione di Raghad. Moglie di Hussein Kamel Al Majid, ex
fedelissimo di Saddam ucciso nel 1996 dopo aver disertato in Giordania, negli
ultimi anni avrebbe avuto anche ruoli di primo piano nella diaspora del Baath.
In particolare, nel 2007 è stata accusata di aver pagato l’insurrezione irachena
assieme alla madre. Per questo è stato emanato un mandato di cattura, ma oggi
vive con i suoi cinque figli e le altre due sorelle ad Amman. Nel marzo del
2021, è apparsa per la prima volta in tv intervistata da Al Arabiya. In
quell’occasione, non ha nascosto l’intenzione di tornare in futuro in Iraq e
concorrere per incarichi politici.
La situazione
nell’Iraq di oggi
Al di là delle
vicende dei protagonisti di venti anni fa, la guerra del 2003 oggi ha lasciato
nella società irachena non poche ferite. Lo hanno dimostrato le guerre civili
successive e le varie insurrezioni jihadiste. Anche se sul fronte della
sicurezza negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti, la stabilità a
Baghdad rimane una chimera. Il quadro politico è frammentato e frazionato in
diversi rivoli settari, circostanza che rende molto problematica la
ricostruzione delle zone distrutte dai conflitti e l’attuazione di riforme in
grado di far ripartire un’economia al collasso. Una fetta molto ampia della
popolazione vive in povertà e non sembrano esserci sbocchi positivi
all’orizzonte.
C’è poi la
questione della sovranità. Anche se le operazioni Usa sono terminate nel 2011,
nel Paese rimangono i militari statunitensi così come sono presenti anche i
miliziani filo iraniani inviati negli anni della guerra all’Isis. Emblematico in
tal senso quanto accaduto il 3 gennaio 2020, giorno in cui droni Usa hanno
colpito e ucciso il generale iraniano Qassem Soleimaini a pochi passi
dall’aeroporto di Baghdad.
A venti anni
dalla guerra, l’Iraq è ancora in cerca di stabilità, normalità e identità. Le
eredità di quel conflitto hanno quindi le sembianze di drammi attuali non ancora
superati e ben lontani dal trovare una soluzione.
MAURO INDELICATO
La guerra che
ha stravolto il Medio Oriente
Mauro Indelicato
il 20 Marzo 2023 su Inside Over.
La caduta
di Saddam Hussein, avvenuta il 9 aprile 2003 con l’arrivo dei carri armati Usa
nel centro di Baghdad, ha avuto molti effetti nella regione mediorientale. Il
motivo è essenzialmente basato sul fatto che l’Iraq, senza più un solido governo
al potere, si è trasformato in una potenziale polveriera. Il Paese, attraversato
storicamente da forti tensioni settarie e da una netta divisione tra sciiti,
sunniti e curdi, è diventato terreno di scontro sia tra i vari attori interni
che tra le potenze regionali.
La guerra del
2003 quindi, è possibile considerarla come un detonatore delle varie turbolenze
mediorientali ed è per questo che ha contribuito a cambiare volto non solo
all’Iraq ma anche alla storia dei Paesi circostanti.
Baghdad
nell’orbita iraniana
Durante l’era di
Saddam Hussein, l’Iraq ha vissuto in una situazione quasi paradossale. Pur
essendo il Paese a maggioranza sciita, il rais e la sua cerchia di fedelissimi a
Baghdad appartenevano alla minoranza sunnita. Circostanza che non ha mancato di
creare tensioni nel corso dei 24 anni di regime. Saddam ha spesso visto con
diffidenza l’emergere di gruppi politici e religiosi sciiti, stanziati
soprattutto nel sud del Paese. Questo ha portato, tra le altre cose, a un
aumento del livello di scontro con l’Iran.
Nello stesso anno
in cui il rais ha preso le chiavi del governo iracheno, a Teheran
una rivoluzione islamica portava al potere la teocrazia sciita guidata
dagli Ayatollah. Tra i due Paesi è scoppiata una guerra durata otto anni, al
termine della quale le relazioni diplomatiche non sono mai state ristabilite del
tutto.
Quando gli Usa
hanno detronizzato Saddam, gli sciiti iracheni hanno subito premuto per avere
una forte rappresentanza in seno alle nuove autorità. Le prime elezioni del 2005
hanno visto la vittoria dei partiti sciiti, a scapito di quelli sunniti. L’Iran
ha così potuto mettere le mani su Baghdad. Un effetto certamente non voluto e
quasi sicuramente non calcolato dagli Usa alla vigilia della guerra. Tra l’Iraq
filo sciita e la teocrazia iraniana, è nata una forte convergenza. In tal modo,
gli Ayatollah hanno iniziato ad avere il controllo di larghe fette del nuovo
potere iracheno.
Gli effetti di
questo repentino cambiamento si sono avuti anche in ambito regionale. Teheran ha
iniziato a pianificare la strategia cosiddetta della “mezzaluna sciita“. Un
progetto volto a legare idealmente il proprio governo con il nuovo Iraq post
Saddam, con la Siria governata dallo sciita alauita Bashar Al Assad, estendendo
poi la propria sfera di influenza fino a Beirut. Qui infatti l’Iran ha iniziato
a sfruttare maggiormente l’asse con i movimenti sciiti libanesi e, in
particolare, con gli Hezbollah.
Si sono così
create le basi per confronti molto accesi in tutta la regione. L’attivismo
iraniano ha infatti acuito il braccio di ferro tra Teheran e i suoi storici
antagonisti. Tra questi occorre annoverare l’Arabia Saudita e
le petromonarchie del Golfo. Le guerre scoppiate nel decennio successivo, a
partire da quella nello Yemen, sono ascrivibili al confronto a distanza tra la
teocrazia sciita degli Ayatollah e le monarchie sunnite. Importante sottolineare
anche la crescita dei timori per la propria sicurezza da parte di Israele, altro
storico rivale dell’Iran in medio oriente.
08/08/1998. Il
presidente Saddam Hussein sorride durante un messaggio televisivo per gli
iracheni nel 10° anniversario della vittoria della guerra durata 8 anni contro
il vicino Iran. Nel messaggio, Saddam si diceva convinto che la nazione avrebbe
prevalso sugli Stati Uniti così come aveva fatto con l'Iran.
Il radicale
cambiamento ai vertici di Baghdad, ha avuto conseguenze anche all’interno del
mondo sunnita iracheno. In alcune frange è emersa la preoccupazione di diventare
succubi della maggioranza sciita. Circostanza che ha creato, tra le altre cose,
terreno fertile per la propaganda jihadista. Già nel 2014 risultavano attivi in
Iraq diversi gruppi terroristici. Al loro interno, non solo iracheni ma anche
combattenti stranieri. Al Qaeda, il movimento terroristico di Osama Bin Laden,
ha preso così le redini e ha approfittato della situazione per lanciare la
propria guerra santa contro le truppe statunitensi.
Ad emergere in
questo contesto è stata la figura del terrorista giordano Abu Musab Al Zarqawi.
A lui lo stesso Bin Laden ha dato il suo benestare per la nascita di Al Qaeda in
Iraq. L’insurrezione jihadista è andata avanti per diversi anni, trovando
manforte soprattutto nella provincia di Al Anbar, tra Ramadi e Falluja.
Particolarmente grave la situazione nel 2007, con il Paese di fatto ostaggio di
una guerra civile settaria tra sunniti e sciiti. Al Zarqawi è stato ucciso nel
2006, ma i suoi successori hanno implementato le attività di Al Qaeda in Iraq.
Il gruppo si
trasformerà in seguito “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante” (Isil) e con il
nuovo leader Abu Bakr Al Baghdadi sarà impegnato dal 2011 nella guerra civile
siriana, al fianco di Al Nusra ed altre sigle islamiste contrarie al governo di
Assad. L’Isil diventerà meglio nota con l’acronimo di Isis e il gruppo darà vita
allo Stato Islamico, capace di conquistare l’intero nord dell’Iraq e vaste
porzioni della Siria tra il 2014 e il 2017. Oggi lo Stato Islamico non c’è più,
ma il Paese continua a essere attraversato dalle tensioni jihadiste.
Il duello tra
Washington e Teheran in territorio iracheno
Proprio la lotta
all’Isis ha portato in Iraq la presenza di diverse forze internazionali. Da un
lato la coalizione a guida Usa, impegnata nell’est della Siria e nel nord
dell’Iraq contro il califfato. Dall’altra un’alleanza tra più gruppi
paramilitari sciiti, coadiuvati dall’Iran. Dietro l’intento comune di
sconfiggere lo Stato Islamico, è emersa anche la lotta per contendersi la
propria influenza su Baghdad.
Nel cuore del
territorio iracheno quindi, ancora oggi convivono forze di Washington con forze
vicine a Teheran. Un’incompatibilità emersa soprattutto nel 2020, quando un raid
degli Usa a Baghdad ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimaini, architetto
del progetto della mezzaluna sciita. Per tutta risposta, l’Iran ha bombardato
basi statunitensi presenti nel Kurdistan iracheno. L’Iraq si è quindi
trasformato nel terreno di scontro tra Stati Uniti e Iran. Un braccio di ferro
che ha contribuito ad alimentare le tensioni in tutta l’area mediorientale e che
ha trascinato al suo interno anche le altre potenze regionali.
La mai risolta
questione curda
La guerra del
2003 e la fine del potere di Saddam, hanno dato ai curdi la possibilità di
gestire in modo autonomo i propri territori. La nuova costituzione irachena, ha
riconosciuto il Kurdistan come regione autonoma con capoluogo Erbil. Qui ha sede
di fatto uno Stato nello Stato. I curdi iracheni hanno stretto accordi e legami
di natura commerciale in modo indipendente rispetto a Baghdad.
Ma al di là delle
vicende interne all’Iraq, l’autonomia accordata ai curdi ha riacceso la
questione anche in tutti gli altri Paesi della regione in cui i curdi
costituiscono un’importante minoranza. A partire dalla Turchia. Il
presidente Erdogan, dopo un’iniziale apertura al dialogo, ha scelto una linea
dura contro tutte le principali organizzazioni curde. Ad Ankara il timore è
legato al fatto che i curdi presenti in Turchia possano rivendicare la stessa
autonomia raggiunta in Iraq.
Anche in Siria la
questione è stata più volte al centro delle discussioni. Il governo di Damasco,
prima del 2011, ha visto con sospetto l’attivismo dei gruppi curdi. Quando nel
Paese è divampata la guerra civile, gli stessi curdi hanno approfittato dei
problemi del governo centrale per organizzarsi in modo autonomo. Le forze di
autodifesa hanno fondato la regione del Rojava. Attualmente le sigle che
riuniscono i combattenti curdi sono in parte appoggiate dagli Usa e sono
stanziate nell’est della Siria, al di là dell’Eufrate. Anche questo un elemento
che sta contribuendo ad alimentare tensioni, con Ankara che dal 2016 in poi ha
iniziato a bersagliare le forze curde in territorio siriano. MAURO INDELICATO
Iraq,
santuario del jihad e utopia dello Stato islamico.
Davide
Bartoccini
il 22 Marzo 2023 su Inside Over.
Dove un tempo
sorgeva l’antica Mesopotamia, corridoio fertile bagnato dai grandi fiumi della
Mezzaluna, fanatici islamisti, sunniti e sciiti, uniti solo dall’odio per i raid
dei cacciabombardieri americani, decisero di ricongiungersi – nonostante
la separazione millenaria – per vendicare l’ennesima invasione armata mossa
dall’Occidente sotto il nome di operazione Iraqi Freedom. Così l’Iraq, che aveva
appena assistito all’occupazione della capitale Baghdad in virtù della presenza
delle “famose” armi di distruzione di massa detenute dal governo iracheno
baathista di Saddam Hussein, accusato di avere intessuto legami con
l’organizzazione terroristica di Al Qaeda, si apprestava a diventare santuario
dei proseliti che armavano l’ennesima “Guerra Santa” contro gli Stati Uniti, e
culla di un utopico Stato islamico.
L’organizzazione
jihadista islamica sunnita irachena – affiliata alla sigla di Al Qaeda che aveva
colpito al cuore gli americani con gli attentati dell’11 settembre, scatenando
l’invasione dell’Afghanistan nel contesto della lotta al terrorismo – venne
fondata dal militante giordano Abu Musab al-Zarqawi nel 1999, iniziò a colpire
nell’agosto del 2003, durante l’occupazione della Coalizione internazionale che
aveva rovesciato Saddam, per espandersi e rilasciare un piano programmatico
suddiviso in quattro punti principali nel 2005. Il desiderio di Abu Musab
al-Zarqawi per riprendere il totale controllo dell’Iraq prevedeva la sconfitta e
l’espulsione delle forze di occupazione statunitensi dal Paese per ristabilire
la completata autorità islamica – ossia erigere un califfato in ottemperanza
della Sunna – e lanciare solo in un secondo momento un'”ondata jihadista” da
estendere “ai Paesi laici confinanti con l’Iraq”, per raggiungere e annientare
la potenza dello Stato di Israele.
09/04/2003 Un
marine americano copre il volto di una statua del presidente Saddam Hussein con
la bandiera americana mentre i militari si preparano ad abbatterla. Rendendosi
conto che il gesto avrebbe costituito una pericolosa provocazione per gran parte
del mondo arabo, alla fine la bandiera fu sostituita da quella irachena.
Mentre il governo
appoggiato dagli Stati Uniti metteva al bando il Baath, e gli emissari
occidentali scioglievano la sconfitta Guardia Repubblicana irachena per prendere
le redini di un nuovo Esercito regolare da addestrare e appoggiare nel processi
di normalizzazione – che si sarebbe dimostrato molto più lungo, sanguinoso, e
impervio del previsto – i jihadisti affiliati ad Al Qaeda e sotto la nuova
sigla Al-Tawhid-wal-jihad, attinsero nello scontento provocato e non curato
dall’operazione militare lanciata dagli americani; che non avevano
solo bombardato e occupato il Paese in base a quelli che verranno archiviati da
una parte degli storici come interessi giustificati da congetture infondate –
sebbene ricordiamo tutti l’allora segretario di stato Colin Powell che sbandiera
al cospetto del Consiglio di Sicurezza delle Nazione Unite una fialetta contente
la “prova” dell’esistenza delle armi batteriologiche di Saddam – ma
avevano escluso da ogni tipo di incarico militare o posizione di rilievo i
rappresentati del vecchio regime lasciando dilagare uno scontento che facilmente
poteva ricollegarsi all’ideologia politica ed al fanatismo religioso.
La nascita
dell’Isis
Quando nel giugno
del 2006 il leader dei qaedisti iracheni al-Zarqawi viene eliminato da un raid
statunitense, gli succede Abu Ayyub Al-Masri, il quale annuncia in breve tempo
la fondazione di una Stato islamico dell’Iraq, accogliendo Abu Bakr
Al-Baghdadi come comandante di quello che diventerà noto nel mondo come un
nuovo califfato nero. L’entità autoproclamata, per ovviare alla decimazione di
obiettivi di alto livello come leader e uomini chiave delle diverse cellule
terroristiche operata dalla Cia e dai Seal con l’appoggio dei letali “droni
killer” – che non si risparmieranno nel provocare vittime collaterali e
ulteriori proseliti del jihad -, ricostituisce la sua struttura avvalendosi
degli ex agenti dei servizi segreti e degli ex militare del partito Baath che
avevano servito Saddam, contando nelle sue fila sunniti e sciiti, e ampliandosi
alla branca siriana di Al Qaeda che si imporrà nel territorio siriano durante la
successiva guerra civile.
La priorità di Al
Baghadi – nuovo nemico numero uno della Casa Bianca che nel frattempo aveva
eliminato elimina Osama Bin Laden in Pakistan (2 maggio 2011) – è quella di
colpire obiettivi statunitensi ma anche obiettivi sciiti collusi con gli
occupanti americani. Alimentando il “conflitto settario tra sciiti e sunniti in
un progetto che sfugge alla comprensione di Al Qaeda” ma porta comune al
raggiungimento del progetto che si era prefisso Al Zarqawi: la creazione di uno
Stato islamico in Iraq che si imporrà come un califfato dove predicare la parola
del profeta e restaurare integralmente le leggi della sharia.
L’epilogo
straziante di un’utopia tradita
Sulla brace
dell’invasione statunitense, e sulle ceneri del regime di Saddam Hussein
(catturato dalle forze speciali americane il 13 dicembre 2003 e impiccato a
Baghdad il 30 dicembre 2006) si espanderà così lo Stato islamico che, al massimo
del suo cruento e deprecabile splendore, tra il 2015 e il 2016, si estenderà per
oltre 30mila chilometri in quello che la stampa internazionale inizierà a
chiamare Siraq. Con una forza ribelle di decine di migliaia di jihadisti che
terranno in scacco oltre sei milioni di abitanti, e manterranno con i proventi
del petrolio ottenuto dalla conquista di Mosul. Il califfato nero, utopia
deprecabile nella sua manifestazione reale, si rivelerà essere una declinazione
totalitaria dello Stato islamico fondato sulla politica del terrore più che la
nuova età dell’oro paventa da Al Baghadi – eliminato dai Seal mentre si
nascondeva in Siria (27 ottobre 2019) mentre il suo Califfato Nero crollava
sotto l’avanzata dei Peshmerga, roccaforte dopo roccaforte, resa dopo resa,
bomba intelligente dopo bomba intelligente, colpo dopo colpo sparato in nome
di Allah secondo alcuni, in nome del solo spirito di vendetta secondo altri.
Lasciandoci di fronte agli strascichi di un conflitto che mantiene radici
profonde in quella terra martoriata che ha visto migliaia e migliaia di morti.
In Siria, in Iraq e nel Kurdistan iracheno. DAVIDE BARTOCCINI
La storia
delle armi chimiche (mai trovate) di Saddam Hussein
Roberto
Vivaldelli il 24 Marzo 2023 su Inside Over.
L’Iraq ha avuto
un rapporto decennale con le armi chimiche, che cominciò a sviluppare sin dagli
anni’ 60, per poi farne largo uso nella guerra contro la Repubblica Islamica
dell’Iran (1980-1988). È nel giugno 1981, infatti, che Baghdad diede vita
al Progetto 922, gestito direttamente dal Ministero della Difesa di Saddam
Hussein. Si trattava di un progetto ambizioso che attingeva risorse e competenze
dal complesso di laboratori al-Rashad, capace di produrre decine di tonnellate
di gas mostarda. Secondo Nti, l’Iraq di Saddam iniziò a usare armi chimiche
contro le truppe iraniane sin dal 1982, benché l’uso di tali armi in un
conflitto bellico fosse vietato sin dal 1925, quando fu firmato il Protocollo di
Ginevra. Nel corso della guerra – e nel silenzio tombale della “comunità
internazionale”, nonostante le proteste iraniane – Baghdad continuò a impiegare
iprite, gas lacrimogeni e infine l’agente nervino tabun contro l’esercito
nemico: si stima che gli attacchi con armi chimiche da parte delle truppe di
Hussein provocarono, in otto anni di guerra brutale, complessivamente oltre un
milione di vittime iraniane entro la fine del 1988.
Durante la guerra
tra Iraq e Iran, secondo quanto riportato da Al-Jazeera, circa “7.500 militari e
civili iraniani sono stati uccisi dalle truppe irachene” usando gas nervino e
gas mostarda. Il dato emerge da un rapporto di Shahriar Khateri, un alto
funzionario dell’Opac, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
con sede a L’Aia. Tale rapporto afferma che circa un milione di iraniani sono
stati “esposti” ad agenti chimici durante la guerra. Ancora oggi, a circa
quarant’anni di distanza da quel conflitto, 75mila feriti ricevono ancora cure
per “lesioni croniche da armi chimiche”. Un rapporto del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite datato marzo 1986 descrisse come “angosciante” il numero di
“vittime per armi chimiche” e l’entità e la gravità delle loro ferite.
Dalle armi
chimiche contro l’Iran alla Guerra del Golfo (1991)
Gli Stati Uniti
erano a conoscenza del fatto che l’Iraq impiegava al tempo armi chimiche nei
confronti delle truppe iraniane. Come nota il Wilson Center, la documentazione
declassificata della CIA (Central Intelligence Agency) e della DIA (Defence
Intelligence Agency) degli Stati Uniti confermarono che l’amministrazione del
presidente Ronald Reagan sostenne l’Iraq di Saddam Hussein contro l’Iran degli
Ayatollah e chiuse non un occhio, ma due, sull’impiego di armi chimiche da parte
del dittatore iracheno. In particolare, un documento declassificato della Cia
datato 23 marzo 1984, dimostra che gli Usa erano perfettamente consapevoli
dell’uso gas nervino da parte di Baghdad contro le truppe iraniane nella città
irachena di Bassora, che nel 1987 divenne il campo di battaglia più sanguinoso
dell’intera guerra, e del piano di “impiegarlo in quantità militarmente
significative” entro il tardo autunno di quello stesso anno.
Il sostegno Usa a
Hussein durò fino alla fine della guerra, nel 1988. Tutto cambiò il 2 agosto
1990, quando il Ràis ordinò l’invasione e l’occupazione del Kuwait, provocando
la dura risposta militare degli Stati Uniti e della coalizione occidentale – la
più significativa è “Desert Storm” del gennaio 1991 – e portando gli iracheni
rapidamente alla sconfitta (Hussein rimase invece al potere). La Risoluzione
687 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 3 aprile 1991
dopo la sconfitta dell’Iraq nella Guerra del Golfo, impose a quel punto il
completo smantellamento dei programmi di armi di distruzione di massa dell’Iraq
e di tutte le sue armi chimiche prodotte nei decenni precedenti. Tale
Risoluzione delle Nazioni Unite stabilì anche che una Commissione speciale
dell’ONU (UNSCOM) avrebbe supervisionato e guidato il processo di
smantellamento. “Nel dicembre 1998 – riporta sempre il Wilson Center – gli
ispettori dell’UNSCOM avevano supervisionato la distruzione di 38.537 munizioni
chimiche piene e vuote, 690 tonnellate di agenti CW, più di 3.275 tonnellate di
precursori chimici e oltre 425 pezzi di apparecchiature di produzione chiave”.
La Seconda Guerra
del Golfo
Il 19 marzo 2003
una coalizione guidata dagli Stati Uniti invase l’Iraq e rovesciò Saddam.
Secondo gli Stati Uniti e il Regno Unito, Saddam Hussein aveva nel frattempo
rilanciato il suo programma di armi chimiche, in aperta violazione
della Convenzione sulle armi chimiche del 1997. In particolare, gli Stati Uniti
sostennero che l’Iraq non aveva distrutto 1,5 tonnellate dell’agente nervino VX,
1.000 tonnellate di gas mostarda, violando altresì la risoluzione 1441 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’accusa di Washington, tuttavia, si
rivelò infondata poiché la Commissione di monitoraggio, verifica e ispezione
delle Nazioni Unite (UNMOVIC – che aveva sostituito l’UNSCOM – stabilì che non
c’erano prove della continuazione o ripresa da parte dell’Iraq dei programmi
di armi di distruzione di massa.
Celebre a quel
punto fu lo “show” al Consiglio di Sicurezza dell’Onu dell’allora Segretario di
Stato americano Colin Powell del febbraio 2003: secondo Powell, infatti,
Hussein, era in possesso armi chimiche e biologiche ed era legato ad al-Qaeda.
“L’Iraq – affermò – ha già precedentemente violato i suoi impegni, violando 16
passate risoluzioni durante gli ultimi 12 anni. La Risoluzione 1441 non aveva a
che fare con una parte innocente, bensì con un regime che questo stesso
consiglio ha condannato ripetutamente nel corso degli anni. La risoluzione 1441
ha dato all’Iraq un’ultima opportunità, l’ultima opportunità di collaborare o
affrontare serie conseguenze. Nessun membro del Consiglio presente durante la
votazione quel giorno ebbe nessuna illusione sulla natura e gli scopi della
risoluzione o su quali sarebbero state le serie conseguenze se l’Iraq non avesse
collaborato”. Nonostante i dubbi sulle prove fornite da Powell, il 20 marzo la
coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti invase l’Iraq e diede inizio
alla Seconda Guerra del Golfo. Nel giro di pochi mesi Baghdad capitolò. Il 1º
maggio 2003 il presidente George W. Bush atterrò sulla portaerei Abraham
Lincoln, quella che aveva partecipato alle operazioni nel Paese, annunciando
così la vittoria degli Stati Uniti. Il 30 dicembre 2006, l’ex Presidente e
leader del partito Partito Baʿth, Saddam Hussein, venne giustiziato da un
tribunale speciale iracheno.
Saddam Hussein
era colpevole di innumerevoli crimini, ma non aveva ricostituito il programma
destinato alla produzione di armi chimiche o addirittura di armi di distruzione
di massa, come si evinse da un rapporto della CIA del 2004 e dalle
conclusioni della commissione d’inchiesta inglese presieduta da Sir John
Chilcot, secondo la quale Bush e Blair trascinarono l’Occidente in una guerra
contro l’Iraq sulla base di prove inesistenti, destabilizzando un Paese e
causando la morte di migliaia di civili e militari. Peraltro, nell’aprile 2003
gli stessi Stati Uniti incaricarono l’Iraq Survey Group (ISG), guidato dall’ex
ispettore delle Nazioni Unite David Kay, di localizzare scorte e attrezzature
sospette di armi di distruzione di massa. Tuttavia, Kay respinse l’ipotesi che
ci fossero state attività significative di armi di distruzione di massa irachene
dalla fine della prima guerra del Golfo. L’ex membro dell’UNSCOM Charles A.
Duelfer sostituì così David Kay come capo dell’ISG e confermò la tesi infondata
dell’amministrazione Bush e di Colin Powell.
Dopo il 2003
Benché le armi di
distruzione di massa fossero un’invenzione – e pretesto per dare avvio al
“regime change” in Iraq – va precisato, tuttavia, che il governo iracheno non
aveva smaltito come avrebbe dovuto le armi chimiche che aveva prodotto nei
decenni precedenti e, in particolare, negli anni ’80. Un’inchiesta del New York
Times di CJ Chivers ha svelato che, complessivamente, le truppe americane
trovarono circa 5.000 testate chimiche, proiettili o bombe aeronautiche, secondo
interviste con dozzine di militari, funzionari iracheni e americani, e documenti
di intelligence ottenuti ai sensi del Freedom of Information Act. Sebbene tutte
queste munizioni siano state prodotte prima del 1991, rappresentavano un
pericolo per i militari; almeno 17 soldati americani e sette agenti di polizia
iracheni furono esposti ad armi chimiche. Una successiva indagine di Chivers ed
Eric Schmitt rivelò un importante tentativo della CIA volta ad acquisire vecchie
armi chimiche che nel frattempo erano finito sul mercato nero.
Membro dell’OPCW
Benché il Paese
sia tutt’altro che stabile sotto il profilo politico, le armi chimiche sembrano
essere un lontano ricordo: l’Iraq, infatti, è dal 2009 membro attivo dell’OPCW.
In qualità di organo di attuazione della Convenzione sulle armi chimiche,
l’OPCW, con i suoi 193 Stati membri, sovrintende allo sforzo globale per
eliminare definitivamente le armi chimiche. Dall’entrata in vigore della
Convenzione nel 1997, è il trattato di disarmo di maggior successo che ha
eliminato un’intera classe di armi di distruzione di massa. Come sottolineato in
un comunicato congiunto nel 2021 dell’OPCW e del governo iracheno, nonostante le
enormi sfide affrontate, l’Iraq è riuscito ad adempiere in anticipo ai suoi
obblighi contenuti nella Convenzione sulle armi chimiche. Baghdad ha infatti
annunciato la distruzione dei resti del precedente programma chimico e nel marzo
2018 il direttore generale dell’OPCW ha rilasciato un certificato che acclara
questo importante traguardo, chiudendo definitivamente una pagina nera della
storia del Paese. ROBERTO VIVALDELLI
Menzogne,
arroganza, guerre: se la storia ignora la memoria.
Massimo Nava su Il
Corriere della Sera l’8 marzo 2023.
Anniversari e
ricorrenze rimandano al conflitto fra sovranità degli Stati e diritti dei
popoli, che ha offerto negli ultimi vent’anni i più svariati pretesti per
interventi armati
Decisamente, il mese
di febbraio è stato un mese di anniversari importanti. Non solo quello, appena
ricordato, dell’invasione russa dell’Ucraina, ma anche di quello di vent’anni
fa, in cui maturò la decisione degli Usa di invadere l’Iraq. Storia e Memoria
non si divertono con le coincidenze, ma le analisi dovrebbero tenerne conto.
La maggioranza dei
Paesi rappresentati all’Onu ha condannato l’azione della Russia, ma allora
l’Assemblea assistette a due drammatici interventi contrapposti. Il 5 febbraio,
il segretario di Stato Usa, Colin Powell, cercò di dimostrare che il dittatore
Saddam Hussein fosse in possesso di armi di distruzione di massa e che pertanto
andasse attaccato, con l’obiettivo di abbattere il regime e avviare un processo
democratico. Ma il ministro degli esteri francese, Dominique de Villepin, si
oppose con fermezza, sostenendo la necessità di perseguire la via diplomatica e
i controlli delle agenzie internazionali sugli arsenali dell’Iraq. Di fatto, si
creò una spaccatura fra Francia e Stati Uniti, la cui onda lunga sarebbe
arrivata in Europa e nel mondo arabo e africano. L’immagine dell’America fu
offuscata.
La Storia darà
ragione alla Francia. Non solo perché le accuse di Powell si dimostrarono false,
come lui stesso ammise anni dopo, ma perché la guerra in Iraq avrebbe fatto a
pezzi il diritto internazionale e innescato una drammatica instabilità in tutto
il Medio Oriente, le cui conseguenze furono il Califfato dell’Isis, gli
attentati di matrice islamica in Europa, la guerra in Siria. In Iraq,
all’invasione e ai bombardamenti seguirono anni di attentati contro la
popolazione civile e scontri fra le componenti religiose. In Afghanistan,
cominciò un’altra operazione militare, fino all’ignominiosa riconquista da parte
dei talebani.
«In Iraq — disse de
Villepin dopo il conflitto — non erano in gioco soltanto guerra e pace, ma
anche le regole su cui deve essere fondato l’ordine internazionale. L’intervento
preventivo non può essere una regola». L’allora segretario delle Nazioni Unite
Kofi Annan definì l’intervento in Iraq con un solo aggettivo: «Illegale».
Come in una
profezia, de Villepin aveva indicato il rischio di aggravare le divisioni tra
società, culture e popoli, un terreno fertile per il terrorismo e l’instabilità
internazionale. «La guerra è sempre la sanzione di un fallimento. (...) Parlo a
nome di un vecchio Paese, la Francia, di un continente come il mio, l’Europa,
che ha conosciuto guerre, occupazioni, barbarie...». Ma furono parole al
vento. Allora, come del resto oggi, la diplomazia fu messa tra parentesi,
accantonata come un segno di debolezza o peggio di benevolenza verso il nemico.
Salvo ritornare di moda in un deserto di lutti e macerie.
Colin Powell a un
giornalista dell’Abc News ammise: «Naturalmente. È una macchia. Io sono colui
che ha agito in nome degli Stati Uniti e questo sarà parte della mia storia. È
stato doloroso». Ma il 20 marzo, esattamente vent’anni fa, la guerra cominciò e
l’Iraq fu invaso dalla cosiddetta « coalizione di volenterosi», guidata da Stati
Uniti e Gran Bretagna e sostenuta — ieri come oggi — dal più solerte alleato
degli americani, la Polonia.
Non erano necessarie
sfere di cristallo, rapporti dell’intelligence o profonda conoscenza dell’Iraq
per prevedere che la guerra sarebbe stata breve e il dopoguerra infinito.
Bastava ascoltare testimoni del tempo come il vecchio Amir, che citava Lawrence
d’Arabia: «Quando si comincia una guerra da queste parti è come mangiare una
zuppa con il coltello»; o guardare vecchie fotografie, come quella del 1917 (per
chi ama le coincidenze, era sempre in marzo), che raccontavano l’invasione
britannica. I soldati che entravano a Bagdad erano agli ordini del generale
Stanley Maude che disse: «Non veniamo qui come nemici, né come conquistatori, ma
come liberatori». Seguirono rivolte e massacri.
I vecchi di Bagdad
non potevano accertare l’esistenza delle armi di distruzione di massa, il
pretesto della guerra, ma nemmeno immaginare che la tragedia del loro Paese
sarebbe cominciata con una bugia proclamata nella massima istituzione
internazionale.
La guerra divise
l’Europa, dal momento che Francia e Germania si opposero all’intervento, mentre
Gran Bretagna, Polonia e Italia sostennero la decisione americana. Anni dopo,
anche il Parlamento di Londra mise sotto accusa il premier Tony Blair,
confermando che l’intervento fu deciso sulla base di motivazioni false e non
seriamente vagliate.
La Francia, allora
paladina del diritto internazionale e dell’opposizione alla guerra, cambiò
tuttavia registro anni dopo: l’ex presidente Nicolas Sarkozy fu infatti il primo
sostenitore del bombardamento della Libia per eliminare Gheddafi. Seguirono
guerra civile, scontri tribali, ondate migratorie, instabilità endemica.
Anniversari e
ricorsi storici, oggi come ieri, rimandano al conflitto fra sovranità degli
Stati e diritti dei popoli e delle minoranze. Conflitto che ha offerto negli
ultimi vent’anni i più svariati pretesti e giustificazioni per interventi
armati. Basti ricordare la legittima difesa e la lotta al terrorismo
(Afghanistan), il dovere d’ingerenza (Bosnia, Kosovo), le armi di distruzione di
massa e l’esportazione della democrazia (Iraq), la protezione di una minoranza
(Libia). Giustificazioni più o meno etiche, come il «bombardamento umanitario»,
un ossimoro, o dettate da ambizioni e interessi strategici, che hanno
contribuito a indebolire il sistema internazionale delle regole e a mortificare
il ruolo delle Nazioni Unite, con il risultato che il vuoto di legalità è stato
progressivamente riempito da altre logiche, da obiettivi politici e militari con
pretesa di fondamento morale e ideologico e in sostanza dalla più ignobile delle
leggi, quella del più forte, come nella martoriata Ucraina, vittima della legge
di Putin.
Il grande trauma.
Gli effetti della guerra all’Iraq sulla strategia Usa.
Lorenzo Vita il 22
marzo 2023 su Inside Over.
Venti anni dopo
l’inizio dell’invasione dell’Iraq, è lecito domandarsi gli effetti di quella
guerra sulla diplomazia americana. L’attacco contro il regime di Saddam
Hussein e la successiva “guerra infinita” nata tra le sabbie dell’Iraq sono
scaturiti, almeno nell’intento, come momento cardine di una politica estera Usa
ancora incentrata sull’unilateralismo e sul desiderio di incidere sui destini
del Medio Oriente consolidando la propria posizione rispetto ai tentennamenti
degli alleati europei e con una Russia ancora traumatizzata dalla caduta
dell’Unione Sovietica. Tuttavia, quel conflitto che doveva essere la
certificazione della grande strategia di Washington in Medio Oriente e che univa
i vari focolai della “guerra al terrore” si è rivelata, dopo pochi anni, una
ferita forse mai davvero sanata sia nell’agenda mondiale americana sia nel
rapporto tra strateghi e opinione pubblica.
La “guerra
infinita” irachena, vista oggi a venti anni di distanza dal suo inizio e con le
lenti di oggi, appare più come un innesco per le crisi nate subito dopo che una
risoluzione di quello che era considerato un problema strategico per Washington,
ovvero Saddam.
I dubbi prima
dell’invasione
Diversi osservatori
e anche report di analisti e intelligence degli anni immediatamente successivi
all’invasione avevano già mostrato delle importanti perplessità
sull’impostazione del conflitto e soprattutto su quanto esso potesse incidere in
modo positivo sulla sicurezza nazionale statunitense. Interessante, a questo
proposito, il lungo rapporto realizzato dall’allora Democratic Policy Committee,
ora Democratic Policy and Communications Committee, con cui i democratici Usa
elencavano costi e conseguenze della guerra in Iraq, definita in particolare in
chiave anti-repubblicana e come la “guerra di Bush”.
Al netto del chiaro
intento di colpire l’amministrazione del presidente che aveva iniziato
la “guerra al terrore”, alcuni commenti e dichiarazioni contenute nel
dettagliato rapporti dei democratici individuano concetti-chiave che possono
essere visti anche in chiave contemporanea.
Molti sottolineavano
un impegno militare che affaticava e impoveriva il complesso militare Usa senza
un reale obiettivo strategico a lungo termine. Altri, invece, sottolineavano
come la guerra a Baghdad potesse essere più una distrazione dai veri avversari
sistemici Usa. Inoltre – come sottolineato dai National Intelligence
Estimates del 2006 – la guerra in Iraq, invece di colpire il terrorismo globale,
lo aveva alimentato fornendo ai combattenti della jihad globale un ulteriore
pretesto per lottare contro Washington, accusata di avere invaso un Paese
musulmano e di averlo occupato manu militari per i propri interessi.
L’effetto
indesiderato della guerra
Questa valutazione,
che risale a pochissimi anni dopo la decisione di attaccare il regime di Saddam,
appare ancora più rilevante se si pensa che i documenti racchiusi nei Nie sono
di fatto la produzione di quella stessa intelligence che, pochi anni prima,
aveva avallato l’ipotesi di una produzione di armi di istruzione di massa in
Iraq tale da giustificare l’attacco. Segno quindi che la comunità di
intelligence di Washington aveva già corretto il tiro delle proprie valutazioni
approfondendo, appena tre anni dopo, le conseguenze del conflitto nell’ottica di
un rischio di caos regionale e di esplosione del terrorismo islamico.
A questo
proposito, nella sintesi pubblica delle valutazioni delle agenzie Usa si legge:
“Riteniamo che il jihad iracheno stia plasmando una nuova generazione di leader
e manovalanza terroristi; il successo jihadista percepito lì ispirerebbe più
combattenti a continuare la lotta in altri luoghi”. Inoltre, continua il testo,
“il conflitto iracheno è diventato la ’cause celebre’ per i jihadisti,
alimentando un profondo risentimento per il coinvolgimento degli Stati Uniti nel
mondo musulmano e coltivando sostenitori del movimento jihadista globale“.
Il nodo
dell’incapacità di risolvere il problema della jihad globale e di averlo anzi
riattivato proprio con la guerra si è poi confermato anche negli anni
dello Stato islamico, che anzi è nato proprio nel brodo di coltura iracheno. Gli
errori dell’invasione e della gestione del conflitto si sono poi materializzati
con la nascita di veri e propri santuari del terrorismo aiutati anche
dall’inadeguatezza del sistema iracheno sopravvissuto all’invasione.
Un nuovo modo di
percepire gli Usa
Questi gravi deficit
della guerra contro Saddam hanno avuto ulteriori effetti sul piano regionale,
tra cui bisogna ricordare soprattutto il modo in cui è cambiata – in maniera
forse definitiva – la percezione degli Stati Uniti. Dopo l’attacco all’Iraq,
Washington, vista in maniera ancora positiva da buona parte dei Paesi
dell’area nonostante l’alleanza con Israele e le differenze culturali sentite
dalle opinioni pubbliche, ha subito un sensibile crollo della fiducia dei propri
partner.
I Paesi del Medio
Oriente, dell’Asia centrale e in generale tutti gli Stati a maggioranza
musulmana hanno iniziato a considerare gli Stati Uniti come un nemico, come
potenza non più interessata a gestire la regione ma a imporre la propria agenda.
Questo ha avuto un contraccolpo importante anche sui rapporti tra Usa e i
maggiori alleati dell’area, in particolare la Turchia – che come partner Nato
concesse lo spazio aereo ma non il proprio suolo per l’invasione – e l’Arabia
Saudita, che non partecipò alla coalizione dei volenterosi al pari di quasi
tutti gli Stati mediorientali. Inoltre, come poi in effetti si è confermato nel
corso degli anni, l’invasione dell’Iraq è diventato un precedente fondamentale
anche (paradossalmente) nell’agenda dell’acerrimo nemico di Baghdad, l’Iran, che
dopo la guerra preventiva contro il regime iracheno, ha rafforzato il proprio
desiderio di raggiungere le capacità di arricchimento dell’uranio.
Oltre a
questo, l’instabilità prodotta in Medio Oriente ha continuato a propagare i
propri effetti a tutti i Paesi dell’area, con la conseguenza che Washington si è
trasformata in un elemento critico e non più affidabile. Infine, l’incapacità di
certificare il motivo ufficiale dell’invasione, cioè il presunto arsenale sporco
di Baghdad, ha ulteriormente rafforzato i sentimenti antiamericani, al punto
che, come dimostrato anche dopo la guerra in Ucraina, le famigerate “fialette”
di Colin Powell sono diventate l’argomentazione più classica per criticare le
iniziative diplomatiche e militari americane nel mondo. In questo modo, quindi,
la guerra in Iraq, ma soprattutto il caos provocato successivamente, hanno
rafforzato le potenze che si sono mostrate come alternative proprio a quel
sistema perorato da Washington, e cioè Russia e Cina. Rimosso nel tempo il
grande nodo del regime di Saddam Hussein, negli occhi dell’opinione pubblica e
delle leadership mediorientali (ma non solo) è rimasto il vuoto di potere
lasciato in Iraq e l’instabilità per i venti anni successivi, con l’avvento di
Daesh e l’inserimento dell’Iran a certificare il fallimenti dei propositi Usa.
La spaccatura con
l’Europa
Se questi sono gli
effetti regionali, la percezione degli Stati Uniti va poi anche osservata
nell’ottica internazionale. Se infatti la guerra in Ucraina ha di nuovo blindato
l’Occidente sotto l’ala americana specialmente a causa dei tentennamenti
europei nei confronti della Russia, va ricordato che prima del 2022 gli Usa
venivano ancora identificati da buona parte degli establishment e delle opinioni
pubbliche del Vecchio Continente come una superpotenza confusionaria.
L’immagine più
vicina era quella del disastroso ritiro da Kabul e dell’abbandono
dell’Afghanistan in mano ai talebani. Ma prima di questa, il caos mediorientale
nato dal conflitto iracheno e certificato dalla guerra in Siria (e in parte
dello Yemen) aveva indebolito l’immagine Usa a vantaggio di altre superpotenze.
Se si mettono insieme i dubbi di molti Paesi Ue sulla guerra (a partire da
Francia e Germania) con le critiche rivolte successivamente per la gestione del
Paese e gli effetti sulla regione e sull’Europa, si comprende come gli Usa
abbiano vissuto circa 15 anni di crescente divario con l’altra sponda
dell’Atlantico. Uno iato che si è ampliato con la ritirata dall’Afghanistan e
che si è richiuso solo con il pieno sostegno di Washington alla resistenza di
Kiev.
In tutto questo, le
gravi critiche interne nei confronti della guerra in Iraq, diventata con Donald
Trump il più classico esempio di “guerra infinita”, hanno modificato
sensibilmente anche le capacità di azione Usa in campo mediorientale. Il
fallimento del conflitto iracheno, ritenuto da molti l’emblema
dell’impossibilità di “esportare democrazia” ma anche della rivincita
dell’isolazionismo, è così diventato un trauma al punto da innescare non solo un
ripensamento della strategia Usa nell’area, ma anche il pericolo di come vengano
percepite le iniziative di Casa Bianca e Pentagono nella regione. Tramontata
l’epopea della guerra al terrorismo di matrice islamica, il Medio Oriente è
tornato a essere per l’opinione pubblica Usa uno scenario lontanissimo e
sconosciuto, che in larga parte doveva quindi interessare poco anche alla classe
dirigente.
Trump ha vinto le
elezioni proprio facendo leva sulla risoluzione rapida e il più possibile
definitiva delle guerre scatenate dalle precedenti amministrazioni. E
l’investimento di miliardi di dollari nel conflitto ha provocato una forma di
grande ritrosia da parte di molti elettori sulle spese militari e sugli
interventi all’estero. Per un Paese che ha in sé non solo l’anima
dell’isolazionismo, ma anche della democrazia rappresentativa, è chiaro che
qualsiasi leader debba fare i conti anche con questo modus
pensandi dell’elettorato, specie della classe media. E ciò implica non solo un
disinteresse verso i destini dell’Iraq, quantomeno a parole, ma anche una sorta
di imbarazzo dei capi di Stato Usa nell’interfacciarsi con i partner
mediorientali rispetto alle enormi sfide che la regione offre agli strateghi
atlantici.
Dacci ancora un
minuto del tuo tempo!
Se l’articolo che
hai appena letto ti è piaciuto, domandati: se non l’avessi letto qui, avrei
potuto leggerlo altrove? Se non ci fosse InsideOver, quante guerre dimenticate
dai media rimarrebbero tali? Quante riflessioni sul mondo che ti circonda non
potresti fare? Lavoriamo tutti i giorni per fornirti reportage e approfondimenti
di qualità in maniera totalmente gratuita. Ma il tipo di giornalismo che
facciamo è tutt’altro che “a buon mercato”. Se pensi che valga la pena di
incoraggiarci e sostenerci, fallo ora. LORENZO VITA
Iraq. Le
autostrade della morte, una pagina di storia dimenticata.
Piccole Note
(putiniana) l’1 Marzo 2023 su Il Giornale.
Nell’articolo sulle
domande poste dal Washington Times a Biden riguardo alla guerra ucraina, abbiamo
accennato alle autostrade della morte, il più terribile massacro della storia
moderna.
Si consumò nel corso
della prima guerra irachena, dopo l’invasione del Kuwait da parte di Saddam
Hussein e prima dell’invasione americana dell’Iraq. Nessuno lo ricorda perché la
prima guerra irachena, del 1991, vide quasi tutto il mondo al fianco – in via
subordinata – degli Stati Uniti (un po’ come accade adesso per l’Ucraina).
Una storia di
stretta attualità, anche per quanto riguarda la manipolazione dell’informazione.
Pubblichiamo un documento sull’eccidio di massa, presentato da Joyce Chediac
alla Commissione d’inchiesta per il Tribunale internazionale per i crimini di
guerra di New York (pubblicato nel 2018 su Liberation – giornale di sinistra,
ma con azionista di maggioranza il banchiere Edouard de Rothschild).
Autostrade della
morte
Voglio rendere una
testimonianza su quelle che vengono chiamate le “autostrade della morte”. Si
tratta delle due strade kuwaitiane, disseminate dei resti di 2.000 veicoli
militari iracheni straziati, e dei corpi carbonizzati e smembrati di decine di
migliaia di soldati iracheni, che si stavano ritirando dal Kuwait il 26 e 27
febbraio 1991 in ottemperanza alle risoluzioni Onu.
Gli aerei
statunitensi hanno intrappolato i lunghi convogli distruggendo i veicoli situati
in testa e in coda ai convogli, e poi hanno martellato per ore gli ingorghi
risultanti. “Era come sparare a un pesce in un barile”, ha detto un pilota
statunitense. L’orrore è ancora lì, da vedere.
Sull’autostrada
interna per Bassora ci sono miglia e miglia di veicoli bruciati, distrutti e
fracassati di ogni tipo: carri armati, auto blindate, camion, automobili, camion
dei pompieri, come scrive la rivista Time del 18 marzo 1991. Sulle sessanta
miglia di autostrada costiera, le unità militari irachene sono distese a terra
in pose raccapriccianti, scheletri bruciacchiati di veicoli e uomini, neri e
terribili sotto il sole, racconta il Los Angeles Times dell’11 marzo 1991.
Mentre 450 persone,
arrendendosi, sono sopravvissute al bombardamento della strada interna, questo
non è avvenuto nelle 60 miglia della strada costiera. Lì, per 60 miglia, tutti i
veicoli sono stati mitragliati o bombardati, tutti i parabrezza sono andati in
frantumi, tutti i carri armati sono bruciati, tutti i camion appaiono crivellati
da proiettili. Nessun sopravvissuto è noto o probabile. Le cabine dei camion
sono state bombardate così tanto che sono state incassate nel terreno ed è
impossibile vedere se contengano autisti o meno. I parabrezza si sono sciolti e
enormi carri armati sono ridotti in rottami.
Baghdad annuncia il
ritiro
“Neanche in Vietnam
ho mai visto niente del genere. È terribile”, ha detto il maggiore Bob Nugent,
un ufficiale dell’intelligence dell’esercito. Questa carneficina unilaterale,
questo massacro razzista di persone arabe, è avvenuto nonostante il fatto che il
portavoce della Casa Bianca Marlin Fitzwater avesse promesso che gli Stati Uniti
e i partner della coalizione non avrebbero attaccato le forze irachene che si
stavano ritirando dal Kuwait. Questo è sicuramente uno dei crimini di guerra più
atroci della storia contemporanea.
Le truppe irachene
non sono state cacciate dal Kuwait dalle truppe statunitensi, come sostiene
l’amministrazione Bush. Non si stavano ritirando per riorganizzarsi e riprendere
la battaglia. Si stavano ritirando veramente, tornavano a casa, rispondevano
agli ordini di Baghdad, che aveva dichiarato di voler ottemperare alla
Risoluzione 660 [dell’Onu] abbandonando il Kuwait.
Alle 17:35 (orario
standard del luogo) la radio di Baghdad aveva annunciato che il ministro degli
Esteri iracheno aveva accettato la proposta sovietica sul cessate il fuoco e
aveva dato l’ordine a tutte le truppe irachene di ritirarsi nelle posizioni
assunte prima del 2 agosto 1990, in conformità con la risoluzione 660 delle
Nazioni Unite.
Il presidente Bush
aveva reagito immediatamente dalla Casa Bianca dicendo (attraverso il portavoce
Marlin Fitzwater) che “non c’erano prove che suggerissero che l’esercito
iracheno si stia ritirando. Infatti, le unità irachene continuano a combattere…
continuano a far guerra”.
Il giorno
successivo, il 26 febbraio 1991, Saddam Hussein aveva annunciato alla radio di
Baghdad che le truppe irachene avevano effettivamente iniziato a ritirarsi dal
Kuwait e che il ritiro sarebbe stato completato quel giorno. Ancora una volta,
Bush aveva reagito definendo l’annuncio di Hussein “un oltraggio” e “una
crudele bufala“.
La risoluzione 660
delle Nazioni Unite
Testimoni oculari
kuwaitiani attestano che il ritiro è iniziato nel pomeriggio del 26 febbraio
1991 e la radio di Baghdad aveva annunciato alle 2:00 (ora locale) di quella
mattina che il governo aveva ordinato a tutte le truppe di ritirarsi.
Il massacro dei
soldati iracheni in ritirata viola le Convenzioni di Ginevra del 1949 […] che
proibisce l’uccisione di soldati al di fuori dei combattimenti. Il punto
controverso riguarda l’affermazione dell’amministrazione Bush secondo la quale
le truppe irachene si stavano ritirando per riorganizzarsi e combattere di
nuovo.
Tale affermazione è
l’unico modo per cui il massacro potrebbe essere considerato legale ai sensi del
diritto internazionale. Ma l’affermazione è falsa. Le truppe si stavano
ritirando, ponendo fine all’invasione per ordine diretto di Baghdad, che aveva
annunciato che la guerra era finita, che l’Iraq si era ritirato e si sarebbe
pienamente conformato alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Attaccare i soldati
che tornano a casa in queste circostanze è un crimine di guerra.
L’Iraq accettò la
risoluzione 660 delle Nazioni Unite e si offrì di ritirarsi dal Kuwait
attraverso la mediazione sovietica il 21 febbraio 1991. Una dichiarazione di
George Bush del 27 febbraio 1991, secondo cui non sarebbe stata concessa tregua
alcuna ai soldati iracheni rimasti, viola persino il Manuale militare degli
Stati Uniti del 1956 La Convenzione dell’Aia del 1907, che disciplina la guerra
di terra, spiega che è illegale anche dichiarare che non sarà concesso quartiere
ai soldati in ritirata.
Il 26 febbraio 1991,
il seguente dispaccio è stato archiviato dal ponte di comando della USS Ranger,
a firma di Randall Richard, giornalista del Providence Journal: “Gli attacchi
aerei contro le truppe irachene in ritirata dal Kuwait sono stati lanciati oggi
con tale intensità da questa portaerei che i piloti hanno detto di aver preso
con sé tutte le bombe che si trovavano sul ponte di volo. Gli equipaggi, che
lavoravano sulle note della colonna sonora di Lone Ranger, spesso rinunciavano
al proiettile preferito. . . perché ci voleva troppo tempo per caricarlo”.
La giornalista del
New York Times Maureen Dowd ha scritto: “Mentre il leader iracheno era posto
davanti alla sconfitta militare, Bush decise che preferiva scommettere su una
guerra di terra violenta e potenzialmente impopolare piuttosto che rischiare
l’alternativa: una soluzione imperfetta elaborata dai sovietici e dagli
iracheni, che l’opinione pubblica mondiale avrebbe potuto accettare come
tollerabile.
In breve, piuttosto
che accettare l’offerta dell’Iraq di arrendersi e abbandonare il teatro di
guerra [cioè il Kuwait ndr], Bush e gli strateghi militari statunitensi decisero
semplicemente di uccidere quanti più iracheni possibile finché c’era questa
opportunità.
Soldati e civili
Un articolo di
Newsweek su Norman Schwarzkopf [comandante in capo delle truppe alleate ndr],
intitolato “A Soldier of Conscience” (11 marzo 1991), osservava che prima della
guerra di terra il generale era preoccupato solo di quanto tempo il mondo
sarebbe rimasto a guardare gli Stati Uniti scatenare l’inferno in Iraq prima di
dire: ‘Aspetta un attimo, ora basta’. Lui [Schwarzkopf] non vedeva l’ora di
inviare truppe di terra per finire il lavoro. Il motivo per il massiccio
sterminio dei soldati iracheni era dato dalla volontà degli Stati Uniti di
distruggere l’equipaggiamento iracheno. Ma in realtà il piano era di impedire
del tutto la ritirata ai soldati iracheni. Powell ha osservato che, anche prima
dell’inizio della guerra, i soldati iracheni sapevano di essere stati mandati a
morire in Kuwait.
Rick Atkinson del
Washington Post ha affermato che “il cappio è stato stretto” attorno alle forze
irachene in modo così efficace che “la fuga è impossibile” (27 febbraio 1991).
Tutto questo non ha nulla a che vedere con una guerra, è un massacro.
Ci sono anche
indicazioni che alcune delle vittime del bombardamento avvenuto durante il
ritiro fossero palestinesi e civili iracheni. Secondo la rivista Time del 18
marzo 1991, non furono colpiti solo veicoli militari, ma anche automobili,
autobus e camion. In molti casi, le auto erano cariche di famiglie palestinesi e
di tutti i loro averi.
I resoconti della
stampa statunitense hanno cercato di far apparire il rinvenimento di beni
domestici bruciati e bombardati come se le truppe irachene avessero saccheggiato
il Kuwait. Gli attacchi ai civili sono specificatamente vietati dagli Accordi di
Ginevra e dalle Convenzioni del 1977.
Cosa è successo
davvero? Il 26 febbraio 1991 l’Iraq aveva annunciato di aderire alla proposta
sovietica e che le sue truppe si sarebbero ritirate dal Kuwait. Secondo
testimoni oculari kuwaitiani, citati dal Washington Post dell’11 marzo 1991, il
ritiro iniziò sulle due autostrade e verso sera era in pieno svolgimento. Verso
mezzanotte è iniziato il primo bombardamento statunitense.
Centinaia di
iracheni sono saltati giù dalle loro auto e dai loro camion, in cerca di riparo.
I piloti statunitensi hanno preso qualsiasi bomba si trovasse vicino al ponte di
volo, dalle bombe a grappolo alle bombe da 500 libbre. Riesci a immaginarle
sganciate su un’automobile o un camion? Le forze statunitensi hanno continuato a
sganciare bombe sui convogli fino a quando tutti quegli esseri umani non furono
uccisi. Così tanti jet sciamarono sull’autostrada interna che si creò un ingorgo
in cielo, tanto che i controllori di volo dei jet da combattimento temevano
collisioni a mezz’aria.
Crimini di guerra
Le vittime non hanno
opposto resistenza. Non venivano attaccati in una feroce battaglia né cercavano
di riorganizzarsi per dar vita a una controffensiva. Erano solo papere, secondo
il comandante Frank Swiggert, il capo del Ranger Bomb Squadron. Secondo un
articolo del Washington Post dell’11 marzo 1991, intitolato “Gli Stati Uniti si
affrettano a modellare la vista dell’autostrada della morte”, il governo degli
Stati Uniti si è coordinato e ha fatto tutto il possibile per nascondere questo
crimine di guerra alla gente di questo paese e al mondo.
Ciò che ha deciso il
governo degli Stati Uniti è diventato poi il focus della campagna di pubbliche
relazioni gestita dal Comando centrale degli Stati Uniti a Riyad, secondo lo
stesso articolo del Washington Post. La spiegazione ufficiale è stata che i
convogli erano impegnati in una “classica battaglia tra carri armati”, come a
suggerire che le truppe irachene cercassero di reagire o addirittura avessero la
possibilità di reagire.
Il Washington Post
afferma che gli alti ufficiali del comando centrale degli Stati Uniti a Riyad
erano preoccupati per ciò che vedevano, cioè che ci fosse una crescente
percezione pubblica sul fatto che le forze irachene stessero lasciando il Kuwait
volontariamente e che i piloti statunitensi li stessero bombardando senza pietà,
il che era la verità. Quindi il governo degli Stati Uniti, dice il Post, ha
minimizzato le prove che le truppe irachene stavano effettivamente lasciando il
Kuwait.
I comandanti
dell’esercito statunitense hanno fornito ai media un quadro accuratamente
dettagliato e preciso degli eventi in rapida evoluzione. L’idea era di far
vedere il ritiro dell’Iraq come una ritirata strategica resa necessaria dalla
forte pressione militare alleata. Ricordate quando Bush è venuto al Rose Garden
e ha detto che non avrebbe accettato il ritiro di Saddam Hussein? Anche questo
ne faceva parte, e Bush era coinvolto in questo insabbiamento.
Alla dichiarazione
di Bush seguì subito un briefing via Tv dell’esercito che, dall’Arabia Saudita,
spiegava che le forze irachene non si stavano ritirando, ma venivano sospinte
fuori dal campo di battaglia. In realtà, decine di migliaia di soldati iracheni
giunti in Kuwait avevano cominciato a ritirarsi più di trentasei ore prima che
le forze alleate raggiungessero la capitale, Kuwait City. Non si erano mossi per
un’asserita pressione da parte dei carri armati e della fanteria degli alleati,
Tale deliberata
campagna di disinformazione su questa azione militare e il crimine di guerra che
si è effettivamente consumato, questa manipolazione dei comunicati stampa per
ingannare l’opinione pubblica e tenere nascosto il massacro al mondo costituisce
anche una violazione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti,
il diritto dei cittadini a essere informati.
Estratto da “La
cortina di vetro”, di Micol Flammini (ed. Mondadori – Strade Blu), pubblicato
da linkiesta.it il 15 marzo 2023.
Da qualsiasi parte
si guardi la storia dell’Europa, la Polonia e sempre presente, ed e stata
costantemente un centro di sofferenza e di indomabile resistenza. […] Per capire
la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina, e il caso di guardare con
attenzione a quello che e accaduto in Polonia nel 1939: e un copione con altri
personaggi, ma che si ripete, e se l’attacco congiunto di Hitler e Stalin contro
Varsavia ricorda quello, iniziato il 24 febbraio 2022, di Mosca contro Kiev e
perché le cose in comune non sono poche.
La campagna di
Hitler contro la Polonia era iniziata rivendicando la protezione dei cittadini
tedeschi rimasti, dopo la Prima guerra mondiale, sotto le autorità polacche,
soprattutto di quanti vivevano a Danzica, citta libera ma sotto la giurisdizione
del ministero degli Esteri di Varsavia.
L’invasione del
paese fu preceduta da una delle prime operazioni false flag della storia,
un’espressione (falsa bandiera) che indica atti di sabotaggio e macchinazioni
per far ricadere su altri la responsabilità del casus belli, divenuta molto nota
proprio con la guerra della Russia all’Ucraina, quando si pensava che Mosca
stesse cercando di creare un pretesto per invadere Kiev.
I nazisti
studiarono a lungo l’operazione false flag da mettere in atto per attaccare la
Polonia. Alcuni tedeschi vestiti con uniformi polacche assaltarono la stazione
radio di Gleiwitz allora in Germania, oggi Gliwice in Polonia, uccisero alcune
guardie di frontiera e dai microfoni dell’impianto diffusero un messaggio alle
minoranze polacche, incitandole a prendere le armi contro i tedeschi. Il giorno
dopo, 1° settembre, il più potente e moderno esercito dell’Europa dell’epoca
entro in Polonia, con il proposito di portare a termine una guerra lampo.
In due giorni
distrusse l’aviazione polacca, e l’esercito di Varsavia che si era ammassato
alla frontiera reagì con il suo fiore all’occhiello: la cavalleria. Questo
episodio di grande eroismo, pur venato di mitologia, aiuta a capire quanto i
polacchi fossero determinati a rischiare il tutto per tutto pur di salvaguardare
l’indipendenza appena conquistata. Se poi si siano lanciati con la cavalleria
contro i mezzi corazzati nazisti perché effettivamente fossero convinti di avere
qualche chance o perché, pur di non perdere la liberta, erano pronti a farsi
massacrare, questo non si saprà mai. Fatto sta che questo episodio rimane tra i
più memorabili della guerra.
La Polonia inoltre
era aggredita da tutti i lati: mentre i tedeschi divoravano l’ovest del paese,
annettendo e occupando, i sovietici avevano iniziato la loro avanzata da est
adducendo come pretesto la protezione delle minoranze ucraine e bielorusse
maltrattate dal governo polacco allo sbando.
Quando Putin ha
attaccato l’Ucraina, ha usato una motivazione simile: salvare le minoranze
russe, vittime delle violenze del governo di Kiev. I polacchi di allora, pero,
erano stati abbandonati dai propri alleati, che non avevano ascoltato le
richieste di aiuto di Varsavia e avevano sottovalutato la pericolosità e la
determinazione del regime nazista. Un errore che non e stato commesso nei
confronti degli ucraini. […]
La Polonia e sempre
stata certa di essere la frontiera dell’Europa, dell’atlantismo e anche della
cristianità, e il fatto che la storia entri anche nelle campagne elettorali, sia
materia di dibattito e l’attuale partito al governo, il PiS, la manipoli contro
gli avversari indica quanto per i polacchi sia importante.
L’ingresso prima
nella NATO e poi nell’Unione europea ha rappresentato per Varsavia la
rassicurazione che non sarebbe più stata sola di fronte alla minaccia russa e di
essere entrata a far parte del mondo al di la della cortina di ferro, che per i
paesi dell’Est europeo non e mai caduta, si e soltanto spostata.
Estratto
dell’articolo di Domenico Quirico per “la Stampa” il 20 marzo 2023.
Le guerre sono quasi
sempre mancanza di un perché […] sono soltanto confusione e paura. Venti anni fa
[…] iniziò la invasione dell'Iraq da parte degli americani e degli inglesi. Il
perché era […] una gigantesca deliberata, pianificata, bugia. A ingannarci non
fu Saddam, il dittatore, solo l'ultima delle canaglie psicopatiche del
Novecento. […] Ci ingannò una democrazia, anzi la Democrazia, e ci incamminammo
verso la peggiore delle catastrofi, la catastrofe morale.
Con l'America
eravamo fiduciosi, inermi […] Una avvelenata propaganda ci corruppe. Siamo
entrati da allora in una epoca […] di dissoluzione. Quella guerra ha distrutto
molto, uomini sentimenti valori, non siamo stati in grado di ricostruire
granché. E dopo venti anni siamo di nuovo in guerra. Incapaci di distinguere
ormai verità e bugie.
Erano passati solo
pochi minuti dalla scadenza dell'ultimatum: il presidente Bush aveva dato poche
ore di tempo a Saddam Hussein per lasciare l'Iraq. In perfetto orario gli aerei
americani iniziarono a colpire Baghdad per mostrare a Saddam, subito, che non
era più invulnerabile. […] Poche ore dopo missili iracheni colpirono a caso il
territorio del Kuwait. I soldati americani indossarono frettolosamente le
maschera antigas e i completi per la guerra chimica. Già. L'angoscia per le
micidiali armi chimiche del Rais...
Precauzione inutile.
Nessuno dei comandanti aveva spiegato loro che l'esistenza di quelle armi faceva
parte della Grande Bugia. Sugli schermi delle televisioni irachene apparve il
dittatore: arrogante, violento come al solito. Per promettere «la vittoria» e
«la gloria», inveendo contro «gli invasori diabolici» e «i sionisti. […]».
Venti anni dopo che
serve rievocare quella guerra: le avanzate rapide verso Bassora, Baghdad,
Tikrit, le colonne dei soldati di Saddam in fuga calcinate dalle bombe al
fosforo, la statua del dittatore trascinata al suolo con la faccia verso il
cielo […] Ciò che si deve rievocare, scrupolosamente, bugia dopo bugia, senza
dimenticar nulla è come ci ingannarono. Bush e i suoi sgangherati apostoli del
Nuovo Ordine Globale. Che cosa era? Un violento, immorale, ipocrita imperialismo
del caos, fatto di invasioni illegali, prepotenze diplomatiche, saccheggi
economici, menzogne umanitarie.
Ripensiamo al tempo
che precedette quel 30 marzo: le torri che crollano, i tre aerei trasformati in
missili Cruise dal genio terrorista e suicida di Bin Laden, il patriottismo
americano che vibra […] sul New York Times , la bibbia quotidiana dei
‘'liberal'', i bugiardi servizi di Judith Miller sulle armi di distruzione di
massa irachene «pronte all'impiego nel giro di 45 minuti!» diamine! È provato...
lo giura anche Blair […]
Ah! Se avessimo
ascoltato l'undici settembre, le torri ancora fumavano di morte, Rumsfeld al
Pentagono già annunciava che bisognava attaccare non solo l'Afghanistan ma anche
l'Iraq […] E sì, si diedero proprio da fare di brutto. Cheney, il
vicepresidente, a garantire che in Niger c'erano le prove dell'acquisto
dell'uranio da parte di Saddam per costruire l'atomica. Confermava, guarda
guarda, Rasmussen premier danese […] Paziente passò all'incasso nel 2009:
segretario generale della Nato. […]
Fu la macchinazione
perfetta, sfrontata, selvaggia di come anche in una democrazia si può inventare
una guerra ancor più efficacemente che nelle tirannidi. Al segretario di Stato
Colin Powell spettò la recita finale, in una seduta del Consiglio di sicurezza.
Annunciò che avrebbe comunicato ciò che gli Usa sapevano sulle armi di
distruzioni di massa e sulla partecipazione dell'Iraq ad attività terroristiche.
Poi brandì davanti alle telecamere una provetta piena di polverina bianca.
Presiedeva la seduta
il ministro degli Esteri tedesco Joscha Fischer. Lui sapeva che quella prova era
una menzogna spudorata. Perché la fonte americana aveva solo un nome: il dottor
ingegner Rafid al Janabi, un iracheno che per ottenere rifugio in Germania aveva
fatto sensazionali rivelazioni ai servizi tedeschi: che in Iraq c'erano truppe
già pronte a impiegare le armi chimiche nascoste alle ispezioni dell'Onu. I
servizi avevano facilmente accertato che era un bugiardo, per di più un bugiardo
mediocre. […] Attese il 2005 il segretario di Stato per dire che quella recita
lo «addolorava ancora».
[…] A Washington
intanto annunciavano che in un anno il Paese sarebbe stato ricostruito. Mentire
alla fine ti lega come una corda sempre più stretta. Non ti puoi fermare. Saddam
è stato impiccato, i mediocri e pericolosi ideologi della semplicità manichea
dell'impero americano sono degli ex in pensione o sono morti. Ma da quella bugia
è balzato fuori il disordine in cui viviamo, il califfato totalitario in Iraq e
la guerra in Ucraina. Dopo il 2003 non è più possibile dare un limite
cronologico alle guerre […]
20 marzo 2003:
quando l’Occidente legittimò l’invasione dell’Iraq con una fake news.
Enrica
Perucchietti su L'Indipendente il 20 Marzo 2023.
Mancavano poche ore
a mezzanotte del 20 marzo 2003, quando le televisioni statunitensi interruppero
improvvisamente le trasmissioni per mandare in onda il discorso del
presidente George W. Bush che annunciava l’avvio delle operazioni contro
l’Iraq di Saddam Hussein.
L’operazione, sulla
scia degli attentati dell’11 settembre 2001 e di Amerithrax, aveva trovato
l’avallo della Gran Bretagna di Tony Blair, della Spagna di José Maria Aznar e
dell’Italia di Silvio Berlusconi, oltre che di una ventina di altri leader e
Paesi.
Le immagini vivide
delle esplosioni e degli incendi, nella notte di Baghdad, colonizzarono gli
schermi delle televisioni di tutto il mondo. La guerra era iniziata. Quegli
stessi schermi, poco più di un mese prima, avevano rilanciato la fake news che
valse come pretesto per spingere la Casa Bianca a invadere l’Iraq e ottenere
la legittimazione morale del conflitto.
Era il 5 febbraio
2003 quando, presso il Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite, l’allora
Segretario di Stato, Colin Powell, aveva tenuto un discorso in cui aveva parlato
delle armi batteriologiche in possesso dell’Iraq, mostrando ai rappresentanti
degli altri Paesi, con un gesto teatrale, una fiala che conteneva una polvere
bianca. Agitando la fiala, Powell aveva accusato l’Iraq di essere in grado di
produrre circa 25 mila litri di antrace, secondo quanto dicevano gli ispettori
delle Nazioni Unite. Nel suo discorso Powell aveva fatto anche riferimento al
«Grosso faldone dei servizi segreti sulle armi biologiche dell’Iraq» e di
laboratori mobili per la produzione di quelle armi, di testimonianze che
accreditavano quanto riportato, mentre alle sue spalle il direttore della
CIA George Tenet seguiva le sue parole con espressione seria e coinvolta.
Il ricordo
delle lettere all’antrace, diffuse all’indomani dell’11 settembre era ancora
vivo nell’opinione pubblica americana e l’immagine di quella fiala ancorò
l’idea, poi dimostratasi falsa, di una minaccia che proveniva da Saddam Hussein.
Il clima di terrore
e di esasperazione in seguito agli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono
portarono a elaborare la tesi ufficiale che le missive velenose rientrassero
nella “seconda parte” dell’attacco dell’11 settembre. La responsabilità
dell’invio della posta avvelenata fu inizialmente attribuita proprio ad al
Qaeda. Il governo Bush strumentalizzò tale minaccia per convincere il mondo
della necessità di attaccare l’Iraq, in quanto Saddam Hussein avrebbe avuto i
magazzini pieni di antrace.
[Articolo del
Corriere della Sera del 08 settembre 2002 rivelatosi poi una fake news]Si
scoprì, successivamente, che le spore usate negli attacchi appartenevano a un
ceppo particolarmente potente, denominato “Ames”, usato in almeno una dozzina
di laboratori di ricerca degli Stati Uniti per testare i vaccini e le nuove cure
per la malattia. Al Qaeda non c’entrava nulla con quegli attentati. Amerithrax permise,
però, di intraprendere la guerra infinita contro il “terrore islamico”, portando
all’approvazione del Patriot Act e all’ennesima, insensata spirale di sangue e
violenza: la guerra contro l’Iraq. Il ruolo di Powell fu fondamentale: senza la
sua messinscena la “più grande democrazia” non avrebbe ottenuto il consenso per
invadere l’Iraq.
Il 6 ottobre 2004,
davanti alla Commissione del Congresso usa, il capo degli ispettori
americani, Charles Duelfer, presentò un rapporto di quasi mille pagine a opera
dei servizi segreti americani in cui si smontava l’esistenza di armi di
distruzione di massa detenute segretamente da Saddam, decretando
come ingiustificata e illegittima la guerra in Iraq.
Secondo Duelfer,
Saddam aveva mantenuto l’intenzione di ottenere armi di distruzione di massa, ma
dopo la prima guerra del Golfo del 1991 la capacità dell’Iraq si era
drasticamente ridotta. Le conclusioni di Duelfer sono state confermate da tutte
le inchieste successive e dai numerosi dossier elaborati dal Veteran
Intelligence Professionals for Sanity (vips), gruppo di analisti ed ex ufficiali
dell’intelligence che aveva messo in dubbio la narrazione governativa.
A conferma di ciò,
l’inchiesta condotta dalla Commissione inglese presieduta da Sir John Chilcot che
ha esaminato 150 mila documenti e ascoltato più di cento testimoni per cercare
di stabilire la verità su una delle pagine più controverse della storia
britannica. Secondo il rapporto elaborato dalla Commissione, l’intervento
militare in Iraq sarebbe stato «una decisione precipitosa» e i piani su cui
l’attacco si fondava erano completamente inadeguati. Il casus belli legato al
presunto possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime di Baghdad
venne fatta con “una certezza ingiustificata”.
Secondo Chilcot,
l’intervento armato non era affatto l’unica risorsa a cui ricorrere e si
sarebbero dovuti adottare altri rimedi alternativi e pacifici per raggiungere
il disarmo, come per esempio una strategia di contenimento e proseguire con le
ispezioni o il monitoraggio. [di Enrica Perucchietti]



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: