 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
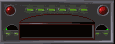
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
ANNO 2021
L’ACCOGLIENZA
SECONDA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE

L’ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale, pluritematico e
pluriterritoriale, riferito al 2021, consequenziale a quello del 2020. Gli
argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed
approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e degradanti di
queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma
dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si
ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
AUSPICI, RICORDI ED ANNIVERSARI.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
L’ACCOGLIENZA
INDICE PRIMA
PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
I Muri.
Schengen e Frontex.
L’Abbattimento ed il Controllo dei Muri.
Gli stranieri ci
rubano il lavoro?
Quei razzisti
come…
Il Sud
«condannato» dai suoi stessi scrittori.
Quei
razzisti come gli italiani.
Quei razzisti come
gli spagnoli.
Quei razzisti come i
francesi.
Quei razzisti come
i belgi.
Quei razzisti come
gli svizzeri.
Quei razzisti come
i tedeschi.
Quei razzisti come
gli austriaci.
Quei
razzisti come i polacchi.
Quei razzisti come
i lussemburghesi.
Quei razzisti come
gli olandesi.
Quei razzisti come
gli svedesi.
Quei razzisti come
i danesi.
Quei razzisti come
i norvegesi.
Quei razzisti come
i serbi.
Quei
razzisti come gli ungheresi.
Quei razzisti come
i rumeni.
Quei razzisti come
i bulgari.
Quei razzisti come
gli inglesi.
INDICE SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Quei razzisti come
i greci.
Quei razzisti come
i maltesi.
Quei razzisti come
i turchi.
Quei razzisti come
i marocchini.
Quei razzisti come
gli egiziani.
Quei
razzisti come i somali.
Quei razzisti come
gli etiopi.
Quei razzisti come
i liberiani.
Quei razzisti come
i nigeriani.
Quei
razzisti come i Burkinabè.
Quei
razzisti come i ruandesi.
Quei
razzisti come i congolesi.
Quei
razzisti come i sudsudanesi.
Quei razzisti come
i giordani.
Quei razzisti come
gli israeliani.
Quei
razzisti come i siriani.
Quei razzisti come
i libanesi.
Quei razzisti come
gli iraniani.
Quei razzisti come gli emiratini.
Quei razzisti come
i dubaiani.
Quei razzisti come
gli arabi sauditi.
Quei razzisti come
gli yemeniti.
Quei razzisti come
i bielorussi.
Quei
razzisti come gli azeri.
Quei razzisti come
i russi.
INDICE TERZA
PARTE
Quei razzisti come
gli Afghani.
La Storia.
L’11 settembre 2001.
Il Complotto.
Le Vittime.
Il Ricordo.
La Cronaca di un’Infamia.
Il Ritiro della Vergogna.
La presa del Potere dei Talebani.
Media e regime.
Il fardello della vergogna.
Un esercito venduto.
Il costo della democrazia
esportata.
INDICE QUARTA
PARTE
Quei razzisti come
gli Afghani.
Fuga da Kabul. Il Rimpatrio degli stranieri.
L’Economia afgana.
Il Governo Talebano.
Chi sono i talebani.
Chi comanda tra i Talebani.
La Legge
Talebana.
La Religione Talebana.
La ricchezza talebana.
Gli amici dei Talebani.
Gli Anti Talebani.
La censura politicamente corretta.
I bambini Afgani.
Gli Lgbtq afghani.
Le donne afgane.
I Terroristi afgani.
I Profughi afgani.
INDICE
QUINTA
PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Quei razzisti come
i giapponesi.
Quei razzisti come
i sud coreani.
Quei razzisti come
i nord coreani.
Quei razzisti come
i cinesi.
Quei razzisti come
i birmani.
Quei razzisti come
gli indiani.
Quei razzisti come
gli indonesiani.
Quei
razzisti come gli australiani.
Quei razzisti come
i messicani.
Quei
razzisti come i brasiliani.
Quei razzisti come
gli haitiani.
Quei razzisti come i cileni.
Quei razzisti come
i venezuelani.
Quei razzisti come
i cubani.
Quei razzisti come
i canadesi.
Quei razzisti come
gli statunitensi.
Kennedy: Le Morti
Democratiche.
La Guerra
Fredda.
La Variante
Russo-Cinese-Statunitense.
INDICE
SESTA PARTE
SOLITI PROFUGHI E FOIBE. (Ho scritto un saggio
dedicato)
L’Olocausto
dimenticato.
La lunga amicizia tra Hitler
e Stalin.
Gli olocausti
comunisti.
E allora le foibe?
Il Genocidio degli
armeni.
Il Genocidio degli
Uiguri.
La Shoah dei Rom.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI. (Ho
scritto un saggio dedicato)
Chi comanda sul
mare.
L’Esercito
d’Invasione.
La Genesi di
un'invasione.
Quelli che …lo Ius
Soli.
Gli Affari dei
Buonisti.
Quelli che…Porti
Aperti.
Quelli che…Porti
Chiusi.
Due “Porti”, due
Misure.
Cosa
succede in Libia.
Cosa succede in
Tunisia?
L’ACCOGLIENZA
SECONDA
PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
·
Quei
razzisti come i greci.
Le prigioni dei migranti nel cuore di
Lesbo, diventata il limbo d’Europa. “Mai più”, giurò
la Ue dopo il rogo della collina lager di Moira. E invece un anno dopo non è
cambiato niente: profughi in attesa, rimpatri illegali. E carcere. Francesca
Mannocchi La Repubblica l'8 dicembre 2021. Sul muro che circonda la collina di
Moria campeggiano ancora due scritte: Welcome to Europe e Human rights graveyard
(Benvenuti in Europa, Cimitero dei diritti umani). È la sintesi, spietata, di
cosa è stato per migliaia di persone vivere nell’hotspot di Moria, Lesbo, fino
all’otto settembre dello scorso anno quando un incendio ha distrutto tutto. Oggi
il terreno intorno alla struttura è deserto, non ci sono più tende, né le
baracche costruite con pezzi di alberi e plastica, sono vuoti i container, la
guardiola, la torretta che sovrasta il cancello, così come l’area che era stata
adibita a prigione per tutti i richiedenti asilo la cui richiesta era stata
respinta e perciò destinati al rimpatrio.
Gianluca Perino per "il
Messaggero" il 20 settembre 2021. «I greci ci hanno picchiato, tolto i
telefonini e l'acqua. Poi hanno staccato il motore dal gommone, lo hanno buttato
via e ci hanno spinto al largo, alla deriva». Mentre parla, Samir mima i calci e
i pugni ricevuti. È seduto, assieme ad un'altra ventina di migranti, sulla parte
posteriore di una vedetta della Guardia Costiera turca. Hanno pagato 400 dollari
a testa a dei mercanti di uomini per arrivare da Smirne fino alle coste greche.
Un viaggio non impossibile e decisivo, perché poi si prosegue via terra verso il
nord Europa, verso il sogno della Germania, della Svezia o addirittura
dell'Inghilterra. Sono siriani, somali, eritrei, con loro anche un ragazzo che
viene da Gibuti. Ma il progetto di questi disperati, la scorsa notte, si è
infranto contro il muro greco. «Ci riproveremo», dicono. E in realtà qualcuno
confessa di essere già al secondo o al terzo tentativo. Li hanno soccorsi i
militari di Ankara a quaranta chilometri al largo di Cesme, una cittadina nel
sud ovest del paese che si affaccia sul mar Egeo. Qui ci sono tanti hotel di
lusso, spiagge attrezzate con tutti i comfort. E, malgrado sia già settembre
inoltrato, è pieno di turisti. Che non percepiscono nemmeno lontanamente quello
che succede, ogni giorno, nel mare di questo splendido angolo di Turchia.
LA NOTTE Lontano, al largo,
quasi sempre di notte, va in scena infatti quella che è diventata una vera e
propria battaglia del mare. Il copione, drammatico, sempre lo stesso: i migranti
provano ad arrivare in Grecia, ma la Guardia costiera di Atene li respinge,
utilizzando i metodi che Samir, e tanti altri come lui, raccontano sempre più
frequentemente. E il rischio che prima o poi ci scappi una strage è alto,
soprattutto nei mesi in cui le condizioni meteo peggiorano sensibilmente. Lo
sanno bene gli uomini della Guardia Costiera turca, che ogni giorno intervengono
per salvare i profughi che Atene rispedisce nelle loro acque. Ankara ha messo in
campo uomini e mezzi in un numero sempre crescente. Le vedette, tra quelle molto
veloci e quelle più capienti, sono più di una ventina soltanto per quanto
riguarda l'aera di Smirne.
L'IRRITAZIONE DI ANKARA C'è
forte irritazione, da parte turca, per come la Grecia sta gestendo il dramma dei
migranti al largo delle coste. Grecia che, da parte sua, ha sempre smentito di
utilizzare metodi così estremi, anche se le testimonianze degli immigrati e
degli ufficiali turchi che intervengono in mare raccontano tutta un'altra
storia. Non solo. I respingimenti in atto da qualche tempo a questa parte
dell'Egeo sono stati documentati anche dalla Commissione per i diritti umani del
Consiglio d'Europa e dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Si tratta di
una pratica illegale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui
rifugiati e del diritto internazionale, ma per il momento, di fatto, nessuno è
ancora intervenuto a mettere un po' di ordine in questa vicenda drammatica dal
punto di vista umanitario ma anche complessa dal punto di vista più politico.
IL CASO DI LESBO Le storie che
arrivano da questa striscia di mare, nemmeno troppo lontana dall'Italia, sono
spesso drammatiche. E raramente a lieto fine. Il comandante dei gruppi di
intervento della Guardia Costiera, che preferisce restare anonimo per motivi di
sicurezza, racconta che una volta sono dovuti intervenire per salvare un gruppo
di migranti che era sbarcato sulle coste dell'isola greca di Lesbo. «Erano
riusciti ad entrare in un bosco - dice - ma qui sono stati catturati dalla
polizia greca, che dopo averli picchiati ed averli privati di telefonini e
giubbotti salvagente, li ha rimessi su dei gommoni e rispediti al largo nelle
nostre acque». Con loro c'era anche una donna incinta di otto mesi. «Purtroppo
due persone non ce l'hanno fatta - racconta ancora il comandante - perché, come
tanti altri che si imbarcano dall'Africa, non sapevano nuotare. Per fortuna,
però, siamo riusciti a portare velocemente in ospedale la ragazza: non era in
buone condizioni, ma i medici l'hanno fatta partorire in anticipo e, alla fine,
lei e il bambino sono stati bene».
I NUMERI Lo sforzo messo in
campo dalla Guardia Costiera turca nell'ultimo periodo è importante. Soltanto
nel 2021, i dati sono riferiti fino al 15 settembre, hanno portato in salvo
8.423 migranti che erano alla deriva. Non solo. Nella loro attività di search
and rescue sono riusciti anche ad arrestare oltre quaranta mercanti di uomini.
Ma l'impressione è che questa battaglia sarà ancora lunga. «Io e i miei uomini -
spiega il comandante - siamo allerta 24 ore su 24. È un impegno duro da portare
avanti ma siamo orgogliosi, perché riusciamo a salvare ogni giorno decine di
vite».
(ANSA il 21 agosto 2021) - La Grecia ha eretto una
barriera dotata di un sistema di sorveglianza lungo un tratto di 40 chilometri
del suo confine con la Turchia per fermare un'eventuale ondata di migranti
dall'Afghanistan. Lo riporta la Bbc. "Non possiamo aspettare passivamente il
possibile impatto", ha detto ieri il ministro della Protezione dei cittadini,
Michalis Chrisochoidis, durante una visita nella regione di Evros: "I nostri
confini rimarranno inviolabili". Le dichiarazioni di Chrisochoidis seguono i
commenti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale un forte
aumento della popolazione che lascia l'Afghanistan potrebbe rappresentare "una
seria sfida per tutti". Secondo Erdogan "una nuova ondata di migrazione è
inevitabile se le misure necessarie non vengono prese in Afghanistan e in Iran".
Da parte sua, Chrisochoidis ha osservato che la crisi afgana ha creato nuove
"possibilità per i flussi di migranti" in Europa.
Un muro d’acciaio e cannoni sonori: così
la Grecia blinda la frontiera per tenere fuori i migranti.
Una nuova barriera è in costruzione per respingere i flussi dalla
Turchia. Dove l’anno scorso Erdogan fece ammassare migliaia di profughi per
premere su Bruxelles. Elena Kaniadakis su L'Espresso il 22 luglio 2021. «Lì
comincia l’Asia»: Giorgos Chalpakis indica una macchia grigia nella boscaglia
verde di fronte a lui. Oltre gli alberi, nella cappa di calore estivo che pesa
sulla Tracia, si intravedono gli edifici bianchi dei villaggi turchi. «Alle mie
spalle invece ci sono solo campi, campi a perdita d’occhio fino alla Bulgaria:
ma con una bandiera greca ben piantata in terra» puntualizza il signor Giorgos.
Osservata più da vicino, la macchia grigia non è altro che una barriera in
acciaio, alta cinque metri, piantata su fondamenta in calcestruzzo lungo il
corso del fiume Evros, Maritsa per i bulgari, Meriç per i turchi, che segna il
confine tra Grecia e Turchia, prima di tuffarsi nell’Egeo. Un nuovo muro, lungo
27 chilometri, è in costruzione nella regione per bloccare i flussi migratori e
difendere i confini dopo gli episodi del marzo dell’anno scorso, quando Erdogan
fece ammassare alla frontiera migliaia di profughi per fare pressione
sull’Europa. In questo confine militarizzato, dove la polizia, l’esercito e gli
agenti di Frontex pattugliano i campi e la boscaglia, le mucche al pascolo e le
anatre che popolano il fiume sono le uniche a muoversi liberamente all’ombra del
muro. L’anno scorso, ufficialmente, 46 migranti hanno perso la vita nel
tentativo di attraversare la regione: la maggior parte è annegata nell’Evros.
Lungo la strada sterrata che conduce all’abitato di Poros, dove è in costruzione
un nuovo segmento della barriera, i veicoli di Frontex danno il cambio ai
trattori degli abitanti. Nel paese accanto, Feres, un cartello sbiadito ricorda
in altro modo che quel lembo di terra è ancora Europa: la chiesa bizantina,
unico edificio a rompere la monotonia delle case a un piano con i tetti di
tegole, è stata restaurata – si legge – grazie ai fondi dell’Unione europea.
Chi, come Chalpakis, da Feres non se ne è andato, lavora nei campi di mais,
cocomeri e meloni. L’inquietudine che ha afferrato la comunità nel marzo
dell’anno scorso non c’è più, ma la diffidenza rimane. «I visitatori che fanno
domande sono spie delle Ong», avverte un residente all’entrata del paese. Le
ronde armate per catturare i migranti sembrano a loro volta acqua passata: «Oggi
c’è più polizia e ci sentiamo protetti, ma se occorre i proprietari controllano
che nessuno entri nei loro campi», commenta allusivo un altro residente. Il muro
è una barriera fisica, ma anche digitale: la pandemia ha offerto l’occasione per
testare nuove tecnologie di sorveglianza, come telecamere a lungo raggio e
cannoni sonori, dispositivi acustici capaci di riprodurre suoni insopportabili
per l’orecchio umano, il cui utilizzo è stato oggetto di dibattito in ambito
europeo. «Ritengo sia uno strano modo di proteggere i confini», ha commentato la
commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson. «Ma la Grecia non rischia,
per questo, la procedura di infrazione». Per Chrysovalantis Gialamas, presidente
dell’Unione della polizia di frontiera dell’Evros, si tratta di polemiche
inutili: «Siamo abituati a manifestare la nostra presenza ai trafficanti
attraverso segnali luminosi o sonori», spiega il poliziotto. Sull’efficacia del
muro, non ha dubbi: «Se a Kastanies non ci fosse stata la barriera, a quest’ora
avremmo dovuto affrontare problemi ben più gravi». Il paese di Kastanies, valico
ufficiale tra Grecia e Turchia, è stato l’epicentro degli scontri dell’anno
scorso tra esercito e migranti accalcati lungo la frontiera. Dalla zona, nelle
giornate più limpide, si distinguono chiaramente i minareti di Edirne, simbolo
di questo territorio conteso nei secoli: un tempo capitale dell’Impero ottomano,
la città venne ceduta ai bulgari nel primo Novecento, poi ai greci, con il nome
di Adrianopoli, e infine alla Turchia. Da qui parte la maggior parte dei
migranti diretti in Europa, con l’obiettivo di raggiungere presto Salonicco, la
prima grande città lungo il cammino: più si rimane vicino alla frontiera,
infatti, più il rischio di essere espulsi aumenta. Secondo Amnesty International
almeno mille persone, l’anno scorso, sarebbero state respinte illegalmente dalla
regione dell’Evros in Turchia. «Documentiamo i respingimenti in Grecia dal
2013», spiega Jennifer Foster, ricercatrice di Amnesty. «Ma oggi appare più
chiaro il coordinamento con cui le autorità e persone in abiti civili, non
identificate, respingono in maniera sistematica i migranti, alcuni dei quali
hanno perfino i documenti che attestano il loro status di rifugiati». A mezz’ora
di macchina a sud di Kastanies, lungo il confine con la Turchia, si incontra il
paese di Didymoteicho. Accanto al sito di una moschea ottomana in rovina, tra le
più antiche presenti in Europa, si trova la stazione degli autobus. È qui che
nel 2016 Fady, un rifugiato siriano residente in Germania, era giunto alla
ricerca del fratello di 11 anni, scomparso nell’Evros dopo avere attraversato il
confine con l’obiettivo di raggiungerlo. Fady stava mostrando ai passanti la
foto del fratello nella speranza che qualcuno lo riconoscesse, quando degli
agenti di polizia lo hanno avvicinato nel piazzale: da quel momento, nel giro di
poche ore, Fady è stato arrestato, detenuto, privato dei documenti di identità,
a nulla sono servite le sue proteste in un tedesco stentato, e respinto a forza
in Turchia assieme ad altri migranti. È l’inizio di un incubo durato tre anni,
durante i quali Fady ha lottato contro la burocrazia del consolato tedesco a
Istanbul per riottenere i suoi documenti, ha iniziato ad avere problemi di cuore
e per 13 volte ha tentato di raggiungere clandestinamente l’Europa, finché, nel
2019, è riuscito a riprendere possesso dei documenti e a stabilirsi di nuovo in
Germania. «Credevo che quel giorno non sarebbe mai arrivato», racconta Fady. «Ma
anche quando ho avuto la carta di identità tra le mani, riuscivo a pensare a una
sola cosa: trovare mio fratello». Il caso di Fady è il secondo, relativo ai
respingimenti illegali, sottoposto al Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite, e il primo contro la Grecia. A occuparsene sono le Ong Glan e
HumanRights360: «Fady è stato sia vittima di respingimento in base al diritto
internazionale che espulso illegalmente in quanto residente dell’Unione europea»
spiega Valentina Azarova, una degli avvocati di Glan che assiste Fady. «Il
nostro obiettivo è ottenere un risarcimento per gli anni che gli sono stati
sottratti, e allo stesso tempo far sì che il respingimento venga considerato
l’esito di una prassi consolidata nella regione». Il ministro greco per
l’Immigrazione, Notis Mitarachi, ha sempre sostenuto che la politica migratoria
del Paese sia «severa ma giusta» e che la guardia costiera e la polizia operino
nel rispetto delle leggi internazionali. «Le storie di respingimenti illegali
sono menzogne diffuse dai trafficanti di esseri umani», sostiene Gialamas.
«Molti dei poliziotti che lavorano nell’Evros discendono da famiglie greche
espulse dalla Bulgaria o dalla Turchia: sappiamo bene cosa voglia dire sentirsi
immigrati». Fady ricorda che gli agenti che lo hanno spinto a forza su una barca
per riportarlo in Turchia avevano il volto coperto e intimavano di non
guardarli. «I responsabili di queste violenze agiscono nell’impunità, ma
l’Europa deve sapere cosa fanno», sostiene. Il suo caso non è unico: le Ong che
monitorano la regione hanno documentato altre storie simili. «Sconsigliamo
sempre di tornare nell’Evros perché è molto rischioso», spiega Natalie Gruber
della Ong Josoor. «Ci siamo occupati di cinque rifugiati con la residenza in
Austria o in Germania che sono stati respinti illegalmente in Turchia e abbiamo
lavorato anni per permettergli di tornare in Europa. Chi viene in aiuto dei
propri familiari, inoltre, corre il rischio di essere accusato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». Per le famiglie dei migranti
dispersi, la regione dell’Evros è un buco nero nella mappa dell’Europa: «Non
esistono indagini sulle sparizioni», spiega Azarova. «E i corpi trovati nel
fiume dai pescatori spesso non vengono identificati perché le famiglie hanno
scarso accesso a questo tipo di informazioni. Il Mediterraneo è stato definito
un cimitero umano: l’Evros lo è altrettanto». Per gli abitanti di Feres, l’unico
modo per avvicinarsi al fiume è ottenere un permesso per andare a caccia o
lavorare nei campi. «Il nostro è solo un territorio di passaggio. Non è qui che
si possono trovare le risposte a quello che sta accadendo», riflette Chalpakis
studiando il confine. «Il muro fermerà queste persone? No, nessuno di noi si
illude a tal punto». Da quando è stato respinto in Turchia, Fady non è più
tornato nell’Evros. Il fratello, che oggi avrebbe 16 anni, risulta ancora
disperso. Ogni tanto il dolore al cuore, per cui è in cura farmacologica,
ritorna: «Quando il dottore in Germania mi ha visitato per la prima volta era
sorpreso che un paziente della mia età avesse un problema del genere: “Cosa ti è
successo?” Mi ha chiesto. Non importa con quanto impegno cerchi le parole per
raccontare quello che ti hanno fatto», riflette Fady: «Certe parole,
semplicemente, non esistono».
·
Quei
razzisti come i maltesi.
Monica Ricci Sargentini per il "Corriere della
Sera" il 30 luglio 2021. «Lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità
dell'assassinio» di Daphne Caruana Galizia, la giornalista investigativa maltese
uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017 che invece di
essere protetta è stata esposta ai suoi nemici da un governo corrotto i cui
«tentacoli» sono arrivati fino ai vertici della polizia. È un giudizio
pesantissimo quello contenuto nel rapporto finale dell'inchiesta pubblica
condotta - dopo le pressioni del Consiglio d'Europa - da una commissione
composta dagli ex presidenti del Tribunale Michael Mallia, Joseph Said Pullicino
e Justice Abigail Lofaro. Nel corso degli ultimi due anni, l'indagine chiesta
dalla famiglia della giornalista ha portato alla testimonianza di decine di
persone, compresi investigatori, politici e giornalisti. Hanno testimoniato
anche l'ex premier Joseph Muscat (dimessosi sull'onda delle proteste), l'ex capo
di gabinetto Keith Schembri e l'ex ministro dell'Energia e poi del Turismo
Konrad Mizzi (l'unico che ha rifiutato di rispondere in Aula). L'obiettivo era
stabilire se lo Stato maltese avesse fatto tutto il possibile per proteggere la
giornalista e poi perseguire i responsabili dell'omicidio. La risposta è stata
un sonoro «no». Lo Stato, hanno scritto i giudici nel rapporto di 437 pagine,
«ha creato un'atmosfera di impunità, generata dai più alti livelli
dell'amministrazione all'interno dell'Auberge de Castille (la sede del governo
maltese alla Valletta)». Caruana Galizia, uccisa a 53 anni, con i suoi articoli
aveva denunciato la corruzione nel Paese e all'estero, mettendo in difficoltà
sia i politici al governo che quelli all'opposizione.
·
Quei
razzisti come i turchi.
La "sete" di Erdogan asciuga la
Mesopotamia. Chiara Clausi il 10 Novembre 2021 su Il
Giornale. Per costruire 22 dighe e 19 impianti Ankara devia Tigri ed Eufrate.
Con effetti catastrofici. Mentre a Baghdad le milizie sciite filo-Iran sfidano
il premier Mustafa al-Kadhimi, e si rischia una nuova guerra civile, la minaccia
più grande per la Mesopotamia arriva dal Nord. Il faraonico progetto della
Turchia, il Great Anatolia Project, per regolare il flusso dell'Eufrate e del
Tigri ha infatti effetti devastanti sul Paese. Ankara ha in programma 22 dighe e
19 centrali elettriche e ha cominciato a riempire i primi invasi. Storicamente,
l'Anatolia sudorientale si trovava sulla rotta commerciale tra Oriente e
Occidente. É stata una via di passaggio cruciale per molti secoli. Tuttavia i
cambiamenti nelle rotte commerciali e nei metodi agricoli hanno posto fine alla
sua antica importanza. Ora questa area è ritornata centrale. Ma con nuove
tensioni dettate dal cambiamento climatico. Quest'anno si è registrata la
peggiore siccità da un secolo nel Nord della Siria e in tutto l'Irak. Come
racconta la storia di Kamel. Quattro anni fa, il torrente che attraversava il
villaggio iracheno di al-Hamra si è prosciugato. Ora, «tutti gli alberi sono
morti», ha spiegato l'agricoltore che coltiva agrumi nel villaggio. I contadini
hanno provato anche a scavare pozzi ma hanno trovato le falde acquifere troppo
salate e non adatte all'agricoltura. «Hanno ucciso gli alberi e tutti i nostri
raccolti», ha denunciato. Le terre intorno ad al-Hamra, che un tempo erano campi
e frutteti, sono diventate un deserto nel giro di pochi anni, e il letto del
torrente è ridotto a un fossato arido. Un rapporto del governo iracheno ha
avvertito che sette milioni di persone rischiano di rimanere senza acqua
potabile. L'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, la
riduzione delle piogge, il livello ridotto dei fiumi sono una combinazione
micidiale che produce già i primi effetti. Quest'anno è stata colpita in
particolare la provincia di Salahaddin, a Nord-Est di Baghdad. Il cambiamento
climatico è uno dei fattori che ha portato alla desertificazione e alla siccità
in Irak, ma pure i livelli ridotti dell'acqua nei fiumi Tigri ed Eufrate stanno
esacerbando questo fenomeno. Tutto ciò avviene mentre i leader mondiali si sono
riuniti a Glasgow per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (COP26). E la cooperazione internazionale è diventata indispensabile.
Questa crisi idrica potrebbe accrescere anche il rischio di conflitti per
l'acqua nella regione. Ma oltre alla riduzione dei livelli dell'acqua, molti
iracheni devono lottare anche con l'inquinamento dell'acqua e con alti livelli
di salinità. Secondo Human Rights Watch, più di 118 mila persone sono state
ricoverate in ospedale nel 2018 con sintomi legati alla contaminazione
dell'acqua nel governatorato di Bassora. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite
per la migrazione nel 2019 più di 21mila persone sono state sfollate a causa
della mancanza di accesso all'acqua pulita. E per il rapporto il rischio di
sfollamento a causa della carenza d'acqua rimane alto. Inoltre decenni di guerre
in Iraq hanno devastato gran parte delle infrastrutture idriche del paese. Anche
durante il conflitto con l'Isis. Infatti la raccolta dell'acqua durante
l'assedio dello Stato Islamico era a volte un'attività fatale. Tante persone
sono morte cercando di prendere l'acqua dal fiume e dai pozzi, durante i
bombardamenti dei jihadisti e degli aerei della coalizione. Ma Kamel nutre
ancora una forte speranza per l'Irak. E il suo urlo di disperazione gli fa dire:
«Non vogliamo altri servizi, chiediamo solo acqua, tutta la mia vita dipende
dall'acqua». Chiara Clausi
Gian Micalessin per “il
Giornale” il 24 ottobre 2021. L'espulsione degli ambasciatori di dieci Paesi
occidentali (Stati Uniti, Francia, Germania, Canada, Finlandia, Danimarca, Paesi
Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia) messi alla porta dal presidente turco
Recep Tayyp Erdogan per aver chiesto la liberazione di Osman Kavala, un
dissidente e filantropo colpevole di battersi per i diritti umani e per le
minoranze curde e armene, è vergognosa. Benché i giudici lo abbiano assolto
dall'accusa di aver finanziato l'opposizione e il governo non sia riuscito a
provare la sua presunta partecipazione al colpo di stato del 2016, Kavala è in
galera da oltre quattro anni. Il tutto mentre la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo ne pretende la scarcerazione dal 2019 e il Consiglio d'Europa prepara
una procedura d'infrazione contro Ankara. In tutto questo, però, siamo noi
italiani a doverci vergognare di più. Tra i nomi dei diplomatici battutisi per
la liberazione di Kavala manca, infatti, quello del nostro ambasciatore ad
Ankara. La nostra diplomazia, a differenza di un Mario Draghi che non esitò a
definire Erdogan un dittatore, non ha mai preso posizione sullo stato dei
diritti umani in un paese che negli ultimi anni non ha perso occasione di
compromettere i nostri interessi nazionali. La Turchia, anche se la Farnesina,
il Ministro Luigi Di Maio e il nostro ambasciatore ad Ankara sembrano averlo
scordato, è lo stesso paese che nel novembre 2019 stipulò un accordo marittimo
con il governo di Tripoli finalizzato, tra i vari obbiettivi, a tagliar fuori
l'Italia da qualsiasi ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo. Un accordo
seguito, settimane dopo, da quello che trasformò parte del porto di Misurata,
città dove abbiamo un ospedale militare, in una base della Turchia. Per non
parlare dei tentativi di mettere le mani sulla Guardia Costiera di Tripoli da
noi finanziata e, più in generale, di subentrare all'Italia come potenza di
riferimento in Libia. Il tutto mentre i nostri confini orientali restano, dal
2015, una delle mete di quei migranti usati da Erdogan come arma di ricatto nei
confronti dell'Europa. Certo, dietro le distrazioni della nostra ambasciata ad
Ankara e della Farnesina c'è il tentativo di difendere gli oltre 9 miliardi di
esportazioni (dati 2020) che - assieme a un interscambio da oltre 17 miliardi e
all'attività di oltre 1500 nostre aziende - fanno dell'Italia il sesto partner
commerciale della Turchia. Ma se alleati e partner europei del peso di Stati
Uniti, Francia, Germania e Olanda hanno deciso di mettere a rischio le relazioni
diplomatiche con un regime come quello turco, allora qualcuno dall'Ambasciata di
Ankara fino alla Farnesina farebbe bene a chiedersi se quei 9 miliardi di
esportazioni valgano la vergogna di cui ci copriamo ignorando la desolazione di
una Turchia trasformata nel cimitero dei diritti umani. La cacciata di quei
dieci ambasciatori ci trasforma nell'ultimo puntello d'un regime sempre più
isolato internazionalmente e sempre più a corto d'ossigeno su un fronte interno
dove inflazione galoppante e svalutazione erodono i consensi di Erdogan. E in un
paese sull'orlo della bancarotta politica ed economica, il ruolo di partner
privilegiato rischia di rivelarsi una maledizione anziché un vantaggio.
Turchia, Erdogan rinuncia a espellere i
10 ambasciatori occidentali: "Ma siano più cauti". La
Repubblica il 25 ottobre 2021. Il presidente turco non darà seguito alla
minaccia di espulsione dei diplomatici definiti "persona non grata" a causa
della loro richiesta di liberazione del filantropo Osman Kavala. Mentre la
valuta ha toccato il minimo storico di 9,85 per un dollaro, dopo la
dichiarazione. "Non è nostra intenzione creare una crisi diplomatica. Chi ci
critica d'ora in poi sarà più attento”, ha detto il presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, in riferimento ai 10 ambasciatori a rischio espulsione per aver
firmato un appello per la liberazione del filantropo Osman Kavala, in carcere
dal 2017 con l'accusa di aver finanziato le proteste di Gezi Park nel 2013 e di
aver partecipato al fallito golpe del 2016.
Le tensioni
diplomatiche. Retromarcia di Erdogan: crolla la lira turca e non espelle più i
10 ambasciatori dell’appello Kavala.
Redazione su Il Riformista il 25 Ottobre 2021. Niente espulsione
per i 10 ambasciatori in Turchia: Recep Tayyip Erdogan fa marcia indietro dopo
che sabato scorso aveva definito “persona non grata” i diplomatici e minacciato
l’allontanamento dal Paese. “È arrivata un’altra dichiarazione da parte dei
diplomatici che cita il loro impegno rispetto all’articolo 41 della Convenzione
di Vienna e credo che ora saranno più cauti”, ha detto il Presidente turco. I
dieci ambasciatori – i Paesi interessati erano Canada, Francia, Finlandia,
Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Usa – avevano
firmato l’appello per la liberazione del dissidente Osman Kavala, imprenditore e
filantropo, detenuto da oltre 1.400 giorni. Kavala è a capo della sezione turca
dell’organizzazione filantropica di George Soros e fu arrestato nel 2017 con
l’accusa di aver finanziato le proteste del 2013 del Gezi Park. L’imprenditore
fu assolto nel 2020 da un tribunale di Istanbul che ne ordinò la scarcerazione.
Kavala fu ri-arrestato per il fallito colpo di astato del 2016. “Impareranno a
conoscere e capire la Turchia o dovranno andarsene“. Questo sabato scorso.
L’agenzia Bloomberg ha scritto oggi che funzionari diplomatici e consiglieri del
governo turco hanno consigliato al presidente Recep Tayyip Erdogan di non dare
seguito alla minaccia di espellere i 10 ambasciatori occidentali. La lira turca
nel frattempo è crollata, si è svalutata di oltre il 2% in un giorno arrivando a
sfondare la barriera di 1 dollaro per 9,80 lire turche e di 1 euro per 11,40
lire. Il record negativo si è registrato mentre è atteso, secondo fonti citate
dall’agenzia Reuters, un taglio al 16% degli interessi sui prestiti da parte
delle banche statali turche in linea con la scelta della Banca centrale di
abbassare di 200 punti base i suoi tassi di riferimento. L’ennesimo tonfo della
valuta nazionale turca arriva a pochi giorni dal declassamento della Turchia da
parte della Financial Action Task Force, organizzazione intergovernativa che si
occupa di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento al
terrorismo. “Non volevamo provocare una crisi ma la magistratura turca non
prende ordini da nessuno” e la loro “mancanza di rispetto doveva ricevere una
risposta”, ha affermato Erdogan, scagliandosi ancora duramente contro gli
ambasciatori e parlando di “dichiarazioni infondate e irrispettose”. Lo scontro
è rientrato dopo che i diplomatici hanno diffuso un comunicato identico nel
quale ribadiscono l’impegno a non interferire negli affari interni di un Paese
che ospita le loro sedi. L’appello sollecitava alla scarcerazione di Kavala,
come già stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2019. Il
filantropo ha già annunciato che non si presenterà alla prossima udienza del
processo del prossimo 26 novembre. Il Consiglio d’Europa potrebbe avviare un
provvedimento disciplinare nei confronti della Turchia se Ankara non adempirà
alla sentenza di Strasburgo. La crisi dei diplomatici, nonostante la marcia
indietro, è probabilmente destinata a lasciare strascichi. Questo fine settimana
a Roma per il G20 Erdogan incontrerà anche le massime autorità di alcuni Paesi i
cui diplomatici aveva definito come “persona non grata”. Tra questi anche il
Presidente statunitense Joe Biden. Con gli USA scotta anche la questione del
sistema missilistico russo S-400 comprato da Ankara, seconda potenza della NATO,
dalla Russia. La Turchia di Erdogan nel suo ruolo di battitore libero in
politica estera è protagonista sul piano internazionale anche nella guerra
civile in Siria e nel conflitto in Libia. Con Washington resta aperto il caso
di Fethullah Gulen, che Erdogan considera il leader del tentato golpe del 2016,
al momento residente in Pennsylvania.
Futura D'Aprile per editorialedomani.it il 26
ottobre 2021. La Turchia ha dichiarato persona non grata dieci ambasciatori
occidentali che avevano firmato un appello per la liberazione del filantropo
Osman Kavala, detenuto da quattro anni senza una sentenza di condanna. Kavala è
accusato di aver preso parte al tentato golpe del 2016, di aver partecipato alle
manifestazioni antigovernative del 2013 di Gezi Park e di essere vicino al
magnate George Soros, figura particolarmente invisa al presidente Recep Tayyip
Erdogan. Nel 2020 la Corte europea dei diritti dell’Uomo era intervenuta sulla
vicenda chiedendo la scarcerazione di Kavala, ma ad oggi gli appelli per la sua
liberazione sono sempre caduti nel vuoto. A dover lasciare il paese anatolico
dopo l’annuncio del ministero degli Esteri sono i rappresentanti diplomatici di
Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Nuova Zelanda,
Norvegia, Svezia e Stati Uniti. Nell’elenco degli espulsi manca però l’Italia.
Un’assenza che fa riflettere sullo stato delle relazioni tra Roma e Ankara e
sulle priorità del nostro paese in politica estera. L’Italia continua a chiudere
gli occhi sulle continue violazioni dei diritti umani in Turchia e sul crescente
numero di oppositori rinchiusi in carcere senza una sentenza di condanna, come
nel caso di Kavala. Fin dal fallito golpe del 2016, Erdogan ha usato i poteri
conferitigli dallo stato di emergenza per incarcerare o licenziare attivisti per
diritti umani, insegnanti, accademici, scrittori, avvocati, giudici, funzionari
pubblici, sindacalisti, ex militari e parlamentari curdi. Il tutto con
l’obiettivo ultimo di mettere a tacere ogni forma di opposizione e di dissuadere
la popolazione civile dal ribellarsi al suo presidente. Eppure neanche la
politica neo-ottomana messa in campo da Erdogan nel Mediterraneo è riuscita a
far cambiare posizione all’Italia, che vede i suoi stessi interessi
costantemente lesi dall’espansione turca in quello che continua ad essere
descritto come il mare nostrum. Nel 2019, solo per fare un esempio, la Turchia
ha stipulato un accordo con il governo di Tripoli per la definizione dei confini
marittimi e per la gestione delle risorse minerarie presenti al largo delle
coste libiche, a discapito degli interessi energetici e geopolitici italiani. Ma
Ankara ha anche cercato di mettere le mani sulla controversa Guardia costiera
libica, addestrata ed equipaggiata da un’Italia ben poco attenta all’uso che
veniva fatto delle sue motovedette. La Turchia è stata abile nello sfruttare a
suo vantaggio l’ambiguità di Roma nei confronti del dossier libico, arginando
l’influenza italiana nel paese africano e giocando sulla debolezza dell’allora
premier Fayez al-Serraj per mettere definitivamente piede in Libia. Ankara
inoltre continua a sfruttare la presenza di 5 milioni di profughi sul suo
territorio per ricattare l’Italia e l’Unione europea, dicendosi costantemente
pronta ad aprire i propri confini e a scatenare una nuova crisi umanitaria. A
partire da questa posizione di forza, Ankara ha anche potuto minacciare gli
interessi greci ed europei nel Mediterraneo senza incorrere in alcuna sanzione,
grazie anche alla posizione conciliante assunta dall’Italia in sede comunitaria.
Per Roma, quindi, la tutela dei rapporti economici con la Turchia continua ad
essere la vera priorità. D’altronde secondo i dati Istat l'interscambio
commerciale con il paese anatolico nel 2020 ha fruttato 15 milioni all’Italia,
nonostante i danni causati dalla pandemia. Il nostro paese è il quinto partner
commerciale della Turchia a livello mondiale e il secondo tra gli Stati Ue dopo
la Germania. Nel mercato turco inoltre sono attive oltre 1.500 imprese italiane
e gli investimenti diretti nel 2018 hanno raggiunto i 523 milioni di euro. Non
vanno poi dimenticati gli interessi del settore militare e della difesa: nel
2020 le autorizzazioni per le esportazioni di materiale di armamento hanno
raggiunto un valore di 34.6 milioni, dopo i 63.7 del 2019 e i 362.3 del 2018.
Alla luce di questi dati è facile farsi un’idea di quanto profondi siano i
legami economici tra Italia e Turchia, ma tutto ciò è abbastanza perché il
governo italiano continui ad avere un atteggiamento così tanto accondiscendente
nei confronti di Ankara? La Turchia non ha riguardi verso gli interessi
geopolitici di Roma o dell’Unione europea, né tantomeno per quei diritti umani
che la stessa Italia si è impegnata a promuovere anche al di fuori dei propri
confini. Eppure neanche il governo guidato da Mario Draghi sembra intenzionato a
modificare la posizione dell’Italia nei confronti della Turchia. Ad aprile il
premier ha definito il presidente Erdogan un “dittatore”, ma non ha mai messo in
discussione i rapporti con la Turchia, specificando che con il leader turco
bisogna continuare “a cooperare per gli interessi del paese”. Anche se questi
non vengono in realtà rispettati.
Migranti, gas e petrolio: come la Turchia
di Erdogan ricatta l’Europa. Francesco Battistini e
Milena Gabanelli su Il Corriere della Sera il 10 ottobre 2021. Si dice spesso
che i migranti possono diventare una straordinaria risorsa economica e politica.
Vero. Se c’è un posto dove il concetto viene applicato alla lettera, questo è la
Turchia di Recep Tayyip Erdogan, ma in tutt’altro senso. Per lui le grandi crisi
umanitarie dall’Afghanistan alla Siria, fino alla Libia, sono diventate
l’occasione per incassare soldi, e lo strumento di ritorsione con il quale
giocare una complessa partita strategica ed energetica. La sua linea è chiara:
dall’uso dei migranti all’influenza politico-militare, ogni mezzo è buono per
diventare l’anello forte tra il mondo islamico e l’Europa.
L’ascesa di Erdogan
Come s’è arrivati a un Erdogan così determinante?
Bisogna risalire al primo decennio del Duemila. Quando le tre guerre che via via
scoppiano in Afghanistan (2001), in Iraq (2003) e in Siria (2011) fanno della
Turchia il passaggio obbligato di milioni di rifugiati. Erdogan, l’ex sindaco
d’Istanbul e leader del nuovo partito islamista che si batte per l’ingresso
della Turchia nell’Ue, viene eletto premier. Fino alle Primavere arabe del 2011,
garantisce un contenimento della cosiddetta Rotta Balcanica, la via dei
disperati che attraversa Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia e raggiunge il
cuore continentale in Ungheria e in Croazia. Per lungo tempo, sulle isole
greche, non si superano mai i 10 mila sbarchi l’anno. E gli immigrati entrano in
Europa soprattutto dall’Africa, attraversando il Mediterraneo centrale. Le
cose però cambiano in poco tempo per tre ragioni. La prima: la scoperta di gas
davanti alle coste mediorientali. La seconda: dopo un lungo dibattito si
chiudono definitivamente le porte all’ingresso della Turchia nell’Ue, a causa
dell’ostilità della Germania che teme un’enorme onda di «asylanten» turchi. La
terza: la guerra in Siria ha mosso quattro milioni di rifugiati verso la
Turchia, con mezzo milione di bambini nati solo negli ultimi cinque anni.
Isolato dagli europei, assediato dai profughi ed escluso dalla partita
energetica, Erdogan cambia obbiettivi e strategie. Vediamo quali.
Chiamiamolo «pizzo»
La Turchia oggi è uno dei Paesi al mondo col più
alto numero di rifugiati, oltre 5 milioni, su una popolazione di 80. Stanco di
fare da portinaio al passaggio via terra di siriani e iracheni, pakistani e
afghani, dal 2016 decide di monetizzare l’emergenza – 6 miliardi e 700 milioni
di euro incassati dall’Ue, più un altro mezzo miliardo in arrivo, purché i
gommoni non sbarchino sulle isole greche – e di farne uno strumento di ricatto
per acquisire peso internazionale. All’assemblea generale dell’Onu, il 24
settembre 2021, mentre Kabul precipitava nel caos, il leader turco ha
dichiarato: «Se gli americani mandano da noi i profughi afghani, ci diano il
sostegno logistico, diplomatico e finanziario che ci serve. E coi talebani
tratteremo noi». Il governo di Ankara, senza fornire dettagli, ha stimato in 40
miliardi di dollari gli aiuti necessari a gestire i dieci anni di crisi siriana.
E ora che le emergenze si sono moltiplicate, la sua politica è diventata quella
di «esternalizzare» il controllo delle frontiere europee: io mi tengo i migranti
che verrebbero da voi, ma in cambio voi mi pagate in denaro sonante e in
aperture politiche.
L’oro sottomarino
La ritorsione sui migranti però non funziona sul
tavolo della guerra per le risorse di gas in quel pezzo di mare davanti a
casa. Nei fondali del Mediterraneo orientale, dal 2010, sono stati scoperti
enormi giacimenti di gas naturale. Alla corsa all’oro sottomarino
partecipano l’Egitto, la Grecia, Cipro, Israele, tutti Paesi che hanno rapporti
poco amichevoli con Ankara e che, d’accordo con l’Europa, stanno progettando un
gasdotto per tagliare fuori gli inaffidabili turchi. Chiuso nella doppia morsa,
Erdogan s’è dovuto chiedere come uscirne. La soluzione l’ha trovata guardando
all’altra sponda del Mediterraneo: la Libia. Proprio là, dove dovrebbe passare
il nuovo gasdotto, e dove è possibile riproporre lo stesso schema di
taglieggiamento sperimentato con la crisi siriana. Nel 2015, quando un milione e
300 mila profughi siriani si muovono dalle coste turche per entrare in Europa,
Erdogan li contiene ottenendo in cambio diverse concessioni, compresa una quota
di visti più facili per i suoi cittadini.
Gas, armi, e migranti
L’occasione per Erdogan si presenta nel gennaio
2020. La debolezza della nostra politica estera in Libia durante i due governi
Conte, ha lasciato spazio libero, e consentito a Erdogan di sbarcare in meno di
due anni, centinaia di «consiglieri militari». Facendo sì che Ankara e Tripoli
firmassero un accordo esclusivo per il controllo delle coste della Tripolitania,
per la difesa reciproca e per lo sfruttamento di gas e petrolio nel Mediterraneo
centrale. Approfittando della guerra civile tra il generale Khalifa Haftar
(appoggiato da russi ed egiziani) e il governo di Tripoli, sostenuto dalla
comunità internazionale, la Turchia invia truppe, armi, e sposta dalla Siria in
Libia i suoi miliziani mercenari, in appoggio al governo di Tripoli. Una mossa
abile: da quel momento, Erdogan può sedersi al tavolo dell’undicesimo maggior
produttore di petrolio al mondo, chiedendo a Tripoli pure la gestione
dell’aeroporto e del porto di Misurata per i prossimi 99 anni. Solo un mese
prima dell’intervento militare contro Haftar, Erdogan ha firmato proprio coi
tripolini un accordo per lo sfruttamento delle loro risorse naturali
sottomarine, 10 miliardi per la ricostruzione di strutture e infrastrutture, e
nel frattempo ha iniziato a controllare i flussi in arrivo dal Sahel e
dall’Africa subsahariana. Un esempio di questo nuovo ruolo nel Mediterraneo
centrale si vede subito: nel gennaio 2020 la fregata turca Gaziantep, impegnata
a scortare un carico d’armi diretto a Tripoli, recupera di sua iniziativa un
barcone di migranti diretto in Italia e lo riporta in Libia. È un respingimento
illegale, ma sufficiente a legittimare la presenza turca nel mare «nostro».
Le minacce all’Europa
Dopo l’accordo con l’Ue sui migranti siriani, il
gioco turco è evidente: le frontiere prima si chiudono, passando dal milione 300
mila profughi sulle rotte balcaniche del 2015 a una media di 20 mila nel 2018,
per poi riaprirsi nel 2019 con 159 mila profughi sulle coste greche. E quando
l’Europa decide di imporre sanzioni economiche per le operazioni militari di
Erdogan in Siria, o peggio ancora sui curdi, ecco la minaccia: «Se provate a
chiamare invasione le nostre operazioni – dice il leader turco nel 2019
–, spalancheremo i nostri confini e vi manderemo tre milioni e mezzo di
rifugiati». E le sanzioni si attenuano. La promessa è mantenuta l’anno dopo: nel
2020 Ankara batte cassa, ma Bruxelles è lenta a rispondere, e allora la Turchia
sposta 130 mila disperati sui 120 km di frontiera terrestre con la Grecia. Tempo
pochi mesi e l’accordo economico con l’Ue viene rinnovato. È un gioco facile, se
sei tu a regolare i rubinetti delle migrazioni sia da Est sia da Sud e, intanto,
ti prepari a controllare anche quelli di gas e petrolio. E in spregio a ogni
regola: la Turchia non ha mai rispettato la clausola, contenuta nell’accordo con
l’Ue, che le impone di riaccogliere un migrante sbarcato nelle isole greche per
ogni migrante che viene ricollocato in Europa. In cinque anni se n’è ripresi
2.140, contro i 15 mila sbarcati in Grecia solo nel 2020. Lo stesso vale per i
soldi che l’Europa ha versato per bloccare il traffico: sono destinati al
riammodernamento di dogana e frontiere, in realtà vengono usati per comprare
armi e combattere la minoranza curda. Questa situazione sta esasperando i Paesi
europei più esposti sull’ultimo confine Ue con la Turchia, Grecia e Bulgaria,
che sono fra i 12 governi che hanno chiesto a Bruxelles di alzare muri, da
aggiungere a quelli che già ci sono. E ora sulla rotta mediterranea si potrebbe
prospettare lo stesso scenario: se l’Europa o l’Italia oseranno sollevare
obiezioni sui gasdotti, o su tutte le altre partite libiche sulle quali Erdogan
sta negoziando, è pronta la leva dei migranti. Sappiamo bene che il fenomeno dei
flussi migratori non lo risolvi costruendo muri, ma anche aver pensato di
uscirne indenni nascondendoli sotto al tappeto del dittatore turco la dice lunga
sulla incapacità strategica dell’Unione.
Il Mit, il servizio segreto
della Turchia.
Emanuel Pietrobon su Inside Over il 22 settembre 2021. Ogni
grande potenza meritevole di tale titolo possiede degli eserciti paralleli,
rispondenti unicamente al comando dello stato profondo, attivabili in caso di
necessità. Necessità che possono essere il soffocamento di una pericolosa
sedizione, l’annichilimento di una o più quinte colonne e/o la prevenzione di un
colpo di Stato in divenire. Questi eserciti ombra possono essere delle realtà
del mercenariato, come il Gruppo Wagner o l’Academi (ex BlackWater), oppure
delle organizzazioni guerrigliere e/o terroristiche che, con la scusante del
denaro – come nel primo caso – o della battaglia ideologica – come nel secondo
caso –, combattono per conto di una capitale e sono fedeli ad una sola bandiera.
E questi eserciti alternativi, talvolta, possono assumere le fattezze di veri e
propri stati paralleli la cui esistenza è nota ad una cerchia ristrettissima di
persone – in Italia è celebre il caso di Gladio. Nel caso della Turchia, una
delle potenze più lungimiranti e fraintese dell’età attuale, le armate che
difendono fondamenta e mura del sistema erdoganiano sono diverse, variegate e
risultano accomunate da un elemento: la micidialità. Perché queste armate sono
i Lupi Grigi del Partito d’azione nazionalista di Devlet Bahceli, i
narcotrafficanti stanziati tra America Latina e Asia centrale, i padrini del
crimine organizzato come Alaattin Cakici, una galassia di sigle e movimenti
appartenenti all’islam politico e al jihadismo – dalla Fratellanza
Musulmana all’Esercito Siriano Libero –, la compagnia Sadat e l’Organizzazione
di Intelligence Nazionale (Mit).
Mit: che cos'è, cosa fa,
quando nasce. L’Organizzazione di Intelligence Nazionale (MIT, Millî İstihbarat
Teşkilatı) è l’agenzia di intelligence della Turchia. Il quartier generale si
trova a Etimesgut, provincia di Ankara, in un edificio che il volgo ha
ribattezzato evocativamente kale, ovvero il castello. Fondato nel 1965, in
sostituzione al Servizio di Sicurezza Nazionale (MEH, Milli Emniyet Hizmeti)
risalente all’epoca di Mustafa Kemal, il Mit è stato ed è un insieme di cose
(simultaneamente) sin dal giorno uno: un ente dall’impronta fortemente militare,
uno strumento nelle mani del governo di turno ed un Grande Fratello in grado di
sorvegliare e punire i nemici dello Stato ovunque si trovino, sia in patria sia
all’estero. Legato ad alcuni dei principali servizi segreti dell’Occidente e
dell’Oriente da accordi di collaborazione in materia di antiterrorismo, come
la Cia e il Fsb, il Mit agisce nel e gode del massimo riserbo – missioni e
operazioni sono oggetto di una classificazione quasi-imperitura, similmente
al Mossad – ed è dotato di una struttura verticistica a livelli contingentati,
ovvero che precludono la possibilità di carriera negli alti ranghi agli agenti
appartenenti a gruppi religiosi minoritari. Deputato alla raccolta di
intelligence su fascicoli critici per la sicurezza nazionale, ad attività di
controintelligence e guerra cibernetica, nonché al contrasto diretto e fattivo
di minacce effettive e potenziali alla Turchia e ai suoi abitanti, il Mit è
teoricamente obbligato a fare rapporto delle sue attività al presidente, al
comandante in capo delle forze armate e al segretario generale del Consiglio di
sicurezza nazionale, sebbene negli anni recenti sia divenuto ostaggio di una
persona sola: Recep Tayyip Erdoğan.
Colonna portante del sistema
erdoganiano. A partire dal giorno dopo il tentato colpo di Stato del luglio
2016, l’evento che sembra aver determinato il collasso dell’antico ordine
kemalista e consacrato l’ascesa definitiva del sistema erdoganiano, il Mit è
stato assoggettato completamente al nuovo potere, per conto del quale è
divenuto il cacciatore di gulenisti. Nell’aprile 2018, cioè a poco meno di due
anni dal fallito golpe, il Mit aveva esperito consegne straordinarie
(extraordinary rendition) in 18 nazioni, portando dinanzi ai tribunali anatolici
ottanta cittadini turchi ricercati per la presunta adesione alla rete gulenista.
Una caccia all’uomo globale, senza limiti di giurisdizione, che con il tempo si
è estesa ulteriormente e le cui dimensioni possono essere rappresentate soltanto
per mezzo dei numeri:
Più di 130 i cittadini
turchi che il Mit ha arrestato illegalmente all’estero, e successivamente
riportato in patria, da luglio 2016 a luglio 2021.
Più di 31 i Paesi che, in
accordo o meno con Ankara, sono stati interessati dalle suddette extraordinary
rendition.
622mila i cittadini
turchi che, nello stesso periodo di riferimento, sono stati indagati per
terrorismo a causa dei loro presunti rapporti con la rete gulenista.
Più di 125mila i dipendenti
pubblici che hanno perduto il lavoro a causa della loro presunta adesione al
circolo gulenista.
Più di 5 i Paesi del Vecchio
Continente in cui il Mit ha proceduto a catturare e rimpatriare presunti membri
della rete gulenista, quando agendo legalmente (a mezzo di regolare
estradizione) e quando illegalmente (consegna
straordinaria): Albania, Bulgaria, Kosovo, Moldavia, Romania, Ucraina.
Più di 5 i Paesi del Vecchio
Continente in cui le indagini del Mit hanno portato la giustizia turca ad
inoltrare richieste di estradizione nei confronti di presunti gulenisti, il cui
processo di rimpatrio è attualmente in corso e/o in fase di esame: Bosnia ed
Erzegovina, Germania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia e Repubblica Ceca.
I numeri della caccia al
gulenista sembrano, e in effetti sono, stratosferici. Numeri che parlano delle
capacità del Mit, i cui agenti sono in grado di operare nei teatri più
impensabili e remoti – come il Gabon, il Sudan, la Malesia e la Mongolia –,
anche in assenza di contatti in loco, e che sono il risultato di una lunga
tradizione in materia di spionaggio internazionale e arresti illegali. Non è dal
2016, in effetti, che il Mit è coinvolto in questo tipo di attività – le
extraordinary rendition –, essendo stato fondato all’acme della guerra
asimmetrica tra Ankara e il PKK. Guerra che aveva portato il Mit nel mondo
dapprima della comparsa di Fethullah Gulen. Guerra che, il 15 febbraio 1999,
aveva portato il Mit a Nairobi (Kenya) per compiere l’extraordinary rendition
più importante della storia recente della Turchia, quella ai danni di Abdullah
Öcalan, il fondatore del PKK.
I tentacoli del Mit in Europa.
Non è soltanto a causa della rete gulenista che la Turchia ha inviato i propri
agenti segreti in tutto il mondo. Perché prima che emergesse questa minaccia,
come è arcinoto, Ankara ha dovuto affrontare l’insurgenza curda – che ancora
oggi pone un serio pericolo per l’integrità territoriale e per la sicurezza
fisica dei cittadini turchi. Non sorprende, dunque, che uno dei due obiettivi
principali del Mit in Europa (e nel mondo) sia il rintracciamento di tutti quei
militanti del PKK ritenuti una minaccia alla sicurezza nazionale. Come il Mit
agisca in Europa, che è l’area dell’estero vicino turco ospitante il maggior
numero di espatriati curdi, è stato svelato nel corso del tempo, grazie alle
indagini delle forze di polizia, dei servizi di sicurezza e dei giornalisti
investigativi del Vecchio Continente. In una sola parola: diaspora. Diaspora
turca, per l’esattezza. Gli agenti del Mit, in breve, hanno infiltrato da tempo
immemorabile le diaspore turche spalmate a macchia d’olio in Europa, in
particolare quelle datate e numerose di Austria, Francia, Germania e Paesi
Bassi. Un’infiltrazione che, con molta probabilità, risale all’epoca della
Guerra fredda e che negli anni è stata approfondita, consolidata e sofisticata,
come mostrano e dimostrano i numeri e i fatti:
13 gli imam turchi attualmente
indagati in Germania perché presumibilmente legati al Mit e coinvolti in
attività di spionaggio.
Circa 6mila i turchi di
Germania che il Mit avrebbe reclutato per portare avanti operazioni spionistiche
e/o di raccolta di intelligence ai danni di gulenisti, militanti curdi e
politici “di interesse” per la Turchia.
Circa 200 i turchi di Austria
che il Mit avrebbe arruolato per le medesime ragioni di cui sopra.
Tre i militanti curdi che il
Mit, grazie all’intelligence raccolta dai propri informatori in loco, avrebbe
assassinato a Parigi nel 2013.
Più di 300 le persone e più di
200 le associazioni che l’esercito invisibile del Mit avrebbe spiato in Germania
nell’anno 2017.
568 i turchi in Grecia che,
secondo documenti diffusi da Nordic Monitor, il Mit avrebbe spiato nel corso del
2019 per via dei loro presunti legami con la rete gulenista.
Gli strumenti con i quali il
Mit avvicinerebbe i compatrioti, che si trovino ad Amsterdam o che vivano a
Stoccolma, sono sempre gli stessi. I primari, per frequenza d’utilizzo, sono i
gruppi criminali – come l’oggi estinto Osmanen Germania –, le associazioni
patriottiche – come Millî Görüş –, le moschee – che Ankara gestisce attraverso
Diyanet, operante in tutta Europa – e le sedi diplomatiche – cioè ambasciate e
consolati. Le capacità nell’arte del sorvegliare-e-punire hanno reso il Mit uno
dei servizi segreti più efficienti del pianeta, ma sono i numeri della
demografia turca in Europa – perché la demografia è potere; potere (geo)politico
– che gli hanno permesso di espandersi capillarmente nell’intero continente,
neutralizzando obiettivi sensibili da Londra a Parigi e compiendo arresti
illegali in lungo e in largo nei Balcani. Numeri che con il tempo dovrebbero
aumentare e che, incidendo pesantemente sulla composizione etnica di diversi
Paesi – dalla Svezia alla Germania –, potrebbero facilitare un incremento della
presa del Mit sul continente. La poststorica e anziana Europa è dunque avvisata:
gli 007 del Mit sono qui tra noi, già oggi, e domani saranno sempre di più. Essi
sono e simboleggiano questo mondo che cambia; questo mondo sempre meno
eurocentrico e sempre più turco.
La guerra santa di Erdogan contro
l’Europa. Emanuel Pietrobon su Inside Over il 21
luglio 2021. I giornalisti hanno il costume di dare appellativi accattivanti ai
personaggi famosi, che siano degli atleti o che siano degli statisti, che siano
degli onesti imprenditori o che siano dei temibili criminali. L’appellativo è un
marchio rispondente al dogma attronomico del nomen omen, cioè è esplicativo
delle caratteristiche della persona che lo ha ricevuto, ed è suscettibile di
esercitare dei potenti effetti mitopoietici presso le masse, che da sempre
abbisognano di qualcosa o di qualcuno in cui credere e immedesimarsi. Nel caso
della Turchia contemporanea, una potenza alla ricerca di rivalsa su antichi
rivali e di spazi vitali nei quali prosperare, si può affermare come i
giornalisti occidentali dei primi anni Duemila abbiano avuto un’incredibile
lungimiranza nel ribattezzare Recep Tayyip Erdoğan osmanicamente, attribuendogli
il titolo di Sultano. Perché oggi, 2021, a vent’anni esatti dalla fondazione del
Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp, Adalet ve Kalkınma Partisi),
Erdoğan è molto di più di un presidente: è il califfo di una Sublime Porta
ricostruita, sulla quale riecheggiano nuovamente gli adhān del muezzino
dell’Ayasofya – che aveva promesso di rimoscheizzare nel lontano 1994 –, che ha
saputo trasformarsi dal malato d’Europa all’incubo d’Europa e che sogna con
ardore e in armi di sventolare la mezzaluna e stella turca dall’Adriatico alla
Grande muraglia.
Il Sultano incompreso. Oggi è Erdoğan contro la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (rea di una sentenza sgradita circa
l’utilizzo del velo islamico negli ambienti di lavoro), ieri era Erdoğan
contro Charlie Hebdo e la campagna anti-islamista di Emmanuel Macron (che aveva
svegliato terroristi dormienti in Francia e innescato proteste antifrancesi dal
Marocco all’Indonesia), domani – e sempre – sarà Erdoğan contro chiunque si
metta fra lui e il sogno di una Turchia a capo di quella realtà
transcontinentale che è il Türk dünyası, ovverosia il mondo turcico.
Capire Erdoğan non è difficile né impossibile, ma
il punto è che agli analisti e ai politologi occidentali, abituati a leggere la
Turchia utilizzando occhiali rosa Made in the West, mancano sia la volontà sia
l’umiltà. La volontà di guardare la Turchia per ciò che è, e non per ciò che
essi vorrebbero che fosse. E l’umiltà di superare quell’elefantiaco limite
interpretativo che è l’occidentalo-centrismo. Erdoğan, come abbiamo ripetuto
innumerevoli volte sulle nostre colonne – pronosticando con successo eventi e
corsi d’azione, tra i quali lo sveltimento dei lavori lungo il cosiddetto
“corridoio panturco” e il potenziamento del Consiglio Turco –, non è né un
incidente della storia né una mosca bianca circondata da forze politiche e
cittadini frementi dalla voglia di tornare sul cammino dell’Occidente. Erdoğan
è la storia, nonché la più potente espressione di quella Turchia profonda che
più volte, dal secondo dopoguerra ai Novanta, ha tentato di porre fine al
dominio armato del kemalismo nella politica e nella società – vedasi, a questo
proposito, il paragrafo Menderes e l’ascesa di Necmettin Erbakan. Erdoğan è il
figlio legittimo di una nazione fondata sui miti sempiterni della valle di
Turan, dei lupi di Ergenekon, di padre Osman e del conquistatore Maometto II.
Una nazione che ha vissuto e voluto l’Occidente il tempo di una forzatura
storica chiamata Atatürk. Una nazione che in Occidente viene identificata con
l’ingannevole cosmopolitismo libertineggiante di Istanbul, ma la cui complessità
sfugge alle letture con gli occhiali rosa dei turisti della politologia.
Complessità che spiega perché, ad esempio, la politica estera erdoganiana goda
del supporto unanime di ogni partito – dall’estrema destra all’estrema sinistra
e dagli islamisti ai laicisti – o perché la rimoscheizzazione di Ayasofya (ex
Santa Sofia), quivi ritenuta una mera mossa distrattiva – ignorando la promessa
di un giovane Erdoğan datata 1994 –, fosse sognata da sette turchi su dieci.
La complessità della Turchia. La complessità di
quella nazione che è la Turchia, derisa nel peggiore dei casi e semplicemente
ignorata nel migliore, andrebbe colta, valorizzata ed integrata nelle analisi
relative alle questioni interne ed esterne che la riguardano. Perché
l’alternativa all’equanimità è l’occidentalo-centrismo: un limite interpretativo
che vizia e inquina i tentativi di comprendere il mondo. Nel caso della Turchia,
la grande incompresa della contemporaneità, l’applicazione
dell’occidentalo-centrismo alle letture analitiche è l’equivalente di
un’autocondanna all’inefficacia nella formulazione di pronostici e scenari.
Perché le letture occidentalo-centriche, ad esempio, dipingono Erdoğan come
perennemente prossimo alla ghigliottina, nonostante la realtà sia ben diversa: è
ancora sul trono, è stato difeso dalla popolazione nel corso del golpe del
luglio 2016 e l’Akp sta registrando un boom di iscrizioni. E le letture
occidentalo-centriche, inoltre, descrivono l’economia turca come sull’orlo di
un’implosione a causa delle periodiche svalutazioni della lira e delle ondate
inflattive, ignorando la rilevanza del fattore storico e le peculiarità del
sistema Turchia: l’economia anatolica non è mai stata connotata dalla stabilità,
ragion per cui i suoi scienziati della moneta sono abituati a galleggiare tra
stati di crisi semi-permanenti e ragion per cui, nonostante le previsioni
distopiche, il pil quest’anno crescerà del 5,5% e il pil calcolato a parità dei
poteri d’acquisto lo scorso anno ha superato quello dell’Italia.
Riequilibrare i rapporti con l’Europa. Le letture
occidentalo-centriche, infine, tendono a ritrarre erroneamente Erdoğan come un
uomo solo, costretto a reggersi sul supporto del Partito Nazionalista e dei Lupi
Grigi di Devlet Bahceli e a fare leva su una continua opera di distrazione delle
masse, pena un probabile rovesciamento dal basso. Pensieri illusori, che non
riescono ad andare oltre la superficie, che non sono in grado di spiegare perché
il popolo sarebbe insorto a difesa di Erdoğan la notte del 15 luglio 2016 e
perché le diaspore stanziate in lungo e in largo per l’Europa siano
tendenzialmente a favore dell’Akp. La dirigenza comunitaria non riuscirà a
venire a capo dell’annoso dossier anatolico fino a quando non capirà la
dogmatica verità alla base di tutto: la Turchia non è solo Erdoğan, ma Erdoğan è
la Turchia. E questa potenza, tanto incompresa quanto sottovalutata, ha cessato
di essere il malato d’Europa da molto tempo – l’invasione di Cipro fu il primo
segno di convalescenza –, trasformandosi in qualcos’altro: nel Terror Europae.
L’Europa, secondo la diagnosi infausta e irreversibile effettuata da Erdoğan,
può essere assoggettata nel nome del riscatto – la revisione del trattato di
Losanna – e dell’emancipazione – una maggiore autonomia geopolitica
dall’Occidente – perché nolente a mostrare muscoli a causa del sonno poststorico
e destinata al tramonto per via di ragioni etno-demografiche. Queste ultime, di
cui la dirigenza turca ha colto la significanza strategica nel lungo e
lunghissimo termine – si pensi a quando Erdoğan invitò i turchi europei “a fare
cinque figli” per sveltire il ritmo della sostituzione etnica in Europa –,
potrebbero condurre la progenie di Osman a convertirsi da minoranza irrilevante
a quasi-maggioranza nelle prossime decadi in Bulgaria e Germania, sullo sfondo
di simultanei processi di islamizzazione traversanti un nugolo di nazioni, tra
le quali Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svezia. L’Europa, in breve, oltre che
avvolta dal manto soporifero del coma poststorico, va lentamente
de-europeizzandosi, perdendo progressivamente i propri caratteri etno-religiosi
originari; una combinazione tanto irripetibile quanto cataclismica dalla quale
gli strateghi dell’aquilina presidenza Erdoğan stanno tentando di capitalizzare
in ogni ambito: diplomatico, economico, politico e religioso. Questo è il motivo
per cui la Turchia sta seguendo con interesse il diffondersi nel Vecchio
Continente di partiti confessionali di ispirazione islamica – oramai presenti in
Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Svezia –, investendo nelle attività di
proselitismo portate avanti dal quartetto Diyanet–Fratellanza Musulmana-Lupi
Grigi-Milli Gorus e, non meno importante, interferendo in ogni questione interna
all’Europa in grado di mobilitare la umma attorno al nuovo sultanato – dalla
controversia sul discorso di Ratisbona alla sentenza della Corte di Giustizia
dell’Ue. Erdoğan, in estrema sintesi, non è un incidente della storia e i
problemi della vecchia e sterile Europa con la Turchia non si estingueranno con
la sua dipartita. Perché Erdoğan è l’uomo della Turchia profonda, una realtà
che, silenziata per decenni dalla difesa armata della costituzione, è riuscita,
dopo il trauma della detronizzazione di Erbakan, a rimettere al centro della
politica e della società quelli che sono stati i valori fondanti della nazione
sin dall’antichità: l’islam, il culto dell’impero e il panturchismo. E l’Europa,
per questa Turchia tornata alle origini, non può che rappresentare ciò che è
stata sin dai tempi della cattura di Costantinopoli: un rivale con cui
competere sempre, da combattere quando necessario e da vassalizzare se
possibile.
Il reality show del super
boss che svela il patto Stato-mafia del governo Erdogan.
Corruzione, traffico di droga,
omicidi e armi ai jihadisti: Sedat Peker, dall’esilio forzato di Dubai, dichiara
guerra al ministro dell’Interno Soylu. A colpi di video-scoop postati su
YouTube. E il presidente tace. Mariano Giustino su L'Espresso il 24 giugno 2021.
Con una piccola telecamera e un treppiede, un mafioso turco, che fino a poco
tempo fa organizzava manifestazioni a sostegno del presidente Recep Tayyip
Erdogan e che ha goduto del favore dei circoli filo-governativi, sta scuotendo
la Turchia dall’inizio di maggio. È Sedat Peker, ultranazionalista e boss della
criminalità organizzata, rifugiatosi dal 2019 a Dubai, che come in un reality
show, davanti a milioni di telespettatori, fa la guerra ad alti funzionari
turchi e ministri pubblicando una serie di video-scoop dal suo account YouTube,
accusando di corruzione, di omicidio, di stupro, racket e di traffico di
stupefacenti alcune delle figure politiche più potenti del paese, compresi
parlamentari, alti funzionari della sicurezza e in particolare il ministro degli
Interni turco, Süleyman Soylu. Con i libri dello scrittore americano Mario Puzo,
“La Famiglia” e “Il Padrino”, poggiati in bella vista sulla scrivania, Peker ha
rivelato, nei suoi video, che gli sono stati commissionati da funzionari ed ex
ministri dell’Akp l’uccisione di un giornalista turco-cipriota, il pestaggio di
un parlamentare che aveva insultato la famiglia di Erdogan e le spedizioni
illegali di armi ai jihadisti siriani. In uno dei suoi ultimi video ha
rovesciato una valanga di accuse contro il ministro Soylu accusandolo di
collusione con il losco uomo d’affari Sezgin Baran Korkmaz, attualmente
ricercato dalle autorità turche per riciclaggio di denaro sporco. Soylu lo
avrebbe aiutato a fuggire dalla Turchia per evitargli l’arresto. Peker ha anche
raccontato di aver spedito in Siria, nel novembre 2015, giubbotti, binocoli e
altri dispositivi militari per l’equipaggiamento dei combattenti turkmeni
siriani, ma ha aggiunto che il Sadat, una forza paramilitare fondata dal
generale di brigata in pensione Adnan Tanrıverdi, allora consigliere di Erdogan,
gli aveva chiesto di aggiungere al carico della spedizione camion pieni di armi
ufficialmente destinate ai ribelli turkemi alleati di Ankara, ma che invece
erano andate a Jabhat al-Nusra, la propaggine siriana di al-Qaeda in Siria. E
così il Sadat, considerata da alcuni media come «esercito parallelo» del
presidente, già impiegato in Libia e Siria, torna di nuovo all’ordine del
giorno. Peker ha goduto per anni, ufficialmente, della protezione della polizia
e, come altri esponenti della mafia turca, ha un background ultranazionalista e
ha fatto parte del backstage dell’alta politica del suo paese. È presente in
foto e video con celebrità anche politiche, compreso il presidente Erdogan. Ha
ripetutamente minacciato di morte gli oppositori del governo, in particolare
curdi ed esponenti di sinistra, inclusi i 1.300 accademici per la pace che nel
2016 lanciarono un appello per un ritorno al processo di pace nel sudest
anatolico: «Faremo scorrere il vostro sangue e ci faremo una doccia col vostro
sangue», disse in un suo comizio. Peker dice che le sue rivelazioni sono un vero
e proprio regolamento di conti, una risposta a tutto quello che ha subito dagli
agenti di polizia che su mandato del ministro degli Interni Soylu avevano fatto
irruzione nella sua casa e avevano puntato le pistole contro sua moglie e le sue
figlie. Non è un caso che nei suoi video abbia preso di mira particolarmente
l’ambizioso ministro che gli aveva promesso protezione, ma che non aveva
mantenuto la sua parola; da qui, la decisione del boss di regolare i conti
accusandolo di essere colluso con uomini di affari senza scrupoli e con
esponenti della criminalità organizzata. Il quadro che Peker dipinge nei suoi
video va oltre la corruzione e potrebbe essere descritto come criminalizzazione
dell’intero apparato statale. Le sue dettagliate accuse suggeriscono che la
criminalità organizzata sarebbe stata utilizzata nelle lotte di potere
all’interno dell’amministrazione dello Stato e del partito di governo, nonché
per diffondere propaganda politica, gestire economie clandestine, manipolare i
media, intimidire l’opposizione e la società civile. Le rivelazioni di Peker
accendono i riflettori anche sulla nuova rotta della cocaina che dalla Colombia
attraversa la Turchia, traffico che, secondo il leader mafioso, vedrebbe
coinvolte figure di alto profilo. Lungo una delle principali rotte del
contrabbando di eroina, che dall’Afghanistan giunge in Europa, la Turchia negli
ultimi anni ha visto un aumento anche del traffico di droga; ciò ha indotto
alcuni osservatori a ipotizzare che il paese sia diventato per l’Europa un
centro di distribuzione di stupefacenti che provengono dall’America Latina e
dall’Oriente. Peker ha affermato in un suo video che il porto di Izmir, terza
città più grande del paese, era la destinazione di 4,9 tonnellate di cocaina
sequestrate in Colombia lo scorso anno e che l’ex ministro degli Interni Mehmet
Agar era coinvolto in quel traffico e ha accusato il ministro dell’Interno in
carica di aver insabbiato le indagini. Il leader turco era rimasto a lungo muto
dinanzi alle accuse contro Soylu e non sembrava volere o potere impedire che il
fango continuasse ad abbattersi contro il suo partito, forse per timore di
essere coinvolto direttamente nelle rivelazioni del boss. Ma qualche giorno
prima del Vertice Nato di Bruxelles, il Presidente ha rotto il silenzio dicendo
che dietro le “calunnie” che hanno colpito il suo partito vi è la longa manus di
organizzazioni criminali, quali il gruppo curdo armato PKK, la rete dei seguaci
del predicatore islamico Fethullah Gülen, FETÖ, ritenuto responsabile del
fallito golpe del 2016, e residui di organizzazioni armene. Subito dopo il
ministro degli Interni Suleyman Soylu ha presentato una richiesta di
estradizione alle autorità degli Emirati Arabi Uniti. È noto che tra Ankara e
Dubai non intercorrono buoni rapporti, sono rivali regionali e inoltre non
esiste un trattato di estradizione tra i due paesi. Peker, ha dunque sospeso le
pubblicazioni dei suoi esplosivi video e ha affermato che la polizia degli
Emirati lo avevano fermato per interrogarlo, ma che contro di lui non vi è al
momento alcuna decisione di arresto. Da tempo, all’interno dell’Akp e del
cerchio magico che ruota attorno a Erdogan, è in corso una faida, una guerra
senza quartiere. Un feroce scontro per il potere tra le correnti tayyipciler
(erdoganiani) dei Pelikancilar (la corrente Pelikan dell’ex ministro delle
Finanze Albayrak, genero del presidente, che prende il nome dal film con Julia
Roberts, “Il Rapporto Pelican”) e quella dei Soylucular (che fa capo al ministro
Soylu) forte dei güvenlikçiler, i securitari, funzionari della polizia che
spingono per una ferrea politica securitaria. Le rivelazioni di Peker segnalano
anche una spaccatura esistente all’interno del campo nazionalista turco: tra
filoccidentali da una parte ed eurasisti anti Nato (filorussi e filocinesi),
dall’altra. E mettono in luce anche una prassi statale inquietante che si basa
sull’impiego di mezzi illegittimi per combattere i cosiddetti «nemici dello
Stato». Infatti, in diversi momenti della storia della Turchia moderna, i
tentacoli dello Stato hanno preso di mira comunisti, socialisti, minoranze,
islamisti, oppositori liberal e politici curdi, a seconda di chi in quel momento
veniva percepito come una minaccia dal potente di turno. Gli ex presidenti
turchi Süleyman Demirel e Kenan Evren (il generale del golpe del 12 settembre
1980) hanno entrambi ammesso pubblicamente l’esistenza dello «Stato profondo».
Per questo è illuminante la nota frase di Demirel: «Quando è necessario, lo
Stato esce dalla routine della legalità». Negli anni ’90 ciò significava
uccisioni extragiudiziali di politici curdi, omicidi di giornalisti di alto
profilo e l’intervento mafioso nelle gare d’appalto statali. E, per rendere
accettabile tutto questo, si invocava la necessità della «difesa della nazione»
per la sua «sopravvivenza», definita col termine nazionalista-islamico di Beka.
Lo Stato profondo è quella rete oscura di funzionari della sicurezza e
criminalità organizzata che opera al di fuori dei canali legali e che si erge a
difensore dell’interesse supremo della nazione, ma che in realtà protegge gli
interessi del regime di turno sostenendo politiche di sicurezza
antidemocratiche. E insieme all’interventismo dei militari ha spesso contrastato
i governi democraticamente eletti. L’ironia della sorte è che il Partito della
Giustizia e dello Sviluppo (Akp) di Erdogan salì al potere quasi due decenni fa
con la parola d’ordine di liberare lo Stato da questa mentalità autoritaria e di
ripulirlo dalla presenza di «bande criminali». Il presidente turco era riuscito
nella prima parte del suo mandato ad arginare l’influenza della criminalità
organizzata e delle sue reti, forte dell’agenda europeista, del processo di
adesione della Turchia all’Ue. Ma dopo il fallito colpo di stato del 2016, ha
epurato tutta l’amministrazione dello Stato per estirpare dal suo corpo ogni
possibile nemico e, per rimpiazzare i funzionari licenziati, ha fatto ricorso
agli ex apparati dello Stato profondo, stringendo alleanze con gli
ultranazionalisti, legittimando personaggi come Peker e richiamando in servizio
ex funzionari della sicurezza. L’ancoraggio della Turchia all’Occidente è stato
sempre uno dei fattori che ha mantenuto viva la speranza di un percorso
democratico del paese e il suo Stato profondo sembrava essersi dissolto. Ora che
l’ancoraggio sta venendo meno, quegli oscuri demoni sono di nuovo alla ribalta.
Il duello che avrebbe cambiato
il mondo di oggi. Andrea Muratore il 27 Maggio 2021 su
Il Giornale. Nel 1916 Ataturk rifiutò il comando delle truppe turche intente a
domare la rivolta in Arabia. Dove la storia avrebbe potuto riservare un
confronto diretto con Lawrence d'Arabia. Mustafa Kemal Ataturk è ricordato e,
spesso inopportunamente, presentato in antitesi all’attuale presidente Recep
Tayyip Erdogan come padre della Turchia contemporanea succeduta all’Impero
ottomano. Uno dei padri non solo della Turchia ma anche del Medio Oriente
contemporaneo, visto in prospettiva. Un'altra figura fondamentale che operò sul
campo opposto rispetto a Mustafa "Pascià" ai tempi della Grande Guerra fu Thomas
Edward Lawrence, passato alla storia come "Lawrence d'Arabia", l'organizzatore e
il condottiero della Grande rivolta araba che contribuì a destabilizzare
l'Impero Ottomano dall'interno e a aprire alla Gran Bretagna la porta della
regione, sempre più strategica per il suo ruolo nelle dinamiche energetiche
globali e nei collegamenti intercontinentali. Ebbene, inconsapevolmente, ben
prima che la storia incidesse a caratteri cubitali i loro nomi tra i grandi del
Novecento, Ataturk e Lawrence avrebbero potuto trovarsi a combattere
direttamente. In uno scontro che avrebbe potuto riscrivere i destini personali
di uno dei due, forse di entrambi, in prospettiva della regione intera. Accadde
sul finire del 1916, quando il governo imperiale di Costantinopoli propose a
Ataturk la possibilità di comandare l’armata turca impegnata nell’Hegiaz a
domare la rivolta araba. Il rifiuto di Ataturk a darsi disponibile per un’azione
di controguerriglia impedì un incontro storico con Thomas Edward Lawrence che
avrebbe rappresentato un duello di portata storica. L’autorevolezza del
“Pasha” Ataturk non sarebbe stata, dopo la fine della Grande Guerra, la stessa
se il comandante della rivoluzione repubblicana turca non avesse potuto uscire
con onore della disfatta nel conflitto da combattente invitto nelle varie
battaglie e consolidare ulteriormente la sua fama negli anni successivi al 1918,
segnato dall’armistizio di Mudros e dall’occupazione alleata di Costantinopoli.
Da Gallipoli fino agli ultimi giorni di conflitto, passati affrontando nella
zona di Aleppo le truppe dell'Intesa, Ataturk non ottenne un singolo insuccesso
in battaglia, includendo nel computo anche le sfide con le truppe russe nel
Caucaso. Parimenti, Lawrence fu audace e geniale condottiero che innovò al
deserto l'arte della guerriglia. La prese di Aqaba, fortezza ottomana sul Mar
Rosso espugnata con un raid dalla terraferma compiuta dalle truppe cammellate
sbucate nel deserto bruciato dalla calura estiva nel 1917, fu indubbiamente
facilitata dall'incapacità dei comandanti ottomani di contrapporre alla rivolta
una strategia efficace. Come avrebbe potuto cambiare il destino della rivolta se
ad affrontare Lawrence fosse stato proprio il futuro presidente della Turchia
postbellica? La storia non si fa con i se e con i ma. Tuttavia, porsi una
domanda del genere è lecito alla luce del fatto che Ataturk ben conosceva le
dinamiche della guerriglia avendole applicate lui stesso pochi anni prima, nella
difesa della Tripolitania e della Cirenaica ottomane: Ataturk si distinse con
onore nella guerra combattuta dagli Ottomani contro l’Italia in Libia tra il
1911 e il 1912, comandando le unità nella zona di Derna, organizzando la
guerriglia e la resistenza delle tribù locali, dopo aver anticipato Lawrence
d’Arabia attraversando l’Egitto britannico vestito con gli abiti tribali
tradizionali per poter far la spola con la madrepatria. Il 18 ottobre 1912, alla
firma dell’armistizio con l’Italia, Derna fu consegnata senza esser stata
espugnata sul campo. Come Lawrence, Ataturk capì che l'errore principale degli
ottomani nei confronti delle tribù arabe era la loro volontà di porre
esplicitamente il ceppo turco come dominante a scapito degli abitanti delle
province dominate dalla Sublime Porta. Nazionalista panturco, Ataturk capì che
per comandare con efficacia la difesa delle roccaforti libiche avrebbe dovuto
inevitabilmente conquistare la fiducia dei leader locali. Il Gazi non esitò a
stringere patti di ferro con la tribù dei Senussi, a promuoverne le pratiche
sufi nelle bande di irregolari poste al suo comando, a vestire con gli abiti
tradizionali per conquistare il loro consenso: tutte dinamiche che Lawrence
avrebbe applicato nei deserti arabi. Prima di Lawrence, il comandante turco
portò all'innovazione l'arte della guerra nel deserto, fatta di movimenti sotto
traccia, di spostamenti notturni, di dinamiche simili a quella della guerra
navale, in cui avanzate e ritirate hanno senso nel quadro di una strategia
complessiva che non mira esclusivamente al controllo del territorio. E, ancora,
prima di Lawrence, Ataturk seppe capire il peso politico del riconoscimento di
una causa nazionale per sostenere la coesione con truppe "straniere" da parte
delle tribù arabe. Il Feisal, sceriffo della Mecca, di Ataturk fu Seyid Ahmed
Senussi, zio del futuro re di Libia Idris I. Vi è dunque da pensare che lo
scontro avrebbe, in un certo senso, segnato i destini della regione. Ataturk era
statista e uomo d'armi e non avrebbe esitato a cercare di isolare il
guerrigliero Lawrence politicamente, mirando a creare un nuovo consenso con gli
Arabi soggetti a Costantinopoli. Campo in cui il fallimento ottomano fu, alla
prova dei fatti, totale, spianando la strada alla dissoluzione del dominio
turco nella regione. Se in una contesa del genere a prevalere fosse stato
Mustafa Kemal, difficilmente la causa araba avrebbe potuto svilupparsi con la
stessa dinamicità e si sarebbe potuto arrivare con eguale velocità alla
spartizione del Medio Oriente imposta dopo la fine dell'Impero ottomano da
francesi e britannici. Vincendo contro Ataturk, invece, Lawrence avrebbe potuto
togliere al futuro "Padre dei Turchi" ed eroe nazionale l'aura di invincibilità
in battaglia su cui Mustafa Kemal fece presa quando guidò la rivoluzione contro
le condizioni punitive imposte dal Trattato di Sevres e la riconquista completa
dell'Anatolia, sede della Repubblica di Turchia postbellica. In entrambi i casi,
questa ucronia avrebbe cambiato decisamente gli assetti mediorientali per come
li conosciamo. Visto dall'ottica dell'Ataturk politico, l'aver rifiutato di
domare la ribellione nell'Hegiaz e di sfidare Lawrence fu la decisione, col
senno di poi, migliore in quando accelerò il progetto di "turchizzazione"
dell'Anatolia, catalizzato dalla disfatta bellica a cui Lawrence diede un
contributo fondamentale. Ma vista con l'occhio del soldato la scelta fu, dal
punto di vista del futuro leader della Repubblica turca, un errore. Kemal uscì
invitto da una guerra persa. E questo nessun comandante può definirlo un
trionfo, se non dal punto di vista dell'onore personale. Le sabbie del Medio
Oriente avrebbero potuto, in tal caso, decidere di consegnare solo uno dei due
nomi all'epoca della storia del Novecento. Su cui militarmente le figure di
Ataturk e Lawrence ancora oggi troneggiano.
Da repubblica.it il 12 aprile 2021. La presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen ha discusso oggi pomeriggio con
il presidente del Consiglio europeo Charles Michel della visita ad Ankara,
esattamente una settimana dopo l'incidente del Sofagate. Lo ha reso noto una
fonte della Commissione europea precisando che la presidente ha chiarito che non
permetterà mai più che una situazione del genere si ripresenti un'altra volta.
Nel corso del loro faccia a faccia i due leader hanno discusso una serie di
argomenti di attualità. Domani parteciperanno entrambi alla Conferenza dei
presidenti al Parlamento europeo.
Dagoreport il 7 aprile 2021. La
notizia del giorno nel mondo occidentale è il trattamento da sguattera riservato
alla presidente della Commissione Europea, Von der Leyen, da parte di Erdogan.
Il sultano di Ankara lascia Ursula senza poltrona durante la visita dei leader
Ue: lui e il presidente del consiglio europeo Charles Michel prendono posto con
le rispettive bandiere alle spalle, mentre la presidente viene lasciata prima in
piedi, poi in un divano. Mancava poco che Erdogan le chiedesse di passare lo
straccio e di portare il caffè. Come è stata possibile una pubblica umiliazione
cosi' clamorosa dell'Europa tutta, attraverso la persona che la rappresenta? Un
passo indietro, di natura tecnica. L'Unione Europea non è uno Stato sovrano, e
come tale manca di quelle strutture che possono sembrare inutili orpelli ma sono
parte integrante della struttura di un Paese. Il cerimoniale della Repubblica,
ad esempio, da noi saldamente piazzato tra il primo piano della Farnesina e il
palazzo del Quirinale. Presieduto da un ambasciatore di grado, è quello che si
occupa di "incarrozzare" le macchine nelle visite ufficiali, che stabilisce chi
debba sedersi e dove, seguendo gerarchie e protocolli rigidissimi e molto
antichi. In una visita di Stato ogni dettaglio è studiato, stabilito, negoziato
nei minimi dettagli da mani esperte e capaci. Perché la forma è sostanza. In un
mese la Commissione ha collezionato due sconfitte clamorose in politica estera.
Prima della mortificazione di Ursula senza seggiola, c’era stata la visita a
Mosca dell'Alto rappresentate per la politica estera, Josep Borrell, con
l’obiettivo di ottenere la liberazione del dissidente politico Alexei Navalny:
non solo Borrell non ha ottenuto il risultato - e lo si sapeva in anticipo - ma
ha anche subito l'espulsione di tre diplomatici europei accusati di aver
partecipato alle manifestazioni antigovernative (Ha subìto anche l’affronto,
durante la conferenza stampa con il ministro degli esteri russo Lavrov, di
vedere l’Europa accusata di violazione dei diritti umani. Sul piano diplomatico,
un disastro clamoroso). La Commissione Europea dispone solo di un servizio per
le relazioni esterne, a cui a capo siede Josep Borrell, lo spagnolo che è alto
rappresentante dell'Unione. Come direttore generale ha scelto Stefano Sannino,
diplomatico di lungo corso e indubbia esperienza. Ma forse non è abbastanza. La
mancanza di un corpo diplomatico e di un servizio di cerimoniale capace di fare
il proprio dovere sta emergendo in modo prepotente. Il dito è puntato contro
Erdogan, ci mancherebbe. Ma chi avrebbe dovuto proteggere Ursula Von der Leyen
e, con lei, l'Europa tutta, non è stato in grado di farlo. Non ci si può
aspettare condiscendenza da parte di un ceffo come Erdogan, bisogna pretendere
il rispetto delle regole e bisogna farlo attraverso i canali che da secoli sono
preposti a questo. Inutile ogni commento su quel merluzzo lesso di Charles
Michel, presidente del Consiglio europeo, che si è seduto assecondando lo sgarbo
di Erdogan e lasciando in piedi la Von der Leyen.
(ANSA il 7 aprile 2021) - ROMA,
07 APR - La visita dei leader Ue in Turchia lascia in eredità un incidente di
protocollo che sui social, fra numerose critiche, è stato già ribattezzato
"sofagate". Di mezzo c'è infatti un divano, quello su cui il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan ieri ha fatto accomodare la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, mentre lui e il presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel, prendevano posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle
spalle. La scena è ripresa in un video diventato virale in cui si sente un
mugugno di disappunto da parte di von der Leyen mentre gli altri due si
accomodano sulle poltrone. Nella scena successiva si vede la presidente della
Commissione Ue seduta su un divano posto alla destra degli interlocutori. La
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "chiaramente è rimasta
sorpresa, lo si vede nel video, ma ha preferito dare priorità alle questioni di
sostanza rispetto al protocollo". Lo ha detto il portavoce della commissione
europea Eric Mamer rispondendo ai giornalisti sul 'sofagate' durante la visita
ieri ad Ankara precisando comunque che la Commissione "si aspetta di essere
trattata secondo il protocollo adeguato" e che "saranno presi contatti con tutte
le parti coinvolte perché non si ripeta in futuro". (ANSA).
Monica Ricci Sargentini
per corriere.it il 7 aprile 2021. La presidente della Commissione europea Ursula
von der Leyen trattata come una presenza marginale per la quale non è nemmeno
prevista una sedia. È successo ieri ad Ankara durante l’incontro con il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Le donne sono le nostre madri» ama
ripetere il presidente turco per sottolineare quanto le rispetti e le consideri.
Ma evidentemente devono saper stare al loro posto. Tutte. Persino Ursula von der
Leyen che occupa la carica più alta nell’Unione Europea. Nessuno, però, sembra
aver protestato nella giornata di ieri. La presidente della Commissione Ue era
giunta in Turchia insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ma
quando i tre sono entrati in una sala riccamente decorata nel palazzo
presidenziale di Ankara c’erano solo due sedie predisposte. Gli uomini si sono
seduti mentre von der Leyen, in chiaro imbarazzo, li fissava incerta. Alla fine
la leader europea ha fatto un cenno con la mano destra come a dire «non vi
preoccupate» e si è andata a sedere su un divano beige a circa tre metri di
distanza, di fronte al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che però è
ben al di sotto di lei nel protocollo diplomatico. L’increscioso episodio,
immortalato dai fotografi e dal video ufficiale dell’incontro è immediatamente
rimbalzato sui social con l’hashtag #sofagate. Come mai Michel non ha mosso un
dito? Perché non ha offerto il suo posto a von der Leyen? Perché lei ha
accettato la situazione senza reagire? Sono le domande che si pongono gli
internauti sui social. L’eurodeputata olandese Sophie in’t Veld ha fatto notare
su Twitter che nei precedenti incontri tra il leader turco e i due presidenti
europei i tre occupavano sedute equivalenti. Foto di precedenti incontri tra
Erdogan e gli allora presidente del Consiglio Ue Tusk e capo della Commissione
Jean-Claude JunckerFoto di precedenti incontri tra Erdogan e gli allora
presidente del Consiglio Ue Tusk e capo della Commissione Jean-Claude Juncker.
La gaffe diplomatica avviene a ridosso dell’uscita della Turchia dalla
Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Una decisione criticata
dall’Unione Europea e dal mondo intero.
Dimenticanza o gesto politico?
Erdogan e lo sgarbo all’Europa, il "Sultano" turco lascia von der Leyen senza
sedia: scoppia il "sofagate". Fabio Calcagni su Il Riformista il 7 Aprile 2021.
La recente visita di una delegazione europea in Turchia, alla "corte" del
presidente Recep Tayyip Erdogan, ha lasciato dietro di sé strascichi e polemiche
dall’eco vastissimo. Soltanto oggi è emerso infatti il video, già ribattezzato
del "sofagate" (sofa in inglese significa divano, ndr), in cui infrangendo o
dimenticando volutamente qualsiasi cerimoniale, il ‘Sultano’ turco fa accomodare
la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del
Consiglio europeo, l’ex premier belga Charles Michel, rispettivamente su un
divano e una sedia. Entrati nel sontuoso palazzo presidenziale di Ankara, ad
attendere i tre e il ministro degli Esteri turco Melvut Cavusoglu ci sono però
solo due sedie: Erdogan senza pensarci fa sedere Michel, con la von der Leyen
che resta attonita in piedi. Dopo qualche secondo di imbarazzo, in cui lo stesso
Michel resta fermo senza reagire, la numero della Commissione Ue emette un verso
quasi gutturale fino a quando viene fatta accomodare su un divano, ben
distanziata da Erdogan e dallo stesso Michel. Una scena che Ursula von der Leyen
non ha commentato direttamente. Il portavoce della Commissione europea Eric
Mamer rispondendo ai giornalisti sul "sofagate" ha spiegato che la presidente
“chiaramente è rimasta sorpresa, lo si vede nel video, ma ha preferito dare
priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo”. Mamer ha comunque
sottolineato che la Commissione “si aspetta di essere trattata secondo il
protocollo adeguato” e che “saranno presi contatti con tutte le parti coinvolte
perché non si ripeta in futuro”. L’incontro era servito a Turchia ed Unione
Europea per discutere di alcuni dossier chiave: dalla questione migranti alla
lotta al cambiamento climatico, fino al rispetto dei diritti umani. Su
quest’ultimo punto la von der Leyen si era detta “molto preoccupata” per la
scelta turca risalente ad alcune settimane fa di ritirarsi dalla Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne. Che la mossa di Erdogan di far sedere
Michel sia un gesto sessista e politico? Ad evocarlo è stata l’eurodeputata
olandese Sophie in ‘t Veld, che su Twitter ha ricordato come in passato negli
incontri tra Erdogan e i precedenti presidenti europei, Jean-Claude Junker e
Donald Tusk, occupavano tutti sedute "equivalenti". Il non detto è che la mossa
di Erdogan potrebbe essere un incidente voluto, l’ennesimo gesto di disprezzo
verso le donne da parte di un presidente che sta portando il suo Paese sempre
più verso l’islamismo radicale, unito ad un nazionalismo sempre più sfrontato ed
evidente anche dall’interventismo negli scenari di guerra esteri.
Erdogan lascia Von der Leyen senza sedia:
è “sofagate”. Il Dubbio il 7 aprile 2021. Il
presidente turco riceve il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e
la presidente della Commissione europea ad Ankara. Ma per lei non c'è la sedia.
Un incidente o uno sgarbo ben studiato? L’episodio è già diventato un caso
diplomatico. E a Bruxelles lo hanno soprannominato il «sofagate» con tanto di
hashtag per i social. Parliamo del torto commesso dal presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, ma anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel,
nei confronti della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,
lasciata senza sedia al ricevimento nel Palazzo di Ankara. La presidente della
Commissione europea era giunta in Turchia insieme al presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel e i tre sono entrati in una sala riccamente decorata. Ma
c’erano solo due sedie predisposte: si sono seduti i due uomini e Von der Leyen
è rimasta in piedi. Il filmato che ritrae la scena è già la parte più vista e
discussa del vertice. «Ehm», è stata la reazione muta ma indignata di von der
Leyen che con un cenno ha voluto chiedere spiegazioni e ricevere indicazioni su
dove accomodarsi. Le è quindi stato assegnato un divanetto a tre metri di
distanza, di fronte al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu,
declassandola secondo il protocollo diplomatico e, soprattutto, come donna. La
presidente è stata «chiaramente sorpresa, come si vede nel video», dal
trattamento ricevuto, ma «ha scelto di concentrarsi sulla sostanza dei problemi
e non sulla forma», ha chiarito il portavoce della Commissione europea, Eric
Mamer. «La visita è stata preparata usando i canali con la nostra delegazione ad
Ankara. L’ufficio di protocollo della Commissione non ha partecipato per
limitare i contatti a causa del Covid», spiega Mamer. «L’episodio – sottolinea –
non dovrebbe far passare in secondo pianole ragioni del viaggio». «Mettiamo le
cose in chiaro. Qualcuno dovrebbe vergognarsi a causa della mancanza di un posto
adeguato per Ursula von der Leyen nel palazzo di Erdogan. L’Ue ha segnalato
l’apertura al dialogo, ma siamo fermi sui nostri valori. Le donne meritano lo
stesso riconoscimento dei loro colleghi maschi», ha scritto il Ppe, principale
formazione politica all’Europarlamento, in un tweet. «La presidente von der
Leyen lasciata senza sedia da Erdogan se ne sarebbe dovuta andare, vendicando
così anche le donne turche, i cui diritti sono oggi sotto attacco. Vergognoso
l’atteggiamento di Charles Michel che non sembra aver mosso un dito», ha
rincarato il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei.
Certo è che il simbolismo dell’ex ministra tedesca confinata in un divanetto
laterale è potente: visi può leggere la scarsa coesione tra istituzioni Ue, il
declino della Germania post Merkel, un residuo di maschilismo nelle relazioni
internazionali o un semplice disastro dei responsabili del cerimoniale. La
sedia, del resto, è sempre stata un’immagine evocativa: nell’arte può indicare
una presenza ma anche un’assenza, una perdita o la speranza di un ritorno. Nella
costruzione europea è passata alla storia la politica della «sedia vuota»
adottata nel 1965 da Charles de Gaulle: la Francia boicottò tutte le riunioni
della Cee per contestare la svolta federalista proposta dalla Commissione di
istituire un bilancio comunitario autonomo e di rafforzare i poteri del
Parlamento europeo. La crisi si concluse solo l’anno dopo con il «compromesso di
Lussemburgo» che introdusse il diritto di veto: da allora basta una sedia per
bloccare le decisioni in materia di sicurezza, affari esteri e imposizione
fiscale.
"Arrogante", "Ursula signorile". E ora è
rivolta contro Erdogan. Per la rubrica il bianco e il
nero abbiamo interpellato la forzista Gabriella Giammanco e l'ex ministro Livia
Turco sullo sgarbo istituzionale compiuto dal premier turco Erdogan nei
confronti del presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen. Francesco
Curridori - Ven, 09/04/2021 - su Il Giornale. Per la rubrica il bianco e il
nero abbiamo interpellato la forzista Gabriella Giammanco e l'ex ministro Livia
Turco sullo sgarbo istituzionale compiuto dal premier turco Erdogan nei
confronti del presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen.
Secondo lei, la Von der Leyen ha fatto bene a
comportarsi così? E lei che avrebbe fatto al suo posto?
Turco: “Credo che Ursula Von Der Leyen si sia
comportata bene. Il suo atteggiamento così elegante rende ancora più evidente
l'ineleganza e l'arroganza di Erdogan”.
Gianmanco: “Allo stesso modo. Ursula von der Leyen
si è comportata in modo signorile, ha evitato di discutere sulla forma
concentrandosi sulla sostanza dell’incontro, dando una vera e propria stoccata a
Erdogan nel momento in cui gli ha posto la questione dei diritti femminili.
Discutibile, invece, il comportamento di Michel. Nel 2015, ad Antalya, entrambi
i leader dell’Ue dell’epoca, Juncker e Tusk, furono fatti accomodare in due
poltrone equidistanti da quella di Erdogan. Come ha osservato il portavoce della
Commissione Ue, durante gli incontri coi capi di Stato o di governo esteri, il
Presidente della Commissione e del Consiglio europeo siedono allo stesso modo.
Evidentemente ad Ankara qualcosa è andato storto nonostante le delegazioni,
quella ospitante e quella in visita, si confrontino sempre prima dell’inizio di
una missione”.
Charles Michel avrebbe dovuto alzarsi e lasciare
il posto alla Ursula?
Turco: “Sì, assolutamente. O comunque non sarebbe
dovuto essere tacito e complice di questa situazione”.
Gianmanco: “Sicuramente non avrebbe dovuto sedersi
facendo finta di nulla”.
L'Unione Europea esce indebolita da questa
vicenda?
Turco: “Non credo che ne esca indebolita. Più che
altro emerge una grande differenza tra le istituzioni europee e quelle turche.
Vedo solo l'arroganza altrui, non la nostra debolezza”.
Gianmanco: “Questo episodio non ha restituito
l’immagine di un’ Europa pronta a lottare per i propri principi liberali e
democratici, per i diritti e i valori su cui si fonda. Non parlerei, però, di
‘indebolimento’, non è un singolo episodio a determinare la forza o la debolezza
dell’Unione europea semmai l’assenza di una politica estera e di difesa comune.
Tutte questioni che si potranno risolvere solo se il processo di integrazione
sarà portato avanti, anche superando il diritto di veto dei singoli Paesi membri
su certe tematiche”.
Questa vicenda segna la fine di ogni ipotetico
ingresso della Turchia in Europa?
Turco: “L'ingresso della Turchia in Europa diventa
sempre più complicato sicuramente a causa di gesti così poco rispettosi che
rivelano una cultura un po' patriarcale e arrogante, ma non solo.
L'accantonamento della Convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza
sulle donne è un fatto gravissimo. È il regime illiberale di Erdogan che rende
difficile l'ingresso della Turchia in Europa”.
Gianmanco: “L’Europa non è solo un’unione
economica, occorre aderire a principi liberali, democratici, di laicità e
rispettare i diritti umani per poter pensare a un percorso comune. Di certo, al
momento, con Erdogan, tutto ciò appare impraticabile”.
L'Unione Europea dovrebbe continuare a finanziare
la Turchia sui migranti?
Turco: “Credo che l'Europa debba cambiare la sua
politica migratoria perché appaltare alla Turchia il controllo delle frontiere
mi pare una scelta di debolezza dell'Europa. Credo che doversi affidare ai
controllori delle frontiere esterne sia un elemento ulteriore di revisione della
politica europea dell'immigrazione”.
Gianmanco: “Ritengo che il fenomeno migratorio non
possa prescindere da accordi con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e
quindi dalla necessità di dialogare, per quanto possibile, con Ankara. È, però,
anche vero che la Turchia non può continuare ad utilizzare i migranti come
strumento di pressione senza poi rispettare alla lettera i patti. Quello che sta
accadendo al confine con la Grecia è intollerabile".
Draghi a Erdogan: "Dittatore". La Turchia
convoca l'ambasciatore. Il premier attacca il
"Sultano" sul caso Von der Leyen. La Turchia reagisce sul piano diplomatico.
Tensione con Roma. Lorenzo Vita - Gio, 08/04/2021 - su Il Giornale. Il caso
diplomatico tra Unione europea e Turchia riecheggia anche a Roma, nelle stanze
di Palazzo Chigi. Dopo le accuse dei parlamentari, ora è il turno del
premier Mario Draghi, che risponde così a una domanda in conferenza stampa su
quanto accaduto in Turchia con protagonisti Ursula von der Leyen, Charles Michel
e Recep Tayyip Erdogan: "Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan
nei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato.
Mi è dispiaciuto tantissimo per l'umiliazione che Von der Leyen ha dovuto
subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori di cui però si ha
bisogno di collaborare, o meglio di cooperare, uno deve essere franco
nell'esprimere la differenza di vedute, di comportamenti, di visioni, ma pronto
a cooperare per gli interessi del proprio paese". Draghi entra a gamba tesa nel
dibattito sul "sofa-gate" di Ankara e lo fa con parole molto dure nei confronti
del presidente turco. "Dittatore" non è un termine che si usa in modo casuale. E
di certo Draghi non è un presidente del Consiglio che solitamente si inerpica in
frasi roboanti o in pura propaganda. Le parole hanno un peso e definire in quel
modo il presidente della Turchia significava lanciare un segnale chiarissimo non
solo nei confronti della Turchia, ma anche per far comprendere la direzione
intrapresa dal blocco euro-atlantico di cui Draghi è uno dei principali
interpreti. Parole che ovviamente hanno acceso lo scontro diplomatico. E non
poteva essere altrimenti. Subito dopo la conferenza stampa in cui il premier ha
definito Erdogan un "dittatore" sostanzialmente necessario, il ministero degli
Esteri turco ha convocato l'ambasciatore italiano, Massimo Gaiani. A renderlo
noto è stata l'agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu. A stretto giro arriva
anche la condanna del ministro degli Esteri, Mevut Cavusoglu. "Il premier
italiano, nominato, Mario Draghi, ha rilasciato una dichiarazione populista e
inaccettabile nei confronti del nostro presidente della Repubblica, che è stato
scelto attraverso elezioni", ha detto il capo della diplomazia turca. E ha poi
aggiunto: "Condanniamo con forza le parole riprovevoli e fuori dai limiti e le
rispediamo al mittente". Cavusoglu ha poi chiesto che "vengano immediatamente
ritirate le dichiarazioni sgradevoli e fuori dai limiti" dette da Draghi nei
confronti di Erdogan. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto
durante la trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4 e ha commentato così la
tensione tra Italia e Turchia dopo le parole del premier: "In queste ore sentirò
Mario Draghi e coordineremo le iniziative che si devono intraprendere, non
anticipo niente". E sulla questione "sofa-gate" ha sentenziato: "Ritengo che si
tratti prima ancora di protocollo di un minimo di galanteria".
Turchia, Draghi ritiri subito le frasi su
Erdogan. (ANSA l'8 aprile 2021) All'ambasciatore
italiano ad Ankara Massimo Gaiani, convocato stasera al ministero degli Esteri
turco, "è stato sottolineato che ci aspettiamo che queste brutte e sfacciate
affermazioni" del premier italiano Mario Draghi sul presidente turco Recep
Tayyip Erdogan, "che non sono conformi allo spirito di amicizia e di alleanza
tra Italia e Turchia, vengano immediatamente ritirate". Così una nota del
ministero degli Esteri di Ankara.
(ANSA il 9 aprile 2021) "A seguito delle
inaccettabili dichiarazioni fatte oggi dal primo ministro italiano" Mario Draghi
"sul nostro presidente" Recep Tayyip Erdogan, "l'ambasciatore italiano ad Ankara
è stato immediatamente convocato questa sera presso il nostro ministero",
riferisce il comunicato turco. A conferire con il nostro ambasciatore è stato Il
viceministro degli Esteri con delega agli Affari Ue, Faruk Kaymakci, che
nell'esprimere la "forte condanna" della Turchia per le parole di Draghi, ha
sottolineato che Erdogan "è il leader eletto con il più forte sostegno del voto
popolare in Europa". La nota di Ankara entra poi nel merito della vicenda del
caso 'Sofagate', da cui sono partite le dichiarazioni di Draghi. "Nessuno può
mettere in dubbio l'ospitalità della Turchia. Il nostro Paese - si legge - non
prenderà parte a una insensata e maliziosa discussione all'interno dell'Ue" e
giudica "vani i tentativi di danneggiare l'agenda positiva tra Turchia e Ue".
"Da noi non ci sono dittatori. Se volete vedere un dittatore, guardate alla
vostra storia. Guardate Mussolini". Così il vice-leader dell'Akp del presidente
turco Recep Tayyip Erdogan, Numan Kurtulmus, rivolgendosi all'Italia, dopo che
il premier Mario Draghi ha definito Erdogan un "dittatore". (ANSA). "Il primo
ministro nominato d'Italia ha superato i limiti definendo come "dittatore" Recep
Tayyip Erdogan, che è stato eletto Presidente dal popolo turco con il 52%.
Condanniamo fermamente questo stile, che non ha posto nella diplomazia. Chi
cerca il dittatore guardi alla storia d'Italia". Lo scrive su Twitter il capo
della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, in un messaggio
in italiano. Una condanna analoga giunge anche dal portavoce del capo dello
stato turco, Ibrahim Kalin, che sempre via Twitter chiede che "questa
affermazione venga corretta immediatamente". (ANSA).
Draghi contro Erdogan.
Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti” il 9
aprile 2021. A un certo punto, durante la conferenza stampa, hanno chiesto a
Draghi: cosa ne pensa dello sgarbo di Erdogan alla presidente Ursula von der
Leyen? Risposta: «Non condivido assolutamente le posizioni di Erdogan e penso
non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per
l'umiliazione che la presidente della Commissione von der Leyen ha dovuto
subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori, chiamiamoli per
quel che sono, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di
vedute, di opinioni e di visione della società».
Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha
definito «offensive e imprudenti» le dichiarazioni di Draghi. «Condanniamo con
forza le inaccettabili parole del premier nominato italiano sul nostro
presidente eletto». In serata, poi, ha convocato l'ambasciatore italiano in
Turchia Massimo Gaiani per protestare.
Riguardo alla faccenda della sedia per Ursula, il
ministro ha detto: «Nel protocollo implementato nella riunione su scala
ristretta tenutasi presso l'ufficio del nostro Presidente, le richieste della
parte dell'UE sono state soddisfatte».
«Stando a una nota del Consiglio europeo ai
diplomatici non è stato permesso di visitare in anticipo la sala dell'incontro
poiché troppo vicina agli uffici di Erddgan. Lo stesso è avvenuto per la sala da
pranzo, che però è stata vista qualche minuto prima, e si è provveduto ad
aggiungere una sedia, anche lì, mancante. Come non farsi venire il sospetto -
vista la sala da pranzo - che lo stesso sarebbe accaduto per la sala
dell'incontro? La sedia per von der Leyen, è chiaro, non era stata prevista dai
turchi, ma senz'altro non è stata richiesta dagli europei. Se così fosse stato,
"la richiesta sarebbe stata soddisfatta"» [Sta].
«Il colpo da ko: un (anonimo) alto funzionario
turco insinua che il "sofagate" sia nato dalle "gelosie" tra Michel e von der
Leyen. Bersaglio centrato, visto che il dubbio serpeggia anche a Bruxelles, dove
viene attribuita al belga una certa gelosia verso la tedesca» [D'Argenio, Rep)].
La Turchia, per l'Italia, è il quinto partner
commerciale più importante, il secondo a livello europeo dopo la Germania.
A Roma, intanto, i deputati del Partito
democratico hanno sistemato una sedia vuota al centro dell'emiciclo di
Montecitorio per protestare contro quella che definiscono «un'offesa a tutte le
donne».
Emanuele Bonini per La Stampa l'8 aprile 2021.
Bruxelles – Adesso il sofagate finisce in Parlamento. Gli eurodeputati, ancora
in pausa a Bruxelles sulla scia delle festività pasquali, non restano a guardare
e dai loro collegi elettorali organizzano il lavoro delle prossime
settimane. Per la sessione plenaria di fine mese (26-29 aprile) i due gruppi più
numerosi, popolari (Ppe) e socialdemocratici (S&D) chiedono che si discuta in
Aula della missione ad Ankara dei presidenti di Commissione e Consiglio europeo,
per fare luce sulla vicenda e chiedere la testa di Charles Michel, reo di
essersi prestato al gioco del presidente turco. La missione di Ursula von der
Leyen e Charles Michel in Turchia «avrebbe dovuto essere un messaggio di
fermezza e unità del nostro approccio al presidente Erdogan». Invece, lamenta il
capogruppo del Ppe, Mafred Weber, «purtroppo ha portato a divisioni, poiché l'Ue
non è riuscita a stare insieme quando era necessario». Da qui la richiesta di
calendarizzare il dibattito, che trova d’accordo anche il centro-sinistra. «Le
relazioni UE-Turchia sono fondamentali, ma lo sono pure l'unità dell’Ue e il
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle donne», incalza la
capogruppo S&D, Iratxe Garcia Perez, che vuole «chiarire» cosa è successo e cosa
non ha funzionato in Turchia. Proprio dai banchi dei socialdemocratici parte
l’attacco frontale a Michel, liberale, accasato nel stesso gruppo (Renew) del
partito del presidente francese Emmanuel Macron. Alla loro capogruppo Perez le
europarlamentari del PD Alessandra Moretti e Patrizia Toia chiedono di farsi
promotrice di una «iniziativa di censura nei confronti del Presidente del
Consiglio Michel» per la sua «palese inadeguatezza». Parlamento contro
Consiglio, popolari contro liberali, macroniani contro non-macroniani. Comunque
andrà a finire il presidente turco ha già vinto. L’Unione europea è caduta nella
trappola orchestrata ad arte, e dopo il sofagate litiga e si divide. E sul caso
“Sofà-gate”, questa sera, nel corso della conferenza stampa sul punto
pandemia-vaccini e futuro economico dell’Italia, è intervenuto anche il premier
Mario Draghi che ha toccato anche temi di carattere nazionale. «Erdogan è un
dittatore di cui si ha bisogno. Non condivido affatto il comportamento di
Erdogan. E' stato un comportamento di cui mi dispiace moltissimo per
l'umiliazione che la presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, ha dovuto
subire». E poi: «Con questi..chiamiamoli dittatori, bisogna essere franchi
nell'espressione della visione della società ma pronti a cooperare per gli
interessi del Paese. Bisogna trovare l'equilibrio giusto».
Draghi all’assalto di Erdogan: cosa c’è
dietro l’affondo del premier. Lorenzo Vita su Inside
Over il 9 aprile 2021. Mario Draghi irrompe nella crisi tra Europa e Turchia e
lo fa con una presa di posizione durissima nei confronti del presidente
turco Recep Tayyip Erdogan. In conferenza stampa il presidente del Consiglio ha
apostrofato il leader di Ankara come un “dittatore“, definendolo tutt’al più
necessario, come interlocutore, per tutelare gli interessi nazionali. Una mossa
che ha scatenato l’ira della Turchia che non solo ha convocato l’ambasciatore
italiano ad Ankara ma ha anche chiesto ufficialmente che Draghi faccia marcia
indietro per le parole rivolte nei confronti del presidente. La tensione tra i
due Paesi è palese. Il premier italiano, non certo noto per la durezza del suo
linguaggio in conferenza stampa, ha espresso parole chiare e gravi. Impossibile
pensare che il governo turco non reagisse di fronte a quelle frasi. E quindi è
del tutto evidente che se non vogliamo parlare di gaffe, possiamo allora parlare
di una scelta di comunicazione precisa da parte del presidente del Consiglio.
Una mossa che svela non soltanto una rinnovata assertività diplomatica italiana
nel Mediterraneo, ma anche la scelta da parte di Draghi di muoversi sui due
binari che hanno da subito contraddistinto il suo incarico: europeismo e
atlantismo. Sul fronte europeo, è chiaro che Draghi abbia voluto inviare un
segnale. Mentre l’Ue si è dimostrata impacciata e rigida nei confronti del
presidente turco, e mentre Angela Merkel ed Emmanuel Macron non hanno
manifestato in modo netto la loro distanza da quanto avvenuto ad Ankara, Draghi
ha fatto capire di poter essere un elemento molto più importante nelle gerarchie
europee. La sua è una presa di posizione netta, dura e particolarmente incisiva.
E la decisione di entrare così a gamba tesa a difesa di Ursula von der Leyen ma
soprattutto contro Erdogan sembra voler dire qualcosa a tutta l’Europa: la sua
leadership in Italia può tramutarsi in una leadership europea. E lo può fare
sfruttando non solo le occasioni che gli si presentano nel corso del tempo ma
anche l’indubbia fragilità mostrata sia da Macron che da Merkel. Con l’asse
franco-tedesco indebolito, Draghi può puntare a entrare come “terzo incomodo”
tra i due poli d’Europa. E può farlo per il credito ottenuto in questi anni a
Francoforte ma anche per convergenze internazionali particolarmente importanti.
In questo allineamento planetario in favore di Draghi rientra anche l’arrivo
di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Il presidente democratico non è
per niente soddisfatto di quanto avvenuto in questi anni in Turchia. Considera
Erdogan un problema, non ha nemmeno provato a telefonargli dopo settimane dal
suo insediamento, e l’impressione è che da parte della Casa Bianca si voglia
rendere chiaro un concetto: la Turchia è un importante alleato Nato ma deve
sottostare a quanto deciso dal quartier generale atlantico. Una questione che è
diventata molto rilevante per Biden soprattutto nell’ottica di contrapposizione
a Cina e Russia, che in questi anni hanno invece stretto con la Turchia dei
legami molto forti. Il divario tra Biden e Erdogan può sicuramente fare il gioco
di Draghi, dal momento che invece il premier italiano gode eccome dei favori di
Washington. Il presidente del Consiglio ha già fatto capire di avere molto a
cuore le relazioni con gli Stati Uniti. Ed è chiaro che l’avversione della Casa
Bianca per l’attuale amministrazione turca trova in Italia una sponda
importante. Soprattutto perché la possibilità di avere il placet americano
aiuterebbe Roma a riprendere settori vitali della Libia finiti in questi anni
nelle mani proprio di Ankara. E il viaggio a Tripoli è stato particolarmente
importante proprio per far capire il ruolo italiano nel Paese. Tutto così
semplice? Non proprio. Vero che Draghi ha il sostegno di Europa e Stati Uniti
anche sul fronte turco, ma il premier ha detto una frase un po’ più complessa
quando si riferiva Erdogan come a un “dittatore”. Il presidente del Consiglio ha
infatti detto: “Con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare,
bisogna essere franchi per affermare la propria posizione ma anche pronti a
cooperare per gli interessi del proprio Paese, bisogna trovare l’equilibrio
giusto”. Ecco, su questa frase occorre riflettere. Perché è proprio qui che
l’Italia si gioca tutto. La Turchia è un partner molto importante dell’Italia
nel Mediterraneo. L’interscambio commerciale è ottimo, gli accordi in diversi
settori economici sono fondamentali, esistono progetti bilaterali sul fronte
della logistica, ma è soprattutto una relazione che vede in Libia il suo
principale teatro di incontro. E di scontro. Ankara e Roma hanno condiviso, pur
con posizioni diverse, l’asse con Tripoli quando Fayez al Sarraj rischiava di
capitolare. La Turchia addestra la Guardia costiera libica, che a sua volta
dovrebbe interrompere il traffico di esseri umani dalle coste nordafricane. E
non va dimenticato che i militari italiani, insieme a quelli turchi, sono
presenti sia a Tripoli che Misurata, e sono loro ad aver reso possibile la
permanenza di un governo a Tripoli. È chiaro che il gioco turco sia quello
(anche) di strappare spazio di manovra all’Italia in Tripolitania. Inviare
droni, mercenari e navi non è certo per beneficienza: e l’Italia è la prima a
essere stata lesa ne suoi interessi nel Paese nordafricano. Ma la cooperazione
esiste ed è innegabile. Se non altro perché non va dimenticato che mentre Italia
e Turchia supportavano l’ex premier Sarraj, altri sostenevano più o meno
velatamente l’assedio di Khalifa Haftar, tra cui Russia, petromonarchie arabe e,
in parte, la Francia. La stessa Grecia, rappresentata in questi giorni a Tripoli
da Kyriakos Mitsotakis, non ha nascosto in certe fasi un’infatuazione per il
maresciallo della Cirenaica. E anzi, il vertice di ieri in Libia tra Draghi e
l’omologo greco potrebbe essere stato il preludio di questo scontro con Erdogan
e di un rinnovato allineamento con Ue e Nato. Insomma, se la questione
del sofa-gate può essere semplice da analizzare e commentare, diverso è il caso
dei rapporti tra due Stati quando si è sul campo di battaglia. E quelli tra
Italia e Turchia sono rapporti non solo complessi, ma anche molto delicati.
Dalla Libia al Mediterraneo orientale fino al Corno d’Africa, lì dove l’Italia
ha perso il suo ascendente facendo spazio proprio alle manovre di Ankara, c’è
una Turchia con cui bisogna trattare. La durezza nei confronti di Erdogan è
legittima; ma se poi lo si considera un interlocutore necessario per gli
interessi nazionali, allora le cose cambiano. Specialmente perché le armi
contrattuali, al Sultano, non mancano affatto.
L’Italia, l’ira del Sultano e lo spettro
dell’effetto farfalla. Emanuel Pietrobon su Inside
Over il 9 aprile 2021. Si dice che il battito d’ali di una farfalla a New York
possa provocare un urugano dall’altra parte del mondo o, parafrasando Alan
Turing, che un evento apparentemente insignificante come lo spostamento
femtometrico di un elettrone al tempo uno potrebbe innescare una catena di
eventi culminante in una valanga omicida al tempo due. Si chiama effetto
farfalla ed è una teoria che pertiene alla matematica e alla fisica, sebbene
possa trovare valida applicazione anche nella geopolitica e nelle relazioni
internazionali. Perché historia homines docet che gli eventi più impensabili,
spesso e inconsapevolmente, hanno dato vita agli esiti più inattesi, improbabili
e travolgenti, senza che l’Uomo, guidato com’è da un orizzonte temporale
terreno, transitorio e labile, potesse prevenirli o cavalcarli. È il caso di una
rivoluzione partita in Francia nel 1789, che vent’anni dopo avrebbe dato avvio
all’emancipazione dell’Iberoamerica dall’impero spagnolo, o di uno sciopero
operaio nel porto di Danzica nel 1970, che ventuno anni più tardi avrebbe
condotto all’estinzione dell’Unione Sovietica. La cognizione del ruolo giocato
dall’effetto farfalla nella storia apre gli occhi allo statista, che soltanto
allora comprenderà la nodalità del fissare gli occhi sull’orizzonte e del tenere
il ritmo spasmodico degli eventi del mondo. Non v’è altra maniera, infatti, per
determinare se e quando la farfalla ha battuto le ali. E, peraltro, già lo
scriveva Niccolò Machiavelli in quell’opera intramontabile intitolata “Il
principe” che “bisogna sempre presagire non solo i pericoli presenti, ma
soprattutto quelli futuri, per contrastarli in ogni modo”. Quelle insedie
attuali di cui ci ha messo in guardia lo stratega fiorentino sono rappresentate
dalle due ali di lepidottero che battono. È vero: non sappiamo né quando né dove
la valanga colpirà, perché potrebbe essere oggi come fra dieci anni, ma siamo
tenuti a rammentare anche la parte salvifica della tesi di Turing, cioè che
dalle slavine ci si può salvare. Nel caso italiano, sapendo quando la farfalla
ha battuto le ali – il 6 aprile, giorno dello sbarco a Tripoli di Mario Draghi –
e sapendo quali teatri potrebbero essere travolti dalla cascata mortifera di
neve – perché tornati in Libia su mandato dell’amministrazione Biden per
fronteggiare Russia e Turchia –, è imperativo che il recupero del nostro posto
al Sole venga inquadrato all’interno di una strategia lungimirante,
onnicomprensiva, focalizzata sulla prevenzione ed estesa dal Mediterraneo al
Caucaso meridionale.
Il peso delle parole. L’8 aprile, all’indomani
dell’incidente che ha coinvolto Ursula von der Leyen ad Ankara, Mario Draghi ha
definito Recep Tayyip Erdogan “un dittatore di cui si ha bisogno”; parole che
hanno determinato la convocazione dell’ambasciatore italiano in Turchia.
Scettico riguardo la teoria secondo cui la sedia non pervenuta sarebbe il frutto
di un errore di protocollo, il primo ministro italiano ha voluto apporre
un’etichetta magniloquente al capo di Stato turco, consapevole dell’importanza
della semantica nella politica e, dunque, dei rischi ai quali andava incontro.
Perché etichettare qualcuno equivale a categorizzarlo, dotarlo di un’identità e
di un’appartenenza specifiche, che, in questo caso, risultano antagonistiche e
antipodiche alla liberal-democratica Italia, rispondendo alla logica schmittiana
e manichea dell’amico–nemico. Definendo Erdogan un dittatore, Draghi lo ha
catalogato come un membro di quella comunità di stati illiberali che
l’amministrazione Biden ha promesso di combattere, operando una netta
distinzione tra “noi” (democratici) e “loro” (dittatoriali), segnando una
profonda discontinuità con il passato recente, ovverosia con la politica
dell’accomodamento di necessità di Luigi di Maio, e confermando implicitamente
di aver ricevuto un mandato antiturco da oltreoceano. Il punto dell’intera
questione, però, è un altro: il governo Draghi è sicuro di volersi imbarcare
nella missione ad alto rischio affidatagli dagli Stati Uniti (e a latere
da Francia e Germania)? In palio c’è il recupero dell’influenza sulla Libia, per
quanto parziale e risibile rispetto all’epoca Berlusconi, ma dietro l’angolo si
celano innumerevoli insidie, che, urge il coraggio di ammetterlo, potrebbero
dare vita ad una slavina. Perché l’Italia non si ritroverà ad affrontare una
potenza in declino, ma una in ascesa, e l’eventuale decisione di trattare
simultaneamente la Russia con aperta ostilità non farà che elevare l’aleatorietà
della partita, anche perché, occorre tenerlo in considerazione, non abbiamo
una forma mentis imperiale e impostata sull’offensiva.
Dove potrebbe colpire la Turchia. La farfalla ha
battuto le ali, perciò è giunto il momento di capire quando, come e dove avrà
luogo il cataclisma. Non è dato sapere il quando, ma il come e il dove possono
essere pronosticati con una certa disinvoltura dato che la provvidenza sembra
aver unito in maniera (quasi) indissolubile Italia e Turchia: dove c’è l’una, lì
c’è anche l’altra. Nel decennio del profondo sonno, cominciato nel lontano 2011
con il semaforo verde al cambio di regime in Libia, l’Italia si è
progressivamente e silenziosamente ritirata da Balcani occidentali e
Mediterraneo allargato, regalando o appaltando a terzi la gestione del proprio
estero vicino, divenuto sempre più estero e sempre meno vicino. Approfittando
dell’uscita dall’Orbe dell’Urbe, i giannizzeri della Sublime Porta rinata hanno
creato avamposti fortificati lungo e dentro lo spazio di prosperità nostrano –
disegnato malignamente dal fato come una terra eternamente condivisa e contesa
tra popoli italici e turchi sin dai tempi della Serenissima e dello Stato
Pontificio –, che, presto o tardi, potrebbero essere volti contro di noi.
Urgono, a quest’ultimo proposito, delle precisazioni a scopo di disambiguazione:
non si sta facendo riferimento a scenari fantapolitici di guerre aperte o per
procura, ma a realistiche operazioni asimmetriche, manovre destabilizzanti e
campagne di bellicismo economico che potrebbero assumere le seguenti forme: La
riaffermazione della primazia italica in Libia, specialmente nei settori
energetico e infrastrutturale, potrebbe venire sfidata da atti di sabotaggio,
insurgenze estemporanee in prossimità degli obiettivi nostrani e concorrenza
aggressiva da parte dei grandi privati turchi (e russi). Da non trascurare,
infine, le seguenti realtà: intere sezioni del Paese sono divenute dei
protettorati informali di Ankara e Mosca, l’era dell’italocentrismo è terminata
da un decennio, la carta migratoria. Complicazioni potrebbero sorgere nei
Balcani occidentali, dove l’impronta italiana è andata sbiadendo e arretrando,
soprattutto tra Albania, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina. Tre nazioni, le
suddette, dove la Turchia può vantare un’influenza culturale (e politica)
crescente e raccoglierà sicuramente i frutti prelibati dell’impareggiabile
macchina umanitaria messa in moto durante la pandemia. Anche in questo caso,
progetti di cooperazione, agende congiunte e piani di investimento potrebbero
subire dei bruschi e improvvisi arresti. La situazione non è più splendente
nell’Africa orientale, dove la Sublime Porta ha dato prova dell’avvenuto
sorpasso sull’Italia in occasione del caso Silvia Romano, liberata grazie
all’opera di mediazione dei servizi segreti turchi, e sta siglando accordi
riguardevoli in materia di sicurezza e cooperazione militare. Delle molteplici
lezioni che l’Italia dovrebbe aver tratto dal caso Romano, una risalta tra
tutte: la nostra rete spionistica nello spazio ex coloniale è prisca,
anacronistica, da riciclare, cioè non è all’altezza di vivere la competizione
tra grandi potenze. Ultimo ma assolutamente non meno importante è il mondo
turcico, compreso fra Caucaso meridionale e Asia centrale, dove la diplomazia
nostrana ha gettato con successo le basi per una trasmigrazione geopolitica.
Scontro frontale con la Turchia e antagonizzazione della Russia, sino ad oggi
silente sulla nostra espansione nello spazio postsovietico, significherebbero
avvio delle ostilità su teatri per noi pivotali (l’Azerbaigian è il nostro primo
rifornitore di petrolio dal 2013) e difficilmente difendibili a causa
dell’assenza di alleati utili e validi in loco.
Cosa fare e cosa non fare. L’Italia ha le carte in
regola per competere con la Turchia, ponendo fine all’epoca dell’accomodamento
varata da Luigi di Maio ed emancipandosi dallo status di socio di minoranza? Sì.
Abbiamo il capitale necessario, il sicuro appoggio dei grandi privati nostrani
e, sembrerebbe, il supporto tacito degli Stati Uniti, quindi di Francia e
Germania. Se vogliamo cogliere l’opportunità di rendere il Mediterraneo
allargato meno caotico e più italiano, però, è tassativa la formulazione di una
strategia studiata nei minimi dettagli e basata sulla considerazione di ogni
possibile scenario. È nell’interesse italiano coltivare l’inimicizia della
Russia? No. Un filo invisibile lega il caso Biot e le prese di posizione
anti-erdoganiane dell’esecutivo: la volizione di segnalare alla Casa Bianca che
l’Italia vuole giocare la partita, preferibilmente in posizione d’attacco. La
linea dello scontro su due fronti sarebbe controproducente per una ragione molto
semplice: le due potenze unirebbero le forze per contrastarci e indebolirci sia
in Libia sia nell’Asia postsovietica. A quel punto il vantaggio detenuto nei
confronti di entrambe, se affrontate singolarmente, sarebbe annullato. Fedeltà
all’atlantismo e linea morbida con il Cremlino non si escludono vicendevolmente,
anzi sono una peculiarità storica e consolidata della tradizione diplomatica
italiana. Scontro frontale o aggiustamento dei ruoli? L’Italia ha i mezzi, gli
alleati e l’economia, ma è priva dell’elemento (possibilmente) più importante:
la forma mentis imperiale. La Turchia ha potuto ricostruire un’influenza
rilevante sugli ex territori ottomani perché, pur essendo carente del fattore
economico, è in possesso di volontà di potenza e lungimiranza. L’attuale modus
convivendi non è sostenibile nel lungo termine, perché favorirà Ankara a nostro
detrimento, ma la soluzione non proverrà dallo scoppio di venefiche rivalità con
una potenza avvezza alla diplomazia delle cannoniere – che potrebbero
avvantaggiare il terzo spettatore: la Francia –, bensì dal riaggiustamento
paritario dei ruoli attraverso una semplice quanto efficace solerzia geopolitica
da parte italiana. Quale strategia per l’Italia di Draghi? Sappiamo che la
farfalla ha battuto le ali, possediamo un elenco delle baite esposte al rischio
valanga e abbiamo cognizione dell’alta rischiosità di combattere su due fronti
simultaneamente, dunque abbiamo tutto ciò di cui necessitiamo per evitare di
cadere nell’errore fatale della discalculia. Proattività in luogo dell’abulia,
prudenza anziché azzardo e occhi puntati sulla cima della montagna: la partita
può avere inizio.
Ankara replica a Draghi: «Chi cerca un
dittatore guardi alla storia d’Italia». Durante la
conferenza stampa di ieri Draghi aveva commentato l'incidente diplomatico con
Ursula von der Leyen definendo il presidente turco «un dittatore di cui si ha
bisogno». Dura la reazione: «Parole gravissime». Il Dubbio il 9 aprile 2021. Il
capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, ha attaccato
il premier Mario Draghi, definito «nominato», al contrario del presidente turco
Recep Tayyip Erdogan, eletto con il 52% dei voti. «Il premier nominato d’Italia
ha superato i limiti e definito dittatore il nostro presidente, eletto con il
52% dei voti dal popolo turco. Parole che non trovano posto nella democrazia,
pronunciate con uno stile da condannare. Se qualcuno cerca un dittatore allora
guardi alla storia d’Italia», ha twittato Altun. Il PM nominato d’Italia ha
superato i limiti definendo come “dittatore” Recep Tayyip Erdoğan che è eletto
Presidente dal popolo turco con il 52%. Condanniamo fermamente questo stile che
non ha posto nella diplomazia. Chi cerca il dittatore guardi alla storia
d’Italia. Nella conferenza stampa organizzata ieri a Palazzo Chigi il premier
Draghi aveva commentato il recente incidente di protocollo avvenuto lo scorso 6
aprile che ha coinvolto la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen durante visita ad Ankara da Erdogan, condotta con il presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel. «Non condivido il comportamento del
presidente turco nei confronti della presidente della Commissione europea e
credo non sia stato appropriato», ha risposto Draghi alle domande dei
giornalisti. «Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione subita dalla
presidente von der Leyen», ha aggiunto il premier italiano in merito
all’incidente di protocollo che ha relegato su di un divano la presidente della
Commissione Ue mentre il presidente turco Erdogan e Michel erano seduti l’uno a
fianco all’altro su di una sedia. «Con questi dittatori, di cui però si ha
bisogno per collaborare, bisogna essere franchi per affermare la propria
posizione ma anche pronti a cooperare per gli interessi del proprio Paese,
bisogna trovare l’equilibrio giusto», ha detto Draghi. Dura la replica di
Ankara: «Condanniamo fortemente il discorso inaccettabile e populista, e le
affermazioni brutte senza alcun limite del Presidente del Consiglio nominato sul
nostro Presidente della Repubblica eletto e le rimandiamo al mittente», ha
scritto in un tweet del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Mentre
il vicepresidente turco Fuat Oktay, ha dichiarato: «Condanno le dichiarazioni
indecenti del primo ministro Draghi sul nostro presidente e lo invito a
scusarsi».
Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"
l'8 aprile 2021. Che Erdogan fosse Erdogan, lo si sapeva. Adesso sappiamo che
anche Michel è Michel. Il despota turco riceve a palazzo i due presidenti d'
Europa, Ursula von der Leyen (Commissione) e Charles Michel (Consiglio), ma di
sedie per gli ospiti ce n' è una sola. A rigor di cerimoniale spetterebbe a von
der Leyen, e non in quanto donna, ma per la maggiore rilevanza politica del suo
ruolo. Mentre Erdogan è proprio in quanto donna che intende umiliarla e così
invita Michel a occupare la seggiola dorata con i braccioli. Ci sono momenti che
definiscono un carattere e un continente. Se Michel cedesse il posto alla
collega, Erdogan verrebbe retrocesso di colpo a quello che è: un autocrate
misogino, convinto che il potere di ricatto che esercita sull' Europa riguardo
ai migranti lo autorizzi a infliggerci qualsiasi insolenza. Come europei ne
usciremmo ingigantiti nell' autostima. Invece Michel si siede senza fare una
piega, con un mix deprimente di inconsapevolezza e paura di sbagliare, lo stesso
che ha guidato le istituzioni di Bruxelles nella fallimentare partita dei
vaccini. Per un attimo spero che von der Leyen schiaffeggi quei due maschi
inutilmente alfa, ma è una signora di buone maniere e contiene il suo imbarazzo
nei limiti di un suono onomatopeico: «Ehm». Poi, per non peggiorare le cose,
accetta di accomodarsi su un sofà laterale. Che rabbia. Ecco, se proprio devo
trovare un aspetto positivo in questa vicenda, è la prima volta che mi arrabbio
non come italiano, ma come europeo.
Turchia, Michel: “Mi dispiace di essere
sembrato indifferente”. Ilaria Minucci su Notizie.it
l'08/04/2021. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha pubblicato
un lungo post su Facebook per spiegare quanto avvenuto durante la visita in
Turchia. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha pubblicato un
lungo post su Facebook relativo all’incontro avvenuto ad Ankara con il
presidente turco Recepe Tayyip Erdogan, al quale si era recato in compagnia
della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In particolare,
oltre a ribadire l’importanza e la risonanza internazionale dell’evento, il
presidente del Consiglio europeo ha scelto di commentare lo spiacevole episodio
che ha coinvolto la collega von del Leyen, noto con l’espressione “sofa-gate”.
Continuano le polemiche sorte in seguito alla visita di Charles Michel e Ursula
von der Leyen a Erdogan, durante la quale non è stata riservata
nessuna sedia d’onore alla presidente della Commissione europea. Mentre Michel
ed Erdogan occupavano le rispettive sedie, infatti, la donna si è vista
costretta ad accomodarsi sul divano, posizionandosi di fronte a Mevlut
Cavusoglu, ministro degli Esteri turco. In merito alla spiacevole vicenda
verificatasi Ankara, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è stato
accusato di aver mostrato distacco e indifferenza nei confronti del trattamento
riservato alla collega. Nella giornata di mercoledì 7 aprile, quindi, Charles
Michel ha deciso di fare chiarezza in merito all’accaduto, pubblicando un lungo
post sul suo profilo Facebook ufficiale nel quale dichiara: “Le poche immagini
che sono state mostrate hanno dato l’impressione che sia stato insensibile alla
situazione. Niente è più lontano dalla realtà né dai miei sentimenti profondi
né, infine, dai principi di rispetto che mi sembrano essenziali. In quel
momento, pur percependo la natura deplorevole della situazione, abbiamo scelto
di non peggiorarla con un incidente pubblico e di privilegiare in questo inizio
di riunione la sostanza della discussione politica che stavamo per iniziare,
Ursula e io, con i nostri ospiti”.
Il presidente del Consiglio europeo, poi, si è
mostrato dispiaciuto principalmente per due motivi: “In primo luogo, mi dispiace
di aver dato l’impressione di essere stato indifferente alla goffaggine del
protocollo nei confronti di Ursula. Tanto più che sono onorato di partecipare a
questo progetto europeo, di cui due grandi Istituzioni su quattro sono guidate
da donne, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. E sono anche orgoglioso che
una donna, la prima nella storia, mi sia successa come Primo Ministro del
Belgio. Infine, sono rattristato, perché questa situazione ha messo in ombra
l’importante e benefico lavoro geopolitico che abbiamo svolto insieme ad Ankara
e di cui spero che l’Europa raccolga i frutti”.
(AGI
il 28 aprile 2021) -
Istanbul, 28 apr. - La Turchia risponde alla presidente della Commissione
Europea, Ursula Von der Leyen, che ieri aveva parlato del sofagate, accusando
Ankara di averla lasciata senza poltrona in quanto donna. "L'essere donna e
l'abbandono della convenzione di Istanbul con l'episodio del divano della Von
der Leyen non hanno alcuna relazione. Quanto accaduto e' il risultato della
mancanza di coordinamento dell'Ue nello stabilire il protocollo. Un errore nel
protocollo non puo' diventare un problema sulla parita' di genere. Abbiamo
massimo rispetto e siamo fieri dell'amicizia con la Presidente Von der Leyen",
si legge nel comunicato del ministero degli Esteri.
EMANUELE BONINI per lastampa.it il 26 aprile 2021.
Quanto accaduto ad Ankara ha il sapore dell’umiliazione e del tradimento. Ursula
von der Leyen torna sull’incidente della sedia mancante all’incontro con il
presidente turco Recep Tayip Erdogan, e il massimo vertice della Commissione
europea rimprovera e accusa il presidente del Consiglio europeo di averla
condannata alla figura che ha fatto il giro del mondo. «Sono una donna, sono la
prima donna a capo della Commissione europea, sono la presidente della
Commissione europea e mi aspettavo di essere trattata come tale. Ma così non è
stato», lamenta von der Leyen prendendo la parola nell’Aula del Parlamento
europeo, che apre i lavori con quanto accaduto durante la visita in Turchia due
settimane fa. «Ho cercato una giustificazione per quanto accaduto nei trattati,
ma non le ho trovate». Vuol dire che «sono stata trattata in questo modo perché
donna». Quindi l’affondo nei confronti di Michel. «Mi sono sentita ferita e
sola, come donna e come europea». L’intervento di von der Leyen segue quello di
Michel, sotto il fuoco dei parlamentari che hanno raccolto firme per chiedere le
dimissioni del leader dei liberali europei. Il presidente del Consiglio europeo
conferma la sua versione dei fatti. Ripete che i servizi protocollari non hanno
avuto accesso alla sala della riunione, che non potevano sapere quale fosse la
disposizione dei posti a sedere. Ripete che al momento dell’incontro ha
preferito non fare nulla per evitare di creare un incidente ancora maggiore.
Chiede scusa e assicura di essersi chiarito con von der Leyen, ma quando la
presidente della Commissione prende la parola emerge lo strappo tra i due.
«Dobbiamo garantire che ragazze e donne siano protette sempre e ovunque in
Europa, perché il rispetto della donna misura lo spettro della democrazia» di un
Paese e di un sistema di Paesi. In questo l’Ue ha fallito, con Michel che ha
contribuito. Le parole di von der Leyen scatenano inevitabilmente le critiche in
Aula. Particolarmente critica la capogruppo dei socialdemocratici europei,
Iratxe Garcia Perez. «So che non si è reso conto del problema, ci credo. Ed è
proprio questo il problema. Come donna mi sono sentita offesa».
Marco Gervasoni per "il Giornale" l'8 aprile 2021.
Miracolo! Ursula von der Leyen si è accorta che Erdogan è islamico. Ma che non è
solo tale, è anche a capo di un progetto di espansione della religione
maomettana in tutti i Paesi della Ue. E che usa il suo potere ogni momento per
raggiungere questo obiettivo. Potere anche simbolico, anzi soprattutto simbolico
- secondo alcuni la forma più alta di potere. La fotografia della presidente
della Commissione Ue assisa su un canapé in basso e a distanza dagli uomini
resterà negli annali come memento. Essa non ci dice tanto su Erdogan: tutti
ormai sappiamo chi sia e quale siano i suoi intenti. Condannare il suo gesto
come sgarbo diplomatico, politico, culturale, è ovvio. Talmente ovvio che
verrebbe da chiedere a Ursula: ma lei era rimasta l' unica nel mondo a non
conoscere il Sultano? Che potesse agire così era prevedibile. No, la foto
rimarrà negli annali come testimonianza dell' infingardaggine della Ue e dell'
ipocrisia del suo «Stato guida», la Germania, principale sponsor del Sultano.
Von der Leyen era presente infatti alla riunione non per sorseggiare un tè ma
per discutere dell' ennesimo cedimento al capo di Stato turco. Da anni infatti
la Ue elargisce una gran quantità di fondi (che poi sono soldi nostri, dalle
nostre tasse) a Erdogan perché, con metodi non molto ortodossi, freni l'
invasione degli immigrati. Invece di adottare una propria politica di difesa dei
confini Ue, che dovrebbe prevedere in primo luogo il blocco navale, Bruxelles
affida il compito sporco al capo di Stato turco, in cambio di generose
elargizioni di denaro. Regalando così al Sultano un potere immenso di ricatto:
regolarmente infatti Erdogan minaccia di far saltare il patto, sapendo di
impugnare la scimitarra dalla parte del manico. Senza il muro turco, infatti, l'
afflusso sarebbe talmente devastante da far sembrare il 2015 un anno di
bonaccia. E in cambio di questo la Ue chiude gli occhi su tutto, a cominciare
dalle violazione dei diritti umani, tema su cui è occhiutamente severa verso
Paesi della stessa Ue come Ungheria e Polonia, neppure lontanamente comparabili
alla Turchia. La Ue gira poi il capo di fronte ai metodi utilizzati da Erdogan
per frenare l' invasione, mentre sostiene politicamente le Ong che fanno
sbarcare clandestini sulle nostre coste. E finge di non accorgersi del progetto
espansionistico del Sultano. Che non vuole solo soldi: non accetta che alcuno si
opponga alla costruzione di moschee nelle città europee, vedi da ultimo quella
gigantesca di Strasburgo. Molto ipocrita e molto falsa l' indignazione attuale.
Dopo le proteste di maniera, gli affari con Erdogan infatti ricominceranno. E il
Sultano avrà vinta l' ennesima partita, quella simbolica.
Pietro Senaldi sul sofa-gate di Ankara:
"L'Europa ha steso i tappeti rossi a Erdogan: ora impari".
Libero Quotidiano l'08 aprile 2021. Il direttore di Libero Pietro
Senaldi sul caso diplomatico della sedia negata a Ursula von der
Leyen, presidente della Commissione Ue, nel palazzo presidenziale di Ankara:
“Sedersi sul sofà di un sultano è molto più comodo che sedersi su una seggiola.
Detto questo, per quello che non ha fatto la von der Leyen in Europa avrebbero
potuto fare ben di peggio, soprattutto dopo aver steso i tappetti rossi
a Erdogan. Perché Laura Boldrini che indossava il velo venne osannata per aver
rispettato la cultura musulmana e in questo caso invece si accusa Erdogan di
essere maschilista? Il politicamente corretto distorce la realtà: a tal punto
che la von der Leyen sta dove sta solo perché è madamigella della
cancelliera Angela Merkel”.
L’umiliazione del sofa gate di Erdogan è
il simbolo della debolezza dell’Europa con la Turchia.
di Federica Bianchi su L'Espresso l'8 aprile 2021. La poltrona
negata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen dimostra quanto il
presidente turco si senta potente. Mentre la Ue promette altri tre miliardi al
“sultano” nel giorno in cui lui fa arrestare i suoi oppositori. Ottenere la
propria autonomia strategica è sicuramente un obiettivo nobile e, soprattutto,
possibile per l'Unione europea. Peccato però che nei fatti sia la Commissione
sia il Consiglio si stiano dimostrando incapaci di farcela. Dopo la disastrosa
visita a Mosca, in cui Borrel quest'inverno si è fatto letteralmente bullizzare
dalla stampa di regime, ad avere fatto fare una pessima figura alle istituzioni
europee e ai cittadini europei questa settimana sono stati la presidente della
Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles
Michel. Che poi, nell'ordine di gravità, è il secondo a meritare il podio.
Durante la visita ad Ankara del 6 aprile, dopo i saluti in piedi, Recep Tayiip
Erdogan ha fatto accomodare Charles Michel sulla sedia accanto alla sua nella
grande sala delle udienze mentre ha lasciato in piedi Von der Leyen, la quale è
stata ripresa in un video diventato virale a tossire nella mascherina, come per
dire «Ed io?». Lei, che non ha protestato, si è dovuta accontentare di un
divanetto posto a tre metri di distanza dalle sedie dei due leader uomini,
davanti al divanetto su cui era accomodato il ministro degli Esteri, di grado
più basso di quello di Von der Leyen. Con un gesto da bullo machista, non certo
da statista, Erdogan ha voluto ribadire che non cederà sul mancato rispetto dei
diritti umani e sul trattamento delle donne come cittadine di serie B perché
tanto è certo che alla fine l'Europa non insisterà davvero. Non solo. Lasciando
in piedi la presidente della Commissione, a differenza di quanto aveva fatto nel
2015 con Jean-Claude Juncker, ha inviato anche un chiaro segnale di cosa pensa
dell'Europa federale e delle sue istituzioni mentre ha dato valore al ruolo di
rappresentante dei singoli 27 stati di Michel. Quest'ultimo sarebbe da rimandare
all'asilo ad imparare le regole del vivere comune europeo: non solo non ha avuto
la normale reazione di alzarsi per cedere la sedia alla presidente ma non ha
nemmeno chiesto al cerimoniale una seconda sedia per Von der Leyen. È rimasto
lì, seduto accanto al sultano in fieri, emblema diventato virale di come in
Europa non ci si comporta. Erdogan in un colpo solo è riuscito a dividere le
istituzioni europee e a umiliare le donne. Michel, sarà per ambizione, ripicca o
narcisismo, si è prestato al gioco del dittatore. Si è difeso su Facebook
dicendo che le autorità turche hanno rispettato strettamente il protocollo e che
né lui né Von der Leyen hanno voluto fare scene ma concentrarsi sugli interessi
dei cittadini. Eppure con questa toppa mal riuscita ha dimostrato di non avere
nessuna idea che il protocollo è politica in sé, come ha sottolineato Wolfang
Ischinger, capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (luogo principe della
geopolitica globale) ed esperto di linguaggi diplomatici, e di non avere capito
la gravità del suo gesto davanti a uno dei personaggi politici più detestati
dagli europei. Tutto quello che è venuto dopo ha perso d'importanza. A partire
dalla richiesta a Erdogan del rispetto dei diritti umani e dei diritti delle
donne da parte di Ankara. D'altronde, come possono la Turchia e il resto del
mondo ritenere l'Europa capace di far rispettare i propri valori se i suoi
stessi leader non sanno farsi rispettare? Se è finita male non è che la missione
europea in Turchia sia cominciata meglio. Forse non avrebbe dovuto cominciare
affatto. Due capi di stato europei che si recano ad Ankara per offrirle soldi e
aiuto in cambio di assistenza sul controllo delle loro frontiere esterne proprio
nei giorni in cui Erdogan arresta generali e ammiragli pensionati, rei di avere
criticato pubblicamente il progetto di costruzione del canale di Istanbul
accanto al Bosforo perché viola la convenzione di Marsiglia sulla
demilitarizzazione del Mar Nero. Una repressione che s'innesta su anni di
repressioni indiscriminate contro qualsiasi forma di dissenso contro la politica
islamista. Solo pochi giorni prima Erdogan aveva ritirato la Turchia dalla
Convenzione di Istanbul sulla protezione delle donne come richiesto dal clero
fondamentalista. «Erdogan sta giocando con l'Europa», dice Wolfang Munchau del
think tank Eurointelligence: «La cosa è sorprendente visto che è lui a trovarsi
in una situazione di bisogno economico. Ma sa che l'Europa non imporrà sanzioni
perché né l'Italia né la Germania le accetteranno mai, e che l'Unione dipende
dalla volontà turca di agire da cuscinetto per i rifugiati, alla quale è
disposta a pagare qualsiasi prezzo». Che poi aggiunge: «Lo stesso gioco lo sta
facendo Putin in Russia. Il successo diplomatico dei due (Putin e Erdogan) si
basa sulla mancanza di una strategia di politica estera da parte dell'Unione che
vada oltre la ricerca del proprio interesse commerciale, per il quale non
occorre strategia». Così Von der Leyen ha lasciato Ankara promettendo a Erdogan
«come gesto di buona volontà» oltre tre miliardi di euro che dovranno essere
varati dal Consiglio europeo (sono soldi degli stati membri e non dell'Unione) a
giugno e un'eventuale ammodernamento dell'unione doganale, che però dovrà
passare dalle forche caudine del Parlamento europeo, molto meno tenero con i
dittatori. La linea rossa dei diritti umani e dei diritti delle donne appare
ormai sbiadita, più vecchio ritornello che minaccia concreta. Come perfino il
#sofagate ha dimostrato.
Estratto dell'articolo di Giordano Stabile per "la
Stampa" l'8 aprile 2021. […] Il portavoce della Commissione, Eric Mamer, ha
puntualizzato che Ursula von der Leyen «è stata chiaramente sorpresa come si può
vedere nel filmato, ma ha scelto di dare la priorità alla sostanza sulle
questioni di protocollo o di forma, è quello che i cittadini europei si
sarebbero attesi da lei». Non tutti. Sulla Rete in molti sottolineano come «da
un dittatore abituato a non rispettare i diritti umani basilari te lo aspetti,
da un collega democratico no». Tanto più che al centro dei colloqui c' erano
proprio diritti fondamentali e la parità fra donne e uomini. Per il Nouvel
Observateur la scena dimostra che su questo fronte «c' è ancora molto da fare,
persino in Europa, visto che Charles Michel avrebbe potuto quanto meno lasciarle
il suo posto». La presidente si è presa una piccola rivincita nella
dichiarazione finale. «I diritti umani non sono negoziabili», ha ribadito. E
questa volta intendeva anche i propri.
DAGONOTA il 9 dicembre 2021.
Molti ricorderanno il "Sofa-gate", durante la visita della presidente della
Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ad Ankara. Fu lasciata in piedi, la
Signora, con un gesto che provocò l'indignazione del mondo intero. A sedere,
invece, il presidente turco Erdogan e il presidente del Consiglio dell'Unione
europea, il belga Charles Michel. La foto della Presidente senza seggiola fece
il giro del mondo, tutti puntarono il dito contro il dittatore misogino e
maschilista. Su questo disgraziato sito, scrivemmo che le visite ufficiali
vengono preparate dalle rispettive delegazioni. In modo condiviso e congiunto,
nei più minimi dettagli. E che i posti attribuiti ai rappresentanti delle
istituzioni europee vengono decisi e concordati dai rispettivi servizi di
protocollo. Non sono decisioni che vengono prese in modo unilaterale, non è
nonna Peppina che fa i posti per la cena di Natale. Che, forse, la colpa
dell'offesa alla Von der Leyen e, con lei, a tutte le donne del mondo, non era
da cercare solo ad Ankara. A qualche mese dallo scandalo, scopriamo che il
pomposo capo del protocollo della Commissione Europea, il diplomatico francese
Nicolas de la Grandville, è stato spedito a schiarirsi le idee in Norvegia. Era
a capo del servizio dal 2010, dai tempi della Commissione Barroso. Lo troviamo
ora negli uffici della Commissione europea...in Norvegia. Nel frattempo è stato
pubblicato un bando anche per il posto del capo del cerimoniale del Consiglio
dell'Unione europea, ora vacante. Siamo davvero sicuri che il delitto (e il
castigo) siano da cercare solo ad Ankara? Ah, non saperlo
(ANSA l'8 aprile 2021) - "Durante la visita" di
martedì ad Ankara dei presidenti della Commissione e del Consiglio Ue, Ursula
von der Leyen e Charles Michel, "è stato seguito il protocollo standard. La
presidente della Commissione europea non è stata trattata in modo diverso. Né la
delegazione Ue ha chiesto una diversa disposizione. In questa situazione, ci
saremmo aspettati che i due ospiti si fossero accordati tra loro". Lo dichiarano
all'ANSA fonti governative turche.
Dagoreport l'8 aprile 2021. L'Europa, che
dall'esterno viene percepita come entita' unica e compatta, è in realtà formata
da organi diversi guidati e gestiti in modo diverso. Con un po' di esegesi della
visita ad Ankara dei vertici europei, cerchiamo di capire chi abbia la
responsabilità di fare in modo che vada tutto secondo creanza. I viaggi e gli
incontri all'estero della presidente Von der Leyen sono gestiti dall'ufficio del
protocollo della Commissione e dalle ambasciate all'estero, che dipendono dal
servizio estero e dunque da Borrell e Sannino. A capo del protocollo della
Commissione c'è un ambasciatore francese. A capo dell'ambasciata di Ankara c'è
invece un ambasciatore tedesco. Non sono funzionari europei, euroburocrati che
possono inciampare su come sistemare le seggiolinine, ma ambasciatori di grado
che ben padroneggiano le regole del gioco. L'inchiesta interna che sta partendo
tra gli ovattati corridoi europei punta il dito contro l'ambasciatore europeo ad
Ankara, Nikolaus Meyer-Landrut. Non e' un funzionario europeo, ma un diplomatico
tedesco, che e' stato consigliere della Merkel dal 2011 al 2015 e ambasciatore
tedesco in Francia dal 2015 al 2020. L'ambasciata europea in Turchia ha senza
dubbio organizzato la visita. L'umiliazione di Von der Leyen potrebbe dunque
essere frutto di un "errore" proprio di un ambasciatore tedesco. Mani troppo
esperte però per poter pensare ad un errore…Altro responsabile della visita è il
servizio di protocollo della Commissione. A capo c'e' un francese, Nicolas de La
Grandville. Siede lì dal 2010. Anche lui, come Meyer-Landrut, è un diplomatico
di carriera e non un funzionario europeo. Ha passato la vita al Ministero degli
esteri francesi, è stato consigliere diplomatico del presidente Sarkozy e
addirittura capo del protocollo del ministero degli Esteri francese. Anche lui,
dunque, conosce e maneggia le regole del protocollo. La tesi della mancanza di
attenzione da parte degli uffici della Commissione o della loro sciatteria
nell'organizzare la visita ad Ankara per il G20 diventa assai poco verosimile.
Chi avrebbe dovuto occuparsene, sia dal lato del servizio protocollo sia da
quello dell'ambasciata di Ankara, ha mani troppo capaci per commettere errori
così grossolani. Con queste premesse, qualche "addetto ai livori" di Bruxelles
evoca l'idea di un tremendo trappolone fatto alla Von der Leyen, in un momento
in cui lei si ritrova debole a causa di una campagna vaccinale che non va come
dovrebbe…
Fr.Bas. per il "Corriere della Sera" l'8 aprile
2021.
1 Come funziona il protocollo nelle visite
ufficiali dei capi di Stato? In occasione di cerimonie o visite ufficiali da
parte di capi di Stato e di governo niente è lasciato al caso. Ma anche
l'organizzazione di summit internazionali prevede un cerimoniale preciso. I
protocolli in genere sono il risultato di un confronto tra la delegazione
ospitante e quella in visita ancora prima dell'inizio della missione. È chiaro
che durante la visita ad Ankara della presidente della Commissione Ue Ursula von
der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel qualcosa è
andato storto, perché c'era solo una sedia accanto a quella del presidente turco
Recep Tayyip Erdogan.
2 Qual è l'ordine delle precedenze tra le
istituzioni europee? In base al cerimoniale di Stato, pubblicato sul sito di
Palazzo Chigi, e non diversamente da quanto prevede Bruxelles, tra le
istituzioni europee prima viene il presidente del Parlamento Ue, poi quello del
Consiglio europeo e infine quello della Commissione. In base al Trattato di
Lisbona il presidente del Consiglio europeo assicura la rappresentanza esterna
dell'Ue per le questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune,
fatte salve le competenze dell'Alto rappresentante dell' Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza. Però come ha osservato il portavoce della
Commissione Ue, durante gli incontri con i capi di Stato o di governo esteri (ad
esempio durante i vertici tra l'Ue e un Paese terzo), il presidente della
Commissione e del Consiglio europeo siedono allo stesso modo.
3 Quali sono i precedenti? Il 16 novembre 2015 ad
Antalya entrambi i leader Ue dell'epoca, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk,
furono fatti accomodare in due poltrone equidistanti ai lati di Erdogan. Il 23
gennaio 2020 a Gerusalemme, alla cerimonia del 75mo anniversario della
liberazione di Auschwitz, l'ordine di intervento dei presidenti fu: Parlamento
Ue, Commissione e Consiglio europeo.
Von der Leyen sul divano, l’ex-capo
cerimoniale di Palazzo Chigi “assolve” Michel: «Se si alzava, era peggio».
Valerio Falerni venerdì 9 Aprile 2021 su Il Secolo
d'Italia. D’accordo, Erdogan non è si rivelato quel gentleman che tutti
pensavamo che fosse. Ma è solo sua la colpa dell’imperdonabile sgarbo a Ursula
von der Leyen? Si fosse trattato di una visita priva, sia lui sia Charles
Michel avrebbero meritato un corso intensivo di bon ton, quantunque di questi
tempi non faccia esattamente tendenza. Ma si tratta di rapporti tra Stati, tra
istituzioni e in questo caso non esistono delikatessen, ma solo regole,
protocolli e cerimoniali. E a sentire uno che se ne intende come Massimo
Sgrelli, che per tre lustri proprio queste orchestre ha diretto a Palazzo Chigi,
siamo di fronte ad un «incidente diplomatico-protocollare». Si poteva evitare?
«Sì», risponde lui. Bastava che il «protocollo turco e quello di Bruxelles»
assicurassero alle«tre autorità partecipanti all’incontro le stesse sedie». Più
facile di così. Sgrelli è una vera autorità in materia. È l’autore de Il galateo
istituzionale, una sorta di bibbia per addetti ai lavori. C’è dunque da
credergli quando dice che nella mancata poltrona alla Von der Leyen l’errore è
triplo. Il primo è del protocollo turco che «non ha allestito lo scenario
adatto». Significa «dare delle sedute omogenee a tutti, visto che le autorità
partecipanti all’incontro avevano un rango omogeneo». Non assegnare una sedia
d’onore anche alla presidente della Commissione Ue è da matita blu. Relegandola
infatti su un sofà, i protagonisti dell’incontro sembravano solo Erdogan e
Michel. Dal canto suo, Bruxelles ha sbagliato a non verificare preventivamente
che «lo scenario fosse corretto e idoneo». Infine, Michel: che però Sgrelli
“assolve”. «Se si fosse alzato – spiega – l’incidente sarebbe diventato di
carattere istituzionale e non più solo tra persone». La sua passività, invece,
ha evitato che lo sgarbo di Erdogan alla Von der Leyen si trasformasse in uno
scontro tra Ue e Turchia. Ora c’è un solo modo per capire se l’incidente sia
stato voluto o meno dal Sultano. «Dipenderà molto – dice Sgrelli –
dal destino del capo del cerimoniale della presidenza turca». Scommettiamo?
Dagospia l'8 aprile 2021. Jean Quatremer
per liberation.fr. L’ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è rimasto
sbalordito quando ha ricevuto, mercoledì mattina, un'e-mail poco diplomatica
firmata dal capo di gabinetto di Ursula von der Leyen, presidente della
Commissione europea. Secondo le nostre informazioni, la tedesca Bjoern Seibert
si è indignata per l'"umiliazione" inflitta alla von der Leyen dalla Turchia
durante la visita ufficiale che ha fatto ad Ankara il giorno prima, e non esita
ad affermare che ciò renderà più difficile la trattativa sulla modernizzazione
dell'accordo dell’unione doganale che lo lega ai Ventisette...Ankara ha subito
chiamato Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo dei capi di Stato e
di governo, anch'egli presente al viaggio, per informarsi sui motivi di questa
minacciosa e-mail, visto che la presidenza turca non ha capito assolutamente
come avrebbe maltrattato Von der Leyen. L'ex primo ministro belga ha dovuto
rassicurare i suoi interlocutori spiegando che si è trattato di uno sfortunato
malinteso...Perché Seibert ha avuto una tale esplosione di rabbia, che avrebbe
potuto portare a un incidente diplomatico mentre gli europei stanno cercando di
riallacciare i rapporti con questo partner difficile? La scena, che ha fatto il
giro dei social network, si è svolta martedì nel palazzo presidenziale del
presidente turco, all'inizio dell'incontro tra Recep Tayyip Erdogan, Mevlüt
Cavusoglu, il suo ministro degli Esteri, Charles Michel e Ursula von der Leyen.
I quattro entrano nell'enorme sala riunioni per accomodarsi, non attorno a un
tavolo, ma in modo più informale su poltrone e divani. Ma la scena appare, a
prima vista, scioccante: se Erdogan e Michel siedono su poltrone affiancate (a
distanza per via del Covid), Von der Leyen e Cavusoglu devono sedersi su divani
posti perpendicolarmente. Von der Leyen rimane in piedi, sbalordita, e non esita
a mostrare la sua sorpresa. Alla fine, va a sedersi con disappunto al centro
dell'enorme divano, lontano da Michel ed Erdogan. Insomma, la regia dà
l'impressione che Erdogan l'abbia consapevolmente maltrattata relegandola su un
divano come semplice segretaria. Da lì a fare il collegamento con il suo
disprezzo verso le donne (ha ritirato il suo Paese il 19 marzo dalla Convenzione
di Istanbul sulla violenza contro le donne), è stato un attimo: un passaggio che
hanno fatto in tanti, sia sui social che al Parlamento europeo. E nemmeno
Charles Michel è risparmiato: perché non ha reagito? Come sempre, attenzione
alle immagini. In realtà, i turchi non hanno assolutamente nulla a che fare con
questa “coreografia” che è frutto del protocollo dell'Unione Europea. Infatti si
tratta di un "accordo interistituzionale" del 1 marzo 2011 che prevede che il
presidente del Parlamento europeo venga prima, seguito dal presidente del
Consiglio europeo, dal presidente di turno del Consiglio dei ministri e, infine,
il presidente della Commissione. In altre parole, quando i presidenti del
Consiglio europeo e della Commissione sono in missione in paesi terzi, il primo
è ufficialmente il capo della delegazione, non il secondo. Insomma, non esiste
"una poltrona per due", contrariamente a quanto ha detto Eric Mamer, portavoce
della Commissione: «I presidenti delle due istituzioni hanno lo stesso grado
nel protocollo e spetta alle autorità turche, responsabile dell'incontro,
spiegare perché è stato offerto quel posto alla signora Von der Leyen». In
realtà spiega un diplomatico: «I turchi, che hanno una mente molto gerarchica,
hanno semplicemente applicato alla lettera l'ordine del protocollo europeo».
Soprattutto «non è chiaro quale sarebbe stato l'interesse di Erdogan di umiliare
il presidente della Commissione quando, come tedesca vicina ad Angela Merkel, è
la sua migliore alleata. Se avesse voluto trasmettere un messaggio, Michel,
considerato l’uomo di paglia della Francia, sarebbe stato più appropriato».
«Pensare che voleva umiliare una donna vuol dire conoscerlo male: ha dimostrato
di non avere problemi a trattare con le donne occidentali», ha aggiunto un suo
collega. Soprattutto «Erdogan è stato molto premuroso durante la visita - ha
detto un testimone - È nel suo interesse stringere la mano tesa dagli europei in
un momento in cui gli Stati Uniti non sono più pronti ad accettare il loro
espansionismo aggressivo, con la loro economia in declino e le difficoltà sulla
scena politica interna». Tuttavia, quando è entrato nella stanza, Charles
Michel, vecchio politico, ha visto che c'era un problema, soprattutto quando ha
notato la furia di che Ursula von der Leyen. Ma cosa poteva fare? Alzarsi e dare
la precedenza a Ursula von der Leyen? Chiedere una sedia aggiuntiva? Sarebbe
stato umiliante far capire ai turchi di aver commesso un errore quando tutto era
stato attentamente negoziato a monte...Da qui la reazione particolarmente
inopportuna di Seibert, il suo capo di gabinetto, che, senza alcun mandato, si è
permesso di minacciare un governo straniero per fargli piacere... Insomma, se ci
fosse stato uno scandalo, non avrebbe dovuto rivolgersi ad Ankara, ma a
Bruxelles. Sui giornali e sui social network di mezza Europa si sta parlando
molto dell’incidente diplomatico avvenuto lunedì ad Ankara, in Turchia, durante
un incontro ufficiale fra Unione Europea e governo turco. All’inizio
dell’incontro, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è
rimasta senza un posto dove sedersi, dato che le uniche due sedie disponibili
erano state occupate dal presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e dal
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Dell’incidente se ne sta parlando così
tanto per questioni oggetto di un ampio dibattito da tempo: per esempio lo
scarso riguardo nei confronti dei capi delle istituzioni europee da parte di
leader stranieri, il sessismo nei confronti delle leader donne, i rischi e le
difficoltà di avere a che fare con presidenti autoritari come Erdogan, e il
conflitto latente fra istituzioni dell’Unione Europea. Sul fatto che l’incidente
sia avvenuto davvero, e che non si sia trattato di uno spiacevole equivoco, non
ci sono dubbi. Nella stanza dove si è tenuto l’incontro non era stata
predisposta una sedia per von der Leyen, che si è dovuta sedere sul divano
lontano da Michel e Erdogan. «La presidente della Commissione è rimasta
chiaramente sorpresa, e lo si può vedere anche dal video», ha detto il portavoce
di von der Leyen, Eric Mamer, in una conferenza stampa tenuta martedì. Una fonte
europea del Wall Street Journal ha raccontato che Von der Leyen non era entrata
nella stanza prima dell’incontro con Erdogan, lasciando intendere che se se ne
fosse accorta avrebbe chiesto una sedia per sé. Von der Leyen si è invece seduta
di fronte a un altro divano su cui c’era il ministro degli Esteri turco, Mevlüt
Çavusoglu, che per protocollo diplomatico non siede sulla sedia dato il suo
ruolo meno importante rispetto a Erdogan. La versione più aggiornata del
trattato fondativo dell’Unione Europea prevede all’articolo 15 comma 6 che il
presidente del Consiglio Europeo, cioè Michel, «assicura la rappresentanza
esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza
comune»: cioè i due temi di cui Michel e Von der Leyen hanno discusso con
Erdogan. Anche una delle ultime versioni del protocollo ufficiale del Consiglio
dell’Unione Europea spiega che «fra le più alte cariche dell’Unione Europea,
nell’ambito della rappresentanza esterna», il presidente del Consiglio Europeo
precede il presidente della Commissione. Secondo la prassi in vigore, però,
nessuno dei leader nazionali tratta Von der Leyen come se la sua carica fosse di
grado inferiore rispetto a quella di Michel, a prescindere dal protocollo
ufficiale. Anche perché in termini di potere, se proprio bisogna fare un
confronto, Von der Leyen ne ha assai più di Michel: la prima dirige infatti
l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che conta quasi 33mila dipendenti e gode
di notevoli autonomie in vari ambiti; il secondo svolge quasi solo la funzione,
molto rilevante ma anche assai delimitata, di mediatore delle riunioni del
Consiglio Europeo, l’organo in cui siedono i 27 capi di stato e di governo
dell’Unione e che ne decide l’agenda politica. In tutti i più recenti incontri
con leader nazionali a cui Michel e Von der Leyen hanno partecipato insieme,
alla presidente della Commissione è stato riservato lo stesso trattamento di
Michel. In un caso, come durante la visita fatta nel marzo del 2020 al confine
fra Grecia e Turchia, a Von der Leyen è stato persino riservato un posto di
maggiore rilevanza rispetto a Michel, a fianco del primo ministro greco Kyriakos
Mitsotakis. Nelle ultime ore stanno emergendo delle foto scattate nel 2015
durante una riunione del G20 ad Adalia, in Turchia, in cui l’allora presidente
del Consiglio Europeo, Donald Tusk, e il presidente della Commissione Europea,
Jean-Claude Juncker, erano seduti ai lati di Erdogan, su poltrone identiche. Per
molti osservatori l’incidente diplomatico è stato un sintomo del sessismo che le
leader donne subiscono da sempre a tutti i livelli della politica, anche ai più
alti. Del resto Erdogan aveva spesso fatto già in passato commenti
discriminatori e offensivi nei confronti delle donne, come quando nel 2016 disse
che le considerava «prima di tutto delle madri». Di recente il suo governo ha
annunciato il ritiro dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
mentre diverse inchieste hanno mostrato come negli ultimi anni la libertà delle
donne turche sia progressivamente peggiorata. Alcuni politici e commentatori
europei hanno sostenuto però che anche Michel avrebbe potuto prendere una
posizione più netta, e rifiutarsi di partecipare all’incontro oppure cedere la
sua sedia a Von der Leyen. «Perché è rimasto zitto?», si è chiesta su Twitter la
parlamentare europea Sophie in ‘t Veld, olandese e appartenente al gruppo dei
Liberali. «Da Erdogan non ci aspetta niente di diverso, ma fa amarezza il fatto
che il presidente del Consiglio Europeo sia sceso al suo livello», ha commentato
l’ex cancelliere austriaco Christian Kern. A Bruxelles esiste da tempo un
movimento piuttosto sotterraneo che segnala episodi di sessismo all’interno
delle istituzioni: uno dei più attivi è MeTOOEP, che lavora al Parlamento
Europeo e oltre a fare pressione per ottenere una piena parità di genere nelle
istituzioni raccoglie testimonianze di molestie e violenze subite dalle donne.
Altri hanno segnalato che non è la prima volta che rappresentanti delle
istituzioni europee fanno figure del genere durante delicate visite
diplomatiche. «È la seconda volta in due mesi che avvengono imbarazzanti
incidenti diplomatici con vicini problematici», ha fatto notare la giornalista
di affari europei Beatriz Ríos, citando la recente e fallimentare visita
dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, in Russia. Secondo
alcuni, quello che è successo è la dimostrazione che l’Unione Europea non abbia
l’autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera
indipendente. «Il passo falso del divano è una perfetta allegoria della politica
estera europea», ha scritto Roman Pable, esperto di relazioni internazionali e
consulente politico del gruppo dei Liberali al Parlamento Europeo: «sul piano
internazionale veniamo trattati senza alcun rispetto, ma invece che discutere
del perché succede ci mostriamo indignati senza cambiare niente di sostanziale,
ma restando in pace con noi stessi». Altri invece ne parlano come di un errore
strategico. «Se l’Unione Europea deve impegnarsi in rischiosi passaggi
diplomatici, non dovrebbe mandare Von der Leyen e Michel insieme», ha commentato
su Twitter Alexander Clarkson, ricercatore di studi europei per il King’s
College di Londra: «mandare due importanti istituzioni europee offre più margine
a una figura autoritaria per giocare col protocollo, e dare una simbolica
dimostrazione di forza. Questi sono i punti su cui il Servizio europeo per
l’azione esterna [il servizio dell’Unione Europea per gli affari esteri]
dovrebbe alzare il proprio livello». Clarkson ha lasciato intendere, insomma,
che la responsabilità dell’incidente non sia stata di Michel, quanto dei
funzionari che avevano preparato l’incontro. Infine, la gestione dell’incidente
ha anche dimostrato un certo disallineamento fra due importanti istituzioni
europee come il Consiglio e la Commissione. Gli uffici della comunicazione delle
due istituzioni non hanno concordato una risposta condivisa, e anzi si sono dati
reciprocamente la colpa per l’incidente diplomatico. La Commissione ha fatto
commentare l’incidente a Mamer, che fra le altre cose ha sottolineato come i
sopralluoghi degli incontri siano stati eseguiti dallo staff del Consiglio
Europeo; il Consiglio Europeo invece non ha commentato pubblicamente
l’incidente, ma parlando informalmente con Politico ha fatto sapere che dal
proprio punto di vista il protocollo è stato rispettato, dato che Michel era la
carica europea più alta presente durante l’incontro.
(ANSA il 9 aprile 2021) - I presidenti del
Consiglio e della Commissione europea, Charles Michel e Ursula Von der Leyen,
non si sono ancora parlati, a tre giorni dal sofagate di Ankara. Per il momento
non sono previste telefonate, secondo quanto si apprende a Bruxelles. Ieri in
un'intervista alla tv belga LN, Michel aveva detto di aver provato a raggiungere
von der Leyen al telefono, e pensava di riuscire a parlarci in serata.
Francesca Sforza per “La Stampa” il 9 aprile 2021.
Non c' era diplomatico europeo, nella giornata di ieri, che non avesse al suo
attivo, nella memoria, almeno un aneddoto relativo all' arte antica, complicata
e sottile del cerimoniale: bicchieri rimossi all' ultimo momento, placement
corretti pochi minuti prima dell' impiattamento, macchine da incarrozzare in un
modo o nell' altro durante i cortei di accoglienza, istruzioni dettagliate negli
allineamenti delle receiving line. Per questo, mai come in questa occasione il
«Non è come pensi» dichiarato dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel a
giustificazione di quanto accaduto mercoledì ad Ankara - con la presidente della
Commissione Ursula von der Leyen costretta a sedersi su un sofà in mancanza di
una sedia accanto al presidente turco Erdogan e a Michel medesimo - ha ricordato
il genere più patetico delle giustificazioni possibili. «Alcune delle immagini
che sono state trasmesse - ha scritto Michel in un post su Fb nella sera di
mercoledì - hanno dato l' impressione che potessi essere insensibile alla
situazione che si era prodotta: niente di più lontano dalla realtà o dai miei
sentimenti profondi». Non una scusa, dunque, né un' ammissione di leggerezza -
volendo essere particolarmente benevolenti con se stessi - ma l' ultimo degli
errori di una gran brutta giornata del suo mandato: il rinvio di responsabilità
al protocollo turco, alle sue regole, e «all' interpretazione rigorosa che ne è
stata data». La considerazione per cui «Non mi sono alzato in piedi per non
creare un incidente ancor più grave», diciamolo, non fa che peggiorare le cose.
A quel punto i turchi, che fino ad allora avevano preferito tacere, sono stati
costretti a replicare, e lo hanno fatto con le parole del ministro degli Esteri
Cavusoglu, numero due del governo, e seduto durante l' incontro con Erdogan nel
sofà di fronte a Von der Leyen. «Arrivano accuse estremamente ingiuste contro la
Turchia ha detto da una conferenza stampa in Kuwait. La Turchia è uno Stato
dalle radici profonde che non accoglie un ospite per la prima volta, così come
non è la prima volta che viene effettuata una visita in Turchia». Senza
risparmiare dettagli, Cavusoglu ha ricordato che non esiste un protocollo turco
a sé stante per le visite di leader stranieri, ma c' è sempre un coordinamento
tra le regole internazionali e l' ospitalità nazionale. «E anche stavolta si è
agito così». Come funziona in pratica? Prima di ogni visita, le diverse
delegazioni del cerimoniale, composte da funzionari diplomatici, si incontrano
per definire i dettagli della visita. Discussioni apparentemente di lana caprina
su posti a sedere, menu, vini o non vini da servire, cose o non cose da
indossare sono in realtà fili sottilissimi a cui sono appese intere carriere.
«Nel protocollo implementato nella riunione su scala ristretta tenutasi presso
l' ufficio del nostro Presidente - ha rivelato il ministro turco Cavusoglu - le
richieste della parte dell' UE sono state soddisfatte». Stando a una nota del
Consiglio Europeo ai diplomatici non è stato permesso di visitare in anticipo la
sala dell' incontro poiché troppo vicina agli uffici di Erdogan. Lo stesso è
avvenuto per la sala da pranzo, che però è stata vista qualche minuto prima, e
si è provveduto ad aggiungere una sedia, anche lì, mancante. Come non farsi
venire il sospetto - vista la sala da pranzo - che lo stesso sarebbe accaduto
per la sala dell' incontro? La sedia per Von der Leyen, è chiaro, non era stata
prevista dai turchi, ma senz' altro non è stata richiesta dagli europei. Se così
fosse stato, «la richiesta sarebbe stata soddisfatta». Si può forse rimproverare
ai turchi di non aver informato il cerimoniale Ue dell' assenza di una terza
sedia per la presidente? «Protocol is politics», ha twittato ieri al proposito
Wolfgang Ischinger, capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ricordando
un vecchio adagio al suo collega, l' ex ambasciatore tedesco Nikolaus
Meyer-Landrut, che ha guidato la delegazione Ue ad Ankara e che appare come il
maggiore indiziato del pasticcio «Sofà-Gate». Il protocollo è politica, non tè e
pasticcini.
Emma Bonino per “la Stampa” il 9 aprile 2021.
Appurato che l'incidente diplomatico di Ankara non ha nulla a che vedere con la
mancanza di sedie e tantomeno con il galateo, proviamo a rimettere in fila i
fatti a partire dall' ultimo in ordine di tempo: la versione della Turchia, che
si è chiamata fuori e ha attribuito l'errore ai responsabili del cerimoniale
europeo, non è stata smentita. Tanto per cominciare ci sono le ambizioni
incrociate delle tre principali istituzioni europee. Per quanto si lavori
insieme, la rivalità tra il Consiglio Europeo, la Commissione e il Parlamento è
vecchia quanto l' UE. Altrettando nota è la competizione personale tra Charles
Michel e Ursula von der Leyen, una corsa a primeggiare che era meno evidente in
altri tempi, come quando nel 2015 Donald Tusk e Jean-Claude Junker trovarono ad
Ankara una sedia per ciascuno. La seconda questione riguarda la Von der Leyen,
che stavolta viaggiava senza consiglieri diplomatici e aveva affidato il
protocollo all' ufficio di Michel e ai turchi. Mi sembra evidente che ci sia un
vulnus e che certe missioni andrebbero preparate con maggiore attenzione anche
ai dettagli per prevenire potenziali insidie, soprattutto nelle capitali con le
quali i rapporti non sono esattamente amichevoli. Ma l' aspetto più importante
riguarda i dossier di cui i rappresentanti europei avrebbero dovuto discutere
con la controparte, il presidente Recep Tayyip Erdogan, "il dittatore" di cui si
ha bisogno, come ha scandito il premier Mario Draghi con la sua capacità di
parlare chiaro. Nessuno lo aveva espresso così chiaramente prima di lui, a parte
me, ovviamente, che a differenza di Draghi non faccio testo. Attenzione, perché
il problema alla fine è tutto lì, il dilemma quotidiano tra diritti umani e
interdipendenze, connessioni economico-strategiche, posti di lavoro. Dicevamo
però dei dossier. Basta rileggersi le ultime pagine sulla Turchia del documento
finale dell' ultimo vertice dei capi di stato e di governo per aver un' idea
della posta in gioco: si cita il contenimento dei migranti finanziato da un
fondo ad hoc annuale, che deve essere rinnovato anche dal parlamento europeo,
c'è poi la partita dell' update dell' unione doganale vecchia e da sempre
imperfetta e c'è infine una parte sulle trivellazioni a Cipro. Non a caso
neppure una parola sul ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Ne
hanno parlato durante l'incontro di mercoledì? Immagino di sì. Sarebbe
interessante sapere allora con quale esito dal momento che i due dossier più
importanti di cui avevano mandato devono passare dal Parlamento di Strasburgo.
La Turchia fa la Turchia. E siamo comunque davanti ad uno sgarbo politico
evidente, di mancato riconoscimento dell' Europa. Charles Michel dal canto suo
avrebbe potuto muoversi diversamente, per esempio lasciare la sua poltrona alla
presidente Ursula von der Leyen, gesto inequivoco di coesione istituzionale
europea. Invocarne oggi le dimissioni mi sembra una richiesta esagerata ma in
questo caso, a conti fatti, chi ne esce con le ossa rotte sono le istituzioni
europee. E non è la prima volta. Ricordate alcune settimane fa la visita dell'
Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell a Mosca, quando
sotto i suoi occhi furono espulsi dei funzionari europei? Appunto.
Caso Von der Leyen, le magistrate
italiane accanto ad Ursula: "Atto discriminatorio".
Liana Milella su La Repubblica l'8 aprile 2021. Le giuriste del nostro Paese
protestano per il sofa-gate: "Calpestata nuovamente la dignità delle donne".
Anche le donne magistrate italiane - oltre la metà di tutti i giudici del nostro
Paese - protestano per il sofa-gate. Per Ursula von der Leyen marginalizzata sul
divano turco anziché nel posto che le spetta. Nell'indifferenza e nel complice
silenzio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Calpestata
nuovamente la dignità delle donne". "Scorrettezza istituzionale". "Atto
palesemente discriminatorio". "Segnale di allontanamento dai valori della Carta
dell'Unione europea dei diritti dell'uomo". E quindi "ferma condanna" di un
episodio che - secondo le toghe rosa italiane - dimostra come sia in atto "un
arretramento nel percorso di uguaglianza di cui proprio Ursula può ritenersi un
simbolo". È una nota durissima quella che l'Admi, l'Associazione donne
magistrato italiane, con la sua presidente Isabella Ginefra, aggiunge alle
migliaia di proteste di queste ore. Un episodio di cui le giuriste del nostro
Paese mettono in luce il chiaro intento "discriminatorio", il pessimo segnale
contro il cammino di parità delle donne nel mondo.
Il rammarico dopo il caso di Ankara. Von
der Leyen sul Sofagate: “Mi sono sentita sola come Presidente, donna ed
europea”. Antonio Lamorte su Il Riformista il 13
Aprile 2021. Ursula von der Leyen ad Ankara ha provato imbarazzo. Anzi di più:
si è sentita sola, come “presidente”, come “donna”, come “europea”. Queste le
parole della Presidente della Commissione oggi alla Conferenza dei presidente
del Parlamento Europeo. Il riferimento all’incidente, al caso cosiddetto del
“sofagate“, ovvero di quello che è successo martedì scorso nella capitale turca,
quando il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente del Consiglio
Europeo Charles Michel si sono accomodati sulle sedie lasciando la Presidente
sul divano. Le parole di von der Leyen apprese dall’AdnKronos. Michel si sarebbe
invece cosparso il capo di cenere: si è difeso e si è scusato ripetutamente. Ha
espresso rammarico, ha definito il caso un’offesa a tutte le donne, riporta
l’Ansa. Un errore, secondo l’ex premier belga, che il servizio di protocollo del
Consiglio non abbia avuto accesso alla sala riunioni con Erdogan. Da questo
momento le missioni dovranno essere preparate congiuntamente da Commissione e
Consiglio, ha aggiunto. Per von der Leyen il caso resta legato alla questione di
genere, da legare a doppio filo al ritiro della Turchia dalla Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne. La Presidente ha fatto riferimento agli
articoli 15 e 17 del Trattato dell’Unione Europea (Tue), che attribuiscono pari
dignità a Commissione e Consiglio. In una frazione di secondo ha deciso di
restare, ha raccontato. Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha
sottolineato che la vicenda deve insegnare alle istituzioni Europee a “procedere
insieme”. Critici gli interventi dei presidenti dei gruppi. Impegno solenne a
procedere insieme da parte di Michel e von der Leyen. Il Sofagate non si chiude
quindi. In Italia ha avuto un lungo strascico dopo che il Presidente del
Consiglio Mario Draghi, interpellato sulla vicenda in conferenza stampa, ha
definito Erdogan un “dittatore”.
Da tg24.sky.it il 2 maggio 2021. A quasi venti
giorni di distanza non si placano le polemiche per il Sofagate che ha coinvolto
la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante la visita
ad Ankara al presidente turco Recep Tayip Erdogan. A tornare sull'argomento, il
26 aprile, è stato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, anche lui
presente al summit. "Ho espresso diverse volte il mio rammarico per la
situazione che si è venuta a creare nel viaggio ad Ankara. Le nostre squadre non
hanno potuto avere accesso alla sala. Insieme alla Commissione ci siamo
impegnati perché non accada più in futuro - ha detto Michel intervenendo al
parlamento europeo al dibattito sulla Turchia (VIDEO) - in quell'istante avevo
deciso di non reagire ulteriormente per non creare un incidente politico che
avrebbe rovinato mesi di preparativi e sforzi politici e diplomatici", ha
aggiunto Michel. "Sono la prima donna a esser presidente della Commissione
europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia,
come una presidente della commissione - ha detto poco dopo invece Von der Leyen
(VIDEO) -. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello
che è successo è accaduto perché sono una donna". E ancora: "Mi sono sentita
ferita come donna e come europea - ha aggiunto - questo riguarda i valori che
sono alla base della nostra Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora fare perché
le donne siano trattate con parità".
Perché Erdogan umilia l’Europa. Draghi lo
infilza: è un dittatore. La Turchia non ha nessuna
intenzione di cedere su almeno quattro dossier: i profughi, le frontiere
marittime del Mediterraneo orientale, la Libia e i diritti umani. Il tutto è
funzionale a uno scopo: mostrare che l’Unione europea è ostile agli interessi
del Paese e causa della crisi economica devastante. Alberto Negri su Il
Quotidiano del Sud il 9 aprile 2021. «Sono dispiaciutissimo per l’umiliazione
inflitta alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Erdogan
è un dittatore, di cui però si ha bisogno» Il presidente del consiglio Mario
Draghi è molto netto nel condannare il “sofà-gate” di Ankara. ma la pantomima di
poltrone e sofà sta oscurando il vero problema. La Turchia non ha nessuna
intenzione di cedere su almeno quattro dossier: i profughi, le frontiere
marittime del Mediterraneo orientale, la Libia e i diritti umani. Il tutto è
funzionale a uno scopo: mostrare che l’Unione europea è ostile agli interessi
della Turchia e che è una delle cause della crisi economica spaventosa che sta
attraversando il Paese. Un crisi dovuta alla politica economica spericolata di
Erdogan che coinvolge l’Europa in pieno visto che il 50% del commercio estero di
Ankara è con l’Unione, così come sono europei una buona parte dei prestiti in
sofferenza alle imprese e ai soggetti turchi. La storia della sedia della
presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen e del belga Charles Michel,
capo assai inadeguato del Consiglio europeo, è uno degli scherzetti che ama
giocare Erdogan ai suoi ospiti più sprovveduti, che ovviamente ci sono cascati
in pieno. Erdogan, che tiene in galera migliaia di persone, gli oppositori
politici e nega i diritti umani e quelli delle donne, vuol far capire che a casa
sua fa quello che vuole. Ma ha una nozione di casa parecchio “allargata”, che si
estende a buona parte del Mediterraneo. L’Unione europea come è noto paga
profumatamente Erdogan (sei miliardi di euro) per tenersi in casa oltre tre
milioni di profughi siriani e di altre nazionalità ma non ha nessuna intenzione
di rinunciare all’arma dei rifugiati per tenere sotto pressione Bruxelles sulla
rotta dell’Egeo e dei Balcani, valvola di sfogo tanto temuta dalla Germania
della cancelliera Merkel ormai sul viale di un rapido tramonto visto che si
ritirerà con le elezioni politiche di settembre. Quindi il “reis” turco
continuerà a dare rassicurazioni a parole, a incassare i quattrini europei ma
anche a fare quello che vuole nel momento in cui i suoi interessi e quelli di
Ankara venissero minacciati. Le frontiere marittime sono un altro contenzioso
bollente. La Turchia non accetta le frontiere marittime internazionali e più
volte ha inviato in maniera provocatoria le sue navi da esplorazione nelle acque
ritenute da Grecia e Cipro “zone esclusive di sfruttamento”. In queste zone
offshore operano i francesi con la Total, l’Eni italiana e anche le società
americane. Per difendere lo stato attuale delle cose si è formata una coalizione
capeggiata dalla Francia con Grecia, Cipro, Israele ed Egitto che intende
contrastare le ambizioni della Turchia. In queste acque dovrebbe passare il
gasdotto verso l’Europa con le risorse energetiche del Mediterraneo orientale
che renderebbe meno decisive le pipeline che trasportano il gas russo in Turchia
e nei Balcani. L’Europa ha sanzionato la Turchia ma si tratta di misure
cosmetiche perché la Germania intende trattare con Ankara in quanto teme il
ricatto sui profughi. Anche l’Italia è possibilista ma per un’altra ragione: in
Tripolitania la Turchia è la potenza militare dominante, sono stati i turchi a
salvare la capitale dall’assedio di Haftar e gli italiani dipendono per la loro
sicurezza dalle milizie turche e filo-turche. Anche l’ambasciata italiana
visitata l’altro giorno dal premier Draghi. Erdogan ci ricatta su quasi tutto
perché siamo fessi e codardi. Nel novembre del 2019, con il generale Khalifa
Haftar alle porte di Tripoli, il governo libico chiese aiuto militare a Italia,
Usa e Gran Bretagna per fermarlo: era una questione di vita o di morte. Noi
questo aiuto lo abbiamo rifiutato e i libici si sono rivolti a Erdogan per
contrastare il generale Khalifa Haftar sostenuto dai mercenari russi, dagli
Emirati e dall’Egitto. Quindi la Turchia ha mandato uomini, droni e persino le
milizie jihadiste reclutate in Siria riportando una netta vittoria militare. Che
ci piacciano o meno le cose stanno così e le chiacchiere della nostra diplomazia
e dei nostri governi stanno a zero. Questo è il secondo grave errore che abbiamo
commesso in Libia in un decennio, il primo fu quello di bombardare Gheddafi nel
2011: allora sì avremmo dovuto restare neutrali visto che lo avevamo ricevuto in
pompa magna soltanto sei mesi prima a Roma firmando oltre ad accordi economici
intese sulla reciproca sicurezza. Insomma un’alleanza in piena regola e votata
dal 90% del Parlamento. Che cosa succede adesso? Gli Stati Uniti hanno aperto un
nuovo fronte di guerra fredda con la Russia anche in Libia dove Mosca potrebbe
insediare una base militare in Cirenaica. Quindi gli Usa hanno chiesto ai leader
europei di darsi da fare per sostenere il governo di Tripoli: è questo il vero
motivo geopolitico per cui l’atlantista Draghi, su richiesta e con il pieno
appoggio di Washington, è andato in Libia dove ha incontrato tra l’altro il
premier greco Mitsotakis. In un solo giorno a Tripoli c’erano due primi ministri
europei: un messaggio chiaro rivolto a Mosca ma anche a Erdogan che è l’uomo
forte della situazione. Anche la Turchia è nella Nato, anche la Turchia si
confronta con la Russia in Siria e in Azerbaijan oltre che in Libia, ma Erdogan
e Putin si mettono d’accordo quando vogliono come hanno già dimostrato, una cosa
che fa saltare la mosca al naso a Biden e al suo segretario di stato Blinken che
ai tempi dell’amministrazione Obama sostenne la caduta di Gheddafi e ora
vorrebbe cacciare la Russia dalla Cirenaica. Ecco perché Erdogan tratta a pedate
i rappresentanti europei e li umilia, visto tra l’altro che Francia e Germania
non hanno mai voluto la Turchia dentro l’Unione. Il suo punto di vista è questo:
lui rischia i suoi soldati in Siria e in Libia e adesso gli europei e gli
americani vorrebbero che se ne andasse da Tripoli lasciando che fossero gli
altri a godere i frutti politici ed economici della situazione? Non se ne parla
proprio: e infatti nessuno ritirerà le truppe, né i turchi né i russi, tutti
attestati su una linea del cessate il fuoco che l’Unione europea vorrebbe
monitorare con un suo contingente allargando così i compiti della missione Irini
per l’embargo navale sulle armi. Si capisce bene allora che una sedia non è solo
una questione di arredamento diplomatico ma rappresenta cosa si muove davvero
dietro la pace e la guerra nel Mediterraneo: una spasmodica lotta di potenze.
Da repubblica.it il 14 aprile 2021. La
dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale
maleducazione, una totale mancanza di tatto". Lo ha detto il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan, citato da Anadolu, replicando al premier Mario Draghi, che
una settimana fa lo aveva definito "dittatore". Finora Erdogan non aveva
risposto direttamente al premier italiano. A intervenire erano stati vari
esponenti del governo turco più i media ufficiali. Erdogan lo ha detto parlando
in occasione di un evento alla Biblioteca nazionale presidenziale turca. Le
dichiarazioni di Draghi hanno suscitato reazioni di indignazione da parte di
diversi esponenti della classe politica e delle autorità turche. Il leader
ultraconservatore Devlet Bahceli, del partito del Movimento nazionalista (Mhp),
principale partner di coalizione di Erdogan, ha detto ieri ai membri del suo
gruppo parlamentare che le dichiarazioni di Draghi rivelano "un'ammirazione
segreta per Mussolini".
Draghi. Sui giornali governativi:
"Mussolini dittatore". Ma la gente sui social: "Finalmente qualcuno dice la
verità". Marco Ansaldo su La Repubblica il 9 aprile
2021. La stampa riporta le parole "scioccanti" del primo ministro italiano
contro il presidente turco dopo lo sgarbo del sofa-gate a Ursula von der Leyen.
Gli anti-Erdogan: "Una voce libera: l'Italia". I Lupi grigi soffiano sul fuoco
contro Roma. I curdi con Palazzo Chigi. “Italia mafia”. “Mussolini dittatore”.
“Dura reazione di Ankara a Draghi”. Però anche: “Il premier italiano ha detto
quello che tutti, anche qui, pensano e non possono dire”. La Turchia si è
svegliata oggi con una nuova crisi, e c’è purtroppo abituata. Da quasi vent’anni
il Paese è stressato dai contenziosi causati dal suo leader, e non passa giorno
senza un nuovo fronte aperto.
Questa mattina è il momento dell’Italia. E i
giornali e i siti online, al 95 per cento filo governativi, riportano le parole
“scioccanti”, come si legge, del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi,
“un premier di ripiego”, commenta l’osservante quotidiano Yeni Safak. Le
reazioni istituzionali e governative non si sono fatte attendere. I
collaboratori principali del capo dello Stato, Recep Tayyip Erdogan, hanno fatto
scudo attorno al loro presidente puntando su un approccio difficilmente
smontabile: in Turchia si svolgono regolari elezioni e i nostri rappresentanti
vengono eletti democraticamente. Ma un conto è quanto dice la casta al potere,
fra istituzioni e media. Un alto discorso è la pancia del Paese. E allora, se si
vanno a vedere i social, quelli almeno non ancora silenziati finora (molti lo
sono già, ma i turchi sono un popolo molto creativo e hanno trovati sistemi
alternativi per comunicare in rete), danno il polso di quello che emerge oltre i
comunicati ufficiali. Gli utenti si sbizzarriscono allora nell’applaudire “il
premier italiano che finalmente ha detto la verità”. E quindi: “Bravo Draghi”.
“Qualcuno in Europa si accorge della realtà di quel che avviene in Turchia”.
“Una voce libera: l’Italia”. “Draghi coraggioso”. E, anche, qualche preoccupato
“Adesso Turchia e Italia sono in guerra”. C’è così chi si spinge a ricordare i
tempi, poco più di vent’anni fa, del confronto aspro sul caso Ocalan. Quando tra
il 1998 e il 1999 il leader e fondatore curdo del Pkk (Partito dei lavoratori
del Kurdistan), estromesso dalla Siria dove si era rifugiato nella guerra
combattuta contro l’esercito turco in Anatolia, scelse di andare a Roma dove si
era appena formato il governo rosso-verde di Massimo D’Alema. “Apo” allora era
descritto nei giornali di Istanbul come “il killer dei bambini”, così dovevano
scrivere i giornalisti ogni volta che lo nominavano. E in ogni caso era il
“nemico numero uno” di Ankara. Ne nacque una crisi con Roma che portò alla quasi
rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi, a una difficilissima
ricucitura, a una partita di Champions League fra Galatasaray e Juventus
blindata da decine di migliaia di forze di polizia a Istanbul con Giovanna
Melandri e Piero Fassino come ambasciatori, e le aziende italiane che non
vendevano più una sola ruota di gomme (la Pirelli, ad esempio, per bocca del suo
rappresentante). Oggi si rischia uno scenario simile, se le scuse italiane non
arriveranno prontamente per bocca di Draghi o dell’ambasciatore ufficiale ad
Ankara, Massimo Gaiani, subito convocato nella stessa serata al ministero degli
Esteri turco. Difficile però che l’Italia, adesso apprezzata anche in Europa per
le parole “franche” espresse dal suo presidente del Consiglio, le ritiri. Le
istituzioni comunitarie devono trovare unità, dopo il sofa-gate di Ankara che ha
indignato tutto il mondo, e il litigio formidabile tra Ursula von der Leyen e
Charles Michel appena usciti dalla stanza di Erdogan, facendo ritardare
vistosamente la conferenza stampa successiva prevista. Occorrerà però trovare
una soluzione anche interna, a Roma, visto che il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, è rimasto sorpreso dalle parole del premier, mai concordate con la
Farnesina. Un altro fronte turco è quello dell’opposizione, composta dunque dai
repubblicani del Chp e dai filo curdi dell’Hdp, mentre il Partito di azione
nazionalista Mhp (composto dalle frange di Lupi grigi pronti a ricordare tra
poche settimane il 40° anniversario dell’attentato al Papa) è allineato sulle
posizioni di Erdogan, e lo spinge anzi a dichiarazioni più aspre. I repubblicani
non hanno al momento espresso posizioni: osservatori turchi rilevano che lo
shock dovuto alla recente fine del processo ai golpisti con decine di ergastoli
comminati, e al fermo di dieci ammiragli dichiaratisi contrari al progetto
faraonico di Kanal Istanbul (un secondo Bosforo), è forte, e il partito non
reagisce avendo altri pensieri, pandemia inclusa e la Turchia è molto
preoccupata in proposito. Plausi invece si raccolgono fra i curdi. I due
co-leader, un uomo e una donna, come da tradizione curda, del Partito
democratico dei popoli, Pervin Buldan e Mithat Sancar, guardano con attenzione e
interesse agli sviluppi internazionali. La loro formazione rischia la chiusura,
così sta progettando Erdogan che ne teme la forza propulsiva alle elezioni, e un
forte impegno anche all’estero può aiutare un movimento che rigetta con forza le
accuse di terrorismo e si dichiara pienamente coinvolto nelle istituzioni
democratiche. Anche tra i curdi, ora, Draghi è il benvenuto.
Erdogan risponde a Draghi: "Totale
maleducazione, colpite le relazioni tra Italia e Turchia".
Marco Ansaldo su La Repubblica il 14 aprile 2021. Il presidente
turco ha atteso giorni prima di replicare al premier italiano, che lo aveva
definito "dittatore". ERDOGAN “dittatore”? Le scuse dall’Italia alla Turchia non
sono ancora arrivate. Sono passati giorni, ma Roma non ha risposto all’invito di
“ritrattazione” fatto da Ankara all’ambasciatore italiano Massimo Gaiani che se
ne è fatto latore con il governo. E allora ecco che la rabbia del presidente
turco si abbatte direttamente su chi ha espresso quelle parole: Mario Draghi.
Draghi: "Dispiace moltissimo per l'umiliazione
subita da Ursula Von der Leyen. Erdogan è un dittatore". “Le dichiarazioni del
primo ministro italiano sono di una totale indecenza e maleducazione”. Erdogan
non usa mezzi termini. E’ assertivo e determinato tanto nelle azioni, quanto
nelle affermazioni: “Le sue parole hanno colpito come un’ascia le relazioni fra
Italia e Turchia, che erano arrivate a un livello molto buono fino a quando il
signor Draghi non ha parlato in questo modo”, dice. I suoi sottoposti, che
spesso ne misurano la durezza e lo guardano con grande timore reverenziale, lo
sanno benissimo. Erdogan è esplosivo nei sui scoppi di ira. Così il capo dello
Stato turco, dopo alcuni giorni di attesa, è infine intervenuto sulla “questione
italiana”, come ormai la definiscono in Turchia. Parlando a un evento tenuto in
una biblioteca di Ankara, si è riferito direttamente al caso delle parole
pronunciate giovedì scorso da Draghi durante una conferenza stampa a Palazzo
Chigi. "Vi dico di non dare alcuna importanza a quali parole utilizza o non
utilizza il presidente del Consiglio italiano. Questo signore di nome Draghi,
rilasciando questa dichiarazione, ha purtroppo colpito i nostri rapporti. Noi,
grazie alla forza che ci ha conferito il popolo, avendo preso in consegna questa
volontà popolare, continueremo il nostro percorso al servizio della Nazione".
L’uomo definito da tutti il Sultano per le mire espansionistiche che rimandano
all’Impero ottomano ha poi argomentato sulla vicenda, usando per sé la terza
persona singolare e per Draghi è passato direttamente al tu: “Prima di dire una
cosa del genere a Tayyip Erdogan devi conoscere la tua storia. Ma abbiamo visto
che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta”. Chiaro il
riferimento a Benito Mussolini, evocato nei giorni scorsi dalla stampa
filogovernativa di Ankara che ha ricordato all’Italia il proprio passato,
rivendicando le molte elezioni in cui, dal 2002 a oggi, il leader turco è stato
eletto, vincendo spesso con largo margine, forte di un consenso ampio ottenuto
soprattutto in Anatolia, più che sulla costa, saldamente repubblicana. Erdogan
ha anche parlato di “totale impertinenza” delle affermazioni del presidente del
Consiglio italiano. I media turchi hanno subito riportato come “Draghi abbia
purtroppo danneggiato” lo sviluppo delle “relazioni Italia-Turchia”. E ora,
dunque, aspettiamo che cosa accadrà sul fronte diplomatico e economico fra
Ankara e Roma.
Ilario Lombardo per "la Stampa" il 15 aprile 2021.
Chi frequenta il mondo della diplomazia e conosce i turchi diceva: non
lasceranno cadere l' offesa. E così è stato. Il presidente turco Recep Tayyip
Erdogan ha aspettato una settimana, per dare modo a Mario Draghi se non di
scusarsi, almeno di correggere il tiro dopo averlo definito «un dittatore con
cui dobbiamo avere a che fare». Una frase pronunciata a commento dell'
umiliazione subita dalla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen,
costretta a sedere su un divano mentre il presidente del Consiglio europeo
Charles Michel si accomodava su una sedia accanto al presidente turco. A nulla è
servito il gesto di convocare l' ambasciatore italiano ad Ankara Massimo Gaiani
e l' esplicita richiesta di una marcia indietro. Draghi è rimasto in silenzio,
con grande imbarazzo della diplomazia italiana poco abituata a questi affondi
ruvidi e attentissima a calibrare le parole, soppesandole sulla bilancia dei
rapporti economici e politici. Passata una settimana senza nemmeno un segnale di
riavvicinamento Erdogan ha risposto. E lo ha fatto a suo modo, lasciando
trapelare attraverso le agenzie ufficiali un incontro con i giovani in una
biblioteca di Ankara: «Quello che ha fatto - ha detto a commento delle parole
del capo del governo italiano - è una totale mancanza di tatto, una totale
scortesia e maleducazione. Con queste osservazioni ha minato come un' ascia lo
sviluppo delle relazioni Turchia-Italia. Lui è stato nominato, non è stato
neanche eletto, prima di parlare in questi termini tenga a mente la propria
storia». Un affondo che rilancia la difesa indignata che ha animato l' opinione
pubblica turca in questi giorni, secondo la quale il Paese di Benito Mussolini
non potrebbe dare lezioni a un presidente eletto democraticamente e che per
questo motivo non può essere definito «dittatore». Non è però solo una sottile
questione di lessico se pure nei più alti ambienti diplomatici l' argomento fa
breccia. Il primo a spiegarlo a Draghi è stato il suo consigliere diplomatico
Luigi Mattiolo, a caldo, subito dopo la dichiarazione del presidente del
Consiglio. Fonti di governo raccontano alla Stampa che subito dopo la conferenza
stampa di Draghi, alla presenza di altri membri dello staff, Mattiolo ha
spiegato al capo del governo che la sua uscita avrebbe potuto generare «gravi
conseguenze»: «Non può essere definito un dittatore, dobbiamo rettificare in
qualche modo». Ex ambasciatore italiano ad Ankara, Mattiolo conosce gli spiriti
turchi ma il suo consiglio è stato subito respinto da Draghi: «Io non rettifico
nulla». Questa la posizione e questa resta. Anche una settimana dopo. È il suo
modo di parlare, dicono a Palazzo Chigi, «franco e diretto». Nessun retroscena,
aggiungono: non ha voluto lanciare un avvertimento al presidente turco sulla
Libia, dove si scontrano gli interessi di Roma e di Ankara. E confermano: «Non
replicherà alle parole di Erdogan». Lo fanno le forze di maggioranza e di
opposizione che da destra a sinistra si scagliano contro il Sultano, mentre gli
ambasciatori Gaiani e Mattiolo sono a lavoro per ricucire la lacerazione che è
già costata all' Italia l' importante commessa di quattro elicotteri destinati
dalla Leonardo ad Ankara. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, si
starebbe puntando a organizzare un faccia a faccia pacificatore, anche se il
clima rovente di queste ore rende impossibile prevederlo a breve. Ma la Turchia
è un tassello troppo importante per gli interessi italiani (quasi 20 miliardi di
scambi commerciali). Alla Farnesina, lontano da ogni tipo di riflettore, si
fatica a trovare una parola diversa da «gaffe» per definire la dichiarazione di
Draghi e una fonte spiega che ormai tutto si gioca sull'«autorevolezza del
presidente del Consiglio, che può spingere l' Europa a seguire questa linea di
franchezza nei rapporti», facendo dimenticare a poco a poco quanto successo.
Erdogan e il sofa-gate: diplomazia al
lavoro con la Turchia. Ma la linea di Draghi non cambia.
Tommaso Ciriaco su La Repubblica il 9 aprile 2021. Il premier
deciso a giocare un ruolo di testa in Europa. Il peso del nuovo corso negli Usa
e dello scenario libico. Nessuno, ventiquattr'ore dopo, è in grado di affermare
con certezza se quella definizione così dura dedicata al presidente turco Recep
Tayyip Erdogan, "dittatore", sia stata preparata, studiata e quindi scagliata in
conferenza stampa seguendo un copione già scritto. Probabilmente no, o comunque:
non tutto era stato pianificato. E nessuno può prevedere fino in fondo gli
effetti di questa sortita. La sostanza, però - quella sì - ricalca una linea
che Mario Draghi intende seguire nei prossimi mesi. Frutto di convinzioni
consolidate e della nuova fase internazionale. Di certo, il premier è descritto
in queste ore come sereno e non troppo turbato da quanto accaduto. Sia chiaro: i
canali diplomatici sono già in movimento, com'è ovvio che sia in casi del
genere. Ma il presidente del Consiglio non dà segnali di bruschi cambi di
direzione, né di clamorose marce indietro. Esistono due piani, in questa
partita. E vanno tenuti ben distinti. Il primo attiene all'incidente diplomatico
della "sedia" negata alla presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen, che ha generato la reazione di Draghi. Netta, pubblica, in diretta
televisiva, con il logo della Presidenza del Consiglio alle spalle. La più dura
registrata in Europa. Ed è culminata con due parole che non si prestano a
fraintendimenti: la presidente della Commissione è stata "umiliata" e,
soprattutto, Erdogan è un "dittatore" con cui comunque "si ha bisogno di
collaborare". La reazione di Ankara, immediata, ha portato alla convocazione
dell'ambasciatore italiano in Turchia. E anche il ministro degli Esteri si è
subito scagliato contro l'ex banchiere centrale. A fronte di questi eventi,
molto si è messo in moto. "Se ne stanno occupando le diplomazie", fanno sapere
da Palazzo Chigi a metà giornata. Significa che i contatti tra le due
rappresentanze sono in corso. Significa che il premier italiano ha già avuto
modo di discutere della questione con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al
telefono. E che nelle prossime ore incontrerà il responsabile della Farnesina,
appena farà rientro in Italia reduce da due giorni di missione in Malì. Ridurre
il danno significa anche gradire la scelta di Matteo Salvini di rinviare a data
da destinarsi il sit-in - previsto per stamane - di fronte alla rappresentanza
diplomatica turca nella Capitale. Questa, dunque, è la tela diplomatica. Che
sarà condizionata, evidentemente, anche dall'eventuale reazione pubblica di
Erdogan, attesa per oggi ma che ancora, a sera, non è stata registrata dai media
turchi. Ma le parole di Draghi vanno inquadrate anche allargando lo sguardo al
contesto geopolitico internazionale. E' questo il punto che segnalano tutti gli
interlocutori di Palazzo Chigi, in queste ore. Un filo che partendo da
Bruxelles, arriva fino a Tripoli e Washington. È cronaca che Draghi abbia di
recente visitato la Libia, nel corso del suo primo viaggio internazionale. In
quello scacchiere Ankara gioca da oltre un anno una partita assai aggressiva,
proprio in un teatro tradizionalmente caro a Roma. Gli interessi, è evidente,
non collimano, anche se questa "concorrenza" non basta da sola a spiegare
l'affondo verbale del premier italiano. E infatti c'è di più. L'attivismo di
Draghi va letto alla luce della nuova fase che potrebbe presto aprirsi in Europa
e che, di certo, si è già aperta negli Stati Uniti. L'imbarazzo con cui
Bruxelles ha reagito al caso della "sedia" è emblematica, e sotto gli occhi di
tutti. In questo senso, il premier ha scelto scientificamente di intestarsi la
reazione più dura contro Erdogan. L'ambizione pare quella di conquistare un
ruolo centrale nel Continente. In questo, interpretando anche alcuni indizi che
arrivano dagli Stati Uniti. Non sono solo le mosse di Joe Biden rispetto alla
Russia, o quell'esplosivo "killer" scelto per definire Putin. Nel corso
dell'ultimo Consiglio europeo, il presidente degli Stati Uniti ha selezionato
concetti durissimi verso le autocrazie e indicato la rotta ai partner Ue:
"Stando insieme, fianco a fianco, Usa e Unione europea possono dimostrare che le
democrazie sono più adatte a proteggere i cittadini". Chi conosce la filosofia
di Draghi non nasconde la sintonia con questo approccio. E d'altra parte, anche
il linguaggio sembra adattarsi alla nuova era, con quali conseguenze "sul campo"
si vedrà. Nel frattempo, vanno registrate alcune reazioni gelide con cui a
Bruxelles è stata accolta la sortita del premier italiano. "La Turchia è un
Paese che ha un Parlamento eletto e un presidente eletto - ha detto oggi un
portavoce della Commissione, interpellato sulle parole di Draghi - verso il
quale nutriamo una serie di preoccupazioni e con il quale cooperiamo in molti
settori. Si tratta di un quadro complesso, ma non spetta all'Ue qualificare un
sistema o una persona". Una freddezza che non sembra però scalfire le
convinzioni dell'ex banchiere. Che, spiegano da più fronti, ha sempre usato e
continuerà a usare un linguaggio diretto, in un certo senso non mediato e quindi
anche a suo modo rischioso, soprattutto rispetto alle potenze esterne
all'alleanza democratica occidentale. Ma che nello stesso tempo promette
comunque, in nome della real politik, di continuare a promuovere il dialogo con
questi leader, in nome di un pragmatismo necessario.
Francesca Sforza per “la Stampa” il 10 aprile
2021. Impertinenti, inopportune, inaccettabili»: è questa l' aggettivazione che
la diplomazia turca ha usato per definire le dichiarazioni del premier italiano
Mario Draghi a proposito del presidente turco Erdogan («un dittatore di cui si
ha bisogno»). Ankara chiede senza mezzi termini che quelle dichiarazioni vengano
«immediatamente ritirate», ma forse si accontenterebbe di una telefonata di
scuse. Le scuse tuttavia non arriveranno, se si guarda alla linea assunta dal
governo italiano nei confronti della Turchia non da ieri, ma almeno dall' ultimo
Eurosummit del 25 marzo scorso, quando Draghi ha duramente criticato lo stato di
diritto turco e l' uscita dalla Convenzione di Istanbul. Oltre agli americani,
tradizionalmente su questa posizione, il premier Draghi incontra il sostegno
dell' opinione pubblica e dell' intero arco parlamentare italiano - ostile alla
Turchia in chiave anti-islamica a destra e filo-curda a sinistra - e ieri ha
anche incassato il sostegno del Ppe, che con Manfed Weber ha dichiarato: «Con la
Turchia meglio parlare chiaro e togliere dal tavolo la procedura di allargamento
dell' Unione». Tutto bene dunque? Insomma, perché i nostri interessi con la
Turchia ammontano al momento a circa 20 miliardi di interscambio l' anno -
ambienti vicini a Leonardo vedevano in bilico, ieri, la commessa per l' acquisto
di 15 elicotteri, tanto per cominciare - e poi ci sono i nostri interessi
geopolitici nel Mediterraneo. Negli ultimi anni, a fatica, con la tecnica di due
passi avanti e uno indietro, l' Italia era comunque riuscita a ritagliarsi uno
spazietto strategico nell' area, che con la Libia da ricostruire aveva i margini
per diventare più largo. L' imperfetto però a questo punto è d' obbligo, perché
in quella zona sono due i Paesi con cui bisogna dialogare: uno è l' Egitto - con
cui i rapporti sono congelati per via del caso Regeni - e l' altro è la Turchia.
I sostenitori della linea moderata, che tradizionalmente sul dossier turco
dimorano al Ministero degli Esteri, hanno già cominciato a mettere sul tavolo
possibili soluzioni. Ma anche lì, si fatica a trovare una traiettoria, almeno
stando a una delle poche dichiarazioni rilasciate: «Coordineremo tutte quelle
iniziative che si devono coordinare», ha detto il ministro Di Maio nel corso di
una trasmissione tv. Da una parte c' è la gestione del breve e medio termine -
chi conosce la diplomazia turca sa che la tecnica dell' attendismo, del rinvio,
del lasciar decantare nell' attesa che passi la bufera, è destinata a fallire -
dall' altra quella del lungo termine, che riguarda la collocazione strategica
italiana futura. Ci si chiede se non siamo all' alba di un cambio strutturale
della politica estera nazionale, un turning point che potrebbe vederci
sostanzialmente fuori dal Mediterraneo che conta, più vicini a Stati Uniti e
Francia, più lontani da Berlino. I più preoccupati sembrano essere proprio i
tedeschi, che ieri si sono mossi alla ricerca di spiegazioni per capire come
regolarsi: se anche l' Italia si sposta su posizioni decisamente antiturche come
già la Francia, Grecia e Cipro, come sarà possibile condurre una mediazione
nell' area del Mediterraneo orientale? Che i tedeschi ci vengano dietro è da
escludere, non fosse altro per la composizione etnica delle loro città: un
problema con la Turchia diventerebbe un problema di politica interna nell' arco
di ventiquattr' ore. Mai come questo momento l' ancoraggio a Bruxelles sembra
quello da cui gli interessi italiani possono venire difesi al meglio. Anche se
mai come dopo il Sofà-Gate le fragilità dell' Unione sono sembrate tanto grandi.
Mario Draghi contro Erdogan e il silenzio
di Angela Merkel: il premier italiano lancia la sua scalata in Europa?
Libero Quotidiano il 10 aprile 2021. Chiamandolo “dittatore”
in una conferenza stampa con tanto di logo di Palazzo Chigi alle sue
spalle, Mario Draghi ha fatto letteralmente perdere le staffe a Recep Erdogan,
che evidentemente si è sentito toccato nel profondo. D’altronde quella espressa
dal presidente del Consiglio è una verità incontrovertibile, oltre che una mossa
politica dai risvolti molto chiari: “Dopo aver strizzato l’occhio alla Cina e
alla Russia con i due governi guidati da Giuseppe Conte - è l’analisi di
Adalberto Signore su Il Giornale - Draghi torna su quelli che sono storicamente
i due capisaldi della nostra politica estera, fin dai tempi della Dc: europeismo
e atlantismo. Con la realpolitik come faro”. Nelle ore successive alla sua
uscita pubblica contro Erdogan, definito “dittatore” con cui bisogna però
“cooperare” (e non collaborare, scelta di parole non casuale), Draghi è stato
descritto dal suo staff come “tranquillo” e “per nulla turbato” dalla reazione
dura della Turchia, che ha subito convocato l’ambasciatore italiano. Ma al di là
di questo, già ieri Erdogan ha evitato di tornare sull’argomento e di esprimere
pubblicamente una posizione contro l’Italia. Evidentemente il presidente del
Consiglio ha colpito nel segno… Ma la sua uscita è importante non solo per
marcare le distanze dalla Turchia di Erdogan. Sempre Signore su Il Giornale fa
notare che in Europa si è registrato un certo silenzio delle cancellerie più
importanti, a partire da quella tedesca di Angela Merkel. Sia lei che la
Commissione Ue hanno scelto di lavarsene le mani: “Certamente un eccesso di
prudenza. Ed è in questo eccesso di cautela dell’Europa che Draghi inizia a
muoversi con un piglio che inizia a far breccia, non tanto in casa nostra quanto
all’estero. E a far pensare - per la prima volta dopo molti anni - che
un premier italiano possa ambire ad un ruolo di leadership a livello europeo”.
Che pena l’Europa che si inginocchia ai
piedi del sultano sessista e liberticida. Che l’età
dei diritti sia al tramonto, ce lo hanno dimostrato con chiarezza Draghi, von
der Leyen e Michel. Coloro che avrebbero il compito di preservare e difendere le
istituzioni democratiche tuttora esistenti in Europa. Barbara Spinelli su Il
Dubbio il 9 aprile 2021. Leggendo i giornali degli ultimi due giorni, viene da
pensare che davvero i diritti umani siano un’ideologia occidentale in declino. E
che a favorire tale lento ma inesorabile declino siano proprio quei governanti
europei che invece avrebbero il compito di preservare e difendere le istituzioni
democratiche tuttora esistenti in Europa, sorte dalle ceneri dei campi di
concentramento nazisti nel secondo dopoguerra del secolo scorso. Che l’età dei
diritti sia al tramonto, ce lo hanno dimostrato con chiarezza Draghi, von der
Leyen e Michel. Draghi, pur di recuperare gli interessi economici in Libia, si è
spinto ad affermare che “Sul piano dell’immigrazione noi esprimiamo
soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo
aiutiamo e assistiamo la Libia”, anche dopo che, al contrario, Fatou Bensouda,
la procuratrice della Corte penale internazionale dell’Aia, ha messo nero su
bianco nel suo rapporto al Consiglio di sicurezza dell’ONU la responsabilità del
generale Haftar e delle milizie dal medesimo controllate nei crimini di guerra e
nelle “sistematiche atrocità” commesse contro migranti e profughi. Von der Leyen
e Michel, dopo i già sonori schiaffi assestati da Erdogan al sistema europeo di
tutela dei diritti umani, il primo attraverso il menefreghismo dimostrato
davanti alla sentenza della Corte Europea dei diritti umani con la quale si
chiedeva l’immediata liberazione del leader HDP Selahattin Demirtas, dichiarando
urbi et orbi che “la sentenza non è vincolante per Ankara”, il secondo, con la
fuoriuscita dalla Convenzione di Istanbul, si sono dimostrati propensi ad
accettare sottomessi anche il terzo, inflitto a favore di telecamere in
occasione della visita ad Ankara. Che si sia trattato di un pasticcio
diplomatico è fuor di dubbio: strano però che i funzionari della Commissione non
si siano coordinati con quelli del Consiglio d’Europa per la preparazione della
visita, e ancor più strano che i funzionari di Ankara ignorassero la pari
dignità di entrambe le istituzioni. Perché è pur vero che il capodelegazione era
Michel, ma quando si ricevono due istituzioni di pari importanza, le si
assegnano posti di pari rilievo. Invece Ursula, a sedia mancante, si è
accontentata del divanetto, declassata alla compagnia del Ministro degli Esteri
Cavasoglu, lasciando la scena ai due uomini di potere. Ammesso che l’assenza
della sedia sia stato frutto dell’imperizia dei funzionari europei, tuttavia a
sedia mancante era chiaro che la scelta sul che fare avrebbe avuto una portata
simbolica pregnante. Accettare il terzo schiaffo o ribadire il necessario
rispetto della pari dignità istituzionale, a maggior ragione in quanto
l’istituzione messa in disparte era rappresentata da una donna, attendendo in
piedi l’arrivo della terza sedia? Purtroppo, Ue e Consiglio d’Europa hanno
incassato il terzo schiaffo senza colpo ferire, ed anzi nella conferenza stampa
congiunta hanno pure spiegato il motivo di tanto aplomb: intensificare gli
scambi economici e rafforzare i finanziamenti per la gestione dei flussi
migratori. Erdogan è stato scaltro: come nel gioco delle tre carte, rimbalzando
tra i protocolli, ha mostrato al mondo intero la debolezza della diplomazia
europea e la relatività dell’ideologia occidentale dei diritti umani, predicata
ma non praticata. L’immagine che Michel e Von der Leyen ci hanno consegnato,
come d’altronde Draghi con le sue dichiarazioni, è quella di un esecutivo
fragile, vulnerabile, per il quale il prevalere degli interessi politici ed
economico- finanziari impone la relativizzazione nella tutela dei diritti umani,
la sudditanza a criminali di guerra, dittatori e despoti, che se ne compiacciono
ingrassando le loro tasche, per fare il lavoro sporco. E così, mentre Al- Sisi,
Haftar ed Erdogan se la ridono compiaciuti della fragilità italiana ed europea –
fragilità ideologica e politica- e si godono i vantaggi economici che ne
derivano, noi guardiamo la democrazia morire lentamente, affossata dalle logiche
speculative dei governi, che non esitano a barattare sicurezza, commesse
milionarie e rifornimenti energetici con il silenzio assenso ai regimi
dittatoriali del Mediterraneo all’eliminazione interna della resistenza
democratica, e all’erosione dello stato di diritto mediante la cancellazione
della separazione dei poteri, dell’indipendenza della magistratura, dei principi
di uguaglianza e non discriminazione.
I migranti dietro al "sofa-gate". Il
retroscena sulla sedia proibita. Il vertice di Ankara
serviva ad Unione Europea e Turchia per riprendere il dialogo su alcuni dossier
vitali per l'agenda politica internazionale, tra cui la gestione dei rifugiati
siriani. Daniele Dell'Orco - Ven, 09/04/2021 - su Il Giornale. Per "sofà-gate"
si intende la dimostrazione plastica della capacità dell'Europa di spostare
l'attenzione dalle tematiche rilevanti per concentrarsi sul colore. Perché sì,
l'atteggiamento di Erdogan nei confronti del Presidente della Commissione
Ue Ursula von Der Leyen è stato brutale, ma forse meno rispetto al nocciolo
centrale del vertice: i migranti. Attorno alla gestione dei flussi migratori
ruotano tutti gli altri dossier che animano i rapporti tra Turchia e Unione
Europea: diritti umani (la Turchia ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione
europea contro la violenza sulle donne), ingerenze geopolitiche, scontri
diplomatici. La von Der Leyen, insieme al Presidente del Consiglio Ue, Charles
Michel, si sono resi conto che l'escalation degli scontri con Ankara non
conviene a nessuno. E anzi, il meeting rappresentava una tappa importante verso
una ripresa della dialettica che la stessa Turchia, in piena crisi finanziaria,
auspica con l'Ue, dopo un 2020 di massima tensione e la minaccia di sanzioni
contro Erdogan per le azioni "illegali e aggressive" su vari fronti. I
diplomatici francesi l'hanno definita “offensiva di charme”, e si tratta di una
strategia, quella del Sultano, di provare a tendere la mano all'Europa dopo mesi
a dir poco turbolenti: dagli insulti con Macron, alla disputa sulle
trivellazioni nel Mar Egeo, fino ovviamente alla riapertura dei confini con la
Tracia che aveva proiettato centinaia di migliaia degli oltre 4 milioni di
profughi siriani stipati in Anatolia lungo la cosiddetta Rotta Balcanica.
Proprio in questo senso, dopo i 6 miliardi di euro già elargiti con l'accordo
del 2016 da Bruxelles per "proteggere" i confini tra Grecia e Turchia, entrambe
le parti in causa caldeggiano un rinnovo dei finanziamenti. Questi nodi
dell'agenda diplomatica rappresentano punti di interesse comune tra tutti gli
Stati dell'Ue, dalla Francia che appunto con la Turchia non nutre buoni rapporti
(addirittura dall'Eliseo accusano Erdogan di aver tentato di interferire nelle
scorse elezioni presidenziali), alla Germania che con la Turchia cerca di tenere
saldo un rapporto secolare, fino alla stessa Italia, che ha ancora il suo bel
daffare nella gestione dei flussi migratori dalla Libia (quasi 10mila sbarchi da
inizio del 2021), che con Ankara condivide diversi dossier di politica
internazionale (Nord-Africa, Maghreb, Balcani, Mediterraneo orientale, Africa
orientale) e che in quella "cooperazione" auspicata da Draghi nelle sue
dichiarazioni su Erdogan che hanno creato un incidente diplomatico non da
poco si riferisce proprio alla gestione degli accordi commerciali e politici,
della convergenza sul riconoscimento di un governo in Libia, del blocco dei
migranti. Il sofà-gate, insomma, ha mostrato chiaramente come tematiche
"simboliche" in seno all'Europa finiscano per sovvertire l'ordine gerarchico
degli argomenti davvero importanti. È anche così che, il Vecchio Continente,
mostra il suo ventre molle.
Il Canale, la Libia e Washington: la vera
sfida tra Draghi ed Erdogan. Lorenzo Vita su Inside
Over l'11 aprile 2021. Quella che si sta per concludere non è stata una
settimana come le altre per la Turchia. È iniziata con una retata che ha
coinvolto i più importanti ammiragli in pensione del Paese accusati di golpe ed
è finita con il “sofa-gate” di Ankara fino ad arrivare alle parole di Mario
Draghi nei confronti di Recep Tayyip Erdogan, definito come un “dittatore” dal
presidente del Consiglio. I tre episodi sembrano completamente slegati tra loro,
almeno in apparenza. Cosa può unire dieci ammiragli accusati di aver firmato un
documento che paventava un golpe a una conferenza stampa del premier italiano a
Palazzo Chigi? Tutto farebbe propendere per due questioni completamente sperate,
eppure esiste un filo conduttore: una sottile linea rossa che lega Ankara a Roma
e che fa tappa a Istanbul e Tripoli e che svela uno dei più complessi equilibri
di potere del Mediterraneo. Partiamo dagli arresti che hanno coinvolto gli ex
ammiragli turchi, tra i quali l’ideatore di Mavi Vatan, Cem Gurdeniz. Tutto
nasce da una dichiarazione con cui 104 personalità legate alla Marina e al mondo
nazionalista hanno criticato aspramente l’idea del Canale di Istanbul (il
progetto faraonico per creare una via d’acqua parallela al Bosforo) e l’ipotesi
di uscire dall’accordo di Montreux del 1936. I mandati di arresto per gli alti
ufficiali in pensione della Marina sono il frutto di un sospetto: secondo
Erdogan e la magistratura turca quella lettera firmata dai militari ormai non
più servizio sarebbe molto simile a certi documenti firmati in concomitanza dei
colpi di Stato che hanno coinvolto la Turchia. Ma l’accusa nasconde anche un
altro segnale: non solo si ferma un blocco, quello nazionalista e laico, che
contesta Kanal Istanbul e l’uscita da Montreux, ma si fa vedere a Russia e Stati
Uniti – cioè le due potenze coinvolte nel Bosforo – che la possibilità di
escludere il canale dalla Convenzione del 1936 è un’ipotesi reale. Tanto reale
che si considera pericoloso chi ne condanna aspramente l’ipotesi, pure se questo
significa arrestare un uomo che ha plasmata l’attuale dottrina navale turca.
Alla Russia, l’idea che la Turchia esca da Montreux non piace per
nulla. Vladimir Putin ha chiamato Erdogan proprio per esprimergli il punto di
vista russo sulla necessità di mantenere vivo l’accordo evitando di manomettere
il regime del transito negli Stretti Turchi. Il presidente turco ha voluto
evitare di tornare sull’argomento dicendo che per adesso l’uscita non è in
discussione, ma è chiaro che l’attenzione del Cremlino è la spia di cosa può
succedere dal punto di vista internazionale. Perché se Mosca ha tutto
l’interesse a evitare che si infranga l’equilibrio del Mar Nero, a Washington
c’è molta curiosità sul punto: specialmente perché avviene in una fase di
escalation che riguarda l’Ucraina e le coste meridionali della Russia. Gli Stati
Uniti sarebbero molto interessati a un canale escluso da quella convenzione
firmata ai tempi di Atatürk e della prima Unione Sovietica. La Convenzione
limita non solo il passaggio delle navi militari dei paesi che non si affacciano
sul Mar Nero, ma anche il loro stazionamento, limitato a un massimo di 21
giorni. Se la Turchia decidesse di rinegoziare i termini del trattato o
escludere il Canale da questa Convenzione, per Washington si concretizzerebbe la
possibilità di liberare un choke point fondamentale dando libero sfogo alla
libertà di navigazione e all’idea di armare il Mar Nero. E questo Erdogan lo sa
benissimo, perché usando quest’offerta e fermando i più alti ufficiali e
strateghi anti Usa, il messaggio arrivato in America è chiarissimo. Il
riavvicinamento agognato da Erdogan con gli Stati Uniti chiaramente passa anche
per la Libia. E qui viene in gioco l’Italia. È chiaro che la Turchia dalla
Tripolitania non se ne andrà così facilmente. Ha inviato droni, armi, navi,
mercenari dalla Siria e consiglieri militari: difficilmente abbandonerà il campo
senza ottenere garanzie di mantenere il controllo su Tripoli e Misurata e sulle
sue maggiori basi in Libia. Ma questo significa che avrà per forza bisogno di un
minimo placet americano. Anche perché la Turchia ha già dimostrato di essere
molto brava a trattare con la Russia, presente in Cirenaica, pur rimanendo
formalmente nella Nato. L’offerta di Kanal Istanbul può sembrare avventata e
quasi utopistica: ma è chiaro che a Erdogan in questo momento serve far capire
agli Stati Uniti di poter di nuovo fare affidamento sulla Turchia. Una necessità
tale da far rispolverare al governo turco anche il tema degli uiguri in Cina,
tanto caro all’America ma con il rischio di infastidire il potente partner
cinese. Questo gioco turco ovviamente complica molto le mosse di chi si
considera il miglior alleato degli Stati Uniti nel Mediterraneo, e cioè
l’Italia. Draghi ha confermato più volte che la sua linea politica è quella
europeista e atlantista. Il caso Biot in questo senso è esemplare. Ma è evidente
che nella partita libica e in quella del Levante la Turchia ha molte più armi da
mostrare a Joe Biden. Il presidente Usa di certo non apprezza Erdogan, ma
l’ipotesi di Ankara che torna nell’alveo Nato e che spezza l’asse con Mosca non
può essere presa sottogamba. Specialmente perché abbiamo visto come Biden veda
come fumo negli occhi sia la Russia che la Cina. Ecco quindi che le parole di
Draghi su Erdogan assumono un ben altro significato: la “gaffe” del premier non
è evidentemente collegata alla sedie negata a Ursula von der Leyen, ma molto più
pragmaticamente serve a tirare una linea rossa tra il modus operandi italiano e
quello turco. Per Draghi non c’è possibilità di paragonare i due paesi, a tal
punto che considera Erdogan un dittatore con cui collaborare. Concetto
decisamente in contrasto con il fatto che la Turchia non è solo un importante
partner italiano ma anche un alleato in seno alla Nato. Quell’uscita dopo il
viaggio a Tripoli e dopo l’incontro con il nuovo premier libico e con il premier
greco Mitsotakis indica un segnale anche da parte dell’Italia: per Palazzo Chigi
è Roma il vero referente di Washington nel Mediterraneo.
Massimo Giannini per “la Stampa” l'11 aprile 2021.
Mario Draghi che dà del “dittatore” a Erdogan. È la classica buccia di banana
sulla quale scivola un leader arrivato al potere con le apparenti credenziali di
un “impolitico”, o è invece la ruvida frustata di un primo ministro che insegue
un più raffinato disegno diplomatico? Le sacre fonti di Palazzo Chigi invitano a
non caricare di significati eccessivi l’accusa che il presidente italiano ha
rivolto al suo omologo turco: era indignato per il trattamento scandalosamente
sessista riservato alla presidente della Commissione europea in visita ufficiale
ad Ankara, e questo è tutto. Può darsi che sia così. Ma quello che è accaduto,
depurato dalla possibile motivazione psicologica, sollecita comunque qualche
riflessione politica. Intanto perché l’affondo del premier rappresenta in ogni
caso uno strappo lessicale e istituzionale: nel galateo delle diplomazie nessun
capo di Stato e di governo usa dire ciò che pensa in modo così netto e quasi
brutale. E poi perché, a distanza di quattro giorni e nonostante le proteste
ufficiali della Turchia, il premier non ha fatto nulla per troncare e sopire.
Dunque, cosa c’è dietro la sortita di Draghi? Suggerisco due chiavi di lettura.
La prima chiave di lettura è fattuale: Erdogan è un dittatore perché viola
sistematicamente i diritti del suo popolo e del popolo curdo e reprime le
libertà fondamentali, di espressione e di genere. Comprensibile nella sostanza,
irricevibile nella forma: come ha scritto giustamente Nathalie Tocci, Erdogan è
un pessimo autocrate, maschilista e nazionalista, ma in Turchia non c’è una
dittatura, il presidente è stato eletto dai cittadini, le tre maggiori città
sono in mano a sindaci dell’opposizione e tra due anni si svolgeranno nuove
elezioni. Draghi non può non saperlo. Se nonostante questo ha evocato la
“dittatura”, e poi non ha fatto nessuna marcia indietro, è verosimile che abbia
voluto lanciare qualche messaggio. Agli amici e ai nemici. E qui siamo alla
seconda chiave di lettura, che è invece geo-strategica. Con la sua intemerata,
per quanto “tecnicamente” imprecisa, il premier riempie a modo suo l’inquietante
vuoto di leadership dell’Unione in Europa, in Medioriente, nel mondo. Un vuoto
che deriva dal declino dell’asse franco-tedesco, con una Merkel in uscita e un
Macron in attesa. Che precipita nella ritirata comunitaria dai grandi teatri
globali del conflitto militare-industriale, dal Corno d’Africa alla Siria
all’Iraq. Che si manifesta nel clamoroso fallimento della campagna vaccinale,
con una copertura finora limitata al 14% dei cittadini europei, contro il 38%
degli americani e il 58% dei britannici. Che deflagra simbolicamente proprio con
il “Sofà-gate” in terra turca, con un patetico Charles Michel che invece di
cedere la poltrona alla collega Von der Leyen usa a vanvera il “protocollo” per
giustificare la sua figuraccia, quasi più oscena di quella di Erdogan. Prendendo
di petto il Sultano, Draghi sembra voler ridare voce all’Unione e tono
all’Italia. A partire proprio dal Mediterraneo, che un tempo era Mare Nostrum e
adesso è risucchiato nel gorgo dei nuovi imperialismi asiatici. Mettiamo in fila
i fatti degli ultimi dieci giorni. Il capo del governo ha prima lanciato un
segnale chiaro a Putin, facendo arrestare una spia che vendeva segreti a Mosca.
Poi è volato a Tripoli a dare sostegno al governo provvisorio di Dbeiba e a
supportare la presenza dell’Eni (anche se ha commesso il grave errore di
“ringraziare” la Guardia Costiera libica per i salvataggi, mentre avrebbe dovuto
denunciarne i misfatti). Infine ha sferrato il colpo a freddo su Erdogan. Tre
atti che sembrano uniti da una sola trama: dimostrare ai russi e ai turchi che
in Libia, e non solo in Libia, l’Italia c’è e vuole giocare la sua partita. Un
avviso ai naviganti che vale anche per gli alleati europei: deboli, divisi e
indecisi a tutto. E in questo caso, forse, c’è una saldatura più marcata con
l’America post-trumpiana. L’Erdogan “dittatore” di Draghi fa il paio con il
Putin “killer” di Biden. Un linguaggio comune, improprio ma inequivoco, per
riallacciare le relazioni transatlantiche all’insegna della difesa delle
democrazie occidentali e della denuncia esplicita dei regimi illiberali. Che se
non sono dittature (come nel caso della Cina) sono per lo meno “democrature”
(come nel caso della Turchia e della Russia). E che al di là della “volontà di
potenza” di chi le comanda, non sono né insensibili né impermeabili al “soft
power” esercitato dal mondo libero. Erdogan è in palese difficoltà. Si avvicina
alle elezioni del 2023 col fiato sempre più corto. È in crisi nera
sull’economia: il Pil non cresce, l’inflazione vola al 15% e la cacciata del
governatore della Banca centrale Naci Abgal ha prodotto una svalutazione della
lira turca pari al 15% sul dollaro. È in conflitto con interi pezzi della
società: milioni di giovani non dimenticano le proteste di Piazza Taksim e
centinaia di migliaia di donne scendono in piazza ogni fine settimana dopo la
clamorosa decisione del governo di uscire dalla Convenzione di Istanbul contro
la violenza di genere. È in caduta verticale nei sondaggi: ad oggi il suo
partito, l’Akp, non raggiungerebbe il 51% neanche con gli alleati del Movimento
Nazionalista. Putin non se la passa tanto meglio. In patria cresce il disagio
alimentato dal martirio a bassa intensità di Navalny nella colonia penale di
Pokrov, dove il leader dei dissidenti si consuma in uno sciopero della fame che
nutre le speranze malcelate del Cremlino su una sua fine rapida e magari non
troppo dolorosa. Fuori dai confini crescono le tensioni nel Donbass, dove lo Zar
non ha ancora deciso quale strategia intraprendere, mentre il ministro degli
esteri ucraino Dmitro Kuleba denuncia ufficialmente “l’aggressione armata della
Federazione Russa” e il New York Times scrive “le intenzioni di Putin non sono
chiare ma la manovra, decisa per mettere alla prova il nuovo presidente
statunitense, potrebbe rapidamente degenerare”. Queste autocrazie non sono
superpotenze inespugnabili. E con queste autocrazie dobbiamo comunque “fare i
conti”, come ha detto lo stesso Draghi. In senso diplomatico, ed anche in senso
economico: perché dove passano le merci non passano gli eserciti, perché in
Turchia lavorano 1.500 aziende italiane e perché con Ankara abbiamo un
interscambio che vale 19 miliardi. Ma queste autocrazie vanno affrontate a viso
aperto. Perché, come scrive Anne Applebaum nel suo “Tramonto della democrazia”,
è anche possibile che la nostra civiltà stia già dirigendosi verso l’anarchia o
la tirannia, che il XXI secolo vedrà arrivare al potere una nuova generazione di
“chierici”, fautori di idee autoritarie, e che la paura del Covid genererà anche
la paura della libertà. Ma dipende solo da noi far sì che la pandemia ispiri
invece un nuovo senso di solidarietà, e che la realtà del dolore e della morte
insegni alle opinioni pubbliche a diffidare di bugiardi, populisti, imbonitori.
E persino dittatori, veri o falsi che siano.
Gianluca Di Feo per “la Repubblica” l'11 aprile
2021. La crisi non è affatto chiusa. Ad Ankara le parole di Mario Draghi, che ha
definito «un dittatore» il presidente Erdogan, continuano a provocare
dichiarazioni infuocate di ministri e leader politici. Il governo turco pretende
scuse ufficiali e non sembra disposto ad accontentarsi di un chiarimento
attraverso i canali diplomatici. E poiché da Roma non arrivano risposte, le
autorità turche hanno cominciato a lanciare segnali minacciosi, marchiando la
disponibilità di alzare il livello del confronto. Una pressione nell' ombra,
destinata a pesare senza però ricorrere ad atti formali. Con un obiettivo
chiaro: far capire che il prezzo del braccio di ferro potrebbe pagarlo l'
economia italiana. La prima a finire nel mirino è stata Leonardo, la holding
tecnologica a controllo statale. Dopo due anni di trattative, proprio in questi
giorni era prevista la firma del contratto per l'acquisto di dieci elicotteri d'
addestramento AW169. Una commessa del valore di oltre 70 milioni di euro, che
doveva essere la prima trance di un accordo per sostituire i vecchi Agusta-Bell
206 della scuola delle forze armate turche: l'importo complessivo per l' azienda
italiana potrebbe superare i 150 milioni. A fine marzo Ismail Demir, il
presidente delle Industrie della Difesa ossia l' ente governativo che gestisce
le commesse, aveva annunciato l' accordo con Leonardo. Ma dopo le parole di
Draghi i turchi hanno fatto sapere che "al momento" l' operazione è sospesa.
Avvisi simili sono stati recapitati anche ad altre compagnie nazionali attive in
Anatolia. Tra loro ci almeno due società private e Ansaldo Energia, proprietaria
del 40 per cento di un gruppo che da un anno sta negoziando con banche e
autorità turche la gestione dei debiti per centinaia di milioni accumulati dalla
centrale elettrica di Gebze, nella zona industriale di Istanbul. È chiaro che
Ankara intende far valere la rilevanza delle relazioni economiche tra i due
Paesi. Prima del Covid, l'interscambio era arrivato a toccare 17 miliardi l'anno
con quasi 1500 società italiane impegnate in Turchia: una delle più importanti è
Ferrero, che produce lì una parte consistente delle nocciole con un business da
centinaia di milioni l' anno. Fonti di Palazzo Chigi minimizzano la situazione,
sostenendo che la nostra diplomazia è all' opera per rasserenare le relazioni. E
finora il presidente Erdogan ha scelto di non affrontare il tema. Ma uno dietro
l'altro i suoi ministri hanno preso posizione, condannando Draghi. Quello dell'
industria Mustafa Varank ha dichiarato: «Non esistono lezioni di democrazia che
la Turchia può ricevere dal primo ministro "incaricato" dell' Italia, che ha
inventato il fascismo». Poi ha detto che i governanti italiani lasciano morire i
richiedenti asilo e devono prendere lezioni di umanità dalla Turchia,
invitandoli ad ammirare il presidente. Non a caso, quasi tutti gli interventi
fanno leva sul tema dell' immigrazione. Il portavoce dell' Akp, il partito di
Ergogan, ha usato parole durissime: «Hanno chiamato il nostro presidente
"dittatore" e poi hanno aggiunto che devono collaborare con noi sull'
immigrazione - ha scandito Omer Celik - . È il massimo dell' ipocrisia. Queste
persone che trattano i migranti in maniera dittatoriale e immorale, pensano di
doverci dare lezione di democrazia. Per prima cosa portate la vostra democrazia
fuori dalle acque del Mediterraneo, poi parlate».
L’attacco di Erdogan ai diritti umani è
l’ultima mossa di un leader allo sbando. Contestato
nelle piazze, in calo di popolarità, con un partito diviso. Il presidente turco
sceglie il pugno di ferro. Ma questa volta rischia. Mariano Giustino su
L'Espresso il 6 aprile 2021. I primi mesi di quest’anno in Turchia sono stati
particolarmente foschi: con la nomina di fiduciari del presidente turco ai
vertici delle accademie, come è avvenuto alla Bogaziçi, l’Università del
Bosforo, a seguito di un decreto presidenziale varato nella notte del 2 gennaio
e poi, sempre di notte, dal 17 marzo, in 72 ore, con una scarica di colpi allo
stato di diritto e ai diritti umani fondamentali senza precedenti da quando il
Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) di Recep Tayyip Erdogan è al
potere. Dapprima, vi è stata la richiesta della messa al bando del terzo
maggior partito del paese, il Partito democratico dei popoli (Hdp), accompagnata
da quella dell’interdizione di 687 suoi membri dall’esercizio dell’attività
politica perché accusati di sostegno al terrorismo. Poi, il 19 marzo, l’uscita,
per decreto presidenziale, dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e
sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata
dalla Turchia il 12 marzo del 2012 dopo averla sottoscritta l’11 maggio del
2011. Erano altri tempi per l’Akp. La cancellazione dall’ordinamento turco della
Convenzione del Consiglio d’Europa era da più di un anno al centro delle
richieste dei circoli islamisti e dell’estrema destra che costituiscono lo
zoccolo duro della base militante ed elettorale dell’Akp e del suo prezioso
alleato, Devlet Bahçeli, presidente del Partito del movimento nazionalista
(Mhp), formazione politica dei Lupi Grigi, con basi ideologiche nell’estrema
destra panturanica, xenofoba e antioccidentale. Ma, come si sa, il movimento
femminista e quello Lgbtiq in Turchia sono molto agguerriti e subito si è levata
la loro protesta in diverse città del paese. Per giorni nei quartieri centrali
della megalopoli turca, alle ore 21, si è udito il fragore della “tencere ve
tava çalmak”, la battitura di pentole e padelle, fatte risuonare dalle donne
affacciate alle finestre e ai balconi. Le femministe della piattaforma “We Will
Stop Femicide” assieme a gruppi Lgbtiq, manifestano ogni giorno e nel fine
settimana si danno appuntamento al molo di Kadıköy, uno dei quartieri più
iconici della sinistra turca. «Non puoi cancellare la nostra lotta di decenni.
Non rinunceremo mai ai nostri diritti, li abbiamo conquistati lottando con i
denti e con le unghie», gridano al ritmo della musica pop. In un momento in cui
alcuni circoli islamisti in Turchia stanno discutendo di riportare le leggi
anti-adulterio (che presumibilmente includerebbero la condanna e la repressione
del sesso prematrimoniale), le donne con le loro canzoni, anche sulla passione
erotica, esprimono un’aperta ribellione e costituiscono il motore della lotta
contro l’oppressione. Il richiamo all’uguaglianza di genere e la promozione dei
diritti Lgbtiq presenti nella Convenzione di Istanbul erano da sempre indigesti
per i conservatori turchi. Ma i numeri della violenza sulle donne e della
violenza di genere sono agghiaccianti: dall’inizio dell’anno sono già 71 le
donne uccise e nel 2020 sono state 284. Negli ultimi 18 anni, da quando l’Akp è
al potere, sono state 6.732. Ma perché il presidente turco ha deciso di
rinnegare un trattato internazionale che nel 2011 era un fiore all’occhiello
della sua politica riformatrice di avvicinamento all’ordinamento dell’Unione
europea? Il direttorato delle Comunicazioni presso la presidenza della
Repubblica turca in un suo comunicato, di lunedì 22 marzo, esprime molto bene le
motivazioni che sono alla base di questa decisione: «la Turchia si è ritirata
dalla Convenzione di Istanbul perché il trattato internazionale considera
l’omosessualità una condizione umana del tutto normale e ciò è incompatibile con
i valori sociali e familiari della Turchia». In sintesi, il governo turco
ritiene che la Convenzione incoraggi gli orientamenti non eterosessuali e che
dunque minacci l’istituzione fondamentale della famiglia. Anche l’associazione
Kadem, co-fondata dalla figlia del Presidente (Sumeyye Erdogan Bayraktar), ha
ora cambiato idea sostenendo che «a tutelare le donne ci sono già le leggi
nazionali, a partire dalla Costituzione». La visione della nuova Turchia di cui
parla tanto il Capo dello Stato consiste nel recupero dei valori locali e
nazionali che rappresenterebbero le radici dell’identità turco-islamica che la
rivoluzione kemalista aveva represso, cancellato, introducendo appunto valori
estranei. E dunque quelli di genere non sono considerati valori della tradizione
turca, ma sono importati e dunque dovrebbero essere soppiantati da quelli locali
e nazionali (Yerli ve Milli). Per questo sta smantellando stato di diritto e
diritti umani. Il leader turco vede, mese dopo mese, i suoi consensi diminuire e
sembra convinto che possa risalire nei sondaggi toccando le corde della identità
nazionalista-islamista anche più radicale. Si rende conto che per avere la
certezza di vincere le prossime elezioni dovrà eliminare dalla scena politica ed
elettorale il più insidioso partito d’opposizione, per questo è disposto anche a
correre il rischio di passare alla storia come capo di un governo che chiude un
partito come aveva fatto il potere kemalista e golpista nel corso della storia
repubblicana contro i partiti islamisti e contro il suo stesso partito nel 2007.
È dal 2018 che il partito del Presidente non ha la maggioranza assoluta in
Parlamento e dunque ha bisogno del suo prezioso alleato Devlet Bahçeli al quale
ora ha offerto su un piatto d’argento la testa del Partito democratico dei
popoli (Hdp), terza maggiore forza politica rappresentata nel Parlamento turco.
Bahçeli sembra sempre più il “leader ombra” della Turchia, dopo aver
“intrappolato” Erdogan in un angolo con accanto gruppi di potere
politico-affaristici, corrotti e vicini a ideologi dell’estremismo di
destra-nazionalista, come quella dei Lupi Grigi con basi ideologiche
nell’estrema destra panturanica, xenofoba e antioccidentale. Il leader turco
appare sempre più allo sbando, in piena difficoltà, soprattutto per la grave
crisi economica che sta attraversando la Turchia. Logorato e indebolito da
diciotto anni di potere, ora è anche alle prese con una faida interna al suo
partito che ha vissuto già due scissioni con la fuoriuscita di leader storici e
fondatori e non sembra più in grado di concepire e dettare una sua agenda e una
sua strategia. Ecco perché si affida oltre che al Mhp anche al piccolo partito
anti Nato, Vatan Partisi (Partito della Patria) e a circoli del nazionalismo
estremo, a quelli islamisti e agli eurasisti che guardano alla Russia e alla
Cina, tutte correnti, che seppur elettoralmente marginali, hanno non poca
influenza nella società turca dal momento che, dopo il tentato golpe del 2016,
sono tornate ad occupare posizioni di rilievo in particolare nelle Forze armate
e controllano gangli vitali delle istituzioni del paese. Siamo alla versione
moderna del sogno antico dei primordi della Repubblica di una “Turchia senza
curdi” quando tutte le minoranze, specialmente quelle escluse dal Trattato di
Losanna (24 luglio 1923), si videro bandite e negate, costrette a celare la
propria identità non turchizzata, la propria lingua nelle scuole, nei media e,
più in generale, nelle istituzioni pubbliche. Se l’Hdp dovesse essere chiuso,
sarebbe l’ottavo partito filocurdo ad essere messo al bando per il suo presunto
coinvolgimento in attività “terroristiche”. Il potere di chiudere un partito
politico spetta alla Corte costituzionale che dovrà decidere con la maggioranza
dei due terzi. Assieme alla richiesta di dichiarare fuorilegge l’Hdp, è stata
presentata anche quella del divieto di esercitare politica per suoi 687 membri.
Si vuol dunque impedire che i dirigenti dell’Hdp ancora in libertà attivino un
altro partito. L’Hdp infatti ha già pronta un’altra organizzazione, pienamente
operante e che è il Partito democratico delle Regioni (Dbp). I curdi sono
abituati ad essere messi fuorilegge, hanno sempre saputo che quando la loro
presenza sarebbe diventata scomoda per il regime, quest’ultimo avrebbe chiuso il
loro partito come è accaduto ben sette volte. Quando fondano una organizzazione
politica, contemporaneamente ne aprono una di riserva perché la legge sui
partiti in Turchia richiede che una forza politica per operare deve avere sedi
aperte e registrate in almeno 41 province, cioè nella maggior parte del paese. E
l’interdizione dalla vita politica di 687 dirigenti di questo partito servirà
proprio a impedire che vi possano essere in libertà esponenti politici pronti a
trasferirsi nella nuova formazione politica. Questa volta però la
criminalizzazione e la repressione degli esponenti curdi non sta raccogliendo
consensi al di fuori della ristretta cerchia dell’alleanza di governo. Se una
grande maggioranza del partito anticurdo di Bahçeli sostiene la chiusura
dell’Hdp, nell’Akp di Erdogan vi sono diffuse voci di dissenso e, al di fuori di
questo schieramento, questa pratica mutuata dai regimi del passato è quasi
unanimemente condannata. Contrari sono, oltre al maggior partito d’opposizione,
il Partito repubblicano del popolo (Chp) di Kemal Kılıçdaroglu; Meral Aksener,
sua alleata con l’Iyi Parti (Il Buon Partito di destra nazionalista), il leader
del Partito del Futuro (Gelecek Partisi), dell’ex primo ministro Ahmet
Davutoglu, il leader del Partito della democrazia e del progresso (Deva),
dell’ex vice primo ministro, Ali Babacan, e il leader del piccolo partito
islamista, Saadet Partisi, di Temel Karamollaoglu. Contrario è anche l’ex capo
di stato Abdullah Gül, fondatore assieme a Erdogan dell’Akp, ma ora fuoriuscito
anch’egli dal partito e ispiratore del Deva. Contrari sono anche i sindaci delle
due maggiori città turche, il sindaco di Ankara, Mansur Yavas, e il sindaco di
Istanbul, Ekrem Imamoglu, entrambi del maggior partito d’opposizione Chp. Sia
Yavas che Imamoglu hanno accresciuto fortemente la loro popolarità scavalcando
addirittura nei sondaggi, seppur di pochissimo, il leader turco. E dunque
l’obiettivo del Presidente è quello di limitare fortemente il loro potere a
livello locale privando le casse delle municipalità amministrate dal Chp dei
fondi statali necessari per i servizi di pubblica utilità in maniera tale da
provocare disagio e contrarietà nella popolazione. Recentemente il governo ha
sottratto alla gestione della municipalità di Istanbul centinaia di aree
pubbliche, compreso il parco Gezi di piazza Taksim, affidandole a una fondazione
di facciata che fa capo allo stato. Se dovesse essere chiuso l’Hdp, si potrebbe
creare uno scenario simile a quello a cui abbiamo assistito nelle elezioni
locali del 31 marzo 2019 quando il partito di Erdogan subì una sconfitta
bruciante in tutti i grandi centri urbani del paese grazie anche ad una
intelligente ed efficace alleanza elettorale: quella tra il Chp e l’Iyi Parti
che vedeva l’Hdp praticare la “desistenza” con la rinuncia a presentare propri
candidati nei grandi centri urbani, dirottando tutti i suoi elettori sul Partito
repubblicano del popolo. Questa desistenza potrebbe essere una carta vincente se
praticata anche nel sudest anatolico. Per questo il presidente turco potrebbe
decidere di convocare elezioni anticipate, per evitare che l’opposizione prenda
le sue contromisure e si rafforzi ulteriormente. E intanto il governo cambia i
confini di quattro province dell’Anatolia, quelle di Diyarbakir, Ordu, Giresun e
Mus, per modificare i collegi elettorali e riequilibrare l’elettorato a favore
dell’Akp e del suo alleato Mhp. La pratica che gli americani definiscono di
Gerrymandering: manipolazione dei distretti elettorali.
Il pugno di ferro di Erdogan contro
diritti e opposizioni per recuperare consensi. Mariano
Giustino su L'Espresso il 26 marzo 2021. Dopo aver deciso l’uscita dalla
Convenzione di Istanbul, il presidente turco cerca di eliminare dalla scena il
partito filocurdo Hdp: interdetti 687 membri, rischia la messa al bando. Il
deputato Gergerlioğlu arrestato dentro il Parlamento e portato via in pigiama
La catena della repressione in Turchia sembra non
avere limite. Dopo la richiesta della messa al bando del terzo maggior partito
del paese, il Partito democratico dei popoli (HDP), di sinistra libertaria e
filocurda, vi è stata l’interdizione di 687 suoi membri dall’esercizio
dell’attività politica perché accusati di sostegno al terrorismo. Poi il governo
turco ha annunciato l’uscita, per decreto presidenziale, dalla Convenzione di
Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica, ratificata dalla Turchia il 14 marzo del 2012 dopo averla
sottoscritta l’11 maggio del 2011. La Corte costituzionale esaminerà il caso
della richiesta di chiusura dell’HDP il 31 marzo e nello stesso giorno verrà
esaminata la domanda di Ömer Faruk Gergerlioğlu, parlamentare di questo partito
a cui è stato tolto il seggio e che ora rischia di finire in prigione. Erdoğan
sembra convinto, col suo alleato Devlet Bahçeli, che potrà arrestare la sua
emorragia di consensi coltivando l’elettorato di estrema destra nazionalista e
quello dell’islamismo più radicale ed eliminando dalla scena politica ed
elettorale il più insidioso partito d'opposizione, l’HDP. Il presidente turco,
come è noto, dal 2018 non ha la maggioranza assoluta in Parlamento: dunque ha
bisogno del suo prezioso alleato di estrema destra e gli ha offerto su un piatto
d'argento la testa dell'HDP. Era stato infatti il leader del Partito del
movimento nazionalista (MHP), Devlet Bahçeli in persona, a inoltrare presso la
Corte suprema la richiesta di messa in stato d’accusa dell’HDP; ora la Corte
costituzionale dovrà decidere, a maggioranza dei due terzi, se scioglierlo o
meno. Se lo facesse, l’HDP sarebbe l'ottavo partito filocurdo ad essere chiuso.
Secondo l’atto d'accusa si chiede lo scioglimento dell'HDP a norma dell'articolo
68 della Costituzione, perché ritenuto antidemocratico in quanto accusato di
rappresentare il braccio politico del partito fuorilegge dei lavoratori del
Kurdistan (PKK) ritenuto un’organizzazione terroristica oltre che dalla Turchia
anche dagli Stati Uniti e dell’Unione europea. Bahçeli sembra il "leader ombra"
della Turchia, dopo aver "intrappolato" Erdoğan in un angolo con accanto gruppi
di potere politico-affaristici, corrotti e vicini a ideologi dell’estremismo di
destra-nazionalista, come quella dei Lupi Grigi con basi ideologiche
nell’estrema destra panturanica, xenofoba e antioccidentale. Il leader turco
appare sempre più allo sbando, in piena difficoltà, soprattutto per la grave
crisi economica che sta attraversando la Turchia. Logorato e indebolito da
diciotto anni di potere, il Presidente è anche alle prese con una faida interna
al suo partito che ha vissuto già due scissioni con la fuoriuscita di leader
storici e fondatori e non sembra più in grado di concepire e dettare una sua
agenda e una sua strategia. Ecco perché si affida, oltre che al MHP, anche al
piccolo partito anti NATO, Vatan Partisi (Partito della Patria) e a circoli del
nazionalismo estremo, a quelli islamisti e agli eurasisti che guardano alla
Russia e alla Cina. Tutte correnti, che seppur elettoralmente marginali, hanno
non poca influenza nella società turca, dal momento che, dopo il tentato golpe
del 2016, sono tornate ad occupare posizioni di rilievo, in particolare nelle
Forze armate, e controllano gangli vitali delle istituzioni del Paese. I primi
giorni di primavera in Turchia sono stati segnati da scene che ricordano i
terribili anni '90 quando la repressione contro i curdi assunse proporzioni
impressionanti. L’arresto avvenuto in Parlamento del deputato dell’HDP, Ömer
Faruk Gergerlioğlu, ha ricordato la detenzione di parlamentari curdi eletti tra
le file dell’allora Partito socialdemocratico (SHP) colpevoli di aver giurato in
Parlamento in lingua curda il 6 novembre 1991. Tra questi vi furono Orhan Doğan,
Leyla Zana, premio Sakharov nel 1995, che persero lo status di parlamentari e il
2 marzo del 1994 furono arrestati. Dopo 27 anni un altro parlamentare eletto nel
partito di sinistra filocurda viene arrestato in Parlamento e ciò rivela come
l'approccio della Turchia alla questione curda sia rimasta dopo tanti anni
immutato. Gergerlioğlu, fervente musulmano, tenace attivista dei diritti umani,
si è visto privato del suo seggio parlamentare il 17 marzo, per aver condiviso
nel 2016 sui social media un articolo sul PKK. Sebbene il suo post non
includesse alcun incitamento alla violenza, a febbraio la corte d'appello ha
confermato la condanna del 2018 a due anni e sei mesi di prigione con l’accusa
di «aver svolto propaganda per un'organizzazione terroristica». Con una mossa
senza precedenti, Gergerlioğlu ha deciso di adottare una forma di lotta
nonviolenta e si è rifiutato di abbandonare gli uffici del Parlamento occupando
la stanza del gruppo parlamentare del suo partito. «Nessuno può cacciarmi via
dal Parlamento perché sono stato mandato qui da novantamila elettori», ha
dichiarato alla stampa Gergerlioğlu. Ha trascorso quattro notti nel suo ufficio
parlamentare, ma all'alba del 21 marzo, un folto gruppo di agenti di polizia ha
fatto irruzione nella sua stanza e lo ha arrestato. Gergerlioğlu era in pigiama
e da osservante musulmano si preparava alla preghiera del mattino. Non indossava
scarpe né abiti e non gli è stato permesso di vestirsi. "Fatemi prima pregare,
poi mi vesto e vengo con voi", aveva implorato, ma le sue richieste sono state
respinte. È stato portato nel quartier generale della polizia in pantofole e
canottiera. Dopo qualche ora è stato liberato ed è in libertà condizionale. Il 2
marzo 1994, Orhan Doğan fu arrestato assieme ad altri deputati curdi in modo
analogo: la polizia entrò in Parlamento, circondò il gruppo di parlamentari, li
trascinò fuori e li caricò con forza nella volante. La foto di quell’arresto con
la polizia nell’aula parlamentare diventò in seguito un simbolo dell'approccio
della Turchia alla questione curda. E ora, 27 anni dopo, anche questa foto di
Ömer Faruk Gergerlioğlu, in pantofole e in canottiera, mostra che dopo più di un
quarto di secolo, l’approccio turco alla questione curda non è per nulla
cambiato. Gergerlioğlu è uno dei più prestigiosi attivisti per i diritti umani
del paese, vittima della persecuzione post tentato golpe del 2016, quando fu
raggiunto dai famigerati decreti KHK varati durante lo stato di emergenza, la
sua carriera di prestigioso medico pneumologo fu distrutta. Licenziato
dall’ospedale e ridotto in condizione di indigenza, fu accusato di sovversione
contro i poteri dello stato per un suo tweet in cui proponeva la ripresa del
dialogo col PKK. Ha impegnato tutta la sua vita al servizio dei diritti
dell’uomo. Sua moglie si è ammalata gravemente e l’HDP nel 2018 lo ha candidato
alle elezioni parlamentari, dove è risultato eletto. La sua attività
filantropica si era concentrata sui diritti dei detenuti, fino a rappresentarne
la voce, la voce dei senza voce, dei prigionieri, dei dimenticati nelle carceri
turche. È stato anche perseguitato per aver denunciato, sempre su Twitter,
episodi di tortura avvenuti prevalentemente contro alcune detenute nelle carceri
e nei commissariati di polizia. Per questo pende su di lui anche l’accusa di
aver fomentato l’odio e di aver diffamato le istituzioni dello stato. L’arresto
di Gergerlioğlu era scattato dopo le dichiarazioni del leader del MHP Bahçeli
che lo aveva additato come «un separatista impegnato in attività illegali, uno
spregevole individuo da rimuovere dal Parlamento con urgenza». Oggi, centinaia
di membri dell'HDP sono dietro le sbarre con accuse legate al terrorismo, una
pratica, questa, preferita dal governo per mettere a tacere i curdi.
Gli ammiragli difendono un trattato del
1936 ed Erdogan li fa arrestare. La Repubblica il 5
aprile 2021. Dieci ex alti ufficiali in pensione sono stati detenuti per aver
firmato una dichiarazione di appoggio alla Convenzione di Montreux che vedevano
messa in discussione dal raddoppio del Bosforo voluto dal presidente. Per le
autorità la critica richiama i golpe militari. Domani Michel e Von der Leyen ad
Ankara. In Turchia dieci ammiragli in pensione sono stati arrestati per aver
firmato una lettera in cui dichiaravano il proprio appoggio a un accordo
marittimo ratificato 85 anni fa: l'accusa contro di loro è cospirazione contro
l'ordine costituzionale, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolou. La
dichiarazione in favore della Convenzione di Montreux - firmata da un centinaia
di ex ufficiali di alto grado - è stata considerata una sfida al potere civile e
una evocazione dei passati interventi del potere militare nella gestione dello
Stato, un riferimento ai tre colpi di Stato militari avvenuti tra il 1960 e il
1980. Gli ufficiali avevano espresso le proprie preoccupazioni a proposito della
Convenzione di Monteux, da cui il presidente Recep Tayyip Erdogan potrebbe
decidere di ritirarsi. Il governo intende costruire un grande canale parallelo
al Bosforo per mettere in comunicazoone il Mare Nero e il mar di Marmara.
IL CASO. Una fonte ufficiale turca ha sottolineato
che la Convenzione di Montreux non potrebbe coprire il canale. La Convenzione
firmata nel 1936 dà alla Turchia il controllo sul Bosforo e sui Dardanelli e in
tempo di pace garantisce l'accesso alla navigazione civile. Limita inoltre
l'accesso ai battelli militari e regolamenta il traffico commerciale straniero.
Gli ufficiali facevano notare che andrebbero evitate dichiarazioni o azioni che
possano mettere in discussione la convenzione di Montreux "un trattato
importante per la sopravvivenza della Turchia". Lo scontro con gli ammiragli è
solo l'ultimo capitolo della profonda frattura tra il potere secolare
dell'esercito e il partito religioso al potere. Un portavoce dela presidena ha
dichiarato "Un gruppo di soldati in pensione si sta mettendo in una posizione
ridicola e meiservole riecheggiando i passati colpi di Stato militari". Questo
aprile si preannuncia come il mese della resa dei conti tra il governo turco e i
golpisti accusati di aver tentato di rovesciare il governo il 15 luglio 2016.
Sono ben 33 i processi in programma, il cui svolgimento è previsto in 9 diverse
province del Paese, con ben 816 imputati alla sbarra, tutti accusati di far
parte della rete di Fetullah Gulen, ideologo islamico residente negli Usa,
ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe. Nel fitto calendario delle
udienze in programma spicca il prossimo mercoledì la lettura della sentenza per
i 497 imputati nel processo alla "guardia presidenziale,
così denominato perché molti degli accusati avevano l'incarico di
garantire l'incolumità del presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan e
del suo entourage. Il "maxi-processo" e' relativo agli scontri avvenuti la notte
del 15 luglio 2016 tra diverse fazioni dell'esercito, quando i golpisti e
lealisti arrivarono ad aprire il fuoco gli uni contro gli altri, mentre diverse
decine di civili scesi per protestare nelle strade della capitale Ankara furono
falciati dai colpi delle armi automatiche. La sentenza sarà letta nelle aule
allestite fuori dal carcere di Sincan, ad Ankara, in cui sono detenuti gran
parte degli imputati. Domani ad Ankara saranno i leader del Consiglio europeo
Charles Michel e della Commissione, Ursula von der Leyen. Incontreranno il
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con l'intento di dare nuovo impulso alle
relazioni e presentare la roadmap europea stabilita al summit dei capi di stato
e di governo del 25 marzo. In particolare, si parlerà di una nuova tranche di
finanziamenti Ue affinché il paese anatolico continui ad accogliere sul suo
territorio i rifugiati siriani, ma anche di possibili avanzamenti nella politica
dei visti, e di un approfondimento dell'unione doganale. Prima dell'incontro con
Erdogan, Michel parteciperà ad una tavola rotonda con i rappresentanti
dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, Unicef e l'ente dell'Onu per la parità di genere
(la Turchia si è ritirata di recente dalla Convenzione di Istanbul contro la
violenza sulle donne).
La notte della Marina turca: retata per
gli ex ammiragli. Lorenzo Vita su Inside Over il 6
aprile 2021. Una notte che cambia, ancora una volta, il destino della Turchia e
della sua Marina. Le autorità di Ankara hanno arrestato 10 ex ammiragli ritenuti
colpevoli di aver scritto una dichiarazione che ha accusato il governo turco
sull’idea del ritiro del Paese dalla Convenzione di Montreux. Tra i detenuti c’è
anche Cem Gurdeniz, l’ideatore di Mavi Vatan, la dottrina strategica della
Patria Blu. La dichiarazione, firmata da 104 ex alti ufficiali della Marina
turca ormai in pensione, era una forte presa di posizione in difesa dell’accordo
siglato nel 1936 e che regola il transito attraverso Bosforo e Dardanelli. Una
convenzione messa in dubbio da uomini vicini all’Akp, il partito di Recep Tayyip
Erdogan, perché, con il progetto di costruire un canale che bypassi il Bosforo,
questo accordo – dicono – perderebbe di senso. Ipotesi letta con terrore da
parte degli ex alti ufficiali di Marina, che invece ritengono essenziale il
mantenimento di Montreux proprio per evitare che il controllo del Bosforo e dei
Dardanelli passi dalla Turchia a potenze straniere. E che considerano ancora
oggi quel trattato come uno dei capolavori della strategia di Atatürk, ritenuto
da questi segmenti della Marina un modello da seguire. La dichiarazione degli ex
ammiragli è stata letta dai funzionari di Erdoğan come una minaccia di colpo di
Stato. Un incubo per un presidente con una leadership sempre più debole e che ha
vissuto sulla sua pelle il fallito golpe del 2016. Ma è un timore che affiora
ciclicamente in tutta la Turchia anche per la sua storia più recente: i militari
hanno sempre avuto un ruolo molto attivo in politica a tal punto da aver
organizzato colpi di Stato nel momento in cui ritenevano in pericolo la
Costituzione repubblicana. Erdogan non ha mostrato alcun dubbio. Il Sultano ha
accusato gli ex ammiragli dicendo che quella dichiarazione non era da
considerare frutto della libertà di espressione ma un messaggio che racchiudeva
l’ipotesi di un golpe. “Questo atto, avvenuto a mezzanotte, è sicuramente in
malafede”, ha detto Erdogan, sia “nel tono” che “nel metodo”. “Non è in nessuna
circostanza accettabile per ammiragli in pensione fare un tale attentato nel
cuore della notte in un Paese la cui storia è piena di colpi di stato e
memorandum”, ha aggiunto Erdogan una volta terminato il vertice con il capo
dell’intelligence, il capo di stato maggiore e i principali membri del
gabinetto. E per adesso non sembrano esserci annunci di alcuna marcia indietro.
La raffica di arresti è particolarmente interessante per tutta la Turchia. Non è
un mistero che Ankara da tempo viva una situazione fatta di arresti e di accuse
di cospirazioni e tentativi di golpe. E tutto questo si è ampiamente accentuato
dopo il fallito golpe del 2016, vero momento di svolta della politica di Erdogan
sia a livello interno che a livello esterno. Ma fa riflettere che a finire
questa volta sotto la scure della procura turca sia quel mondo kemalista e
nazionalista che in realtà sembrava aver ottenuto il sostegno dallo stesso
presidente dopo il fallito golpe. Lo dimostra l’importanza che Mavi Vatan ha
assunto in questi anni nel dibattito pubblico turco, ma lo conferma anche il
fatto che i suoi principali ideologi sono diventati personaggi noti al grande
pubblico proprio dopo il 2016, anno in cui Erdogan non solo ha ricominciato a
interessarsi al mare, ma anche a ricucire i rapporti con l’universo dei militari
kemalisti. Per il mondo di Gurdeniz e degli alti ufficiali di Marina turchi, il
momento in cui la Patria Blu è diventata parte della strategia nazionale ha
rappresentato il vero punto di svolta di una rapporto difficile con
l’Akp iniziato già anni prima, quando la Marina era stata completamente
decapitata da un’altra pesantissima raffica di arresti che aveva coinvolto anche
in quel caso il contrammiraglio Gurdeniz. Era il 2011, l’esplosione dei processi
“Ergenekon” e “Sledgehammer” portò alla condanna del contrammiraglio e di altri
ufficiali di Marina. Un’altra lunga notte che la moglie dell’ammiraglio ricorda
benissimo e che, intervistata a Cumhuriyet, ha messo in parallelo con quanto
accaduto in queste ore: “Dieci anni fa, abbiamo avuto un processo di tre anni e
mezzo. Adesso è un déjà vu in tutte le sue forme. Sento che stanno accadendo le
stesse cose e sono preoccupata sia per me che per il mio paese. Questi uomini
hanno espresso un’opinione, e in nessun altro paese al mondo sarebbe avvenuta
un’indagine per questo motivo”. In quell’occasione, Gurdeniz accusò
indirettamente gli Stati Uniti di essere il vero mandante degli arresti, e in
molti articoli si cita proprio il pericolo nato dalla rete del
predicatore Fetullah Gulen. La sua teoria è che gli apparati turchi più
atlantisti avrebbero provveduto a decapitare la Marina prima che potesse
aumentare la propria forza e soprattutto provare a spostare il baricentro turco
verso una progressiva autonomia strategica. Gli stessi indiziati – nella
prospettiva di Erdogan – del fallito colpo di mano del 2016. Una ferita che si è
chiusa solo momentaneamente dopo il golpe ma che ha iniziato a riaprirsi in
questi ultimi mesi in cui la Patria Blu, Mavi Vatan, sembrava in grado di essere
la dottrina portante della strategia turca. Ricordiamo infatti che l’altro alto
ufficiale che si era prodigato per Mavi Vatan, l’ammiraglio Yachi, aveva subito
un decreto presidenziale con cui si ordinava la sua degradazione. Onta che Yachi
ha preferito evitare dimettendosi e tornando a insegnare all’università, ma che
ha comunque fatto comprendere allo stesso Gurdeniz di dover stare
particolarmente attento ai movimenti del governo. Ora, con la nuova ondata di
arresti, l’impressione è che Erdogan abbia effettuato due azioni in
contemporanea. Da un lato ha fermato quella componente della Marina che ha
spinto per una nuova dottrina molto pervasiva della strategia del Paese e che si
rifà apertamente ad Atatürk. Una scelta diametralmente opposta all’islamismo
erdoganiano dell’Akp e alle direttive di Devlet Bahçeli, regista oscuro della
politica del Sultano e artefice della svolta estremista degli ultimi tempi
confermata dall’uscita dalla Convenzione per i diritti delle donne. E questo
probabilmente ha inciso (e non poco) sulla rapidità con cui i funzionari turchi
hanno proceduto all’arresto della scorsa notte. Erdogan ha sfruttato la Patria
Blu per espandere la proiezione di forza turca nell’Egeo e nel Mediterraneo
orientale, gli serviva dopo l’ondata di arresti per il presunto golpe, e
soprattutto aveva bisogno di quella lettura geostrategica indipendente da
Washington. Dall’altra parte, il presidente turco ha fatto intendere a tutti i
partiti e movimenti extra-governativi che non saranno tollerate “fughe in
avanti”, mettendo bene in chiaro che la giustizia è di nuova pronta a
intervenire. E a tal proposito, non va dimenticato che questo mese ci sarà una
vera e propria resa dei conti tra Erdogan e gli accusati del golpe del 2016, con
33 processi in programma e 816 imputati. Già mercoledì sarà data lettura della
sentenza per 497 imputati per quello che viene chiamato il processo alla
“guardia presidenziale”. E con gli arresti in Marina il giro di vite sembra
essere sempre più netto. Questi arresti sono anche un segnale di una nuova
politica strategica turca? La domanda ora affiora con le analogie per i processi
del 2011. Arrestando Gurdeniz, l’impressione è che la sua Mavi Vatan possa
essere trasformata nuovamente in una dottrina che serpeggia nelle patrie galere
e non più, come avveniva fino a pochi giorni fa, nei talk show televisivi e sui
manifesti in giro per le strade. Patria Blu si presentava come la dottrina
strategica di ascesa della potenza navale turca, ma anche come un segnale di
riscossa dei kemalisti. In assenza del suo ideologo e con l’arresto di così
tanti ex ammiragli, potrebbe anche essere l’inizio di un’ulteriore nuova era di
rapporti tra Ankara e il Mediterraneo. La questione del Bosforo diventerà
pertanto centrale per capire da che parte vorrà dirigersi la Turchia anche sul
fronte marittimo. Russia e Stati Uniti osservano con molto interesse. Montreux
interessa a entrambi e a nessuno sfugge che il Bosforo e il prossimo Canale di
Istanbul rappresentano prima di tutto le porte di Mosca per il Mediterraneo. Una
Turchia che mette in dubbio l’accordo sul transito in quello stretto è un
problema che il Cremlino non potrà certo sottovalutare: specialmente se andrà
avanti il piano del nuovo canale.
Per Erdogan un matrimonio funziona se
picchi la moglie: Turchia, altro colpo alla laicità.
Libero Quotidiano il 22 marzo 2021. Erdogan assesta un nuovo colpetto allo Stato
laico trascinando la Turchia fuori della Convenzione europea contro la violenza
sulle donne. E dire che il documento in questione era stato sottoscritto dai
Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa proprio a Istanbul nel 2011. La mossa
del Sultano è, come detto, l'ennesima di una lunga serie; soltanto il giorno
prima la magistratura turca aveva iniziato a vagliare la richiesta governativa
di bandire il partito curdo (moderato) Hdp. L'uscita dalla Convenzione di
Istanbul è un favore agli amici di lunga data del presidente e leader islamista,
cioè i religiosi sunniti, che Recep Tayyip sta cercando con successo di tenere
alleati alla destra nazionalista. Insomma: un colpo al curdo e uno alla
laicità. Dei 47 Paesi del Consiglio d'Europa (organismo non Ue che vigila sul
rispetto dei diritti dell'uomo) 34 avevano firmato e ratificato il documento.
Ora restano 33 con la Turchia che raggiunge la Russia fra quelli totalmente
contrari. Gli altri (tra cui Armenia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Moldavia, Slovacchia, Cechia, Regno Unito, Ucraina) hanno firmato ma poi i
rispettivi parlamenti non hanno ratificato. Gli ambienti religiosi turchi non
hanno mai digerito in particolare l'articolo 37 e il 42, il primo contro il
matrimonio forzato, il secondo sul delitto d'onore, entrambi diffusi nelle aree
arrretrate dell'Anatolia. Ma tutti i numeri sulla violenza contro le donne in
Turchia sono drammatici. Secondo i dati della piattaforma contro i femminicidi
(Kadin Cinayetlerini durduracagiz platformu), nel 2021 sono già state uccise 74
donne per mano di uomini, dopo che nel 2020 erano stati contati almeno 300 casi
e 171 fra morti e suicidi sospetti. Nel 2019 e nel 2018 in Turchia erano stati
contati rispettivamente 474 e 440 femminicidi. Tra i casi ritenuti sospetti non
ci sono solo le morti avvenute in circostanze ancora da chiarire ma anche i
suicidi, a cui molte donne si trovano costrette dal clima familiare di ripudio e
odio che può scattare per una relazione che la famiglia non approva, o per aver
rifiutato matrimoni combinati. La magistratura, ancora in parte laica, ha
cercato di porre un freno, con 5.748 condanne a pene detentive inflitte lo
scorso anno. Un numero minimo, se si considera che, in base ai dati forniti dal
ministero degli Interni, nel 2020 ben 271.927 uomini sono stati soggetti a
restrizioni imposte da autorità giudiziaria, 6.050 uomini sono stati condannati
per violenza domestica, 99 donne sono state costrette a cambiare identità e
residenza e 409 hanno dovuto abbandonare il luogo di lavoro. Migliaia di donne
sono scese in piazza ieri a Istanbul per protestare contro la decisione del
governo. Con loro anche attivisti gay e lesbiche. Il motivo della presenza di
questi ultimi è che la Convenzione non si occupa delle donne in senso biologico
ma in base alla "teoria del genere". Nell'art.3 (Definizioni), al comma c, si
specifica che l'identità sessuale è «socialmente costruita». La formulazione è
tuttora contestata anche da altri Paesi, in particolare dalla Polonia. Discussi
sono anche gli articoli 60 e 61 che impegnano i firmatari a concedere permessi
di soggiorno alle donne migranti vittime di abusi.
·
Quei
razzisti come i marocchini.
Era reclusa da giugno in carcere.
Ikram Nzihi libera, svolta per la studentessa italo-marocchina condannata per
una vignetta sull’Islam. Fabio Calcagni su Il
Riformista il 23 Agosto 2021. La giovane studentessa
italo-marocchina Ikram Nzihi “a breve sarà liberata”. A darne l’annuncio oggi è
stato il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a Marrakech, a
margine dell’udienza in appello a carico della studentessa 23enne. Ikram
Nzihi, nata in Italia da genitori marocchini e studentessa di giurisprudenza a
Marsiglia, era stata condannata a tre anni per offese contro la religione per
aver condiviso una vignetta satirica su Facebook sull’Islam nel 2019 e dallo
scorso giugno era reclusa in carcere. “Nel processo d’appello sono
state ascoltate le ragioni della difesa e, grazie all’ottima collaborazione
istituzionale con le autorità locali, Ikram uscirà di prigione. La nostra
connazionale sta bene, a lei e alla sua famiglia vanno i miei migliori auguri”,
ha sottolineato Amendola. “In queste settimane – ha aggiunto il sottosegretario
– abbiamo lavorato insieme al nostro ambasciatore a Rabat Armando Barucco, al
Consolato e di concerto con il ministro Di Maio e la Farnesina. Ad agosto ho
seguito il caso personalmente, parlando con le parti interessate e andando a
trovare Ikram Nzihi nel luogo di detenzione. Continuano i solidi rapporti tra
Italia e Marocco, frutto di un partenariato strategico”. Soddisfazione per il
risultato è stata espressa anche dalla Farnesina. Voglio ringraziare
l’Ambasciatore italiano in Marocco Armando Barucco e il sottosegretario Enzo
Amendola per l’impegno che hanno dedicato alla causa. Assieme abbiamo seguito la
vicenda dal primo momento, avendo a cuore unicamente il benessere della nostra
connazionale, nel pieno rispetto del lavoro delle istituzioni e della giustizia
marocchine”, ha affermato il ministro Di Maio. Ikram era stata fermata lo scorso
20 giugno all’aeroporto di Marrakech dalla polizia di frontiera: era giunta nel
Paese dalla Francia per raggiungere la famiglia in vista dell’Eid al Fitr (Festa
del sacrificio) del 21 luglio. Una volta mostrati i documenti alla dogana, è
stata accusata di aver “offeso pubblicamente l’Islam” per un post satirico su
Facebook pubblicato nel 2019.
·
Quei
razzisti come gli egiziani.
Egitto, condannato a cinque
anni l’attivista Alaa Abdel Fattah.
Marta Serafini Il Corriere
della Sera il 20 dicembre 2021. Quattro anni al suo avvocato e al blogger
Mohamed «Oxygen». Tutti e tre accusati di diffusione di notizie false. Non si
fermano le condanne in Egitto agli attivisti per i diritti umani. Il noto
blogger Alaa Abdel Fattah, attivista per i diritti umani e protagonista della
rivoluzione del 2011, è stato condannato a cinque anni. Condannati anche il suo
avvocato Mohamed el-Baqer e il blogger Mohamed «Oxygen» Ibrahim entrambi a
quattro anni. I tre imputati erano accusati di «diffusione di notizie false»,
stessa accusa per cui Patrick Zaki, dopo il rilascio, dovrà comunque presentarsi
a processo il primo febbraio. Alaa Abdel Fattah e Mohamed el-Baqer sono accusati
di aver criticato le autorità circa il trattamento dei detenuti e per alcuni
decessi in custodia avvenuti in circostanze sospette; Mohamed «Oxygen» Ibrahim,
invece, per aver denunciato sui social media il mancato rispetto dei diritti
sociali ed economici da parte del governo. «I loro scritti non hanno in alcun
modo incitato alla violenza e all’odio e i tre avrebbero dovuto essere tutelati
dalla costituzione egiziana e dagli obblighi internazionali in materia di
libertà d’espressione», sottolinea Amnesty International. «Sono tre condanne
crudeli e senza appello, nei confronti di tre dissidenti e difensori dei diritti
umani che mai avrebbero dovuto mettere piede in una prigione. C’è grande
preoccupazione per l’impatto che queste condanne potranno avere sulle loro
condizioni di salute psicofisica. Chiediamo al presidente al Sisi di usare le
sue prerogative, in modo che queste condanne siano annullate», ha commentato
Riccardo Noury portavoce di Amnesty International in Italia. Alaa Abdel
Fattah era stato arrestato il 29 settembre 2019 così come Mohamed Baker, suo
avvocato, proprio mentre andava a incontrare il suo cliente in un ufficio della
procura. In occasione del loro trasferimento in carcere, nel mese di
ottobre, Alaa Abdel Fattah era stato bendato, denudato, preso a calci e a pugni
e, insieme a Mohamed Baker, sottoposto a insulti e minacce. La procura non ha
disposto indagini. Mohamed «Oxygen» Ibrahm era stato arrestato il 21 settembre
2019. Il 19 novembre 2020 un tribunale del Cairo aveva arbitrariamente aggiunto
Alaa Abdel Fattah e Mohamed Baker alla «lista dei terroristi» per cinque anni.
Oltre all’impossibilità di ricorrere in appello a un tribunale di grado
superiore, le procedure dei tribunali d’emergenza non riconoscono molti diritti,
come quello ad avere un periodo di tempo adeguato a preparare la difesa, a
comunicare coi propri avvocati difensori e a un’udienza pubblica. Alaa Abdel
Fattah e Mohamed Baker non hanno colloqui privati coi loro legali dal mese di
maggio. Alaa Abdel Fattah blogger, attivista e pensatore è uno dei protagonisti
della rivoluzione egiziana del 2011, che ha trascorso sette degli ultimi otto
anni in carcere insieme ad altri 60mila prigionieri politici egiziani. Il padre,
Ahmed Seif al Islam, fu imprigionato due volte sotto il presidente Anwar al
Sadat e altre due sotto Hosni Mubarak. Durante la prigionia fu torturato con
scariche elettriche e gli furono rotte le braccia e le gambe. Nonostante questo,
si laureò in legge nel carcere dove stava scontando una pena di cinque anni.
Uscito di prigione, fondò l’Hicham Mubarak center e divenne uno dei più
rispettati avvocati per i diritti umani in Egitto. La madre, Laila Soueif, è
docente di fisica e attivista della prima ora.
Marta Serafini per corriere.it il 7 dicembre 2021.
È iniziata - e terminata rapidamente dopo qualche minuto - stamattina a Mansura,
in Egitto sul delta del Nilo, la terza udienza del processo a carico di Patrick
Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna sotto accusa per
diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici e detenuto in
carcere esattamente da 22 mesi. Quando lo hanno portato velocemente in aula, non
era ammanettato. Era vestito di bianco come altre volte. Ha detto «sto bene», ma
era agitato. Due secondi al volo per parlare con la mamma e poi l’hanno portato
via. Si è appreso che uno dei due diplomatici italiani presenti in tribunale ha
potuto parlagli brevemente per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni
italiane e Patrick ha ringraziato per quello che l’Italia e l’Ambasciata stanno
facendo per lui. Il diplomatico italiano si era intrattenuto anche con i
genitori di Patrick poco prima. La legale di Patrick Zaki, Hoda Nasrallah, ha
chiesto l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità
durante l’arresto del 7 febbraio 2020 e sia la correttezza dell’articolo sui
copti alla base del processo. L’udienza, dopo l’intervento del legale, è stata
sospesa dopo appena 4 minuti. Al Tribunale non circolano ipotesi accreditabili
circa la possibile durata dell’interruzione.
Marta Serafini per corriere.it il 7 dicembre 2021.
Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da
quasi due anni con l’accusa di diffusione di notizie false, è formalmente
libero. Il giovane «non è stato assolto», ma verrà rilasciato dal carcere nelle
prossime ore e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1 febbraio.
L’ordine di scarcerazione — secondo fonti legali vicine a Zaki — è stato già
firmato. Hoda Nasrallah, la legale di Zaki, ha confermato al Corriere che il
rilascio dovrebbe avvenire a breve dal carcere di Tora al Cairo. Lobna Darwish
di Eipr, la Ong con cui collaborava Zaki e che si occupa della sua difesa
legale, ha confermato al Corriere che Zaki a breve verrà trasferito al Cairo.
L’annuncio è stato accolto con un urlo di gioia nel tribunale di Mansoura, dove
oggi si è svolta una nuova udienza del processo. Alla base del procedimento
contro Zaki — che al momento dell’arresto aveva 28 anni, e ne ha compiuti 30 in
una cella egiziana — c’erano tre articoli giornalistici sulla persecuzione dei
cristiani copti in Egitto. L’Italia, nei mesi scorsi, aveva trattato e ricevuto
assicurazioni per ottenere che la condanna corrispondesse al tempo che Zaki
aveva già trascorso in carcere. «Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è
più in carcere», ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.
«Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un
doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico». «Quando lo hanno arrestato
nel febbraio 2020 abbiamo aspettato per ore all’aeroporto del Cairo sperando di
vederlo arrivare, aveva appena passato i controlli, “tutto bene mamma”, mi ha
detto per telefono. Poi lo hanno fermato», ha detto la madre di Zaki nei giorni
scorsi al Corriere. «Diceva sempre così Patrick. “Tutto bene”». Il 20 novembre a
Zaki è stato riconosciuto il premio Cutuli. «Mi piacerebbe scrivere presto per
il Corriere della Sera», aveva fatto sapere il ricercatore attraverso la sorella
Marise in occasione della premiazione. Il Corriere, come promesso, si augura
presto di poter pubblicare il suo articolo.
Patrick Zaki sarà scarcerato, le mani
gelate della sorella e poi l’urlo liberatorio del papà: «Grazie Italia».
Marta Serafini su Il Corriere della Sera il 7 Dicembre 2021.
MANSOURA — Una giornata che sono cento. E che cambia temperatura come le mani di
Marise, la sorella di Patrick. Fredde come il ghiaccio mentre il giudice si
prende il suo tempo per deliberare. «Grazie, grazie, per quello che state
facendo per lui». E Marise si tormenta la manica del maglione blu mentre gli
occhi non smettono di correre in giro. Vedere il fratello durante la prima parte
dell’udienza, anche solo per pochi minuti, ha portato un po’ di caldo nelle
vene. Ma è durato poco, troppo poco, dopo 22 mesi di angoscia. «È riuscito a
salutare la mamma era tanto che non si vedevano, almeno un mese», sussurra. E
lui è ancora lì, dietro le sbarre. Poi tutti fuori dall’aula, in mezzo ai
parenti degli altri detenuti. Una guardia con la pistola viene a controllare i
documenti. Le voci iniziano a rimbalzare. «Ci sarà un rinvio». Si rientra.
Marise e mamma Hala in prima fila si stringono l’una all’altra. Le mani sono
calde ora, il sangue circola più veloce. Nell’altro banco Hoda Nasrallah,
l’avvocata della Eipr, la ong con cui Patrick collaborava, sta ferma immobile
con la schiena dritta, nei banchi dietro di lei, tutti gli attivisti e i
compagni della Eipr. Poi i rappresentati diplomatici della delegazione di
osservatori voluta dall’ambasciata italiana. Entrambi che non smettono di andare
avanti e indietro. «L’ho visto bene, dai, meno nervoso delle altre volte». In
ultima fila papà George. C’è tempo per due parole. «Io non dico niente. Solo
pensarlo a casa mi pare impossibile, un sogno. Ma grazie, grazie davvero». Nella
gabbia c’è un detenuto «comune», un uomo che ha firmato un assegno in bianco.
«Il giudice ora ordinerà il suo rilascio», dice qualcuno. E di nuovo le mani di
Marise sono di ghiaccio. Rientra il giudice, c’è via vai con il banco. Mr.
Salim, l’avvocato dell’ambasciata italiana, che tutti conosce e tutto sa
sussurra piano, «buon segno, buon segno». Il magistrato dà la notizia
all’avvocata: Patrick sarà liberato . Ecco l’urlo di Hala e Marise. «Mabrouk,
mabrouk» congratulazioni, come per una nascita. «Tamem, tamem», va tutto bene,
va tutto bene, la frase che Patrick ripete sempre alla mamma. I funzionari del
tribunale fanno allontanare tutti. In strada Hoda e Lobna Darwish, dirigente
della Eipr che fin qui è rimasta ferma in mezzo alla tempesta, si abbracciano
stretto. Lacrime, sorrisi, pacche sulle spalle. Da Bologna arriva il messaggio
della professoressa Rita Monticelli, del master. «Lo aspetto, aspetto qui».
Marise e Hala si precipitano a cercare del cibo. Patrick non mangia da domenica.
«Ma dov’è Patrick ora? Dove lo portano?». Forse lo rilasciano già oggi, forse
no. Forse prima lo riportano a Tora. Forse esce qui a Mansoura. Forse. C’è chi
salta in auto e parte per il Cairo, chi resta. Poi cala il silenzio. E restano i
clacson incessanti della città. Iniziano a rimbalzare le notizie. «Marise dov’è
Patrick ora? L’hanno rilasciato?». «Non sappiamo niente di certo. Non l’abbiamo
ancora visto». Il sole cala sulla casa dove Patrick è cresciuto e dove lo
aspettano. Le mani tornano ad essere fredde. Lobna della Eipr paziente risponde
a tutti. «Dovrebbero avergli fatto firmare dei documenti». Marise va al
commissariato a verificare se hanno portato lì Patrick. «No, niente». Anche
all’ambasciata italiana aspettano. I telefoni accesi fino a tardi. Papà George
spera ancora sia per oggi. Ma alla stazione di polizia dove Patrick dovrebbe
essere portato dalla prigione di Mansoura sono chiari. «Non è ancora qui. Forse
è al dipartimento della Nsa, l’intelligence egiziana». Ed è di nuovo freddo.
Sudore ghiacciato sul palmo delle mani. Patrick non è ancora fuori.
Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non
assolto. Albert Voncina su L'Espresso l'8 Dicembre
2021. Il ricercatore egiziano dell’università di Bologna potrà uscire dal
carcere dopo 22 mesi di reclusione. La prossima udienza è prevista il primo
febbraio. Rilasciato, ma non assolto. Il ricercatore dell’università di Bologna
Patrick Zaki potrà finalmente uscire dal carcere, dove è rinchiuso dal 7
febbraio 2020, e potrà attendere la prossima udienza prevista il prossimo primo
febbraio lontano dalle sbarre che lo hanno circondato per 22 mesi. Lo ha
stabilito oggi la corte di Mansoura, dove Zaki è stato trasferito nei giorni
scorsi dal carcere cairota di Tora, in cui aveva trascorso quasi tutta la sua
custodia cautelare. Lo studente egiziano sarà dunque libero, «anche se non è
stato assolto» dalle accuse, come riferito da alcuni avvocati al termine
dell’udienza. Ad attendere all’esterno dell’aula del tribunale la sentenza su
Patrick - vestito di bianco, colore simbolo degli imputati - c’erano il padre
George, la madre Hela, la sorella Marise, gli amici e alcuni attivisti. Oltre ai
legali di Zaki in tribunale erano presenti anche due diplomatici italiani. Alla
loro domanda su come stesse, lo studente ha risposto: «Bene, bene, grazie». Zaki
potrebbe essere liberato già nelle prossime ore, anche se per il momento non c’è
alcuna conferma ufficiale. A Patrick, secondo quanto si apprende, non è stato
imposto l’obbligo di firma in vista della prossima udienza, fissata il primo
febbraio. «Abbiamo appreso che la decisione è la rimessa in libertà ma non
abbiamo altri dettagli al momento», ha spiegato la legale Hoda Nasrallah
all'Ansa. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso con una nota di
Palazzo Chigi soddisfazione per la scarcerazione di Zaki, la cui vicenda è stata
e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano.
Immediata anche la reazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Primo
obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a
lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al
nostro corpo diplomatico», ha scritto Di Maio su Twitter. «Un enorme sospiro di
sollievo perché finisce il tunnel di 22 mesi di carcere e speriamo che questo
sia il primo passo per arrivare poi ad un provvedimento di assoluzione. L'idea
che Patrick possa trascorrere dopo 22 mesi una notte in un luogo diverso dalla
prigione ci emoziona e ci riempie di gioia. In oltre dieci piazze italiane
questa sera scenderemo con uno stato d'animo diverso dal solito e più
ottimista», commenta Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International
Italia. «La notizia che tanto aspettavamo. Patrick Zaki sarà scarcerato.
Speriamo presto di poterlo riabbracciare qui a Bologna», ha invece esultato il
sindaco di Bologna Matteo Lepore. Una sentenza, quella emessa durante la terza
udienza a carico dello studente 30enne, tutt’altro che scontata. Contro Patrick
ci sono diversi capi di accusa, per cui rischia fino a cinque anni di carcere.
Il mandato di cattura contiene le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale,
incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false
e propaganda per il terrorismo.
Lo studente 30enne detenuto da 22 mesi
per “diffusione di notizie false”. Patrick Zaki
scarcerato ma non assolto, la svolta all’udienza in Egitto. Antonio Lamorte su
Il Riformista il 7 Dicembre 2021. Patrick George Zaki sarà scarcerato ma non
assolto. È quanto fa sapere l’Ansa da Mansoura, in Egitto, dove lo studente è
detenuto e dove stamane al Palazzo di Giustizia si è tenuta la terza udienza sul
caso. Il 30enne, ricercatore e studente all’Università di Bologna è in carcere
da 22 mesi, dal febbraio 2020, con l’accusa di “diffusione di notizie false”. La
notizia è stata confermata da alcuni avvocati all’esterno del Palazzo di
Giustizia. Non è ancora stato chiarito ma la scarcerazione potrebbe avvenire già
tra oggi e domani. L’ordine sarebbe stato comunque già firmato. La decisione è
stata accolta con urla di giubilo all’interno del tribunale. Zaki dovrà
ricomparire davanti alla Corte il prossimo 1 febbraio. “Sto bene, grazie
Italia”, le parole del 30enne, in una cella nel Palazzo di Giustizia di Mansoura
dove si è tenuta l’udienza, a un diplomatico italiano come riportato dall’Ansa.
Presenti, come nelle precedenti udienze, due diplomatici italiani, su richiesta
dell’Ambasciata italiana anche funzionari di altri Paesi (USA, Spagna, Canada),
un avvocato della Delegazione dell’Unione Europea e un legale di fiducia della
rappresentanza diplomatica italiana al Cairo. Tutti per monitorare il processo
come prima avevano fatto per tutte le sessioni di rinnovo della custodia
cautelare. Zaki non era ammanettato ed era vestito di bianco quando è arrivato
in aula. Da poco è stato trasferito dalla prigione di Tora, nei pressi de Il
Cairo, a quella di Mansoura, vicino casa sua. “In carcere ha freddo, nemmeno una
coperta, ha ancora fortissimi dolori alla schiena. Non gli lasciano i libri per
continuare a studiare”, ha detto a Il Corriere della Sera la madre Hala,
intervistata nella casa dove lo studente è cresciuto. “Non gli fanno avere né
acqua né cibo”, ha aggiunto il padre George. A soli quattro minuti dall’inizio
l’udienza era stata sospesa: la legale del ragazzo, Hoda Nasrallah, ha chiesto
l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante
l’arresto del 7 febbraio 2020 e sia la correttezza dell’articolo sui copti alla
base del processo. Articolo che era comparso sul sito Darj. Zaki è accusato di
propaganda sovversiva per alcuni post sui social network e per alcuni articoli
sulle persecuzione ai danni dei cristiani copti. È stato arrestato il 7 febbraio
2020, appena atterrato per una vacanza in Egitto. Da allora la sua custodia in
carcere è stata puntualmente rinnovata. Il rinvio a giudizio è arrivato per
“diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” sulla base di un articolo
scritto dallo stesso studente. Zaki era arrivato a Bologna dopo aver vinto una
Borsa di Studio per un master Gemma dedicato agli studi di genere e delle donne.
La nota della Presidenza del Consiglio: “Il Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick Zaki, la cui
vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo
italiano”. La giornalista di Rai3 e del quotidiano Domani ha fatto sapere di
aver “appena parlato al padre di Patrick. Dovrebbe uscire alle 18. È molto
contento e ringrazia tutti”.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
Zaki ritrova la libertà: "Grazie Italia".
Chiara Clausi su Il Giornale l'8 dicembre 2021. Un
abbraccio e un pianto liberatorio. È stato quello tra la sorella di Patrick
Zaki, Marise, e la madre, Hala, dopo una notizia attesa da quasi due anni.
Patrick, il ricercatore egiziano di 30 anni, che frequentava un master in Studi
di Genere all'Università di Bologna in carcere da 669 giorni, è stato liberato.
Non è ancora stato assolto però, e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il
primo febbraio. Patrick, durante i 4 minuti in cui è stato in aula fuori dalla
gabbia, era vestito di bianco, colore simbolo degli imputati, portava una
mascherina nera calata sul mento, codino, occhiali rotondi. Come sempre. Fuori
dall'aula del tribunale insieme alla madre e alla sorella, c'erano anche il
padre e gli amici. Lo studente invece non era in aula al momento dell'annuncio.
Ma poco prima dell'inizio dell'udienza aveva detto «grazie, grazie sto bene»
alzando il pollice. Il padre di Patrick, George, dopo la decisione, ha
abbracciato i due diplomatici italiani presenti all'udienza e ha detto: «Vi
siamo molto grati per tutto quello che avete fatto». Zaki era stato da poco
trasferito dal carcere cairota di Tora, dove ha trascorso quasi tutta la sua
custodia cautelare, dove dormiva per terra, a una prigione di Mansura, la sua
città natale. Immediatamente dopo l'arresto, aveva raccontato il suo avvocato,
Patrick era stato torturato. Picchiato, spogliato, bendato, sottoposto a scosse
elettriche sulla schiena e sull'addome, insultato verbalmente. Per molti mesi
gli era stata negata la possibilità di comunicare con l'esterno e di ricevere
visite dalla famiglia, anche se ufficialmente era stato detto a causa
dell'emergenza coronavirus. Ma non finisce qui. C'erano state gravi polemiche
sul fatto che le autorità egiziane gli stessero negando le cure mediche. Patrick
soffre di asma, oltre che di ansia e depressione. Il suo dolore alla schiena si
era aggravato ed era molto dimagrito negli ultimi tempi. Ma la partita non è
conclusa. In tribunale, la legale, Hoda Nasrallah, ha chiesto l'acquisizione di
altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante l'arresto avvenuto
il 7 febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo che la correttezza dell'articolo sui
copti alla base del processo. I capi d'accusa menzionati nel mandato di arresto
sono minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali,
sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Inoltre,
Patrick avrebbe compiuto propaganda sovversiva attraverso alcuni post pubblicati
su Facebook. Il rinvio a giudizio è avvenuto invece per «diffusione di notizie
false dentro e fuori il Paese» sulla base di tre articoli scritti da Zaki. In
particolare ne spicca uno, scritto nel 2019, sul giornale Daraj, sui cristiani
copti in Egitto perseguitati dallo Stato Islamico, e discriminati da alcuni
segmenti della società musulmana. Tema caro a Zaki perché anche lui appartiene
alla comunità copta egiziana. Subito dopo la sentenza è arrivato il commento di
Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia: «È un enorme sospiro
di sollievo perché finisce il tunnel di 22 mesi di carcere e speriamo che questo
sia il primo passo per arrivare a un provvedimento di assoluzione», ha
dichiarato. «Non me l'aspettavo. Non siamo abituati a ricevere buone notizie sul
processo, ma oggi sono molto contento per lui, la sua famiglia e per tutti
quelli che hanno portato avanti la campagna per la libertà di Patrick». ha
raccontato Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di
studi di Patrick Zaki, quando frequentava il master in studi di genere
all'Università Alma Mater di Bologna.
Free PatrickZaki è libero, ma l’Egitto
continuerà il suo assurdo processo politico.
Futura D’Aprile su L'Inkiesta.it il 7 dicembre 2021. Il giovane egiziano è stato
scarcerato dopo 22 mesi di detenzione, ma la prossima udienza del primo febbraio
2022 potrebbe concludersi con una condanna definitiva. Rischia fino a 5 anni di
carcere a causa di un articolo in cui si denunciavano i mancati provvedimenti
del regime di al-Sisi per garantire la sicurezza della minoranza dei cristiani
copti. Dopo ventidue mesi di carcere, Patrick Zaki è tornato libero, per ora.
Il 7 dicembre il tribunale egiziano ha ordinato la scarcerazione del giovane
studente iscritto all’Università di Bologna e detenuto in Egitto dal febbraio
2020 con l’accusa di “diffusione di notizie false dentro e fuori il paese”. Il
caso Zaki però non può dirsi ancora concluso. Le accuse contro il giovane sono
ancora in piedi e il primo febbraio 2022 si attende la nuova udienza. Lo
studente rischia fino a 5 anni di carcere per diffusione di false informazioni a
causa di un articolo in cui si denunciavano i mancati provvedimenti del regime
di Abdel Fattah al-Sisi per garantire la sicurezza della minoranza dei cristiani
copti, a cui lo stesso Zaki appartiene. Nonostante ciò, la notizia della
scarcerazione è stata accolta con grande gioia all’interno dell’aula, dove erano
presenti i parenti del giovane oltre alla delegazione dell’Unione europea, due
diplomatici italiani e alcuni funzionari delle ambasciate di Stati Uniti, Spagna
e Canada. I legali di Zaki temevano l’ennesimo prolungamento della detenzione
preventiva, a cui il giovane è stato sottoposto negli ultimi ventidue mesi. Le
udienze tenutesi fino a ieri si sono sempre concluse con un nulla di fatto e con
un rinnovo della detenzione del giovane, trasferito tra l’altro dal carcere di
Mansura, sua città natale, a quello di Tora al Cairo, noto per la durezza dei
trattamenti riservati ai detenuti. Per più di cinque mesi gli è stato anche
negato il diritto a ricevere visite familiari, ufficialmente a causa delle
restrizioni imposte dal governo per contenere i contagi da coronavirus.
La difesa
L’udienza in cui si è decisa la scarcerazione di
Zaki è stata breve. La sospensione è arrivata dopo soli quattro minuti, dopo che
il capo del team della difesa, Hoda Nasrallah, aveva chiesto di aver accesso a
tutte le prove a carica del suo cliente, facendo specifico riferimento alle
immagini delle telecamere di sicurezza dell’aeroporto del Cairo. Zaki è stato
fermato il 7 febbraio durante il controllo passaporti e portato in un edificio
della National security agency dove, secondo i suoi avvocati, sarebbe stato
picchiato, torturato con scosse elettriche, abusato verbalmente e minacciato di
stupro.
Nelle carte delle indagini, però, è riportato che
il giovane è stato arrestato l’8 febbraio a Mansura, mentre era nell’abitazione
della sua famiglia. Tramite le registrazioni dell’aeroporto, la difesa vuole
invece dimostrare che Zaki è stato prelevato appena atterrato in Egitto e che il
suo arresto è stato formalizzato solo 24 ore dopo. Gli avvocati hanno anche
richiesto l’accesso al verbale redatto dal funzionario della Sicurezza nazionale
riportante l’arresto al Cairo e a quello in cui viene ufficialmente registrato
il fermo a Mansura del giovane. La difesa ha anche chiesto di poter ascoltare la
testimonianza del fratello di un soldato cristiano ucciso da terroristi
islamici, per dimostrare che quanto riportato da Zaki nell’articolo uscito nel
2019 sul portale el-Daraj corrisponde al vero.
La stampa egiziana
La notizia dalla scarcerazione di Zaki ha riempito
i media italiani, ma ha invece trovato poco spazio in Egitto. Alcuni giornali
online indipendenti in lingua inglese e che sfuggono alle maglie della censura
hanno dato la notizia della sentenza emessa ieri dal giudice, ma la questione è
passata abbastanza sotto traccia nel paese nordafricano. Il tema d’altronde è
piuttosto delicato. Zaki è ufficialmente accusato di diffusione di notizie
false, ma le motivazioni hanno una forte connotazione politica e riguardano sia
il trattamento riservato nel paese alla minoranza copta, quanto (più
indirettamente) il lavoro svolto dal giovane a Bologna all’interno della
comunità Lgbt.
I rapporti con il Cairo
Eppure i rapporti tra Egitto e Italia in questi
ventidue mesi non hanno subito alcuna modifica. I due paesi continuano ad avere
normali rapporti diplomatici e commerciali, come dimostra anche la recente
partecipazione delle maggiori aziende dalla Difesa all’Expo militare tenutosi al
Cairo. D’altronde nemmeno l’omicidio del ricercatore Giulio Regeni e i continui
depistaggi operati dai servizi di intelligence e di sicurezza sono stati
sufficienti perché il governo italiano facesse le dovute pressioni alla
controparte egiziana. Per quanto riguarda quest’ultima vicenda, si attende
adesso la data del 10 gennaio, quando si terrà una nuova udienza davanti dal Gup
di Roma dopo la pubblicazione della relazione finale della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte del giovane ricercatore. Una data vicina a
quella della prossima udienza di Patrick Zaki, che potrebbe concludersi con una
condanna definitiva e senza appello.
Da ansa.it l'8 dicembre 2021. Patrick Zaki è stato
scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito, lo studente egiziano
dell'Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre.
"Tutto bene": queste le prime parole che Patrick Zaki ha pronunciato, parlando
in italiano, appena rilasciato. L'abbraccio è avvenuto in una stretta via su cui
affaccia il commissariato, fra transenne della polizia del traffico e un camion
con rimorchio. Per abbracciare la madre Patrick ha lasciato a terra un sacco
bianco di plastica che portava assieme a una borsa nera.
"Un abbraccio che vale più di tante parole.
Bentornato Patrick!". Lo scrive su Fb il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio, postando una foto dell'abbraccio tra Zaki e la
sorella all'uscita dal carcere.
"Aspettavamo di vedere quell'abbraccio da 22 mesi
e quell'abbraccio arriva dall'Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli
enti locali, l'università, i parlamentari che hanno fatto sì che quell'abbraccio
arrivasse".
Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty
International Italia commenta la notizia del rilascio di Zaki. "Un abbraccio -
dice Noury - soprattutto ai mezzi di informazione che hanno tenuto alta
l'attenzione per questi 22 mesi. Ora che abbiamo visto quell'abbraccio
aspettiamo che questa libertà non sia provvisoria ma sia permanente. E con
questo auspicio arriveremo al primo febbraio, udienza prossima".
Carlo Verdelli per il “Corriere della Sera” l'8
dicembre 2021. Nei giorni del naufragio della civiltà, appena denunciati con
forza disperata da papa Francesco, una notizia finalmente diversa,
controcorrente, di gioia invece che di ripetuto dolore. Un sommerso che invece
si salva, torna libero, si riguadagna un pezzo inatteso di futuro. Preparati a
lasciare la tua cella, Patrick Zaki, figlio sgradito d'Egitto, fratello di tanti
studenti italiani che ti hanno adottato. Questione di ore, massimo di giorni, e
l'incubo senza fine dove eri precipitato svanirà. O almeno dovrebbe,
condizionale d'obbligo quando si ha a che fare con Paesi che non praticano la
democrazia ma il suo contrario. Hai nelle ossa, nei polmoni, negli occhi
l'enormità di 670 giorni di carcere infame, senza materasso per dormire, senza
medicine per curarti l'asma, senza una colpa da cui difenderti né una ragione
per sopportare il fatto che di colpo, un giorno, il 7 febbraio 2020, a neanche
29 anni, ti hanno tolto all'improvviso la libertà. Ma tu hai resistito a tutto.
Ti sei aggrappato come un naufrago alla speranza che da qualche parte,
specialmente in quell'Italia dove eri stato studente per un master a Bologna,
non si erano dimenticati di te. E forse questo ha contato nell'esito clamoroso
di queste ore. Forse la mobilitazione di movimenti, università, città,
instancabile nonostante le frustrazioni dei ripetuti prolungamenti della tua
detenzione preventiva (45 giorni più altri 45 più altri 45), qualcosa ha smosso
nei meccanismi ineluttabili e perversi del potere. Forse la richiesta di
cittadinanza italiana, avanzata all'unanimità dalla maggioranza del Parlamento
che sostiene il nostro governo, ha aiutato una diplomazia impigrita da una
ragion di Stato che, in nome degli affari e delle convenienze strategiche, è
spesso capace di chiudere un occhio, e anche tutti e due. Forse hanno avuto un
peso le parole di Liliana Segre, quando si è spinta fino in Senato a Roma per
sostenerti: «Sono qui come nonna di Zaki, e come lui so che cosa vuole dire la
porta chiusa di una cella e l'angoscia che possa succedere di peggio quando si
apre». E forse, da ultimo, non è stata inutile anche la pressione di alcuni
giornali, e il Corriere della Sera è tra questi quando ancora ieri raccontava il
tormento dei tuoi genitori e di tua sorella, in attesa come tutto il mondo
libero di quello che ti sarebbe successo all'indomani, udienza importante del
tuo irreale calvario giudiziario. I fari tenuti accesi sul buio della tua
prigione hanno magari impedito che quel buio diventasse impenetrabile. Vero che
non è finita. Non è quasi mai finita quando c'è di mezzo un regime che si
considera arbitro e padrone delle vite degli altri, dei suoi cittadini, dei
sudditi. Dovrai ripresentarti davanti a una Corte egiziana il primo febbraio,
perché sarai anche libero ma non ancora assolto (da quale accusa, chissà).
Potrebbero decidere di tornare a rovinarti l'esistenza in qualsiasi momento. Ma
intanto sei praticamente fuori, potrai dormire prestissimo, una delle prossime
notti, nella tua casa di Mansoura, con la famiglia che ti ha aspettato ogni
secondo di questi 22 mesi, o magari anche tornare a studiare in quella Bologna,
dove in ogni tua lettera dal carcere bestiale di Tora, al Cairo, chiedevi di
poter ripartire dopo il tunnel dove ti avevano cacciato. «Riportatemi in piazza
Maggiore. Grazie alla città, alle bandiere gialle. Io combatterò per questo».
Combattere e vedere riconosciuto, in un giorno di festa, che non è impossibile,
che non è tutto inutile, è un segno che pretende un seguito. Le pressioni delle
piazze, della società civile, e l'effetto domino che determinano sulle
attenzioni di un Paese come l'Italia, possono davvero cambiare il corso delle
cose, anche per gli ultimi, le vittime più incolpevoli della perdita di
qualsiasi valore per il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano.
Salvato, per adesso, il soldato Zaki, arruolato in una guerra di inciviltà che
non lo ha mai riguardato, diventa ancora più urgente proseguire con convinzione
sulla stessa strada. È evidente che il prossimo passo, nei confronti
dell'Egitto, non può che avere a che fare con la riapertura del processo sulla
fine ignobile di Giulio Regeni. Quella vita meravigliosa non si può più salvare.
Ma almeno tutta la verità sulla sua esecuzione e i suoi assassini, ecco, quello
è un obiettivo non contrattabile, non più rinviabile, irrinunciabile. La
liberazione di Patrick è benedetta ma si completa soltanto con la fine
dell'omertà sullo studente Giulio, italiano del mondo.
Patrick Zaki è libero, ma le accuse non
sono cadute: «Grazie a chi mi ha sostenuto. Avete tenuto accesa la luce». Marta
Serafini su Il Corriere della Sera il 9 dicembre 2021.Intervista a Zaki,
scarcerato dopo 22 mesi: «In cella leggevo quel che potevo, il mio libro
preferito è “L’amica geniale”. E scrivevo, quando mi era permesso. Vorrei
pubblicare i miei diari. In carcere una delle cose che ti fa più soffrire è il
pensiero del dolore che provochi a chi ti vuol bene. Ora vorrei andare a Napoli.
E conoscere Liliana Segre»
«Sono ancora un po’ confuso, tutto sta andando
velocemente. Ma ora sono felice, sono qui con la mia famiglia, con tutte le
persone che amo. Tutto qui».
Non indossa più la tuta bianca dei detenuti in
attesa di giudizio, Patrick Zaki. È seduto nel salotto della sua casa di
infanzia a Mansoura. Alle sue spalle un arazzo di spugna che raffigura Cristo. È
il più calmo di tutti, nella stanza. Intorno a lui, il magico «dream team» di
donne. La sorella Marise, la fidanzata, un’amica, mamma Hala che, dopo 22 mesi
di lontananza, angoscia e paura, ora non lo perdono di vista un attimo. C’erano
loro ad aspettarlo fuori dal commissariato di polizia di Mansoura da cui è stato
rilasciato ieri dopo 670 giorni di detenzione. E ci sono loro mentre Patrick
entra nell’appartamento dove è cresciuto e sull’auto verso il Cairo. In salotto,
intanto, papà George non smette di sorridere un attimo. Zaki ha cambiato
montatura di occhiali («l’altra l’ho persa durante un trasferimento da una cella
all’altra»). La barba è lunga, il sorriso quello delle fotografie di prima
dell’arresto. Sotto il maglione scuro, la maglietta dell’Università di Bologna.
Poi i jeans preferiti. I palmi della mani, neri al momento del rilascio, ora
sono puliti. Intorno, la cagnetta Julie scodinzola felice.
Patrick, innanzitutto ben trovato. Quando hai
capito che stavi per tornare libero?
«Non mi hanno annunciato che sarei
stato rilasciato. All’improvviso mi hanno portato al commissariato, e hanno
iniziato a prendermi le impronte. Non capivo cosa stesse succedendo, non c’erano
segnali che mi stessero per scarcerare. Ero confuso. Non posso dire tutti i
dettagli e preferisco non parlare delle condizioni di detenzione. Ma poi ho
capito che c’era una speranza. È la speranza, sai, la cosa più difficile da
tenere in vita quando ti tolgono la libertà».
Hai abbracciato prima tua mamma, poi la tua
fidanzata e infine tua sorella Marise. Qual è stata la prima cosa che hai detto
a questo gruppo di donne che lotta per te da 22 mesi, insieme a tuo padre e
tutto lo staff della Eipr?
«Ho detto grazie. E poi “Temam”: va tutto bene».
Patrick ride, si interrompe.
La frase che hai sempre ripetuto a tua madre fin
da quando lei stava in angoscia nel 2011 ai tempi della rivoluzione e tu ti eri
trasferito a vivere al Cairo…
«Già. Una delle cose che più ti fa soffrire quando
sei in carcere è il pensiero del dolore che provochi alle persone cui vuoi bene.
Io devo solo dire grazie, grazie all’Italia per essere stata vicina a me e alla
mia famiglia. Grazie a tutti quelli che hanno tenuto accesa la luce. E l’elenco
è lunghissimo».
Abbiamo tempo, ora.
«Gli amici in ogni parte del mondo, che si sono
dati da fare per me. Ma anche la vostra delegazione diplomatica che è venuta
alle udienze. Poi l’università di Bologna. Tutti i compagni di master, ma in
particolare c’è una persona».
Chi è?
«La professoressa Rita Monticelli. È la mia
mentore al master Gemma a Bologna (quando Patrick è stato arrestato nel 2020
stava frequentando il primo semestre). Una persona che mi ha trattato come un
figlio. E non mi ha trasmesso solo conoscenza ma anche valori. L’empatia, il
rispetto. E l’ascolto. E poi mia sorella Marise. Ma sicuramente così faccio
arrabbiare qualcuno, mi fermo qui».
L’Italia si è adoperata per il tuo rilascio a più
livelli. Il premier Mario Draghi ha seguito costantemente il tuo caso. Il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio ti ha dedicato un abbraccio pubblico.
L’ambasciatore Quaroni ti ha chiamato al telefono.
«Vedere in aula i vostri rappresentanti
diplomatici durante le udienze mi ha dato forza. E sono sicuro che ci sono
decine e decine di altre persone cui dovrò stringere la mano».
Anche la società civile ha avuto un ruolo
fondamentale. «Aspettavamo di vedere quell’abbraccio da 22 mesi», ha commentato
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.
«Non dimenticherò mai tutte le volte in cui
durante le visite mi venivano raccontato delle manifestazioni, delle piazze. E
di tutte le iniziative organizzate per chiedere il mio rilascio in questi quasi
due anni».
La senatrice Liliana Segre ha votato per la
richiesta di cittadinanza dicendo di essere in Aula idealmente come tua nonna,
come persona che sa cosa vuole dire stare chiusa dentro stanza da cui non si può
uscire. Vuoi dirle qualcosa?
«Mi ha riempito di orgoglio sapere che una persona
del suo livello e della sua statura morale si sia interessata a me. Voglio
conoscerla. Assolutamente. Spero che questo avvenga quanto prima».
Patrick ora sei libero ma le accuse a tuo carico
non sono cadute. Il giudice ha fissato un’udienza all’inizio di febbraio come
dice la tua legale Hoda Nasrallah. Pensi di poter tornare in Italia un giorno?
«Spero, ovviamente, che questo avvenga presto. Non
so se ci sia un’interdizione per viaggiare all’estero. Per ora so che posso
tornare al Cairo».
Dalle tue lettere traspariva grande dolore per il
master in studi di parità di genere dell’Università di Bologna che non hai
potuto finire. Lo riprenderai?
«Spero davvero presto. Il prima possibile. Non
vedo l’ora di poter riabbracciare i miei compagni, i miei professori. E c’è un
posto dove vorrei andare prima o poi, in Italia».
Qual è?
«Napoli. Non ci sono mai stato. La mia bisnonna
Adel veniva da Napoli. Non parlo così bene l’italiano, ma l’accento di quella
parte del Paese mi ha sempre affascinato. Amo molto gli autori napoletani».
Hai potuto leggere in carcere?
«Sì. Dostoevskij, Saramago. E poi L’amica
geniale di Elena Ferrante. Il mio preferito, forse. I libri dell’Università
invece erano più complicati da avere. Ho provato anche a scrivere qualche volta
ma non sempre mi era permesso tenere il blocco».
Già, scrivere… Ti piace?
«Permette di rielaborare, di processare
l’accaduto. Una persona a me vicino mi ha insegnato questo».
Alza lo sguardo Patrick, e in cambio gli arriva un
sorriso di rimando indietro. Ma in quegli occhi c’è anche un rimprovero, dolce.
Basta parlare con gli altri. Prenditi il tuo tempo, Patrick. Ricordati cosa ti
hanno fatto, sembrano dire quegli occhi.
Dal Corriere il 20 novembre scorso hai ricevuto un
premio che speriamo di poterti consegnare molto presto di persona, il premio
alla memoria di Maria Grazia Cutuli, l’inviata uccisa in Afghanistan nel 2001…
«Sì, mia sorella mi ha detto. Maria Grazia… questo
premio significa tanto per me. Non lo merito, ci sono eroi là fuori che
combattono, in Egitto, più di me, molto più di me. Ma è un premio per cui
ringrazio di cuore, Maria Grazia è molto molto importante per me, e questo
riconoscimento rappresenta un grande sostegno che ho ricevuto dal Corriere, come
istituzione. E presto spero di scrivere i miei diari, quello che ho passato,
sul Corriere. Aspettatemi!».
Uscito dal commissariato di Mansura ha
abbracciato la madre. Le sue prime parole sono state in italiano. Di Maio:
«Bentornato Patrick». La Repubblica l'8 dicembre 2021.
Patrick Zaki è stato scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito,
lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha
abbracciato la madre. "Tutto bene": queste le prime parole che Patrick Zaki ha
pronunciato, parlando in italiano, appena rilasciato. L'abbraccio è avvenuto in
una stretta via su cui affaccia il commissariato, fra transenne della polizia
del traffico e un camion con rimorchio.
Per abbracciare la madre Patrick ha lasciato a
terra un sacco bianco di plastica che portava assieme a una borsa nera.
"Un abbraccio che vale più di tante parole.
Bentornato Patrick!". Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio,
postando una foto dell'abbraccio tra Zaki e la sorella all'uscita dal carcere.
"Aspettavamo di vedere quell'abbraccio da 22 mesi
e quell'abbraccio arriva dall'Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli
enti locali, l'università, i parlamentari che hanno fatto sì che quell'abbraccio
arrivasse". Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International
Italia commenta la notizia del rilascio di Zaki. "Un abbraccio - dice Noury -
soprattutto ai mezzi di informazione che hanno tenuto alta l'attenzione per
questi 22 mesi. Ora che abbiamo visto quell'abbraccio aspettiamo che questa
libertà non sia provvisoria ma sia permanente. E con questo auspicio arriveremo
al primo febbraio, udienza prossima".
Giu. Sca. per "il Messaggero" il 9 dicembre 2021.
Per adesso Patrick Zaki non potrà venire in Italia. Il rientro nella città che
l'ha adottato, Bologna, è solo rinviato. Anche se occorre prudenza. Le reazioni
del regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi sono imprevedibili. Zaki è,
infatti, considerato un problema locale. La sua storia va vista nella più ampia
condizione dei cristiani Copti in Egitto. Una minoranza costantemente
perseguitata, cittadini di serie b rispetto al resto della popolazione
musulmana. La colpa di Zaki, per la locale magistratura, è quella di aver avuto,
da cristiano, il coraggio di scrivere articoli a difesa dei cristiani nel 2019.
Una lunga ricostruzione in cui il 30enne denunciava una serie di vessazioni
patite dai Copti che poi gli è valsa l'arresto, la detenzione lunga 22 mesi con
annesse torture. Come scrive in una relazione la Onlus Porte Aperte «nella
società egiziana, i cristiani sono considerati cittadini di seconda classe dalla
maggioranza islamica. Una minoranza svantaggiata nella sfera politica e nei
rapporti con lo Stato. In tale contesto, il Governo è restio a rispettare e fare
rispettare i loro diritti». E ancora, si legge sempre sul sito di Porte Aperte,
«lo Stato sembra concedere poca attenzione ai diritti umani fondamentali e al
pluralismo democratico. Il livello di violenza contro i cristiani rimane
estremamente elevato». Una minoranza ampia, di 16 milioni di persone, in una
popolazione di 100 milioni. Nella visione del regime non deve assolutamente
passare il messaggio che la pressione internazionale possa avere contribuito
alla scarcerazione del 30enne. Sarebbe un segno di debolezza che il Cairo non
vuole proiettare al proprio interno. E sebbene le richieste incessanti
dell'Italia, con il sostegno degli Usa, siano andate avanti nei 22 mesi di
carcerazione, il principale motivo che ha spinto l'Egitto a concedere la
liberazione (il processo continuerà) di un suo cittadino è collegato
all'assassinio di Giulio Regeni. Lo studente italiano ammazzato dai servizi di
sicurezza locali tra gennaio e febbraio del 2016. Il messaggio che il Cairo
manda sotto voce a Roma è quella di una sorta di compensazione, una
comunicazione cinica. Sull'omicidio Regeni gli egiziani non vogliono che venga
fatta giustizia né in Patria né in Italia. È quindi difficile che dall'altra
sponda del Mediterraneo collaborino per la notifica dell'avviso di garanzia
dell'inchiesta che il pm Sergio Colaiocco ha condotto dalla Capitale per
individuare i responsabili delle torture culminate con l'omicidio di Regeni. E
senza la notifica dell'atto della richiesta di rinvio a giudizio, in Italia non
si può processare nessuno. Ecco allora che Zaki viene liberato come una
concessione rispetto a un muro che il Cairo solleva sul brutale assassinio dello
studente di Cambridge. È in quest' ottica che negli ambienti di governo italiano
si legge la scarcerazione di Zaki. Occorre sempre ricordare che sulla testa del
30enne pende la spada di Damocle del processo. In qualsiasi momento le autorità
locali possono ritornare sui loro passi. La Farnesina che ha lavorato a fari
spenti lo sa bene. E nessuno, negli ambienti diplomatici, vuole urtare la
sensibilità egiziana ben sapendo quale possa essere la reazione. Nessuno vuole
che la macchina di repressione inghiottisca lo studente egiziano dell'Università
di Bologna come è accaduto allo studente italiano dell'Università di Cambridge.
Patrick Zaki, Nicola Porro:
"Sapete come funziona la giustizia in Italia?", quello che i giornali non
dicono.
Libero Quotidiano il 9 dicembre 2021. "Oggi c’è solo Patrick Zaki, la più
ridicola è la Stampa con quattro pezzi che partono in prima pagina": Nicola
Porro, nella sua consueta rassegna stampa della mattina, annota gli articoli e
gli argomenti più importanti della giornata. Oggi in primo piano c'era, appunto,
la scarcerazione dello studente egiziano, dopo 22 mesi di detenzione. Il
giornalista, però, ha voluto far notare un dettaglio, che molti giornali non
hanno riportato: "Nel frattempo in Italia arrestano come se non ci fosse un
domani. Sul Riformista Tiziana Maiolo avverte che nel nostro Paese è peggio che
in Egitto con il caso Pittella, arrestato per la terza volta, accusato di
concorso esterno in associazione mafiosa, uno di quei reati difficilmente
dimostrabili". "La cosa straordinaria - continua Porro - è che l'hanno arrestato
perché ha scritto una lettera a Mara Carfagna. Così avrebbe violato i suoi
arresti domiciliari". Parlando della ministra per il Sud, il giornalista ha
chiarito: "Sono certo che Carfagna non abbia fatto altro che dare questa lettera
alla polizia perché preoccupata". Anche se poi ha aggiunto: "Maiolo fa notare
però che non è vietato mandare lettere se si è agli arresti domiciliari, perfino
se sei al 41bis". E' un discorso di giustizia e garantismo quello fatto da
Porro, che poi sull'argomento chiosa in questo modo: "Giusta l'indignazione nei
confronti di Zaki, ma poi in Italia arrestiamo per tre volte
Pittella". Specificando: "Che nemmeno conosco".
Patrick Zaki, Nicola Porro
e il paradosso della giustizia in Italia: "Quello che non viene scritto".
Il Tempo il 09
dicembre 2021. Dopo 22 mesi di detenzione, il tribunale egiziano di Mansura ha
ordinato il rilascio, in attesa del processo, per Patrick Zaki, l'attivista per
i diritti umani e studente incarcerato a febbraio 2020. La prossima udienza si
terrà il 1 febbraio, ma mentre difesa e pubblici ministeri prepareranno le loro
argomentazioni finalmente Zaki sarà libero, probabilmente da mercoledì o nei
giorni seguenti. Zaki, studente dell'Università di Bologna oggi 30enne, è stato
arrestato nel febbraio 2020 poco dopo essere atterrato al Cairo per un breve
viaggio di ritorno dall'Italia. Da allora è stato detenuto e accusato di aver
diffuso notizie false sull'Egitto a livello nazionale e all'estero. Le accuse
derivano da articoli di opinione scritti da Zaki nel 2019 e che parlano della
discriminazione contro i cristiani copti in Egitto. Nicola Porro, nella
sua rassegna stampa mattutina segnala gli articoli più importanti della giornata
evidenziando che su tutti i quotidiani c'è solo la notizia di Zaki fuori dal
carcere dopo mesi di apprensione e di interessamento da parte dell'Italia: "Oggi
c’è solo Patrick Zaki, la più ridicola è la Stampa con quattro pezzi che partono
in prima pagina" commenta il giornalista che evidenzia un particolare di cui
invece pochi parlano: "Nel frattempo in Italia arrestano come se non ci fosse un
domani. Sul Riformista Tiziana Maiolo avverte che nel nostro Paese è peggio che
in Egitto con il caso Pittella, arrestato per la terza volta, accusato di
concorso esterno in associazione mafiosa, uno di quei reati difficilmente
dimostrabili". "La cosa straordinaria - continua Porro - è che l'hanno arrestato
perché ha scritto una lettera a Mara Carfagna. Così avrebbe violato i suoi
arresti domiciliari". Parlando della ministra per il Sud, il giornalista ha
chiarito: "Sono certo che Carfagna non abbia fatto altro che dare questa lettera
alla polizia perché preoccupata". Anche se poi ha aggiunto: "Maiolo fa notare
però che non è vietato mandare lettere se si è agli arresti domiciliari, perfino
se sei al 41bis". Porro ritiene "giusta l'indignazione nei confronti di Zaki ma
poi - evidenzia - in Italia arrestiamo per tre volte Pittella". "La cosa
straordinaria - spiega Porro - è che l'hanno arrestato perché ha scritto una
lettera a Mara Carfagna. Così avrebbe violato i suoi arresti domiciliari".
Scarcerazione Patrick Zaki,
Roberto D'Agostino: "Sono intervenuti i servizi segreti americani, non certo i
nostri..."
La7.tv l'08/12/2021
Un appello (e gli aiuti):
Usa decisivi.
Fausto Biloslavo il 9 Dicembre 2021 su Il Giornale. Lettera di 56
deputati Usa. E ora si complica l'affaire Regeni. La lista Usa dei prigionieri
da rilasciare, centinaia di milioni di dollari di aiuti militari in ballo e lo
stop in punta di diritto al processo Regeni hanno dato il via libera alla
liberazione di Patrick Zaki. «È un'operazione americana spinta dal Congresso e
negoziata dalla Casa Bianca per ottenere delle concessioni nel campo dei diritti
umani - rivela una fonte del Giornale - A livello politico siamo ai ferri corti
con l'Egitto dopo la decisione del governo di costituirsi parte civile nel
processo sul caso Regeni».
Otto mesi dopo l'arresto al
Cairo dello studente egiziano dell'università di Bologna, 56 membri democratici
del Congresso di Washington hanno inviato al presidente egiziano Abdel Fattah al
Sisi una lettera di una pagina e mezza. Nella missiva su carta intestata del
Congresso i parlamentari chiedono la liberazione di sedici attivisti compreso
«Patrick George Zaki». I rappresentanti americani vanno dritti al punto: «La
esortiamo a rilasciare immediatamente e incondizionatamente i prigionieri che
abbiamo citato (...). Queste sono persone che non avrebbero mai dovuto essere
incarcerate», si legge nella lettera.
Una volta insediato alla Casa
Bianca il presidente americano Joe Biden ha usato il bastone e la carota con
l'Egitto per ottenere un'apertura sui diritti umani. «Gli Stati Uniti
garantiscono 1,3 miliardi di dollari all'anno di aiuti militari al Cairo - fa
notare la fonte del Giornale che conosce il tema - Gli egiziani devono anche
ammodernare i loro F-16 e Biden ha congelato qualche fondo sbloccando altri.
Ottenendo alla fine un gesto distensivo soprattutto nei confronti della
richiesta del Congresso».
Il 15 settembre la Casa Bianca
ha concesso il via libera a 170 milioni di dollari di aiuti militari e ne ha
congelati altri 130. La cifra fa parte del pacchetto di 300 milioni che il
Congresso lega al rispetto dei diritti umani. Non è un caso che all'udienza che
ha concesso la libertà vigilata a Zaki era presente pure un inviato Usa assieme
ai diplomatici della nostra ambasciata al Cairo e rappresentanti di Canada e
Spagna.
La mossa americana sarebbe
stata caldeggiata dall'ambasciatore italiano in Egitto Cairo Giampaolo Cantini,
Al Cairo fino ad agosto, e poi seguita dalla nuova feluca Michele Quaroni. Il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio solo da settembre a oggi ha discusso di Zaki
con il suo pari grado egiziano alla media di una volta al mese.
Gli Stati Uniti hanno blandito
il presidente al Sisi anche in campi non militari, come l'assegnazione al Cairo
della Cop 27 del prossimo anno sui cambiamenti climatici. Ad annunciarlo ci ha
pensato il 3 ottobre l'inviato Usa sul clima, John Kerry, proprio alla pre-Cop
di Milano. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, «esprime soddisfazione per
la scarcerazione di Patrick Zaki, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la
massima attenzione da parte del Governo italiano». Nelle stesse ore del
vittorioso comunicato di Palazzo Chigi, il ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani metteva il dito sulla piaga della Cop 27 in Egitto e
l'impunito omicidio di Giulio Regeni. «Andiamo lì - dice il ministro - e che
facciamo? Facciamo finta di nulla. Per me questo è un grosso problema».
Oltre alle mosse americane gli
egiziani hanno liberato Zaki dopo lo stop al processo ai funzionari dei servizi
segreti del Cairo per il brutale omicidio deciso dalla Corte d'Assise a causa di
cavilli legati alla notifica degli atti.
Il rischio adesso è che la
liberazione di Zaki allontani sempre più qualsiasi spiraglio sul caso Regeni con
al Sisi che pensa di avere fatto abbastanza. Non solo: lo studente egiziano è
libero, ma con una spada di Damocle sulla testa. Il primo febbraio dovrà tornare
in tribunale per la sentenza sulle accuse che lo hanno già tenuto in galera 688
giorni. All'Italia conviene mantenere, almeno per ora, un profilo basso sul suo
caso e su Regeni.
Fausto Biloslavo. Girare il
mondo, sbarcare il lunario scrivendo articoli e la ricerca dell'avventura hanno
spinto Fausto Biloslavo a diventare giornalista di guerra. Classe 1961, il suo
battesimo del fuoco è un reportage durante l'invasione israeliana del Libano nel
1982. Negli anni ottanta copre le guerre dimenticate dall'Afghanistan,
all'Africa fino all'Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto
prigioniero a Kabul per sette mesi. Nell’ex Jugoslavia racconta tutte le guerre
dalla Croazia, alla Bosnia, fino all'intervento della Nato in Kosovo. Biloslavo
è il primo giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai talebani dopo
l’11 settembre. Nel 2003 si infila nel deserto al seguito dell'invasione alleata
che abbatte Saddam Hussein. Nel 2011 è l'ultimo italiano ad intervistare il
colonnello Gheddafi durante la rivolta. Negli ultimi anni ha documentato la
nascita e caduta delle tre “capitali” dell’Isis: Sirte (Libia), Mosul (Iraq) e
Raqqa (Siria). Dal 2017 realizza inchieste controcorrente sulle Ong e il
fenomeno dei migranti. E ha affrontato il Covid 19 come una “guerra” da
raccontare contro un nemico invisibile. Biloslavo lavora per Il Giornale e
collabora con Panorama e Mediaset. Sui reportage di guerra Biloslavo ha
pubblicato “Prigioniero in Afghanistan”, “Le lacrime di Allah”, il libro
fotografico “Gli occhi della guerra”, il libro illustrato “Libia kaputt”,
“Guerra, guerra guerra” oltre ai libri di inchiesta giornalistica “I nostri
marò” e “Verità infoibate”. In 39 anni sui fronti più caldi del mondo ha scritto
quasi 7000 articoli accompagnati da foto e video per le maggiori testate
italiane e internazionali. E vissuto tante guerre da apprezzare la fortuna di
vivere in pace.
Fausto Biloslavo per “il
Giornale” il 10 dicembre 2021. Patrick Zaki è libero, dopo 22 mesi, meno che a
metà. Lo studente egiziano potrebbe tornare in carcere soprattutto se i media,
la politica e i suoi fan non manterranno un rigoroso basso profilo, fino a
quando non tornerà in Italia. Non solo: il silenzio tombale sul caso Regeni
rischia di trasformarsi in definitivo epitaffio, ma giustamente la famiglia e la
sua battagliera legale, pur felici per la liberazione di Zaki, non intendono
fare buon viso a cattivo gioco. E oggi mamma Paola, papà Claudio e l'avvocato
Alessandra Ballerini, in un evento pubblico a Genova, potrebbero non essere
teneri con il governo e le mosse egiziane. Zaki è formalmente in libertà
cautelare fino alla prossima udienza del 1° febbraio. Lo sa bene la stessa
Amnesty international che si è battuta per la sua scarcerazione. E lo sa ancora
meglio il governo e soprattutto l'ambasciata italiana al Cairo, guidata da
Michele Quaroni, che segue la linea del «silenzio operativo». Non è un caso che
l'ambasciatore non avrebbe preso contatti diretti con la famiglia Regeni. Il 1°
febbraio è difficile che Zaki venga prosciolto dalle accuse con una conclusione
a tarallucci e vino. Ben più probabile che per il reato «di diffusione di
notizie false» si becchi una multa, che in Egitto significa praticamente la
grazia oppure una pena equivalente ai 22 mesi già passati in carcere. I nostri
servizi avevano informalmente lavorato in tal senso. Però il reato è punibile
fino a cinque anni di carcere, una bella spada di Damocle sulla testa dello
studente copto. Ed esiste anche una seconda fantomatica accusa, apparentemente
sospesa, di «associazione terroristica», comune ai detenuti politici in Egitto,
che prevede 12 anni di carcere. Mohamed Hazem, attivista e caro amico di Zaki,
ha dichiarato ieri con chiarezza che «dobbiamo rimanere focalizzati sul
processo, la battaglia non è ancora finita». Lo sanno bene le «amazzoni» che
circondano lo studente egiziano dall'avvocato Hoda Nasrallah, alla sorella e
fidanzata di Zaki. Proprio loro si sono prodigate per farlo parlare il meno
possibile con la stampa italiana se non su banalità come la maglietta del
Bologna calcio. Niente, ovviamente, sui maltrattamenti che avrebbe subito al
momento dell'arresto. Una parola in più potrebbe costargli caro, ma non tutti in
Italia vogliono rendersi conto della realtà egiziana. I rinnovati appelli da
sinistra sulla cittadinanza auspicata dal Parlamento rendono la libertà di Zaki
sempre più provvisoria. Sul fronte del caso Regeni l'attesa scarcerazione dello
studente che frequentava l'università di Bologna rischia di favorire lo stallo.
Il processo è fermo fino a quando l'ambasciatore Quaroni non trova il domicilio
dei funzionari dei servizi egiziani imputati della morte di Giulio. Una missione
praticamente impossibile. L'ipotesi di arbitrato internazionale, che
allungherebbe i tempi, non è vista di buon occhio dai familiari. Alla spiacevole
sensazione che gli egiziani abbiano mollato Zaki per non fare alcuna concessione
su Regeni si aggiungono i paragoni con altri casi di serie B. Vicende
giudiziarie che riguardano cittadini italiani, non egiziani, «prigionieri del
silenzio», che non hanno la fortuna dei riflettori accesi come è avvenuto con il
Cairo. Primo fra tutti Chico Forti, che secondo il ministro Luigi Di Maio,
doveva tornare in Italia un anno fa dopo quasi un quarto di secolo in carcere
negli Usa, forse innocente. Per non parlare delle tante, clamorose, vicende
dimenticate fra i 2.024 detenuti italiani all'estero, che non sono prigionieri
di al Sisi.
Zaki, la libertà pagata a
caro prezzo. In cambio silenzio e lo stop su Regeni.
Fausto Biloslavo il 10
Dicembre 2021 su Il Giornale. Chi tiene alle sorti dello studente sa che non ha
senso esultare. E il caso dell'italiano ucciso potrebbe impantanarsi per sempre.
Patrick Zaki è libero, dopo 22 mesi, meno che a metà. Lo studente egiziano
potrebbe tornare in carcere soprattutto se i media, la politica e i suoi fan non
manterranno un rigoroso basso profilo, fino a quando non tornerà in Italia. Non
solo: il silenzio tombale sul caso Regeni rischia di trasformarsi in definitivo
epitaffio, ma giustamente la famiglia e la sua battagliera legale, pur felici
per la liberazione di Zaki, non intendono fare buon viso a cattivo gioco. E oggi
mamma Paola, papà Claudio e l'avvocato Alessandra Ballerini, in un evento
pubblico a Genova, potrebbero non essere teneri con il governo e le mosse
egiziane.
Zaki è formalmente in libertà
cautelare fino alla prossima udienza del 1° febbraio. Lo sa bene la stessa
Amnesty international che si è battuta per la sua scarcerazione. E lo sa ancora
meglio il governo e soprattutto l'ambasciata italiana al Cairo, guidata da
Michele Quaroni, che segue la linea del «silenzio operativo». Non è un caso che
l'ambasciatore non avrebbe preso contatti diretti con la famiglia Regeni.
Il 1° febbraio è difficile che
Zaki venga prosciolto dalle accuse con una conclusione a tarallucci e vino. Ben
più probabile che per il reato «di diffusione di notizie false» si becchi una
multa, che in Egitto significa praticamente la grazia oppure una pena
equivalente ai 22 mesi già passati in carcere. I nostri servizi avevano
informalmente lavorato in tal senso. Però il reato è punibile fino a cinque anni
di carcere, una bella spada di Damocle sulla testa dello studente copto. Ed
esiste anche una seconda fantomatica accusa, apparentemente sospesa, di
«associazione terroristica», comune ai detenuti politici in Egitto, che prevede
12 anni di carcere. Mohamed Hazem, attivista e caro amico di Zaki, ha dichiarato
ieri con chiarezza che «dobbiamo rimanere focalizzati sul processo, la battaglia
non è ancora finita». Lo sanno bene le «amazzoni» che circondano lo studente
egiziano dall'avvocato Hoda Nasrallah, alla sorella e fidanzata di Zaki. Proprio
loro si sono prodigate per farlo parlare il meno possibile con la stampa
italiana se non su banalità come la maglietta del Bologna calcio. Niente,
ovviamente, sui maltrattamenti che avrebbe subito al momento dell'arresto. Una
parola in più potrebbe costargli caro, ma non tutti in Italia vogliono rendersi
conto della realtà egiziana. I rinnovati appelli da sinistra sulla cittadinanza
auspicata dal Parlamento rendono la libertà di Zaki sempre più provvisoria.
Sul fronte del caso Regeni
l'attesa scarcerazione dello studente che frequentava l'università di Bologna
rischia di favorire lo stallo. Il processo è fermo fino a quando l'ambasciatore
Quaroni non trova il domicilio dei funzionari dei servizi egiziani imputati
della morte di Giulio. Una missione praticamente impossibile. L'ipotesi di
arbitrato internazionale, che allungherebbe i tempi, non è vista di buon occhio
dai familiari.
Alla spiacevole sensazione che
gli egiziani abbiano mollato Zaki per non fare alcuna concessione su Regeni si
aggiungono i paragoni con altri casi di serie B. Vicende giudiziarie che
riguardano cittadini italiani, non egiziani, «prigionieri del silenzio», che non
hanno la fortuna dei riflettori accesi come è avvenuto con il Cairo. Primo fra
tutti Chico Forti, che secondo il ministro Luigi Di Maio, doveva tornare in
Italia un anno fa dopo quasi un quarto di secolo in carcere negli Usa, forse
innocente. Per non parlare delle tante, clamorose, vicende dimenticate fra i
2.024 detenuti italiani all'estero, che non sono prigionieri di al Sisi.
Patrick Zaki, il primo
politico seguito dopo il carcere? Foto clamorosa: trionfo nel centrodestra.
Libero
Quotidiano il 10 dicembre 2021. Patrick Zaki, finalmente scarcerato ma ancora
sotto processo in Egitto, ha appena aperto un suo account su Twitter. Il suo
primo messaggio è stato: "Libertà, libertà, libertà". Un concetto semplice ma
forte allo stesso tempo. A corredo una foto in cui si mostra sorridente e con
un'etichetta del Bologna calcio tra le mani. Lo studente, infatti, si trovava a
Bologna prima di finire in carcere. Lì frequentava un master, dove adesso - come
detto da lui stesso - spera di tornare. Impossibile non notare che per il
momento Zaki segue solo due persone su Twitter. Uno è l'account ufficiale di
Google. L'altro invece è il profilo di Antonio Tajani, ex presidente del
Parlamento europeo e numero due di Forza Italia. Un riconoscimento non di poco
conto per il partito di Silvio Berlusconi e, in generale, per tutto il
centrodestra. I follower, invece, per il momento sono circa 600. Tanti i
commenti sotto il suo primo post. "Torna preso in Italia, ti aspettiamo", ha
scritto un utente. Un altro invece: "Bellissimo vederti sorridente e libero".
Nonostante la scarcerazione, però, il 30enne non è ancora stato assolto dalle
accuse di aver diffuso notizie false "dentro e fuori" il suo Paese d'origine. La
prossima udienza, infatti, si terrà il primo febbraio 2022. Zaki è stato
rinviato a giudizio alla fine della scorsa estate, ma la sua permanenza in
carcere, da febbraio 2020, era stata rinnovata di volta in volta sulla base di
ordinanze di custodia cautelare.Sapete come funziona la giustizia in Italia?"
Patrick Zaki, ecco l’articolo sui
cristiani copti per cui l’Egitto accusa lo studente.
Patrick Zaki su Il Corriere della Sera il 14 settembre 2021. L’incriminazione:
«diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese». Pubblicato nel 2019 sul
sito web Daraj, l’articolo è una sorta di diario delle persecuzioni cui sono
sottoposti nel Paese musulmano i copti, minoranza a cui il giovane appartiene.
Non passa un mese senza che si verifichino incresciosi atti di violenza contro i
copti egiziani, dai tentativi di trasferimento forzato nell’alto Egitto fino ai
sequestri di persona, chiusura delle chiese o attentati dinamitardi. Questo
articolo si propone il semplice scopo di seguire gli avvenimenti di un’unica
settimana, come annotati nei diari dei cristiani d’Egitto. Il primo giorno
dell’ultimo Eid al-Fitr, l’Egitto è stato colpito da un gravissimo attacco
terroristico che ha reclamato la vita di quattordici effettivi tra le forze
armate e la polizia egiziana, di vario ordine e rango. Poiché non sono state
menzionate vittime cristiane tra le reclute, siamo rimasti sorpresi nel ricevere
la notizia di un funerale militare tenutosi nella cittadina natale di uno dei
soldati cristiani, Abanoub Marzouk, proveniente da Bani Qurra, e dal centro di
addestramento Qusiya di Assiut. Ho diffuso la notizia sul mio blog, nel quale
chiedevo come mai si era taciuto il nome di Abanoub. Mi sono visto piombare
addosso una valanga di critiche dagli utenti delle reti social, come pure da
parte di certi giornalisti egiziani, i quali mi hanno confermato che cose del
genere sono «normali», in quanto le forze armate non pubblicano mai i nomi delle
vittime degli attacchi terroristici nel Sinai per motivi di sicurezza e per non
deprimere il morale delle truppe stazionate in quei luoghi. Tutte queste
pressioni mi hanno convinto a cancellare il mio post. Ho aggiunto che forse mi
ero sbagliato e non si era trattato di un atto di discriminazione e ho chiesto
scusa ai miei colleghi. Qualche ora più tardi, si è diffusa la notizia di
scontri e violenze nella cittadina natale della recluta Abanoub Marzouk, poiché
l’esercito voleva intitolare una scuola a suo nome e la popolazione locale si
era violentemente opposta alla decisione, in quanto la recluta era «cristiana».
I media egiziani si sono guardati bene dal far luce sulla vicenda, ma alcuni
giornalisti e attivisti cristiani hanno sollevato obiezione. Nader Shukri, un
reporter che tratta di affari cristiani in Egitto, ha scritto: «Il governatore
della provincia ha consigliato a Abanoub Naheb, fratello della vittima, che se
qualcuno lo invita a un matrimonio, e offre agli sposi dieci sterline, l’altro
non vada in giro a dire che doveva offrirgliene cento. Questo in risposta al
rifiuto del fratello di mettere il nome del martire su un ponte, che è un
semplice attraversamento di un canale, «facendo inoltre notare che una targa del
genere non è assolutamente indicata a onorare il sacrificio di un soldato morto
in un attacco terroristico». Successivamente Ishaq Ibrahim, ricercatore presso
l’Iniziativa egiziana per la tutela dei diritti della persona, ha commentato su
Facebook: “Coloro che hanno rifiutato di dare il nome di Abanoub a una scuola
non fanno parte né dei fratelli musulmani, né dei salafiti, né degli
integralisti. Siamo coraggiosi e diciamo chiaramente che la decisione è stata
presa da un funzionario dello stato per motivi discriminatori. Dare la colpa ai
gruppi religiosi equivale a uno scaricabarile delle responsabilità». Per poi
aggiungere: «Il governatore di Assiut, dopo aver criticato il funzionario per
non aver dato il nome di Abanoub a una scuola, ha fatto sistemare una targa
commemorativa su un ponticello della sua città natale, che scavalca un canale,
malgrado l’opposizione della famiglia del defunto! Con questa soluzione, il
governatore ha pensato da un lato di accontentare tutti, dando formalmente
il nome della vittima a “qualcosa”, e dall’altro di scansare ogni seccatura che
gliene verrebbe se avesse dato il nome a una scuola. Tra l’altro, il nome di
ponti e strade nei piccoli centri non ha nessuna importanza, perché non viene
nemmeno registrato nel piano urbanistico, né utilizzato dai residenti». Ibrahim
ha rimarcato, nel suo post, l’assenza del ruolo dello stato e la totale
indifferenza davanti al razzismo sistematico praticato dagli abitanti del luogo,
mai affrontato dai funzionari statali, che hanno ceduto alle pressioni e non
hanno intitolato una scuola alla giovane vittima. Il governo egiziano ha fatto
prova di estrema passività in questa vicenda, rifiutandosi di adottare misure
decisive per impedire la sistemazione della targa commemorativa di Abanoub
Marzouk su un ponticello. Il governatore della provincia è intervenuto allora
per risolvere il problema e ho scoperto che aveva dato il nome di Abanoub
Marzouk a uno dei ponti in costruzione all’ingresso della cittadina natale della
vittima. E così almeno uno, tra i tanti problemi che affliggono i cristiani
d’Egitto, è stato risolto grazie a un «ponte»! Indagando sui modi più comuni per
onorare ufficiali e militari morti in servizio, ho scoperto che il governo ha
dedicato un certo numero di strade, scuole e piazze principali alla memoria
delle vittime del Sinai, dal 2013 a oggi. Questo mi spinge a sollevare non poche
domande su come il governo abbia gestito il caso di Abanoub Marzouk, la recluta
cristiana, che i suoi concittadini hanno rifiutato di onorare intitolandogli una
scuola, con il beneplacito del governatore, per timore dei militanti islamici
più estremisti. Il figlio maschio eredita la quota di due figlie femmine, anche
se sono cristiani! «Nella legge egiziana, non è stabilito da nessuna parte che
al maschio spetti la quota di eredità di due femmine». È così che si è espresso
il giudice, nella dichiarazione del tribunale, in risposta alla relazione
pubblicata di recente dall’avvocata per i diritti umani Hoda Nasrallah. Dopo la
morte del padre, Hoda ha deciso di proseguire la battaglia da sola, ma non a suo
esclusivo beneficio, bensì a tutela di tutte le donne cristiane. Il terzo
articolo della costituzione del 2014 dichiara che «i principi contenuti nelle
sacre scritture dei cristiani e degli ebrei d’Egitto rappresentano la fonte
legislativa principale nel dirimere ogni questione relativa al loro statuto
personale, affari religiosi e la scelta dei loro capi spirituali». L’articolo
245 dell’Ordinamento copto ortodosso, varato nel 1938, afferma nel terzo
capitolo, per quanto riguarda l’eredità e il diritto di ciascun erede, che «i
discendenti diretti avranno la precedenza sugli altri familiari, pertanto
riceveranno tutta l’eredità o quanto resta dopo aver attribuito la quota legale
al marito o alla moglie. Nel caso di più eredi, con il medesimo grado di
parentela, l’eredità verrà suddivisa tra di loro in parti uguali, senza alcuna
differenza tra eredi maschi ed eredi femmine». Hoda ha respinto la proposta dei
due fratelli, quando hanno chiesto che venisse seguito l’iter stabilito dalle
autorità giudiziarie secondo la normativa vigente, promettendo tuttavia di
suddividere successivamente l’eredità in parti uguali. Ma Hoda mirava a un
obiettivo più alto, ben al di là del suo caso personale, e cioè all’introduzione
di normative che in futuro avrebbero cancellato le ingiustizie patite dalle
donne cristiane attraverso la legge egiziana sul diritto di famiglia, dalle
questioni delle separazioni fino all’eredità. Molti maschi
cristiani approfittano della legge egiziana che non riconosce i diritti dei
cristiani nella normativa sull’eredità e si accaparrano più di quanto a loro
spettante, grazie alle sentenze dei tribunali e all’esecuzione delle stesse. La
legge pertanto diventa un ostacolo per tutte le donne, impedendo loro di
accedere ai loro diritti, specie nel caso delle donne cristiane.
È una battaglia che si traduce in una forma di
persecuzione contro le donne cristiane sotto la legge islamica, benché la
religione cristiana non sottoscriva queste idee né tuttavia le abbia mai
affrontate, né da vicino né da lontano: le ingiustizie della società
patriarcale sono tendenzialmente sostenute e giustificate dalla legge.
«Non accettiamo la tua testimonianza perché sei un
cristiano!»
Un post di questo tenore ha raggiunto una
diffusione inverosimile su Facebook qualche settimana fa, e si riferisce a
quanto accaduto al padre di un dottore, Mark Estefanos, coperto d’insulti in
tribunale. Tutto ciò in seguito a lunga storia del padre, ingegnere e dipendente
statale per 35 anni. Il padre doveva recarsi in tribunale per testimoniare in
una vertenza riguardante un collega, ma il giudice ha respinto la testimonianza
dell’ingegner Makarios perché cristiano. «Un copto non avrà mai nessuna autorità
su un musulmano». Il padre e il figlio, dottore, sono rimasti sbalorditi, e
quest’ultimo ha pubblicato un post per riferire che a causa di situazioni come
queste sta pensando di lasciare l’Egitto, perché non gode degli stessi diritti
dei suoi connazionali.
Questo problema fu sollevato per la prima volta
nel 2008, quando Ahmed Shafiq, cittadino musulmano, chiese la testimonianza del
suo vicino di casa cristiano, Sami Farag, in una questione ereditaria, caso 1824
del 2008, ma il tribunale di Shubra El-Kheima respinse le dichiarazioni di un
cittadino cristiano, in quanto la sua testimonianza non era ritenuta
ammissibile, sotto il profilo legale nonché religioso, contro un musulmano.
Il tribunale costrinse Shafiq a reperire un
testimone musulmano. Per tornare alla costituzione… scopriamo che esiste una
palese contraddizione sul diritto alla testimonianza e la sua normativa, visto
che nel secondo articolo si dichiara che «l’Islam è la religione di stato,
l’arabo la sua lingua ufficiale, e i principi della Sharia islamica sono alla
base della legislazione», mentre l’articolo 53 recita che «i cittadini sono
uguali davanti alla legge e godono di uguali diritti, libertà e doveri pubblici,
e non esiste discriminazione tra di loro in base a fede religiosa, credenze,
genere, origine, razza, colore, lingua, disabilità, classe sociale, appartenenza
politica o geografica, o qualunque altra ragione. La discriminazione e
l’incitamento all’odio costituiscono un crimine, punito dalla legge. Lo Stato ha
l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni forma di
discriminazione e a tal scopo la legge regola la nomina di una commissione
indipendente». D’altro canto, la Sharia islamica respinge la testimonianza di un
non musulmano in più di un testo. «Nel diritto in materia di assunzione di
prove, non si trova nulla che faccia distinzione tra cristiani e musulmani e
impedisca di accogliere la testimonianza di qualsiasi cittadino», con queste
parole si è espresso l’avvocato Reda Bakir dell’Iniziativa egiziana per i
diritti della persona. Facendo riferimento al diritto sull’assunzione delle
prove, è chiaro che non esiste alcun articolo legale che imponga di respingere
la testimonianza di un non musulmano.
Muhammad Hassan, ex avvocato dei diritti umani e
ricercatore in campo giudiziario, tuttavia conferma: «Sono propenso
all’applicazione della legge islamica per tutto ciò che riguarda questioni
religiose incontestabili. Non si tratta di essere al di sopra della legge o
altro. Ma l’esercizio dell’autorità è riservato ai musulmani, e l’Egitto è la
patria dell’Islam, mentre il dhimmi (non musulmano) paga la jizya (tasse) per
agevolare le sue istanze».
Basta questa semplice osservazione per spiegare
quello che la comunità cristiana in Egitto è costretta a sopportare in una sola
settimana! (Traduzione Rita Baldassare)
«Il calvario dei cristiani copti in
Egitto», l’articolo per cui Zaki è incriminato. Da
editorialedomani.it il 14 settembre 2021.
Pubblichiamo in versione integrale l’articolo di
Patrick Zaki del 2019 per cui i pm egiziani accusano lo studente di diffusione
di notizie false. «Questo articolo è un semplice tentativo di seguire gli
eventi» scriveva Zaki. Traduzione di Monica Fava
Pubblichiamo in versione integrale l’articolo
di Patrick Zaki del 2019 per cui i pubblici ministeri egiziani accusano lo
studente di diffusione di notizie false. Patrick è in carcere da febbraio del
2020, il processo è partito il 14 settembre 2021. Traduzione di Monica Fava.
Non passa mese senza che si verifichino incidenti
dolorosi contro i copti egiziani, dai tentativi di sfollamento nell’alto Egitto,
ai rapimenti, alla chiusura di chiese o ad altri attentati. Questo articolo è un
semplice tentativo di seguire gli eventi di una settimana della vita quotidiana
di cristiani egiziani…
Non passa un mese per i cristiani in Egitto senza
8 o 10 incidenti dolorosi, dai tentativi di sfollarli nell’alto Egitto, ai
rapimenti, alla chiusura di una chiesa o qualcosa che viene fatto saltare in
aria, all’uccisione di un cristiano, la conclusione è sempre «disturbo mentale».
Questo articolo è un semplice tentativo di seguire
gli eventi di una settimana dai diari dei cristiani d’Egitto, una settimana è
sufficiente per rendersi conto della portata del calvario che vivono.
Il giorno seguente la fine dello scorso Ramadan,
nella festa di Eid al-Fitr, l’Egitto è stato vittima di un enorme attacco
terroristico che ha causato la morte di quattordici membri delle forze egiziane,
di diversi ranghi della polizia e dell’esercito. Poiché non era stato fatto il
nome di alcun soldato cristiano, ci ha sorpreso la notizia di un funerale
militare nella città natale di uno dei soldati cristiani egiziani, Abanoub
Marzouk del villaggio di Bani Qurra, affiliato al Centro Qusiya di Assiut.
UN POST
Ho scritto un post sul blog per chiedere le
ragioni di questo blackout sul nome di Abanoub. Ho ricevuto una serie di
attacchi da utenti di social network e anche da giornalisti egiziani che
confermavano che queste cose sono “normali”, perché le forze armate non
pubblicano i nomi di chi muore martire negli attentati terroristici in Sinai,
per ragioni di sicurezza e per il morale delle truppe che si trovano là. Tutte
queste pressioni mi hanno indotto a cancellare il post. Ho detto che forse mi
ero sbagliato, che non era un atto di discriminazione, e mi sono scusato con i
colleghi.
Alcune ore dopo, si è diffusa la notizia
dell’insorgere di gravi problemi nel paese natale del soldato, Abanoub Marzouk,
al cui nome le forze armate avevano deciso di intitolare una scuola: la gente
della città si era opposta con decisione perché il soldato era un “cristiano”. I
media egiziani non hanno fatto abbastanza luce sulla questione, ma diversi
giornalisti e attivisti cristiani hanno espresso le loro obiezioni.
Nader Shukri, un giornalista che segue le vicende
dei cristiani in Egitto, ha scritto: «Un governatore dice al fratello del
martire Abanoub Naheh: “Se andassi a un matrimonio e regalassi agli sposi 10
sterline, non mi dire che avrei dovuto regalargli 100 sterline”. Questa è la sua
risposta al rifiuto di un fratello del martire a farsi intitolare un ponte,
quando si tratta solo di un passaggio sopra un canale”, sottolineando che quella
dedica non è commisurata al valore di onorare un soldato caduto in un attentato
terroristico.
Poi Ishaq Ibrahim, un ricercatore dell’Egyptian
Initiative for Personal Rights, ha commentato su Facebook. “Quelli che hanno
rifiutato di intitolare ad Abanoub una scuola non appartengono ai Fratelli
musulmani, non sono salafiti, non sono estremisti o altro. Abbiate il coraggio
di dire che è stato un pubblico funzionario che ha preso questa decisione
lasciandosi influenzare dai suoi pregiudizi. Qualsiasi tentativo di addossare la
colpa a gruppi religiosi è un modo per annacquare le proprie responsabilità”.
Poi ha aggiunto: “Il governatorato di Assiut, dopo aver criticato la sua
decisione di non intitolare al martire Abanoub una scuola, ha messo il suo nome
accanto a un piccolo ponte sopra uno dei canali nel suo villaggio, nonostante i
familiari del defunto si fossero opposti!! In questa maniera il governatorato ha
voluto accontentare tutti: gli ha formalmente intitolato ‘qualcosa’ e, al tempo
stesso, si è tirato fuori dalle polemiche nate dopo la decisione di dedicargli
una scuola. Peraltro, i nomi dei ponti e delle strade nei villaggi non sono
importanti, perché non sono registrati nei documenti ufficiali e spesso non sono
utilizzati dalla gente comune”.
Nel suo post Ibrahim ha messo in evidenza
l’assenza del ruolo dello stato e il condono del razzismo sistematico della
gente del villaggio, che le autorità hanno deciso di non affrontare, cedendo
alle pressioni e rinunciando all’idea di dedicare la scuola ad Abanoub.
IL GOVERNO EGIZIANO
Il governo egiziano non ha reagito e non ha preso
alcuna nessuna misura decisa per impedire di intitolare la scuola ad Abanoub
Marzouk, così è intervenuto il governatore a risolvere il problema. Quando ho
cercato di capire in che modo il governatore avesse risolto problema, ho
scoperto che aveva dedicato a Abanoub Marzouk il ponte in costruzione
all’ingresso del villaggio. Insomma, il problema, come tutti i problemi dei
cristiani in Egitto, è stato risolto con un “ponte”!
Quando abbiamo cercato come fosse stato reso
omaggio ad altri ufficiali o altre reclute morti nello stesso attentato o in
altri, abbiamo scoperto che il governo in generale ha dedicato un buon numero di
strade, scuole e piazze frequentate a molti dei soldati che sono caduti in Sinai
dall’inizio del 2013 a oggi. Questo ci spinge a fare domande sulle ragioni per
cui il governo ha gestito in questo modo il caso di Abanoub Marzouk, il soldato
cristiano a cui i compaesani hanno rifiutato di intitolare la scuola del
villaggio, cosa che il governatore ha accettato temendo l’ira dei militanti.
Un uomo riceve un’eredità pari a quella di due
donne, anche nel caso dei cristiani!
«Nel diritto egiziano non c’è questa cosa che un
uomo riceve una quota di eredità pari a quella di due donne». Così ha stabilito
un giudice e così dice la relazione del tribunale dopo la dichiarazione
sull’eredità dell’avvocata per i diritti umani Huda Nasrallah (che oggi difende
Zaki, ndr), di recente pubblicazione. Huda ha dichiarato che, dopo la morte del
padre, ha deciso di combattere la sua battaglia da sola, ma non solo per sé,
bensì in nome di tutte le donne cristiane.
Il terzo articolo della Costituzione del 2014
afferma che “i principi delle scritture dei cristiani e degli ebrei egiziani
sono la fonte legislativa principale per regolare lo statuto personale, gli
affari religiosi e la selezione delle guide spirituali”.
L’articolo 245 del Regolamento della Chiesa
ortodossa copta, pubblicato nel 1938, afferma nel terzo capitolo, riguardo agli
eredi e al diritto di ciascuno di loro all’eredità, che «i discendenti
dell’erede hanno la priorità sugli altri parenti sull’eredità, pertanto ricevono
tutta l’eredità o quello che ne resta dopo che il marito o la moglie hanno
ricevuto la loro parte. Nel caso ci siano eredi multipli con lo stesso grado di
parentela con il defunto, le proprietà saranno divise tra di loro in parti
uguali, senza differenza fra uomini e donne».
Huda ha rifiutato la proposta dei suoi due
fratelli, quando hanno chiesto che il processo si svolgesse nel modo solito in
cui le autorità giudiziarie sono solite procedere e che la dichiarazione di
eredità fosse ricevuta in qualsiasi forma, e poi l’eredità divisa tra loro in
parti uguali. Hoda aveva un obiettivo più ambizioso, ben oltre il suo caso
personale, e cioè di istituire provvedimenti che fossero applicati anche in
seguito, per far fronte alle ingiustizie che subiscono le donne egiziane
riguardo al diritto della persona, dai casi di separazione all’eredità. Molti
cristiani uomini approfittano del fatto che i tribunali non riconoscono la
religione cristiana nelle sue norme sull’eredità e prendono più di ciò che gli
spetterebbe per diritto secondo la loro religione, perché lo ha ordinato il
tribunale e devono rispettarlo. Di conseguenza la legge è diventata un ostacolo
per le donne nell’ottenere i propri diritti, specialmente per le donne
cristiane.
Questa battaglia dimostra una forma di
persecuzione contro le donne cristiane in base al diritto islamico, anche se la
religione cristiana non afferma questi concetti e non li ha affrontati, né da
vicino né da lontano. Tuttavia, i mali della società patriarcale sono
sostanzialmente supportati e giustificati dalla legge.
«Non accettiamo la sua deposizione perché è un
cristiano!»
Questo post è stato diffuso ampiamente su Facebook
qualche settimana fa e racconta che cosa è successo al padre del dottor Mark
Estefanos e degli insulti che ha ricevuto in tribunale. Questo dopo una lunga
vicenda del padre, un ingegnere che ha lavorato in un’istituzione pubblica per
35 anni. Il padre doveva presentarsi in tribunale per testimoniare di fronte al
giudice su un caso riguardante un collega, ma il giudice ha rifiutato la
deposizione dell’ingegner Makarios perché cristiano. «Non c’è tutela legale per
un copto rispetto a un musulmano». Il padre e suo figlio, un medico, sono
rimasti estremamente turbati e quest’ultimo ha pubblicato il post, sottolineando
che episodi così lo inducono sempre a pensare di andarsene dall’Egitto, perché
non gode degli stessi diritti degli altri.
Il problema è stato sollevato per la prima volta
nel 2008, quando Ahmed Shafiq, un cittadino musulmano, richiese la testimonianza
del suo vicino cristiano, Sami Farag, nel caso di dichiarazione d’eredità
1824/2008, ma il tribunale di Shubra el-Kheima rifiutò la deposizione di un
cittadino cristiano adducendo il motivo che la deposizione di un cristiano non
era legalmente/religiosamente consentita contro un musulmano. Il tribunale
obbligò Shafiq a portare un testimone musulmano.
Tornando alla costituzione...
C’è una chiara incoerenza sul diritto a
testimoniare e la sua applicazione, poichè il secondo articolo afferma che
«l’islam è la religione di stato, l’arabo è la lingua ufficiale e i principi
della shari’a islamica sono la principale fonte legislativa».
L’articolo 53 afferma che «i cittadini sono uguali
di fronte alla legge e hanno gli stessi diritti, libertà e doveri pubblici, non
c’è discriminazione fra di essi sulla base della religione, delle convinzioni,
del genere, dell’origine, della razza, del colore, della lingua, della
disabilità, della condizione sociale, dell’affiliazione politica o geografica, o
di qualsiasi altra ragione. La discriminazione e l’incitamento all’odio
costituiscono un reato perseguibile dalla legge. Lo stato è obbligato a prendere
le misure necessarie per eliminare tutte le forme di discriminazione e la legge
regola l’istituzione di una commissione indipendente a tale scopo».
D’altro canto, la shari’a in più di un testo non
accetta la deposizione di un non musulmano. «Non c’è nulla nel diritto
procedurale che distingua fra cristiani e musulmani e impedisca di accettare la
deposizione di un qualsiasi cittadino», ha dichiarato l’avvocato Reda Bakir
dell’Egyptian Initiative for Personal Rights. Facendo riferimento al diritto
procedurale è già evidente che non esiste nessuna disposizione di legge che
impedisca di accettare la testimonianza di un non musulmano.
Muhammad Hassan, un ex avvocato per i diritti
umani e ricercatore giuridico, ha confermato: «Sono incline alla legge islamica
in questioni relative a costanti religiose che non sono in discussione. Non si
tratta di legge o cose del genere. La tutela è nella casa dei musulmani, dato
che l’Egitto è dimora dell’Islam e il dhimmi (non-musulmano) paga le jizya
(tasse) per facilitare i suoi affari».
Questa era una semplice osservazione di quello che
può succedere alla comunità cristiana in Egitto solo in una settimana!
Il cuore antico del cristianesimo in
Medio Oriente. Mauro Indelicato su Inside Over il 7
dicembre 2021. “Nel mondo milioni di cristiani continuano a vivere emarginati,
in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia
vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa
che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in
particolare coloro che vivono in Libano, Siria e India“. Il Libano, rispetto ai
vicini arabi, ha una particolarità: è l’unico Paese del mondo arabo ad essere a
maggioranza cristiana. O almeno così era fino all’immediato secondo dopoguerra.
L’afflusso di profughi palestinesi prima e siriani poi, ha rivoluzionato il
mosaico demografico. Tuttavia la presenza di cristiani è ancora molto
significativa. I censimenti nel Paese dei cedri si fanno oramai a bassa voce,
non esistono statistiche ufficiali, ma la comunità dovrebbe rappresentare circa
il 40% della popolazione. Ed è questo il dato principale. Perché dona al Libano,
quando si parla di cristianità in medio oriente, un ruolo politico, storico e
sociale fondamentale.
Il ruolo dei maroniti
La diffusione del cristianesimo nell’area libanese
la si deve soprattutto alla Chiesa cosiddetta “maronita“, sviluppatasi intorno
al V secolo. Il suo nome deriva dal fondatore San Marone, un asceta vissuto in
Siria e morto nel 452. I suoi discepoli hanno dato vita a una comunità che nel
corso dei decenni ha considerato l’odierno Libano come sua base principale.
Inizialmente la chiesa maronita ha seguito il Patriarca di Antiochia.
Successivamente si è dotata di maggiore autonoma, pur rimanendo comunque
all’interno dell’alveo romano. I maroniti infatti hanno sempre riconosciuto
l’autorità papale. Dunque oggi è possibile considerare la Chiesa maronita come
pienamente organica alla Chiesa cattolica. Una sorta di “dualismo identitario”
sancito ufficialmente nel sinodo maronita nel 2004. Qui i vescovi maroniti hanno
approvato i cinque elementi distintivi della comunità. Gli ultimi due riguardano
proprio la fedeltà alla Cattedra di San Pietro e il suo radicamento nella storia
del Libano. Per questo ancora oggi sono proprio i maroniti a costituire il
numero più rappresentativo dei fedeli cristiani nel Paese. Una circostanza ben
rintracciabile a livello politico. Quando nel 1943 il Libano ha optato per
l’indipendenza dalla Francia, è stato stilato un “patto nazionale“, valevole
ancora oggi, con il quale si è sancita la divisione delle più importanti cariche
politiche. Ai cristiano maroniti è stata affidata la nomina del presidente della
Repubblica. Da allora fino ad oggi i capi di Stato libanesi sono sempre stati
maroniti. L’afflusso di profughi dalla Palestina dopo la prima guerra
arabo-israeliana del 1948 ha determinato non poche tensioni. Gli equilibri tra
le varie comunità etniche e religiose in Libano sono stati messi pesantemente in
discussione. L’ingresso dell’Olp, l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina, i disagi economici avvertiti dalla popolazione sciita e i timori dei
maroniti di perdere la maggioranza, hanno esasperato il clima. Tutto questo ha
portato al periodo più buio della storia recente libanese, culminato con la
grande crisi del 1958 e la guerra civile iniziata nel 1975. A livello politico,
i partiti rappresentanti i maroniti sono confluiti nelle Falangi e nelle Forze
Libanesi, queste ultime vere e proprie milizie sciolte poi soltanto negli anni
’90. In questa fase la sicurezza è rimasta precaria per tutti i vari cittadini
libanesi, tanto cristiani quanto musulmani. Le ferite aperte durante il
conflitto ancora oggi non sono state del tutto rimarginate.
I cristiani nel Libano di oggi
Quella maronita non è comunque l’unica comunità
cristiana libanese. Fino al 1932 il 10% della popolazione professava la
religione ortodossa. Una percentuale oggi inferiore e non meglio precisata. Gli
ortodossi libanesi in gran parte appartengono alla comunità greco-ortodossa.
Sono presenti, con percentuali inferiori al 10%, i cattolici romani e in minor
misura i cattolici di rito armeno. Poco meno del 2% invece appartiene alla
famiglia protestante. Più o meno tutte le varie comunità cristiane sono
rappresentate da partiti politici. I maroniti hanno come riferimento soprattutto
le Falangi e le Forze Libanesi, ma dal 2005 sulla scena parlamentare si è
affacciato anche il Movimento Patriottico Libero di Michel Aoun, attuale
presidente della Repubblica. In parlamento sono presenti anche membri di partiti
armeni e indipendenti appartenenti alle altre confessioni cristiane. Il punto di
equilibrio, in un sistema che privilegia la suddivisione su base settaria degli
incarichi, è stato raggiunto con gli accordi di Taif del 1989. Con quel
documento, che ha sancito la fine della guerra civile, ai cristiani è stata
riservata la metà dei seggi in parlamento, mentre l’altra metà è suddivisa tra
sciiti, sunniti e drusi. Un compromesso che, unito alla conferma
dell’attribuzione ai maroniti del ruolo di presidente della Repubblica, ha
contribuito a far diminuire le tensioni. Ma i problemi non mancano. I cristiani,
al pari del resto della popolazione, stanno patendo gli effetti di una lunga e
deleteria crisi economica. Oggi a Beirut e in tutte le altre principali città
del Paese, i principali servizi sono a rischio: manca il
carburante, l’elettricità viene erogata per poche ore al giorno, il prezzo dei
beni di prima necessità è alle stelle. Crisi politiche e mancanza di riforme
hanno lasciato sul lastrico il Libano e questo, tra le altre cose, sta facendo
sorgere il timore di nuovi scontri tra le varie comunità. I cristiani libanesi
hanno quindi due sfide davanti a loro. Da un lato respingere le tensioni e,
dall’altro, contribuire alla rinascita del Paese dei cedri. Obiettivi non
semplici, anche considerato il mai domato spettro del terrorismo jihadista.
Da rainews.it il 3 aprile 2021.
Lo ha annunciato il generale Ossama Rabei, capo dell'authority che gestisce il
canale, precisando che all'imbarcazione e al suo carico non sarà permesso
lasciare l'Egitto se la questione dei danni verrà portata in tribunale. In
un'intervista telefonica durante un talk show televisivo, Rabei ha riferito che
l'importo tiene conto dell'operazione di salvataggio, dei costi del traffico
bloccato e delle tasse di transito perse per la settimana. "È un diritto del
Paese", ha detto Rabei, senza specificare chi dovrebbe pagare il risarcimento.
Nel frattempo è ripresa la navigazione nel canale di Suez. L'enorme nave da
carico si trova attualmente in uno dei laghi di contenimento del canale, dove
sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Giovedì, i
responsabili tecnici della nave, Bernard Schulte Shipmanagement, hanno riferito
in una e-mail all'Associated Press che l'equipaggio sta collaborando con le
autorità nell'inchiesta che deve chiarire il motivo per il quale la
portacontainer si è arenata. Gli investigatori dell'authority del Canale di Suez
hanno avuto accesso al Voyage Data Recorder, la scatola nera della nave. Rabei
dal canto suo ha fatto sapere che se l'indagine andrà a buon fine e il
risarcimento verrà pagato, la nave potrà viaggiare senza problemi. Tuttavia, se
la questione del risarcimento sfociasse in un contenzioso, allora l'Ever Given e
il suo carico di circa 3,5 miliardi di dollari non sarebbero autorizzati a
lasciare l'Egitto. Il contenzioso sarebbe complesso, considerato che la nave è
di proprietà di una società giapponese, gestita da uno shipper taiwanese e batte
bandiera panamense. La nave è stata disincagliata lunedì grazie alle operazioni
condotte da una serie di rimorchiatori e con l'aiuto dell'alta marea, da allora
il blocco del traffico marittimo nel Canale di Suez, causato dall'incagliamento,
ha continuato ad attenuarsi, con il numero di navi in attesa di transito che è
sceso a 206 unità. La società Leth Agencies, che gestisce il canale, ha
affermato che, da quando la portacontainer è stata liberata, Suez è stato
attraversato da 357 navi.
Da tgcom24.mediaset.it il 27 marzo 2021.
L'Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di
dragaggio e l'inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given
che da martedì blocca l'importante collegamento marittimo tra Asia ed Europa. La
stessa Authority ha però avvertito che si tratta di una procedura complessa che
prevede vari tentativi, che potrebbero anche andare a vuoto. L'aiuto degli Stati
Uniti- Intanto la marina degli Stati Uniti si è detta disponibile a contribuire
alle operazioni e valuta di inviare una squadra di esperti per consigliare le
autorità locali. "Abbiamo offerto l'assistenza degli Stati Uniti alle autorità
egiziane per aiutare a riaprire il canale", affermano funzionari Usa. "Ci stiamo
consultando con i nostri partner egiziani su come possiamo sostenere al meglio i
loro sforzi". La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito che gli Stati
Uniti hanno ufficialmente offerto la loro assistenza alle autorità egiziane.
Psaki ha detto che le conversazioni con i funzionari egiziani sono "in corso" e
ha confermato che la Casa Bianca "sta monitorando la situazione da vicino".
Dailymail.com il 27 marzo 2021. Fermi tutti! Ma
quali ‘forti venti”, potrebbero esserci stati "errori tecnici o umani" che hanno
portato la nave cargo Ever Given ad arenarsi contro le rive del Canale di Suez.
Lo afferma Osama Rabie, capo dell'Autorità egiziana del Canale di Suez, che ha
confermato che "i forti venti e i fattori meteorologici non erano le ragioni
principali" per l'affondamento della nave nell'affollato canale, avvenuto cinque
giorni fa. Un video di Vessel Finder ricrea l'incidente utilizzando il tracker
di bordo della nave e mostra il momento in cui ha virato a sinistra prima di
andare improvvisamente a dritta e colpire le sponde. Due tentativi per rimuovere
la nave portacontainer lunga 400 metri - e riaprire la rotta commerciale che
facilita il 12% delle spedizioni internazionali - saranno effettuati oggi dopo
che gli sforzi di ieri sono falliti. La nave battente bandiera di Panama, lunga
quanto l'Empire State Building, si è arenata a circa 6 km a nord dell'ingresso
meridionale, vicino alla città di Suez, e ha causato una coda di circa 280
navi. Navi che sembrano fare affidamento sulla liberazione del cargo nave e
stanno ancorando fuori dalla Suez piuttosto che girare intorno al Capo di Buona
Speranza - il che potrebbe aggiungere 14 giorni e 5.000 miglia nautiche al
viaggio, col rischio di esporli alla pirateria. I lavoratori del canale stanno
tentando di estrarre la sabbia intorno alla prua della nave che è incastonata
nella parete orientale del canale e potrebbe dover scavare decine di metri per
consentire alla nave di galleggiare. Nel frattempo rimorchiatori e draghe stanno
lavorando nella parte posteriore della nave per liberare la poppa contro la
parete occidentale. Se questi sforzi falliscono, dovranno intervenire gru
specializzate per aiutare a rimuovere parte del carico, con container che pesano
fino a 33 tonnellate ciascuno. Non solo: si preparano piani per pompare acqua
dagli spazi interni della nave per alleggerire il carico, e domenica dovrebbero
arrivare altri due rimorchiatori per unirsi ad altri che stanno già cercando di
spostare l'enorme nave. Un funzionario dell'Autorità del Canale di Suez ha
comunicato del progetto di fare almeno due tentativi oggi per liberare la nave
quando la marea cala. Secondo la società giapponese Shoei Kisen KK, proprietaria
della nave portacontainer, almeno 10 rimorchiatori sono già stati schierati per
aiutare a rimettere a galla la nave. Intanto, dalla Casa Bianca, Joe Biden, ieri
ha detto: "Abbiamo attrezzature e capacità che la maggior parte dei paesi non ha
e stiamo vedendo cosa possiamo fare e quale aiuto possiamo essere". Il fatto che
la Casa Bianca sia pronta al soccorso sottolinea quanto sia essenziale il Canale
di Suez per il buon funzionamento del commercio globale. Aziende e governi
stanno già avvertendo ritardi per le merci in arrivo dall'Asia. Ikea ha
avvertito di ritardi nelle forniture, che interesseranno principalmente le merci
dall'Asia, come elettricità e mobili. Gli analisti affermano che ogni ora in cui
la nave rimane incuneata sul canale ha un costo per stimato di 290 milioni di
sterline. Una chiusura prolungata del corso d'acqua è particolarmente cruciale
per il trasporto del petrolio e gas in Europa dal Medio Oriente. Si teme che
merci come lavatrici, parti di automobili e giocattoli che vengono comunemente
importati dalla Cina e altri partner commerciali asiatici potrebbero
scarseggiare poiché le navi da carico destinate all'Europa rimangono bloccate
nel canale di Suez. Prevedendo lunghi ritardi, i proprietari della nave bloccata
hanno invece dirottato una nave gemella, la Ever Greet, su una rotta intorno
all'Africa. Anche altri cargo vengono deviati. Il vettore di gas naturale
liquido Pan Americas ha cambiato rotta nel medio Atlantico, ora punta a sud per
aggirare la punta meridionale dell'Africa, secondo i dati satellitari di
MarineTraffic.com. La Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti, che opera
nel Mar Rosso, è stata contattata negli ultimi due giorni da un certo numero di
compagnie di navigazione, temendo di poter essere attaccate. Zhao Qing-feng,
responsabile dell'ufficio dell'Associazione degli armatori cinesi a Shanghai, ha
dichiarato al Financial Times che le navi che scelgono di percorrere la rotta
africana dovranno assumere personale di sicurezza aggiuntivo per garantire che
siano al sicuro. Nel frattempo Willy Lin, presidente del Consiglio dei
caricatori di Hong Kong, ha detto che una coalizione internazionale di navi da
guerra navali potrebbe dover essere coinvolta per proteggere le navi da carico
se la crisi si trascina. La Ever Given, costruita nel 2018 con una lunghezza di
quasi 400 metri e una larghezza di 60 metri, è tra le più grandi navi da carico
del mondo. Può trasportare circa 20.000 container alla volta. In precedenza era
stato nei porti della Cina prima di dirigersi verso Rotterdam nei Paesi Bassi.
Cristiano Tinazzi per "Il Messaggero" il 31 marzo
2021. Dopo sei giorni di attesa, la nave Ever Given è stata liberata. Il
traffico nel canale di Suez è finalmente ripreso. In coda, per passare nel
canale, si sono accumulate più di quattrocento navi e ci vorranno giorni per
smaltire il passaggio di tutte le imbarcazioni e riportare alla normalità il
traffico navale. Un incidente che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo
intero, a causa delle sue ripercussioni sulla catena globale degli
approvvigionamenti energetici e commerciali. Un blocco che è costato quasi dieci
miliardi di dollari al giorno. Poco prima del disincagliamento della
portacontainer, l'agenzia di rating Fitch aveva prospettato danni per centinaia
di milioni di euro per le compagnie di riassicurazione. La svolta è avvenuta
poco dopo le tre del pomeriggio, quando il cargo battente bandiera panamense è
tornato a navigare. Già nella notte il portacontainer era stato raddrizzato per
l'ottanta per cento grazie al lavoro di tredici rimorchiatori, col contributo
anche del rimorchiatore italiano di altura Carlo Magno, che ha lavorato tirando
la poppa. Ma la parte più problematica era sbloccare la prua, come rilevato uno
degli esperti intervenuto sul posto, Peter Berdowski, direttore esecutivo della
Royal Boskalis, casa madre di Smit Salvage, alla radio pubblica olandese. Per
rimettere in navigazione il portacontainer della classe megaship è stato
necessario dragare in questi giorni trentamila tonnellate di sabbia dal fondo
del canale. Il capitano della portacontainer e i venticinque membri indiani
dell'equipaggio intanto rischiano gli arresti domiciliari e accuse penali. «C'è
un pericolo evidente che l'equipaggio della nave venga usato come capro
espiatorio», ha detto il capitano Sanjay Prashar, membro del National Shipping
Board (Nsb), al Times of India. «Prima di tutto è necessario accertare le cause
che hanno portato la gigantesca nave ad arenarsi», ha affermato Prashar,
aggiungendo che «per verificare i fatti è necessario ascoltare ed esaminare le
registrazioni delle conversazioni fatte durante il viaggio della nave e così si
può arrivare a capire che cosa abbia causato l'intoppo». Dopo l'annuncio della
ripresa della navigazione, il capo dell'Authority del Canale di Suez,
l'ammiraglio Osama Rabie, ha previsto che ci vorranno circa tre giorni e mezzo
per smaltire tutto il traffico nel canale. Le perdite da parte egiziana per
mancati pedaggi sono dai dodici ai quindici milioni di dollari, ha confermato
Rabie, il quale ha sottolineato come l'incidente abbia «messo in luce
l'importanza del canale». La portacontainer si è poi diretta con i propri motori
verso in un bacino interno allo stretto per essere sottoposta a una revisione
tecnica. In tono trionfalistico, è intervenuto anche il presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi, recatosi in visita a Suez dopo il disincaglio della Ever
Given: «Sono qui per lanciare un messaggio attraverso i media e dire che il
canale di Suez è potente e in grado di assumersi la responsabilità del commercio
internazionale». Al-Sisi ha celebrato «l'enorme complessità tecnica»
dell'impresa ricordando, con toni nazionalistici, che gli egiziani «hanno
scavato il canale con i corpi dei loro antenati e lo hanno difeso con le anime
dei loro padri nella guerra dei sei giorni del 1967». Retorica nazionalista
vecchio stile che in Egitto ha ancora un certo effetto su parte della
popolazione. Le reazioni sui social media a proposito della crisi di Suez,
definita un calvario, per al-Sisi sono state «una dimostrazione di quanto gli
egiziani amino il loro Paese». Il presidente egiziano ha infine ringraziato «gli
amici dell'Egitto del Golfo e nel mondo per aver offerto sinceramente la loro
assistenza e per aver contribuito a risolvere in tempi record e con il numero
minimo possibile di perdite la crisi del Canale di Suez». Dopo la notizia della
riapertura del canale sono migliorate le principali borse europee, nonostante le
notizie sulla pandemia, e il petrolio è sceso dello 0,5%, attestandosi a 60,6
dollari al barile.
La crisi di Suez dimostra il fallimento
delle grandi opere promesse da al-Sisi. Giuseppe
Acconcia su Notizie.it il 29/03/2021. Lo stop al commercio globale potrebbe
aprire il vaso di Pandora delle mille contraddizioni di un presidente che
impoverisce il suo popolo in nome della salvaguardia della propria immagine.
Dopo il colpo di stato militare del 2013, l’Egitto era stato definito da molti
capi di stato un modello di stabilità per il Nord Africa e il Medio Oriente.
Tutto sembrava andare in questa direzione quando nell’agosto del 2015 venne
inaugurata un’estensione di appena 35 km del Canale di Suez. Sembrava che
l’esercito egiziano volesse confermare la sua immagine di modernizzatore del
Paese. L’opera è stata conclusa a tempo di record in poco più di un anno. Eppure
a distanza di sei anni il Canale di Suez è stato chiuso per una settimana a
partire dallo scorso martedì, il cargo portacontainer Ever Given di 400 metri è
stato a fatica liberato e si è creato un enorme ingorgo che ha bloccato le 370
navi in transito. Le operazioni vanno avanti mentre si stima che le perdite
ammontino a circa 9,6 miliardi di dollari al giorno. Eppure, nonostante progetti
faraonici di città satellite e per attrarre investimenti esteri, gli egiziani
continuano ad impoverirsi.
Il Canale di Suez da Nasser ad al-Sisi. Il Canale
originale, nazionalizzato dal presidente egiziano Gamal Abdel Nasser nel
1956, era lungo 193 chilometri, 80 dei quali già a doppia corsia (una bretella
di 53 chilometri è stata aggiunta nel 1980). Con l’estensione del Canale,
inaugurato il 6 agosto 2015 alla presenza del presidente francese François
Hollande e del premier russo Dimitry Medvedev, si è passati a 115, 5
chilometri percorribili nei due sensi. In altre parole cargo e navi mercantili
possono raggiungere i porti della Gran Bretagna partendo dai Paesi del Golfo in
14 giorni anziché 24. Non solo, si sono accorciati i tempi di attesa per le navi
dirette in Europa: da undici passano a tre ore. Si riducono anche i tempi di
attraversamento del Canale (da 18 a 11 ore). Secondo i piani, si sarebbe dovuti
passare così dalle 49 navi al giorno che attraversavano Suez a 97. Al momento
dell’estensione nel 2015, il Canale controllava il 19% (240 mila tonnellate di
merci) dei traffici marittimi mondiali e la sua centralità è continuata ad
andare crescendo esponenzialmente dal 2000 in avanti. Eppure, l’opera, costata 8
miliardi di dollari, ha accresciuto i profitti del Canale di Suez di appena il
4,7% tra il 2015 e il 2019, ben al di sotto dei 100 miliardi all’anno annunciati
alla vigilia. Molti analisti critici nei confronti del progetto di estensione
del Canale di Suez avevano sottolineato che gli effetti sull’economia egiziana
in seguito alla realizzazione dell’opera sarebbero stati minimi. Non solo, i
lavori per l’estensione del Canale hanno fatto registrare un impatto ecologico
consistente. Non sono stati disposti studi sufficienti per l’impatto ambientale
dell’opera. 1500 case sono state rase al suolo per la costruzione dei cantieri.
Cinquemila abitazioni sono state distrutte lungo lo scavo. Gli abitanti di
Ismailia hanno denunciato di non aver ricevuto nessuna compensazione per aver
perso la loro casa. Durante i lavori gli ingegneri hanno riscontrato quantità
eccessive di acqua da drenare che hanno fatto temere per la stabilità
dell’opera. In più, al-Sisi aveva promesso per la realizzazione della bretella
la creazione di «un milione di posti di lavoro». Eppure l’opera non ha inciso
sugli alti tassi di disoccupazione giovanile che restano preoccupanti per il
Paese.
Gli sforzi per le grandi opere di al-Sisi. Secondo
i piani entro la fine del 2019 dovevano essere terminati anche i lavori per la
realizzazione della città satellite del Cairo, centro amministrativo del paese.
Tra i progetti realizzati c’è una delle torri più alte in Africa, con i suoi 350
metri. Sono state realizzate qui ampie zone residenziali e imponenti centri
commerciali. A lavori terminati, la città ospiterà un totale di 5 milioni di
abitanti potenziali. Tra i finanziatori dei lavori c’è anche Mohammed Alabbar,
uno degli emiri che ha realizzato con ingenti investimenti i lavori di
costruzione di imponenti grattacieli a Dubai. Nei primi anni di presidenza
al-Sisi, sono stati numerosi i segnali positivi in termini di investimenti
esteri in Egitto al tempo della presidenza di Donald Trump. Un esempio concreto
è venuto da grandi imprese statunitensi ed europee che sono tornate a fare
affari in Egitto. Per esempio, il consigliere di amministrazione di Visa, Alfred
Kelly, ha realizzato nuovi investimenti nel Paese in seguito ai risultati
ottenuti in tema di digitalizzazione dell’economia. Kelly ha anche salutato
positivamente l’obiettivo promosso dalle autorità egiziane nel favorire i
pagamenti digitali. Il Cairo ha puntato così ad attrarre nuovi investimenti dopo
i contratti da oltre 8 miliardi di dollari siglati nella visita di al-Sisi in
Francia nel 2015 con imprenditori francesi. A quota 8,5 miliardi di dollari
ammontavano gli accordi commerciali conclusi con l’Italia nella visita a Roma e
Milano del premier egiziano Ibrahim Mahleb nel luglio 2014. Il Golfo di Suez,
insieme al Mediterraneo orientale e al Delta del Nilo, è l’area dove sono
cresciuti di più gli investimenti esteri per lo sviluppo di giacimenti nel
mercato petrolifero egiziano. Non solo, la realizzazione di quest’opera, in una
regione colpita da grave instabilità politica com’è il Sinai, ha anche permesso
al Cairo di puntare di più sulla produzione di gas: grazie alla gestione del
Canale di Suez e della Suez-Med Pipeline. Dopo gli attacchi jihadisti ai
gasdotti nel Sinai e lo stop all’esportazione di gas verso Israele e Giordania
(2012), le imprese energetiche Usa (Noble) e l’israeliana Delek guardano sempre
di più al mercato energetico egiziano per le loro esportazioni.
L’economia egiziana è al collasso. Eppure,
nonostante gli annunci e l’avvio delle grandi opere, l’economia egiziana è al
collasso. Mentre al-Sisi è stato impegnato a ricostruire la sua immagine
all’estero e a tagliare la spesa pubblica per ottenere le tre tranche di
prestito di 12 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale
(FMI), povertà e disuguaglianze in Egitto non hanno accennato a diminuire. E
così nel 2015, al-Sisi ha chiesto al mondo tra i 200 e i 300 miliardi di
dollari per lo sviluppo del Paese. Eppure, tra il 2015 e il 2019, il presidente
egiziano ha fatto crescere il debito pubblico investendo 200 miliardi di dollari
in mega progetti infrastrutturali. Ha radicato nuove forme di capitalismo di
Stato, guidato dall’élite militare, e fondato sull’appropriazione di fondi
pubblici, la proprietà in mano ai militari delle principali aziende del paese
(dalla produzione del latte e dei frigoriferi fino ai grandi resort turistici) e
politiche di austerità, inclusi tagli ai sussidi sul pane e le bollette
dell’elettricità. La politica economica di al-Sisi ha prodotto il deprezzamento
della lira egiziana del 50% rispetto al dollaro, alti tassi di inflazione e la
crescita dei tassi di povertà in un paese dove già un terzo delle persone vive
con meno di un dollaro al giorno. Lo scorso novembre la Banca mondiale ha
pubblicato un report secondo il quale il debito pubblico egiziano avrebbe
raggiunto il 96% del Pil nel 2020-2021, nel 2013 era all’87%. Non solo, lo
scorso maggio, l’Egitto ha emesso 5 miliardi di dollari in eurobond, seguiti da
3,75 nel mese di marzo 2021, si tratta della maggiore emissione nella storia del
paese. I problemi non riguardano solo l’aumento dei prezzi e il debito
pubblico, la crescita economica tra il 2015 e il 2019 (4,8%) è
stata inferiore alla media degli ultimi anni di presidenza Mubarak. La crescita
al di sotto delle aspettative riguarda anche il settore non petrolifero,
confermando che l’aumento della povertà sta facendo diminuire il livello di
consumi nel Paese. Non si sono fermati neppure gli scioperi e le mobilitazioni
degli operai. Quattromila operai dell’ Egyptian Iron e Steel Company , impegnata
in mega progetti voluti dal presidente al-Sisi, hanno avviato un sit-in di
protesta lo scorso 17 gennaio contro la liquidazione della fabbrica. Simili
proteste hanno avuto luogo nel dicembre 2020 da parte dei lavoratori delle
fabbriche tessili di Kafr al-Dawar preoccupati della possibile liquidazione
dell’impianto che resterà fermo almeno per i prossimi nove mesi. L’incapacità di
al-Sisi nella gestione economica dopo il suo insediamento in seguito al colpo di
stato del 3 luglio 2013 è stata messa a dura prova dalla crisi del Canale di
Suez. Lo stop al commercio globale potrebbe aprire finalmente il vaso di Pandora
delle mille contraddizioni di un presidente che in nome della salvaguardia della
sua immagine e di quella dell’esercito, di una millantata stabilità politica
sinonimo di repressione permanente, sta impoverendo il suo popolo e esacerbando
le carenze infrastrutturali del Paese.
Come ha fatto l'Egitto a passare dalla
primavera Araba alla repressione di al-Sisi. Piazza
Tahrir al Cairo è stata il simbolo del movimento di democratizzazione che ha
interessato nord-Africa e medio Oriente dieci anni fa. Ma quel sogno è morto
presto, lasciando spazio alla dittatura militare. Federica Bianchi su L'Espresso
il 2 febbraio 2021. A dieci anni dalla Primavera araba, suo tentativo di
risveglio, l’Egitto è ormai sprofondato in un lungo inverno dittatoriale che ha
permanentemente congelato ogni anelito di democrazia. L’esercito non soltanto ha
ripreso il controllo del Paese con astuzia nel 2013 ma, complice un Occidente,
dagli Usa alla Francia, più interessato alla stabilità della regione che ai
diritti dei suoi cittadini, negli ultimi anni Il Cairo non ha sentito il bisogno
di sbandierare o fingere un sostegno popolare per esercitare il potere assoluto.
Ogni opposizione è stata definitivamente stroncata senza nessuna concreta
obiezione. L’Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi ospita nelle sue carceri
oltre 60mila prigionieri politici, negli ultimi due mesi del 2020 ha eseguito 57
pene capitali (il doppio rispetto a tutto l’anno precedente) e occupa il
166esimo posto su 180 in termini di libertà di stampa. Appena salito al potere
nel 2013, al-Sisi non solo massacrò durante la prima protesta 800 oppositori
politici ma impose subito nuove leggi per impedire ogni futura protesta; poi nel
2015 impose una legislazione anti-terrorismo che lascia all’esercito arbitrio
assoluto; nel 2017 varò una legge per privare della cittadinanza gli egiziani
residenti all’estero (se ritenuti pericolosi per lo Stato) e nel 2018 passò una
norma anti-terrorismo cibernetico per impedire ogni aggregazione in rete.
D’altronde la rivoluzione del 25 gennaio 2011 era nata sul web e si era
organizzata sui social. Questo il clima in cui nel gennaio 2016 è stato
arrestato e torturato a morte Giulio Regeni, colpevole di fare troppe domande
scomode, e in cui è oggi in carcere Patrick Zaki, reo di difendere i diritti
umani e, in particolare, quelli delle donne. In Egitto i mariti sono ancora
padroni assoluti e le mogli marciscono in galera per adulterio. Sono anni che il
mondo si interroga su come una rivoluzione che ha ridato speranza a milioni di
disperati possa essere finita così male. Come dal temuto Hosni Mubarak si sia
passati al crudele al-Sisi. E dire che per per due anni e mezzo piazza Tahrir,
un’enorme rotonda nel cuore del Cairo, schiacciata tra il Nilo e il museo
egizio, era divenuta il simbolo mondiale della democrazia, dove i progressisti
del movimento 6 Aprile e di Kefaya si confrontavano con i giovani della setta
islamica dei Fratelli musulmani, riconoscibili per quei lividi in fronte,
orgogliosamente ottenuti appoggiando di continuo il capo a terra in preghiera.
Tutti intorno a una tazza di tè alla menta, uniti dallo stesso anelito non solo
di democrazia ma soprattutto di espressione, un lusso, sull’altra sponda del
Mediterraneo. Ad unirli avevano il nemico. A dividerli l’ideologia senza
compromessi. Gli islamisti, sostenuti dalla maggioranza del Paese, volevano
ottenere il potere politico dopo decenni di oppressione. I progressisti erano e
restano minoranza, ma una minoranza più preparata e dialogante con un Occidente
afflitto dal terrorismo islamico. Entrambi i fronti non hanno saputo scendere a
patti. Inesperienza politica e una certa dose di sfortuna hanno giocato contro.
Quando il professore islamista Mohamed Morsi è stato votato democraticamente
presidente nel 2012, ha fatto guerra agli ex compagni rivoluzionari anziché
scendere a compromessi con i liberali di Mohamed El Baradei e tessere insieme
reti per imbrigliare l’immenso potere dell’esercito, che in Egitto controlla
tutto, dall’economia alla società. Quest’ultimo ha prima finto di sostenerlo,
poi si è organizzato, reclutando giornalisti locali e servizi segreti per
alimentare il discontento nella popolazione verso il “terrore islamico”,
utilizzando con sapienza i giornalisti occidentali per diffondere la propria
propaganda come fosse la volontà del popolo. Ma un movimento come Tamarod,
Ribelle, di Mahmoud Badr, il giovane dalla retorica facile che passava ore a
conversare con la stampa di mezzo mondo, si scoprì dopo, era tutto tranne che
figlio del popolo. Così, senza rendersene conto, in un tripudio di bandiere e
canti patriottici, l’Egitto è finito contento nel colpo di Stato ordito
dall’esercito, salutato come custode della Patria, il 3 luglio 2013. Non
intuendo neppure che, l’arresto del presidente Morsi, avvenuto qualche giorno
dopo, rappresentava un nefasto presagio del futuro. Un futuro che oggi è
cronaca.
·
Quei razzisti come i somali.
Una catena infinita di
vendette. Cosa sta succedendo in Somalia e perché da 10 anni si combatte senza
sosta.
Sergio D'Elia su Il Riformista il 2 Luglio 2021. La Somalia è la terra africana
dove la storia millenaria di Caino e Abele continua a rappresentare una tragica
attualità. I nemici dello Stato si chiamano Al-Shabaab. Lo Stato che li combatte
è diviso in altrettanti Stati, tutti gelosi della loro indipendenza, uniti solo
nella lotta senza quartiere al terrorismo islamico. Da oltre dieci anni gli uni,
i “buoni”, si confrontano con gli altri, i “cattivi”. Si combattono senza sosta
e si somigliano nella sostanza. La catena infinita dell’odio e della vendetta è
un gioco di specchi delle parti in causa nel quale il bene e il male si
confondono, il giusto e lo sbagliato si annullano. La stessa legge, quella del
taglione, ispira gli uni e gli altri, gli islamisti e
gli anti-islamisti. L’amalgama di sistemi giuridici, di tradizioni e diritto
consuetudinario, un tempo, disegnava un codice molto più civile della legge
della Sharia che la Somalia a un certo punto ha introdotto nel tentativo di
placare l’ira degli Al-Shabaab. Alla mossa politica “pacifista” del governo, gli
estremisti islamici hanno corrisposto con una ferocia ulteriore e un
integralismo religioso rafforzato. Gli Al-Shabaab hanno decapitato o fucilato
centinaia di persone: cristiani o apostati dell’Islam, ladri, adulteri e maghi,
spie al servizio del governo somalo, della forza militare dell’Unione Africana,
della CIA e dell’MI6 inglese. La scena è sempre la stessa: un sedicente giudice
coranico emette la condanna a morte davanti a centinaia di residenti convocati
con gli altoparlanti al centro della città e costretti ad assistere
all’esecuzione dei malcapitati legati a un palo. Dopo l’esecuzione, gli
Al-Shabaab seppelliscono le vittime in luoghi chiamati “cimiteri degli
infedeli”. Il governo somalo risponde in automatico, e con una violenza uguale e
contraria. Processi da giustizia sommaria sono celebrati da tribunali militari
che operano ad ampio spettro e non vanno molto per il sottile. Non solo
processano soldati accusati di reati militari, ma anche soldati, poliziotti,
combattenti di Al-Shabaab e civili accusati di reati comuni. La velocità con cui
le condanne a morte sono eseguite impedisce agli imputati di presentare ricorso
e al Presidente di esaminare il caso per una possibile grazia o commutazione
della pena. Anche le Nazioni Unite hanno espresso la propria preoccupazione per
il “frettoloso” procedimento giudiziario che ha portato a decine di esecuzioni.
Domenica scorsa, nell’arco di una sola giornata, la Somalia ha vissuto una
sequenza impressionante di azioni e reazioni, di cause ed effetti, di delitti e
vendette. Al mattino, cento islamisti hanno attaccato Wisil, una piccola città
nello stato di Galmudug. Al-Shabaab ha rivendicato l’azione che avrebbe causato
34 vittime tra le forze di sicurezza. Circa due ore dopo l’attacco a Wisil, le
autorità dello stato del Puntland hanno giustiziato 21 uomini accusati di
appartenere ad Al-Shabaab. Il giorno prima, il ministro della sicurezza del
Puntland era sfuggito a un attentato dinamitardo di Al-Shabaab che avevano preso
di mira il suo corteo di auto. I 21 giustiziati per vendetta erano stati
condannati in processi separati per una serie di omicidi e attacchi terroristici
che sono costati la vita a leader regionali e comunitari, agenti di sicurezza e
giornalisti. Diciotto di loro sono stati allineati vicino a una collina di
sabbia fuori dalla città di Galkayo. Il plotone di esecuzione ha aperto il
fuoco, giustiziandoli. Nelle stesse ore, altri tre uomini sono stati fucilati
a Garowe e nella città di Qardho. È stata la più grande esecuzione singola di
militanti di Al-Shabaab in Somalia. Domenica pomeriggio, un altro plotone
d’esecuzione, stavolta di Al-Shabaab, ha giustiziato in pubblico sei persone,
tra cui una donna di 36 anni, Fartun Omar Abkow. Erano accusate di spionaggio
per conto della CIA e sono state fucilate in una piazza nella città
di Sakow, nella regione del Medio Jubba. È stata la vendetta degli Al-Shabaab
per l’esecuzione dei suoi militanti nel Puntland. A New York, al Palazzo di
Vetro, la Somalia ha sempre votato a favore della moratoria sulla pena di morte.
A Mogadiscio, non hai mai smesso di praticarla presso l’Accademia di polizia del
generale Kahiye. In questi anni, la comunità internazionale non gli ha mai
chiesto conto di questa doppiezza. Anzi, ha continuato ad assistere la Somalia
nel peggiore dei modi. Con il paternalismo della cooperazione allo sviluppo ha
speso molto in “aiuto umanitario” e investito poco in Stato di Diritto. Con il
militarismo nella lotta al terrorismo ha affidato la giustizia ai plotoni
d’esecuzione dell’esercito somalo e ha praticato in proprio quella segreta e più
sbrigativa delle uccisioni coi missili sparati dai droni. Occhio per occhio, la
Somalia è diventata oggi un Paese accecato dall’odio, paralizzato dalla paura,
desertificato dalla violenza. Una terra dove abita solo Caino. Sperando contro
ogni speranza, scriviamo ora un’altra storia, in cui a emergere siano il diritto
e la coscienza, grazia e giustizia. Sergio D'Elia
La ricostruzione. Chi sono
gli al-Shabaab, gli estremisti islamici che hanno rapito Silvia Romano.
Redazione su Il
Riformista il 11 Maggio 2020. Il nome degli al-Shabaab è tornato alla ribalta
con il rapimento della volontaria italiana Silvia Romano, rilasciata venerdì 8
maggio dopo 18 mesi di prigionia. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di
Roma e dai carabinieri del Ros, la 25enne è stata tenuta prigioniera
in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista di al-Shabaab. Emersi nel 2006
dopo la sconfitta dell’Unione delle Corti Islamiche da parte del Governo
Federale di Transizione, gli al-Shabaab, dal 2008 sono nella lista delle
organizzazioni terroristiche degli Usa e nel 2012 hanno giurato fedeltà
ad al-Qaeda. Sono stati protagonisti e firmatari di sanguinosi attentati, tra
cui quello al centro commerciale Westgate a Nairobi che nel settembre del 2013
costò la vita a 67 persone. Due anni dopo, nel 2015 fecero una strage contro un
campus universitario in Kenya, con un bilancio di almeno 147 morti, e nel
dicembre 2018 un attentato con autobomba a Mogadiscio che ha contato almeno 85
morti. E’ dello scorso settembre invece l’attacco degli al-Shabaab contro la
base americana all’aeroporto militare di Baledogle, nello stesso giorno in cui a
Mogadiscio una bomba è esplosa al passaggio di un convoglio di mezzi militari
italiani. GLI AL-SHABAAB – Definiti come la peste del Corno d’Africa in quanto
identificati come uno dei più violenti gruppi di guerriglieri somali, gli
al-Shabaab, in italiano “i giovani”, sono un movimento di resistenza popolare
nella terra delle due migrazioni. La loro nascita è dovuta ad uno scopo preciso:
quello di rovesciare il governo di Mogadiscio, utilizzando regolarmente
attentatori suicidi contro il governo, i militari ed i civili. Di stampo
islamico, il gruppo è opposto al TFG, Governo Federale Transitorio della
Somalia, e a tutto ciò che non rientra nei canoni islamisti, oltre che essere
alleato di al-Qaeda. Il gruppo dei ‘giovani’ inizia ad allinearsi ad al Qaeda
sia nell’ideologia che nella tattica e ad avere come obiettivi i civili con
attacchi suicida molto più frequenti. Infatti al-Shabaab fa leva sulla sua
relazione con al Qaeda per attrarre combattenti stranieri, i cosiddetti foreign
fighters e donazioni in denaro dai sostenitori della cellula jihadista. Anche se
i loro efferati attentati sono stati commessi in maniera ricorrente dal 2008,
quando sono stati dichiarati terroristi dal Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, la loro esistenza risale al 2006 formando l’Unione dei Tribunali Islamici
(ICU) che governavano la Somalia prima di essere cacciati da Mogadiscio con
l’intervento delle truppe etiopiche. L’obiettivo principale del gruppo è quello
di riconquistare tutte le terre storicamente “islamiche” ora in mano ai non
credenti imponendo la stretta osservanza della Sharia Law o comunemente
conosciuta come legge di Maometto. Questa formazione islamista è presente nelle
regioni del sud della Somalia e mantiene vari campi di addestramento nei pressi
di Chisimaio. Alcuni finanziamenti per al-Shabaab provengono dalle attività dei
pirati somali, anche se per quanto riguarda le armi il loro principale
rifornitore è l’Eritrea, da sempre nemico dell’Etiopia. L’attuale leader degli
al-Shabaab è Ahmed Umar, nominato dopo che nel 2014 l’allora leader degli
al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, è stato ucciso in un raid di un drone americano.
Dal 2016 gli Stati Uniti, infatti, hanno intensificato i raid aerei, gli
attacchi con droni e le operazioni contro il gruppo in Somalia.
·
Quei
razzisti come gli etiopi.
Chi è Abiy Ahmed.
Mauro Indelicato su Inside Over il 21 novembre 2021. Abiy Ahmed è
il primo ministro dell’Etiopia dal 2 aprile 2018. Di etnia oromo, la
maggioritaria nel Paese ma anche tra le più emarginate, deve la sua fama
internazionale al premio nobel per la pace ricevuto nel 2019 e alla sua immagine
di giovane primo ministro modernizzatore. Tuttavia il nome di Abiy Ahmed è
destinato a essere legato anche alla guerra avviata dal suo governo nella
regione etiope del Tigray.
La famiglia multireligiosa di Abiy Ahmed
Abiy Ahmed nasce a Beshasha, piccola località
dell’attuale Stato di Oromia, il 15 agosto 1976. La sua famiglia appartiene
all’etnia oromo. Si tratta dell’etnia predominante in Etiopia, ma allo stesso
tempo quella che negli anni accusa le maggiori discriminazioni. Nell’anno di
nascita di Abiy Ahmed, al potere vi è il cosiddetto “negus rosso”, ossia Hailé
Menghistu, a capo di un regime filo comunista.
La sua famiglia non sembra risentire molto dei
trambusti politici di quel momento. Il padre è un semplice contadino, uno dei
tanti impegnati nelle terre di Oromia. C’è però una particolarità, non così rara
nelle province a maggioranza oromo. Se il padre è di religione musulmana, la
madre invece è cristiano ortodossa. Sono diverse già all’epoca le famiglie
formate da due differenti religioni. A Beshasha, così come nei villaggi
circostanti, la percentuale di musulmani e cristiani si equivale.
La famiglia di Abiy Ahmed, oltre a essere
multireligiosa, è anche molto numerosa. Il futuro premier è il tredicesimo
figlio di suo padre, nonché il sesto avuto dal rapporto tra suo padre e sua
madre, quest’ultima sua quarta moglie. Questo contesto familiare influisce in
futuro sulla formazione politica di Abiy Ahmed, la cui linea da premier è quella
di superare le varie divisioni settarie sia etniche che religiose.
Il giovane Abiy aderisce comunque alla formazione
religiosa della madre, anche se in un secondo momento lascerà il cristianesimo
ortodosso per sposare l’adesione alla Chiesa Evangelica Pentecostale.
La formazione del futuro premier etiope
Le scuole in Etiopia in quegli anni iniziano ad
essere diffuse e ad arrivare anche nei paesi più remoti. Abiy Ahmed può quindi
permettersi la formazione elementare nel suo villaggio natio. Si sposta a 14
anni ad Agaro per frequentare gli istituti superiori.
Riesce, nonostante limitate risorse economiche
familiari, ad iscriversi all’università. I suoi studi accademici iniziano
comunque dopo i 20 anni in quanto Abiy Ahmed in quel periodo è maggiormente
concentrato nello sviluppo della carriera militare. La sua prima laurea arriva
nel 2009. Il primo titolo è in ingegneria informatica e viene conseguito ad
Addis Abeba. Successivamente Abiy Ahmed, in parallelo con la sua carriera
politica, continua a studiare nella capitale etiope in economia, con una laurea
presa nel 2011, e in filosofia. La fine degli studi universitari in quest’ultima
facoltà risale al 2017, con un dottorato su “pace e conflitti”.
L'affiliazione di Ahmed all'Oromo Democratic Party
Ma l’avvicinamento di Abiy Ahmed al mondo politico
non si ha all’università. Al contrario, il primo contatto con la politica è a 14
anni, quando il futuro premier aderisce all’Oromo Democratic Party (Odp). Si
tratta di una formazione partitica e paramilitare impegnata nella lotta contro
Menghistu. Il movimento è alleato con quello di altre etnie contro il governo
centrale di Addis Abeba. Per questo Abiy Ahmed entra a contatto con altri
contesti del suo Paese, uscendo dalla sua regione di origine.
Buona parte dei ribelli sono di etnia tigrina e
infatti il giovane inizia a parlare tigrino e amarico, quest’ultima lingua
franca del Paese. Nello stesso anno in cui Abiy aderisce all’Odp, ossia nel
1991, il governo del negus rosso viene rovesciato. A quel punto le varie milizie
ribelli danno vita al nuovo esercito etiope e il futuro premier decide
intraprendere la carriera militare.
Abiy Ahmed ha 16 anni quando nel 1993 diventa
ufficialmente un soldato del nuovo esercito. L’anno dopo fa parte del
contingente etiope spedito in Ruanda a sostegno della missione delle Nazioni
Unite. Come soldato viene coinvolto nel conflitto scoppiato nel 1998 tra Etiopia
ed Eritrea. Il suo impiego però non è come soldato semplice. Al contrario, Abiy
risulta organico a una squadra incaricata a scoprire il posizionamento delle
forze avversarie lungo i confini contesi. Entra quindi a tutti gli effetti
nell’intelligence etiope.
Durante i suoi anni nell’esercito, conosce Zinash
Tayachew. Si tratta di una giovane donna di etnia ahmara impegnata anch’essa a
prestare servizio militare. Tra i due nasce una storia sentimentale che li porta
presto al matrimonio. È lei, peraltro cantante delle canzoni gospel in chiesa, a
far avvicinare Abiy Ahmed alla religione evangelica. I due in futuro hanno tre
figli e adottano un quarto figlio.
Con il cessate il fuoco nel 2000 tra Etiopia ed
Eritrea, il futuro premier decide di continuare la sua carriera nell’esercito e
alternarla con gli studi universitari.
La fondazione dell'Agenzia Etiope per la sicurezza
informatica
La sua laurea in informatica e le competenze
acquisite nel settore, fanno di Abiy un riferimento all’interno dell’esercito
per la sicurezza informatica. Non a caso nel 2006 figura tra i fondatori
dell’Agenzia Etiope per la sicurezza informatica (Insa), di cui diventa anche
vice presidente. Per un periodo ricopre l’incarico di direttore ad interim.
L'ingresso in politica di Abiy Ahmed
Nel 2010 arriva un’importante svolta. Abiy Ahmed
decide di lasciare l’esercito e l’agenzia Insa per dedicarsi unicamente alla
politica. Punto di partenza per questa sua nuova avventura è ancora una volta
l’Oromo Democratic Party (Odp). Il partito fa parte della coalizione del Fronte
democratico rivoluzionario del popolo etiope (EPRDF), al potere dal
rovesciamento di Menghistu e dominata al suo interno dal Tplf, il partito cioè
dell’etnia tigrina.
Nell’anno in cui Abiy Ahmed decide di impegnarsi
esclusivamente alla politica, viene eletto alle elezioni nazionali quale
deputato del collegio di Agaro. Durante il suo primo mandato parlamentare
scoppiano tensioni e scontri tra musulmani e cristiani nelle sue zone di
origine. Per questo viene mandato dall’Odp a mediare. Il suo ruolo per arginare
le violenze viene considerato importante. Tanto che pochi anni dopo è uno dei
deputati scelti per la fondazione del Forum per il dialogo e per la pace,
organismo creato proprio per dirimere le controversie tra le diverse confessioni
religiose presenti in Etiopia e in particolare nello Stato di Omoria.
Nel 2015 arriva la rielezione per un secondo
mandato in parlamento. In quell’anno scoppia la questione relativa ai piani
urbani di sviluppo di Addis Abeba. I progetti, mandati avanti dall’allora
governo guidato dal tigrino Desalegn, prevedono la costruzione di nuovi
quartieri della capitale in terreni posseduti soprattutto dagli oromo.
Molti cittadini di etnia oromo scendono in piazza.
Non solo c’è la questione della salvaguardia delle terre ma anche, più in
generale, quella dell’emarginazione politica di cui i membri di questa etnia si
sentono vittime. Abiy è tra i politici che si oppongono al progetto. Nel 2016 il
governo congela i piani e per il deputato oromo arriva un’importante ventata di
popolarità. Da questo momento in poi, oltre ad essere riferimento dell’Odp, Abiy
viene visto come uno dei leader politici etiopi in maggiore ascesa. Per un anno
diventa anche ministro della Scienza e della Tecnologia.
L'ascesa politica e la nomina a premier il 2
aprile 2018
La certificazione della sua scalata politica
arriva nell’ottobre 2017, quando Abiy viene eletto segretario generale dell’Odp.
Adesso è a tutti gli effetti leader del partito di cui fa parte già da quando ha
14 anni.
Il contesto politico è caratterizzato ancora una
volta dalle proteste degli oromo. Il governo risponde con il pugno di ferro,
arrestando molti manifestanti e in alcuni casi le violenze culminano anche con
diverse vittime in piazza. Non riuscendo a far rientrare la tensione, il premier
Desalegn decide a inizio 2018 di gettare la spugna e annuncia le dimissioni.
A questo punto si apre la corsa per la successione
all’interno del Fronte Rivoluzionario democratico del popolo etiope. Dal 1991 in
poi il leader infatti della coalizione viene per consuetudine anche nominato
capo del governo. Per 27 anni questi ruoli sono spettati a membri tigrini del
Tfpl. Nel 2018 ci sono oramai i presupposti per un cambio di mano. E così,
spinto anche dalla popolarità acquisita negli anni precedenti, Abiy Ahmed è
eletto segretario della coalizione di governo. Il 2 aprile 2018 giura
formalmente come capo del nuovo governo, diventando quindi premier. È il primo
cittadino oromo ad assumere questo compito.
Il premio nobel per la pace del 2019
Abiy Ahmed viene da subito visto, all’interno come
all’estero, quale leader riformatore. In economia avvia alcune liberalizzazioni
e spera di attrarre capitali stranieri. Dà seguito inoltre ai progetti
infrastrutturali quali, tra tutti, la cosiddetta diga della rinascita. Ma
all’estero la sua notorietà arriva soprattutto dalla pace con l’Eritrea.
Stipulata sul finire del 2018 e firmata ufficialmente a Gedda, la fine
definitiva delle ostilità con Asmara segna un punto importante nella carriera
politica di Abiy Ahmed. Tanto da essere insignito, nell’anno successivo, quale
vincitore del nobel per la pace. Al premier etiope viene riconosciuta buona
parte del merito per il termine della guerra.
La fondazione del Partito per la Prosperità
L’ideale politico portato avanti da Abiy Ahmed è
possibile tradurlo con un termine specifico, quello cioè di “etiopianismo”. Si
tratta della volontà da parte del premier di rendere
maggiormente centralizzato lo Stato etiope, partendo dai tratti in comune tra le
varie etnie che compongono la nazione. Storia, tradizioni e appartenenza al
mondo etiope sono quindi i tratti prevalenti di quella identità con la quale
Ahmed vorrebbe cementificare lo Stato.
In tal modo si andrebbe a superare l’attuale
impostazione basata sul federalismo etnico e sull’autonomia di cui godono tutte
le principali componenti etniche e religiose dell’Etiopia. Per mandare avanti
questo obiettivo il premier, in qualità anche di segretario della coalizione di
governo, decide di fondare un partito unico in grado di raggruppare tutti i vari
movimenti fino a quel momento federati. Abiy Ahmed nel 2019 scioglie l’Odp,
passo seguito anche dai segretari degli altri partiti della coalizione. Viene
data vita al partito unico denominato Partito della Prosperità. Il primo
segretario della nuova formazione è lo stesso Abiy Ahmed. L’intento, da qui in
avanti, è dare forma a partiti fondati su una base ideologica e non etnica.
La guerra nel Tigray
L’unico partito a tirarsi fuori dalla nuova
formazione è il Tplf. I tigrini, al potere per 27 anni, non vedono di buon
occhio né il Partito della Prosperità e né l’etiopianismo del premier. Inizia un
braccio di ferro politico tra le due parti che culmina con le elezioni
locali dell’ottobre 2020 nel Tigray, lo Stato dove vive gran parte dei tigrini e
dove il Tplf è molto radicato. Il governo di Abiy Ahmed nell’estate del 2020
decide, in ragione anche dell’epidemia di Covid-19, di rinviare le consultazioni
locali. Ma i dirigenti del Tplf convocano ugualmente le elezioni, vinte dal
partito tigrino con una grande maggioranza.
A quel punto, il premier decide di intervenire
militarmente. Per lui si presenta davanti l’occasione per sconfiggere l’ultima
forza in grado di ostacolare il suo progetto politico. Il 3 novembre 2020 Abiy
Ahmed dà ordine alle truppe federali di avanzare nel Tigray. A fine mese viene
conquistata Makallè, capoluogo della regione.
La guerra tuttavia non volge al termine. Al
contrario, il Tplf passa al contrattacco. A giugno i tigrini riprendono il
capoluogo e si alleano con l’Ola, un gruppo indipendentista oromo. Nel novembre
2021 le forze ostili al governo centrale sono a 220 km da Addis Abeba. Abiy
Ahmed proclama lo stato d’emergenza nazionale. La guerra ha dinamiche negative
che il premier alla vigilia non si aspetta. E anche la sua reputazione
internazionale rischia di essere rivista.
·
Quei
razzisti come i liberiani.
Gorge Weah ha 55 anni: dai
gol e dal Pallone d’Oro con il Milan alla presidenza della Liberia.
Fiorenzo Radogna su
Il Corriere della Sera l'1 ottobre 2021. L’ex attaccante viene una infanzia
poverissima: 13° figlio, con l’aiuto della nonna lui e i fratelli evitarono di
finire bimbi soldato. Primi calci in Camerun, poi la Francia e la gloria con i
rossoneri.
Pallone d’oro e presidente dei
diamanti
Questo 1 ottobre compie 55
anni l’ex top player, oggi a capo di un Paese problematico eppure ricchissimo;
di diamanti e significati geo-politici: la Liberia di George Tawlon Manneh
Oppong Ousman Weah da Monrovia (classe 1966). Ieri devastante ariete (fra le
altre) soprattutto di un Milan a cavallo di due cicli europei vincenti, oggi al
vertice di una democrazia, come suo 25° presidente. Grafico di un’esistenza
fuori dal comune — e condotta sempre al vertice — fra gli assi cartesiani del
calcio internazionale e un impegno politico; ai tempi del Pallone d’Oro (1995)
imprevisto e imprevedibile. Portato avanti con la veemenza di certi gol, la
caparbietà radicale di chi conosce bene il proprio obiettivo: lo punta, lo
afferra, ne fa storia. «King» George, quando un soprannome d’antan ha in sé il
seme di un futuro destino. Sette aspetti di uomo fuori dal comune.
Una nonna (e un pallone) nel
destino
Tredicesimo di tredici figli –
«pa’» William e «mà» By, separati, erano spariti —; infanzia fra baracche di
legno, lamiera e zanzare fra Clara Town e Gibraltar (periferie portuali di
Monrovia). 14 in una stanza; caldo umido che si appiccica addosso; come il
grasso degli ingranaggi di quell’Ak47 che rischia, bimbo, di ritrovarsi in mano.
Come tanti (troppi) piccoli liberiani. Bambini-soldato – la metà non sanno né
leggere né scrivere — arruolati in chissà quale esercito (contro)rivoluzionario.
Due comete a indicargli la strada: l’amorevole nonna Emma, una palla di pezza
che rotola. Sono gli anni 70, una via di fuga c’è. Sì, George supererà i 40
anni, l’età media liberiana di quegli anni...
Radicalmente liberiano (e
africano)
Al netto dei suoi remoti
trascorsi calcistici liberiani, George resterà sempre profondamente «africano».
A differenza di molti suoi colleghi-calciatori guarderà sempre al Paese di
origine, come riferimento passato, presente e futuro. Emerso, dopo il campionato
liberiano nel Mighty Barollee nell’Invincible Eleven, nel più performante
massimo torneo camerunese (Tonnerre Yaoundé), comincerà a consacrarsi in Francia
al Monaco (dall’88 al ‘92; 129 partite, 59 reti). In breve sarà ricco ed
investirà tantissimo nel proprio Paese, fra la propria gente.
Solo gli stupidi...
«Solo gli stupidi non cambiano
mai idea». George Weah era già un calciatore planetario — a metà anni 90 –
quando abbracciò la fede mussulmana, aggiungendo Ousmane nel suo (già lungo)
nome. Rimangono negli occhi di molti tifosi del Psg (poco prima che passasse al
Milan) le immagini del campione (dal ‘92 al ‘95: 96 presenze, 32 gol a Parigi)
che in campo, prima di ogni gara — in ginocchio, braccia aperte — si raccoglieva
nella preghiera islamica. Poi la morte della nonna, scintilla del ritorno alla
fede cristiana. E il 1995. In quel dicembre, già rossonero, France Football gli
consegnerà il Pallone d’Oro. Periodo milanista (dal ‘95 al 2000 due Scudetti:
95-96 e 98-99; 147 gare, 58 reti in tutto), George si spiega alla stampa. «Non
voglio far politica. Anche perché l’Africa tutta, non solo la Liberia, non ha
ancora capito cos’è la democrazia. La gente della Liberia mi vuole bene, sono un
simbolo di unità e voglio stare al di sopra delle fazioni». No, cambierà idea
(anche la Liberia). Lui non sarà mai uno stupido.
Bizzarrie e lauree
Sfoggerà ricchezze e
altruismi. Sua, in Liberia, una villa con quasi venti camere, centinaia di paia
di scarpe – per un ex-bambino sempre scalzo –, abiti e decine di immobili (mai
dimenticati i tetti in lamiera dell’infanzia). Dall’Africa alla Francia;
dall’Italia agli Usa. E poi una laurea negli States (Gestione d’impresa alla
DeVry University), un’altra – in Arte e amministrazione sportiva alla Parkwood
University di Londra, accademia poi chiusa dai Federali Usa in accordo col
governo britannico — che perse valore; e nel 1999 un dottorato onorario in
umanità dal A.M.E. Zion University College della Liberia. Nel frattempo il
matrimonio con Clar Weah, statunitense di origine giamaicana e i tre figli
(George Jr., Martha e Timothy George). In viaggio alloggerà negli hotel più
lussuosi, ma dormirà (quasi sempre) per terra. «Sono fatto così».
L’impegno alle urne
Chiuso col calcio, dopo le
ultime residuali esperienze calcistiche anglo-francesi (Chelsea, ManCity e
Marsiglia) e una passerella negli Emirati (2002, Al-Jizira), il ritiro. Per
darsi alla politica: figura di riferimento nello stato fondato da ex-schiavi
liberati, già nel 2005 sfiorò l’elezione a Presidente (sconfitto dall’economista
Ellen Johnson Sirleaf) e divenne senatore (2014). Poi ricandidatosi alla massima
carica nel 2017, dopo l’annullamento delle elezioni (per brogli), a dicembre fu
regolarmente eletto Presidente della Liberia (61,5 % dei voti). In carica dal 22
gennaio 2018, dopo 12 anni di presidenza di Ellen Johnson-Sirleaf (premio Nobel
per la pace e prima donna alla guida di uno stato africano).
La sua presidenza
Carica di (immancabili)
polemiche e accuse la politica dell’ex attaccante, nel 1999 incoronato
dall’IFFHS come «calciatore africano del secolo». Deciso, in quella estera, nel
cercare partner per la sua Liberia (in particolare la Francia) e fra i paesi
confinanti (Senegal). E avviluppato in una politica interna che non ha tardato a
portare strascichi. Come nelle grandi manifestazioni di piazza (dal giugno ‘19),
emerse dal declino economico: salari differiti, inflazione, prezzi delle materie
prime alle stelle e – presunta – corruzione. Il «Weah step down campaign» (il
movimento per le dimissioni di Weah) ha raccolto migliaia di adesioni; King
George li ha accusati di essere uno strumento in mano alle opposizioni.
Un’ennesima difesa (opposizione) da saltare, fendere, dissolvere. Come in
quell’incredibile gol – il coast to coast al Verona dell’8 settembre 1996 -: 90
metri di corsa solitaria a schivare avversari e avversità. Come in una vita (di
successo), intera.
·
Quei
razzisti come i nigeriani.
Boko Haram ultimo atto: lo
jihadismo sembra aver i giorni contati.
Daniele Bellocchio su Inside
Over il 15 settembre 2021. Forse la storia della ribellione islamista di Boko
Haram è arrivata a un punto di svolta. La setta jihadista che dal 2009 ad oggi
ha provocato oltre 350.000 morti e un esodo di 4 milioni di persone nel nord est
della Nigeria e nella regione transfrontaliera del Lago Ciad, ha subito
nell’ultimo mese una durissima battuta d’arresto. Stando infatti a quanto
riportato dall’emittente britannica BBC, a partire da fine agosto, oltre 6mila
ribelli musulmani hanno disertato consegnandosi alle autorità militari nigeriane
e camerunensi. A diffondere la notizia della resa di migliaia di mujaheddin è
stato il governo di Abuja che ha fatto sapere che l’avanzata delle truppe
regolari nel nord ovest del Paese e la morte di una delle figure cardine della
formazione jihadista, Abubakar Shekau, sono stati i principali motivi
all’origine della consegna delle armi e della diserzione di un numero
considerevole di ribelli islamici. “Stanno disertando a frotte. Per grazia di
Dio e, con la dovuta cautela, speriamo che con questa svolta tutto finisca
presto”, ha detto una fonte della sicurezza di Abuja alla testata
nigeriana Vanguard. Nell’articolo della testata nigeriana ufficiali
dell’esercito regolare spiegano anche che l’impiego congiunto di artiglieria e
mezzi corazzati, della marina sulle acque del Lago Ciad e dell’aviazione nei
cieli nigeriani sono stati i fattori principali che hanno portato alla
smobilitazione in massa dei combattenti islamisti. Un successo militare che,
unito ai contrasti interni alla formazione ribelle, alle faide intestine per la
successione alla leadership dopo la morte di Shekau e anche a una situazione di
crisi alimentare che ha travolto il Sahel e il nord est della Nigeria, ha visto
sgretolarsi poco a poco, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, uno dei
gruppi terroristici più feroci e spietati all’interno della galassia dello
jihadismo internazionale. Da un lato la notizia dell’implosione del gruppo
terrorista fa sperare la popolazione civile e, in molte città che sono state
travolte negli ultimi anni dalla violenza ferina dei combattenti di Shekau, la
disfatta delle bandiere nere è stata accompagnata da celebrazioni e
dimostrazioni di giubilo. Parallelamente però sono sorti molti interrogativi su
come affrontare questa resa di massa e quale futuro disegnare per gli ex
terroristi. Per il governatore dello stato del Borno Babagana Zulum, leader di
uno dei territori che negli ultimi anni sono stati maggiormente colpiti dal
terrorismo di Boko Haram, la diserzione in massa dei ribelli jihadisti porta a
un problema di carattere etico e morale di estremo spessore che, se non
affrontato nei modi corretti, potrebbe far insorgere problematiche molto serie e
gravose per il Paese. “Siamo in una situazione molto difficile perché ora ci si
parano davanti due interrogativi; o intraprendere un cammino di riconciliazione
e reinserimento oppure proseguire con una logica di guerra e far pagare ai
terroristi arresi la propria pena per ciò che hanno fatto. È un quesito molto
annoso perché o proseguiamo con la guerra oppure dobbiamo accettare nella
società i combattenti jihadisti, gli stessi uomini che per 12 anni hanno ucciso
la popolazione e sono stati gli assassini di uomini, donne e bambini”.
Proseguendo nella sua dichiarazione alla testata nigeriana il governatore dello
stato del Borno ha poi aggiunto: “Accettare i pentiti di Boko Haram ha il
rischio di offendere gravemente i sentimenti delle vittime. Ma nel momento in
cui i combattenti di Boko Haram disposti ad arrendersi non dovessero affrontare
un percorso di reinserimento e deradicalizzazione, c’è il rischio che si
uniscano all’ISWAP (la branca africana di ISIS operativa in Nigeria e nel bacino
del Lago Ciad) o ad altre formazioni islamiste operative nel Sahel e la via
della pace quindi si restringerebbe considerevolmente. Io al momento posso solo
dire questo: possiamo perdonare ma non possiamo dimenticare”. Un aspetto
importante è che la stragrande maggioranza dei combattenti che si sono arresi
appartenevano all’ala di Boko Haram conosciuta come JAS, e con a capo il leader
storico Abubakar Shekau. Al momento in Nigeria e nella zona di frontiera con
Ciad, Camerun e Niger opera però anche l’ISWAP, un gruppo nato da Boko Haram ma
che poi si è separato giurando fedeltà a Daesh e iniziando a creare un Califfato
tra le sabbie saehliane. Il timore dell’esecutivo di Abuja è quindi quello che
se non vengono attuate le giuste politiche di amnistia e reinserimento questi
miliziani pentiti possano andare ad allargare le fila del gruppo jihadista
ancora attivo o addirittura divenire una quinta colonna del Califfato
all’interno della società civile nigeriana. Ad oggi la volontà del governo
sembra proprio quella di sottoporre i terroristi a un percorso di
deradicalizzazione e graduale inserimento nella società. InsideOver, nel 2019,
aveva raccontato attraverso un reportage esclusivo come le pratiche di
deradicalizzazione e accompagnamento nel tessuto sociale, in Ciad, avessero
permesso poi ad ex terroristi di divenire delle figure cardine nella lotta al
proselitismo e alla propaganda delle bandiere nere. Ora in Nigeria la questione
è però più complessa perché il numero di pentiti è estremamente consistente, e
un loro inserimento significa anche occuparsi di una loro formazione culturale e
professionale, di un loro ritorno alle comunità d’origine e di un ingresso
graduale anche nel mondo del lavoro. Tutte politiche che spesso non sono state
attuate per le centinaia di migliaia di vittime di Boko Haram che vivono nelle
tendopoli del più popoloso paese d’Africa. Il quesito in massima sintesi si
riduce a questo interrogativo: ”è legittimo aiutare i carnefici quando non è
stato possibile farlo con le vittime?”. Una risposta a questa domanda è
difficile darla, il Paese è diviso e spaccato tra chi sostiene la politica della
linea dura e chi invece predica la necessità della riconciliazione, in ogni caso
la Nigeria oggi si trova ad affrontare non solo un semplice interrogativo di
carattere nazionale ma una sfida globale, perché scegliere la strada giusta
significa nei fatti mettere fine allo jihadismo, intraprendere un nuovo corso
della storia e dimostrare che la Nigeria non sarà il nuovo Afghanistan ma una
terra libera dal totalitarismo dell’odio.
Nigeria. Assalto al collegio: rapite 300
studentesse. Redazione Internet su Avvenire venerdì 26
febbraio 2021. Un drammatico copione che si ripete: uomini armati hanno fatto
irruzione, nella notte, in una scuola secondaria femminile del Nord-ovest.
Ancora un rapimento di massa da una scuola-convitto nigeriana. Uomini armati
hanno rapito, nella notte, circa trecento studentesse a Zamfara,
nella Nigeria nordoccidentale. Lo riferiscono i media nigeriani, spiegando che a
essere stata presa di mira è la Government Secondary School di Jangebe. Uomini
armati, alcuni dei quali in uniforme, avrebbero preso di mira la scuola verso
l'una di notte e avrebbero prelevato le studentesse a bordo di veicoli.
Confermando l'attacco in un incontro con i giornalisti, il commissario Suleiman
Anka ha detto che si sta ancora verificando il numero delle studentesse rapite.
Un dipendente della Government Girls Secondary School ha dichiarato a condizione
di anonimato al quotidiano 'Punch' che uomini armati hanno fatto irruzione
all'interno dell'istituto scolastico e rapito più di trecento studentesse. Il
padre di una di loro e una professoressa hanno confermato alla Bbc lo stesso
numero di studentesse prese in ostaggio. Secondo il portale di notizie Pm News
Nigeria, gli assalitori hanno raggiunto la scuola dopo aver attaccato un posto
di blocco dell'esercito di Abuja nella zona. Non si hanno notizie di vittime. La
scorsa settimana, 42 persone sono state rapite da una scuola nello Stato
nigeriano del Niger, nell'ovest. A dicembre oltre 300 ragazzi sono stati
sequestrati da un istituto a Kankara, nello Stato settentrionale di Katsina, e
poi rilasciati dopo una serie di negoziazioni con funzionari del governo.
Alessandro Da Rold per "La Verità" il 26 febbraio
2021. C'è un documento del 14 giugno 2018 che potrebbe mettere in serio
imbarazzo il governo della Nigeria, costituitosi parte civile nel processo Opl
245, dove Eni e Shell sono accusate di corruzione internazionale. È una lettera
firmata dall'ex ministro del petrolio Emmanuel Ibe Kachiwu dove si possono
leggere le richieste da parte di Abuja di esercitare il diritto di «back-in
right» (il diritto di rientrare con una quota dopo i rischi di esplorazione), in
linea con gli accordi del 2011 stipulati proprio con le due compagnie
petrolifere sotto accusa. La missiva, indirizzata a Massimo Insulla (direttore
di Nigerian Agip exploration), rivela quindi che il governo nigeriano, a ben
sette anni di distanza dal contratto e per di più a processo già in corso, non
ravvedeva alcun problema o illecito nella condotta di Eni e Shell. I toni del
ministro del Petrolio sono molto cordiali, si legge appunto che Abuja intende
rispettare l'articolo 11 dell'accordo del 2011 e che soprattutto è interessata
alla decisione delle compagnie petrolifere di iniziare a estrarre petrolio. In
pratica i nigeriani convengono con Eni e Shell, come si dice nel gergo
petrolifero, di passare dalla «oil prospecting license» alla «oil mining lease»:
dopo aver trovato il petrolio bisogna iniziare a estrarlo. La lettera smentisce
anche la costituzione di parte civile decisa dal governo il 5 marzo del 2018, in
apertura del processo Opl 245 di fronte alla settima sezione del Tribunale di
Milano. Perché chiedere i danni su una licenza di estrazione che sarebbe stata
comprata grazie alla corruzione e poi invece, tre mesi dopo, riconoscere la
validità del prodotto di quella stessa licenza? Per di più nella richiesta di
parte civile presentata dall'avvocato Lucio Lucia si smentisce il ministro
nigeriano dell'epoca, perché si sostiene che le clausole di «back-in rights»
siano stata ottenute «illegittimamente» e siano persino un ostacolo per il
rientro del governo. Di più, si sostiene che Eni e Shell abbiano cercato in ogni
modo di escludere la Nigeria da diritti contenuti nel contratto: un'affermazione
smentita dalla lettera del 2018 di Emmanuel Ibe Kachiwu. Non è l'unico dei tanti
misteri che ha caratterizzato in questi anni la linea difensiva del Paese
africano. Del resto nel 2017 la Nigeria non intendeva costituirsi parte
civile. Poi nel 2018 cambiò idea, decidendo di affidarsi allo studio legale
Johnson & Johnson, dove il titolare è lo sconosciuto Babatunde Olabode Johnson,
un presunto avvocato che si fa coprire le spese legali da una società anonima,
l'americana Poplar falls llc, fondata nel 2016 nel Delaware dal fondo Drumcliffe
partners. Come già raccontato dalla Verità lo scorso anno, in questa ragnatela
di sconosciute società si nascondono particolari molto particolari. Stando ai
contratti, infatti, Poplar falls incasserà il 35% in caso di successo nella
causa. Si potrebbe trattare di una cifra spropositata, perché gli avvocati che
seguono la Nigeria nel processo di Milano hanno chiesto danni per 1,1 miliardi
di euro. La cifra, quindi, dovrebbe toccare i 382 milioni di euro per la Poplar,
a cui si aggiungerebbero anche 55 solo per Drumcliffe. Sempre stando agli
accordi con Johnson & Johnson, i soldi che potrebbero arrivare in caso di
condanna di Eni e Shell non andranno subito al governo di Abuja, quindi non
torneranno ai cittadini nigeriani, ma rimarranno su un conto vincolato
controllato da un avvocato nominato sempre da Poplar. Queste strane vicende sono
da mesi all'attenzione dell'opinione pubblica nigeriana. In Italia in tanti
hanno iniziato a porsi delle domande su dove voglia davvero andare a parare il
presidente della Nigeria Muhammadu Buhari. Del resto, il comportamento
incomprensibile del 2018 negli anni successivi è proseguito. Mentre il processo
continuava a celebrarsi nelle aule del Tribunale di giustizia di Milano, sempre
la Nigeria - a metà 2020 - ha deciso di affidarsi a un altro studio legale di
Londra, Franklin Wyatt. Quest' ultimo sarebbe stato incaricato di trovare un
nuovo accordo con Eni e Shell, con l'obiettivo di evitare la data di scadenza
della concessione, ovvero il maggio del 2021. Ma qualcosa è andato storto. Non a
caso Eni ha deciso di avviare un arbitrato internazionale presso la Banca
mondiale per dirimere la controversia sul giacimento. Il prossimo 17 marzo si
aprirà la camera di consiglio sul processo. E i giudici di Milano decideranno
l'innocenza o la consapevolezza delle due compagnie petrolifere come dei loro
amministratori, tra cui l'attuale amministratore delegato di Eni Claudio
Descalzi. Dopo un investimento di 2 miliardi di dollari, infatti, Eni e Shell
perderanno a maggio i diritti di estrazione senza aver mai estratto una goccia
di petrolio. Il governo di Abuja spera di incassare 1,1 miliardi di euro. Ma non
si sa dove andranno a finire i soldi. Mentre l'indotto delle estrazioni
petrolifere, 200.000 posti di lavoro e 41 miliardi di dollari in 25 anni, è
andato perso. Del resto, dopo dieci anni così, quale compagnia vorrà occuparsi
di Opl 245?
·
Quei razzisti come i Burkinabè.
Thomas Sankara, il Che
Guevara d’Africa che voleva cambiare il suo Paese. E aspetta ancora giustizia.
Rivoluzionario, carismatico, il presidente dello Stato africano fu ucciso da un
commando il 15 ottobre 1987, in una congiura internazionale. Ora finalmente si
apre il processo contro i suoi assassini. Giovanni Pigatto su L'Espresso il 18
maggio 2021. Rivoluzionario, ma senza l’idealismo di Che Guevara, fervente
socialista, ma senza le derive staliniste o maoiste, terzomondista, ma senza mai
piangersi addosso, pur da presidente di una delle Nazioni più povere e arretrate
del mondo, mente libera, ma pratica e tutto fuorché utopista. Nell’Africa nera è
molto difficile incontrare qualcuno che non sappia chi sia Thomas Sankara. Il
presidente del Burkina Faso morto nel 1987 è diventato un simbolo grazie al suo
esempio, perché ha fatto vedere al mondo che non servivano tante utopie per
cambiare le cose, ma volontà, carisma e idee chiare. Per questo è stato ucciso
dopo neanche quattro anni di governo, in una congiura internazionale dalle tinte
fosche che proprio in queste settimane si tenta di definire grazie, finalmente,
a un processo formale nei confronti dei suoi assassini, quasi trentaquattro anni
dopo quel 15 ottobre 1987, «giorno in cui uccisero la felicità», come recita un
documentario dedicato a questa storia. Il 12 aprile, infatti, il tribunale
militare di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, ha aperto ufficialmente un
processo nei confronti di Blaise Compaoré, il successore di Sankara alla
presidenza, nonché amico e compagno di una vita, accusato di attentato alla
sicurezza dello Stato e complicità nell’assassinio. Un processo tardivo, ma
necessario, perché attorno alla morte di Sankara non c’è solo una vendetta o la
sete di potere di un compagno che diventa traditore, ma c’è un caso
internazionale che ha coinvolto Stati stranieri e che si inserisce nel periodo
storico dell’ultima fase della Guerra Fredda. Thomas Sankara è stato senza ombra
di dubbio un personaggio diverso da tutti gli altri, e per questo difficile da
inquadrare con comode etichette. Nei suoi appena quattro anni di governo
intervenne in tutti gli aspetti della vita dei suoi concittadini, dimostrando
una lungimiranza e una visione molto concreta: fece costruire pozzi, scuole,
centri per la maternità, ospedali, farmacie, cercando però allo stesso tempo di
emancipare il proprio Paese dagli aiuti internazionali che, sosteneva, altro non
erano se non un nuovo controllo neocolonialista sugli Stati dell’Africa.
Invitava a consumare “burkinabé”, prodotti locali, fece costruire ferrovie,
formò insegnanti per abbattere il tasso altissimo di analfabetismo, fece
coltivare milioni di piante per fermare la desertificazione (ogni occasione
pubblica era buona per mettere un albero a dimora). Iniziò una imponente
campagna vaccinale contro morbillo, meningite e febbre gialla che coinvolse
volontari e militari dell’esercito, arrivando a vaccinare fino a un milione di
bambini a settimana, e ora più che mai ci rendiamo conto di che numero
impressionante potesse essere, a maggior ragione in condizioni difficili come
quelle del Burkina Faso degli anni Ottanta. Si adoperò fin da subito per
combattere la piaga della fame che colpiva la maggior parte del suo popolo e che
fu il suo vero chiodo fisso, promettendo e riuscendo a garantire almeno due
pasti e dieci litri di acqua al giorno per tutti i burkinabé. Quando a cavallo
tra anni Settanta e Ottanta il Partito Radicale di Marco Pannella fece propria
la battaglia contro la fame nel mondo, l’interlocutore simbolico e naturale
divenne proprio Sankara, incontrato a Ouagadougou da Pannella e dall’allora
segretario del Partito Radicale Giovanni Negri, nel marzo del 1985. Duro nei
confronti dei Paesi del Nord del mondo, non ebbe mai paura di pronunciare
interventi scomodi scegliendo le occasioni di maggiore portata e mediaticità.
Celeberrimo il suo discorso alle Nazioni Unite del 4 ottobre 1984 in cui fece un
discorso sferzante contro il neocolonialismo: «Parlo, anche, in nome dei
bambini. Di quel figlio di poveri che ha fame e guarda furtivo l’abbondanza
accumulata in una bottega di ricchi. Il negozio è protetto da una finestra di
vetro spesso; la finestra è protetta da inferriate; queste sono custodite da una
guardia con elmetto, guanti e manganello, messa là dal padre di un altro bambino
che può, lui, venire a servirsi». Il discorso fu talmente dirompente e scomodo
che venne presto tolto dagli archivi delle Nazioni Unite, e sopravvisse a lungo
solo grazie alla registrazione audio di un giornalista burkinabé che aveva
seguito il presidente a New York. Sankara ereditava un Paese poverissimo,
all’entrata del deserto del Sahara, senza un accesso al mare, che aveva ottenuto
l’indipendenza dalla Francia nel 1960, in cui si erano susseguiti uno dopo
l’altro diversi colpi di Stato che di volta in volta avevano apparentemente
sconvolto le istituzioni, per poi in realtà non cambiare niente per davvero. Ma
il colpo di Stato del 1983, quello di Sankara e compagni, sarebbe stato
profondamente diverso. Per il primo anniversario del golpe, il 4 agosto 1984,
Sankara volle dare una svolta al suo Paese, a partire dagli odiosi simboli che
ancora ricordavano il passato coloniale. Quel giorno sarebbe partito proprio dal
nome, Alto Volta, e l’avrebbe cambiato in Burkina Faso, “la terra degli uomini
integri” nelle lingue dioula e mooré. Poi avrebbe annunciato che anche tutti gli
altri simboli dello Stato sarebbero cambiati: la bandiera, l’inno nazionale. Il
Burkina Faso era veramente uno degli Stati più poveri del mondo, senza alcuna
materia prima da vendere o da sfruttare, senza il petrolio che aveva la Nigeria,
senza le miniere del Mali, senza le pietre preziose del Congo, solo un vasto
territorio semidesertico, terra di pastori e agricoltori che vivevano lì da
secoli combattendo con le stagioni. I sette milioni di persone che ci vivevano
contavano un medico ogni 50 mila abitanti, una mortalità infantile di 107
neonati ogni mille nascite, un tasso di scolarizzazione del 2 per cento,
un’aspettativa di vita che sfiorava appena i 44 anni, un debito estero di oltre
il 40 per cento del Pil, una desertificazione galoppante, e così via. Ma tutto
questo, e tantissimo altro, venne stroncato violentemente il 15 ottobre del
1987, quando un commando di uomini armati fece irruzione nell’edificio dove
Sankara stava presiedendo un consiglio dei ministri, aprì il fuoco e ammazzò il
presidente insieme a una dozzina di collaboratori. Se da una parte fu chiaro fin
da subito che in mezzo ci doveva essere Blaise Compaoré, l’amico e il compagno
di una vita che decise di tradirlo per diventare lui presidente (cosa che
puntualmente accadde), dall’altra negli anni sono emersi sospetti e accuse che
hanno fatto diventare la morte di Sankara un caso internazionale che conserva
ancora oggi diverse zone d’ombra. Sono molti i motivi per cui della morte di
Sankara non sappiamo ancora tutto e per cui l’istituzione di un processo è
arrivata così tardivamente. Prima di tutto, Blaise Compaoré riuscì a rimanere
presidente del Burkina Faso fino al 2014, quando una serie di manifestazioni di
protesta lo costrinsero a dimettersi e a fuggire e chiedere asilo in Costa
d’Avorio, Paese del quale ha la cittadinanza per via del suo matrimonio con una
ivoriana. Durante la sua presidenza, Compaoré non solo ha sempre negato la sua
complicità nell’assassinio di Sankara, ma ha anche (inutilmente) tentato in
tutti i modi di cancellarne la memoria, costringendo la sua famiglia a fuggire
all’estero, impedendo di fatto che venissero condotte delle indagini per trovare
la verità, facendo sequestrare e distruggere diversi documenti e carte di
Sankara. In secondo luogo, la Francia, che aveva mantenuto (e mantiene tuttora)
un certo controllo sulle sue ex colonie, possedeva nei suoi archivi sottoposti a
segreto di Stato una serie di documenti riguardanti la morte di Sankara e i
fatti immediatamente precedenti e immediatamente successivi. Questi documenti
sono stati desecretati solo negli ultimi anni, e addirittura l’ultimo collo è
stato consegnato alle autorità burkinabé solo nel marzo di quest’anno, per
volontà del presidente Macron. Infine, quello che c’è dietro la morte di Sankara
è oggettivamente intricato, e risalire alle responsabilità precise di ciascuno è
e sarà molto complicato. Negli anni, grazie al lavoro di molti giornalisti, tra
i quali è doveroso citare l’italiano Silvestro Montanaro (scomparso da poco) e
il suo documentario “Ombre africane”, si è riusciti a fare un po’ di chiarezza
almeno su chi fossero gli autori e gli Stati stranieri coinvolti. Una rete che
parte da Oltreoceano, con un ruolo degli Stati Uniti e della Cia, coinvolge la
Liberia del signore della guerra Charles Taylor, la già citata Costa d’Avorio
del presidente filofrancese Félix Houphouët-Boigny, fino alla Francia, con tutti
i suoi “Monsieur Afrique” usati nel tempo per mantenere i contatti politici ed
economici con le ex colonie, e alla Libia di Gheddafi, allora terra di
addestramento e fornitore di armi a chi volesse avventurarsi in un colpo di
Stato. Questo processo ora ha tutte le carte in regola per poter proseguire e
arrivare finalmente alla verità, se non alla giustizia. Verità forse tardiva, ma
importante anche e soprattutto per comprendere i rapporti sovranazionali spesso
tossici tra il Nord e il Sud del mondo.
Thomas Sankara: il debito è il nuovo
colonialismo. Piccole Note il 13 luglio 2021 su su Il
Giornale. Thomas Sankara è sconosciuto ai più, almeno per noi che riconduciamo
il mondo ai nostri piccoli confini. In Africa è un eroe, un modello,
un’ispirazione per tutti quelli che sognano la fine del colonialismo (o neo che
è uguale) che costringe ancora tanta parte del continente a forme di schiavitù
meno manifeste (sulle quali nessuna parola dei Black Lives Matters e nessun
inginocchiamento). Proprio contro la più subdola e potente di queste forme di
schiavitù si schierò Sankara con una lungimiranza rara, oggi forse estinta: la
schiavitù del debito. L’allora presidente del Burkina Faso – che vuol dire
“terra degli uomini integri”, nome che lui stesso diede al suo Paese, già Alto
Volta – a metà degli anni ’80 capì con grande anticipo che la nuova schiavitù
dei Paesi africani – ma non solo, visto il recente caso della Grecia – è
l’accoppiata finanziamento/debito. In una drammatica sessione dell’Unione
africana che si tenne ad Addis Abeba Sankarà tenne un discorso memorabile, che
gli costò la vita, come d’altronde aveva profetizzato nel suo intervento,
denunciando con forza il sistema del debito che i paesi occidentali usavano – e
usano – per conservare controllo e supremazia sulle ex colonie. Un sistema che
strangolava, e strangola, i Paesi, prosciugandone le scarne risorse ed impedendo
qualunque forma di investimento e sviluppo. L’infernale circolo vizioso,
infatti, fatto di interessi progressivi, rende il debito inestinguibile, tanto
che ormai gli Stati che ne sono soggiogati si ritrovano a pagare gli interessi
degli interessi, cumulando nuovi prestiti e nuovi cappi al collo. Sankara aveva
capito bene il meccanismo, e tentò di convincere tutti i Paesi africani a
combattere insieme questo meccanismo, semplicemente non pagando. Un’idea
eversiva? Sul punto si può ricordare la più recente presa di posizione di
Giovanni Paolo II, che in occasione del Giubileo del 2000 chiese con insistenza
ai Paesi creditori di rimettere i debiti dei Paesi africani. Di seguito
riportiamo passi dell’intervento.
[Sankara] “Non possiamo rimborsare il debito
perché non abbiamo di che pagarlo…perché non siamo responsabili del
debito…perché gli altri ci devono ciò che le più grandi ricchezze non potranno
mai ripagare: il debito del sangue. Noi pensiamo che il debito si analizzi prima
di tutto dalla sua origine. Le origini del debito risalgono alle origini del
colonialismo”. “Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci
avevano colonizzato…che gestivano i nostri stati e le nostre economie. Sono i
colonizzatori che indebitavano l’Africa con i finanziatori internazionali. Noi
non c’entriamo nulla con quel debito né possiamo pagarlo”.
Se l’origine del debito non era imputabile agli
stati africani, non lo era nemmeno il suo incremento progressivo negli anni del
post-colonialismo. Infatti, non era una libera scelta dei popoli dell’Africa, ma
una collusione tra governi fantoccio, mandati al potere e sostenuti dai Paesi
creditori, e i “tecnici”, parola magica sotto il cui cappello è uso, ancora
oggi, nascondere qualunque nefandezza. I “tecnici” ovviamente arrivavano sempre
dall’Occidente.
[Sankara] “Il debito è la prosecuzione del
colonialismo con i colonizzatori trasformati in assistenti tecnici… sono loro
che ci hanno proposto i canali di finanziamento... siamo stati portati a
compromettere i nostri popoli per 50anni… Il debito, nella sua forma attuale,
controllato e dominato dall’imperialismo, è una riconquista dell’Africa
sapientemente organizzata, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo
obbediscano a norme che ci sono completamente estranee, così che tutti noi siamo
resi schiavi della finanza”.
Sankara smaschera anche il gioco della
“onorabilità” del debito, perché la partita non è giocata ad armi pari. Infatti,
pagare il debito, per gli Stati africani, vuol dire morire di fame, malattie,
carestie e altri flagelli che la mancanza di risorse rende impossibile
fronteggiare.
[Sankara] “…Rimborsare il debito…non è un problema
morale…non è un problema di onore. Il debito non deve essere rimborsato prima di
tutto perché se noi non paghiamo in nostri finanziatori non moriranno… invece,
se paghiamo, noi moriremo”.
Straordinariamente attuale anche la definizione
degli schieramenti. Non è un problema tra Europa e Africa o tra Nord e Sud del
mondo. È una partita che si gioca tra ricchi e poveri, tra chi sfrutta e chi è
sfruttato, a Nord come a Sud.
[Sankara] “Del resto le masse popolari in Europa
non sono contro le masse popolari africane, piuttosto quelli che vogliono
sfruttare l’Africa sono gli stessi che sfruttano l’Europa… dobbiamo dire agli
uni e agli altri che il debito non sarà pagato”
Thomas Sankara è coraggioso e lungimirante, ma non
è affatto ingenuo e sa bene che se rimarrà solo a combattere questa battaglia,
non ha alcuna speranza…
“Chi non vorrebbe che il proprio debito sia
cancellato subito? Chi non lo vuole, può prendere il proprio aereo e andare
subito alla Banca Mondiale a pagarlo! Lo vogliamo tutti! La mia non è una
provocazione… vorrei che la nostra conferenza possa dire chiaramente che noi non
possiamo pagare il debito. Non dobbiamo dirlo con spirito bellicoso, questo per
evitare che ci facciano assassinare individualmente. Se sarà solo il Burkina
Faso a rifiutarsi di pagare il debito, non sarò qui alla prossima
conferenza, invece con il sostegno di tutti, di cui ho molto bisogno, potremo
evitare di pagare, consacrando le nostre magre risorse al nostro sviluppo”.
L’ultima parte dell’intervento di Sankara è forse
quella che scaccia i residui dubbi in chi lo voleva eliminare. Thomas si
scaglia, infatti, contro le armi e le guerre (in)civili che insanguinano il
continente.
[Sankara] “Vorrei concludere dicendo che ogni
volta che un paese africano compra un’arma è contro un africano…perciò dobbiamo
anche, nella scia della risoluzione del problema del debito, trovare una
soluzione al problema delle armi. Sono un militare e porto un’arma, ma vorrei
che ci disarmassimo… potremo fare la pace a casa nostra. Potremmo anche usare le
nostre immense potenzialità per sviluppare l’Africa. Perché il nostro suolo è
ricco: abbiamo abbastanza braccia e un mercato immenso…abbiamo abbastanza
capacità intellettuali per creare e utilizzare la scienza e la tecnologia”..
L’appello finale per un Africa unita e pacificata
suona forse un po’ utopistico, ma l’alternativa al sogno di Sankara è l’incubo
irreversibile al quale era ed è consegnato il suo continente.
“Dobbiamo realizzare un fronte unito di Addis
Abeba contro il debito… prendiamo la decisione di limitare la corsa agli
armamenti di cui sono preda i paesi deboli e poveri… facciamo sì che il mercato
africano sia il mercato degli africani: produciamo in Africa, lavoriamo i nostri
prodotti in Africa, consumiamo in Africa… dobbiamo avere come orizzonte di
vivere come africani: è il solo modo di vivere liberi e degni”.
Il discorso di Adis Abeba è del luglio dell’87.
Sankara sarà ucciso il15 ottobre successivo.
Thomas Sankara: il debito è il nuovo
colonialismo. Piccole Note il 14 luglio 2021 su su Il
Giornale. L’avventura di Thomas Sankara alla guida del Burkina Faso è durata
poco più di 4 anni, ma non è stata vana utopia. Era un uomo pratico, di
estrazione popolare, e sapeva quali erano le battaglie che andavano combattute
per permettere ai burkinabè di provare a risollevare il paese, uno dei più
poveri del mondo, con un tasso di analfabetismo altissimo, una aspettativa di
vita di 40anni e lo spettro della carestia sempre alle porte.
Due pasti al giorno e acqua potabile. In due anni
di lavoro riuscì ad assicurare ai 7 milioni di burkinabè due pasti al giorno e
acqua potabile, un traguardo utopistico ancora oggi per quasi tutte le nazioni
africane.
Fece costruire infrastrutture di cui il Burkina
Faso era quasi totalmente privo, come pozzi, scuole e ospedali e, in parallelo,
cercò di affrancare il proprio paese dalla schiavitù degli aiuti internazionali
sostenendo una sorta di autarchia, invitando cioè i cittadini a utilizzare i
prodotti locali per favorire lo sviluppo agricolo e industriale, al quale aveva
messo mano. Sapeva che il ruolo della scuola era fondamentale per lo sviluppo
del Paese e si impegnò a fondo e con lungimiranza nella lotta contro
l’analfabetismo, iniziando col formare una classe di insegnati. Con un singolare
anticipo sui tempi, iniziò una vera e propria battaglia green, non tanto a
livello ideologico, ma sul concreto, combattendo la desertificazione che stava
erodendo le terre del suo Paese, piantando alberi ovunque fosse possibile. Pari
fu l’impegno per promuovere imponenti campagne vaccinali contro le malattie che
ogni anno chiedevano migliaia di vite alla sua gente, come il morbillo, la
meningite e la febbre gialla. Straordinariamente moderno anche l’approccio alla
condizione femminile a cui Sankara dedicò particolare attenzione: per la prima
volta in Africa (e non solo) le donne assunsero per meriti ruoli di potere vero,
nell’esercito, nella polizia e nella politica, fino ad assurgere alla dirigenza
di alcuni ministeri dello Stato (e quando ancora la politica occidentale era
appannaggio esclusivo degli uomini). “Dobbiamo dare un lavoro a ogni donna,
dobbiamo dare alle donne i mezzi per una vita dignitosa”, diceva.
Il piccolo Burkina Faso in pochi anni era
diventato non solo un Paese migliore, ma anche un esempio per altri Paesi
africani. Cosa inaccettabile per i tanti ambiti di potere che avevano costruito
imperi – finanziari, imprenditoriali, politici – grazie al saccheggio delle
ricchezze del continente.
L’omicidio e la sua eredità. Come accennato nella
nota precedente, Sankarà venne ucciso tre mesi dopo il discorso di Addis Abeba
dal suo più grande amico e collaboratore, Blaise Compaoré, con l’appoggio di
mercenari di quel Charles Taylor che, “evaso” da una prigione americana, approdò
in Africa divenendo in breve presidente della Liberia (dove consumò varie
atrocità, per le quali in seguito venne condannato a 50anni di carcere). Il bel
documentario di Silvestro Montanaro “E quel giorno uccisero la felicità”,
che RAI3 mandò in onda nel 2013, in orario da semi-clandestinità, narra anche
delle complicità occidentali in questo tipico golpe africano, orchestrato da
servizi più o meno segreti di tali Paesi. Ucciso il suo ex amico, Compaorè prese
il suo posto alla presidenza del Paese e si adoperò a cancellare tutte le
riforme attuate dal suo predecessore, come anche la sua memoria, arrivando al
punto di distruggere più volte la sua tomba, sempre ricostruita dai tanti che
non l’avevano dimenticato. Come recita la Treccani “Compaorè avviò un formale
processo di democratizzazione (nel 1991 si fece eleggere alla presidenza della
Repubblica, carica in cui è stato riconfermato nel 1998, nel 2005 e nel 2010).
Il Burkina Faso ha avuto un periodo di stabilità politica fino allora
sconosciuta, che ha consentito l’apertura agli investimenti stranieri e
l’adozione di misure di privatizzazione e liberalizzazione dell’economia in
linea con le direttive del Fondo monetario internazionale”. L’anomalia è
rientrata e il mondo lo registra con la soddisfazione del caso. Dell’aprile di
quest’anno “la notizia che un tribunale militare burkinabè processerà l’ex
presidente Blaise Compaoré per l’assassinio del suo predecessore, Thomas
Sankara” (Il Fatto Quotidiano). Che questo tribunale possa fare piena luce
sull’assassinio di Sankara, cioè anche sulle responsabilità dell’Occidente,
appare alquanto impossibile, ma va così va il mondo. “La nostra rivoluzione avrà
valore solo se, guardando intorno a noi, potremo dire che i burkinabé sono un
po’ più felici grazie a essa: perché i burkinabé hanno acqua potabile e cibo
abbondante e sufficiente, sono in buona salute, perché hanno scuole e case
decenti, perché sono vestiti meglio, perché hanno diritto al tempo libero;
perché hanno l’occasione di godere di più libertà, più democrazia, più dignità.
La rivoluzione è la felicità. Senza felicità, non possiamo parlare di
successo”.. Thomas Sankara aveva descritto così il senso della sua azione, pochi
giorni prima di morire. Alla sua morte saranno resi noti tutti i suoi averi: 100
dollari e una chitarra. Nota a margine. Spesso, nel criticare la Via della Seta
cinese, l’America accusa la Cina di approcciarsi ai Paesi interessati a tale
progetto globale usando la trappola del debito. Esattamente quella trappola che
America ed Europa hanno usato e usano per soggiogare l’Africa e altri Paesi
poveri del mondo… bizzarrie della propaganda.
·
Quei razzisti come i
ruandesi.
Manila Alfano per "il
Giornale" il 21 settembre 2021. Considerato un eroe per il mondo, accusato di
terrorismo nel suo Paese. Il Ruanda ha emesso la sentenza contro l'uomo che
durante il genocidio del 1994 salvò oltre mille persone. Oggi il governo gli
presenta il conto: nove capi di imputazione pendono sulla sua testa, compreso
quello di «terrorismo», condannato a 25 anni di carcere. Paul Rusesabagina, è
l'uomo che ha ispirato il film «Hotel Rwanda», è lo «Schindler africano», che
con il suo coraggio è riuscito a mettere in salvo centinaia di persone.
Rusesabagina, 67 anni, non era presente all'annuncio della sentenza, dopo aver
dichiarato più volte negli anni di non aspettarsi giustizia in un processo
definito una «vergogna». Le stesse organizzazioni per i diritti umani e
l'opposizione al governo ruandese denunciano il processo come atto di vendetta
politicamente motivato. «Non ha beneficiato di un processo equo e pertanto la
sentenza è da rivedere», ha dichiarato la ministra degli Esteri belga Sophie
Wilmès, secondo la quale non è stata rispettata neppure la presunzione di
innocenza. Sinora è stato dichiarato colpevole di formazione di gruppo armato
illegale e adesione a gruppo terroristico, ma restano sospese le accuse di
omicidio, sequestro, rapina a mano armata legate a terrorismo. Paul Rusesabagina
era diventato una celebrità mondiale dopo che il film di Terry George del 2004
raccontò la sua storia: nel 1994, durante il genocidio che in 100 giorni uccise
più di 800.000 persone, lui riuscì a salvare più di 1.000 tutsi nascondendoli
nell'hotel dove lavorava. Rusesabagina è passato negli anni da essere una figura
celebrata a una contrastata dal governo, a causa delle critiche mosse al
presidente Paul Kagame. Dopo l'uscita del film, ha utilizzato la sua popolarità
per denunciare quelli che secondo lui erano gli abusi e le violazioni del
governo di Kagame, comandante tutsi che con le sue truppe pose fine al genocidio
del 1994 e che dal 2000 è il presidente del Rwanda. La sentenza è arriva oltre
un anno dopo la scomparsa di Rusesabagina mentre era in visita a Dubai: l'uomo
era ricomparso giorni dopo in manette in Ruanda, accusato di aver sostenuto il
braccio armato della sua piattaforma politica di opposizione, il Movimento
ruandese per il cambiamento democratico. Il gruppo aveva rivendicato la
responsabilità di attacchi nel 2018 e 2019 nel sud del Paese, in cui erano morti
nove ruandesi. Rusesabagina ha sempre dichiarato la propria innocenza, e la
famiglia denuncia che fu sequestrato e riportato in Ruanda contro la sua
volontà. L'ex manager e i suoi avvocati hanno boicottato le udienze da marzo,
denunciando un processo «politico» reso possibile dal suo «sequestro»
organizzato dalle autorità ruandesi, nonchè i maltrattamenti durante la
detenzione. L'eroe di Hotel Rwanda viveva in esilio dal 1996 tra gli Stati Uniti
e il Belgio, paesi da cui aveva ottenuto la cittadinanza. È stato arrestato
nell'agosto 2020 in Ruanda in circostanze oscure, quando è sceso da un aereo che
pensava fosse diretto in Burundi. Invece, una volta a terra, l'amara sorpresa.
Dopo denunce e indignazione della stampa straniera, il governo ruandese ha
dovuto ammettere di aver «facilitato il viaggio» a Kigali, ma ha affermato che
l'arresto era «legale» e che «i suoi diritti non sono mai stati violati». Gli
Stati Uniti, il Parlamento europeo e il Belgio di cui è cittadino hanno espresso
preoccupazione.
“Terrorista”: ecco la
sentenza contro l’eroe di Hotel Rwanda.
Daniele Bellocchio su Inside
Over il 20 settembre 2021. A un anno dal suo arresto, Paul Rusesabagina, l’eroe
del film Hotel Rwanda, è stato condannato per “terrorismo” e ora rischia il
carcere a vita. Questa mattina la Corte Suprema ruandese si è pronunciata in
questo modo nei confronti dell’uomo conosciuto in tutto il mondo come l’Oscar
Schindler africano, per aver salvato, durante il genocidio ruandese del 1994,
oltre 1200 cittadini tutsi dalle milizie genocidarie hutu. Per comprendere come
si è arrivati a questa sentenza storica che fa di uno degli eroi di fine ‘900 un
terrorista, e che, nel giro di poche ore dal suo pronunciamento, ha già
sollevato polemiche a livello internazionale, occorre riavvolgere il rocchetto
degli eventi sino al 1994 quando nel Paese delle Mille Colline si consumava uno
dei crimini e delle tragedie più efferate della nostra contemporaneità. Da
aprile a luglio del 1994 nel Paese dei Grandi Laghi si registrò un massacrò che
vide oltre 800’000 cittadini di etnia tutsi morire sotto i colpi di machete
delle milizie suprematiste hutu. In quei mesi di follia e ferocia, che sarebbero
stati poi consegnati alla storia come i giorni del genocidio ruandese,
Paul Rusesabagina era il manager del lussuoso Hotel delle Mille Colline a Kigali
e l’uomo, di origine hutu, sfruttò la sua carica e i mezzi a sua disposizione
per mettere al riparo 1.268 tutsi e hutu moderati, dalle esecuzioni sommarie e
dalle barbarie che travolgevano le strade della capitale e i villaggi del Paese
africano. La fine della guerra in Ruanda coincise con la presa del potere da
parte del leader del Fronte Patriottico Ruandese Paul Kagame e Rusesabagina si
trovò subito in contrasto con il nuovo esecutivo che accusò di metodi
autoritari. Nel 1996, l’ex gestore dell’albergo delle ”Mille Colline” si
trasferì prima in Belgio, dove chiese asilo politico, e poi negli USA. Nel 2004,
con l’uscita nelle sale del film candidato all’Oscar “Hotel Rwanda” la storia di
Rusesabagina raggiunse una notorietà di livello planetario e l’uomo ottenne nel
2005, dal presidente George W. Bush, la Presidential Medal of Freedom, la
massima onorificenza civile degli Stati Uniti. Dal suo esilio Rusesabagina ha
sempre lanciato duri attacchi nei confronti di Kagame e del suo cerchio magico
accusando l’esecutivo ruandese di aver preso una deriva autoritaria e di non
rispettare la popolazione hutu. Negli anni però, alle accuse mosse da
Rusesabagina, hanno fatto seguito numerosi racconti che hanno macchiato la
figura di colui che era considerato uno dei massimi esponenti della difesa dei
diritti umani a livello planetario. Testimonianze raccolte dalla stampa
internazionale hanno ridisegnato la figura dell’ex manager dell’Hotel di Kigali
dipingendolo come uno speculatore che si è arricchito chiedendo soldi e beni
alle migliaia di civili che ha messo in salvo nel suo albergo. Ciò che però non
è stato mai appurato è se queste fossero accuse comprovate o costruzioni fatte a
tavolino dal governo di Kagame per infangare e discreditare la figura di uno dei
suoi più conosciuti e autorevoli oppositori. Certo è che Rusesabagina ha
proseguito la sua attività di oppositore dando vita nel 2017 al Movimento
ruandese per il cambiamento democratico (Mrcd), e questa sigla si sospetta che
abbia avuto anche un’ala armata, il Fronte di liberazione nazionale (Fln),
resosi responsabile di alcuni attentati nel sud del Ruanda, tra il 2018 e il
2019, che hanno provocato la morte di 9 persone. Lo scontro tra Rusesabagina e
Paul Kagame è proseguito con attacchi e accuse reciproche ma nessuno avrebbe mai
immaginato che l’esito di questa controversia sarebbe stato quello di una
condanna per terrorismo arrivata al termine di un iter giudiziario
caratterizzato più da ombre che da luci e che in molti, tra editorialisti,
attivisti dei diritti umani e legali, ritengono avere i connotati di una resa
dei conti personale tra il governo ruandese e il suo nemico pubblico numero uno.
Alla sentenza di poche ore fa si è arrivati infatti dopo un anno di accuse,
incongruenze e denunce di violazioni dei diritti dell’accusato a partire
dall’arresto avvenuto lo scorso agosto quando l’aereo su cui viaggiava l’ex
gestore dell’albergo ruandese è atterrato in Ruanda anziché in Burundi dov’era
diretto. Le dinamiche e le circostanze dell’arresto ad oggi rimangono molto
caliginose così come tutto l’iter giudiziario che ha portato questa mattina
l’eroe di Hotel Rwanda ad essere accusato di terrorismo. Durante questi tredici
mesi di detenzione molti sono stati gli appelli fatti dalle organizzazioni
umanitarie, tra cui Human Rights Watch, affinché venisse fatta chiarezza su
quanto stava avvenendo nel carcere di Kigali. A Rusesabagina infatti é stato
impedito di essere scarcerato sotto cauzione per motivi di salute, Vincent
Lurquin, l’avvocato belga dell’imputato é stato espulso dal Paese in quanto
persona non grata, é stato provato che materiale riservato, appartenente a
Rusesabagina, é stato intercettato e sequestrato dalle autorità del
penitenziario e inoltre ci sono stati casi di testimoni che hanno ritrattato più
volte le loro deposizioni. Ma, nonostante la richiesta del parlamento europeo
che venissero garantiti a Rusesabagina i diritti di un cittadino europeo, avendo
lui cittadinanza belga, nonostante la mobilitazione internazionale e le
richieste dei famigliari e degli attivisti dei diritti umani di fare chiarezza
sui numerosi quesiti irrisolti; l’iter giudiziario é comunque proseguito e
questa mattina é arrivato al suo epilogo. Rusesabagina si é presentato davanti
al giudice indossando la divisa rosa dei detenuti e con le manette ai polsi e si
è ritrovato alla sbarra a dover rispondere di nove capi d’accusa tra cui
terrorismo, formazione di un gruppo armato illegale, rapimento, incendio doloso
e omicidio. Dopo ore di attesa, il giudice Beatrice Mukamurenzi ha emesso la
sentenza esprimendosi in questi termini nei riguardi dell’accusato: “Ha fondato
un’organizzazione terroristica che ha attaccato il Ruanda. Ha contribuito
finanziariamente alle attività terroristiche. Ha approvato disposizioni mensili
di fondi per queste attività. Ha inventato un codice per nascondere queste
attività”. Alla fine Rusesabagina è stato condannato per i suoi legami con il
Fronte di Liberazione Nazionale ma gli avvocati della difesa hanno dichiarato
che non esistono prove inconfutabili riguardo al fatto che l’organizzazione
agisse come braccio armato del Movimento ruandese per il cambiamento
democratico, di cui Rusesabagina era uno dei fondatori. La figlia di
Rusesabagina, che ha assistito al processo in remoto da Bruxelles, sulle colonne
del New York Times, ha gridato allo scandalo e alla messinscena, molti
opinionisti e giornalisti hanno parlato di processo politico e una delle analisi
più efficaci, sempre per il quotidiano statunitense, è stata fatta da Timothy P.
Longman, professore di scienze politiche e affari internazionali alla Boston
University e autore di due libri sul Ruanda. “Questo processo si inserisce
all’interno di una lunga storia di repressione di qualsiasi voce di dissenso da
parte del governo ruandese”. E poi il professore Longman ha proseguito dicendo:
“Il verdetto nel caso Rusesabagina a questo punto è quasi irrilevante. Ciò che è
stato fatto attraverso questo processo è qualcosa di molto più grande, è stato
mandato un chiaro messaggio ad ogni cittadino ruandese in patria e all’estero:
nessuno potrà mai sentirsi al sicuro nel momento in cui dirà qualcosa contro il
presidente Kagame e il Fronte patriottico ruandese”.
·
Quei razzisti come i congolesi.
Il Congo sanguina.
Daniele Bellocchio
su Inside Over il 6 dicembre 2021. “Vogliamo raccontare i drammi senza fine
del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista,
depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e
da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi
da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il
giornalista Daniele Bellocchio.
“Era un uomo di grande
umanità, umile e un vero amico del popolo congolese. Amava il Congo e i
congolesi. Dentro di lui c’era un grande calore umano e un grande rispetto per
le persone. Nutrivamo grande stima nei suoi confronti. La sua memoria resterà
indelebile nei nostri cuori”. E poi: “Dalle stelle da cui ci sta guardando ora,
potrà essere fiero se noi porteremo avanti i sogni per i quali è vissuto e
morto”. È con queste parole che il Premio Nobel Denis Mukwege ha ricordato Luca
Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo che ha
perso la vita in seguito a un attacco condotto da alcuni ribelli nella provincia
congolese del Nord Kivu soltanto 9 mesi fa.
Luca Attanasio, nato a Varese
nel 1977, uno dei più giovani ambasciatori italiani nel mondo, la mattina del 22
febbraio 2021 sta percorrendo la Route Nationale 2, la direttrice che mette in
comunicazione Goma, il capoluogo della regione del Nord Kivu, con le aree
settentrionali della provincia, per verificare la distribuzione del cibo nelle
scuole di Rutshuru. Il convoglio, composto da un pick delle Nazioni Unite e da
uno del World Food Programme, viaggia senza scorta, il vulcano Nyragongo
troneggia all’orizzonte, la savana lentamente lascia spazio alle colline e
nell’impenetrabile florilegio di piante, boschi e sterpaglie, intanto sono
annidati decine di ribelli, sbandati, e disertori che nascosti nella
vegetazione, pianificano attacchi, programmano sequestri, preparano le armi e
passano all’azione.
All’improvviso un posto di
blocco nei pressi della cittadina di Kanyamahoro. Un gruppo di uomini armati
dapprima posiziona dei tronchi sulla strada, poi alza i kalashnikov, i miliziani
sparano contro le macchine e uccidono l’autista Mustapha Milambo. Alcuni rangers
del Parco del Virunga, insieme ad alcuni regolari dell’esercito di Kinshasa, si
precipitano sulla scena dell’accaduto. L’arrivo dei militari provoca uno scontro
a fuoco tra i banditi e i governativi e in pochi minuti, questioni di istanti,
dalle remote regioni del Congo sopraggiunge una notizia che pietrifica il mondo
intero: l’ambasciatore italiano Luca Attanasio di 43 anni, il carabiniere
Vittorio Iacovacci di 31 e l’autista Mustapha Milambo sono stati assassinati.
L’esecutivo di Kinshasa, da
subito, punta il dito contro i ribelli hutu dell’FDLR, poi, in seguito alla
smentita da parte dei rivoluzionari, spiega che si è trattato di un tentativo di
rapimento finito drammaticamente. Il governo congolese apre un’indagine, lo
stesso fanno l’UNDSS (United Nations Department of Safety and Security) e la
magistratura italiana che invia sul campo un nucleo dei ROS. Ad oggi però,
nonostante il lavoro degli investigatori, a una verità su quanto successo ancora
non si è arrivati, tutto rimane ondivago, permeato da ipotesi, supposizioni e
punti di domanda senza risposta.
L’unica certezza è quella
dell’evidenza di una tragedia pubblica e privata che ha visto l’ambasciatore
Attanasio, diplomatico italiano, padre di famiglia e marito, morire insieme a un
militare dei Carabinieri di soli 30 anni, in quelle terre che lui amava e per le
quali stava lavorando e dedicando tutta la sua professionalità.
Di nuovo Italia e Congo, due
Paesi apparentemente lontani, si trovano quindi vicini, uniti nel dolore e
travolti dal gorgo delle maledizioni. Perché, sempre in Congo, nel 1960, è stato
assassinato dai ribelli il Viceconsole italiano Tito Spoglia e un anno dopo a
Kindu, 13 aviatori italiani, che facevano parte della missione dei caschi blu,
sono stati barbaramente uccisi da un gruppo di insorti.
La storia si ripete, di nuovo
e, a unire Roma con Kinshasa, oggi come ieri, è un anatema, un filo rosso,
sottile ma evidente, netto e tranchant; proprio come i confini del Congo, che
non limitano soltanto una nazione ma sono uno scisma fisico e temporale del
nostro presente, una presenza di coscienza di un mondo altro al di fuori di
questo mondo nostro.
Lo spartiacque del Congo
Come si arriva a uno dei
numerosi punti di frontiera che puntellano la Regione dei Grandi Laghi,
immediatamente, si ha infatti la percezione di essere sospesi su uno
spartiacque. Da un lato l’Africa che, uscita da conflitti e crisi umanitarie, ha
intrapreso un percorso di crescita economica e sviluppo; dall’altro lato il
Congo che invece travolge, investe e disorienta ancora prima che vi si acceda.
Si osservano, appena arrivati
al confine, le colonne di cittadini che lasciano il Paese per cercare riparo
nell’accogliente terra di Kampala. All’istante, una volta giunti alla frontiera,
si viene accerchiati dal bailamme dei venditori di chincagliere e, nel momento
stesso in cui ci si incammina per l’ispezione dei bagagli, si è immediatamente
scrutati senza sosta dagli sguardi indagatori dei funzionari governativi. Solo
dopo aver atteso, con ascetica pazienza, che i controlli doganali siano stati
effettuati, ecco che la Repubblica Democratica del Congo apre le sue porte.
Pigri militari intabarrati in
divise madide di sudore, nascosti in garrite e aggrappati ai loro kalashnikov,
sollevano la sbarra che dà accesso al cuore dell’Africa; l’universo Congo si
svela e da quel momento la terra dei minerali e della miseria endemica, dei
bambini soldato e dei missionari eroi, degli stupri di guerra e del premio Nobel
che lotta contro la violenza sulle donne, delle ribellioni orfane dei ribelli e
dei costruttori di pace mai domi nella loro missione, travolge e trascina dentro
di sé.
L’odore di carbone nell’aria,
la nebbia sottile che si solleva dalle montagne, la terra nera, vulcanica, che
contrasta con il verde di una natura feroce e matrigna che tutto circonda,
colpiscono nell’istante stesso in cui si varca la frontiera. E sebbene siano
anni ormai che ci rechiamo in questo lacerto di Africa centrale per raccontarne
conflitti ed epidemie, condanne e remissioni, mai siamo riusciti ad abituarci a
questo scontro frontale, a questa calata verso un precipizio di contraddizioni e
di dicotomie, di tragedie e salvezze. E tra poco, di nuovo, dovremo affrontare
tutto questo, perchè a breve ci recheremo per InsideOver nelle province
orientali del Paese della regione dei Grandi Laghi per raccontare alcuni dei
problemi più gravi e iconici della nostra contemporaneità che qui si stanno
consumando lontano dai riflettori dei media internazionali: l’avanzata dello
jihadismo, lo sfruttamento illegale del sottosuolo, la distruzione delle foreste
e il divampare costante di nuove zoonosi.
Abbiamo deciso di tornare
nell’ex colonia belga per descrivere la lotta che sta conducendo il governo
di Kinshasa contro i gruppi islamisti dell’Adf, la formazione legata
all’Isis che, in Congo, ha dato vita all’Iscap, la Provincia dell’Africa
Centrale del Califfato. Sfruttando l’assenza di infrastrutture, la povertà
assoluta, la porosità delle frontiere e la situazione di instabilità che perdura
da decenni, le forze islamiste hanno avviato una guerriglia che attraverso
rapimenti, massacri di civili e attacchi indiscriminati ha condannato la
popolazione locale a vivere in uno stato di terrore assoluto. Nelle regioni
orientali del Paese è stata proclamata a maggio dell’anno scorso la legge
marziale; un estremo provvedimento adottato dal governo del presidente
Thsisekedi per cercare di contrastare le milizie ribelli e porre un freno
all’insicurezza che travolge la zona.
Tutte le autorità civili in
Ituri e Nord Kivu sono state sostituite dalle autorità militari e proveremo a
seguire quindi gli uomini dell’esercito congolese, le FARDC, nella loro guerra
contro le formazioni irregolari e per la pacificazione del territorio. Non ci
limiteremo a raccontare solo l’esercito di Kinshsasa ma anche il contingente di
interposizione dei Caschi Blu dell’Onu che, dopo una missione decennale,
probabilmente verrà smobilitato nel breve termine e quindi è quanto mai
necessario ora interrogarsi e verificare, direttamente sul campo, soprattutto
dopo quanto successo in Afghanistan, quali conseguenze potrebbe avere un ritiro
di una forza di pace da un’area così instabile come la regione orientale del
Congo.
Nell’est del Congo non ci sono
solo i gruppi islamisti, le formazioni ribelli sono più di cento e il motivo per
cui questa terra è infettata da un coacervo di sigle irregolari è uno solo: la
ricchezza del sottosuolo. Dal momento che non possono essere raccontati gli
effetti senza prima aver analizzato le cause dei fenomeni, cercheremo di andare
a descrivere l’origine della dannazione dell’est del Congo: i giacimenti
minerari. Proveremo quindi a calarci nelle miniere di Rubaya dove, per una
manciata di dollari al giorno, decine di uomini consumano le proprie vite
estraendo quintali del minerale più prezioso che esista: il coltan.
Ribelli e regolari, materie
prime e minatori, sono tutti i fattori di un’equazione che ha come risultato
finale la dannazione della popolazione civile. Le genti dell’est del Congo
vivono sotto assedio della guerra, delle malattie e della miseria più assoluta.
Dall’inizio del 2020 i civili uccisi per mano delle milizie armate sono stati
oltre 2000 e gli sfollati 2milioni, inoltre il World Food Programme ha
dichiarato, nel suo ultimo report sulla Repubblica Democratica del Congo, che
sono 22 milioni le persone che soffrono la mancanza di cibo. Ci spingeremo
allora nei villaggi assediati e nei campi profughi per raccontare il dramma che
sta travolgendo uomini, donne e bambini, e poi cercheremo di raccontare anche
gli sforzi di chi sta cercando di trovare una soluzione a una tragedia che
troppo spesso è stata dipinta come irrisolvibile e ontologica.
Il Congo sanguina ed è nostro
dovere, in quanto giornalisti, non girarci dall’altra parte ma raccontare quanto
sta avvenendo immergendoci, ancora una volta, in questa terra di estremismi e di
contrasti dove se da un lato è tangibile e concreto il concetto di morte allo
stesso tempo, in nessun luogo come il Congo, si può conoscere e comprendere la
dimensione più alta del valore della parola vita racchiusa in storie come quella
di Luca Attanasio: ambasciatore, marito, padre e per sempre, uomo di pace.
Le milizie che insanguinano
la Repubblica Democratica del Congo.
Lorenzo Vita su Inside Over il
7 dicembre 2021. “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra
tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo
sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che
riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si
occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista Daniele
Bellocchio.
Sostieni il reportage “
Nel territorio più orientale
della Repubblica Democratica del Congo, le milizie si muovono a decine e come
schegge impazzite. Compiono rapimenti, mietono vittime, combattono tra loro e
contro l’esercito, gestiscono traffici di minerali e lottano non solo per se
stesse, ma anche per i Paesi limitrofi. O forse anche molto più lontani.
La morte dell’ambasciatore
italiano Luca Attanasio, ucciso mentre percorreva la strada che collega
Rutshuru-Goma, ha riportato tragicamente all’attenzione di molti la terribile
situazione della Repubblica democratica del Congo. Un Paese in cui la parte
orientale è costellata da fazioni ribelli che non sono semplici predoni o bande
armate improvvisate. Tante, spiegano gli analisti, sono composte da uomini che
sono militari di professione, convertiti in ribelli semplicemente per
sopravvivenza o per ambire a guadagni più elevati legati al traffico di materie
prime.
Un caos infernale in cui si
muovono i Paesi che confinano con quell’area (in particolare Burundi, Ruanda e
Uganda) e che si trovano così a poter sfruttare i gruppi ribelli per provare a
espandere l’influenza su un territorio ricchissimo, che proprio per questo è
condannato a subire il terrore e il sangue.
Angelo Ferrari, analista e
africanista per Agi, spiega in un suo articolo che “nell’area si confrontano
oltre venti gruppi etnici con propri miliziani”. La formazione più nota e
radicata sul territorio è quella Mayi Mayi, che raccoglie al suo interno diverse
anime. Sorte come resistenza alle forze ruandesi che penetravano nelle regioni
oltre il confine, le milizie hanno assunto diverse identità e obiettivi e i suoi
leader sono spesso stati accusati di crimini di guerra. Il nome, spiegano gli
autori del “Historical Dictionary of the Democratic Republic of the Congo”
deriva da una parola Swahili che significa “acqua”. I suoi miliziani credevano
infatti che attraverso alcune pratiche magiche legate all’acqua potessero
salvarsi dai proiettili dei nemici. E così quel termine collegato a questi
rituali propiziatori è diventato il simbolo di questa galassia di signori della
guerra e miliziani che si muove nei territori orientali del Congo. Un gruppo con
decine di morti sulla coscienza e con accuse che riguardano alcuni tra i più
efferati delitti avvenuti nel Paese.
Non sono le uniche milizie a
combattere nel Paese. Una delle più importanti – quella che Bienvenue Pombo,
membro della commissione d’inchiesta per la morte di Attanasio, aveva definito
a Repubblica come la milizia responsabile dell’assalto – è quella che va sotto
il nome di Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). Per la
missione Monusco, l’operazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della
Repubblica democratica del Congo, questa forza rappresenta “il più grande gruppo
armato straniero illegale” del Paese africano. Per l’Onu, non è chiaro se le
Fdlr siano lì per premere sul governo del Ruanda o per rovesciare il potere
prendendo il sopravvento sulla madrepatria. Quello che è certo è che migliaia di
loro uomini operano nel territorio del Kivu, nei pressi del vulcano Nyiragongo,
e proprio nel settore in cui Attanasio è stato tragicamente ucciso.
Un altro nome che terrorizza
le aree orientali e settentrionale della Repubblica democratica del Congo è
quello guidato da Joseph Kony, il Lord’s Resistence Army (Lra), l’Esercito di
resistenza del Signore. È una delle armate più inquietanti del panorama delle
milizie locali. Unite da un fanatismo religioso cristiano, misticismo animista e
da spirito nazionalista, gli uomini di Kony sono accusati di crimini orrendi. La
Corte Penale Internazionale li ritiene colpevoli di schiavitù, rapimenti,
arruolamenti di bambini e di innumerevoli omicidi. Per gli Stati Uniti sono
un’organizzazione terroristica. Un’orda di centinaia di persone che ha
terrorizzato tutta quella regione dell’Africa e che si è spostata dall’Uganda
fino al Sud Sudan e ora in Congo. La sua forza si è ridotta nel tempo, ma questo
non ha escluso attacchi e le conseguenza nefaste della sua guerra.
Un altro gruppo che ha le sue
radici in Uganda è quelle delle Allied democratic Forces (Adf), le Forze
democratiche alleate. Le milizie Adf, nate nell’area del Rwenzori e guidate,
come spiega sempre Ferrari su Agi, dall’ex cristiano convertito all’Islam, Jamil
Mukulu, sono salafiti che vogliono imporre la più dura delle leggi islamiche in
Uganda e in tutti i territori che controllano. A novembre del 2021, l’ultimo
assalto è stato nel Nord Kivu, con la morte di alcuni civili e la reazione
dell’esercito nazionale che ha ucciso i terroristi. Da qualche anno, spiegano
gli osservatori di Africanews, alcuni attacchi da parte delle Adf sono stati
rivendicati dallo Stato islamico, qui identificato come “Provincia dell’Africa
centrale” (Iscap in inglese). Anche per gli analisti del Centre for Strategic
and International Studies, dall’arresto di Mukulu nel 2015, “l’Adf ha rilasciato
quantità crescenti di propaganda che riflette l’allineamento ideologico con lo
Stato Islamico. Ciò include una maggiore attenzione agli sforzi per uccidere i
civili non musulmani”. Un segnale di come l’islamismo sia esteso ormai anche in
quest’area dell’Africa.
I fantasmi dell’Ebola
infestano gli incubi del Congo.
Federico Giuliani su Inside
Over il 12 dicembre 2021. “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo,
una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata
dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che
riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si
occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista Daniele
Bellocchio.
L’illusione ha retto per circa
cinque mesi. Sembrava che nella Repubblica Democratica del Congo Ebola fosse
ormai un nemico sconfitto, un virus da relegare negli archivi della storia, una
battaglia vinta da raccontare alle future generazioni. Lo scorso maggio Kinshasa
annunciava la fine dell’ultima epidemia di Ebola a tre mesi dalla segnalazione
di una ricomparsa del “nemico invisibile” nel Kivu Nord, a est del Paese. In una
nota, l’Unicef spiegava che l’epidemia era stata contenuta grazie alla rapida
risposta delle autorità congolesi, e che quella appena soffocata era la terza
fiammata di Ebola nel Paese in meno di un anno.
A ottobre la realtà ha
stravolto i piani di una nazione nel frattempo aggredita anche dal Sars-CoV-2.
Tre nuovi casi di Ebola sono apparsi nell’est del Paese, nel distretto sanitario
di Butsili, nei pressi della città di Beni, dove tra l’altro si era verificato
l’ultimo focolaio estinto. I funzionari provarono a giustificare quanto accaduto
ipotizzando che la riacutizzazione del virus potesse essere collegata alla
massiccia epidemia che, a cavallo tra il 2018 e il 2020, aveva ucciso oltre
2.200 persone e infettate più di altre mille. Il risveglio del “fantasma” può
essere stato causato da infezioni latenti che, in qualche modo, sono riuscite a
resistere all’interno degli organismi dei sopravvissuti. C’era infatti stato un
precedente di casi legati all’epidemia 2018-2020: era scoppiato a febbraio e,
dopo esser stato contenuto a maggio, aveva causato sei vittime.
Il passato che ritorna
Inizio, fine, inizio, fine. E
così fino alla prossima illusione di aver neutralizzato la minaccia Ebola. Il
Congo è salito su queste montagne russe fin troppe volte, visto che ha
annunciato la fine di oltre undici epidemie. Se i numeri relativi ai
recenti contagi e ai decessi sono stati tutto sommato contenuti, lo si deve ai
vaccini sperimentali, vero e proprio punto di svolta nel contenere più
rapidamente i recenti focolai.
Intanto, l'Università di
Oxford ha iniziato a reclutare volontari per uno studio di Fase 1 volto a
testare un vaccino contro il virus Ebola, sia del ceppo Zaire che del ceppo
Sudan, due delle specie più letali. Ma la scienza non può permettersi di perdere
un istante, perché la Repubblica Democratica del Congo, nonostante abbia
imparato a fare i conti con il "fantasma", si trova in una situazione
delicatissima. L'area più a rischio, come detto, sembrerebbe essere quella
localizzata nel nord est del Paese, già teatro di un contesto di guerra di vari
focolai. Da agosto 2018 sono emersi numeri spaventosi, con oltre 2mila morti e
più di 3,100 contagi. Adesso la domanda che si fanno gli esperti è una: l'ultimo
focolaio è soltanto un ritorno di fiamma correlato alla precedente ondata oppure
è un nuovo capitolo?
Un nemico temibile
La febbre emorragica
dell'Ebola è una delle malattie più virulente che l'essere umano conosca.
I sintomi provocati da questo virus comprendono febbre, mal di testa e mal di
gola. Poco dopo si scatenano dolori addominali, vomito e diarrea, seguiti
talvolta da un'eruzione cutanea purpurea e singhiozzo, forse dovuto
all'irritazione dei nervi che controllano il diaframma. Di solito, i sintomi più
pericolosi si manifestano giorni dopo l'insorgenza della malattia, quando le
cellule infettate dal virus si attaccano dentro i vasi sanguigni, provocando la
fuoriuscita del sangue da naso e bocca (e non solo).
I contagiati finiscono col
subire un calo della pressione sanguigna e morire a causa di choc e collasso
multiplo degli organi. L'autore Richard Preston ha definito Ebola "un parassita
che trasforma ogni parte del corpo in una melma digerita di particelle virali".
E non c'è da sorprendersi di una descrizione del genere, visto che il tasso di
mortalità di questa malattia oscilla intorno al 90%. Ebola non è contagiosa ma,
allo stesso tempo, è altamente infettiva. Ecco perché il fantasma che infesta
gli incubi della Repubblica Democratica del Congo è così spaventoso.
·
Quei razzisti come i sudsudanesi.
Dieci anni di Sud Sudan,
storia di uno Stato fallito.
Daniele Bellocchio su Inside
Over il 31 ottobre 2021. Dieci anni sono passati da quando il mondo volgeva lo
sguardo verso il continente africano e celebrava la nascita del Sud
Sudan. L’indipendenza del nuovo Paese dell’Africa, il 9 luglio 2011, veniva
festeggiata non solo a Juba e tra i confini della nazione racchiusa tra il
Sudan, l’Etiopia, il Kenya, la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda e la
Repubblica Centrafricana, ma anche a livello internazionale. Il mondo intero
infatti vedeva nella nascita del cinquantaquattresimo stato africano la fine di
una guerra che durava da decenni e di una situazione che costringeva le genti
del Sud Sudan a vivere oppresse, discriminate, escluse economicamente e
segregate dalla popolazione di origine araba del nord e dai vertici di Khartoum.
L’autonomia e l’indipendenza sono state plaudite dai leader di tutti i Paesi del
primo mondo e, da Tokyo a Washington, tutti i capi di stato si sono prodigati
nel promettere aiuti e sostegni al neonato stato africano. Le parole però si
sono infrante sul frangiflutti della realtà. Quello che era stato battezzato
come un sogno di pace si è tramutato in breve tempo in un nuovo incubo di
guerra. Sebbene la comunità internazionale si sia impegnata nel costruire le
infrastrutture di un Paese che usciva frantumato da una guerra civile inclemente
e feroce, ciò che non è stato fatto e non è stato considerato, è che non erano
assenti solo i sistemi basici del Paese, ma persistevano a mancare le fondamenta
vere e proprie della nazione: la coesione nazionale, l’unità dei leader
politici, la riconciliazione sociale e l’idea di cittadinanza. Così il più
giovane stato africano ha catalizzato in sé gli errori e gli orrori che dopo le
indipendenze degli anni ’60 si erano verificati in molti altri paesi del
continente: tribalismo, nepotismo, furto di risorse pubbliche e autoritarismo, e
la violenza ha infettato in breve tempo i gangli vitali della società sud
sudanese e ha trascinato il Paese, in soli tre anni, in una guerra civile che
ancor oggi, nonostante siano stati firmati dei fragili accordi di pace, prosegue
a intermittenza. In questi giorni in cui si dovrebbe festeggiare l’anniversario
della nascita di una nazione invece si assiste con impotenza all’ennesimo
fallimento di uno stato africano che ,su una popolazione di 11milioni di
abitanti, ne registra 4 milioni e mezzo nei campi profughi interni e in quelli
dei paesi confinanti e ad oggi, secondo il Global Crisis Severity Index, il Sud
Sudan risulta essere uno dei Paesi più instabili al mondo e le prospettive di
una ripresa nel futuro prossimo sono al momento intangibili. Per comprendere
perché il Sud Sudan sia oggi tormentato da odio e crisi umanitarie bisogna
riavvolgere il rocchetto della storia almeno sino agli anni sessanta e conoscere
così alcune vicende storico e politiche e alcune parole chiave che sono
determinanti per avere una visione chiara di ciò che è successo dalla metà del
‘900 sino ad oggi in questa regione africana.
La storia
Il Sud Sudan ha sempre fatto
parte, sino al 2011, del Sudan, uno stato che, anche durante il periodo
coloniale, ha avuto una storia alquanto travagliata e atipica rispetto agli
altri paesi africani. E’ stato, questo Paese, nell’occhio di diverse potenze
europee, ed, è qui, per l’esattezza a Fascioda, che si sono fronteggiati inglesi
e francesi e si è rischiata una guerra aperta tra due eserciti coloniali. E’
questa terra bagnata dal Nilo ad essere stata una dei palcoscenici delle
prime resistenze armate anticoloniali mosse da una forte componenti religiosa
islamica, ed è sempre il Sudan ad aver avuto una forma coloniale unica essendo
stato dalla fine del ‘900 sino al 1955 un protettorato anglo egiziano abitato da
popolazioni islamiche e arabe nel nord e da gruppi etnici dell’Africa
equatoriale e sub-sahariana nel sud.
La scoperta del petrolio
La divisione etnica e
geografica ha sempre caratterizzato la storia di questa nazione tanto che già
nel 1955, un anno prima dell’indipendenza del Paese, nelle regioni meridionali è
nato un gruppo guerrigliero che rivendicava l’indipendenza del sud: il Movimento
di resistenza del Sud Sudan (Ssrm nell’acronimo inglese). La guerra civile vera
e propria però tra il nord e il sud è iniziata nel ’62 e solo nel ’69, quando i
militari hanno portato al potere il colonnello Nimeiri che ha ascoltato le
istanze autonomista delle genti del sud si è avuta la parvenza di una fine delle
ostilità. Nel ’72 infatti, ad Addis Abeba, c’è stata la firma di un accordo di
pace che ha sancito lo statuto di regione autonoma al Sud Sudan. Ma nel ’78 è
successo un qualcosa che ha sparigliato le carte, ha annullato ogni accordo
pregresso, ha infiammato avidità e corruzione e ha acceso gli istinti più
brutali nelle leadership locali: nella regione autonoma del Sud Sudan sono stati
rinvenuti giacimenti di petrolio. La scoperta dell’ oro nero ha portato il
colonnello Nimeiri a imporre la sharia in tutta la nazione e a revocare
l’autonomia al sud. Una decisione che ha avuto il peso di una dichiarazione di
guerra e infatti nel 1983, i partigiani del Sud Sudan hanno ripreso in mano le
armi e, sotto la guida di John Garan, è nato l’SPLA (Sudan People Liberation
Army), ed è iniziata la seconda guerra civile. Nel 1989 il Paese è stato
sconvolto da un altro colpo di stato, quello Omar El Bashir, uno dei dittatori
più sanguinari della storia recente africana che rimarrà in carica per 30 anni e
che proseguirà la sua guerra contro l’esercito indipendentista del sud.
Il cessate il fuoco
Una data importante, che
porterà da lì a qualche anno alla separazione del Sud Sudan è il 2004 perchè il
7 gennaio di quell’anno è stato firmato un protocollo che prevedeva la divisione
in parti uguali delle rendite petrolifere del Sudan (in gran parte nel sud) tra
il governo di Khartoum e il Movimento/esercito di liberazione del popolo
sudanese (Spla/m). Una stretta di mano molto significativa tanto che, l’anno
dopo, il 9 gennaio del 2005, è stato siglato l’ Accordo globale di pace (Agp)
tra Khartoum e l’Spla, a Nairobi, che prevedeva un cessate-il-fuoco permanente,
autonomia per il sud, un governo di coalizione tra Khartoum e Spla/m, e un
referendum da tenere nel sud, entro sei anni, per decidere sull’indipendenza o
meno di quelle regioni. Nella parte meridionale del Paese questo accordo è stato
salutato come una vittoria soprattutto perchè John Garang, il capo dei ribelli,
divenuto vicepresidente del Sudan, ha concesso enorme autonomia alla sua gente.
Pochi mesi dopo però, in un incidente aereo, Garang è morto e il suo posto è
stato preso da Salva Kiir e gli accordi di pace sono stati sul punto di saltare
e la guerra sembrava doversi infiammare di nuovo. Si sono registrati infatti
scontri tra lealisti e irregolari in tutto il paese, soprattutto nelle regioni
contese dei Monti Nuba, dello Stato del Blu Nile e della contea di Abey, zone
ricchissime di giacimenti petroliferi. Ma la crisi umanitaria e un arbitrariato
internazionale che ha stabilito a chi appartenessero i pozzi petroliferi hanno
convinto le due parti a silenziare le armi e a dicembre 2009 si è arrivati
all’accordo tra il governo di Khartoum e quello di Juba sul referendum per
l’indipendenza del sud da tenere nel 2011.
L’indipendenza e la guerra
civile
Si è arrivati quindi, nel
2011, al fatidico referendum sull’autodeterminazione del Sud Sudan, che ha visto
i favorevoli all’indipendenza trionfare alle urne con il 98,83% dei voti, e il 9
luglio, è stata de facto proclamata la nascita del più giovane stato africano.
E’ una vita da subito travagliata, quella del nuovo stato che, un anno dopo il
referendum, ha affrontato una crisi politica ed economica con Karthoum in merito
all’esportazione del greggio e i due Paesi sono stati molto vicini
dall’intraprendere una guerra. Ma una volta risolta la situazione in politica
estera a Juba si è assistito all’inizio di una crisi interna che non ha ancora
visto la fine. Nel 2013 il presidente Salva Kiir ha sospeso dapprima il ministro
delle finanze, Kosti Manibe, e il ministro per gli affari di governo, poi ha
rimosso il vicepresidente, Riek Machar Teny, ha sciolto l’intero governo e
licenziato tutti i ministri; poi ha dato vita a un nuovo governo con i suoi
fedelissimi e ha nominato come vicepresidente James Wani Igga, ex comandante
ribelle dell’Spla/m. Ma l’epurazione dei rivali politici e la deriva autoritaria
di Salva Kiir non erano finite. A dicembre il Presidente ha accusato l’ex vice
Machar di aver ordito un golpe, e a questo punto non c’è stato più nulla da
fare: in Sud Sudan è scoppiata la guerra civile. Violenze a Juba, nelle
principali città del Paese e anche nei villaggi più remoti hanno lasciato subito
una scia di sangue e migliaia di morti e la guerra, che ufficialmente si
protrarrà sino a febbraio 2020, ha visto contrapporsi le due principali etnie: i
dinka, maggioritari, fedeli a Kiir e i nuer invece fedeli a Machar. Il bilancio
finale, dopo svariati accordi di pace risultati fallimentari, sarà di 4 milioni
di sud sudanesi costretti a fuggire dai propri villaggi, oltre 400mila
vittime, massacri e casi di pulizia etnica, stupri di guerra e una crisi
umanitaria senza pari che ha portato persino il Papa a invitare al digiuno e
alla preghiera per la pace nel Paese africano. Si è dovuto attendere il 2020
prima che la guerra in Sud Sudan potesse dirsi definitivamente conclusa. A Roma
il 12 Gennaio 2020, presso la Comunità di Sant’Egidio è stata firmata la
“Dichiarazione di Roma”, che per la prima volta ha visto tutte le parti
politiche del Paese firmare un accordo di cessate il fuoco e a febbraio una
delegazione di Sant’Egidio si è recata in Sud Sudan per la firma dell’Accordo
politico di Juba, frutto dell’intesa tra il presidente Kiir e il leader
dell’opposizione Machar e che ha portato alla formazione di un governo di unità
nazionale.
Un bilancio
Nonostante gli accordi di
pace, la formazione di un esecutivo transitorio e la riapertura del Parlamento
la violenza non è mai del tutto finita in Sud Sudan e secondo l’ONG sud sudanese
Community Empowerment Progress Organization (CEPO), tra gennaio e maggio 2021
oltre 3000 persone sono state uccise o ferite in scontri intercomunitari e ad
oggi la situazione, aggravata anche dall’epidemia di Covid, rimane estremamente
precaria: l’economia è criticissima, le armi continuano a circolare e le
differenze etniche permangono divenendo un argine concreto a una rinascita
unitaria del Paese. E sebbene dal 2013 ad oggi, molti sforzi siano stati fatti
per uscire dalla crisi bellica, il Sud Sudan però se vuole cambiare rotta e, a
dieci anni di distanza della sua nascita, intraprendere un percorso diverso deve
ascoltare e fare tesoro delle parole di un suo illustre cittadino, Koj Madut
Jok, antropologo e sottosegretario del ministro della cultura che, nel suo libro
”A Shared struggle: people and cultures of Sud Sudan”, ripreso in un editoriale
della rivista Nigrizia, ha scritto queste parole per parlare di quella che è la
grande piaga della sua nazione e quale deve essere la soluzione:“In questo
momento, quasi tutte le questioni riguardanti la violenza di stato sono basate
sull’etnia, con i gruppi minoritari che si lamentano di essere esclusi e che la
loro terra è invasa. Quasi tutte le frequenti ribellioni hanno radici in
risentimenti etnici o settoriali. Il Sud Sudan diventerà mai una nazione
unificata, dove, ad esempio, l’appartenenza etnica non sarà più un elemento da
considerare nelle interviste per un lavoro, dove non ci saranno più gruppi
politico-militari fondati su base etnica, dove l’assegnazione di servizi,
progetti di sviluppo, contratti pubblici non dipenderà dal gruppo etnico? Ora
tutto questo è la norma e crea un contesto politico caratterizzato da sospetto e
sfiducia…Se non si trova una soluzione a questa questione divisiva, la stabilità
politica in Sud Sudan rimarrà con ogni probabilità un concetto vago”.
·
Quei
razzisti come i giordani.
Igor Pellicciari
per formiche.net il 7 aprile 2021. Due orientamenti opposti regolano una delle
questioni più dibattute nelle scienze sociali, ovvero il rapporto ideale
auspicabile tra ricercatore e oggetto di studio. Uno prescrive che egli mantenga
un distacco da ciò che osserva per evitare che un coinvolgimento emotivo finisca
con il falsarne percezione e conclusioni. L’altro suggerisce al contrario che
egli si cali quanto più possibile nella realtà studiata per poterne cogliere il
senso che altrimenti faticherebbe a comprendere da estraneo. Nell’appello del 14
marzo scorso a sostenere il modello giordano sviluppammo considerazioni
oggettive di politica internazionale, seppure mossi nell’occasione da una
esperienza soggettiva (lo svolgere un incarico diplomatico presso il Regno
Hashemita di Giordania). A meno di un mese di distanza, un commento sull’
“attentato alla stabilità del paese” (nelle parole del vice-premier e ministro
degli affari esteri Ayman Safadi) non può prescindere da entrambe queste
prospettive: quella del ricercatore distaccato e quella del diplomatico
coinvolto. Fatta questa doverosa premessa, su quanto accaduto (e trapelato) si
possono per ora avanzare alcune osservazioni sia di politica internazionale che
interna. La prima è che l’immediata ed enorme eco mondiale suscitata dalle
notizie provenienti dalla Giordania è forse la migliore conferma di quella
esponenziale crescita di centralità vissuta dal Paese negli ultimi due decenni,
amplificata dall’essere rimasto l’unico stabile dell’area medio-orientale. La
seconda è che forse è in questa stessa importanza che vanno cercati sia gli
elementi ispiratori del tentativo di sovvertire l’ordine ad Amman, sia i motivi
del suo fallimento. La stabilità giordana ha radicalmente trasformato il Paese,
storicamente povero di risorse naturali, aumentandone attrattività geo-politica
ed economica. Da semplice territorio di sfogo “temporaneo” della questione
palestinese in attesa di una improbabile soluzione, la Giordania è diventata
crocevia degli equilibri di tutto il Medio-Oriente, arrivando ad influenzare
anche quelli del Golfo. La cosa iniziò a delinearsi con la guerra in Iraq quando
il Paese divenne per anni base logistica prima e poi sempre più centro di
orientamento strategico delle principali operazioni multilaterali e bilaterali
su Baghdad. La cui presenza si è istituzionalizzata con l’aggiungersi di
attività qui decentrate dalla Siria, Yemen, Libano. Di pari passo, Amman è
diventata nuova cassaforte per ingentissimi capitali in fuga dai ricordati
scenari in crisi. In una parte minore essi sono stati investiti nel Paese (in
particolare nell’immobiliare ad opera di gruppi libanesi come la famiglia
Hariri) mentre per il resto hanno creato una ricchezza finanziaria di rendita,
parcheggiata in attesa di tempi migliori. Per inciso, come in tutti gli scenari
con un eccesso di stranieri stanziali di lungo periodo (profughi e operatori
internazionali), essa ha drogato un’economia locale fatta di servizi che ha
aumentato costi, diseguaglianze sociali, corruzione e malcontento nella
popolazione locale. Con la Giordania nuovo centro di interesse
politico-finanziario non è da escludere che l’idea di un cambio di leadership
nel Paese sia partita da fuori, da una delle potenze regionali dell’area.
Tuttavia, la stabilità di Amman è oramai questione che va oltre i confini del
Medio Oriente o del Golfo e coinvolge i principali attori internazionali del
momento. Il suo mantenimento è uno dei pochi punti su cui, nel corrente
dis-ordine mondiale, concordano all’unisono Stati Uniti, Russia, Cina.
Considerando il loro forte dispiegamento di intelligence in Giordania (senza
dimenticare quella di Israele, che vi ha un’importante presenza diplomatica) si
può ipotizzare che da questi ambienti sia partito in anticipo un avvertimento
indirizzato al Mukhabarat locale, la cui proverbiale formazione professionale ha
beneficiato negli anni dalla stretta collaborazione con lo stesso Mossad. Una
considerazione finale riguarda invece lo sviluppo che ha preso il sistema
politico-costituzionale giordano durante il regno di Re Abdallah II. E porta ad
ipotizzare che, anche qualora non sventato dai servizi, il complotto ad Amman
comunque non sarebbe andato a buon fine. Divenuto Sovrano a sorpresa nel 1999 e
sconosciuto ai più, Re Abdallah fu accolto da commenti scettici sulla possibile
durata del suo Regno. Alcuni osservatori internazionali ne paragonarono la
posizione all’ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi: debole nel carisma, quasi
assoluto nelle prerogative sovrane. In due decenni il Re ha chiaramente
sovvertito le aspettative e di fatto invertito il punto di partenza iniziale. Da
un lato è riuscito a diventare figura carismatica e popolare anche per avere
mantenuto viva la sua vocazione militare che lo ha portato ad essere leader
riconosciuto dell’esercito, che rimane insieme all’intelligence uno dei
capisaldi della stabilità interna giordana. Dall’altro, la monarchia si è
costituzionalizzata in senso parlamentare con un progressivo aumento del legame
fiduciario dell’esecutivo rispetto al legislativo e una minore invadenza
arbitraria nell’azione di governo sul piano interno da parte del Sovrano,
rimasto ad occuparsi in prima persona della cruciale politica estera iniziata
dal padre Re Hussein. Con la parlamentarizzazione della vita politica e una
definizione costituzionale più chiara delle prerogative del Sovrano,
inevitabilmente hanno perso di importanza ed incidenza i profili e gli eventuali
disegni politici dei restanti membri della famiglia reale. Relegati da tempo a
ruoli marginali, essi hanno scarsa presa in quelle forze armate fedeli
direttamente al Sovrano, in quanto credibile e riconosciuta autorità militare.
Non a caso, sventata la crisi, Re Abdallah ha dichiarato di volere risolvere la
questione con il Principe Hamzeh “all’interno della famiglia”. Come a dire, il
Regno è superiore a tutto.
Giordania, l'audio del principe Hamzeh
alla guida delle tribù contro re Abdullah. Il capo di
Stato maggiore spiega al principe che viene arrestato per gli incontri con
persone "che hanno parlato troppo..." Chiara Clausi - Mer, 07/04/2021 - su Il
Giornale. La saga della casa reale giordana riserva ogni giorno colpi di scena.
Tanto che ieri Amman ha imposto il divieto di pubblicare qualsiasi cosa
riguardasse il caso del principe Hamzeh bin Hussein, accusato di ordire un colpo
di stato contro il fratellastro, il re Abdullah II. L'ordine arriva il giorno
dopo che l'ex erede al trono aveva firmato una dichiarazione in cui riaffermava
la sua fedeltà al monarca. «Per assicurare il rispetto della segretezza delle
indagini dei servizi di sicurezza sul principe Hamzeh e altri soggetti, è stato
deciso di vietare la pubblicazione di qualsiasi cosa relativa all'indagine in
questa fase», ha spiegato alla televisione il magistrato Hassan al-Abdallat. I
trasgressori saranno sottoposti a sanzioni penali. Ma la disposizione
difficilmente fermerà le continue fughe di notizie. Ieri è emerso un nuovo
audio. È la registrazione dell'incontro fra il principe Hamzeh e il capo di
Stato maggiore dell'esercito, Yousef Huneiti. L'audio è circolato poco dopo che
il palazzo e un mediatore vicino al principe Hamzeh hanno riferito che era in
corso una trattativa. Nella registrazione si sente il capo dell'esercito dire
che il principe viene punito per incontri avuti con persone che «hanno
cominciato a parlare più di quanto avrebbero dovuto». Hamzeh ha criticato
apertamente le politiche del governo e ha stretto legami con potenti leader
tribali, in una mossa considerata una minaccia al re. Ma il principe nel corso
della conversazione si infuria e alza la voce arrabbiato contro Huneiti: «Vieni
da me e mi dici a casa mia cosa fare e chi incontrare nel mio Paese, chi del mio
popolo? Mi stai minacciando?». E ancora: «La cattiva performance dello Stato è a
causa mia? Perdonami ma gli errori sono colpa mia?». Il generale Huneiti,
parlando con voce calma, nega di averlo minacciato e dice che sta semplicemente
consegnando un messaggio da parte di capi dell'intelligence, ma Hamzeh gli grida
addosso e gli chiede di andare via. Nessun accenno al coinvolgimento nella
vicenda di potenze straniere. La registrazione trapelata è arrivata il giorno
dopo che il principe ha firmato una lettera rilasciata dalla corte reale. «Gli
interessi della patria devono rimanere al di sopra di ogni altra cosa, e
dobbiamo tutti sostenere sua maestà il re e i suoi sforzi per proteggere la
Giordania e i suoi interessi nazionali», diceva Hamzeh nella lettera
dattiloscritta firmata in presenza del principe Hassan, lo zio utilizzato per
mediare il conflitto. Hamzeh è molto temuto dalla corte perché ha un seguito nel
Paese, per la sua sorprendente somiglianza con suo padre, il defunto re Hussein.
I video del principe sono spesso condivisi quando il malcontento bolle nel regno
e molti in più occasioni lo hanno invocato per salvare la nazione. Ma ora anche
le potenze della regione iniziano a muoversi. Lunedì c'è stata una visita non
programmata in Giordania da parte di una delegazione saudita di alto rango,
guidata dal ministro degli Esteri Faisal bin Farhan al-Saud. Riad ha offerto il
suo «pieno sostegno al re Abdallah II» e i funzionari sauditi hanno chiesto il
rilascio di Bassem Awadullah, un personaggio di spicco arrestato sabato.
Awadullah è un ex consigliere supremo del re e ha servito come inviato speciale
del monarca in Arabia Saudita, che gli ha concesso la cittadinanza. Anche se la
Giordania ha solo circa 10 milioni di abitanti, ha un'importanza strategica
enorme in una regione turbolenta. Confina con Israele e la Cisgiordania, la
Siria, l'Irak e l'Arabia Saudita, ospita truppe statunitensi e milioni di
palestinesi e oltre mezzo milione di rifugiati siriani. «Questo è solo l'inizio
di una crisi e non la fine», ha detto il capo dell'istituto di ricerca Phenix
Center for Economic and Informatics di Amman.
Il Regno hashemita. Intrigo in Giordania,
20 arresti per presunto golpe: coinvolto il principe Hamza, fratellastro del re.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 4 Aprile 2021.
Complotto di portata e interesse internazionale in Giordania. Un’ondata di
arresti. Giro di vite si potrebbe dire se non si susseguissero in queste ore
ipotesi, dichiarazioni, smentite, trame ancora oscure. Ci sarebbe dietro un
colpo di stato ai danni del re Abdallah II. E quindi una ventina di arresti tra
alti dignitari del regno. Il nome che fa scalpore è quello di Hamzah bin
Hussein, fratellastro del monarca. Il principe ha mandato un video
alla BBC affermando di essere stato costretto agli arresti domiciliari. “Ho
avuto una visita del capo di stato maggiore delle forze armate giordane che mi
ha informato che non mi era permesso uscire, comunicare o incontrare persone
perché durante incontri a cui avevo partecipato – o sui social o durante visite
da me compiute – erano state espresse critiche al governo o al re “. E quindi ha
aggiunto di non essere stato accusato direttamente di aver espresso delle
critiche. “Non sono responsabile del crollo della governance, della corruzione e
dell’incompetenza che è stata prevalente nella nostra struttura di governo negli
ultimi 15-20 anni e che ora sta peggiorando. E non sono responsabile neanche
della mancanza di fiducia che le persone hanno nelle istituzioni. Si è raggiunto
un punto in cui nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi
cosa senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato”. La
tesi del complotto contro il re è stata subito riportata dal Washington Post che
ha parlato con fonti dell’intelligence. Il capo di stato maggiore giordano,
generale Yousef al Huneiti, ha fatto sapere che ad Hamzah è stato intimato di
astenersi da spostamenti e da altre attività che potrebbero essere sfruttate per
destabilizzare il regno hashemita. Amman ha negato ufficialmente gli arresti
domiciliari di Hamzah. Gli altri venti dignitari sono stati motivati per ragioni
“di sicurezza”. Hamzah, ex principe ereditario, è stato privato del titolo nel
2004. È figlio di re Hussein e di Noor, quarta moglie di origini americane. È
cresciuto con dodici tra fratelli e fratellastri. Il suo titolo è stato
conferito a Hussein, primogenito di Abdallah II e della regina Rania. Ha
denunciato che il suo telefono e internet gli sono stati interrotti. La
dichiarazione alla Bbc sarebbe arrivata attraverso l’avvocato. L’intrigo di
palazzo o il presunto tale è quindi al momento ancora un enigma. Il palazzo di
Abdallah II è protetto da mezzi blindati e militari. La Giordania è un Paese
fondamentale per la nuova amministrazione americana del presidente Joe Biden. Un
Paese fondamentale negli equilibri della Regione. Sulla monarchia preme la crisi
economica, peggiorata dalla pandemia da coronavirus, e le pressioni affinché il
re riveda l’accordo di pace firmato con Israele ventisette anni fa.
Lo scontro tra il re
Abdallah II e il principe Hamzah bin Hussein.
Giordania, il golpe fallito e lo zio a fare da
mediatore nella sfida tra fratellastri. Redazione su Il Riformista il 5 aprile
2021. La pace, almeno apparante, dopo il tentativo di golpe avvenuto
in Giordania. Il principe Hamzah bin Hussein ha promesso di “restare fedele”
al re Abdallah II, suo fratellastro. “Resterò fedele all’eredità dei miei
antenati, a Sua Maestà (il re) e al suo principe ereditario e mi metterò a loro
disposizione”, ha scritto il principe in una lettera, secondo una nota di
palazzo reale. Dal canto suo, il re di Giordania ha deciso di risolvere i
dissidi con il fratellastro ed ex principe ereditario Hamzah all’interno della
famiglia e ha affidato il compito di mediare a suo zio, il principe Hassan. Lo
ha annunciato la Corte reale, secondo quanto riportano i media locali. “Alla
luce della decisione del re Abdullah II di affrontare la questione del principe
Hamzah nell’ambito della famiglia hashemita, sua Maestà ha affidato il compito a
suo zio, il principe Al Hassan”, ha detto la Corte in un comunicato pubblicato
su Twitter. La tensione in Giordania è salita alle stelle dopo l’arresto di
almeno 16 persone, tra cui il principe Hamzah, accusate di aver cospirato per
destabilizzare il Paese insieme al principe Hamzah bin Hussein, fratellastro del
re Abdallah II. Lo stesso principe è intervenuto nelle scorse ore affermando di
aver ricevuto dall’esercito “ordini inaccettabili” a cui non obbedirà. “Il capo
di stato maggiore dell’esercito è venuto da me e ha lanciato minacce a nome dei
capi delle agenzie di sicurezza”, ha detto Hamzah in una registrazione circolata
online, “Ho registrato i suoi commenti e li ho inviati ai miei conoscenti
all’estero e alla mia famiglia nel caso in cui accadesse qualcosa”. “Non voglio
un’escalation ora”, ha poi assicurato il fratellastro del re ma, ha aggiunto,
“ovviamente non mi atterrò” agli ordini di “non uscire, twittare o entrare in
contatto con le persone”. “E’ inaccettabile che un capo di stato maggiore
dell’esercito dica questo”, ha aggiunto. Le autorità giordane hanno riferito
domenica di aver sventato un “complotto” di Hamzah per destabilizzare il regno
con il sostegno straniero. Il principe ha negato di aver preso parte a qualsiasi
cospirazione e ha affermato di essere stato preso di mira per essersi espresso
contro la corruzione e il malgoverno. Il ministro degli Esteri giordano Ayman
Safadi ha riferito che nell’ambito dell’operazione sono stati arrestati dai 14
ai 16 associati di Hamzah, oltre a Bassem Awadallah, ex ministro di gabinetto e
un tempo capo della corte reale, e Sharif Hassan bin Zaid, un membro della
famiglia reale. Il capo della diplomazia non ha però fornito ulteriori dettagli
sul presunto complotto. Abdullah e Hamzah sono entrambi figli del defunto re
Hussein, che, a due decenni dalla morte, resta una figura amata nel Paese. Dopo
essere salito al trono nel 1999, Abdullah ha nominato Hamzah principe
ereditario, ma gli ha poi revocato il titolo cinque anni dopo. In this Monday,
April 2, 2001 file photo, Jordan’s King Abdullah II laughs with his brother
Prince Hamzah, right, shortly before the Jordanian monarch embarked on a tour of
the United States. Prince Hamza said he has been placed under house arrest. in a
videotaped statement late Saturday, April 3, 2021. Il rapporto tra i due è stato
descritto generalmente come buono ma Hamzah a volte si è espresso contro le
politiche del governo e più recentemente ha stretto legami con potenti leader
tribali, una mossa che è stata avvertita come una minaccia per il re. Le potenze
occidentali e i Paesi arabi si sono schierati tutti al fianco di Abdallah, il
che riflette l’importanza strategica del Paese nella regione. L’appoggio al re è
arrivato da Usa, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirati Arabi
Uniti, Israele e anche dall’Unione europea. “L’Ue sostiene pienamente il re
Abdallah II e il suo ruolo di moderatore nella regione”, ha scritto su Twitter
Nabila Massrali, portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas). La
stabilità di Amman è da tempo sotto osservazione nella regione, soprattutto da
quando l’amministrazione Trump si è schierata con forza con Israele, mettendo
all’angolo i palestinesi, molti dei quali sono ospitati dalla Giordania che è
custode dei luoghi sacri a Gerusalemme. Dopo la pace del 1994, tra Israele e
Giordania in anni recenti ci sono stati momenti di tensione, proprio in
relazione alla questione palestinese.
Barak Ravid per axios.com il 5
aprile 2021. Un uomo d'affari israeliano ha contattato l'ex principe ereditario
giordano Hamzah bin Hussein sabato e ha proposto di inviare un jet privato per
portare la moglie e i figli in Europa. L'intrigo: Il governo giordano sostiene
che l’israeliano abbia legami con l'agenzia di spionaggio del Mossad, mentre
l'uomo d'affari sottolinea di essere solo un amico del principe. Perché è
importante: Il governo giordano sostiene che il principe Hamzah e i suoi
associati abbiano cospirato contro il re Abdullah insieme ad alcune persone
straniere. I presunti collegamenti con Israele e il Mossad sono molto efficadi
dal punto di vista comunicativo per la campagna del governo giordano contro il
principe Hamzah, visto che l’opinione pubblica giordana non vede di buon occhio
lo stato ebraico. Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha detto in una
conferenza stampa domenica che una persona con collegamenti con un servizio di
sicurezza straniero ha avvicinato la moglie del principe Hamzah e si è offerta
di organizzare un jet privato per scortare lei e la sua famiglia in un paese
straniero. Diverse ore più tardi l'agenzia di stampa giordana "Ammon", vicina ai
servizi di sicurezza giordani, ha pubblicato il nome di un presunto ex ufficiale
del Mossad, Roy Shaposhnik. Shaposhnik mi ha contattato e ha rilasciato una
dichiarazione che nega quanto affermato dal governo giordano sul suo
coinvolgimento nel presunto colpo di stato. Mi ha detto di non essere mai stato
un ufficiale del Mossad, ma ha confermato di aver proposto assistenza al
principe Hamza e alla sua famiglia come parte della loro amicizia. Cosa dice
Shaposhnik: "Sono un israeliano che vive in Europa. Non ho mai lavorato nei
servizi segreti israeliani. Non ho alcuna conoscenza degli eventi che hanno
avuto luogo in Giordania o delle persone coinvolte. Sono uno stretto amico
personale del principe Hamzah". Ha aggiunto che voleva solo aiutare la moglie
del principe e i loro figli in questo momento difficile. Tra le
righe: Shaposhnik, 41 anni, 15 anni fa faceva parte del partito centrista Kadima
in Israele, ed è stato consigliere dell'allora primo ministro Ehud Olmert. Più
tardi è passato al settore privato e ha lavorato per una società di sicurezza,
che fa capo all’uomo d’affari americano Erik Prince. Dopo diversi anni ha
fondato la propria azienda, RS Logistical Solutions, che lavora con il
Dipartimento di Stato americano e altri governi in tutto il mondo. La società di
Shaposhnik ha anche fornito servizi logistici alla società di Prince mentre
addestrava i soldati iracheni in Giordania. Fu allora che incontrò il principe
Hamzah attraverso un amico comune. I due e le loro famiglie divennero amici
intimi. Una fonte che ha familiarità con la questione mi ha detto che Shaposhnik
ha inviato subito un messaggio di testo alla moglie del principe Hamzah e ha
proposto di inviare un jet a prendere lei e i loro figli fino a quando la
situazione non si sarà chiarita.
Da allora, Shaposhnik non ha
avuto alcun contatto con il principe Hamzah e la sua famiglia, che sono agli
arresti domiciliari e senza possibilità di comunicare con il mondo esterno, ha
detto la fonte.
·
Quei
razzisti come gli israeliani.
Davide Frattini per il "Corriere della Sera" il 23
dicembre 2021. I capelli sempre impomatati, il sorriso lucido quanto quel ciuffo
pettinato all'indietro. Gli israeliani hanno imparato negli ultimi cinque anni a
conoscere il volto e gli atteggiamenti di questa ex spia che di anni ne ha
compiuti 60 a settembre. Dei predecessori sapevano a mala pena il nome e fino al
1996 neppure quello, il capo dell'Istituto veniva identificato con l'iniziale. A
Yossi Cohen una semplice Y non sarebbe bastata. Anche prima di concludere il
mandato da direttore del Mossad ha voluto costruirsi un profilo pubblico,
riflettori accesi sull'ombra in cui l'organizzazione incaricata delle operazioni
esterne cerca sempre di muoversi.
Quando nel 2018 Benjamin Netanyahu - allora primo
ministro, ha considerato Cohen un possibile successore alla guida della destra -
annuncia che gli agenti segreti sono riusciti a recuperare i dossier del
programma nucleare iraniano, ai reporter arriva la conferma da fonti anonime che
il blitz dentro a Teheran sia stato pilotato in diretta da Cohen stesso (la
fonte anonima secondo tutti).
Ormai in pensione (dallo scorso giugno) è sempre
lui a divulgare altri dettagli su quel raid durante un'intervista televisiva: la
squadra - dice - era composta da 007 che parlavano diverse lingue straniere;
l'archivio era nascosto in una zona industriale e a un certo punto le guardie e
gli operai iraniani hanno cominciato ad arrivare mentre gli operativi stavano
scassinando («non è che puoi saltare dall'altra parte del muro e scappare»).
Sceglie un paragone hollywoodiano: «Lo stile è
alla Ocean's Eleven con George Clooney, fiamma ossidrica per aprire la
cassaforte». Avrebbe spiattellato ancora di più a quella che il programma
investigativo del Canale 13 sostiene essere stata la sua amante, una relazione
iniziata nel 2018 quando Cohen era il boss delle spie israeliane.
I due si sarebbero conosciuti sull'aereo dove la
donna lavorava come assistente di volo e di altri viaggi in giro per il mondo -
che però avrebbero dovuto rimanere clandestini - Yossi si sarebbe vantato con
lei e con il marito. Che ha deciso di rivelare la vicenda al giornalista Raviv
Drucker in una lunga confessione trasmessa l'altra sera.
Ha spiegato di aver conosciuto Cohen attraverso la
moglie, di averci cenato. «È un chiacchierone - dice Guy Shiker, noto
nell'ambiente finanziario - e una volta ha raccontato che il Mossad controllava
il medico personale di un leader arabo. Oppure di come avesse dovuto travestirsi
da guida turistica per una missione. Si vantava del suo stile manageriale, che
diventato direttore aveva cacciato sei capi divisione perché non gli erano
leali».
Shiker ha scritto sulla sua pagina Facebook di
essere andato in tv per proteggere i due figli (Cohen ne ha quattro): «Il prezzo
del silenzio è sempre più caro». L'ex 007 smentisce e la donna ha cercato di
fermare la messa in onda attraverso un intervento del giudice: i suoi avvocati
negano «la relazione con Cohen o che lui abbia parlato di azioni segrete alla
coppia». Sostengono «che il matrimonio non è finito a causa di Cohen come
dichiarato da Shiker, la nostra cliente aveva presentato la domanda di divorzio
già nel 2016». L'inchiesta di Drucker rivela anche che Cohen avrebbe sfruttato
la posizione al Mossad per raccogliere informazioni sul marito e che lo stesso
Shiker lo avrebbe sollecitato ad assumere la sua assistente personale offrendole
un posto nella stazione dell'agenzia a Bangkok. La richiesta sarebbe stata
accolta.
Israele, sei
ong "umanitarie" sotto indagine per terrorismo.
Fiamma Nirenstein
il 25 Ottobre 2021 su Il Giornale. Le organizzazioni, finanziate da Onu e Ue,
sono il volto presentabile del Fronte popolare di liberazione palestinese. La
disputa in atto dovrebbe far tremare tutto il mondo: tu chiamalo terrorismo, io
lo chiamo organizzazione per i diritti umani, e lo finanzio coi nostri soldi. Il
ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha collocato sei fra le maggiori
organizzazioni non governative palestinesi nella lista delle organizzazioni
terroriste. Questo significa che i loro traffici bancari e i movimenti dei loro
leader e affiliati sono adesso sotto controllo. Le informazioni: molto accurate.
L'accusa è servire da mano pubblica all'organizzazione terrorista Fronte
popolare per la liberazione della Palestina, Fplp, fornendole un'identità
ibrida, e rastrellare così consenso e denaro dall'Onu e dall'Unione europea.
Questi soldi alimentano, secondo Gantz, il fiume di sangue; le organizzazioni
accusano Israele di persecuzione e rivendicano un ruolo caritativo. Certo, anche
gli Hezbollah, Hamas, i talebani si prendono cura di bambini, vedove, vecchi.
Così sorride il professor Gerald Steinberg, che con costanza ha indagato il tema
col suo Ngo Monitor. Sul sito troviamo tutti i particolari: «Dieci anni fa
presentammo i risultati all'Unione europea, la Mogherini ci disse che le prove
non bastavano». E oggi il Dipartimento di Stato Americano, protesta di non
essere stato informato. Israele nega l'accusa. Le organizzazione nella lista
terrorista sono: Adameer, Al Haq, Bisan, Difesa dei bambini-Palestina (Dci-P)
Unione delle donne (Upwc); Unione degli Agricoltori (Uawc). Il punto di partenza
è l'Fplp, un vulcano di attività terrorista, che ha ucciso il ministro
israeliano Rehavam Ze'evi nel 2001, ha compiuto sei attacchi suicidi
nell'Intifada con 13 vittime, tre al mercato a Gerusalemme; ha tentato di
uccidere il rabbino capo Ovadya Yossef; ha ucciso a colpi d'ascia cinque persone
alla sinagoga Har Nof nel 2014. Terribile anche l'assassinio della 17enne Rina
Shnerb nell'agosto del 2019, in cui il padre e il fraatello vennero feriti. Gli
assassini sono parte dell'organizzazione degli agricoltori, finanziata dall'UE.
L'Fplp, paleomarxista, radicata a Ramallah, in competizione con Fatah che non
osa metterla ai margini, è stata, come spiega bene Steinberg, capace di mettere
in piedi, priva dei finanziamenti di Abu Mazen, una rete autonoma di
organizzazioni non governative che l'alimenta autolegittimandosi. Così che i
documenti provano, dice Steinberg, con le foto, che i diplomatici in visita dei
vari Paesi, di fatto si incontrano con leader del Fplp. Un paradosso per cui
negli ultimi dieci anni gli sono stati dati dall'Europa circa 200 milioni euro
del contribuente, sostiene Steinberg. Il direttore amministrativo degli
«agricoltori» è stato arrestato, e così anche il contabile, per bombe,
attentati, reclutamento di terroristi. Hashem Abu Maria, il leader
dell'organizzazione per i bambini, è morto in uno scontro a fuoco con
l'esercito, il presidente dell'asseblea dei soci è stato direttore della rivista
dell'Fpl. Questa organizzazione è finanziata anche direttamente dall'Italia. Le
leader dell'Unione femminile sono quasi tutte membri dei comitato centrale e del
direttivo dell'Fplp; il Centro palestinese per i diritti umani, già nella lista,
ha un vicepresidente che è stato capo dell'ala militare dell'Fplp di Gaza,
condannato all'ergastolo: Al Haq ha un direttore, Shawan Jabarin, che fu
accusato di reclutare e organizzare il training dei membri del Fplp. L'Italia
finanzia direttamente anche al Haq. La lista è lunga, ma parla chiaro:
ammantarsi di diritti umani è un'abitudine consolidata per chi vuole distruggere
Israele, e il cinismo della politica internazionale fa finta di non capire,
anzi, aiuta questo sistema. Per cui il diritto va in polvere, la vittima diventa
persecutore, il terrorista che ignora ogni principio democratico diventa il
protagonista dell'era delle organizzazioni non governative.Fiamma Nirenstein
(ANSA il 18 settembre 2021) -
E' stato un robot killer capace di sparare 600 colpi al minuto e operato da
remoto via satellite dagli israeliani ad uccidere lo scorso novembre lo
scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh alla periferia di Teheran. Lo scrive il
New York Times rivelando i retroscena dell'operazione, in parte già trapelati
all'indomani dell'attacco. Il robot è come un tiratore scelto ad alta
tecnologia, equipaggiato con intelligenza artificiale e occhi a più telecamere.
Una macchina da guerra che va ad arricchire l'arsenale delle armi ad alta
tecnologia per eliminare target remoti. Col vantaggio che, a differenza di un
drone, non attira l'attenzione nel cielo e può essere collocato ovunque:
caratteristiche, sottolinea il Nyt, che probabilmente cambieranno il mondo della
sicurezza e dello spionaggio.
Da open.online il 10 ottobre 2021. Enrico Michetti
torna sulle polemiche scoppiate ieri per un suo vecchio articolo sulla Shoah.
«Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione
razziale, anche in tempi non sospetti, ed in primis quella rappresentata dalla
Shoah, mi rendo conto che in quell’articolo ho utilizzato con imperdonabile
leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici pregiudizi e ignobili
luoghi comuni nei confronti del popolo ebraico», ha dichiarato il candidato
sindaco di Roma. «Per questo mi scuso sinceramente per aver ferito i sentimenti
della comunità ebraica, che come tutti gli italiani apprezzo e ritengo parte
perfettamente ed orgogliosamente integrata della città di Roma da sempre e nel
Paese tutto». Nell’articolo finito al centro delle polemiche, Michetti scriveva:
«Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria,
iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E
sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la
stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei
campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse
perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i
destini del pianeta».
The Believer (film).
Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. The Believer è un film del 2001, diretto da Henry Bean e
scritto con la collaborazione di Mark Jacobson. Tratta da un'opera teatrale
scritta dallo stesso Bean, la pellicola narra fatti biografici e vicende
personali ispirati alla vita di Daniel Burros, membro attivo dell'American Nazi
Party, antisemita convinto seppure sia stato circonciso e cresciuto secondo le
tradizioni ebraiche della famiglia.
Trama. The Believer è la
storia di Daniel Balint, un giovane skinhead neonazista di periferia. Fin
dall'inizio mostra il suo sentimento riguardo al concetto di razza: sceso da un
bus insieme a un ebreo aspetta di avvicinarlo in una strada isolata per colpirlo
con calci e pugni. La sera stessa partecipa a un raduno di militanti nazisti,
che sembrano voler parlare della sola politica e del concetto di nazione e
identità: infatti, non appena Daniel si intromette parlando delle leggi razziali
naziste e dell'idea di razza pura, nessuno gli dà credito, ma riuscirà comunque
ad aprire un lungo discorso che colpirà il capo della riunione, Curtis Zampf.
Facendosi strada nel mondo del neofascismo e del neonazismo si convince di
uccidere Ilior Manzetti, un ebreo bulgaro direttore di una banca d'investimento.
Per fare ciò occorre tempo e denaro, e di questo si occupa Curtis, il quale
comunque mostra timore nel farsi avanti politicamente con un omicidio. Dopo
essere uscito dalla casa di Curtis, Danny si ritrova con alcuni suoi amici
neonazisti e con loro fa a botte contro tre neri che li avevano importunati in
una strada di New York. Entrambe le parti vengono incarcerate, ma Danny e i suoi
amici vengono liberati sotto cauzione pagata da Carla, un'amica di Curtis. Per
tutto il film è ricorrente una scena d'infanzia di Daniel: ancora piccolo in una
classe di una scuola ebraica, comincia una lunga conversazione con il professore
di religione su Abramo, sul peccato originale e sui problemi dell'ebraismo e del
"popolo eletto", fino a quando scappa di classe correndo per le scale scendendo
i piani. Daniel viene contattato da un giornalista del New York Times - che si
era in precedenza inserito sotto mentite spoglie nel circolo dei seguaci di
Curtis - e una mattina lo incontra in un ristorante. Con lui apre un lungo
discorso sul sionismo, gli ebrei e la sessualità, un possibile complotto
ebraico (dal controllo dei media, alla finanza), ma durante l'intervista il
giornalista fa capire di essere molto arguto dal momento che, informandosi sul
passato di Danny, è venuto a scoprire che da piccolo è stato istruito in una
scuola ebraica arrivando a celebrare il bar mitzvah. La cosa fa innervosire
Danny a tal punto che tira fuori una pistola minacciando il giornalista di
uccidersi se avesse pubblicato l'articolo sul quotidiano. Su invito di Curtis,
Daniel, insieme al suo amico Billings, si reca presso un campo di skin
neonazisti per adempiere a ciò che ha promesso, cioè uccidere Manzetti, e nel
frattempo imparare il più possibile del nazismo e del problema ebraico. Ma è
proprio durante questo periodo di addestramento che la banda di neonazisti viene
portata in tribunale da due ristoratori ebrei che sono stati da loro picchiati.
Il giudice dà ai ragazzi due possibilità: passare un mese in carcere o
partecipare a una seduta con sopravvissuti all'Olocausto. Durante la seduta, i
ragazzi scherniscono e insultano i partecipanti all'incontro. Uno dei presenti
ricorda un episodio di crudeltà che ha vissuto durante la guerra: suo figlio, a
soli tre anni, è stato ucciso da un soldato tedesco sotto i suoi occhi. Daniel è
disgustato dal fatto che il sopravvissuto non avesse avuto la forza di reagire
e, quando gli anziani presenti gli rispondono che lui stesso non si sarebbe
comportato diversamente, decide di lasciare l'incontro: l'episodio diventerà un
pensiero ricorrente per il protagonista, che immagina di riviverlo dapprima nel
ruolo del soldato e successivamente nel ruolo dell'ebreo, in un futile tentativo
di resistenza. Daniel, insieme ai nuovi amici, organizza un attentato
dinamitardo nella sinagoga principale della città piazzando una bomba sotto il
pulpito, programmandola per l'esplosione alcuni giorni dopo la celebrazione
religiosa. Tuttavia la bomba non esplode, probabilmente a causa di un difetto
nell'alimentazione del detonatore. Danny, nel frattempo, si muove per fare un
passo avanti e viene coinvolto da Drake nel tentato omicidio di Manzetti.
Appostati fra i cespugli di notte, Drake e Daniel attendono che Manzetti esca da
un edificio dove ha tenuto una conferenza: Daniel mira, spara ma sbaglia, forse
di proposito. Ciò fa infuriare Drake che crede che lo abbia fatto apposta e si
rende conto che il suo camerata in realtà è ebreo, cosa che sospettava da tempo:
ne nasce una lite durante la quale Daniel spara a Drake prima che lui faccia
altrettanto e scappa via convinto che Drake sia morto. Curtis apre
un'associazione fascista alla luce del sole e incarica Danny di farsi carico
della raccolta fondi. Le prime conferenze di Daniel sembrano un successo ma dato
che, oltre ai militanti, servono anche i soldi per la retta e l'affitto, Daniel
si muove anche in questa direzione. Durante un colloquio con un bancario circa
la donazione di quest'ultimo nasce un diverbio durante il quale Daniel accusa il
potenziale finanziatore di essere un ebreo. La vita di Daniel si fa sempre più
complicata, stretta tra l'antisemitismo e la sua riscoperta della religione
ebraica, che avviene a seguito dell'incontro con ex compagni di scuola, ormai
adulti, che frequentano la sinagoga. Anche Carla, la ragazza di cui Daniel si è
invaghito, si appassiona allo studio dell'ebraico e dell'ebraismo,
apparentemente al fine di conoscere il nemico. A tal proposito, resasi conto che
Daniel legge e parla l'ebraico, si fa insegnare questa lingua e insieme leggono
passi della Torah; addirittura Carla arriva a partecipare a incontri in
sinagoga. I due hanno anche una discussione su come il Dio degli ebrei sia
essenzialmente indefinibile e distante dagli uomini. Daniel sembra ritrovare
l'identità ebraica persa, ma, mentre partecipa a una preghiera insieme a dei
vecchi amici, litiga con un vecchio compagno di scuola, Avi, circa il sionismo e
il nazismo, che Danny pone sullo stesso livello, ovvero ideologie razziste. Su
queste parole scatta la rissa con Avi e Daniel viene accompagnato fuori
dall'edificio. La sera stessa, Daniel tiene un discorso con personalità
importanti impegnate nel neofascismo a New York su invito di Curtis ma, durante
il discorso, invita i presenti ad amare gli ebrei in quanto ritiene che questo
sia l'unico modo per distruggere un popolo che con l'odio si rafforza. Il
messaggio non viene colto e quando Daniel inizia a cantare una preghiera in
ebraico viene allontanato dalla moglie di Curtis, infuriata per l'atteggiamento
tenuto da Danny. Tuttavia Daniel, ancora preso dal proposito di uccidere un
ebreo, mette una bomba nella sinagoga, proprio sotto il pulpito e la programma
per le 19:30 del giorno seguente, orario in cui si svolgerà la funzione del Yom
Kippur. La mattina del giorno dell'esplosione, al telegiornale viene data la
notizia dell'omicidio di Manzetti: anche se tutti credono sia stato Daniel, in
verità il responsabile è Drake, fortunosamente sopravvissuto al colpo di fucile.
La sera del fatidico attentato il protagonista viene colpito dal rimorso,
soprattutto perché alla preghiera vi sono alcuni suoi amici cari: di
conseguenza, dopo essersi sostituito al lettore ufficiale dell'orazione, avverte
tutti di fuggire il prima possibile dalla sinagoga. Solo lui rimane all'interno
aspettando l'esplosione per liberarsi di quella vita oramai diventata un
tormento. Prima di morire ha nuovamente la visione ricorrente di lui alla scuola
ebraica: questa volta però Daniel si vede adulto. Il professore desidera
continuare il discorso su Isacco che, dice, potrebbe essere morto e risorto nel
nuovo mondo. Simbolicamente, Danny lo ignora e continua testardamente a salire
le scale, trovando solo infinite altre scale, altri pianerottoli e lo stesso
insegnante che lo invita a desistere poiché "non c'è niente lassù".
Film The Believer: frasi
Danny Balint (Ryan Gosling):
"Prendi le più grandi menti
ebree: Marx, Freud, Einstein. Che cosa ci hanno dato? Il comunismo, la
sessualità infantile e la bomba atomica!"
"Il nulla senza fine..."
"Danny, dove stai andando? Lo
sai che non c'è niente lassù!"
The Believer, il coraggio
delle riflessioni scomode.
Di Riccardo Rosati su Ereticamente il 21 luglio 2015. I
“Protocolli dei Savi di Sion”, apparsi all’inizio del secolo scorso, sono stati
oggetto di vari studi e critiche, e sono ormai chiaramente giudicati un falso in
chiave antisemita, redatto dalla polizia segreta russa tra il 1903 e il 1905.
Ciò malgrado, il punto non è questo, ovvero quello della non autenticità di tali
scritti, ma è un altro: benché falsi, alcune delle teorie in essi contenute sono
da considerarsi plausibili? Per giunta, esse si sono poi attuate nel tempo e
hanno una qualche logica di base nello scenario politico internazionale?
Piuttosto che subire sempre la “fobia antisemita”, la quale impedisce oggi di
criticare qualsiasi ebreo che possa addirittura aver commesso dei reati, senza
venir immancabilmente bollati come “antisemiti” – pensiamo all’entourage di
Dominique Strauss-Kahn che ha accusato il film di Abel Ferrara “Welcome to New
York” (2004), ispirato alle note vicende dell’uomo d’affari francese di
religione ebraica, di essere antisemita – dovremmo ragionare su alcune evidenti
influenze della finanza e intellighenzia ebraiche sul mondo occidentale. Ci
sarebbe poi la necessità di fare dei distinguo tra “antisemitismo” e
“antisionismo”, che non sono affatto la stessa cosa. Per far ciò, ci vorrebbe
ben più spazio di quello messo a nostra disposizione. Purtuttavia, anni fa uscì
in America un film che con immenso coraggio ebbe modo di raccontare una storia
realmente accaduta e che dovrebbe farci riconsiderare la melassa buonista in cui
siamo impantanati da anni e che ha fatto degli ebrei una comunità praticamente
di intoccabili. La storia di cui andremo a parlare è realmente accaduta e,
proprio in virtù di ciò, ci permettere di “parlare”, senza essere messi subito a
tacere, poiché determinati membri delle nostre società non si possono più
nemmeno criticare. “The Believer”(2001) è un film diretto da Henry Bean e
scritto con la collaborazione di Mark Jacobson. La pellicola narra i fatti
biografici di Daniel Burros (1937 – 1965), membro attivo dell’American Nazi
Party, antisemita di primo piano nel suo Paese. Due fatti in questa storia
lasciano davvero senza parole: 1) Non si tratta dello sfogo razzista di qualche
folle sceneggiatore, bensì di una storia vera. 2) Il protagonista – Danny è
stupendamente interpretato da Ryan Gosling – è un nazista ebreo. “Il mondo
moderno è una invenzione ebraica”, questa è in sintesi la essenza del pensiero
di Danny. Certo, il tutto sa molto di complottismo mondiale, lo stesso che
spinse alla creazione dei sopracitati “Protocolli dei Savi di Sion”.
Ciononostante, la storia raccontata nel film di Bean non si perde affatto nel
più becero antisemitismo, anzi, ogni concetto viene affrontato in modo talmente
profondo, anticonvenzionale, che durante la visione della pellicola si resta in
più occasioni interdetti, con un tarlo che monta nella forma della seguente
domanda: “Forse ci hanno mentito su molte cose?”. Sia ben chiaro che le
riflessioni di Danny non si esauriscono in un insopportabile negazionismo sulla
Shoah! Esse intaccano invece efficacemente dei precetti culturali che sono ormai
Legge! “Perché così tanti ebrei comunisti?”. Ecco una altra domanda che esce
prepotentemente fuori nel film. Non possiamo certo negare questo dato, come il
fatto che poi il marxismo sia penetrato nei gangli della società occidentale,
alterandone almeno in parte l’identità. Quello che Danny contesta, e la fa con
un eloquio raffinato, mai volgare, è la “cultura del pianto” che ha permesso a
una minoranza, come quella ebraica, di ottenere un potere sovente superiore a
quello della stessa maggioranza. Economia, stampa, università, difficile
contestare come la influenza di molte figure di spicco in questi campi e, di
conseguenza, sulla vita e il modo di pensare occidentali siano state e sono
tutt’ora degli ebrei. Strano no? O vogliamo forse credere alla baggianata che
gli ebrei sono più intelligenti? Sarebbe razzismo al contrario. Non ci risulta
che Bernini o Pirandello fossero di confessione giudaica. Il personaggio di
Danny è davvero “malevolmente” seducente, esercitando una attrattiva tipica di
quelle intelligenze scomode, le quali hanno il brutto vizio di dire quelle
verità che nessuno vuole sentire. Egli sa bene di cosa parla, avendo frequentato
da bambino una scuola ebraica, dove però litigava con i suoi insegnanti, poiché
si permetteva di mettere in discussione i dogmi della Fede, che nell’Ebraismo
sono ben più consolidati che nel Cristianesimo di oggi. Egli si mostra
palesemente come una persona erudita, che ama leggere, quanto fare a pugni. Il
suo spessore intellettuale si nota, ad esempio, in una delle scene iniziali,
quando presenzia a un incontro politico in un salotto di destra. Qui, ha un
fitto scambio di vedute con Curtis, il quale ha una visione assai meno
estremista della sua. La loro sofisticata polemica permette inoltre di mettere
in evidenza le chiare differenze ideologiche tra una interpretazione fascista e
una nazista della società. Colpisce la lucida, quanto fredda, capacità di
analisi politica del protagonista, che lo spinge a dire frasi del tipo: “La
Germania una altra volta, ma fatto per bene”. Sempre in questa scena, Curtis,
che nella trama gioca talvolta la parte dell’antagonista politico di Danny,
sottolinea un concetto di grande importanza, definendo quello che lui chiama:
“Errore americano”, riferito alla ostilità mostrata verso il fascismo dalla
società statunitense dal Secondo Dopoguerra in poi. Trattasi di una assoluta
verità, anzi potremmo persino spingerci oltre, sostenendo come la cultura
ufficiale americana, nelle università, nei libri e nei film, abbia persino
manipolato il concetto stesso di fascismo, descrivendolo come la origine di ogni
sistema totalitario, negandone qualsiasi lato positivo, e proponendone una
lettura talmente artefatta da farlo diventare col tempo sinonimo di “nazismo”;
quando basta avere una discreta e onesta conoscenza dei fatti per sapere che vi
erano enormi differenze tra i due regimi. Strano è comunque che in tutta la
storia non venga mai pronunciato il nome di Mussolini. L’espressione “ebreo che
odia se stesso” è usata per indicare una persona di religione ebraica che nutre
pensieri antisemiti. Essa è apparsa per la prima volta nel libro “Der Jüdische
Selbsthass” (“L’odio di sé ebraico”, 1930) del filosofo tedesco ed ebreo Theodor
Lessing. Solitamente questa scottante e assai poco nota tematica è legata alla
critica al sionismo, la quale ha avuto dei sostenitori persino all’interno della
stessa comunità ebraica internazionale. Va de sé, che si è sempre trattato di
una minoranza intellettuale, ma è una realtà che va in ogni modo conosciuta,
studiata e compresa: cosa spinge un ebreo a considerare la propria cultura come
nociva per il mondo? Ci vorrebbero vari dottissimi libri, e non certo un
semplice articolo, per cercare di abbozzare almeno una risposta a un quesito
tanto complesso e scomodo. Una cosa però la possiamo dire, ovvero che la storia
raccontata in “The Believer” può senz’altro fornire un valido aiuto per cercare
le risposte a un problema che sembra quasi paradossale, ma che se poi ci si
addentra nella questione, proprio così folle non è: Daniel Burros è esistito
veramente, aveva idee politiche ben precise e, alla fine, non potendo in alcun
modo conciliarle con la sua origine ebraica si è tolto la vita, come del resto
fa anche il protagonista del film. “The Believer” potrebbe ricordare un altro
ottimo titolo, forse però non così riuscito come quello di Bean. Ci riferiamo a
“American History X” (1998) di Tony Kaye. Siamo sempre in quella America
degradata dove cova una destra nazista che si nutre del disagio sociale dei
bianchi più poveri. Tuttavia, il protagonista Derek (Edward Norton) se la prende
principalmente con i neri e non è certo intellettualmente paragonabile a Danny,
giacché quest’ultimo è veramente una “mente autodidatta” e decisamente più colto
di Derek. Per non parlare poi del finale, assai più lieto che in “The Believer”,
ma non avrebbe potuto essere differentemente, visto che il conflitto insanabile
tra fede e politica in Danny poteva solo che risolversi col suo totale
annientamento. Il film di cui abbiamo parlato, e del quale consigliamo
spassionatamente la visione a quelle persone che nutrono un necessario dubbio,
in una società dove la menzogna è la unica regola, è politicamente notevole;
forse uno dei migliori di sempre da questo punto di vista. Trattasi di una
storia che riecheggia involontariamente “Il mito del sangue” (1942) di Julius
Evola, con tutte le scomodissime argomentazioni sulla razza che ne conseguono.
Come quello del grande filosofo italiano, il ragionamento che presenta questa
pellicola non è fazioso, bensì coraggioso! Una qualità, il coraggio, assai rara
di questi tempi. Lo scrittore americano Ray Bradbury ebbe modo di dichiarare in
una intervista a Herman Harvey del 1962: “I giornali sono il boccone di
traverso della nostra epoca”;
parole degne di una grande penna come era lui. Proprio alla stregua delle sue
spesso impopolari dichiarazioni a giornali e quotidiani (pubblicate di recente:
Ray Bradbury, “Siamo noi i marziani. Interviste [1948-2010)]”, a cura di
Gianfranco de Turris e Tania Di Bernardo, Bietti, 2014), “The Believer” è un
film che spinge, anzi, potremmo dire persino impone una riflessione, politica,
ma anche teologica, adempiendo a una delle due funzioni principali della Settima
Arte: da una parte intrattenere, dall’altra far pensare. Daniel Burros è stato
un uomo in carne ed ossa, un attivista politico di un certo peso. Ragion per
cui, i soliti benpensanti del progresso non se la possono cavare, liquidando il
tutto con la, ormai, solita incontrastabile parola: “razzismo”. Noi ci offriamo,
da intellettuali e studiosi di cinema, di sostenere il peso pure delle
riflessioni più scomode: cosa spinge un ebreo a odiare se stesso? Se all’ascolto
c’è ancora qualche – come diceva Italo Calvino – Uomo di Coscienza, allora
magari si potrà condividere questo peso assieme. Pubblicato
da Ereticamente il 21 Luglio 2015
The Believer, il più bel
film sull’antisemitismo, fra polemica e profondità.
Roberto Zadik su
mosaico-cem.it il 26 Gennaio 2016. In questo periodo di Giornata della Memoria,
di riflussi tremendi di antisemitismo, di antisionismo e di aggressività di
vario tipo, mi sembrava doveroso ripescare in questo mio blog un bel film come
“The believer”. Uscito 15 anni fa sugli schermi italiani, chiacchieratissimo e
criticato negli Usa e qui cestinato nel dimenticatoio dopo il solito “botto”
iniziale, questa pellicola è davvero originale per tanti motivi e malgrado sia
uscita diversi anni fa, ero un baldo giovane di 25 anni quando l’ho visto,
merita di essere riesumato dal solaio. In questo mio blog dedicato a cinema,
musica e cultura del mondo ebraico contemporaneo non parlo solo di film nuovi ma
mi piace ogni tanto ripescare prodotti notevoli anche se di un po’ di tempo fa.
Per quale motivo “The Believer è un film importante? Innanzitutto perché ha
lanciato il bravissimo attore mormone canadese Ryan Gosling, (trucido e
affascinante Scorpione ascendente Pesci, 35 anni, esploso anni dopo con lenta e
scivolosa scalata e ora famoso per film come “Drive” e “La grande scommessa” di
recentissima produzione. Poi perché questa pellicola americana, che nel cast
oltre allo straordinario Gosling vede altri due solidi attori come Billy Zane,
sconosciutissima star del film “Titanic” e Theresa Russell, non parla al
passato, con storie di Shoah, di ricordi, di anni ’30 e ’40, ma
dell’antisemitismo oggi attraverso la crisi esistenziale e identitaria
profondissima del protagonista ebreo Daniel Balint che diventa uno spietato e
sarcastico naziskin influenzato dai suoi amici e dalla sua ragazza che invece si
avvicinerà all’ebraismo.
Una storia fortissima che
incatena lo spettatore e lo ammalia grazie a un ritmo da film d’azione, merito
del bravo regista Henry Bean, (strano nome che può tradursi come “Enrico
Fagiolo” e poi sparito come fugace lampo) e a dialoghi affilati, azzeccati e
molto ben confezionati. Com’è possibile essere ebreo e al tempo stesso
antisemita? Da dove deriva l’antisemitismo e quali sono i suoi stereotipi e le
sue subdole trappole? Sebbene molti spettatori e critici attaccarono il film,
accanto ai tanti elogi, definendolo “esagerato” o “paradossale” questo
lungometraggio premiato a vari prestigiosi festival si ispira, invece, alla
storia vera dell’ebreo Daniel Burros che divenne naziskin. Sono passati quindici
anni dal film che in certi passaggi ricorda un altro bel lavoro come “Talk
Radio” di Oliver Stone ma Gosling e il regista sono più profondi, emotivi e
esistenziali e l’America rappresentata è diversa, non quella ottimista e anni
’80 del film di Stone ma gli Usa violenti, cupi e feriti e insospettabilmente
razzisti degli anni 2000. Diverse scene sono memorabili, dall’aggressione del
crudele Balint diventato naziskin all’indifeso seminarista ebreo che apre in
maniera angosciante la pellicola, che rappresenta la crudeltà di attaccare
verbalmente e fisicamente persone indifese solo perché “diverse”, situazione che
tristemente si è ripresentata più volte nelle recenti cronache di antisemitismo
e di violenza europea e mondiale. I ricordi di Balint quando nella scuola
ebraica poneva domande scomode e imbarazzanti al suo insegnante di Torah che
rispecchiano i dubbi di tanti laici e il dissidio laici-religiosi molto vivo
nell’ebraismo contemporaneo. L’intervista del giornalista del New York Times
anche lui ebreo come Balint che rimane sconvolto nell’ascoltare i discorsi
deliranti e gelidamente articolati del ragazzo mentre sciorina i soliti
stereotipi antisemiti con inquietante rabbia. Dallo strapotere degli ebrei nei
media, alla mentalità manipolatrice e attaccata al denaro, al fatto che “gli
ebrei sono tutto astrazione e diverse idee contorte dalla psicanalisi, al
comunismo sono colpa loro” come dice Balint. Gosling è veramente eccezionale e
all’epoca aveva solo 22 anni nell’impersonare un personaggio tanto fragile e
crudele come Balint che rappresenta un certo “odio di sè” ebraico del mondo
ashkenazita, seppure all’estremo, l’assimilazione e l’influenzabilità, la
confusione e il senso di disorientamento che molti ebrei della mia generazione e
più giovani spesso vivono nei tempi odierni circondati da sentimenti ambigui, da
compagnie sbagliate, indecisi su valori e convinzioni e immersi in questo clima
che oscilla fra tolleranza e diffidenza. Molto accurata nel film anche la
rappresentazione della Sinagoga, i dialoghi sullo Shabbat, sulla kasherut,
coinvolgenti le liti su sionismo, nazismo, antisemitismo e le discussioni di
Balint coi sopravvissuti alla Shoah. Il rabbioso protagonista contesta tutto e
vorrebbe credere, da lì il titolo “The Believer” (Il credente), che si oppone e
aggredisce perché si sente ferito, che parla preoccupato di assimilazione, che
si commuove quando ascolta i racconti delle vittime dei lager e si innervosisce
con loro perchè non hanno reagito alle barbarie subite. Per questi dialoghi e
situazioni, per i sentimenti che è in grado di risvegliare e le riflessioni che
questa stimolante pellicola suscita, “The Believer” è più di un semplice film
che si avvale della sceneggiatura del bravo giornalista Mark Jacobson e della
sensibilità del regista Henry Bean e dalla travolgente espressività di Gosling.
Molto utile e educativo, sebbene decisamente provocatorio, scomodo e a tratti
polemico, come “Arancia Meccanica” di Kubrick che creò al regista diversi
problemi, il film è complesso e va filtrato dal buon senso data la forza delle
sue immagini e dei contenuti e posso capire che tanti ne siano rimasti perplessi
e spiazzati. Del resto l’originalità in questa epoca di banalità e di
conformismo, di filmetti commerciali e “facili” è un dono preziosissimo e com’è
giusto che sia il film si rivela spiazzante e splendido per forza narrativa e
emotiva. Magistrale anche la scena finale dove Balint cerca di far saltare la
Sinagoga ma alla fine si suicida e torna a litigare col suo professore di Torah
in cerca del senso della sua esistenza.
IL FILO A PIOMBO DELLE
SCIENZE. A volte la gente non vuole ascoltare la verità perché non vuole vedere
le proprie illusioni distrutte. Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche
pericolose della verità. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)
THE BELIEVER su
perpendiculum.blogspot.com mercoledì 3 ottobre 2018.
Lingua originale: Inglese,
ebraico
Paese di produzione: Stati
Uniti d'America
Anno: 2001
Durata: 102 min (secondo altri
98 min)
Dati tecnici: Colore e B/N
Rapporto: 1.66: 1
Genere: Drammatico
Regia: Henry Bean
Soggetto: Henry Bean, Mark
Jacobson
Sceneggiatura: Henry Bean
Produttore: Susan Hoffman,
Christopher Roberts
Produttore esecutivo: Daniel
Diamond, Jay
Firestone, Adam Haight,
Eric Sandys
Casa di produzione: Fuller
Films, Seven Arts
Pictures
Fotografia: Jim Denault
Montaggio: Mayin Lo, Lee Percy
Effetti speciali: Drew
Jiritano, Thomas Viviano,
Andrew Mortelliti, Andrea
Swistak
Musiche: Joel Diamond
Scenografia: Susan Block
Costumi: Alex Alvarez,
Jennifer Newman
Trucco: Renee Di Dio, Renee
Von Maluski, Angela
Gallagher, Seth Lombardi
Interpreti e personaggi
Ryan Gosling: Danny Balint
Billy Zane: Curtis Zampf
Theresa Russell: Lina
Moebius
Summer Phoenix: Carla
Moebius
Heather Goldenhersh: Linda
A.D. Miles: Guy Danielsen
Natasha Leggero: Valerie
Joshua Harto: Kyle
Elizabeth Reaser: Miriam
Glenn Fitzgerald: Drake
Sacha Knopf: Cindy
Pomerantz
Henry Bean: Ilio Manzetti
Jordan Lage: Roger Brand
Ebon Moss-Bachrach: Priaty
Doppiatori italiani
Massimiliano Manfredi:
Danny Balint
Massimo De Ambrosis:
Curtis Zampf
Isabella Pasanisi: Lina
Moebius
Barbara De Bortoli: Carla
Moebius
Budget: 1,5 milioni di dollari
Incassi al botteghino: 1,3
milioni di dollari, di cui:
USA: 416.925 dollari
Italia: 56.786 dollari
Francia: 56.493 dollari
Messico: 35.204 dollari
Spagna: 743.908 dollari
(Fonte: Box Office Mojo)
Riconoscimenti: 2001 –
Courmayeur Noir in festival
Premio Leone Nero al
miglior film
2001 – Festival
cinematografico internazionale di Mosca
San Giorgio d'oro
2001 – Sundance Film
Festival
Gran Premio della Giuria
Trama: Daniel "Danny" Balint è
un neonazista suburbano, un giovane skinhead fanatico e violento che consuma la
sua vita spettrale in una periferia desolata di New York. C'è soltanto un
piccolo problema: Daniel Balint è ebreo. Aveva ricevuto un'educazione ortodossa
e da bambino era uno studente di una yeshiva, ossia una scuola talmudica.
Brillante e dotato di un intelletto molto acuto, si era fin da subito fatto
notare per le sue interpretazioni non ortodosse delle Scritture. La sua idea
portante era di una logica ferrea. Dio aveva comandato ad Abramo di sacrificare
suo figlio Isacco, trattenendo all'ultimo la mano armata pronta ad uccidere.
Tuttavia nel momento stesso in cui il patriarca aveva levato il coltello per
compiere il sacrificio umano, era come se lo avesse compiuto davvero. Isacco era
stato davvero ucciso e subito era resuscitato, dando però origine a una ferita
insanabile, che aveva piagato gli Israeliti per sempre. Ogni ebreo mostrava i
segni dell'accaduto e li avrebbe portati su di sé fino alla Fine dei Tempi.
Ovviamente queste idee non piacevano all'insegnante di Torah, che litigava con
il giovane eterodosso ogni giorno in modo furioso. La Verità compresa da Daniel
non era colta né compresa dagli altri studenti, tutti stupidissimi e
conformisti. Questa Verità possiamo scriverla a caratteri cubitali e
incorniciarla. DIO È UN BULLO. Egli ti dice così: "Io sono tutto e tu non sei
niente, per questo posso farti tutto ciò che voglio". Sì, il Dio Bullo può anche
uccidere ogni persona, mutilarla, renderla invalida, renderla demente, colpirla
con una malattia immonda, farla incarcerare, torturarla e perseguitarla in modo
atroce. Non c'è scampo, non c'è riparo dall'arbitrio del Boia Cosmico. Come ci
si sente a sapere di essere in balia di un mostro sadico? Ecco, Daniel Balint
non ha retto a questa consapevolezza e ha iniziato la sua discesa agli Inferi,
che lo porterà all'incontro col Mostro della Follia. Incurante dei dolori
arrecati a suo padre e a sua sorella, gira per la città con una maglietta con
una grande svastica, ricavata da una bandiera del Terzo Reich. Porta bene in
evidenza anche un piccolo stemma delle SS su una spalla. La sua vita è violenta.
Su un autobus si imbatte in uno studente ebreo, lo segue quando scende, gli
tende un'imboscata, lo insulta e lo massacra di botte. Tuttavia qualcosa lo
distingue da altri skinhead, la cui brutale esistenza si esaurisce nella mera
fisicità, senza alcuna forma di pensiero nel cranio: egli cerca invece di
trasmettere le proprie idee, di diffonderle come un virus. In questa sua ricerca
Daniel si imbatte nel circolo neofascista guidato da Curtis Zampf e da sua
moglie Lina Moebius, così inizia a partecipare alle riunioni. Quando parla delle
leggi razziali naziste e della necessità dell'antisemitismo, tutti lo guardano
come se fosse un extraterrestre. Il neofascismo di Curtis Zampf è più che altro
una forma di politica identitaria, per certi versi simile a quello che oggi
viene etichettato come "sovranismo". Questa dottrina auspica la decomposizione
degli Stati Uniti d'America nelle comunità etniche che ne formano il tessuto
sociane, ognuna sovrana e indipendente. C'è profondo scetticismo sull'odio
antisemita, ritenuto una cosa del passato da superare, in grado soltanto di
arrecare danni. Eppure i discorsi di Daniel, fondati sulla retorica del Mein
Kampf, finiscono con l'affascinare il circolo di Curtis e della sua consorte.
Entra in scena la figlia dei due coniugi, Carla Moebius, che è subito colpita
dal giovane neonazista: se ne innamora perdutamente. Tutti sono colpiti
dall'intelligenza acuta di Daniel nell'esporre i propri argomenti. Quando arriva
a proporre l'uccisione del banchiere ebreo Ilio Manzetti, Curtis e Lina si
oppongono recisamente. Tuttavia è chiaro che l'antisemitismo cova come brace
sotto la cenere ed è tenuto nascosto persino in privato per paura dei delatori e
di subire persecuzione. Per questo Curtis e la moglie investono molto nel
ragazzo, arrivando a pagare la cauzione per lui e per i suoi compagni quando
vengono arrestati per aver scatenato una rissa di strada con alcuni robusti
Mandingo. I guai sono appena iniziati: il giornalista biondiccio Guy Danielsen,
che sta scrivendo un articolo sui gruppi dell'odio, intervista Daniel e ascolta
la sua dettagliata esposizione di rabbiose invettive antisemite, quindi gli
rivela qualcosa di traumatizzante: egli ha scoperto la sua vera identità e ha
anche contattato il rabbino Stanley Nadelman, l'insegnante che lo ha preparato
al Bar Mitzvah. Daniel riesce a cavarsela estraendo la pistola e minacciando il
suicidio. A questo punto Daniel viene invitato da Curtis e da Lina nel loro
campo, dove numerosi neonazisti si radunano e si esercitano con le armi. Subito
sa farsi valere. Accade però qualcosa di decisamente bizzarro. Egli ha una
relazione con Carla Moebius, che finisce con dargli appuntamento nella propria
stanza a mezzanotte, dicendogli di entrare dal balcone. Quando Daniel si reca
all'appuntamento, vede la ragazza che copula con il padre nella posizione
della cowgirl. Non ci sono dubbi: lei siede a cavalcioni sull'uomo, impalata dal
suo fallo e a un certo punto riceve nella vagina lo sperma che l'ha generata!
Sconvolto dall'incesto, il giovane si reca con i suoi compagni in un
ristorante kosher, dove inizia ad attaccare briga. Ne scaturisce una rissa: lui
e i suoi sodali, dopo aver chiesto di potersi ingozzare di prosciutto e di
formaggio, le prendono e finiscono nuovamente in carcere. Il giudice dà loro una
scelta tra un mese di carcere e un incontro con sopravvissuti all'Olocausto. I
neonazisti scelgono la seconda opzione. Durante questo incontro accade qualcosa
di decisivo. Gli anziani superstiti vengono scherniti più volte, tanto che
l'assistente sociale minaccia l'interruzione della misura alternativa. A un
certo punto uno di loro racconta che un soldato tedesco ha ucciso suo figlio di
soli tre anni, trafiggendolo con la baionetta. Daniel è preso dalla furia e si
chiede come l'uomo possa essere rimasto immobile, senza tentare di difendere il
figlio. La moglie del sopravvissuto afferma che lui al suo posto avrebbe fatto
lo stesso, non avrebbe avuto possibilità alcuna, o sarebbe stato annientato. Per
il resto della sua vita, Daniel avrà terribili flash mentali, in cui si vedrà
sia con le sembianze del soldato che con quelle del padre del bambino ucciso.
Qualcosa in lui si sta incrinando. Liberato, Daniel torna dai suoi amici e
insieme organizzano un attentato in una sinagoga. Entrano di notte nel tempio
per piazzare una bomba sotto il pulpito. Durante il raid, Daniel cerca di
impedire la profanazione dei rotoli della Torah, dando prova di conoscere il
mondo ebraico. I compagni, che sono stolti bestioni, non riescono davvero a
capire. La bomba si rivela un fallimento. Daniel porta a casa la Torah e ripara
con cura i danni che ha subìto. Il fanatico Drake coinvolge il giovane
nell'attentato al banchiere Manzetti, vantandosi di aver ucciso quattro ebrei.
Così viene preparato un agguato, che non va a segno: Daniel manca il colpo.
Drake lo accusa di aver fallito apposta e vede qualcosa di strano: un panno con
caratteri ebraici che pende dal fianco del compagno. Ne scaturisce una lite e
Daniel spara a Drake, pensa di averlo ucciso, quindi fugge nella notte. Anziché
sbrogliarsi, la matassa si complica incredibilmente. Il tentativo di Curtis di
far uscire alla luce del sole il suo movimento neofascista, l'incontro di Daniel
con i suoi ex compagni di scuola, la sua relazione con Carla, che si fa da lui
insegnare l'ebraico e arriva a frequentare la sinagoga. L'azione procede tra
vari colpi di scena fino all'unico epilogo possibile: la nemesi del
protagonista.
Recensione: Un film da vedere
e rivedere. Un capolavoro totale, che purtroppo non ha avuto i riconoscimenti
che meritava. In fondo non dovrebbe stupire più di tanto se è stato un tale
insuccesso. Le genti del mondo non sono in grado di comprendere argomenti troppo
complessi. Non capiscono il modo di pensare degli Israeliti proprio come non
capiscono la natura del Nazionalsocialismo e più in generale delle ideologie
antisemite. Allo stesso identico modo. Banalizzano ogni cosa, proprio perché non
è loro impossibile afferrare categorie troppo distanti da quelle che hanno
ricevuto dall'ortodossia del pensiero unico politically correct. Per questo
motivo l'opera di Henry Ban è andata incontro al disastro economico: un milione
e mezzo di dollari spesi per produrre il film, soldi che poi non sono tornati
nemmeno tutti indietro. All'appello mancavano duecentomila dollari e non è stato
generato alcun nuovo reddito. Un vero peccato. L'ennesima occasione persa per
dare fastidio al conformismo vigliacco delle masse acefale. Quando qualcuno è un
genio, la vita in genere non gli si presenta facile, mentre è consentito a
squallidi speculatori come i neoblogger e gli influencer di accumulare denari
manipolando il vuoto assoluto, vendendo pataccate come i loro ridicoli brand.
Nel Web anglosassone The Believer è ritenuto una vera e propria patata bollente
e rifuggito come un'epidemia di peste. A quanto pare nessun distributore di una
certa importanza ha voluto averci a che fare, dopo che una sua proiezione al
Centro Simon Wiesenthal ha dato origine a vivaci proteste. Trasmesso qualche
volta sulla TV via cavo, è stato cancellato in seguito agli attentati dell'11
settembre alle Torri Gemelle. Certo, non c'entra una cippa col fondamentalismo
islamico, ma andatelo a spiegare ai Neocon!
Daniel Balint e i pompini.
Intervistato dal giornalista Guy Danielsen in un bar, il protagonista introduce
un argomento che in genere viene taciuto. Comincia a parlare dei pompini!
Innanzitutto chiede all'uomo dai capelli ricci color paglia se è mai stato a
letto con una ragazza ebrea. Alla risposta affermativa, scava ulteriormente e
vuole sapere se lei gli ha fatto un pompino. Ebbene sì, è proprio quello che è
accaduto. La ragazza ha preso l'uccello in bocca al suo amante e lo ha
succhiato, portandolo a schizzare lo sperma. A questo punto inizia l'astioso
trattato di Daniel Balint sul sesso orale, da lui tecnicamente etichettato come
una perversione. Egli sostiene che i pompini sarebbero stati inventati dal
Popolo Eletto, che ne sarebbe ossessionato. Quindi accusa gli Israeliti di non
essere in grado di penetrare e di aver quindi inventato questa forma di sesso,
da lui considerata "infantile" e fondamentalmente "omosessuale". Fa l'elogio
della copula, che definisce come il mezzo adatto per fare godere una donna. Per
contro, i pompini sono in grado di manipolare l'uomo e di compromettere la sua
integrità, riducendolo a un essere incapace di affermarsi. Questo pur ammettendo
che ricevere il sesso orale è "molto piacevole" - segno che deve averlo
sperimentato. A questo punto scatta la rappresaglia del biondo e occhialuto
Danielsen, che tira fuori la scomoda faccenda del Bar Mitzvah e del rabbino
Nadelman. Tutto ciò sembra essere passato inosservato, nonostante sia ben raro
che in un film si arrivi a parlare esplicitamente dei pompini e ancor più raro
che li si condanni. Sarebbe il caso di compiere un approfondito studio
antropologico sull'argomento "estremisti di destra in USA e pompini". Ci si
potrebbe fare una tesi di laurea. Peccato che gli antropologi non ritengano
queste cose degne di interesse. Una volta mi è capitato di trovare nel famoso
sito Stormfront.org un commento di un tale che in sintesi condannava i pompini
perché "piacciono da morire agli ebrei". Non so fino a che punto sia diffuso
questo bizzarro pacchetto memetico che associa la cultura ebraica alla pratica
del sesso orale. Ogni tanto capita di imbattersi nei forum pornografici
americani in narrazioni di uomini che non amano farsi fare i pompini. Per
indagare è sufficiente digitare in Google stringhe del tipo "men who don't like
blowjobs". Si trovano resoconti davvero molto morbosi. Ricordo di aver letto di
una ragazza che si lamentava del fatto che il suo ex la allontanava ogni volta
che lei cercava di avvicinare la bocca ai suoi genitali. Sospirava, affermando
di non essere riuscita a farglielo nemmeno una volta. Un'altra era una milf che
ha raccontato di aver avuto un incontro occasionale in un bar con un uomo che
non le ha permesso di prenderglielo in bocca e si è limitato a copulare more
ferarum. Come lei ha cercato di convincerlo a farlo spruzzare nella sua bocca,
lui l'ha spinta via e ha emesso il seme nel vuoto. In genere nelle comunità
online testimonianze di questo tipo destano grande scalpore.
Una milf scandalizzata ha paragonato l'uomo che non ama i pompini al bigfoot,
ossia a una creatura inesistente. Non so però dire se le motivazioni alla base
di questi strani episodi siano collegate in qualche modo all'estremismo di
destra. Erano questi uomini neonazisti? Erano membri del Ku Klux Klan? Non ho
prove sufficienti per affermarlo. In alcune narrazioni da me rinvenute nel Web,
il rifiuto della fellatio era connesso a brutte esperienze con donne inesperte
che sfregavano il glande con i denti: queste occorrenze vanno quindi espunte
dalla casistica. Nel film di Bean, vediamo la sensuale Carla Moebius con le
labbra che le fremono dalla libidine, tanto è presa dalla voglia di succhiarlo a
Daniel. Ci sarà riuscita?
L'ultimo monologo di Daniel
Balint. L'atteso discorso dell'agitatore neonazista inizia in un modo
assolutamente inatteso, che trasforma ogni astante in una statua di sale come la
moglie di Lot. Questo è l'incipit: "SHEMA YISRAEL!" Già alla prima emissione
salmodiata di quei fonemi si registrano reazioni di grande sconcerto e di
insofferenza tra il pubblico, che reagisce come un gruppo di musulmani riuniti
in una moschea in cui fosse trascinato all'improvviso un grosso porco estinto
tutto coperto di sterco. C'è persino un afroamericano, che contorce le narici
quasi per sfuggire ai lezzi di un fantomatico stronzo. La grande ipocrisia di
quella congrega è degna della massima stigmatizzazione. L'incestuoso Curtis
Zampf, fottitore della propria figlia, voleva fondare un partito neofascista
alla luce del sole e invitare ai dibattiti ebrei come Noam Chomsky, appoggiando
al contempo la diffusione dell'antisemitismo. Poi Daniel Balint col suo genio
folgorante gli rompe le uova nel paniere! Senza mezzi termini, spiazza tutti
dicendo che bisogna amare gli Ebrei, in modo incondizionato e non ipocrita. Dice
che bisogna accoglierli, che l'integrazione è la sola arma in grado di
neutralizzarli. Poi passa a spiegare le ragioni del suo sentire. L'antisemitismo
è ciò che ha permesso nei secoli la conservazione dell'identità ebraica. Senza
l'antisemitismo, non esisterebbero più Israeliti da tempo, perché avrebbero
contratto matrimoni misti e avrebbero smarrito la propria cultura, il proprio
senso di alterità. La peggior maledizione per il Popolo Eletto è proprio
questa. "Vi perderete voi tra le genti", minaccia il Signore degli Eserciti,
pieno d'ira. Per evitare questo destino di annientamento peggiore della morte
stessa, l'ostilità dei Gentili è un prezzo che è necessario pagare, anche se
comporta oppressione, omicidi e pogrom. Senza l'Olocausto, lo Stato di Israele
non sarebbe mai esistito, le ciance di Theodor Herzl non sarebbero bastate a far
tornare gli Ebrei alla Terra Promessa. Questi concetti, perfettamente razionali
e corrispondenti alla realtà dei fatti, non sono capiti dal pubblico, che
rumoreggia pieno di sdegno. Tutti si aspettavano da Daniel qualcosa di
elementare nella sua banalità, un discorso ventrale e crepitante, privo di
concetti e ricco di bile. Invece ecco una vera e propria sfinge, in grado di far
crollare l'intero edificio su cui si regge l'estremismo di destra.
Daniel Balint e Daniel Burros.
Il regista-sceneggiatore e il suo collaboratore Mark Jacobson hanno preso spunto
da una storia vera, quella di Daniel Burros. Questa è la sintesi apparsa sul
Jerusalem Report: "The film has its roots in a true story. Daniel Burros was a
nice Jewish boy from Queens who somehow went from being his rabbi's star pupil
to a hotheaded proponent of the long-defunct Third Reich. After a stint in the
Army, he became involved with the American Nazi Party and the Ku Klux Klan. In
1965, following Burros' arrest at a KKK event in New York City, the New York
Times disclosed that he was Jewish. Hours after the paper hit the stands, Burros
took his own life."
Questa è una traduzione per
coloro che ancora non hanno nozione alcuna della lingua inglese: "Il film ha le
sue radici in una storia vera. Daniel Burros era un bravo ragazzo ebreo del
Queens che per qualche motivo divenne da pupillo del suo rabbino a impetuoso
proponente del Terzo Reich, da tempo defunto. Dopo un periodo nell'esercito,
venne coinvolto nel Partito Nazista Americano e nel Ku Klux Klan. Nel 1965, in
seguito all'arresto di Burros a una manifestazione del KKK a New York, il New
York Times ha rivelato che egli era ebreo. Qualche ora dopo l'uscita del
quotidiano, Burros si è tolto la vita." La vicenda terrena di Daniel Burros non
è un infetto parto della mia fantasia. Vien voglia di sbattere l'accaduto in
faccia a coloro che reputano impensabile che un ebreo possa essere al contempo
un antisemita viscerale. Al momento non mi è dato sapere se il bravo ragazzo del
Queens odiasse i pompini come il protagonista del film di Bean, salvo poi
farseli fare ugualmente.
La sindrome dell'ebreo che
odia se stesso. C'è una cosa molto singolare che Daniel Balint riporta ai suoi
stupidissimi compagni appartenenti al White Trash. Adolf Eichmann conosceva bene
la Torah e il Talmud. Conosceva perfettamente la lingua ebraica e si districava
nella complessa terminologia, che disorienterebbe chiunque. Eichmann sapeva
tutto. Come spiegarsi questa cosa? Semplice: il genocida, poi rapito dal Mossad
e processato in Israele, era un ebreo rinnegato, proprio come Daniel Burros. La
cosa non deve stupire: vi erano numerosi Mischlinge in posti chiave del Partito.
Sappiamo che Eichmann è un cognome nobiliare tedesco, di per sé non tipico di
discendenti di Abramo. Probabilmente è il ramo materno a riservare grandi
sorprese. Anche se Daniel non lo menziona, possiano analizzare in breve anche il
caso di Reinhard Heydrich, rimandando a una successiva e più approfondita
trattazione. Colui che fu chiamato "La Bestia Bionda" o "Un giovane e crudele
Dio della Morte" in un'occasione si ubriacò e fu sentito inveire davanti a uno
specchio, maledicendo il suo "ebreo interiore". Suo padre parlava alla
perfezione lo Yiddish e in più occasioni raggelò in presenti, che iniziarono a
domandarsi chi fosse realmente. A scuola era bullizzato in modo pesante: lo
soprannominavano "Moshe Heydrich" e "Süss l'Ebreo". Tra gli stessi membri del
Partito era noto come "Mosè biondo". Chiaramente il mondo è pieno di persone
pronte a fare l'impossibile per screditare chi menziona questi dati di fatto.
Quella del bullismo subìto è stata un'esperienza comune ad Adolf Eichmann. Si
vede quanto il bullismo sia devastante. Anziché essere combattuta con la massima
severità, questa piaga è sempre stata tollerata da insegnanti che sono anche
complici. I nodi però alla fine vengono al pettine. Gratta un uomo che ha subìto
bullismo e potresti trovare un potenziale genocida. Non esito a dichiarare che
se per uno scherzo del destino avessi davanti a me la fatidica valigetta del
Presidente degli Stati Uniti d'America, darei immediato avvio alle procedure per
il lancio di tutto l'arsenale nucleare, senza nemmeno un istante di esitazione.
Ain Soph, il Nulla senza
confini. In un'intervista trasmessa sui canali televisivi all'indomani del
fallito attentato alla sinagoga in cui era stata collocata una bomba inesplosa,
il rabbino afferma che Dio è intervenuto per salvare la comunità. Le sue parole
sono sorprendenti, perché chiama Dio con l'epiteto Ain Soph, spiegato come "Il
Nulla senza confini". Si converrà che è una cosa ben strana. Come può un capo
religioso assimilare Dio a una condizione che le genti reputano essere sinonimo
di non esistenza? La locuzione Ain Soph (varianti ortografiche Ayin Sof, Ein
Sof, etc.) la tradurrei più propriamente come "Senza confini", anche se la
glossa "Il Nulla senza confini" è frequentemente riportata. L'argomento
rabbinico è molto sofisticato: Dio è inassimilabile a qualsiasi cosa concepibile
da mente umana, quindi persino allo stesso concetto di esistenza. Sarebbe
impossibile riassumere qui la complicatissima teologia che sta alla base di
queste definizioni. Perché Bean e Jacobson hanno voluto fare menzione di questo
aspetto di certo incomprensibile alla maggior parte degli spettatori? Bisogna
arrivare al finale del film per capirlo.
Visione di pre-morte. Poco
prima di morire a causa dell'esplosione della bomba collocata sotto il pulpito
della sinagoga durante lo Yom Kippur, Daniel Balint ha una visione molto
significativa. Sale le scale dell'edificio della yeshiva e a ogni piano incontra
il suo insegnante. L'uomo gli dice che ha riflettuto sulla teoria eretica di
Isacco morto e resuscitato, giungendo ad accettarla. La sequenza sembra quella
di un loop infinito: Daniel, il cui corpo è quello che aveva al momento della
morte - non è più il bambino ribelle - è intrappolato negli stessi fotogrammi ad
ogni piano. Questo finché a un certo punto il circuito temporale chiuso sembra
rompersi. Egli arriva a un piano in cui qualcosa cambia: filtra dall'alto una
strana luce. L'insegnante lo avverte che là in alto non c'è nulla. C'è il
Nulla.
Riflessioni conclusive. In
nessun modo il giovane ebreo che odia se stesso è riuscito a superare il
monoteismo, a lasciarsi alle spalle l'idea secondo cui tutta l'esistenza risale
a un unico principio, a un unico Creatore. Se avesse compiuto questo salto,
sarebbe diventato un Manicheo. A volte si ha l'impressione che mancasse poco, ma
questa trasformazione gli era impossibile a causa della sua educazione
teologica, che lo ha spinto in un vicolo cieco.
Giordano Stabile per "la Stampa" il 22 luglio
2021. Dove arrivava Benjamin Netanyahu, arrivava Pegasus. Un filo rosso lega i
Paesi che hanno utilizzato lo spyware ideato dall'israeliana Nso e i viaggi
all'estero l'ex premier israeliano. Arabia Saudita, Ungheria, Azerbaigian,
Ruanda, Messico. Tutti Stati che hanno allacciato o riallacciato, anche in
segreto, le relazioni con Israele e sono diventati clienti privilegiati dei suoi
prodotti militari e di intelligence. In dodici anni filati da primo ministro
Netanyahu è riuscito ad allargare molto la sfera di influenza dello Stato
ebraico, uno dei suoi maggiori successi. Ma adesso l'exploit tecnologico che ha
accompagnato la sua azione diplomatica rischia di ritorcersi contro. Le
rivelazioni di Forbidden Stories sulle centinaia se non migliaia di politici,
giornalisti, attivisti, oppositori spiati e a volte arrestati suscitano
preoccupazioni. In Francia sono già state avviate indagini, dopo che i telefoni
del presidente Emmanuel Macron sono stati infettati dal malware. L'Ungheria è di
nuovo nel mirino delle ong per i diritti umani e Reporter senza frontiere ha
esortato lo Stato ebraico a sospendere l'esportazione di «tecnologia volta alla
sorveglianza». Un mercato lucroso, ma con riflessi pesanti sul rispetto dei
diritti umani. Il governo israeliano ha respinto le accuse su un legame diretto
con i servizi offerti dall'Nso. Di certo però i viaggi di Netanyahu aprivano
molte porte. Nell'estate del 2016 l'ex premier parte per uno «storico viaggio»
in Africa, con la tappa principale in Ruanda. Nel dicembre dello stesso anno
visita il Kazakhstan e l'Azerbaigian. Nel luglio del 2017 è il primo leader
israeliano ad arrivare in Ungheria. A settembre parte per il Messico, altra
prima assoluta. Nel gennaio del 2018 è in India. In tutti questi Paesi l'uso di
Pegasus per infiltrarsi nei cellulari dei cittadini comincia pochi mesi o al
massimo un anno e mezzo dopo, nel caso di Budapest. Israele ha interesse a
potenziare le capacità di intelligence dei nuovi alleati. Il Ruanda si offre per
accogliere immigrati irregolari dall'Africa che lo Stato ebraico vuole
espellere. L'Azerbaigian confina con l'Iran, è una base ideale per controllare
il principale avversario in Medio Oriente. Viktor Orban si pone come la voce più
vicina alle posizioni israeliane nella Ue, anche su Gerusalemme e Territori
occupati. L'uso di Pegasus comincia nel febbraio del 2018, subito dopo
l'incontro fra Netanyahu e il consigliere per la sicurezza Jozsef Czukor.
Coincidenze che hanno insospettito, fra gli altri, anche il Financial Times. Il
quotidiano londinese sottolinea come Pegasus sia diventato «una componente
essenziale dell'espansione diplomatica» israeliana. Anche l'export di armi, fin
dagli anni Cinquanta, lo è stata, ma la sorveglianza di massa pone maggiori
problemi. Il ministero della Difesa, che approva ogni licenza per le
esportazioni, ha ribadito che vengono prese «misure appropriate» per evitare
abusi. Il co-fondatore di Nso, Shalev Hulio, è tornato a negare che il software
sia stato usato per spiare «rappresentanti della società civile non legati a
fatti di terrorismo o crimine». Ma la condanna in Marocco del giornalista Omar
Radi, controllato da Pegasus, o i telefoni infettati della moglie e della
fidanzata dell'editorialista del «Washington Post» Jamal Khashoggi, ucciso nel
consolato saudita di Istanbul, gettano ombre preoccupanti. Pure questi Paesi
rientrano nella «rete diplomatica» di Netanyahu, che nel dicembre del 2020 aveva
annunciato il ristabilimento delle relazioni con Rabat, e nel novembre dello
stesso anno aveva incontrato in segreto sul Mar Rosso il principe ereditario
saudita Mohammed bin Salman. Anche perciò Reporter senza frontiere chiede, con
il suo numero uno Christophe Deloire, una moratoria sulla vendita di questi
prodotti, «fino a quando non sarà istituito un quadro normativo di protezione».
Perché scoppiano così facilmente le
guerre in Medio Oriente (e contro Israele).
Daniel Pipes su L'Inkiesta il 16/6/2021. I leader arabi minimizzano la disfatta
militare perché le terribili implicazioni dei conflitti non li riguardano
minimamente. La sofferenza della popolazione è irrilevante e il governante può
aspettarsi di sopravvivere illeso. Anzi, il disastro sul campo di battaglia può
essere politicamente utile. Quando il portavoce di Saddam Hussein incontrò il
segretario di Stato americano alla vigilia della guerra del Kuwait nel gennaio
1991, Tariq Aziz disse qualcosa di importante a James Baker. «Mai», lo cita una
trascrizione irachena, «un regime politico (arabo) è entrato in guerra con
Israele o con gli Stati Uniti e ha perso a livello politico». Elie Salem,
ministro degli Esteri libanese per la maggior parte degli anni Ottanta e noto
professore di politica, ha concordato: la logica della vittoria e della
sconfitta non trova piena applicazione nel contesto arabo-israeliano. Nelle
guerre con Israele, gli arabi celebravano le loro sconfitte come se fossero
vittorie, e presidenti e generali erano più conosciuti per le città e le regioni
che avevano perso che per quelle che avevano liberato. Esagerano leggermente,
poiché la sconfitta subita da Israele nel 1948-1949 da parte degli eserciti
siriano, egiziano, iracheno e giordano costò molto a quei regimi con tre di loro
che crollarono e uno che sopravvisse a malapena. A parte questa eccezione, le
perdite militari di solito non danneggiano i governanti arabi sconfitti. In
effetti, il disastro sul campo di battaglia può essere politicamente utile, e
non solo contro Israele o gli Stati Uniti, ma anche nei conflitti intra-arabi e
con iraniani, africani o europei. Nei sessantacinque anni trascorsi dal 1956, le
perdite militari non hanno quasi mai rovinato i governanti di lingua araba e
talvolta sono state loro utili. L’analisi che segue mostra questo schema
attraverso ventuno esempi, diciannove dei quali brevi e due analisi più lunghe,
ne dà una spiegazione e infine ne trae una conclusione.
Esempi, 1956-2014.
La crisi di Suez del 1956. Il presidente egiziano
Gamal Abdel Nasser ha subito un’umiliante disfatta militare per mano di inglesi,
francesi e israeliani, eppure, questo evento «lo ha rafforzato politicamente e
moralmente», scrive Shukri Abed. Questa sconfitta, di fatto, ha aiutato Nasser a
diventare la figura dominante nella politica araba del successivo decennio.
La guerra d’Egitto in Yemen, 1962-1967. Dopo
cinque anni di intensa guerra, grandi spese e molte vittime, Nasser ritirò
incondizionatamente le truppe egiziane, già debilitate dalla guerra dei Sei
Giorni, dalla guerra civile dello Yemen. Nasser non ha pagato quasi nessun
prezzo politico interno per questo disastro.
Lo scontro tra Siria e Israele, aprile 1967. Il 7
aprile, i siriani persero sei MiG-21 e gli israeliani non persero nessun aereo,
ma la battaglia non causò costernazione a Damasco. Al contrario, dieci giorni
dopo, il presidente Nur ad-Din al-Attasi definì la perdita degli aerei «molto
utile per noi».
La guerra dei Sei giorni, giugno 1967. Una delle
più grandi sconfitte militari nella storia umana indusse l’egiziano Nasser a
scusarsi con i suoi elettori e ad offrire loro le sue dimissioni, ma essi
reagirono riversandosi in massa nelle strade e chiedendo al
loro ra’is (presidente) di rimanere al potere, cosa che fece, più potente che
mai, fino alla sua morte per cause naturali, nel 1970. In Siria, il ministro
della Difesa Hafez al-Assad, tre anni dopo il disastro del 1967, divenne il
dittatore assoluto del suo Paese per tre decenni. Re Hussein di Giordania rimase
sul trono fino alla sua morte, avvenuta anch’essa tre decenni dopo, mantenendo
intatto il suo potere e molto rispettato.
La battaglia di Karama, 1968. Sebbene Fatah di
Yasser Arafat avesse perso il suo primo grande scontro armato con gli
israeliani, rivendicò la vittoria, convincendo molti, cosa che avrebbe fatto
molte volte da allora in poi. Anche il generale israeliano Aharon Yariv ammise
che «sebbene sia stata una sconfitta militare per loro, è stata una vittoria
morale».
La guerra dello Yom Kippur, 1973. All’inizio. gli
israeliani fecero un passo falso, a si ripresero ottenendo un brillante successo
militare contro gli eserciti di Egitto e Siria. Tuttavia, il presidente egiziano
Anwar Sadat dipinse la guerra come un trionfo egiziano celebrato ancora oggi, e
utilizzò questo presunto successo per legittimare la successiva diplomazia con
Israele.
Anche il siriano Assad ottenne una grande
vittoria. Il suo biografo, Moshe Ma’oz, osserva: «Sebbene da un punto di vista
puramente militare, Assad avesse perso la guerra, è riuscito a trasformare la
sua sconfitta in una vittoria agli occhi di molti siriani e altri arabi». I
siriani, riferisce Ma’oz, hanno sostenuto «La conduzione fiera e audace della
guerra da parte di Assad nelle sue ramificazioni militari e diplomatiche». Di
conseguenza, il suo «prestigio e la popolarità aumentarono vertiginosamente in
Siria durante la guerra e in seguito».
La guerra d’Algeria nel Sahara occidentale,
1975-1991. Il governo marocchino e quello algerino appoggiarono le parti opposte
in una lunga guerra civile in cui, alla fine, prevalsero il Marocco e i suoi
alleati. Chadli Bendjedid, presidente dell’Algeria dal 1979 al 1992, pagò poco
il prezzo politico del fallimento.
L’occupazione siriana del Libano, 1976-2005. Il
debole e diviso governo del Libano non poté impedire alle forze siriane di
entrare nel Paese o di rimanervi per ventinove anni. Nonostante questo lungo
fallimento, l’élite al potere proseguì come se nulla fosse fondamentalmente
cambiato. Quando una rivolta popolare finì per cacciare i siriani, quell’élite
andò avanti impassibile.
La guerra Iran-Iraq, 1980-1988. Saddam Hussein
iniziò la guerra tra Iran e Iraq, che si divise in due fasi principali. Nella
prima, dal settembre 1980 al luglio 1982, Saddam fu all’attacco. Quando le cose
si misero male, e l’Iraq dovette successivamente giocare in difesa per sei
lunghi anni, il rais non pagò alcun prezzo interno. Ma la cosa più sorprendente
fu che, due anni dopo la fine della guerra, il 15 agosto 1990 (tredici giorni
dopo l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq), Saddam Hussein restituì
all’improvviso all’Iran tutte le conquiste ottenute in otto anni di
combattimenti: «In un annuncio fatto alla radio di Baghdad, l’Iraq ha dichiarato
che avrebbe riconosciuto i contesi confini dell’Iran antecedenti alla guerra,
che avrebbe rilasciato tutti i prigionieri di guerra e che avrebbe iniziato a
ritirare le truppe da circa mille miglia quadrate della parte sudoccidentale
dell’Iran occupate fin da venerdì». Questo ignominioso ritiro passò quasi
inosservato e non lese Saddam.
Israele contro la Siria, 1982. In una guerra aerea
in Libano, le forze siriane persero una novantina di aerei contro le forze
israeliane, senza abbatterne nessuno. Ma Assad ne uscì illeso, semmai, la sua
audacia nell’affrontare il terribile nemico israeliano accrebbe la sua statura.
Israele contro l’OLP a Beirut, 1982. Attraverso la
magia verbale, Arafat trasformò un’umiliante ritirata da Beirut in una vittoria
politica rilevando quanto tempo impiegarono gli israeliani (ottantotto giorni)
per sconfiggerlo, molto più del necessario per sconfiggere gli eserciti arabi
convenzionali (nove giorni nel 1956, sei nel 1967 e venti nel 1973). Rashid
Khalidi, allora esponente dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
(OLP) e ora professore alla Columbia University, arrivò al punto di confrontare
la minuscola operazione di Beirut (e i suoi ottantotto morti israeliane) con i
due anni e mezzo di assedio di Leningrado da parte dei nazisti (con i suoi circa
due milioni di morti). Il passare del tempo trasformò ulteriormente questa
disfatta in un glorioso successo; nella rivisitazione di Hamas alcuni anni dopo:
«Il nostro popolo (…) ha umiliato [Israele] (..). e ha incrinato la sua
determinazione».
Il ritiro dell’OLP da Tripoli, 1983. Quando le
forze siriane costrinsero l’OLP a lasciare la sua ultima roccaforte in Libano,
Arafat reagì prevedibilmente trasformando questo ritiro in un successo morale.
Secondo i suoi biografi, ’il leader dell’OLP, nel bel mezzo di un’altra storica
battuta d’arresto, era ancora intento a sfruttare l’occasione, per tutto il suo
valore teatrale».
Il bombardamento statunitense della Libia,
1986. Dopo aver subito l’ignominia di essere stato attaccato dagli aerei da
guerra statunitensi, Muammar Gheddafi trasformò la sua stessa sopravvivenza in
qualcosa di magniloquente. Tra le varie misure, il rais libico commemorò questo
risultato aggiungendo la parola “Grande” (’uzma) al nome formale del suo Paese,
che divenne la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista. Nove anni
dopo, ricordava ancora l’episodio come un disastro per gli Stati Uniti:
L’America non ammette mai le sue perdite. Non
abbiamo abbattuto quindici dei suoi aerei quando fecero irruzione [nel 1986]? Ma
ha ammesso solo la perdita di due aerei. L’America non parla mai delle sue
sconfitte e delle sue perdite: tiene la bocca chiusa. Si è persino rifiutata di
ammettere che il capo della squadriglia che ha attaccato la mia casa è stato
abbattuto e ucciso nello schianto. Non hanno mai ammesso la sua perdita fino a
quando non li abbiamo messi in imbarazzo mostrando il suo cadavere che abbiamo
consegnato al Vaticano.
Milizie ciadiane contro Libia, 1987. In Ciad, la
Libia perse in modo umiliante contro forze decisamente inferiori a livello
numerico e per equipaggiamento, come scrissi a quattro mani all’epoca: «Le
Toyota a quattro ruote motrici sconfissero un convoglio di carri armati». Questo
disastro, tuttavia, non ebbe ripercussioni visibili sul prestigio o sul dominio
di Gheddafi sulla Libia.
Iraq contro Kuwait, 1990. L’attacco iracheno al
Kuwait fece seguito a mesi di minacce da parte di Baghdad; le forze kuwaitiane
non erano in allerta e vennero rapidamente sopraffatte, spingendo immediatamente
e ingloriosamente l’emiro Jaber al-Ahmad as-Sabah a fuggire oltre il confine in
Arabia Saudita, dove supervisionò il governo kuwaitiano in esilio da una suite
d’albergo. Nonostante la sua mancanza di preparazione e le azioni non eroiche,
Jaber non affrontò sfidanti durante o dopo i combattimenti.
Hezbollah contro Israele, 2006. Hezbollah perse
contro Israele, ma lo fece in modo rispettabile, rafforzando così la presa di
Hassan Nasrallah sull’organizzazione. Parlando a una manifestazione di massa
dopo i combattimenti, il leader di Hezbollah rivendicò una «vittoria divina e
strategica». Paradossalmente, Nasrallah in seguito ammise di aver commesso un
errore nell’iniziare il conflitto [16], ma si dette poca attenzione a ciò, e
quindici anni dopo mantiene il controllo.
Hamas contro Israele, 2008-2009. Chiamata in
Israele operazione “Piombo fuso”, questa guerra di 3 settimane vide Israele fare
molto bene sul campo di battaglia (come simboleggiato dalla morte di circa cento
volte più palestinesi che israeliani) e in modo schiacciante nell’arena politica
(come simboleggiato dal Rapporto Goldstone delle Nazioni Unite e da una
conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza che fruttò 4,5 miliardi
di dollari). I leader di Hamas emersero dalla guerra rafforzati dalla sconfitta
militare.
Hamas contro Israele, 2012. Le Forze di Difesa
Israeliane potrebbero aver ucciso molti dei leader di Hamas, distrutto le sue
infrastrutture e lasciato Gaza vacillante, ma, come previsto, il giorno dopo
l’entrata in vigore del cessate il fuoco, Hamas indisse dei festeggiamenti di
celebrazione che si conclusero drammaticamente con la morte di una persona e il
ferimento di altre tre a causa di colpi di arma da fuoco sparati in aria. Non
solo questo, ma Hamas sancì che il 22 novembre sarebbe stato un giorno da
celebrare ogni anno da allora in poi: «Chiediamo a tutti di festeggiare,
visitare le famiglie dei martiri, i feriti, coloro che hanno perso la casa».
Hamas contro Israele, 2014. La guerra devastò
Gaza, ma un sondaggio condotto dai palestinesi dopo la fine delle ostilità
rilevò che il 79 per cento affermava che Hamas aveva vinto; al contempo, Ismail
Haniyeh risultò essere il preferito degli intervistati a ricoprire la carica di
presidente palestinese, passando dal 41 per cento al 61 per cento. (Poche
settimane dopo, queste percentuali scesero leggermente, rispettivamente al 69 e
al 55 per cento). Quel sostegno si estese anche alle tattiche, con il 94 per
cento degli intervistati a favore dello scontro militare con le truppe
israeliane e l’86 per cento che si espresse a sostegno del lancio di razzi
contro Israele.
Questo sondaggio mostra che i leader arabi possono
perdere contro chiunque: una potenza occidentale (Stati Uniti, Gran Bretagna,
Francia), Israele, una milizia africana, uno Stato musulmano non arabo (Iran) o
uno Stato confinante arabo (Yemen, Siria, Iraq), e poco importa. Il prezzo
politico è quasi sempre minimo e talvolta la sconfitta comporta un vantaggio
effettivo.
Case study I: la guerra del Kuwait, 1991
L’invasione irachena del Kuwait portò alla
formazione di una coalizione guidata dagli Stati Uniti di trentanove Stati che
attaccò le forze irachene il 17 gennaio 1991 e le ostilità terminarono il
successivo 28 febbraio, quando Baghdad capitolò. Emerse rapidamente un chiaro
consenso sul fatto che il leader iracheno Saddam Hussein dovesse rassegnare le
dimissioni o sarebbe stato deposto.
Il rais, però, non aveva tali intenzioni e aveva
preparato il terreno per grandiose rivendicazioni. Il suo regime inizialmente
parlò di una «battaglia veramente decisiva e storica» che segnò «l’inizio della
fine dell’imperialismo mondiale». Dopo che ebbe inizio l’attacco guidato dagli
Stati Uniti, Baghdad istituì la radio a onde corte “Mother of Battles Radio” (in
arabo, : Idha’at Umm al-Ma’arik) per trasmettere la sua imminente vittoria sulle
forze alleate.
In seguito, le cose non andarono così bene, con la
disfatta delle forze irachene (tiro al tacchino) e il conseguente
danno semi-apocalittico alle infrastrutture irachene. Nonostante ciò, i media
del regime insistettero con sconsideratezza per ottenere una famosa vittoria
sull’operazione “Tempesta del Deserto”. «Avete trionfato su tutti i leader del
male messi insieme», informò Radio Baghdad le forze irachene, affermando di aver
calpestato «nel fango» il prestigio dell’America.
Anche dopo aver ammesso formalmente la sconfitta,
Baghdad continuò a rivendicare la vittoria. Un incredibile esempio di ciò,
arrivò quattro anni dopo la fine dei combattimenti, quando il capo Stato
maggiore Iyad ar-Rawi affermò: «La nostra vittoria è stata leggendaria. Il
magnifico esercito iracheno ha inciso nel libro della Madre di Tutte le
Battaglie il massacro più impressionante, quando ha schiacciato le forze
americane e alleate durante la prima battaglia terrestre». Rawi proseguì
parlando della battaglia (fittizia) dell’Aeroporto del Kuwait e di un enorme
scontro di carri armati a sudovest di Bassora, definendolo come una delle «più
feroci battaglie di carri armati che sia mai stata combattuta». George H.W.
Bush, concluse Rawi fu «costretto a dichiarare un cessate il fuoco unilaterale
il 28 febbraio 1991, perché sapeva che le forze statunitensi non potevano
sostenere le perdite derivanti dalle battaglie terrestri».
I sostenitori all’estero approvarono queste
pretese di vittoria. Nel novembre 1994, alla cerimonia di consegna dei diplomi
della polizia palestinese, un coro intonò canzoni in omaggio a Saddam Hussein.
Il fatto che ad alcuni sostenitori di Saddam non importasse se avesse
effettivamente vinto o meno sul campo di battaglia, contribuì ad alimentare la
finzione. Così Hichem Djaït, l’intellettuale più noto della Tunisia e fervido
sostenitore di Saddam, rilevò: «Non abbiamo nulla da perdere da questa guerra,
anche se finisce con una sconfitta».
Questa chiara mistificazione contribuì a tenere
ancora in piedi il governo di Saddam, permettendogli di intimidire qualsiasi
aspirante ribelle, fluttuando al di sopra dei disastri che colpirono il suo
Paese, compreso un calo del 90 per cento del reddito pro capite, e a rimanere al
potere per altri dodici anni. Solo quando le forze guidate dagli Stati Uniti
tornarono nel 2003, questa volta con l’intento specifico di deporlo, cadde dal
potere e finì in un buco.
Case Study II: Hamas contro Israele, 2021
Hamas e i suoi alleati concordano quasi
all’unanimità sul fatto di aver vinto il conflitto con Israele del maggio 2021,
nonostante quello che l’Associated Press ha definito «l’orribile peso che la
guerra ha avuto su innumerevoli famiglie palestinesi che hanno perso i propri
cari, le case e gli esercizi commerciali».
Appena due giorni dopo l’inizio dei combattimenti,
il leader di Hamas Ismail Haniyah aveva già annunciato che la sua organizzazione
aveva «conseguito la vittoria nella battaglia per Gerusalemme». Tali
affermazioni si sono moltiplicate dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco
il 21 maggio, quando Haniyah ha rivendicato una «vittoria strategica e divina» e
ha inoltre annunciato che Hamas «ha sconfitto le illusioni dei negoziati, ha
sconfitto l’affare del secolo, ha sconfitto la cultura della sconfitta, ha
sconfitto i progetti di disperazione, ha sconfitto i progetti di insediamento,
ha sconfitto i progetti di coesistenza con l’occupazione sionista e ha sconfitto
i progetti di normalizzazione [delle relazioni] con l’occupazione sionista».
Allo stesso modo, Khalil al-Hayya, un leader di
Hamas, partecipando a un raduno di massa a Gaza ha detto che «ci sono
festeggiamenti in tutte le città della Palestina (…) perché noi abbiamo ottenuto
questa vittoria insieme», aggiungendo: «Abbiamo il diritto di gioire. (…) Questa
è l’euforia della vittoria». Ziad al-Nahala, leader della Jihad Islamica
Palestinese (JIP), si è rallegrato del trionfo della sua organizzazione e ha
minacciato di bombardare Tel Aviv come rappresaglia per «qualsiasi operazione
omicida mirata ai nostri combattenti o leader».
Hanno festeggiato anche i sostenitori
stranieri. Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, ha definito gli attacchi di
Hamas contro Israele una «grande vittoria». L’ayatollah iraniano Ali
Khamene’i si è congratulato per una «vittoria storica» e il comandante della
Forza Quds, forza speciale del Corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica,
Esmail Ghaani, ha acclamato i combattimenti perché hanno «distrutto l’orgoglio
dell’esercito sionista». (A sua volta, un portavoce della JIP ha ringraziato il
governo iraniano per essere «partner della nostra vittoria».) Anche il primo
ministro marocchino Saad Eddine El Othmani, che mesi prima aveva firmato un
accordo di normalizzazione delle relazioni con Israele, si è congratulato con
Haniyeh per la «vittoria del popolo palestinese».
E pare che anche la popolazione palestinese ne
fosse convinta. Infatti, non appena è entrato in vigore il cessate il fuoco
delle due di notte, «per le strade di Gaza è tornata una frenesia di vita. La
gente è uscita dalle proprie case, alcuni gridando Allahu Akbar o fischiando dai
balconi. Molti hanno sparato in aria, festeggiando la fine dei combattimenti.
Grandi folle hanno celebrato la fine del conflitto, elogiando Hamas».
I festeggiamenti si sono diffusi ampiamente nel cuore della notte:
I residenti di Gaza hanno applaudito dalle loro
terrazze. Spari celebrativi sono risuonati nei quartieri per lo più bui, alcuni
clacson di auto strombazzavano, con i conducenti che hanno sfidato le strade
butterate di crateri di bombe, e le lodi a Dio risuonavano dalle moschee intorno
a Gaza City. I gaziani hanno sfilato in spiaggia, rivolgendo verso l’alto le
luci dei loro telefonini.
Nei giorni successivi ci sono state celebrazioni
su larga scala da parte di Hamas e del suo alleato più piccolo, la Jihad
Islamica Palestinese.
Questi festeggiamenti hanno delle implicazioni
politiche. «La reputazione di Hamas tra i palestinesi è cresciuta notevolmente»,
osserva Khaled Abu Toameh, «a causa del lancio di migliaia di razzi e missili in
tutto Israele». I palestinesi, arguisce Toameh, «considerano i leader di Hamas
come i veri eroi dei palestinesi e cercano di impegnarsi in una lotta armata
contro Israele»: non sopportano Mahmoud Abbas e l’Autorità Palestinese. In altre
parole, la sconfitta sul campo di battaglia ha apportato a Hamas importanti
vantaggi politici.
Spiegazioni
Da dove deriva questa impunità? Sei fattori
contribuiscono a spiegarlo: onore, fatalismo, cospirazionismo, retorica,
propaganda e confusione.
Onore. L’onore riveste importanza tra gli
arabofoni al punto che tenerlo alto può contare più del raggiungimento
dell’obiettivo. «Per gli arabi, l’onore è più importante dei fatti», spiega
Margaret K. Nydell, insomma, la causa conta più dei risultati ottenuti. Elie
Salem concorda, e parlando degli arabi dice: «Sono stati glorificati per i loro
intenti, non per i loro risultati». Questo spiega perché «nel perdere la guerra
del giugno 1967, Jamal Abd al-Nasir divenne un eroe. Ottenendo la pace, ma
dissentendo dalla prevalente psicologia araba, Anwar al-Sadat divenne un
infame». Più in generale, Fouad Ajami spiega:
In una storia politica araba disseminata di sogni
infranti poco onore sarebbe stato concesso ai pragmatici che conoscevano i
limiti di ciò che si poteva e non si poteva fare. La cultura politica del
nazionalismo ha riservato la sua approvazione a coloro che hanno condotto
campagne rovinose perseguendo missioni impossibili.
Fatalismo. Il participio passato maktùb (scritto)
riassume il fatalismo musulmano, pertanto, non il leader non va incolpato. As’ad
Abu Khalil della California State University osserva la tendenza a spiegare in
tempi di sconfitta che «le persone non hanno alcuna influenza né alcun effetto
sulle loro azioni e sui loro comportamenti. È solo Dio che agisce». Invocando
«l’ineluttabilità del destino», assolvono «i regimi e gli eserciti arabi da ogni
responsabilità» per la sconfitta. Questo schema, osserva, «è diventato tipico al
punto da essere prevedibile».
Così, all’indomani della disfatta israeliana delle
forze armate egiziane nel giugno 1967, Nasser cercò di dimostrare che né lui né
l’esercito avrebbero potuto evitare la sconfitta subita. Per assolvere il suo
governo dalla colpa e segnalare che non avrebbe potuto fare altro che quello che
aveva fatto, ricorse a un proverbio arabo («La precauzione non cambia il corso
del destino») e a un’analogia quotidiana (l’Egitto era «come un uomo investito
in strada da un’auto»). Al contempo, re Hussein di Giordania consolò i suoi
sudditi con questa riflessione: «Se non siete stati ricompensati con la gloria,
non è stato perché vi mancasse il coraggio, ma perché è volontà di Allah».
Cospirazionismo. Il cospirazionismo presuppone che
ogni scontro con Israele o con le potenze occidentali implica che il nemico
intende eliminare i loro governanti, occupare i loro Paesi, cambiare i loro
sistemi politici e sfruttare le loro risorse. Quando queste implicazioni non si
verificano, la loro elusione viene dipinta come una vittoria. Abdel-Moneim
Said, un analista egiziano, osserva: «Abbiamo celebrato la vittoria perché il
nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi come li abbiamo definiti.
Quanto ai nostri obiettivi, è stato dato per scontato fin dall’inizio che non
sarebbero entrati nelle nostre equazioni di guerra e pace». Ad esempio, gli
egiziani ritenevano che questo fosse l’obiettivo israeliano nel 1967, sostenuto
dagli Stati Uniti, e Said ricorda la sua esperienza in una pubblicazione
studentesca dopo quella perdita: «Con mia grande sorpresa, ho scoperto che
alcuni dei miei colleghi di quel giornale credeva che avessimo vinto la guerra
del 1967!». In che modo?
La logica era la seguente: lo scopo
dell’aggressione israelo-americana era quello di rovesciare il glorioso
presidente e il sistema socialista in Egitto, ma dato che il presidente era
ancora al potere dopo che la popolazione aveva sfilato in manifestazioni di
massa a suo sostegno e della sua saggia leadership, il 9 e il 10 giugno, e dato
che il sistema socialista era ancora in vigore, i nemici non avevano raggiunto i
loro obiettivi. Quindi, abbiamo vinto!
Said rileva che questa stessa “linea generale di
logica” prevale in altri casi, come per Saddam Hussein dopo la guerra del Kuwait
del 1991, per Hassan Nasrallah dopo la guerra tra Hezbollah e Israele del 2006,
per Bashar Assad nella guerra civile siriana e i combattimenti del 2014 tra
Hamas e Israele.
Nel caso del 2014, Said nota l’enorme disparità di
morti in guerra (2.100 palestinesi contro 72 israeliani) e di distruzione,
quindi conclude che «i risultati della recente guerra a Gaza difficilmente
possono essere considerati una vittoria palestinese». Tuttavia, i leader di
Hamas hanno proclamato la vittoria sulla base del fatto che «l’obiettivo
israeliano era eliminare Hamas e porre fine al lancio di missili. Pertanto,
finché sia Hamas sia i missili esisteranno, i palestinesi dovrebbero gioire di
questa clamorosa vittoria».
Retorica. La retorica è una caratteristica di
spicco della vita politica araba, che fa sì che leader e seguaci siano
affascinati dal potere delle parole anche se estranee alla realtà. E. Shouby, di
madrelingua araba e psicologo, nel 1951, disse che gli arabofoni «enfatizzavano
il significato delle parole in quanto tali, prestando meno attenzione al loro
significato» rispetto a quanto avviene nelle lingue occidentali, portando a una
«confusione tra le parole e le cose che rappresentano». Walter Laqueur notò nel
1968 la «capacità quasi illimitata [degli arabi] di credere ciò che vogliono
credere».
Theodore Draper spiegò ulteriormente questa
nozione nel 1973:
Ogni volta che vengono citate dichiarazioni arabe,
sorge la questione della “retorica” araba. Dovrebbe essere presa sul serio o
gli arabi sono propriamente dediti a una retorica esagerata? Ogni volta che un
portavoce arabo dice qualcosa di particolarmente provocatorio o di oltraggioso,
c’è sempre qualcuno che dice che «non lo pensano mai veramente». (…) Ho perfino
sentito il ministro degli Esteri di un Paese arabo informare un gruppo di
americani che gli arabi sono allergici al razionalismo occidentale e che, se gli
occidentali desiderano trattare con gli arabi, devono adottare l’apparentemente
irrazionale modo di pensare arabo.
Propaganda. La propaganda induce alcuni leader
arabi a cercare sostegno per la loro causa. Curiosamente, questo assume due
forme opposte, una per gli arabi e i musulmani, l’altra per gli israeliani e la
Sinistra globale. Nel primo caso entra in gioco l’adagio del “cavallo forte”: i
governanti cercano di mostrarsi come figure eroiche che le masse dovrebbero
seguire. I motivi per cui Saddam Hussein ha conquistato la maggior parte del
mondo occidentale sono così spiegati da Hussein Sumaida, un iracheno: «Vincere
non contava. Quello che importava era dare spettacolo e conquistare i cuori e le
menti del mondo arabo focoso».
Gli israeliani e la Sinistra globale rispondono
all’esatto contrario, vale a dire presentarsi come deboli e vittime comprensivi.
A tal fine, Hamas attacca periodicamente (2008-2009, 2012, 2014, 2021) Israele,
sapendo molto bene di perdere sul campo di battaglia militare, ma aspettandosi
di ottenere un vantaggio nell’arena politica: tra la Sinistra israeliana, nei
campus universitari di tutto il mondo, nella stampa internazionale, nelle
organizzazioni internazionali, e non solo.
Barry Rubin la definisce la strategia del suicidio
e ne parafrasa la logica: «Inizierò una guerra che non posso vincere per creare
una situazione in cui l’altra parte distrugga la mia infrastruttura e uccida la
mia gente. Allora perderò militarmente, ma vincerò la battaglia. Come?» Rubin
elenca tre vantaggi: gli israeliani sono codardi, quindi qualsiasi danno
subiscono li farà tirare indietro; la sofferenza degli abitanti di Gaza farà
sentire in colpa gli israeliani e si ritireranno; la “comunità internazionale”
spingerà gli israeliani a smettere di combattere e a concedere benefici a Hamas.
Confusione. Qual è la verità? Presi tra due
resoconti contraddittori della realtà, gli esseri umani tendono a optare per
quello che preferiscono, che si tratti di immigrazione (Angela Merkel: Wir
schaffen das [“Ce la faremo!”]), di prospettive referendarie (Brexit), o di
esito delle elezioni (Stop the steal [Fermate il furto]). Cosa pensare quando
“Baghdad Bob” dice che gli americani troverebbero il loro “cimitero” a Baghdad
nel momento in cui cominceranno a intravedersi i carri armati statunitensi?
Naturalmente, quando Saddam Hussein venne catturato, alcuni arabi reagirono con
incredulità, e un certo Hassan Abdel Hamid, un commerciante egiziano, si rifiutò
di credere alla notizia, definendola «propaganda e bugie americane». Questo
miasma incoraggia le popolazioni arabe a ignorare la realtà delle sconfitte
militari, così come i massacri che provocano, e ad appoggiare piuttosto questi
leader.
Conclusione
Questo modello di sopravvivenza o di beneficio
dalla sconfitta si estende ad altri leader. Nella guerra indo-pakistana del
1965, ad esempio, il ministro degli Esteri pakistano Zulfikar Ali Bhutto guidò
il suo governo in un disastroso conflitto con l’India e ne uscì più popolare che
mai, e questo lo portò a ricoprire la carica di primo ministro otto anni dopo.
Nelle parole del suo biografo, «Quanto più diventava oltraggiosa la sua retorica
(…) tanto più Zulfi Bhutto appariva eroico al pubblico pakistano». Allo stesso
modo, la leadership iraniana estese la sua guerra con l’Iraq e passò all’attacco
dal luglio 1982 all’agosto 1988; fallita questa offensiva, l’Ayatollah Khomeini
«bevve dal calice avvelenato» accettò un cessate il fuoco, e né lui né il suo
regime soffrirono per i loro sei anni di follia. Più di recente, le cupe
avventure militari di Recep Tayyip Erdoğan in Siria e in Libia non hanno
intaccato il suo potere.
Al contrario, perdere le guerre di solito ha
importanti implicazioni per un leader non musulmano. In Medio Oriente, Golda
Meir e Moshe Dayan pagarono a caro prezzo la deludente prestazione israeliana
del 1973, così come Nikol Pashinyan per la terribile esibizione armena del 2020.
Anche le sconfitte nelle guerre periferiche di solito hanno un impatto
importante: l’Algeria sulla politica francese, il Vietnam su quella americana e
l’Afghanistan sulla politica sovietica. È particolarmente difficile immaginare
leader non musulmani che sopravvivano a sconfitte così devastanti come quella
dell’Egitto, nel 1967, e dell’Iraq, nel 1991.
Il fatto che i governanti sconfitti possano
celebrare le disfatte invita al rischio morale e li rende più aggressivi. Perché
preoccuparsi se una sconfitta e le sue terribili implicazioni non ti riguardano?
Questo schema spiega ampiamente perché il Medio Oriente è teatro di così tante
guerre. Il denaro per le armi è sempre abbondante, la sofferenza della
popolazione è irrilevante, le perdite economiche sono insignificanti e il
governante può aspettarsi di sopravvivere illeso. Con una posta in gioco così
bassa, occorre dare una possibilità alla guerra e sperare per il meglio.
Daniel Pipes e Middle East Quarterly, traduzione
di Angelita La Spada.
Chi è Lehava, il movimento
estremista anti-assimilazione.
Futura D'Aprile su Inside Over
il 14 giugno 2021. Prevenire l’assimilazione della Terra Santa è sia il nome che
la missione di Lehava, il gruppo estremista che sta guadagnando sempre più
consensi in Israele e in particolar modo a Gerusalemme. Il movimento, fondato
nel 2015 da Bentzi Gopstein, chiede l’espulsione dei palestinesi, l’annessione
della Cisgiordania (e non solo) allo Stato di Israele, il divieto di matrimoni
misti e l’allontanamento dei cristiani dalla Terra Santa. Il successo di Lehava
è in crescita da quando la formazione Sionismo religioso, creata alla vigilia
delle elezioni grazie agli sforzi di Benjamin Netanyahu, è riuscita ad entrare
nella Knesset, segno dello spostamento sempre più a destra di una parte della
popolazione israeliana.
Come nasce Lehava. Lehava è
stato fondato nel 2005 dal 51enne Bentzi Gopstein, studente del rabbino Meir
Kahane e seguace del Kahanismo, l’ideologia alla base del movimento politico
Kach bandito da Israele negli anni Novanta. Il partito fu escluso dalle elezioni
del 1988 e del 1992 e definitivamente sciolto nel 1994 sulla base della Legge
elettorale che bandiva formazioni considerate razziste. Ad oggi, sia Kach che
Kahane Chai – formazione nata nel 1990 dopo l’assassinio del rabbino Kahane –
sono considerate organizzazioni terroristiche da Israele, Stati Uniti, Canada,
Giappone ed Unione europea. Nel 2015, secondo quanto riportato da Channel 2,
l’allora ministro della Difesa Moshe Ya’alon aveva chiesto allo Shin Bet di
raccogliere informazioni sul movimento per una eventuale classificazione quale
entità terroristica. Tra gli idoli di Lehava, oltre a Kahane, vi è anche Baruch
Goldstein, l’uomo che nel 1994 aprì il fuoco nella Moschea di Abramo
a Hebron durante le preghiere per il Ramadan, causando la morte di 29 fedeli.
Come si legge sulla pagina ufficiale, il movimento nasce per proteggere le donne
ebree, contrastando la nascita di relazioni con uomini appartenenti ad altre
religioni o riportando sulla “retta via” le ragazze che si sono allontanate
dalla comunità di appartenenza.
Cosa vuole Lehava. Alla base
dell’ideologia di Kahane, a cui Lehava si ispira, vi è la creazione del Grande
Israele, uno Stato unicamente ebraico che comprenda non solo la Cisgiordania, ma
anche il Sinai egiziano, il Libano, la Siria e parte dell’Iraq. La creazione di
una terra per i soli ebrei implica non solo l’espulsione degli arabi, ma anche
di coloro che non appartengono alla religione ebraica. Il movimento
anti-assimilazione si è distinto fin dal primo momento per la sua totale
avversione ai matrimoni misti, principale motore della tanto temuta
assimilazione contro cui Lehava si batte. Emblematico a questo proposito fu
l’opposizione che il gruppo dimostrò nel 2014 nei confronti del matrimonio tra
il palestinese Mahmoud Mansour e Morel Malka, ebrea convertitasi all’islam. I
seguaci di Lehava inscenarono delle vere e proprie proteste durante la
celebrazione delle nozze per convincere Morel Malka a tornare sui suoi passi. Ma
a finire nel mirino del movimento estremista non sono solo gli arabi. Nel 2015,
Gopstein organizzò delle manifestazioni contro la celebrazione del Natale in
Israele, definendo i cristiani dei “vampiri” e chiedendone l’allontanamento
dalla Terra Santa. “Gli ebrei non possono essere uccisi, ma possono essere
convertiti”, aveva scritto al tempo Gopstein. “Dobbiamo cacciare questi vampiri
prima che succhino nuovamente il nostro sangue”. Lo stesso anno, il fondatore di
Lehava era anche stato interrogato dalla polizia dopo aver giustificato il rogo
delle Chiese presenti in Israele in quanto luoghi di culto di falsi idoli. Una
convinzione in linea con il Kahanismo, secondo cui anche la Moschea al-Aqsa a
Gerusalemme dovrebbe essere rasa al suolo per costruire al suo posto il Terzo
Tempio.
Un successo crescente.
Le elezioni di marzo 2021 e le proteste che hanno infiammato Gerusalemme il mese
seguente sono due eventi importanti per capire l’attuale successo di Lehava. I
movimenti khanisti erano assenti dallo spettro parlamentare israeliano dagli
anni Ottanta, ma le ultime elezioni hanno sancito l’entrata nella Knesset
di Sionismo religioso, una formazione di estrema destra erede del partito Kach.
Al suo interno vi è anche Otzma Yehudit (Potere ebraico) dell’avvocato Itamar
Ben-Gvir, considerato una delle figure più influenti all’interno di Lehava.
L’entrata in Parlamento di Sionismo religioso e la possibilità che faccia parte
del prossimo governo preoccupano buona parte dell’opinione pubblica israeliana,
ma sono il segno di un costante spostamento sempre più a destra di una parte
dell’elettorato. Il movimento può anche fare affidamento sulla tacita
approvazione delle autorità nei confronti delle sue manifestazioni. A fine
aprile i seguaci di Lehava hanno organizzato una marcia di protesta a
Gerusalemme scandendo slogan come “Morte agli arabi” e attaccando i passanti
senza alcun ostacolo da parte delle forze dell’ordine, che hanno invece represso
duramente le manifestazioni dei palestinesi svoltesi negli stessi giorni.
Deposto il re, ecco cosa Bennett non può
evitare nel post Netanyahu. Alberto Stabile su
L'Espresso/La Repubblica il 15 giugno 2021. Dal conflitto con Hamas alla
questione del nucleare iraniano. I dossier che il nuovo governo deve affrontare
senza poter prescindere dall’eredità di Bibi. Grazie ad un accordo ad
excludendum, traducibile anche come un pasticcio in cui otto partiti che più
diversi fra di loro non si può si sono ritrovati concordi sull'unico proposito
d'impedire a Benyamin Netanyahu di guidare per l'ennesima volta il governo
d'Israele, e sul resto delle questioni più urgenti hanno scelto di tacere, tanto
non si sarebbero trovati d'accordo su nulla, hanno raggiunto il loro obbiettivo
e quello che era stato definito dai suoi inguaribili sostenitori “il re
d'Israele”, titolo che il popolo della destra israeliana aveva già generosamente
conferito ad Ariel (Arik) Sharon, è stato alla fine spodestato. Al posto di
primo ministro che il popolare Bibi aveva ricoperto per oltre dodici anni, un
record superato forse soltanto dal fondatore dello stato ebraico, David Ben
Gurion, arriva un personaggio incolore, di modesta statura politica, leader di
un partito marginale nella galassia dell'estrema destra nazionalista religiosa,
rivelatosi più abile ad arricchirsi con una start-up riguardante un sistema di
sicurezza per le banche, che a progredire nella carriera militare abbracciata
entusiasticamente nel mito di Yoni Netanyahu, il fratello di Bibi, l'eroico
comandante dei Commando dello Stato Maggiore (Sayeret Matkal) morto ad Entebbe
il 4 luglio del 1976 in quella che viene tutt'ora considerata come la più ardita
operazione militare per la liberazione di ostaggi nella storia d'Israele.
Naftali Bennett, questo il nome del nuovo premier, era molto attratto anche
dall'altro Netanyahu, il politico, al punto che quando nel 2005 Bibi ascese al
vertice del partito conservatore, Likud, sebbene un Likud dissanguato dalla
fuoriuscita di Sharon e dei tanti che lo avevano seguito nella nuova formazione
da lui fondata, Kadima, dopo il ritiro dagli insediamenti nella Striscia di
Gaza, anche Bennett entrò nel Likud e più tardi sarebbe diventato chief of
staff, capo di gabinetto, di Netanyahu. Ma per poco, perché la costanza dei
legami politici non sembra essere una virtù del nostro, il quale nel 2009
capisce che potrà ottenere molto più da alleato che da seguace di Bibi e fonda
la Casa Ebraica, il primo di una serie di partitini colonialisti e razzisti,
accomunati dalla fede assoluta nella Terra d'Israele (Eretz Israel) e nella
necessità di riscattarla strappandola ai palestinesi. Gli stessi estremisti che
adesso accusano Bennett di aver tradito la causa, dando vita ad un governo con i
“sostenitori del terrorismo”, allusione al partito arabo guidato dal leader
palestinese-israeliano Mansour Abbass, entrato a far parte del governo che
domenica scorsa ha ottenuto la fiducia. Il governo del “minimo sindacale”,
potremmo definirlo, dopo aver seguito attentamente il discorso programmatico
pronunciato alla Knesset del nuovo premier e letto le interviste del
co-fondatore della nuova maggioranza del “cambiamento”, Yair Lapid, leader del
partito centrista Yesh Atid (“C'è un futuro”) una sorta di “Yes we can”
all'israeliana. Il nuovo governo, in realtà una specie di caleidoscopica
alleanza di sinistra-centro-destra efficacemente riassunta nello slogan “con
tutti tranne che con Bibi”, farà tutto quello su cui i suoi partecipanti sono
già d'accordo, vale a dire qualche riforma, la ferrovia Gerusalemme-Tel Aviv,
l'Università della Galilea, ovviamente amplierà gli investimenti militari, ma
metterà da parte tutto il resto. Che non è poco. L'incendio divampato il mese
scorso tra Sheik Jarrah, Gaza e la Galilea, provocando l'ennesima guerra contro
Hamas e la risposta mai così temeraria di Hamas contro il territorio israeliano
con migliaia di razzi, i morti tra i civili palestinesi, gli scontri all'interno
della moschea Al Aqsa e i gravi incidenti tra le due comunità scoppiati nelle
città a popolazione mista araba ed ebraica, hanno rappresentato per il nuovo
premier, Bennett, il “promemoria che il conflitto coi palestinesi è ancora qui”.
Vero. È lì da quasi cento anni, e almeno 73, ufficialmente se solo si contano le
guerre guerreggiate. Ma come intende affrontarlo il nuovo governo? A sentire
Bennett, sembra di riascoltare le frasi ripetute fino alla noia da Netanyahu,
contro “i nostri nemici che negano la nostra stessa esistenza nella Terra
d'Israele”. E questo a premessa che “non si tratta di un conflitto sopra la
terra”, il che palesemente è. Ma per venirne a capo occorre “forza militare,
resilienza e fede nella giusta causa”, che, par di capire, si tradurrà nel
“rafforzare gli insediamenti in tutta la Terra d'Israele”, con un'enfasi
particolare sulla parola “tutta”. Assieme al monito che, riecheggiando una frase
del leader del Movimento revisionista ebraico, Vladimir Jabotinski, avverte
Hamas di non provarci a mettere in dubbio la capacità di deterrenza israeliana,
o sarà costretta a scontrarsi contro un “muro di ferro”. Quanto all'Iran, idem:
Israele non permetterà che la Repubblica islamica acquisisca la bomba atomica.
Lo Stato ebraico si ritiene libero di agire. Perché, ha detto Bennett,
“soffriamo ancora delle conseguenze sul nucleare che ha imbaldanzito l'Iran a
suon di miliardi di dollari e gli ha offerto legittimazione internazionale”.
Conclusione, che segnala una prima evidente dissonanza nei confronti di Biden e
dei tentativi in atto da parte della nuova amministrazione di ricostruire il
tessuto diplomatico che rese possibile il dialogo tra Usa e Iran, “un nuovo
accordo sarebbe un errore”. Accenno che a Netanyahu deve esser sembrato acqua
fresca al confronto con le sue sparate contro il “peggior accordo diplomatico
mai firmato nella storia”, i disegni sulla bomba sventolati all'Assemblea
generale dell'Onu, l'odio manifestato verso Obama con l'insultante discorso al
Congresso americano e, infine, il sostegno incondizionato offerto a Trump nella
decisione di rompere un trattato che, anche secondo i servizi d'Intelligence
americani, l'Iran aveva rispettato. Così, il fantasma del sovrano deposto
continuava ad svolazzare sugli scranni della Knesset resi invivibili
dall'aggressività dei deputati ultra nazionalisti e, l'indomani, nei commenti
dei giornali, impegnati ad accompagnare l'uscita di scena dell'ennesimo re
d'Israele con un coro degno dell'occasione e dunque a riconoscere che c'era
stato del buono nel suo lungo regno e non soltanto del marcio. Anche se, certo,
provocare quattro elezioni in due anni, attaccare frontalmente istituzioni che
sembravano al di sopra della ciarla politica, come la magistratura, o la
polizia, o alcuni Capi di Stato Maggiore, seminare la divisione nel paese
accusando gli “arabi (israeliani) di marciare in massa verso le urne”, favorire
l'estremismo dei gruppi razzisti e fanatici cui ha teso la mano e proposto
alleanze, e tutto questo per evitare di finire sul banco degli imputati, questo,
alla fine, è quello che ha provocato la rivolta di molta parte del mondo
politico, mascherata da “governo del cambiamento”, e da “con tutti tranne che
con Bibi”. Ma come negare, altresì, i risultati ottenuti? Fra questi vengono
elencati: la decisione di Trump di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a
Gerusalemme, con l'evidente riconoscimento dell'annessione unilaterale della
parte orientale della città e l'altrettanto unilaterale riconoscimento che
trattasi della “capitale unita e indivisibile “dello Stato d'Israele; il
riconoscimento americano della sovranità israeliana sulle alture del Golan,
territorio siriano strappato alla Siria nella guerra del 1967; la
“compartimentazione” del conflitto coi palestinesi per usare un termine che
vorrebbe essere elogiativo adoperato dal New York Times, e la sua riduzione
della resistenza contro la spietata occupazione militare a semplice problema di
ordine pubblico; l'espansione degli insediamenti e infine, udite udite, gli
accordi di Abramo che hanno permesso a Netanyahu di dimostrare quanto fondato
fosse il suo assunto secondo cui non esiste alcuna questione palestinese che, se
non risolta, impedirebbe la pace tra Israele e i Paese Arabi, perché Emirati
Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan alla fine, hanno firmato accordi con
Israele. Ovviamente non si dice che ad ognuno di questi paesi, gli Stati Uniti
(Trump) hanno offerto importanti concessioni e che i palestinesi, cioè
l'incarnazione vivente di uno dei più lunghi e sanguinosi conflitti della storia
moderna, sono del tutto assenti dalla retorica degli accordi di Abramo stretti
fra i popoli discendenti del profeta. Ad osservarle attentamente, le conquiste
di Netanyahu sembrano altrettanti colpi mortali inferti al processo di pace, ma
c'è da aggiungere che esse non sarebbero state possibili senza la condiscendenza
degli Stati Uniti e il silenzio complice della comunità internazionale,
paralizzata dai ricatti di Trump. Ma quando è esplosa la guerra di Gaza,
l'ultima, davanti alle scene agghiaccianti dei palazzi sbriciolati sotto le
bombe a guida intelligente americane esportate in israeliane, anche i quattro
aderenti agli accordi di Abramo hanno minacciato di richiamare gli ambasciatori.
Ma questo nessuno l'ha scritto.
È la prima volta dopo 12
anni. Naftali Bennett è il nuovo premier di Israele: finisce l’era di Netanyahu.
Elena Del
Mastro su Il Riformista il 13 Giugno 2021. Finisce l’era di Benjamin Netanyahu.
Con una risicata maggioranza di 60 voti contro 59, la Knesset ha accordato la
fiducia al nuovo governo di Israele guidato da Natali Bennett. Per la prima
volta da 12 anni un governo senza Netanyahu. Ultrazionalista di destra, a capo
del piccolo partito Yamina, Bennett ha giurato da premier pochi minuti dopo la
votazione. Guida una coalizione varia e fragile che include otto partiti con
profonde differenze ideologiche: in base all’accordo di coalizione, Bennett
resterà premier fino a settembre del 2023, poi la palla dovrebbe passare a Yair
Lapid, leader del centrista Yesh Atid, per altri due anni. Gli otto partiti che
compongono la coalizione, che includono una piccola formazione araba che fa la
storia entrando nel governo, sono uniti nell’opposizione a Netanyahu e a nuove
elezioni (il Paese ne ha già avute quattro in due anni) ma concordano su poco
altro. È probabile che proveranno a portare avanti un’agenda limitata che prova
a ridurre le tensioni con i palestinesi e a mantenere buone relazioni con gli
Usa senza lanciare altre grandi iniziative. Leader più a lungo in carica nella
storia di Israele, Netanyahu resta a capo del Likud e diventa leader
dell’opposizione. È stato premier la prima volta dal 1996 al 1999 e poi
continuativamente dal 2009 al 2021. Durante la votazione è rimasto seduto e in
silenzio; poi, indossando una mascherina nera, si è alzato e ha stretto la mano
a Bennett, prima di sedersi brevemente sulla poltrona del leader
dell’opposizione e andare via. Lui, che è a processo per corruzione, resta il
capo del più grande partito in Parlamento, il Likud, ed è atteso che farà
un’opposizione molto forte. Se anche un solo partito della coalizione cedesse,
il governo potrebbe cadere e per lui si aprirebbe un’opportunità di tornare al
potere. La promessa di tornare a guidare il Paese Netanyahu l’ha fatta
nell’acceso dibattito alla Knesset che ha preceduto la fiducia a Bennett: “Se è
nostro destino essere all’opposizione, lo faremo a testa alta” e “se Dio vorrà,
rovesceremo” il governo “prima di quanto pensiate”, ha detto l’ormai ex premier.
Per lui, “l’Iran sta festeggiando perché questo è un governo debole”. Dal canto
suo Bennett, che durante il suo intervento è stato contestato dall’opposizione,
ha assicurato che “Israele non permetterà all’Iran di armarsi di armi nucleari”
e “non sarà parte dell’accordo” sul nucleare, il cui rinnovo reputa un errore.
Lo stallo politico è cominciato ad aprile del 2019, quando nelle elezioni
Netanyahu non riuscì a ottenere il sostegno sufficiente a formare una nuova
coalizione di governo. Seguirono altre due elezioni senza un esito chiaro. Le
terze elezioni portarono a un governo di unità nazionale in cui Netanyahu
accettò di condividere il potere con l’allora leader dell’opposizione Benny
Gantz, ma l’accordo saltò a dicembre, facendo scattare le quarte elezioni. Pur
avendo ottenuto la maggioranza nella Knesset, Netanyahu non è stato in grado di
formare un governo, aprendo la strada a questa nuova coalizione.
(Fonte:LaPresse)
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Israele, finisce l'era
Netanyahu: al suo posto Bennett. Quale futuro per la Palestina?
Le Iene News il 14 giugno
2021. Dopo 12 anni consecutivi al governo, Benjamin Netanyahu è costretto a
lasciare la carica di primo ministro d’Israele. Al suo posto arriva Naftali
Bennett, alla guida di una eterogenea coalizione che potrebbe avere breve
durata. Il nuovo premier sembra avere idee molto simili al suo predecessore
sullo scontro tra israeliani ed ebrei: ci sarà mai la pace? Quando Benjamin
Netanyahu assunse la carica di primo ministro d’Israele, il mondo era molto
diverso da come lo conosciamo oggi. Barack Obama si era insediato da poche
settimane come presidente degli Stati Uniti; in Italia Silvio Berlusconi guidava
stabile il suo quarto governo; Instagram e Tik Tok non esistevano; la grande
crisi finanziaria che ha travolto l’Europa non aveva ancora cambiato il nostro
modo di vivere. Era il 31 marzo del 2009. Nel suo discorso di insediamento, Bibi
- così è soprannominato Netanyahu - assicurò che lui non intendeva dominare i
palestinesi, ma anzi era disposto a concedere loro i poteri di autogoverno,
esclusi quelli che avrebbero messo - secondo lui - a rischio lo stato d’Israele.
Da pochi anni era finita la "Seconda Intifada", una rivolta palestinese contro
l’oppressione esercitata da Tel Aviv in quei territori. Ieri, il 13 giugno del
2021, Bibi ha lasciato lo scranno occupato per oltre 12 anni, il più lungo
mandato nella storia di Israele. E lo ha fatto subito dopo la fine dell’ennesima
crisi arabo israeliana, che in due settimane ha lasciato sul selciato centinaia
di morti (soprattutto palestinesi). I rapporti tra palestinesi e israeliani sono
stati spesso, probabilmente troppo spesso, al centro della scena politica
durante i 12 anni consecutivi di mandato di Benjamin Netanyahu (ne ha servito
anche un altro, tra il 1996 e il 1999). Continue tensioni e scontri che hanno
portato l’ormai ex primo ministro a spostarsi, negli anni, da posizioni
centriste a posizioni sempre più oltranziste nei confronti dei palestinesi e dei
paesi vicini con cui Israele ha pessimi rapporti diplomatici, tra tutti l’Iran.
Secondo Haaretz, tra i più importanti quotidiani d’Israele, Netanyahu è arrivato
a convincere gli israeliani che l’occupazione dei territori palestinesi non solo
è sostenibile, ma anche conveniente. La promessa di concedere ai palestinesi la
loro sovranità è ormai sbiadita, lontanissima nel tempo. E sbiadita nel
frattempo è anche la leadership dello stesso Netanyahu, costretto a lasciare lo
scranno più importante della politica israeliana dopo due anni ininterrotti di
crisi di governo. A prendere il suo posto è Naftali Bennett, che è stato
assistente di Netanyahu molti anni fa e adesso è a capo del partito dei coloni
israeliani, il più oltranzista nelle posizioni contro i palestinesi. Guida una
colazione raccogliticcia, che va dalla destra al centro alla sinistra fino al
partito arabo conservatore, che per la prima volta accede a un governo
israeliano. La sua maggioranza si regge sull’astensione di uno dei 120 deputati
della Knesset, e c’è chi è pronto a giurare che il nuovo esecutivo avrà vita
brevissima. In effetti, a ben guardare i partiti che compongono la nuova
coalizione di governo, è chiaro che a unirli sia un solo desiderio: mandare a
casa Benjamin Netanyahu e la sua destra religiosa. Ma la cacciata di Bibi non
sembra, e quasi sicuramente non sarà, sufficiente a riaccendere la speranza di
pace tra israeliani e palestinesi: Naftali Bennett in passato si è espresso
chiaramente contro la soluzione dei due stati. E non solo: Bennett è pure
contrario a riconoscere pari diritti tra i cittadini israeliani ebrei e non
ebrei. Nel 2013, parlando dell’occupazione della Cisgiordania, disse che “non
esisteva” perché “non c’è mai stato uno Stato palestinese qui”. Annunciando
l’accordo con il partito centrista e laico di Yair Lapid - rinnegando una
promessa fatta in campagna elettorale - ha subito dichiarato che il suo governo
“non farà ritiri e non consegnerà territori” ai palestinesi. Insomma il cambio
di guida in Israele potrebbe portare a molti cambiamenti, ma difficilmente
questi riguarderanno gli scontri tra arabi e israeliani. Una guerra infinta, che
dura da cento anni e di cui non si vede la fine: noi de Le Iene abbiamo provato
a raccontarvela nel corso degli anni, con una serie di servizi realizzati sia in
Israele che nei Territori palestinesi. Abbiamo provato a raccontarvi quanto
abbiamo compreso di questo scontro, ascoltando le voci sia dell’una che
dell’altra parte. Potete rivedere i nostri servizi nel video in testa a questo
articolo. Con la speranza che un giorno questo lungo e durissimo conflitto possa
finalmente vedere la parola fine.
La complessa agenda
economica di Naftali Bennett punta sulla tecnologia.
Andrea Muratore su Inside Over
il 14 giugno 2021. Naftali Bennett si è insediato alla guida del governo di
larghe intese che in Israele ha detronizzato, dopo dodici anni, Benjamin
Netanyahu, scalzato assieme al suo Likud dal potere di larga coalizione
imbastito dal leader di Yamina, formazione nazionalista di destra, e nuovo
premier di Tel Aviv e dal leader centrista Yair Lapid, che si alternerà con
Bennett nel 2023 come premier. L’ampia coalizione che forma l’esecutivo, che
comprende anche il partito Bianco e Blu dell’ex militare Benny Gantz, i
labruisti, i verdi di Meretz, la destra religiosa di Focolare Ebraico e,
attraverso il loro appoggio esterno, la Lista Araba Unita, è in larga
parte coesa dalla volontà di mettere in minoranza Netanyahu e spingerlo
all’opposizione dopo lungo tempo. “Il potere logora chi non ce l’ha”,
diceva Giulio Andreotti, e questa prassi è stata accolta dai partner della nuova
coalizione che mirano a trovare coesione e una comune direzione di marcia nel
compattamento dell’esecutivo attorno al ritorno dei partiti a lungo messi
all’opposizione o ridotti a partner di minoranza del Likud. Per rendere meno
brusco il cambio di guida al vertice di Israele e favorire una linea di
continuità, Bennett ha anche deciso di mantenere nel loro incarico due pedine
chiave della catena di comando dell’ex premier Netanyahu. Si tratta del
Consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat e di quello militare Avi
Blut. Dove invece si potranno vedere maggiori discontinuità è in campo
economico. Il motivo è chiaro: un esecutivo tanto complesso nasce per garantire
la difesa dello status quo in diversi campi, dal conflitto coi palestinesi alla
questione dei coloni, cristallizzando i focolai di tensione politica e spingendo
al dialogo forze contrastanti o addirittura diametralmente opposte. Ma per i
suoi connotati eterogenei l’esecutivo di Bennet non potrà non orientare su altri
punti dell’agenda le sue priorità. L’economia, il rafforzamento della sicurezza
industriale e produttiva di Israele, la lotta alle disuguaglianze sono
fondamentali per lo Stato ebraico: in primo luogo perché temi meno divisivi; in
secondo luogo perché volano per una possibile vittoria politica di lungo termine
qualora, per fare un esempio ben comprensibile, a beneficiarne fosse l’intera
massa della popolazione, araba ed ebraica. L’obiettivo è creare sviluppo e
garantire coesione al Paese. Bennett si troverà a gestire un’agenda economica da
lui già guidata dal 2013 al 2015 in qualità di ministro di Netanyahu. L’ex
manager e imprenditore nel settore della cybersicurezza ha una visione complessa
dell’agone economico. Bennett ritiene infatti, da un lato, che sia necessario in
Israele un minor intervento pubblico dello Stato nell’economia così come una
riduzione delle facoltà di manovra di apparati come il ministero della difesa in
seno al sistema nazionale nei settori strategici, ma ritiene anche che ciò si
debba coniugare con un maggior investimento in istruzione, coesione sociale e
incentivi all’occupazione per permettere la creazione di competenze nella
popolazione che si avvia all’età lavorativa, la trasformazione dei settori e la
coesione sociale. Soprattutto, il nazionalista Bennett non ha mai trascurato il
fatto che il lavoro, l’imprenditoria e l’istruzione possano essere la strada per
rafforzare l’integrazione degli arabo-israeliani, che già di base sperimentano
tenori di vita ben più dignitosi di quelli dei palestinesi, ma non sono ancora
ai livelli della maggioranza della popolazione. Non a caso
Bennett, nota StartMag, “nell’ultima campagna elettorale, all’inizio di
quest’anno, ha rivendicato la sua formazione manageriale per ‘guarire’
l’economia israeliana in crisi a causa dell’epidemia di Covid, con una ricetta
incentrata sul taglio delle tasse e deregulation”. Fondatore di Cyota, azienda
costruita negli Stati Uniti per occuparsi di cybersicurezza e lotta alle frodi,
venduta per 145 milioni di euro a Rsa Solutions nel 2005, Bennett è stato poi
amministratore delegato di Soluto, azienda pioneristica del cloud computing
venduta nel 2013 ad Asurion per oltre 100 milioni di dollari. Il nuovo premier
ritiene che le energie del Paese debbano in particolar modo focalizzarsi sul
rilancio dell’imprenditorialità dei suoi connazionali e sul coinvolgimento degli
arabi, specie nei settori ad alta tecnologia. Adam Fisher, partner del fondo di
investimento Bessemer che ha contribuito a far sviluppare finanziariamente
Soluto, ha dichiarato: “Spero che in Israele vedremo più personaggi dell’hi-tech
entrare in politica. L’hi-tech è il settore economico di punta del Paese, è
completamente indipendente, globale e al tempo stesso sionista. È inclusivo e
capace di portare insieme arabi e ebrei”. L’innovazione appare il volano
strategico per far ripartire l’economia. Anche nel durissimo 2020,
contraddistinto da continui lockdown, gli investimenti complessivi, pubblici e
privati, nell’innovazione hanno toccato quota 10,6 miliardi di dollari. Erano
stati un’enormità, 21,74 miliardi nel 2019, nota Corriere Comunicazioni: il
dimezzamento appare solo temporaneo e recuperabile. Inoltre, nello Stato ebraico
si contano 45 “unicorni”, società private attive nella tecnologia e
nell’informatica con valore superiore al miliardo di dollari, il 10% a livello
mondiale. Come spiega Jonathan Pacifici nel saggio “Gli unicorni non prendono il
Corona”, Israele ha mostrato punte di successo nella tecnologia anche durante la
pandemia. Sanità, sicurezza, energia, aerospazio: i settori in cui l’innovazione
ha fatto da driver fondamentale sono numerosissimi. Su questo tessuto Bennett
intende operare per rafforzare la fibra dell’economia israeliana, la cui
direzione sarà affidata a un “grande vecchio” della politica nazionale, Avigodr
Lieberman, esponente di peso di Focolare Ebraico, a lungo braccio destro di
Netanyahu ora alla guida delle finanze dopo essere stato ministro degli esteri
(2009-2012, 2013-2015) e della difesa (2016-2018). Bennett è un uomo di grande
esperienza e, come Liberman, ha ben chiaro il fatto che una delle direttrici su
cui l’economia israeliana può crescere è quella del rafforzamento commerciale di
Tel Aviv nei campi strategici e dell’alta tecnologia. Non a caso Bennett, già da
ministro dell’economia di Netanyahu, ha aperto la strada alla cooperazione
multilaterale con diversi Paesi del Medio Oriente, dell’Asia, dell’Africa per
rafforzare le partnership di Israele e la sua presenza in mercati terzi.
Un’espansione di Israele in mercati terzi si prevede decisiva per rilanciare
occupazione, lavoro e sviluppo sistemico. Così come può avvenire anche nel campo
del settore energetico che, dall’estrazione nel Mediterraneo alle rinnovabili,
vede Israele attivo su tutta la filiera. E si sa che energia e innovazione sono
settori saldamente uniti e interdipendenti. Poter mettere assieme istanze
ambientaliste, volontà di coesione sociale degli arabi, tutela del lavoro,
difesa della produzione e strategie per la ripartenza non sarà facile: ma
attorno all’innovazione Bennett ha sicuramente un perno su cui far ruotare una
strategia.
Chi è Naftali Bennett.
Futura
D'Aprile su Inside Over il 14 giugno 2021. Dopo essere stato per anni uno degli
uomini più vicini a Benjamin Netanyahu, Nafatli Bennett ha definitivamente preso
le distanze dal leader del Likud diventando il king maker delle elezioni di
marzo 2021. Ex ministro della Difesa, per gli Affari della diaspora,
dell’Economia e dell’Educazione, Bennett si è presentato alle ultime elezioni a
capo di Yamina, partito di estrema-destra da lui stesso fondato nel 2019,
ottenendo sette seggi. Durante la campagna elettorale non ha preso una posizione
esplicita nei confronti di Netanyahu, finendo così con il diventare l’ago della
bilancia nella formazione del nuovo governo e diventando il nuovo premier, di
fatto chiudendo l’era-Bibi. Ecco la sua storia:
Dall'esercito all'informatica.
Nato ad Haifa nel 1972 da genitori americani, Bennett ha passato i primi dieci
anni della sua vita tra Israele, Stati Uniti e Canada prima che la famiglia
decidesse di trasferirsi definitivamente ad Haifa. Sia la madre che il padre
sono ebrei ortodossi moderni, come lo stesso leader di Yamina.
Bennett ha servito
nell’esercito israeliano dal 1990 al 1996 e ha fatto parte della Sayeret Matkal,
l’unità militare di forze speciali con compiti di ricognizione, operazioni
antiterrorismo e raccolta di intelligence in territorio ostile. La Sayeret
Matkal si occupa anche del recupero ostaggi fuori dai confini dello Stato
ebraico. Di questa stessa unità fece parte anche il fratello di Benjamin
Netanyahu, Yonatan. Durante i suoi anni nella Sayeret Matkal, Bennett ha
raggiunto il grado di maggiore e ha continuato a servire come riservista,
venendo così richiamato durante la guerra in Libano nel 2006 per far parte
dell’unità Maglan, cui spettava il compito di svolgere missioni dietro le linee
nemiche. Dopo il 1999, Bennett ha ottenuto una laurea in Legge all’Università
ebraica di Gerusalemme e si è trasferito a Manhattan dove ha fondato la
compagnia di software anti-frode Cyota, successivamente venduta nel 2005 per 145
milioni di dollari. Grazie ai ricavi della vendita della sua start-up, Bennett
ha fatto ritorno in Israele ed è entrato in politica.
Carriera politica. Bennett ha
iniziato la sua carriera politica al fianco di Benjamin Netanyahu: ha ricoperto
per due anni – dal 2006 al 2008 – il ruolo di capo dello staff e si è occupato
della campagna per le primarie del Likud del 2007.
Nel 2010, Bennett è stato poi
nominato direttore generale dello Yesha Council, una lobby che si occupa di
promuovere la costruzione di insediamenti in Cisgiordania, un tema molto caro
all’attuale leader di Yamina. Bennett è rimasto nel Likud fino al 2012, quando
decise di unirsi a Casa ebraica candidandosi alle primarie per la leadership del
partito, in quel momento in forte crisi nei sondaggi. Sotto la sua guida, Casa
ebraica riuscì ad ottenere 12 seggi alle elezioni legislative del 2012 e Bennett
divenne ministro dell’Economia e degli Affari religiosi. Un mese dopo gli fu
affidato anche il ministero per gli Affari della diaspora. Nel governo Netanyahu
nato nel 2015, Bennett ottenne invece il ruolo di ministro dell’Istruzione, ma
rinunciò alla carica quello stesso anno, tornando a sedersi tra i banchi della
Knesset. L’ultimo incarico da lui ricoperto è stato quello di ministro della
Difesa dal 2019 al 2020. Entrato nuovamente in Parlamento nel 2018 con Casa
ebraica, Bennett decise di lasciare il partito per fondare insieme ad altri
parlamentari Nuova destra. L’esperimento fu fallimentare: alle elezioni del 2019
il partito non superò la soglia di sbarramento. Bennett però imparò subito la
lezione e diede vita a Yamina, una coalizione con Casa ebraica e Tkuma che vinse
sette seggi alle seguenti elezioni. La formazione ha avuto vita breve, ma il
successo di Yamina è rimasto invece stabile: in vista delle urne del 2021, Tkuma
– oggi Sionismo religioso – ha lasciato la coalizione, ma Bennett è comunque
riuscito a vincere sette seggi.
Pensiero politico di Bennett.
A livello economico, Bennett è considerato un ultraliberale. A suo parere, il
settore privato, vero motore dell’economia, deve essere il più libero possibile
dal controllo del governo, mentre le disparità sociali posso essere risolte
tramite maggiori investimenti nell’educazione. Da ministro dell’Economia ha poi
cercato di diversificare il settore dell’export, aprendo il Paese verso i
mercati di Africa, Asia e Sud America e riducendo così la dipendenza dall’Ue.
Hanno invece fatto discutere le sue affermazioni sui matrimoni dello stesso
sesso, a cui Bennett si oppone in quanto aderente alla corrente ortodossa. Da
ministro dell’Educazione ha invece vietato alle scuole di invitare in aula i
membri di Breaking the silence o qualsiasi altro movimento critico nei confronti
della presenza militare israeliana in Cisgiordania. Bennett è anche ricordato
per aver cercato di implementare delle politiche che portassero ad una maggiore
integrazione degli ultra-ortodossi e delle donne arabo-israeliane nel settore
dell’economia grazie a programmi di apprendimento specifici.
La questione palestinese. La
posizione di Bennett nei confronti della questione palestinese è chiara: nessuno
Stato palestinese indipendente e sovrano potrà mai vedere la luce. Grande
sostenitore dalla costruzione di insediamenti nei Territori occupati, Bennett ha
proposto di annettere a Israele l’area C della Cisgiordania offrendo ai
palestinesi che vi risiedono la possibilità di ottenere la cittadinanza
israeliana. Le aree A e B dovrebbero invece essere amministrate dall’Anp, con
Idf e Shin Bet ad occuparsi della sicurezza. Il piano di Bennett prevede anche
la costruzione di maggiori infrastrutture nell’area annessa e nelle restanti per
garantire la crescita economica di tutto il territorio. Gaza dovrebbe invece
passare sotto il controllo dell’Egitto. Il leader di Yamina è quindi contrario
alla soluzione dei due Stati e ritiene che non possa esserci alcuna soluzione
alla questione palestinese. Secondo Bennett è anche scorretto parlare di
occupazione israeliana della Cisgiordania dato che “non è mai esistito uno Stato
palestinese”. In caso di formazione di un nuovo governo con lui quale primo
ministro, Bennett si è tuttavia impegnato a non promuovere l’aumento degli
insediamenti nella West Bank.
CCla. Per "il Giornale" il 14
giugno 2021. Soldato coraggioso, milionario proprietario di società tecnologiche
che si è fatto da sé, attivista politico e poi leader di una sua formazione.
Naftali Bennett, l'uomo che ha scalzato Netanyahu, è scaltro, instancabile,
ambizioso, e molto sicuro di sé. È anche un grande giocatore d' azzardo con una
notevole capacità di raggiungere i suoi obiettivi. È nato ad Haifa nel marzo
1972, ma ora vive a Raanana sobborgo a nord di Tel Aviv dove vivono molti
anglofoni e hanno sede diverse start-up. Il leader 49enne, è il più giovane di
tre figli di genitori immigrati americani Jim e Myrna, che si sono trasferiti in
Israele da San Francisco nel 1967, sulla scia della Guerra dei Sei Giorni.
Determinato fin dall' inizio, ha superato le prove per far parte dell'unità di
comando più prestigiosa dell'esercito, Sayeret Matkal e ha servito poi nel
reparto di ricognizione Maglan. Ha lasciato il servizio militare dopo sei anni.
Tre anni dopo, alla tenera età di 27 anni, viveva a Manhattan e fondava la sua
prima azienda tecnologica, Cyota, che ha venduto sei anni dopo per 145 milioni
di dollari. Il suo pallino per la politica è arrivato durante la guerra del
Libano del 2006. Ha prestato servizio come riservista in quella guerra,
partecipando ad operazioni dietro le linee nemiche per distruggere cellule di
Hezbollah. Poi si è dedicato alla politica ed è stato capo di gabinetto sotto
Benjamin Netanyahu, allora leader dell'opposizione, dal 2006 al 2008, quando ha
litigato con la moglie di Bibi, Sara, ed è stato escluso così dal Likud. Dopo il
ritiro da Gaza, che non approvava, si è buttato su una posizione di destra
nazionalista, favorevole all' annessione dei Territori in Cisgiordania. È stato
ministro delle Finanze e della Difesa in vari governi di Netanyahu, fino a
staccarsi dall' alleato di sempre alle ultime elezioni. Una mossa che gli ha
fatto guadagnare la premiership. Ma il loro rapporto è stato difficile fin dall'
inizio. Bibi nel corso della fulminea ascesa politica di Bennett ha cercato
diverse volte di schiacciare il popolare parvenu. Il neo premier invece nella
sua scalata ha lavorato molto sulla sua immagine per cercare di andare oltre
quella di un leader nazional-religioso e raggiungere anche elettori laici e
centristi. Quando è diventato ministro dell'istruzione ha incoraggiato gli
studenti delle scuole superiori a specializzarsi in matematica e fisica, e ha
sostenuto come il sistema educativo fosse il motore per l'industria tecnologica
della nazione. Bennett stringe la mano alle donne, e sua moglie Gilat originaria
di una famiglia laica non si copre i capelli. Quando si sono svolte le elezioni
del marzo 2021 - la sua scommessa più ambiziosa - ha puntato tutto sulla sfida
aperta al potere di un Netanyahu «fallito». Ma per i suoi oppositori è irritante
che diventi primo ministro mentre guida una fazione di soli sette seggi e da
Netanyahu è pure stato accusato di essere un traditore. La sua scaltrezza e
intuito però sembrano dargli ragione e portano sempre più in alto il parvenu che
ha spodestato Bibi the King.
Cosa è successo nel 1973: Guerra del
Kippur e prima crisi petrolifera. Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 6 Giugno 2021. Abbiamo parlato nella scorsa puntata del 1973 senza
accennare all’evento più drammatico, imprevisto e carico di conseguenze che
allora sembrarono catastrofiche e inguaribili. La guerra di Yom Kippur.
Quell’anno la festività ebraica di Yom Kippur, la più importante, quella che
raduna la stessa tavola dopo lunghissima preparazione tutte le famiglie
religiose e laiche del popolo di Israele, coincise con il mese di digiuno e di
pace musulmano del Ramadan. Onestamente, proprio nessuno aveva immaginato che
potesse accadere una cosa del genere, nemmeno in Israele dove i servizi segreti
e le antenne erano irte e sintonizzate da sempre su tutti i segnali provenienti
dal mondo nemico di Israele. Fu una guerra tremenda e improvvisa in cui
l’Egitto alleato della Siria dell’Iraq attaccò lo stato di Israele nel tentativo
di ribaltare le sorti della guerra di sei anni prima, quella del 1967 che in
soli sei giorni si era risolta in una disfatta totale delle forze arabe che
avevano lungamente pianto per quella sconfitta cocente e disonorevole. Israele
non se l’aspettava. Nessuno al mondo se lo aspettava. Fu un grande colpo
dell’intelligence sovietica perché la guerra di Yom Kippur fu una guerra
sovietica in cui specialmente l’Egitto ricevette dall’Urss le armi più moderne e
anche l’addestramento si dimostrò accurato e perfettamente efficiente sul campo
di battaglia. L’ artiglieria funzionava e si batteva con quella israeliana il
cui personale era stato colto nel sonno e scaraventato alle sue postazioni.
All’inizio fu un trauma da formicaio: man mano che la notizia dell’attacco
raggiungeva le case, tutti i cittadini, maschi e femmine, vecchi e giovani, si
ritrovarono all’istante soldati rispondendo alle chiamate già prestabilite nei
punti convenuti. Ma l’effetto sorpresa fu devastante. La notizia arrivò
in Occidente e in Oriente come un colpo di fulmine e – in breve – tutti coloro
che odiavano gli ebrei gioirono, tutti coloro che provavano pena e senso di
protezione per loro e non soltanto per gli israeliani, caddero in uno stato di
profonda depressione finché Tsahal (l’esercito) e l’IDF nel suo complesso si
riorganizzarono. Quando andai a intervistare Mohachem Begin, qualche anno dopo,
gli chiesi quale fosse stato stata la causa della faticosa ripresa e poi della
vittoria, e mi rispose: “Gli egiziani fanno come gli inglesi: raccolgono i loro
ufficiali nell’alta borghesia e nell’aristocrazia politica. Mettono al comando i
figli dei potenti. I nostri sono selezionati tra gli adolescenti più audaci,
nelle strade, e così abbiamo un personale militare pronto a combattere senza
arrendersi. Noi odiamo la guerra e non possiamo permetterci il lusso della
sconfitta. In questo – mi disse ancora Begin – consiste la differenza fra
noi israeliani e gli arabi: loro possono perdere tutte le guerre ma essere
ancora pronti a cancellarci dalla faccia della terra, mentre noi possiamo
vincere tutte le guerre ma sappiamo che se perderemo la prossima perderemo vita,
figli e patria”. Tutti dissero allora: questa sarà la più grave crisi energetica
della storia. Chiuderanno i pozzi petroliferi. La benzina andrà alle stelle. Il
mondo diventerà povero perché non potrà più trasportare cibi al mercato. È
l’inizio della fine della civiltà. Parlavano soltanto dei disastri che la guerra
mediorientale avrebbe causato al prezzo del petrolio, non ricordando che quando
sale il prezzo del petrolio in Medioriente, quello russo fa affari d’oro. La
guerra cominciò il 6 ottobre 1973 con un attacco simultaneo e preparato con
segretezza militarmente encomiabile dalla Siria, dall’Egitto, e poi dagli altri
paesi arabi della coalizione. Ma fu prima di tutto la vendetta egiziana. Gli
egiziani erano stati malamente umiliati nel 1956 quando Nasser nazionalizzò
il canale di Suez che apparteneva ad una compagnia privata franco-inglese
abilitata ad operare sul territorio nazionale egiziano, e Anthony Eden, già
ministro degli Esteri di Winston Churchill, affamato di una guerra che
riaffermasse l’esistenza dell’impero britannico, si mise a urlare che Nasser era
come Mussolini e che andava trattato come Mussolini e sconfitto come Mussolini.
Non che Nasser fosse troppo dissimile da Mussolini, ma era, come quasi tutti gli
egiziani, filo-inglese, sentendosi debitore dell’impero per tutte le innovazioni
di cui la sua patria aveva fatto uso per diventare una nazione relativamente
moderna. Nel ‘56 gli israeliani si accodarono all’attacco franco-inglese mentre
americani e sovietici – per la prima volta uniti dopo la seconda guerra mondiale
– intimarono l’alt alle operazioni che avrebbero dovuto concludersi con la
conquista del Sinai da che lo avevano invaso seguendo un piano secondo cui
il Regno Unito avrebbe ottenuto un mandato dell’Onu come peace-keeper per
rinsaldare la propria potenza. Nel 1956, sotto la frusta di Mosca e
di Washington, inglesi e francesi tornarono alle loro case abbattuti umiliati e
gli israeliani semplicemente, si ritirarono. Poi ci fu la grande vittoria
israeliana del 1967, i sei giorni. L’esercito di Zahal guidato dal
generale Moshe Dyan con una teatrale benda nera, sull’occhio perduto in guerra,
travolse l’esercito egiziano con un blitz krieg all’israeliana in cui i soldati
combattevano come gruppi di pirati collegati via radio. Stavolta invece le cose
andavano per le lunghe: in Siria si era appena installato Hafez al Assad il
padre dell’attuale Bashar al Assad, un uomo del partito Baath nazionalsocialista
antisemita, a suo tempo alleato dei nazisti tedeschi. Inoltre era un leader
laico, anzi ateo e quindi malvisto dei religiosi sunniti che gli negavano il
pieno appoggio di una popolazione sensibile quasi soltanto al richiamo dei
muezzin. Lo sbandamento israeliano durò sette giorni durante i quali egiziani e
siriani penetrarono profondamente in Israele. Ma fu presto chiaro che la loro
strategia militare, di scuola tradizionale sovietica, era vecchia anche se bene
organizzata. Lo shock nel comando operativo israeliano fu molto duro ma
l’analisi che ne seguì dette i suoi frutti. Fu deciso infatti di suddividere le
formazioni di carri israeliani in piccoli gruppi di due o tre fra loro dotati di
una eccellente comunicazione radiofonica di cui le forze armate sovietiche non
erano ancora provviste. I carri israeliani riuscirono così a penetrare
attraverso le linee egiziane e con una serie di operazioni di ingegneria molto
ardite le avanguardie della fanteria israeliana riuscirono a varcare il canale
di Suez su passerelle gettate su pontoni galleggianti dai genieri e su quelle
passarono poco dopo gli stessi carri armati israeliani ormai in Africa sulle
piste che conducevano al Cairo: alla loro testa era un generale che per questa
operazione diventò famoso, Ariel Sharon, che sarà il primo ministro e molti anni
dopo decise di donare la striscia di Gaza strappata agli egiziani, personalmente
a Yasser Arafat sperando così di chiudere una partita sanguinosa. (Ma Sharon
fece questo regalo senza calcolare la forza e la potenza di Hamas, nemica sia
dei palestinesi che degli israeliani). Allora i combattimenti furono sanguinosi
anche perché i soldati egiziani e siriani si batterono con disciplina e coraggio
e morirono in grandi quantità. In tre settimane i morti nel complesso furono
15.000 di cui solo 2000 israeliani. Fu allora che Anwar el Sadat, il presidente
egiziano che si era giocato la vita con la guerra, capì che era arrivato il
momento di arrivare a far pace con gli israeliani e di mandare al diavolo i
russi. Fu a causa di quella guerra del 1973 che l’Egitto decise di normalizzare
le relazioni con lo Stato ebraico, di sfidare le forze che si opponevano al suo
interno, e furono proprio quelle forze che qualche anno dopo presentarono il
conto con un attentato letale che uccise Sadat mentre assisteva alla parata
delle sue forze armate. L’Egitto pagò la propria decisione di far pace
con Israele, nel ‘73, con l’espulsione immediata dalla Lega araba, un organismo
oggi scomparso, bellicoso, militaresco, e che durò finché durò la guerra fredda
cioè fino alla caduta di Berlino nel 1989. La guerra per tentare di
sopprimere Israele e che Israele invece aveva vinto, divise la destra dalla
sinistra in Italia e nel mondo. In breve, quasi tutta la gente di sinistra sia
pur tra qualche se e qualche ma, fece il tifo per una operazione che non avrebbe
dovuto soltanto correggere confini ma avrebbe dovuto cancellare lo Stato ebraico
che le Nazioni Unite avevano ordinato che nascesse insieme ad uno stato
palestinese. Dal 6 all’ 11 ottobre del 1973 era durata l’illusione della
vittoria ma già all’alba del 12 si vide che la realtà era diversa.
La Siria perdeva definitivamente le alture del Golan, su cui aveva piazzato la
sua artiglieria per battere Israele. Mentre ancora duravano i combattimenti, gli
Stati Uniti si offrirono come mediatori per un cessate il fuoco. Ma Mosca si
oppose finché eserciti arabi sembrava vincessero. Nell’ultima fase, gli
americani decisero di rifornire massicciamente e senza alcun sotterfugio le
forze israeliane che seguitarono a combattere dopo il cessate il fuoco ordinato
dall’Onu. Fu quello uno dei momenti di massimo attrito tra Stati Uniti ed Unione
Sovietica. Henry Kissinger, segretario di Stato di Nixon, volò a Mosca per
chiedere ai sovietici che intenzioni avessero, perché il suo paese – disse – non
avrebbe più tollerato l’uso della guerra per annientare Israele. I russi, a
parti invertite, furono costretti loro a chiedere agli americani di imporre
all’esercito israeliano di cessare la sua avanzata sul Cairo e di deporre le
armi. La guerra di Yom Kippur sconvolse i prezzi del petrolio su cui prese il
comando l’Opec, l’organizzazione dei paesi produttori, imponendo valori fittizi
e cominciò una trattativa che spaccò l’occidente: gli americani erano furiosi
con gli europei perché non avevano mosso un dito per soccorrere Israele o anche
semplicemente per dire chiaramente da che parte stavano. L’Europa sentiva
l’America come una potenza non amica le cui azioni avrebbero potuto
compromettere gli interessi europei determinati dal prezzo del petrolio e quindi
la guerra di Yom Kippur fu considerata l’evento che mise fine alla perenne
amicizia dell’Europa debitrice nei confronti degli Stati Uniti è sua alleata.
L’America repubblicana rispose a brutto muso che avrebbe fatto da sola,
esattamente come poi accadrà con Donald Trump. Anche l’America si spaccò. La
fazione filoeuropea, allora come oggi, cancellò la sua tradizione, che era
quella di stare dalla parte degli israeliani, cambiò campo benché il nerbo
dell’elettorato democratico americano fosse costituito allora come oggi da ebrei
di sinistra. Questo evento gigantesco determinò uno scossone brutale in tutte le
agenzie dei servizi segreti europei e americani, un capovolgimento della
politica sovietica nei confronti dei paesi arabi, una revisione radicale delle
questioni energetiche e dei problemi dei prezzi del petrolio e una risposta
conseguente ed immediata di quella guerra fu la vampata del terrorismo sotto le
bandiere filopalestinesi e filolibiche pur di creare uno schieramento
anti-americano che permettesse la collusione della destra con la sinistra. In
Italia subito dopo nacquero le Brigate Rosse cui si sarebbero aggiunte le
sedicenti brigate nere dei Nar neofascisti con le stesse modalità e armamenti e
sloganistica, di quelle ispirate al mondo sovietico. Cominciava così un lungo
decennio in cui si svolse una guerra a bassa intensità coperta da strati di
retorica. Le conseguenze più sdolcinate furono quelle delle domeniche ecologiche
in bicicletta che tanti ricordano come un’età felice molto simile alle giornate
naturalistiche di oggi in cui tutti ci precipitavamo con le bici, i bambini sul
collo o in canna, le merende sul portapacchi e le borse a penzolare dal manubrio
per raduni in luoghi pieni di zanzare in cui con grande spirito di adattamento
ci dichiaravamo ci dichiaravamo tutti più o meno fieri di esser parte di una
grande coalizione anticapitalista.
CRONOLOGIA DI VENTI ANNI
1956: Il Presidente egiziano Nasser nazionalizza
la Compagnia del Canale di Suez. Fallisce l’attacco Anglo-Francese all’Egitto.
1958: Scoppia la rivoluzione in Iraq. Gli Stati
Uniti intervengono in Libano. Viene proclamata la Repubblica Araba Unita fra
Egitto e Siria.
1960: Nasce l’Organizzazione dei Paesi Esportatori
di Petrolio (OPEC).
1965: Prima azione di resistenza armata da parte
dei Feddayn di Yasser Arafat.
5/11 giugno 1967: Guerra dei sei giorni, Israele
occupa la parte orientale di Gerusalemme, la Cisgiordania, la striscia di Gaza,
la penisola del Sinai e l’altopiano del Golan, che si annetterà del dicembre del
1981.
22 novembre 1967: Il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite chiede all’unanimità il ritiro di Israele dai territori occupati.
1970: Muore il Presidente Egiziano Nasser. I
Palestinesi vengono espulsi dalla Cisgiordania.
1972: Un gruppo di Palestinesi sequestra gli
atleti Israeliani alle Olimpiadi di Monaco, l’azione si conclude in una strage.
1973: Guerra del Kippur e prima crisi petrolifera.
1974: Arafat pronuncia il discorso del mitra e
dell’ulivo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1975-1976: In Libano è guerra civile, la Siria e
Israele invadono il paese.
Paolo Guzzanti. Giornalista e politico è stato
vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato
senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il
Popolo della Libertà.
La congiura degli (dis)eguali. Uniti solo
dall'odio verso Bibi. Fiamma Nirenstein il 31 Maggio
2021 su Il Giornale. Estrema destra, centro, sinistra. Con l'appoggio arabo
Accozzaglia con un unico scopo: eliminare il premier. Bennett l'ha ripetuto
giustificando la sua scelta, come tutti si aspettavano, e presentandola come un
sacrificio politico e personale: è per evitare le quinte elezioni in due anni
che accetto di far parte del «governo del cambiamento» di cui sarò il primo
ministro, dato che Netanyahu non ha i numeri. Ma non è vero: la destra avrebbe
avuto i numeri, ma ha fatto i capricci, si è spaccata, si è abbandonata
all'estremismo di Smotrich che ha dichiarato che con l'appoggio arabo non
avrebbe mai accettato, e poi, e soprattutto, all'ambizione personale di Naftali
Bennett, capo di Yemin, la Destra, e di Gideon Sa'ar; e sempre a destra, anche
l'odio inveterato di Lieberman ha bloccato quella che era la scelta degli
elettori. Bennett, Sa'ar, Lieberman e anche Benny Gantz: tutti avevano un conto
aperto con Netanyahu. Così adesso Bennett il giovane, capace tecnocrate,
ufficiale di valore, critico sì, ma fino a ieri da destra, farà il primo
ministro a rotazione, prima di Yair Lapid. Sarà il primo anche se ha meno uomini
per il maggiore sacrificio ideologico: a lui il premio più grande, e anche
l'accusa di aver tradito e venduto tutto il suo patrimonio ideale. La sua base
ribolle, e difficilmente accetterà che la metta in gioco col partito Meretz,
ultrapacifista e amico di Abu Mazen, o con Yair Lapid, che non può soffrire i
religiosi, appena un po' meno di Lieberman che li vuole tutti coscritti. Ma
Bennett ha ceduto a due spinte che il suo carattere ambizioso gli ha imposto:
l'occasione unica di essere il premier del piccolo Stato a cui il mondo intero
guarda dicendogli ogni giorno «non posso vivere né con te né senza di te», e
soprattutto far fuori lo statista che da 12 anni siede in Rehov Balfour,
riconosciuto come un leader storico da chi lo ama e da chi lo odia, come Sa'ar,
come Lieberman, come tanti altri che lo accusano di arroganza, noncuranza,
prepotenza. Ma Bennett aveva promesso ai suoi elettori di non fare alleanze con
Lapid, di restare fedele al guscio della destra. È un impegno che adesso sarà
difficile mantenere: significa liberalismo economico accentuato, apparato della
difesa forte e deciso di fronte ai pericoli, fedeltà al sionismo delle origini,
compresa la questione dei territori disputati e dei cosiddetti «coloni» di cui
Bennett è stato sempre un sostenitore, tanto quanto altri membri del nuovo
governo li detestano. Ma la proposta della rotazione con Lapid lo affascinava da
tempo, e adesso vi è tornato dopo il breve ripensamento durante le operazioni a
Gaza e gli scontri con gli arabi israeliani. Quando avranno realizzato il sogno
«chiunque fuorché Bibi» cosa resterà a questo gruppo? La verità è che Netanyahu,
che sembra potere uscire indenne anche dall'assalto giudiziario, sarà un macigno
sulle spalle dei partitini al governo lontani fra di loro e senza un leader in
comune. Netanyahu è il primo ministro che parla, d'accordo o no, a tutto il
mondo e a tutta Israele. e che tutti considerano anche per la severità nel
considerare la sicurezza di Israele e insieme per la disponibilità a
condividerne i risultati col mondo minacciato dal terrorismo; è, oggi
soprattutto, il leader che ha salvato con un'azione unica, il suo Paese dalla
pandemia. Adesso come potranno Yair Lapid, C'è un futuro, Blu e bianco di Benny
Gantz, Israele casa nostra di Avigdor Lieberman, Gideon Sa'ar con Nuova
speranza, fin qui di destra o di centrosinistra, Meerav Michaeli, laburista,
Tamar Zandberg del partito radicale estremista, e il futuro primo ministro con 5
o 6 seggi di Yemina, la Destra, parlare con una voce forte a fronte della nuova
ipotesi di accordo con l'Iran cui Joe Biden tiene moltissimo e che Netanyahu
aveva reso una battaglia principale dello Stato d'Israele? Il recupero
dell'economia dopo il Covid, l'eventuale guerra a Gaza se Hamas dovesse
attaccare di nuovo, o in Libano con gli Hezbollah, o il rapporto con Abu Mazen,
la politica verso gli insediamenti, gli Accordi di Abramo... Tutti temi su cui
dei convegnisti possono discutere a lungo. Ma in Israele spesso le decisioni si
prendono al volo, pena la vita.
Dagotraduzione dal DailyMail il 25 maggio 2021.
Sabato scorso il World Values Network ha comprato un’intera pagina del New York
Times per un appello particolare alla cantante Dua Lipa e alle modelle Bella e
Gigi Hadid. Secondo il rabbino Shmuley Boteach, a capo dell’organizzazione, le
tre star hanno «accusato Israele di pulizia etnica» e «diffamato lo stato
ebraico». Non si è fatta attendere la risposta di Dua Lipa, che ha condannato
l’annuncio: «Respingo completamente le false e spaventose accuse che sono state
pubblicate oggi nella pubblicità del New York Times diffusa dal World Values
Network». «Questo è il prezzo che pago per aver difeso i diritti umani dei
palestinesi contro un governo israeliano le cui azioni sono state già condannate
come percecutori e discriminanti sia da Human Rights Watch che dal gruppo
israeliano per i diritti umani V’Tselem». «Prendo questa posizione – ha
continuato la cantante, che sta uscendo con il fratello delle due Hadid, Anwar –
perché credo che tutti, ebrei, musulmani e cristiani, abbiano il diritto di
vivere in pace tra cittadini uguali di uno stato che scelgono». «Il World Values
Network sta usando spudoratamente il mio nome per portare avanti la sua brutta
campagna con falsità e palesi travisamenti di chi sono e di cosa rappresento.
Sono solidale con tutte le persone oppresse e rifiuto tutte le forme di
razzismo». La polemica non si è fermata il rabbino del World Values network ha
risposto così al post di Dua: «Dua Lipa sta facendo i capricci sui social media.
Sfoga il suo odio antisemita ma impazzisce quando viene additata per i suoi
pregiudizi e il suo bigottismo. Dovrebbe imparare che quando gli ebrei dicono
“Mai più”, intendono “Mai più”». «Non permetteremo che il popolo ebraico venga
demonizzato da personaggi come Dua Lipa».
Anna Guaita per “il
Messaggero” il 28 maggio 2021. La guerra delle bombe e dei razzi è ferma per il
momento, ma quella delle parole continua anche più infiammata. Il Consiglio dei
Diritti Umani dell'Onu, che ha sede a Ginevra in Svizzera, è entrato fermamente
nella lotta fra palestinesi e israeliani, decidendo di aprire un'inchiesta sulla
sanguinosa battaglia che si è fermata lo scorso 21 maggio dopo un inteso lavorio
diplomatico internazionale. La presidente del Consiglio, Michelle Bachelet, ha
preso posizione di condanna sui razzi lanciati da Hamas contro Israele, che ha
definito «una chiara violazione della legge umanitaria internazionale», ma è
stata più dura nei confronti di Israele e delle sue bombe, rivelando che gli
agenti Onu in loco «non hanno trovato prove che le costruzioni colpite fossero
usate a scopi militari o ospitassero gruppi armati». Bachelet ha ammonito che se
l'inchiesta aperta dimostrasse che effettivamente gli attacchi di Israele a Gaza
sono stati «indiscriminati e sproporzionati, potrebbero costituire crimini di
guerra», e ha concluso che «non ci sono dubbi che Israele abbia diritto a
difendere i propri cittadini e residenti. E tuttavia i palestinesi hanno
anch'essi diritti. Gli stessi diritti». La reazione di Israele è stata immediata
e arrabbiata. Il premier Benjamin Netanyahu ha accolto la decisione del
Consiglio per i Diritti Umani sostenendo che deriva da «una chiara ossessione
anti Israele». Netanyahu ha sostenuto che ancora una volta «un'immorale
maggioranza automatica al Consiglio ha coperto una organizzazione terrorista
genocida (Hamas) che prende deliberatamente di mira i civili israeliani
trasformando i civili di Gaza in scudi umani». Secondo il premier, il Consiglio
attribuisce automaticamente la colpa «a una democrazia che agisce legittimamente
per proteggere i suoi cittadini da migliaia di attacchi indiscriminati con i
razzi». E ha concluso che l'apertura dell'inchiesta non è che una farsa che
«ridicolizza la legge internazionale e incoraggia i terroristi nel mondo». Una
certa disapprovazione è venuta anche dagli Usa, la cui missione a Ginevra ha
rilasciato una dichiarazione in cui si esprime rammarico per la decisione del
Consiglio. È bene ricordare che gli Usa non fanno parte del Consiglio sui
Diritti Umani dell'Onu e quindi sono presenti a Ginevra solo come osservatori.
La seduta di ieri è stata convocata su richiesta del Pakistan, uno dei 47 Paesi
che formano il Consiglio. A sua volta, il Pakistan agiva per conto dei
palestinesi e dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica. I palestinesi
hanno chiesto all'assemblea dei Paesi riuniti che venga condotta un'indagine
sulla «sistematica violazione dei diritti civili» che sarebbe compiuta da
Israele sui palestinesi nei territori occupati. È stata ascoltata anche una
attivista venuta dal quartiere di Sheikh Jarrah, dove decine di famiglie
palestinesi vengono sfrattate da case che secondo la legge appartenevano a
israeliani e devono essere restituite a loro: «Non vogliamo la vostra simpatia
ha detto Muna El-Kurd -. Vogliamo che fermiate questa pulizia etnica ai danni
dei palestinesi». Sono accuse pesantissime, che Israele rintuzza
categoricamente, come ha rifiutato la denuncia di «apartheid», attribuita al
ministro degli Esteri di Parigi Jean-Yves Le Drian che, in un'intervista dei
giorni scorsi, ha parlato appunto di un «rischio apartheid» nello Stato ebraico
a causa delle violenze tra arabi e ebrei durante il conflitto. Il ministro degli
Esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha espresso forte contrarietà: «Quelle di Le
Drian - ha detto - sono parole inaccettabili che distorcono la realtà. Ci
aspettiamo dagli amici che non si esprimano in maniera irresponsabile».
Da tpi.it il 28 maggio 2021. Totti verrà raggiunto
nella capitale israeliana da quattro sorteggiati tra gli iscritti al concorso
indetto dal noto marchio di birra, che seguiranno con lui lo scontro finale tra
le due squadre inglesi. “Ciao Israele fans, sono molto felice di venire in
Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions
League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. See
you soon“, dice il numero uno della Roma nel messaggio di lancio
dell’iniziativa. La partenza di Totti per Tel Aviv arriva in un momento
delicato, nel pieno del cessate il fuoco raggiunto tra Israele e il movimento
nazionalista palestinese Hamas dopo giorni di ostilità che hanno provocato
numerose vittime, ufficialmente 232 palestinesi a Gaza, di cui 65 bambini, e 12
in Israele, di cui due bambini. Motivo per cui la notizia della partenza del
calciatore ha scatenato diverse polemiche, particolarmente forte è stato
l’attacco di Chef Rubio. “Comunque la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato
illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti,
gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per
poi finire camerata“, scrive su Twitter il cuoco e attivista romano Gabriele
Rubini.
Da laroma24.it il 31 maggio 2021. Fabio Sonnino e
Samuele Giannetti sono romani di nascita e romanisti per fede e per passione. Ma
più di tutto, sono il presidente e il vicepresidente della scuola calcio Roma
club Gerusalemme, la città in cui vivono e lavorano da tantissimi anni. La foto,
postata sui social, di Totti in posa dietro la bandiera del Club ha avuto
immediatamente moltissime condivisioni. Ed ha finito per diventare una sorta di
risposta implicita alle polemiche innescate nei giorni scorsi da Gabriele
Rutini, nell’arte dei fornelli Chef Rubio, che su Twitter aveva attaccato l’ex
giallorosso L’antefatto è la serata di sabato. Serata trascorsa dal Pupone in
una villa vicino a Tel Aviv per vedere la partita di Champions che si giocava ad
Oporto. Un evento promozionale organizzato da un noto marchio di birra. "Ma
quella di Totti - spiega Samuele Giannetti — è stata un’operazione puramente
commerciale che nulla ha a che vedere con le ultime tensioni in Israele. Tanto è
un’operazione commerciale che allo stesso evento, negli anni passati, sono stati
invitati Pirlo, Ronaldinho e Del Piero. E mai nessuno li ha attaccati». E
quello di Totti, sabato scorso, era un altro dei suoi regali. «Prima della
pandemia, a più riprese, siamo venuti a Roma a Trigoria con una piccola
delegazione di giovani leve — spiega Sonnino — E Francesco li ha incantati coi
palleggi e i tiri importa». Ragazzini col sogno di diventare calciatori, rapiti
dalle prodezze del re del “cucchiaio”.
Giampiero Mughini per Dagospia il 28 maggio 2021.
Caro Dago, non è facile indicare quali siano stati “crimini di guerra” dopo che
le due parti in campo se le sono date di santa ragione. E’ impossibile farlo
scegliendo gli episodi uno a uno, separati dal contesto. Ove i nazi avessero
vinto la Seconda guerra mondiale, sui banchi degli accusati al modo del processo
di Norimberga sarebbero andati i capi politici e militari britannici che avevano
ordinato il mostruoso bombardamento di Dresda, una città tedesca che non
ospitava installazioni militari. Vedo adesso che un tribunale dell’Onu punta il
dito sui bombardamenti di Gaza ad opera dell’aviazione israeliana. Sono
moltissimi i civili palestinesi uccisi da quei bombardamenti, molti i bambini
vittime innocentissime. Non ci sono prove, sembrerebbe dire l’Onu, che gli
edifici presi a bersaglio dai bombardieri israeliani ospitassero davvero
installazioni militari. Nel suo comunicato l’Onu critica “anche” i 4000 razzi
lanciati da Hamas su Israele a dove coglieva coglieva. Detta così mi sembra una
bestialità inaudita, e lo dico da cittadino repubblicano dell’Europa del terzo
millennio. Non ho nessun altro titolo per mettere becco sulla questione. Lo
faccio solo per dire quanto sia palmare che alle origini della tragedia di
questi undici giorni di distruzione e morte c’è l’operato brutale di una gang
terroristica di nome Hamas, i cui primi prigionieri sono i cittadini palestinesi
di Gaza. Non è che loro abbiano ammazzato meno bambini israeliani per una loro
scelta generosa, non è che loro indirizzassero i razzi solo sulle caserme
israeliane o sul quartiere generale del Mossad. Loro hanno fatto meno danni solo
perché Israele ha un efficientissimo sistema di difesa contro i razzi e perché
la buona parte di quegli ordigni ricadevano sullo stesso territorio di Gaza.
Loro stavano semplicemente facendo la prova generale di quella che è la loro
strategia finale e la loro ragion d’essere, distruggere Israele fino all’ultima
sua donna e all’ultimo suo bambino. Niente di meno che questo, assolutamente
niente. Poi succede che quando le ostilità comincino, l’orrore della contesa si
dispiega in tutta la sua ampiezza, come racconta benissimo un film israeliano
sulla guerra in Libano che ho rivisto qualche giorno fa in streaming. Lasciano
allibiti di orrore i paesaggi urbani di una Gaza su cui sono piovute armi
micidiali. Case distrutte, gente per strada che non ha più un tetto, bambini
nelle braccia delle madri. Solo che tutto questo lo devono a Hamas,
assolutamente lo devono a loro. Gaza fosse nelle mani di un gruppo dirigente
tedesco o israeliano o nordeuropeo, in questi ultimi vent’anni avrebbe potuto
diventare una ridente cittadina che si affaccia sul Mediterraneo. Molti di noi
avrebbero scelto volentieri di passarci qualche giorno di vacanza, di tastare
con mano le condizioni della gente palestinese, nostri fratelli né più né meno
che la gente israeliana. E del resto le istituzioni europee e mondiali pagano
dei buoni soldi alla gente di Gaza. Solo che quei soldi passano dalle mani
criminali di Hamas, quelli che dopo aver vinto le elezioni a Gaza portarono su
dopo averlo legato il cuoco di Abu Mazen e lo scaraventarono giù dal terzo
piano, gente che li usa per costruire razzi e tunnel sotterranei. Qualsiasi
discorso sugli undici giorni stramaledetti di guerra deve partire da questo
presupposto, da questo giudizio di fatto. Se non lo fa non è un discorso ahimè
quanto necessario sul futuro possibile di Gaza, e bensì cialtroneria.
Da “Swg” il 25 maggio 2021. IL CONFLITTO
ISRAELO-PALESTINESE. A otto anni dal conflitto israelo-palestinese del 2014,
l’opinione degli italiani sulla responsabilità dei due schieramenti si mantiene
stabile: per una larga parte, 4 rispondenti su 10, si tratta di concorso di
colpa, mentre il 18% addita gli israeliani e il 9% i palestinesi. Aumenta però
il senso di confusione per cui una quota crescente non se la sente di valutare
(+17% rispetto al 2014). Insieme agli elettori del PD e dei Cinquestelle, la
generazione Z (gli under 26) si schiera maggiormente con i palestinesi (+10%),
in linea con il nuovo trend registrato negli Usa, dove molti teen si sono
mobilitati online sotto l’hashtag #PalestinianLivesMatter. Sui mezzi impiegati
da entrambi gli schieramenti la condanna è forte: 4 su 10 considerano i
bombardamenti israeliani un crimine di guerra, 3 su 10 descrivono il lancio di
razzi da parte di Hamas come un atto terroristico. In merito alle cause del
conflitto, oggi oltre un terzo del campione indica la dimensione geopolitica di
competizione internazionale nell’area, prima ancora del movente religioso o di
politica interna.
All’Europa i cittadini italiani chiedono di
condannare le violenze e muoversi con gli strumenti diplomatici (43%): l’invio
di ispettori o forze di pace e l’uso di sanzioni sono citate solo da una
minoranza. Escluso invece da tutti il supporto militare.
Israele e Hamas siglano il cessate il
fuoco: dopo 11 giorni di guerra stop a raid e razzi.
Redazione su Il Riformista il 20 Maggio 2021. La notizia tanto attesa è
arrivata. Dopo un conflitto arrivato ormai all’undicesimo giorno, con 227 morti
nella Striscia di Gaza (tra cui 65 bambini e 39 donne) e 12 in Israele, arriva
la tregua tra lo Stato ebraico e Hamas, il gruppo politico-militare che
controlla il lembo di terra ‘casa’ dei palestinesi. Le forti pressioni
internazionali, a partire da quelle del presidente americano Joe Biden, hanno
avuto un risultato concreto: il gabinetto di sicurezza israeliano, riunitosi per
circa tre ore, ha votato all’unanimità per il cessate fuoco. Notizia poi
confermata dall’ufficio del premier Netanyahu, in un comunicato nel quale si
afferma che i ministri hanno concordato “di accettare l’iniziativa egiziana per
un cessate il fuoco reciproco senza condizioni”. Una mossa arrivata dopo la
presentazione ai ministri israeliani, da parte dell’esercito, degli vi militari
raggiunti durante l’operazione ‘Guardiano delle Mura’, alcuni di questi “senza
precedenti”. Un cessate il fuoco confermato dalla controparte
palestinese, Hamas, che ha definito l’accordo “simultaneo e reciproco”. Il
cessate il fuoco entrare in vigore dalle 2 del mattino di venerdì, l’una di
notte in Italia. L’accordo è commentato positivamente dal ministro degli Esteri
palestinese Riad Al-Malki, che dal Palazzo di Vetro dell’Onu all’ufficialità
della notizia ha spiegato: “È un bene che il popolo palestinese, gli oltre 2
milioni di loro a Gaza, potranno dormire stanotte sapendo che domani avranno un
clima migliore. Ma non è abbastanza, non è affatto abbastanza”. L’ipotesi di uno
stop al conflitto era stata rilanciata questa mattina dal Wall Street
Journal citando fonti vicine ai negoziati, secondo le quali i mediatori egiziani
avevano compiuto “progressi nei colloqui con i leader di Hamas”. Il giornale
economico statunitense scriveva infatti che Israele aveva “ammesso” di essere
vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari e che un cessate il fuoco
poteva essere “imminente, possibilmente entro 24 ore”, secondo quanto confermato
anche da fonti vicine ad Hamas alla Cnn. Nella notte era arrivato l’ulteriore
pressing americano, col confronto tra il segretario di Stato americano Antony
Blinken e l’omologo israeliano Gabi Ashkenazi in cui il ‘ministro degli Ester’
Usa aveva ribadito di aspettarsi “una de-escalation sulla strada per un cessate
il fuoco”. Conferme arrivate anche su Twitter, dove Blinken aveva spiegato di
aver discusso al telefono degli “sforzi per mettere fine alla violenza in
Israele, Cisgiordania e Gaza, che ha causato la perdita di vite di civili
israeliani e palestinesi, compresi bambini”.
Israele-Palestina: perché le guerre
scoppiano sempre a Gaza. Francesco Battistini e Milena
Gabanelli il 21 maggio 2021 su Il Corriere della Sera. La pace impossibile. Uno
dei più lunghi conflitti della storia moderna. L’origine di tutti i focolai in
Medio Oriente. Dal 1946 a oggi, l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato 700
risoluzioni, più di 100 ne ha votate il Consiglio di sicurezza. La comunità
internazionale ha esaminato almeno 20 piani di pace. Ma dopo 54 anni
d’occupazione dei Territori palestinesi, adesso che fra arabi e israeliani siamo
entrati nella dodicesima guerra in più di 70 anni, qualunque soluzione sembra
lontanissima.
Sette anni di calma. Era dall’estate 2014 che non
si sentivano squillare le sirene con tanta frequenza. Una quiete, solo
apparente, perché negli ultimi sette anni quasi 200 palestinesi sono rimasti
vittime d’attacchi aerei o d’operazioni di terra; diversi soldati israeliani
sono stati uccisi, con decine di civili feriti, e 163 attentati a quei coloni
ebrei che, dal 1967, hanno progressivamente occupato la Cisgiordania. E 1.920
palestinesi sono stati feriti dalla polizia, con 8.139 uliveti di proprietà
araba vandalizzati dai coloni. Come mai questa linea è stata superata proprio
ora? Da una parte c’è Netanyahu, al quinto mandato, bersagliato da inchieste
per corruzione, frode e abuso d’ufficio, e senza una maggioranza di governo.
Dall’altra parte, i palestinesi che restano divisi. In Cisgiordania, dal 2006 è
presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, 85 anni, leader del partito
Fatah, ma il suo mandato è scaduto da dodici anni: non si va mai alle urne
perché tutti i sondaggi prevedono una vittoria del movimento islamico di
resistenza Hamas. Nato negli anni ’80, durante la protesta palestinese della
Prima Intifada, nel 2006 prese il controllo della Striscia di Gaza. È un
movimento che dichiara incompatibile Israele con una Repubblica islamica di
Palestina. E Israele, al pari degli Usa e della Ue, lo considera
un’organizzazione terroristica.
Gli amici di Hamas. È questa spaccatura
palestinese a spiegare perché, negli ultimi quindici anni, il conflitto si sia
concentrato sempre su Gaza. Hamas gode dell’amicizia d’un grande sponsor
politico come la Turchia di Recep Erdogan, che dal 2010 tenta di forzare il
blocco israeliano intorno alla Striscia. Secondo i servizi israeliani e lo
stesso Abu Mazen, però, oggi è l’Iran il grande amico di Hamas. Il finanziamento
diretto è per circa 6 milioni di dollari al mese, arrivati fino a 30 negli
ultimi due anni. Una cifra versata attraverso gli islamici di Hezbollah che
controllano il Sud del Libano. Gli Hezbollah sono sciiti come gli ayatollah di
Teheran e si battono, come Hamas, per la distruzione del vicino Israele.
2015: accordo sul nucleare. Dunque per Netanyahu,
gli iraniani sono il nemico numero uno. A causa del programma atomico, ripreso
nel 2002, che secondo l’Onu ha anche scopi militari e viola il Trattato
internazionale di non proliferazione nucleare. Nel 2015 i cinque Paesi del
Consiglio di sicurezza Onu, Germania e Ue, hanno firmato con l’Iran un accordo
voluto dal presidente americano Obama e osteggiato da Netanyahu, che prevede tra
l’altro la fine delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente a Teheran. Quel
patto è stato una svolta. Ha normalizzato le relazioni tempestose con l’Iran. È
da quel momento che contro Israele si sono raffreddate anche le ostilità di
Hamas e del piccolo gruppo sunnita che lo fiancheggia, il Movimento per il Jihad
in Palestina responsabile di molti attacchi suicidi e finanziato, pure lui,
dagli Hezbollah filoiraniani.
2018: l’inversione di Trump. Poi è arrivato Trump,
che nel 2018 ha stracciato l’accordo sul nucleare. Non solo: trasferisce
l’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendola come capitale
unica e indivisibile d’Israele. E ha ribaltato le alleanze, riavvicinandosi ai
tradizionali alleati dell’Arabia Saudita, grandi nemici tanto dell’Iran quanto
della Turchia.
L’inversione a U americana è stata la grande
vittoria diplomatica di Netanyahu. E infatti dopo di essa, con la stessa
puntualità con cui s’erano fermati, sono ricominciati fra Israele e Teheran gli
scontri per aria (colpite in Siria le postazioni delle milizie sciite,
finanziate dall’Iran), per mare (con incursioni sui cargo israeliani e sulle
petroliere iraniane che transitano per il Golfo d’Arabia) e per terra, con due
attentati alle centrifughe nucleari di Natanz. Dall’Iran, sono ripartite verso
Gaza forniture d’armi sempre più sofisticate. E dopo dieci anni, è ripresa la
campagna di eliminazione degli scienziati iraniani che lavorano al nucleare: il
27 novembre scorso è stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, capo del programma atomico
di Teheran. Un assassinio che è seguito a quello, nel gennaio 2020, del generale
Qassem Soleimani, il potente capo delle Guardie della Rivoluzione, colpito sulla
sua auto da un drone americano.
Pioggia di dollari. La rottura definitiva
dell’amministrazione Trump con l’Iran ha portato, il 13 agosto 2020, alla
cosiddetta «Pace di Abramo»: l’accordo tra Israele e i più ricchi dei Paesi
arabi, Emirati e Bahrein, di tradizione musulmana sunnita e quindi contrapposti
agli sciiti iraniani. La «Pace di Abramo» ha un significato politico ben preciso
e serve a dirci una cosa: che la soluzione dei Due Popoli e Due Stati,
ipotizzata dagli accordi di pace di Oslo e firmata nel 1993 da Rabin e Arafat,
non è più una condizione. In altre parole: il mondo arabo non si impunta per
contendersi Gerusalemme, i confini restano quelli di oggi senza tirare più in
ballo quelli precedenti la guerra dei Sei Giorni del 1967, e i profughi del 1948
in Libano e Giordania restano dove stanno. L’accordo – ammesso che il presidente
Joe Biden voglia mantenerlo - prevede una pioggia di soldi sulla Cisgiordania di
Abu Mazen, sempre più corrotta e dipendente dagli aiuti internazionali: 50
miliardi di dollari in investimenti stranieri per i prossimi dieci anni, assieme
alla promessa d’un Pil raddoppiato entro il 2030, d’un milione di posti di
lavoro, della povertà ridotta del 50%, d’un export schizzato dal 17 al 40% del
Pil, d’un ranking della Banca mondiale pari a quello del Qatar.
L’avanzata degli insediamenti. Non è detto che i
soldi bastino. E basti un accordo disegnato a tavolino nel 2020, peraltro senza
i palestinesi. Il pericolo d’una Terza Intifada, se mai scoppierà, è legato a
quel che s’è mosso in questi anni di tregua armata. Il complotto di corte contro
il re di Giordania — che in aprile ha portato all’arresto del fratellastro del
sovrano Abdallah, sospettato di voler rovesciare una famiglia regnante dove la
regina (Rania) è una palestinese — anche questo rientra nei timori d’un
allargamento della questione palestinese, dove i profughi dalla Cisgiordania
sono il 70%. Il sogno d’Abramo rivela i suoi limiti. Due dei tre Paesi che hanno
aderito — Emirati, Bahrein — hanno già protestato per le bombe su Gaza. E
intanto nei Territori palestinesi non s’è fermata la sistematica violazione dei
diritti umani, assieme alla politica degli espropri e degli insediamenti
illegali d’Israele. «Più che coi nemici, mi sembra di trattare con agenti
immobiliari», un giorno ironizzò amaro il negoziatore palestinese Saeb Erekat,
calcolando il tempo a favore delle betoniere che costruiscono insediamenti: nel
2025, i coloni saranno più di 700mila. Un settimo della popolazione palestinese
in Cisgiordania. A quel punto sarà la geografia, prima di qualsiasi guerra con
Hamas, a impedire definitivamente la nascita di uno Stato palestinese.
E l’Europa. Piccola postilla. C’era una volta la
Ue, che si batteva per il rispetto degli accordi di Oslo. «Ormai il conflitto
coinvolge più gli euro che l’Europa», disse il famoso mediorientalista, Nathan
Brown. E infatti ci laviamo la coscienza finanziando l’Autorità palestinese, che
senza i nostri soldi non vivacchierebbe: abbiamo evitato di disturbare il
manovratore politico, finché era solo l’America, ma i giochi adesso possono
farsi più complessi. Le guerre, più dure. E agli europei si chiederebbe un ruolo
diverso.
Soleimani, la “confessione” di Israele.
Lorenzo Vita su Inside Over il 23 dicembre 2021.
L’uccisione di un nemico non è mai una notizia da dare facilmente. Significa
svelare di fronte al mondo quello che viene solo sospettato o detto a mezza
bocca. La conferma di una campagna precisa, chirurgica, a volte anche plateale
ma senza alcuna vera ammissione di colpa.
Israele, in questo senso, compie da molti anni
operazioni di raid e omicidi mirati in cui il suo nome non appare da nessuna
parte, ma solo sospettato. È una verità che tutti conoscono eppure che nessuno
può dire con certezza, perché sono gli stessi vertici dello Stato ebraico a non
dire mai con certezza quando e se colpiscono, nemmeno a fatto avvenuto. Un po’
come avviene da diversi anni in Siria, dove i raid dell’aeronautica israeliana
sono ormai regolari eppure le Idf, le Israel defense forces, evitano in ogni
caso eccessi di trionfalismo. E lo stesso avviene con i cosiddetti omicidi
mirati: quelle operazioni dei servizi di intelligence in cui vengono uccisi gli
elementi più importanti degli apparati nemici e in cui non esistono conferme,
se non in inchieste giornalistiche o rivelazioni di gole profonde più o meno
volute per inviare un segnale. Basti pensare al caso dello scienziato Mohsen
Fakhrizadeh, uno dei vertici del programma nucleare iraniano. Lo stesso dicasi
per Baha Abu al Ata, guida del braccio militare della Jihad islamica, ucciso da
un raid israeliano a Gaza mentre era nella propria abitazione. E sono solo
alcuni degli ultimi episodi in cui si parla di veri e propri omicidi chirurgici
compiuti da forze militari e agenti segreti dello Stato ebraico.
Stupisce, quindi, (anche se ultimamente non
troppo, e scopriremo perché) che Israele, tramite le parole dell’ex capo
dell’intelligence militare, generale Tamir Hayman, abbia ammesso il
coinvolgimento nell’omicidio di Qasem Soleimani. Il generale iraniano, vertice
dei Pasdaran iraniani e a capo delle operazioni all’estero dei Guardiani della
rivoluzione, venne ucciso nel gennaio del 2020 in un attacco con un drone
condotto dagli Stati Uniti all’aeroporto di Baghdad. In una intervista
alla rivista Malam pubblicata dall’Israel Intelligence Heritage and
Commemoration Center, Hayman ha affermato che l’eliminazione di Soleimani “fu un
successo perché ai nostri occhi il nemico principale è l’Iran”. “È raro che un
uomo di grado talmente elevato sia al tempo stesso l’organizzatore della forza
combattente, uno stratega e anche colui il quale impartisce ordini”, ha spiegato
il generale, il quale ha aggiunto che “Soleimani rappresentava un forte
potenziale di danno per la stabilità della regione, era la locomotiva del treno
dell’espansione iraniana”. Il generale, che ha terminato il suo incarico a
ottobre, ha poi confermato che esistono “due omicidi significativi e importanti”
avvenuti durante il suo mandato. Uno è appunto quello di Soleimani, l’altro,
citato in precedenza, quello di Abu al-Ata.
Per Israele si tratta di un’ammissione che non è
solo la confessione di un ex vertice dell’intelligence militare. Da tempo lo
Stato ebraico ha scelto una strada diversa anche nel modo di comunicare: per
certi versi anche più sfacciata. Da un lato si inviano segnali molto diretti
all’avversario regionale, l’Iran, in un momento di tensione per i pochi
risultati sul negoziato per il programma nucleare. Dall’altro lato, il messaggio
è rivolto a tutti coloro che sono considerati nemici dagli apparati israeliani:
non è solo un avvertimento rivolto a Teheran, ma, come dimostrato anche dalla
conferma dell’assassinio di uno dei leader della Jihad islamica, anche per tutti
coloro che costruiscono una strategia contro Israele. L’omicidio mirato diventa
quindi un’arma al pari di un raid: un metodo pubblico, non per questo ritenuto
migliore, ma sicuramente accettabile. Ed è un importante punto di svolta anche
per i rapporti di vicinato e con vecchi e nuovi alleati: l’intelligence sa come,
dove e chi colpire. Anche più degli Stati Uniti.
Hamas minaccia: "Residenti
Tel Aviv state attenti". Guerra di Gaza, Israele bombarda grattacielo sede di
Al-Jazeera e AP: “Inorriditi, il mondo saprà meno cose ora”.
Redazione su Il Riformista il
15 Maggio 2021. Israele ha abbattuto il grattacielo Al Jala, che agli ultimi
piani ospita gli uffici dei media di Al Jazeera e Associated Press e di altre
agenzie di informazioni, perché “Hamas lo usava come nascondiglio”. Prosegue la
guerra nelle Striscia di Gaza con l’ultimo bombardamento che ha fatto crollare
l’edificio di 12 piani. In precedenza Israele aveva bombardato i tunnel dei
miliziani costruiti dopo lo scontro del 2014 e un campo profughi provocando la
morte di diversi bambini. “Hamas ha trasformato zone residenziali a Gaza in
postazioni militari”. Ha giustificato così l’attacco il portavoce militare
israeliano. “Usa edifici elevati a Gaza per fini militari di vario genere come
la raccolta di informazioni di intelligence, la progettazione di attacchi,
operazioni di comando e controllo, e per le comunicazioni”. Il portavoce ha
aggiunto che la aviazione israeliana ha avuto cura di non colpire civili,
“ricorrendo a messaggi sms” e “colpendo preventivamente il tetto” dell’edificio
con un primo attacco di avvertimento “che fa rumore e non danni”. “Tutti i
grattacieli colpiti da Israele erano sfruttati per fini militari”, ha rimarcato,
specificando che “quando Hamas utilizza un edificio elevato per fini militari,
esso diventa un obiettivo militare legittimo. Il diritto internazionale è
chiaro”. All’attacco è seguita la reazione di Hamas, che ha minacciato nuovi
razzi contro Tel Aviv. Abu Obeida, portavoce dell’ala militare, le Brigate Izz
al-Din al-Qassam, ha annunciato una dura reazione: “I residenti di Tel Aviv e
del centro d’Israele devono stare attenti”, ha detto, citato da Times of Israel.
In precedenza, l’ultimo lancio di razzi su Tel Aviv aveva provocato un morto in
un edificio colpito a Ramat Gan, sobborgo cittadino. La vittima è un uomo di 50
anni, colpito nel suo appartamento dalle schegge innescate dall’esplosione.
Hamas ha fatto sapere che l’attacco è “la vendetta” per i morti nella famiglia
Abu Hatab, colpita a Gaza all’alba, con unico superstite un bimbo di pochi mesi.
La reazione di AP: “Scioccati
e inorriditi”. “Siamo scioccati e inorriditi dal fatto che l’esercito israeliano
abbia preso di mira e distrutto l’edificio che ospita l’ufficio di AP e altre
organizzazioni giornalistiche a Gaza. Conoscevano da tempo l’ubicazione del
nostro ufficio e sapevano che c’erano dei giornalisti. Abbiamo ricevuto un
avviso che l’edificio sarebbe stato colpito”, ha dichiarato il presidente
dell’agenzia americana AP Gary Pruitt, “Stiamo cercando informazioni dal governo
israeliano e siamo impegnati con il dipartimento di Stato degli Stati Uniti per
cercare di saperne di più. Questo è uno sviluppo incredibilmente inquietante.
Abbiamo evitato per un pelo una terribile perdita di vite umane. Una dozzina di
giornalisti e liberi professionisti di AP erano all’interno dell’edificio e per
fortuna siamo stati in grado di evacuarli in tempo”. “Il mondo”, ha concluso
Pruitt, “saprà meno di ciò che sta accadendo a Gaza a causa di ciò che è
accaduto oggi”.
La Casa Bianca: “Garantire
incolumità giornalisti”. “Abbiamo comunicato agli israeliani che garantire la
sicurezza e l’incolumità dei giornalisti e dei media indipendenti è una
responsabilità fondamentale”. Lo ha scritto su Twitter la portavoce della Casa
Bianca Jen Psaki.
Giornalista Al Jazeera:
“Lavoriamo in ospedale”. E’ l’ospedale Al Shifa di Gaza City “l’unico posto più
sicuro che conosciamo” e dove “siamo in grado di lavorare”. A riferirlo è
la giornalista di Al Jazeera Youmna al-Sayed che ha poi spiegato che il
proprietario dell’edificio ha ricevuto e quindi comunicato l’ordine di
evacuazione soltanto un’ora prima dell’attacco e che i militari israeliani hanno
rifiutato di concedere ulteriore tempo.
Unicef: “40 bambini uccisi e
38 scuole danneggiate”. “Ieri sera, altri 8 bambini palestinesi sono stati
uccisi nella Striscia di Gaza. Il più piccolo aveva 4 anni, il più grande 15.
Dall’inizio dell’escalation 5 giorni fa, 40 bambini sono stati uccisi nella
Striscia di Gaza e 2 in Israele. Questi sono bambini. Questa è una grave
violazione”. E’ quanto rende noto l’UNICEF. “Decine di altri bambini sono stati
feriti. Molti giovani palestinesi sono stati arrestati”, prosegue il Fondo Onu
per l’infanzia, aggiungendo che “35 scuole nella Striscia di Gaza e 3 scuole in
Israele sono state danneggiate dalle violenze. Gli attacchi alle scuole e alle
strutture educative rappresentano una grave violazione contro i bambini”.
Francia, tensioni al corteo
pro-Palestina. In decine di città francesi si stanno tenendo manifestazione a
sostegno dei palestinesi mentre continua il conflitto tra Israele e Hamas.
L’attenzione è concentrata in particolare su Parigi dove i manifestanti hanno
deciso di marciare nonostante il divieto emesso dalle autorità e confermato dal
tribunale amministrativo. Il capo della polizia di Parigi Didier Lallement ha
ordinato la chiusura dei negozi intorno al punto di partenza della marcia in un
quartiere operaio nel nord di Parigi. Gli organizzatori hanno affermato che
intendono “denunciare le aggressioni israeliane” mentre la polizia ha avvertito
che userà gli idranti contro chi sfida il divieto. Le proteste sono state
consentite in numerose altre città, tra cui Lille e Marsiglia. Le autorità hanno
giustificato il divieto a Parigi ricordando che nel 2014 una protesta
pro-palestinese vietata contro l’offensiva israeliana a Gaza è degenerata in
violenze e scontri con la polizia. L’escalation degli attacchi missilistici tra
Israele e Hamas ha messo a dura prova le autorità francesi, che temono il
conflitto possa accendere violente proteste nel Paese.
Manifestazioni pro-Palestina
anche in Inghilterra. Un fiume di manifestanti a sostegno della Palestina ha
sfilato per le vie di Londra lungo Hyde Park verso l’ambasciata israeliana
a Kensington. Lo riporta il sito della Bbc. Alcuni fumogeni rossi e verdi –
riferisce l’emittente britannica – sono stati salutati da applausi dai
manifestanti che sventolavano bandiere palestinesi. Tra i cori “Palestina
libera” chiedono che Israele fermi gli attacchi aerei e che il governo
britannico intervenga.
Gianluca Perino per "il Messaggero" il 17 maggio
2021. «Se cercheremo di eliminarli? Certo. Chiunque ha organizzato e sta
mettendo in pratica questo attacco nei confronti di Israele è un nostro target».
L'alto ufficiale dell'IDF, l'esercito di Gerusalemme, per ragioni di sicurezza
preferisce mantenere l'anonimato. Ma non fa giri di parole. E spiega che in cima
alla lista dello Stato ebraico ci sono soprattutto i tre pezzi da novanta di
Hamas che stanno dirigendo le operazioni dall'interno della Striscia: Yahya
Sinwar (il cui covo è stato distrutto la scorsa notte ma, a quanto pare, lui si
è salvato), Mohammed Deif e Marwan Issa. Ma chi sono questi uomini? E che posto
occupano nella catena di comando dell' organizzazione terroristica?
I DOCUMENTI Secondo i rapporti dell'intelligence
israeliana il più pericoloso è Mohammed Deif. Il 55enne nato a Khan Younis,
nella parte Sud della Striscia, è il potente capo dell'ala militare di Hamas ed
è l'uomo che ha progettato e fatto realizzare la rete di tunnel (costata oltre
un miliardo di dollari) che doveva servire per spostare armi, difendere Gaza da
una eventuale invasione via terra e consentire ai vertici dell'organizzazione
terroristica di muoversi con maggiore facilità e meno rischi. Un'opera
faraonica, che però è stata di fatto smantellata un paio di giorni fa da una
serie di raid israeliani. Non solo. L'IDF, nelle scorse ore, è riuscito anche ad
uccidere alcuni dei fedelissimi di Deif, che adesso è più solo e, in parte,
anche più vulnerabile. Ma non è detto che per questo sia più facile da colpire.
«Nelle nostre operazioni - spiega ancora l'ufficiale dell'IDF - dobbiamo sempre
tenere conto della popolazione civile di Gaza, che Hamas sfrutta per raggiungere
i propri scopi. Non vogliamo fare vittime innocenti. I terroristi, invece, non
hanno scrupoli. Anzi, sperano che muoiano più palestinesi possibile per
giustificare la loro esistenza con l'Iran e gli altri sponsor. E per cercare di
portare la comunità internazionale dalla loro parte». È quindi molto difficile
raggiungere Deif sul proprio terreno. Anche perché spesso, per evitare di essere
colpiti, i capi di Hamas si mischiano alla popolazione civile, tenendo riunioni
in scuole e in altri uffici pubblici.
GLI ATTENTATI Oltretutto, Mohammed Deif è già
sfuggito a cinque tentativi di eliminazione da parte israeliana. Attacchi che
gli hanno causato anche pesanti danni fisici (cieco da un occhio, è stato
gravemente ferito alla spina dorsale e deve muoversi su una sedia a rotelle) ma
dai quali alla fine è riuscito sempre ad uscirne vivo. Gerusalemme gli dà la
caccia da oltre venti anni, perché è ritenuto responsabile, tra le altre cose,
dell'uccisione dei soldati Shahar Simani, Aryeh Frankenthal e Nachshon Wachsman,
e di alcuni attentati agli autobus a Gerusalemme e Ashkelon che hanno causato la
morte di oltre cinquanta cittadini israeliani. In realtà è una specie di
fantasma, si muove con grande attenzione e frequenta una cerchia molto ristretta
di fedelissimi. Tanto è vero che in circolazione ci sono pochissime foto che lo
ritraggono e tutte risalenti ad almeno venti anni fa.
GLI ALTRI Ma in cima alla lista ci sono anche
Yahya Sinwar e Marwan Issa. Il primo, scampato all'attacco di ieri, è il capo di
Hamas di Gaza, in pratica il numero due del movimento guidato da Ismail Haniyeh.
Come Deif è nato a Khan Yunis, in un campo profughi, 59 anni fa. Alle sue spalle
ha una lunga scia di crimini, che gli hanno garantito la scalata all'interno
dell'organizzazione. È stato anche catturato e condannato a quattro ergastoli
per il rapimento e l'uccisione di due soldati israeliani. Ma poi è uscito di
prigione grazie ad uno scambio di prigionieri per il soldato israeliano Gilad
Shalit. Grazie a questa opportunità è potuto rientrare a Gaza nel 2011, dove ha
preso il comando di Hamas a partire dal 2017. Tra i tre, quello di peso minore è
sicuramente il 56enne Marwan Issa, che però ricopre comunque una posizione di
spicco all'interno dell'ala militare di Hamas. E che, soprattutto, gode della
fiducia di Mohammed Deif.
Mattatoio Gaza.
Piccole Note il 19
maggio 2021 su Il Giornale. Amira Hass verga un durissimo atto di accusa contro
i bombardamenti di Gaza in una nota pubblicata da Haaretz dal titolo: “Gaza
viene cancellata: Israele sta spazzando via intere famiglie di proposito”.
Secondo la Hass, che si rifà a fonti dell’organizzazione israeliana B’Tselem e
delle Nazioni Unite, nel corso dei bombardamenti alcuni edifici sono stati
abbattuti, “per quanto è noto, senza alcun preavviso” che permettesse agli
occupanti di “evacuare le case prese di mira”, come invece è accaduto per altri
target, come ad esempio la Torre che ospitava al Jazeera, l’Associated Presse e
altri media internazionali. Da qui l’alto numero dei civili uccisi, di cui molti
bambini. “Spazzare via intere famiglie attraverso i bombardamenti israeliani è
stata una delle caratteristiche della guerra del 2014″, scrive la Hass. “Nei
circa 50 giorni di guerra, i dati delle Nazioni Unite dicono che 142 famiglie
palestinesi furono cancellate (742 persone in totale). I numerosi incidenti di
ieri e di oggi attestano che non si trattava di errori: e che il bombardamento
di una casa con tutti i suoi occupanti ancora al suo interno dipende da una
decisione dall’alto, esaminata e approvata dai giuristi che supportano i
militari”.
Nessun preavviso. Nel 2014,
scrive la Hass, tante vittime innocenti furono causate dal fatto “che l’esercito
israeliano non ha fornito alcun preavviso ai proprietari della casa [presa di
mira] né agli inquilini; o dal fatto che l’avviso non ha raggiunto l’indirizzo
corretto in tempo”. Quindi, dopo aver elencato vari casi in cui i bombardamenti
sono stati preceduti da un preavviso per salvare i civili, spiega: “Il fatto
stesso che l’esercito israeliano e lo Shin Bet [l’intelligence militare ndr] si
preoccupino di chiamare e ordinare l’evacuazione delle case dimostra che le
autorità israeliane hanno i numeri di telefono correnti degli abitanti di ogni
struttura che stanno per distruggere. E hanno i numeri di telefono dei parenti
delle persone sospettate o note per essere attiviste di Hamas o della Jihad
islamica”. “Il registro della popolazione palestinese, compreso quello di Gaza,
è nelle mani del ministero dell’Interno israeliano. e ha dettagli come nomi,
età, parenti e indirizzi”. Ciò perché l’Autorità palestinese deve comunicare a
Israele nuovi nati, indirizzi e quanto altro, continua la Hass. Informazioni che
prima di essere ufficializzate devono “ricevere l’approvazione israeliana,
perché senza di essa i palestinesi non possono ricevere la carta d’identità
quando sarà il momento o, nel caso di minori, non potranno viaggiare da soli o
con i loro genitori attraverso i valichi di frontiera controllati da Israele”,
viaggi necessari per quanti si recano a lavorare fuori dalle ristrettezze
economiche della Striscia o altro. “È chiaro, quindi, che l’esercito conosce il
numero e i nomi dei bambini, delle donne e degli anziani che vivono in ogni
edificio residenziale che bombarda”, conclude la Hass. Di obiettivi militari e
non. L’altro corno della questione riguarda il motivo per cui un edificio viene
abbattuto, cioè la sua definizione di “obiettivo militare”, riguardo al quale
non è previsto alcun preavviso ovviamente, che prevede uno spettro molto ampio
di possibilità. La Hass spiega che alcuni degli edifici abbattuti “sono stati
individuati come infrastrutture operative o di comando e controllo
dell’organizzazione o infrastrutture terroristiche, anche se tutto ciò che
avevano era un telefono o semplicemente aveva ospitato una riunione” di membri
dell’organizzazione. Infine, flessibile è anche il concetto di “proporzionalità”
sul quale si basano le operazioni dell’esercito israeliano, che soppesa anche la
possibilità e l’entità dei “danni collaterali” dei bombardamenti. “Una volta che
l”importanza’ di un membro di Hamas è considerata alta e la sua residenza è
identificata come obiettivo legittimo per i bombardamenti, il danno collaterale
‘ammissibile’,- in altre parole il numero di persone innocenti uccise, compresi
bambini e neonati – diventa molto ampio”. Commovente la nota della Hass, che
elenca nomi e cognomi dei civili innocenti morti a Gaza: ad oggi sono 213, di
cui 63 bambini. Resta che anche Hamas non è che lanci fiori sul territorio
israeliano, e che i civili innocenti ebrei sono altrettanto importanti, sia i
vivi che, purtroppo, i morti, che sono. Detto questo Hamas non ha armi di
precisione: un razzo al massimo può essere indirizzato verso una città, non su
un obiettivo più specifico, al contrario della controparte, che sa dove e quando
colpire. Importante un altro articolo di Haaretz, firmato da Amos Harel, che
spiega come nel corso dei colloqui intercorsi in questi giorni tra i più
importanti esponenti politici israeliani e i capi dell’esercito è emerso che la
“stragrande maggioranza di essi ritiene che l’ operazione a Gaza sia prossima
alla conclusione”. Gli obiettivi strategici sarebbero cioè stati conseguiti,
dato che all’esercito era stato dato mandato di tagliare le unghie ad Hamas e
ripristinare la deterrenza, non altro e più radicale.
Ma, spiega, Harel, Netanyahu
vuole una “vittoria netta”, un successo che si riverberi anche nell’ambito
politico israeliano. A tale proposito ricorda che il suo rivale Yair Lapid ha
ancora due settimane di tempo per cercare di formare un governo alternativo al
suo, come da mandato del presidente di Israele. “Nulla di nuovo sotto il sole”,
conclude Harel, conclusione alla quale ci associamo. Il mattatoio continua.
L'escalation a Gaza. “I media non cedano
alla propaganda di Hamas”, intervista a Noemi Di Segni.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 20 Maggio 2021.
Dolore, inquietudine e rigetto di una visione propagandistica della tragedia che
si sta consumando a Gaza e in Israele. Sono i sentimenti che dominano
nell’ebraismo italiano e di cui Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle
comunità ebraiche italiane (Ucei), si fa interprete in questa intervista a Il
Riformista.
Bombe, razzi, morte e distruzione. A Gaza, in
Israele. Quali sentimenti prova di fronte a tutto ciò?
Tantissima tristezza, tantissima angoscia e
tantissima disperazione e struggimento. Lo strazio è anche per il crimine di
donne e bambini utilizzati come scudi umani. Uffici e centrali terroristiche
ubicati nei palazzi ordinari civili. Perché? Poi si comincia a ragionare sui ma
e i però e i perché. Tutta l’analisi lato israeliano è un’analisi lunga e
complessa. Come comunità ebraiche abbiamo a cuore questa situazione sia per
l’identità ebraica che abbraccia e comprende Israele e una storia che comprende
tutto il sentire ebraico. Per noi Israele è un punto di riferimento e lo Stato
d’Israele va difeso e ha il diritto di difendersi e di essere riconosciuto e
salvaguardato. Questo da un punto di vista da qui verso Israele. Ma poi da
Israele a qui: quello che succede nei territori israeliani, nei territori che
sono il controllo dell’Autorità Palestinese, genera un quadro di pressioni e di
sentimenti in qualsiasi altra parte del mondo e anche dove ci sono le comunità
ebraiche che a loro volta ricevono l’eco di quello che succede in maniera molto
forte, come esplicitazione di antisemitismo a livello locale.
Qual è il segno di questo antisemitismo?
È un antisemitismo che nasce da una
rappresentazione assolutamente appiattita e monocolore, frutto di una propaganda
ben studiata della parte palestinese nelle sue varie articolazioni. L’Autorità
Palestinese, il terrorismo palestinese, Hamas e le altre organizzazioni
palestinesi hanno un disegno ben preciso, ben chiaro che non accetta l’esistenza
d’Israele. E su questo è assolutamente necessario che governi e media capiscano
con chi si ha a che fare, con il supporto di potenze note, Iran, Turchia, Qatar…
All’interno di questo disegno di distruzione c’è l’uso della propaganda. Israele
non mostra le proprie vittime, né quelle degli altri. E non le fa vedere, quelle
degli altri, non per negarle, ma perché non crede che sia un modo di comunicare
in una situazione di questo genere. Non fa vedere i propri cittadini feriti,
massacrati, assassinati. Non li esibisce. Lo stile urlante, quello della
propaganda, non ci appartiene. E qui torno ad Hamas…
E alla sua “guerra” di propaganda…
Una propaganda fatta di immagini struggenti, molto
gravi che alcuni giornali italiani hanno messo in evidenza. Cosa che non è stata
fatta in anni e anni di conflitti e di guerre. Neanche i bambini siriani
venivano messi così sulle pagine dei giornali per creare pietà nel mondo per
quel che succede in altri Paesi con guerre tuttora in corso. Ma per la Palestina
sì. C’è un modus operandi giornalistico che favorisce la condivisione di
immagini, materiali che sono propaganda, non informazioni che arrivano dal lato
palestinese. O immagini completamente costruite ad arte, inesistenti nella
realtà, di come i soldati israeliani trattano bambini o donne palestinesi.
Immagini inventate totalmente, come è facilmente dimostrabile. Questo è qualcosa
di letale. Usare una propaganda che penetra a gocce, a gocce che diventano
fiumi, nell’opinione pubblica, non solo palestinese ma nei media internazionali
ed europei, che finisce per supportare l’azione di chi mira alla distruzione,
all’annientamento totale d’Israele e del suo popolo. Questo è esattamente quello
che è accaduto prima della Seconda Guerra mondiale. È esattamente la stessa
cosa. L’alert io lo rivolgo a chi deve imparare a distinguere un linguaggio da
un altro. Questo genera ulteriore stress e ansia. Non si tratta di fare pace “al
mignoletto” come fra bambini che hanno litigato. Siamo davanti a una situazione
storica e geopolitica estremamente complessa, perché comporta tante ideologie e
tanti interessi che vanno anche oltre i confini d’Israele e dei due popoli. Due
popoli, due Stati, si ripete.
Impossibile?
È uno slogan troppo facile. Due popoli esistono,
ma due Stati con chi? Con chi si fa questo Stato palestinese? Questo è l’enorme
punto interrogativo irrisolto. E va ricordato che la proposta di costituire lo
Stato palestinese è stata fatta nel ’47, è stata fatta da Ehud Barak nei
negoziati di Camp David e fu risposto no. È stato liberato il territorio di Gaza
che da anni non è più sotto controllo. È stato fatto il ritiro unilaterale da
parte di Sharon, dopo di che si è detto: organizzatevi in questo territorio. E
quel territorio, la Striscia di Gaza, ha un confine con Israele e ha un confine
con l’Egitto. Perché quel territorio ha oggi quell’assetto, mentre gli altri
territori hanno un assetto diverso? Ci sarà una spiegazione legata anche a chi
controlla quei territori per davvero. Perché Israele riesce ad arrivare ad
accordi di pace con altre potenze arabe e qui no? Non può essere solo la
“cattiveria” israeliana che vuole distruggere il popolo palestinese. Se avessimo
voluto distruggere Gaza, perché allora le operazioni sono così mirate,
chirurgiche? Se uno davvero odiasse, se davvero fossimo come siamo dipinti,
allora basterebbe una bomba per radere al suolo tutto in tre minuti. Non è stato
fatto perché è chiaro che non è questa la volontà, il disegno. Io vorrei con
tutto il cuore che il popolo palestinese vivesse in una situazione di raccordo
con la popolazione israeliana, ma quel popolo è sotto il controllo delle proprie
autorità che non consente di andare avanti in questa direzione. Come comunità
ebraiche siamo preoccupate per questo modo di rappresentare il conflitto
israelo-palestinese, in particolare in questo momento così drammatico. E ad
aggravare la preoccupazione c’è un altro fatto…
Quale?
Quello che accade nelle città miste, etnicamente
vissute da ebrei israeliani e da arabi israeliani. Ciò che sta accadendo fa
malissimo. Perché mentre sulla parte degli accordi con i palestinesi la
situazione, anche per quanto riguarda Gaza, è molto complessa e investe
negoziati anche a livello internazionale, sul piano delle città miste
israeliane, lì c’è una sfida che dipende da noi. Da noi tutti, cittadini,
autorità locali, governo. Come si vive in armonia, come si convive giorno per
giorno, casa per casa, negozio per negozio. Io ricevo tantissimi messaggi,
fioccano iniziative per dire noi: vogliamo vivere insieme. Medici, ingegneri,
persone che lavorano al supermercato, persone che stanno al lavaggio delle
macchine insieme. In qualsiasi fotografia di vita quotidiana, arabi ed ebrei
israeliani che esplicitano di voler vivere insieme. E va assolutamente
recuperato questo senso di fiducia. La sfida è sul quotidiano. E siccome l’ho
visto con i miei occhi, posso testimoniare che si può. Questo dipende da noi. E
ciò passa anche per l’isolamento di quelle frange che puntano alla divisione e
allo scontro. Israele non è pacco di fiocchi rosa. Ci sono tantissime sfide
nella società israeliana, anche all’interno del mondo ebraico. Ma la forza
d’Israele non è quella di essere un fiocco rosa. La sua forza è essere una
democrazia che affronta i problemi,
E sul versante palestinese?
La diplomazia va sostenuta. Un accordo va
ricercato. Ma ci sono presupposti dai quali non si può prescindere. Il primo dei
quali è il riconoscimento del diritto di d’Israele all’esistenza e la
salvaguardia di questo diritto. E poi c’è la strumentalizzazione ideologica che
viene fatta su Gerusalemme, e che va ben oltre ciò che si vorrebbe fare di Gaza
o sui confini. Haniyeh, il capo politico di Hamas, ha fatto un discorso
ideologico su Gerusalemme, che catalizza molto consenso. Lui si vuole affermare
come leader. E anche questo sfugge alla comprensione di chi vive in Europa. C’è
una dialettica aspra all’interno degli stessi movimenti palestinesi, di chi
vuole affermare il proprio potere sugli altri. Il mondo deve capire le ragioni
d’Israele. Ciò che sta avvenendo in Israele, a Gaza, riguarda l’Europa, riguarda
l’Italia. Non basta guardare da lontano con pietà. Non basta l’appello del Papa.
Qui bisogna intervenire e salvaguardare valori che sono della cultura nostra, in
Italia e in Europa. E questi valori sono riflessi nella difesa d’Israele. Se non
si comprende questo, se si cede alla propaganda e non si fa informazione, si
regala ad Hamas il controllo dei valori distorti. E il mondo perde. Ed è quello
che è successo negli anni ’30. Propaganda, propaganda, propaganda. E poi il
disastro.
Umberto De Giovannangeli. Esperto di Medio Oriente
e Islam segue da un quarto di secolo la politica estera italiana e in
particolare tutte le vicende riguardanti il Medio Oriente.
Guido Olimpio per il "Corriere della Sera" il 17
maggio 2021. È il 16 febbraio 2003. Nidal Farahat è al lavoro in un'officina di
Gaza su un modello di drone acquistato sul mercato civile. Con lui alcuni
militanti di Hamas, membri dell'apparato impegnato nello sviluppo di armi.
Qualche istante dopo sono dilaniati da una bomba nascosta nel mini-velivolo, una
trappola del Mossad. L'omicidio mirato è il primo in una lunga campagna di
Gerusalemme per neutralizzare gli uomini coinvolti nel programma per lo sviluppo
di razzi. All'epoca erano i Kassam, costo sui 300 dollari, gittata una dozzina
di chilometri. La morte di Farahat è una perdita simbolica, ma non ferma i
progetti delle fazioni che aumentano gli sforzi per avere sistemi migliori. Nel
2009 importano, con l'assistenza dell'Iran, i missili Fajr. I carichi arrivano
via nave in Sudan, proseguono lungo le piste dei contrabbandieri verso il Sinai
egiziano per essere quindi trasferiti a Gaza. Israele reagisce con i suoi metodi
abituali. Nel gennaio 2009 esce la notizia di un raid aereo contro un convoglio
di camion nella regione sudanese di al Shananun, informazioni parlano del
trasporto di armamenti, girano sospetti persino sugli Usa. Invece sono stati gli
israeliani, responsabili anche dell'affondamento di un cargo nei pressi di Port
Sudan. A dicembre dello stesso anno una misteriosa esplosione coinvolge un bus a
Damasco. A bordo vi erano esperti di Hamas e iraniani, tutti coinvolti nel piano
di riarmo. I pasdaran forniscono materiale finito e tecnologia, svolgono la
funzione di consiglieri mentre l'alleato mette in piedi una propria «industria»
con inventiva e determinazione viste le condizioni di Gaza. L'asse
Iran-Hebzollah-Gaza non si interromperà mai. Non passa neppure un mese ed arriva
un colpo clamoroso: l'assassinio in un hotel di Dubai di Mahmoud al Mabhouh. La
vittima ricopre un ruolo cruciale nella catena di approvvigionamento militare,
viaggia molto, è l'interlocutore di Teheran e di personaggi fidati in Sudan. I
killer usano una sostanza letale, sperano che il decesso sia imputato ad una
crisi cardiaca. La polizia locale non «dorme», denuncia la trama del Mossad,
pubblica le foto dei responsabili. Show mediatico per avvertire Gerusalemme. I
«cacciatori di teste» si limitano ad attendere. Rispuntano in Ucraina l'11
febbraio 2011, quando rapiscono su un treno Diran Abu Sisi, ingegnere, esperto
nel campo missilistico in Est Europa. Lo portano nello Stato ebraico, lo
chiudono in cella e ottengono informazioni importanti. Che probabilmente sono
usate per un nuovo strike a Port Sudan ai primi d' aprile: il target è il
presunto successore di al Mabhouh. E a fine maggio, ancora nel porto sudanese,
salta in aria Nasser Said, membro del clan Abada, presentato come uno dei perni
dei traffici. A giugno a Damasco trovano il corpo semicarbonizzato di Kamel
Ranaja, indicato come procacciatore di armi. Altra sequenza: il 24 ottobre 2012
i sudanesi accusano Gerusalemme di aver bombardato con i caccia una fabbrica di
munizioni a Yarmuk. È una lotta senza tregua, perché i palestinesi ad ogni
confronto rivelano pezzi più potenti, ne estendono il raggio d'azione, li
nascondono meglio. Capacità che provocano le contromosse dell'intelligence
contro elementi impegnati in ricerche belliche. Nel 2016 una sofisticata
operazione elimina a Sfax, in Tunisia, Mohamed Zawahiri. Superano la sua cautela
con il pretesto di un'intervista (finta). Ancora più lontano dal teatro
l'agguato dell'aprile 2018: Kuala Lumpur, Malaysia, dove cade sotto il tiro di
una coppia di sicari Fadi al Batsh. La guerra segreta del Mossad ha privato il
nemico di teste pensanti, ha ostacolato la linea di rifornimento. Non è però
riuscita a impedire che i militanti ottenessero ciò che volevano: mezzi non
comparabili alla potenza dell'avversario, tuttavia sufficienti per mantenere la
sfida.
Israele e Palestina, storia di una guerra
infinita e di una convivenza (im)possibile. Le Iene
News il 14 maggio 2021. Tra Israele e la fazione palestinese di Hamas a Gaza è
di nuovo guerra aperta da giorni, dopo la decisione del governo israeliano di
chiudere la "porta di Damasco", un importante varco di accesso alla Spianata. Ma
il conflitto tra parte del popolo arabo e quello ebraico che da un secolo
convivono su quelle terre affonda le sue radici molto in profondità: ecco da
dove nascono gli scontri di questi giorni, anche con un servizio di Antonino
Monteleone in cui incontriamo una famiglia palestinese e una israeliana delle
colonie. Dessau è una piccola cittadina tedesca nel cuore della Sassonia, una
delle regioni che oggi compongono la repubblica federale di Germania. A quasi
tremila chilometri di distanza sorge una delle città più famose e importanti
della storia, Gerusalemme, che in questi giorni è tornata tristemente alla
ribalta per gli scontri tra le autorità israeliane e Hamas. Proprio di
Gerusalemme e di questo conflitto infinito vi abbiamo parlato anche nel servizio
di Antonino Monteleone del 2017 che vedete qui sopra: abbiamo passato un po’ di
tempo in compagnia di una famiglia palestinese e di una israeliana delle colonie
per capire meglio questo conflitto che sembra senza fine. I conflitti tra
israeliani e palestinesi continuano, a fasi alterne, da oltre settant’anni, da
quando il 14 maggio del 1948 David Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di
Israele. Ma per capire questo conflitto che insanguina da decenni la Terra Santa
bisogna partire da lontano, proprio da quella cittadina tedesca che sonnecchia
appoggiata sulle rive dell’Elba. Il 6 settembre del 1729 le gelide acque del più
importante fiume dell’Europa centrale tennero a battesimo Moses Mendelssohn,
filosofo tedesco di origine ebraica e importante pensatore dell’Illuminismo.
Alle sue opere si fa risalire la nascita - o meglio la rinascita -
dell’Haskalah: un movimento di pensiero che riteneva necessario
introdurre modifiche allo stile di vita tradizionale degli ebrei, permettendone
la contaminazione con altre culture senza però rinnegare i fondamenti della
propria identità. È a questo movimento di pensiero che si deve, per esempio, la
modernizzazione della lingua ebraica. Ed è da questo filone dell’Illuminismo,
nato e sviluppatosi in Germania, che un secolo dopo nacque l’ideologia politica
del sionismo. Non si può riassumere in breve né la complessità dell’Haskalah, né
quella del sionismo. In questo contesto basti sapere che quest’ultimo sosteneva
il diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico e la nascita di uno Stato
d’Israele in quelle terre che la Bibbia definiva le “terre d’Israele”. A cavallo
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, importanti ondate
migratorie interessarono l’allora territorio di Palestina sotto il controllo
dell’Impero Ottomano: migliaia di ebrei iniziarono a trasferirsi in quelle terre
anche per l’impulso culturale del sionismo, un fenomeno che prenderà il nome di
Aliyah, “la salita” in ebraico. Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1918,
la Palestina passò sotto il controllo dell’Impero Britannico e il processo
migratorio degli ebrei aumentò considerevolmente: Londra, favorevole all’idea di
creare due stati distinti, separò le terre del proprio mandato in Transgiordania
a est ed insediamenti ebraici a ovest. È la prima pietra della diffidenza e poi
scontro tra ebrei e arabi nella zona. Dalla fine della Grande Guerra all’inizio
delle persecuzioni ebraiche da parte della Germania nazista, la popolazione
ebraica residente in Israele passò da 80mila a 400mila persone. E già in quegli
anni la tensione tra gli abitanti musulmani e quelli ebrei iniziò a montare,
dando non pochi problemi alle autorità inglesi nel gestire l’ordine pubblico in
Palestina. Nel 1936 la situazione degenerò e iniziò quella che oggi viene
chiamata “grande rivolta araba”: un’insurrezione degli arabi palestinesi contro
i coloni di origine ebraica durata fino allo scoppio della Seconda guerra
mondiale. Le popolazioni arabe della zona, che già vent’anni prima si erano
sollevate in modo simile contro l’occupazione ottomana, lamentavano la
benevolenza con cui i britannici sembravano favorire l’immigrazione ebraica.
Migliaia di arabi e centinaia di ebrei morirono durante gli scontri. Alla
tensione si aggiunse l’ulteriore ondata migratoria causata dalle feroci
persecuzioni contro gli ebrei in Germania prima e in Italia dopo. Lo scontro tra
palestinesi ed ebrei, insomma, è iniziato anni prima che Israele nascesse. È in
quegli anni che nacque e si sviluppò la città di Tel Aviv, futura capitale de
iure di Israele. Ed è proprio in quegli anni che le attività economiche ebraiche
e arabe, fino ad allora sostanzialmente interconnesse, si separarono in modo
deciso. Furono proprio quegli scontri tra le due fazioni che piantarono
definitivamente il seme di quanto stiamo vivendo ancora oggi. Facendo un salto
in avanti nel tempo, arriviamo alla fine della Seconda guerra
mondiale: l’atrocità della Shoah portò gli occidentali a vedere la nascita di
uno Stato d’Israele come una sorta di compensazione di quanto accaduto. Il 29
novembre 1947 l’Onu stabilì ufficialmente la nascita di due stati separati,
Israele e la Palestina. Nel primo, che occupava un po’ più della metà del
territorio del mandato britannico, avrebbero vissuto mezzo milioni di ebrei e
quasi altrettanti arabi. Nel secondo, la popolazione era quasi tutta araba. Ma
questi ultimi lamentavano l’ingiusta partizione delle terre: molte di quelle
fertili sarebbero infatti state destinate a Israele. Caso a parte Gerusalemme,
la città santa per gli ebrei e i cristiani e la terza città più importante per i
musulmani: sarebbe stata zona franca gestita direttamente dall’Onu. Senza
entusiasmo, gli ebrei accettarono il progetto delle Nazioni unite. Gli arabi
della zona, supportati dagli stati circostanti, no: appena finì il mandato
britannico sulla Palestina, il leader del popolo ebraico Ben Gurion proclamò la
nascita dello Stato d’Israele. Il giorno dopo, il 15 maggio 1948, gli eserciti
di Egitto, Siria, Libano, Iraq e Transgiordania invasero il neonato Stato.
Contro ogni prospettiva e pronostico, Israele vinse nettamente la guerra. In
meno di un anno il conflitto terminò e Israele occupò moltissimi territori
esterni ai suoi confini. Quasi un milione di palestinesi furono costretti ad
abbandonare le loro case: “al-Nakba”, la catastrofe, così i palestinesi chiamano
l’esilio a cui furono costretti dal conflitto. Crucialmente, anche Gerusalemme
Ovest fu occupata da Israele, che lì trasferì gli uffici del governo e proclamò
capitale dello stato. Molti dei territori che sarebbero dovuti essere parte
dello stato di Palestina, furono occupati dagli altri stati arabi: la striscia
costiera di Gaza dall’Egitto, la Cisgiordania dalla Giordania. La Città Santa
entrò così in uno stato di guerra permanente che dura fino a oggi. Metà città
controllata da Israele, l’altra metà controllata dalla Giordania. Intanto, per
ritorsione alla cacciata dei palestinesi dai territori occupati da Israele, gli
stati arabi limitrofi iniziarono a loro volta a cacciare gli ebrei: quasi un
milione di persone si trasferirono così in Israele, aumentando la presenza
ebraica nei confini. Nei decenni successivi si sono combattute altre guerre
aperte tra Israele e i suoi vicini: nel 1956 Israele partecipò alla guerra di
Francia e Gran Bretagna contro l’Egitto per il controllo del canale di Suez.
Meno di un decennio dopo, nel 1964, nacque l’Organizzazione per la liberazione
della Palestina, con il sostegno della Lega araba. Nel 1967 si passò nuovamente
alle armi, con Israele che attaccò l’Egitto causando la risposta di Siria e
Giordania: lo stato ebraico vinse nettamente la guerra, occupando Gerusalemme
Est, la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, le alture del Golan e la penisola del
Sinai. Nel 1973 Egitto e Siria contrattaccarono, nello scontro divenuto famoso
come “guerra dello Yom Kippur”, festività ebraica durante la quale fu lanciato
l’attacco. Una battaglia terminata in stallo, con l’Egitto che riottenne il
Sinai in cambio del riconoscimento dell’esistenza di Israele (prima di allora
nessuno stato arabo l’aveva riconosciuta). Quella del 1973 rimane di fatto
l’ultima guerra aperta combattuta tra gli stati confinanti arabi e Israele, ma
di certo non è l’ultimo periodo di guerra o guerriglia nella zona. Nel 1987, a
seguito delle continue colonizzazioni di Israele dei territori occupati, venne
lanciata dai palestinesi la “prima Intifada”: atti di disobbedienza civile,
scioperi generali, boicottaggio di prodotti israeliani, barricate e attacchi
alle forze militari israeliane. Tel Aviv rispose con durezza: in quattro anni
furono oltre mille i palestinesi uccisi dagli israeliani e quasi altrettanti
quelli uccisi da altri palestinesi, perché accusati di collaborare con il
nemico. Alla prima Intifada, terminata nel 1993, ne seguì una seconda iniziata
nel 2000: l’allora leader israeliano Ariel Sharon visitò la Spianata (del Tempio
per gli ebrei, delle Moschee per i musulmani), scatenando la reazione dei
palestinesi. Furono altri cinque anni di guerriglia, che causarono la morte di
mille israeliani e 5mila palestinesi, in grande maggioranza vittime civili. Tra
le due Intifade, l’assassinio del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin per
mano di un estremista di destra ebraico, avvenuto nel 1995, segnò la fine dei
difficilissimi colloqui di pace tra le due fazioni. Il 13 settembre del 1993
infatti è rimasta ancora oggi la data in cui la pace tra israeliani e
palestinesi è sembrata più vicina: l’immagine dei due leader, Rabin e Yasser
Arafat, che si stringono la mano sotto lo sguardo compiaciuto del presidente
americano Bill Clinton, passò alla storia e aveva riacceso le speranze di pace
dei due popoli. Speranza che purtroppo è rimasta lettera morta. Nel corso degli
ultimi decenni infatti la tensione tra israeliani e palestinesi è continuata a
crescere con vicendevoli scontri e attacchi. Il governo di Israele ha
colonizzato territori occupati che i palestinesi rivendicano come propri. Alcune
città - di cui Betlemme è l’emblema - vivono in uno stato di durissima
occupazione militare: l’intero centro abitato è circondato da un muro, con
checkpoint per poter entrare e uscire. E la popolazione araba denuncia le
continue angherie che è costretta a subire. La Palestina oggi è ridotta alla
Striscia di Gaza e a parte della Cisgiordania: Gaza è controllata da Hamas,
un’organizzazione politica e paramilitare che - almeno da alcuni stati, tra cui
gli Stati Uniti - è indicata come organizzazione paraterroristica.
La Cisgiordania è invece governata da al-Fatah, anch’essa un’entità politica e
paramilitare che non è però accusata di praticare azioni terroristiche. A
rendere ulteriormente complicato il quadro politico della zona - e le condizioni
di vita dei palestinesi - c’è il conflitto, che dura ormai da quindici anni,
proprio tra Hamas e al-Fatah: nel 2006 le due fazioni palestinesi si sono
combattute per il controllo della striscia di Gaza. La guerra è stata vinta a
Gaza da Hamas e da allora le due aree non contigue che formano la Palestina
odierna sono controllate da due entità che a stento dialogano tra di loro in una
situazione di spartizione di fatto. Insomma, come è facile intuire le terre di
Israele e Palestina sono una vera polveriera. Per capire fino in fondo le
tensioni che animano quelle terre però manca ancora un elemento,
quello religioso, fin qui di sottofondo al racconto ma in realtà cruciale negli
eventi dell’ultimo secolo. E se si parla di religione, nessun luogo al mondo ne
è impregnato come Gerusalemme. Gerusalemme è una Città Santa per ebrei,
cristiani e musulmani. Conquistata da re David nel 1000 a.C., fu capitale dello
stato ebraico fino alla conquista per mano di Alessandro Magno nel 331. Tutti i
tentativi di ellenizzare la città, operati dalle varie occupazioni che si sono
succedute nei secoli, hanno però sempre trovato una fiera resistenza da parte
degli abitanti ebrei. Nel 70 d.C., a seguito dell’ennesima ribellione contro
la dominazione straniera - questa volta romana - l’imperatore Tito ordinò la
distruzione del Tempio che sorgeva sulla Spianata. Nel VII secolo Gerusalemme
cadde sotto la dominazione araba che, escluso l’intermezzo della conquista
cristiana a seguito della prima crociata, è durata quasi ininterrottamente fino
alla fine della Prima guerra mondiale e l’arrivo degli Inglesi, di cui abbiamo
già raccontato. Gerusalemme dunque è stata al centro di moltissimi eventi
storici, che abbracciano le tre grandi religioni monoteiste: è stata la capitale
del regno d’Israele dove sorgeva il Tempio ebraico, è stata la città dove s’è
svolta la predicazione e l’uccisione di Gesù, è stata anche teatro della
preghiera prima di ascendere al cielo del profeta Maometto nel 621. Tutto questo
fa di Gerusalemme Città santa per tre distinte religioni, che nel corso dei
secoli si sono spesso fatte la guerra per detenerne il controllo. Oggi il Muro
del Pianto, che “regge” la Spianata su cui ormai due millenni addietro sorgeva
il Tempio, è il luogo di preghiera più sacro dell’ebraismo. Ma sulla Spianata
sorgono da secoli la moschea al-Aqṣā e la Cupola della Roccia: insieme formano
l’al-Ḥaram al-Sharīf, il terzo sito più sacro del mondo per i musulmani. In
poche decine di metri quadrati si concentrano due dei luoghi di preghiera più
importanti del mondo. Chi di voi è stato nella Città santa - che come abbiamo
raccontato dal 1967 è occupata militarmente da Israele - sa bene cosa sia in
realtà oggi il Muro del pianto e la Spianata: una sorte di fortezza, difesa da
centinaia di soldati, dove la tensione tra due popoli e due fedi si respira come
elettricità nell’aria. La santità ha lasciato da tempo il campo alle armi. E
basta una scintilla per far esplodere quell’elettricità. Le rivolte di questi
giorni, anche se come abbiamo raccontato hanno radici storiche e culturali ben
più profonde, sono state scatenate dalla decisione del governo israeliano di
chiudere uno dei più importanti varchi d’accesso alla Spianata, la porta di
Damasco che affaccia sulla parte nord ovest della città: un atto visto dai
palestinesi come l’ennesima negazione dei propri diritti da parte dell’occupante
israeliano. Una scelta legittima di governo al tempo della pandemia per evitare
assembramenti, per le autorità ebraiche. E così Israele e Palestina sono di
nuovo in guerra aperta. A oggi sono più di cento le persone che hanno perso le
vita, in grande maggioranza civili palestinesi: le forze regolari israeliane
stanno pesantemente bombardando la Striscia di Gaza costringendo i palestinesi
alla fuga, dopo che dalla Striscia stessa erano partiti attacchi missilistici
verso le città israeliane (in gran parte naturalizzati dall’Iron Dome, un
sistema di protezione antiaereo israeliano). Si dice che: “Chi sarà capace di
portare la pace a Gerusalemme, potrà portarla in tutto il mondo”. Noi tutti
aspettiamo l’arrivo di quel giorno.
Perché l’ultima chance di pace in Medio
Oriente morì con Yitzhak Rabin. Francesca Salvatore su
Inside Over il 15 maggio 2021. Nel luglio del 1992 Yitzhak Rabin divenne premier
in Israele, il primo ad essere nato nel Paese: era lui l’eroe di guerra che, in
qualità di capo di Stato maggiore, polverizzò i progetti tattici egiziani
durante la Guerra dei sei giorni. Da quel momento, la vita e le missioni di
Rabin si intrecciarono saldamente ai destini della vicenda arabo-israeliana.
Prima dell’estate del 1992, infatti, Rabin visse molteplici vite: da militare ad
ambasciatore negli Stati Uniti, ministro, perfino uno scandalo finanziario che
lo costrinse a stare nell’ombra. Un’eterna rivalità con Shimon Peres, che poi
sarebbe stato fondamentale nella svolta verso l’Olp. Ma all’alba di quel nuovo
decennio post Guerra fredda, Rabin scelse di abbandonare il pugno di ferro
trasformandosi da “Mister sicurezza” a interlocutore, seppur cauto, dell’Olp.
Sul tavolo, la sempiterna opzione della nascita di un soggetto autonomo
palestinese, osteggiata dal Likud. Una complessa situazione acuita dalle
tensioni esacerbatesi dopo lo scoppio dell’intifada a cui il governo
conservatore di un altro Yitzahak (Shamir) rispose col pugno di ferro nel 1990.
La svolta del 1993-94. Mentre la diplomazia
seguiva i suoi canali, sottotraccia, i laburisti salirono al potere e Rabin
impresse una svolta decisiva verso i negoziati. Alla fine dell’estate del 1993
una “dichiarazione di principi” raggiungeva un compromesso storico fra le due
parti: autogoverno palestinese per la striscia di Gaza e Gerico e autonomia
(seppur inferiore) per i territori occupati. Il 13 settembre di quell’anno a
Oslo, Shimon Peres e Mahmoud Abbas firmavano a Washington l’elaborato realizzato
con la mediazione norvegese. Un anno dopo, per imporre
l’imprimatur internazionale a quello sforzo, il leader palestinese Yasser
Arafat, Rabin e il ministro degli esteri israeliano Shimon Peres ricevettero
il premio Nobel per la Pace. Quell’anno non era iniziato sotto i migliori
auspici: a cominciare dal massacro di Hebron del 25 febbraio, in cui un ebreo
israeliano uccise 29 palestinesi musulmani in una moschea. Nello stesso anno,
altri attentati, rivendicati soprattutto da Hamas, colpirono Tel Aviv, segnando
22 morti. Nel resto del mondo, il 1994 sembrava imprimere significati nuovi al
sistema internazionale, di segno, però, opposto: la guerra nei Balcani, il
conflitto somalo, il genocidio ruandese ma anche la cementificazione dell’Unità
europea e Mandela presidente del Sudafrica. Un nuovo ordine che guardava al
centro del Medio Oriente come a un termometro del mondo che sarebbe venuto. Ecco
perché un’ulteriore svolta sarebbe stata impressa, nell’immaginario collettivo,
due anni dopo a Washington, quando Rabin e Arafat, con la benedizione di Bill
Clinton si strinsero la mano sotto i riflettori del mondo intero.
I contenuti della pace. Al di là della solennità
epica del momento, la pace del 1995 era un accordo più che concreto e obbligò i
contraenti a mettere sul piatto della bilancia principi fino ad allora
irrinunciabili: venivano definiti i paletti di un processo nel quale Israele
acconsentiva alla nascita di un’entità statale palestinese (anche se il termine
“stato indipendente” non venne utilizzato) e l’Olp si piegava a riconoscere lo
stato di Israele, “rinunciando” al desiderio di espellere gli israeliani
dall’area. Questi ultimi, inoltre, acconsentivano al ritiro da Gaza e da parte
della Cisgiordania. Israele, inoltre, riconobbe l’Olp come unico rappresentante
del popolo palestinese. A sottendere gli aspetti militari vi era poi un
corposo piano di crescita economica comune, considerato la base per il decollo
internazionale dell’area e per la coesistenza pacifica.
Promesse epocali, rinunce epocali. Gli accordi
fondevano due serie fondamentali di scambi. In primo luogo, Israele si sarebbe
affrancata dalla responsabilità della popolazione palestinese, pur mantenendo il
controllo strategico del territorio. I palestinesi si sarebbero sbarazzati del
giogo militare israeliano e avrebbero ottenuto l’autogoverno, giungendo
gradualmente a conquistare lo status di nazione. In secondo luogo, il
disconoscimento della violenza da parte di Arafat e il suo impegno a combattere
il terrorismo – attraverso l’uso di una forza di polizia nazionale palestinese –
sarebbe stato una garanzia anche per gli israeliani. I palestinesi, inoltre,
avrebbero attinto dalla grande quantità di aiuti esteri dagli Stati Uniti (e da
altri Paesi ) e dagli accordi economici stipulati con Israele progettati per
promuovere l’occupazione e il commercio. La sterzata di Rabin suscitò un’enorme
opposizione da parte del Likud, sebbene la maggioranza degli israeliani, in un
primo momento, lo sostenne fortemente, soprattutto perché l’accordo avrebbe
permesso a Israele di sbarazzarsi della polveriera di Gaza. Specularmente, non
tutti i palestinesi, tuttavia, furono favorevoli al nuovo corso di
Arafat. Hamas vi si oppose violentemente scagliando una serie di attacchi
terroristici contro civili israeliani.
La morte di Rabin e l’occasione perduta.
L’atmosfera in Israele e nei territori palestinesi occupati, nei mesi precedenti
l’assassinio di Rabin, era turbolenta; un misto di speranza, paura e odio. In
alcuni manifesti, sventolati alle manifestazioni contro gli accordi, i nemici
israeliani di Rabin solevano ritrarlo come un nazista, con l’uniforme nera delle
Ss. Tra i palestinesi, i militanti di Hamas avevano già iniziato una campagna di
attentati suicidi: Oslo per loro era una resa e non poteva esserci alcun
compromesso territoriale con uno Stato che credevano non dovesse esistere.
Eppure, la sensazione generale, popolare e intellettuale, suggeriva che gli
estremisti, sebbene scalciassero, fossero stati messi finalmente sotto scacco.
Rabin, che era stato a lungo il volto della macchina bellica di Tel Aviv, amava
ripetere: Io, che ho inviato eserciti al fuoco e soldati fino alla morte, oggi
dico: salpiamo per una guerra che non ha vittime, né feriti, né sangue né
sofferenza. È l’unica guerra a cui è un piacere partecipare: la guerra per la
pace. Vederlo morire, per poi essere pianto dal mondo intero, costrinse anche
Israele a interrogarsi sul non averlo protetto abbastanza. I negoziatori non
avevano ancora toccato i punti più difficili dell’accordo di pace: i confini
finali di uno Stato palestinese, il futuro di Gerusalemme, dei profughi
palestinesi e degli insediamenti ebraici nei territori occupati:
presumibilmente, sarebbe stata solo questione di tempo. L’euforia per quelle
strette di mano ebbe vita breve. La sera del 4 novembre 1995, alle 21.30, al
termine di una manifestazione in favore del processo di pace e degli Accordi di
Oslo a Tel Aviv, Rabin venne raggiunto da due proiettili. Erano stati esplosi
da Yigal Amir, un giovane estremista “armato” dalle frange ebraiche più
radicali, le cui ire Rabin aveva scatenato. Nel 1996 il Likud, ostile agli
accordi, vinse le elezioni ed ebbe inizio l’era Netanyahu. Si provò a far
rivivere lo spirito di Oslo a Camp David: ma all’alba del nuovo Millennio, i
negoziati tornarono a fallire come era accaduto nei cinquant’anni precedenti. La
finestra lasciata aperta sulla storia si chiudeva violentemente per non
riaprirsi mai più.
La trappola infernale contro Hamas.
Lorenzo Vita su Inside Over il 14 maggio 2021.
L’annuncio dell’operazione via terra da parte delle Israel Defense Forces non è
stato un errore. All’inizio il portavoce delle forze dello Stato di Israele ha
parlato di un’incomprensione scusandosi con i media internazionali. Ma a poche
ore dalla smentita, l’ipotesi che prende sempre più forza è che non si sia
trattato di un “misunderstanding”, ma di una precisa tattica di guerra. La
storia è andata più o meno così. Poco dopo la mezzanotte, i media internazionali
hanno affermato quasi simultaneamente che le truppe dell’esercito israeliano
avevano fatto il loro ingresso nella Striscia di Gaza. In effetti, il giorno
prima, il comando meridionale delle Idf aveva presentato i piani di attacco per
un’operazione di terra e – anche se l’annuncio appariva più come un avvertimento
che come una reale possibilità di attacco – molti parlavano della possibilità di
un’incursione su larga scala quantomeno delle forze speciali. Dopo qualche ora,
i siti internazionali e i telegiornali hanno cambiato la notizia. Non c’era
più l’annuncio dell’invasione di terra ma di bombardamenti con l’utilizzo di
carri armati all’interno del territorio israeliano. Un dietrofront importante
perché, naturalmente, cambiava completamente la descrizione di quanto stava
avvenendo ai confini tra Israele e la Striscia di Gaza. Ma è sembrato abbastanza
difficile credere che i reporter, i giornalisti che avevano contatto con le
forze armate e i commentatori più attenti avessero preso un abbaglio inventando
una presunta invasione da parte dello Stato ebraico. Cosa era successo? Stando
alle prime informazioni riportate da diversi quotidiani israeliani, i
corrispondenti internazionali avevano ricevuto un messaggio da parte dell’Unità
del portavoce delle stesse Idf con cui si annunciava l’avvio delle operazioni
terrestri. Steve Hendrix, inviato del Washington Post a Gerusalemme, ha scritto
su Twitter un post in cui ha ripercorso i momenti salienti della nottata e i
messaggi delle Idf. Secondo il corrispondente, alle 00:17 è stato inviato il
seguente messaggio: “Le forze aeree e di terra dell’IDF stanno attualmente
attaccando nella Striscia di Gaza”. All’una e mezza una conferma: “*
Dichiarazione ufficiale IDF *Ci sono truppe di terra a Gaza”. Alle 2:13 la
smentita di quanto sopra: “Chiarimento: attualmente non ci sono truppe di terra
dell’IDF all’interno della Striscia di Gaza”. Il portavoce estero delle
Idf, Jonathan Conricus, si è scusato con i giornalisti stranieri parlando di un
errore e di essere dispiaciuto per averli tratti in inganno. Ma quello che è
avvenuto nella notte potrebbe non essere affatto un errore. E i primi a
segnalarlo sono stati proprio i media israeliani, in particolare uno, Canale 12,
che in un articolo ha parlato espressamente della trappola messa in atto dalle
Idf per annientare il più possibile le forze di Hasm durante i bombardamenti
avvenuti nella notte nella Striscia di Gaza. L’idea è che quanto avvenuto nella
notte non sia stato un errore, ma una scelta precisa delle forze israeliane che
hanno così deciso di usare la “nebbia di guerra” per indurre i miliziani di
Hamas a rifugiarsi nei tunnel sotto Gaza, la cosiddetta “metropolitana”. I
tunnel, quei canali strategici che permettono alle milizie dell’exclave
palestinese di rifornirsi di armi, contrabbandare materie prime, spostare uomini
e svolgere tutte quelle attività non tollerate da Israele, sono così diventate
da armi a trappole. Trappole di fuoco e cemento colpite dalla pioggia di missili
lanciata dall’aviazione israeliana e dei droni. I bombardamenti, tra i più
massicci degli ultimi anni, sono durati circa 40 minuti e hanno riversato sul
suolo di Gaza circa 450 bombe. Una resa dei conti che lo Stato ebraico attende
dal 2014, quando dopo l’operazione “Margine di protezione” Hamas ha iniziato a
costruire quella rete inestricabile di tunnel che per i comandi delle Idf è
ancora il vero grande incubo per qualsiasi operazione di terra.
Davide Frattini per corriere.it il 13 maggio 2021.
Ancora bombe, missili, morti e distruzioni: un migliaio di razzi sparati da
Hamas verso Israele, centinaia di attacchi aerei dello Stato ebraico su case e
strade della Striscia di Gaza. L’escalation non cessa e la situazione è tesa
nelle comunità di alcune città israeliane. Al terzo giorno di fuoco il
segretario generale dell’Onu António Guterres si dice «preoccupato» dalla
prospettiva di «una guerra vera e propria». Il bollettino, per ora: 400 feriti
tra i palestinesi e un centinaio tra gli israeliani secondo i rispettivi
governi; sei morti israeliani e almeno 65 palestinesi. Tra loro c’erano 14
bambini. E sul fronte israeliano uno di 6 anni è rimasto ucciso a Sderot. Hamas
conferma l’annuncio di poche ore prima del premier Benjamin Netanyahu che i raid
israeliani di ieri su Gaza hanno ucciso 16 «ufficiali graduati» del movimento
paramilitare, tra cui il comandante della brigata locale. Il leader di Hamas
Ismail Haniyeh ha risposto che «il confronto con il nemico non ha una fine
prevista», facendo eco alle parole del capo di stato maggiore israeliano Aviv
Kochavi, che aveva ordinato a «tutti i comandi di prepararsi a un conflitto
esteso e senza limiti di tempo». «Non è che l’inizio», ha detto Netanyahu.
«Israele», ha aggiunto il ministro della difesa Benny Gantz, «non è pronto a una
tregua». E mentre i razzi di Hamas vengono intercettati dallo scudo Iron
Dome (secondo l’esercito l’85%), Israele accusa Hamas di avere annidato i propri
quartieri generali nel mezzo dei centri abitati, dove si trova gran parte dei
500 obiettivi militari colpiti negli ultimi due giorni, tra cui un palazzo di
dieci piani che sarebbe stato sede dell’«intelligence» del movimento. E più
esplosiva — e per il governo di Netanyahu più difficile da gestire dei razzi di
Hamas, secondo l’analista americano Jonathan Schanzer su Twitter — è la
situazione delle città israeliane dove la popolazione è mista e la convivenza
più stretta, come Bat Yam e il villaggio di Lod dove da ieri è stato dichiarato
lo stato di emergenza con centinaia di arresti. Da due notti i residenti arabi
attaccano quelli che possono riconoscere come ebrei e martedì notte hanno dato
fuoco a una sinagoga. Parla di «pogrom» l’ex presidente del Parlamento
israeliano Reuven Rivlin, che con la stessa parola aveva condannato gli
estremisti ebrei in passato. Ora è indignato con i deputati arabi: «Il loro
silenzio è inaccettabile quanto il sostegno al terrorismo e ai disordini». Ayman
Odeh, alla guida della formazione araba più grande, invita a «continuare le
proteste senza danni a persone e proprietà». Sempre a Lod, martedì, un uomo
armato ha sparato contro una folla di arabi, uccidendo il trentatreenne Musa
Hassuna: il suo arresto ha aizzato i ministri di Netanyahu. I disordini si sono
estesi ad Acri, la fortezza sulla costa a nord, a Ramle e a Jaffa che fa parte
della municipalità di Tel Aviv. Lo stato di emergenza permette al capo della
polizia di imporre il coprifuoco per domare quella che Netanyahu definisce
«anarchia»: «Dobbiamo proteggere la nazione dai nemici all’esterno e dai
rivoltosi all’interno».
Netanyahu: "Agiremo per tutto il tempo
necessario". Gaza, diluvio di fuoco nella notte:
Israele attacca con missili e carri armati, 115 morti. Redazione su Il
Riformista il 14 Maggio 2021. E’ di almeno 115 un primo bilancio
delle vittime provocate dai raid dell’aviazione israeliana nella Striscia di
Gaza a tre giorni dall’inizio del conflitto e dopo l’ultima notte di
bombardamenti con il lancio, da parte di 160 caccia, di 450 missili per
colpire 150 obiettivi palestinesi, compresa una rete di tunnel che sarebbe stata
utilizzata dai militanti del partito Hamas. I feriti sono invece 600 mentre
delle 115 vittime, 27 sono minori e 11 le donne. Israele sostiene che la maggior
parte delle vittime siano membri di gruppi armati palestinesi o siano state
uccise da un razzo di Hamas che è atterrato all’interno della Striscia.
La gaffe sull’invasione via terra. Un portavoce
dell’esercito, Jonathan Conricus, ha invece corretto una sua precedente
dichiarazione secondo la quale le forze di terra sarebbero già entrate nel
territorio di Gaza. Il responsabile ha detto che unità dell’esercito e
dell’aviazione stanno conducendo attacchi verso la Striscia con carri armati e
artiglieria ma restando dalla parte israeliana del confine. Lungo la frontiera
si sarebbero concentrati tra i 3mila e i 4mila soldati. “Le forze di difesa
israeliane – scrive il Times of Israel – sembrano aver indotto erroneamente i
media stranieri a credere che l’esercito avesse lanciato un’invasione di terra
nella Striscia durante il suo massiccio bombardamento del nord di Gaza. Nella
sua dichiarazione iniziale in inglese, l’esercito ha espresso in modo ambiguo
dove si trovavano le sue forze di terra durante l’attacco, dicendo che ‘le
truppe aeree e di terra dell’IDF stanno attualmente attaccando nella Striscia di
Gaza’. Quando è stato chiesto di chiarire la questione, ovvero se ci fosse stata
un’invasione di terra, il portavoce dell’IDF Jonathan Conricus ha risposto:
‘Si’. Come e’ scritto nella dichiarazione. In effetti, le forze di terra stanno
attaccando a Gaza. Questo vuol dire che sono nella Striscia'”. Parole che
Conricus tra l’altro ha ripetuto anche al corrispondente dell’ANSA a Tel Aviv
che lo ha chiamato per avere conferma diretta dell’avvio dell’intervento di
terra. Ma, continua Times of Israel, sebbene dire che l’esercito era dentro Gaza
“fosse tecnicamente corretto”, è stato fuorviante: “Alcune truppe dell’IDF erano
effettivamente posizionate in un’enclave tecnicamente all’interno del territorio
di Gaza, ma a tutti gli effetti sotto il controllo israeliano. Per questo la
loro presenza lì non poteva rappresentare un’invasione di terra”. “Tutto ciò –
conclude il Times of Israel – ha portato alla diffusione di notizie false in
tutto il mondo, incluso da parte del New York Times e del Washington Post,
secondo cui Israele aveva lanciato una campagna di terra nella Striscia di Gaza,
cosa che invece non aveva fatto”.
Netanyahu: “Agiremo per tutto il tempo
necessario”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere
che Hamas pagherà un prezzo alto per i lanci di missili contro la popolazione
israeliana e che “l’operazione continuerà per tutto il tempo necessario. Agiremo
con tutte le nostre forze contro i nemici all’esterno e contro i fuorilegge
all’interno per riportare la calma nello Stato di Israele”. Media locali
riferiscono di famiglie palestinesi che stanno scappando dal Nord della Striscia
verso Gaza City a causa di quello che viene descritto come un vero e proprio
diluvio di fuoco. L’agenzia stampa palestinese Wafa riferisce di due morti e una
dozzina di feriti a Beit Lahia. Ieri l’esercito aveva dispiegato al confine con
la Striscia unità di fanteria e corazzati e richiamato 9,000 riservisti.
L’esercito ha ordinato alla popolazione israeliana nel raggio di 4 chilometri
dalla Striscia di rimanere chiusi nei rifugi fino a nuova comunicazione. Nel
corso della notte si è registrata un’altra vittima israeliana a Sderot. Sono
circa 2.000 i razzi e i colpi di mortaio lanciati dalla Striscia di Gaza in
direzione di ISRAELE da lunedì scorso, dall’inizio delle ostilità tra ISRAELE e
Hamas. Lo rendono noto le forze israeliane (Idf), secondo quanto riportano i
media locali. La maggior parte dei razzi diretti verso aree abitate di ISRAELE
sono stati intercettati dal sistema Iron Dome.
Stefano Pioppi per formiche.net il 12 maggio 2021.
Nelle ultime 38 ore ben 1.050 razzi sono stati lanciati contro Israele. Sono gli
ultimi numeri forniti, questa mattina, dalle Forze di difesa israeliane (Idf).
Di quelli diretti contro zone abitate ne sarebbe stato intercettato il 90%.
Sempre oggi sarebbe stato inoltre colpito un drone proveniente dalla Striscia di
Gaza, a conferma della crescente minaccia rappresentata da sistemi a pilotaggio
remoto, anche piccoli e ben poco sofisticati (conta più ciò che portano).
Protagonista della difesa è la “Cupola di ferro”, il sistema Iron Dome che sta
accompagnando, insieme alle sirene, le notti israeliane. Il sistema è stato
progettato appositamente per intercettare razzi a corto raggio, colpi di mortaio
e pezzi di artiglieria provenienti dai territori palestinesi e dall’area del
Libano sottoposta al controllo di Hezbollah. Sistema mobile terrestre, l’Iron
Dome si colloca nella categoria “V-Shorad”, per la difesa di minacce a raggio
più che corto, entro i quaranta chilometri. Si compone di tre elementi
principali: il radar ELM 2084, il sistema di gestione e controllo (BMC), e i
lanciatori trasportabili dotati di missili Tamir, vettori da tre metri di
lunghezza per un diametro di 160 millimetri, peso di 90 chilogrammi e raggio da
due a 40 chilometri. Secondo Rafael (che guida la realizzazione del sistema),
ogni batteria di Iron Dome permette di difendere un’area di 150 chilometri
quadrati. È composta da un radar, un sistema di controllo, tre piattaforme di
lancio, ciascuna con venti missili Tamir. I vettori sono dotati di apposite
alette per la manovrabilità e di sensori elettro-ottici per colpire il
bersaglio. L’avanzata tecnologia permette la detonazione nelle immediate
prossimità della minaccia; l’esplosione verso l’esterno produce un anello di
schegge intorno alla testata del missile, formando come uno scudo (abbastanza
visibile nei video che circolano online) per aumentare le capacità di
intercettazione. L’ELM 2084, realizzato dalla Israeli Aerospace Industries, è un
radar 3D a scansione elettronica. Secondo il costruttore permetterebbe di
individuare fino a 1.100 minacce simultaneamente fino a 70 chilometri di
distanza. Fornisce rapidamente l’alert agli operatori BMC che attivano
l’eventuale lancio di intercettazione. Il radar segue le prime fasi di viaggio
della minaccia, distinguendo quelle dirette verso obiettivi sensibili da quelle
che invece sono destinate ad aree non abitate. Ciò permette di conservare gli
intercettori, capacità molto utile in caso di attacchi massivi come quelli in
questione. Lo stesso radar ELM 2084 è impiegato anche sul sistema di fire
control di David Sling, la “fionda di Davide”, che copre la difesa aerea a
raggio intermedio. A completare il sistema di difesa c’è poi l’Arrow per le
minacce a raggi ancora maggiori. Il sistema Iron Dome è operativo dal 2011, e ha
visto impieghi importanti a difesa di Israele sin da subito, con progressivi
aggiornamenti, per lo più nella parte software. A novembre 2012, le forze armate
di Tel Aviv dichiararono l’intercettazione dell’85% dei 400 razzi sparati dalla
Striscia di Gaza. Nell’estate del 2014, quando gli scontri furono
particolarmente sanguinosi, le batterie di Iron Dome intercettarono il 90% degli
800 razzi diretti contro obiettivi sensibili in territorio israeliano, quota
minore dei complessivi 4.500 colpi lanciati, per lo più dunque su aree
disabitate. L’efficacia al “90%” è ribadita in ogni comunicazione relativa
all’Iron Dome. Per alcuni osservatori è relativamente bassa, considerando le
migliaia di razzi a disposizione di Hezbollah. Oggi il Jerusalem Post si chiede:
“Is Iron Dome era dominance over?”. L’accento è soprattutto sugli avversari, che
nel tempo avrebbero imparato come sfruttare il 10% di spazio disponibile per
accrescere la letalità degli attacchi. Il timore israeliano è che il sistema di
batterie per la difesa a corto raggio possa essere saturato facilmente in caso
di lanci massicci in contemporanea. Per questo, via Haaretz, nel 2018 il già tre
volte ministro della Difesa Moshe Arens spiegava che, accanto alla difesa della
“Cupola di ferro”, occorreva procedere eliminando le capacità d’offesa
dell’avversario. Non è un caso, dunque, che le Forze israeliane rispondano
prontamente nei casi di inizio escalation, andando a colpire postazioni di
Hamas, magazzini e tunnel. È successo anche questa volta. Il ministro Benny
Gantz ha spiegato ieri l’obiettivo di colpire “duramente” le forze attive nella
Striscia di Gaza. Il dicastero della Difesa ha fatto sapere che circa 80
velivoli militari si sono attivati a tal fine, compresi gli avanzati caccia di
quinta generazione, gli F-35. A maggio 2018, fu l’Aeronautica israeliana a
segnare l’assoluto debutto operativo del Joint Strike Fighter, con almeno due
bombardamenti in Siria contro postazioni iraniane. L’Iron Dome nasce come
sistema totalmente “made in Israel”, con sviluppi risalenti agli anni 2000,
quando la difesa di Tel Aviv si trovò poco protetta rispetto alle minacce a
corto raggio derivanti dal conflitto in Libano. In linea con il partenariato
strategico con gli Stati Uniti, nel corso degli anni l’Iron Dome è entrato nella
cooperazione bilaterale, con Washington pronta a coprire con il proprio budget
alcune quote del programma, coinvolgendo l’industria e stelle e strisce. Secondo
l’attento portale Missile Threat del Csis, oggi circa il 55% delle componenti
del sistema è realizzato negli Usa in virtù degli accordi tra l’israeliana
Rafael e l’americana Raytheon. Anche gli Stati Uniti hanno beneficiato
dell’intesa. Nel 2016 lo US Army testò il proprio sistema MML con il lancio di
missili Tamir. Il costo di un singolo intercettore Tamir si aggira intorno ai
100mila dollari, mentre l’intero sistema Iron Dome vale 100 milioni di dollari.
Simona Verrazzo per "il Messaggero" il 12 maggio
2021. Soffiano venti di guerra tra israeliani e palestinesi, nel secondo giorno
di violenze tra lanci di razzi e incursioni aeree, ed è in continuo aumento il
numero delle vittime. Ieri due donne sono morte nella città di Ashkelon, nel sud
di Israele, ultima grande città prima della Striscia di Gaza. Un'altra vittima,
sempre una donna, a Tel Aviv. I morti nel territorio palestinese invece
sarebbero circa trenta in due giorni. Secondo Hamas, il gruppo islamista che
controlla la Striscia di Gaza dal 2007 e che ha lanciato l'offensiva, tra le
vittime dei raid ci sono anche «10 bambini». È la notizia più tragica di una
giornata cominciata con Israele che annunciava di richiamare 5.000 riservisti
per portare avanti le incursioni aeree sulla Striscia di Gaza, e che ha visto il
lancio di 480 razzi dal territorio palestinese più altri 130 in serata.
Netanyahu ha dichiarato lo stato di emergenza a Lod, dove sono stati inviati
rinforzi.
LE PROTESTE E LA RISPOSTA L'escalation di violenze
era iniziata lunedì, dopo già una settimana di proteste tra le due parti per i
luoghi sacri di Gerusalemme, quando lo Stato ebraico ha risposto a una pioggia
di razzi con cui Hamas ha tentato di forzare il sistema antimissili israeliano
Iron Dome. All'azione palestinese, denominata Operazione Spada di Gerusalemme,
Israele ha risposto con le incursioni aeree da parte dell'Aviazione, in quella
che è stata denominata Operazione Guardiano delle Mura, destinata - annunciano i
vertici militari - a durare diversi giorni. Ingenti le forze messe in campo, con
80 velivoli israeliani impegnati a centrare oltre 140 obiettivi, con le fonti
militari israeliane che hanno riferito dell'uccisione di due dirigenti di Jihad
islamica, altro gruppo islamista presente nella Striscia di Gaza, e di Iyad
Fathi Faik Sharir, comandante delle unità anticarro di Hamas. Il lancio di razzi
non si è comunque fermato e ieri in serata Hamas ha indirizzato i suoi colpi
anche verso la città di Tel Aviv, dove è stato chiuso lo scalo. «Abbiamo deciso
di accrescere ancora di più la potenza e il ritmo degli attacchi. Hamas riceverà
un colpo che non si aspetta», ha detto il premier israeliano, Benyamin
Netanyahu, al termine di una consultazione con i vertici militari. Dopo
Gerusalemme, dove gli scontri si sono concentrati sulla Spianata delle Moschee,
luogo sacro per i musulmani, sotto cui sorge il Muro del Piano, luogo sacro per
gli ebrei, le operazioni si sono spostate verso sud e la Striscia di Gaza,
territorio palestinese a ridosso con l'Egitto. L'esercito israeliano ha deciso
l'invio di rinforzi al confine, tra questi la Brigata di fanteria Volani, la VII
Brigata Corazzata e unità di intelligence. Le autorità hanno invitato la
popolazione delle città meridionali, tra cui Sderot, Ashdod e Ashkelon, a non
uscire di casa ed è in quest'ultima località che si sono registrate le prime
vittime civili israeliane, tre donne anziane rimaste uccise in tre separati
attacchi. Dalla scorsa settimana la tensione è nuovamente cresciuta, e si temono
nuove violenze per domani, ultimo giorno del mese di Ramadan, sacro per i
musulmani. Giorno delicato anche venerdì, quando lo Stato ebraico celebra la
dichiarazione di indipendenza. All'origine degli scontri lo sfratto di alcune
famiglie palestinesi dalle loro abitazioni di Sheiikh Jarrah, rione di
Gerusalemme est dove da anni cresce la presenza di famiglie ebraiche attorno
alla tomba di un antico rabbino. La comunità internazionale cerca una via
diplomatica per un cessate il fuoco. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, riunito
d'urgenza, non ha raggiunto un accordo per una dichiarazione comune. Gli Stati
Uniti, membro permanente, hanno ritenuto «non appropriato un messaggio pubblico
in questa fase». L'incontro era stato richiesto da Tunisia, Norvegia e Cina,
altro membro permanente. L'Unione europea ha chiesto la fine immediata delle
violenze, così come il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. «L'Italia
ribadisce la sua preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze in
particolare a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza».
Israele shock: le
sinagoghe in fiamme. Chiara
Clausi il 13 Maggio 2021 su Il Giornale.
Gli arabo-israeliani incendiano i luoghi di
culto a Lod. Il presidente Rivlin: "Pogrom". Lo scambio di fuoco micidiale tra i
militanti palestinesi nella Striscia di Gaza e l'esercito israeliano si è
intensificato ancor più. L'Onu teme una «guerra su vasta scala». La mediazione
dei Paesi arabi, come l'Egitto, è per il momento fallita. Hamas e la Jihad
islamica in due giorni hanno lanciato 1.050 razzi e colpi di mortaio, 850 sono
atterrati in Israele o sono stati intercettati dal suo sistema di difesa aerea
«Iron Dome», mentre 200 non sono riusciti a superare il confine e hanno colpito
Gaza stessa. La pressione sulle città del Sud è però devastante. Ieri sera
un'altra raffica di missili è arrivata fino a Tel Aviv, una casa è stata colpita
a Ashkelon e Hamas ha lanciato razzi per vendicare la morte dei suoi comandanti.
Un altro razzo ha colpito un condominio a Sderot. Un bambino di sei anni è stato
ferito e con lui molti altri. Forti boom e sirene hanno risuonato senza
interruzione a Modiin, Beersheba e a Tel Aviv. Fra martedì e ieri sono state
demolite anche due palazzine a Gaza. Raid più mirati hanno invece eliminato
almeno quattro comandanti di Hamas e tre della Jihad. Sono i combattimenti più
duri dal 2014. I palestinesi lamentano 53 vittime, molti «bambini», mentre sei
israeliani sono stati uccisi da lunedì. Ieri un razzo anticarro sparato da Gaza
ha centrato un veicolo che si trovava nei pressi della linea di demarcazione. Un
sergente 21enne dell'esercito è morto in ospedale, due commilitoni sono in gravi
condizioni. Le vittime israeliane includono anche un padre di 52 anni e sua
figlia di 16 anni che sono morti nella città di Lod, vicino a Tel Aviv, quando
un razzo ha colpito la loro auto. Mentre a Gaza cinque membri di una famiglia
sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano. Le strade sono piene di
macerie dove gli edifici sono crollati e molte auto sono state schiacciate o
bruciate. Ma è anche il fronte interno a preoccupare. Gli arabi israeliani hanno
organizzato proteste violente in diverse città israeliane. La città di Lod,
vicino a Tel Aviv, è in stato di emergenza dopo che, oltre a centinaia di auto,
sono state incendiate anche diverse sinagoghe. Il presidente israeliano Reuven
Rivlin ha denunciato il «pogrom» di Lod da parte di «una folla di arabi assetati
di sangue ed esaltati». «Sono scene - ha attaccato - imperdonabili». Mentre il
primo ministro Benjamin Netanyahu ha precisato che il governo utilizzerà tutte
le sue forze per proteggere Israele dai nemici all'esterno e dai rivoltosi
all'interno. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha ribadito invece che gli
attacchi israeliani sono stati «solo l'inizio». Nel frattempo, l'aeroporto Ben
Gurion ha interrotto brevemente i voli martedì ed è stato colpito un gasdotto
tra le città di Eilat e Ashkelon. Disordini anche in altre città con una grande
popolazione araba israeliana, così come a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Il
leader di Hamas Ismail Haniyeh ha tuonato: «Se Israele vuole intensificare i
combattimenti, noi siamo pronti, se vuole fermarsi, siamo anche pronti».
"Hamas ha ingaggiato
lo scontro per ottenere la leadership islamista".
Fiamma Nirenstein il 13 Maggio 2021
su Il Giornale.
Il generale: "Non è ancora la resa dei conti, ci saranno altri round. Ma Israele
ha il dovere di proteggere il proprio popolo". No, lo scontro di queste ore fra
Israele e Hamas non è una resa dei conti definitiva: è soltanto un round, anche
se molto importante. Lo dice il generale Yossi Kuperwasser, uno degli esperti
più importanti del Jerusalem Center for Public Affairs, famoso esperto di
strategia, di sicurezza e di mondo arabo. Dall'esercito dove ha diretto il
settore ricerca, è passato a direttore generale del ministero degli Affari
Strategici occupandosi con taglio nuovo di antisemitismo. Adesso fra un incontro
e l'altro ci affida i suoi pensieri, molto diretti e privi di illusioni o
ideologie. Netanyahu e il ministro Gantz sembrano promettere alla popolazione
bombardata, tormentata da Hamas, lo smantellamento definitivo
dell'organizzazione. «Si tratta di un altro capitolo di una lunga storia, un
capitolo con caratteri di estrema durezza data la smodata aggressività di Hamas
che ha bombardato Gerusalemme e Tel Aviv, terrorizza la popolazione civile del
sud giorno dopo giorno, ha fatto morti e feriti a tutte le latitudini con un
attacco premeditato e sanguinoso». Sta però pagando un duro prezzo, come se ci
fosse una risposta non proporzionale. Ci sono crolli imponenti e bambini uccisi
durante le eliminazioni mirate dei capi di Hamas. «Penso che stavolta chi non ha
un pregiudizio incancrenito e pesante contro Israele capisce che sotto un
attacco di migliaia di missili, Israele ha il dovere di fermare l'attacco e di
proteggere la popolazione. Israele deve attaccare gli edifici in cui si
nascondono i capi di Hamas, e tuttavia noi avvertiamo uno a uno gli abitanti
prima di colpire; quanto ai bambini che cerchiamo in tutti i modi di non
colpire, secondo Defense for Children Palestine alcuni sono stati uccisi da
missili palestinesi mal costruiti e sparati (Dcip). Detto questo, l'escalation
di Hamas deve fermarsi».
Lei stesso dice che è solo un
round. Presto ci saranno gli stessi problemi?
«Perché presto? Dal 2014, dopo
l'ultima guerra abbiamo avuto poche aggressioni. Si tratta di garantire la messa
fuori giuoco delle armi e dei leader terroristi per un bel pezzo. È quello che
stiamo facendo».
Perché Israele non cerca di
smantellare Hamas?
«Perché nessuno ha intenzione
di governare di nuovo la striscia di Gaza; non lo vuole l'Egitto, non lo vuole
Fatah, non vedo perché dovremmo metterci noi in questo guaio».
L'ipotesi «stivali sul terreno»
non è contemplata?
«Ci sono tanti modi di vincere
una guerra, quella è la più rischiosa, si cerca di evitarlo».
Hamas lo sa. Perché ha
intrapreso una guerra perduta?
«Ne sta ricavando altissimi
riconoscimenti nel mondo in cui ambisce alla leadership ideologica, quello
islamista che mette la Moschea di Al Aqsa e Gerusalemme in testa ai suoi
interessi. Ha intrapreso la guerra perché questo le garantisce di battere Abu
Mazen e poi perché deve sperimentare i missili nuovi preparati con l'aiuto
dell'Iran».
E questo li compensa dalle
distruzioni in corso.
«Reputano i guadagni ideologici
maggiori delle perdite».
Hamas conta anche sul sostegno
di Iran e Turchia.
«E non solo. Sente anche che i
commenti dell'amministrazione americana gli consentono margini di manovra. Si è
sentito rassicurato».
Intanto i moti degli arabi
israeliani a Lod sono molto preoccupanti. Una nuova Intifada di cittadini
israeliani musulmani contro gli ebrei?
«Difficile dirlo. Noi
sopravvalutiamo sempre l'integrazione, il senso di comunanza nella democrazia.
La loro leadership alla Knesset ha rifiutato il giuramento di fedeltà al Paese,
gli abitanti delle case di Lod vedono stupefatti i vicini dare fuoco alle auto
nei comuni parcheggi. Storia molto difficile».
Quanto dura ancora questa
guerra?
«Se è una guerra, dura ancora
settimane. Se invece è solo un grande scontro e possiamo accontentarci di
risultati che garantiscano la quiete, poco. Per ora, Hamas ha ancora i missili
nascosti, e i terroristi che li lanciano a centinaia».
Netanyahu parla di
"campagna militare". Quarta guerra di Gaza, perché è scoppiato il nuovo
conflitto Israelo-Palestinese.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 12 Maggio 2021.
L’avevano cancellata dall’agenda politica internazionale. Scomparsa dai “radar”
dei media. E invece la “polveriera palestinese” è tornata ad esplodere. Prima
a Gerusalemme, la Città contesa, e poi nella Striscia di Gaza e nelle città
frontaliere israeliane. Raid aerei, razzi, colpi d’artiglieria, mobilitazione di
riservisti, sirene che risuonano per segnalare il pericolo che viene dal cielo.
La quarta guerra di Gaza è iniziata. A cambiare è il nome in codice
dell’operazione avviata dalle Idf, le Forze di difesa israeliane. Stavolta è
“Guardiano delle Mura”. E per non essere da meno, anche le milizie palestinesi
hanno battezzato la loro resistenza armata, operazione “Spada di Gerusalemme”.
Ventiquattr’ore di attacchi ininterrotti, di razzi, feriti e vittime, in un
conflitto che si inasprisce ulteriormente con l’invio di truppe israeliane al
confine con la Striscia e il richiamo di 5mila riservisti. È di almeno 28 morti,
compresi nove bambini, e 152 feriti il bilancio delle operazioni israeliane
nella Striscia di Gaza: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Salute
di Gaza, Ashraf al-Qudra, citato dalla tv satellitare al-Jazeera. Secondo i
militari israeliani “vanno ancora chiarite” le circostanze della morte dei nove
bambini. E anche Israele conta le sue prime vittime: due donne, ferite
mortalmente da uno degli oltre 250 razzi sparati dai miliziani palestinesi da
Gaza verso Israele, in particolare verso Gerusalemme, Ashdod e Ashkelon. Più di
70 i feriti curati in ospedale, oltre 30 sono in pronto soccorso e due in gravi
condizioni. Lo riferiscono fonti mediche, citate dai media. Un’altra persona
anziana, secondo la radio militare, è in fin di vita. La risposta di Tsahal,
l’esercito israeliano, non si è fatta attendere: colpiti oltre 130 obiettivi
militari nell’enclave palestinese. Un portavoce militare israeliano ha inoltre
riferito che a essere stata colpita è anche una cellula di Hamas che usava
missili anti-carro a Gaza. L’esercito ha anche deciso l’invio di rinforzi al
confine di Gaza: tra questi, la Brigata di fanteria Golani e la 7/a Brigata
Corazzata, oltre a unità di intelligence e aviazione. Gli attacchi su Gaza
continueranno e “tutti i comandi si devono preparare ad un conflitto più esteso
senza limiti di tempo”, annuncia il capo di stato maggiore dell’esercito
israeliano, Aviv Kochavi, confermando l’ordine ai militari di colpire i membri
operativi di Hamas e della Jihad islamica a Gaza. Il premier israeliano Benjamin
Netanyahu ha convocato ieri mattina consultazioni sulla sicurezza nel suo
ufficio a Tel Aviv dopo l’escalation delle ultime ore. Israele «intensificherà
ulteriormente la potenza ed il ritmo degli attacchi» contro la Striscia di Gaza,
ha dichiarato il primo ministro al termine della una riunione. «Siamo nel mezzo
di una campagna militare», afferma Netanyahu, citato dal Times of Israel. «Da
ieri pomeriggio (lunedì per chi legge, ndr) l’esercito ha eseguito centinaia di
attacchi contro Hamas e la Jihad islamica a Gaza. Abbiamo colpito comandanti e
molti obiettivi di alta qualità», ha aggiunto. In serata, Israele avrebbe
respinto una richiesta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che sarebbe
stata avanzata da Hamas. Lo riporta l’emittente Channel 12 secondo cui sarebbero
stati “intermediari arabi” a consegnare il ‘messaggio’ di Hamas a Israele. Le
autorità dello Stato ebraico avrebbero respinto la proposta, sostenendo che il
movimento islamista non avrebbe ancora pagato il giusto prezzo per i suoi
attacchi contro Israele. «Il nostro obiettivo è di colpire duramente Hamas,
indebolirlo e fargli rimpiangere la sua decisione» di lanciare missili contro
Israele. A dirlo è il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, parlando con
i giornalisti vicino ad una batteria di missili del sistema di difesa Iron Dome
nel sud d’Israele. L’operazione militare in corso durerà diversi giorni con le
forze aeree, terrestri e navali israeliane, che bombarderanno obiettivi di Hamas
e la Jihad islamica. «Ogni bomba ha il suo indirizzo. Continueremo nelle
prossime ore e i prossimi giorni. È difficile dire quanto tempo ci vorrà», ha
rimarcato, citato da Times of Israel. Ad accendere lo scontro è stato
l’ultimatum di Hamas che, a fronte del mancato ritiro delle truppe israeliane
dall’area della moschea di Al Aqsa e da Sheikh Jarrah, quartiere palestinese a
Gerusalemme est, ha sparato sei razzi contro la città a circa cento chilometri
di distanza. Era dal 2014 che non veniva colpita. Le autorità israeliane hanno
chiuso tutte le scuole nelle comunità vicino Gaza, limitando le riunioni di
persone a 10 all’aperto e 50 all’interno. Imprese e posti di lavoro sono aperti
solo se vi è un accesso ai rifugi per tutti. Hammed a-Rakeb, un dirigente di
Hamas citato dalla radio pubblica israeliana, ha affermato che questo attacco è
una risposta ad attacchi lanciati in precedenza da Israele contro appartamenti
dove si trovavano comandanti militari. «Abbiamo lanciato razzi
contro Ashkelon dopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di
Gaza City. Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un
inferno». È quanto aveva affermato in mattinata il portavoce dell’ala militare
di Hamas, – le Brigate Ezzedin al-Qassam – Abu Ubaidah, secondo quanto
riporta Haaretz. Intanto due comandanti della Jihad islamica, Kamel
Kuraika e Sameh al-Mamluk, sono rimasti uccisi in un attacco condotto
dall’aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio
nel rione Rimal di Gaza. Con loro è rimasto ferito in modo grave un altro
comandante della Jihad islamica, Muhammad Abu al-Atta, fratello del leader
militare della Jihad islamica nel nord della Striscia ucciso da Israele nel
2019. Da Washington a Bruxelles (Ue), dal Palazzo di Vetro (Onu) a Mosca: la
comunità internazionale sforna appelli alla moderazione e al freno
dell’escalation militare. Appelli che, come sempre, non sortiscono effetto. Gaza
e Israele si preparano ad una nuova notte di fuoco. Come le tante che si sono
susseguite negli anni. È l’impotenza della forza. In Terrasanta le “colombe” non
volano più. A regnare sono i falchi.
Umberto De Giovannangeli.
Esperto di Medio Oriente e Islam segue da un quarto di secolo la politica estera
italiana e in particolare tutte le vicende riguardanti il Medio Oriente.
Israele e Gaza, un
conflitto nuovo e vecchio allo stesso tempo.
Piccole Note il 12 maggio 2021
su Il Giornale. Ancora
non è guerra aperta tra Israele e Gaza, ma poco ci manca, o forse gli scambi di
colpi di questi giorni sono solo l’avvio della stessa, mentre all’interno del
Paese continuano gli scontri tra palestinesi e forze dell’ordine, che potrebbero
essere i prodromi di una nuova Intifada. La conta dei morti e dei feriti sale e
continuerà a salire se non accade qualcosa. Situazione che appare irreversibile
nella sua corsa verso il precipizio di una nuova mattanza di Gaza, e di bambini
di Gaza, e di nuove paure per gli ebrei di Israele, dove seppure i morti sono e
saranno di meno, non hanno certo minor rilevanza. Nella precedente nota,
riferivamo un cenno su Haaretz sul fatto che la situazione favorisce
oggettivamente il premier israeliano, che vedeva il suo regno al tramonto e che
l’acuirsi delle tensioni può conservare al potere, impedendo la nascita di un
governo formato dai suoi antagonisti con l’appoggio del partiti arabi. Yossi
Verter, in particolare, riferiva lo stop ai negoziati per la formazione di un
nuovo governo, mossa che avrebbe offerto a Netanyahu un “incentivo per mantenere
alta la tensione”. Certo, il premier ora è obbligato a mostrare i muscoli a
fronte del lancio di razzi da Gaza, dato che nessun Paese, come ha detto il
presidente Reuven Rivlin, può tollerare di esser bersagliato da missili (1). Ma
sembra solo limitarsi a minacciare sfracelli contro Gaza, non sembrando
particolarmente interessato a trovare un modo per far rientrare le armi nelle
fondine, come invece accaduto altre volte in tempi recenti, quando invece ha
cercato e trovato accordi con Hamas dopo simili – seppur in scala minore –
escalation. Interessante, sul punto, un articolo di Times of Israel che inizia
così: “L’Egitto ha contattato Israele per aiutare a calmare le tensioni in corso
di questi giorni, funestati da disordini a Gerusalemme e dal lancio di razzi da
Gaza, ma non ha ancora ricevuto una risposta, come ha detto il suo ministro
degli esteri martedì in una riunione di emergenza della Lega araba”. E nel
prosieguo dell’articolo si legge: “Un diplomatico che ha familiarità con i
tentativi di mediazione ha detto al Times of Israel che Hamas martedì mattina ha
fatto sapere di essere interessato a ridurre le tensioni, ma che avrebbe
risposto se gli attacchi israeliani fossero continuati […]. Il diplomatico ha
anche dichiarato che Israele non ha risposto alle proposte del suo paese dirette
a porre fine alle violenze in corso”. Garbuglio ad ora inestricabile. Sul punto,
l’editoriale di Haaretz, che spiega come “le ragioni dello scoppio di questa
violenta protesta sono collegate a una serie di cattive decisioni prese a
Gerusalemme durante il mese di Ramadan”, che hanno acuito le tensioni. Il capo
della polizia “Yaakov Shabtai ha svolto un ruolo decisivo in tutto questo, e la
sua affermazione che la polizia era stata ‘troppo morbida’ indica un
preoccupante problema di percezione della realtà”. Al di là degli errori di
Shabtai, continua Haaretz, il fatto è che “la polizia è costretta ad affrontare
i sintomi di un problema molto più profondo che sta esplodendo in questi giorni:
la realtà di 54 anni di occupazione”. “Nel suo desiderio di combattere il
nazionalismo palestinese, indebolirlo e persino farlo sparire, il primo ministro
Benjamin Netanyahu ha attaccato e infiammato gli animi contro gli arabi
israeliani in modo criminale. Invece di affrontare il problema, ha preferito
escludere, discriminare, giudaizzare e portare dichiarati razzisti alla
Knesset. Questa strategia disastrosa sta ora esplodendo in faccia a Israele”.
Tempi bui, ma, come dimostra l’editoriale di Haaretz, non tutti in Israele sono
concordi nel ritenere che l’unica via che ha il Paese sia un nuovo,
sanguinoso, redde rationem con gli arabi. Anche l’America, nonostante non possa
che stare a fianco del suo più prossimo alleato, ha uno sguardo meno unilaterale
sul lungo conflitto arabo-israeliano. Ciò rende le prospettive un po’ meno
catastrofiche, anche se il momento resta buio e gravido di nefasti presagi.
(1) Fa accezione Damasco, che
deve invece accettare il lancio di missili dall’enclave terrorista di Idlib.
Quando l’esercito siriano e i russi hanno provato a reagire per eliminare la
minaccia, la comunità internazionale li ha ammoniti a non rispondere agli
attacchi. Allora la Casa Bianca intimò subito lo “stop” a Damasco, arrivando a
minacciare addirittura un intervento a sostegno di Idlib. Ieri, invece,
nonostante alla Casa Bianca sedesse un altro inquilino, Washington ha dichiarato
che Israele ha “diritto a rispondere ai missili“. Certi “diritti” evidentemente
non sono per tutti.
Il recente attacco
contro Israele rivela il problema dei sistemi antimissile.
Paolo Mauri su Inside Over il 12 maggio 2021.
L’ultima offensiva missilistica scatenata contro Israele è forse la più violenta
che si ricordi, e non è un caso. Secondo le Idf (Israel defense forces),
oltre 1050 razzi e colpi di mortaio sono stati lanciati dalla Striscia di
Gaza verso il territorio dello Stato ebraico dalla sera del 10 maggio, di cui
200 non sono riusciti a superare il confine e sono caduti all’interno
dell’enclave. Oltre 400 sono stati diretti in profondità nel territorio
israeliano in due enormi ondate la sera dell’11 e dalle 3 del mattino circa di
mercoledì 12. Si tratta del più pesante attacco sin dal 2014. Per fare un
paragone, proprio quell’anno, a luglio sono stati sparati 2874 razzi e 15 colpi
di mortaio, ma distribuiti nell’arco di tutto il mese, con un picco di 197 il
10. Quella di questi giorni assume le caratteristiche, quindi, di un’offensiva
senza precedenti per il rateo dei lanci effettuati.
Come funziona Iron Dome. Questa
peculiarità del recente attacco non è affatto casuale, e dipende dalle
caratteristiche del sistema difensivo israeliano Iron Dome. Si tratta di un
complesso strumento da difesa aerea in grado di intercettare razzi, colpi di
mortaio, Uav di cui ricorrono proprio quest’anno i 10 anni dell’ingresso in
servizio. Iron Dome è formato da tre elementi fondamentali: un radar di scoperta
e tracciamento, un sistema di controllo del fuoco e gestione della situazione di
combattimento (Bmc) ed una unità di lancio missili (Mfu). Una batteria di Iron
Dome consiste di tre/quattro lanciatori fissi trasportabili su camion ciascuno
dei quali dotato di 20 missili “Tamir” associati ad un radar sviluppato dalla
israeliana Elta. Ogni batteria può coprire un’area di approssimativamente 150 km
quadrati con un raggio di azione compreso tra i 4 ed i 70 chilometri. Il missile
“Tamir”, cuore del sistema, è lungo tre metri ed ha una circonferenza di 160
millimetri per un peso di circa 90 chilogrammi. È equipaggiato con un sensore
elettro-ottico e ha alette stabilizzatrici mobili in grado di dargli un buon
grado di possibilità di cambiare la traiettoria di volo. La testata di guerra,
esplosiva, viene innescata da un sensore di prossimità. Iron Dome lavora,
secondo il concetto di difesa area multistrato, di concerto con i Patriot, e coi
sistemi Arrow-2 e 3, David’s Sling ed Iron Beam pensato per poter intercettare i
più insidiosi proietti di mortaio. Il successo più eclatante di Iron Dome è
stato durante l’Operazione Pillar nel novembre 2012. L’operazione è iniziata nel
pomeriggio del 14 novembre e, quando la sera del 21 entrò in vigore il cessate
il fuoco, 1506 razzi erano stati lanciati contro Israele. Di questi 875 sono
risultati caduti in aree non abitate e quindi non sono stati intercettati da
Iron Dome. Altri 152 lanci sono da considerarsi falliti (questo significa i
razzi sono caduti nella Striscia di Gaza) pertanto il sistema israeliano risulta
aver intercettato 421 razzi, mancandone 58 caduti in aree edificate causando
danni.
L’efficacia della “Cupola di
Ferro”. Fonti ufficiali israeliani danno la percentuale di intercettazione di
Iron Dome compresa tra l’85 e il 90%; secondo le statistiche dell’industria
produttrice, la Rafael, questa si assesterebbe fermamente al 90%. Sono dati non
privi di controversie: nel 2014 un ricercatore dimostrò che l’efficacia era
molto più bassa (tra il 6 ed il 12%) e lo “scudo” era dato per la maggior
parte dalla prontezza del sistema di allarme precoce di Israele e dall’avere un
alto numero di rifugi, che insieme all’addestramento della popolazione, che in
caso di attacco sa esattamente cosa fare, ha ridotto drasticamente il numero
delle vittime. In attesa che l’offensiva di Hamas di questi giorni termini, e
quindi di poter sapere quanti razzi e colpi di mortaio sono stati sparati in
totale e quanti sono stati intercettati, possiamo però fare alcune
considerazioni tattiche su quanto sta accadendo. Iron Dome, come tutti i sistemi
di difesa antimissile, nonostante la concentrazione di strumenti atti a
rispondere in modo appropriato a diverse offese, ha una falla: in caso
di attacco di saturazione, ovvero quando si trova a dover affrontare un alto
numero di proietti o razzi, non riesce ad eliminarli tutti e qualcuno sfugge
alle “maglie” del sistema. Questo è tanto più possibile quanto più è alto il
rateo di lancio. Iron Dome ha quindi un “punto di saturazione” oltre il quale
vede la sua efficacia diminuire. Il sistema, cioè, è in grado di intercettare un
certo numero (non pubblicato) di bersagli contemporaneamente e non di più. Il
lancio massiccio di razzi, effettuato in un’unica salva concentrata, può quindi
riuscire a sfondare le difese e causare danni. Questa, stando a quanto ci
riporta la cronaca degli ultimi giorni, è proprio la tattica usata da Hamas per
la sua offensiva, che quindi sembra aver fatto tesoro delle esperienze fatte
negli anni precedenti.
Un problema comune. Una falla,
quella di Iron Dome, che non è peculiare solo del sistema israeliano, ma che è
comune a tutti gli strumenti antimissile in servizio,
dai Patriot e Thaad statunitensi, agli S-300 e 400 russi, passando per
il Gmd antimissili balistici sempre di fabbricazione Usa. Questo aspetto può
essere mitigato assumendo un’architettura multistrato (e quindi multisistema):
l’ombrello Abm (Anti Ballistic Missile) degli Stati Uniti, ad esempio, prevede
diversi sistemi che lavorano in coordinazione, su più livelli, e dispiegati su
un’ampia area geografica. L’Aegis – imbarcato e ashore – il Thaad, il Gmd ed i
Patriot forniscono una copertura maggiore a difesa dei missili balistici proprio
grazie a queste caratteristiche appena citate, ma in caso di attacco massiccio
la loro efficacia nell’intercettare tutti i vettori, e quindi eliminare la
minaccia, resta fortemente in discussione, e possiamo dire, con ragionevole
certezza, che lo “scudo” lascerebbe passare qualche decina di vettori. Per
quanto riguarda la minaccia data da razzi campali e colpi di mortaio trovano
utile impiego anche sistemi tipo C-Ram – una sorta di Ciws (Close In Weapon
System) terrestre – ma anche in questo caso vale la stessa considerazione fatta
per un attacco di saturazione.
Troppi e troppo vicino.
Tornando a Iron Dome e alla sua efficacia, bisogna considerare anche
alcune peculiarità date dalla geografia e dal sistema stesso: gli attacchi
vengono sferrati dalla Striscia di Gaza, che possiamo considerarla un’enclave
stretta tra il mare, Israele e l’Egitto, quindi a pochissima distanza dagli
obiettivi nello Stato ebraico. Il sistema israeliano, poi, risulta incapace di
far fronte a minacce a brevissimo raggio: non può abbattere razzi o proiettili
la cui gittata è inferiore a 5-7 chilometri. Inoltre sembra che Iron Dome abbia
difficoltà a intercettare razzi sparati su traiettorie “piatte” anche su
distanze più lunghe (fino a 16-18 chilometri). Qualcosa che ci ricorda molto la
tattica usata dai veicoli di rientro (Rv) per missili balistici
tipo Hgv (Hypersonic Glide Vehicle) di fabbricazione russa che, avendo un
profilo di volo molto più basso rispetto ai classici Rv, rendono molto
difficoltosa la loro intercettazione restando non visibili dai sistemi di
ingaggio radar per lungo tempo, fattore a cui va sommata la loro estrema
velocità.
Prima però di trarre ulteriori
considerazioni su quanto Iron Dome abbia realmente neutralizzato la maggior
parte degli attacchi missilistici a cui stiamo assistendo in questi giorni
dobbiamo aspettare che l’offensiva termini, in quanto si tratta della prima
volta che Hamas utilizza i suoi razzi in questo modo.
Da "corriere.it" il 16 maggio 2021. Almeno 2 morti
e una sessantina di feriti nel crollo di una tribuna nella sinagoga ortodossa di
Givat Zeev. Alcuni video pubblicati su Twitter mostrano una sinagoga piena di
gente e una gradinata che crolla improvvisamente. L’incidente avviene mentre in
Israele si festeggia Shavuot, una delle tre feste di pellegrinaggio. Accade
poche settimane dopo che 45 persone sono state uccise in un crollo simile in un
santuario sul monte Meron, nel nord del Paese.
Israele, 44 morti nella calca al raduno
religioso al Monte Meron: dubbi sulla dinamica. Libero
Quotidiano il 30 aprile 2021. Una terrificante tragedia in Israele: almeno 44
sono state calpestate a morte e 150 ferite, all'uscita, dopo la mezzanotte di
giovedì, da un raduno religioso a cui hanno partecipato oltre 50mila ebrei
ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione
dell’Alta Galilea. Le immagini che arrivano dal luogo della sciagura sono
sconvolgenti, tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini piccoli. Magen David
Adom — l’equivalente israeliano della Croce Rossa — riferisce che i suoi
paramedici stanno prestando cure a oltre 150 persone. Il servizio di soccorso
riferisc che sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno trasportando i feriti
all’ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all'ospedale
Rambam di Haifa, all'ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem
di Gerusalemme. Ancora non è del tutto chiara la causa della strage.
Inizialmente si è parlato del crollo di una gradinata con uno stand a uno dei
concerti a cui stavano prendendo parte 50.000 persone. Secondo quanto riferito
poi dal Time of Israel, al contrario, la sciagura sarebbe stata almeno in parte
causata da una passerella scivolosa: nel corso del concerto o circa 20.000
persone si sono riversate lungo una stretta passerella tra due muri. A terra
c'era una pavimentazione metallica scivolosa, che avrebbe fatto cadere le
persone generando il disastro.
Tra le vittime anche bambini piccoli.
Disastro in Israele, pellegrini schiacciati dalla calca a un raduno
religioso: 44 morti e 150 feriti. Rossella Grasso su Il Riformista il 30
Aprile 2021. Oltre 50mila ebrei ultraortodossi si erano radunati per celebrare
la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione dell’Alta Galilea, in
Israele. Dopo la mezzanotte il dramma: almeno 44 persone sono morte schiacciate
sotto il peso della folla e sono almeno 150 i feriti. Tra le vittime ci
sarebbero anche “bambini piccoli”. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha
definito l’incidente “un terribile disastro”. E intanto la Magen David Adom, i
soccorsi israeliani, stanno continuando a evacuare la zona trasferendo i feriti
all’ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all’ospedale
Rambam di Haifa, all’ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem
di Gerusalemme. Una vera tragedia. Non si capisce ancora bene cosa sia successo.
Da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe crollata una gradinata con uno
stand di uno dei concerti a cui stavano prendendo parte in 50mila. Secondo
quanto riporta invece il quotidiano online Times of Israel la tragedia sarebbe
stata causata, almeno in parte, da una passerella scivolosa. Durante il concerto
circa 20.000 persone si sono riversate lungo una stretta passerella tra due
muri. A terra c’era una pavimentazione metallica scivolosa, che ha fatto cadere
alcune persone durante la corsa all’uscita. Le autorità avevano autorizzato solo
la presenza di 10.000 persone nel recinto della tomba ma, secondo gli
organizzatori, sono stati noleggiati più di 650 autobus in tutto il Paese, vale
a dire almeno 30.000 persone. La stampa locale parla addirittura di 100.000.
Ogni anno gli ebrei si radunano sul monte Meron per celebrare la festività di
Lag B’Omer, che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni
romane. Pregano sulla tomba di Rabbi Shimon Ber Yochai, un saggio e mistico del
II secolo d.C. Secondo la tradizione questi è l’autore del testo mistico dello
“Zohar” (lo splendore). Un evento che attira sempre migliaia di fedeli, a volte
fino a mezzo milione di persone. L’anno scorso era stato annullato a causa del
Covid ma quest’ anno è stato autorizzato e nonostante le misure di prevenzione e
distanziamento è stato impossibile evitare la tragedia. Un altro disastro era
avvenuto sul monte Meron anche nel 1911. Allora decine di persone morirono nel
crollo di un edificio vicino alla tomba del rabbino.
Rossella Grasso. Giornalista professionista e
videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali
occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha
collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di
stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana,
si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo
Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al
Napoli Film Festival.
(ANSA il 30 aprile 2021) Sale ad almeno 150 il
bilancio dei feriti della calca scatenatasi al raduno religioso ebraico sul
monte Meron, in Galilea, dove sono morte 44 persone travolte dalla folla. Lo
rendono noto fonti di soccorso citate dai media israeliani, secondo le quali
almeno 24 persone sono in gravi condizioni e sei di queste rischiano la vita.
Da ilgiorno.it il 30 aprile 2021. Una fuga di
massa durante una celebrazione religiosa ha causato una strage in Israele: è di
almeno 44 morti e oltre 60 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni -,
infatti, il bilancio dell'incidente avvenuto dopo mezzanotte tra il 29 e il 30
aprile nella calca durante la celebrazione della festività ebraica Lag B'Omer
sul monte Meron, in Galilea. I numeri sono forniti dai media israeliani che
citando fonti di soccorso e di sicurezza. Sul posto erano presenti decine di
migliaia di persone, si stima oltre centomila ebrei osservanti, e secondo le
ultime informazioni, tutto sarebbe avvenuto quando alcune di queste persone sono
scivolate dai gradini delle scalinate trascinando con sé altri partecipanti e
innescando una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate.
Secondo un'altra ricostruzione, però, potrebbe essere crollata una sezione di
posti a sedere dello stadio, innescando poi la fuga. In ogni caso la polizia
avrebbe cercato di trattenere la fuga, come appare dai video postati su Twitter.
Alcuni testimoni hanno accusato la polizia di aver bloccato l'uscita. Ai
soccorsi hanno partecipato decine di ambulanze e anche elicotteri militari. Il
premier Benjamin Netanyahu ha definito l'incidente "un terribile disastro". "È
successo tutto in una frazione di secondo; le persone sono cadute, calpestandosi
a vicenda. È stato un disastro", ha detto un testimone. Il comandante del
distretto settentrionale delle forze di polizia Shimon Lavi, che ha
supervisionato le disposizioni di sicurezza al monte Meron, ha detto di
assumersi la responsabilità del disastro. "Ho la responsabilità generale, nel
bene e nel male, e sono pronto a sottopormi a qualsiasi indagine", ha dichiarato
ai giornalisti. C'è un continuo "sforzo per raccogliere prove per arrivare alla
verità", dice.
La festività. Come ogni anno in occasione della
festività ebraica di Lag ba-Omer, (che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C
contro le legioni romane) ieri decine di migliaia di ebrei si sono recati sul
monte Meron per pregare sulla tomba Shimon Ber Yochai, un celebre rabbino del
secondo secolo d.C. Secondo la tradizione questi è l'autore del testo mistico
dello 'Zohar' (lo splendore). Da anni questo evento è il più affollato in
Israele, richiamando a volte fino a mezzo milione di persone. L'anno scorso, a
causa del coronavirus, era stato annullato. Quest'anno, col miglioramento della
situazione sanitaria, era stato autorizzato, ma con numerose limitazioni che
però non hanno resistito alla pressione della folla immensa. Secondo alcune
notizie, c'erano tre volte più persone di quelle autorizzate. Un altro disastro
era avvenuto sul monte Meron anche nel 1911. Allora decine di persone morirono
nel crollo di un edificio vicino alla tomba del rabbino.
Francesco Semprini per "La Stampa" l'8 aprile
2021. Agenti stranieri camuffati da reporter de La Stampa hanno tentato di
raccogliere e divulgare informazioni volte a screditare la leadership degli
Emirati arabi uniti. È quanto emerge da un'inchiesta del giornale online «Daily
Beast» secondo cui l'azione è stata condotta da Bluehawk CI, società di
investigazioni private con sede in Israele. «All'inizio del 2020 individui che
si sono spacciati per ricercatrice di Fox News e giornalista del quotidiano
italiano La Stampa hanno approcciato due uomini coinvolti in contenziosi contro
Ras Al Khaimah, uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti -
spiega la testata Usa -. Gli impostori hanno tentato di carpire dai loro
interlocutori informazioni circa le azioni legali che li vedono contrapposti
alla leadership dell'Emirato». In un caso hanno agito su Facebook utilizzando
nome e foto di utenti reali per creare il profilo fake di «Julia», fantomatica
reporter de La Stampa. Con l'obiettivo di approcciare Khater Massaad, cittadino
con doppio passaporto svizzero e libanese che ha lavorato come capo del fondo
sovrano Rakia sino al 2012. «La scelta della testata - spiegano fonti informate
- è legata alla sua assidua copertura delle vicende regionali, sino a quel
momento». Nel 2015, i giudici hanno condannato Massaad in contumacia per
appropriazione indebita di fondi. Accuse definite dal diretto interessato false
e motivate politicamente, perché - sostiene - è considerato oppositore del
governo dell'emirato. «La falsa giornalista italiana si è avvicinata a Massaad
tramite un messaggio Facebook chiedendo di discutere il suo rapporto con il
governo di Ras Al Khaimah», spiega Daily Beast. Lo scambio tra i due sarebbe
stato molto limitato. Massaad insospettito da qualche incertezza
dell'interlocutore non ha proseguito il colloquio. «A quanto pare, ha fatto bene
- prosegue il sito Usa -, visto che il curioso giornalista italiano era un
agente legato a Bluehawk CI». A smascherare il cacciatore di segreti reali è
stato proprio Facebook che ha dimostrato come il falso profilo di cronista de La
Stampa fosse stato illecitamente utilizzato dalla società israeliana di business
intelligence. Il social ha adottato provvedimenti immediati tra cui la
cancellazione dell' utente "fake". Completa estraneità quindi della testata,
come ribadito in una nota del direttore Massimo Giannini. Stesso metodo è stato
ha utilizzato con una finta «ricercatrice presso il canale di notizie Fox a New
York», interessata a scrivere sui «numerosi casi di immigrazione e detenzione
tra i confini degli Emirati e Penisola araba». La fantomatica "Samantha" ha
contattato nel febbraio 2020 Oussama El Omari, cittadino americano che aveva
lavorato come amministratore delegato della zona di libero scambio di Ras Al
Khaimah e ha citato in giudizio l'emirato nel 2016 per un pagamento non
corrisposto. La causa è stata archiviata nel 2017. Anche in questo caso è emerso
il legame con la società fondata da Guy Klisman, ex ufficiale dell'intelligence
militare israeliana. Non è chiaro invece chi potrebbe aver assunto Bluehawk CI e
perché. El Omari ha intentato un'azione legale sostenendo che dietro il falso
giornalista Fox si celano dipendenti di aziende dell'emirato.
Davide Frattini per
il “Corriere della Sera” il 5 marzo 2021. Una volta erano gli
agricoltori-soldati dei kibbutz, che poco si preoccupavano dell'estetica e di
quella barba germogliata incolta a differenza dei campi. Ancora oggi sono gli
ultraortodossi che per fede religiosa non si rasano. Sempre di più avanzano gli
hipster che fanno della peluria ben curata un simbolo di identità da indossare
ed esibire. Lasciarla andare ispida - come il sabra, il fico d'India in ebraico,
simbolo dei pionieri cresciuti spinosi nel deserto - ha sempre fatto parte di
una certa mascolinità israeliana, compreso il ritorno a casa dal miluim (il
servizio militare nei riservisti, obbligatorio una volta l'anno) arruffati e
poco lavati. Fino al 2016, quando i generali che assistevano a un'esercitazione
congiunta con le forze americane, hanno notato una differenza nel grugno
guerresco: «I nostri erano i soli a esibire tutte quelle barbe lunghe, a volte è
un segno di trascuratezza che si trasferisce in battaglia», hanno commentato i
portavoce. Così lo Stato Maggiore ha deciso di inserire nel regolamento
l'obbligo di radersi e presentarsi all'adunata con il volto ripulito. La Corte
Suprema è intervenuta per evitare discriminazioni verso i giovani militari
laici, la leva per i maschi dura tre anni: gli osservanti ottengono la dispensa
dal taglio per intercessione dei rabbini militari e i giudici hanno decretato
che lo stesso diritto andasse accordato a chi dimostri attraverso una procedura
su per la catena di comando che la barba è parte profonda della sua identità. Da
allora le richieste per questi casi speciali sono state migliaia, le esenzioni
concesse dagli ufficiali ben poche. In gennaio un gruppo di 17 soldati ha deciso
di presentare una nuova petizione alla Corte e hanno raccolto via Facebook i
soldi (120 mila shekel, oltre 30 mila euro) per sostenere le spese legali. Il
simbolo della campagna è lo stemma di Tsahal, le forze di difesa israeliane,
effigiato da una lunga barba e i promotori spiegano «di voler spingere
l'esercito a concentrarsi sulle questioni essenziali: investire tempo e risorse
nella difesa della nazione». Sostengono che la discriminazione delle barbe crea
«malcontento nei ranghi»: «Perché complicare la vita di questi ragazzi - dicono
Bar Pinto e Gilad Levi all'agenzia France Presse - che fanno uno sforzo per
proteggere la patria e offrono il periodo migliore della loro vita?». Anche
perché quelli disposti al sacrificio - nonostante l'obbligo - sono sempre meno:
Benny Gantz, il ministro della Difesa, ha avvertito che tra gli esoneri degli
haredim (gli ultraortodossi: situazione mai davvero risolta per legge),
certificati medici, studi all'estero, metà dei giovani israeliani non indossa la
divisa. Cinque anni fa le nuove regole avevano finito con lo spaccare il pelo
anche tra i praticanti: i sionisti religiosi, che spesso sono la maggioranza
nelle unità combattenti, hanno protestato perché rischiavano di venire
penalizzati rispetto ai più ortodossi. «Non taglierete in tondo i capelli ai
lati del capo, né spunterai gli orli della tua barba», prescrive il Levitico. E
un potente rabbino aveva allora ordinato ai fedeli nell'esercito di «rispettare
la norma anche se dovessero prendersi cento frustate».
Sharon Nizza per "la Repubblica" il 4 marzo 2021.
La procuratrice capo della Corte Penale Internazionale dell' Aia (Cpi), Fatou
Bensouda, ha annunciato l' apertura di un' indagine "sulla situazione in
Palestina" che valuterà potenziali crimini di guerra commessi da Israele in tre
ambiti: l' operazione a Gaza Margine Protettivo del 2014, le "marce della
rabbia" palestinesi del 2018 al confine della Striscia di Gaza e la politica
degli insediamenti israeliani. L' indagine riguarderà anche crimini commessi da
Hamas e "altri gruppi armati palestinesi": gli attacchi intenzionali contro
civili israeliani e l' uso di civili come scudi umani, nonché crimini contro la
popolazione palestinese come la privazione del diritto a un processo equo,
omicidi intenzionali e torture. Per il ministro degli Esteri palestinese Riyad
al-Maliki è «un passo atteso da tempo che aiuterà lo sforzo incessante della
Palestina per ottenere giustizia». Il portavoce di Hamas Hazem Qassem si dice
fiducioso che «le nostre azioni ricadano nell' ambito della resistenza
legittima». «Il fatto che un' organizzazione terroristica come Hamas accolga con
favore la decisione è indice di quanto non abbia alcuna validità morale», ha
replicato il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi, mentre il premier
Netanyahu promette che «lotteremo per la verità e ribalteremo la decisione»,
definita "antisemita". La decisione era attesa, specie dopo che il 5 febbraio la
Cpi aveva riconosciuto la propria giurisdizione su Cisgiordania, Gaza e
Gerusalemme, nonostante Israele, non avendo ratificato il Trattato di Roma
istitutivo della Cpi, non aderisca alla Corte. In Israele parlano di decisione
politica e ipocrita, indicando come Bensouda, che a giugno termina il mandato,
abbia deciso di dare priorità a questa indagine rispetto alle inchieste
preliminari concluse a dicembre sulla situazione in Ucraina e Nigeria. E, mentre
Israele compila una lista di ufficiali che potrebbero trovarsi al centro delle
indagini - a cui il ministro della Sicurezza Gantz garantisce ogni sostegno
legale - , da un punto di vista procedurale ci vorrà tempo prima che vengano
adottate iniziative concrete. Per ottemperare al principio di complementarità,
per cui la Cpi può intervenire solo quando gli Stati non vogliano o siano
incapaci di investigare autonomamente, la Corte dovrà ancora esprimere una
valutazione sui procedimenti aperti in autonomia dalle autorità giudiziarie
israeliane in relazione alle accuse. Israele punta sull' autonomia del suo
sistema giudiziario, ma per fare leva su questo, ora deve decidere se
collaborare con la Corte. L' annuncio potrebbe trasformarsi in merce di scambio
in altri scenari: Blinken ha condannato a febbraio la Corte, ma questo sostegno
potrebbe ora avere un prezzo per Israele, specie considerando che Netanyahu
avrebbe chiesto a Biden di mantenere le sanzioni imposte da Trump alla Cpi:
potrebbe costare concessioni su altri dossier, come le trattative sul nucleare
iraniano o la ripresa di colloqui con i palestinesi.
Caterina Galloni per blitzquotidiano.it il 22
febbraio 2021. Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato nucleare iraniano assassinato a
novembre nei pressi di Teheran, sarebbe stato ucciso da un’arma con un peso
totale di una tonnellata contrabbandata in Iran dall’agenzia di intelligence
israeliana Mossad. È quanto riportato da The Jewish Chronicle citando fonti
dell’intelligence, aggiungendo che una squadra di oltre 20 agenti, tra cui
cittadini israeliani e iraniani, ha effettuato l’imboscata a Fakhrizadeh dopo
otto mesi di sorveglianza. I media iraniani avevano riferito che lo scienziato
era morto in ospedale dopo essere stato colpito a bordo della sua auto da
assassini armati. Poco dopo il decesso, l’Iran ha puntato il dito contro
Israele, il ministro degli Esteri Javad Zarif su Twitter aveva parlato di “gravi
indicazioni di un ruolo israeliano”.
Chi era Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh, 59 anni,
da lungo tempo era sospettato dall’Occidente di essere l’ideatore di programma
segreto riguardante la bomba nucleare. Per anni, dai servizi segreti occidentali
e israeliani era stato ritenuto il misterioso leader di un programma segreto
interrotto nel 2003, e che attualmente Israele e Stati Uniti accusano Teheran di
tentare di ripristinare. Secondo il Jewish Chronicle, l’Iran ha “segretamente
valutato che ci vorranno sei anni” prima che un sostituto dello scienziato sia
“pienamente operativo” e che la sua morte avrebbe “prolungato il periodo di
tempo necessario all’Iran per sviluppare una bomba atomica da tre mesi e mezzo a
due anni”.
L’arma del Mossad che ha distrutto le prove dopo
l’omicidio. Jewish Chronicle, ha riferito che il Mossad ha montato la pistola
automatica sul pick-up Nissan e che “l’arma su misura, azionata a distanza da
agenti a terra mentre osservavano l’obiettivo, era pesante perché includeva una
bomba che ha distrutto le prove dopo l’omicidio”. Ha aggiunto che l’attacco è
stato effettuato “solo da Israele, senza coinvolgimento americano”, ma che gli
agenti statunitensi hanno ricevuto una qualche forma di preavviso”.
Sapevano tutto di lui, anche che
dopobarba usava": così Israele ha ucciso il capo del programma nucleare
iraniano. Vincenzo Nigro su La Repubblica il 12
febbraio 2021. Il Jewish Chronicle, più antico giornale ebraico in inglese,
ricostruisce l'assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, colpito in un attentato a
Teheran il 27 novembre. Un gruppo di spie sul terreno e un'arma sofisticatissima
- poi fatta saltare in aria - sono state le chiavi dell'operazione. Nei giorni
scorsi il Jewish Chronicle, il più antico giornale ebraico pubblicato in inglese
a Londra dal 1841, ha offerto una lunga ricostruzione dell'assassinio di Mohsen
Fakhrizadeh. Lo scienziato nucleare iraniano fu colpito in un attentato il 27
novembre del 2020: l'uomo era soprannominato dagli israeliani "il padre"
del programma nucleare iraniano e quella per colpirlo fu un'operazione molto
complessa, messa in piedi dal Mossad e dai suoi operativi di nazionalità
iraniana dopo mesi di appostamenti. La ricostruzione del Chronicle conferma
alcuni elementi che erano girati già in dicembre. Sono questi: innanzitutto è
stata utilizzata una mitragliatrice automatica a controllo remoto, del peso di
una tonnellata. L'arma venne fatta entrare in Iran pezzo dopo pezzo e fatta
saltare in aria con tutto il veicolo su cui era stata piazzata per eliminare
elementi delicati che non dovevano cadere in mano iraniana. Secondo elemento: il
ruolo di Fakhrizadeh nel programma nucleare iraniano era stato individuato da
Israele nel 2018 con il furto a Teheran di un importante archivio sul programma
nucleare iraniano. Dall'archivio emerse il ruolo dello scienziato, che
sovrintendeva ai vari aspetti della ricerca. L'operazione fi avviata nel marzo
del 2020, nelle settimane inIziali del Coronavirus. Una squadra di 007
israeliani venne introdotta in Iran dove si riunì con gli altri agenti locali
del gruppo: in tutto oltre 20 persone, un numero elevato. Da quel momento iniziò
il controllo di Fakhrizadeh: "Per otto mesi la squadra respirò con lui, si
svegliò con lui, dormì con lui, viaggiò con lui: sapevano anche quale dopobarba
utilizzava". Gli attentatori israeliani decisero di colpire Fakhrizadeh sul
tragitto verso la villa di famiglia di Absard, poco fuori Teheran. Il professore
era scortato da almeno 12 guardie del copro, il convoglio viaggiava su 4
veicoli. Gli agenti israeliani piazzarono un Suv Nissan con la mitragliatrice ai
lati di una strada che l'uomo percorreva abitualmente. L'attentato avvenne il
27 novembre, mentre l'uomo era in auto con le guardie del corpo e la moglie:
l'arma sparò in tutto 13 colpi, nessuno della famiglia o fra le guardie del
colpo (secondo il Chronicle) venne colpito. La Nissan con la mitragliatrice fu
fatta esplodere immediatamente dopo. A questo punto il giornale inglese riporta
le considerazioni di una sua fonte: "Grazie a Dio tutti i nostri agenti sono
riusciti a uscire, nessuno è stato preso, non ci sono neanche arrivati vicino:
la sicurezza iraniana non è affatto male ma il Mossad è molto meglio. Il regime
(iraniano) è stato umiliato e devastato, anche il Mossad è rimasto sorpreso dal
forte impatto dell'attacco". Una valutazione fatta dal Mossad è che ci vorranno
sei anni perché l'Iran riesca a trovare un sostituto di Fakhrizadeh.
Il Chronicle aggiunge un particolare cruciale: l'amministrazione di Donald
Trump (già sconfitto nelle elezioni di novembre) non era stata avvertita. "Gli
americani non furono coinvolti, è stata assolutamente un'operazione israeliana.
non era una questione politica ma di sicurezza, non c'entrava nulla con Trump o
le elezioni Usa". Il governo israeliano non ha voluto commentare in nessun modo
il racconto del Jewish Chronicle, ma in qualche modo l'autorevolezza della
rivista e lo stesso silenzio di Israele confermano la ricostruzione, Che fatta
in queste ore diventa un nuovo elemento nella battaglia politica e anche di
informazione che Israele sta conducendo contro l'Iran per fermare il suo
programma nucleare.
·
Quei razzisti come i siriani.
Da huffingtonpost.it il 24
dicembre 2021. Un Narcostato affacciato sul Mediterraneo. Così l’Economist aveva
definito la Siria questa estate, così lo descrive il New York Times pubblicando
un’inchiesta che fa luce sui protagonisti, sui volumi e sul valore
multimiliardario del traffico di droga che attraversa e oltrepassa il Paese
mediorientale. Il prodotto di punta è il Captagon, una anfetamina sintetizzata
in laboratori clandestini, molto popolare negli stati arabi. Originariamente
usata per curare il deficit di attenzione e la narcolessia, venne dichiarata
illegale nel lontano 1981, quando aveva ormai preso piede negli Stati del Golfo
Persico. La produzione di captagon si è diffusa prima in Libano, per arrivare in
Siria con l’esplosione della guerra. I trafficanti siriani trovarono quindi un
terreno particolarmente fertile: non solo materie prime facilmente reperibili e
uno sbocco sulle rotte mediterranee, ma anche una comoda situazione di caos
estremo causata dal conflitto. Il proseguire incessante della guerra, le
sanzioni statunitensi comminate contro la Siria, il collasso finanziario del
vicino Libano, la pandemia che incide sulle rimesse dei siriani all’estero, ha
portato ad un tracollo economico devastante. Questo ha convinto numerose figure
vicine al presidente al-Assad ad investire in questo nuovo business, dando vita
ad un cartello profondamente legato e protetto dallo Stato. A sovrintendere la
produzione e la distribuzione, spiega la testata americana, è infatti la Quarta
Divisione Corazzata dell’esercito siriano, unità d’élite agli ordini del
Generale Maher al-Assad, fratello più giovane del presidente Bashar. Poco sotto
il vertice della piramide, ma in una posizione chiave, uomini d’affari come Amer
Khiti e Khodr Taher, entrambi arricchitisi notevolmente durante e grazie alla
guerra, e vicini al governo di Assad, come spiega sempre il Nyt. Il massiccio
incremento del traffico di droga è diretta conseguenza dei dieci anni di
conflitto che hanno travolto la Siria, alzando vertiginosamente il livello di
povertà, e portando affaristi, quadri militari e vertici politici a cercare
nuove fonti di guadagno – in denaro contante – e nuovi modi per eludere le
sanzioni statunitensi. E a quanto pare le anfetamine illegali rendono bene,
molto meglio dei prodotti legali che hanno ampiamente sorpassato. Attualmente
sono il bene nazionale di esportazione di maggior valore, stando al database di
retate globali di captagon costruito da New York Times. Negli ultimi anni si è
verificata una vera e propria esplosione: solo quest’anno, sono state
sequestrate nel mondo più di 250 milioni di pillole di captagon. Quattro anni fa
il bilancio era 18 volte inferiore. In Italia sono state trovate 84 milioni di
pillole nascoste in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti
in maniera tale da impedire agli scanner di individuare il contenuto.
Giuseppe Gagliano
per startmag.it il 13 dicembre 2021. Cosa scrive il New York Times sull’impero
della droga di Assad in Siria. La recentissima inchiesta del New York Times
sull’impero della droga che la famiglia Assad ha costruito in Siria conferma
quanto rilevato dall’Economist nell’agosto del 2021. Più nello specifico la
droga commercializzata è il Captagon, un composto di anfetamina e altre sostanze
stimolanti. La produzione e la distribuzione di questa droga sintetica coinvolge
direttamente una parte importante delle forze armate siriane e cioè la quarta
divisione dell’esercito siriano diretta da Maher al-Assad, fratello minore del
presidente. A livello economico questa droga sintetica raggiunge la cifra record
di 2,9 miliardi di dollari e naturalmente giunge in Europa e cioè in Grecia e in
Italia (nel luglio del 2020 la guerra di finanza di Salerno ne aveva infatti
sequestrato una quantità per un valore di mercato di 84 milioni). Per giungere
in Italia la droga passa attraverso la Svizzera e più esattamente attraverso la
società fantasma come la GPS Global Aviation Supplier di Lugano. L’importanza di
questo traffico era stata già evidenziata dal periodico The Economist, come
dicevamo poc’anzi. Che cosa rivelava l’inchiesta del periodico? In primo luogo
veniva sottolineato come la Siria sia diventato il primo fornitore mondiale di
questa droga sintetica e cioè è diventata la principale merce di esportazione e
fonte di valuta pregiata del paese. Stando infatti alle indagini del Centro che
la ricerca di Cipro, le autorità di altri paesi hanno sequestrato droghe siriane
per un valore di circa 3,4 miliardi di dollari e quindi data l’entità notevole
di questa cifra è chiaro che la commercializzazione di questa droga sta
diventando uno strumento per finanziare il governo centrale. Ciò non deve
sorprendere, dal momento che già negli anni 90 la Siria e più esattamente la
valle della Beqa’ è stata la principale fonte di hashish. Tuttavia l’apice della
produzione di droga è cominciata soltanto nel 2011, cioè dopo la guerra civile.
A parte la famiglia Hassad, Hezbollah svolge ieri come oggi un ruolo
fondamentale: proprio nelle montagne di Qalamoun non solo ha prodotto hashish,
ma ha prodotto anche le pillole di captagon. Tuttavia è certamente la Siria a
svolgere il ruolo centrale in questo traffico e più esattamente le due fabbriche
chimiche site rispettivamente nella città di Aleppo e di Homs. Al di là del
fatto – assolutamente scontato – che il regime di Assad è un regime
assolutamente autoritario, è tuttavia altrettanto evidente che il ruolo della
droga – e i profitti che determina – costituisce un aspetto molto importante
anche per le nostre democrazie: e cioè che lo Stato ufficiale collabora in modo
sinergico con il Deep State sia nelle democrazie che negli Stati autoritari.
Pensiamo – a titolo esemplificativo – al ruolo che i contras ebbero proprio nel
commercio di droga per contrastare la minaccia comunista, ed in particolare
faccia di ananas cioè Noriega un uomo chiave non solo per gli USA ma anche per
la P2, come rivelato da Francesco Pazienza nella sua autobiografia Il
Disubbidiente.
·
Quei
razzisti come i libanesi.
Chi è Samir Geagea.
Mauro Indelicato su
Inside Over il 23 novembre 2021. Samir Geagea è l’attuale presidente delle Forze
Libanesi, uno dei più importanti partiti della comunità cristiano-maronita.
Protagonista molto discusso della guerra civile libanese, dal 1994 al 2005
risulta recluso per le responsabilità a lui attribuite di un attentato compiuto
a Beirut nei primi anni ’90. Da sempre su posizioni anti siriane, nel corso
degli anni mantiene un ruolo di primo piano nella vita politica del Libano.
L'infanzia e gli studi di
Geagea
Samir Geagea nasce il 25
ottobre 1952 da una famiglia cristiana in un quartiere di Beirut. Il padre
lavora per l’esercito e, nonostante una posizione economica non agiata, riesce a
far studiare il figlio al liceo prima e all’università poi. Samir infatti
risulta iscritto nella facoltà di medicina presso l’Università Americana di
Beirut. Ma quando ha 23 anni nel Paese scoppia la guerra civile. Un evento
destinato a incidere profondamente nella vita di Samir Geagea.
Gli studi interrotti con lo
scoppio della guerra civile
Fino a prima dell’inizio del
conflitto Samir Geagea non sembra essere molto coinvolto nel mondo politico.
Tuttavia poco dopo il suo ingresso all’università risulta iscritto al Partito
delle Falangi Libanesi, formazione cristiano-maronita guidata da Bachir Gemayel.
In quel periodo tutti i principali partiti iniziano ad avere delle proprie
fazioni armate. La tensione in Libano è molto alta e le varie comunità
etnico-religiose decidono di prepararsi allo scontro.
La scintilla del conflitto
scoppia nel 1975. A quel punto anche Samir Geagea viene risucchiato dagli eventi
della storia. Da quel momento in poi l’impegno politico diventa prioritario
nella sua vita, tanto da interrompere gli studi universitari. Lascia quindi la
facoltà di medicina per aderire a pieno titolo sia alle Falangi Libanesi che
alle milizie armate del partito. Prova a completare l’università iscrivendosi
nel 1976 alla Saint Joseph, ma gli eventi della guerra anche in quel caso non
gli consentono di arrivare alla laurea.
La militanza nelle Forze
Libanesi
La guerra imperversa in Libano
e soprattutto a Beirut. Per questo nel 1976 Bachir Gemayel decide di unire tutte
le varie forze cristiane, anche al di fuori delle Falangi, e fondare il gruppo
delle Forze Libanesi.
Samir Geagea aderisce alla
nuova coalizione armata e ne diventa uno dei più importanti rappresentanti
giovanili. Lo stesso Gemayel inizia a considerarlo tra gli elementi su cui
puntare, soprattutto da un punto di vista militare.
Il massacro di Ehden del 1978
Il leader delle Forze Libanesi
mette per la prima volta alla prova Samir Geagea affidandogli una parte del
commando destinato a prendere in consegna Tony Frangieh, a capo di una milizia
interna denominata “Brigata Marada” in contrasto con le posizioni di Gemayel.
Quest’ultimo ha infatti una linea anti siriana e considera il ruolo di Damasco
come deleterio per l’indipendenza e l’integrità del Libano.
La milizia di Frangieh, al
contrario, ha ottimi rapporti con il governo siriano. Anzi, il
capostipite Suleiman Frangieh, presidente della Repubblica dal 1970 al 1976,
intrattiene relazioni politiche molto strette con il presidente siriano Hafez Al
Assad. Questo dà vita a un contrasto ben presto portato dal piano politico a
quello militare.
Nella primavera del 1978 un
membro delle Forze Libanesi viene assassinato nel nord del Paese, in una zona
dove la Brigata Marada è molto radicata. Il sospetto di Gemayel è che dietro
l’omicidio ci sia un ordine impartito da Tony Frangieh. Da qui la decisione di
raggiungere quest’ultimo nella propria abitazione per arrestarlo. Il compito
viene affidato il 13 giugno 1978 a due gruppi, uno dei quali comandato da Samir
Geagea. I suoi uomini devono raggiungere la località di Ehden, dove si trova la
villa dei Frangieh.
Qualcosa però va storto. Lo
stesso Geagea viene ferito in un agguato prima di arrivare sul posto. La sua
mano rimane parzialmente paralizzata e questo gli impedisce di completare il
proprio tirocinio in medicina. Quello che accade dopo è uno degli episodi più
cruenti della guerra civile libanese. A Ehden va in scena un cruento scontro
armato, in cui rimangono uccise 40 persone. Tra queste lo stesso Tony Frangieh,
assieme alla moglie e alla figlioletta di appena tre anni. Della sua famiglia si
salva solo il figlio Soleiman. L’eccidio di Ehden rappresenta, tra le altre
cose, uno degli episodi più controversi nella vita politica di Geagea. Ancora
oggi è ignoto il suo ruolo nel massacro. In tanti però gli imputano quanto meno
una certa responsabilità politica e morale.
Le posizioni anti siriane di
Geagea
Nel corso della sua militanza
nelle Forze Libanesi, Samir Geagea mantiene sempre posizioni antistanti a quelle
di Damasco. Nei primi anni ’80 Gemayel gli affida il comando delle fazioni
armate del partito nel nord del Libano. Qui in più occasioni ingaggia battaglie
dirette contro l’esercito siriano. Così come sono diversi gli scontri contro le
fazioni armate dell’Olp e di altri gruppi palestinesi.
Nel 1982 Israele invade il sud
del Libano per contrastare l’Olp. Lo Stato ebraico intrattiene buoni rapporti
con le Forze Libanesi e la presenza dei soldati israeliani favorisce l’elezione
a presidente della Repubblica di Gemayel. Quest’ultimo però viene ucciso pochi
giorni prima dell’insediamento. A succedergli è il fratello Amin Gemayel, il
quale ha posizioni più moderate nei confronti dei siriani.
Il comando delle Forze
Libanesi viene preso da Elie Hobeika, con Samir Geagea che diventa uno dei più
importanti leader militari.
Samir Geagea a capo delle
forze libanesi
Hobeika nel 1985 dà vita a una
svolta importante. Sigla con Nabih Berri, leader del partito sciita Amal, e
con Walid Jumblatt, leader druso, un patto tripartito per favorire la
pacificazione. Ma non tutti all’interno delle Forze Libanesi sono d’accordo. Il
forte sospetto è che questa nuova alleanza contribuisca a rafforzare il ruolo
della Siria all’interno del Libano.
Il 15 gennaio 1986 i militanti
vicini a Samir Geagea, divenuto a tutti gli effetti capo militare delle Forze
Libanesi, ordiscono contro Hobeika. Quest’ultimo viene costretto, dopo un
assedio del proprio quartier generale, a rassegnare le dimissioni. Gli stessi
militanti proclamano quindi Samir Geagea quale nuovo leader delle Forze
Libanesi. Tre anni più tardi, con gli accordi di Taif, viene sancita la fine
della guerra civile.
Quale leader delle Forze
Libanesi e quale importante rappresentante della comunità cristiano-maronita, a
Geagea viene offerto nel 1990 un posto nel nuovo governo post bellico. La
proposta viene tuttavia rifiutata. Geagea considera il nuovo esecutivo
eccessivamente vicino alla Siria, le cui truppe peraltro rimangono presenti in
Libano come forza stabilizzatrice in virtù degli accordi di Taif. I rapporti tra
le Forze Libanesi e Damasco rimangono quindi tesi anche con la fine della
guerra.
Le forze libanesi trasformate
in partito dopo la guerra
Nel 1992 Samir Geagea prova ad
avere una maggiore legittimazione politica. Confermato alla guida delle Forze
Libanesi, in quell’anno si candida anche alla guida del partito delle Falangi.
In tal modo avrebbe il controllo dell’intera formazione, sia militare che
partitica. Tuttavia Geagea perde il confronto con Saadeh. Quest’ultimo, deciso a
non dare un orientamento anti siriano alle Falangi, espelle Geagea e tutti i
suoi seguaci.
A questo punto l’ex leader
militare fonda il partito delle Forze Libanesi e dà definitivamente addio alla
coalizione nata nel 1976. Le formazioni delle Falangi e delle Forze Libanesi
sono adesso due distinte entità partitche.
L'arresto di Geagea del 1994
Nel 1990 viene propugnata
un’amnistia per i crimini commessi durante la guerra. In tal modo nessun leader
politico libanese che ha avuto ruoli nel conflitto rischia dei processi. C’è
però un piccolo particolare: l’amnistia è data per le azioni commesse prima del
1990, non dopo. Nel 1994 una bomba esplode in una chiesa nella cittadina
di Zouk, causando nove morti. Il governo punta il dito contro Samir Geagea,
accusandolo di aver mantenuto in vita una milizia mascherata all’interno di un
partito.
Si ordina quindi lo
scioglimento delle Forze Libanesi mentre il 21 aprile del 1994 la magistratura
spicca un mandato di arresto per Geagea. Quest’ultimo perde l’amnistia e viene
condannato sia per l’attentato di quell’anno che per il ruolo avuto nel
precedente conflitto. La detenzione è descritta come non rispettosa dei diritti
umani dalle stesse Nazioni Unite. In particolare, Geagea viene imprigionato in
un locale senza finestre dei sotterranei del ministero della Difesa. Ha diritto
di vedere soltanto i familiari più stretti e le conversazioni vengono
costantemente monitorate. Secondo i suoi sostenitori, la sentenza di condanna ha
solo motivazioni politiche e fa di Geagea l’unico leader libanese a essere
imprigionato per i fatti riconducibili alla guerra civile.
Il rilascio dopo la morte di
Hariri del 2005
Il 14 febbraio 2005 muore in
agguato l’ex premier Rafiq Hariri. L’omicidio dà vita a un’ondata di proteste a
Beirut e in tutto il Libano. I manifestanti puntano i riflettori sul presunto
ruolo della Siria nella morte dell’ex capo del governo. La piazza chiede la fine
della presenza siriana nel Paese e questo spinge la politica libanese a
dividersi di fatto in due grandi coalizioni: da un lato gli anti siriani e
dall’altro i filo siriani. Del primo gruppo fanno parte i partiti sunniti vicini
alla famiglia Hariri e le Falangi che, assieme ad altre formazioni minori, danno
vita all’Alleanza del 14 marzo. La coalizione vince le elezioni e fa approvare
il 18 luglio 2005 un disegno di legge di amnistia per Samir Geagea.
Quest’ultimo, viste le sue posizioni anti siriane, viene quindi politicamente
riabilitato e può ricostituire le Forze Libanesi.
Al momento del rilascio,
avvenuto a fine luglio, le sue condizioni di salute appaiono precarie. È
costretto a ricorrere alle cure in Francia, terminate soltanto dopo tre mesi. Il
25 ottobre 2005 Geagea torna in Libano per la prima volta da uomo libero dopo 11
anni.
L'attuale ruolo di Geagea
nella politica libanese
La liberazione di Geagea
coincide con un suo ritorno in politica. Il suo partito ottiene 8 seggi nelle
elezioni del 2009 e 12 invece in quelle del 2018. Nel 2014 prova a essere eletto
presidente della Repubblica con il sostegno dell’Alleanza del 14 marzo, ma è
costretto poi a desistere.
Come capo delle Forze
Libanesi, Geagea viene visto con sospetto dal partito sciita Hezbollah. Il 14
ottobre 2021 si verifica uno scontro armato nel centro di Beirut durante una
manifestazione organizzata proprio da militanti sciiti. Il loro obiettivo è
chiedere la destituzione di Tarek Bitar, il magistrato che
indaga sull’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020. Le proteste
degenerano in scontri a fuoco in cui muoiono almeno 7 persone. Hezbollah dà la
colpa degli eventi a cecchini delle Forze Libanesi appostati negli edifici
vicini. Geagea nega ogni coinvolgimento e accusa a sua volta gli sciiti di aver
fomentato disordini.
Che cos’è la rivoluzione
dei Cedri.
Mauro Indelicato su Inside Over il 2 novembre 2021. Con il termine “rivoluzione
dei Cedri” ci si riferisce a una serie di manifestazioni andate in scena
in Libano tra l’inverno e la primavera del 2005. Epicentro delle proteste è la
capitale Beirut e il casus belli è da individuare nell’assassinio dell’ex primo
ministro Rafiq Hariri. La rivoluzione dei Cedri porta alla caduta del governo di
Karami e allo scioglimento del parlamento, nonché all’indizione di nuove
elezioni. Ma la conseguenza più grande si ha sul piano internazionale: a seguito
delle proteste, la Siria, presente in Libano dal 1976, ritira le proprie truppe.
L'attentato a Rafiq Hariri
Alle 12:55 del 14 febbraio
2005 Beirut viene sconvolta da una violenta esplosione. In un lampo la capitale
ripiomba nell’incubo vissuto vent’anni prima, quando era il principale fronte
avanzato della guerra civile libanese. Il violento boato proviene da una strada
vicina all’Hotel Saint George. L’esplosione è provocata da un’autobomba fatta
saltare in aria mentre l’arteria adiacente all’albergo vive il consueto traffico
dell’ora di punta. In quel momento nel punto dell’esplosione transita l’auto
di Rafiq Hariri. Quest’ultimo è l’uomo politico più influente del Libano post
guerra.
Primo ministro dal 1992 al
1998 e ancora dal 2000 al 2004, uomo d’affari con stretti legami con l’Arabia
Saudita, Hariri imprime il suo nome nella ricostruzione del Paese. Dopo le
dimissioni sul finire del 2004, in molti però scommettono su un suo prossimo
rientro alla guida dell’esecutivo. Sono però importanti i contrasti con il
presidente della Repubblica, Emile Lahoud. Cristiano, considerato vicino alla
Siria, è proprio il rapporto con Damasco a far deteriorare i suoi rapporti con
Hariri. L’ex premier viene considerato sempre più distante dal governo siriano,
presente con il proprio esercito in Libano dal 1976 con le truppe autorizzate a
rimanere dagli accordi di Taif del 1989.
L’attentato provoca 22 morti,
tra cui lo stesso Hariri e almeno sue 9 guardie del corpo. Ma soprattutto
l’agguato scatena indignazione in seno all’opinione pubblica. Nasce un
sentimento profondamente anti siriano, che ben presto manda in piazza migliaia
di persone.
L'inizio delle proteste
Sia durante che dopo il
funerale di Hariri la capitale Beirut e diverse altre grandi città libanesi sono
paralizzate dalle proteste. In centinaia scendono per strada sventolando
bandiere del Paese dei Cedri. Per questo la stampa occidentale conia il termine
“rivoluzione dei Cedri”. Le manifestazioni non sono legate a una precisa
appartenenza etnica o religiosa ma, al contrario, appaiono trasversali. Il filo
comune è dato dalla richiesta di allontanamento delle truppe siriane.
Una posizione portata avanti
in primis dal Movimento del Futuro, il partito sunnita fondato da Hariri. Ma a
questa formazione si aggiungono anche le Falangi cristiano-maronite e i drusi
radunati nel Partito Socialista Progressista di Jumblatt. Per loro dietro
l’omicidio di Rafiq Hariri c’è proprio la Siria, preoccupata di perdere la
propria influenza in Libano.
Al di là degli schieramenti
politici, il movimento di protesta che scende in piazza vede la presenza di
numerosi giovani. Per loro, a prescindere dall’appartenenza confessionale o
partitica, la priorità è rendere Beirut autonoma da Damasco. Non a caso se la
stampa occidentale usa il termine rivoluzione dei cedri, nel mondo arabo si
parla di “intifada dell’indipendenza”. Le proteste non assumono contorni
violenti. Buona parte delle manifestazioni sono pacifiche e non culminano con
scontri. Vengono occupate piazze, vie di comunicazione, scuole e università. Il
Libano è paralizzato ma, al tempo stesso, non in preda agli spettri della guerra
civile.
Le dimissioni del governo di
Karami
Le manifestazioni portano il
28 febbraio 2005, a due settimane esatte dall’attentato contro Hariri,
alle dimissioni dell’esecutivo. Il governo in quel momento è guidato Omar
Karami, sunnita considerato però molto vicino alla Siria. Il presidente Lahoud
prende atto del passo indietro, anche in considerazione delle forti pressioni
arrivate dalla piazza.
Una volta annunciate le
dimissioni, a Beirut si notano scene di festa per strada. Tuttavia la fine del
governo di Karami apre la strada anche a un’instabilità istituzionale pericolosa
per gli equilibri libanesi interni. I manifestanti inoltre iniziano a chiedere
anche un passo indietro del presidente Lahoud. A marzo viene presa la decisione
di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni tra maggio e giugno.
La manifestazione anti siriana
del 14 marzo 2005
Nella ricorrenza del primo
mese dall’attentato, migliaia di persone si radunano a Beirut sia per ricordare
Rafiq Hariri e sia per tornare a chiedere alla Siria un passo indietro dal
Libano. Qualche giorno prima il presidente siriano, Bashar Al Assad, dichiara in
televisione di essere pronto a ritirare le sue truppe entro pochi mesi.
Un’affermazione che arriva anche a seguito di una certa pressione
internazionale. Oltre a Francia e Usa, le prime potenze a dar manforte alle
richieste dei manifestanti, anche Germania e Russia chiedono ad Assad di
richiamare i propri soldati. Particolarmente significativa è la posizione di
Mosca, storica stretta alleata della Siria.
I gruppi di protesta in piazza
in quel 14 marzo vedono nell’allontanamento dei soldati di Damasco la vera
svolta decisiva per il Libano. La prova di forza dei manifestanti, i quali
parlano di oltre 50.000 persone in strada nella sola Beirut, orienta la
cosiddetta rivoluzione dei Cedri verso una linea sempre più anti siriana.
La nascita dell'Alleanza del
14 marzo
Con lo scioglimento del
parlamento e l’indizione di nuove elezioni, le proteste di piazza cambiano anche
il quadro politico. In Libano le divisioni partitiche solitamente rispecchiano
quelle settarie e confessionali. Dopo l’omicidio Hariri e l’inizio delle
proteste, la politica libanese si divide invece in due fazioni trasversali: da
un lato la coalizione filo siriana e dall’altro quella invece anti siriana.
Sul primo fronte si trovano i
due partiti sciiti di Amal ed Hezbollah, assieme ad altre formazioni minori di
orientamento laico. La coalizione viene denominata “Alleanza dell’8 marzo”.
Sull’altro fronte invece si assiste a un’alleanza tra il Movimento del Futuro di
Hariri, preso in mano dal figlio dell’ex premier assassinato Saad Hariri, i
drusi di Jumblatt e i cristiani delle Falangi e delle Forze Libanesi. Assieme
danno vita alla cosiddetta “Alleanza del 14 marzo”, in relazione alla data della
più grande manifestazione della rivoluzione dei Cedri.
La scarcerazione de Geagea e
il ritorno di Aoun
Tra le conseguenze delle
proteste anti siriane vi è quella del ritorno di due figure invise a Damasco. In
primo luogo si assiste alla riabilitazione politica delle Forze Libanesi,
sciolte nel 1994 e da sempre contrarie alla presenza siriana. Il suo
leader, Samir Geagea, è in carcere da 11 anni con l’accusa di aver compiuto
attacchi anche dopo la fine della guerra civile. Geagea, durante il conflitto,
ha rappresentato uno dei leader militari e politici più ostili alla Siria.
Durante la rivoluzione dei Cedri in tanti ne chiedono il rilascio. La fine della
sua prigionia avviene a luglio.
L’altra figura politicamente
riabilitata è quella di Michel Aoun, la cui presidenza nel 1990 termina sotto i
colpi di cannone sparati dall’artiglieria siriana verso il palazzo del governo.
Da allora vive in esilio in Francia. La piazza ne chiede un rientro. Circostanza
che avviene nel mese di maggio. C’è però un colpo di scena: Michel Aoun fonda un
nuovo partito, il Movimento Patriottico Libero, il quale si schiera contro la
coalizione anti siriana e stringe un’alleanza con Amal ed Hezbollah.
Il ritiro della Siria dal
Libano
Intanto da Damasco si danno
seguito agli annunci di Assad di marzo. A inizio aprile i primi soldati siriani
oltrepassano il confine e rientrano in patria. Nel giro di poche settimane,
caserme e basi siriane lasciano il Libano e le infrastrutture vengono consegnate
all’esercito locale. Se in un primo tempo si parla di un’ultimazione del ritiro
entro l’estate, in realtà l’ultimo gruppo di soldati siriani lascia il Paese dei
Cedri il 30 aprile. Quel giorno si chiude un’epoca iniziata nel 1976, anno in
cui Damasco decide di intervenire direttamente in Libano nell’ambito della
guerra civile.
Le elezioni della primavera
del 2005
Affievolite le proteste di
piazza grazie all’indizione di nuove consultazioni e al ritiro della Siria, il
mese di maggio è contrassegnato dalla campagna elettorale. Le votazioni sono
fissate a più tappe tra il 29 maggio e la prima decade di giugno. Il Libano va
al voto tra non poche incognite. La sfida principale è tra l’Alleanza anti
siriana del 14 marzo e quella filo siriana dell’8 marzo.
I responsi premiano, come
prevedibile, la prima coalizione. Gli anti siriani conquistano 69 seggi su 128.
All’interno dell’alleanza vincitrice il primo partito è il Movimento del Futuro
di Hariri, forte di 36 seggi. Seguono i drusi di Jumblatt con 16 deputati, 6
seggi a testa vanno invece ai cristiani delle Falangi e delle Forze Libanesi.
Altri 5 posti parlamentari sono assegnati a formazioni minori interne
all’alleanza.
Sull’altro fronte, la
coalizione filo siriana si ferma a 35 seggi, 15 dei quali attribuiti ad Amal e
14 ad Hezbollah, più altri deputati di diverse formazioni minori. Il Movimento
Patriottico Libero di Aoun conquista invece 15 deputati, tra cui lo stesso
rientrante leader. Il 30 giugno, a circa un mese dal voto, l’Alleanza del 14
marzo trova l’accordo per eleggere Fouad Siniora quale nuovo primo ministro.
Il Libano dopo la fine della
protesta
La rivoluzione dei Cedri
ottiene importanti risultati nell’immediato, con la fine del governo di Karami,
l’indizione di nuove elezioni e soprattutto il ritiro siriano. Ma nel lungo
periodo, chi nel 2005 scende in piazza è destinato a rimanere deluso. Il Libano
non riesce a superare le divisioni settarie, né a rinnovare la sua classe
politica. La tanto attesa autonomia dalla Siria non porta a un Paese in grado di
reggere da solo il peso delle sue difficoltà. Lo si vede nel 2006, anno della
guerra tra Israele ed Hezbollah, così come nei successivi periodi di instabilità
politica contrassegnati da mesi senza governi in carica.
A Beirut si torna in piazza
nel 2019 per protestare contro la corruzione e condizioni di vita sempre più
esasperanti. Il 4 agosto 2020 un’esplosione all’interno del porto della
capitale causa più di 200 morti e blocca ancora di più l’economia. Nell’ottobre
2021 il Paese rimane senza carburante e con una scarsa erogazione dell’energia
elettrica. Di fatto, lo Stato sembra scivolare verso il fallimento.
Anni dopo la rivoluzione dei
Cedri inoltre viene messo in dubbio il coinvolgimento della Siria nell’omicidio
di Rafiq Hariri. Nel 2010 il figlio Saad, in un’intervista sul quotidiano Asharq
al-Awsat, ammette di non avere prove sulle responsabilità di Damasco e parla di
“accuse politiche” alla Siria. Il 18 agosto 2020 il tribunale speciale per il
Libano, incaricato di indagare sull’attentato del 14 febbraio 2005, rileva di
non avere prove in grado di accusare ufficialmente il governo siriano per
l’omicidio di Hariri.
Carneficina in strada a
Beirut, cecchini sparano sui manifestanti: 6 morti e 30 feriti.
Antonio Lamorte su Il
Riformista il 14 Ottobre 2021. Strage nelle strade di Beirut, capitale del
Libano. Spari sulla folla, presumibilmente esplosi da tiratori scelti, scesa in
piazza a protestare contro Tarek Bitar, il giudice che si occupa delle indagini
sulla devastante esplosione del 4 agosto 2020 nel porto della città, quando
morirono oltre 200 persone a causa di un carico di nitrato di ammonio confiscato
e depositato nel porto senza misure di sicurezza per sei anni. La
manifestazione, per chiedere la rimozione del giudice, era stata organizzata dal
movimento paramilitare oltre che partito sciita Hezbollah e dai suoi alleati. La
protesta si teneva davanti al Palazzo di Giustizia. Ancora da chiarire con
precisione la dinamica degli eventi. Sono morte almeno sei persone e più di
trenta sono state ferite dai colpi di arma da fuoco. Per Hezbollah e Amal, i due
partiti armati libanesi, “cecchini” hanno cominciato a sparare per primi e hanno
denunciato “l’aggressione” da parte di “gruppi armati organizzati”. Sempre
secondo le due organizzazioni sciite i cecchini miravano alla testa, erano
appostati sui palazzi di fronte alla rotonda di Tayyoune, quartiere di Ayn
Remmane. “L’aggressione ha lo scopo di spingere appositamente il Paese verso la
sedizione su base religiosa. Un giornalista dell’Associated Press ha detto di
aver visto un uomo aprire il fuoco con una pistola e altri uomini sparare da un
balcone di un edificio in direzione dei manifestanti. Il quartiere degli scontri
è considerato roccaforte dei partiti cristiani maroniti, rivali di Hezbollah e
Amal. I due movimenti sciiti accusano Tarek Bitar di prendere di mira
soprattutto politici alleati a loro negli interrogatori: e quindi di essere di
parte. L’inchiesta va avanti da 14 mesi. Per due volte in un mese il giudice ha
sospeso le indagini dopo essere stato denunciato da alcuni ex ministri che aveva
convocato perché sospetti di negligenza. Appello alla pace e alla calma da parte
del Primo Ministro Najib Mikati (miliardario, secondo Forbes l’uomo più ricco
del Paese) che solo un mese fa era riuscito a creare un nuovo governo dopo oltre
un anno di vuoto istituzionale. Il nuovo esecutivo dovrà quindi affrontare non
solo una crisi economica durissima; una crisi energetica altrettanto grave –
quasi un giorno è durato il blackout totale dello scorso fine settimana, anche
se è da mesi che la corrente viene centellinata dallo Stato per via della
scarsità di carburante; oltre alle conseguenze dell’esplosione e della pandemia
da coronavirus. In queste ore i militari sono stati dispiegati nella
capitale. L’Orient le jour scrive di grande paura nelle scuole della zona che
hanno aperto e che subito hanno dovuto chiudere, perché alcune non hanno aperto
viste le previsioni di scontri. I sospetti dei movimenti sciiti vanno verso
le Forze Libanesi, movimento cristiano maronita, che ha negato qualsiasi
coinvolgimento. Le tensioni nel Paese sono tracciate sulla scorta della guerra
civile che per 15 anni ha dilaniato il Paese fino al 1990. Il quotidiano Daily
Star ha fatto sapere di essere offline per “circostanze al di fuori del nostro
controllo”. “In questo momento è necessario dare prova della massima
moderazione, garantire che sia ripristinata la calma e che i cittadini siano
protetti”, il tweet di Joanna Wronecka, coordinatore speciale delle Nazioni
Unite per il Libano. “La classe politica e i leader politici hanno la
responsabilità di ciò che sta succedendo, allo stesso modo hanno la
responsabilità di assicurare che le indagini sull’esplosione al porto di Beirut,
bloccate da oltre un anno, vadano avanti. I libanesi hanno legittime pretese di
ricevere delle risposte”, le parole del portavoce dell’Unione Europea per la
politica estera.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
Il Libano è al buio, senza
cibo e medicine. Ma i politici nascondono milioni nei paradisi fiscali.
Mentre il Paese affronta una crisi economica devastante, i Pandora Papers
rivelano le ricchezze dei membri del nuovo governo. Intanto il costo del paniere
alimentare di base di una famiglia è cinque volte il salario minimo
nazionale. Francesca Mannocchi su L'Espresso il 12 ottobre 2021. «Gli uomini le
donne e i bambini chiedono giustizia, non accetteremo una volta ancora la vostra
impunità». Questa la frase che campeggia su uno striscione di fronte alla porta
3 del Porto di Beirut. A srotolare lo striscione i parenti delle 215 vittime
dell’esplosione del 4 agosto del 2020. Si ritrovano qui ogni 4 del mese, da
quattordici mesi, a chiedere giustizia. A chiedere che i responsabili vengano
indagati, processati e puniti. Che la morte dei loro cari non resti solo una
commemorazione destinata a diventare col tempo l’ennesimo esercizio della
memoria di un lutto, in un Paese che per decenni è stato attraversato da perdite
e conflitti. Ogni mese alle 18.07, nell’ora esatta in cui l’esplosione di 2.750
tonnellate di nitrato d’ammonio ha fatto tremare la città ormai più di un anno
fa, i parenti delle vittime accendono le candele di fronte alle immagini delle
persone amate che hanno perso. Un bambino di fronte all’immagine di un giovane
uomo sorridente chiede: «Dov’è mio padre? Chi lo ha portato via?». Le immagini
sono una mappa di età e confessioni. Donne, bambini, uomini, musulmani e
cristiani. Musulmane e cristiane sono le donne che pregano insieme, tenendosi la
mano in una fede che, per una volta, non ha barriere. Hiyam al-Bikai stringe tra
le mani la foto del suo unico figlio, Ahmad Kadaan, è morto a 23 anni, due mesi
prima di sposarsi. «Oggi dovrei essere una nonna che visita suo figlio e i suoi
nipoti e invece sono una madre che ogni giorno va al cimitero». Hiyam ha
trasformato il dolore in battaglia. È la prima a sfidare la polizia durante le
manifestazioni, è in prima fila di fronte al tribunale. Era lei a gridare la
parola giustizia quando, per la seconda volta l’inchiesta sull’esplosione era
stata sospesa. La prima volta era stato il turno del giudice Fadi Sawan, rimosso
dall’incarico. Poi è toccato al giudice attuale, Tarek Bitar. Proprio la mattina
del 4 ottobre, il giorno della commemorazione mensile, la corte d’Appello di
Beirut ha respinto le richieste di rimozione di Bitar presentate dagli ex
ministri e funzionari e addetti alla sicurezza indagati dallo stesso Bitar.
«Devono pagare per quello che hanno fatto, per tutto quello che hanno fatto, non
solo per il porto, ma anche per aver rubato tutti i nostri soldi», dice Rima
al-Zahid, il cui fratello era un impiegato portuale ed è morto nell’esplosione.
«I documenti che mostrano l’esistenza delle loro società offshore sono la prova
che quello che gridiamo da anni è vero: hanno rubato i nostri soldi, li hanno
portati via i risparmi di un Paese intero e questa inchiesta ne è la
dimostrazione». Il 4 ottobre Beirut si è svegliata con le notizie dei Pandora
Papers. I nomi ai vertici delle istituzioni sono tutti lì: l’attuale primo
ministro Najib Mikati, il governatore della banca centrale Riad Salameh, l’ex
primo ministro Hassan Diab, il potente banchiere Marwan Kheireddine, i loro
parenti usati come prestanome. Una lista che ha il sapore della beffa nel Libano
che vive non una crisi ma tante emergenze che si sommano, il collasso economico,
la gestione di due milioni di sfollati in un Paese di quattro milioni di
abitanti, l’instabilità politica, a cui si sono aggiunti gli effetti della
pandemia e le tragiche conseguenze economiche dell’esplosione del 2020 che
secondo la Banca Mondiale ha provocato dai 4 ai 4,5 miliardi di dollari di
danni, in un Paese il cui il 90 per cento delle importazioni arrivava dal porto
di Beirut. La pubblicazione dei documenti sulle società offshore di politici,
imprenditori e banchieri libanesi avviene durante la peggiore crisi economica
mai vissuta dal Libano. Dal 2019, la lira libanese, che la Banca Centrale
mantiene al cambio ufficiale di 1.500 per dollaro Usa (entrambe le valute sono
utilizzate in Libano), ha perso oltre il 90 per cento del suo valore di mercato,
superando i 20.000 per dollaro in luglio, la maggior parte delle persone
guadagna e spende nella valuta locale, il cui valore di mercato nero varia ogni
giorno, mentre i prezzi del cibo sono aumentati del 400 per cento, nei settori
commerciali il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 50 per cento e un milione
di persone vive ormai in una condizione di insicurezza alimentare. Secondo la
banca Mondiale, quella libanese è la peggiore crisi economica al mondo dalla
metà dell’800. Alla fine di settembre il tasso di inflazione annuale è salito al
livello più alto di tutti i Paesi monitorati da Bloomberg superando lo Zimbabwe
e il Venezuela. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 137,8 per cento
rispetto a un anno fa. Dopo l’esplosione, l’ex primo ministro Saad Hariri ha
provato per diciotto volte a formare un governo, presentando diverse liste dei
ministri al presidente Michel Aoun. Tante le liste quante i rifiuti. Poi la
rinuncia definitiva di Hariri. Dentro i palazzi si spartiva il potere, fuori dai
palazzi ci sono cinque cambi diversi: uno ufficiale con le vecchie riserve di
dollari, uno ufficioso con i dollari fresh money che arrivano sui conti bancari
libanesi e tre cambi diversi al mercato nero, uno per le medicine, uno per il
carburante, uno per gli altri beni di consumo. Dentro i palazzi le liti per le
assegnazioni dei ministeri chiave, fuori dai palazzi la fame. Dopo dieci mesi è
ora la volta di Najib Mikati, nominato lo scorso dieci settembre. Uomo d’affari,
imprenditore delle telecomunicazioni, uno degli uomini più ricchi del Libano,
secondo Forbes ha dalla sua un patrimonio di quasi tre miliardi di dollari. Nel
2019, mentre in strada scoppiavano le proteste, è stato accusato di corruzione
per aver tratto profitto illegalmente da prestiti immobiliari destinati a
famiglie a basso reddito. Il caso, non sorprende, fu insabbiato. Mikati viene da
Tripoli, la città più povera del Paese, e anche questo dato è lo specchio delle
contraddizioni libanesi, è già stato due volte primo ministro, l’ultima da
giugno 2011 a maggio 2013. Fa parte di quella categoria di politici accusata dai
manifestanti di essere la causa della rovina del Paese. E i Pandora Papers lo
dimostrano, rivelando che ha ricchezze nascoste in paradisi fiscali offshore, in
un momento in cui la gente comune libanese non può accedere ai propri risparmi
bancari. Eppure un governo era necessario, perché al governo sono vincolati gli
aiuti esteri. Senza un governo in funzione non arrivano i soldi e il Libano ha
un debito di 90 miliardi di dollari. Il Libano ha chiesto aiuto al Fondo
monetario internazionale, agli Stati Uniti e alla Francia ma gli aiuti sono
condizionati all’adozione di misure di trasparenza e a un governo efficiente.
Difficile che lo sia quello di Mikati. Più facile che rappresenti una momentanea
cosmesi, che continui a garantire il vecchio sistema di potere per condurre il
Paese alle elezioni del prossimo maggio, ammesso che non vengano rinviate. Ma la
grande domanda che i cittadini si fanno è: come possono coloro che hanno causato
i problemi, che hanno sottratto risparmi ai cittadini, che hanno distrutto il
valore della moneta e messo in ginocchio l’economia, proporsi come la soluzione?
Il racconto della crisi libanese è un racconto di disuguaglianze. Il racconto di
una città che sono due. Quella dell’opulenza, e quella della gente comune, che
non ha elettricità e mangia una volta al giorno. È in quartieri come Bourj
Hammoud e Nabaa che la distanza tra questi due mondi è radicale. Nabaa è un
quartiere popoloso nella parte orientale di Beirut, è un quartiere misto, ha una
storia di convivenza e accoglienza di rifugiati nei momenti di bisogno, ci
vivono armeni, palestinesi, iracheni e siriani fuggiti dalla guerra. Decine i
negozi che hanno chiuso, botteghe, negozi alimentari. Panetterie. Quella di Abu
Ali resiste «ma ancora per poco», dice l’uomo, 63 anni, prima di infornare il
pane. Prepara i man’touch con lo zaatar, il tradizionale pane con un misto di
erbe e spezie. L’odore invade il piccolo spaccio. Ad aspettare i man’touch un
gruppo di bambini che contano le lire, ma non ne hanno abbastanza: «È così ogni
giorno, abbiamo smesso di comprare carne e verdura, presto la gente smetterà
anche di comprare il pane». Molte panetterie hanno chiuso a Nabaa perché i
negozianti non possono permettersi il diesel per alimentare i generatori di
corrente privati e le interruzioni di elettricità, in quartieri come questo,
possono arrivare a 21 ore al giorno. Quelli che rimangono aperti provano a
sopravvivere. Per decenni, il Libano ha fatto affidamento sulle importazioni di
beni essenziali come il carburante, le medicine e il cibo, beni che fino allo
scorso luglio beneficiavano di sussidi. Per affrontare la carenza di dollari tre
mesi fa il governo ha ridotto i sussidi per alcuni beni, e il costo di prodotti
di base come riso e fagioli è più che raddoppiato. Secondo un rapporto dello
scorso luglio dell’Osservatorio di crisi del Libano presso l’Università
americana di Beirut (AuB) il costo del paniere alimentare di base di una
famiglia era cinque volte il salario minimo nazionale, che ammonta a 675.000
lire libanesi al mese, che prima valevano 450 dollari al cambio ufficiale e oggi
valgono 45 dollari al mercato nero. Sulla stessa via della panetteria di Abu
Ali, Alexander, 50 anni, vende prodotti per l’igiene personale. Almeno, li
vendeva prima della crisi. Oggi nel suo negozio non entra più nessuno: «Mangiare
si deve mangiare per forza, se c’è una cosa che facilmente si può sacrificare
sono i detersivi e la carta igienica». Gli scaffali della sua bottega sono pieni
e impolverati e raccontano la fluida realtà di un Paese in cui fino a pochi mesi
fa, finché c’erano i sussidi, gli scaffali erano vuoti. Oggi che i sussidi non
ci sono più e il valore della lira continua a precipitare, gli scaffali sono
pieni perché nessuno può più permettersi nemmeno uno shampoo. Alexander ha due
figli e spera, come molti padri, che riescano a lasciare il Paese. Anche loro,
come altre seimila persone al giorno, hanno chiesto il passaporto agli uffici
della Sicurezza generale. Erano in piazza anche loro due anni fa: «La
rivoluzione del 17 ottobre la chiamavano». Usa l’imperfetto, Alexander, perché
di quella rabbia, di quella richiesta di giustizia sociale, oggi, resta solo la
voglia di scappare. Il 70 per cento dei giovani libanesi vuole lasciare il
Paese. Quelli che riusciranno si andranno ad aggiungere ai milioni delle
diaspore precedenti, quella della guerra civile conclusasi nel 1990 e quello
della guerra con Israele del 2006, diaspore che hanno portato la popolazione
libanese fuori dal Paese a essere tre volte superiore a quella interna: quindici
milioni. «Magari dall’estero manderanno un po’ di soldi e medicine», dice
Alexander, che ha ancora tremila dollari di risparmi in banca, ma può prelevarli
solo in lire e il loro valore è precipitato. Gli servono per comprare le
medicine a suo padre che soffre di ipertensione, ma nemmeno quelle si trovano
più. Nelle farmacie, mancano medicinali generici come il paracetamolo e i pochi
che ci sono vengono venduti in pillole e non a scatole. «Quando sono esauriti
nelle farmacie, puoi stare sicuro di trovarle al mercato nero», dice Alexander
che ha pagato una scatola di medicine per suo padre a 50 dollari, il
corrispettivo di uno stipendio medio locale. Nemmeno gli ospedali funzionano a
pieno regime da mesi lavorano al 50 per cento della capacità, secondo l’Oms il
40 per cento dei medici e il 30 per cento degli infermieri hanno lasciato il
Paese in modo permanente o temporaneo. È al buio anche il suo negozio, non c’è
elettricità ed è inutile comprare carburante e far funzionare il generatore in
un negozio in cui non entra più nessuno. Bussano solo le madri che hanno bisogno
di pannolini e assorbenti. Costano venti volte più dell’anno scorso. E Alexander
regala sia i pannolini che gli assorbenti: «Un giorno Dio se ne ricorderà. Ma
non farti ingannare da quartieri come questo, Beirut è sempre doppia, da una
parte la gente che ha bisogno di tutto, dall’altra la gente che può ancora
permettersi tutto», dice, prima di abbassare la serranda e andare a casa. Lungo
le curve che portano a Rouche con i suoi hotel di lusso e i ristoranti sul mare
le luci sono tutte accese, nelle abitazioni lungo la corniche l’elettricità non
manca, le famiglie passeggiano e i giovani della Beirut privilegiata, scendono
dai loro Suv per entrare nelle discoteche e nei locali intorno all’hotel
Phoenicia. Roukoz Alam, che gestisce un ristorante lungo la costa, dice che gli
affari non sono andati mai tanto bene come la scorsa estate: «Qui da noi i
prezzi erano stracciati per la crisi, non ho mai visto tanti turisti come
quest’anno, libanesi che tornavano dall’estero soprattutto». I locali come il
suo, come gli hotel lungo la costa, accettano solo pagamenti in dollari, il
costo di una stanza per notte equivale a due stipendi mensili di un cittadino
libanese. Lontano dal lungomare, i quartieri che fino a un anno fa brulicavano
di giovani sono spenti. È spenta la zona intorno a piazza dei Martiri, è spenta
Hamra. È la crisi intermittente di Beirut. Da una parte la luce, accesa, dei
pochi a cui la vita non è cambiata, delle società offshore, dall’altra le
finestre buie, la luce spenta, del novanta per cento della popolazione che non
riesce a mettere insieme il pranzo e la cena.
·
Quei
razzisti come gli iraniani.
L'Iran dà il via all'era
Raisi: attaccate 4 petroliere in Oman.
Chiara Clausi il 4 Agosto 2021
su Il Giornale. Il neopresidente si insedia ufficialmente e si presenta. Le
priorità: stop alle sanzioni Usa e lotta all'inflazione. L'ultraconservatore
Ebrahim Raisi è stato confermato ufficialmente come nuovo presidente della
Repubblica islamica iraniana dalla Guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ieri
alla cerimonia, allo spazio Hoseiniye Imam Khomeini nel centro di Teheran, hanno
partecipato i principali leader politici e militari del Paese. «Seguendo la
scelta del popolo, incarico il saggio, infaticabile, esperto e popolare Ebrahim
Raisi come presidente della Repubblica islamica dell'Iran», ha scritto Khamenei
in un decreto letto dal suo capo di gabinetto. Raisi, che fino a poco tempo fa
era a capo della magistratura, ha vinto le elezioni presidenziali lo scorso
giugno con quasi il 62 per cento dei voti. La consultazione è stata segnata però
dalla più bassa affluenza alle urne dal 1979, l'anno della Rivoluzione. Raisi
nel suo discorso inaugurale ha toccato i temi più scottanti che il Paese dovrà
affrontare. «Lavoreremo per arrivare alla revoca delle sanzioni americane,
ingiuste e oppressive, ma la vita degli iraniani non sarà legata alla volontà
degli stranieri», ha assicurato. Sul tavolo infatti c'è prima di tutto il
dossier nucleare, e poi lo scontro con Israele nella cosiddetta «guerra delle
petroliere», inasprita dopo l'attacco con un drone suicida a una nave gestita da
un miliardario israeliano, al largo dall'Oman di cui lo Stato ebraico ritiene
responsabile Teheran. Un incidente che preoccupa pure Stati Uniti e Gran
Bretagna. E ieri altre quattro navi hanno perso il controllo in questo stesso
pezzo di mare. L'equipaggio della Asphalt Princess è stato preso in ostaggio da
uomini armati, al largo di Fujairah, e la Golden Brilliant, battente bandiera di
Singapore, avrebbe colpito una mina. L'Iran è di nuovo sotto accusa, e Israele
ha chiesto il sostegno degli alleati. Ora si rischia anche un altro incidente,
ma questa volta diplomatico. Enrique Mora, il massimo rappresentante dell'Ue ai
colloqui di Vienna, dovrebbe partecipare all'inaugurazione di Raisi giovedì. Una
mossa fortemente criticata da Israele. Oltre ai problemi sullo scacchiere
internazionale esistono però anche quelli di politica interna. «La gente ha
chiesto un governo che colmi il divario tra la gente e il governo», ha precisato
Raisi, che si è impegnato anche a combattere la corruzione. Il suo discorso si è
inevitabilmente concentrato sull'economia del paese, che ha un tasso di
inflazione alle stelle di oltre il 40 per cento, un'elevata disoccupazione e un
enorme deficit di bilancio. Il neopresidente ha detto che ha già pronti i piani
per risolvere queste grane. Aveva promesso di tagliare l'inflazione, costruire
quattro milioni di case in quattro anni e creare un milione di posti di lavoro
all'anno. Come se non bastasse obiettivo di Raisi e del suo entourage è
rinforzare i legami con la Cina e la Russia e ridimensionare quelli con
l'Occidente. Ma ci sono anche altri nodi sul fronte interno: oltre alla
pandemia, le proteste per la mancanza d'acqua partite dal sud ovest ricco di
petrolio e poi dilagate in altre zone del Paese, anche a Teheran. Nel frattempo
le trattative per il ripristino dell'accordo sul nucleare sembrano in una fase
di stallo. Il sesto round di colloqui si è tenuto il 20 giugno, due giorni dopo
l'elezione di Raisi alla presidenza. Ma non è stato ancora annunciato quando
riprenderà il prossimo. Con l'uscita di scena del pragmatico Hassan Rohani
l'Iran perderà purtroppo una importante spinta alla moderazione in questi
negoziati cruciali per il futuro del paese. Chiara Clausi
Il 48% al voto, il capo della
magistratura al potere. In Iran vince Raisi ma trionfa
l’astensione, l’attacco di Israele: “Presidente-macellaio più estremista di
sempre”. Redazione su Il Riformista il 19 Giugno 2021. Con una affluenza al
volto inferiore al 50%, il conservatore Ebrahim Raisi, capo della magistratura,
e favorito del leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, è
stato eletto presidente dell’Iran con il 61,95% dei voti. La vittoria era data
per certa e già in mattinata, prima dell’ufficialità dei risultati, i rivali si
sono congratulati con Raisi. Il magistrato ha promesso che il nuovo governo farà
ogni sforzo per risolvere i problemi del Paese e in particolare i problemi del
popolo. E ha detto che si consulterà con il presidente del Parlamento iraniano e
altri esponenti politici, “per formare un governo che possa mantenere la fiducia
della gente”. Sebbene l’Ayatollah Khamenei abbia parlato di vittoria del popolo
contro la propaganda dei media occidentali, i dati hanno mostrato la bassa
partecipazione dell’elettorato. L’affluenza è stata del 48,8%, il dato più basso
della Repubblica islamica. L’elezione ha scatenato la reazione di Israele. “Dopo
che il Leader Supremo ha effettivamente dettato al pubblico iraniano chi poteva
scegliere, meno del 50% dei cittadini iraniani aventi diritto al voto ha eletto
il suo presidente più estremista fino ad oggi”, twitta il portavoce del
ministero degli Esteri israeliano Lior Haiat. Raisi è stato definito come “il
macellaio di Teheran denunciato dalla Comunità internazionale per il suo ruolo
diretto nelle esecuzioni extra giudiziali di oltre 30mila persone”. “Il nuovo
presidente dell’Iran, è un estremista responsabile della morte di migliaia di
iraniani”, ha aggiunto il ministro degli Esteri Yair Lapid, leader del partito
politico Yesh Atid, “La sua elezione dovrebbe provocare una rinnovata
determinazione a fermare immediatamente il programma nucleare iraniano e porre
fine alle sue distruttive ambizioni regionali”. L’ufficialità della vittoria di
Raisi è arrivata a metà mattinata. Il ministero dell’Interno ha annunciato che
il conservatore ha incassato 17.926.345 di voti contro i 3.412.712 dell’ex
comandante dei Pasdaran, Mohsen Rezaei, i 2.427.201 del riformista ex capo della
Banca centrale Abdolnasser Hemmati, e i 999.718 di Amirhossein Ghazizadeh
Hashemi. Hemmati è stato tra i primi a congratularsi con Raisi: “Spero che la
sua amministrazione fornisca motivi di orgoglio per la Repubblica islamica
dell’Iran, migliori l’economia e la vita per la grande nazione iraniana”, ha
scritto su Instagram. L’elezione di Raisi “promette l’istituzione di un governo
forte e popolare per risolvere i problemi del Paese”, ha scritto Rezaei su
Twitter. A congratularsi con il nuovo leader è stato anche il presidente
russo Vladimir Putin che ha espresso la speranza di un “ulteriore sviluppo di
una cooperazione bilaterale costruttiva”. Il voto si è concluso alle 2 di notte
di sabato, dopo che il governo ha esteso l’orario di apertura dei seggi per
smaltire l'”affollamento”. La televisione di Stato ha cercato di minimizzare sul
dato della bassa affluenza e ha trasmesso scene di seggi stracolmi in diverse
province, cercando di mostrare una corsa alle urne dell’ultimo minuto. Da quando
la rivoluzione del 1979 ha rovesciato lo Scià, la teocrazia iraniana ha citato
l’affluenza alle urne come segno della sua legittimità, a cominciare dal primo
referendum (che ottenne il 98,2% dei consensi) per chiedere sei i cittadini
volessero o meno una Repubblica islamica. L’elezione arriva mentre il Paese è
afflitto non solo dalla pandemia di Covid-19, ma anche da una pesante crisi
economica causata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti durante l’era dell’ex
presidente Usa Donald Trump, che si è ritirato unilateralmente dal Jcpoa. I
rapporti tra Teheran e Washington restano tesi, così come quelli con Israele.
Anche Tel Aviv ha visto un cambio dell’esecutivo con l’estromissione di Benjamin
Netanyahu dalla guida del Paese dopo 12 anni. Resta da vedere come e se
l’avvento dei nuovi leader, compreso l’arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden,
cambierà gli equilibri nella regione mediorientale.
Giordano Stabile per “La Stampa” il 20 giugno
2021. Sarà il primo presidente iraniano a entrare in carica con già sulle spalle
sanzioni americane per «crimini contro l'umanità». E un'enorme macchia nera nel
passato, le esecuzioni di massa del 1998, ordinate dall' ayatollah Khomeini alla
fine della guerra con l'Iraq ed eseguite dal «quartetto della morte». Ebrahim
Raisi era uno dei quattro giudici implacabili che mandarono al patibolo almeno
2500 oppositori. Di lì è cominciata però anche la sua scalata ai massimi
vertici, fino alla presidenza della Repubblica, conquistata venerdì con il 61,95
per cento dei voti, quasi 18 milioni di preferenze. Un successo schiacciante
rispetto agli tre candidati, che assieme hanno raccolto poco più di cinque
milioni di schede. Raisi, sessant' anni, ce l'ha fatta al secondo tentativo,
dopo la bruciante sconfitta contro Hassan Rohani, nel 2017, quando prese
soltanto il 38,3 per cento. In quattro anni tutto è cambiato. Dopo il fallimento
delle riforme economiche e degli accordi sul nucleare nel secondo mandato di
Rohani, gli oltranzisti hanno preso le redini del potere, compatti dietro la
guida suprema Ali Khamenei. I riformisti, eredi di Hashemi Rafsanjani e Khatami,
sono stati emarginati. A 43 anni dalla rivoluzione, e a 33 dalla morte di
Khomeini, la Repubblica islamica entra in una nuova fase. La personalità di
Khomeini aveva creato un bilanciamento fra oltranzisti e progressisti, ma il
lunghissimo regno di Khamenei ha finito per distruggerlo. Si marcia verso il
"partito unico dei Pasdaran" e non a caso i manifesti che invitavano ad andare
al seggio portavano l'immagine della mano mozzata e sanguinante del generale
Qassem Soleimani, ucciso dagli americani il 3 gennaio 2019: «Fatelo per lui».
All' interno di una repubblica islamica militante, Raisi si incornicia alla
perfezione. Nato a Mashhad, uno dei principali centri religiosi, in una famiglia
di chierici, ha frequentato i seminari di Qom da quando aveva quindici anni. Poi
ha sposato Jamileh Alamolhoda, figlia di Ahmad, grande imam del santuario Reza
di Mashhad. Un matrimonio destinato a far decollare la sua carriera e a
rafforzare le sue credenziali, in quanto secondo gli oppositori non ha mai
raggiunto il grado di ayatollah. Poco importa, l'appoggio di Khamenei gli ha
spianato tutte le strade, non esclusa quella della successione in futuro alla
Guida suprema. Una ricompensa anche per il lavoro sporco nell' ultima fase
dell'era Khomeini, quando il Paese era esangue dopo otto anni di conflitto con
Saddam Hussein e l'imam malato cercava in tutti i modi di salvare la
"rivoluzione". Nel luglio del 1988 arriva l'infausto ordine di giustiziare i
prigionieri politici, in gran parte Mujaheddin del popolo. Raisi è allora
viceprocuratore di Teheran e opera assieme al procuratore Morteza Eshraqi e il
capo dell'Intelligence nella famigerata prigione di Evin. Migliaia di detenuti
vengono interrogati, torturati e portati al patibolo, comprese centinaia di
donne. Per questi fatti Raisi è sotto sanzioni americane. Per questo il ministro
degli Esteri israeliano Lapid ieri ha commentato: «È un macellaio estremista».
Le esecuzioni sono un'ombra nera che si trascina da oltre tre decenni ma sul
fronte interno il nuovo leader iraniano può contare anche su molti sostenitori,
in parte ex fan di Mahmoud Ahmadinejad. Le sue promesse di lotta senza pietà
alla «corruzione» e alle «ingiustizie sociali» attirano il mondo del bazar,
soffocato dall' inflazione e dalla burocrazia. La sua prima uscita pubblica, un
incontro con il presidente uscente Rohani, è stata nel segno della moderazione:
«Spero che possiamo attuare nel miglior modo possibile la pesante responsabilità
messa sulle nostre spalle», ha dichiarato con un'aura di umiltà. Ha davanti una
montagna da scalare per conquistare la fiducia dei suoi cittadini e del mondo.
Kepel: «Poco carisma, è un vincitore che
rivela la debolezza del regime». Lorenzo Cremonesi per
il “Corriere della Sera” il 20 giugno 2021. «L'elezione di Ebrahim Raisi a
fronte di una bassa partecipazione al voto, probabilmente molto minore di quanto
annunciato ufficialmente, è rivelatrice della grande debolezza del regime
iraniano. In passato gli Ayatollah cercavano di mantenere una qualche forma di
modus vivendi pacifico con la società civile, permettendo la nomina di un
presidente moderato e riformista. Ma oggi sentono più che mai cedere il terreno
sotto i piedi, sono isolati, hanno bisogno di fare quadrato». A pochi giorni
dalla pubblicazione in Italia del suo nuovo libro, «Il ritorno del Profeta.
Perché il destino dell'Occidente si decide in Medio Oriente», Gilles Kepel
analizza le elezioni in Iran e gli ultimi sviluppi internazionali.
Ma la nomina di un presidente falco non rischia di
riaccendere gli scontri di piazza in Iran?
«Diventa molto più possibile. Raisi non ha nulla
di carismatico, nessuno dimentica le sue responsabilità nell' esecuzione di
migliaia di oppositori politici, non sarà capace di fare digerire agli iraniani
i sacrifici imposti dal radicalismo ideologico degli Ayatollah. D' altro canto,
il regime non può rischiare, non può più permettere divisioni interne. Sul
tavolo ci sono i negoziati sul nucleare con l'America di Joe Biden. Ma oggi
Teheran è a mal partito. L' Iraq sta fuggendo fuori controllo per la prima volta
dal 2003. In Siria i russi esigono una rinascita economica, che necessita di
aprire all' Europa a scapito della presenza iraniana. Il disastro libanese è
colpa degli sciiti di Hezbollah, protetti da Teheran. Persino il rapporto con
Hamas appare incrinato. Sei anni fa noi europei cercavamo la collaborazione con
l'Iran per battere Isis. Ora non serve più».
Un giudizio sull' ultimo vertice Nato?
«Biden ha un bel insistere sulla minaccia cinese,
però per noi europei i problemi maggiori continuano a venire dal mondo
islamico».
I più pressanti?
«Gli stessi degli ultimi anni. Prima di tutto,
quelli dei migranti illegali, che fanno da corollario al problema jihadista:
resta grave ed è destinato a farsi presto ancora più esplosivo. Il permanere dei
prezzi bassi del petrolio, la crisi economica tunisina, algerina, libica,
egiziana, la destabilizzazione del Sahel, sono tutti fattori che incrementeranno
i flussi delle partenze dal Mediterraneo meridionale verso le nostre coste. Mi
attendo in particolare un maggior numero di barconi dalla Tunisia. Rischiamo di
litigare tra di noi partner Ue. E ciò, se non viene regolato presto, porterà
alla crescita del peso politico delle destre e dai partiti xenofobi».
Conseguenze?
«Gli estremisti islamici e le organizzazioni
caritative dei Fratelli Musulmani approfitteranno della generosità ingenua delle
sinistre europee e dei movimenti di accoglienza cattolici per accrescere la loro
presenza nelle nostre società.
Già al vertice Ue di Ajaccio l'anno scorso avevano
prevalso gli interessi particolari. I partiti al governo in Germania temono
l'influenza di Erdogan sull' elettorato d' origine turca. L' Italia non intende
litigare con Putin per salvaguardare l'arrivo del gas e gli scambi economici.
Ognuno pensa per sé e perdiamo tutti».
C' è però un atlantismo di ritorno che aiuta a
cementare le relazioni con gli Usa.
«Certamente, con Biden si ricompatta la Nato. Ma
adesso gli interessi europei rischiano di diventare ancillari rispetto a quelli
americani. Washington sottolinea la minaccia cinese e insiste sul contenimento
di Putin. Non capisce la centralità del Mediterraneo per noi. È sufficiente
analizzare come Biden si sia ritrovato spiazzato di fronte alla recente crisi di
Gaza per vedere quanto per lui il Medio Oriente sia uno scenario secondario,
come del resto lo era per Obama e Trump».
Può spiegare?
«Gli Stati Uniti non erano pronti per mediare tra
Israele e Hamas. Tanto che Biden ha dovuto telefonare in fretta e furia ad Al
Sisi ed Erdogan, due dittatori con cui non voleva avere a che fare, se non per
denunciare le violazioni dei diritti umani. Ma alla fine sono stati loro a
garantire il cessate il fuoco».
Nel suo libro non c' è capitolo che non menzioni
quanto sia pericolosa la politica di Erdogan per l'Europa.
«Erdogan si proietta come Mehmet II, il Sultano
della conquista di Costantinopoli nel 1453. Lo si è visto benissimo a Istanbul
nella scelta della restaurazione a moschea di Santa Sofia il 24 luglio 2020. Una
mossa simbolica: Erdogan diventa una sorta di Ataturk nazionalista e però
religioso, un Sultano allo stesso tempo del suo popolo e di tutto l'Islam, che
mira a ricostruire l'antica potenza imperiale, sino alle porte di Vienna».
Il 23 luglio a Berlino si tiene una nuova
conferenza sulla Libia. Cosa cambia?
«Per fortuna Italia e Francia abbandonano le
vecchie lotte suicide e decidono di agire assieme. Sino a poco fa proprio
Turchia e Russia avevano approfittato del nostro braccio di ferro per dividersi
il Paese. Berlino potrebbe diventare il simbolo di una nuova politica europea
comunitaria. Dobbiamo sperarlo. La cooperazione italo-francese potrebbe
garantire una Libia unita sotto la guida del nuovo premier Abdul Hamid, Abdul
Hamid Dabaiba».
Anna Guaita per “il Messaggero” il 20 giugno 2021.
L'accordo sul nucleare si farà, e presto, ma non bisogna sperare in altro, con
il nuovo presidente iraniano. Il Messaggero parla a Aaron David Miller sul
risultato delle presidenziali in Iran. Miller è stato consigliere delle
Amministrazioni Usa sul Medio Oriente per 25 anni. E' stato al fianco di sei
segretari di Stato, sia democratici che repubblicani, e di recente è diventato
vicepresidente del think tank Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Che significato ha la vittoria di Ebrahim Raisi in
politica estera?
«Stiamo assistendo a una concentrazione del potere
non solo nelle mani del leader supremo, ma in quelle di una forza militare in
crescita veloce e dell'intelligence. Questa concentrazione fa sì che un nuovo
presidente non avrà una ricaduta sensibile sulla politica estera».
La traiettoria non cambia?
«La protezione del regime rimane la principale
filosofia della politica di Teheran. Vedremo che la repressione del dissenso
aumenterà, e il dissenso chiaramente esiste come ci prova l'affluenza alle urne
così bassa. In politica estera vedremo che l'Iran continuerà a gettare la sua
ombra sull' area, dal Libano all' Iraq alla Siria».
E cosa succede della riconferma dell'accordo sul
nucleare che è in fase di negoziato a Vienna?
«Sono persuaso che il rientro nell' accordo
avverrà nelle prossime settimane. Ma questa nozione che qualcuno ha nel mondo
diplomatico che dopo la riconferma del Joint Comprehensive Plan of Action,
l'Iran sarà più mite e amichevole nei confronti degli Stati Uniti è del tutto
infondata».
Non pensa che ci sarà un ulteriore negoziato, per
un accordo più duraturo e più forte come spera Biden?
«Un negoziato può avvenire, possono sedersi a un
tavolo, ma se speriamo in ulteriori concessioni dobbiamo essere pronti a farne
anche noi. Ci chiederanno di sicuro qualcosa in cambio. Magari di tornare a
commerciare direttamente con noi, di cancellare l'embargo commerciale, qualcosa
di politicamente impossibile. Ma non c' è da illudersi su ipotetici futuri
negoziati. Gli iraniani vogliono solo ritornare all' accordo sul nucleare perché
così verranno cancellate le sanzioni che strangolano la loro economia».
Come vede il futuro fra l'Iran e il mondo
occidentale?
«Guardi, è vero che l'accordo sul nucleare è lungi
dall' essere perfetto. È vero che anche quando sarà rifirmato, qui negli Usa
nessuno stapperà lo champagne. È vero che i repubblicani lo odiano e anche molti
democratici non lo amano. Ma non possiamo non ammettere che è il meglio che si
può ottenere ora, se non vogliamo che fra due anni Teheran abbia la prima bomba
nucleare. Stiamo guadagnando tempo. Non è la soluzione ideale, ma per ora noi in
Occidente dobbiamo accontentarci. Senza questo accordo, non avremmo nessun modo
per impedire che l'Iran costruisca armi nucleari».
Intanto cosa ci si aspetta in questo tempo così
guadagnato, che quel 52% che si è astenuto, riesca a organizzare un'opposizione?
«Non c' è un'opposizione organizzata adesso in
Iran. Certo, ci sono state proteste e manifestazioni. Ma io penso che avremo un
Iran autoritario ancora per un lungo tempo. Ma sempre più disposto ad aprire
l'economia».
Cioè un Iran sul modello cinese?
«Sì, esatto. Tutti questi poteri autoritari, dalla
Cina a Cuba alla Russia hanno dimostrato disponibilità ad aprire l'economia al
mondo, pur mentre all' interno seguono una politica repressiva».
Non crede nella possibilità di una rivoluzione?
Dopotutto ne hanno già fatta una!
«Ma anche tutte le rivoluzioni della primavera
araba, le rivoluzioni dal basso, sono finite con regimi autoritari con
l'eccezione della Tunisia. I poteri autoritari durano a lungo, si aggiustano, si
adattano, adesso in Iran i poteri forti sono più uniti che mai».
Lei è molto pessimista.
«E' la realtà. E tuttavia penso che se Rouahni
avesse potuto ripresentarsi, chissà... Se non ci fosse stata l'interferenza del
leader supremo e delle Guardie della Rivoluzione, forse l'uomo che aveva
impersonato le speranze e le aspirazioni di milioni di iraniani sarebbe stato
rieletto. Invece abbiamo un autoritario, che sbloccherà l'accordo sul nucleare e
quindi le sanzioni, e così farà credere che solo gli autoritari possono avere
successo. E in parte dobbiamo ringraziarne Trump, la sua uscita dall' accordo e
l'imposizione di sanzioni che hanno prostrato il Paese, senza ottenere nulla in
cambio».
Fiamma Nirenstein per “il
Giornale” il 12 aprile 2021. Un «incidente» a Natanz, centrale nucleare
iraniana, sempre in primo piano, già investita nel luglio scorso da una
misteriosa esplosione, ha fermato proprio il giorno dopo l'inaugurazione le
nuove, bellissime, centrifughe di ultima generazione, proibite dall'accordo
Jcpoa stretto nel 2015. Sabato scorso il presidente Rouhani aveva annunciato che
l'Iran aveva iniziato a iniettare l'uranio in forma di gas hexafluoride nelle
centrifughe di Natanz IR-6 e IR-5. Una tecnica molto avanzata e veloce, fuori
delle norme, usando la quale (oltre forse ad altri sistemi) «in meno di quattro
mesi» come aveva annunciato Behrouz Kamalvandi, il portavoce della AEOI
l'Organizzazione Atomica Iraniana, qualche giorno prima, «abbiamo prodotto 55
chili di uranio arricchito al 20 per cento, e in meno di otto mesi possiamo
raggiungere i 120 chili». Passi evidenti sulla strada della bomba atomica
nonostante una beffarda assicurazione che si tratta di strutture civili, minacce
palesi proprio mentre il presidente Hassan Rouhani di ritorno dagli Usa,
riferendosi al summit di Vienna si era vantato che «tutte le parti del patto
nucleare hanno concluso che non c'è nessuna conclusione migliore del Jcpoa e che
non c'è nessuna altra strada che la sua totale realizzazione». Una sfida, per
altro in questi giorni riportata dai mallevadori europei (per ora Iran e Usa non
si incontrano direttamente) ai due maggiori interlocutori, che risulta evidente:
per noi, dice l'Iran, il blocco immediato delle sanzioni, anche di quelle non
legate all'arricchimento atomico (per esempio quelle sui diritti umani, o
sull'assalto balistico al Medio Oriente) per voi la ripresa del patto da cui
Trump ha ritirato gli Usa nel 2018. Un patto che non ha mai garantito che l'Iran
rinunciasse ai suoi fini atomici e bellici, oltre a restare inchiodata alla sua
totale violazione dei diritti umani. La centrale ha subito «un'interruzione
dell'elettricità»: qui non si tratta di impianti che si fermano tagliando un
filo o toccando un interruttore. Il blocco è complesso, e arresta processi
superveloci e protetti, il cui «stop» comporta un danno consistente e perdurante
nel tempo. È dunque una delle tante imprese che si sospettano compiute dalla
mano del Mossad (ieri il canale 13 della TV israeliana ha parlato di una fonte
occidentale attendibile) nel cuore del regime degli Ayatollah e fra i ranghi
delle Guardie della Rivoluzione. La lista è infinita e impressionante;
l'eliminazione del capo del sistema atomico Fahrizadeh; l'asporto degli archivi
atomici per cui l'Iran seguitava a costruire la bomba dopo l'accordo; attacchi
alle centrali; scontri navali fra cui l'attacco nel Mar Rosso di un cargo
«Saviz», una piattaforma logistica di supporto delle Guardie della Rivoluzione
per le guerre mediorentali; innumerevoli operazioni dal cielo, nelle acque, per
bloccare il rifornimento e la costruzione iraniani di armi ai suoi «proxy» in
Siria, Hezbollah, libanesi e iracheni e a Hamas. Ieri pomeriggio è giunto in
Israele il segretario alla difesa americano Lloyd Austin, un amichevole e severo
gigante. Devono essere state dette parole significative: l'attacco a Natanz
segnala parecchie cose per l'agenda americana. Per esempio, che pare che Israele
abbia una struttura di intervento a Teheran molto robusta, e non consentirà di
distruggerla al Paese che ha giurato con intento ideologico profondo e sincero.
L'Iran, gli Usa lo sanno, tesse le sue tele anche con la Cina e gli Stati
dell'Asia Centrale. Zarif si è appena fatto un bel giro da quelle parti. Anche
gli Ayatollah, che hanno definito «un attacco terroristico» quello di Natanz,
lanciano le loro minacce agli Usa di Biden. Tempi di scelte difficili.
Iran: l'intelligence
israeliana manda in tilt il sito di Natanz.
Piccole Note il 12 aprile 2021 su Il Giornale.
L’intelligence israeliana ha messo a
segno un attacco all’impianto nucleare di Natanz, nel cuore dell’Iran. Non ha
rivendicato ufficialmente, come al solito, ma i media israeliani e
internazionali non nutrono dubbi in proposito. A essere colpite sono state le
centrifughe usate per arricchire l’uranio, con grave rischio di una fuoriuscita
di materiale radioattivo, per fortuna evitata. Teheran, a differenza di quanto
avvenuto per l’attacco a una sua petroliera avvenuto nei giorni scorsi, non può
derubricare la cosa a questione secondaria. Non può esimersi, cioè, dal
denunciare ad alta voce l’attacco, dato l’obiettivo sensibile e il disastro che
poteva procurare: una fuga radioattiva, peraltro, avrebbe inevitabilmente
provocato una risposta militare. La guerra segreta che si sta consumando in
Medio oriente sta prendendo pieghe sempre più rischiose, né si vede come possa
essere frenata. I media israeliani non possono non elogiare il grande successo
militare della loro intelligence, che avrebbe conseguito il risultato di
ritardare di nove mesi lo sviluppo della bomba atomica iraniana. Ma il vero
obiettivo dell’attacco, al solito, non è tanto il nucleare iraniano, ma i
cruciali colloqui su questo tema avviati la scorsa settimana a Vienna, dove Iran
e Stati Uniti hanno fatto i primi passi per ripristinare l’accordo sull’atomica
iraniana. Colloqui indiretti, cioè mediati dall’Europa, ma che avevano dato
frutti, come da ammissione di entrambe le parti. L’attacco a Natanz, in questo
senso, è esploso come una bomba sotto il tavolo dei negoziati, che riprenderanno
a breve. Lo scrive il New York Times che, nel riferire l’accaduto, spiega che i
colloqui di Vienna non sono affatto facili, e dopo l’attacco “potrebbero essere
diventati ancora più difficili”. Per tre motivi. Anzitutto perché alimentando le
tensioni tra Tel Aviv e Teheran si allargano anche le distanze tra quest’ultima
e Washington, stretta alleata di Israele. In secondo luogo perché rende più
fragile l’ala moderata degli iraniani, quella interessata a negoziare, incalzata
dai duri e puri che ritengono del tutto inutile trattare con una controparte
sulla quale non si può fare alcun affidamento. Il terzo motivo è che l’Iran,
dopo l’uscita di Washington dal trattato, aveva iniziato ad arricchire uranio
per far pressione sull’America, per costringerla al dialogo. Tale arricchimento,
cioè, più che una questione militare ha uno scopo politico: è una leva per
costringere Washington a trattare (peraltro, usata anche da Washington per
spiegare ai suoi riluttanti alleati che il negoziato è l’unica via di uscita da
questo incubo). “L’analista della Difesa di Channel 13 Alon Ben-David – scrive
sul punto il Timesofisrael – ha affermato che il danno a Natanz potrebbe minare
la leva dell’Iran nei colloqui con gli Stati Uniti”. L’attacco, se vero che ha
ritardato lo sviluppo della bomba atomica di nove mesi, toglie anzitutto quella
leva, ma indica anche che per evitare l’atomica iraniana si può percorrere anche
un’altra strada, quella militare. Per questo, invece, le autorità iraniane hanno
affermato che il danno sarà riparato a breve, anzi al posto delle vecchie
centrifughe ne metteranno altre di nuova generazione, in grado di velocizzare
l’arricchimento (Tansim). Importanti, da questo punto di vista, le parole del
ministro degli Esteri Javad Zarif: “Pensano che raggiungeranno il loro
obiettivo. Ma i sionisti otterranno come risposta [al loro attacco] un
incremento dello sviluppo del nucleare”. “L’Iran – ha aggiunto – non cadrà nella
trappola che gli è stata tesa, ritirandosi dai colloqui che potrebbero
ottenergli la revoca delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti” (al
Jazeera). Ma quanti hanno in mente l’idea di sabotare i colloqui, in America
come in Israele, hanno dalla loro il tempo. La strategia è alquanto chiara:
rendere il dialogo infruttuoso, ponendo condizioni che Teheran non può
accettare, come ad esempio chiedere che smetta di arricchire sic et simpliciter
l’uranio prima di revocare le sanzioni o che essa rinunci, in tutto o in gran
parte, al suo programma missilistico. E più il dialogo va per le lunghe, più c’è
tempo per sabotarlo, sia reiterando azioni militari, sia alimentando
l’opposizione politica allo stesso, in America come in Iran, sia, infine,
aggiungendo nuove condizioni inaccettabili. Non solo, tra nove mesi a Teheran si
terranno le elezioni: se l’accordo non sarà chiuso entro tale scadenza, i
moderati rischiano di soccombere agli intransigenti; e con Teheran in mano ai
falchi non ci sarà più spazio per un dialogo e la parola passerà alle armi.
Sempre che ciò non accada prima. “L’analista della Difesa di Channel 12 Ehud
Ya’ari – scrive, infatti, Timesofisrael – ha affermato che, a causa delle fughe
di notizie del Mossad sui media ebraici, nelle quali [l’intelligence] si assume
la paternità dell’incidente di Natanz, "Ci stiamo avvicinando al momento" in cui
Teheran non avrà altra scelta che rispondere con un attacco militare”.
Allo stesso tempo, Ya’ari fa
notare che queste operazioni non hanno avuto alcun impatto sullo sviluppo
dell’atomica di Teheran, infatti, “nonostante le varie battute d’arresto
attribuite a Israele, l’Iran ha continuato a fare progressi con il suo programma
nucleare”. Ciò vuol dire che in realtà non esiste una via militare per frenare
tale sviluppo che non sia una guerra aperta. Guerra che non vedrebbe coinvolta
la sola Israele, dato che dovrebbe intervenire giocoforza anche l’America, con
quel che ne consegue per la pace del mondo.
Il caso in Iran. La brutalità della
Qisas, la legge del taglione: 19enne aiuta il boia a giustiziare la madre.
Valerio Fioravanti su Il Riformista il 19 Marzo 2021.
In Iran una ragazza di 19 anni ha “partecipato
attivamente” all’impiccagione della madre. La notizia risulta talmente stridente
da meritare un approfondimento. La storia è stata pubblicata il 15 marzo da Iran
Human Rights, una Ong che per comprensibili motivi di sicurezza non identifica
mai i propri corrispondenti, ma asserisce di pubblicare le notizie provenienti
dall’Iran solo dopo averne ricevuto conferma da almeno due fonti diverse. Quindi
sì, è molto verosimile che una giovane donna, Maryam Karimi, sia stata impiccata
il 13 marzo nella prigione di Rasht, e che la figlia abbia partecipato
attivamente all’esecuzione. Così IHR ha ricostruito la vicenda: «Maryam Karimi
era accusata di aver ucciso il marito, un uomo violento, che abusava di lei, e
che non voleva concederle il divorzio. Il padre della donna, Ebrahimi
Karimi, che non aveva altro modo per salvare la figlia, l’aveva aiutata
nell’omicidio». Entrambi vennero condannati a morte 13 anni fa. All’epoca i
coniugi avevano una figlia di 6 anni, alla quale era stato detto che tutt’e due
i genitori erano morti. Poche settimane fa, per prepararla psicologicamente
all’esecuzione, alla giovane è stata detta la verità. Dopo l’esecuzione della
figlia, Ebrahimi Karimi è stato portato al patibolo perché potesse vederla
penzolare, ma poi, per motivi che la fonte non è stata in grado di specificare,
è stato riportato in isolamento, e non giustiziato a sua volta. Sembra anzi che
nell’arco delle prossime 48 ora verrà tolto dall’isolamento e riportato al
reparto “normale”. L’Iran, come è noto, ha modellato il proprio codice
penale sull’interpretazione sciita del Corano. I reati di sangue sono normati
dal concetto di “Qisas”, termine che in Occidente viene tradotto come
“restituzione dello stesso tipo” oppure, più colloquialmente, “legge del
taglione”. La famiglia della vittima può richiedere “qisas”, oppure può
concedere il proprio “perdono”. A volte il perdono è gratuito, quasi sempre fa
seguito ad un risarcimento, detto “diya”, che letteralmente sarebbe “prezzo del
sangue”. Le trattative economiche per il “prezzo del sangue” generano a volte
delle “esecuzioni abortite”: il condannato viene sottoposto a tutti i
preparativi per l’esecuzione, compreso l’ultimo colloquio con i familiari, e
all’alba viene portato al patibolo, e gli viene infilato il collo nel cappio. A
quel punto il direttore del carcere annuncia che sono in corso ulteriori
trattative, e l’esecuzione viene sospesa. Sono riportati casi di persone che
hanno subito queste “esecuzioni abortite” anche più di una volta. Se l’accordo
viene raggiunto, il condannato lascia il braccio della morte, e in alcuni casi
viene anche scarcerato. Altrimenti i parenti delle vittime vengono sollecitati a
compiere loro stessi alcune delle manovre relative all’impiccagione. Nei
resoconti delle esecuzioni capita di leggere che il “parente” ha scalciato
personalmente lo sgabello da sotto le gambe del giustiziando. Questo
coinvolgimento delle “vittime”, nella sensibilità contemporanea, appare molto
controverso. Lo stesso IHR, che da 5 anni edita un rapporto annuale
sul “perdono” ha un atteggiamento ambivalente. Nell’ultima edizione (2020)
notava con favore che per ogni 2 esecuzioni effettuate, 3 erano state annullate
grazie al “perdono”, e che la tendenza a perdonare sta crescendo al ritmo del
10% l’anno. Il direttore di IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, però, commentando
l’esecuzione di Maryam, ha messo in luce anche l’altra faccia della medaglia:
«Le leggi della Repubblica islamica fanno di una ragazza il cui padre è stato
ucciso quando era bambina, la carnefice di sua madre. La Repubblica Islamica è
oggi il principale promotore della violenza all’interno della società iraniana.
Porre la responsabilità dell’esecuzione sulle spalle dei parenti delle vittime
favorisce il perpetuarsi di ulteriori violenze e crudeltà». Noi europei, con il
nostro “stato di diritto”, ci sentiamo molto lontani dal meccanismo tribale
iraniano che assegna potere di vita o di morte al privato cittadino. Eppure, ci
si passi la lettura paradossale, forse tra le nostre culture c’è un punto di
contatto. La ministra Cartabia sta proponendo l’introduzione della “giustizia
riparativa” nei nostri codici. Sarebbe una misura altamente innovativa. Speriamo
ci riesca, così anche in Italia la parte lesa, se si riterrà soddisfatta dal
percorso riabilitativo del reo, potrà aiutarlo ad ottenere uno sconto di pena.
Come dire, la parte buona del Qisas. A volte il progresso segue percorsi ben
strani.
DAGONEWS il 12 marzo 2021. Due producer collegati
a un cantante pop iraniano residente in California sono stati arrestati dopo che
nel video musicale compare un’attrice porno. Il cantante Sasy, 32 anni, il cui
vero nome è Sasan Yafteh, ha pubblicato il video musicale della sua canzone
"Tehran Tokyo" al quale partecipa l'attrice di film per adulti Alexis Texas.
Texas inizia il video indossando abiti tradizionali, incluso un velo, per poi
iniziare a spogliarsi restando con un costume nero mentre balla con Sasy. Anche
se non ci sono contenuti espliciti nel video, i sostenitori della linea dura
temono che il video possa “traviare” i giovani. E ora, le forze di sicurezza
iraniane hanno arrestato i fratelli Mohsen e Behrouz Manouchehri, i producer che
hanno lavorato alla canzone nella città meridionale di Shiraz, ha rivelato Rafe
Rafahi, il manager di Sasy Farshid. I fratelli Manouchehri devono ora affrontare
un processo penale a Teheran. Reagendo all'arresto, Rafahi, CEO di EMH
Productions con sede a Los Angeles, ha detto del video: «È piuttosto folle.
Alexis Texas balla come qualsiasi persona in un normale video musicale, non sta
facendo nulla di inappropriato in queste scene. La missione di Sasy non è creare
scompiglio, è rendere felici le persone».
Da huffingtonpost.it il 19 febbraio 2021. Un
appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l’impegno e la passione che
negli anni l’hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all’ultimo
momento il sogno di Samira Zargari, commissaria tecnica della nazionale iraniana
di sci alpino femminile, si è infranto davanti a una legge che ha permesso al
marito di impedirle di lasciare l’Iran per guidare le sue atlete ai Mondiali di
Cortina. La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato ieri l’Iran alla
volta dell’Italia, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. “Fino
all’ultimo - ha fatto sapere la Federsci iraniana - abbiamo cercato di trovare
una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare le
sciatrici è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnica della
Federazione. Ancora una volta, dunque, in Iran le vicende sportive si
intrecciano con quelle politiche, e in particolare con la condizione delle donne
e le loro faticose lotte per l’emancipazione. In base alla legge della
Repubblica islamica, per ottenere il passaporto una donna ha bisogno del
permesso del marito, ma quando anche sia in possesso del documento di espatrio
lo stesso marito può impedirle di lasciare il Paese di volta in volta. E in
passato ciò è già successo ad altre protagoniste della scena sportiva iraniana.
Il caso più clamoroso fu, nel 2015, quello di Niloufar Ardalan, capitana della
nazionale di calcetto, alla quale il marito, un giornalista sportivo, aveva
vietato di partire per partecipare ai Mondiali in Guatemala dopo una lite. La
vicenda provocò una tale ondata di proteste che le autorità dovettero
intervenire e un giudice concesse alla calciatrice il permesso di lasciare il
Paese, annullando il veto del coniuge. Non prima, tuttavia, che la stessa atleta
prendesse apertamente posizione contro la legge vigente in un post su Instagram.
Le proteste contro le normative che limitano i diritti delle donne in Iran
prendono spesso spunto da vicende sportive. Come nel caso della tragica vicenda
di Sahar Khodayari, la trentenne che nel 2019 si suicidò con il fuoco per
protestare contro il divieto alle donne di entrare allo stadio. La vicenda di
quella che i social media ribattezzarono ‘la ragazza in blu’ - dal colore
dell’Esteghlal, la sua squadra del cuore, a quel tempo allenata da Andrea
Stramaccioni - provocò un’ondata di emozione senza precedenti nel Paese. E anche
in quell’occasione le autorità furono costrette ad un compromesso, lasciando
entrare per una partita della nazionale con la Cambogia 3.500 donne in settori
separati delle gradinate dello stadio Azadi di Teheran, che ha una capienza di
quasi 80.000.
Guido Olimpio per il “Corriere della Sera” il 5
febbraio 2021. Un messaggio giudiziario e politico a Teheran. C' è questo nella
sentenza per Assadollah Assadi, diplomatico iraniano condannato a 20 anni di
prigione. Un tribunale belga lo ha riconosciuto colpevole di aver progettato un
attentato contro una manifestazione di esuli a Parigi, nell' estate del 2018.
Terzo segretario all' ambasciata iraniana a Vienna, dove arriva nel 2014, il
funzionario è ritenuto il responsabile della rete europea del Dipartimento 312,
entità dei servizi di intelligence. Per questo si sposta in tutto il continente
per allacciare rapporti e reclutare elementi, compresa una coppia che vive da
tempo in Belgio, Amir Saadouni e la moglie Nasimeh Naami. È a loro che Assadi,
nome in codice Daniel, consegna un ordigno in un fast food del Lussemburgo, una
bomba che deve essere innescata durante un evento nella capitale francese. Il
meeting è organizzato dal Consiglio per la Resistenza iraniana e sono attesi
rappresentanti stranieri, tra questi Rudy Giuliani, Newt Gingrich. L'
operazione, però, è stoppata dall' intervento della polizia belga che, il 30
giugno 2018, blocca i due attentatori dopo una soffiata. Assadi invece è
fermato, con la famiglia, in Germania. Le indagini sono ampie, condotte da
Germania, Belgio, Austria, Francia. Gli inquirenti hanno ricostruito tutti i
movimenti di «Daniel», lavoro favorito anche dalla documentazione sequestrata.
In particolare un taccuino verde, dove la spia ha annotato appuntamenti,
trasferte, spese, e il Gps delle auto utilizzate. Dalle carte processuali
risulta che ha visitato 289 località in undici Paesi diversi. Nella lista appare
anche l' Italia - 13 volte - con tappe a Milano e Venezia. Assadi somiglia più a
Pollicino che a 007. L'enorme massa di indizi solleva dubbi sulla sua
professionalità, un funzionario che peraltro aveva già operato in zone
difficili, come l' Iraq. E alimenta tesi alternative, con trappole e
provocazioni. Ma è anche possibile che «Daniel» sia rimasto incastrato dal suo
stesso network. Sapevano chi era fin dal primo giorno che ha messo piede a
Vienna, lo hanno lasciato fare per «vedere» i suoi contatti. Magari si è fidato
delle sue «reclute» - qualcuno ha fatto il doppio gioco? - e quando è apparsa la
bomba lo hanno fermato. Avevano le prove per istruire un processo clamoroso ad
Anversa negando al funzionario lo scudo dell' immunità diplomatica. Quindi il
verdetto, pesante anche per i tre complici che dovranno scontare dai 15 ai 18
anni. La condanna di Assadi racchiude molti aspetti. Primo. Chiama in causa
direttamente l' Iran, i suoi apparati (Bruxelles lo ha indicato in modo netto).
Secondo. Mette in guardia Teheran sulle conseguenze di attività clandestine:
negli ultimi anni in Olanda, Danimarca e Turchia si sono verificati attacchi nei
confronti di oppositori iraniani. Terzo. La magistratura non si è fatta
intimorire dalle minacce di ritorsioni, messaggi «trasmessi» dallo stesso
imputato. Quarto. La vicenda fornisce munizioni a quanti chiedono che Joe Biden
non riapra il dialogo con Teheran. Davanti agli addebiti la Repubblica islamica
ha parlato di atto illegale, di una manovra creata dagli avversari per mettere
in difficoltà il presidente Rouhani. Ma ha anche pensato al dopo rastrellando
diversi iraniani con la doppia cittadinanza: messi in prigione con vari
pretesti, rischiano di restare a lungo in cella oppure la sentenza capitale.
Sono degli ostaggi - tra loro anche Ahmadreza Djalali, ricercatore che aveva
lavorato in Italia - da usare in uno scambio per riavere Assadi. Baratti
contestati dalle associazioni umanitarie in quanto convalidano accuse
fabbricate, ma è anche vero che sono il modo per evitare che un innocente
finisca sul patibolo.
L’Iran è la nuova base di Al Qaeda?
Francesca Salvatore su Inside Over il 14 gennaio 2021. L’Iran sarebbe il “nuovo
Afghanistan” secondo il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. A conferma di
questo, l’uccisione, il 7 agosto scorso, del n.2 di Al Qaeda Abdullah Ahmed
Abdullah, accusato di essere una delle menti degli attacchi mortali del 1998
contro le ambasciate americane in Africa e meglio noto con il nome di
battaglia Abu Muhammad al-Masri. Il terrorista è stato ucciso in quel di Teheran
insieme a sua figlia, Miriam, la vedova del figlio di Osama bin Laden, Hamza bin
Laden.
L’omicidio di al-Masri. Da subito, l’uccisione di
al-Masri era stata avvolta dal mistero. Nell’immediato, Al Qaeda non ne aveva
annunciato la morte, tantomeno l’intelligence iraniana. A lungo inserito
nella lista dei most wanted terrorist dell’FBI, era stato incriminato negli
Stati Uniti per crimini legati ai bombardamenti delle ambasciate statunitensi in
Kenya e Tanzania: i federali avevano posto sulla sua testa una taglia da 10
milioni di dollari. Secondo le fonti americane, al-Masri (nato ad Al Gharbiya,
in Egitto) era sotto protezione dell’Iran dal 2003, ma almeno dal 2015 viveva
liberamente nel quartiere dei Pasdaran di Teheran. Nell’immediato, il governo
iraniano aveva negato l’uccisione. Anzi, i media iraniani, pochi giorni dopo la
sparatoria, riferirono l’uccisione di un misterioso docente libanese
(identificato come ‘Habib Daoud’) e di sua figlia, mentre i social media legati
ai Guardiani della Rivoluzione riferirono dell’uccisione di un militante del
movimento sciita Hezbollah. Washington, invece, credette fin da subito che Habib
Daoud fosse la copertura assegnata ad al-Masri nella Repubblica Islamica.
Le dichiarazioni di Pompeo. Secondo Pompeo i
legami tra Teheran e al-Qaeda hanno iniziato a cementarsi notevolmente nel 2015,
quando l’amministrazione Obama, insieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, era
alle prese con il Jcpoa. L’Iran governato dagli sciiti e Al Qaeda
prevalentemente sunnita sono stati a lungo considerati nemici nella regione e,
sebbene siano stati segnalati agenti qaedisti che utilizzano il territorio
iraniano, le affermazioni di un maggiore coordinamento sono state
precedentemente accolte con scetticismo all’interno sia dell’intelligence che
del Congresso. Le accuse del Segretario di Stato uscente sono state mal digerite
dal ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, che ha prontamente
accusato Pompeo di “bugie guerrafondaie” in un tweet. In questo c’è il timore
fondato che il governo degli Stati Uniti possa utilizzare questa presunzione per
condurre un’escalation ai danni del governo iraniano sotto altre forme: ai sensi
della legislazione statunitense, l’autorizzazione all’uso della forza militare
dal 2001 consente alle forze statunitensi di perseguire Al Qaeda ovunque nel
mondo. Una mossa che l’amministrazione Trump, anche nelle ultime battute del suo
mandato, avrebbe potuto utilizzare per lasciare un’impronta nella regione:
tuttavia, gli eventi degli ultimi giorni rendono questa opzione pressoché
impossibile. Sono in molti, inoltre, nell’establishment attuale di Washington e
in numerosi think tank, a credere che questa ipotesi sia poco plausibile: ciò
che non convince è la tempistica con la quale Pompeo avrebbe fatto le sue
rivelazioni. Nello stesso discorso, inoltre, Pompeo si è spinto oltre,
annunciando una ricompensa di 7 milioni di dollari per chiunque abbia
informazioni su un membro di Al Qaeda che si crede sia in Iran, identificato
come Muhammad Abbatay o come Abd al-Rahman al-Maghrebi.
Cosa sappiamo sui due “frenemies”. Esistono prove,
al netto dell’uccisione di al-Masri, a sostegno di quanto dichiarato da Pompeo?
In parte sì. Nel gennaio del 2017 la direzione della National
Intelligence americana annunciò la pubblicazione su internet dell’ultima parte
dei documenti trovati nel covo di Osama bin Laden ad Abbottabad, in Pakistan,
nel 2010. L’amministrazione Obama aveva già declassificato e rilasciato alcuni
dei Bin Laden files che evidenziavano abbastanza chiaramente le tensioni tra
Iran e Al Qaeda, mantenendo invece classificati tutti quelli che potessero
compromettere gli accordi sul nucleare. L’ulteriore declassificazione, invece,
aveva portato a galla altri documenti che provavano, tra le altre cose, propri i
legami cooperativi tra Al Qaeda e l’Iran. Alcuni dettagli erano cose ben
risapute, come il fatto che il governo iraniano, dopo l’attacco americano in
Afghanistan, dette rifugio ai capi di Al Qaeda in fuga e aiutò il gruppo a
ricostituirsi in barba all’atavica frattura tra sunniti e sciiti. Tra i vari
file un documento di 19 pagine che contiene le osservazioni valutazione di un
alto jihadista sulle relazioni del gruppo con l’Iran. L’autore spiega che l’Iran
ha offerto ad alcuni “fratelli sauditi” “tutto ciò di cui avevano bisogno”,
inclusi “soldi, armi” e “addestramento nei campi di Hezbollah in Libano, in
cambio di interessi americani in Arabia Saudita e nel Golfo”.
L’intelligence iraniana avrebbe, inoltre, facilitato il viaggio di alcuni agenti
attraverso l’elargizione generosa di visti, mentre ne proteggeva altri. Abu Hafs
al-Mauritani, un influente ideologo qaedista, prima dell’11 settembre, avrebbe
contribuito, ad esempio, a negoziare un rifugio sicuro per i suoi compagni
jihadisti all’interno dell’Iran. I file mostrano anche come le due parti abbiano
avuto accesi disaccordi in passato: ciononostante, lo stesso bin Laden avrebbe
invitato alla cautela quando si trattava di minacciare l’Iran. In una lettera
precedentemente rilasciata, avrebbe descritto il Paese proprio come “la
principale arteria di Al Qaeda per i fondi, il personale e le comunicazioni”.
·
Quei razzisti come gli emiratini.
Vincenzo Nigro per repubblica.it il 27 giugno
2021. Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso la data dello sfratto. Entro il 2
luglio i militari e i materiali della Difesa italiana dovranno lasciare
l'aeroporto di Al Minhad, la base avanzata nel Golfo Persico utilizzata dal 2003
innanzitutto per trasferire uomini e materiali in Afghanistan, ma capace anche
di svolgere un ruolo per le missioni in Kuwait e in Iraq. È l'emiro in persona,
il principe Mohammed Bin Zayed, ad aver deciso ormai da mesi una linea sempre
più aggressiva diplomaticamente contro l'Italia. "Mbz" risponde a una delle
ultime decisioni del governo Conte, quando a fine gennaio per rispondere alle
pressioni della parte più massimalista dei 5Stelle il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio congelò le licenze (già regolarmente concesse) all'esportazione di
circa ventimila bombe da aereo agli Emirati e anche all'Arabia Saudita. Di Maio
e Conte accoglievano l'appello di una campagna a favore di un embargo contro i
paesi che combattono nello Yemen. Con il particolare non insignificante che
ormai da quasi 2 anni gli Emirati non combattono più contro i ribelli houthi
nello Yemen. E gli stessi sauditi hanno iniziato ad adottare profili di impiego
degli aerei che causano molte vittime in meno fra i civili. La durissima
irritazione del principe emiratino venne rafforzata dal fatto che, in maniera
incomprensibile, il ministero degli Esteri congelò anche contratti e fornitura
di materiali per gli aerei delle "frecce tricolori" degli Emirati, che giarda
caso cono gli MB 339 di Leonardo simili a quelli della pattuglia italiana. Quei
velivoli devono essere ammodernati con un contratto di 70 milioni di euro, ma
alla "Unità di Autorizzazione di Armamento Militare" della Farnesina è stato
ordinato di bloccare anche quei contratti. La reazione di Mbz è stata quella di
cancellare contratti italiani anche nel settore civile, e di iniziare a lanciare
anche una serie di punture di spillo. La prima è stata il blocco dell'aereo
Boeing che all'inizio di giugno trasportava in Afghanistan un gruppo di
giornalisti che seguiva il ministro Guerini. Al Boeing venne negato il diritto
di sorvolo degli Emirati, un permesso detto "diplocleareance" che era già stato
concesso all'Aeronautica militare. Adesso arriva la chiusura della base di Al
Minhad: l'accesso a quell'aeroporto vicino ad Abu Dhabi è meno importante per
l'Italia, perché il ritiro dall'Afghanistan di fatto è stato completato. Ma lo
schiaffo politico al governo di Roma è umiliante. Da giorni il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini ha provato a spiegare al collega Luigi Di Maio e adesso
anche al premier Mario Draghi che i rapporti con Emirati e Arabia Saudita non
possono essere compromessi. "Ne va non solo delle forniture militari, ma della
collaborazione politica in tutto il Medio Oriente con partner essenziali per
l'Italia", dicono fonti alla Difesa. La soluzione poteva essere quella di far
approvare alla Camera o al Senato una nuova mozione parlamentare che "smontasse"
la richiesta di embargo fatta al governo. La mozione ancora non è stata
presentata ufficialmente, verrà presentata alla Commissione Difesa del Senato.
Ma l'operazione politica è complicata: esponenti del Pd dicono adesso ""vogliamo
essere sicuri che i deputati dei 5Stelle condividano la necessità di una
correzione di rotta, altrimenti non faremmo che aggravare la situazione". Il Pd,
in altre parole, non vuole farsi trovare col cerino in mano, ed essere accusato
di autorizzare nuove esportazioni militari. Nelle ultime ore il dossier-Emirati
in ogni caso è arrivato a Palazzo Chigi, è stato anticipato al presidente del
Consiglio Mario Draghi, sul tavolo del consigliere diplomatico Luigi Mattiolo. I
tempi stringono, c'è questa data del 2 luglioentro cui la base dovrebbe essere
chiusa. I ministri Di Maio e Guerini hanno intenzione di porre il tema
direttamente a Draghi nel prossimo Consiglio dei ministri, che sarebbe fissato
il 1° luglio. Fra l'altro non è chiaro neppure cosa potrebbe fare rapidamente il
premier per evitare lo schiaffo della chiusura. Nei giorni scorsi il Guerini ha
telefonato al suo collega ministro della Difesa emiratino. Anche i capi militari
del regno sono stati contattati dal generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato
maggiore della Difesa. Ma a tutti i responsabili emiratini rispondono solo una
cosa: "È Mbz in persona che sente come un'offesa gravissima la vostra decisione
di applicare l'embargo, ed è lui che andrà convinto con le mosse giuste che
l'Italia vorrà prendere". Molti nel governo sperano che sia Draghi in persona a
chiamare l'emiro per raffreddare la crisi. Ma non è detto che una inversione di
rotta sia una decisione semplice.
Da "LaPresse" l'11 giugno
2021. Gli Emirati Arabi hanno intimato all'Italia di smobilitare lo scalo di Al
Minhad, utilizzato dalle nostre truppe in arrivo e in partenza da Herat
(Afghanistan). Lo apprende LaPresse da fonti della Farnesina. Adesso il nostro
contingente potrà rientrare in Italia da uno scalo in allestimento in Kuwait.
Fausto Biloslavo per “Il
Giornale” il 12 giugno 2021. Il ritiro dall'Afghanistan è a rischio. Gli Emirati
arabi minacciano di sloggiare l'Italia dalla base di Al Minhad, snodo strategico
per riportare a casa tutto il materiale non solo bellico da Herat. Ieri
l'agenzia LaPresse, citando fonti anonime della Farnesina, aveva dato per certa
l'intimazione dello sfratto. Il ministero degli Esteri smentisce e la Difesa
conferma «che il rischio esiste, ma si sta lavorando per evitarlo». Giovedì il
responsabile del dicastero, Lorenzo Guerini, ha parlato al telefono con
l'omologo emiratino, Mohammed bin Ahmed al Bowardi. Secondo l'agenzia stampa
degli Emirati è stato discusso «il rafforzamento della cooperazione tra i due
Paesi in campo militare e nel settore della difesa». L'8 giugno all'aereo con i
giornalisti che volava verso Herat per l'ammaina bandiera è stato proibito lo
spazio aereo degli Emirati. E la Farnesina aveva convocato l'ambasciatore per
spiegazioni. Gli emiratini sono inferociti per lo stop di gennaio voluto dai
grillini e dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle esportazioni di armi
per il coinvolgimento del paese nella guerra nello Yemen, in realtà in parte
superato dagli eventi. E anche il nostro avvicinamento al Qatar, rivale giurato,
compresa la recente vendita di navi da guerra, è una spina nel fianco dei
rapporti con Abu Dhabi. La crisi è tale, che la Difesa sta predisponendo piani
alternativi, più costosi, che allungherebbero i tempi del ritiro con relativo
pericolo per le nostre truppe se ce ne andassimo dopo gli americani. Una ventina
di giorni fa dovevamo ancora fare tornare in Italia 2 chilometri di materiale,
soprattutto shelter e container, comprese le armerie, ma ci sono anche
elicotteri, blindati e altri velivoli. I piani del Coi, Comando Operativo di
vertice Interforze, prevedono di chiudere tutto a fine giugno o in luglio. Dalla
base di camp Arena a Herat è stato pianificato un ponte areo con una trentina di
voli grazie al noleggio di Antonov e Ilyushin IL-76. Da Herat atterrano ad Al
Minhad a Dubai e poi il materiale viene imbarcato nel porto di Jebel Alì per
raggiungere l'Italia. Ogni volo costa circa 300mila euro e la nave verrà pagata
700mila euro. L'ultima fase del ritiro costerà almeno 10 milioni. «Se non
possiamo passare per gli Emirati è un grosso problema» spiega lo spedizioniere
Valter Amatobene, specializzato in aree di crisi. «Come alternativa immaginerei
il Kuwait, dove siamo già presenti in una base, o Gedda in Arabia Saudita. Ogni
volo costerà circa 50mila euro in più oltre alla differenza dei giorni di
navigazione» calcola Amatobene, che opera in Afghanistan. In realtà, la Difesa
sta studiando altre opzioni, sempre nella penisola arabica, a cominciare
dall'Oman attraverso le basi dei nostri alleati occidentali. Se perdessimo la
base di Dubai sarebbe un disastro strategico e logistico anche per altre
missioni. Negli Emirati sono impiegati 106 militari e Al Minhad è uno snodo
cruciale non solo per il ritiro dall'Afghanistan, ma pure per le operazioni nel
Corno d'Africa e Prima Parthica in Irak. Il governo Conte, che ha provocato la
frittata, non ha tenuto conto dei rancori pregressi come il caso
Alitalia-Etihad, che ha provocato un'indagine della procura di Civitavecchia sul
ruolo degli emiratini. Per non parlare della Piaggio aviazione comprata dagli
arabi, che poi non ha mai prodotto un previsto drone militare. Ci ha pensato la
Casa Bianca, mentre i grillini sventolavano lo stop alle armi agli Emirati, a
vendere caccia F-35 e droni per 23 miliardi di dollari ad Abu Dhabi.
Michele Nones
per affarinternazionali.it il 15 giugno 2021. Chi va in montagna sa bene quanto
può essere pericoloso muoversi incoscientemente fuori dai tracciati: il rischio
è quello di provocare una valanga dagli effetti devastanti. Nessuno lo fa
consapevolmente, ma non cambiano gli effetti. Non tutti, però, ci vanno. Nelle
relazioni internazionali avviene lo stesso ed è solo così che si può spiegare il
peggioramento delle relazioni fra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia
Saudita. A richiamarvi l’attenzione ci ha pensato il divieto di sorvolo deciso
all’ultimo momento dagli Emirati Arabi Uniti nei confronti del velivolo militare
italiano che trasportava i giornalisti in Afghanistan per la cerimonia della
fine del nostro intervento in quel lontano paese, al seguito del ministro della
Difesa Lorenzo Guerini. Una decisione inaspettata e preoccupante perché conferma
che si sta diffondendo nel mondo post-Covid una pessima tentazione: dirottare i
voli e chiudere gli spazi aerei per ragioni politiche. Una nuova forma di
embargo aeronautico che rischia di compromettere la difficile ripresa del
sistema del trasporto aereo internazionale che, invece, dovrebbe essere
nell’interesse di tutti favorire. L’occasione scelta per manifestare il forte
disappunto emiratino nei nostri confronti non è stata certamente la migliore,
visto che il viaggio era legato al forte e continuo impegno dell’Italia nel
cercare di stabilizzare le aree di crisi e contrastare il fondamentalismo
islamico. Con queste stesse motivazioni, peraltro, i due Paesi arabi sono da
anni impegnati nello Yemen. Ma solo gli ingenui potevano non aver colto i
crescenti segnali che ci sono stati lanciati nei quasi cinque mesi trascorsi
dallo “schiaffo” che abbiamo un po’ incoscientemente dato a questi due Paesi,
revocando in modo plateale l’autorizzazione a ricevere gli involucri delle bombe
d’aereo prodotti in Italia, come era avvenuto negli ultimi sei anni. Una
decisione comunicata con grande clamore il 29 gennaio dal ministro degli Esteri
Luigi Di Maio e che ha lasciato isolato il nostro Paese rispetto a partner ed
alleati (che sono – non va dimenticato – anche nostri concorrenti). Vi sono
alcune questioni che, comunque, avrebbero dovuto spingerci ad agire con maggiore
prudenza e riservatezza, ma, continuando in troppi ad usare la politica
internazionale per condurre battaglie politiche di casa nostra, abbiamo
“avvelenato i pozzi” e adesso non sappiamo come venirne fuori. Anche perché,
fuori metafora, questi sono anche pozzi petroliferi. La prima questione è di
natura politica e tocca la natura orgogliosa del mondo arabo, legata al loro
carattere e alla più recente indipendenza. Avere di fatto bollato i due Paesi
come “esecrabili”, ha urtato pesantemente il loro orgoglio e sta coinvolgendo
inevitabilmente tutti i settori della collaborazione e dell’interscambio. Dal
loro punto di vista, d’altra parte, la posizione è chiara: se non si vuole
collaborare con loro nel campo della sicurezza e difesa, non lo si fa nemmeno
negli altri campi. Va peraltro ricordato che solo venti giorni prima della
decisione italiana il nostro ministro degli Esteri aveva incontrato in Arabia
Saudita il principe ereditario Mohammad bin Salman e il suo omologo, firmando un
Memorandum of Understanding per l’avvio del dialogo strategico bilaterale fra i
due Paesi. Difficile spiegare ai sauditi cosa è poi rapidamente cambiato.
Andrebbe, invece, posta grande attenzione al modo di gestire le relazioni
internazionali, soprattutto quando riguardano Paesi con cui vogliamo mantenere e
sviluppare un clima di collaborazione. Le stesse decisioni possono avere
conseguenze molto diverse a seconda di come vengono preparate e comunicate. In
questo caso una decisione politica comunicata sui social è un esempio da manuale
di ingenuità e irresponsabilità. La seconda questione riguarda la diversa
intensità dei nostri rapporti con gli Emirati e con l’Arabia Saudita. Nello
scorso decennio abbiamo ripetutamente cercato e accolto calorosamente gli
investimenti emiratini in Italia, soprattutto come salvataggio di imprese in
crisi, dall’Alitalia alla Piaggio. Queste iniziative, in particolare, dopo aver
bruciato miliardi di euro arabi, sono comunque finite malamente. Abbiamo
utilizzato e stiamo utilizzando, dal 2015, la loro base di Al Minhad e, dal 2002
al 2015, quella di Al Bateen per la nostra Forward Logistic Airbase,
indispensabile per garantire i nostri collegamenti aerei con il teatro afghano.
Dieci anni fa abbiamo venduto un gruppo di velivoli da addestramento e formato i
loro piloti per la loro pattuglia acrobatica, ma dall’inizio dell’anno non
forniamo le parti di ricambio. Per altro con gli Emirati abbiamo avuto dal 2003
un Memorandum of Understanding di collaborazione nel campo della difesa, che da
tre anni stiamo rinegoziando. I rapporti con loro sono, quindi, molto più
stretti che non quelli con l’Arabia Saudita e questo avrebbe dovuto portarci ad
ancora una maggiore prudenza. Tutto questo è emerso nella freddezza con cui sono
state accolte le ultime visite ufficiali italiane, militari e civili, fra cui
quella del ministro degli Esteri a fine aprile. Ma, evidentemente, qualcuno ha
pensato che scherzassero, dimenticandosi che siamo più noi ad avere bisogno di
loro come esportatori di petrolio e come investitori, oltre che come acquirenti
dei nostri prodotti, che non loro ad avere bisogno di noi. Nel frattempo i
nostri concorrenti sono già in fila per sostituirci. La terza questione riguarda
il fatto che una simile decisione avrebbe dovuto essere condivisa a livello
interministeriale. La normativa prevede, infatti, che le revoche delle
autorizzazioni siano “disposte con decreto del ministro degli Affari esteri
sentito il Cisd”, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di
armamento per la difesa. Ma, purtroppo, nel 1993 è stato cancellato questo
Comitato passandone le competenze al ministero degli Esteri, che le dovrebbe
esercitare “d’intesa” con quelli della Difesa e dello Sviluppo economico, oltre
che con la presidenza del Consiglio. Si è sostenuto che sia stato coinvolto il
Consiglio dei ministri, ma non ve ne è traccia nei comunicati ufficiali. Forse
anche perché in realtà dal 26 gennaio ministro degli Esteri e governo erano già
dimissionari. Adesso bisognerebbe rapidamente inserire nuovamente un Comitato
interministeriale al vertice del sistema di controllo delle esportazioni in modo
da tenere conto di tutte le implicazioni politiche, economiche, industriali,
tecnologiche della nostra politica esportativa militare, definendo in quella
sede le linee direttrici e le decisioni di carattere strategico. In questo modo
si potrebbe anche impedire che prosegua l’effetto valanga con i due paesi arabi.
La quarta questione riguarda l’affidabilità dell’Italia sul delicato tema della
sicurezza e difesa. Un conto è evitare la vendita di certi equipaggiamenti verso
determinati Paesi (a tal proposito bisognerebbe però chiedersi se negli ultimi
sei anni il problema non avrebbe potuto essere disinnescato e, di nuovo, perché
le valutazioni politiche italiane sono cambiate, oltre tutto quando gli attacchi
condotti dagli insorgenti yemeniti colpiscono direttamente il territorio
dell’Arabia Saudita, finendo con il coinvolgere il diritto all’autodifesa). Un
altro conto è, invece, annullare un contratto in assenza di embarghi e formali
condanne internazionali verso questi Paesi (le condizioni previste dalla nostra
normativa per la revoca delle autorizzazioni). E che la decisione italiana sia
stata, invece, politica, lo dimostra il fatto che il divieto riguarda solo
alcune tipologie di armamenti. Ma i sofismi italiani ben difficilmente possono
evitare che l’Italia sia considerata, come minimo, poco affidabile. E quando è
in gioco la sicurezza e la difesa, ogni Paese ha inevitabilmente la massima
attenzione e sensibilità. Forse la valanga può essere ancora fermata o
“deviata”: gli unici a poterlo tentare sono i più autorevoli nostri vertici
politici e il governo in quanto tale.
La (vera) partita tra
Italia ed Emirati.
Lorenzo Vita su Inside Over l'11 giugno 2021. Lo sgarbo
degli Emirati Arabi Uniti per il volo italiano diretto in Afghanistan potrebbe
essere solo uno dei sintomi di un problema molto più ampio. La “Sparta” del
Golfo Persico non ha apprezzato le ultime mosse italiane nei suoi confronti. E
nonostante la fredda (ma cordiale) accoglienza di Luigi di Maio nel paese per
l’expo di Dubai, l’impressione è che quello tra Italia ed Emirati sia un
rapporto che ha subito lacerazioni importanti. Il problema per gli Emirati
arriva soprattutto da due ordini di ragioni. Il primo riguarda il blocco
all’esportazione di armi imposto dall’Italia per l’accusa di utilizzare quelle
stesse munizioni contro civili nella guerra in Yemen. L’accusa, la stessa che
aveva portato al blocco da parte americana, ha rappresentato per Abu Dhabi un
colpo durissimo sia a livello di immagine che a livello strategico. Gli EAU
contavano sulle forniture dell’industria italiana, con cui era legata da molti
decenni sia in campo bellico che in campo civile. E la scelta di fermare
l’esportazione di armi, oltre a costringere gli Emirati a convertirsi ad altre
aziende estere, ha dato un segnale di inaffidabilità nei rapporti che non è
affatto piaciuta a Mohammed Bin Zayed. Vincenzo Camporini, già capo di Stato
Maggiore della Difesa, ha spiegato in questi termini ad Aki – Adnkronos
International la decisione emiratina di bloccare il Boeing dell’Aeronautica
italiana. “Si dovrebbero rivedere le decisioni prese dal ministro degli Esteri”
ha detto Camporini, visto che sono state fermate “tutte le forniture militari
agli Emirati, comprese alcune cose che francamente lasciano basiti”. Il
riferimento è ad esempio ai pezzi di ricambio per la pattuglia acrobatica di Abu
Dhabi. “Gli Emirati hanno la pattuglia acrobatica che vola con aeroplani
italiani e gli abbiamo bloccato i pezzi di ricambio. Si tratta di velivoli di
addestramento. Nessuno può pensare vengano usati per motivi bellici al di là
della valutazione unilaterale su quello che sta accadendo nel Medio Oriente.
Quindi il governo emiratino è chiaramente molto irritato ed essendo molto
irritato ha reagito come probabilmente avrebbe reagito chiunque”. Camporini,
oggi a capo del settore Sicurezza per Azione, ha poi incalzato: “Noi dovremmo
riflettere sulla nostra politica dell’esportazione di materiale d’armamento
perché attualmente le cose non stanno andando bene”. E l’accusa riguarda anche
la modalità di scelta di questo blocco di vendita degli armamenti. Perché mentre
la legge 185 del 1990 aveva messo in piedi un comitato interministeriale su
queste decisioni, in modo di dare “una visione collegiale” del governo, dopo tre
anni quello stesso comitato è stato abolito per affidare tutto “a un ufficio del
ministero degli Esteri” che opera “senza un coinvolgimento del governo, con
valutazioni che in questo momento particolare io trovo abbastanza discutibili”.
La decisione di fermare l’export di armi si inserisce inoltre in un quadro di
rapporti delicato, in cui Italia ed Emirati si sono trovate molto spesso
dall’altra parte della barricata sia per quanto riguarda il Medio Oriente che
per quanto concerne il Nord Africa. Roma ha blindato in questi anni il rapporto
con il Qatar, acerrimo nemico di Abu Dhabi, intessendo una fitta trama di
interessi convergenti che vanno dalla Libia all’Africa fino ai rapporti con la
stessa industria militare. Agli Emirati non va giù che mentre è stata bloccata
la vendita di armi nei confronti di Abu Dhabi, l’Italia continua rifornire le
forze armate di Doha, in particolare la flotta. La Marina qatariota ha
nell’Italia uno dei principali partner internazionali. Soltanto a giugno c’è
stato il varo del Sheraouh, pattugliatore della classe Musherib, nei cantieri di
Muggiano, l’inaugurazione del centro di addestramento Halul 1 in coordinamento
con la Marina militare italiana, e negli stabilimenti di Riva Trigoso sono
iniziati i lavori per la futura nave ammiraglia della flotta del Qatar. Scelte
importanti che confermano la convergenza di interessi tra un nemico sistemico
per gli Emirati e l’Italia. A questi nodi mediorientali, in cui l’Italia di
fatto sta rafforzando un avversario degli Emirati mentre ha bloccato la vendita
di armi proprio ad Abu Dhabi, si aggiunge il nodo strategico regionale.
In Libia i rapporti tra Italia ed EAU sono diventati molto difficili nel momento
in cui Roma ha virato in modo più netto al supporto di Tripoli mentre Abu Dhabi
ha sostenuto sia a livello politico che a livello militare le forze legate a
Khalifa Haftar. Un problema che investe anche i rapporti tra Italia e Turchia,
altro nemico emiratino, e che riguardano anche il coinvolgimento italiano in
Sahel e nel Corno d’Africa, dove gli EAU tentano da molti anni di inserirsi
nella partita sfruttando anche le pieghe dei rapporti tra Italia e Francia, con
quest’ultima che ha impresso una decisa sterzata anti-turca in tutta l’area del
cosiddetto Mediterraneo allargato. La questione emiratina diventa poi
particolarmente importante se si pensa alle ripercussioni globali di questo
scontro per l’Italia. Roma ha sempre mantenuto una posizione privilegiata nel
Golfo Persico proprio per la capacità di muoversi su diversi fronti senza
entrare troppo nelle diatribe regionali. Questo ha permesso per decenni
alle aziende italiane e alle nostre forze armate di essere praticamente di casa
in un’area così complessa come quella mediorientale. La mossa del precedente
governo Conte di bloccare la vendita di armi – insieme ai problemi legati alle
inchieste su Alitalia-Etihad e al nodo Piaggio – ha di fatto interrotto un
rapporto che andava avanti da molti anni e che permetteva all’Italia di non
essere considerata appartenente a un blocco. Ora invece Roma si trova nella
posizione di non essere considerata né super partes né alleata, ma semplicemente
inaffidabile. E lo dimostra il fatto che mentre si blocca l’export di armi agli
EAU, si è anche propensi a scontrarsi con l’altro avversario di Abu Dhabi,
ovvero Ankara. Gli effetti però possono essere pericolosi. Gianluca di Feo,
su Repubblica, ha parlato per esempio della possibilità che gli Emirati possano
escludere l’utilizzo italiano della base di Al Minhad a Dubai. La base,
utilizzata anche da australiani, britannici e americani, è considerata un hub di
fondamentale importanza nella strategia italiana non solo nel Golfo, ma anche
per l’Asia centrale, ed è oggi il ponte per il ritiro dall’Afghanistan. Un
pericolo che l’Italia deve evitare a ogni costo.
Cosa c’è dietro lo schiaffo
diplomatico degli Emirati Arabi all’Italia.
Francesca Salvatore su Inside
Over l'8 giugno 2021. Un secco no, quello delle autorità emiratine, al passaggio
nel proprio spazio aereo di un C130 dell’Aeronautica militare italiana che, con
a bordo 42 giornalisti italiani e numerosi a militari, era diretto a Herat,
in Afghanistan, per la cerimonia dell’ammainabandiera del tricolore nella base
di Camp Arena. Il diniego ha costretto il C130 a effettuare un atterraggio
nell’aeroporto saudita di Dammam per una lunga sosta mentre la trattativa tra il
comandante del velivolo italiano, il maggiore Valentina Papa, e le autorità
emiratine procedeva. Il volo era partito a mezzanotte da Pratica di Mare e
inizialmente prevedeva l’arrivo a Herat per le 9,30 locali (le 7 italiane). Le
autorità locali sono state irremovibili, riservandosi fino all’ultimo di dare un
via libera che poi non hanno comunque concesso. A bordo è stata anche valutata,
in contatto con le autorità della Difesa italiana interessate, l’ipotesi di
tornare indietro, annullando la presenza della stampa alla cerimonia di Herat,
nel frattempo posticipata di alcune ore. Poi, la decisione di proseguire, con
una nuova rotta verso l’Afghanistan, necessariamente più lunga, per aggirare il
territorio degli Emirati, seguendo un percorso che non prevedesse il sorvolo di
basi militari. Un grave sgarbo diplomatico che lascia di stucco la Farnesina. Su
istruzione del ministro Luigi Di Maio, il segretario generale del ministero
degli Esteri ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato l’ambasciatore degli
Emirati Arabi Uniti Omar Al Shamsi. Sul caso, il ministro della Difesa Lorenzo
Guerini ha dichiarato: «La questione non è dipesa da noi, sono state mosse
alcune iniziative di carattere diplomatico, è stato convocato l’ambasciatore
degli Emirati al ministero degli Esteri per chiedere spiegazioni e per
manifestare tutto il disappunto e lo stupore per avere negato il sorvolo
rispetto a decisioni che erano già state comunicate, assunte e garantite». Ciò
che sorprende maggiormente è che, come si fa in questi casi, il piano di volo
era stato precedentemente approvato, ma solo all’ultimo minuto Abu Dhabi non ha
concesso il via libera al sorvolo dei propri cieli, costringendo la comandante a
trovare un aeroporto alternativo per atterrare, rifornirsi e cambiare di
conseguenza il percorso. Al netto di un misunderstanding o di problemi tecnici,
sui quali si farà luce nelle prossime ore, il pensiero va a una valutazione
complessiva delle relazioni bilaterali tra il nostro Paese e gli Emirati: i
rapporti sono complicati ma non sospesi, sebbene lo stop alle forniture militari
deciso dall’Italia potrebbe avere qualche ruolo nello sgarro diplomatico di
oggi. Negli scorsi mesi la decisione era stata ufficializzata da un atto
dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento che fa capo alla
Farnesina. Gli ordigni che l’Italia esportava sono stati utilizzati
principalmente nel conflitto in Yemen, Paese dove Arabia Saudita ed Emirati sono
coinvolti militarmente nel quadro della coalizione araba che sostiene il governo
Hadi, riconosciuto dalla comunità internazionale, e combatte i ribelli Houthi.
Il provvedimento riguarda almeno sei diverse autorizzazioni già sospese a luglio
2019, tra le quali la licenza Mae 45560 relativa a quasi 20mila bombe aeree
della serie Mk. Una sorta di embargo legato al fatto che in Yemen non sono stati
discriminati i bersagli civili da quelli dei ribelli Houthi. Un’occasione per
uno stress test dei rapporti con Abu Dahabi si era presentata un mese fa, quando
una delegazione del ministero della Difesa si era recata in loco e negli
incontri con gli omologhi locali si era deciso di avviare nuove attività di
cooperazione attraverso la firma di un protocollo. Un tampone al gelo delle
relazioni bilaterali, dunque, che rischiava di produrre un impatto negativo
sull’interscambio economico e commerciale con il rischio di annullamento di
molte commesse (Eni, Leonardo, le grandi imprese italiane coinvolte nei progetti
infrastrutturali emiratini). Un gesto che resta, qualora lo fosse, una
ritorsione a scoppio ritardato, visto e considerato anche che gli Emirati sono
l’unico Paese del Golfo che ospita un contingente di militari italiani e che è
in costruzione la prima chiesa cattolica del Paese, un precedente innovativo per
tutto il mondo islamico. Meno probabile l’ipotesi, paventata nelle prime ore
dopo l’accaduto, di un diniego per ragioni di genere: il fatto che il velivolo
fosse pilotato da una donna non sembra, al momento, essere causa diretta o
indiretta dell’accaduto.
·
Quei
razzisti come i dubaiani.
Da "huffingtonpost.it" il 21 giugno 2021. Da anni
è al centro delle preoccupazioni dell’opinione pubblica, soprattutto negli Stati
Uniti, dopo essere stata sequestrata nel 2018 nel tentativo di fuggire dal
padre, lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La principessa di Dubai Latifa
è riapparsa però oggi in un post su Instagram con un’amica. Le due, stando a ciò
che viene scritto nel post, si troverebbero in Spagna, per una “festa
europea”. L’immagine sul social network è stata pubblicata da una donna
identificata nei media britannici come ex membro della Royal Navy, chiamata
Sioned Taylor. Nella foto Taylor appare insieme a Sheikha Latifa bint Mohammed
Al Maktoum all’aeroporto Adolfo Surez Madrid Barajas. La didascalia scritta da
Taylor, punteggiata da una faccina sorridente, recitav: “Grande vacanza europea
con Latifa. Ci stiamo divertendo ad esplorare!”. I fari sulla vicenda della
principessa di Dubai - figlia dell’emiro di Dubai nonché vice presidente e primo
ministro degli Emirati, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum - si sono accesi a
marzo, quando in un video pubblicato su YouTube la 32enne denunciava di essere
tenuta prigioniera dalla sua famiglia e di essere vittima di abusi. Nel video
Latifa annunciava anche la sua fuga da Dubai, accusando il padre di
maltrattamenti. Alla domanda su Sheikha Latifa, Taylor ha scritto in un altro
commento “lei è fantastica” con un’emoji pollice in su. Taylor ha pubblicato
immagini di Sheikha Latifa anche lo scorso maggio. In quelle foto le due
apparivano in due centri commerciali locali di Dubai. Sheikha Latifa, 35 anni,
aveva cercato di fuggire dal paese nel 2018, per poi essere sequestrata e
trattenuta dal commando su una barca al largo dell’India. Nei video diffusi a
febbraio dalla BBC, Sheikha Latifa si descriveva come se si trovasse in una
villa che “è stata trasformata in una prigione”. La potenziale fuga in mare
della donna e le sue conseguenze hanno cominciato a mettere al centro
dell’attenzione la figura dello sceicco Mohammed, che si ritiene abbia diverse
dozzine di figli da più mogli. La vita familiare dello sceicco è diventata di
nuovo una questione pubblica nel 2020, quando un giudice britannico ha stabilito
che lo sceicco aveva condotto una campagna di paura e intimidazione contro la
sua ex moglie e aveva ordinato il rapimento di due delle sue figlie, una delle
quali Sheikha Latifa.
Da "repubblica.it" il 16 febbraio 2021. La
principessa Latifa Al Maktoum - figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, uno dei capi di Stato più ricchi del mondo, sovrano di Dubai e
vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti (Eau) - accusa il padre di averla
rapita e di tenerla in "ostaggio" dopo il tentativo di fuga dal Paese nel 2018.
In un video fatto pervenire al programma Panorama della Bbc, la figlia dello
sceicco racconta di essere stata fermata da un commando che l'ha drogata e
riportata alla sua prigionia, mentre tentava di fuggire a bordo di
un'imbarcazione. Il video fa parte di una serie di messaggi segreti che la
principessa ha inviato ai suoi amici per chiedere aiuto. I video sono stati
registrati per diversi mesi grazie a un telefono che Latifa ha ricevuto
segretamente circa un anno dopo la sua cattura e il suo ritorno a Dubai. Li ha
registrati in un bagno perché era l'unico posto con una porta che poteva
chiudere a chiave. Nei messaggi ha spiegato in dettaglio come si è opposta ai
soldati che l'hanno portata giù dallo yacht "prendendoli a calci" e mordendo il
braccio di un membro del commando. Dopo essere stata drogata e aver perso
conoscenza è stata trasportata su un jet privato e non si è svegliata finché non
è atterrata a Dubai. Finora è stata tenuta in isolamento senza accesso ad
assistenza medica o legale in una villa con porte e finestre sbarrate
sorvegliata dalla polizia. In precedenza, i portavoce del governo di Dubai
avevano riferito che la principessa era al sicuro, affidata alle cure della sua
famiglia. L'ex inviata per i diritti delle Nazioni Unite Mary Robinson, che
aveva descritto Latifa come una "giovane donna problematica" dopo averla
incontrata nel 2018, ora dice di essere stata "orribilmente ingannata" dalla
famiglia della principessa. L'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani e presidente dell'Irlanda si è unito agli appelli per un'azione
internazionale per stabilire le condizioni attuali e il luogo in cui si trova
Latifa. Nei mesi scorsi Mohammed al Maktoum è stato sconfitto di fronte alla
giustizia britannica al termine di una clamorosa causa di divorzio intentata
contro di lui da una delle sue consorti, Haya bint Hussein, sorella del re di
Giordania, riuscita a fuggire - a differenza di Latifa - e a trovare poi rifugio
in una lussuosissima quanto blindata residenza di Londra. La vicenda giudiziaria
ha provocato grande imbarazzo nel Regno Unito, coinvolgendo due dinastie e due
Paesi arabi considerati alleati strettissimi di Londra, come di Washington.
Chiara Clausi per "il
Giornale" il 18 febbraio 2021. Le sorti della principessa prigioniera e triste,
Latifa, figlia del sovrano di Dubai, diventano un caso internazionale. La sua
vicenda è balzata all' attenzione di tutti media da quando sono stati condivisi
da Bbc Panorama i video registrati di nascosto da Latifa nel bagno della villa
in cui è segregata. «Sono ostaggio, non sono libera, sono schiava, sono
rinchiusa in questa prigione, la mia vita non è nelle mie mani», è l' urlo di
disperazione della principessa nella clip. «Non so se sopravviverò alla
situazione», ha poi continuato. «La polizia mi ha minacciato che starò in
prigione per tutta la vita e non vedrò mai più il sole». Le Nazioni Unite hanno
dichiarato che solleveranno il caso alle autorità degli Emirati Arabi Uniti.
«Anche altre parti del sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite potrebbero
essere coinvolte dopo aver analizzato il nuovo materiale», ha detto l' Ufficio
dell' Alto Commissario delle Nazioni Unite. Nel frattempo pure il Regno Unito è
intervenuto e ha affermato che i video sono «profondamente preoccupanti». Il
ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha precisato che le clip
mostravano «una giovane donna in profonda angoscia», e ha aggiunto che Londra
avrebbe guardato «molto da vicino» qualsiasi sviluppo. Ma alla domanda se si
possano imporre sanzioni, Raab ha spiegato: «Non mi è chiaro se ci siano le
condizioni a sostegno di questa azione». Il primo ministro Boris Johnson ha
anche espresso preoccupazione ma «aspetterà e vedrà come le Nazioni Unite
andranno avanti». «Speriamo che un' indagine dell' Onu sarà decisiva per
ottenere finalmente il rilascio della principessa Latifa», ha affermato invece
Rodney Dixon, l' avvocato che ha presentato il caso all' Onu. Ma non è il primo
episodio di questo tipo nella famiglia del sovrano di Dubai. L' Alta Corte di
Londra aveva già stabilito che lo sceicco aveva orchestrato una campagna «mirata
a intimidire e spaventare» la principessa Haya, la sua sesta moglie, sorella del
re di Giordania, fuggita nel Regno Unito con i loro due figli piccoli nel 2019
perché sosteneva di aver paura per la sua vita. La Corte aveva anche appurato
che in precedenza l' emiro aveva già «ordinato e orchestrato» il rapimento di
due delle sue figlie avute da un precedente matrimonio, Latifa, e sua sorella,
Shamsa. Le accuse contro lo sceicco sono particolarmente sensibili per l'
establishment britannico poiché il sovrano degli Emirati ha interessi
commerciali significativi nel Regno Unito ed è una delle figure più importanti
delle corse ippiche. Il sovrano ha una vasta azienda di corse di cavalli e
frequenta spesso eventi importanti come il Royal Ascot, dove è stato fotografato
con la regina Elisabetta II. Gli Emirati Arabi Uniti hanno stretti rapporti con
numerosi Paesi occidentali, inclusi anche gli Stati Uniti che lo considerano un
alleato strategico. Ma gli attivisti per i diritti umani sostengono che nel
piccolo Stato del Golfo non c' è tolleranza per il dissenso e le donne sono
ancora molto discriminate. Sebbene gli Emirati Arabi Uniti non siano rigidi come
la vicina Arabia Saudita, le donne hanno ancora bisogno del permesso del loro
tutore per sposarsi e il divorzio è molto più difficile da ottenere per loro che
per gli uomini.
·
Quei
razzisti come gli arabi sauditi.
Cristiana Mangani per “il Messaggero” il 14
novembre 2021. Il calcio donne si evolve, lotta per la parità di genere e compie
passi in avanti. Dal 22 novembre l'Arabia Saudita darà il via al campionato di
calcio femminile Saudi women's football league. Ad annunciarlo è stata la
Federcalcio di Riad sottolineando che il torneo segna un cambiamento importante
per le donne saudite a cui solo nel 2018 è stato concesso di poter assistere
allo stadio alle partite di calcio. Un segnale di apertura da parte del regno
saudita che sta cercando di liberarsi dell'immagine di paese ultraconservatore,
anche se le sportive saranno in campo con velo e pantaloni. La competizione si
svolgerà in due fasi, le squadre prima si sfideranno in tre leghe regionali a
Riad, quelle qualificate giocheranno le finali all'inizio del 2022 a Jeddah. La
creazione di questo campionato è un «momento importante» per la federazione, ha
dichiarato il suo presidente, Yasser al-Misehal, e fa parte di un programma di
sostegno al calcio femminile lanciato nel 2017. Sotto la guida del principe
ereditario Mohammed ben Salman, l'Arabia ha recentemente avviato un programma di
riforme economiche e sociali che include anche un allentamento di alcuni divieti
per le donne. I leader sauditi, criticati per le violazioni dei diritti umani
del regno, utilizzano da diversi anni lo sport come leva diplomatica per
migliorare l'immagine del Paese sulla scena internazionale. Lo scorso mese di
agosto, la tedesca Monica Staab è stata nominata allenatrice della nazionale e
il 2 novembre ha tenuto il primo allenamento, un giorno storico per il calcio
femminile. La 62enne ha una grande esperienza nel Golfo, in precedenza ha
guidato le squadre del Qatar. Era stata scelta per modellare la struttura
calcistica in un progetto dedicato in Gambia, poi è arrivata la proposta da
Riad. «Quando mi hanno chiamata dall'Arabia Saudita non ci credevo», ha scritto
sul sito della Fifa. Staab, che si occupa anche della formazione delle
allenatrici, deve selezionare una squadra di 30 giocatrici tra le 700 tesserate,
«tutte donne che studiano o lavorano, praticano lo sport per passione con enormi
sacrifici». L'esordio internazionale è previsto a febbraio, contro le
Maldive. Ma i progetti sono molto più ambiziosi: dal 18 novembre il lancio di
una Lega femminile che si giocherà in tre città. «Quel che succede è
incredibile, e non si crede se non lo si vede - ha dichiarato ancora Staab -:
ragazze che portano con sé un'incredibile voglia di libertà e tanti sogni. In 10
anni vogliono andare al Mondiale, io dico calme, ci arriveremo. Stiamo lottando
Claudio Savelli per "Libero
quotidiano" il 14 ottobre 2021. Mohammad Bin Salman in Italia era un nome noto
ben prima che fosse associato all'Inter "grazie" a Matteo Renzi. «È mio amico»,
disse infatti il leader di Italia Viva lo scorso marzo, quando il principe
ereditario al trono dell'Arabia Saudita fu accusato dalla Cia di essere il
mandante dell'"omicidio Jamal Khashoggi", il giornalista (critico nei confronti
dell'operato del regno saudita) del Washington Post ucciso nel consolato saudita
di Istanbul il 2 ottobre 2018 mentre stava ottenendo i documenti per il suo
matrimonio. La responsabile Onu, Agnes Callamard, aveva annunciato la presenza
di «prove credibili» sull'ordine diretto di Bin Salman, il quale ha negato di
aver ordinato l'omicidio ma si è assunto «piena responsabilità perché commesso
da individui che lavorano per il governo saudita». Poi, giusto per spiegare la
stoffa del personaggio, è passato dalle parole ai fatti: a settembre, un
tribunale saudita ha emesso otto condanne (senza nome) per l'omicidio Khashoggi,
cinque sono stati giudicati colpevoli e condannati a morte, poi commutati in
ergastolo, altri tre hanno ricevuto pene detentive. Insomma le accuse non
fermano di certo l'ascesa al potere di Bin Salman. Questa alle volte macchia la
sua immagine e quella del suo Paese, ma al principe interessa seminare in vista
dell'ascesa al trono saudita, a cui ha diritto essendo figlio maggiore della
terza moglie del padre Salman bin Abdulaziz al Saud: a quel punto, Bin Salman,
ora 35enne, confida di aver già una larga fetta di mondo tra le mani. Dopo la
laurea in legge nel 2009 alla King Saud University di Riad, Bin Salman diventa
consigliere speciale del padre. Nel 2015 è nominato Ministro della Difesa e come
atto d'ingresso inaugura una politica estera aggressiva in cui rientra "Decisive
Storm", l'operazione della coalizione araba per cancellare la milizia degli
Houthi nello Yemen, gruppo armato sciita. L'obiettivo è liberare l'Arabia
Saudita «dall'estremismo e del terrorismo senza fermare la crescita del Paese»,
secondo quanto dichiara il principe, ma il modo è considerato inaccettabile dal
resto del mondo: un terzo degli attacchi aerei sauditi colpiscono obiettivi
civili, inclusi ospedali e scuole, e i combattimenti provocano la morte di oltre
110mila persone. Così l'Arabia Saudita viene stata accusata di crimini di
guerra. Di nuovo, nulla ferma Bin Salman, che cerca di acquisire popolarità
interna annunciando il ritorno dell'islam moderato come chiave per modernizzare
il regno. Intanto lancia un'ampia campagna anti-corruzione, apparentemente per
recuperare soldi dai guadagni illeciti, in realtà per epurare potenti principi e
uomini d'affari arabi: così rimuove gli ultimi ostacoli per ottenere il
controllo totale del regno. Il divieto per le donne al volante è terminato nel
giugno 2018 in Arabia - l'ultimo paese al mondo in cui esisteva - e a Bin Salman
è stato dato gran parte del merito. Nel 2016 può introdurre il piano di sviluppo
"Vision 2030": l'obiettivo è riformare il modello economico del Regno saudita,
rendendolo indipendente dal petrolio entro il 2030 attraverso la
diversificazione degli investimenti in altri settori. Quali? Naturalmente il
turismo, supportato e promosso dalla rinnovata campagna "Visit Saudi" circolata
negli scorsi mesi anche nella televisione italiana, la cultura,
l'intrattenimento e lo sport, ovvero gli strumenti che offrono il cosiddetto
"soft power", la capacità di persuadere, convincere e attrarre popolazioni
altrimenti ostili. I tentacoli di Mohammad Bin Salman affondano anche
nell'arte. Si è rivelato essere infatti il misterioso acquirente del (presunto)
«Salvator Mundi» di Leonardo, il dipinto più costoso della storia, battuto in
un'asta di Christie' s da un suo intermediario a colpi di 20 milioni e infine
acquistato per 450 milioni di dollari. È lo stesso dipinto finito poi al centro
di un caso internazionale con la Francia, quando Emmanuel Macron decise di non
esporlo al Louvre di Parigi per la mostra dedicata a Leonardo in quanto la sua
autenticità era (ed è) contestata dagli esperti d'arte. Così il principe lo
propose alla filiale del Louvre di Abu Dhabi, vicini di casa concorrenti in
politica: un paradosso, per questo forte atto politico. Si dice che oggi sia
appeso su un muro di "Serene", lo yacht da 458 milioni del principe. Dall'arte
al calcio è un attimo, concesso dalla sconfinata liquidità accumulata
dall'Arabia e accumulata nel fondo PIF (Public Investment Fund), che avrebbe
mandato di gestione di un patrimonio di 347 miliardi di dollari per conto dei
regnanti. Circa 360 milioni di euro sono stati stanziato per l'acquisto del 100%
del Newcastle (Yasir Al-Rumayyan, governatore del fondo saudita, è diventato il
presidente) per cui la trattativa durava da più di due anni e su cui la Premier
aveva più volte posto il veto. Logico che PIF possa continuare lo shopping nel
calcio con club di rilievo in Italia (l'Inter?) e in Francia (il Marsiglia?), in
modo da contestare il crescente potere dei vicini: Bin Salman lancerebbe la
sfida al Qatar, proprietario del Psg, e a Abu Dhabi, padrone del City. Il terzo
incomodo arabo nel calcio potrebbe diventare presto uno delle prime potenze
mondiali.
Simona Verrazzo per "il
Messaggero" il 12 luglio 2021. Attiviste che difendono i diritti umani, in
particolare quelli delle donne, sottoposte a scariche elettriche, frustate,
pestaggi e violenze sessuali nelle carceri, anche segrete, dell'Arabia Saudita.
È questo l'agghiacciante quadro descritto nel rapporto di Human Rights Watch,
una delle più grande ong del mondo, relativo al 2018. Ne emerge un'immagine del
paese ben diversa da quella che negli ultimi anni il regno sta cercando di
diffondere nella comunità internazionale, pubblicizzando l'avvio
dell'emancipazione femminile voluta dall' erede al trono, il principe Mohammed
Bin Salman, come l'accesso delle donne al mondo del lavoro e la fine di divieti
femminili, soprattutto quello elettorale e di guida. Torture e abusi fisici e
psichici di attiviste di alto rango, tra cui spicca Loujain al-Hathloul,
avvocatessa che si è battuta per l'accesso delle donne al diritto a guidare, ma
anche uomini come lo scrittore Mohammad Al-Rabea, arrestato nel maggio 2018, in
quella che è stata una delle più dure ondate di repressione e che ha visto
coinvolti noti nomi della società civili, come l'uomo d' affari Abdulaziz
Al-Mesha' al, l'avvocato Ibrahim Al-Modaimeegh e il professore Aziza Al-Yousef.
Nel rapporto di HRW il riferimento più noto è quello a Loujain al-Hathloul,
rilasciata a febbraio dopo lo sdegno per il suo arresto. Ad aggiungere valore al
documento sono le testimonianze delle stesse guardie carcerarie, carnefici e
testimoni. «Nuove prove che indicano l'uso di torture brutali su donne che
difendono i diritti delle donne e altri detenuti di alto profilo mettono ancora
più a nudo il disprezzo saudita per lo stato di diritto e il fallimento di
qualunque credibile tentativo di indagare su queste accuse». è scritto in una
nota di Michael Page, vicedirettore di Human Rights Watch l'area MENA (Medio
Oriente e Nord Africa). Le testimonianze riportate da HRW si riferiscono in
particolare al carcere di Dhabhan, a nord di Gedda, e a un'altra prigione
definita segreta. In uno dei messaggi di testo riportati, una guardia carceraria
menziona per nome una importante attivista saudita per i diritti delle donne che
le autorità saudite hanno arrestato in un'ampia repressione iniziata nel maggio
2018. Al momento Human Rights Watch sta nascondendo il suo nome.
ABUSI SESSUALI «In una delle
sue sessioni di tortura, ha perso conoscenza ed eravamo tutti terrorizzati - è
la trascrizione - Temevamo che fosse morta e che ci saremmo assunti la
responsabilità perché le istruzioni erano di non uccidere nessuno dei detenuti,
uomini o donne». In un altro messaggio di testo, la guardia carceraria ha fatto
riferimento alle molestie sessuali che durante gli interrogatori sauditi hanno
inflitto alla nota avvocatessa. «Loujain al-Hathloul - si legge - È stata
sottoposta a molestie sessuali senza precedenti. Si divertivano a insultarla è
la prosecuzione La prendevano in giro dicendo che è libera e non le
dispiacerebbe essere molestata, come infilando le mani nella sua biancheria
intima o toccandole le cosce o sputandole e urlandole parole degradanti». Già
nel novembre 2018, le ong per i diritti umani aveva iniziato a segnalare
violenze e torture nelle carceri saudite.
Stefano de Paolis per l'ANSA il 29 dicembre 2020.
Loujain al-Hathloul, 31 anni, attivista per i diritti umani, è divenuta nota in
tutto il mondo per aver fatto campagna a favore del diritto delle donne del suo
Paese, l'Arabia Saudita, a guidare l'automobile. Nel maggio del 2018, pochi mesi
prima di vedere quel diritto finalmente riconosciuto, Loujain è stata però
arrestata, con pesanti accuse. Ora, dopo oltre due anni e mezzo dietro le
sbarre, è stata condannata da un Tribunale penale istituito per processare casi
di terrorismo: cinque anni e otto mesi di prigione. La sentenza, secondo fonti
di stampa saudite, riguarda l'accusa di "incitamento a cambiare il regime di
governo del regno e aver cooperato con individui ed entità per portare avanti
un'agenda straniera". Parte della condanna, due anni e dieci mesi, è stata però
sospesa, a patto che al-Hathloul "non commetta altri crimini per altri tre
anni", ha riferito sua sorella, Lina al-Hathloul. E questa riduzione, unita al
tempo già passato in carcere, potrebbe far sì che la donna sia liberata "nei
prossimi due mesi", ha scritto Lina su Twitter. Organizzazioni per la difesa dei
diritti umani hanno accusato le autorità saudite di aver arrestato al-Hathloul e
alcune altre attiviste saudite in seguito alla loro campagna per garantire alle
donne il diritto di guidare. Accuse che le autorità hanno sempre respinto, come
hanno sempre respinto le affermazioni secondo cui al-Hathloul nel corso della
detenzione ha dovuto subire torture, con scosse elettriche, frustate e molestie
sessuali, oltre ad essere stata confinata in isolamento totale per oltre tre
mesi dopo l'arresto. Secondo la sua famiglia, le sarebbe stata peraltro offerta
la libertà se avesse accettato di dire che non era stata torturata. La vicenda
ha contribuito ad aumentare la pressione internazionale sulle autorità saudite
già accusate a più riprese di disprezzo dei diritti umani, in particolare dopo
l'atroce assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, in cui è stato
implicato perfino il leader di fatto del Regno, il principe ereditario Mohammed
Bin Salman, noto come MBS. L'imminente liberazione di al-Hathloul potrebbe ora
allentare la tensione e Riad potrebbe trarne giovamento specie alla vigilia
dell'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, che avrà una politica sul
rispetto dei diritti umani con ogni probabilità ben più severa rispetto al
presidente uscente, Donald Trump.
Chi sono i sauditi e perché
sono importanti.
Giovanna Pavesi su Inside Over il 26 giugno 2021. La dinastia
saudita, per come il mondo la conosce oggi, è il “risultato” di secoli di
storia, intrighi, battaglie e conquiste durate anni. Istituita dal sultano del
Najd, Abd al-Aziz Al Sa ‘ud, governa dal 1926 il regno arabo saudita, nato dopo
la vittoriosa annessione al sultanato del regno hascemita del Hijaz. La realtà
saudita, da sempre, intreccia potere, politica e religione, ma soprattutto negli
ultimi anni è stata il baricentro economico non solo dell’Asia occidentale (di
cui fa parte), ma di tutto il mondo. Dietro ai Saud, che “prestano” il nome a
una delle più influenti famiglie della contemporaneità, c’è la storia di un
Paese, dei suoi nemici e dell’odierna Arabia Saudita, pedina fondamentale e
composita dello scacchiere politico internazionale. Le sue origini sono da
collocare tra il 1446 e il 1447, quando il clan dei Mrudah si stabilì nella
Penisola Arabica. Quello fu il primo fondamentale tassello a cui, però,
seguirono la fondazione dell’Emirato di Dir ‘iyya nel 1774, del Najd nel 1818 e,
infine, la fondazione del Regno dell’Arabia Saudita nel 1932. Ma per comprendere
meglio la complessa struttura dello Stato contemporaneo è necessario partire
dalle sue origini e soprattutto dai suoi antenati. Tutti appartenenti al clan
dei Mrudah.
Le origini: gli antenati dei
sauditi. Il primo “antenato” della dinastia saudita di cui gli storici e gli
esperti hanno informazioni certe è Mani ibn Rabi al-Muraydi, che si stabilì a
Diriyya tra il 1446 e il 1447, con il suo clan, quello dei Mrudah. Secondo
quanto riportato dalla tradizione, tutto iniziò quando Mani venne invitato da un
parente (che governava una serie di villaggi nella zona che oggi corrisponde a
Riad) a visitare l’area che la sua famiglia controllava. Ibn Dir diede a Mani le
proprietà di al-Mulaybid e Ghusayba, in cui lo fece insediare con la sua
famiglia. Mani, una volta stabilitosi in quella zona, chiamò la regione al
Diriyya, in omaggio al parente benefattore, Ibn Dir. I Mrudah divennero quindi i
sovrani di al-Diriyya, dominio che prosperò tra i corsi d’acqua nella Wadi
Hanifa e che divenne un importante insediamento nel Najd (regione che,
attualmente, si trova al centro dell’Arabia Saudita). E se all’inizio la
spartizione del potere all’interno del clan risultava facilmente governabile,
con la crescita della dinastia iniziarono a emergere le prime lotte per il
potere. Così uno dei due rami della famiglia partì per Dhruma, mentre gli al
Watban lasciarono la regione e si diressero nella città di al-Zubayr, nell’Iraq
meridionale. La famiglia degli al-Muqrin (il cui nome derivava dallo shaykh Sa
‘ud ibn Muhammad ibn Muqrin, che morì nel 1725) , in seguito, divenne sovrana
tra i Mrudah di Diriyya.
Il primo Stato saudita e il
wahhabismo. Il primo vero Stato saudita venne fondato ufficialmente nel 1774,
durante un periodo di grandi cambiamenti storici e di conquiste (anche
religiose). Alla sua massima estensione, l’Emirato di Dir ‘iyya comprendeva la
maggior parte dell’attuale Arabia Saudita e si imponeva come un luogo
di dominatori. Spinti da tanto potere, alleati, seguaci e sostenitori dei
sauditi, in quel periodo storico, si resero protagonisti di incursioni nello
Yemen, in Oman, in Siria e in Iraq. E se l’ascendente era forte sul piano
politico e di conquista, anche la religione iniziò a giocare un ruolo decisivo
in quell’area. Studiosi ed esperti di islam ritengono infatti che, nel periodo
di espansione, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, un arabo della tribù sedentaria dei
Banu Tamim, e i suoi discendenti abbiano avuto un importante (e decisivo)
ascendente sul governo saudita di quel periodo. Fu così che i sauditi e i loro
alleati, che si riferivano a loro stessi come muwahhidun (parola che significa
“monoteisti”), vennero definiti wahhabiti (dal nome del fondatore) e si
riconobbero in un gruppo di musulmani sunniti particolarmente osservanti. Il
wahhabismo, che si sviluppò come movimento di riforma religiosa all’interno
della comunità islamica sunnita hanbalita, è stato per oltre due secoli il credo
dominante nella Penisola Arabica ed è ancora una componente identitaria
importante dell’Arabia Saudita. Nei fatti, da sempre, il wahhabismo costituisce
una forma estremamente rigida di islam, che insiste su un’interpretazione quasi
letterale del Corano. Intanto, comunque, il potere della dinastia Saud si
consolidò senza particolari difficoltà e così, al primo imam, Muhammad ibn Sa
‘ud, succedette il figlio maggiore, ‘Abd al-Aziz Muhammad Sa ‘ud, nel 1765.
L'attacco di Karbala e le
conseguenze. Nel 1802, ‘Abd al-Aziz Muhammad Sa ‘ud guidò un esercito di 10mila
soldati wahhabiti nella città santa di Karbala, nell’odierno Iraq meridionale,
dove nel 680 venne ucciso Hosein, nipote del profeta Maometto e una delle figure
più importanti dell’islam sciita. In quella circostanza, i soldati di Sa ‘ud
uccisero più di 2mila persone, saccheggiarono la città e demolirono l’imponente
cupola dorata posta sulla tomba di Hosein. Da quel luogo, i sauditi portarono
via di tutto: oggetti preziosi, gioielli, armi, monete e altri beni di valore.
L’attacco di Karbala, che non si risolse soltanto in una comune questione
bellica, ebbe una risonanza religiosa determinante e convinse egiziani e
ottomani a ritenere i sauditi una minaccia alla pace della regione. ‘Abd al-Aziz
venne ucciso nel 1803, secondo alcuni da uno sciita che cercava vendetta per
quanto accaduto a Karbala l’anno prima, e a lui succedette il figlio Sa ‘ud. E
fu proprio con quest’ultimo che lo Stato saudita raggiunse la sua massima
estensione storica. Quando Sa ‘ud morì nel 1814, il suo successore, ‘Abd Allah,
si trovò costretto ad affrontare l’invasione ottomano-egiziana, lanciata con lo
scopo di recuperare il territorio ottomano perduto in precedenza. ‘Abd Allah
venne sconfitto e fatto prigioniero dalle truppe egiziane, che in seguito
presero anche la capitale Dir ‘iyya, nel 1818. L’Emirato di Dir ‘iyya finì con
la sua decapitazione da parte degli ottomani a Istanbul e la distruzione
egiziana della capitale Dir ‘iyya. Alcuni membri del clan saudita vennero poi
mandati dagli egiziani nell’attuale Turchia e in Egitto.
Il secondo Stato saudita:
l'Emirato del Najd. Alcuni anni dopo la caduta di Dir ‘iyya, nonostante
le esecuzioni e gli arresti, i sauditi riuscirono a ristabilire la loro autorità
nella regione del Najd, fondando l’Emirato del Najd, con capitale Riad. Quello
fu ufficialmente il secondo Stato saudita. Rispetto all’Emirato di Dir ‘iyya,
l’espansione territoriale del Najd fu sicuramente più ridotta (non ci fu la
riconquista di Hegiaz o di Asir, per esempio) e un’altra differenza sostanziale
fu un’osservanza certamente minore del credo religioso, nonostante i governanti
sauditi continuassero a utilizzare il titolo di imam e ad avvalersi di studiosi
salafiti per l’interpretazione del testo sacro. A segnare il lungo regno furono
anche diverse tensioni interne alla famiglia saudita, che provocarono la caduta
della dinastia. E così dopo alcuni conflitti e una guerra civile, il primo a
tentare di riprendere il potere dopo la caduta di Dir ‘iyya fu Mishari ibn Sa
‘ud, fratello dell’ultimo sovrano della capitale.
Il fondatore della seconda
dinastia. Nel 1824, Turki ‘Abd Allah, un saudita che riuscì a evitare la cattura
da parte degli egiziani, riuscì a espellere questi ultimi e i loro alleati
locali da Riad. Grazie a quel gesto, Turki, nipote del primo imam saudita,
Muhammad ibn Sa ‘ud, iniziò a essere considerato ifondatore della seconda
dinastia saudita e, in base alle analisi degli studiosi, sarebbe il vero
antenato dei sovrani sauditi attuali. Fece di Riad la capitale e decise di
accogliere lì molti parenti fuggiti dalla prigionia in Egitto, compreso suo
figlio Faysal. Turki venne ucciso nel 1834 da un lontano cugino, Mihari ibn ‘Abd
al-Rahman, che fu condannato a morte da Faysal, il quale alla morte del padre
divenne il più importante sovrano saudita del secondo regno. A quattro anni
dalla sua nomina, Faysal affrontò una seconda invasione del Najd da parte degli
egiziani. Ma in quella circostanza, la popolazione locale non reagì, né
resistette e Faysal venne sconfitto e fatto prigioniero in Egitto nel 1838.
L'insediamento di Khalid e il
ritorno di Faysal. Dopo l’allontanamento di Faysal, gli egiziani fecero
diventare sovrano di Riad Khalid ibn Sa ‘ud, sostenendolo con il loro apparato
militare. Questi era sì l’ultimo fratello ancora in vita dell’ultimo imam del
primo Stato saudita, ma aveva anche passato diverso tempo alla corte egiziana.
Nel 1840, l’avvio di nuovi conflitti esterni costrinse gli egiziani a ritirarsi
completamente dalla Penisola Arabica, lasciando Khalid ibn Sa ‘ud solo e poco
supportato. Percepito come un governatore a tutti gli effetti egiziano e solo
ufficialmente saudita, fu spodestato poco tempo dopo da ‘Abd Allah ibn
Thumiyyan, del ramo familiare degli Al Thuniyyan. Faysal, liberato nello stesso
periodo, riuscì a riprendersi Riad, ad assumere il controllo della zona e a
designare suo figlio ‘Abd Allah come principe ereditario, anche se divise i suoi
domini tra tutti suoi eredi: ‘Abd Allah, Sa ‘ud e Muhammad. Alla morte di
Faysal, nel 1865, ‘Abd Allah assunse il governo di Riad, ma il fratello Sa ‘ud
lo sfidò. Un’altra guerra civile insanguinò lo Stato e la sovranità della città
passò da un fratello all’altro. Tuttavia, in precedenza, un vassallo dei sauditi
che apparteneva alla famiglia Al Rashid, colse nella crisi familiare
l’opportunità di inserirsi e di intervenire nel conflitto, accrescendo così il
proprio potere. Ibn Rashid, poco alla volta, estese la propria autorità su tutta
la regione del Najd, inclusa la capitale Riad, ed espulse l’ultimo leader
saudita, dopo la battaglia di Mulayda nel 1891.
L’ascesa di Ibn Sa ‘ud e la
nascita dell’Arabia Saudita. Dopo la sconfitta a Mulayda, ‘Abd al-Rahman ibn
Faysal fu costretto all’esilio con la sua famiglia, nel deserto dellArabia
orientale, tra gli appartenenti alla comunità beduina di al-Murra, e in seguito
si rifugiò in Kuwait, ospite dell’emiro Mubarak al Sabah. Nel 1902, suo figlio,
‘Abd al-Aziz si impegnò a ripristinare la sovranità saudita a Riad. Sostenuto da
una decina di seguaci e accompagnato da altri membri della sua cerchia
familiare, ‘Abd al-Aziz riuscì a impossessarsi del forte Masmak e a uccidere il
governatore nominato da Ibn Rashid. Secondo quanto riporta il racconto, ‘Abd
al-Aziz, soltanto con una manciata di soldati, riuscì a prendere il palazzo e
venne immediatamente proclamato sovrano di Riad e come nuovo capo della dinastia
saudita, ‘Abd al-Aziz divenne allora Ibn Sa ‘ud.
Abd al-Aziz dell’Arabia
Saudita è stato il fondatore e primo sovrano del Paese. Nei trent’anni
successivi provò a ristabilire la sovranità della sua famiglia nella Penisola
Araba, iniziando dalla regione del Najd (dalla quale proveniva il clan). Tra i
suoi principali rivali c’erano, ovviamente, il clan al Rashid ad Hali (al quale,
di fatto, aveva sottratto la sovranità), lo sharif della Mecca in Hijaz,
i turchi ottomani ad al-Hasa e il ramo “Sa ‘al-Kabir” della famiglia, cioè i
discendenti di Sa ‘ud ibn Faysal, zio di Ibn Sa ‘ud ormai scomparso, i quali si
definivano i legittimi eredi al trono. Per un po’, Ibn Sa ‘ud riconobbe la
sovranità dei sultani ottomani, ma scelse infine di schierarsi contro di loro,
al fianco dei britannici. Con il trattato di Darin, che venne firmato nel 1915,
i territori di Ibn Sa ‘ud diventarono ufficialmente un protettorato britannico
(e li rimasero fino al 1927). ‘Abd al-Aziz conquistò il Najd nel 1922 e l’Hijaz
nel 1925. E da sultano del Najd diventò prima re del Hijaz e Najd e poi, nel
1932, si autoproclamò re del Regno dell’Arabia Saudita. Negli anni successivi,
una serie di importanti scoperte, svelarono le potenzialità di quei territori.
Nel 1937, per esempio, vicino a Dammam, alcuni periti americani scoprirono
l’enorme riserva petrolifera che, negli anni a seguire, avrebbe fatto la fortuna
del Paese. Intanto, Ibn Sa ‘ud, che si sposò e divorziò diverse volte, ebbe 12
figli ed entrò a far parte di diversi clan e tribù del suo territorio (tra cui
le tribù Banu Khalid, Ajman, Shammar e al-Shaykh, discendenti di Muhammad ibn
‘Abd al-Wahhab). Scelse di indicare il suo figlio maggiore, Sa ‘ud, come suo
possibile erede, a cui sarebbe dovuto succedergli Faysal. La famiglia saudita
venne riconosciuta a tutti gli effetti come una famiglia reale e ogni suo
membro, maschio o femmina che fosse, venne insignito del titolo
di amir e amira (in arabo, principe e principessa). Nel 1945, Ibn Sa ‘ud volle
consolidare la sua alleanza con gli Stati Uniti, legame che ha retto per tutto
il Novecento. Morì nel 1953 ed è tuttora celebrato ufficialmente come il padre
fondatore dello Stato. La data della riconquista di Riad, nel 1902, venne scelta
per celebrare il centenario dell’Arabia Saudita. Oggi, soltanto i suoi
discendenti possono prendere il titolo di altezza reale.
L'attuale dinastia. Alla morte
di Ibn Sa ‘ud, il figlio Sa ‘ud salì al trono senza troppe difficoltà, ma la sua
gestione economica della casa reale portò a una lotta interna per il potere con
il nuovo principe ereditario Faysal. Così, nel 1964, la famiglia reale, aiutata
da un responso giuridico del gran mufti del Paese, obbligò Sa ‘ud ad abdicare in
suo favore. Nello stesso periodo, alcuni dei figli più giovani di Ibn Sa ‘ud
scelsero di abbandonare la famiglia ed entrare in Egitto con l’appellativo di
“principi liberi”. Faysal li convinse a tornare indietro, ma la scelta di
lasciare il Paese li escluse da futuri ruoli di governo. Il sovrano morì
assassinato nel 1975, per mano del nipote Faysal ibn Musa ‘id (che venne
giustiziato subito dopo) e salì al trono Khalid, un altro fratello (anche se il
principe designato sarebbe stato Muhammad, che però rinunciò), che però morì per
un attacco di cuore nel 1982. Gli successe Fahd, il più vecchio dei potenti
“sette Sudayri“, chiamati in questo modo perché figli di Ibn Sa ‘ud e Hassa
al-Sudayri. Nel 1986, Fahd decise di eliminare il precedente trattamento reale
di “sua Maestà” e lo sostituì con il “Custode delle Due Sacre Moschee“, in
riferimento alle città sante sunnite della Mecca e di Medina. Nel 1995, Fahd
ebbe un infarto che lo rese fisicamente disabile e il principe ereditario, ‘Abd
Allah, gradualmente, assunse molte delle responsabilità del re, fino alla sua
morte, che avvenne nell’agosto del 2005. ‘Abd Allah venne proclamato sovrano nel
giorno del decesso del padre e subito nominò suo fratello più giovane, Sultan
bin ‘Abd al-‘Aziz, che era ministro della Difesa e secondo vice primo ministro,
come nuovo successore. Il 27 marzo del 2009, ‘Abd Allah nominò il principe Nayef
ministro degli Interni, secondo vice primo ministro e, infine, principe
ereditario il 17 ottobre del 2011. Sultan morì nello stesso periodo, mentre
Nayef terminò la sua vita a Ginevra, in Svizzera, il 15 giugno del 2012. Il 23
gennaio 2015, ‘Abd Allah, dopo nove anni di regno, si spense a causa di una
lunga malattia. Così, il principe ereditario Salman bin ‘Abd al-Aziz al Sa
‘ud fu proclamato nuovo re. È attualmente il sovrano del Paese ed è di tendenza
conservatrice. Per quanto più restio al cambiamento sociale e alle riforme
politiche, è previsto che il re continui sul sentiero tracciato dal suo
predecessore, che teneva alla modernizzazione, ma che supervisionò un regime
criticato per lo scarso rispetto dei diritti umani. Il 21 giugno 2017, il
sovrano ha nominato suo figlio, il 35enne Mohammad bin Salman al Sa ‘ud, erede
apparente e, come principe ereditario, è il primo nella linea di successione al
trono.
La successione e la gestione
del potere. Il re dell’Arabia Saudita è, a tutti gli effetti, il capo di Stato
del Paese e il monarca del regno, ma è anche e soprattutto il capo della
famiglia saudita. I monarchi che, nel tempo, si sono succeduti dopo la morte del
fondatore sono tutti suoi figli, in ottemperanza alla legge araba, la quale
prevede che alla successione di un’istituzione sia chiamato il componente più
anziano della famiglia. Lo decide un’assemblea del nucleo, che sceglie l’erede
dalla generazione del predecessore o da quella immediatamente successiva,
privilegiando non tanto e non sempre il figlio di un sovrano deceduto, quanto il
più anziano membro della famiglia. A differenza delle famiglie reali
occidentali, la monarchia saudita non ha un ordine di successione ben definito.
Tuttavia, una volta diventato re, il sovrano designa il proprio erede al trono
(che diventa quindi il principe ereditario del regno). Alla morte del re,
quest’ultimo dovrebbe prendere il suo posto e in caso di assenza di poteri del
monarca è sempre lui ad assumerne le facoltà. In ogni caso, il re detiene un
potere politico quasi assoluto e nomina i ministri del suo ufficio. I dicasteri
decisivi sono, da sempre, la Difesa, gli Interni, gli Esteri e quasi tutti i 13
posti di governatore regionale sono riservati agli al Saud. In genere, la
maggior parte dei portafogli, come quello per le Finanza, il Lavoro,
l’Informazione, le Pianificazioni, gli Affari petroliferi e l’Industria vengono
affidati a cittadini comuni, affiancati da vice appartenenti alla dinastia. La
famiglia al Saud detiene anche la maggior parte delle cariche più importanti
(militari e governative), anche se il supporto degli ulama, cioè i teologi
islamici più importanti, e di parte della popolazione risultano fondamentali per
il mantenimento e la gestione del potere. Le varie cariche di governo di lunga
durata hanno tramandato la creazione di veri e propri feudi dove i principi più
anziani hanno mescolato le loro ricchezze private con quelle dei rispettivi
domini, intrecciando ancora di più politica e dinastia.
L'opposizione e i dissidenti.
Considerata a capo di un governo autoritario e teocratico, l’attuale dinastia
saudita è stata spesso oggetto di molte critiche per il trattamento della
dissidenza e lo scarso rispetto dei diritti umani. Gli oppositori dei Saud hanno
spesso definito la monarchia un sistema di governo dittatoriale e totalitario.
Ed è vero che, negli anni, diverse forme di resistenza si sono opposte alla
gestione autoritaria dei Saud e la risposta della famiglia reale è stata oggetto
di critiche internazionali. Il 20 novembre del 1973, per esempio, il santuario
alla Mecca venne occupato da 500 dissidenti armati (in particolare uomini della
tribù Ikhwan degli Otayba), compresi alcuni egiziani che frequentavano
l’università islamica di Medina. L’occupazione venne guidata da Juhayman
al-Otaybi e ‘Abd Allah al-Qahtani, i quali denunciavano la corruzione e
l’immoralità del governo saudita (“colpevole” della sua modernizzazione
socio-tecnologica e di vendere il petrolio all’America). Il gesto ebbe poco
seguito al di fuori del gruppo che inscenò la protesta e la famiglia saudita si
rivolse agli ulama per risolvere la questione. I religiosi decisero di emettere
una fatwa, che autorizzava l’assalto al santuario da parte delle forze armate
saudite, aiutate da soldati francesi e pachistani, che impiegarono due settimane
per far uscire i ribelli dal luogo sacro. In quella circostanza, tutti i
sopravvissuti, compreso al-Otaybi, vennero condannati alla pena capitale e
decapitati pubblicamente. Attualmente, non sembrano del tutto chiare le modalità
con cui sono trattati gli oppositori politici. Rimane, infatti, ancora un
parzialmente un mistero, la fine del giornalista del Washington post e
dissidente saudita, Jamal Khashoggi, ucciso e fatto sparire in Turchia
nell’autunno del 2018, mentre si trovava all’interno dell’ambasciata del regno.
La ricchissima (e influente)
famiglia Saud. Secondo quanto riportato da un articolo dell’agosto del 2019
del Corriere della sera, quella di re Salman risulta essere una delle famiglie
più ricche del mondo. E non è corretto ridurre il motivo di tanta ricchezza
soltanto alle vaste riserve di petrolio (che fruttano una fortuna stimata in 100
miliardi di dollari): molte delle persone appartenenti a questo nucleo
familiare, negli anni, hanno accumulato beni e fortune attraverso
l’intermediazione di contratti governativi e fondiari e creando imprese che
servono, per esempio, aziende statali. Soltanto il principe ereditario, infatti,
controlla personalmente beni per oltre un miliardo di dollari.
Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera" il 31
marzo 2021. Le vie del deserto sembrano particolarmente trafficate. Specialmente
quelle che conducono sotto la tenda del principe Mohammed bin Salman, l'uomo
forte dell'Arabia saudita - e mandante diretto, secondo la stessa Cia,
dell'assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Sono soprattutto gli
ex primi ministri europei che non sembrano avere particolari esitazioni a
stringere la mano insanguinata di MBS (sigla con cui è conosciuto il principe).
Del nostro Matteo Renzi sapevamo già, così come delle sue lodi al «rinascimento
saudita» (per maggiori informazioni, chiedere alla vedova Khashoggi); ma adesso
si scopre che a godere dell'ospitalità di Bin Salman, addirittura in campeggio
fra le dune, è stato pure l'ex premier britannico David Cameron, volato lì in
qualità di lobbista della Greensill Capital, la discussa società finanziaria di
cui era diventato consulente dopo aver lasciato Downing Street. Il viaggio, ha
raccontato il Financial Times , sarebbe avvenuto all'inzio del 2020, subito
prima dello scoppio della pandemia. Ma Cameron era andato a Riad già
nell'ottobre del 2019, per partecipare alla cosiddetta «Davos del deserto»: una
visita che era avvenuta un anno dopo l'omicidio Khashoggi e che già Amnesty
International aveva criticato perché poteva «essere interpretata come una
dimostrazione di supporto per il regime saudita» nonostante «gli spaventosi
precedenti in tema di diritti umani». Considerazioni che evidentemente non hanno
impedito a Cameron (e dopo di lui a Renzi) di fraternizzare col despota
mediorientale. D'altra parte, gli ex premier sono di bocca buona: il loro
modello sembra essere Tony Blair, che dopo aver lasciato la politica attiva ha
fatto da consulente ai peggiori regimi, da quello egiziano di Al-Sisi a quelli
dei satrapi centro-asiatici. Ma come si sa, pecunia non olet : e Cameron
dall'attività di lobbista per la Greensill Capital, esercitata tanto con i
sauditi che col governo di Londra, si apprestava a incassare 60 milioni di
sterline. La finanziaria però è crollata per le sue dubbie pratiche d'affari e
ora a Londra si reclama a gran voce che Cameron risponda a parecchie domande.
“Renzi in Arabia? I parlamentari non
prendano soldi dai governi stranieri”. Calenda: "Metà
del mondo non è democratico e bisogna averci a che fare, ma attraverso le
relazioni diplomatiche, non incassando soldi personalmente mentre si è pagati
dai cittadini italiani. Questo è il punto". Il Dubbio martedì 2 marzo 2021.
“Invece di continuare questa discussione all’infinito sarebbe meglio varare una
norma che vieti ad un rappresentante in carica di percepire soldi direttamente o
indirettamente da un governo straniero”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione
ed europarlamentare, intervistato dal Corriere della Sera, sulla partecipazione
di Matteo Renzi alla "Davos nel deserto" a Riad. Renzi è membro del board del
Future investment initiative voluta da Mohammed bin Salman, da cui riceverebbe
un compenso annuo di 80 mila euro. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe
Biden, ha indicato nel principe ereditario dell’Arabia Saudita il mandante del
rapimento e dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Renzi ha
definito l’Arabia un “baluardo contro l’estremismo islamico, uno dei principali
alleati dell’Occidente da decenni”. “Difendersi menzionando i rapporti tra
governi vuol dire buttare la palla fuori campo – sostiene Calenda -. Metà del
mondo non è democratico e bisogna averci a che fare, ma attraverso le relazioni
diplomatiche, non incassando soldi personalmente mentre si è pagati dai
cittadini italiani. Questo è il punto”.
"Contro di me odio e vendetta dei pm
rossi orfani di Conte". Premessa: senatore Matteo
Renzi, lei parla di vaccini, di giustizia, o d'altro, per non rispondere alle
critiche per i suoi rapporti con l'Arabia Saudita? Augusto Minzolini - Mar,
02/03/2021 - su Il Giornale.
Premessa: senatore Matteo Renzi, lei parla di
vaccini, di giustizia, o d'altro, per non rispondere alle critiche per i suoi
rapporti con l'Arabia Saudita?
«È vero il contrario. Stanno strumentalizzando la
tragedia di Kashoggi perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia. Nel
merito ho risposto su tutti i giornali, dal Financial Times a Le Monde: ciò che
faccio può essere discusso da chiunque, ma è perfettamente lecito, pubblico e
legittimo. La questione saudita è stata posta da quel noto statista di Di
Battista, uno che apprezzava Maduro e definiva Obama golpista e non capisce che
l'Arabia è il baluardo contro il fondamentalismo. E ovviamente dai più rancorosi
del Pd. Credo di essere la loro ossessione. Se parlassero un po' più di idee e
un po' meno di me, ci guadagnerebbero almeno in salute».
Il più duro, però, è stato uno degli esponenti di
primo piano di Magistratura Democratica, Nello Rossi. È arrivato a dire che
bisognerebbe «stringere un cordone sanitario» intorno a Matteo Renzi...
«Nello Rossi è uno degli esponenti più in vista di
Magistratura democratica. Si può dire che ne è stato l'ideologo. Un personaggio
che ha un lungo passato come magistrato. Ascoltatissimo ed influente non solo
nella sua corrente. Non so, andrebbe approfondito, se nella sua carriera è mai
venuto in contatto con il cosiddetto sistema Palamara, quello raccontato nel
libro scritto con Sallusti. Ebbene, l'uso dell'espressione cordone sanitario nei
confronti di una persona che ha un ruolo nelle istituzioni parlamentari, che
ricopre una carica importante in un partito della maggioranza di governo e che
in passato è stato anche presidente del Consiglio, lo trovo a dir poco
allucinante. Resto allibito ma non sorpreso, perché avverto un clima di odio e
di rabbia che cova in una parte dell'establishment di questo Paese rimasto
legato agli equilibri del governo passato che non si dà per vinto...».
Dai veleni alle querele. Il
caso Arabia Saudita scuote la maggioranza.
Pd e grillini contro l'alleato
Renzi per i rapporti con Riad. E lui denuncia Travaglio. Paolo Bracalini - Lun,
01/03/2021 - su Il Giornale. Con una maggioranza che va dal Pd alla Lega,
passando per Forza Italia e Cinque stelle, il tasso potenziale di litigiosità è
enorme. Le tensioni non sono ancora esplose in modo fragoroso ma agitano le
acque fin dal primo giorno di insediamento di Draghi e si stanno facendo sentire
in particolare sull'asse M5s-Iv-Pd. La presenza di Renzi, il disgregatore della
precedente maggioranza di Conte, è un forte elemento perturbatore, soprattutto
per i Cinque stelle alle prese con la scissione della corrente di Di Battista,
ma con scosse anche dentro il Pd. Il punto è ancora il rapporto tra il leader di
Italia Viva e l'Arabia Saudita, visto che Renzi svolge un incarico (retribuito)
di conferenziere e membro dell'advisory board del FII Institute, un organismo
controllato dal fondo sovrano saudita Saudi public investment Fund (Pif)
presieduto dal principe Mohammad bin Salman. La vicenda è riesplosa dopo il
rapporto della Cia che accusa espressamente il principe ereditario bin Salman
per l'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. La nuova
autodifesa di Renzi («L'Arabia Saudita è un baluardo contro l'estremismo
islamico ed è uno dei principali alleati dell'Occidente da decenni») ha
scatenato le critiche degli alleati, dal Pd («È irresponsabile dal punto di
vista morale e istituzionale ricevere un compenso economico da una dittatura
straniera mentre si svolgono le funzioni di Senatore» attacca Andrea Romano) e
dai Cinque stelle che definiscono «una farsa» la spiegazione di Renzi e chiedono
che «convochi formalmente una conferenza stampa per rispondere alle domande dei
giornalisti, piuttosto che fare comodi monologhi» scrivono i deputati M5s della
commissione Esteri. L'ex M5s Alessandro Di Battista chiede le dimissioni del
leader Iv dalle colonne del Fatto, quotidiano vicino alla galassia grillina che
titola: «Renzi d'Arabia si tiene i soldi insanguinati». Articoli che fanno
partire l'ennesima querela del senatore di Rignano, che pubblica una foto con
tenuta e casco da bici accompagnata dal commento: «Oggi è una giornata
bellissima, con un sole che scalda il cuore. Non è il giorno giusto per fare
polemica o per arrabbiarsi. È sempre il giorno giusto, invece, per citare in
giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano vista l'ennesima aggressione di
questa mattina. Non c'è da arrabbiarsi. Solo prendere nota, denunciare e
aspettare le sentenze. Il tempo è galantuomo». La convivenza tra Renzi e
grillini insieme nel governo Draghi si annuncia movimentata. Ma non c'è solo
quello a far traballare la maggioranza, anche il passaggio di due big del Pd
come Pier Carlo Padoan e Marco Minniti dalla politica rispettivamente a
Unicredit e Leonardo-Finmeccanica, alimenta le polemiche sulle porte girevoli
tra politica e interessi privati. Anche qui ad alimentarle è Di Battista,
tornato alla carica come disturbatore dell'asse tra grillini e Pd, un nervo
scoperto del Movimento sopratutto ora che i vertici intendono consegnare il M5s
a Conte proprio con l'obiettivo di saldare l'alleanza a sinistra anche alle
prossime scadenze elettorali. Un abbraccio con il «partito di Bibbiano» che è
indigesto per molti elettori grillini, e sui cui soffia Dibba: «Due ex ministri
del governo Gentiloni, prima Padoan e ora Minniti, sono passati dall'essere
deputati a incarichi per imprese attive nei settori di cui si occupavano da
ministri. È tutto a norma di legge, ma in un Paese normale non dovrebbe
accadere».
Da ansa.it il 28 febbraio 2021. "Ricevo molti
attacchi da PD, Leu e soprattutto Cinque Stelle che, strumentalizzando una
tragedia come quella dell'uccisione del giornalista saudita Khashoggi, mi
invitano a chiarire rispetto alla mia partecipazione all'evento
'Neo-Renaissance' di Riyad". Lo scrive Matteo Renzi sua enews, rispondendo alle
polemiche. A chi gli chiede se svolga "attività stile conferenze o
partecipazione ad advisory board o attività culturali o incarichi di docente
presso università fuori dall'Italia", Renzi risponde che "sì" lo fa, che "sono
previste dalla legge" e che riceve "un compenso sul quale pago le tasse in
Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente
legale e legittimo", spiega. Poi, parlando del programma Vision2030, Renzi
spiega che "rispettare i diritti umani è una esigenza che va sostenuta in Arabia
Saudita come in Cina, come in Russia, come in tutto il Medio Oriente, come in
Turchia. Ma chi conosce il punto dal quale il regime saudita partiva sa
benissimo che Vision 2030 è la più importante occasione per sviluppare
innovazione e per allargare i diritti". Riguardo la vicenda Khashoggi, afferma
ancora, "ho condannato già tre anni fa quel tragico evento -e l'ho fatto anche
nelle interviste" e "su tutti i giornali del mondo. Difendere i giornalisti in
pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l'ho fatto sempre, anche quando sono
rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti turchi
arrestati. Difendere la libertà dei giornalisti è un dovere, ovunque,
dall'Arabia Saudita all'Iran, dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba,
alla Cina". "Sì. Non solo è giusto, ma è anche necessario. L'Arabia Saudita è un
baluardo contro l'estremismo islamico ed è uno dei principali alleati
dell'Occidente da decenni. Anche in queste ore - segnate dalla dura polemica
sulla vicenda Khashoggi - il Presidente Biden ha riaffermato la necessità di
questa amicizia in una telefonata al Re Salman. Ma Biden ha chiesto giustamente
di fare di più. Soprattutto sulla questione del rispetto dei giornalisti", ha
aggiunto Renzi.
Perché Md si occupa delle visite a Riad
se non c’è nulla di illecito? Non solo M5S, Pd e Leu.
Anche Magistratura democratica punta il dito contro Matteo Renzi per le
conferenze saudite. Rocco Vazzana su Il Dubbio il 2 marzo 2021. Non solo M5S, Pd
e Leu. Anche i magistrati puntano il dito contro Matteo Renzi per le conferenze
saudite. O meglio, una parte della magistratura organizzata, Md (la corrente di
sinistra delle toghe) che sulla sua rivista on line Questione giustizia ospita
un articolo dal titolo più che eloquente: «Legittimare un despota? E per un
piatto di lenticchie?». A firmarlo è il direttore Nello Rossi, già avvocato
generale presso la Corte di cassazione ed ex membro del Csm. «Se l’Italia vuole
conservare un accettabile grado di credibilità nel contesto internazionale, deve
stringere un cordone sanitario intorno a sortite come quella ‘ araba’ di Matteo
Renzi, ricordandogli che essere stato presidente del Consiglio comporta oneri
anche quando si è cessati dalla carica e che essere parlamentari di una
Repubblica democratica non è compatibile eticamente e politicamente – con
l’adulazione dei despoti», scrive il magistrato in quiescenza. Ma è proprio
questo il punto: perché un magistrato, seppur in pensione, si occupa di politica
e di etica sulla rivista di una corrente dell’Anm? Cosa sarebbe accaduto a parti
invertite, se cioè fosse stato un politico, seppur non più in attività, ad
attaccare un magistrato nel pieno delle sue funzioni? Il problema non riguarda
il punto di vista di Nello Rossi, che può essere condivisibile o meno, ma
l’opportunità delle parole pronunciate da chi non dovrebbe curarsi di questioni
attinenti alla giustizia. Altrimenti i campi si mescolano fino a diventare
indistinti e un potere costituzionalmente riconosciuto rischia di prevaricare su
un altro. E come nel caso di Renzi a Riad: anche per Nello Rossi nulla di
illecito, tanto di sconveniente.
Raphael Zanotti per "La Stampa" il 3 marzo 2021.
Quando parliamo delle armi che l' Italia ha venduto all' Arabia Saudita durante
il governo Renzi riportiamo cifre, citiamo report, mostriamo grafici. Ma la
morte non è mai una somma aritmetica. Alle 3 del mattino dell' 8 ottobre 2016 la
famiglia Al Ahdal stava dormendo nella sua abitazione a Deir Al-Hajari, piccola
cittadina nello Yemen nord occidentale, quando una bomba sganciata da un caccia
dell' aviazione saudita ha raso al suolo la loro casa. Husni, sua moglie Qaboul
- incinta al quinto mese - e i figli Taqia, Fatima, Sarah e Mohammed sono morti
nel sonno, dilaniati da un ordigno venduto all' Arabia Saudita. Tra i calcinacci
e i giochi dei bambini sono stati trovati i resti di una bomba MK80. Il sistema
di guida intelligente non ha saputo distinguere la casa degli Al Ahdal dal
checkpoint militare che distava 300 metri dalla loro camera da letto. Un anello
di sospensione, componente bellico necessario per caricare la bomba sull' aereo,
riportava la sigla della Rwm Italia, la ditta autorizzata dal nostro governo a
vendere a Riad ventimila bombe al prezzo di 411 milioni di euro. Da pochi
giorni, per quelle morti, sono indagati i vertici della Rwm Italia e dell' Uama,
l' autorità italiana che concede le autorizzazioni all' export di armamenti. È
la prima volta che accade. Tanto che l' Italia è diventata un caso
internazionale. L'indagine è condotta dalla procura di Roma ed è stata avviata
grazie all' enorme lavoro di denuncia portato avanti da tre organizzazioni: la
Rete italiana Pace e Disarmo, il centro europeo per i diritti costituzionali e
umani Ecchr di Berlino e la Ong yemenita Mwatana che nell' aprile del 2018
avevano presentato un esposto lamentando la violazione delle norme italiane e
internazionali nella vendita di armi ai sauditi. Inizialmente la procura aveva
chiesto l' archiviazione nonostante avesse accertato che l' anello di
sospensione era stato esportato nel novembre 2015. Il gip di Roma, tuttavia, ha
rigettato l' archiviazione e ha disposto altri sei mesi di indagine per
accertare le eventuali responsabilità italiane e della Rwm. L' Uama poteva non
sapere che uso avrebbe fatto l' Arabia Saudita delle armi che le venivano
vendute? Come mai i funzionari italiani non hanno tenuto in considerazione i
rapporti sulla guerra in Yemen, che già all' epoca segnalavano la possibile
commissione di crimini di guerra da parte della coalizione saudita? C' è un
passaggio fondamentale nell' ordinanza del giudice di Roma, che forse spiega più
di mille parole come si è giunti a questo punto. L' Uama, nel 2016, ha
autorizzato la più grande commessa di bombe che il nostro Paese abbia mai avuto,
sostenendo che si trattava di un' operazione «in linea con la legislazione
nazionale e internazionale, in grado di generare un positivo indotto sul piano
economico e sociale per l' Italia». Scrive il giudice: «Il pur doveroso,
imprescindibile impegno dello Stato per salvaguardare i livelli occupazionali
non può, nemmeno in astratto, giustificare una consapevole, deliberata
violazione di norme che vietino l' esportazione di armi verso Paesi responsabili
di gravi crimini di guerra e contro le popolazioni civili». È l' annientamento
di uno dei meccanismi più perversi dell' industria bellica in generale: il
mantenimento dei posti di lavoro o il doveroso sviluppo di un settore
industriale strategico da parte di uno Stato non può in alcun modo giustificare
la violazione dei diritti umani. L'indagine riguarda la Rwm e l' Uama, ma non
possiamo chiudere gli occhi. Se tra il 2014 e il 2016, durante il governo Renzi,
l'export delle armi italiane è sestuplicato, questo non può dipendere da
funzionari o dalle abilità produttive di un attore privato. L'industria bellica
non può prescindere dalle indicazioni in politica estera provenienti dal
governo. E di tutto questo, forse, un giorno, dovremo rispondere alla famiglia
Al Ahdal.
Ora si indaga sulle armi italiane vendute
all’Arabia Saudita. Roberto Vivaldelli su Inside Over
il 4 marzo 2021. Il boom di armi italiane vendute ai sauditi durante il governo
Renzi diventa un caso internazionale oltre che giudiziario. Come riporta La
Stampa, infatti, risultato indagati i vertici della Rwm Italia, ditta
autorizzata dal nostro governo a vendere a Riad 20mila bombe al prezzo di 411
milioni di euro, e dell’Uama, l’autorità italiana che concede le autorizzazioni
all’export di armamenti. L’indagine, condotta dalla procura di Roma, è stata
avviata grazie all’esposto presentato nell’aprile 2018 dalla Rete italiana pace
e disarmo, dal centro europeo per i diritti costituzionali e umani Ecchr di
Berlino e dalla Ong yemenita Mwatana: anche se in un primo momento la procura
aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine, il gip l’ha rigettata e ha disposto
altri sei mesi di indagine per accertare le eventuali responsabilità italiane e
della Rwm. In particolare, va fatta chiarezza sull’attacco a Deir al-Hajari, nel
nord-ovest dello Yemen, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016. Lo si deve, fra
gli altri, alla famiglia al-Ahdal, sterminata da un bombardamento della
coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Come denuncia la
Rete italiane Pace e Disarmo in un post pubblicato lo scorso 27 ottobre sul sito
dell’organizzazione, “esistono ampie e affidabili prove che nella guerra nello
Yemen vengano utilizzati equipaggiamenti militari prodotti in Italia, come gli
aerei da combattimento Eurofighter Typhoon e Tornado (prodotti congiuntamente
dal Consorzio Eurofighter, di cui Leonardo S.p.A. è uno degli azionisti) e le
bombe della serie MK 80 (prodotte in particolare da RWM Italia S.p.A.), i cui
resti sono stati trovati sul luogo di potenziali crimini di guerra in Yemen.
Questo materiale viene esportato in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Kuwait”.
L’export di armi italiane verso Riad diventa un
caso. In questo contesto, scrive sempre l’organizzazione che si batte contro
l’esportazione delle armi italiane verso i Paesi del Golfo, l’11 dicembre 2019 è
stata depositata una Comunicazione alla Corte Penale Internazionale da parte di
ECCHR, Mwatana for Human Rights e delle loro organizzazioni partner, tra cui la
Rete Italiana per il Disarmo (ora Rete Italiana Pace e Disarmo). La
Comunicazione “sollevava la questione della responsabilità delle aziende
italiane ed europee produttrici di armi, nonché delle autorità nazionali che
rilasciano licenze di esportazione, nel conflitto yemenita. Queste
organizzazioni della società civile internazionale chiedono un’indagine sulla
presunta complicità dei dirigenti delle aziende in 26 attacchi aerei che hanno
ucciso o ferito illegalmente civili e distrutto o danneggiato scuole, ospedali e
altri luoghi protetti”.
“Gravi violazioni di diritti umani”. Infatti, in
risposta alle gravi violazioni dei diritti umani commesse nello Yemen, nel
luglio 2019 il Governo italiano ha sospeso fino a gennaio 2021 tutte le licenze
per bombe aeree, missili e loro componenti verso l’Arabia Saudita e gli Emirati
Arabi Uniti. Ma nonostante lo stop, denunciava in un altro post datato maggio
2020 l’organizzazione umanitaria, nei mesi scorsi “sono state rilasciate nuove
autorizzazioni per quasi 200 milioni di euro e le consegne definitive
certificate dalle Dogane hanno raggiunto i 190 milioni di euro” verso il regno
saudita e gli Emirati (Guarda il reportage di InsideOver dallo Yemen). Le gravi
violazioni commesse dalla coalizione a guida saudita in Yemen sono state
denunciate da numerose organizzazioni internazionali. Nel 2019, un gruppo di
esperti delle Nazioni Unite ha presentato un rapporto a Ginevra mettendo in
evidenza la possibilità che in Yemen si siano perpetrati “una serie di crimini
di guerra”. Secondo le indagini condotte dal gruppo di esperti dell’Onu, le
violazioni comprendono crimini commessi attraverso gli attacchi aerei,
bombardamenti indiscriminati, uccisioni e detenzioni arbitrarie, torture e
violenza sessuale. Secondo Amnesty International, dal 2015 in poi, la coalizione
guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che appoggia il governo
yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, continua a bombardare
infrastrutture civili e a compiere attacchi indiscriminati, che uccidono e
feriscono centinaia di civili. Inoltre, tutte le parti in conflitto hanno
soppresso la libertà d’espressione ricorrendo a detenzioni arbitrarie,
sparizioni forzate, maltrattamenti e torture. La stessa Ong aveva avviato una
campagna per chiedere di interrompere l’export di armi verso l’Arabia Saudita.
Boom di export di armi durante il governo Renzi.
Come già evidenziato da InsideOver, durante il governo Renzi (22 febbraio 2014
al 12 dicembre 2016) l’export di armi è schizzato alle stelle, grazie proprio
alle generose commesse arrivate dall’Arabia Saudita. Nel 2013, prima
dell’insediamento di Renzi a Palazzo Chigi, il nostro Paese aveva autorizzato
l’esportazione di armi per un valore di 2,1 miliardi di euro. Nulla in confronto
al periodo nel quale Renzi era in carica, dove l’export è cresciuto del 581%,
toccando i 14,6 miliardi di euro, come documentato da Giorgio Beretta del’Opal
di Brescia, l’osservatorio permanente sulle armi leggere. Con Renzi al governo,
secondo La Stampa, Riad ha ottenuto l’autorizzazione a ricevere oltre 855
milioni di euro in armamenti contro i poco più di 170 milioni del triennio
successivo.
Alessandro Di Matteo per “La Stampa” il 28
febbraio 2021. In gergo militare si parlerebbe di "danni collaterali",
addirittura di "fuoco amico". Il rapporto della Cia - diffuso
dall'amministrazione Biden per lanciare una serie di messaggi ai principali
protagonisti dello scacchiere medio-orientale - finisce per trascinare, di
nuovo, nella bufera Matteo Renzi, che pure vanta buoni rapporti con il
neo-presidente Usa e con il suo principale sostenitore, Barack Obama. Ad
attaccare è Sinistra italiana, ma anche M5S e lo stesso Pd, cioè gli ex alleati
del Conte bis. Il problema, per il leader di Iv, è che quelle quattro pagine
della Cia chiamano in causa direttamente il principe ereditario saudita Mohammed
Bin Salman, per il brutale omicidio del giornalista Jamal Kashoggi. Proprio quel
Bin Salman pubblicamente omaggiato da Renzi durante una conferenza a Ryad a fine
gennaio, quando definì l'Arabia il teatro di un possibile «nuovo rinascimento».
Evento per il quale il leader Iv ha anche percepito un compenso di decine di
migliaia di euro come oratore. Tutto regolare, per l'ex premier. Ma non per i
suoi ex compagni di coalizione. Ad affondare i colpi, stavolta, è anche il Pd.
Gianni Cuperlo incalza: «Il senatore Renzi aveva annunciato che, una volta
archiviata la crisi di governo, avrebbe offerto le motivazioni di quella sua
iniziativa. È opportuno che lo faccia. Se possibile presto». Ma anche il
vicecapogruppo alla Camera Michele Bordo: «Penso sia arrivato il momento che
Renzi chiarisca fino in fondo la natura dei suoi rapporti con l'Arabia Saudita e
con il principe ereditario». Addirittura, non esclude una «iniziativa
parlamentare», anche se allo stato non è stata presa nessuna decisione al
riguardo. Simili le parole di Maria Edera Spadoni, M5S: «Renzi deve chiarire la
natura dei suoi rapporti col principe saudita Mohammed Bin Salman e quello con
la fondazione Future investment iniziative». Ma, appunto, Renzi ritiene che non
ci sia nulla da chiarire. Il leader di Iv replica attraverso la "enews", la sua
newsletter settimanale. Per il leader di Italia viva «Pd, Leu e soprattutto
Cinque Stelle stanno strumentalizzando una tragedia come quella dell'uccisione
del giornalista saudita». La linea di difesa è la stessa usata un mese fa: a
quell'evento in Arabia saudita, «la Davos del deserto», spiega, «partecipano
regolarmente moltissimi leader della finanza e della politica provenienti da
tutto il mondo». L'ex premier elenca tutte le interviste nelle quali,
nell'ultimo mese, ha parlato della vicenda, quindi ripete che il compenso preso
per la conferenza è «perfettamente legale e legittimo», mentre «il Pd sotto la
mia gestione e Italia viva dalla sua nascita non hanno mai ricevuto denari da
governi stranieri o strutture ad essi collegati». Renzi ricorda di avere
«condannato già tre anni fa» l'omicidio di Kashoggi e ripete che mantenere
rapporti con l'Arabia è «giusto e necessario», perché è un «baluardo contro
l'estremismo islamico». Spiegazioni che non bastano ai suoi ex alleati. Bordo,
al telefono, lo spiega chiaramente: «Deve chiarire meglio, non basta la "enews"
settimanale. E non può essere lui a fare contemporaneamente le domande e le
risposte». Per l'esponente Pd non sono sufficienti nemmeno tutte le interviste
citate da Renzi: «Quando le ha fatte non c'era ancora il rapporto della Cia.
Oggi c'è un elemento di novità rispetto al quale un chiarimento è utile. Dice
che i presidenti del consiglio vanno in Arabia? Ma lui non è presidente del
consiglio, è un senatore che va a fare conferenze pagate 80mila euro». Solo
accuse pretestuose, per Renzi: «Spiace solo che si utilizzi la vicenda saudita
per coprire le difficoltà interne italiane e per giustificare un'alleanza dove -
come spesso è accaduto a una certa sinistra - si sta insieme contro l'avversario
e non per un'idea».
Giampiero Mughini per Dagospia
il 28 febbraio 2021. Caro Dago, pur dopo avere deciso di scriverlo sono molto a
disagio per quello di cui ti sto scrivendo. Il fatto è che di politica estera ne
so poco, forse pochissimo. Non sono mai stato in Arabia Saudita né ho letto
particolarmente di quell’ambiente, di quel Paese, della personalità politica di
Bin Salman, ossia di colui che guida e domina l’Arabia da molti anni e che
probabilmente ha avuto una responsabilità diretta dell’avere i suoi sgherri
maciullato il giornalista Jamal Kashoggi. Contemporaneamente a tutto questo, e
del resto lo sai, io apprezzo molto Matteo Renzi, lo reputo uno che se ne mette
in tasca dieci dei politici italiani del nostro tempo. L’ho fatta così lunga per
dirti che ho letto con molto disagio il bell’articolo odierno sul ”Fatto” di
Marco Lillo e gli altri articoli che su quel quotidiano gli stanno accanto.
Lillo scrive che Renzi dovrebbe dimettersi da quel think tank di cui fa parte e
per il quale riceve una paga annua. Ovvio che chiunque, da Obama a Tony Blair,
può andare in giro per il mondo e fare tutte le chiacchiere che vuole ed esserne
pagato. Ci mancherebbe altro. Però, ecco il punto, andare a dire nudo e crudo
che il Paese di cui sei in quel momento un ospite pagato si trova in una fase
“rinascimentale” della sua storia è un’affermazione troppo forte non dico per
passare inosservata e bensì per essere dimenticata. No, quell’affermazione non
va dimenticata. E’ troppo forte. Quando io l’ho ascoltata per la prima volta e
ne sono allibito, ho pensato – ho sperato – che Renzi avesse delle informazioni
di prima mano che escludessero la responsabilità del leader saudita nel martirio
del giornalista, che lui volesse con quell’affermazione dare lustro al ruolo
“riformista” di Bin Salman, un ruolo che sono in tanti a reputare tale. In
politica è fondamentale “trattare”, trattare con chiunque, come svela benissimo
la splendida serie “Occupied” attualmente su Netflix, quella in cui gli autori
si immaginano che i russi semi-occupino la Norvegia e dunque che fare?, dato che
affrontarli militarmente sarebbe un suicidio. In politica si tratta anche con il
diavolo. Quando le forze alleate dovevano scegliere qualcuno del vertice
politico/militare nazi con cui “trattare” la fine della guerra guerreggiata,
scelsero Heinrich Himmler, il capo supremo tra quanti avevano portato a termine
il massacro degli ebrei europei. Non c’è dubbio che vada preservato il ruolo
dell’Arabia Saudita come Stato cuscinetto fra Israele e i Paesi che in
quell’area le sono più drammaticamente avversi. Lo stesso Joe Biden non ha certo
mandato dei marines a dare dei calci negli stinchi a Bin Salman, ha invece
telefonato al padre. Ha fatto un distinguo intelligente e importante. Renzi ha
sbagliato, ha sbagliato nettissimamente a usare quelle specifiche espressioni in
quello specifico colloquio con quello specifico personaggio. Sbagliare è umano,
in politica come negli altri campi. L’importante è non perseverare. Renzi deve
prendere le distanze dal sé stesso di quel suo duetto di più e meglio di come
abbia fatto finora. Molto di più e molto meglio. Glielo chiediamo noi che gli
siamo amici e che lo stimiamo.
Niccolò Carratelli per "la
Stampa" il 9 marzo 2021. Quando, ieri mattina, Matteo Renzi è atterrato
all'aeroporto di Milano Malpensa, con un volo di linea Emirates proveniente da
Dubai, non era solo. Con lui, su quell'aereo, ha viaggiato l'amico di una vita,
l'uomo di cui è stato testimone di nozze, l'imprenditore Marco Carrai. Non era
facile riconoscerlo, nascosto dietro la mascherina, mentre prendeva il bus
interpista insieme al leader di Italia Viva. Ma lo hanno visto, era lui. Renzi e
Carrai insieme a Dubai, quindi. Il motivo del loro viaggio non è chiaro, né
sappiamo chi siano andati a incontrare. Certo è che entrambi, in questi anni,
hanno sviluppato relazioni e interessi nella penisola araba. Per Carrai, uno su
tutti: la Toscana Aeroporti, società di cui è presidente e che gestisce gli
scali di Firenze e Pisa, ha come azionista di maggioranza la Corporacion America
Italia, che entra nel capitale nel 2017, con la benedizione di Renzi e del Pd
locale. Vale la pena qui ricordare che, prima di quell'acquisizione, tra il 2014
e il 2016, la stessa società aveva fatto due donazioni, per un totale di 75mila
euro, alla fondazione Open, la cassaforte del renzismo, nel cui direttivo sedeva
all'epoca lo stesso Carrai. In seguito, nel luglio del 2018, il 25% delle quote
azionarie di CAI è stato rilevato dalla Mataar Holdings, società con sede ad
Amsterdam, indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai, il
principale fondo di investimento del governo degli Emirati, con asset totali del
valore di 166 miliardi di dollari. L'amministratore delegato dell'ICD si chiama
Mohammed Ibrahim Al Shaibani, che è anche nel consiglio di amministrazione di
Corporacion America Italia, oltre che nel board di Dubai Aerospace Enterprise:
la più grande compagnia di leasing aeronautico al mondo, creata dal fondatore e
numero uno della Emirates, lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, membro della
famiglia reale. Ma il nome da tenere a mente è quello di Al Shaibani. L'uomo del
regime ben inserito nel giglio magico fiorentino. Il trasporto aereo lo unisce a
doppio filo con Carrai, che nel 2018 aveva anche costituito (come socio di
minoranza) la filiale italiana di Iss Global Forwarding, colosso della logistica
aeroportuale con sede nella zona franca dello scalo di Dubai. Il gruppo, che ha
filiali in tutto il mondo, è di proprietà del solito fondo governativo ICD. Non
stupisce, quindi, che l'imprenditore Carrai sia andato a Dubai per colloqui di
lavoro, per parlare di affari, investimenti, progetti. Tutto legittimo. Il punto
è cosa sia andato a fare il senatore Renzi, a che titolo abbia accompagnato
l'amico e quale ruolo abbia giocato negli incontri che sicuramente i due hanno
avuto durante le loro 48 ore scarse trascorse nell'emirato. Ma c'è un'ultima
domanda che merita una risposta. La normativa anti-Covid prevede, per chi torna
dall'estero, 14 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria: Renzi
e Carrai la stanno rispettando, visto che non rientrano in nessuna delle
categorie esentate dall'obbligo?
Giovanna Vitale per "la
Repubblica" il 9 marzo 2021. Né per vacanza né per un lavoro retribuito. Chiuso
nella sua magione fiorentina, infastidito dalle «polemiche surreali» (così la
ministra Elena Bonetti) scaturite dal viaggio lampo a Dubai, Matteo Renzi non ha
intenzione di dare spiegazioni. Convinto di non doverne a nessuno. E ai pochi
che riescono a bucare il muro di silenzio dietro cui resta trincerato tutto il
giorno spiega solo di aver avuto una buona ragione per volare negli Emirati
Arabi. Dove, ha confidato, si è pagato tutto da sé: sia il biglietto di andata e
ritorno su un volo di linea, sia la lussuosa suite affacciata sul mare dell'
Hotel Burj Al Arab Jumeirah. E chi sosterrà il contrario, ribadisce, verrà
querelato. La certezza è che a condurlo lì non è stato né uno speech di quelli
che ha iniziato a tenere in giro per il mondo nella veste di ex premier
italiano; né un weekend di piacere nel Paese di Khalfa Ahmad al-Mubrak, l'
imprenditore emiratino presidente del Manchester City con cui intrattiene da
anni rapporti amichevoli, tanto da essere anche andato in Inghilterra, prima
della pandemia, per assistere alle partite della squadra britannica. Un viaggio
di piacere, peraltro, non rientra fra le possibilità contemplate dalla rigida
normativa anti-Covid in materia di spostamenti: in quel Paese consentiti solo
per lavoro, studio, salute o assoluta urgenza. Il viaggio è un caso anche per la
vicinanza alla contestatissima visita di Renzi in Arabia Saudita, con lodi al
principe bin Salman e al "Rinascimento saudita", in quell' occasione parte di un
rapporto di lavoro retribuito. Stavolta la ragione della missione resta avvolta
dal mistero: escluso un ingaggio professionale o il viaggio di piacere, tra i
fedelissimi si avanza l' ipotesi che l' ex premier abbia discusso di futuri
incarichi di lavoro o abbia trattato questioni politico- diplomatiche, sebbene a
titolo personale, come dimostra il pagamento delle spese di viaggio. La ministra
Bonetti, all' oscuro della trasferta come la totalità di Iv, fa una difesa d'
ufficio: «Nell' ambito del suo lavoro e delle sue attività, il senatore Renzi ha
delle relazioni internazionali. E quando ha preso un compenso l'ha sempre fatto
nella piena trasparenza e legalità». Ma «è proprio questo il punto», reagiscono
con stizza i 5S: «Nei suoi viaggi fa gli interessi della nazione o svolge una
consulenza retribuita per altri Paesi?». Una questione dirimente anche per l'
eurodeputato Dino Giarrusso: «Ora gli restano solo due scelte: dimettersi da
senatore e dedicarsi alla carriera privata, o interrompere subito ogni rapporto
ambiguo con potenze straniere». Sarcastico il grillino Ferrara: «Mi auguro che
sia andato negli Emirati in coincidenza con la Giornata della donna per
promuovere la condizione femminile che lì è ancora molto critica. Sono certo che
il leader di Iv chiarirà la natura dei suoi attuali rapporti con un Paese con il
quale, da premier, ha patrocinato diversi affari di Stato poco chiari e poco
vantaggiosi per l' Italia».
Da adnkronos.com il 9 marzo
2021. Matteo Renzi e il viaggio a Dubai nell'ultima enews del leader di Italia
Viva, che accusa alcune testate di diffondere fake news e nella quale spiega
come sia suo "dovere, non diritto, chiedere i danni". "A me dispiace fare azioni
civili contro alcune testate. Ma dobbiamo essere chiari: le critiche servono e
aiutano a crescere, le fake news no. Tutti possono criticare, nessuno può
diffamare", scrive Renzi, che continua: "Per anni ho sottovalutato la montagna
di accuse che mi venivano rivolte: da due anni ho deciso di cambiare stile: se
qualcuno scrive falsità, è mio DOVERE, non diritto, chiedere i danni. Perché
continuare a far finta di nulla sarebbe come ammettere di aver fatto qualcosa di
illegale o di illecito - prosegue il leader di Iv -. Niente di personale, sia
chiaro. Ma per troppo tempo ho sottovalutato l’alluvione di fake news contro di
me. Adesso ho semplicemente deciso di reagire, colpo su colpo". "Nel frattempo,
guardiamo il positivo: prima mi criticavano per le mie/nostre idee sull’Italia.
Ora che finalmente il Paese sta cambiando passo e che molte delle nostre
battaglie vengono riconosciute, nessuno ci critica più per la politica italiana
(anzi, in molti ci danno ragione, anche se a bassa voce) ma si aggrappano ai
miei viaggi. Prendiamola con allegria, amici, e senza mai arrabbiarsi: è il
segno che sulle questioni italiane non hanno più nulla da criticare", sottolinea
Renzi. "C’è un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il Pd
deciderà cosa fare, dopo che il Segretario uscente Nicola Zingaretti ha detto di
vergognarsi del proprio partito", continua il leader Iv nella enews. "I Cinque
Stelle hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte,
nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l’esperienza pentastellata
in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti -prosegue il leader di Iv-. La mia
opinione è che per qualche mese ci sarà ancora da… ballare. Tutto ha iniziato a
cambiare, ma molto ancora cambierà. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un
lontano ricordo per tutti. Per questo sarà fondamentale allenarsi come fosse una
maratona, non come fossero i 100 metri". E sull'emergenza covid e i decessi in
Italia, Renzi parla di "quota centomila. Devastante pensare al numero di decessi
per Covid in questo anno, centomila solo in Italia. Non è una cifra, è una
tragedia". "Ciascuno di noi ha un nome, un volto, un proprio caro da ricordare.
Proprio quando, nel primo anniversario del lockdown, l’Italia supera questo
tragico confine numerico, non possiamo che rilanciare l’appello per una campagna
di vaccinazione organizzata in modo militare e dire grazie alla scienza che sta
lavorando notte e giorno per sconfiggere la pandemia", prosegue il leader del
Pd. "Vorrei che dedicassimo più attenzione anche alla questione dei anticorpi
monoclonali, che sono un grande passo in avanti nella lotto contro il
Coronavirus e dei quali, nelle prossime ore, tornerò a parlare su Facebook,
Instagram e Twitter", aggiunge Renzi.
Otto e mezzo,
Matteo Renzi a Dubai. Massimo Giannini sgancia un'altra bomba: "Chi c'era con
lui".
Libero Quotidiano il 09 marzo 2021. "Matteo Renzi vuole
querelarmi ma non so perché". Massimo Giannini sulla Stampa ha dato la notizia
del viaggio a Dubai del leader di Italia Viva. L'ex premier ha chiarito di non
esserci andato "né per lavoro né per vacanza", "ma ha confermato di esserci
andato", sottolinea Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.
"Quando all'alba ho ricevuto il suo messaggio sul mio cellulare che mi informava
che avevamo scritto tutte sciocchezze, diciamo così, io ho temuto che ci fossimo
sbagliati. Poi mi ha telefonato mentre era a Dubai, quindi non capisco più quali
sono le ragioni che potrebbero portarci a giudizio né lui ha voluto darmele,
dicendomi che le saprò quando arriverà l'atto di citazione". "Io continuo a
pensare che le sue frequentazioni pericolose con quei regimi e quei mondi
meriterebbero una spiegazione", incalza Giannini. "Abbiamo aggiunto che c'è
forse un aspetto in più. Renzi a Dubai era con Marco Carrai, noto imprenditore
toscano e amico intimo di Renzi che con la fondazione Open e le sue attività ha
sostenuto molto le attività politiche dello stesso senatore di Italia Viva".
"Forse questa è una pista? - domanda sibillino Giannini - Non lo so, perché
Renzi continua a non spiegare. Secondo me invece dovrebbe spiegarlo non a me ma
a gli elettori italiani ma da questo punto di vista non ci sente. Se la causa
che faremo servirà a chiarire la situazione benvenga, io non so qual è il reato
ma io sono pronto".
Renzi
d'Arabia: la Cia accusa il principe “amico” bin Salman.
Le Iene News il 09 marzo 2021. L’intervista di Matteo Renzi al principe saudita
Mohammad bin Salman ha generato infinite polemiche politiche, sia per i temi
trattati che per il compenso ricevuto dal senatore italiano. Ma soprattutto
perché la Cia accusa bin Salman per l’efferato omicidio del giornalista Jamal
Khashoggi: la nostra Roberta Rei ci racconta cosa è successo. Nelle scorse
settimane la visita del leader di Italia viva e senatore Matteo Renzi in Arabia
Saudita ha generato infinite polemiche politiche: l’ex premier si è recato a
Riyadh per intervistare il principe dell’Arabia Saudita Mohammad bin Salman. Le
sue dichiarazioni sul “nuovo Rinascimento” e sul costo del lavoro nel paese
hanno fatto discutere, così come il compenso che l’ex premier riceve da una
fondazione saudita riconducibile a bin Salman. Ma il vero motivo per cui
l’intervista ha fatto scalpore è proprio il principe Mohammad bin Salman, che
Renzi chiama “my friend”. Bin Salman è accusato dalla Cia di essere il mandate
terribile omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, fatto letteralmente a pezzi
all’interno dell’ambasciata saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018. La nostra
Roberta Rei, nel servizio che potete vedere in testa a questo articolo, ci
racconta come è stato pianificato e realizzato quell’efferato omicidio. Jamal
Khashoggi è stato ucciso perché era un giornalista libero, ben informato sugli
affari della famiglia regnante in Arabia Saudita. La Iena intervista anche Bryan
Fogel, regista premio Oscar che ha girato il documentario The Dissident, proprio
sull’omicidio di Jamal Khashoggi. Roberta Rei ha provato a parlare anche con
Matteo Renzi, senza però avere una risposta. E allora gli suggeriamo alcune
domande, che potete vedere qui sopra. Tra queste ce n’è una che ci preme
particolarmente: il Rinascimento si fa tagliando a pezzi i giornalisti e
mettendoli nelle valigie?
Marco Macca per fcinter1908.it il 3 marzo 2021.
Non solo BC Partners e Fortress. Anche gli occhi dell'Arabia Saudita sull'Inter.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti,
il fondo presieduto da Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale, si
sarebbe mosso sotto traccia per il club nerazzurro e immettere liquidità nella
società, come vorrebbe Suning. "Suning, decisa a tenere il timone dell'Inter,
cerca finanziatori per ottenere la necessaria liquidità: tra i tanti soggetti,
si è aggiunto sotto traccia anche il Saudi Public Investment Fund, fondo
presieduto da Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale saudita, che ha
già guardato alla Premier League in passato".
Nicola Porro, scivolone su
Jamal Khashoggi: "Mercante d'armi? Mi scuso, un errore mostruoso".
Libero Quotidiano
il 09 marzo 2021. "È stato un errore mostruoso". Con questa premessa Nicola
Porro si scusa con tutti i suoi lettori. Colpa di una notizia apparsa sul suo
sito nicolaporro.it, dove si dava spazio a Jamal Khashoggi, editorialista
del Washington Post ucciso dal regime saudita. Qui però Khashoggi è stato
definito un "mercante di armi". "Alla mia piccola redazione e al sottoscritto -
spiega il conduttore di Quarta Repubblica - è sfuggito". Poi la firma
del Giornale definisce quanto accaduto grave, "per di più nei confronti di un
giornalista ucciso mostruosamente. Non posso che scusarmi". In realtà l'articolo
è di Carlo Andrea Bollino, prof ordinario di Economia all'Università di Perugia.
Bollino il 2 febbraio pubblicava sul sito di Porro l'articolo "Gli 8 misteri
sull'embargo all'Arabia Saudita". Ma è al punto 4 che scivola: "Khashoggi non
era solo un giornalista ma anche un mercante di armi e nessuno di noi sa ancora
veramente cosa è successo". Tra i primi a notare l'errore il Fatto
Quotidiano che, per sua ammissione, dice di aver scritto a Porro attraverso
Twitter senza però ricevere risposta. "Non ho visto quel tweet, purtroppo", ha
giustificato il conduttore quei 30 giorni intercorsi tra la notizia e le scuse.
Per Porro non è il primo scivolone. In onda su Rete Quattro il giornalista si
era scusato con Sergio Mattarella. Il motivo? Mentre Alessandro Sallusti parlava
della centralità avuta da chi era al Colle all’epoca dei fatti riguardanti la
condanna a Silvio Berlusconi, dietro apparivano le immagini dell'attuale
presidente della Repubblica. Un errore visto che all'epoca c'era Giorgio
Napolitano.
La fidanzata di Khashoggi all’attacco del
principe saudita: “Mohammed Bin Salman va punito immediatamente”.
Massimiliano Cassano su Il Riformista l'1 Marzo 2021. Il principe ereditario
saudita Mohammed Bin Salman “deve essere punito senza indugio” perché non ha più
“nessuna legittimità politica”. L’attacco arriva da Hatice Cengiz, fidanzata del
giornalista saudita Jamal Khashoggi, a pochi giorni dalla pubblicazione di un
report della Cia che ha riconosciuto in Bin Salman il responsabile
dell’uccisione del reporter nell’ottobre del 2018 nel consolato dell’Arabia
Saudita ad Istanbul. Hatice ha scritto un comunicato, pubblicato anche sui
social, in cui ritiene “essenziale che il principe ereditario, che ha ordinato
il brutale omicidio di una persona innocente, sia punito immediatamente”. La
donna, 39 anni, di origini turche, chiede a gran voce che dopo aver desecretato
i documenti, gli Stati Uniti intervengano contro l’erede alla Corona in Medio
Oriente, considerato però dagli Usa come un fondamentale alleato nel contrasto
all’Iran. La sua è una richiesta che “non solo porterebbe la giustizia che
stiamo cercando per Jamal ma impedirebbe anche ad azioni simili di ripetersi in
futuro”. Per Hatice, se il principe non sarà punito, “si manderà per sempre il
segnale che il maggior colpevole di un assassinio può cavarsela, il che ci
metterebbe tutti in pericolo e sarebbe una macchia sulla nostra umanità”. Il 2
ottobre del 2018 Hatice Cengiz stava aspettando in auto fuori dall’ambasciata
saudita a Istanbul che il suo compagno sbrigasse alcune pratiche burocratiche.
In quei momenti però Khashoggi veniva ucciso e poi fatto a pezzi da alcuni
agenti di Riad, che secondo la Corona saudita avrebbero agito “in autonomia”
e non su istruzione del principe. Il Paese ha infatti “respinto del tutto” il
rapporto della Cia e negato ogni responsabilità nell’omicidio. Nel dicembre 2020
il documentario “The Dissident” ha raccontato la storia di Jamal Khashoggi, e
nel frattempo Hatice Cengiz è diventata una testimonial internazionale di
primissimo livello impegnata a favore della libertà di stampa nel mondo. Sul
caso si è svolto un processo in Arabia Saudita che ha condannato in via
definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene tra 7 e 10 anni,
rivedendo un precedente verdetto che prevedeva cinque condanne a morte. “Un
processo farsa”, secondo la compagna del giornalista, che ha accusato Riad di
voler chiudere il caso senza indicare la verità sul mandante dell’assassinio.
Il caso del giornalista saudita.
“Mohammad Bin Salman autorizzò l’operazione per catturare o uccidere Khashoggi”,
il report Usa. Vito Califano su Il Riformista il 26
Febbraio 2021. Il principe dell’Arabia Saudita Mohammad Bin Salman ha approvato
l’operazione per “catturare o uccidere” il giornalista Jamal Khashoggi,
collaboratore anche del Washington Post. È quanto emerge da un rapporto
dell’intelligence degli Stati Uniti. Il giornalista venne attirato nel consolato
saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018, ucciso e fatto a pezzi. “Basiamo questa
valutazione sul controllo del principe saudita sul processo decisionale nel
regno, sul diretto coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della
cerchia di Muhammad bin Salman nell’operazione, sul sostegno del principe
ereditario all’uso di misure violente per silenziare il dissenso all’estero,
incluso Khashoggi”, recita il rapporto secondo Cnn. È infatti dal 2017, continua
a spiegare il dossier, che Mbs (com’è soprannominato il principe) ha
il controllo delle organizzazioni di sicurezza e intelligence del Regno Saudita.
È quindi “altamente improbabile che funzionari sauditi possano aver effettuato
un’operazione di questa natura senza la sua autorizzazione”. Una notizia, quella
della pubblicazione del documento atteso per oggi, che ha fatto molto discutere.
Anche perché l’intelligence aggiunge dettagli raccapriccianti: a quanto
ricostruito il principe ereditario “considerava Khashoggi una minaccia per il
Regno e ha ampiamente sostenuto l’uso di misure violente, se necessario, per
zittirlo. Nonostante i funzionari sauditi avessero pianificato in anticipo
un’operazione non specificata contro Khashoggi, non sappiamo con quanto anticipo
essi abbiano deciso di fargli del male”. Il documento elenca anche i nomi di 21
persone considerate a vario titoli partecipanti, complici o responsabili
dell’omicidio del giornalista. La squadra sarebbe stata composta da 15
funzionari vicini alla corte saudita. Una squadra guidata dallo stretto
consigliere del principe ereditario, Saud al-Qahtani, “che ha affermato
pubblicamente a metà del 2018 di non prendere decisioni senza l’approvazione del
principe ereditario”. Altro particolare che porta al principe ereditario è la
partecipazione del team di sette membri della squadra d’èlite del RIF che
“risponde solo a lui e aveva partecipato direttamente a precedenti operazioni di
soppressione dei dissidenti nel Regno e all’estero sotto la direzione del
principe ereditario”. Il rapporto stilato l’11 febbraio riporta anche
l’ultimo depistaggio: indossare i vestiti e l’Apple Watch della vittima per far
credere che Khashoggi avesse lasciato l’ambasciata di Istanbul. Il portavoce
della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che gli Stati Uniti ricalibreranno il
loro rapporto con il Regno Saudita. Il segretario di stato statunitense, Antony
Blinken, ha annunciato l’istituzione del Khashoggi ban, politica che “consente
al dipartimento di Stato di imporre restrizioni sui visti a persone che, agendo
per conto di un governo straniero, si ritiene siano state direttamente impegnate
in gravi attività extraterritoriali contro i dissidenti, comprese quelle che
sopprimono, molestano, sorvegliano, minacciano o danneggiare giornalisti,
attivisti o altre persone percepite come dissidenti per il loro lavoro, o che si
impegnano in tali attività nei confronti delle famiglie o di altri stretti
collaboratori di tali persone. Anche i familiari di tali individui possono
essere soggetti a restrizioni sui visti ai sensi di questa politica, ove
appropriato”. I primi a essere colpiti dal Khashoggi ban saranno 76 individui
considerati coinvolti nella minaccia di dissidenti all’estero. Non è
destinatario il principe ereditario bin Salman. Il dipartimento del Tesoro degli
Stati Uniti aveva invece annunciato sanzioni nei confronti di Ahmad Hassan
Mohammed al Asiri, ex vice capo dell’intelligence generale dell’Arabia Saudita,
e della Forza di intervento rapido.
Cinque condanne a morte per l’omicidio
del giornalista Jamal Khashoggi. Redazione su Il
Riformista il 23 Dicembre 2019. Il tribunale di Riad, in Arabia Saudita, ha
condannato a morte cinque persone per l’omicidio del giornalista saudita Jamal
Khashoggi, avvenuto all’interno del consolato dall’Arabia Saudita a Istanbul, in
Turchia, il 2 ottobre del 2018. Non è stato invece incriminato Saud al-Qahtani,
ritenuto l’assistente del principe ereditario, Mohamed bin Salman. La procura di
Riad ne ha disposto il rilascio, ma al-Qahtani resta indagato per l’omicidio del
giornalista. Altre tre persone sono state condannate a 24 anni di carcere per
aver cercato di "insabbiare il crimine". Secondo la più recente indagine
Onu pubblicata il 19 giugno 2019, dal giornale inglese “The Guardian”, il
principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dovrebbe essere indagato per
l’omicidio del giornalista Khashoggi. Il rapporto dell’Onu, redatto da Agnes
Callamard parla di omicidio “premeditato”, con prove credibili di responsabilità
del principe ereditario dell’Arabia Saudita.
L’AUTOESILIO CONTRO IL REGIME – Khashoggi era da
tempo un giornalista scomodo per il regime saudita. Lasciò la sua nazione nel
settembre 2017 e andò in esilio autoimposto, denunciando che il governo del
principe ereditario Mohammad bin Salman e del re Salman lo aveva “bandito da
Twitter”.
L’OMICIDIO, L’INDAGINE E I DEPISTAGGI – Il
giornalista il 2 ottobre 2018 si recò al consolato saudita di Istanbul per
ottenere un documento che provasse che era divorziato. Questo documento gli
avrebbe permesso di sposare la sua fidanzata, Hatice Cengiz, una cittadina
turca, che lo aspettava fuori dall’edificio. Khashoggi però non lasciò più
l’edificio: il giornalista è stato infatti ucciso e fatto a pezzi all’interno
del consolato. Le indagini e le inchieste hanno infatti dimostrato come
Khashoggi sia stato ucciso da un commando di 11 uomini sauditi, mandati quasi
certamente in Turchia dal principe ereditario saudita. I giornali turchi,
citando fonti interne alle forze di sicurezza, hanno in più occasioni svelato
infatti come Mohammed bin Salman abbia avuto un ruoli di primo piano nella
pianificazione dell’assassinio. Sotto la pressione della comunità internazionale
l’Arabia Saudita, con una mossa di facciata, ha sostenuto quindi che l’uccisione
di Khashoggi era stata organizzata dal generale Ahmed al Assiri ed era stata
guidata da Saud al Qahtani. Entrambi sono stati licenziati dai loro rispettivi
incarichi ma, come ha scritto il Wall Street Journal, Qahtani è ancora uno
stretto collaboratore di Mohammed bin Salman, mantenendo però un profilo “più
defilato”.
Da repubblica.it il 26 febbraio 2021. Gli Stati
Uniti hanno diffuso un rapporto sull'omicidio del giornalista e blogger Jamal
Khashoggi - assassinato nel consolato saudita a Istanbul nel 2018 - in cui si
legge che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman "ha approvato un
piano per ucciderlo o catturarlo". Tra le informazioni si legge anche che "gli
agenti non avrebbero eseguito interventi sul giornalista senza l'autorizzazione
superiore". "Basiamo questa valutazione - si legge nel rapporto - sul controllo
del principe saudita sul processo decisionale nel regno, sul diretto
coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della cerchia di Mohammed
bin Salman nell'operazione, sul sostegno del principe ereditario all'uso di
misure violente per silenziare il dissenso all'estero, incluso Khashoggi". Nel
documento dell'intelligence si afferma anche che Mbs vedeva il giornalista
dissidente come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l'uso della violenza
se necessario per metterlo a tacere. Il rapporto elenca 21 persone che gli 007
americani ritengono con "alta fiducia" complici o responsabili per la morte del
giornalista. Il rapporto è stato pubblicato poche ore dopo la telefonata del
presidente americano Joe Biden al re Salman dell'Arabia Saudita, padre di
Mohammed bin Salman.
Valeria Robecco per “il Giornale” il 27 febbraio
2021. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha «autorizzato»
un'operazione per «catturare o uccidere» il giornalista dissidente del
Washington Post Jamal Khashoggi. È ciò che stabilisce l'atteso rapporto
dell'intelligence Usa declassificato e diffuso ieri dall'amministrazione di Joe
Biden. Nel dossier, prodotto dalla direzione della National Intelligence, si
afferma che bin Salman vedeva Khashoggi come una minaccia al regno, e sostenne
ampiamente l'uso della violenza se necessario per metterlo a tacere.
L'intelligence, si legge nel documento di due pagine, ha basato le sue
conclusioni sul controllo assoluto che il principe ereditario, noto come Mbs,
aveva sui processi decisionali di Riad, sul suo «sostegno all'uso di misure
violente per mettere a tacere i dissidenti all'estero, incluso Khashoggi» e la
partecipazione alle operazioni dei suoi alti assistenti e funzionari della
sicurezza. Gli 007 americani infatti elencano anche 21 persone che ritengono con
«elevata fiducia» complici o responsabili per la morte e lo smembramento del
giornalista dissidente - avvenuta nel consolato saudita a Istanbul nel 2018 -
per conto di bin Salman. Washington sta adottando «misure per rafforzare la
condanna mondiale di quel crimine e per respingere i governi che vanno oltre i
loro confini minacciando e attaccando giornalisti e persone percepite come
dissidenti per l'esercizio delle loro libertà fondamentali», spiega il
segretario di Stato Anthony Blinken. Quindi, il titolare di Foggy Bottom
annuncia il nuovo «Khashoggi ban»: gli Usa vieteranno l'ingresso di stranieri
che siano impegnati «in attività extraterritoriali gravi contro i dissidenti»,
ad esempio le molestie ai giornalisti. Come prima azione vengono imposte
restrizioni sui visti a 76 sauditi impegnati nella minaccia di dissidenti
all'estero, incluso il caso Khashoggi. Mentre il governo dell'Arabia Saudita ha
respinto «categoricamente» il rapporto pubblicato dai servizi segreti americani,
ieri sera il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha annunciato
l'adozione di sanzioni contro l'ex vice capo dell'intelligence saudita Ahmad
Hassan Mohammed al Asiri e contro la Forza di intervento rapida in relazione
all'omicidio di Khashoggi. «Coloro che sono stati coinvolti in quella orrenda
uccisione devono essere chiamati a rispondere. Con questa azione, il Tesoro
sanziona la Forza di intervento rapido e l'alto funzionario saudita direttamente
coinvolto nell'omicidio del giornalista. «Gli Stati Uniti - ha aggiunto - sono
uniti ai giornalisti e i dissidenti politici nel contrastare le minacce di
violenze ed intimidazioni. Continueremo a difendere la libertà di espressione,
fondamento di una società libera». Come parte della sua promessa di
«ricalibrare» le relazioni con Riad una volta arrivato nello Studio Ovale, Biden
ha aperto nuovamente all'accordo sul nucleare iraniano e posto fine al sostegno
ai sauditi nella guerra in Yemen, ma non si è ancora mosso per interrompere gli
aiuti militari. La diffusione del rapporto degli 007 inizialmente era attesa per
giovedì, ma la Casa Bianca ha spiegato che il presidente voleva prima aspettare
di parlare con l'85enne re saudita Salman, colui che considera la sua
«controparte». Nella prima conversazione tra i due si è discusso delle relazioni
bilaterali, della sicurezza regionale, degli sforzi per concludere la guerra in
Yemen e dell'impegno americano a difendere Riad dagli attacchi di gruppi filo
iraniani..
Anna Guaita per “il Messaggero” il 27 febbraio
2021. «Risponderemo nel modo appropriato, e quando lo riterremo opportuno». Così
dodici giorni fa la portavoce della Casa Bianca reagiva al primo di tre attacchi
di milizie filo iraniane contro le truppe americane di stanza in Iraq. E la
risposta è venuta nella notte di giovedì. Due aerei da combattimento F-15 hanno
sganciato 7 bombe contro una base utilizzata dalle stesse milizie al confine fra
l'Iraq e la Siria. È stata la prima missione militare della giovane
amministrazione Biden, ed è stata anche molto letale, avendo lasciato almeno 22
morti sul terreno. Polemiche sono subito scaturite nell'ala sinistra del partito
democratico, ma nessuno ha avuto dubbi sui motivi, e sul significato che
l'attacco vuole avere nella politica estera e nazionale del nuovo presidente.
Sul fronte interno Biden ha inteso rassicurare i democratici moderati e i
repubblicani che le sue aperture diplomatiche nei confronti dell'Iran sulla
questione dell'accordo nucleare non vanno interpretate come un segnale di
debolezza verso Teheran. Sul fronte della politica internazionale, il nuovo
presidente intende mandare un ammonimento diretto a Teheran e far capire agli
alleati di condividere la preoccupazione - espressa soprattutto da Israele - che
l'accordo sul nucleare lascia comunque scoperto un fianco pericoloso e cioè il
riarmo convenzionale dell'Iran, e il suo sostegno a milizie destabilizzanti che
agiscono in tutta l'area del Medio Oriente. Alcuni analisti aggiungono una terza
considerazione a queste analisi, e cioè la necessità per l'amministrazione di
non apparire troppo schierato a favore dell'Iran proprio quando sta
ridimensionando l'alleanza con l'Arabia Saudita. Si tratterebbe cioè per Biden
di fare un difficile equilibrismo fra le due potenze regionali rivali, quella
saudita e quella sciita. Da un canto cioè raffreddare i rapporti con Riad in
seguito alla conferma dell'intelligence che fu il principe ereditario Mohammad
bin Salman a ordinare «la cattura o l'uccisione del giornalista Jamal
Khashoggi», e dall'altro aprire all'Iran senza però tradire particolari simpatie
per gli ayatollah e le loro milizie. Il rapporto dell''intelligence Usa su
Khashoggi, insabbiato da Trump, e reso noto ieri da Biden, contrasta con la
versione saudita secondo la quale il principe non sapeva nulla della missione
contro il dissidente, ucciso nel 2018. Washington ha deciso di non colpire bin
Salman con sanzioni, limitandosi a introdurle per l'ex capo dell'intelligence
saudita Al Asiri. I sauditi hanno comunque respinto il dossier, e le relazioni
tra i due Paesi da ieri sono certamente più difficili. L'attacco di giovedì
sera, è stato precisato dal Pentagono e dalla Casa Bianca, era stato discusso
con gli alleati, e aveva ricevuto il via libera sia del governo iracheno che di
quello regionale iracheno-curdo. Il bersaglio è stato scelto proprio per evitare
di sganciare bombe sul territorio dell'Iraq, e il Pentagono ha assicurato che la
base colpita è usata per il contrabbando di armi iraniane dagli stessi miliziani
che hanno effettuato i tre attacchi in Iraq. Il governo siriano ha protestato
per la violazione del suo territorio e ha definito il raid «un vile attacco».
Anche la Russia, che da nove anni combatte in Siria al fianco del governo di
Bashar al-Assad, ha criticato l'attacco americano e ha lamentato che il
preavviso che di solito viene mandato in questi casi per evitare troppe vittime
è arrivato solo cinque minuti prima. Ma la Casa Bianca non ha risposto,
preoccupata piuttosto di ricordare a Putin che anche con lui c'è un contenzioso
aperto, quello dell'Ucraina. A sette anni dall'invasione russa, la Casa Bianca
ha inviato un messaggio a Mosca: «In questo triste anniversario noi riaffermiamo
una semplice verità: la Crimea è Ucraina. Gli Stati Uniti non riconoscono e non
riconosceranno mai la presunta annessione russa della penisola».
Omicidio Khashoggi, Biden pubblica il
rapporto della Cia. «Il principe Bin Salman autorizzò blitz per catturarlo o
ucciderlo». Giuseppe Sarcina su Il Corriere della Sera
il 27/2/2021. Sette bombe di 250 kg sulle milizie irachene appoggiate dall’Iran.
E un rapporto di quattro pagine per denunciare al mondo la responsabilità
diretta del principe saudita Mohammed Bin Salman nell’assassinio del giornalista
Jamal Khashoggi. Nel giro di 24 ore l’Amministrazione di Joe Biden prende due
iniziative di grande impatto sugli equilibri del Medio Oriente. Il dossier della
Cia conferma i sospetti che si erano diffusi subito dopo che Khashoggi fu ucciso
nel consolato saudita di Istanbul, il 2 ottobre del 2018. Un omicidio politico,
«approvato», scrivono gli analisti della Cia, da Bin Salman, il trentacinquenne
erede al trono, fino a pochi mesi fa interlocutore privilegiato di Donald Trump
e del genero consigliere Jared Kushner. La svolta di Biden nei confronti di Riad
è netta. Prima ha bloccato importanti forniture di armi; poi ha
ritirato l’appoggio all’invasione saudita dello Yemen e ora ha autorizzato la
Cia a declassificare una parte delle indagini sull’editorialista del Washington
Post. Giovedì 25 febbraio, il presidente americano ha spiegato tutto ciò in una
complicata telefonata con il Re dell’Arabia Saudita, Salman, 85 anni.
La «correzione» verso i sauditi, si dice a Washington, potrebbe lasciare spazio
all’aggressività dell’Iran. La risposta è arrivata alle due di notte di venerdì
26 febbraio, (ora locale). Un bombardiere americano ha colpito un complesso di
edifici e alcuni camion che trasportavano armi nella zona di Boukamal, lungo il
confine orientale con l’Iraq. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul numero
delle vittime. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani,
un’organizzazione britannica, sarebbero stati uccisi 22 miliziani, appartenenti
alle formazioni sciite appoggiate dall’Iran. Stando a un comunicato diffuso
dagli stessi gruppi paramilitari, ci sarebbe stato solo un morto. Il Pentagono
ha spiegato di aver preso di mira una base utilizzata «anche da Kataeb Hezbollah
e da Kataeb Sayyid al-Shuhada», considerati i responsabili del lancio di missili
contro la base statunitense di Erbil, in Iraq, il 15 febbraio scorso. In
quell’occasione perse la vita un contractor americano e ci furono diversi
feriti, compreso un soldato Usa. Ieri mattina Jen Psaki, portavoce della Casa
Bianca, ha aggiunto: «L’attacco aereo in Siria segnala che il presidente agirà
per proteggere gli americani». È la prima azione militare ordinata da Biden, che
ha seguito il suggerimento del Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, con un
impatto tutto da verificare sulla scena internazionale. Il ministro degli esteri
russo, Sergei Lavrov, si lamenta perché gli americani «ci hanno dato solo pochi
minuti di preavviso», ma nello stesso tempo chiede di «riprendere i contatti»
per «chiarire qual è la posizione di Biden sulla Siria».
Il caso del giornalista saudita.
“Mohammad Bin Salman autorizzò l’operazione per catturare o uccidere Khashoggi”,
il report Usa. Vito Califano su Il Riformista il 26
Febbraio 2021. Il principe dell’Arabia Saudita Mohammad Bin Salman ha approvato
l’operazione per “catturare o uccidere” il giornalista Jamal Khashoggi,
collaboratore anche del Washington Post. È quanto emerge da un rapporto
dell’intelligence degli Stati Uniti. Il giornalista venne attirato nel consolato
saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018, ucciso e fatto a pezzi. “Basiamo questa
valutazione sul controllo del principe saudita sul processo decisionale nel
regno, sul diretto coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della
cerchia di Muhammad bin Salman nell’operazione, sul sostegno del principe
ereditario all’uso di misure violente per silenziare il dissenso all’estero,
incluso Khashoggi”, recita il rapporto secondo Cnn. È infatti dal 2017, continua
a spiegare il dossier, che Mbs (com’è soprannominato il principe) ha
il controllo delle organizzazioni di sicurezza e intelligence del Regno Saudita.
È quindi “altamente improbabile che funzionari sauditi possano aver effettuato
un’operazione di questa natura senza la sua autorizzazione”. Una notizia, quella
della pubblicazione del documento atteso per oggi, che ha fatto molto discutere.
Anche perché l’intelligence aggiunge dettagli raccapriccianti: a quanto
ricostruito il principe ereditario “considerava Khashoggi una minaccia per il
Regno e ha ampiamente sostenuto l’uso di misure violente, se necessario, per
zittirlo. Nonostante i funzionari sauditi avessero pianificato in anticipo
un’operazione non specificata contro Khashoggi, non sappiamo con quanto anticipo
essi abbiano deciso di fargli del male”. Il documento elenca anche i nomi di 21
persone considerate a vario titoli partecipanti, complici o responsabili
dell’omicidio del giornalista. La squadra sarebbe stata composta da 15
funzionari vicini alla corte saudita. Una squadra guidata dallo stretto
consigliere del principe ereditario, Saud al-Qahtani, “che ha affermato
pubblicamente a metà del 2018 di non prendere decisioni senza l’approvazione del
principe ereditario”. Altro particolare che porta al principe ereditario è la
partecipazione del team di sette membri della squadra d’èlite del RIF che
“risponde solo a lui e aveva partecipato direttamente a precedenti operazioni di
soppressione dei dissidenti nel Regno e all’estero sotto la direzione del
principe ereditario”. Il rapporto stilato l’11 febbraio riporta anche
l’ultimo depistaggio: indossare i vestiti e l’Apple Watch della vittima per far
credere che Khashoggi avesse lasciato l’ambasciata di Istanbul. Il portavoce
della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che gli Stati Uniti ricalibreranno il
loro rapporto con il Regno Saudita. Il segretario di stato statunitense, Antony
Blinken, ha annunciato l’istituzione del Khashoggi ban, politica che “consente
al dipartimento di Stato di imporre restrizioni sui visti a persone che, agendo
per conto di un governo straniero, si ritiene siano state direttamente impegnate
in gravi attività extraterritoriali contro i dissidenti, comprese quelle che
sopprimono, molestano, sorvegliano, minacciano o danneggiare giornalisti,
attivisti o altre persone percepite come dissidenti per il loro lavoro, o che si
impegnano in tali attività nei confronti delle famiglie o di altri stretti
collaboratori di tali persone. Anche i familiari di tali individui possono
essere soggetti a restrizioni sui visti ai sensi di questa politica, ove
appropriato”. I primi a essere colpiti dal Khashoggi ban saranno 76 individui
considerati coinvolti nella minaccia di dissidenti all’estero. Non è
destinatario il principe ereditario bin Salman. Il dipartimento del Tesoro degli
Stati Uniti aveva invece annunciato sanzioni nei confronti di Ahmad Hassan
Mohammed al Asiri, ex vice capo dell’intelligence generale dell’Arabia Saudita,
e della Forza di intervento rapido.
La vicenda dell'editorialista del
"Washington Post". Chi era Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso e
smembrato a Istanbul protagonista di “The Dissident”.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 17 Giugno 2021. Che il principe
saudita Mohammed bin Salman sia coinvolto nella sparizione e nell’uccisione del
giornalista, e dissidente saudita, Jamal Khashoggi, lo ha riportato per iscritto
un rapporto dell’intelligence degli Stati Uniti. Proprio dove il giornalista,
collaboratore tra gli altri del Washington Post, si era auto-esiliato dopo la
nomina di Mbs a erede al trono. Un caso internazionale, che ha portato
l’opinione pubblica, in tutto il mondo, a interrogarsi sui legami con la
monarchia del Medio Oriente, sulla libertà di stampa, sullo stato dei diritti
umani e civili in uno dei principali alleati dell’Occidente. L’ex Presidente
americano Donald Trump avrebbe ostacolato la pubblicazione del documento per non
danneggiare un partner considerato strategico. La situazione è cambiata con
l’elezione di Joe Biden, che si è insediato lo scorso gennaio. Il dossier degli
007 è stato reso noto a febbraio 2021. Mbs si è comunque sempre dichiarato
innocente. La storia di Khashoggi ha fatto intanto il giro del mondo. Il regista
premio Oscar per Icarus, Bryan Fogel, ha dedicato un film al giornalista
scomparso. The Dissident, uscito nel 2020. In un articolo per Agi molto
approfondito Brahim Maarad, corrispondente da Bruxelles, aveva messo l’accento
sulle contraddizioni del personaggio e dell’uomo. “Un martire della libertà o
una vittima delle sue stesse contraddizioni? Su di lui si è detto e scritto di
tutto, sia da parte di chi vuole farne un’icona della lotta del mondo arabo per
l’emancipazione dalle dittature, sia da chi mette in guardia nei confronti dei
suoi numerosi voltafaccia”.
Chi era Jamal Khashoggi
Khashoggi era nato a Medina, seconda città
dell’Arabia Saudita, nel 1958, da una famiglia saudita di origini turche. Una
famiglia di spessore: suo nonno Mohammed era stato il medico personale del
fondatore dell’Arabia Saudita (1932), il Re Abdul Aziz al-Saud. Adnan Khashoggi,
suo zio, era invece diventato famigeratamente noto come trafficante d’armi. Da
piccolo, Jamal, aveva studiato l’ideologia islamica e le idee liberali. Si
laureò all’Indiana State University nel 1982. Cominciò a scrivere per i
quotidiani sauditi Saudi Gazzette e Al-Sharq al-Awsat. Seguì sul campo il
conflitto in Afghanistan, esploso nel 1979 con l’invasione dell’Armata Rossa
sovietica. Prima controversia: in una fotografia si vede il cronista con fucile
d’assalto e abiti afghani. Non combatteva ma simpatizzava per i mujaheddin. Si
era infatti avvicinato alle idee dei Fratelli Musulmani, nati in Egitto e volti
alla cancellazione dei resti del colonialismo occidentale nel mondo arabo.
Conobbe e incontrò e intervistò in diverse occasioni quindi Osama Bin Laden,
saudita come lui, fondatore dell’organizzazione islamista e terrorista Al Qaeda,
diventato tristemente noto perché considerato responsabile degli attacchi
dell’11 settembre 2001 agli Stati Uniti. Khashoggi prese tuttavia le distanze da
Bin Laden negli anni ’90, disapprovando l’esaltazione dell’uso della violenza
contro l’Occidente. Quando arrivò all’Al Watan, quotidiano saudita, da redattore
capo, il giornalista fu costretto alle dimissioni dopo appena 54 giorni perché
le sue idee erano considerate troppo progressiste per le autorità saudite. Con
quest’ultime il giornalista intrattenne sempre legami ambigui. Quando il
principe Turki al-Faisal, a capo dell’intelligence saudita per più di 20 anni,
nel 2005 venne nominato ambasciatore a Washington, Khashoggi lo seguì. All’Al
Watan tornò dopo due anni, e ci rimase per quasi tre anni, prima di essere
licenziato. Khashoggi ha quindi lanciato Al-Arab, una rete all news, con il
miliardario saudita Al-Waleed bin Talal. Il Bahrein, fedele alleato saudita,
chiuse l’emittente nel 2015 dopo un’intervista a un funzionario
dell’opposizione. Due anni dopo, 2017, dopo la nomina del principe Mohammed bin
Salman a erede al trono, il giornalista fuggì dall’Arabia Saudita. Auto-esilio.
Nel giro di un paio di mesi il principe Al-Waleed e centinaia di funzionari e
uomini d’affari furono arrestati, coinvolti in un giro di vite feroce
propagandato come un’operazione anti-corruzione. Sul Washington Post Khashoggi
scrisse dunque che con il principe l’Arabia Saudita era entrata in una nuova era
di “paura, intimidazioni, arresti e vergogna pubblica”. Critiche anche per il
conflitto in Yemen, nel quale Riad fronteggia i ribelli Houti alleati dell’Iran
– ancora irrisolto, ha causato migliaia di vittime e destabilizzato il Paese
causando -, per essere stato bandito da Twitter dal suo Paese e per il
boicottaggio promosso ai danni del Qatar. “Il mondo arabo sta affrontando la sua
versione di una cortina di ferro, imposta non da attori esterni ma attraverso
forze interne in lizza per il potere. Dobbiamo fornire una piattaforma per le
voci arabe”, osservò nell’ultimo editoriale sul Washington Post.
L’omicidio
Il 2 ottobre 2018 il giornalista entrò nel
consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia, e non uscì più. Si era
recato presso la sede diplomatica per ottenere i documenti per il matrimonio:
avrebbe dovuto sposare la sua compagna Hatice Cengiz. Da quel giorno fu
dichiarato persona scomparsa. “Ucciso in una colluttazione”, la versione di
Riad. “Fatto a pezzi mentre era ancora vivo”, avevano precisato gli inquirenti
turchi. Il corpo di Khashoggi è stato smembrato. Nel processo l’autista del
consolato, Edip Yilmaz, ha raccontato come quel 2 ottobre della sparizione lui e
altri impiegati turchi furono chiusi in una stanza del consolato e lasciati ad
aspettare per tutta la giornata. Per il caso un processo farsa si è svolto in
Arabia Saudita, a porte chiuse, e otto anonimi sono stati condannati con pene
tra i sette e i venti anni. Il rapporto dell’intelligence Usa che fa riferimento
al ruolo di Mohammed Bin Salman non è stato incluso nel fascicolo del processo.
Le Nazioni Unite hanno chiesto a Riad “di rivelare se i suoi resti (di
Khashoggi, ndr) sono stati distrutti sul posto o come e dove sono stati
smaltiti”.
“La storia di questo giornalista del Washington
Post di 60 anni che era stato assassinato per aver detto cose vere ai potenti mi
ha conquistato come mi ha conquistato la storia di Hatice Cengiz, la sua
fidanzata. Pochi giorni dopo l’assassinio di Jamal, il New York Times pubblicò
un articolo su Omar Abdulaziz, il giovane dissidente saudita che vive in
autoesilio a Montreal, in cui sosteneva di sapere perché Jamal era stato ucciso
e si sentiva in parte responsabile del suo assassinio perché avevano lavorato
insieme. Questa storia ha stimolato in me il desiderio di fare film che abbiano
una componente di attivismo”, ha detto il regista di The Dissident Bryan Fogel.
Il film offre numerosi filmati inediti e testimonianze esclusive. The
Dissident è stato finanziato dalla Human Rights Foundation.
Proprio il caso Khashoggi è stato rinfacciato
a Matteo Renzi – leader di Italia Viva, senatore, segretario del Partito
Democratico ed ex Presidente del Consiglio – dopo la sua visita in Arabia
Saudita, lo scorso gennaio, per una conferenza organizzata da un think tank
proprio con il principe Mbs. “È un grande piacere e un grande onore essere qui
con il grande principe Mohammad bin Salman – aveva detto Renzi – l’Arabia
Saudita possa essere il luogo per un nuovo Rinascimento”. Renzi si è difeso
dicendo che non ci sarebbero prove che bin Salman sia stato il mandante
dell’omicidio altrimenti l’amministrazione Biden avrebbe imposto sanzioni
sull’Arabia Saudita.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
·
Quei
razzisti come gli yemeniti.
Guerra in Yemen: 10mila bambini uccisi o
mutilati. Piccole Note il 20 ottobre 2021 su Il
Giornale. “Una vergognosa pietra miliare è stata aggiunta al conflitto in Yemen”
ha dichiarato il portavoce dell’Unicef James Elder al momento di rendere
pubblico il nuovo rendiconto della guerra che vi imperversa, che ha ucciso o
mutilato finora 10mila bambini. “Lo Yemen è il posto più difficile al mondo in
cui essere un bambino. E, incredibilmente, sta peggiorando”, ha aggiunto.
Infatti, i fanciulli non devono solo evitare bombe a proiettili. In questa
guerra criminale si muore anche di malattia e di fame. L’Agenzia delle nazioni
unite dedicata all’infanzia ha infatti dettagliato che più di 11 milioni di
bambini (quattro su cinque) hanno bisogno di assistenza umanitaria e, di questi,
circa 400.000 soffrono di malnutrizione acuta grave, mentre più di due milioni
non vanno a scuola. E ancora: 1,7 milioni di bambini sono sfollati interni,
vivono cioè in abitazioni improvvisate, spesso tendoni, e 15 milioni di persone
(più della metà delle quali sono bambini) non hanno accesso all’acqua potabile,
ai servizi igienici e vivono in condizioni igieniche degradate.
Gli Usa e gli “elicotteri d’attacco” difensivi
Comunicati del genere si susseguono da anni, e da
anni la crisi umanitaria dello Yemen è classificata come la “peggiore al mondo”.
E da anni il mondo ascolta distrattamente questi allarmi, dato che i media
mainstream dedicano a questa tragedia qualche riga ogni tanto, con articoli in
genere nascosti. È un tema da gestire con cura la guerre yemenita, dato che a
bombardare sono i sauditi, stretti alleati dell’Occidente, colonna portante
dell’asse anti-Iran in Medio oriente e Paese indispensabile per il petrolio.
Tant’è. L’amministrazione Biden, al suo esordio, si era pronunciata con fermezza
su tale crisi, annunciando solennemente la fine del sostegno americano nelle
operazioni offensive in Yemen. Una determinazione che ha ottenuto pieno sostegno
nel Congresso, ma che resta ambigua, essendo rimasta in piedi la partnership con
i sauditi riguardo la difesa. Ciò implica un coordinamento di intelligence e
militare dai contorni più che indefiniti, dal momento che in una guerra è
difficile stabilire con chiarezza i confini tra operazioni offensive e
difensive. Lo dimostra, solo per fare un piccolo esempio, quanto avvenuto a
inizi settembre, quando l’amministrazione Usa ha notificato al Congresso di aver
dato seguito a una vendita di armamenti ai sauditi per un totale di 500 milioni
di dollari. In particolare, la notifica riguarda la vendita di servizi di
manutenzione di hardware per gli “elicotteri d’attacco di fabbricazione
statunitense già di proprietà del regno” (The National News). Una misura
giustificata dalla necessità di rendere l’esercito saudita in grado di
difendersi in caso di attacco, ma si può facilmente immaginare dove siano
impiegati questi elicotteri d’attacco, dato che Riad non ha altre guerre aperte
in corso se non quella yemenita. Tale l’ipocrisia dei signori della guerra.
La guerra al Terrore dirottata
Detto questo, a fronte dell’attivismo di tali
ambiti guerrafondai, per i quali la guerra è solo un proficuo business, sembra
che l’amministrazione Biden stia cercando in qualche modo di fare qualcosa,
lavorando sottotraccia, purtroppo, dato che le accuse incrociate derivanti dal
ritiro afghano l’hanno costretta a rivedere al ribasso i piani per porre fine
alle guerre infinite, alle quali appartiene di diritto il conflitto yemenita,
dato che gli Usa vi si erano impegnati ufficialmente per contrastare la minaccia
delle cellule terroriste che agivano in Yemen. Su Reveal si può leggere
l’interessante, e dettagliata, storia di come gli Stati Uniti fossero
consapevoli del fatto che il governo yemenita, al tempo, avesse “dirottato” la
missione anti-terrorismo americana per combattere i ribelli Houti, cosa che, in
fondo, da allora non è poi cambiata di tanto, al di là dei distinguo. Tornando
all’impegno di Biden, da registrare la recente visita del ministro degli Esteri
saudita, il principe Faisal bin Farhan, negli Stati Uniti, dove ha incontrato il
Capo del Dipartimento di Stato Anthony Blinken. In agenda, Iran e guerra in
Yemen. In parallelo a questa visita, la nota del Washington Post sul negoziato
che si è instaurato tra Teheran e Riad, che è serio, come da dichiarazioni di
entrambe le parti, e che si sta sviluppando in una serie di incontri ad alto
livello. Significativo il titolo del WP: “Arabia Saudita e Iran faranno pace
sullo Yemen?”. Dietro la nuova propensione al dialogo di Riad vi è una chiara
spinta dell’amministrazione Biden, che non può imporre, data la debolezza
interna,, ma può far pressioni per chiudere un conflitto che la mette in serio
imbarazzo dovendo proporsi al mondo come difensori dei diritti umani.
I sauditi nel pallone
In attesa che il punto di domanda del Washington
Post diventi punto esclamativo, c’è da registrare l’attivismo di Riad
nell’ambito sportivo: di queste settimane l’annuncio che il Fondo per gli
investimenti pubblici ha acquistato il Newcastle e ha avviato una trattativa
per l’acquisto dell’Inter. Una mossa che ha visto le squadre della Premier
League insorgere, imponendo una regola che impedisce a una squadra di acquisire
pubblicità da aziende legate al padrone, e poche contrarietà in Italia.
D’altronde, pecunia non olet né è un male che il calcio attiri investitori,
anzi.
Il problema è che tale attivismo non sembra
affatto casuale: l’immagine dell’Arabia Saudita si è alquanto offuscata negli
ultimi anni, sia per il conflitto in Yemen, sia soprattutto per l’omicidio del
giornalista dissidente Jamal Khashoggi, attribuito a Riad (tale assassinio ha
fatto più clamore dell’uccisione di migliaia di bambini yemeniti…). Da qui la
necessità per i sauditi di dare un ritocco alla loro immagine investendo nello
sport più partecipato d’Europa. Calcolo non del tutto errato, considerando poi
che il calcio è un sistema del quale partecipano i media, che attingeranno a
cascata di tali investimenti. E ciò gli guadagnerà ulteriori simpatie. In attesa
del fischio d’inizio delle nuove partite, si spera che finalmente giunga il
fischio finale per il conflitto yemenita. Da qualche tempo, anche i sauditi
vorrebbero uscirne, dato il danno di immagine che gli procura e l’impossibilità
di conseguire la vittoria. Ma a dettar legge è la Macchina della guerra alla
quale si sono consegnati all’inizio di questa brutta storia e che li ha resi
schiavi. Una Macchina che può essere inceppata solo a Washington, da cui
l’importanza del lavoro – seppur ambiguo, timido e sottotraccia –
dell’amministrazione americana.
Ps. Di oggi la notizia che la polizia tedesca ha
arrestato due persone, Achim A. e Arend-Adolf G (nome appropriato) per aver
tentato di costituire una milizia mercenaria da porre al servizio dei sauditi,
consapevoli che avrebbero commesso “omicidi” e che le loro azioni avrebbero
comportato che “civili venissero uccisi e feriti” (generalbundesanwalt). I
sauditi avrebbero rifiutato l’offerta, ma che esistano milizie simili attive in
questa sporca guerra lo ha rivelato il New York Times, con un articolo sul
reclutamento di mercenari colombiani da parte degli Emirati arabi uniti.
·
Quei
razzisti come i bielorussi.
Luigi Guelpa per "il Giornale" il 9 agosto 2021.
Un anno fa come oggi Aleksander Lukashenko si autoproclamava presidente della
Bielorussia, malgrado il mancato riconoscimento delle istituzioni internazionali
e le proteste. Il 9 agosto del 2020 festeggiava un trionfo costruito su evidenti
e grossolani brogli elettorali. Quel giorno apparve in tv per chiosare di aver
ottenuto l'80% delle preferenze, mentre gli osservatori internazionali presenti
a Minsk riuscirono a provare che la leader dell'opposizione, Svetlana
Tikhanovskaya aveva conquistato addirittura 85 dei 126 seggi, con oltre il 70%
delle preferenze. Nell'ultimo anno in Bielorussia è accaduto davvero di tutto,
tra arresti di oppositori e giornalisti, aerei dirottati, rappresentanti delle
opposizioni costretti all'esilio o addirittura «suicidati», e organizzazioni
umanitarie smantellate. Lukashenko ha usato il pugno di ferro, vantando
l'appoggio di Mosca che non sembra essere più solido come un tempo. La
repressione contro l'opposizione e la libertà di stampa va avanti a ritmo
serrato, in risposta alle enormi proteste contro l'autoritarismo e i brogli
elettorali. Secondo le Nazioni Unite, da agosto 2020 a oggi in Bielorussia sono
state arrestate per ragioni futili legate alle proteste più di 35 mila persone.
Molte delle quali potrebbero essere finite nel campo di prigionia per dissidenti
politici di recente costruzione, a circa un'ora di macchina da Minsk, vicino
all'insediamento di Novokolosovo, immortalato dalle immagini della Cnn. Senza
contare che la nuova ondata di detenzioni cominciata a luglio è particolarmente
grave perché ha riguardato una sessantina di Ong note e rispettate. C'era molta
attesa in una nuova mossa della Tikhanovskaya, ma è ormai da quasi un anno in
esilio all'estero, e la sua capacità di esercitare influenza sul Paese si sta
affievolendo. Nelle ultime settimane la leader dell'opposizione, che ora vive in
Lituania, è stata negli Usa, dove ha incontrato membri del Congresso e il
segretario di Stato Blinken. Ha ottenuto numerose dichiarazioni di sostegno e
appoggio, ma nessuna misura concreta. Sperava di convincere Biden (che non l'ha
ricevuta) a imporre contro Lukashenko sanzioni ancora più dure di quelle già
imposte, e fare in modo che il Fondo monetario internazionale posticipasse un
pagamento previsto alla Bielorussia di un miliardo di dollari. Per ora nessuno
di questi obiettivi è riuscito. Anche Vitaly Shyshou, a capo della Ong
Belarusian House in Ukraine, aveva tentato di allestire una nuova macchina che
organizzasse proteste di piazza in occasione dell'anniversario delle
elezioni-farsa, ma il 2 agosto è morto impiccato. Gli osservatori internazionali
non hanno dubbi e ritengono che Shyshou sia stato eliminato dai sicari del
regime. Gli stessi che avrebbero voluto sbattere in cella o in un ospedale
psichiatrico la sprinter Krystsina Tsimanouskaya, che da Tokyo ha ottenuto un
visto umanitario dalla Polonia per lasciare il suo Paese e continuare la
carriera senza il rischio di subire ritorsioni. Lukashenko del resto non si
ferma di fronte a nulla. Lo si è compreso perfettamente a maggio, quando ha
ordinato ai caccia di intercettare un aereo della Ryanair che volava da Atene a
Vilnius, per costringerlo a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Minsk e
arrestare l'attivista dell'opposizione Roman Protasevich che si trovava a bordo.
Ufficialmente non sono previste per oggi manifestazioni di piazza. Domenica si
sono mossi con striscioni e cortei solo i dissidenti che vivono a Vilnius e a
Varsavia. Radio Svaboda, l'ultima voce libera del Paese, annuncia però che
qualcosa potrebbe accadere sul confine con la Lituania, dalle parti di
Rudninkai. Da alcune settimana infatti Lukashenko risponde alle sanzioni volute
da Bruxelles usando i migranti come arma impropria. Il governo bielorusso si sta
impegnando attivamente per portare migranti, via aria, direttamente sul suolo
nazionale, indirizzandoli poi verso la Lituania. Rudninkai, ormai trasformata in
una Calais dell'est, potrebbe diventare l'epicentro delle odierne proteste
anti-regime.
Alessandra Muglia per il "Corriere della Sera" il
5 agosto 2021. Provata, ma finalmente libera. Jeans, camicia e mascherina,
Kristina Tsimanouskaya è arrivata a destinazione. Partita per il Giappone da
atleta sconosciuta al mondo, è tornata ieri in Europa da dissidente riluttante,
celebre in tutto il mondo suo malgrado. La velocista bielorussa che voleva solo
correre si è ritrovata ai Giochi al centro di una crisi diplomatica inaspettata.
Lontana dalla politica, mai avrebbe pensato di trasformarsi in un'icona della
lotta alla repressione, lei che 24enne non ha mai conosciuto un presidente
diverso da Lukashenko, al potere dal 1994. La sua storia dimostra che non
occorre essere un'attivista per finire nel mirino del regime. Ieri sera alle 8
il suo volo è atterrato a Varsavia. Un viaggio ad alta tensione. Avrebbe dovuto
dirigersi da Tokyo direttamente in Polonia ma all'ultimo il programma è
cambiato. Questione di sicurezza: su quell'aereo si erano già prenotati alcuni
giornalisti. E soprattutto, il dirottamento a maggio del volo Ryanair per
arrestare l'oppositore Roman Protasevich, ha imposto cautele in più. Un aereo
Austrian Airlines l'ha portata dopo le 15 a Vienna; da qui in serata il
trasbordo a Varsavia. Giornalisti tenuti a distanza, Kristina è apparsa «in
buona forma ma stanca» a Magnus Brunner, il viceministro austriaco dell'Ambiente
che l'ha incontrata. «È preoccupata per la sua famiglia»: gli agenti del
presidente-dittatore sono già andati a trovare i genitori. «È anche tesa per
quello che l'aspetta». Una nuova vita, pur con il marito, un atleta anche lui
che, fuggito a Kiev appena scoppiato il caso, ieri ha ottenuto il visto polacco.
Resterà un'atleta: la Polonia, oltre al visto umanitario e all'asilo, le ha
offerto la possibilità di continuare a correre. Non si aspettava che le sue
rimostranze sportive al team di allenatori si trasformassero in un caso
internazionale. «Non riesco a capacitarmi, non ho detto nulla riguardante la
politica - ha detto martedì al New York Times - Ho solo manifestato il mio
disaccordo con la decisione dello staff», quella di iscriverla all'ultimo alla
staffetta 4x400 senza neanche avvisarla. Dopo il suo post sono arrivate quelle
che lei ha chiamato «pressioni», in realtà minacce a leggere la sua
conversazione con due tecnici che cercavano di convincerla a tornare a casa.
«Così finiscono i suicidi, cosa vuoi dimostrare?». E lei: «Niente, voglio solo
correre». Kristina non aveva neanche firmato la lettera aperta dei mille atleti
bielorussi per chiedere nuove elezioni: per questo in 35 sono stati espulsi
dalla nazionale. Tra loro l'eptatleta Yana Maksimava e il marito decatleta
Andrei Krauchanka, non convocati per i Giochi: dopo il rimpatrio di
Tsimanouskaya hanno annunciato sui social che «resteremo in Germania, in
Bielorussia non si rischia solo la libertà ma anche la vita». Tsimanouskaya,
invece, aveva solo le Olimpiadi in testa. Una volta a Tokyo, quando per punirla
l'hanno costretta a ritirarsi, sapeva che se fosse tornata a Minsk il suo futuro
era spacciato. La sua fermezza l'ha salvata.
Irene Soave per il "Corriere della Sera" il 5
agosto 2021. Il testo che segue è una parte della conversazione tra l'atleta
bielorussa Kristina Tsimanouskaya, che ha appena criticato sui social i vertici
della sua squadra, il vicedirettore della federazione di atletica leggera Artur
Shumak e l'allenatore capo Yuri Moisevich. I due dirigenti stanno comunicando
all'atleta che dovrà rientrare in Bielorussia. Una parte della conversazione,
registrata clandestinamente, è stata diffusa poco dopo da un canale Telegram,
@nic_and_mike, che pubblica informazioni «da dietro le quinte del potere»;
l'atleta stessa, contattata dal canale in lingua russa Current Time, ne ha
confermato l'autenticità. Dura 19 minuti. Shumak: «Sono arrivate le seguenti
istruzioni: tu oggi te ne torni a casa, non scrivi niente da nessuna parte, non
fai dichiarazioni. Te la dico così come me l'hanno detta, parola per parola. Se
vuoi di nuovo gareggiare per la Bielorussia, vai a casa o dai tuoi o dove ti
pare. Più ti agiti... Hai presente una mosca nella ragnatela? Più si dimena,
peggio è. Ecco, la vita è così. Facciamo cose stupide. Tu hai fatto una cosa
stupida».
Tsimanouskaya: «Non dovevate informarmi? [che
avrebbe dovuto correre nella staffetta, ndr ]»
S: «Te lo rispiego. Qui tu rappresenti la
Repubblica di Bielorussia. Non è tua la colpa se non ti hanno informata, però
resti responsabile di quel che dici. Stai accusando gente qua e là nel paese
senza sapere nemmeno perché e percome. Sai cosa potrebbe provocare la tua
stupidità? Che ci sia chi perde il lavoro. Gente che ha famiglie. Con la tua
stupidità potresti distruggere vite intere. [...] Oltretutto, sai benissimo che
non potresti competere in questo stato emotivo».
T: «Ho vinto un'Universiade in questo stato
emotivo».
S: «Non stavi così. Ora sei fuori controllo».
Moisevich: «E mi dispiace, ma non lascerai un buon
ricordo di te se non ti calmi».
M: «Ora devo andare. Devi anche darmi 350 dollari
di diaria che non avrai più. [ fa i conti ] Guarda, dammi 150 dollari. Se è
troppo te li ridò».
T: «Per me non fanno alcuna differenza».
M: «Non è che siano soldi miei. Non capisci? Ho
sessant' anni, non mi spaventa più nulla, ma se arriva uno di questi funzionari
e dice "Eseguirò gli ordini"? Potrebbe farci una purga tale che non resterebbe
più nulla della squadra. E tu resterai nella storia: diranno, tutto è iniziato
con la Tsimanouskaya. Mi ascolti?»
T: «Non penso che questa storia finirà bene per
me».
M: «No. Hai sentito il ministro? Beh, poi mi ha
parlato: è insubordinazione. [...] Mi ha detto: parlale tu... Se tu te ne vai le
cose andranno avanti, ci saranno medaglie, tutto sarà dimenticato; se resti,
contro la sua volontà, sarà un precedente che interferisce col futuro della
squadra. Non puoi farlo per la squadra? [...] È così che vanno i suicidi, sai?
Il diavolo spinge uno sul davanzale e gli dice: salta, dimostraci che lo sai
fare. E sai cos' è la cosa peggiore? Che alla fine non avrai dimostrato niente a
nessuno. E potevi vivere».
M: «Ora diremo al Comitato che ti sei fatta male,
la risolviamo così, e tu te ne vai. Quando poi tutto si è calmato ti prometto
che resterai nell'atletica leggera».
T: «Non ci credo».
M: «Beh, lo sai che l'alternativa è peggio. Sai
cosa si dice delle cancrene, no? Se non tagli mezza gamba poi muori. Sei una
ragazza sveglia. Sai che ho ragione. [...] Dai, piangi un altro po' e vado a
dire che siamo d'accordo».
T (in lacrime): «Ma non siamo d'accordo».
Da ilgiorno.it il 2 agosto 2021. La Polonia ha
offerto la possibilità di fornire asilo politico alla velocista bielorussa
Krystsina Tsimanouskaya che si rifiuta di tornare nel suo paese dopo le
Olimpiadi: lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato francese per gli Affari
europei Clement Beaune. "Discuteremo con i nostri partner europei se possiamo
concederle asilo politico entro le prossime settimane o addirittura giorni", ha
detto Beaune alla stazione radio RFI. Tsimanouskaya ha accusato le autorità del
suo paese di aver tentato di rimpatriarla con la forza, ed è ora sotto la
protezione della polizia giapponese, ha affermato oggi il Cio. L'atleta
bielorussa al momento è "al sicuro" in un albergo a Tokyo. Lo ha assicurato il
Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Domenica la velocista 24enne, che
partecipa alle Olimpiadi, aveva espresso preoccupazione, dicendo di sentirsi
minacciata, per aver apertamente criticato la sua federazione nazionale. "Ci ha
detto che si sentiva al sicuro", ha reso noto il direttore della comunicazione
del Cio, Mark Adams, precisando che Tsimanouskaya ha passato la notte in un
albergo dell'aeroporto di Tokyo-Haneda. Adams ha aggiunto che il Cio si
confronterà di nuovo con lei in giornata per conoscere le sue intenzioni e
"sostenerla". La giovane, appoggiata dalla Belarusian Sport Solidarity
Foundation, che in Bielorussia sostiene gli atleti imprigionati o messi da parte
per le proprie posizioni politiche (in opposizione al regime di Alexander
Lukashenko), ha detto di essere stata portata con la forza all'aeroporto per le
critiche espresse nei confronti dei suoi allenatori. Una volta arrivata lì è
però riuscita a chiedere aiuto alla polizia. Tramite il suo portavoce, il
governo giapponese ha da parte sua assicurato che continuerà "a collaborare con
le organizzazioni interessate" e che prenderà "le misure adeguate".
Tsimanouskaya ha accusato le autorità del suo paese di aver tentato di
rimpatriarla con la forza, ed è subito stata messa sotto la protezione della
polizia giapponese. "Il Cio ha parlato con la valorosa atleta Tsimanouskaya
direttamente la scorsa notte. Lei stava con le autorità aeroportuali
all'aeroporto di Hanedsa, era accompagnata da membri dello staff di Tokyo 2020 e
si sentiva al sicuro. Ha trascorso in tranquillità la notte presso l'Airport
Hotel. Il Cio continuerà a parlare con lei e con le autorità giapponesi per
determinare i prossimi passi da intraprendere nei prossimi giorni". L'atleta
bielorussa avrebbe dovuto competere nei 200 metri femminili di atletica oggi, ma
si è rivolta alla polizia ad Haneda chiedendo di aiutarla a non essere imbarcata
in un aereo di ritorno verso la Bielorussa, dopo che ha criticato funzionari
della delegazione bielorussa. Tsimanouskaya intende chiedere asilo politico in
Germania o Austria, ma ha già ricevuto la disponibilità da parte della Polonia
ad accoglierla: il Paese le ha infatti intanto concesso un visto per motivi
umanitari e l'atleta si trova già nell'ambasciata di Varsavia. Per quanto
riguarda l'accusa lanciata dall'atleta nei confronti della delegazione
bielorussa di aver tentato di rapirla, Adams ha risposto: "Ha parlato alla
polizia all'aeroporto. Se c'è un reato, se ne occuperà la polizia". "Il regime
bielorusso è oramai alla stregua del peggiore regime sovietico: dirotta,
incarcera, tortura e adesso rapisce. Manca soltanto il veleno e l'armamentario
degli orrori sarà completo. Il tentativo di rapire l'atleta bielorussa Krystsina
Tsimanousskaya dimostra che questo Stato si è trasformato in una signoria
privata del suo presidente abusivo, per questo la Comunità internazionale deve
continuare a condannare tali comportamenti e chiedere l'intervento della Corte
Penale internazionale, prima che si arrivi a degenerare definitivamente". A
dichiararlo è il deputato M5S, Aldo Penna.
Anna Zafesova per "la Stampa"
il 3 agosto 2021. C'è chi la paragona a Rudolf Nureyev, chi a Martina
Navratilova: alle Olimpiadi di Tokyo la velocista bielorussa Kristina
Tsimanouskaya ha resuscitato, suo malgrado, la tradizione delle star dello sport
e dello spettacolo costrette a fuggire dalle dittature. Un genere che sembrava
dimenticato con il tramonto del totalitarismo sovietico, con Nadia Comaneci
l'ultima grande fuggitiva dalla Romania, pochi mesi prima della caduta del
regime. Ma tra Minsk e Mosca, il ritorno al passato è ormai una politica e
un'ideologia, e gli sportivi tornano a essere soldati arruolati in una guerra, e
puniti per il «tradimento». Tsimanouskaya è stata considerata una «traditrice»
dopo aver commentato, su Instagram, la decisione dei dirigenti olimpici
bielorussi di farla correre i 400 metri, oltre che nelle sue specialità dei 100
e dei 200. L'atleta non era stata nemmeno informata che avrebbe dovuto
sostituire le sue colleghe che non riuscivano a superare i controlli
anti-doping, e aveva reagito in una maniera molto esplicita. Nessuna accusa
politica, soltanto critiche ai capi sportivi, ma in Bielorussia il Comitato
olimpico è presieduto dal figlio di Aleksandr Lukashenko, dopo che per anni è
stato lo stesso presidente a guidarlo, e Kristina è stata ritenuta colpevole di
un reato di lesa maestà. I responsabili della nazionale le hanno ordinato di
ritirarsi dalle gare con il pretesto di un «esaurimento», e l'hanno portata
all'aeroporto di Tokyo per caricarla su un aereo per Istanbul (lo spazio aereo
bielorusso viene boicottato dalle compagnie aeree europee dopo che Minsk ha
dirottato, nel maggio scorso, un volo della RyanAir per arrestare il dissidente
Roman Protasevich che si trovava a bordo). Kristina però è riuscita ad avvertire
alcuni connazionali presenti in Giappone, e ad attirare l'attenzione della
polizia aeroportuale, che l'ha presa sotto la sua protezione. La Polonia le ha
immediatamente concesso rifugio nella sua ambasciata a Tokyo, e l'asilo
politico, mentre anche Repubblica Ceca, Slovenia e Francia si facevano avanti, e
l'Ucraina accoglieva il marito e il figlio di Tsimanouskaya, scappati da Minsk
per non diventare ostaggi del regime. La madre dell'atleta invece ha ricevuto
una visita della polizia politica, che le ha chiesto di aiutare a far tornare in
patria la figlia, vittima di un «complotto dei servizi segreti occidentali». I
media d'opposizione bielorussi hanno pubblicato una registrazione nella quale si
sentono i responsabili della nazionale aggredire e minacciare Tsimanouskaya, per
poi prometterle di «mettere a tacere tutto» se avesse accettato di rientrare a
casa e di «tenere la bocca chiusa». Si sente anche l'atleta singhiozzare, e poi
rispondere «non vi credo» alle garanzie di incolumità offerte. Kristina ha
raccontato che lo psicologo della nazionale è stato convocato per cercare di
farla sentire «colpevole» rispetto ai compagni e ai superiori, che hanno usato
anche insulti a sfondo religioso come «sei stata traviata dal demonio, pecchi di
superbia!». Il Comitato Olimpico internazionale deciderà a breve eventuali
sanzioni contro Minsk, e Amnesty International ha lanciato un appello alla
solidarietà con gli sportivi bielorussi. Curiosamente, anche alcuni atleti e
commentatori sportivi russi si sono schierati con Tsimanouskaya, un segno di
come Lukashenko appaia a molti a Mosca più un problema che una soluzione. Dopo
la vicenda dell'aereo dirottato per arrestare un dissidente, il dittatore di
Minsk mostra di nuovo di non voler riconoscere alcun vincolo e regola. Di
solito, gli autoritarismi cercano al contrario di approfittare delle Olimpiadi
per sfoggiare un volto più pacifico, ma nell'anniversario della rivolta contro
la sua rielezione truccata Lukashenko sembra rendersi conto di non poter contare
su un compromesso, né con l'opposizione, né con l'Europa, e di aver scelto
quindi una tolleranza zero al dissenso, costi quel che costi.
Bielorussia, il regime atterra un aereo
per arrestare un dissidente. «Siamo ai dirottamenti di Stato. Inaccettabile».
Luca Sebastiani su L'Espresso il 24 maggio 2021. Il
caso del volo Ryanair dirottato a Minsk per ordine di Lukashenko scatena le
reazioni delle diplomazie. Ue e Stati Uniti condannano l’atto, mentre la Russia
difende il dittatore. Il regime di Aleksandr Lukashenko continua la sua
repressione contro gli oppositori. L’ultimo caso è quello del 26enne giornalista
e blogger Roman Protasevich, fermato dopo che l’aereo di linea su cui stava
viaggiando, partito da Atene e diretto a Vilnius, è stato costretto da un caccia
militare a deviare e atterrare su Minsk. Al momento del dirottamento mancavano
solo due minuti prima che il mezzo entrasse nello spazio aereo della Lituania.
Secondo quanto riferisce la stampa del paese, l’ordine è arrivato direttamente
dal presidente bielorusso, giustificato da segnalazioni di pacchi sospetti
all’interno dell’aereo. Esplosivi e pericoli non sono stati trovati, ma in
compenso il ragazzo è stato bloccato dalle forze di sicurezza e con lui anche la
fidanzata russa 23enne, Sofia Sapega. Dopo l’arresto, il volo è ripartito
raggiungendo la capitale lituana con sei ore di ritardo. A poche ore di
distanza, nella giornata di lunedì, la Bielorussia ha bloccato un altro volo
«per una minaccia terroristica». Una soffiata ha fatto scattare l’allerta e le
procedure di sicurezza su un volo della Lufthansa in procinto di partire da
Minsk verso Francoforte. Una volta che la notizia dell’aereo dirottato è
cominciata a circolare, le reazioni da Bruxelles e da tutto il mondo non si sono
fatte attendere. «Un comportamento oltraggioso e illegale che avrà conseguenze»
è come lo ha definito la presidente della Commissione europea Ursula Von der
Leyen, auspicando la liberazione del giornalista. Gli ha fatto eco Charles
Michel, presidente del Consiglio europeo, che ha esortato ad aprire un'accurata
indagine dell’incidente, mentre per Josep Borrell, l’Alto Rappresentante Ue per
la Politica Estera e di Sicurezza, è un avvenimento «inammissibile». La prima
mossa è stata la convocazione dell’ambasciatore bielorusso in Ue ma potrebbero
arrivare ulteriori sanzioni, visto che sia il Consiglio sia gli ambasciatori
della Nato si riuniranno tra lunedì 24 e martedì 25 per stabilire l’entità dei
nuovi provvedimenti. E una delle misure che verrà messa sul tavolo sarà quella
di sospendere tutti i voli europei provenienti o diretti in Bielorussia fino
alla liberazione di Protasevich. Ma si sono alzate voci non solo dai
rappresentanti ufficiali di Bruxelles. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha
esternato le sue preoccupazioni e ha lanciato un appello, come riferisce l’Ansa:
«Quello che è avvenuto ieri è inaccettabile. Siamo al dirottamento di Stato.
L’Unione europea deve essere unita, non facciamoci dividere da attori terzi
perché è su questa arroganza che si compiono azioni del genere». Anche Londra e
soprattutto Washington hanno manifestato il loro sconcerto per l’accaduto, con
il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello britannico Dominic Raab
che hanno entrambi comunicato l’intenzione di coordinarsi con gli alleati per le
risposte da dare. Espressioni tipiche, quasi di rito e diplomatiche. Ma un po’
meno lo sono state quelle rilasciate da un attore che a suo discapito è
diventato protagonista del dirottamento: Ryanair. In un primo timido comunicato
nella giornata di domenica 23, la compagnia di fatto non ha menzionato l’arresto
del giornalista nè tantomeno la pratica inconsueta delle forze bielorusse.
Tuttavia, poche ore dopo in un’altra nota la società ha condannato «le azioni
illegali delle autorità bielorusse, un atto di pirateria aerea». Il Ceo Michael
O’Leary, su una radio irlandese, ha affermato che sul velivolo c’è il sospetto
siano saliti direttamente agenti del Kgb pronti ad agire e che siano scesi a
Minsk. A bordo avrebbero intimato al personale di deviare e seguire il caccia
bielorusso. Un fatto grave che ha già causato le prime ripercussioni. La
Lituania ha vietato di sorvolare lo spazio aereo della Bielorussia a tutti i
voli che partono o che arrivano nel paese. Ma le avvertenze non si sono limitate
all’aeronautica civile. Il governo ha anche invitato i propri cittadini a non
recarsi a Minsk e di lasciare immediatamente la Bielorussia. Una misura grave,
per due paesi in “pace”. A Vilnius sono stati poi interrogati i piloti per avere
la loro testimonianza. Chi invece ha difeso l’operato di Minsk è stata Mosca,
alleata di Lukashenko e principale sponsor del regime. Il ministro degli Esteri
russo Sergej Lavrov, parlando di «approccio ragionevole», ha invitato tutta la
comunità internazionale a «valutare a mente lucida la situazione». Anche se la
nazionalità russa della compagna del giornalista ha forzato la scelta del
Cremlino di richiedere un incontro del console. La ragazza, che secondo fonti
locali sarebbe reclusa nel carcere di via Okrestina a Minsk, avrebbe fatto in
tempo solo a scrivere un messaggio alla madre prima di essere fermata dai
bielorussi. I due stavano ritornando da un semplice viaggio di vacanza.
Protasevich era fuggito dalla Bielorussia nel 2019, accrescendo quella schiera
di dissidenti politici rifugiati all’estero, specialmente nei paesi baltici e in
Polonia. Una diaspora aumentata in maniera esponenziale dopo le proteste della
scorsa estate. Dai paesi limitrofi sono in molti ad aver proseguito la lotta
contro il regime di Lukashenko, divulgando e pubblicando le prove delle
nefandezze compiute dalle forze di sicurezza di Minsk, sia per le strade che
nelle carceri del paese. Proprio per questo i giornalisti continuano ad essere i
primi bersagli della repressione.
(ANSA il 25 maggio 2021) - "Non tolleriamo che si
giochi alla roulette russa con la vita dei civili": lo ha detto il presidente
del Consiglio europeo Charles Michel presentando le sanzioni contro la
Bielorussia per il "fatto scandaloso accaduto ieri". La risposta Ue "è
all'altezza dell'offesa", ha aggiunto.
(ANSA il 25 maggio 2021) - "Gli Stati Uniti
condannano duramente il dirottamento del volo della Ryanair in Bielorussia per
permettere l'arresto del giornalista Roman Protasevich": lo afferma il
presidente americano Joe Biden, che accoglie favorevolmente la richiesta Ue di
sanzioni economiche mirate. "Ho chiesto al mio team di studiare opzioni adeguate
per i responsabili", ha aggiunto Biden, invocando "un'indagine internazionale
sull'incidente".
(ANSA-AFP il 25 maggio 2021) - La compagnia di
bandiera francese Air France ha annunciato che non volerà per il momento sulla
Bielorussia dopo il caso Ryanair e le sanzioni decise dall'Ue contro Minsk. "Air
France ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo e di conseguenza ha
deciso di sospendere, fino a nuovo ordine, il sorvolo dello spazio aereo
(bielorusso) da parte dei suoi aeromobili", ha annunciato la compagnia in un
comunicato nel quale si precisa che la rotta degli aerei già in volo verso la
Bielorussia "sarà modificata".
Francesca Basso per il "Corriere della Sera" il 25
maggio 2021. Una discussione veloce. I capi di Stato e di governo dei 27 Stati
membri riuniti al Consiglio europeo straordinario si sono trovati rapidamente d'
accordo sulle misure da adottare per «condannare con forza» l'atterraggio
imposto dalle autorità della Bielorussia al volo Ryanair Atene-Vilnius che ha
portato all' arresto del giornalista dissidente Roman Protasevich e della sua
fidanzata Sofia Sapega. I leader Ue hanno chiesto il rilascio immediato di
entrambi e che sia garantita loro la libertà di movimento. Protasevich è apparso
in video dal suo luogo di detenzione assicurando di «stare bene», ma con il
volto segnato. I leader Ue hanno deciso che siano adottate il più velocemente
possibile nuove sanzioni nei confronti di persone ed enti della Bielorussia. Le
sanzioni attuali - divieto di viaggio e congelamento dei beni - hanno già
colpito sette entità e 88 persone tra cui lo stesso dittatore Alexandr
Lukashenko, suo figlio Viktor che è consigliere per la sicurezza nazionale e
altre figure chiave. I capi di Stato hanno invitato tutte le compagnie aeree con
sede nell' Ue a evitare di sorvolare la Bielorussia e chiesto al Consiglio Ue di
adottare le misure necessarie ad evitare il sorvolo dello spazio aereo
dell'Unione da parte delle compagnie bielorusse e di impedire l'accesso agli
scali dell' Ue. Hanno inoltre richiesto un'indagine dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (Icao) sull' accaduto. Inoltre invitano
l'Alto rappresentante Josep Borrell a presentare proposte per nuove sanzioni
economiche mirate o settoriali. La presidente della Commissione Ursula von der
Leyen, a margine del vertice, ha detto che «ci sono 3 miliardi di euro di
investimenti pronti nell' Ue, congelati finché la Bielorussia non diventerà una
democrazia». Questo per fare pressione su Minsk. La giornata è stata un
crescendo di tensioni. L' Alto rappresentante Ue Borrell ha convocato
l'ambasciatore bielorusso presso la Ue. Così hanno fatto Berlino e Roma. Anche
Londra ha convocato l' ambasciatore e ha chiesto alle compagnie aeree
britanniche di evitare lo spazio aereo della Bielorussia. Inoltre il governo
britannico ha bandito la compagnia aerea bielorussia Belavia. Minsk ha espulso
l' ambasciatore lettone e il suo staff, e la Lettonia ha fatto altrettanto in
risposta. I leader Ue hanno espresso solidarietà a Riga. Il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel ha definito l' atterraggio forzato «uno
scandalo internazionale: le vite di civili europei sono stato messe a rischio e
non è accettabile». Per la presidente von der Leyen si è trattato di «un
dirottamento completamente inaccettabile». E per la cancelliera tedesca Angela
Merkel «tutte le spiegazioni invocate dalla Bielorussia sono completamente
inverosimili». Minsk si è difesa dicendo di avere ricevuto «una mail da Hamas»
in cui si minacciava di far «saltare in aria» l' aereo se l' Europa non avesse
«cessato il suo appoggio verso Israele». E la minaccia terroristica è l'
espediente usato anche ieri dalle autorità bielorusse per ritardare la partenza
dall' aeroporto di Minsk del volo della Lufthansa diretto a Francoforte per
controlli di sicurezza. L' Ue ha deciso le prime sanzioni contro la Bielorussia
nell' ottobre scorso in risposta ai brogli nelle elezioni del 9 agosto 2020 e
alla violenta repressione dei manifestanti pacifici. Sul tavolo dei capi di
Stato e di governo dei 27 Stati membri c' era oltre alla Bielorussia anche il
dossier Russia, su cui la discussione si è protratta nella notte. In entrambe le
sessioni, per garantirne la riservatezza, sono stati fatti togliere tutti i
dispositivi elettronici dalla sala.
Da ilfattoquotidiano.it il 24 maggio 2021.
L’Unione europea blocca il pacchetto d’investimenti da 3 miliardi di euro che
dovevano finire in Bielorussia dopo il dirottamento di un volo Ryanair e
l’arresto del dissidente Roman Protasevich che viaggiava a bordo. La presidente
della Commissione, Ursula von der Leyen, entrando al Consiglio Ue che, tra le
altre cose, dovrà decidere quali provvedimenti prendere nei confronti del
governo di Minsk, ha dichiarato che “serve una risposta molto forte contro
questo dirottamento completamente inaccettabile. Lukashenko deve capire che
questo atto non può essere senza conseguenze. Il pacchetto economico da 3
miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue in Bielorussia resta
congelato finché la Bielorussia non diventerà democratica”. E si stanno
discutendo sanzioni dirette contro individui ed entità economiche che finanziano
il regime e contro l’aviazione. La vicenda che ha coinvolto l’ex direttore del
canale Telegram Nexta, nonché oppositore politico di Lukashenko, si allarga di
ora in ora sul piano diplomatico, con la Bielorussia che si difende dagli
attacchi dell’Occidente che “politicizza la situazione” e Mosca che prende le
difese dell’alleato storico, aprendo una nuova frattura con Usa e Ue dopo i
recenti scontri sul caso di Alexei Navalny. Il Consiglio Ue che si riunisce
stasera ha in cima all’agenda la discussione su possibili sanzioni a Minsk,
mentre la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha commentato: “Abbiamo assistito
a un atterraggio forzato, tutte le altre spiegazioni sono del tutto
inverosimili. Roman Protasevich deve essere rilasciato immediatamente, così come
la sua compagna”. La Farnesina, così come altri Paesi europei, ha convocato
l’ambasciatore bielorusso. E anche il presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli, chiede una presa di posizione forte da parte dell’Unione: “I fatti di
ieri sono di una gravità inaudita. Chiediamo l’immediato rilascio e un’indagine
internazionale. La nostra risposta dev’essere forte, immediata e unitaria.
L’Unione europea deve agire senza esitazioni e punire i responsabili. Stasera
avete una grande responsabilità per dimostrare che l’Unione non è una tigre di
carta”. Anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “appoggia le
richieste di un’indagine completa, trasparente e indipendente”. “Ricevuta una
minaccia da Hamas” – Le autorità bielorusse avevano giustificato il loro
intervento e l’atterraggio parlando di allarme bomba a bordo: un allarme che, ha
detto il direttore del dipartimento dell’aviazione del ministero dei Trasporti,
Artem Sikorsky, proveniva da Hamas ed è arrivato via mail. “Noi, i soldati di
Hamas, chiediamo che Israele cessi il fuoco a Gaza e chiediamo che l’Ue rinunci
al suo sostegno a Israele. I partecipanti al forum economico di Delfi tornano a
casa con il volo 4978. Una bomba è stata messa in questo aereo. Se non
soddisfate le nostre richieste, esploderà sopra Vilnius”, recitava la mail
comunicata da Sikorsky. A questo però non è seguito il ritrovamento di alcun
ordigno, ma solo l’arresto di Protasevich. Igor Goloub, comandante
dell’aeronautica, ha inoltre aggiunto che la decisione dell’atterraggio “è stata
presa dal comandante dell’equipaggio senza interferenze esterne”. Una versione
dei fatti lontanissima da quella data alla radio irlandese Newstalk dal ceo di
Ryanair Michael O’Leary, che ha denunciato un “sequestro di Stato” da parte di
Minsk e ha aggiunto che a bordo dell’aereo ci fossero agenti del servizio di
sicurezza bielorusso (Fsb). “Sembra che l’intenzione delle autorità fosse quella
di far uscire un giornalista e la persona che viaggiava con lui”, ha spiegato.
“Crediamo anche che all’aeroporto siano sbarcati agenti del Fsb“, ha aggiunto. E
a meno di 24 ore dallo scoppio del caso Protasevich, un volo Lufthansa per
Francoforte dall’aeroporto di Minsk è stato sospeso per la minaccia un imminente
atto terroristico. “L’indirizzo mail dell’aeroporto nazionale ha ricevuto un
messaggio da persone non identificate sull’intenzione di commettere un atto di
terrorismo sul volo Lufthansa LH1487 sulla rotta Minsk-Francoforte. Il volo
doveva decollare alle 14:20. L’imbarco su questo volo è stato sospeso”, si legge
nel comunicato. Ue discute nuove sanzioni – Dagli Usa il segretario di Stato
americano, Antony Blinken bolla l’azione bielorussa del dirottamento come un
atto “sfrontato e scioccante” e insiste sulla necessità di una “indagine
internazionale”, mentre domani gli ambasciatori della Nato discuteranno del
caso. In Europa, invece, dove il Consiglio Ue è chiamato in serata a discutere
di nuove sanzioni contro Minsk, il ministero degli Esteri tedesco ha convocato
l’ambasciatore bielorusso perché “le spiegazioni avute fin qui dal governo
bielorusso per l’atterraggio forzato sono assurde e non credibili”. “Il primo
punto all’ordine del giorno del Consiglio europeo è la Bielorussia, quello che è
successo ieri è uno scandalo internazionale, lavoriamo a sanzioni che sono sul
tavolo del summit”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel. Mentre il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha detto
di augurarsi “una risposta forte a quello che è successo ieri”, un episodio
“veramente senza precedenti, un fatto vergognoso e incredibile a cui l’Ue deve
dare una risposta. Mi attendo il massimo di risposta possibile perché non si può
stabilire un precedente di questo genere”. La Farnesina ha invece convocato
l’ambasciatore bielorusso a Roma per esprimere la forte condanna dell’Italia,
mentre la Francia evoca già l’opportunità di vietare lo spazio aereo bielorusso
e da Bruxelles il Ppe chiede “l’istituzione di una no-fly zone sulla
Bielorussia, l’adozione del quarto pacchetto di sanzioni e il rilascio immediato
e incondizionato di Pratasevich“. “Il dirottamento di un volo dell’Ue da parte
del regime di Lukashenko è una violazione del diritto internazionale e un atto
di terrorismo di stato. Il limite è superato! I nostri governi devono agire
ora”, si legge nella nota dei popolari europei. La Lituania ha reso invece noto
di aver vietato a tutti i voli di attraversare lo spazio aereo bielorusso, che
anche le compagnie Air Baltic e Sas eviteranno fino a nuove disposizioni. Anche
il ministro dei Trasporti di Boris Johnson, Grant Shapps, ha chiesto alle
compagnie aeree britanniche di non entrare nello spazio aereo bielorusso, mentre
il governo di Londra ha convocato l’ambasciatore bielorusso e sta valutando
sanzioni contro Minsk, come riferito dal ministro degli Esteri, Dominic Raab.
L’asse Bielorussia-Mosca contro le critiche dell’Occidente – Il governo di Minsk
prende le distanze dalle condanne arrivate finora da Bruxelles e Washington –
convinte che il dirottamento giustificato dalla minaccia di una bomba fosse in
realtà finalizzato all’arresto dell’oppositore a bordo – e difende le sue azioni
che, dichiara il ministero degli Esteri, “hanno rispettato pienamente le regole
internazionali stabilite”, aggiungendo che il caso del volo Ryanair in viaggio
da Atene e Vilnius dovrebbe essere visto dal punto di vista della sicurezza che
è stata fornita e che in Occidente politicizzano la situazione e arrivano a
conclusioni affrettate. Il governo ha anche invitato “l’Associazione
Internazionale del Trasporto Aereo, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea e
le autorità aeronautiche interessate a partecipare a un’indagine imparziale
sull’incidente che ha avuto luogo. Minsk è pronta a fornire tutte le
informazioni imparziali” , ha dichiarato il direttore del dipartimento
dell’aviazione presso il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Artyom
Sikorsky. A fianco della Bielorussia si schiera prontamente Mosca, suo storico
alleato: “È scioccante che l’Occidente consideri l’incidente nello spazio aereo
bielorusso ‘scioccante'”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo
Maria Zakharova sulla sua pagina Facebook, notando che i Paesi occidentali sono
stati in passato colpevoli di “rapimenti, atterraggi forzati e arresti
illegali”. Per parte sua la Bielorussia si è inoltre detta disponibile a
ricevere esperti e a dimostrare tutti i materiali relativi all’atterraggio del
volo Ryanair a Minsk. “Non ho dubbi che possiamo garantire la piena trasparenza
in questa questione, gli esperti saranno ricevuti e tutti i materiali saranno
dimostrati, se necessario, al fine di escludere le insinuazioni“, ha detto il
portavoce del ministero degli Esteri bielorusso Anatoly Glaz in una
dichiarazione pubblicata sul sito del ministero. I passeggeri arrestati sul volo
– Oltre a Protasevich ieri è stata arrestata a Minsk anche la sua compagna
Sophia Sapega, cittadina russa di 23 anni che sta frequentando un master
all’Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell’ambito del
programma di Diritto Internazionale e dell’Ue. Anche lei è finita in manette e
si trovava sempre a bordo dello stesso volo dirottato da un MIG-29
dell’aeronautica bielorussa. Protasevich e Sapega non sono però gli unici due
passeggeri fatti scendere a Minsk e fermati dalle autorità: un membro del
Presidium del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, l’ex
ministro della cultura Pavel Latushko, citato da Interfax, spiega che in tutto
sono 4 i passeggeri di nazionalità russa che non hanno proseguito il viaggio
verso Vilnius dopo il dirottamento. Protasevich è di nazionalità bielorussa. Il
portavoce di Putin, Dmitri Peskov, spiega però che il Cremlino non dispone di
informazioni sul presunto fermo “di una cittadina russa o di cittadini russi”.
Cosa rischia Protasevich – Nel settembre 2020 Nexta e gli altri canali associati
erano stati dichiarati “estremisti” e messi fuori legge in Bielorussia.
Protasevich e il collega Stsyapan Putsila erano stati iscritti nella lista delle
“persone coinvolte in atti di terrorismo” e incriminati per “incitamento a
disordini di massa”, “incitamento all’odio sociale” e “gravi violazioni
dell’ordine pubblico”, reati per i quali rischiano fino a 15 anni di carcere.
Protasevich, ricercato per aver organizzato le proteste dello scorso anno contro
Lukashenko, dal 2019 vive in esilio in Polonia, Paese che ha respinto la
richiesta di estradizione di Minsk.
Bielorussia: con Protasevich arrestata la
compagna, è russa. (ANSA il 24 maggio 2021) Le
autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero del volo Ryanair
atterrato ieri d'urgenza a Minsk. Come riferisce il servizio russo della Bbc,
insieme all'ex direttore del canale Telegram Nexta Roman Protasevich, è stata
arrestata la sua ragazza, una cittadina russa di 23 anni, Sophia Sapega, che sta
frequentando un master all'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius
nell'ambito del programma di Diritto Internazionale e dell'Ue. "L'Università sta
facendo ogni sforzo perché Sofia Sapega venga rilasciata il più presto
possibile", ha detto il portavoce dell'ateneo Maxim Milta. Lo riporta la testata
Meduza.
Bielorussia: Usa chiedono rilascio immediato
giornalista
(ANSA il 24 maggio 2021) Gli Stati Uniti
"condannano duramente" il comportamento della Bielorussia e chiedono l'immediato
rilascio il giornalista bielorusso Roman Protasevich. L'ordine di far atterrare
a Minsk l'aereo di Ryanair in viaggio da Atene a Vilnius è stato dato ieri
"personalmente" dal presidente Aleksandr Lukashenko a seguito di un allarme
bomba: lo hanno riferito media di Stato della Bielorussia, a cominciare
dall'agenzia di stampa Belta. Durante la sosta imprevista, durata ore, seguita
all'affiancamento al velivolo di un caccia Mig-29, è stato fermato, costretto a
scendere dall'aereo e arrestato Roman Protasevich, 26 anni, giornalista e
co-fondatore di Nexta, una testata che trasmette su Telegram critica nei
confronti del governo di Lukashenko, al potere a Minsk dagli anni Novanta.
Secondo Belta, che non cita alcun provvedimento giudiziario, a bordo dell'aereo
non sono stati trovati esplosivi. Il velivolo è poi ripartito per Vilnius, la
capitale della Lituania, dove è giunto con circa sei ore di ritardo rispetto
all'orario previsto. Sull'episodio, che ha coinvolto un volo interno all'Ue,
sono intervenuti esponenti dell'Unione europea. Secondo la presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen, quello del governo bielorusso è stato "un
comportamento irresponsabile e illegale" e "ci saranno conseguenze". Di "atto
scioccante" ha detto invece il segretario di Stato americano Antony Blinken.
Secondo il dirigente, Washington "si sta coordinando" con i suoi alleati "sui
prossimi passi".
Bielorussia dirotta un aereo per
arrestare oppositore. Proteste internazionali.
Da agi.it il 24 maggio 2021. Un aereo Ryanair partito da Atene per Vilnius è
stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di
miglia dal confine lituano, da un jet dell’aviazione militare bielorussa. Fra i
179 passeggeri, in serata atterrati nella loro destinazione, ce n’era uno che
interessava particolarmente i servizi di sicurezza di Minsk: un giovane
giornalista, il 26enne Roman Protasevich, già direttore di un canale di
informazioni dell’opposizione, Nexta, attivo su Telegram dai tempi della
contestata vittoria elettorale del premier Alexander Lukashenko, l’estate
scorsa, e successivamente catalogato come “terrorista” dalle autorità
bielorusse. Secondo i siti dell’opposizione che hanno diffuso sui social network
la notizia, e in particolare secondo la leader del movimento Svetlana
Tikhanoskaya, il giovane è stato arrestato subito dopo l’atterraggio di
emergenza e “la sua vita è in pericolo”, essendo la Bielorussia l’ultimo Paese
europeo in cui c’è ancora la pena di morte. Il canale Twitter dell'opposizione
bielorussa Belarus Free Thatre riferisce che "anche la fidanzata di Roman
Protasevic è stata arrestata e trattenuta sullo stesso volo". Il tweet aggiunge
che non ci sono "informazioni su dove si trovino o in quali condizioni siano".
Sempre secondo le informazioni diffuse dagli oppositori e confermate dalla
Lituania, il caccia Mig-29 che ha costretto il velivolo Ryanair ad atterrare era
armato con razzi ed era accompagnato da un biposto Su-29 e da un elicottero da
attacco MI-24. Il dirottamento e l’arresto hanno scatenato la rabbia
dell’Europa, ma le autorità bielorusse si sono giustificate dando una loro
versione dei fatti: dall’aereo era stato lanciato un allarme bomba, e per questo
è stato fatto atterrare a Minsk; si sarebbe trattato di un falso allarme, hanno
poi spiegato le autorità aeroportuali. La spiegazione non ha convinto la
comunità internazionale: da tutta Europa e dal Regno Unito si sono levate voci
di sdegno e preoccupazione oltre alla richiesta formale, da parte delle autorità
di Bruxelles, di consentire immediatamente ai passeggeri di proseguire il loro
volo, come poi avvenuto dopo diverse ore di attesa. La Farnesina ha condannato
l'accaduto: "Ferma condanna dell'Italia per l'atterraggio forzato di un volo
commerciale ad opera delle Autorita' bielorusse", afferma il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, secondo cui si tratta di "una violazione inaccettabile
delle regole internazionali di navigazione aerea". Il premier polacco Mateusz
Morawiecki ha definito l’accaduto un “atto criminale di terrorismo di Stato” e
ha chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si appresta
ad accogliere i 27 capi di Stato e di governo per un vertice domani a Bruxelles,
di approfittare dell’appuntamento per discutere di sanzioni immediate contro
Minsk.
Il giornalista 26enne Fondatore di
Nextra. Chi è Roman Protasevich, l’oppositore di
Lukashenko arrestato dopo il dirottamento del volo Ryanair in Bielorussia.
Elisabetta Panico su Il Riformista il 24 Maggio 2021. Roman Protasevich è il
giornalista 26enne arrestato dopo il dirottamento del volo di linea
Ryanair fatto atterrare in Bielorussia all’aeroporto di Minsk. Era in vacanza ad
Atene con la sua fidanzata 23enne Sophia Sapega e insieme stavano facendo
ritorno a casa a Vilnius in Lituania, dove viveva da novembre. Protasevich è un
oppositore del regime di Aleksandr Lukashenko ed è stato arrestato ieri a
seguito dell’atterraggio “d’emergenza” del volo su cui viaggiava. Il 26enne è il
fondatore di Nextra, il canale Telegram della Bielorussia seguito da 578 milioni
di persone, con sede in Polonia. Il giornalista era finito sotto il mirino del
presidente-dittatore bielorusso dopo che aveva condiviso filmati delle
manifestazioni dell’anno scorso iniziate a causa della rielezione di Lukashenko,
dall’opposizione e da gran parte della Comunità internazionale ritenuta
illegittima. Oggi il ragazzo rischia 15 anni di carcere con accuse di estremismo
in Bielorussia, tra cui l’organizzazione di rivolte di massa e l’incitamento
all’odio sociale. A bordo del volo low-cost c’erano 171 passeggeri e alcuni di
loro hanno raccontato cosa ha detto Roman prima di essere stato arrestato. Uno
di loro, seduto accanto a Protasevich ha raccontato a Delfi.lt cosa è successo
gli attimi dopo la notizia dell’atterraggio. “Ci sono state molte voci. Dopo
un’improvvisa manovra dell’aereo, un ragazzo è andato nel panico. Solo allora
abbiamo capito perché. Secondo alcuni resoconti dei media, non ci sono stati
conflitti a bordo. Solo quando il ragazzo ha scoperto che stavamo per atterrare
si è arrabbiato. Siamo stati portati tutti fuori dall’aereo, i cani hanno
annusato le nostre cose. Questo ragazzo è stato preso da parte e le sue cose
sono state gettate sulla passerella. Gli abbiamo chiesto cosa stesse succedendo.
Ha detto chi era e ha aggiunto: ‘La pena di morte mi aspetta qui’. Era già più
calmo, ma tremava. Un ufficiale era sempre in piedi accanto a lui e presto i
militari lo portarono via”. Secondo quanto invece ha riportato sul canale
Telegram il dissidente già ad Atene aveva la sensazione di essere seguito
“all’aeroporto – ha scritto Roman – un uomo mi è stato dietro fino all’imbarco e
ha tentato di fotografare il mio passaporto”. Un sito bielorusso inoltre ha
detto che di tutti i passeggeri sei non sono mai risaliti sull’aereo per
la Lituania: uno è Roman, l’altra è la fidanzata Sophia e si pensa che gli
ultimi quattro siano degli agenti del KGB bielorusso, i servizi segreti.
Elisabetta Panico. Laureata in relazioni
internazionali e politica globale al The American University of Rome nel 2018
con un master in Sistemi e tecnologie Elettroniche per la sicurezza la difesa e
l'intelligence all'Università degli studi di Roma "Tor Vergata". Appassionata di
politica internazionale e tecnologia
Cos’è Nexta, il canale che incita
l’opposizione in Bielorussia. Emanuel Pietrobon su
Inside Over il 24 maggio 2021. Il nome Nexta è balzato sulle prime pagine dei
quotidiani di tutto il mondo il 23 maggio, quando un volo della Ryanair è stato
costretto ad atterrare in territorio bielorusso nell’ambito di un’operazione
hollywoodiana pianificata dalla presidenza Lukashenko per arrestare Roman
Dmitriyevich Protasevich. Protasevich, noto attivista antigovernativo ed ex
co-gestore di Nexta, il 5 novembre dell’anno scorso era entrato ufficialmente
nel mirino della giustizia bielorussa. Incriminato per incitamento all’odio
sociale, organizzazione di rivolte di massa e azioni che violano l’ordine
pubblico – capi d’imputazione condivisi con il socio e fondatore di
Nexta, Stepan Putilo –, Protasevich era stato successivamente inserito
nell’elenco dei ricercati per terrorismo dai servizi segreti bielorussi (KGB). A
partire da quel momento, all’ombra delle sfilate internazionali di Svetlana
Tikhanovskaya e dell’apparente ritorno alla normalità a Minsk, l’apparato di
sicurezza bielorusso avrebbe cominciato a pedinare Protasevich con l’obiettivo
di catturarlo e portarlo dinanzi ai tribunali patri. Un’operazione spettacolare,
quella del 23 maggio, consumata in spregio al diritto internazionale e con il
probabile benestare del Cremlino, ergo da contestualizzare nel quadro
dell’attuale guerra fredda 2.0 e, più nello specifico, nell’ambito dei
preparativi dell’incontro Putin-Biden – una prova di forza concepita con il fine
precipuo di giungere al tavolo negoziale da una posizione sopraelevata – e che
dovrebbe suscitare delle domande: che cos’è Nexta? Rappresenta realmente un
pericolo per la sicurezza nazionale della Bielorussia? E, soprattutto, chi si
cela dietro al canale Telegram più politicamente influente degli anni recenti?
Alle origini del fenomeno Nexta. Nexta (let.
“qualcuno”) è il termine con il quale si fa riferimento ad una realtà
informativa basata su Telegram, dove è presente con tre canali (Nexta, Nexta
Live e Luxta), fondata nel 2018 da Stepan Putilo, un attivista antigovernativo
classe 1998. Putilo, figlio d’arte – il padre è un giornalista di Belsat, un
canale televisivo polacco in lingua bielorussa – apre il canale Nexta poco dopo
essersi trasferito in Polonia, dove risiede tutt’ora, dedicandosi inizialmente
alla produzione di contenuti anticorruzione e satira contro Aleksandr
Lukashenko. Il canale cessa di essere una realtà simil-studentesca e di nicchia
a soltanto un anno dall’istituzione, quando Putilo produce e diffonde un
documentario capace di fare breccia nelle stanze dei bottoni del palazzo
presidenziale di Minsk, “Lukashenka: Criminal Materials“. Caricato anche su
YouTube, dove registra oltre tre milioni di visualizzazioni, il documento
attrarrà l’attenzione e l’interesse di Roman Protasevich, un giornalista classe
1995 reduce da Euromaidan – ex membro dell’ufficio stampa del Battaglione Azov –
e forte di un bagaglio di conoscenze e competenze acquisite lavorando per Radio
Free Europe. L’entrata di Protasevich nel progetto Nexta si rivela fondamentale
al fine del suo salto di qualità, ovvero della trasformazione da uno dei tanti
canali di sfogo antigovernativo ad il canale anti-Lukashenko per antonomasia.
Gli iscritti aumentano con lo scorrere del tempo, di pari passo con la frequenza
delle pubblicazioni, permettendo ai due giovani attivisti di condurre una
campagna elettorale parallela per Svetlana Tikhanovskaya e di denunciare il
clima di paura e repressione aleggiante nel Paese. Ma sarà soltanto nella tarda
serata del 9 agosto, con la pubblicazione dei risultati delle presidenziali, che
il duo riuscirà a dispiegare totalmente le potenzialità politiche del canale.
La telegrammizzazione del malessere. Le strade
della Bielorussia vengono invase dalla rabbia nell’immediato post-pubblicazione
dei risultati elettorali – Lukashenko riconfermato con l’80% dei voti –, la cui
genuinità viene contestata a gran voce dai partiti di opposizione, dall’Unione
europea e da una parte dell’opinione pubblica. I capi dell’opposizione
cominciano a fuggire all’estero, perché spaventati dalla concreta possibilità di
un arresto arbitrario, ma Nexta non demorde e, nonostante i tentativi di
eliminazione dalla rete, riesce a capitalizzare il malcontento, convertendosi
nell’inusuale ed immateriale voce delle piazze in subbuglio. Piazze che Putilo e
Protasevich supporteranno in una varietà di modi, sfruttando sapientemente il
potere della messaggistica istantanea per spezzare la barriera della distanza.
Il canale Nexta sarebbe diventato, a partire dalla notte del 9 agosto, il nemico
numero uno dell’ordine lukashenkiano. Un nemico intoccabile, perché gestito da
persone residenti all’estero e protetto dal manto impermeabile di Telegram,
quindi ritenuto ragionevolmente micidiale dall’apparato di sicurezza
bielorusso. Il rischio di una EuroMinsk è concreto: il canale incita i
dimostranti a proseguire le proteste, spiegando loro dove e quando riunirsi,
quali punti attaccare e, soprattutto, diffondendo materiale su come affrontare
un reparto antisommossa e su come portare avanti una guerra irregolare nei
contesti urbani. Cosa più grave, gli hacker al servizio di Nexta trafugano e
pubblicano i dati sensibili di personale impiegato presso il ministero degli
Interni – nomi e indirizzi di mille persone vengono dati in pasto agli iscritti
– e i gestori della pagina cominciano ad usufruire della possibilità della
monetizzazione fornita dall’applicazione – fino a 6mila euro ad annuncio –,
mettendo in allerta i servizi segreti sulle reali finalità dell’intero progetto
(autofinanziamento in vista di una rivoluzione?). Il fenomeno Nexta si
ingigantisce con il passare dei giorni, ad una media di centomila nuove
sottoscrizioni giornaliere, attraendo un pubblico di quasi due milioni di
persone all’acme delle proteste. Ma l’appello alla mobilitazione funziona fino
ad un certo punto, perché l’apparato di sicurezza bielorusso non si rivela
vulnerabile quanto quello ucraino, e la crisi rientra entro fine agosto. A conti
fatti, il sistema di potere esce rafforzato dal mese di insurrezione: Lukashenko
è salvo, il rapporto con la Russia viene ripristinato, le piazze sono domate e
l’opposizione è fuggita all’estero. L’epopea di Nexta, però, è ben lungi dal
terminare.
Nexta oggi e domani. Putilo e Protasevich vengono
incriminati il 5 novembre 2020, a tre mesi dallo scoppio delle proteste di
agosto. Accusati dalla giustizia bielorussa di incitamento all’odio sociale,
organizzazione di rivolte di massa e azioni che violano l’ordine pubblico, i due
entreranno nel mirino dei servizi segreti pochi giorni più tardi, in quanto
inseriti nell’elenco dei ricercati per terrorismo. La pressione persuade
Protasevich a fare un passo indietro, fuoriuscendo da Nexta, ma senza che ciò
comporti la morte del canale, che continua a pubblicare contenuti a cadenza
regolare, aggiornando gli iscritti sull’evoluzione del malcontento in
Bielorussia ed anche su quanto accade nella contigua Russia, dove nel frattempo
esplodono il caso Navalny e alcune proteste antigovernative verso l’inizio del
2021.
L’attenzione di Nexta per gli accadimenti che
scuotono Mosca non è casuale – Aleksei Navalny è il modello di riferimento di
Putilo – e neanche innocua – non è da escludere che un eventuale riorientamento
dei contenuti sediziosi da Minsk al Cremlino, in ragione del numero degli
iscritti e del fattore linguistico, possa contribuire alla causa
dell’opposizione extraparlamentare russa. Vladimir Putin è avvisato: se non sarà
il matrimonio fra Navalny e Nexta ad agitare le piazze della Federazione russa,
allora sarà un altro canale Telegram. Perché Nexta ha determinato l’entrata
delle guerre ibride e senza limiti in una nuova era, più micidiale delle
precedenti perché ulteriormente immateriale, intangibile e onnipervasiva, e gli
artisti della destabilizzazione hanno preso appunti. Lukashenko si è salvato –
e, del resto, la storia delle guerre coperte insegna che le dittature sono più
golpe-resistenti dei regimi democratici o semi-democratici – ma altri capi di
Stato potrebbero non essere così fortunati: la telegrammizzazione del malessere
promette tanti miracoli (e cambi di regime).
·
Quei razzisti come gli azeri.
Karabakh: passato, presente
e futuro dell'Azerbaigian.
Emanuel Pietrobon il 25 Agosto 2021 su Il Giornale. L'Azerbaigian
ha dei grandi piani per i territori liberati: città intelligenti, turismo,
ripopolamento e grandi infrastrutture. Una parte significativa del futuro
dell'Azerbaigian si giocherà in quelle aree rispondenti ai nomi del più noto
Karabakh e Zangezur orientale (a cui appartengono cinque dei sette distretti
liberati: Kalbajar, Lachin, Zangilan, Gubadli e Jabrayil), vena scoperta del
Caucaso meridionale e grande linea di faglia huntingtoniana. Qui, terra santa
dei popoli delle montagne che abitano il Caucaso, Baku sta costruendo case,
strade, ferrovie, aeroporti, città intelligenti, parchi tecnologici e centrali
per la produzione di energia con il supporto dei suoi alleati e collaboratori,
in primis Italia, Turchia e Israele. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile,
pensabile e attuabile se la seconda guerra del Karabakh non fosse esplosa e,
soprattutto, se non fosse stata vinta. Perché tutti quei progetti stanno venendo
implementati, poco alla volta e gradatamente, in quelle aree – villaggi, città e
distretti – che in Azerbaigian sono popolarmente note come i territori liberati
e sui quali l’Azerbaigian ha ripristinato la sua sovranità la sera del 9
novembre 2020, dopo un trentennio di occupazione armena cominciato nei primi
anni Novanta.
Karabakh, un cantiere a cielo
aperto. La prima impressione che si ha, una volta usciti dall'aeroporto di Baku,
è che l'Azerbaigian, più che un Paese, sia un enorme cantiere a cielo aperto.
Perché, invero, gru a torre, operai in divisa catarifrangente e lavori di
asfaltatura e costruzione si trovano e possono essere visti ovunque – veramente
e letteralmente ovunque –, da Baku centro a Baku periferia, e da Baku a Ganja,
passando per Șușa e il resto dei territori liberati. I cantieri che costellano
l'Azerbaigian in lungo e in largo, dalle montagne alla costa, sono imbibiti e
madidi di una solennità molto espressiva. Una rappresentazione che parla di una
situazione postbellica che, contrariamente a quella dell'Armenia, in Azerbaigian
viene letta, interpretata e vissuta come sinonimo di rinascita nazionale – tanto
fisica quanto spirituale. Piccoli e grandi cantieri, pur essendo disseminati a
macchia d'olio sull'intero territorio, sono presenti in quantità particolarmente
elevata nel Karabakh e nello Zangezur orientale. Perché è qui, in questa
macro-area, che racchiude i territori liberati, che gru e avvisi di lavori si
susseguono in maniera interminabile, senza sosta né tregua, catturando l'occhio
e l'attenzione dei visitatori. E indubbiamente degni di nota, per dimensioni e
rilevanza, sono i siti all'interno dei quali gli operai stanno costruendo un
aeroporto internazionale – a Fuzuli –, una maxi-autostrada – la
Ahmadbayli-Fuzuli-Șușa, altresì nota come la strada della Vittoria –, un'intera
città – Agdam, l'Hiroshima del Caucaso – e una rete ferroviaria
centochilometrica per collegare Azerbaigian e Nakhchivan. Infrastrutturare il
Karabakh e lo Zangezur orientale sarà impegnativo in termini di capitale e
know-how disponibili e di tempo necessario – da qui il richiamo costante delle
autorità azerbaigiane agli investimenti dall'estero, preferibilmente dalla
triade Italia-Turchia-Israele, perché fondamentali a tal proposito –, ma i
lavori dovranno essere portati tassativamente a compimento: in gioco, invero,
v'è il futuro dell'Azerbaigian quale potenza egemone del Caucaso meridionale. Un
futuro che si scriverà più tra Fuzuli e Șușa che tra Baku e Ganja. Un futuro che
potrà divenire realtà soltanto a patto di sviluppare pienamente il Karabakh e,
non meno importante, di sbloccare le sterminate opportunità di crescita della
regione Caucaso a mezzo della necessaria normalizzazione con l'Armenia.
Il turismo, l'altro oro nero
di Baku. L'infrastrutturazione dell’area non significherà semplicemente
edificazione di nuove strade, autostrade, rotte ferroviarie, collegamenti aerei,
parchi tecnologici, centrali elettriche e solari e parchi eolici, perché il
governo vorrebbe massimizzare il profitto derivante dalla riestensione della
sovranità su una parte della regione attraverso un altro strumento: il turismo.
Infrastrutturare allo scopo di alimentare i flussi turistici, sia interni –
turismo autarchico – sia esterni – turismo internazionale –, equivale a
costruire stazioni sciistiche, parchi divertimento, alberghi ed altri luoghi di
intrattenimento. Perché il Karabakh e lo Zangezur orientale, una volta
ricostruiti, non dovranno essere regioni periferiche dipendenti dal centro,
quanto aree avanzate, autonome e in sintonia con il resto della nazione (e del
mondo). E il turismo può servire a tale scopo. Per capire in che modo il governo
azerbaigiano intenda rendere questi territori appetibili dal punto di vista
turistico, popolandone tanto le case quanto gli alberghi e il futuro aeroporto,
abbiamo raggiunto e intervistato Florian Sengstschmid, l'amministratore delegato
dell’Ente per il turismo dell'Azerbaigian (Azerbaijan Tourism Board). Quando si
scrive e si parla di turismo in Azerbaigian, ci spiega Sengstschmid, urge tenere
in considerazione che "è un settore relativamente giovane" – contribuisce
direttamente al 2,5% del prodotto interno lordo, che diventa un 4% includendo le
entrate indirette – e che l'immagine del Paese presso il pubblico estero non gli
rende giustizia. Perché sebbene per "molti di noi l'Azerbaigian continui ad
essere uno di quegli anonimi Paesi dell'area postsovietica", la verità è che è
una meta internazionale che, spesso e volentieri, ospita dei grandi eventi del
calibro di "Eurovision, Giochi Islamici, Formula Uno ed Europei di calcio". Il
turismo è alle prime armi, dunque, perché la gente ha cominciato a chiedersi
"dove si trovasse Baku" soltanto in occasione dell'Eurovision del 2012, ospitato
da Baku, ma questo non significa che manchino le infrastrutture, il personale
preparato e i pacchetti tematici delle agenzie di viaggio. L'Azerbaigian, al
contrario, "ha tutto dal punto di vista turistico: infrastrutture eccellenti,
grandi marchi internazionali e negozi per le compere". Poco alla volta, inoltre,
vanno prendendo forma dei "campi di nicchia, come il culinario – sviluppato in
sinergia con l'italiana Slow Food –, l'osservazione degli uccelli – [perché]
l'Azerbaigian ha degli ottimi posti per questo tipo di attività – e il vinicolo
– alla cui rinascita hanno contribuito gli italiani". Oltre ai grattacieli
all'americana di Baku, in breve, "c'è molto di più". Ad esempio, prosegue
Sengstschmid, pochi sanno che l'Azerbaigian ha un lungo "e bellissimo litorale"
e "che la stessa Baku ha un grande potenziale – non solo grattacieli, ma anche
parchi dove fare sport, piste ciclabili e da skateboard, case da tè, casini del
caffè, boulevard [...] e il più grande complesso di intrattenimento del Caspio –
il Deniz Mall –, dove c'è persino una cascata all'interno". Baku, parimenti
all'Azerbaigian, è da considerare come "una combinazione tra antico e moderno
molto simile a quella che si può trovare in Italia e nelle città europee: strade
strette, negozi di tappeti e luoghi mistici". E al di fuori della capitale, poi,
va avanti Sengstschmid, si può trovare un po' di tutto: dalle cascate del sud
alle montagne del Caucaso, le cui cime "raggiungono i quattromila metri" e "dove
si può sciare, fare arrampicate sulla roccia e sul ghiacchio". Vedere tutto
questo in un solo viaggio, dai limoni alle vette innevate, è possibile: perché
"la distanza in auto tra il sud e il Caucaso è di sole cinque ore".
Massimizzazione del profitto derivante dallo sfruttamento delle bellezze
dell'Azerbaigian a parte, uno degli obiettivi principali della presidenza Aliyev
è quello della brandizzazione del Karabakh e dello Zangezur orientale. Luoghi
che nell'immaginario collettivo vengono associati alla guerra, ma che, in
realtà, potrebbero offrire delle esperienze uniche a livello visivo e di
arricchimento culturale: dalla vallata di Șușa a Kalbajar, "che ricorda da
vicino le Alpi". E per il motivo di cui sopra che le autorità stanno lavorando
alla modernizzazione dei territori liberati, “come dimostrato dalla costruzione
di un'autostrada e dell'aeroporto di Fuzuli", nonché alla sua messa in
sicurezza, ovvero lo sminamento, e all'elaborazione di "piani adeguati per
potenziali investitori internazionali". E non mancano le idee su come guadagnare
dall’area nell'attesa che venga portata a compimento la sua infrastrutturazione:
"il primo passo", spiega Sengstschmid, "potrebbe essere l'edificazione di una
tratta regolare – comune sia ai locali sia agli stranieri – per visitare posti
come Agdam e Fuzuli, per vedere le devastazioni e le macerie, com'erano, come
sono e cosa sta venendo ricostruito". L'Italia, che qui viene considerata "un
partner molto fedele", è tra i grandi invitati a quella tavola che è l'industria
turistica in divenire dell'Azerbaigian. Secondo Sengstschmid "v'è una gamma
vasta e variegata di aree e settori dove il contributo italiano potrebbe
rivelarsi utile, dallo stabilimento di nuovi alberghi alla produzione di
intrattenimento, sebbene al momento sia limitato alla tecnologia e alle
infrastrutture". E per contributo alla tecnologia e alle infrastrutture,
chiarisce Sengstschmid, si intendono "l'utilizzo di tecnologia italiana nelle
montagne del Caucaso per la produzione di neve artificiale e la manutenzione del
manto nevoso" e le attività di una squadra di esperti italiani "nella
conservazione e nel restauro di siti culturali nel Karabakh". Investitori a
parte, Baku sta invitando nelle proprie terre anche i turisti italiani. Che qui,
spiega Sengstschmid, potrebbero trovare diversi ristoranti italiani e paesaggi
loro familiari. Forse, è per questi motivi, che "fra il 2018 e il 2019 si è
assistito ad un aumento del 10,8% dei flussi turistici in arrivo dall'Italia",
cioè da 11.026 a 12.215. E cosa troverebbero gli italiani una volta messo piede
in Azerbaigian è "un Paese sicuro e multiculturale" – come dimostrato dal fatto
di ospitare "il più grande insediamento ebraico al di fuori di Stati Uniti e
Israele" – e che offre "i resti dell'Albania caucasica", "chiese, moschee,
templi induisti, templi zoroastriani e siti appartenenti a culture e fedi
differenti", "lo Yanar Dag, la montagna che brucia, dal quale esce fuoco sia
d'estate sia di inverno", "l'Ateshgah di Baku, le cui iscrizioni in sanscrito
attraggono i pellegrini induisti" e "molto altro ancora". Sengstschmid ne è
convinto, "questo mix di culture e religioni è uno dei motivi per cui vale la
pena di venire in Azerbaigian". Anche perché, prosegue l'amministratore delegato
dell'ATB, "è un mix che può essere vissuto, percepito e visto in pochi giorni,
dato che questo Paese è relativamente piccolo". Emanuel Pietrobon
·
Quei
razzisti come i russi.
La caduta. Così, nel dicembre di
trent’anni fa, si dissolse l’Urss e si concluse l’era cominciata con la prima
rivoluzione bolscevica. Carlo Bonini (coordinamento
editoriale), Fiammetta Cucurnia, Enrico Franceschini ed Ezio Mauro su La
Repubblica l'8 Dicembre 2021. Trent'anni fa, l'8 dicembre 1991, alle 21 in punto
ora di Mosca, la televisione di Stato annuncia agli allora 294 milioni di
abitanti delle quindici repubbliche socialiste sovietiche che l'Urss ha
legalmente cessato di esistere. Due settimane dopo, la notte di Natale, la
bandiera rossa verrà ammainata sul Cremlino e l'ultimo segretario generale del
Pcus, Mikhail Gorbaciov, nominato sei anni prima per provare a salvare dal
collasso il più grande Stato comunista della terra, un impero multietnico esteso
su 22 milioni di chilometri quadrati e undici fusi orari, si dimetterà dal
partito e dalla guida del Paese.
Dagotraduzione dal Guardian il
13 dicembre 2021. Il presidente russo Vladimir Putin ha raccontato che il crollo
dell'Unione Sovietica ha segnato la fine della “Russia storica”, rivelando di
aver guidato un taxi per sbarcare il lunario dopo la caduta dell'URSS.
Putin, un ex agente dei
servizi di sicurezza del KGB dell'Unione Sovietica, ha sempre lamentato la
caduta dell'URSS, ma questa volta ha affermato che la disintegrazione di tre
decenni fa è stata una «tragedia» per «la maggior parte dei cittadini».
I commenti, riportati domenica
dall'agenzia di stampa statale RIA Novosti, sono stati estratti da un film in
uscita dall'emittente Channel One soprannominato “Russia. Storia recente".
«Dopo tutto, cos'è il crollo
dell'Unione Sovietica? È il crollo della Russia storica sotto il nome di Unione
Sovietica», ha detto il leader russo. Leale servitore dell'Unione, Putin è
rimasto costernato quando è crollata, definendo il crollo «il più grande
disastro geopolitico del XX secolo».
Putin è sensibile
all’espansione delle ambizioni militari occidentali nei paesi ex-sovietici e la
Russia la scorsa settimana ha chiesto alla NATO di annullare formalmente la
decisione del 2008 di aprire le sue porte alla Georgia e all'Ucraina.
La fine dell'Unione ha portato
con sé un periodo di intensa instabilità economica che ha fatto precipitare
molti nella povertà, mentre la Russia, recentemente indipendente, è passata dal
comunismo al capitalismo.
RIA-Novosti, riferendo da
estratti del documentario, ha affermato che Putin ha rivelato di aver lavorato
occasionalmente come tassista per aumentare le sue entrate. «A volte dovevo
guadagnare soldi extra», ha detto Putin.
«Voglio dire, guadagnare soldi
extra in macchina, come autista privato. È spiacevole parlarne ad essere onesti
ma, sfortunatamente, è stato così». La Russia era il centro di un'Unione
Sovietica che crebbe fino a includere 15 repubbliche dal Baltico a ovest fino
all'Asia centrale.
Nel 1991, devastata da
problemi economici, l'Unione si disintegrò e la Russia divenne una nazione
indipendente.
Vladimir Putin brutale con
la giornalista Usa: "Lei è anche una bella donna, ma...", un caso
internazionale.
Libero Quotidiano il 16 ottobre 2021. "Lei è una bella donna, ma
non ascolta": il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto così a una
giornalista americana che lo stava intervistando. Per questo è stato accusato di
atteggiamenti sessisti nei confronti della reporter della Cnbc, Hadley Gamble.
Il leader politico, infatti, prima l'ha definita "bella" e "graziosa", poi però
ha sottolineato, subito dopo, come lei non fosse in grado di capire quello che
lui stava dicendo. L'intervista incriminata è avvenuta qualche giorno fa, nel
corso della settimana dell'energia russa. Mentre l'oggetto della contesa erano i
prezzi del gas. Un argomento evidentemente caro a Putin, che non ha gradito il
modo di fare della giornalista che aveva di fronte. E così ha perso la pazienza,
nel bel mezzo del dibattito è sbottato: "Lei è una bella donna, davvero
graziosa. Ma le dico una cosa e lei mi dice immediatamente il contrario, come se
non avesse sentito quello che ho detto". "Stiamo aumentando le forniture
all'Europa, solo Gazprom del 10%. La Russia ha aumentato le forniture del 15%.
Stiamo aumentando, non diminuendo, le forniture. Ho davvero detto qualcosa di
così difficile da capire?", ha continuato Putin, rispondendo in maniera
stizzita, dopo essere stato incalzato sulla questione dalla reporter.
Il suo “marchio indelebile”
è il dispotismo. Eredità bolscevica, ecco perché non regge il paragone dello
storico Luciano Canfora.
Biagio De Giovanni su Il Riformista il 12 Ottobre 2021.
1917 – Rivoluzione Russa.
Piazza di Pietroburgo con rivoluzionari attorno alla statua dello zar. Luciano
Canfora mette talvolta le sue grandi qualità di storico antico al servizio di
tesi anche polemicamente molto delineate, e di solito il terreno fertile ed
estemporaneo su cui esercita la sua intelligenza è quello della politica.
Avviene talvolta che da lui si apprenda, altre volte che stimoli lo spirito
critico, sempre buono, dunque, l’effetto. Mi è capitato di leggere un suo
articolo sul Corriere della sera, sintesi della Prefazione che ha scritto per un
volume di Sergio Romano, un articolo intitolato così: “L’Urss è morta e vive
ancora. Nella Russia di oggi rimane incancellabile il marchio della rivoluzione
bolscevica”. A prima vista questa idea registra una cosa ovvia, essendo evidente
che una vicenda lunga e complessa come quella di cui si parla abbia lasciato
tracce nelle società e tra i popoli fra i quali è avvenuta, e nella stessa
storia del mondo. Ma non coincidendo affatto il testo di Canfora con la filiera
dell’ovvio, esso racconta una tesi ben più articolata, ma assai discutibile. E
proprio perché sostenuta da un autorevole storico, val la pena parlarne. Marchio
incancellabile della Rivoluzione nella Russia di oggi? Vediamo. L’Urss è morta
quando la Rivoluzione del 1917 è finita nel nulla, come Rivoluzione che aveva
promesso e profetizzato la redenzione dell’umanità -espressione che si trova
nelle “Tesi sulla storia” di Walter Benjamin– o, a essere meno ambiziosi, a
promuovere il superamento del 1789: questa, Rivoluzione borghese, l’altra
Rivoluzione proletaria, dei vinti che non avevano che da liberarsi delle loro
catene, una storia che avrebbe visto i vinti della storia vincere sui vincitori
di sempre. Oggi la Russia è una democrazia di massa illiberale e dispotica, gli
oppositori in carcere, chiusa nei suoi confini culturali e politici. Il “marchio
incancellabile” del dispotismo, proprio della rivoluzione bolscevica, resta,
certo in tono minore, ma deprivato di ogni aspettativa più o meno salvifica. La
Russia non è più quella dello zar, per cui ha ragione Canfora quando afferma che
è sbagliato parlare dello “zar Putin”, ma questo fa ancora parte di quella
filiera dell’ovvio di cui si è detto. Il fatto è che le ambizioni dell’autore
sono ben altre. E si rivelano per intero con il paragone -il cuore
dell’articolo- tra gli esiti della Rivoluzione francese, 1789, e gli esiti del
1917, e qui, per davvero, i conti non tornano, nel confronto “neutrale” del
testo. È vero, e peraltro ben noto, che le vicende successive al 1789 furono
talmente diverse tra loro, dall’impresa napoleonica al ritorno del sovrano,
fratello di quello decapitato, all’esperienza di varie forme di Stato, da
escludere osmosi dirette e coerenti con le idee della Rivoluzione. Ma quella
data, nei principii che affermò, innestandoli nella storia concreta, tra molte e
contrastate vicende, ha contribuito a produrre la costituzionalizzazione
dell’Europa, ha portato il “marchio incancellabile” dei suoi principii in una
idea di libertà politica e di tolleranza, preparata dal pensiero
dell’Illuminismo. Un’idea che sta tra noi, nel nostro pur contraddittorio e
certe volte tragico presente, sta dentro le nostre costituzioni, è la vicenda
che segna un progresso politico incancellabile della storia umana. Il paragone
con il 1917 non regge. Dove questa data è diventata Rivoluzione, in Russia, ha
dominato ininterrottamente, fino al 1989, per un tempo lungo e omogeneo, prima
il terrore politico, poi l’oppressione di popoli confinanti e dello stesso
popolo russo. Il “marchio incancellabile della rivoluzione bolscevica” resta,
dunque, all’interno di quella società, a testimoniare un fallimento, l’esito
povero, chiuso, rovesciato, dell’ultima filosofia della storia che voleva
decidere del destino dell’umanità e finì nel terrore staliniano, ma val la pena
di ricordare che quella del 1917 fu una “Rivoluzione contro il Capitale”, contro
l’opera di Marx, come scrisse Antonio Gramsci. Poco a che vedere,
nell’articolazione della sua storia, con la filosofia di Karl Marx. Essa non fu
preparata da una filosofia, fu un colpo di Stato ben riuscito. Il terrore
incominciò con Lenin, non con Stalin, un marchio incancellabile resta, in forma
certo minore, ed è il dispotismo. Biagio De Giovanni
Elisa Messina ed Enrica Roddolo per "corriere.it"
l'1 ottobre 2021. Da quanti anni non veniva celebrato un «royal wedding», un
matrimonio reale in grande stile nella cattedrale di San Pietroburgo? Almeno da
113 anni, ovvero da quando la rivoluzione bolscevica d’Ottobre rovesciò la
monarchia Romanoff e l’ultimo zar Nicola II. Così per sposi, familiari e
invitati, deve aver avuto il sapore di una rivincita sulla storia il matrimonio
celebrato oggi nel più solenne dei modi tra il gran duca George Mikhailovich, 40
anni, ultimo erede della famiglia Romanov e l’italiana Rebecca Bettarini, 39,
imprenditrice che vive in Russia e autrice di thriller internazionali con lo
pseudonimo di Georgina Perosch. È stata una cerimonia sontuosa, degna di uno
zar, per l’appunto, celebrata con rito ortodosso e a cui hanno partecipato
anche rappresentanti delle famiglie reali europee come la ex regina di Spagna
Sofia: i Romanov, va detto, erano imparentati con molti regnanti, dagli Windsor
ai Savoia ai Borbone. Al matrimonio, infatti erano presenti anche i duchi di
Kent, cugini della regina Elisabetta II. La sposa, che è figlia dell’ex
ambasciatore italiano Roberto Bettarini, indossava un abito di raso bianco dal
lungo strascico, e, in testa, una tiara di diamanti disegnata da Chaumet, il
gioielliere ufficiale della prima moglie di Napoleone, Giuseppina Bonaparte. Una
relazione che dura da dieci anni quella tra l’erede Romanov e l’italiana: il
primo incontro in un ricevimento all’ambasciata francese di Bruxelles. Dopo gli
studi universitari in Italia e diversi anni di lavoro come manager in un azienda
italiana in Russia Bettarini ora presiede una società di consulenza da le
fondata e presiede anche la Russian Imperial Foundation, organizzazione che
raccoglie fondi a finalità di charity, ma soprattutto è autrice di romanzi
gialli su intrighi internazionali: essere cresciuta nell’ambiente diplomatico in
giro per il mondo le ha regalato le chiavi giuste per inventare le sue spy
stories. Rebecca si è convertita recentemente alla Chiesa ortodossa aggiungendo
al suo nome quello di Victoria Romanovna. Quanto allo sposo, anche George
Mikhailovich vanta una vita internazionale. È nato a Madrid, è cresciuto in
Francia, si è laureato in legge ad Oxford ma si è trasferito nella «madrepatria«
russa solo tre anni fa: è figlio della granduchessa Maria Vladimirovna Romanova,
che si è autoproclamata erede al trono imperiale di Russia in quanto nipote del
granduca Kirill, cugino di Nicola II, l’ultimo zar russo giustiziato insieme a
tutta la sua discendenza diretta. Va detto che il titolo di capo della casa
imperiale russa e, di conseguenza, il diritto alla successione al trono (che non
c’è) è oggetto di contesa tra due diversi rami della famiglia: la linea dei
Vladimirovic, a cui appartengono George e sua madre, e la linea dei Nikolaevic.
La Chiesa ortodossa ha canonizzato la famiglia Romanov nel 2000 riconoscendoli
«martiri». Dopo aver vissuto in Belgio per sei anni, la coppia abita ora a
Mosca, a due passi dal Cremlino, residenza dei Romanov fin quando Pietro il
Grande decise di trasferire la capitale a San Petroburgo. Oggi, dopo essere
stato il centro del potere sovietico, è la residenza del presidente Putin.
JACOPO IACOBONI
per lastampa.it l'8 ottobre 2021. Per molti, è stato il matrimonio da sogno
italo-russo, celebrato dalla chiesa ortodossa tra icone russe e stile Fabergé.
Per pochi, invece, si tratta del culmine, romanzesco ma ben reale, di un
contesto di operazioni d’influenza russe in Europa, e in Italia, che lambiscono
l’estrema destra europea e italiana, dietro l’affascinante paravento
propagandistico della storia che è stata venduta: il favolesco “ritorno dei
Romanov”. La Stampa è infine in grado di raccontare qualcosa di più prosaico
sulle nozze tra l’ultimo erede dei Romanov, il granduca George Mikhailovich
Romanov, e l’Italiana Rebecca Bettarini, avvenuto nella cattedrale di Isacco a
San Pietroburgo il 2 ottobre scorso. Dei due sposi si sa che lui è il secondo in
linea di successione al trono russo dopo la madre (Maria Vladimirovna di Russia;
il padre è il principe Principe Franz Wilhelm di Prussia), e è titolare del
rango di Zarevich (il principe ereditario al trono). Di lei, Rebecca Bettarini,
che è figlia di un importante ambasciatore italiano, che ha vissuto in Zaire,
Venezuela, Iran, Parigi e Bruxelles, dove i due sposi si sono conosciuti.
Bettarini nel 2013 fu messa a capo tra l’altro della Russian Imperial
Foundation, la fondazione creata da Romanov nell’anniversario dei 400 anni della
dinastia. Bettarini è stata per dodici anni una dirigente di Finmeccanica,
azienda italiana strategica in Europa nel comparto militare e d’intelligence
(scrive anche interessanti romanzi sotto lo pseudonimo di Georgina Perosch, in
cui il tema centrale è lo spionaggio: ne abbiamo letto uno, La dea della
bellezza, nel quale racconta di una miss Venezuela che viene ingaggiata dalla
Cia per uccidere il suo presidente). Romanov è un importante dirigente di
Norilsk Nikel, un gruppo minerario da 33 miliardi di dollari, diviso e conteso
tra il fondatore Vladimir Potanin (che ne detiene il 30,4%) e Oleg Deripaska,
che con Rusal ne controlla il 27,8 per cento (Deripaska, plurisanzionato in
Occidente, è una delle figure centrali dell’operazione di interferenza della
Russia sulle elezioni americane del 2016). Ma altri particolari meritano di
essere messi in fila. Alcuni noti: alle nozze reggeva a turno la tiara degli
sposi Konstantin Malofeev, uno degli oligarchi sanzionati da Stati Uniti ed
Europa, a cui è tuttora vietato viaggiare in Europa perché accusato di aver
finanziato i separatisti filorussi in Donbass durante la guerra in Ucraina, e di
sostenere in vario modo le destre conservatrici europee. Malofeev è stato anche
accusato (lui nega) di essere un sostenitore attivo della Lega di Matteo
Salvini. Il catering delle nozze è stato offerto da Yevgheny Prigozhin, lo “chef
del Cremlino”, ma soprattutto un altro oligarca sanzionato l’anno scorso perché
considerato dall’Unione europea (e da un report della Commissione intelligence
del Senato americano) il capo del Wagner Group, il gruppo di mercenari russi che
hanno combattuto in teatri di guerra, materiale o ibrida, in Crimea, Siria,
Libia, Centroafrica (Prigozhin tra l’altro è il capo dell’IRA, la Internet
Research Agency, la cosiddetta troll factory di San Pietroburgo che, nel Mueller
Report, è considerata senza dubbi, e con diverse evidenze forensi, la centrale
responsabile di una serie di interferenze e attacchi di disinfo ops nella
campagna elettorale americana del 2016, che portò all’elezioni di Donald Trump).
Tra gli ospiti in chiesa, fotografato in impeccabile abito con reggicoda, c’era
anche il filosofo Alexandr Dugin, il teorico del sovranismo eurasiano, figlio di
un funzionario del KGB, idolatrato dalle destre di mezza Europa, e in tour in
Italia nella stagione dei populisti Lega e M5S al potere. Tra parentesi, la
Russian Imperial Foundation di cui Bettarini era direttrice ha, tra l’altro, una
partnership con Tsaargrad tv, tv diretta appunto da Dugin. Nulla di male,
naturalmente, in questa rete di amicizie e relazioni di estrema destra e
ultraconservatrici: se non fosse che siamo nel pieno delle operazioni
d’influenza geopolitica del Cremlino in Europa, e bisognerebbe almeno saperlo.
Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha chiarito che le nozze «non sono
nell’agenda del Cremlino». Ma chiunque a San Pietroburgo sa che George Romanov è
andato in giro per anni in Europa fregiandosi dell’amicizia di Putin, come una
specie di ambasciatore informale. Al matrimonio, era presente tra gli altri la
portavoce del ministro degli Esteri Sergey Lavorv, Maria Zakharova. Romanov
stesso tiene a chiarire in ogni occasione che il ritorno dei Romanov sul trono
non è minimamente all’ordine del giorno. Al contrario, Putin sta ripristinando
il triangolo ortodossia-mito dello zarismo-Cremlino, nell’unica logica
imperiale: la sua. C’è di più, altri dettagli finora ignoti o ignorati, che
dicono moto dell’amore di Romanov per l’Italia. Grazie ad amici in Toscana
(terra amatissima, con l’Umbria, da russi potenti come Alexander Lebedev e
Vladimir Yakunin), ha acquistato delle proprietà a Celle sul Rigo, all’inizio
della val d’Orcia, nel comune di San Casciano dei Bagni. Ma per farsi raccontare
la sua rete è utile andare a Milano, dove ancora ricordano bene il viaggio
milanese di Romanov nel 2016. Il 26, 27, 28 gennaio, Romanov ebbe una serie di
incontri istituzionali, con l’allora Regione Lombardia guidata dalla Lega (fu
ricevuto dal presidente Roberto Maroni e dall’assessore Giulio Gallera), e
rappresentanti di Assolombarda e Confindustria. Si faceva accompagnare a Milano
dal nobile milanese Mario Filippo Brambilla di Carpiano, da monsignore Dimitri
Fantini (archimandrita della Chiesa Ortodossa di Via Giulini a Milano) e da un
uomo che oggi è salito alla ribalta delle cronache (dopo l’inchiesta di Fanpage,
da cui è scaturita un’indagine per presunto finanziamento illecito a Fratelli
d’Italia e riciclaggio): il barone e immobiliarista Roberto Jonghi Lavarini.
L’evento clou si tenne allo studio legale Grimaldi, con un centinaio di ospiti,
imprenditori e investitori italiani, di cui possediamo una lista non completa,
venuti a dialogare con Romanov. Lo stesso Jonghi Lavarini, sul suo blog, per
raccontare della visita di Romanov riproduce il pdf di una cronaca di giornale
in cui si dice che Romanov, a Milano, «ha ufficializzato il suo rapporto di
collaborazione con Lombardia-Russia, ed i suoi satelliti in Liguria e Piemonte,
la più grande, storica ed organizzata associazione culturale filo-russa in
Italia, presieduta da Gianluca Savoini, giornalista esperto di geopolitica».
Savoini non è stato reperibile per un commento.
Enrica Roddolo per il “Corriere della Sera” il 3
ottobre 2021.
Dottoressa, Altezza imperiale... come dovrei
chiamarLa, adesso?
«Sì Altezza imperiale, date le circostanze questo
è il titolo ma... bisogna andare al significato profondo delle parole,
principessa deriva a princeps, princìpi e sono i valori che condividiamo io e
mio marito. Su questo ci siamo incontrati, amati», risponde al Corriere da San
Pietroburgo Rebecca Bettarini, nel cuore dei festeggiamenti degni dei fasti
imperiali, per le sue nozze con l’erede dell’ultimo zar, il granduca George
Mikhailovich Romanov. Un’italiana che sposa l’erede degli zar: un matrimonio che
ha radunato a San Pietroburgo, l’ex capitale imperiale russa, il Gotha europeo
(con o senza più corona).
Da cent’anni non si celebrava un matrimonio così
in Russia. Il mondo ne parla, dalla Bbc al New York Times. Confusa?
«Sorpresa sì, ma quanto agli invitati, il fatto è
che l’aristocrazia reale è una grande famiglia che ha secoli di storia
condivisa. Sono tutti cugini di primo o secondo grado di mio marito: duemila
invitati in chiesa, Sant’Isacco, una delle cattedrali più grandi al mondo, e
oltre 500 alla cena. Anzi, non fosse stato per il Covid sarebbero stati di più,
poi qualche tampone positivo all’ultimo momento...».
Con il sì di poche ore fa, è entrata nella storia.
Ha sentito il peso della responsabilità?
«Il mio amore per George è un sentimento che va
avanti da molti anni, e abbiamo condiviso tante cose in questo tempo, sono
entrata nel ruolo man mano. Poi certo mi fa impressione sapere che la tiara di
Chaumet che ho indossato finirà in museo, è patrimonio storico ormai. L’anello
di fidanzamento che mi ha regalato era del bisnonno, un gioiello da usare sempre
per quel tempo perché i grandi gioielli dei Romanov dopo la rivoluzione sono
stati confiscati o distrutti».
Come ha incontrato George, nato a Madrid,
cresciuto in Francia come molta nobiltà russa fuggita via, e studi a Oxford?
Sapeva che oltre all’amore era anche l’erede degli zar?
«Ci siamo conosciuti adolescenti alle feste di
discendenti di varia aristocrazia, tutti un po’ imparentati tra loro... anche
nella famiglia di mio padre ci sono legami aristocratici».
Suo padre, l’ambasciatore Roberto Bettarini e
mamma Carla Virginia Cacciatore. Emozionati per questo sì sotto i riflettori del
mondo?
«Papà era così emozionato che all’ingresso in
chiesa è inciampato. Gli ho detto, dai fatti coraggio papà... certo una figlia
unica che si sposa è una forte emozione per i miei genitori. Ma anche la
Granduchessa (Maria Vladimirovna), era molto, molto emozionata, la conosco da
tanti anni ormai e lo capisco subito».
Dopo quegli incontri da ragazzi quando è scoccata
la freccia dell’amore?
«Anni dopo ci siamo rivisti a Bruxelles quando
lavoravamo entrambi in Belgio, dopo laurea e master in relazioni internazionali
io ho lavorato per 12 anni per una grande realtà aerospaziale italiana, lui per
un colosso minerario russo, Norilsk Nickel. La scintilla a una serata in
Belgio... c’era anche il principe Murat, ricordo. Poi ci siamo rivisti a un
ricevimento dell’Ambasciata francese a Bruxelles e abbiamo iniziato a
frequentarci. Lui mi ha detto che voleva avviare l’attività della fondazione
dedicata alla storia di famiglia e mi sono offerta di aiutarlo. Poi gli amori
sono difficili da spiegare, succedono e basta e adesso sogno presto una
famiglia, dei figli».
Già, una famiglia. I Romanov, basta pronunciare il
nome e si apre il grande libro della Storia. La rivoluzione d’ottobre in Russia
nel 1917, l’eccidio della famiglia dell’ultimo zar Nicola II e della zarina
Alexandra, a Yekaterinburg nel luglio 1918.
«Persino sull’isola di Pasqua, abbiamo constatato
con il mio futuro marito, sanno chi erano i Romanov. Ne sono consapevole, è un
nome che vuol dire storia».
Con il granduca suo marito, la granduchessa,
parlate di quel massacro, di quei momenti nella storia. Cosa dicono in famiglia?
«Per loro sono parenti, persone di casa, non
personaggi nella storia. E ci si sente sempre un po’ in soggezione perché loro
ne parlano con i ricordi e le passioni degli esseri umani, non dei nomi sui
libri. La mamma di mio marito, nipote del granduca Kirill Vladimirovich (cugino
dello zar Nicola II), ricorda spesso suo nonno che parlava dello “zio Nicki”,
come suo zio non per il ruolo che aveva. Schegge di vita quotidiana, come il thé
con due zollette di zucchero...».
E non c’è rancore, senso di rivincita per quel che
accadde con la rivoluzione bolscevica, l’eccidio?
«Il passato è il bagaglio culturale di un popolo.
Nel bene o nel male, poco importa. E’ successo. Noi oggi rappresentiamo un
casato con oltre tre secoli di storia che ha influenzato tutta l’Europa. E poche
ore fa, dopo le nozze come è tradizione sono andata a deporre il mio bouquet
nuziale sulla tomba degli ultimi zar, dove anche i nonni di mio marito sono
sepolti, alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo».
La famiglia di suo marito l’ha aiutata a entrare
nel ruolo? In fondo la storia - anche recente - è piena di contrasti tra suocere
e nuore Reali, basta pensare a Meghan Markle.
«Oh sì la madre di mio marito è stata di grande
sostegno, per me è come una seconda madre. Mi ha aiutata molto, e io ho
studiato, mi sono preparata per la conversione ortodossa. E poi sapevo bene cosa
voleva dire la famiglia degli ultimi zar, la granduchessa da trent’anni
partecipa a molte attività storiche e culturali legate al passato e alla chiesa
ortodossa russa».
Tornati in patria negli anni ‘90, i Romanov sono
stati canonizzati dalla Chiesa ortodossa. Suo marito pensa mai al ruolo che
potrebbe avere, se la storia non avesse deciso diversamente?
«Non abbiamo ambizioni politiche, proprio no, non
ci interessa. Come dice mio marito: abbiamo già guidato il Paese per trecento
anni, adesso tocca ad altri».
Al nuovo «zar» Putin?
«Chiamarlo zar è una semplificazione che piace
all’estero, ma Putin non è un nuovo zar... semmai un grande presidente, ha fatto
un lavoro magnifico e gli auguriamo di continuare a farlo. Mio marito ed io, con
il nome dei Romanov, siamo felici di continuare la storia culturale della
famiglia, le tradizioni, i valori. E vedendo l’attenzione internazionale che ha
destato il nostro sì, mi piace che ci sia un’alternativa alla società delle
Influencer. E poi...».
Poi?
«Come Romanov possiamo contribuire al racconto
delle radici della Russia fino alla contemporaneità, è un modo per svelare al
mondo il Paese moderno di oggi, che ha molti legami con l’Italia: gli italiani
sono amati in Russia. In generale gli italiani sono amati nel mondo molto più di
quanto accada in patria».
L’ha sperimentato con la vita diplomatica di suo
padre ambasciatore?
«Sì e sono nata a Roma, per caso perché mio padre
al tempo era in missione a Parigi. E pure lui era nato a Roma per caso, mio
nonno era in Marina e prestava servizio nella capitale quando nacque papà. La
nostra, diplomazia a parte, è una classica famiglia italiana. La mia infanzia è
stata bella, calorosa, un po’ movimentata: tanti luoghi, trasferimenti, lingue
da imparare ma alla fine è stata un allenamento per la mia vita di adesso».
Lasciare abiti borghesi per indossare quelli di
Altezza reale. Una sfida che ha spezzato il cuore e la serenità di tante
commoner. Lei come farà?
«Lo so, ora come Romanov rappresento una famiglia
che vuol dire un Paese e infatti ho voluto un vestito da sposa di taglio
italiano ma con ricami e strascico che ricordavano la storia imperiale russa.
Per fortuna mi è di grande aiuto l’esperienza diplomatica di mio padre. Con papà
ambasciatore siamo stati a Parigi come a Bagdad... prima che nascessi, i miei
genitori hanno vissuto anche in Iran».
Ha invitato anche l’ex imperatrice Farah Diba, la
moglie dell’ultimo Scia. In chiesa c’erano i principi del Liechtenstein, l’ex re
Simeone di Bulgaria e molti altri.
«Sì, peccato che per un guaio di salute Farah Diba
non abbia potuto unirsi a noi».
C’era invece la famiglia reale italiana, i Savoia,
i due rami: Emanuele Filiberto e Aimone di Savoia Aosta. Che nella migliore
tradizione dei grandi eventi del Gotha, alle nozze hanno fatto pace, dopo tante
ruggini...
«Abbiamo voluto la famiglia Savoia, gli Aosta, una
grande festa con tutti i nostri cugini dell’aristocrazia europea».
Pronti adesso per la luna di miele, magari in
Italia?
«Ci attende una settimana di grande lavoro qui in
Russia, tra San Pietroburgo e Mosca dove viviamo da tre anni. Il viaggio di
nozze più avanti. Quanto all’Italia, la verità è che passiamo sempre le vacanze
in Italia».
A proposito, della sua passione per i thriller —
uno, “AristocraZy” sull’amore tra un giovane principe detronizzato e la figlia
di un ambasciatore sembra autobiografico —, cosa sarà adesso? Continuerà a
scrivere? Magari un giallo ambientato al tempo della rivoluzione russa?
«Scrivere gialli è la mia passione non rinuncerei
per nulla al mondo. Ho due nuovi titoli in preparazione e sulla rivoluzione
d’ottobre chissà, mai dire mai. Ora sono una Romanov, ma resto una giallista per
passione»
L’esercito fantasma di Mosca alla
conquista dell’Africa. Jean Marie Reure su Inside Over
il 28 settembre 2021. Secondo una notizia fatta trapelare
dall’agenzia Reuters la settimana scorsa, confermata da ben sette fonti
diplomatiche, il governo di transizione maliano starebbe per siglare un accordo
con l’agenzia di sicurezza privata russa Wagner per un valore complessivo di
circa 10 milioni di dollari al mese. Se i dettagli del contratto rimangono
segreti, la Pmc (Private Military Contractor) russa provvederebbe
all’addestramento delle truppe maliane e fornirebbe i suoi servizi di scorta ai
vertici di Bamako in cambio, oltre ad un lauto pagamento mensile, dello
sfruttamento di tre giacimenti minerari, due di oro e uno di magnesio. La
reazione di Parigi non si è fatta attendere: il ministro degli Affari
Esteri Jean Yves Le Drian, ha infatti prontamente affermato che “la presenza di
contractors russi in Mali è assolutamente inconciliabile con quella francese”.
Anche Berlino, per bocca del suo ministro della Difesa, ha ribadito che la
presenza di contractors russi metterebbe a repentaglio l’operato delle Nazioni
Unite e dell’Unione Europea in Mali e nel Sahel. Il governo maliano ha invece
smentito, definendo la notizia una diceria e dichiarando che il governo del Mali
dialoga con tutte le parti.
Il colpo di stato e il flop di Parigi. Questa
notizia si inserisce in un contesto di crescenti tensioni fra Bamako e Parigi:
l’impegno ormai quasi decennale della Francia in Mali sembra infatti aver
sortito relativamente pochi risultati se non sul piano strettamente militare. Il
nesso fra sicurezza e sviluppo in cui confidava la Francia per stabilizzare uno
dei paesi più estesi dell’Africa subsahariana ha infatti rivelato tutte le sue
debolezze. I progetti di sviluppo tardano a partire e sovente non riescono a
raggiungere le zone più remote del paese. La costante instabilità politica unita
ad una gestione del potere personalistica e corrotta ha creato una sfiducia
diffusa nei confronti del governo centrale che non ha saputo ridurre l’alto
tasso di disoccupazione giovanile né porre fine alla crisi alimentare che mette
a rischio la vita di più di 7 milioni di persone. Le carenze nella gestione
della pandemia di Covid-19 hanno poi agito da moltiplicatore, accrescendo
ulteriormente le tensioni sociali e le disparità tra centro e periferia. Proprio
queste carenze nella governance del paese avevano portato ad un colpo di stato
militare, la notte del 19 agosto 2020, che aveva rimosso il presidente
democraticamente eletto Ibrahim Boubacar Keita (IBK) dando vita al Comitato
Nazionale per la Salute del Popolo (Cnsp). Accolto con favore dalla popolazione,
il comitato presieduto dai vertici dell’esercito maliano si era impegnato ad
organizzare una transizione politica e ad indire nel più breve termine nuove
elezioni. La Francia, l’Unione europea e l’Ecowas avevano accolto la notizia del
colpo di stato con preoccupazione ma le rassicurazioni dei militari circa il
mantenimento degli accordi presi dal precedente governo non avevano di fatto
intaccato la natura del loro impegno in Mali, visto anche il supporto popolare
di cui godeva il nuovo governo.
Soldati francesi dell’operazione Barkhane. Il 24
Maggio 2021, a soli 8 mesi dal primo colpo di stato, i militari maliani
arrestano il presidente ad interim Bah N’Daw e il suo primo ministro Moctar
Ouane, poco dopo la nomina di un nuovo governo che li vedeva esclusi da alcune
posizioni apicali, come quelle del ministero della Difesa e della Sicurezza. Non
solo questo secondo golpe non gode del favore popolare, ma porta anche la
Francia e i partner internazionali a sospendere le operazioni congiunte con le
forze armate maliane. Il 10 giugno 2021 Macron annuncia la fine dell’operazione
Barkhane, escludendo un ritiro completo delle truppe francesi ma annunciando una
sostanziale trasformazione dell’impegno francese. In realtà agli osservatori non
era sfuggito come già durante il golpe di agosto del 2020 alcuni manifestanti
sventolassero bandiere russe e cartelli inneggianti all’amicizia fra Russia e
Mali, elemento piuttosto peculiare dal momento in cui i due paesi non
intrattengono relazioni bilaterali significative. Già nel 2019 però, a margine
del primo summit russo-africano, i due paesi avevano stretto un accordo di
cooperazione in ambito di sicurezza che aveva comportato l’arrivo di alcuni
elicotteri d’attacco MI-35M consegnati da Mosca a Bamako. Contestualmente i
militari francesi avevano dovuto affrontare una campagna di disinformazione in
chiave anti-francese sui social media. La notizia di un possibile contratto
stipulato dal governo del Mali con la PMC Wagner si inserisce quindi in un
contesto complesso, che porta ad interrogarsi sulle mire della Russia in Africa
sub-sahariana.
Wagner, la punta della lancia della penetrazione
russa in Africa. Secondo un rapporto del Centro di Studi Strategici ed
Internazionali (Csis) di luglio del 2021, le Pmc rivestono un ruolo fondamentale
nella strategia di espansione dell’influenza russa. Occorre innanzitutto
sottolineare che in questo caso il termine Pmc è improprio poiché sebbene si
tratti di aziende nominalmente private i vari contractors russi (fra cui
figurano l’Anti-terror Group, Center R, Moran Security Group, RSB Group,
E.N.O.T., Shchit, Patriot e l’ormai famoso Wagner Group) sono tutti legati ad
agenzie di sicurezza russe come l’Fsb, il Gru o direttamente il ministero della
Difesa. Inoltre, la nomea di alcuni di questi gruppi potrebbe far pensare a
piccole unità di operatori altamente specializzati assimilabili alle forze
speciali ma non è così. Le Pmc russe hanno diverse componenti al loro interno
che vanno da interi reparti di fanteria a unità specializzate passando per
istruttori e personale tecnico e di supporto. Altresì eterogeneo è il loro
impiego: oltre a condurre operazioni di combattimento i contractor russi sono
anche in grado di fornire servizi di intelligence e analisi (humint, sigint,
osint), di protezione di personale Vip, di sicurezza per siti strategici ed
operazioni di informazione e propaganda. La versatilità delle Pmc russe, la loro
relativa convenienza economica e la cosiddetta plausible deniability, cioè
l’impossibilità di ricondurre ufficialmente il loro operato alla Russia,
costituiscono i punti di forza di queste aziende. Largamente impiegate nel 2015
nella guerra in Ucraina dell’est, il loro impiego non ha smesso di crescere,
fino a diventare uno dei principali strumenti della guerra asimmetrica o ibrida
russa. Se nel 2105 le Pmc russe operavano in soli 4 stati ad oggi operano in più
di 27 paesi: la loro presenza è stati infatti evidenziata in Africa (Repubblica
Centro Africana, Sudan, Libia, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar,
Botswana, Guinea…), in Medio Oriente (in particolare in Siria, Yemen ed Iraq),
in Europa, in Asia (Afghanistan, Azerbaijan) e in America Latina (in Venezuela
in particolare). Divenute un formidabile strumento per proiettare l’influenza
russa nel mondo, queste Pmc spesso agiscono secondo un preciso modus operandi.
Intervengono in contesti difficili, in paesi relativamente deboli, la cui
governance del territorio è spesso contestata da gruppi ribelli. Le Pmc russe
svolgono quindi un servizio di stabilizzazione, puntellando lo stato target ed
accrescendone le capacità. Al contempo avanzano gli interessi russi accrescendo
l’influenza di Mosca nel paese, ottenendo l’accesso a risorse naturali ed
aumentando i margini profitto degli oligarchi russi che le controllano. Grazie
alla presenza delle sue Pmc, la Russia sarà poi in grado di imporsi come attore
ineludibile dalle trattative sulle sorti del paese (come nel caso della Libia) e
sarà anche in grado di ostacolare la proiezione degli interessi dei suoi rivali
storici quali gli Usa e gli altri partner atlantici. Nel caso dell’Africa
sub-sahariana, la presenza delle Pmc russe è stata osservata in ben 16 stati,
tutti caratterizzati dalla presenza di risorse naturali e da una governance del
territorio parziale e indebolita. La Russia ha così potuto offrire il suo
supporto militare e la sua expertise in fatto di sicurezza pubblica, ottenendo
in cambio vantaggi economici, geopolitici e militari. Uno dei casi più lampanti
è quello della Repubblica Centro Africana (Car): la Russia a novembre del 2017
riceve l’autorizzazione all’esportazione di armi dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite (Unsc) in deroga all’embargo che vige per il paese dal 2013.
Oltre all’esportazioni di armi, la Russia attraverso le sue Pmc in breve tempo
prenderà a fornire diversi servizi a Bangui fra cui l’addestramento delle
truppe, operazioni di combattimento contro i ribelli che a inizio del 2021
minacciavano di avanzare verso la capitale, protezione dei siti estrattivi del
paese, scorte armate, operazioni di (dis)informazione e addirittura consulenza
politica. È proprio nella Repubblica Centro Africana che la propaganda pro Russa
e anti francese si fa più virulenta, tanto da sfociare in una guerra di
informazione coi servizi francesi. Frattanto Valery Zakharov, un ex ufficiale
del GRU, diviene consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Touadéra.
Zakharov, oltre ad avere stretti rapporti con l’FSB, è alle dipendenze di una
società di comodo ricollegabile all’oligarca Eugeny Prigozhin, il quale
controlla attraverso una serie di società di comodo la Pmc Wagner Group oltre ad
alcune compagnie estrattive che operano in Africa sub-sahariana. Secondo la
professoressa di Scienze Politiche al Barnard College ed esperta di Pmc Kimberly
Martens, Zakharov non solo sarà in grado di formare una milizia privata fedele a
Touadéra, ma riuscirà anche a intavolare delle negoziazioni fra il governo del
Car e i ribelli, riuscendo laddove le Nazioni Unite e l’Unione Africana avevano
fallito e ottenendo contemporaneamente concessioni minerarie piuttosto
lucrative.
I veri interessi di Mosca. La penetrazione russa
in Africa non è stata sempre un successo: in Madagascar, per esempio, i
contractors russi non sono riusciti a far vincere nelle elezioni del 2018 i
candidati cui avevano offerto i loro servizi. Il Mozambico recede il contratto
con Wagner dopo che numerosi uomini della Pmc vengono sopraffatti dai ribelli
nella parte nord del paese, incrinando contestualmente l’immagine di successo
del gruppo. Se le operazioni della galassia di Pmc russe in Africa non hanno
sempre riscosso dei successi, il loro utilizzo risponde comunque a tre interessi
principali del governo russo. In primo luogo, ci sono infatti gli interessi
economici. La Russia in Africa non ha che un ruolo residuale, di gran lunga
inferiore a quello americano, francese o cinese, ma la possibilità di un accesso
prioritario alle risorse naturali nel suolo africano permette al Cremlino di
mantenere la competitività nei settori in cui eccelle, in particolare quello
minerario ed energetico. Ci sono poi gli interessi geopolitici: la “svolta
africana” della Russia permette a Mosca di espandere la sua influenza,
ostacolando gli interessi dei suoi competitors e creando una nuova rete di
alleanze per uscire dalla fase di isolamento internazionale dovuta
all’annessione della Crimea. La creazione di basi navali nei paesi africani,
come in Sudan, garantirebbe inoltre un accesso diretto al Mar Arabico e
all’Oceano Indiano. Sul piano militare l’espansione nel continente africano
permette invece a Mosca di stringere nuovi accordi di cooperazione in ambito di
sicurezza e difesa (dal 2015 ad oggi la Russia ha firmato ben 21 accordi di
cooperazione militare), di accrescere la vendita di armi e di costruire nuove
basi militari in zone che finora erano pressoché inaccessibili per il Cremlino.
È quindi naturale che la notizia di un possibile accordo fra il governo del Mali
e il Wagner group desti preoccupazione nelle capitali europee ed occidentali. Il
paese non solo è nel cuore della tradizionale sfera di influenza francese in
Africa, ma è anche una sorta di banco di prova per una missione europea a guida
francese. Se Parigi dovesse perdere la sua influenza in Mali e nei paesi del c.d
G5 Sahel, dovrebbe anche ridimensionare le sue ambizioni di paese guida in un
possibile (ed auspicabile) progetto di difesa europea. In summa, dopo i
fallimenti della Siria e della Libia la Francia e i suoi partner europei non
possono perdere in Mali.
Luigi Ippolito per corriere.it
il 21 settembre 2021. Le trame assassine del regime di Vladimir Putin sono state
portate ulteriormente alla luce da due procedimenti giudiziari, a Strasburgo e a
Londra. Da un lato, la Corte Europea per i Diritti Umani ha giudicato la Russia
responsabile dell’avvelenamento di Aleksandr Litvinenko, l’ex agente del Kgb
ucciso nel 2006 nella capitale britannica con una dose di polonio radioattivo;
dall’altro lato, la magistratura inglese ha incriminato il «regista»
dell’attacco chimico condotto nel 2018 a Salisbury contro l’ex agente russo
Serghej Skripal: anche in questo caso, a essere accusato è un ufficiale dei
servizi militari russi. Alla Corte Europea si era rivolta Marina, la vedova di
Litvinenko: e i giudici di Strasburgo hanno concordato pienamente con i
risultati dell’inchiesta britannica, che già 5 anni fa aveva stabilito che
l’assassinio dell’ex spia diventato dissidente era stato «probabilmente
approvato» da Putin in persona. Gli inquirenti britannici avevano individuati i
killer in due russi, Andrej Lugovoj e Dmitrij Kovtun: e secondo la Corte
Europea, i due si sono mossi «come agenti dello Stato russo». Gli uomini di
Mosca hanno sempre negato ogni responsabilità e Lugovoj è addirittura diventato
deputato nel Parlamento moscovita: ma i magistrati di Strasburgo hanno stabilito
«oltre ogni ragionevole dubbio» che i due russi hanno versato il polonio nella
tazza di tè che ha avvelenato Litvinenko. Alla sua vedova è stato riconosciuto
un risarcimento di 100 mila sterline. Contemporaneamente, in Inghilterra, la
Procura della Corona ha autorizzato l’incriminazione di Denis Sergeev, un agente
russo considerato il coordinatore del commando di due uomini che tre anni fa
avvelenò a Salisbury col nervino l’ex spia Serghej Skripal e sua figlia Yulia. I
due sopravvissero, ma alcuni mesi dopo una donna britannica, Dawn Sturgess,
trovò in un parco una fiala abbandonata col veleno e rimase uccisa. Sergeev era
stato smascherato già più di due anni fa dal sito investigativo Bellingcat, ma
solo ora si è arrivati alla conclusione di un’inchiesta formale. Sia lui che gli
altri due esecutori materiali dell’attacco erano agenti del Gru, i servizi
segreti militari russi, ed erano stati responsabili di altre azioni di
assassinio e sabotaggio in giro per l’Europa: e secondo i britannici «solo lo
Stato russo aveva i mezzi tecnici, l’esperienza e le motivazioni per portare a
termine l’attacco» a Salisbury. Ad accomunare Litvinenko e Skripal c’era il
fatto che si trattava di agenti segreti russi che erano passati dalla parte
dell’Occidente: il primo era diventato un aperto critico del Cremlino mentre il
secondo aveva preso a collaborare con i servizi britannici. Agli occhi di Putin,
due «traditori» la cui morte doveva servire da monito per tutti.
Anna Zafesova per “la Stampa” il 22 settembre
2021. Colpevole: la Corte europea per i diritti umani ha emesso il suo verdetto
sulla responsabilità della Russia nell'omicidio di Aleksandr Litvinenko, morto
nel 2006 a Londra dopo essere stato avvelenato dal polonio. Lo Stato russo dovrà
anche pagare 100 mila euro di risarcimento alla vedova dell'ex spia, Marina, che
dice di non sperare in una reazione di Mosca, ma di considerare molto importante
la sentenza del tribunale europeo. E nello stesso giorno, Londra ha annunciato
di incriminare ufficialmente un terzo uomo coinvolto nell'avvelenamento di
Sergey Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto nel 2018 a Salisbury: si
tratterebbe di un generale dello spionaggio militare russo, Denis Sergeev. Due
omicidi di Stato, due operazioni dell'intelligence russa, due casi clamorosi che
hanno contribuito ad allontanare la Russia dall'Europa, e a riportare
d'attualità le guerre di spie della Guerra fredda. E due messaggi inviati da
Strasburgo e da Londra a Mosca, proprio mentre il Cremlino sta mietendo i frutti
della sua vittoria alle elezioni della Duma di domenica scorsa, segnate da
massicci brogli e manipolazioni. L'indagine sul caso Litvinenko in realtà era
già stata conclusa dalla giustizia inglese anni fa, e i nomi degli indiziati
sono ben noti: Andrey Lugovoy, ex agente delle scorte del Kgb, e Dmitry Kovtun,
ex militare, che hanno portato a Londra il polonio-210, un materiale radioattivo
raro e pericolosissimo, che hanno versato nel tè dell'ex ufficiale del Kgb che
aveva ottenuto rifugio nel Regno Unito. Scotland Yard aveva ricostruito i
movimenti della coppia di russi, che si spacciavano per imprenditori e che
avevano lasciato tracce di polonio in alberghi, aeroporti e ristoranti. Una
monumentale relazione degli inquirenti aveva stabilito che i due avvelenatori
avevano agito «come agenti dello Stato russo», e che esistevano «prove
indirette» del fatto che l'ordine di eliminare Litvinenko - che aveva denunciato
le trame dei suoi ex colleghi - fosse partito dai vertici del governo. Ora la
Corte europea per i diritti umani ha avvallato questa conclusione, respinta
subito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come «totalmente infondata». Un
verdetto che non cambierà la situazione di fatto: Lugovoj viene protetto da anni
da un mandato cattura internazionale dalla sua carica di deputato della Duma,
dove è stato eletto dopo l'incriminazione. E gli emendamenti alla Costituzione
voluti da Vladimir Putin l'anno scorso stabiliscono che le leggi russe hanno la
prevalenza sul diritto internazionale: una misura voluta proprio per cautelarsi
dalle numerose sentenze emesse da Strasburgo a favore di dissidenti russi, tra
cui Alexey Navalny, e di vittime delle violazioni dei diritti umani, come gli
omosessuali ceceni perseguitati in patria. Per questo, forse, sarà molto più
sensibile all'incriminazione del "terzo uomo" nel caso Skripal: ora il probabile
capo della cellula degli avvelenatori ha un nome, un cognome e un volto, in
altre parole, è un 007 bruciato. Denis Sergeev, sbarcato a Londra nel marzo 2018
con i documenti di Sergey Fedotov, ha incontrato nella capitale britannica la
coppia di agenti arrivati da Mosca con un altro volo, ripartendo proprio mentre
si avviavano a spalmare di veleno Novichok la maniglia della casa degli Skripal
a Salisbury. L'identità di Sergeev era già stata ricostruita dal team di
giornalisti investigativi Bellingcat, ma ora le autorità britanniche hanno
confermato il suo ruolo e la sua identità: si tratterebbe di un general-maggiore
del Gru, lo spionaggio militare russo. Le sue tracce si ritrovano anche in
Bulgaria, in coincidenza con l'avvelenamento da Novichok del commerciante di
armi Emilian Gebrev, e nella Repubblica Ceca, dove gli stessi agenti che hanno
tentato di avvelenare Skripal sono stati incriminati per aver piazzato delle
bombe in depositi di armi. Londra ieri ha confermato che i due 007 - apparsi
successivamente alla tv russa assumendo nomi e identità false di «imprenditori
di integratori alimentari» che erano andati a Salisbury «a vedere la guglia
della cattedrale» - si chiamano in realtà Aleksandr Mishkin e Anatoliy Chepiga,
agenti dei reparti speciali del Gru.
Il rozzo contadino Kruscev,
imparò a leggere e scrivere dopo i 30 anni.
Maria Luisa Agnese su Il
Corriere della Sera il 14 settembre 2021. Il presidente sovietico è scomparso
l’11 settembre 1971. Da leader Pcus seppe denunciare i crimini di Stalin.
Affannato e rubicondo, si altera a sentire il delegato filippino attaccare la
sua Unione Sovietica e gli risponde battendo tre pugni sul tavolo. Poi, non
contento, si sfila la scarpa e batte e ribatte. Siamo nell’ottobre 1960 e Nikita
Kruscev, presidente sovietico fa la sua sparata nel tempio dell’Onu e con quel
gesto entra nella leggenda. Qualcuno mise in dubbio che di scarpa si trattò, ma
un filmato di Rai Storia dice che scarpa fu. Il carattere di quel politico
contadino dal cervello molto fino che non fini le elementari e che imparerà a
leggere e scrivere solo dopo i 30 anni, era parecchio fumantino. E per questi
suoi gesti e per quel suo faccione simpatico su un corpo tondo da brevilineo
divenne personaggio mediatico, molto popolare anche in Occidente, complice una
certa sua strana disponibilità a favore di telecamera. Ma non bisognava
sottovalutarne l’astuzia, Nikita non era certo solo un personaggio folcloristico
venuto da Kalinovka, paesino della Russia imperiale vicino all’attuale confine
con l’Ucraina. Si era mosso sapientemente fra le insidie staliniane prima,
diventando membro del Politburo nel 1938 e entrando nel gruppo dei fedelissimi
del dittatore e poi nella destalinizzazione. Nel febbraio 1956, poco prima della
rivolta d’Ungheria, nella Sala Bianca del Cremlino, al XX Congresso del Pcus, il
rozzo Kruscev, diventato segretario generale, denuncia i crimini di Stalin e il
culto della personalità e i giornalisti notano che in sala non compaiono più
ritratti del dittatore giorgiano. Già allora Kruscev teorizzava la «coesistenza
pacifica» asserendo che «le forze del socialismo possono affermarsi senza
rivoluzioni, senza guerre civili, mediante processi parlamentari».
Il confronto con Nixon. E nel
1959, proprio su questi temi improvvisò un confronto con Richard Nixon allora
vicepresidente Usa in visita a Mosca, passato alla storia come «il dibattito in
cucina». Nixon in visita all’Esposizione Nazionale americana si era fermato
davanti a un modello di cucina americana e lì i due ingaggiarono un confronto
sui meriti del capitalismo rispetto al comunismo e viceversa. Apparentemente
Nixon ne uscì vittorioso, ma quando Kruscev pochi mesi dopo ricambiò la visita
gelò gli americani dicendo che la famosa «coesistenza pacifica» avrebbe portato
alla vittoria, appunto pacifica, del sistema comunista. Guardando in camera
disse alla tv: «I vostri nipoti vivranno sotto un regime comunista». Ma in
qualche modo quel nonno sempliciotto e zoticone con il suo linguaggio del corpo
un po’ arrembante rassicurava l’Occidente. E quando nel 1962 scoppia la crisi
per i missili nucleari schierati dai sovietici a Cuba, il mondo resta col fiato
sospeso. John Kennedy alla fine riuscì a prevalere, mentre per Kruscev iniziò il
declino e un complotto mise fine al suo potere nel 1964. Kruscev morì da
pensionato scrivendo memorie, l’11 settembre 1971. Che fosse abile politico o
solo acrobata provetto, con lui se ne erano andati tutti i grandi protagonisti
di quegli anni, John Kennedy e Papa Giovanni XXIII, «gli ideali alla cogliona
fatti coi miti del ‘63, i due Giovanni e pace un po’ alla buona», come avrebbe
cantato Francesco Guccini nel 1978 in 100, Pennsylvania Ave.
L’incredibile esperimento
di DAU. Natasha, il Truman Show stalinista.
Fabio Ferzetti su L'Espresso
l'1 settembre 2021. Un progetto faraonico avviato più di dieci anni fa con
l’obiettivo inquietante di ricreare un mondo scomparso, l’Urss tra il 1938 e il
1968. Molto più di un film. L’ufficiale indossa una giacca militare ma per i
primi minuti vediamo solo le sue mani, mani grosse che sfogliano carte e
maneggiano una penna. I modi sono meticolosi, addirittura garbati. La faccia
occhialuta, i capelli corti sulle tempie, potrebbe essere quella di un preside.
Lei è spaventata ma imperturbabile. Si torce un poco le mani, lo ascolta con
attenzione, cerca di seguire i suoi suggerimenti, ovvero di capire cosa le sta
dicendo davvero. Ma l’ufficiale, che adesso è in camicia, senza mai alzare la
voce d’improvviso la porta in una cella imbottita e inizia a mostrarle cosa la
aspetta. Perché siamo nell’Urss del 1952, Natasha (Natasha Berezhnaya), una
bella donna curata e lievemente sfiorita, fa la cameriera nel ristorante della
Città della Scienza, un incarico delicato in un luogo riservato a una casta di
privilegiati. Nella prima parte del film, minuziosa e a tratti interminabile,
l’abbiamo vista litigare con una giovane collega, disperarsi per la sua vita,
fare bisboccia con i clienti, militari e teste d’uovo. Infine andare a letto con
un ospite dell’Istituto, uno scienziato francese di nome Luc Bigé (i nomi dei
personaggi sono quelli degli interpreti) in una lunga e dettagliata scena
d’amore dal vero, senza simulazioni, molto tenera ed emozionante. Sicché ora è
in trappola. L’ufficiale, che si chiama Vladimir Azhippo, vuole farne
un’informatrice dei servizi segreti e tanto per cominciare le fa firmare una
deposizione in cui accusa il povero francese invaghito delle peggiori
perversioni. Una resa senza condizioni, nonché l’opposto di ciò che abbiamo
appena visto. Dettaglio geniale: mentre scrive la sua falsa deposizione, Azhippo
invita Natasha a non andare fuori dei margini, come una scolaretta. Prima però,
per piegare la sua strenua dignità, le strappa i vestiti, le spiega quasi
contrito cosa potrebbe accaderle, toglie una a una con molta pazienza le
mollette che ha nei capelli («potrebbero finirmi in un occhio, anche se ho una
certa competenza in queste faccende»), la costringe a infilarsi il collo di una
bottiglia nella vagina, scena che ha fatto sobbalzare il Festival di Berlino e
provocato reazioni prevedibilmente indignate, anche se si vede ben poco ed è con
ogni probabilità simulata. «Dobbiamo proprio rimettere in scena gli orrori delle
dittature col pretesto di denunciarle?», ha scritto semplicisticamente Le Monde.
Domanda capziosa, oltre che retorica, perché “DAU. Natasha”, il film appena
sbarcato nelle sale italiane di cui stiamo parlando, non è certo un lavoro
ordinario e tantomeno un banale esercizio di pornografia del dolore. Diretto da
Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel, fotografato in un magnifico 35
millimetri dal grande Jürgen Jürges, già operatore di Fassbinder, Wenders e
Haneke, premiato a Berlino «per l’eccezionale risultato artistico», ma destinato
a spaccare la critica ancor prima che il pubblico, “DAU. Natasha” appartiene
infatti a un esperimento faraonico avviato dal semisconosciuto Khrzhanovskiy più
di dieci anni fa e detto appunto Progetto DAU, anche se la stampa internazionale
lo ha subito ribattezzato “il Truman Show stalinista”. L’idea originaria era
semplice. Girare un “biopic” dedicato all’inesauribile figura di Lev
Landau (1908-1968), fisico sovietico e premio Nobel nel 1962, inviso a Stalin ma
risparmiato per meriti scientifici, noto anche per aver predicato e praticato
l’amore libero. La vera ossessione di Khrzhanovskiy, classe 1975, figlio di un
celebre regista d’animazione, era però un’altra. Ricreare in vitro un mondo
scomparso: l’Urss fra il 1938 e il 1968, resuscitata in tutti i dettagli
materiali e, si suppone, morali, dando vita a un mondo parallelo al cui interno
il regista e i suoi collaboratori selezionano storie e personaggi lavorando
nella quasi totalità dei casi con attori non professionisti che finiscono per
mettere in gioco non solo le loro facce ma i loro sogni e le loro esperienze.
Riassorbita l’idea del biopic dentro un progetto ben altrimenti ambizioso,
Khrzhanovskiy costruisce un “Istituto di Ricerca per la Fisica e la Tecnologia”
ispirato a quello di Landau nella città ucraina di Kharkiv, sui resti di un
complesso sportivo. Ben 12mila metri quadri che ospitano migliaia di tecnici,
attori e comparse per anni, spesso 24 ore al giorno, in una simulazione totale
che rimescola ad arte identità vere e fittizie e abbraccia ogni elemento della
vita quotidiana: dagli abiti, biancheria compresa, agli oggetti più comuni,
dalle tecnologie al taglio di capelli, dal linguaggio (vietato usare parole
allora inesistenti come Internet o Google per esempio, pena multe salate anche
per giornalisti e visitatori) alla valuta usata, vecchi rubli naturalmente, fino
alle tubature e perfino al rumore dello sciacquone, tutto dev’essere
rigorosamente d’epoca. Simulazione paranoide o realtà parallela, l’esperimento
va avanti per anni diventando ben presto una leggenda che attira reporter e
celebrità di ogni campo da tutto il mondo. Se al carismatico direttore
d’orchestra greco Teodor Currentzis tocca il ruolo di Landau, a Kharkiv passano
artisti come Marina Abramovic, fisici come Carlo Rovelli e David Gross, Nobel
2004, registi teatrali come Anatolij Vasil’ev, Peter Sellars e Romeo
Castellucci, matematici come il cinese Shing-Tung Yau, usati talvolta come
attori. Anche se tutte queste celebrità servono forse soprattutto a ricreare una
sorta di “nomenklatura” da contrapporre all’esercito di maestranze e figuranti
impiegati nel progetto, costato secondo stime non ufficiali almeno 70 milioni di
dollari forniti dal magnate russo delle telecomunicazioni, nonché finanziatore
del giornale d’opposizione Novaja Gazeta, Sergei Adonyev. Oltre a “Natasha” e a
“Degeneratsia”, un film di 6 ore intriso di problemi teologici e filosofici,
presentati alla Berlinale, Khrzhanovskiy e il suo team girano infatti altri 13
film più 4 miniserie tv, in buona parte visibili sulla piattaforma DAU.com,
anche se non si deve pensare a un sistema di produzione continuo e oppressivo.
Dall’insieme del progetto promana quasi per forza di cose un’aura sinistramente
totalitaria, le riprese però si svolgono solo per brevi periodi. In tre anni
Jürgen Jürges totalizza 700 ore di girato per 100 giorni di riprese. Ma
soprattutto nulla viene “rubato” alla vita quotidiana di attori e comparse come
in un volgare Grande Fratello sovietico. Al contrario, le sceneggiature sono
abbastanza aperte da spingere ogni interprete a improvvisare, almeno in parte,
perché questo è in fondo lo scopo del Progetto DAU. Ricreare non solo un sistema
sociale ma il suo modo specifico di funzionamento. Ribaltando l’estetizzazione
della politica propria dei regimi totalitari in una gigantesca operazione
consapevolmente, dunque politicamente, artistica. Sintetizza il regista: «Presi
uno a uno tutti questi dettagli sono puro delirio. Nel loro insieme però
finiscono per creare una profondità altrimenti impossibile da raggiungere». Il
problema a ben vedere è tutto lì e non riguarda solo Khrzhanovskiy ma lo sguardo
che ormai posiamo sulla produzione culturale. Certo, non contano solo i
risultati finali, anche il metodo è centrale, ma i reportages dal set del
Progetto DAU hanno fatto a gara nel dipingere il regista come un incrocio tra il
Coppola di “Apocalypse Now” e il colonnello Kurtz perso nella sua brama di
potere. Finendo per considerare l’esito di questa colossale impresa - i film e
la versione teatrale immersiva andata in scena a Parigi - una specie di
trascurabile epifenomeno. Mentre la visione di “DAU. Natasha” sembra dare
ragione a Khrzhanovskiy, per quanto dispotici possano essere stati i suoi
atteggiamenti sul set. L’interrogatorio subito dalla protagonista non sarebbe
così sconvolgente se questa formidabile attrice non professionista alla fine non
ribaltasse i ruoli tentando di sedurre il suo carnefice. E se a interpretare il
funzionario che la interroga non fosse un vero ex-ufficiale del KGB (defunto nel
frattempo), esperto in questo genere di pratiche, che dopo l’esperienza sul set
avrebbe preso coscienza del proprio ruolo finendo per pentirsi e testimoniare
contro la tortura per Amnesty International.
Maurizio Stefanini per “Libero
quotidiano” il 26 agosto 2021. Torna la leggenda dei due Putin. Dopo che cinque
anni fa lo aveva scritto un giornale inglese peraltro non particolarmente
autorevole, adesso sono ambienti del governo georgiano che in via non ufficiale
stanno ripetendo la tesi che il vero Putin è defunto o malato, ed è stato
sostituito. La prova? Da un po' di tempo a questa parte non ostenta più il
perfetto tedesco che aveva appreso quando lavorava per il Kgb in Germania Est, e
nelle occasioni ufficiali si fa assistere da un interprete. Questo tipo di
leggende corrisponde a un plot classico e ben attestato nella storia russa,
anche se in passato più che su un vivo sostituito insistevano su un morto
redivivo. All'inizio del '600, ad esempio, ben tre persone affermarono di essere
Dmitrij, figlio di Ivan il Terribile, miracolosamente scampato all'assassinio
del 1591: un falso Dmitrij I che fu messo sul trono dai polacchi l'11 giugno
1605 e linciato il 27 maggio 1606; un Falso Dimitrij II che regnò su una parte
della Russia tra 1607 e 1610 prima di essere anche lui assassinato; un Falso
Dimitrij III insediato come zar il 2 marzo 1611 e a sua volta ucciso a luglio.
Anche lo zar Pietro III, morto nel 1762 dopo essere stato fatto internare dalla
moglie Caterina II, ebbe ben cinque reincarnazioni. La più famosa fu quella del
contadino cosacco Emel'jan Ivanovic Pugachëv, capo della grande rivolta narrata
nella "Figlia del capitano" di Puskin. E più di recente ci fu l'Anastasia
pretesa figlia di Nicola II scampata alla strage della famiglia da parte dei
bolscevichi, e protagonista di un film e di un cartone animato. La leggenda dei
due Putin nacque nel 2015, quando Putin sparì misteriosamente dalla circolazione
per una decina di giorni. Fu poi rilanciata con forza nel dicembre del 2016 dal
Daily Star: un foglio inglese specializzato in gossip che sparò "Avvelenato e
sostituito da un sosia". Secondo la teoria, l'uomo forte della Russia sarebbe
stato ucciso nel 2014 da un complotto di Cia e MI6 e al posto suo sarebbe stato
messo un alter ego. Il giornale non chiariva se da parte della Cia o da parte
dello stesso potere russo. Altre prove: un confronto di foto, con il passaggio
del neo sullo zigomo. «Vlad è cambiato molto negli ultimi anni». «La sua
peggiorata capacità di parlare tedesco, e il divorzio da sua moglie dimostrano
che il presidente russo non è il vero Vlad» e che il suo «doppio molto
probabilmente è sotto il controllo della Cia». In effetti il neo spostato può
derivare semplicemente da una foto ribaltata al computer e la moglie non è che
le cambiano solo gli alter ego. Il tema più forte è quello del tedesco meno
fluente. Però si è risposto che l'uso dell'interprete può essere dovuto
semplicemente alla necessità di farsi capire dalla gran parte dei russi nelle
dirette tv, mentre magari un tedesco meno fluido dipende solo da una mancanza di
pratica. Dopo tutto, sono ormai oltre 30 anni che Putin non risiede più in
Germania. Anche il preteso controllo della Cia sembra in netto contrasto con una
linea internazionale che invece rispetto agli Usa è entrata sempre più spesso in
rotta di collisione. Semmai, potrebbero essere stati gli ambienti che ruotano
attorno al suo potere ad avere interesse di blindarlo. In realtà nel febbraio
del 2020 Putin con la Tass ha ammesso che esisteva un piano segreto per
sostituirlo. Non però in chiave golpista, bensì per proteggerlo quando compariva
in pubblico. «Ma io ho rifiutato di avere dei sosia»". Secondo quanto ha
spiegato, la questione si era posta nei primi anni Duemila, quando aveva
lanciato una guerra feroce contro i separatisti della Cecenia. Ne erano seguiti
attentati sanguinosi e sequestri di persona in massa, e il pericolo per la
stessa vita del leader russo era percepito come reale. «Secondo il piano di
allora», ha precisato Putin, «un sosia avrebbe dovuto prendere il mio posto in
occasioni pubbliche pericolose, ma io non ho mai voluto che mi sostituissero».
Ma quella del sosia non è neanche la leggenda più estrema. Due fotografie di
soldati sovietici apparse su internet e risalenti una al 1920 e l'altra al 1941
mostrano infatti volti talmente somiglianti a quello di Vladimir Vladimirovic da
lasciare sbalorditi. E in Russia si è parlato allora sia di una presunta
immortalità; sia di una macchina del tempo che gli permetterebbe di viaggiare
nel passato.
Anna Zafesova per “la Stampa” il 19 agosto 2021.
Boris Eltsin che si arrampica sul carro armato mandato dai golpisti per chiamare
alla rivolta. I moscoviti che costruiscono barricate intorno al parlamento
russo. I falchi del Pcus che raccontano in conferenza stampa di aver preso il
potere al Cremlino, con le mani che gli tremano in mondovisione. Mikhail
Gorbaciov che, dopo tre giorni di arresti domiciliari nella sua dacia crimeana,
scende la scaletta dell'aereo che lo riporta a Mosca, il volto scavato, gli
occhi due fosse nere, con alle sue spalle una Raisa devastata che abbraccia la
nipotina avvolta in una coperta: un'immagine da naufrago che preannuncia la
caduta del primo e ultimo presidente sovietico. Il tricolore degli zar che
sventola nelle piazze, soppiantando la bandiera rossa, mentre la statua di
Dzerzhinsky, il fondatore della polizia segreta diventata celebre con il nome
del Kgb, viene sollevata dal suo piedistallo con un cappio al collo, in
un'impiccagione simbolica che doveva concludere, due anni dopo la caduta del
Muro di Berlino, il collasso del castello di carte del blocco sovietico.
Immagini entrate nella storia trent' anni fa, e che tornano alla memoria oggi,
quando si discute di nuovo di regimi crollati in tre giorni. Dovevano essere i
tre giorni che sconvolsero il mondo, come quei dieci giorni che nel 1917 avevano
segnato la nascita dell'impero che si sgretolava ora sotto gli occhi attoniti di
analisti, strateghi e politici, alleati o avversari, che l'avevano considerato
una grande potenza. Una rivoluzione pacifica - il comunismo sovietico cadde al
prezzo di tre vite di giovani che avevano cercato di fermare un blindato dei
golpisti nel centro di Mosca - che conserva molti retroscena misteriosi, ma che
riuscì a vincere grazie a un'alleanza della piazza, della parte più modernizzata
delle élite, e della comunità internazionale. Il tentativo di golpe conservatore
che doveva riportare le lancette dell'orologio indietro non aveva fatto che
accelerare la fine di un sistema che Gorbaciov aveva tentato disperatamente di
riformare prima dell'inevitabile rottamazione. Furono giorni di un entusiasmo e
di un ottimismo globale: l'Unione Sovietica aveva abbattuto il suo Muro, con due
anni di ritardo rispetto ai suoi satelliti nell'Est Europa. Il Kgb era stato
chiuso, Dzerzhinsky mandato in pensione in un parco, dei 16 milioni di membri
del Pcus messo al bando non ne rimaneva più nessuno, e un tale Vladimir Putin,
rimasto disoccupato, stava meditando seriamente di fare il tassista. Sembrava un
indiscutibile lieto fine, la storia era finita, la Guerra fredda pure, la Russia
tornava nel mondo dal quale si era autoisolata 73 anni prima, lasciando libere
le altre 14 repubbliche che avevano composto uno degli imperi di vita più breve
della storia. Sembrava una ricorrenza da celebrare nei secoli, da raccontare ai
nipoti, da immortalare nei film. Soltanto trent' anni dopo, non se la ricorda
nessuno. Chi si è lasciato alle spalle senza rimpianti quell'ideologia e quel
Paese - i Baltici ormai nell'Ue e nella Nato, e l'Ucraina e la Georgia che
stanno bussando alle loro porte - non guarda al passato. Chi avrebbe preferito
che nell'agosto 1991 avessero vinto i golpisti - i nuovi manuali di storia in
arrivo nelle scuole russe raccontano che il collasso dell'Urss sia stato frutto
di un complotto di Eltsin e del presidente ucraino Leonid Kravchuk, ispirato
dagli occidentali - semmai vorrebbe indire il lutto, come Vladimir Putin,
convinto ancora che la fine dell'impero comunista sia stata «la più grande
catastrofe geopolitica del XX secolo». A Mosca si discute appassionatamente di
far tornare Dzerzhinsky sulla piazza dove ha sede l'ex Kgb, che ha cambiato
nome, ma è più potente che mai, nelle prigioni ci sono più dissidenti che nel
1991, la tv trasmette film nostalgici, la Guerra fredda è più fredda che mai, e
circa la metà degli under 24 russi dice ai sondaggisti che vorrebbe scappare
all'estero. L'unica cosa veramente cambiata, con la storia che ha fatto andata e
ritorno, sono i consumi: le code nei negozi sono un ricordo dei più anziani
(insieme allo scarso ma capillare welfare socialista), e la ricchezza viene
cercata e ostentata con uno sfarzo che avrebbe messo in imbarazzo perfino i
Romanov, nel frattempo completamente riabilitati e rimpianti insieme a Stalin.
Nel 1991, si dava per scontato che i Paesi ex sovietici, Russia in testa, si
sarebbero rapidamente uniti alla libertà e al benessere occidentale, con più o
meno difficoltà. Quando questo sogno si scoprì utopico, la priorità di tutti -
di Mosca come delle capitali occidentali - fu quella di garantire una
transizione dal comunismo pacifica: la tragedia della ex Jugoslavia era sotto
gli occhi di tutti. Trent' anni dopo, anche il mito di una dissoluzione non
violenta va archiviato: dalle sanguinose guerre civili nel Tagikistan e in
Georgia, alla tragedia cecena e al «conflitto congelato» in Trasnistria, alla
guerra tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, fino all'annessione
della Crimea e all'invasione russa nel Donbass ucraino, un conflitto di cui non
si vede la soluzione, che a oggi ha fatto 14 mila morti e più di un milione di
profughi, il numero più alto nell'Europa del secondo dopoguerra. Nelle
repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale i leader comunisti sono rimasti al
potere in khanati di stampo nordcoreano. In Russia e Bielorussia due leader che
hanno cavalcato la sindrome post-traumatica della perdita dell'impero si stanno
contendendo il titolo di «ultimo dittatore d'Europa». Non è stata una
transizione pacifica, e la fine dell'ideologia comunista non è bastata a portare
democrazia: l'Unione Sovietica era un colosso su gambe d'argilla, ma anche una
mina a scoppio ritardato, e il giorno in cui la sconfitta del golpe dell'agosto
1991 verrà festeggiata come l'inizio della fine deve ancora arrivare.
Alle origini dell’eurasiatismo: storia e
pensiero di Lev Gumilëv. Emanuel Pietrobon su Inside
Over il 17 agosto 2021. Dopo un periodo di focalizzazione obbligata sugli affari
interni durato dall’immediato post-implosione sovietica all’alba degli anni
Dieci del Duemila – dovuto al dissesto economico-finanziario, alla quasi-guerra
civile nella Russia europea e alla pioggia di separatismi etno-religiosi tra
Volga e Caucaso –, lo Stato-civiltà Russia si è riaffacciato sul balcone con
vista panoramica che dà sul mondo. A partire dalla guerra contro la Georgia, che
è e resta uno dei principali eventi spartiacque del 21esimo secolo, la Russia ha
progressivamente ed estesamente cercato di riaffermare il proprio antico e
storico ruolo di grande potenza. Perché non v’è teatro geopolitico di rilievo
che non abbia assistito al reingresso dei russi: dal Medio Oriente all’Africa,
passando per l’America Latina e l’Eurasia in ogni sua frazione. In alcuni
casi, come quello africano, il Cremlino ha semplicemente capitalizzato il
significativo legato sovietico, ricorrendo a tecniche, tattiche e strumenti di
guerrafreddesca memoria, come armamenti, energia, mercenari, cultura e
università. In altri, come quello latinoamericano, Mosca si è limitata a fiutare
un’opportunità – quella della “primavera rossa” dei primi anni Duemila,
rappresentata da fenomeni quali il lulismo e il bolivarismo – allo scopo di
consumare azioni di disturbo nel cortile di casa degli Stati Uniti. Dalla
Georgia al Nicaragua, passando per le Terre palestinesi e la Mongolia, le mosse
degli abilissimi scacchisti del Cremlino sono accomunate da una peculiarità: mai
figlie dell’impulsività e dell’avventatezza, esse rispondono, sempre e comunque,
a delle logiche tanto fredde quanto ferree, e tanto calcolate quanto
lungimiranti. L’obiettivo del Cremlino, invero, non è mai il pedone in sé e per
sé: è lo scacco matto. V’è un modo per comprendere in profondità la logica delle
azioni di Mosca nell’arena internazionale: andare alla scoperta di coloro che le
hanno ispirate, suggerite e formulate. Personaggi che, contrariamente
all’opinione diffusa, spesso e volentieri non appartengono a questa epoca, ma al
passato remoto. Personaggi come Dmitriy Gerasimov – teorico del passaggio a
nord-est –, Aleksandr Michajlovič Gorčakov – stratega del Grande Gioco
–, Evgenij Primakov – preconizzatore dell’africanizzazione dell’agenda estera
del Cremlino – e Lev Gumilëv – il padre fondatore dell’eurasiatismo.
Nemico giurato di Stalin. Lev Nikolaevič
Gumilëv nasce a San Pietroburgo il primo ottobre 1912. Figlio d’arte – i
genitori erano lo scrittore Nikolai Gumilev e la poetessa Anna Akhmatova –,
Gumilëv cresce e si forma all’interno della neonata Unione Sovietica, assistendo
all’assassinio del padre da parte della Čeka in tenera età – fu giustiziato nel
1921. Ribelle e anticonformista, Gumilëv avrebbe trascorso la giovinezza
alternando università e prigionia, venendo fermato e arrestato più volte in
qualità di sorvegliato speciale del Commissariato del popolo per gli affari
interni (NKVD, Народный
комиссариат внутренних дел). Neanche l’arruolamento nelle forze armate, che nel
1945 lo condusse a combattere a Berlino, lo avrebbe salvato dalle maglie della
(in)giustizia nel secondo dopoguerra. Tradotto in arresto nel 1949, e condannato
a dieci anni in un campo di lavoro, Gumilëv
sarebbe stato il testimone infelice di un ignominioso tentativo di mediazione
tra sua madre Anna Akhmatova e Stalin. Costretta a realizzare un canto corale in
onore del dittatore sovietico – un ditirambo – in cambio della libertà propria e
del figlio, la Akhmatova avrebbe ottenuto soltanto la prima. E lui, Gumilëv,
inconsapevole dell’inganno, avrebbe trascorso gli anni successivi serbando
rancore nei confronti della madre, misinterpretando quel gesto di amore materno.
Dal dopo-Stalin alla
morte. Tornato letteralmente a nuova vita nel dopo-Stalin, Gumilëv sarebbe stato
riscoperto, rivalutato e valorizzato tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Non più
visto dal pubblico (e dalle autorità) come un eterno dissidente, ma per quello
che era realmente – uno studioso appassionato di geografia, etnologia e storia
dei popoli russi e turchici –, Gumilëv avrebbe fatto carriera all’interno
dell’Hermitage e dell’università di Leningrado (oggi università statale di San
Pietroburgo) e trovato un caldo accoglimento presso gli ambienti accademici e
intellettuali. Erudito, austero e contornato da un velo quasi-mistico agli occhi
dei colleghi, Gumilëv avrebbe ottenuto tanta popolarità quanto avrebbe suscitato
discordia e divisione. Le sue idee sull’eurasiatismo, invero, catturavano
l’attenzione della classe dirigente e dei decisori politici, ma il suo
persistente protendere verso il cospirazionismo e l’antigiudaismo lo avrebbe
reso inviso agli occhi di buona parte di intellettuali, sostenitori e politici.
Affascinante ma polarizzante ed ecumenico ma giudeofobo, Gumilëv avrebbe
conseguito la più elevata popolarità e i più grandi riconoscimenti negli ultimi
anni di vita, corrispondenti, tra l’altro, alle ultime fasi dell’Unione
Sovietica. E in ragione del suo contributo significativo alla causa
eurasiatistica, pochi anni dopo la morte – avvenuta il 15 giugno 1992 –, il
presidente kazako Nursultan Nazarbaev avrebbe intitolato la più importante
università del Paese a suo nome, ribattezzandola l’università nazionale
eurasiatica L. N. Gumilëv (Евразийский
Национальный университет имени Л. Н. Гумилёва).
Il pensiero di Gumilev.
Gumilëv può essere considerato
un seguace del determinismo in ogni sua forma: biologico, ambientale e persino
geografico. I popoli, spiegava il pensatore russo, non sono che il riflesso del
loro patrimonio genetico, tramandatogli dagli antenati, e del loro habitat
naturale, il cui modo di plasmare le genti varia a seconda delle sue peculiarità
(confini fluidi o rigidi, montagne o valli, temperature alte o basse, eccetera).
E i popoli, tutti, al di là delle loro caratteristiche, nel pensiero gumilëviano
affrontano un processo di sviluppo lineare e progressivo (etnosi), diviso in
stadi evolutivi – ascesa, acme, rottura, inerzia, omeostasi e memoriale –, che
li accompagna dalla nascita alla morte. L’apogeo di questo processo
civilizzazionale sarebbe costituito dall’acme, dove si registra la prevalenza
dei “passionari” sugli inerti: uomini e donne che alla stasi culturale
preferiscono la produttività, che all’individualismo prediligono il
comunitarismo e che, soprattutto, sono protesi verso la conquista di nuovi
territori perché guidati da uno “spirito marziale”.
Le civiltà e i popoli, in
breve, fioriscono quando dominate dai passionari e appassiscono quando, superata
la fase dell’acme, si addentrano negli stadi involutivi che le condurranno al
decesso. Secondo Gumilëv, un caso particolarmente evidente di civiltà che,
concluso il ciclo della passionarietà aveva abbracciato l’oscurità della fine,
era costituito dall’Europa. Una civiltà più unica che rara, invece – perché
ancora passionaria, perché forgiata dalla guerra sin dai primordi, perché
stanziata su un lebensraum senza eguali dal punto di vista climatico e
botanico-pedologico e perché plasmata dalla mescolanza con i popoli
nomadi-guerrieri turco-mongoli –, sarebbe stata quella russa. I russi, non a
caso, venivano definiti da Gumilëv in termini di portatori di un “super-ethnos“,
cioè i figli della combinazione di più ethne. Ragion per cui, contrariamente
alla vulgata, il pensatore russo invitava a rivalutare positivamente il periodo
dell’invasione mongola della Rus’ di Kiev.
La rinascita durante l'era
Putin. Gumilëv è stato oggetto di una rivalutazione tardiva già in vita, ovvero
durante le ultime fasi dell’epopea sovietica, ma è soltanto dopo la sopraggiunta
morte che è stato introdotto nell’Olimpo dei padri fondatori dell’eurasiatismo e
degli intellettuali più importanti della storia russa. Nonostante il persistere
delle accuse di cospirazionismo giudeofobico – credeva che i ricchi mercanti
ebrei della Rus’ di Kiev avessero avuto un ruolo nell’assoggettamento degli
slavi ai tataro-mongoli, vedendo due prove di ciò nei loro buoni rapporti coi
vari khan e nelle ondate di conversioni all’ebraismo dei cazari –, Gumilëv,
oggi, ha cessato di rappresentare un personaggio divisivo, controverso e
censurato dalla condanna della memoria. Perché Gumilëv, al contrario, è stato
investito di nuova legittimità proprio dal Cremlino, da Vladimir Putin in
persona. Citato periodicamente dal longevo presidente della Russia, il pensiero
gumilëviano appare nel corso di appuntamenti con il mondo accademico, di
dibattiti parlamentari e, ultimo ma non meno importante, in occasione dei
discorsi annuali all’assemblea federale. E il perché di questa riabilitazione
post-mortem è tanto chiaro ai russi quanto semisconosciuto agli occidentali:
Gumilëv inquadrava il collasso dell’odiata Unione Sovietica all’interno della
seconda fase del ciclo evolutivo delle civiltà – quella discendente – e Putin,
l’Uomo inviato al Cremlino dallo Stato profondo per porre fine al caos
eltsiniano, ha creduto fermamente, sin dai primordi, nell’imperativo di portare
a compimento la missione storica di dotare il popolo russo di un’identità con la
quale affrontare le sfide del 21esimo secolo. Prevarranno i passionari, avrebbe
spiegato Putin all’assemblea federale nel 2016, citando Gumilëv. E i passionari
sono coloro che possiedono “l’abilità di andare avanti ed abbracciare il
cambiamento”. Sono coloro dalla cui volontà di potenza dipende il futuro delle
nazioni. Sono coloro che, come Cristo costretto dai legionari a raggiungere il
Golgota tra mille supplizi – da qui il loro nome –, sono l’energia interiore
delle nazioni e rappresentano la loro unica speranza di redenzione, salvezza ed,
eventualmente, resurrezione. E la Russia dell’era Putin, tra ritorno del Sacro
nella vita pubblica e rinazionalizzazione delle masse, non aspira ad altro che a
forgiare nuove generazioni di passionari.
Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa
estera di “Epr Comunicazione” il 15 luglio 2021. Vladimir Putin ha autorizzato
personalmente un'operazione segreta dell'agenzia di spionaggio per sostenere un
"mentalmente instabile" Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016
durante una sessione chiusa del consiglio di sicurezza nazionale della Russia,
secondo quelli che si ritiene siano documenti del Cremlino trapelati. L'incontro
chiave ha avuto luogo il 22 gennaio 2016, suggeriscono i documenti, con il
presidente russo, i suoi capi spia e gli alti ministri tutti presenti. Hanno
concordato che una Casa Bianca con Trump avrebbe aiutato a garantire gli
obiettivi strategici di Mosca, tra cui "l'agitazione sociale" negli Stati Uniti
e un indebolimento della posizione negoziale del presidente americano. Alle tre
agenzie di spionaggio della Russia è stato ordinato di trovare modi pratici per
sostenere Trump, in un decreto che sembra portare la firma di Putin. A questo
punto Trump era il frontrunner nella corsa alla nomination del partito
repubblicano. Un rapporto preparato dal dipartimento di esperti di Putin
raccomandava a Mosca di usare "tutta la forza possibile" per assicurare una
vittoria di Trump. Le agenzie di intelligence occidentali sono a conoscenza dei
documenti da alcuni mesi e li hanno attentamente esaminati. I documenti, visti
dal Guardian, sembrano rappresentare una fuga di notizie seria e molto insolita
dall'interno del Cremlino. Il Guardian ha mostrato i documenti ad esperti
indipendenti che dicono che sembrano essere autentici. I dettagli accidentali
sono accurati. Il tono e la spinta generale si dice siano coerenti con il
pensiero di sicurezza del Cremlino. Il Cremlino ha risposto in maniera smaccata.
Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha detto che l'idea che i leader russi si
fossero incontrati e avessero concordato di sostenere Trump nell'incontro
all'inizio del 2016 è "una grande pulp fiction" quando contattato dal Guardian
giovedì mattina. Il rapporto - "No 32-04 \ vd" - è classificato come segreto.
Dice che Trump è il "candidato più promettente" dal punto di vista del Cremlino.
La parola in russo è perspektivny. C'è una breve valutazione psicologica di
Trump, che è descritto come un "individuo impulsivo, mentalmente instabile e
squilibrato che soffre di un complesso di inferiorità". C'è anche un'apparente
conferma che il Cremlino possieda kompromat, o materiale potenzialmente
compromettente, sul futuro presidente, raccolto - dice il documento - dalle
precedenti "visite non ufficiali di Trump nel territorio della Federazione
Russa". Il documento si riferisce a "certi eventi" accaduti durante i viaggi di
Trump a Mosca. I membri del Consiglio di sicurezza sono invitati a trovare i
dettagli nell'appendice cinque, al paragrafo cinque, afferma il documento. Non è
chiaro cosa contenga l'appendice. "È assolutamente necessario usare tutta la
forza possibile per facilitare la sua [di Trump] elezione alla carica di
presidente degli Stati Uniti", dice il documento. Questo aiuterebbe a realizzare
il favorito "scenario politico teorico" della Russia. Una vittoria di Trump
"porterà sicuramente alla destabilizzazione del sistema sociopolitico degli
Stati Uniti" e vedrà il malcontento nascosto scoppiare allo scoperto, prevede.
Il vertice del Cremlino. Non c'è dubbio che
l'incontro del gennaio 2016 abbia avuto luogo - e che sia stato convocato
all'interno del Cremlino. Una foto ufficiale dell'occasione mostra Putin a capo
del tavolo, seduto sotto una bandiera della Federazione Russa e un'aquila d'oro
a due teste. L'allora primo ministro russo, Dmitry Medvedev, ha partecipato,
insieme al veterano ministro degli esteri, Sergei Lavrov. Erano presenti anche
Sergei Shoigu, il ministro della difesa responsabile del GRU, l'agenzia di
intelligence militare russa; Mikhail Fradkov, l'allora capo dei servizi segreti
esteri russi SVR; e Alexander Bortnikov, il capo dell'agenzia di spionaggio FSB.
Nikolai Patrushev, l'ex direttore dell'FSB, ha partecipato anche come segretario
del consiglio di sicurezza. Secondo un comunicato stampa, la discussione ha
riguardato l'economia e la Moldavia. Il documento visto dal Guardian suggerisce
che il vero scopo segreto del consiglio di sicurezza era quello di discutere le
proposte riservate elaborate dal servizio analitico del presidente in risposta
alle sanzioni statunitensi contro Mosca.
L'autore sembra essere Vladimir Symonenko, l'alto
funzionario responsabile del dipartimento di esperti del Cremlino - che fornisce
a Putin materiale analitico e rapporti, alcuni dei quali basati su intelligence
straniera.
I documenti indicano che il 14 gennaio 2016
Symonenko ha fatto circolare un riassunto esecutivo di tre pagine delle
conclusioni e delle raccomandazioni del suo team. In un ordine firmato due
giorni dopo, Putin ha incaricato l'allora capo della sua direzione di politica
estera, Alexander Manzhosin, di convocare un briefing chiuso del consiglio di
sicurezza nazionale. Il suo scopo era quello di studiare ulteriormente il
documento, dice l'ordine. A Manzhosin fu dato un termine di cinque giorni per
prendere accordi. Ciò che è stato detto all'interno della stanza del secondo
piano del palazzo del Senato del Cremlino è sconosciuto. Ma il presidente e i
suoi funzionari dell'intelligence sembrano aver firmato un piano multi-agenzia
per interferire nella democrazia statunitense, inquadrato in termini di
autodifesa giustificata. Sono citate varie misure che il Cremlino avrebbe potuto
adottare in risposta a ciò che considera come atti ostili da parte di
Washington. Il documento espone diverse debolezze americane. Questi includono un
"profondo divario politico tra sinistra e destra", lo spazio
"media-informazione" degli Stati Uniti, e un umore anti-establishment sotto il
presidente Barack Obama. Il documento non nomina Hillary Clinton, la rivale di
Trump nel 2016. Suggerisce di impiegare le risorse dei media per minare le
principali figure politiche statunitensi. Ci sono paragrafi su come la Russia
potrebbe inserire "virus mediatici" nella vita pubblica americana, che
potrebbero diventare autosufficienti e auto-replicanti. Questi altererebbero la
coscienza di massa, specialmente in certi gruppi, si dice. Dopo l'incontro,
secondo un documento separato trapelato, Putin ha emesso un decreto che
istituisce una nuova e segreta commissione interdipartimentale. Il suo compito
urgente era quello di realizzare gli obiettivi indicati nella "parte speciale"
del documento n. 32-04 \ vd. Tra i membri del nuovo organismo di lavoro sono
stati dichiarati Shoigu, Fradkov e Bortnikov. Shoigu è stato nominato presidente
della commissione. Il decreto - ukaz in russo - diceva che il gruppo avrebbe
dovuto prendere al più presto misure pratiche contro gli Stati Uniti. Queste
erano giustificate da motivi di sicurezza nazionale e in conformità con una
legge federale del 2010, 390-FZ, che permette al consiglio di formulare la
politica statale in materia di sicurezza. Secondo il documento, ad ogni agenzia
di spionaggio è stato dato un ruolo. Il ministro della difesa è stato incaricato
di coordinare il lavoro delle sottodivisioni e dei servizi. Shoigu era anche
responsabile della raccolta e della sistematizzazione delle informazioni
necessarie e della "preparazione di misure per agire sull'ambiente informativo
dell'oggetto" - un comando, sembra, per hackerare sensibili cyber-obiettivi
americani identificati dall'SVR. All'SVR è stato detto di raccogliere ulteriori
informazioni per sostenere le attività della commissione. All'FSB fu assegnato
il controspionaggio. Putin ha approvato il documento, datato 22 gennaio 2016,
che la sua cancelleria ha timbrato. Le misure sono entrate in vigore
immediatamente alla firma di Putin, dice il decreto. Ai capi delle spie è stata
data poco più di una settimana per tornare con idee concrete, da presentare
entro il 1° febbraio. Scritto in un linguaggio burocratico, i documenti sembrano
offrire uno sguardo senza precedenti nel mondo solitamente nascosto del processo
decisionale del governo russo. Putin ha ripetutamente negato le accuse di
interferire nella democrazia occidentale. I documenti sembrano contraddire
questa affermazione. Suggeriscono che il presidente, i suoi ufficiali di
spionaggio e gli alti ministri erano tutti intimamente coinvolti in una delle
più importanti e audaci operazioni di spionaggio del 21° secolo: un complotto
per aiutare a mettere il "mentalmente instabile" Trump alla Casa Bianca. I
documenti sembrano stabilire una tabella di marcia per ciò che è effettivamente
accaduto nel 2016. Poche settimane dopo la riunione del consiglio di sicurezza,
gli hacker del GRU hanno fatto irruzione nei server del Comitato Nazionale
Democratico (DNC) e successivamente hanno rilasciato migliaia di email private
nel tentativo di danneggiare la campagna elettorale della Clinton. Il rapporto
visto dal Guardian presenta dettagli che ricordano il lavoro dell'intelligence
russa, dicono fonti diplomatiche. L'identikit della personalità di Trump è
caratteristico dell'analisi dell'agenzia di spionaggio del Cremlino, che pone
grande enfasi sulla costruzione di un profilo degli individui utilizzando sia la
psicologia reale che quella basata sul pregiudizio. Mosca guadagnerebbe di più
da una vittoria repubblicana, afferma il documento. Questo potrebbe portare ad
una "esplosione sociale" che a sua volta indebolirebbe il presidente degli Stati
Uniti, dice. C'erano benefici internazionali da una vittoria di Trump,
sottolinea. Putin sarebbe in grado, in modo clandestino, di dominare qualsiasi
trattativa bilaterale USA-Russia, di decostruire la posizione negoziale della
Casa Bianca e di perseguire audaci iniziative di politica estera per conto della
Russia, dice. Altre parti del rapporto di più pagine trattano temi non-Trump.
Dice che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo l'annessione della Crimea da
parte della Russia nel 2014 hanno contribuito alle tensioni interne. Il Cremlino
dovrebbe cercare modi alternativi per attirare liquidità nell'economia russa,
conclude. Il documento raccomanda il riorientamento del commercio e delle
esportazioni di idrocarburi verso la Cina. L'obiettivo di Mosca dovrebbe essere
quello di influenzare gli Stati Uniti e i suoi paesi satelliti, dice, in modo
che abbandonino del tutto le sanzioni o le ammorbidiscano.
Documenti "vincolanti”. Andrei Soldatov, un
esperto di agenzie di spionaggio della Russia e autore di The Red Web, ha detto
che il materiale trapelato "riflette la realtà". "È coerente con le procedure
dei servizi di sicurezza e del consiglio di sicurezza", ha detto. "Le decisioni
vengono sempre prese così, con consiglieri che forniscono informazioni al
presidente e una catena di comando". Ha aggiunto: "Il Cremlino gestisce in modo
minuzioso la maggior parte di queste operazioni. Putin ha chiarito alle sue spie
almeno dal 2015 che nulla può essere fatto indipendentemente da lui. Non c'è
spazio per azioni indipendenti". Putin ha deciso di rilasciare le email DNC
rubate dopo una riunione del consiglio di sicurezza nell'aprile 2016, ha detto
Soldatov, citando le proprie fonti. Sir Andrew Wood, ex ambasciatore del Regno
Unito a Mosca e socio del thinktank Chatham House, ha descritto i documenti come
"incantatori". "Riflettono il tipo di discussione e di raccomandazioni che ci si
aspetterebbe. C'è un completo fraintendimento degli Stati Uniti e della Cina.
Sono scritti per una persona [Putin] che non può credere di aver sbagliato
qualcosa". Wood ha aggiunto: "Non c'è alcun senso che la Russia possa aver fatto
un errore invadendo l'Ucraina. Il rapporto è pienamente in linea con il tipo di
cose che mi aspetterei nel 2016, e ancora di più ora. C'è una buona dose di
paranoia. Credono che gli Stati Uniti siano responsabili di tutto. Questa
visione è profondamente scolpita nell'anima dei leader russi".
Francesco Bechis per formiche.net il 16 luglio
2021. Il Russiagate scatena una guerra a base d’inchiostro. Scoppiano scintille
fra il Guardian e Le Monde. Il quotidiano inglese due giorni fa ha sganciato una
bomba: un documento russo che, secondo l’autore, il giornalista investigativo
Luke Harding, dimostra come nel 2016 la Russia di Vladimir Putin abbia scommesso
tutto sull’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, ritenuto
dagli 007 di Mosca “mentalmente instabile”. Per il primo giornale francese,
però, lo scoop potrebbe dimostrarsi una bufala. Le presunte prove allegate dal
Guardian “sono circondate da ripetuti ricorsi alla retorica”, sibila Le Monde.
Tutta l’inchiesta, che già ha sollevato un polverone fra i democratici
americani, ruota intorno a un documento “segreto” in cirillico che dà conto di
una riunione avvenuta il 22 gennaio 2016 fra Putin, il primo ministro Dmitrij
Medvedev, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e i direttori delle agenzie di
intelligence. Obiettivo del meeting, secondo i resoconti ufficiali, lo stato
dell’economia del Paese e le tensioni in Moldavia. Secondo Harding invece
durante l’incontro Putin si sarebbe confrontato con i suoi sui vantaggi per la
Russia di una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali. Fra gli altri, la
certezza che il successo del Tycoon alle urne avrebbe portato a “una
destabilizzazione del sistema sociopolitico degli Usa”. Di qui l’esortazione
finale riportata nel documento: “È assolutamente necessario usare tutte le forze
possibili per facilitare l’elezione di Trump alla presidenza americana”.
Sull’autenticità del rapporto, però, restano molti dubbi. Le Monde li elenca uno
ad uno, criticando la vaghezza delle accuse contro Mosca nell’articolo del
cronista inglese. Il decreto “appare” firmato da Putin, i documenti “si ritiene
provengano” da un leak del Cremlino, e offrono “una conferma apparente” delle
informazioni compromettenti su Trump in mano ai Servizi di Mosca. Anche se
queste informazioni, chiosa Le Monde, sarebbero state raccolte durante
precedenti visite di Trump in Russia “sulle quali non è mai stata fatta luce”.
Di più: “Il documento russo si riferisce a certi eventi riportati nell’Annesso
5. Purtroppo, di questo annesso non c’è traccia nel documento riportato dal
Guardian”. Inoltre, citando Chris Krebs, ex direttore della cybersecurity
americana licenziato da Trump per non aver aderito alla teoria delle elezioni
rubate nel 2020, il testo appare “troppo comodo, e puzza di operazione di
disinformazione”. Ma l’invettiva del più letto quotidiano parigino non finisce
qui. Ha nel mirino lo stesso autore dell’inchiesta del Guardian. Noto per i suoi
best-seller sui grandi gialli internazionali, dal caso Snowden a Wikileaks fino
all’avvelenamento dell’ex agente russo Alexander Litvinenko, Harden ha alle
spalle una carriera trentennale. Eppure, ricorda Le Monde, c’è chi ha messo in
dubbio la sua attendibilità. “Il giornalista Glenn Greenwald, anche lui un ex
Guardian, quando ha pubblicato le rivelazioni di Snowden, ha contestato la
credibilità di Harding, ricordando come in passato abbia falsamente dichiarato
che nel novembre 2018 Paul Manafort, l’ex manager della campagna di Trump, abbia
incontrato Julian Assange all’ambasciata ecuadoriana a Londra”.
Putin-Trump: cosa non torna nella
rivelazione del “Guardian”. Roberto Vivaldelli su
Inside Over il 16 luglio 2021. La “bomba” arriva dal solito Luke Harding –
insieme Julian Borger and Dan Sabbagh – e dalle colonne del
prestigioso Guardian: secondo alcuni documenti esclusivi pubblicati dalla
testata britannica, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe autorizzato
personalmente un’operazione di spionaggio segreta per sostenere un Donald
Trump “mentalmente instabile” alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016
durante una sessione riservata del Consiglio di sicurezza nazionale della
Federazione russa. L’incontro chiave si sarebbe svolto il 22 gennaio 2016, alla
presenza del presidente russo e dei suoi capi dell’intelligence oltre che di
alcuni ministri. I vertici della Federazione russa avrebbero concordato sul
fatto che l’ingresso di Trump alla Casa Bianca avrebbe aiutato a raggiungere gli
obiettivi strategici di Mosca, tra cui il “tumulto sociale” negli Stati Uniti e
un indebolimento della posizione negoziale del presidente americano. Alle tre
agenzie di spionaggio russe sarebbe stato ordinato di trovare modi pratici per
sostenere Trump, in un atto che sembra portare la firma di Putin.
Il Guardian osserva che le agenzie di intelligence occidentali sarebbero a
conoscenza dei documenti da alcuni mesi e li avrebbero fatti esaminare con
attenzione e spiega di aver mostrato i documenti a esperti indipendenti i quali
ritengono che si tratti di materiale autentico. “È assolutamente necessario
usare tutta la forza possibile per facilitare la sua [di Trump] elezione alla
carica di presidente degli Stati Uniti”, afferma il documento diffuso dalla
testata britannica. Secondo il Cremlino, Donald Trump sarebbe un “individuo
impulsivo, mentalmente instabile e squilibrato che soffre di un complesso di
inferiorità”.
Documenti autentici? Il portavoce di Putin ha
criticato lo scoop del Guardian. “Questa è finzione totale”, ha osservato Dmitry
Peskov. “A rigor di termini, è una totale assurdità. Naturalmente, questo è il
segno distintivo di una pubblicazione di qualità assolutamente bassa. O il
giornale sta cercando di aumentare in qualche modo la sua popolarità o si
attiene a una linea rabbiosamente russofoba”. Russia Today accusa inoltre Luke
Harding di aver pubblicato in passato falsi scoop, come quello relativo un
presunto incontro a Londra fra Julian Assange e e il lobbista americano Paul
Manafort che, in realtà, non si è mai verificato.
Veniamo poi al merito dei documenti pubblicati
dal Guardian. Premessa: difficile se non impossibile stabilire con assoluta
certezza se si tratti di materiale autentico o meno. Detto questo, alcuni
esperti esprimono dei dubbi. Secondo il giornalista moscovita e madrelingua Ivan
Tkachev il testo pubblicato dalla testata inglese sarebbe molto sospetto per
alcuni errori di sintassi e grammatica contenuti in esso. “Ho contato 4 errori
linguistici e un paio di casi dubbi sull’uso delle parole” osserva su Twitter.
“Quindi, con un notevole grado di sicurezza, posso presumere che si tratti di un
testo tradotto da Google da una lingua straniera al russo o di un testo composto
con l’aiuto di un russo non istruito, o entrambe le cose. Sarebbe interessante
osservare altri documenti originali”. Secondo altri utenti, invece, si
tratterebbe di un tipico “documento burocratico russo”, ma anche qui le certezze
scarseggiano.
Le agenzie d’intelligence non hanno aiutato Trump.
Va sottolineato che se anche la documentazione resa nota dal Guardian fosse
autentica, non ci sono prove che le agenzie di intelligence russe – come
ordinato da Putin – abbiano poi effettivamente dato una mano a Donald Trump a
sconfiggere Hillary Clinton nel 2016. Facciamo un passo indietro e a quanto già
evidenziato in più occasione da InsideOver in merito al dossier Russiagate. Come
sottolineato da Aaron Maté su The Nation, nel rapporto redatto dall’ex
procuratore speciale Robert Mueller, il governo russo avrebbe “interferito nelle
elezioni presidenziali del 2016 in modo radicale e sistematico”. Alcuni
paragrafi dopo, Mueller spiega che l’interferenza russa si è verificata
“principalmente attraverso due operazioni”. La prima di queste le operazioni
consisteva in “una campagna sui social media che favoriva il candidato alla
presidenza Donald J. Trump e denigrava il candidato alla presidenza Hillary
Clinton”, condotto da una fabbrica di troll russi conosciuta come Internet
Research Agency (Ira). Eppure la squadra di Mueller è stata costretta ad
ammettere in tribunale che questa era una falsa insinuazione: un giudice
federale ha infatti rimproverato l’ex procuratore e il dipartimento di Giustizia
per aver “suggerito erroneamente un collegamento” tra l’Ira e il Cremlino. Il
giudice distrettuale americano Dabney Friedrich ha osservato che l’accusa di
Mueller del febbraio 2018 “non collega l’Ira al governo russo” e sostiene che
si tratta di un’iniziativa privata “condotta da privati”. Non solo, dunque, non
c’è stata alcuna “collusione” fra Donald Trump e la Russia, come stabilito dallo
stesso Mueller, ma un giudice americano smentisce anche vi sia un collegamento
fra la citatissima Internet Research Agency (Ira) e il governo di Vladimir
Putin. Come se non bastasse, la maggior parte dei contenuti dei social media
russi non aveva nulla a che fare con le elezioni (solo il 7% dei post su
Facebook dell’Ira menzionava Trump o Clinton). Se non con le fake news sul web,
allora il Cremlino si è servito dell’enigmatico professor Joseph Mifsud per
aiutare Donald Trump? Come già approfondito da InsideOver, il docente scomparso
nulla aveva legami molto più stretti con l’intelligence occidentale – in
particolare con i servizi inglesi – che non con il Cremlino. Benché, infatti,
l’ex direttore dell’Fbi James Comey abbia definito Mifsud “un agente
russo”, nemmeno il Procuratore speciale Mueller si è mai azzardato a definirlo
tale.
Trump duro con la Russia. Più di Biden. Veniamo
infine alla prova dei fatti: durante la sua presidenza Donald Trump non ha fatto
assolutamente nulla per avvantaggiare il Cremlino. Anzi. Trump ha portato avanti
una politica estera spesso aggressiva nei confronti della Federazione Russa –
che certamente non ha fatto piacere a Putin, come la decisione di ritirare gli
Usa dal trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), siglato a
Washington l’8 dicembre 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev, a seguito del
vertice di Reykjavík. Sotto Trump, il Congresso ha inoltre approvato una legge
che autorizza 250 milioni di dollari di assistenza militare, comprese armi
letali, all’Ucraina. Il Congresso aveva votato per due volte il sostegno
militare a Kiev durante gli ultimi anni dell’amministrazione di Obama, ma la
Casa Bianca ne aveva bloccato l’attuazione. L’amministrazione Trump lo ha invece
approvato. Durante l’amministrazione dell’ex presidente Trump, il gasdotto Nord
Stream 2 è stato uno dei principali punti di conflitto con Mosca e Berlino:
Washington aveva previsto di introdurre misure contro tutte le società europee
che collaborano con la Russia alla costruzione del Nord Stream 2: il Presidente
Usa Joe Biden, al contrario, ha deciso di risparmiare dalle sanzioni la Nord
Stream Ag, la principale azienda impegnata nella costruzione del gasdotto.
Dagotraduzione dal Daily Mail
il 2 luglio 2021. Vladimir Putin ha reso illegale paragonare i sovietici ai
nazisti, ordinando che al contrario si riconosca la missione umanitaria della
Russia per liberare l’Europa. Putin ha firmato ieri sera il disegno di legge che
vieta la pubblicazione di materiale che mette in parallelo “obiettivi e
decisioni” dei sovietici con quelli del Terzo Reich. Bandito anche tutto ciò che
nega il “ruolo decisivo” dell’Armata Rossa nella sconfitta di Hitler. Il
Cremlino ha sempre più indurito il suo revisionismo storico e ha utilizzato la
Seconda Guerra Mondiale per cercare di unire una società che a detta di Putin ha
perso di morale dopo il crollo dell’Unione sovietica del 1991. La nuova
legislazione prevede il riconoscimento «della missione umanitaria dell’Unione
Sovietica nella liberazione dei paesi europei». L'affermazione è destinata a far
infuriare gli ex stati sovietici come Estonia, Lettonia e Lituania, che
sostengono di essere stati occupati dall'Armata Rossa e costretti ad aderire
all'Unione Sovietica. In effetti, la caduta di Berlino, l'orgogliosa vittoria
dell'Armata Rossa celebrata ogni anno nella Piazza Rossa, fu in parte alimentata
dal sospetto di Stalin che gli alleati occidentali non avrebbero restituito il
territorio da loro occupato nella zona sovietica del dopoguerra. Putin ha
presentato la nuova legge a gennaio dopo un periodo di aspre contese con la
Polonia su chi abbia causato la seconda guerra mondiale. Due anni fa, il
parlamento europeo adottò una risoluzione che convenne che l'Unione Sovietica e
la Germania congiuntamente «preparavano la strada allo scoppio della seconda
guerra mondiale» nell'agosto 1939, con la firma del patto Molotov-Ribbentrop.
Putin ha risposto in una conferenza stampa nel dicembre 2019, affermando che
l'Unione Sovietica è stata l'ultimo paese in Europa a firmare un patto di non
aggressione con la Germania nazista dopo che le altre potenze lo hanno placato.
«Stalin non si è macchiato del contatto diretto con Hitler, mentre i leader
francesi e britannici si sono incontrati con lui e hanno firmato alcuni
documenti», ha detto, aggiungendo che le forze sovietiche sono entrate in
Polonia solo «dopo che il governo polacco ha perso il controllo delle proprie
forze armate». Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha definito Putin un
«bugiardo». Anche gli Stati Uniti sono entrati nella querelle. Georgette
Mosbacher, ambasciatore americano a Varsavia, ha twittato: «Caro presidente
Putin, Hitler e Stalin hanno collaborato per iniziare la seconda guerra
mondiale. Questo è un dato di fatto. La Polonia è stata vittima di questo
orribile conflitto».
Dagotraduzione da The Sun il
25 giugno 2021. Secondo i rapporti delle organizzazioni sui diritti umani, nella
Crimea occupata i detenuti rinchiusi nelle infernali prigioni di Vladimir Putin
verrebbero torturati con scariche elettriche e picchiati con tubi di ferro. Tra
gli altri metodi utilizzati, anche quello di stritolargli il pene fino a
sottometterli. La penisola di Crimea è stata annessa illegalmente dalla Russia
nel 2014. Gli osservatori della Unian Information Society hanno denunciato più
di duecento casi di trattamento disumano, di cui un quarto ascrivibili a
tortura. Ibrahimjon Mirpochchaev, nato in Crimea, è stato catturato durante un
raid dell’FSB mentre era in casa. Ai giornalisti ha raccontato la sua storia:
seduto su una sedia, legato mani e piedi con lo scotch, è stato brutalmente
picchiato. Poi gli agenti dell’Fsb lo hanno strangolato, chiedendogli di
confessare di essere un estremista. «Steso a terra, nudo e con le mani e i piedi
legati insieme, mi hanno infilato qualcosa dietro, lo hanno collegato, poi mi
hanno messo uno straccio in bocca. A quel punto hanno acceso una specie di
macchina e sono stato colpito da una scossa elettrica. Mi sentivo come se stessi
bruciando dentro» ha detto l’uomo, che poi è riuscito a scappare. Open Democracy
parla dei detenuti costretti a confessare crimini mai commessi. Come Evgeny
Panov: «Mi hanno torturato con una pinza sul pene, che avvitavano fino a farmi
perdere i sensi». È stato anche sottoposto a elettroshock: «Avevo elettrodi sul
ginocchio destro, sulla gamba sinistra e sull’anca. Poi hanno acceso
l’elettricità. Sono svenuto diverse volte». E non è finita. «Mi hanno colpito in
testa, sulla schiena, sui reni, sulle braccia e le gambe con un tubo di ferro».
I russi non hanno lasciato niente di intentato: «con le ginocchia al petto,
hanno incastrato le mie mani ammanettate davanti alle gambe, e hanno infilato
una sbarra di ferro sotto le ginocchia e mi hanno appeso. Ho provato un dolore
indicibile». Da quando la Russia si è impadronita della penisola di Crimea in
Ucraina, i tartari di Crimea - che quasi all'unanimità si sono opposti
all’annessione - sono stati presi di mira per repressione, spiega Radio Free
Europe. Nel 2020 ha riferito che centinaia di bambini dei tartari di Crimea sono
detenuti dalla Russia. Mumine Saliyeva, attivista tartara della Crimea, il cui
marito, Seiran Saliyev, è stato arrestato, ha parlato delle punizioni estreme
che vengono inflitte quotidianamente lì. «Abbiamo visto persone scomparire senza
lasciare traccia. Le caricano sui furgoni della polizia e le portano nelle
prigioni russe. In Crimea, stanno arrestando gli uomini più nobili, coraggiosi e
moralmente forti. I bambini coinvolti in questa storia sono le creature più
vulnerabili e indifese. Alcuni dei bambini sono disabili, altri hanno malattie
gravi». In un nuovo rapporto l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani (OHCHR) ha già avvertito che la tortura viene
utilizzata dal servizio segreto russo, l'FSB, per estorcere "confessioni" con
"processi" basati esclusivamente su "testimoni" anonimi, avverte.
L’organizzazione ha denunciato i gravi abusi compiuti «nella Repubblica autonoma
di Crimea e nella città di Sebastopoli, in Ucraina» definendo la Crimea un
territorio occupato. La Russia ha rifiutato la richiesta dell'OHCHR di condurre
una missione di persona in Crimea e monitorare in prima persona il trattamento
riservato ai detenuti. Tutte le organizzazioni umanitarie sono tenute fuori
dalla Crimea. L'organizzazione ha intervistato le vittime di presunte violazioni
dei diritti umani in Crimea tramite monitoraggio a distanza.
Fabrizio Dragosei per
il "Corriere della Sera" il 7 giugno 2021. Sono comparse tutte e due allo stesso
evento pubblico, probabilmente per la prima volta da quando Vladimir Putin è al
potere. Ma nessuno può giurare che siano effettivamente le figlie del
presidente, visto che entrambe usano altri cognomi e che nessuno in Russia si
azzarda più a fare domande eccessivamente indiscrete su un argomento che
Vladimir Vladimirovich ha detto con voce forte e chiara di considerare
«off-limits», quello della sua vita privata, la sua famiglia, le eventuali
avventure sentimentali. E chi non capisce l'antifona rischia grosso, come il
giornale Moskovskij Korrespondent che nel 2008 scrisse di un imminente
matrimonio tra il presidente e la ex ginnasta Alina Kabayeva. Pochi giorni dopo
il quotidiano sospese le pubblicazioni. Ma da un po' di tempo le figlie Maria e
Katerina (o meglio due signore con gli stessi nomi) di 36 e di 34 anni, sono
alla ribalta delle cronache per i loro progetti nella genetica e
nell'intelligenza artificiale. Così in questo fine settimana hanno parlato al
Forum economico di San Pietroburgo. A una sessione sugli investimenti economici
Katerina venerdì ha dissertato su tecnologie innovative. Naturalmente è stata
presentata con il suo «vero» cognome, Tikhonova. Sabato è stata la volta di
Maria, anche lei, naturalmente, con il cognome che usa: Vorontsova. Solo che
tutte e due le donne usano il patronimico «giusto» cioè Vladimirovna, vale a
dire figlia di Vladimir. I padri potrebbero ovviamente essere due omonimi, ma il
rispetto con il quale vengono trattate sembra confermare che non siano due
Vladimir qualunque. Katerina, per capire, ha parlato davanti a un uditorio di
ministri e alti funzionari che l'ascoltavano in religioso silenzio. Ad un certo
punto il rettore dell'università di San Pietroburgo che fungeva da moderatore,
si è permesso di fare una battuta mentre Katerina parlava. È stato subito
zittito da un infastidito ministro della Giustizia. In realtà le figlie del
presidente e della ex moglie Lyudmila, sposata nel 1983, sono scomparse dalla
scena ufficiale già nel 1999. L'ex agente del Kgb venne scelto come successore
da Boris Eltsin e nominato primo ministro (nel Duemila prese il posto di Eltsin
che si dimise). Immediatamente le due ragazze che studiavano alla scuola tedesca
di Mosca (la famiglia aveva vissuto nella Germania comunista quando Putin era a
capo della stazione del Kgb di Dresda) vennero ritirate dall'istituto e
continuarono l'anno privatamente. Ufficialmente non si è mai parlato di loro e
Putin in qualche occasione si è limitato a dire che sono fluenti in varie
lingue, perseguono la loro carriera, vivono in Russia. È stato scritto che Maria
aveva sposato un imprenditore olandese e che Katerina si era unita con il figlio
di un amico intimo di Putin, Nikolaj Shamalov. Entrambe però ora usano altri
cognomi, come abbiamo visto. La moglie Lyudmila si sarebbe risposata con un
imprenditore che ha vent' anni meno di lei e vivrebbe in una specie di castello
a Biarritz in Francia. Di Alina Kabayeva si dice che abbia dato tre figli al
presidente e che lui l'abbia sposata segretamente. Di certo sappiamo solo che da
semplice atleta ha fatto una carriera prodigiosa e ora è a capo della holding
che controlla alcune delle principali tv e che è di proprietà di oligarchi e
amici di Putin.
Ricostruzione storica. La zampata
dell’orso: il libro che ricostruisce le operazioni militari della prima guerra
mondiale. Redazione su Il Riformista il 26 Maggio
2021. “La zampata dell’orso” è il titolo del nuovo libro scritto a sei mani da
Basilio Di Martino, Paolo Pozzato ed Elvio Rotondo e pubblicato da Libellula
Edizioni. Il volume ricostruisce le operazioni militari portate avanti durante
il primo conflitto mondiale nel corso della cosiddetta offensiva Brusilov (dal
nome del generale russo Aleksei Alekseevich Brusilov), che rappresentò il
momento più alto delle fortune dell’esercito zarista.
LA NARRAZIONE. La grande offensiva è considerata
la più grande vittoria della Triplice intesa durante tutta la grande guerra. Lo
scontro ebbe inizio il 4 giugno 1916, quando lo zar Nicola II di Russia ordinò
al generale Brusilov di attaccare le forze degli imperi centrali su un fronte di
oltre 500 km che andava dalle paludi del Prypjat, sulla frontiera polacca,
all’estremità dello schieramento austriaco. L’attacco guidato da Brusilov ebbe
fine il 20 settembre 1916, dopo aver raggiunto l’obiettivo principale di
distogliere importanti forze tedesche dal settore di Verdun e soprattutto di
costringere gli austro-ungarici a levare truppe dal settore del Trentino nel
pieno dell’offensiva della Battaglia degli Altipiani (Strafexpedition).
L’offensiva convinse la Romania ad entrare in guerra a fianco dell’Intesa (alla
quale però non diede alcun tipo di valido apporto), mentre le perdite furono
notevoli per entrambi gli schieramenti: oltre 500mila soldati, in una delle
battaglie più sanguinose della storia moderna.
IL VOLUME. Il volume di Di Martino, Pozzato e
Rotondo, grazie all’utilizzo di materiale inedito e a uno studio specifico
sull’aviazione russa, che grande peso ha avuto nell’ambito dell’offensiva
militare che vide protagonista Brusilov, ripercorre uno dei momenti più cruciali
di tutta la grande guerra, che cambierà in maniera determinante uno dei
conflitti che hanno segnato la storia del Novecento. Quel lungo e sanguinoso
ciclo operativo fu sul punto di decidere in modo del tutto inatteso le sorti
della guerra, spingendo l’Austria-Ungheria sull’orlo del baratro. Tuttavia, il
pronto intervento dell’alleato germanico e i fattori di debolezza intrinseca
della Russia, duramente provata dalle disastrose sconfitte del 1914 e del 1915,
contribuirono a far sì che la spinta delle armate del fronte sud-occidentale si
esaurisse già prima della fine dell’estate 1916, producendo un precario
equilibrio che si sarebbe definitivamente rotto nel 1917.
STORIA E DOCUMENTI. Quello che può essere a
ragione considerato l’ultimo, disperato sforzo dell’esercito zarista, ebbe però
due importanti conseguenze: da un lato determinò la definitiva subordinazione
strategica e tattica delle forze imperial regie austro-ungariche (kaiserliche
und königliche Armee) all’alto comando tedesco, dall’altro, con il fallimentare
intervento rumeno ad agire da catalizzatore, accelerò la crisi finale di quello
stesso esercito fino alla sua dissoluzione. L’attuale storiografia europea e
statunitense – a differenza di quella italiana –, se pur attratta dal corso del
conflitto sui fronti francese e belga, non ha mancato, a sua volta, di cogliere
l’importanza degli avvenimenti del fronte orientale per l’andamento complessivo
del conflitto, individuando proprio nell’offensiva Brusilov dell’estate del 1916
un punto di svolta cruciale nella guerra del 1914 – 1918. Cosa può dunque
aggiungere questo nuovo lavoro alla bibliografia già disponibile sull’argomento,
a parte l’ovvio utilizzo della lingua italiana? Sicuramente un approfondimento
tangibile, basato sul fatto che i saggi e gli apporti citati nella struttura del
volume, sebbene in molti casi siano ampiamente documentati sia sulle fonti
d’archivio, sia avvalendosi della memorialistica dei protagonisti, sono ancora
lungi dall’aver esplorato in toto la mole di assoluto rilievo del materiale
disponibile.
GLI AUTORI. Uno dei tre autori dell’opera, Elvio
Rotondo, analista del think tank di geopolitica trentino “Il Nodo di Gordio”, ha
evidenziato che nelle ricerche delle fonti: «non sono stati utilizzati solo gli
apporti della storiografia russa dell’epoca, spesso conditi da vera propaganda
post-rivoluzione, ma sono state impiegate anche le ricerche effettuate da nuove
generazioni di storici russi che hanno garantito l’utilizzo di ulteriori e
importanti materiali, tanto documentari quanto di natura memorialistica, dando
il via all’esplorazione di un filone in precedenza poco approfondito. Quindi
sono state in qualche modo rimesse in discussione molte vicende legate alla
figura del Generale Brusilov, deviando, senza dubbio, dalla storiografia viziata
da forti condizionamenti ideologici e politici dell’Unione Sovietica».
Un altro coautore del volume, Paolo Pozzato,
docente di storia e filosofia, nonché membro della Società italiana di storia
militare, osserva che: «ci sono due ragioni principali per occuparsi
dell’offensiva russa che prende il nome dal generale Brusilov e per dedicarle un
saggio per i lettori italiani. La prima è senz’altro che essa rappresentò una
svolta nell’intero corso della prima guerra mondiale. Gli austro-ungarici
subirono infatti una rotta di dimensioni maggiori anche di Caporetto e dovettero
quindi accettare da quel momento la sudditanza strategica all’alleato tedesco.
La seconda è che essa dimostra come a livello operativo non esista alcuna
“regola” che non possa essere violata con risultati addirittura maggiori di
quelli ci si riprometteva dall’applicazione dei principi tradizionali».
Il terzo coautore, il Generale ispettore capo
dell’Aeronautica militare Basilio Di Martino, evidenzia che «la cosiddetta
offensiva Brusilov presenta caratteri di modernità che smentiscono molti degli
stereotipi relativi all’esercito zarista e propone soluzioni originali al
problema della rottura dei fronti trincerati. Uno degli aspetti di maggiore
interesse è l’impiego che fu fatto dell’aviazione. La Russia non disponeva di
un’industria aeronautica adeguata alle sue ambizioni, nonostante la
disponibilità si alcuni progettisti di grande valore e fu sempre dipendente
dalle forniture degli alleati e dalle produzioni su licenza. Brusilov riuscì
però a sfruttare al meglio quanto aveva a disposizione, facendo della
ricognizione aerea uno dei fattori che gli assicurarono il successo, almeno
finché fu in grado di contare sulla superiorità aerea locale».
Perché il Tatarstan è la spina nel fianco
di Putin. Emanuel Pietrobon su Inside Over il 12
maggio 2021. Giovani, ricolmi di odio nei confronti della società, disincantati
verso la politica, immuni alla nazionalizzazione, guidati da una visione
anarco-nichilista della vita e cresciuti con il mito del massacro della
Columbine High School; quello che a prima vista può sembrare l’identikit unico
ed esclusivo dello strategista medio americano, in realtà, combacia
perfettamente con il profilo dell’attentatore di Kazan e dei suoi precedessori.
La strage di Kazan. Kazan, ore 9,20 dell’11
maggio 2021. Un lucido folle entra nella scuola 175 della capitale
del Tatarstan con l’intenzione di commettere una mattanza, armato di un
esplosivo artigianale e di una mitragliatrice regolarmente acquistata e
detenuta. L’attentatore ha successo, complici l’assenza di controlli e
vigilanza, come dimostrano i numeri della strage: 9 morti e 23 feriti, sia tra
gli alunni sia tra il corpo docente, secondo l’ultimo aggiornamento
disponibile (ore 11 del giorno successivo). Un uomo armato che irrompe in una
scuola e compie un massacro, agendo in una regione a maggioranza musulmana, non
estranea alle tensioni etno-religiose, che sin dagli anni Novanta fornisce
manovalanza alle organizzazioni dell’internazionale jihadista operanti
tra Russia, Asia centrale e Medio Oriente. Il collegamento con Beslan 2004 è
subitaneo, come immediati sono i sospetti su Hizb-ut Tahrir (HT) – la principale
organizzazione terroristica del Tatarstan –, ma l’arresto dello stragista svela
un’altra realtà. L’attentatore, rispondente al nome di Ilnaz Galyaviev, nato
l’11 settembre 2001, non ha agito né per fede né per politica. Su Telegram
vengono recuperate prove utili a ricostruire quadro e cornice del massacro:
mosso dall’odio nei confronti della “spazzatura biologica” (биомусор)
– un linguaggio che ricorda i teorici del gioco omicida della Blue Whale –,
Galyaviev recentemente aveva comunicato ai propri lettori di essere “un dio” e
di avere in mente l’attuazione di una strage. Galyaviev come i terroristi
ceceni? No, Galyaviev come Vladislav Roslyakov (autore del massacro scolastico
di Kerch del 2018: 21 morti e 70 feriti) o come Sergey Gordeev (firma di una
tentata strage in una scuola moscovita nel 2014: 2 morti e un ferito):
adolescenti, russi etnici il più
delle volte, autoradicalizzati, ricolmi di odio nei confronti della società,
disincantati verso la politica, immuni alla nazionalizzazione, guidati da una
visione anarco-nichilista della vita e cresciuti con il mito del massacro della
Columbine High School. Seguire le mosse degli aspiranti stragisti alla Columbine
non è semplice, perché estranei alle realtà organizzate e non sempre propensi a
manifestare il proprio disagio nella realtà virtuale, ma la consapevolezza della
loro esistenza ha condotto le autorità ad estendere i controlli preventivi in
rete, con il risultato che fra il 2017 ed il 2018 è quintuplicato il numero di
gruppi e blog chiusi per incitamento allo stragismo.
Le bombe Tatarstan e
generazione Columbine. La Russia non è alle prese con un’emergenza
all’americana, perché i massacri compiuti dai giovani votati alla misantropia
omicida sono relativamente pochi, ma Kazan è la prova che un problema emergente
esiste e, come tale, non può essere trascurato – pena un letale aggravamento. Il
Cremlino, all’indomani del massacro nella capitale del Tatarstan, ha annunciato
l’introduzione di nuove misure in materia di circolazione delle armi e rilascio
delle licenze, nonché un ulteriore aumento della sorveglianza digitale. Lo
spettro di massacri in stile Columbine in salsa russa, però, è soltanto l’ultimo
dei problemi del Cremlino. Terrorismo islamista e secessionismo continuano ad
essere le minacce principali alla sicurezza nazionale, con il primo che incombe
sulle metropoli della Russia europea ed il secondo che aleggia sulle realtà
remote del Volga, della Siberia e dell’Estremo Oriente. Nel solo 2019, a titolo
esemplificativo, le autorità russe hanno arrestato quasi 900 persone e
smantellato 78 cellule terroristiche. E il Tatarstan, storico bacino di
reclutamento delle principali organizzazioni islamiste e jihadiste operanti
dentro e fuori la Russia – almeno tremila gli islamisti censiti ufficialmente
–, è vulnerabile sia all’effetto Columbine sia alle annose questioni del
secessionismo e della radicalizzazione religiosa. Tale è il livello delle
preoccupazioni in seno al Cremlino in merito al fascicolo Tatarstan, della cui
autonomia ha tratto vantaggio Recep Tayyip Erdogan per promuovere sentimenti
panturchisti e panislamisti tra i giovani, che l’anno scorso ha avuto luogo un
eloquente tentativo di fermare il 468esimo anniversario della presa di Kazan
(Xäter Köne), nella cognizione che sia oramai divenuto un evento intriso di
risentimento russofobico, fonte di tensioni interetniche e oligopolizzato dagli
islamisti di HT e dagli aspiranti separatisti del Centro Pubblico Tataro (ATPC)
e dell’Associazione della Gioventù Tatara Azatlyk. Un problema, quello del
Tatarstan, che avevamo ampiamente analizzato nel passato recente, lo scorso
ottobre, descrivendo ideologia, attività ed influenza di ATPC e Azatlyk, “due
delle forze sociali e culturali più rilevanti e influenti che stanno guidando il
risveglio identitario nel Tatarstan […] e contribuendo a politicizzare la
gioventù tatara e ad ampliare il divario con Mosca e con gli stessi russi che
vivono nella repubblica autonoma”. L’ATPC è, indubbiamente, il più periglioso
tra i due movimenti, perché, come scrivevamo, “è in prima fila in ogni
iniziativa di stampo antirusso: dalla ritualizzazione dell’anniversario della
caduta di Kazan alle proteste contro l’estensione dell’utilizzo della lingua
russa nella sfera pubblica e nell’istruzione, dalla somministrazione di corsi
gratuiti di tataro, rigorosamente scritto in alfabeto latino, alle pressioni sui
governi che si succedono regolarmente affinché rivedano gli accordi sulla natura
della repubblica all’interno della Federazione russa”. Non deve sorprendere,
dunque, che a inizio 2021 sia cominciata la procedura per il suo inserimento
nell’albo delle organizzazioni estremistiche. Il Tatarstan non è una polveriera
pronta ad esplodere, ma il risveglio identitario trainato dal protagonismo della
Turchia – il cui raggio d’azione è esteso dal Caucaso settentrionale all’Estremo
Oriente, ovvero ovunque risiedano popoli turchici – e l’esposizione della
gioventù a fascinazioni perigliose, quali la misantropia omicida e l’islam
radicale, la rendono sicuramente una delle realtà più sensibili all’interno del
panorama federale.
Alle origini
dell’intesa tra Russia e Cina.
Emanuel Pietrobon, Federico Giuliani
su Inside Over il 12 maggio 2021.
Il sistema internazionale sta venendo interessato da dei processi
di deformazione tettonica di natura epocale. Perché la guerra fredda 2.0, e in
esteso la competizione tra grandi potenze, condurranno inevitabilmente ad un
profondo rimescolamento della divisione del potere nelle terre emerse, simile,
per dimensioni e portata, a quello avvenuto all’indomani della fine della
seconda guerra mondiale (crollo definitivo dell’eurocentrismo nelle relazioni
internazionali) o della guerra fredda (estinzione del bipolarismo e avvio del
momento unipolare). In palio, rispetto agli episodi storici menzionati di cui
sopra, non v’è l’egemonia globale: né gli Stati Uniti né la Cina, e meno che mai
la Russia, invero, sono o sarebbero in grado di sostenere i gravi oneri
derivanti dal mantenimento di un impero terracqueo. Il mondo è troppo caotico
perché su di esso troneggi un solo re: la Casa Bianca ha appreso questa dura ed
inalterabile verità nel corso del breve paragrafo unipolare post-guerra fredda,
che, cominciato all’insegna delle crisi in Iraq e Iugoslavia e proseguito
con Afghanistan, Guerra al Terrore (War on Terror) e inattesi ritorni di fiamma
in una varietà di teatri, si trova, oggi, sul viale del tramonto a causa della
resurrezione della Russia, dell’ascesa della Cina e, a latere, di una
competizione tra grandi potenze che, divise dalla (geo)politica, sono accomunate
dall’anelito di accelerare la transizione multipolare. Fondamentale è il ruolo
che sta venendo giocato da Russia e Cina all’interno di questo contesto
altamente conflittuale e dalle implicazioni potenzialmente epocali. Le due
potenze egemoni dell’Eurasia, approfittando del fatto che gli Stati Uniti
abbiano avuto gli occhi puntati sulla Guerra al Terrore per un’intera decade,
hanno lentamente guadagnato terreno nel continente (e oltre) e
istituzionalizzato la loro visione di lungo termine per tramite di un
partenariato strategico che con lo scorrere del tempo ha dato vita ad un asse
adamantino. Ed è così che, nel periodo compreso tra Euromaidan e l’inizio
dell’era Trump, l’Orso e il Dragone hanno messo da parte le ultime diffidenze e
rivalità, tenendo a mente la lezione del tranello Kissinger, inaugurando
ufficialmente l’avvio della nuova guerra fredda tra Occidente e Oriente.
Le ragioni del Cremlino.
Euromaidan è stato per gli anni 2010 quello che gli attentati dell’11 settembre
sono stati per i primi anni 2000: uno spartiacque. Perché la riapertura
ufficiale del confronto egemonico tra Russia e Occidente si deve precisamente
alla rivoluzione colorata più celebre del nuovo secolo, che ha comportato la
transizione subitanea e traumatica dell’Ucraina dalla sfera d’influenza russa a
quella occidentale – traslando in realtà i sogni di Zbigniew Brzezinski – e che
è stata seguita dall’invasione-per-annessione della Crimea da parte del Cremlino
e dall’introduzione di un regime sanzionatorio antirusso da parte del blocco
euroamericano. Ed è a quel punto, in occasione dell’annuncio di un regime
sanzionatorio avente come obiettivo il tracollo economico della Russia,
che Vladimir Putin opta l’incamminamento in una strada battuta in passato e
terminata rovinosamente: l’asse antiegemonico con il Celeste impero.
L’amalgamazione è tanto rapida quanto estesa: non v’è settore che le due potenze
escludano dalla cooperazione avanzata, dai più intuibili (come lo scambio di
beni energetici e il turismo) ai più imprevedibili
(come Artico, telecomunicazioni e difesa). A questo punto sorge un “però”. La
fusione tra le due potenze è avvenuta troppo rapidamente perché possa essere
giustificata da una delle tante rivoluzioni colorate, e da una delle molteplici
e periodiche crisi tra Russia e Occidente. È vero: la differenza tra Euromaidan
e la rivoluzione delle rose in Georgia è immane, ma perché rivolgersi proprio
alla Cina? La verità è che le due potenze, legate da un trattato di amicizia e
buon vicinato siglato nel 2001, stavano ponderando la costruzione di un asse
antiegemonico da molto tempo. Entrambe erano state toccate direttamente dal
dramma delle guerre iugoslave – con Mosca testimone inerme della disgregazione
di Belgrado e con Pechino spettatrice del bombardamento della propria
ambasciata, ufficialmente avvenuto per errore ma ufficiosamente condotto per
punire gli scambi di intelligence con i serbi – ed entrambe avevano appoggiato
con riluttanza i cambi di regime nell’Iraq di Saddam Hussein e
nella Libia di Muammar Gheddafi, sullo sfondo di rivoluzioni colorate nello
spazio postsovietico e di un crescente protagonismo militare occidentale
nell’Indo-Pacifico. Euromaidan, in sintesi, ha svolto la funzione della classica
goccia che fa traboccare il viso: vaso che, lungi dall’essere stato riempito nel
corso del 2014, era stato saturato da oltre un decennio di operazioni di polizia
globale da parte della Casa Bianca. Non a caso, dapprima che la Cina
intervenisse in soccorso della Russia nel dopo-regime sanzionatorio, le due
nazioni avevano dato prova di una volontà collaborativa in Siria e in Venezuela.
Le ragioni di Pechino. Quella
tra Russia e Cina è la più classica delle alleanze strategiche possibili e
immaginabili. Per capirlo, e senza scendere troppo nel dettaglio, basta
focalizzare l’attenzione sui principali punti di forza dei due attori in campo:
Mosca ha da sempre prediletto l’apparato militare, puntando sullo sviluppo di
armi e strumenti sempre più potenti e, al tempo stesso, relegando l’economia in
secondo piano. Ancora oggi, infatti, il governo russo continua a dipendere
eccessivamente dall’esportazione di gas e risorse naturali, risultando troppo
sensibile a fattori esterni avversi (e non parliamo soltanto delle sanzioni
economiche). Pechino ha puntato tutto sulle riforme economiche. Dal 1979, in
maniera “graduale e progressiva”, come amano ripetere i funzionari cinesi, la
Cina si è aperta al mondo esterno mettendo a disposizione degli altri prima la
sua immensa forza lavoro, poi il suo enorme mercato interno. È così che il
Dragone ha frantumato ogni record, arrivando oggi a insidiare gli Stati Uniti
per ciò che riguarda gli indicatori economici più rilevanti. Per quanto riguarda
l’esercito, Xi ha modernizzato le forze armate imitando, non a caso, la Russia.
L’Esercito Popolare di Liberazione cinese (EPL), ovvero il braccio armato
del Partito Comunista cinese, è stato ridimensionato tanto dal punto di vista
numerico che nell’intera struttura di comando. Marina e Aeronautica hanno eroso
spazi di importanza alle forze di terra, ora ridimensionate e ridotte. L’Epl ha,
di fatto, assorbito la dottrina militare di Mosca, sia per ristrutturare
l’esercito che per modernizzare l’equipaggiamento. Xi Jinping ha poi “imitato”
Putin, usando le suddette riforme militari per stabilire un fermo controllo
sull’esercito. Non solo: strateghi e ufficiali cinesi continuano a essere
istruiti nel pensiero russo della cosiddetta New Generation Warfare, ovvero
nella guerra di nuova generazione. Questo punto di contatto ha cementato un
patto d’acciaio tra russi e cinesi sfociato in esercitazioni terrestri,
marittime e aree. Tutte esercitazioni congiunte, affiancate ad altre operazioni
in aree altamente sensibili come l’informazione e la tecnologia antimissile.
Possiamo dunque dire che la Russia ha messo sul tavolo le proprie conoscenze
militari, mentre la Cina ha risposto con una notevole spinta economica.
Considerando che i progetti inerenti alla Belt and Road Initiative hanno un
valore totale di 575 miliardi di dollari, e che l’investimento in campo
energetico vale, da solo, il 45% del pacchetto, la Russia è ben felice di
prestarsi a una sorta di relazione win-win. Non solo: stando alle ultime
statistiche, al termine del primo trimestre del 2020, Mosca ricopre il ruolo di
maggior beneficiario della BRI, con 126 progetti all’attivo e un valore di 296
miliardi di dollari. Facile, dunque, intuire già così le ragioni dell’alleanza
russo-cinese. Siamo di fronte a un rapporto complementare, un asse calibrato al
dettaglio per garantire un mondo multipolare e opporsi, in più ambiti,
all’egemonia incarnata dagli Stati Uniti. Appurate le ragioni della partnership
russo-cinese, è interessante dare un’occhiata alle origini di questa vicinanza.
Iniziamo subito col dire che le relazioni tra Mosca e Pechino sono migliorate
dal 1991 in poi, ossia dopo il crollo dell’Unione Sovietica. In seguito alla
caduta dell’Urss, infatti, la Cina iniziò a specchiarsi nella Federazione Russa,
lasciando in secondo piano la sponda americana. Ricordiamo che quelli erano gli
anni in cui l’opinione pubblica statunitense riteneva plausibile trascinare il
Dragone nell’alveo delle democrazie occidentali soltanto appoggiando le sue
riforme economiche e coinvolgendolo nelle organizzazioni internazionali, tra cui
l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel 1992 Russia e Cina affermarono di
star perseguendo una partnership costruttiva, mentre nel 1996 si parlò di
partnership strategica. Nel 2001, invece, le due potenze firmarono un trattato
di amicizia e cooperazione.
La SCO, un esempio di successo.
La punta dell’iceberg della partnership russo-cinese può essere rappresentata
dall’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). Siamo di fronte al
segno più evidente di una svolta eurasiatica nelle alleanze globali,
realizzabile in molteplici campi d’azione: dalla cooperazione economica e
militare alla lotta al terrorismo, dalle esercitazioni congiunte a una spiccata
convergenza negli atteggiamenti politici e dei valori perseguibili. Alcuni
analisti hanno definito la SCO una sorta di Nato asiatica, visto e considerando
che questo organismo intergovernativo è stato fondato nel giugno 2001 da sei
capi di Stato – Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan – sulle ceneri del precedente Gruppo di Shanghai. Oggi
si sono aggiunti altri Paesi, Pakistan e India, oltre che
Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia nei panni di osservatori
e Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Turchia, Sri Lanka ed Armenia nelle vesti di
partner di dialogo. La SCO, utile sia alla Cina che alla Russia, è operativa per
quanto concerne la cooperazione in sicurezza, economia e cultura. La sua
efficacia potrebbe tuttavia essere indebolita dall’asimmetria insita nella
relazione sino-russa, ben visibile in ambito economico. Il Pil della Russia non
raggiunge neppure quello della provincia cinese del Guandong, mentre la sua
spesa per la difesa, come ha sottolineato ISPI, è appena un terzo rispetto a
quella cinese.
David Sassoli, "divieto di entrare in
Russia". Vladimir Putin, una mossa diplomatica pesantissima: guerra tra Mosca e
l'Unione europea. Libero Quotidiano il 30 aprile 2021.
Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli "nemico pubblico" del Cremlino e
di Vladimir Putin. "In risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22
marzo nei confronti di sei cittadini russi", annuncia una nota di
Mosca, a Sassoli e ad altri 7 responsabili europei "sarà vietato l'ingresso
in Russia". Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, citato
dall'agenzia Ria Novosti. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha
subito espresso "piena solidarietà" a Sassoli. La Russia ha vietato l'ingresso
anche a Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea responsabile per
le politiche su valori e trasparenza, e a Jorg Raupach, capo dell'ufficio del
procuratore generale di Berlino. Colpiti dalle sanzioni russe anche Ivars
Abolins, presidente del Consiglio nazionale dei mass media elettronici della
Lettonia, Maris Baltins, direttore del Centro linguistico statale della
Lettonia, Jacques Maire, membro della delegazione francese all'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, Ana Scott, capo del laboratorio di
sicurezza chimica e nucleare dell'Istituto svedese di ricerca sulla difesa,
e Ilmar Tomusk, capo del dipartimento linguistico dell'Estonia. Lo scorso marzo
l'Unione europea aveva sanzionato la Russia colpendo enti e singole persone
per "le torture e la repressione a danno delle persone LGBTI e degli oppositori
politici in Cecenia". Per tutti i colpiti congelamento dei beni in Europa,
divieto per persone ed entità dell'Ue di sostenere economicamente i sanzionati
e divieto per questi ultimi di viaggiare nei Paesi dell'Unione. Quindi il duro
aut aut per il caso dell'oppositore di Putin Navalny, imprigionato e in precarie
condizioni psicofisiche. La decisione odierna di Mosca rappresenta l'ultima
tappa di una escalation di tensione nei rapporti tra Russia e Bruxelles che dura
da anni e che vede proprio le aziende italiane, molto forte nell'ex impero
sovietico, tra le maggiormente danneggiate dalle sanzioni economiche imposte
contro il Cremlino.
Dalla paura rossa alla paura russa, in
Europa è gelo con il Cremlino. Emanuel Pietrobon su
Inside Over il 30 aprile 2021. La Russia è quella potenza con cui il sistema
Europa è in bellum perpetuum da tempo immemorabile. Storicamente ritenuta più
asiatica che europea (“gratta un russo e troverai un tataro”, diceva Joseph de
Maistre già a fine Settecento), indi trattata alla stregua di un intruso
ritrovatosi per errore alle porte del Vecchio Continente, né più né meno
periglioso della Sublime Porta, la Russia ha uno storico di relazioni lunatiche
e conflittuali con le potenze europee lungo almeno tre secoli. Se è vero
che historia magistra vitae, cioè che la storia è maestra di vita, gli eventi
che hanno avuto luogo tra il blocco-civiltà Occidente e il mondo russo dagli
albori dell’Ottocento ad oggi sembrano corroborare l’esistenza di una
maledizione della geografia per la quale non vi sono né panacee alchemiche né re
taumaturghi: è la maledizione del contenimento infinito. In principio fu Michał
Sokolnicki in combutta con Napoleone nella diffusione de “La volontà di Pietro
il grande” (Aperçu sur la Russie), falso storico utile a legittimare la campagna
di Russia agli occhi dei popoli europei, poi seguirono la caccia alle streghe
durante le presidenziali americane del 1828, la guerra di Crimea – un
contenimento ante litteram –, il Grande Gioco per l’Asia centrale, il Lungo
Telegramma di George Kennan – spaventevolmente rimembrante dell’hoax napoleonico
– e un quarantennio di guerra fredda. La quiete tra i due universi
civilizzazionali è durata relativamente poco, perché nel 2014, causa Euromaidan,
è riesplosa ufficialmente quella che giornalisti e politologi hanno ribattezzato
la “nuova Guerra Fredda”. In realtà, come abbiamo spiegato a più riprese sulle
nostre colonne, la Guerra Fredda non è mai terminata: era entrata in uno stadio
di dormiveglia, proseguendo in maniera morbida (soft) e sotto mentite spoglie,
come dimostrano l’allargamento di Unione europea e Alleanza atlantica tra ex
patto di Varsavia e Balcani, la sequela di rivoluzioni colorate nello spazio
postsovietico e l’appoggio dell’amministrazione Biden alla “rivoluzione della
neve” tentata dall’allora semi-sconosciuto Aleksei Navalny nel 2011. Oggi,
rispetto alla seconda parte del Novecento, è mutata la forma, perché la paura
rossa è stata sostituita dalla paura russa, ma la sostanza rimane identica ed
inalterata: il contenimento infinito. E dopo il parziale rilassamento dell’era
Trump – una pace di piombo costellata di periodiche escalation –, la
tensione tra i blocchi è tornata ai livelli dell’immediato post-Euromaidan a
partire dal 20 gennaio, ovvero da quando alla Casa Bianca si è insediata
ufficialmente l’amministrazione Biden. Captata e recepita la chiamata alle armi
lanciata dal nuovo inquilino della Casa Bianca nella giornata del 17 marzo, tra
gli stati membri dell’Ue ha avuto inizio una corsa frenetica per fornire prove
di lealtà alla nuova amministrazione, principalmente consistenti nell’altolà
allo Sputnik V, in guerre di spie e in rappresaglie diplomatiche, e
geograficamente localizzate tra Baltici, area Visegrad e Balcani – con la
curiosa, ma non sorprendente, partecipazione dell’Italia.
L’Est Europa, cuore della guerra fredda 2.0. È in
quella parte di continente europeo estesa geometricamente dal mar Baltico al mar
Nero, ribattezzata Intermarium da Józef Piłsudski e Nuova Europa da Donald
Rumsfeld, che sta venendo scaricata gran parte della tensione accumulata durante
la pace di piombo dell’era Trump. Qui, dove la (geo)politica è riuscita
nell’obiettivo di dividere ciò che la cultura dovrebbe unire, le principali
realtà statuali postsovietiche e postcomuniste stanno cavalcando con maestria il
clima di rinnovato e aperto antagonismo tra Washington e Mosca, riaprendo
dossier insoluti di sette anni or sono – come il caso Vrbetice –, guerreggiando
diplomaticamente e snidando presunte reti spionistiche rispondenti al Cremlino.
L’obiettivo delle dirigenze di Baltici, V4 (Ungheria esclusa) e Balcani
orientali è duplice: accreditarsi agli occhi degli Stati Uniti e mobilitare le
proprie opinioni pubbliche, anche per ragioni di consenso e calcolo elettorale,
facendo leva sul sempreverde spauracchio del pericolo proveniente dai figli di
Rurik e san Vladimir. I rischi di questa caccia alla streghe, localizzata
nell’Europa orientale e bene accolta dalla Casa Bianca, sono tutt’altro che
bassi: la recente entrata in scena della Romania mostra e dimostra come l’alea
di un esiziale effetto domino nel resto del continente sia lungi dall’essere
irrealistica. Il governo Cîțu, invero, il 26 aprile ha etichettato come persona
non grata un diplomatico russo di stanza a Bucarest, Alexei Grichayev, adducendo
come motivi la volontà di esprimere solidarietà alla Repubblica Ceca e delle
presunte violazioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il
vero epicentro di questa crisi diplomatica estesa da Tallinn a Sofia, e che sta
attraversando Bucarest, Varsavia, Kiev e Bratislava, si trova a Praga, dove sta
avendo luogo una piccola primavera tinta di atlantismo e basata su espulsioni di
diplomatici russi, esclusioni di firme russe da appalti miliardari, operazioni
di polizia a detrimento di presunti circoli spionistici e riapertura di
vecchi cold case. I numeri possono illustrare ed esplicare con efficacia ciò che
alle parole riesce soltanto a metà: la guerra dei diplomatici tra il blocco
euroamericano e la Russia ha condotto a 152 espulsioni nel periodo 15-30 aprile,
ovvero una media di 10 espulsioni al giorno. La classifica è saldamente guidata
dalla Repubblica Ceca, la quale troneggia senza rivali, forte
dell’allontanamento coatto di 81 diplomatici russi, e seguono la Russia (47
espulsi da dieci ambasciate), gli Stati Uniti (10), Polonia e Slovacchia (3 a
testa), Lituania e Ucraina (2 per ognuna), Bulgaria,
Romania, Lettonia ed Estonia (una per ciascuna).
I cechi contro Zeman. A Praga, nel pomeriggio del
29 aprile, dalle 10mila alle 20mila persone si sono date appuntamento in Piazza
Venceslao, teatro dello storico suicidio di Jan Palach, per dare vita ad una
protesta tanto sui generis quanto indicativa del clima nevrastenico che aleggia
in questa parte d’Europa. Il raduno, caratterizzato dall’elevata presenza di
bandiere europee, è stato allestito allo scopo di ottenere le dimissioni
dell’attuale presidente, Milos Zemon, che i dimostranti accusano di eccessiva
russofilia. Zeman, che non è nuovo a certe accuse – nonostante la Repubblica
Ceca aderisca al regime sanzionatorio e non abbia mai tentato di boicottarlo –,
è finito originariamente nell’occhio del ciclone a metà febbraio, perché
interessato ad aprire un tavolo negoziale con il Fondo russo per gli
investimenti diretti in relazione all’acquisto dello Sputnik V, ma la goccia che
ha fatto traboccare il viso, inondando d’acqua le strade di Praga, è stata la
posizione assunta nel merito del caso Vrbetice. Il presidente ceco, oltre ad
aver espresso dubbi circa la matrice russa delle due esplosioni, ha criticato
apertamente la decisione dell’esecutivo di dare il via ad una battaglia
diplomatica con il Cremlino, che in pochi giorni ha comportato il quasi
azzeramento delle attività presso l’ambasciata russa a Praga, e invitato la
popolazione a non cadere preda dell’isteria. Vani gli appelli alla calma e
controproducenti le elucubrazioni, perché il malcontento serpeggiante tra
opposizione e popolazione ha assunto la forma di un’avversione insopprimibile,
che il 29 aprile ha incoraggiato migliaia di cechi a prendere il controllo di
quella piazza da cui, suggestivamente, nel 1968 prese piede la primavera di
Praga.
Il silenzio franco-tedesco. Gli Stati-guida
dell’Ue stanno assistendo con fare circospetto all’evolvere della crisi
diplomatica tra l’Est e Mosca. Il disinteresse ai limiti dell’apatia dell’asse
franco-tedesco si spiega in termini di prudenza machiavellica: Berlino non può
sposare la nuova primavera di Praga per via del Nord Stream 2, nonché per lo
Sputnik V, mentre Parigi ha l’obbligo di mantenere una posizione defilata perché
intromettersi nella guerra delle spie e dei diplomatici equivarrebbe ad
autosabotare il concretamento dell’anelito macroniano di trasformare l’Eliseo
nel ponte tra Casa Bianca e Cremlino. Non sono da escludere a priori, comunque,
delle manifestazioni di lealtà, ricalcanti il modello Biot, più dirette a
rabbonire Washington che a solidarizzare con Praga. Le diplomazie francese e
tedesca vorrebbero intervenire per stemperare la tensione, anche perché
effettivamente in grado di esercitare del potere persuasivo sulla “Nuova
Europa”, ma tale interferenza non è, al momento, né possibile né auspicabile.
Perché questo ambiente, che il presidente ceco ha bollato come isterico – e le
proteste di piazza Venceslao ne sono la prova corroborante –, non è nato per
caso e non si fonda sull’aria: è funzionale, utile e necessario alla
preparazione della bilaterale tra Vladimir Putin e Joe Biden, allo stesso modo
della crisi nel Donbass e del nuovo ciclo di sanzioni da parte statunitense. In
estrema sintesi, crisi controllate, ritorsioni diplomatiche e punizioni
economiche convergono verso uno scopo comune, ossia la creazione di potere
negoziale, ed una meta condivisa, cioè la fine di questa fase transitoria della
nuova guerra fredda. Fase che, come avevamo preludiato sulle nostre colonne,
sarebbe stata connotata da “periodiche escalazioni calcolate e prove di fedeltà
all’ideale atlantista da parte degli alleati europei”.
Angelo Allegri per "il
Giornale" il 20 aprile 2021. Mosca, fine 1999: Vladimir Putin, da qualche mese
premier, è ospite di un ricevimento alla Lubyanka, storica sede dei servizi
segreti russi. Si festeggia la fondazione della Cheka, la polizia bolscevica. L'
uomo destinato di lì a pochi giorni a sostituire Eltsin alla presidenza e a
rimanere per decenni alla guida del Cremlino, è perfettamente a suo agio tra gli
ex colleghi e prende la parola per il brindisi ufficiale: «Cari compagni, voglio
subito riferirvi che il gruppo di agenti infiltrati nel governo ha svolto con
successo la prima parte della sua missione». Una risata generale accoglie la
boutade. È uno scherzo, ma non troppo, dice Mark Galeotti, professore e
ricercatore britannico, massimo esperto di servizi di sicurezza russi. Al di là
(...) (...) del suo passato di agente (e «non esistono ex agenti» è una frase
che gli viene, forse a torto, attribuita) Putin ha fatto dei servizi uno dei
pilastri del suo potere. Calibrando poteri e rivalità, competenze e
attribuzioni, ha dato loro perfino più potere che in epoca sovietica.
PCUS ADDIO In quel periodo a
tenere sotto controllo i servizi erano le varie articolazioni del partito
comunista e ogni reparto aveva il suo commissario politico, la cui rete
disegnava una linea di comando alternativa. Oggi il comando è uno solo e fa capo
direttamente al Cremlino, a Putin e al potente Nikolai Patrushev,
pietroburghese, ex numero uno del Fsb (ex Kgb) e dal 2008 segretario del
Consiglio di sicurezza della Federazione. Del potere e del ruolo degli uomini
della sicurezza Patrushev è il teorizzatore. In un discorso di qualche anno fa
diventato poi famoso descrisse gli agenti come la «nuova nobiltà» destinata a
guidare la Russia (l' espressione è poi diventata anche il titolo di un libro di
Andrei Soldatov, uno dei maggiori esperti del tema). Sotto la sua guida il mondo
dei «siloviki» (letteralmente: uomini della forza) ha assunto la struttura
attuale: cinque apparati principali, per un totale di almeno un milione di
uomini. Tra queste strutture l' ultima nata è stata di recente anche tra le più
impegnate: è la Guardia nazionale, conosciuta come Rosgvardia. Putin l' ha
creata e disegnata di suo pugno nel 2016, riunendo in una sola istituzione le
truppe del ministero dell' Interno nonché reparti speciali e anti-sommossa come
Omon e Sobr: poco meno di 400mila uomini (quattro volte gli effettivi dei
Carabinieri italiani) che hanno guidato la repressione delle recenti proteste
legate al ritorno in patria di Alexei Navalny. Ma l' attività di questo servizio
di sicurezza è più ampia: al corpo appartengono anche un' unità per le attività
cibernetiche e reparti, come la Divisione Dzerzinskij, che schierano in campo
perfino cannoni e carri armati. Rosgvardia è considerata la vera e propria
guardia pretoriana di Putin, che a comandarla ha voluto un «duro» che è anche un
fedelissimo, Viktor Zolotov, sua guardia del corpo personale sin dai tempi in
cui era vice sindaco di San Pietroburgo. Zolotov, che evidentemente ama i
simboli, ha acquisito dallo Stato scegliendola come residenza di famiglia, la
grandiosa dacia-palazzo nei dintorni di Mosca in cui hanno vissuto Felix
Dzerzinskij, il già citato fondatore della Cheka, e Anastas Mikoyan, politico
tra i protagonisti dell' era staliniana. L' altra agenzia di sicurezza poco
conosciuta in Occidente è il cosiddetto Fso, Servizio di protezione federale:
gestisce, come il nono direttorato del Kgb ai tempi dell' Unione Sovietica,
comunicazioni e sicurezza delle residenze ufficiali e degli uomini dell' élite
di potere. Proprio questa caratteristica ne fa un formidabile centro di
informazioni e pettegolezzi su abitudini e vizi dell' establishment. Non è un
caso che Putin inizi la sua giornata lavorativa leggendo il rapporto quotidiano
scritto dal Fso (è contenuto in una valigetta di cuoio insieme a quelli di Fsb e
Gru). Secondo alcune indiscrezioni, l' inquilino del Cremlino, sempre attento a
utilizzare le ambizioni dei diversi apparati della sicurezza come uno strumento
di controllo incrociato, ha di recente ampliato i suoi compiti nel campo dell'
intelligence, che si aggiungono a un altro incarico delicato da sempre affidato
al Fso, la custodia della valigetta con i codici nucleari.
TUTTI FANNO TUTTO Le altre tre
agenzie di sicurezza sono più note: Svr, Fsb e Gru. L' Svr (Sluzba vnesnej
razvedki, «Servizio di intelligence internazionale») è il classico servizio di
spionaggio estero simile alla Cia o al MI6 britannico. Qualche anno fa fece
rumore la scoperta da parte degli americani di una rete di spie inserite dallo
Svr ad alto livello nell' establishment Usa. La più nota tra loro, Anna Chapman,
venne scambiata con Serghey Skripal, doppio agente al servizio dell' Occidente,
scoperto e condannato in Russia e poi oggetto di un tentativo di avvelenamento
al novichok quando era esule in Inghilterra. Con un esempio di quelle
duplicazioni su cui si regge il sistema russo, i compiti dell' Svr si
sovrappongono almeno in parte con quelli del Gru (servizi di sicurezza delle
Forze armate): l' Svr si occupa per esempio anche di spionaggio scientifico,
tecnologico e industriale, materia contigua a quella coperta dallo spionaggio
militare. Del Svr fa parte anche una delle unità più segrete, la cosiddetta
Zaslon, la cui esistenza è stata più volte smentita (salvo poi essere
incongruamente confermata in altre occasioni). Si tratta di un reparto speciale
di 300/400 uomini super addestrati e super armati: come i loro colleghi delle
più famose unità Alpha e Vympel, gestite dal Fsb, sono in grado di affrontare le
missioni più pericolose e delicate. Secondo una serie di indiscrezioni
convergenti agli uomini della Zaslon è stata affidata la sicurezza della
famiglia Assad nei giorni in cui la continuità del loro dominio autocratico
sulla Siria sembrava messa in discussione.
«HACKERARE» È IL MIO
MESTIERE Il cuore del potere repressivo del Cremlino resta però come ovvio l'
Fsb, erede, sia come dimensioni (circa 400mila effettivi) sia come ampiezza di
compiti, del vecchio Kgb. Spazia dalla repressione interna (sono suoi uomini
quelli che hanno tentato di avvelenare l' oppositore Alexei Navalny), all'
intervento sul campo nella guerra in Ucraina, fino alla disinformazione e ai
tentativi di hackeraggio di governi e istituzioni internazionali. Se si eccettua
la repressione dell' opposizione interna molte di queste cose le fa anche il Gru
(Glavnoe razvedyvatel' noe upravlenie, direttorato principale per l'
informazione), che ufficialmente dipende dallo Stato Maggiore delle Forze
armate, ma che poi, per le operazioni più a rischio prende direttamente ordini
dal Cremlino. Erano ufficiali del Gru gli uomini che hanno assoldato l'
ufficiale della Marina arrestato poche settimane fa a Roma. Network ancora più
estesi gestiti sempre dal Gru sono stati scoperti di recente in Repubblica Ceca
e Bulgaria. Condotto (in maniera più che malaccorta) da ufficiali del Gru è
stato il già citato avvelenamento dell' ex agente del servizio Serghey Skripal.
Le glorie più recenti per gli agenti segreti che fanno capo alle Forze armate
vengono però dalla tecnologia. Da anni gli uomini del Gru e i confratelli del
Fsb si sono lanciati nel campo della guerra cibernetica, stringendo accordi con
le migliori università e i migliori licei del Paese specializzati in campo
matematico e informatico. Nel 2017 il ministro della Difesa Serghey Shoigu si
vantava di fronte alla Duma di poter schierare «truppe informative molto più
efficaci e potenti di quelle della vecchia contro-propaganda». Gli attacchi
cyber di gruppi come Apt28 Fancy Bear e Apt28 Cozy Bear (il primo fa capo al
Gru, il secondo al Fsb) hanno seminato il panico in mezzo mondo. Poi, certo, a
volte anche nelle unità più sofisticate si respira un' aria di trascuratezza da
vecchia Unione Sovietica. Dopo l' avvelenamento del «traditore» Skripal i
giornalisti internazionali che indagavano sulla vicenda furono aiutati da una
scoperta imprevista: ben 305 ufficiali del Gru sospettati di attività illegali
all' estero utilizzavano altrettante vetture registrate a un unico indirizzo: la
sede dell' unità per la guerra cibernetica del servizio segreto. Un' ingenuità
quasi da dilettanti.
Il ritorno delle spie bulgare: il gioco
oscuro che è duro a morire. Spie e segreti non
appartengono alla Guerra Fredda: sono ancora protagoniste dei nostri tempi e
continuano a "servire" in nome di ideologia e denaro. Le due cose che dall'alba
dei tempi stimolano sofisticati stratagemmi e trame intricate. Davide
Bartoccini - Lun, 12/04/2021 - su Il Giornale. Spia, colui o colei che
attraverso stratagemmi che prevedono l’inganno, la dissimulazione e la falsa
identità si impossessa d’informazioni coperte da segreti che appartengono a
rivali o nemici, per trarne vantaggi militari, politici o talvolta economici.
Sia per interesse personale che per quello del proprio Paese o mandante. Questa
è la definizione, a grandissime linee, di un’attività svolta da quando l’uomo ha
inventato la guerra. E che ha sempre influito, nelle sorti di essa, più della
guerra stessa. Molti di noi, scrittori o lettori, abbiamo imparato a conoscere
le spie attraverso romanzi e film; e quando parliamo di spy story, pensiamo
subito all’eterno confronto da Guerra fredda tra Cia e Kgb, o agli 007
britannici; pensando spesso che oramai sia storia passata. La verità invece è
ben diversa: le spie oggi sono più attive che mai, e spesso operano in teatri e
territori defilati, come gli stati baltici e quelli balcanici: ex satelliti di
Mosca che ora hanno accesso ai segreti militari che riguardano anche Washington,
dal momento che sono entrati a far parte della Nato. Ecco perché occupandoci di
spionaggio nell'attualità, torniamo a parlare della Bulgaria - vecchia alleata
di Mosca quale firmataria del Patto di Varsavia - ora diventata oggetto
d’interesse di una rete di spie - o meglio di talpe - che conoscendo i trucchi
del mestiere operavano ancora, a livello “amatoriale”, per fornire al Cremlino
informazioni militari trafugate dai palazzi governativi. Soprattutto dal
Ministero della Difesa bulgaro. Negli interessi dei sei agenti “in pensione”,
coordinati dall’ex colonnello settantenne Ivan Ivliev, c’erano quanti più
segreti potessero essere “rivelati”: dai documenti che riguardavano proprio la
Nato, gli Stati Uniti, l’Ucraina, la Bielorussia alle presenze di intelligence
straniere in loco: agenti della Cia, dell’Nsa e delle altre divisioni di
spionaggio internazionale. Del resto, se conosci il profilo di un operativo a
Sofia, domani lo riconosci anche se viene distaccato a Istanbul o a Berlino se
nessuno brucia la sua copertura. E troppe sono le possibilità di utilizzare una
“spia” avversaria a proprio vantaggio. Così la rete di spie gestita da “The
Resident” - nome in codice scelto per l’ex colonnello in pensione - ha passato
sotto compenso e per anni informazioni e resoconti all’ambasciata russa di
Sofia. Dove alcuni diplomatici conniventi - forse agenti in auge e sotto
copertura - li inviavano direttamente a Mosca. Questo almeno fino alle scorse
settimane, quando il controspionaggio bulgaro ha scoperto e arrestato le sei
talpe altolocate - compresa la moglie dell’ex colonnello, che si recava
regolarmente in ambasciata per consegnare plichi di documenti “classificati” e
ritirare il pagamento in dollari. La combriccola di nostalgici russofili, tutti
bulgari che hanno vissuto all’ombra della cortina di ferro e sono stati
addestrati a praticare lo spionaggio dai sovietici del Gru (il servizio
d’intelligence dell’Esercito russo) e del ben più noto Kgb (oggi Fsb, ndr),
contava tutti anziani signori ben inseriti nei palazzi del potere. Uno di loro
partecipava alla stesura del bilancio militare, dunque conosceva nel dettaglio,
probabilmente, informazioni sugli armamenti acquisiti e in via di acquisizione.
Un altro era attaché militare impegnato presso la cancelleria dei documenti
segreti per il parlamento, mentre un terzo era addirittura tra i responsabili
delle “strategie per contrastare le interferenze di Mosca” - che mantiene ancora
uno stretto rapporto con il Paese membro dell’Unione Europea. Ciò che ha
stupito, o più precisamente preoccupato, l’establishment bulgaro e i tutti
partner esteri è stata non solo la facilità con cui la rete del “residente”
operava senza troppi accorgimenti, ma la scoraggiante prova che ai piani alti
dei nuovi alleati Nato abbiano libero accesso, e per giunta pieni poteri,
elementi addestrati dagli specialisti della Lubjanka ai tempi di Bréžnev. Uomini
e donne tanto fedeli a Mosca da essersi occupati, in passato, dei “lavori
sporchi” di fronte ai quali anche gli agenti russi più talentuosi dovevano
passare la mano. Il rischio di essere svelati era troppo alto e le conseguenze
dirette avrebbero potuto innescare escalation pericolose. Due esempi
emblematici, riportati dall’esperta di questioni russe Anna Zafesova, sono
l'attentato a Giovanni Paolo II da parte del “lupo grigio” Alì Ağca, avvenuto
secondo molti su mandato dei servizi segreti bulgari che aveva tratto
ispirazione dai vertici sovietici; e l’omicidio dello scrittore dissidente
Georgiy Markov, assassinato a Londra con un ombrello modificato per sparare
pallini contenenti la Ricina - potente e letale citossina. Un’arma mai
ritrovata, a dire il vero, ma degna della più fervida fantasia di uno Ian
Fleming in grande spolvero. Questo scandalo ha dato un punto di vista
inquietante riguardo la possibilità di altre e ulteriori infiltrazioni che
possono verificarsi ad alto livello in potenze ora fedeli alla Nato, ma un tempo
amiche del Cremlino. La volontà di Mosca di entrare in possesso dei segreti dei
suoi “avversari teorici”, del resto, è sotto gli occhi di tutti e da diverso
tempo. Lo dimostra, tra le altre, l’ignominiosa condotta dell’ufficiale di
Marina che è stato intercettato dagli agenti del Ros mentre cedeva sotto
compenso informazioni a un diplomatico russo in missione a Roma. La Bulgaria,
come l’Italia, ha promesso come da consuetudine, dopo gli arresti, una serie di
espulsioni di diplomatici russi: su modello americano e britannico. Potenze che
si trovano regolarmente al centro di scandali di spionaggio, talvolta
orchestrati da vecchi doppiogiochisti ancora intenzionati a mettere a frutto i
vecchi trucchi del mestiere. Perché le spie non vanno mai in pensione. Anzi
spesso, nutrendo fino all’ultimo una profonda convinzione nei loro vecchi
ideali, preferiscono continuare il “gioco”. Sia perché è un ottimo modo per
sbarcare il lunario, sia perché si annoiano; sia perché non sanno rinunciare al
brivido. In attesa del loro epitaffio.
(ANSA il 5 aprile 2021) Il
presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che gli permette di
candidarsi altre due volte alla presidenza e dunque rimanere potenzialmente al
potere fino al 2036. La legge, modificata con il referendum costituzionale,
vieta a un presidente russo di rimanere in carica per più di due mandati.
Tuttavia questo non si applica a chiunque abbia ricoperto la presidenza prima
dell'entrata in vigore dei relativi emendamenti alla costituzione (in altre
parole, prima del 2020). Pertanto il presidente Vladimir Putin e l'ex presidente
Dmitry Medvedev possono candidarsi alla presidenza per altre due volte. Lo
riporta Meduza. (ANSA).
Roberto Fabbri per "Il Giornale" il 6 aprile 2021.
Sembra che Vladimir Putin non gradisca di sentirsi appiccicare addosso la
qualifica adulatoria di Zar. Il richiamo alla monarchia assoluta, per quanto
lusinghiero in un Paese che ha sempre avuto un debole per gli uomini forti,
disturba l'uomo venuto dal Kgb che ha sempre visto confermare la sua scalata al
potere da trionfali successi elettorali. Eppure, oggi che la sua firma è stata
apposta sotto il testo di una legge che lo autorizza di fatto a rimanere
presidente fino a quando avrà 84 anni, il richiamo al concetto di padre e
padrone di tutte le Russie si riaffaccia. Se davvero riuscirà a mantenersi
assiso sulla poltrona più dorata fino al 2036, avrà battuto perfino il record di
un altro padre e padrone, quello Stalin la cui sanguinaria memoria ha fatto
riabilitare riconoscendogli il ruolo di costruttore e difensore della grandezza
nazionale. Come si è arrivati ad attribuire a un uomo solo la possibilità di
dominare di fatto sulla Russia per 36 anni consecutivi? La procedura seguita
appare formalmente ineccepibile, ma è stato necessario fare ricorso a un trucco.
La legge firmata ieri dalla stessa persona che potrà approfittarne, è stata
varata dalla Duma dopo che i necessari emendamenti alla Costituzione erano stati
approvati a giugno con un referendum: essa stabilisce che vi sia un limite di
due mandati presidenziali, ma guarda caso prevede anche che nel conto non
vengano considerati i mandati già compiuti dal presidente in carica. Ecco dunque
che Putin potrà presentarsi ad altre due elezioni (nel 2024 e nel 2030),
puntando di fatto alla presidenza a vita. A ben vedere, con questo meccanismo
costruito su misura per le sue ambizioni, non punta tanto a esercitare il potere
fino a vecchiaia inoltrata: il suo disegno sembra piuttosto privilegiare una
garanzia di immunità a vita. La legge che il Parlamento dominato dal suo partito
nazionalista Russia Unita aveva approvato include infatti un comma di importanza
fondamentale, che esclude la possibilità di perseguire gli ex presidenti anche
per eventuali reati non commessi durante il mandato. Insomma, una botte di ferro
legale disegnata per impedire che, quando Putin lascerà prima o poi il potere,
possano aprirsi per lui le porte di un tribunale. Occasioni non ne
mancherebbero, se si pensa ai metodi non proprio cristallini con cui lo «zar» ha
arricchito se stesso e beneficato gli uomini della sua cerchia, i cosiddetti
«siloviki» provenienti in massima parte dal mondo inquietante dei servizi
segreti russi. Per non parlare dei numerosi «misteriosi» omicidi di cui sono
rimasti vittima in patria e all'estero personaggi del mondo economico, politico
e giornalistico che avevano osato sfidarlo: da Aleksandr Litvinenko ad Anna
Politkovskaja, da Boris Berezovsky a Boris Nemtsov solo per citare i più famosi
e senza dimenticare il caso clamoroso dell'avvelenamento di Aleksei Navalny,
attualmente ospite di un penitenziario in seguito a una sentenza palesemente
addomesticata. Navalny è l'uomo che è stato capace, attraverso le sue
implacabili denunce di corruzione a carico di Putin, del suo vice Dmitry
Medvedev e del loro «cerchio magico» di suscitare una volontà di opposizione
presso le classi più istruite e tantissimi giovani in Russia. Messi in galera
lui e i suoi collaboratori, lo «zar» ritiene di essersi garantito il futuro. Ma
il fatto che abbia preteso l'immunità a vita per legge la dice lunga su ciò che
davvero lo preoccupa. E proprio ieri Navalny è stato spostato nell'infermeria
del carcere con febbre alta e tosse, al quinto giorno di sciopero della fame. Si
sospetta tubercolosi. Ma il penitenziario smentisce.
Anna
Politkovskaja, la voce libera che il regime russo volle zittire. Sabrina
Pisu su l’Espresso il 6 ottobre 2021. Quindici anni fa l’omicidio della
giornalista che aveva denunciato i crimini del Cremlino. Il ricordo di Lana
Estemirova che allora aveva 12 anni, figlia di un’altra reporter sequestrata e
uccisa. "Anna e mia madre lavoravano insieme in Cecenia. Finché Putin è al
potere non ci sarà verità sulle loro morti”. «Anna è stata uccisa»: il viso di
Natalya Estemirova si fa bianco mentre ripete alla figlia Lana quello che le
hanno appena detto al telefono. Quattro parole che hanno il suono delle quattro
pallottole che quel giorno, il 7 ottobre del 2006, hanno fermato la vita della
collega e amica Politkovskaja. Istanti impressi nei ricordi di Lana Estemirova,
che aveva dodici anni: «Io e mia madre eravamo appena salite sull’autobus nel
centro di Grozny, tornavamo a casa quando è arrivata quella telefonata, aveva
gli occhi spalancati. Ha poi gridato all’autista di fermare l’autobus e siamo
scese, camminavamo, era sotto shock, in silenzio e io non sapevo cosa fare per
consolarla». Lana Estemirova sapeva che era pericoloso il lavoro che facevano
Anna Politkovskaja e sua madre, giornalista e attivista della Ong russa Memorial
in Cecenia, ma quell’omicidio ha trasformato quella preoccupazione in realtà.
Quel pomeriggio di
ottobre, Anna Politkovskaja, che aveva 48 anni, era andata con la sua automobile
al supermercato. Non era sola, una giovane donna e un uomo alto con il volto
coperto da un berretto da baseball la seguivano, come mostreranno dopo le
immagini di una delle telecamere di sorveglianza installate nel negozio. Al
ritorno, ha parcheggiato a pochi metri dall’ingresso del suo palazzo, ha preso
l’ascensore per portare i primi due sacchi fino al suo appartamento, al settimo
piano, e lasciarli davanti alla porta. È scesa poi a prendere il resto della
spesa ma quando al piano terra l'ascensore si è aperto, ad aspettarla c’erano
quattro proiettili. I primi vanno dritti nel cuore e nei polmoni, il terzo si
conficca nella spalla, con una potenza tale da scaraventarla dentro l'ascensore.
È partito, poi, il «kontrolnyi vystrel», il colpo di controllo, un proiettile in
testa sparato a pochi centimetri di distanza, perché la morte doveva essere
certa. L’assassino ha lasciato cadere a terra la pistola Makarov 9 mm. La morte
seguiva Anna, le minacce erano insistenti, lettere, telefonate ma questa paura,
o consapevolezza, non fermava la sua penna, precisa, concisa, inarrestabile e
feroce come quello che raccontava e denunciava nel piccolo quotidiano di
opposizione Novaya Gazeta di cui era corrispondente. Resoconti minuziosi degli
orrori commessi dalle forze russe e da quelle locali cecene nel corso della
seconda guerra in Cecenia, dichiarata da Putin, eletto presidente nel marzo del
2000, e chiamata ufficialmente «operazione antiterrorista nel Caucaso del nord».
Esecuzioni di massa, sequestri, torture, incendi, uccisioni indistinte in nome
della «lotta contro il terrorismo». «Mia madre ed Anna si sono conosciute nel
1999, all’inizio della seconda guerra in Cecenia, mia madre lavorava spesso come
fixer (base sul campo di lavoro, ndr) per lei e Anna quando veniva a Grozny
stava sempre a casa nostra, andavano a fare visita alle vittime, nelle zone in
cui c’erano state le operazioni di rastrellamento delle forze militari russe,
lavoravano anche tutta la notte nel nostro appartamento che all’epoca non aveva
acqua corrente e poca elettricità. Erano un team incredibile ed erano grandi
amiche», racconta Lana Estemirova. «Ero molto felice ogni volta che Anna veniva,
era una persona molto seria e un po’ austera, ma anche con un grande senso
dell’umorismo. Mi portava sempre un libro, li ho ancora con me», continua Lana
Estemirova che della Politkovskaja ricorda «umanità, talento, compassione,
tenacia, gentilezza e coraggio. È stata molto più di una giornalista, è stata
un’attivista, una negoziatrice, un simbolo di speranza per le persone». Una
fonte di ispirazione: «Lo è stata per me, perché ha salvato vite umane, si è
fatta carico del dolore delle persone come se fosse stato il proprio», dice Lana
Estemirova che lavora per la fondazione Justice for Journalist ed è autrice del
podcast Trouble with the True dove dà voce ai cronisti coraggiosi nel mondo.
Anna Politkovskaja annottava ogni cosa, «tutti i particolari che posso»,
documenti, drammi di madri a cui avevano ucciso figli innocenti - «madri
considerate fortunate quando riottengono il corpo del loro figlio. Pazienza se è
deturpato, se lo hanno crivellato di colpi», scriveva riportando con precisione
le loro accuse e richieste di giustizia con la speranza di restituire loro la
dignità, il rispetto calpestato, un anelito di vita. E, quindi, fare dei suoi
scritti delle prove per incriminare i responsabili di quella guerra «che
annienta quanto c’è di vivo nell’anima di chi è ancora vivo». Anna Politkovskaja
conosceva bene le rimozioni della storia, il silenzio che spesso si fa cadere e,
che come scriveva, «non può essere un caso» come era successo alla prima guerra
Cecena. Non c’era un confine tra la vita e la professione, e questo è tutto
dentro una delle sue più note dichiarazioni: «Io vivo la mia vita, e scrivo ciò
che vedo». E la sua vita era non solo vedere e scrivere ma anche trasformare
quelle parole in azioni concrete per aiutare le vittime. Lo ha fatto nel
dicembre del 1999 quando, sotto le bombe, ha tenuto per mano gli anziani per
farli uscire dall’ospizio abbandonato di Grozny, capitale della Cecenia, e
mettendone in salvo 89. E nel 2002 quando ha trattato la liberazione di alcuni
ostaggi rimasti, dal 23 al 26 ottobre, in mano a un commando di una cinquantina
di terroristi ceceni che avevano preso d'assalto il teatro della Dubrovka a
Mosca. «Sono rassegnati a morire e lo dicono, faccio fatica ad accettarlo», dice
alle telecamere interrompendo subito chi continuava a farle domande. «Non
perdiamo tempo, dobbiamo portare acqua agli ostaggi». «Non perdiamo tempo», ma
l'irruzione delle forze speciali russe manda all’aria il suo negoziato, 130
ostaggi perdono la vita soprattutto a causa dei gas utilizzati dalle forze
speciali. Era pronta a negoziare anche nel 2004 quando si stava recando a
Beslan, nell’Ossezia del Nord, dove i terroristi avevano sequestrato una scuola
e preso centinaia di ostaggi, perlopiù bambini. Un tè bevuto sull’aereo la fa
stare molto male e all’atterraggio a Rostov viene ricoverata d’urgenza in
ospedale, il giorno dopo viene trasportata in aereo a Mosca per le cure. Un
tentativo di avvelenamento, i risultati dei suoi esami del sangue che
scompaiono: lei era sicura che fossero stati i servizi segreti russi. Prima di
morire stava preparando un articolo sulle torture praticate da una sezione delle
forze di sicurezza cecene legate al primo ministro Ramzan Kadyrov, fedele di
Putin. Ne aveva parlato a Radio Svodoba due giorni prima di essere uccisa: «Sto
conducendo un’inchiesta. Riguarda le torture perpetrate nelle prigioni segrete
di Kadyrov oggi e nel passato. Persone che sono state sequestrate dagli uomini
di Kadyrov senza alcuna giustificazione. Ho un solo sogno personale nel giorno
del compleanno di Kadyrov. Sogno che sieda sul tavolo degli imputati». Il suo
sogno non si è realizzato, non ancora. Perché i fatti sono tutti lì, messi in
fila da Anna Politkovskaja. Ed è per questo che dopo la sua morte, l’amica e
collega Natalaja Estemirova invece di fermarsi, ha sentito il dovere di fare di
più: «Ha raddoppiato l’impegno, ha sentito di dover raccogliere la sua eredità e
continuare a denunciare quei crimini». Quel patto con Anna Politkovskaja, e con
la verità, è costato la vita a Natalya Estemirova, uccisa il 15 luglio del 2009:
«L’hanno rapita a casa, mentre io dormivo, non me ne sono accorta. Quando mi
sono svegliata credevo fosse andata in ufficio, le ho telefonato ma non
rispondeva, sono andata a cercarla lì, dicendo ai colleghi che non rispondeva»,
ricorda sua figlia. Il suo corpo crivellato di colpi è stato trovato in un bosco
nei pressi della città di Nazran, in Inguscenzia. Anna e Natalya erano nel
mirino del presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, fedele di Putin: «Il
presidente Ramzan Kadyrov aveva minacciato personalmente sia Anna che mia madre
che per proteggermi mi ha mandato via: l’ultimo anno della sua vita sono stata
fuori dalla Cecenia, a casa di alcuni zii, senza poterla vedere, è stato
doloroso». La morte della Politkovskaja è «un omicidio politico», «una punizione
per i suoi articoli», non hanno mai avuto dubbi i colleghi di Novaya Gazeta. Ma
nel 2014, dopo otto anni e tre processi, la giuria popolare del tribunale di
Mosca ha dichiarato colpevoli della sua morte solo i sicari ceceni ma non ha
individuato i mandanti. Per Natalaja Estemirova, invece, nessuno ha ancora
pagato e dopo la sua morte, visto l’alto rischio per gli altri attivisti, la Ong
Memorial è stata chiusa. Sono 58 i giornalisti uccisi in Russia dal 1992 al
2021, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ). «In Russia
dire la verità e difendere i diritti umani è ancora pericoloso, non c’è la
volontà di fare chiarezza su questi omicidi», dice Natalia Zviagina, direttrice
degli uffici di Amnesty a Mosca. «Il Cremlino sta usando la legge repressiva
sugli “agenti stranieri” contro i media indipendenti decimando il giornalismo
investigativo e imparziale nel paese», continua Natalia Zviagina in riferimento
alla legge promulgata nel 2019 da Putin che estende lo status di «agenti
stranieri» anche ai giornalisti indipendenti che devono comunicare al ministero
della Giustizia russo i dati personali dei dirigenti, la contabilità finanziaria
e le revisioni contabili. È reato il mancato rispetto di questi requisiti, con
pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e la reclusione fino a sei anni. «È
una nuova forma di minaccia, molto pericolosa», commenta la direttrice degli
uffici di Amnesty a Mosca, anche lei più volte minacciata per la sua attività.
Ogni anno, nel giorno della morte della Politkovskaja, una folla depone fiori
davanti al suo portone: «Un gesto dal grande valore simbolico, nello stesso
giorno del compleanno di Putin. La richiesta di giustizia è ora un’azione
pubblica, civile com’è stata la sua attività, che andava ben oltre l’essere una
giornalista», dice Natalia Zviagina. «Fino a quando Putin sarà al potere non ci
sarà giustizia per Anna, mia madre e tanti altri. Quando il suo regime finirà
tante verità fino a ora nascoste verranno fuori», è la convinzione di Lana
Estemirova. Intanto in Cecenia, dove, come scriveva la Politkovskaja, «il
baratro tra ciò che è palese e ciò che è segreto sta aumentando sempre di più»,
l’orrore non è finito: «Ci sono ancora torture, rapimenti, omicidi solo che sono
tenuti più nascosti e dietro le porte chiuse ci sono ancora prigioni segrete con
macchie di sangue sui muri. È una verità scomoda sulla quale l’Europa, e
l’Occidente in generale, dovrebbe riflettere», dice Lana Estemirova. L’odio era
quello che Anna Politkovskaja temeva più di qualunque altra cosa: «Si accumula
sempre di più ed è fuori controllo». Un odio che ha documentato e pagato,
trattata prima come una «pazza» e «reietta» e poi uccisa. Ma, ancora oggi, a chi
le avrebbe chiesto di lasciar perdere, lei direbbe: «Come potrei vivere con me
stessa se non scrivessi la verità?».
Come Pietro I o Nicola II? Ecco per cosa
verrà ricordato Putin. Emanuel Pietrobon, Paolo Mauri
si Inside Over il 28 marzo 2021. Vladimir Putin è colui che ha assunto il potere
all’apice della stagione di turbolenze sociali ed economiche che scossero
la Federazione russa a cavallo fra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli
anni Duemila. A lui il merito di aver salvato il Caucaso settentrionale e la
regione del Volga dalla deflagrazione, ponendo fine ad un decennio di insurgenza
e terrorismo, di aver riportato l’economia sul viale della crescita e,
soprattutto, di aver reintrodotto la Russia nell’alveo dei grandi protagonisti
delle relazioni internazionali. Figura tanto affascinante quanto divisiva anche
all’interno della stessa Russia, Putin verrà ricordato dai posteri per una
moltitudine di ragioni: da quelle menzionate poc’anzi all’aver restituito Mosca
al proprio legittimo destino, cioè quello di essere la Terza Roma, passando per
l’onere di aver dovuto affrontare il risveglio dal sonno della guerra fredda con
l’Occidente. In quest’ultimo caso, a lui il riconoscimento per aver evitato che
la Siria della famiglia Assad e il Venezuela di Nicolas Maduro seguissero il
fato dell’Iraq di Saddam Hussein e della Libia di Mu’ammar Gheddafi, ma a lui
anche una serie di gravi responsabilità: dalla “perdita” dell’Ucraina alla
caduta del monopolio russo sull’intero spazio postsovietico. Numeri e fatti
dissonanti alla mano, la domanda sorge spontanea: Putin, già soprannominato “lo
zar” dalla grande stampa occidentale, verrà ricordato dai posteri come un padre
fondatore alla Pietro il Grande o come una vittima del fato alla Alessandro II?
Nell’impossibilità di prevedere il futuro, cerchiamo di apprendere dal passato e
di leggere il presente: questo è quanto accaduto durante l’era Putin tra Ucraina
e Moldavia.
Il prezzo della Crimea. Sull’Ucraina, più volte al
centro della cronaca per via dei conflitti nel Donbass e per la Crimea, è stato
scritto tanto, e spesso con occhi filtrati dall’ideologia. Cercheremo di dare un
quadro generale per spiegare perché la Russia ha fondamentalmente già perso quel
Paese pur avendo inferto due duri colpi, seppure con esiti opposti. Tutto
cominciò con la cosiddetta Rivoluzione Arancione del 2004, che si originò anche
per via delle fragili condizioni politiche ed economiche dell’Ucraina di quel
tempo. Il risultato delle elezioni, avvenute quell’anno, che videro Viktor
Yanukovych, filorusso, vincitore, vennero duramente contestate con l’accusa di
brogli. Questa frode elettorale spinse Viktor Yuschenko, l’altro candidato e
filoeuropeo, a chiedere ai propri sostenitori di scendere in piazza e
protestare. Le violenti proteste portarono a nuove elezioni che, nel dicembre
2005, sancirono la vittoria di Yuschenko. In questo modo l’Ucraina si avvicinò
all’Europa, tanto da volerne chiedere l’adesione, e soprattutto alla Nato. Ma
Yanukovych, sostenuto palesemente da Mosca, non era ancora fuori dai giochi.
Nelle elezioni presidenziali del 2010 ottenne la vittoria contro Yulia
Timoshenko (anche lei una “rivoluzionaria arancione”), che venne arrestata un
anno dopo con l’accusa di abuso di potere per uno scandalo coinvolgente Gazprom.
Yanukovych chiarì subito la sua linea filorussa: l’Ucraina abbandonò i piani di
adesione a Nato ed Unione Europea. Nel 2013, la popolazione, sobillata anche qui
da agenti esterni, scese nuovamente in piazza manifestando a favore dell’Europa
e contro l’amministrazione Yanukovych. Il governo cercò di arginare le rivolte
emanando un pacchetto legislativo composto da 12 leggi, cosiddette
anti-protesta, ma ormai si era scatenato un meccanismo perverso che condusse, a
febbraio 2014, ad una vera e propria rivolta: Euromaidan. La sommossa,
sanguinosa e con la presenza di fazioni estremiste, non fu vana: le leggi
anti-protesta furono rimosse e il presidente Yanukovych lasciò il Paese. Le
nuove elezioni del maggio 2014 videro vincitore Petro Poroshenko, che riprese
una posizione molto più prona all’Occidente riaprendo nel contempo alla
possibilità di adesione alla Nato. Davanti a questa possibilità il Cremlino agì
prontamente per cercare di mettere al sicuro quello che restava dei suoi
interessi strategici nel Paese, ovvero la base navale di Sebastopoli. Sempre nel
2014, e con un colpo di mano magistrale, la Russia mette in pratica la dottrina
Gerasimov sulla guerra ibrida e con un’invasione “non ufficiale” (ricorderete i
famosi “omini verdi”, anche definiti “gentili”) preceduta e affiancata da una
massiccia campagna di conquista “dei cuori e delle menti” che ha utilizzato per
la prima volta anche gli strumenti di comunicazione di massa online, si
impadronisce manu militari della penisola di Crimea. Effettuato il putsch, le
autorità locali (filorusse) decisero di indire un referendum
sull’autodeterminazione della penisola e la conseguente scissione dall’Ucraina.
Il referendum rispecchiò la volontà popolare (secondo le fonti russe più del 96%
della popolazione votò per l’annessione alla Russia), ma non venne riconosciuto
dalla maggior parte della comunità internazionale. Come atto finale di questa
operazione di estensione territoriale, il 18 marzo 2014, la Repubblica di Crimea
e la Federazione Russa firmarono il trattato per l’annessione della penisola
alla Federazione. Il giorno dopo, le forze armate ucraine vennero ritirate dalla
penisola, segnale indicativo del fatto che il processo non poteva più essere
fermato. Oggi, il territorio è definito della Federazione come “circondario
federale di Crimea”, costituito dalla Repubblica di Crimea e dalla città
federale di Sebastopoli.
La questione Donbass. Se la Crimea è stato un
colpo magistrale, così non lo è stato il Donbass. Qui il meccanismo messo in
atto per la prima volta nella penisola si inceppa, e le regioni di Donetsk e
Lugansk, nonostante si siano successivamente autoproclamate repubbliche
autonome, continuano a restare legate al governo di Kiev, che non ha affatto
ritirato il suo strumento militare come ha fatto in Crimea. In Donbass,
nonostante anche qui la Russia sia intervenuta prima in modo non ufficiale poi
quasi apertamente (anche se inizialmente mandando avanti i “contractor”
del gruppo Wagner), ci sono stati e continuano ad esserci combattimenti tra le
due fazioni, cosa che non è avvenuta in Crimea: Kiev, da questo punto di vista,
ha “imparato la lezione” e non ha commesso lo stesso errore due volte, sebbene
la situazione nella regione possa definirsi di completo stallo, in quando gli
accordi di Minsk, che prevedono il cessate il fuoco e la definizione di una road
map per la risoluzione del conflitto, sono ad un punto morto. Qui le ostilità
cominciano poco più un mese dopo gli avvenimenti in Crimea, il 6 aprile 2014,
quando le forze armate separatiste, supportate dal governo russo, occuparono le
istituzioni locali delle regioni di Donetsk, Lugansk e Karkiv. L’occupazione
venne preceduta da proteste popolari pro-Russia, abilmente orchestrate dal
Cremlino, che così facendo credeva che Kiev, ancora alle prese con lo shock per
la Crimea, non sarebbe stata capace di “parare il colpo”. L’oblast di Donetsk fu
proclamato Repubblica Popolare il 7 aprile, mentre quello di Lugansk il 27,
ottenendo entrambi l’indipendenza (anche qui non riconosciuta) l’11 maggio con
un referendum. La risposta militare ucraina, inizialmente inefficace, diventa
più decisa col passare del tempo tanto da suscitare l’intervento russo, sino a
giungere ad una situazione di stallo militare che porta ai già citati e
inefficaci accordi di Minsk. L’aggressione russa – perché tale è stata –, se
possibile, ha spinto ancora di più l’Ucraina nelle braccia della Nato, che oggi
ha ottenuto uno status simile a quello della Georgia di “osservato speciale” per
il suo ingresso nell’Alleanza, ma, per assurdo, proprio l’attuale situazione di
conflitto irrisolto nel Donbass è l’ostacolo maggiore verso questa prospettiva:
un conflitto aperto, sebbene “congelato”, è contrario ai requisiti per
l’ammissione (che spaziano anche sino alla stabilità del regime democratico), e
pertanto, paradossalmente, Mosca potrebbe avere più interesse a mantenere questo
status quo che a risolvere la questione del Donbass. L’Ucraina, infatti, al pari
della Georgia, è ormai persa: la Russia infatti non ha “guadagnato” la Crimea,
ma ha perso il Paese che storicamente rappresenta la sua porta di ingresso
meridionale, per questioni prettamente geografiche. Basta dare uno sguardo ad
una mappa per notare che dal confine con la Polonia sino a quello con la Russia,
passando per Kiev e Karkiv, il territorio è quasi del tutto pianeggiante con la
presenza di un solo ostacolo naturale, rappresentato dal fiume Dnepr. Un
ostacolo che non è servito a frenare le divisioni corazzate tedesche durante la
Seconda Guerra Mondiale, peraltro, ed i russi se lo ricordano ancora
perfettamente. Nella mente degli inquilini del Cremlino, sin dai tempi degli
Zar, questa particolare problematica era ben viva: la Russia, infatti, per
difendere i suoi confini occidentali, proprio per l’assenza di barriere naturali
non ha, storicamente, potuto far altro che espanderli per cercare di frapporre
più “terreno” possibile tra Mosca ed i territori “al di qua” degli Urali – cuore
pulsante della Russia – ed un nemico invasore.
La questione Moldavia. Il 2020 è stato l’anno
della svolta per la piccola ma pivotale Moldavia, uno storico avamposto del
Cremlino che, complici la fine della guerra fredda e l’albeggiare dell’epoca
multipolare, ha assunto la forma di un huntingtoniano stato in bilico (a metà
tra Occidente, Russia e Turchia) il cui fato sembra essere quello dell’ingresso
nel campo occidentale. La rilevanza di questo piccolo Paese incuneato
tra Romania e Ucraina è data da tre elementi: la posizione geostrategica, la
presenza di minoranze strumentalizzabili per minare la stabilità regionale e,
infine, l’essere un punto di snodo centrale per i traffici leciti e illeciti che
avvengono tra l’estrema periferia orientale dell’Unione Europea e lo spazio
postsovietico. Avere il controllo dei punti caldi del Paese, come
la Transnistria e la Gagauzia, equivale a possedere una leva funzionale al
condizionamento della politica domestica ed estera del governo centrale; perciò
la Russia ha stabilito una presenza nella prima regione e la Turchia ha
costruito una sfera d’influenza sulla seconda. La Russia sta perdendo il
controllo della Moldavia perché, molto semplicemente, si è ritrovata ad aver
affrontare una competizione modellata sul “tutti contro uno” che vede il
coinvolgimento di Romania, Turchia, Stati Uniti, Germania e organizzazioni
internazionali come Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Bucarest sta provando ad accelerare il processo d’integrazione del proprio
vicino nell’Ue tramite lobbismo, diplomazia ed economia e, soprattutto, sta
investendo in cultura, cooperazione allo sviluppo e istruzione con il duplice
obiettivo di derussificare la popolazione e incoraggiare le nuove generazioni a
sposare l’idea della rumenosfera, ossia della Grande Romania. Bruxelles e
Washington, invece, hanno ridotto a livelli critici la dipendenza di Chișinău da
Mosca a mezzo di accordi commerciali, investimenti, maxi-prestiti e grandi
opere. I più importanti traguardi delle due potenze sono stati tagliati l’anno
scorso e sono, rispettivamente, la realizzazione del
gasdotto Iași-Ungheni-Chișinău e l’intercessione presso il FMI ai fini dello
sblocco e dell’invio di un maxi-prestito da oltre 200 milioni di dollari al
governo moldavo. La questione dello Iași-Ungheni-Chișinău è meritevole di
ulteriore approfondimento. Lungo centoventi chilometri e realizzato con il
contributo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), il
gasdotto è stato progettato con l’obiettivo specifico di emancipare la Moldavia
dal gas russo ed è stato inaugurato lo scorso agosto. Il canale di trasporto,
ampiamente pubblicizzato da Chișinău come il salvavita che entrerà in funzione
“in caso di problemi sulla rotta tradizionale”, ossia la rete della Gazprom, è
in grado di soddisfare fino al 75% del fabbisogno medio moldavo e transnistriano
e fino al 60% del loro consumo medio durante i mesi freddi. Vi sono, infine,
Berlino, che ha investito e sta investendo nel settore idrico moldavo più di
ogni altra nazione al mondo, facendo dell’acqua un instrumentum regni con il
quale ritagliarsi una sfera d’influenza all’interno del Paese, e Ankara, il cui
dinamismo irrefrenabile ha condotto al conseguimento di risultati di rilievo sia
a Chișinău che a Comrat, capoluogo della Gagauzia. Oggi, 2021, la Turchia è il
settimo investitore ed il settimo partner commerciale della Moldavia e
contribuisce in maniera significativa alla produzione del benessere e alla
vitalità del mercato del lavoro per via della presenza sul territorio di
circa 1.200 imprese. La Sublime Porta, inoltre, ha giocato un ruolo da
coprotagonista nella guerra degli aiuti sanitari combattutasi in Moldavia,
posizionandosi dietro a Russia e Cina per quanto riguarda l’impegno complessivo
ma troneggiando in una regione: la Gagauzia. Nominata oramai per la terza volta,
è giunto il momento di spiegare brevemente che cosa sia la Gagauzia. Trattasi di
una regione autonoma della repubblica moldava abitata dai gagauzi, un popolo
turcico ivi stanziatosi tra il 12esimo e il 13esimo secolo, dalla quale ebbe
inizio la breve stagione di separatismo che colpì la nazione all’indomani del
collasso dell’Unione Sovietica. Le autorità gagauze, infatti, dichiararono la
propria indipendenza nell’agosto 1991 – ossia un mese prima che la più celebre
Transnistria facesse lo stesso – salvo poi abbandonare l’agenda secessionista in
cambio di una vasta autonomia. Un riepilogo della due-giorni in Moldavia dello
scorso agosto dell’influente ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, può
essere utile a comprendere quanto sia marcata la presenza della Sublime Porta in
questo stato in bilico. Il primo giorno di lavoro era stato utilizzato per
partecipare al primo incontro del Gruppo congiunto per la pianificazione
strategica – uno dei frutti maturati dall’elevazione dei rapporti bilaterali al
livello di partenariato strategico –, e il secondo era stato impiegato per
prendere parte all’attesissima inaugurazione del consolato turco a Comrat, la
cui realizzazione era stata chiesta a gran voce dalla popolazione. Perché
l’inaugurazione di un consolato dovrebbe essere importante? Il punto è che la
Gagauzia è stata a lungo un feudo russo al pari della Transnistria, ma la
situazione è cambiata radicalmente da quando Recep Tayyip Erdogan ha deciso di
darle priorità all’interno della propria agenda estera, istruendo l’Agenzia
Turca per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale (TIKA) affinché si
occupasse di riscriverne la mappa urbana, dei servizi e delle infrastrutture.
Qui la Tika ha costruito nuove scuole, ospedali e strade, rinnovato interi
quartieri, contribuito ad incrementare l’accesso della popolazione all’acqua e
all’elettricità e, ultimo ma non meno importante, ha dato impeto ad un processo
di nazionalizzazione delle masse basato sulla somministrazione di corsi di
lingua gagauza e sulla promozione di iniziative e programmi culturali miranti ad
instillare negli abitanti la convinzione che siano parte integrante del mondo
turco. In sintesi, la questione Transnistria si è rivelata utile a rallentare
l’inglobamento della Moldavia nella sfera d’influenza euroamericana, ma il
congelamento in toto del processo non è stato possibile e la sequela di eventi
dell’anno passato ne è la dimostrazione. Perché il 2020 è stato l’anno del
gasdotto Iași-Ungheni-Chișinău, del consolato turco a Comrat, dell’attivismo
statunitense e della diplomazia idrica tedesca, ma è stato, anche e soprattutto,
l’anno dello storico insediamento alla presidenza di una europeista, Maia Sandu,
la cui vittoria ha assestato un colpo quasi letale al sistema di potere ruotante
attorno al socialista e filorusso Igor Dodon.
Angelo Allegri per “il Giornale” il 19 marzo 2021.
«Putin sembra molto stanco. Vent' anni di potere sono un tempo lunghissimo in un
Paese come la Russia, dove gli intrighi politici e le pugnalate alle spalle sono
all' ordine del giorno. Gli piacerebbe dare le dimissioni, ma né lui né il
circolo di persone che gli sono più vicine se lo possono permettere». Catherine
Belton, giornalista del team investigativo dell' agenzia Reuters, ha appena
pubblicato in Italia «Gli uomini di Putin» (La nave di Teseo). È il frutto di 15
anni passati a Mosca, dove la Belton ha lavorato tra l' altro come
corrispondente per il Financial Times e per Business Week.
In che senso non possono permettersi le
dimissioni?
«Gli uomini del suo entourage potrebbero essere
chiamati a rispondere di quanto fatto in questi anni. E stiamo parlando di
crimini e reati. Per il libro ho parlato con una delle persone più vicine a
Putin: già nel 2012 avrebbe preferito rimanere sullo sfondo e non tornare alla
presidenza, ma fu spinto a farlo dal suo circolo più ristretto, perché Medvedev,
che per quattro anni lo aveva sostituito, stava facendo salire alla ribalta i
suoi uomini».
La novità comunque è il linguaggio di Biden, ben
diverso da quello del suo coinquilino alla Casa Bianca, Obama.
«L' amministrazione Obama ha aperto la porta all'
influenza russa nel mondo. La sua volontà di «resettare» il rapporto con Mosca
su toni più soft si è rivelata comodissima per Putin. Che infatti ne ha tratto
grande profitto. Basti pensare alla Siria, lasciata a disposizione dei russi. O
all' attività di infiltrazione nelle istituzioni occidentali grazie a soldi e
corruzione. L' Occidente ha mostrato una compiacenza fuori luogo nel pensare che
la Russia andava trattata come uno scolaretto cattivo ma che non era pericolosa
perché debole. È vero, ma fino a un certo punto».
Che cosa intende?
«L' economia russa è debole, ma il regime di Putin
può usare grandi quantità di contante sparso per il mondo in società offshore di
cui ha il controllo e che può impiegare anche per influenzare la politica.
Quanto al linguaggio di Biden sotto certi aspetti per Putin è più comprensibile,
ma un ambiente ostile renderà più difficile ai russi perseguire i propri
obiettivi. E sul lungo periodo avrà influenza anche sull' atteggiamento dei
russi, che sono sempre più stanchi degli atteggiamenti anti-occidentali».
Ma il consenso per il presidente resta alto.
«È abbastanza vero ma solo se si resta alla
superficie. E non è un caso che al Cremlino siano tanto nervosi e abbiano
reagito in maniera cosi pesante contro il principale oppositore, Navalny. È
vero, per esempio che i rating di quest' ultimo non sono saliti e sono intorno
al 20% da settembre. Ma tra i giovani sono molto più alti, fino al 50/60%. In
più la popolarità di Putin è ai livelli più bassi dal 2014, prima dell'
annessione della Crimea. Per questo le manifestazioni di piazza in Bielorussia o
quelle dell' estremo oriente russo, nella zona di Khabarovsk, hanno fatto così
paura. In settembre ci sono le elezioni politiche: le previsioni di voto per il
partito di Putin, Russia Unita, sono al minimo storico e a malapena raggiungono
il 30%. Potranno mantenere la maggioranza solo con il ricorso a massicce frodi
elettorali».
Ma un attacco così duro come quello di Biden non
rischia di provocare un riflesso patriottico a favore del Cremlino?
«Sul breve periodo forse. Ma, come dicevo, i
sondaggi dimostrano che buona parte dei russi ha un atteggiamento
pro-occidentale. Sono stanchi del continuo confronto. Temono i minori
investimenti, il peggioramento delle sanzioni. Negli ultimi 8 anni il reddito
disponibile è diminuito del 10%. Qualche diversivo in politica estera è
possibile, ma alla fine conterà il tenore di vita della gente, che è sempre più
basso».
Giuseppe D'Amato per “il Messaggero” il 21 ottobre
2021. Ad Aleksej Navalnyj ora il premio Sakharov 2021 del Parlamento europeo;
dodici giorni fa al giornalista di opposizione, Dmitrij Muratov, il primo Nobel
per la pace. L'Occidente pare aver decisamente mutato rotta nei suoi legami con
la Russia di Vladimir Putin. Se negli anni passati, dopo lo scoppio della crisi
ucraina nel 2014, si è tentato di evitare qualsiasi tipo di confronto o scontro
col Cremlino adesso a Bruxelles, a Washington e a Oslo si è passati al
contrattacco.
LE MINACCE
Nel mezzo di questi 12 complicati giorni otto
diplomatici russi sono stati cacciati dalla Nato e, per risposta, Mosca ha
chiuso o fatto chiudere le rispettive missioni di rappresentanza, mentre sono
volate tra le leadership accuse di uso delle materie prime (leggasi gas) come
arma geopolitica. Il barometro dei rapporti tra Occidente e Russia è, in
sintesi, fermo sulla voce buriana.
LIBERTÀ DI PENSIERO
Come era nelle attese della vigilia, Aleksej
Navalnyj, acerrimo oppositore del presidente russo, si è così aggiudicato la più
alta onorificenza Ue in campo della difesa dei diritti dell'uomo, precedendo le
donne afghane anti-talebane e Jeanine Anez, ex capo di Stato della Bolivia,
adesso in carcere con l'accusa di aver organizzato un golpe nel 2019. Questo
premio, dedicato al dissidente sovietico, il fisico russo Sakharov, rappresenta
dal 1988 il più importante riconoscimento continentale per chi lotta per la
libertà di pensiero e di espressione.Attualmente Navalnyj, uno dei punti di
riferimento delle composite opposizioni russe, sta scontando una condanna a due
anni e mezzo di reclusione per aver violato la libertà vigilata, concessagli nel
2014, mentre si trovava l'anno scorso in Germania per curarsi da un
avvelenamento con un agente nervino. Per la sua liberazione, nei mesi scorsi,
accorati appelli sono stati lanciati da vari capi di Stato occidentali, tra i
quali il presidente Usa, Joe Biden, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. La
Corte di Strasburgo ha definito la sentenza di reclusione contro il dissidente
russo «sproporzionata».
VITTORIA DELLA VERITÁ
«È la vittoria della verità», hanno commentato
numerosi simpatizzanti e dirigenti del movimento che fa capo a Navalnyj, molti
dei quali riparati all'estero. «Il premio Sakharov è un riconoscimento a tutti
voi, a tutte le persone che non sono indifferenti, a quanti anche nei tempi più
cupi non sono impauriti nel dire la verità», ha scritto FBK, la Fondazione
anti-corruzione, facente capo all'oppositore anti-Cremlino, che negli anni
passati ha condotto inchieste e pubblicato video contro le élite federali e
quelle regionali. Di recente il movimento vicino a Navalnyj ha ricevuto la
definizione giuridica di estremista e i suoi membri, passati e presenti, non
hanno così potuto candidarsi alle ultime legislative, tenutesi il 18 settembre.
La ricerca voto intelligente, proposto agli elettori dal dissidente contro il
partito del Cremlino, è stato bloccato in Russia il mese scorso su Internet.
Aleksej Navalnyj era uno dei candidati anche al premio Nobel per la pace,
assegnato invece a sorpresa da Oslo al direttore del foglio di opposizione
Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov. Probabilmente, in dicembre, sarà la moglie del
dissidente incarcerato a ritirare a Strasburgo l'alta onorificenza continentale.
L'anno scorso il premio Sakharov era stato assegnato all'opposizione bielorussa,
scesa in strada a protestare contro i brogli alle presidenziali di agosto, e nel
2018 al regista ucraino Oleg Sentsov, condannato da un tribunale russo a 20 anni
di reclusione per terrorismo, ma poi liberato l'anno successivo nel corso di uno
scambio di prigionieri.
Giuseppe D'Amato per "Il Messaggero" l'11 marzo
2021. La risposta russa alla fine è arrivata. L'Autorità per le comunicazioni
federale (Roskomnadzor) ha disposto ieri il «rallentamento» di Twitter. È la
prima volta che viene attuata una misura del genere. Secondo Mosca la compagnia
americana non ha rimosso circa 3 mila post, vietati in Russia, riguardanti
suicidi, droga e pornografia. A nulla, è stato spiegato, erano valse finora
precedenti minacce e multe. La vicenda giudiziaria si trascina dal 2017. «Non
abbiamo il desiderio di bloccare qualcuno - ha spiegato il portavoce del
Cremlino, Dmitrij Peskov -, ma è ragionevole prendere misure per forzare queste
compagnie a tenere conto delle nostre leggi». Roskomnadzor ha ora dato tempo a
Twitter per adempiere alle proprie richieste, altrimenti seguiranno relativi
provvedimenti. Mosca mostra così i muscoli, utilizzando nuove tecnologie nel
quadro del progetto Internet sovrano, chiamato da altri Internet russo,
approvato in Parlamento nel 2019. Qualcuno è anche arrivato ad ipotizzare la
volontà politica di staccare il ramo russo dal web internazionale. La Russia
starebbe iniziando lo stesso percorso seguito dalla Cina, che impedisce
l'accesso a numerosi siti occidentali. In precedenza, tra il 2018 ed il 2020,
Mosca aveva tentato invano di bloccare sul territorio nazionale il sistema di
messaggistica Telegram, andando incontro a figuracce inattese e provocando
disservizi in serie. Adesso viene utilizzata un'altra strategia, con l'uso dei
DPI (installati presso i provider) e non più degli account IP. Ma anche ieri,
come nel caso di Telegram, l'intero sistema ne ha risentito del rallentamento.
Numerosi siti ufficiali, anche governativi - tra cui quello del Cremlino, della
Duma e di vari ministeri - hanno avuto problemi tecnici, rimediati solo nella
tarda giornata. Quanto successo (ossia gli effetti collaterali), ha commentato
Stanislav Selezniov, capo di una Ong, «dimostra l'impreparazione tecnica da
parte di chi ha attuato tale provvedimento». Stando ad Andrej Soldatov, esperto
di sicurezza cibernetica, quanto accaduto è soltanto una prova, un messaggio di
fare attenzione da parte delle autorità recapitato ai social media. Secondo gli
specialisti del settore oltre a Twitter in futuro altre piattaforme occidentali
verranno presto soggette ad analoghe misure. «Questo è solo l'inizio - prevede
Michail Klimariov, direttore della Società di protezione di Internet - Facebook
e Google saranno i prossimi. Stanno mandando un segnale forte». A breve in
aprile sono in agenda presso un tribunale moscovita nuove udienze contro
Twitter, Facebook, Google, TikTok e Telegram per non aver rimosso messaggi
collegati con le manifestazioni di protesta contro l'arresto del blogger e
politico, Aleksej Navalnyj, ora detenuto in carcere, manifestazioni registratesi
in tutto il Paese a cavallo tra gennaio e febbraio. I social media sono
utilizzati tantissimo dalle opposizioni anti-Cremlino e hanno ormai un'efficacia
e influenza paragonabili a quelle delle televisioni, completamente controllate
dal potere. Il caso Navalnyj, una sfida considerata serissima, va inquadrato
anche in questo scenario di scontro mediatico. Le giovani generazioni, fino ai
quarantenni compresi, si informano solo su queste piattaforme, contro le quali
il potere fino ad oggi si è mostrato inerme, subendone del tutto il peso. I
social media sono poi considerati nelle stanze del potere moscovita un mezzo
utilizzato dall'Occidente per interferire in questioni interne. Quest'anno a
settembre sono programmate le elezioni parlamentari. Ecco un'altra ragione della
stretta. Al Forum economico di Davos il presidente russo Vladimir Putin ha
accusato i giganti del web di «controllare la società», di «competere contro gli
Stati» e di «restringere il diritto di esprimere liberamente i propri punti di
vista». In gennaio la Russia aveva anche criticato Twitter per aver annullato
l'account dell'ex presidente Usa Donald Trump e qualche giorno fa Facebook per
aver censurato articoli della stampa pro-Cremlino. Mosca afferma di avere
proprie opinioni e di avere il diritto di sostenerle. L'Occidente, invece,
controbatte e le definisce «mistificazioni, falsificazioni e propaganda».
Paolo Mastrolilli per "la Stampa" il 4 marzo 2021.
Lee Harvey Oswald aveva ucciso John Kennedy per obbedire ad un ordine di Nikita
Krusciov. E questa è sola una delle rivelazioni esplosive contenute nel libro
Operation Dragon, appena pubblicato dall'ex direttore della Cia Jim Woolsey e
dall'ex capo dei servizi segreti romeni Mihai Pacepa. Perché quando poi passiamo
all' Italia, escono notizie che varrebbero ognuna un libro: Stalin aveva cercato
di eliminare Pio XII; Enrico Fermi aveva contribuito a passare i segreti della
bomba atomica a Mosca; Togliatti era stato fatto fuori in Urss perché aveva
urtato Krusciov. Più di recente, poi, sono credibili l'audio di Gianluca Savoini
all'albergo Metropol che documenta la corruzione della Lega, le interferenze
nelle elezioni italiane, e gli obiettivi nascosti della missione inviata in
Lombardia per il Covid.
Perché è convinto che Oswald lavorasse per Mosca?
«Krusciov era uomo emotivo ed impetuoso, e odiava
Kennedy dall' epoca delle crisi dei missili a Cuba, perché lo aveva fatto
sembrare uno stupido costringendolo al ritiro. L'ordine per eliminare il capo
della Casa Bianca era stato emesso. Poi Krusciov aveva capito che così rischiava
la guerra con gli Usa, e aveva bloccato il Kgb. Oswald però era un fanatico e
non era riuscito a fermarsi».
Jack Ruby fu parte dell'operazione?
«Il Kgb gli ordinò di uccidere Oswald, perché
altrimenti avrebbe sicuramente parlato».
Perché gli investigatori e la Commissione Warren
non lo avrebbero scoperto?
«L'analisi delle comunicazioni fra Krusciov ed
Oswald non fu fatta in maniera efficace. Il mio coautore Pacepa, che operava in
quel mondo, ne era convinto. Ora speriamo nella revisione dei fatti».
Voi scrivete che dopo l'uccisione di Kennedy
l'Urss aveva lanciato una campagna di disinformazione, anche attraverso la
pubblicazione di libri, a cui aveva partecipato l'editore di origini italiane
Carlo Aldo Marzani.
«I russi fanno sempre disinformazione, è un
aspetto centrale del loro rapporto col mondo esterno. A volte ci incappano buoni
autori, altre volte quelli cattivi. Sarebbe bello poter verificare credenziali e
motivi di tutti, ma su Kennedy sono stati pubblicati oltre 3.000 libri, e buona
parte contiene bugie».
Denunciate che Marzani era «un noto agente del Kgb
(nome in codice Nord)».
«Il Kgb ha sempre usato centinaia di "illegali",
cittadini stranieri che passano l'intera vita a disposizione di Mosca, magari
per essere chiamati all'azione una sola volta, o anche mai. Ruby era uno di
questi. In genere fanno lavori e conducono esistenze normali, fino a quando
vengono attivati».
Scrivete che uno di loro era Teodoro Castro,
ambasciatore della Costa Rica in Vaticano, che in realtà era l'agente Iosif
Grigulevich mandato da Stalin a Roma per eliminare Pio XII.
«La Chiesa cattolica è sempre stata un target del
Kgb, per molti motivi. Pio XII era inviso per varie ragioni. È una vergogna,
perché durante la Seconda Guerra Mondiale aveva compiuto molti passi per
proteggere gli ebrei ed ostacolare i nazisti. I papi avevano operato in onestà,
a differenza di chi uccideva».
Dite che il complotto era stato cancellato per la
morte di Stalin.
«Il processo decisionale somiglia a quello che
aveva usato Krusciov nei confronti di Kennedy».
Denunciate che il padre della bomba atomica,
Oppenheimer, aveva passato i segreti delle armi nucleari ai sovietici,
parlandone con i colleghi del Manhattan Project, incluso Enrico Fermi.
«La condivisione di questi segreti con Mosca è
avvenuta, con l'accordo di Oppenheimer e gli altri colleghi».
Perché?
«Ragioni ideologiche, e la preoccupazione che i
nazisti arrivassero prima. Coinvolgendo i sovietici speravano di accelerare».
Fermi sapeva ed era d'accordo?
«Questo ho letto, e credo sia così».
Riportate una conversazione di Pacepa con il
leader romeno Gheorghe Gheorghiu-Dej, in cui il suo amico Chivu Stoica dice che
Togliatti era stato ucciso in Crimea, non era morto di malattia.
«È una conversazione che ha ascoltato di persona».
Nel libro sostenete che questi comportamenti sono
una costante dei russi, anche oggi. È credibile che abbiano interferito nelle
elezioni in Italia e il referendum del 2016?
«Assolutamente. I russi interferiscono nella
politica dei vicini da decenni, è quello che fanno. Semmai bisogna chiedersi
perché non lo fanno, quando non avviene. Lo considerano un loro diritto, e non è
limitato alle operazioni digitali o all'uso dell'intelligenza artificiale.
Include anche l'omicidio, come nel caso di Ruby».
L'audio di Gianluca Savoini, collaboratore di
Matteo Salvini che discuteva di corruzione all'hotel Metropol, è credibile?
«Certo. È sfacciato parlarne seduti nella hall di
un hotel a Mosca, ma i russi vanno oltre la sfacciataggine. Sono molto diretti
nelle operazioni di interferenza».
Danno soldi per ottenere favori, o come strumento
di ricatto?
«Usano entrambe le tecniche. L'Italia è da sempre
un target. Pacepa era informato sulle operazioni nell'area del Mediterraneo e lo
confermava».
Quando la Russia aveva inviato la missione in
Lombardia per il Covid, La Stampa aveva rivelato che era condotta da personale
militare dell'intelligence. Il ministero della Difesa di Mosca aveva reagito con
un comunicato minaccioso.
«Noi americani - ride Woolsey - definiremmo una
simile risposta come "spararsi nei piedi", ma i russi hanno un approccio
filosofico diverso».
Il New Yorker ha scritto che hanno usato ceppi di
Covid italiano per fare i test del loro vaccino Sputnik.
Il Belgorod, il sottomarino russo armato
coi nuovi supersiluri atomici. Paolo Mauri su Inside
Over il 3 marzo 2021. Secondo quanto riporta la Tass in un breve comunicato, il
sottomarino a propulsione nucleare per operazioni speciali Belgorod, project
09852, a maggio potrebbe effettuare le prove in mare. “I test del Belgorod
inizieranno a maggio, dopo che il Mar Bianco si è liberato dal ghiaccio. Non
sono in alcun modo legati ai test del siluro atomico Poseidon”, ha riferito una
fonte specializzata all’agenzia di stampa russa. Sevmash, i cantieri in cui
Belgorod è in fase di allestimento, facenti parte della United Shipbuilding
Corporation non hanno commentato questa indiscrezione. Il Belgorod
(identificativo K-239) è stato varato il 23 aprile del 2019 ed è un battello
derivato da quelli di classe Oscar II (Project 949A Antey in Russia) ma
ampiamente modificato. Il sottomarino, infatti, si differenzia molto da quelli
appartenenti a questa classe di unità navali tipo Ssgn (lanciamissili da
crociera). Innanzitutto lo scafo è più grande: le sue dimensioni sono di 178
metri di lunghezza (a fronte dei 154 degli Oscar II e più lungo quindi dei
vecchi classe Typhoon) per 15 metri di larghezza massima (più stretto di tre
metri), che portano il dislocamento totale, in immersione, a 24mila tonnellate
standard (30mila a pieno carico) invece di, rispettivamente, 16.400 e 24mila
delle altre unità. La propulsione è di tipo nucleare assicurata da due reattori
ad acqua pressurizzata tipo Ok-650M.02 in grado di erogare una potenza di 190 Mw
ciascuno collegati, tramite due turbine a vapore, a due eliche di nuovo disegno
che dovrebbero garantire al sottomarino un’elevata silenziosità. Si ritiene che
la velocità massima sia inferiore ai 32 nodi e che la profondità operativa sia
la stessa degli Ssgn da cui deriva, ovvero intorno ai 500/520 metri.
L’equipaggio, stimato, è più numeroso rispetto agli Oscar II: 110 uomini invece
di 94. Le modifiche più importanti hanno riguardato l’eliminazione del
compartimento coi tubi di lancio dei missili da crociera per fare spazio ad un
nuovo settore, lungo circa 18 metri, in grado di accogliere i sottomarini per
operazioni speciali come il Losharik o il Paltus. A prua della falsatorre –
anche questa più lunga rispetto ad una normale di un classe Oscar II – è
presente un nuovo compartimento (lungo 38 metri sino all’estrema prora) che
serve per operare con i nuovi siluri atomici a propulsione nucleare Poseidon: il
Belgorod sembra avere sei tubi lanciasiluri rotanti – come in una pistola
“revolver” – in grado di accoglierli, ma questo dato è ancora da confermare. Il
progetto di trasformazione del Belgorod è datato 2010 mentre i lavori sono
iniziati ufficialmente nel 2012. Il sottomarino, insieme ad altre unità per
compiti speciali, opera per conto del Gugi, il Direttorato Principale per la
Ricerca Marina Profonda, inquadrato nel Gru (Glavnoe razvedyvatel’noe
upravlenie) il servizio informazioni delle Forze Armate russe. Per effettuare
operazioni di spionaggio, cartografia dei fondali e sabotaggio, il Belgorod è
stato pensato in modo da poter ospitare tutta la gamma di minisottomarini e
droni subacquei (Uuv – Unmanned Underwater Vehicle) in servizio nella
Voenno-morskoj Flot (la Flotta Russa). Il sottomarino, comunque, resta ancora
un enigma per gli analisti occidentali: Mosca ha fatto di tutto per mantenere
segreti alcuni dettagli chiave del battello. In particolare è stata
accuratamente celata, anche durante la cerimonia del varo (pubblica), la sezione
di prua, proprio per nascondere importanti dettagli sulla possibile disposizione
e meccanismo di lancio dei nuovi supersiluri a propulsione nucleare.
Izvestia aveva riferito, lo scorso 11 febbraio, che il Belgorod era in
preparazione per effettuare test con il nuovo siluro Poseidon, ma ora arriva la
smentita da parte dei russi. Potrebbe comunque trattarsi solo di
disinformazione, in quanto immagini satellitari commerciali risalenti al 10
febbraio di Severodvinsk, dove è ormeggiato il sottomarino, hanno mostrato il
battello con i portelloni dei tubi lanciasiluri aperti, e si ritiene che, date
le dimensioni, siano quelli per il supersiluro. Le riprese da satellite mostrano
chiaramente due grandi aperture a prua ciascuna larga circa sei due metri,
ovvero tre volte il diametro delle aperture per i normali siluri da 533
millimetri. Questo perché il Poseidon è circa 20-30 volte più grande di un
siluro pesante tradizionale. Rivelato nel 2015, il siluro è un’arma strategica
automatica progettata per scivolare sotto la rete di difesa missilistica
balistica degli Stati Uniti. L’arma è progettata per distruggere importanti
installazioni economiche del nemico in zone costiere e causare danni devastanti
creando ampie aree di contaminazione radioattiva, rendendole così inutilizzabili
per attività militari, economiche o di altro tipo per lungo tempo. Come detto il
Belgorod potrebbe avere sei di questi siluri in dotazione ed essendo così grandi
e alimentati a energia nucleare, sono probabilmente trasportati esternamente
allo scafo a pressione principale, quindi non è ancora chiari il meccanismo
preposto al loro lancio. Sebbene alcuni rapporti affermino che il sottomarino
condurrà imminenti lanci di prova del Poseidon, questo è ritenuto improbabile da
alcuni analisti. Non è infatti ancora chiaro se il sottomarino abbia mai
condotto test di immersione, pertanto i test a cui faceva riferimento l’articolo
di Izvestia riguardano probabilmente il caricamento di siluri inerti in porto e
i controlli meccanici tra il sottomarino e l’arma, che corrisponderebbero alle
immagini satellitari che mostrano i portelloni esteri aperti. Alcune fonti russe
sostengono che il Poseidon non sia solo in grado di manovrare autonomamente, ma
può anche adagiarsi sul fondo e restare in attesa, potenzialmente per anni
essendo propulso da un piccolo reattore nucleare. In questo modo, in particolari
condizioni come ad elevata profondità (il Poseidon si ritiene possa raggiungere
i 6mila metri) sarebbe praticamente impossibile da intercettare e tanto meno
colpire. Se scoperto, poi, può riattivarsi e cambiare posizione in previsione
della chiamata in azione. Chiamata che potrebbe arrivare, in qualsiasi momento,
proveniente da una nave militare di passaggio, una nave di linea o attraverso il
canale radio a bassissima frequenza del sistema di comunicazione Zevs, il
trasmettitore di segnali codificati per mantenere i contatti coi sottomarini
ovunque siano negli oceani del mondo situato vicino alla base navale
di Murmansk, nella penisola di Kola.
Morto l'ultimo autore del golpe contro
Gorbaciov. Ansa il 28/7/2021. L'ultimo autore ancora
in vita del mancato golpe comunista a Mosca nel 1991 che ha innescato la
dissoluzione dell'Urss, è morto all'età di 89 anni, ha annunciato un
responsabile russo. "Oleg Dmitrievitch Baklanov, che ha diretto la nostra
industria spaziale e il ministero delle Costruzioni dell'Urss, è morto oggi" ha
scritto su Twitter il direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri
Rogozine. Poco conosciuto all'estero, Oleg Baklanov fu uno degli otto
responsabili sovietici all'origine del tentativo di deporre Mikhaïl Gorbaciov,
che cominciò il 19 agosto 1991.
Manlio Graziano per “La Lettura – Il Corriere
della Sera” il 19 luglio 2021. Tra poche settimane cadrà il trentesimo
anniversario di uno degli eventi che hanno cambiato la faccia del mondo alla
fine del secolo scorso: il tentativo di colpo di Stato contro Mikhail Gorbaciov,
il cui fallimento accelerò l'implosione dell'Unione Sovietica. Gorbaciov era
stato issato alla testa del Paese nel 1985, con il mandato di «ristrutturare»
l'economia parassitaria dell'Urss, aprendola al libero mercato. Nel giro di poco
tempo, però, fu evidente al mondo intero che lunghi decenni di assistenzialismo
e di spesa militare sproporzionata rispetto alle risorse del Paese erano
difficilmente redimibili: dall'elezione di Gorbaciov al 1991, l'Unione Sovietica
era precipitata da una situazione già difficile all'impotenza totale. Il
collasso economico accelerava la perdita di credibilità e di prestigio
all'interno e all'estero: il Paese era stato costretto a un umiliante ritiro
dall'Afghanistan, alla resa di fronte al riarmo reaganiano, alla perdita di
tutti i Paesi dell'Europa centro-orientale, alla defezione dei suoi già fedeli
alleati in Medio Oriente e, soprattutto, a subire l'inarrestabile movimento
centrifugo delle 15 repubbliche che lo componevano. Nel 1991, l'Urss era
afflitta da un'endemica scarsità di cibo, medicine e altri beni di consumo, le
fabbriche non avevano di che pagare i salari, le scorte di carburante erano la
metà di quel che serviva per passare l'inverno e l'inflazione superava il 300
per cento. A quella situazione avevano in parte contribuito anche i gerarchi
convinti che l'Urss senza i metodi del passato non avrebbe potuto sopravvivere,
e che avevano passato cinque anni a «remare contro» la perestrojka di Gorbaciov:
molti mossi dal desiderio di conservare i propri privilegi, altri da un genuino
patriottismo, e alcuni da una miscela opportunistica dell'uno e dell'altro. In
quei cinque anni si delinearono due forme opposte di «lealismo»: da una parte,
chi pensava che la sopravvivenza dell'Urss dipendesse dalla prosecuzione e
dall'approfondimento delle riforme iniziate da Gorbaciov; dall'altra, chi
pensava che la sopravvivenza dipendesse dal ripristino del vecchio centralismo
burocratico autoritario e poliziesco. Nell'agosto 1991 si giocò il duello finale
tra quelle due forme di «lealismo». Alla vigilia della creazione dell'«Unione
delle repubbliche sovrane» - un nuovo patto tra 12 delle 15 repubbliche
dell'Urss (i tre Paesi baltici si erano già chiamati fuori), approvato pochi
mesi prima dal 70 per cento della popolazione in un referendum - alcuni
personaggi di primo piano decisero di mettere in atto il putsch che era in corso
di preparazione da ormai più di un anno. Il primo ministro Valentin Pavlov, il
vicepresidente Gennadij Janaev, il capo del Kgb Vladimir Krjuckov, il ministro
degli Interni Boris Pugo e il ministro della Difesa Dmitrij Jazov fecero
arrestare Gorbaciov, allora in vacanza in Crimea, e cercarono di assumere il
controllo delle leve dello Stato. Senza però riuscirci: grandi manifestazioni
contro il golpe scoppiarono in molte città (a Mosca, fu il presidente della
Russia Boris Eltsin a mettersi alla testa della resistenza), e le truppe
rifiutarono di sparare sulla folla. Il putsch era fallito. Il giorno dopo,
l'Ucraina dichiarava l'indipendenza. Era, di fatto, la fine dell'Urss. Entrambe
le forme di «lealismo» uscirono dunque sconfitte da quell'estrema prova di
forza. L'esito penoso del conato di putsch dimostrò che l'estremo tentativo di
«rendere l'Urss di nuovo grande» non aveva nessuna possibilità di successo; ma,
al tempo stesso, dimostrò che neppure il tentativo di salvare l'Urss attraverso
le riforme della perestrojka aveva possibilità di riuscire. Deposto per due
giorni dai golpisti, Gorbaciov poté tornare a Mosca protetto da chi si
apprestava a deporlo definitivamente con altri mezzi, sciogliendo puramente e
semplicemente quel che restava del fantasma dell'Unione Sovietica, di cui era
l'ancor più fantasmatico presidente. Non fu, come hanno detto molti, la fine di
un particolare regime politico; fu un'altra finis Russiae , una delle tante che
hanno regolarmente segnato la storia del Paese. La Russia è infatti colpita, più
di ogni altro Paese al mondo, dalla maledizione vichiana dei corsi e ricorsi
storici: a cicli di espansione seguono ineluttabilmente cicli di contrazione.
Contrazione che non si manifesta soltanto nel restringimento dei confini, ma
anche nelle condizioni materiali, politiche e morali dell'intero Paese: il
collasso del 1917 fu il prezzo pagato alla hybris , la tracotanza
espansionistica dell'Ottocento; il collasso del 1991 fu il prezzo pagato alla
hybris espansionistica dell'Unione Sovietica. Questa apparente fatalità è il
risultato della combinazione di due condizioni specifiche: da una parte, la
necessità vitale di espandersi per premunirsi contro i rischi di un'eventuale
invasione; dall'altra, l'incapacità strutturale - per mancanza di mezzi - di
sostenere a lungo i costi dell'espansione. L'origine di queste due condizioni si
perde nella notte dei tempi. Gli storici individuano nelle invasioni dei
Cavalieri teutonici e, soprattutto, dell'Orda d'oro mongola, nel XIII secolo, la
nascita di quel sentimento permanente di insicurezza che G. Patrick March
definisce «paura paranoide di un'invasione». Ma, come pare abbia detto Henry
Kissinger, anche i paranoici ogni tanto hanno ragione: è precisamente il caso
della Russia, piagata da ricorrenti tentativi di conquista. Tentativi frustrati
proprio dalle lunghe e, in definitiva, impercorribili distanze fisiche che si
frappongono tra i territori dei suoi invasori e il cuore pulsante del Paese.
Spiegava March: «La paura paranoide di un'invasione... ha suscitato [nei russi]
una coazione a espandersi a spese dei propri vicini, per timore che questi si
possano espandere a spese loro». Il secondo fattore specifico è l'impossibilità
di sostenere a lungo i costi dell'espansione. Una delle cause principali del
declino e della caduta dei grandi imperi è il loro overstretching , la loro
sovraestensione: l'incapacità, cioè, di mantenere sul lungo periodo il controllo
di tutti i territori conquistati e di rispettare tutti gli impegni presi. Nel
caso particolare della Russia, tale incapacità non si manifesta sul lungo
periodo, ma appare subito, al ritmo stesso delle conquiste; l'overstretching ,
si potrebbe dire, è consustanziale all'esistenza stessa di un impero russo. La
ragione è da ricercarsi nella inclemente geografia del Paese, che lo priva di
vie di comunicazione naturali all'interno e rende impervie le vie di
comunicazione verso l'esterno, data l'assenza di sbocchi aperti su mari
navigabili tutto l'anno. Questi handicap geografici, che sono immediatamente
handicap economici e diventano infine handicap politici, condannano la Russia a
essere tutt' al più una media potenza. Quando pretende di giocare nella
superlega delle grandi potenze, è costretta a spendere più di quanto incassi,
innescando il meccanismo che, dall'espansione, porterà ineluttabilmente alla
contrazione. Questa, in breve, è stata la storia dell'Unione Sovietica a partire
dall'alleanza con Hitler nel 1939, e poi con gli Stati Uniti nel 1941, fino al
suo schianto nel dicembre del 1991. L'ingordigia con cui Stalin restaurò e poi
oltrepassò i confini dell'impero zarista fu pari solo all'incapacità di
mantenere quelle conquiste. Mentre gli Stati Uniti potevano permettersi di
inondare di capitali la parte di Europa rimasta nelle loro mani, la Russia dava
vita a una triste parodia del Piano Marshall (il «Piano Molotov»), che divenne
poi il Comecon, un sistema di accordi bilaterali volti a vincolare i Paesi
satelliti al commercio con l'asfittica economia russa. Il solo modo in cui
l'Urss poté mantenere la propria unità - così come il blocco europeo
centro-orientale ottenuto dagli accordi di Yalta - fu l'impiego sistematico
della repressione poliziesca e militare. Ma, da che mondo è mondo, la forza
bruta non è sufficiente a garantire l'esistenza di un impero, o di uno Stato, o
anche solo di un regime; anzi, il ricorso esclusivo alla forza bruta può
accelerarne la caduta invece di procrastinarla. È quello che accadde nei
convulsi mesi che seguirono il tentato golpe dell'agosto 1991, quando l'Unione
Sovietica si dissolse nel nulla. Il 12 dicembre 1991, i presidenti russo Boris
Eltsin, ucraino Leonid Kravcuk e bielorusso Stanislau ukevic chiusero a Minsk il
capitolo sovietico della storia russa con l'intenzione di aprirne uno nuovo,
partendo dal suo cuore slavo. Un progetto che non decollò mai; non perché
l'«Occidente» si fosse messo di mezzo (cosa che l'«Occidente» fece, comunque),
ma perché la Russia non aveva i mezzi per riuscirci. Nel 2005, Vladimir Putin
definì la dissoluzione dell'Urss la «più grande catastrofe geopolitica del XX
secolo». Anche se il XX secolo non è stato avaro di catastrofi, geopolitiche e
umane, di cui sembra inopportuno stabilire una gerarchia, non c'è da stupirsi
che uno dei più longevi vod (infallibile leader carismatico) della storia russa
lo consideri «il più grande». Fedele al suo ruolo e al suo compito, Putin ha
tutto l'interesse a imputare pubblicamente quella catastrofe ai «nemici» del suo
Paese. Quell'evento, in realtà, si iscrive perfettamente nella continuità
geopolitica della Russia, nella maledizione vichiana che spinge ogni vod emerso
da un ciclo di contrazione a spingersi con cieca determinazione in un nuovo - e,
in definitiva, nuovamente fatale - ciclo di espansione.
I 90 anni di Gorbaciov, padre della
perestrojka e ultimo leader sovietico. Enrico
Franceschini su La Repubblica il 2 marzo 2021. Dopo il crollo dell'Urss, nel
'91, tentò di restare in politica, ma quando si ricandidò alla presidenza prese
meno dell'1 per cento. Finché la salute glielo ha permesso, ha girato il mondo
per conferenze: ora vive nella dacia fuori Mosca che gli concessa dal suo
successore Eltsin. Per uno di quegli scherzi del destino che nessuno poteva
prevedere, Mikhail Gorbaciov compie 90 anni, un traguardo significativo nella
vita di ogni uomo, proprio nel trentesimo anniversario del crollo dell’Unione
Sovietica, l’immensa nazione di cui era stato il leader supremo e della cui
dissoluzione molti nel suo Paese lo ritengono responsabile. Domani, giorno del
compleanno, il suo successore Vladimir Putin gli invierà gli auguri: lo ha
sempre trattato con rispetto ed è stato ricambiato dall’uomo della perestrojka,
che pur avendolo talvolta criticato non è mai arrivato a definirlo un autocrate,
come lo chiamano oggi in Occidente. Ma Putin considera la fine dell’Urss “la più
grande tragedia geopolitica del ventesimo secolo” e ha provato a ricostruirne
almeno un pezzo, tra l’annessione della Crimea in Ucraina e le manovre per una
possibile riunificazione con la Bielorussia: l’attuale capo del Cremlino non ha
certo dimenticato che la superpotenza comunista cadde sotto la guida di
Gorbaciov. La coincidenza del trentennale del collasso sovietico con le sue
novanta candeline dà dunque all’occasione un sapore mesto. Perso il potere nel
1991, Mikhail Sergeevic provò a restare per un po’ in politica, illudendosi di
potere avere consensi: una volta si è anche candidato alla presidenza, ottenendo
meno dell’1 per cento. Da quel momento si è accontentato di presiedere la
fondazione che porta il suo nome e di andare in giro per il mondo per
conferenze, finché l’età e la salute glielo hanno concesso: chi scrive, dopo
averlo conosciuto a Mosca, lo ha rincontrato a Tel Aviv e a Londra. Nel 1999 ha
perso anche la moglie, Raissa, a cui era molto unito e che era stata una “first
lady” diversa dalle precedenti, più moderna e volitiva, quanto lui è stato
diverso dai leader che lo hanno preceduto: Lenin, Stalin, Krusciov, Breznev,
Andropov e Chernenko. Da allora vive alla dacia fuori Mosca conferitagli
da Boris Eltsin, il presidente che prese il suo posto al vertice della Russia, e
mantenutagli da Putin, confortato dalla figlia Irina. I sovietologi, categoria
per un po’ caduta in disuso ma tornata utile, lo hanno chiamato “il riformatore
inconsapevole”, sostenendo che il suo tentativo di riformare il comunismo, ossia
democratizzarlo con la glasnost, alla lettera “trasparenza”, intesa come libertà
di stampa e di pensiero, e con la perestrojka, ovvero la riorganizzazione
politica ed economica, provocarono il caos che ha distrutto l’Urss, senza che il
fautore di questo cambiamento si rendesse conto delle conseguenze. Sicuramente
Gorbaciov fu un riformatore pasticcione, che faceva un passo avanti e un passo
indietro, promettendo un giorno “un’economia alla svedese” (ma per farla,
ribatteva una barzelletta dell’epoca, servirebbero gli svedesi) e il giorno dopo
una svolta conservatrice, come accadde nei mesi prima del golpe d’agosto del
‘91, il putsch dei nostalgici del comunismo duro e puro, che lo tennero
prigioniero per tre giorni nella dacia delle vacanze sul Mar Nero. Il colpo di
Stato fallì per la resistenza di Eltsin e del popolo, oltre che per
l’inconsistenza dei golpisti: ma la disgregazione dell’Unione Sovietica, che era
già in pieno corso, divenne a quel punto inarrestabile, sei mesi dopo la
bandiera rossa scese dal pennone sul Cremlino e Gorbaciov fu costretto a
dimettersi. Credeva di essere accolto come un eroe, al ritorno a Mosca, invece
fu trattato come un complice dei golpisti o perlomeno un corresponsabile: era
stato lui a metterli nei posti chiave, capo del Kgb, ministro della Difesa,
presidente del Soviet Supremo, senza comprendere che si preparavano a tradirlo.
Di una cosa, tuttavia, Gorbaciov era sicuramente consapevole: di non voler
tornare indietro, verso lo stalinismo nelle cui purghe era finito pure suo nonno
contadino, verso la violenza che aveva portato i carri armati sovietici a
Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968. Ci furono spargimenti di sangue anche
nella confusa stagione della perestrojka, nel Baltico e nel Caucaso, ma quale
che fosse la sua responsabilità in quelle circostanze, Gorbaciov cercò sempre di
risolvere le crisi con il dialogo, non con la forza. Ai russi non era simpatico,
anche perché astemio: lo avevano ribattezzato il “Segretario Minerale” quando
alzò il prezzo della vodka per combattere l’alcolismo. “Eppure, un giorno
dovranno riconoscergli i suoi meriti”, ha detto nel Natale scorso Pavel
Palazchenko, suo fido interprete di tanti summit con Ronald Reagan. Finora, quei
meriti glieli hanno riconosciuti soltanto all’estero, tributandogli il premio
Nobel per la pace. Senza di lui, non è chiaro se nel 1989 sarebbe crollato il
muro di Berlino e l’Europa orientale avrebbe potuto ritrovare indipendenza da
Mosca e democrazia. Fu l’uomo della perestrojka ad aprire le porte della
prigione che era stata l’Urss fino alla sua ascesa al potere nel 1985. E chissà,
se un giorno conquisteranno la piena democrazia, forse i russi si ricorderanno
che Gorbaciov sognava di costruire “una casa comune europea”, coronando
l’aspirazione occidentalista avviata dallo zar Pietro il Grande e ricongiungendo
finalmente Santa Madre Russia con il continente a cui è legata dalla geografia,
sebbene non dalla storia. Ma intanto, compie novant’anni. Avendolo intervistato
più volte, negli anni in cui ero corrispondente da Mosca di questo giornale,
domani vorrei potergli fare gli auguri anch’io: C dniom rozhdenia, Mikhail
Sergeevic!
In "fuga" sul carrello: così i
diplomatici russi lasciano la Corea del Nord. L'epopea
del gruppo si è conclusa con il terzo segretario Vladislav Sorokin in piedi, sui
binari, costretto a spingere il carrello a mano per più di un chilometro.
Federico Giuliani - Ven, 26/02/2021 - su Il Giornale. Hanno lasciato la Corea
del Nord a bordo di un vecchio carrello ferroviario. Una piattaforma, per essere
più precisi, attivabile dai suoi passeggeri attraverso l'uso di una leva a pompa
oppure da persone che la spingono manualmente da dietro. Il viaggio di alcuni
familiari dei dipendenti dell'ambasciata russa a Pyongyang è avvenuto così, in
condizioni quasi estreme, come documentano le immagini e i video diffusi dal
Ministero degli Esteri della Federazione russa. Il viaggio, estenuante e
faticoso, è durato oltre 34 ore, dalla capitale Pyongyang a Vladivostok, al
confine settentrionale tra Corea del Nord e Russia. L'epopea del gruppo si è
conclusa con il terzo segretario Vladislav Sorokin in piedi sui binari,
costretto a spingere il carrello a braccia per più di un chilometro. L'immagine
è quasi comica: sopra il mezzo di fortuna, si vede la famiglia dell'uomo,
formata da moglie e figli, assieme a una discreta quantità di bagagli.
D'altronde, quello usato dalla famiglia di Sorokin era forse l'unico modo
possibile per lasciare il Paese. Da un anno a questa parte, infatti, per tenere
a bada la pandemia di Covid-19, Kim Jong Un ha blindato la Repubblica Popolare
Democratica di Corea sia in entrata che in uscita. Ufficialmente, oltre il
38esimo parallelo non vi è traccia di Sars-CoV-2. Per mantenere la situazione
sotto controllo, il governo ha deciso di sospendere i voli della compagnia area
statale Air Koryo.
Un viaggio bizzarro. Le peripezie degli otto
cittadini russi iniziano con un viaggio "in treno". Usiamo le virgolette, perché
il treno utilizzato è, come detto, un antiquato carrello ferroviario da dirigere
lungo l'altrettanto antiquato sistema ferroviario nordcoreano. Questa parte del
viaggio è durata 32 ore. In un secondo momento, la famigliola è salita su
un autobus, prima di caricare le valige su un tram ferroviario e spingerlo per
il restante tragitto. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Sokorin ha dovuto
spingere il carretto a mano per circa un chilometro, compresa la parte sopra il
ponte sul fiume Tumen. Una volta giunti nella stazione russa di Khasan, i
viaggiatori sono stati accolti dai colleghi del Ministero degli Esteri russo. È
lo stesso Ministero degli Esteri russo a raccontare con un post su Facebook la
bizzarra vicenda capitata a Sokorin. "Il 25 febbraio, 8 dipendenti
dell’Ambasciata russa nella Repubblica Popolare Democratica di Corea e i loro
familiari sono tornati in patria. Dato che le frontiere sono chiuse da oltre un
anno e che il traffico passeggeri è stato fermato – si legge sul social - hanno
dovuto affrontare un lungo e difficile viaggio per tornare a casa". "Prima 32
ore di treno da Pyongyang verso Nord, poi altre due ore di autobus fino al
confine e finalmente, l’attraversamento verso il versante russo. Per farlo – ha
quindi concluso il post - hanno dovuto preparare un carrello, metterlo sui
binari, caricarci sopra bagagli e bambini e andare. L’unico uomo del veicolo non
semovente, Vladislav Sorokin, ha fatto da motore, cioè ha dovuto spingere a
braccia il carrello lungo i binari per più di un chilometro. La parte più
difficile è stata il ponte sul fiume Tumannaya".
Isolamento e paura del virus. Al di là del
grottesco viaggio, la notizia ci offre almeno due spunti di riflessione. Il
primo: la Corea del Nord ha preso sul serio la minaccia sanitaria rappresentata
dal virus e, sapendo di non poter contare su un sistema sanitario tale da poter
fronteggiare gli effetti del Sars-CoV-2, ha pensato bene di staccare la spina
con il resto del mondo. Isolarsi per scongiurare ogni forma di contagio. Al
momento, a quanto pare, la mossa di Kim sembrerebbe aver funzionato (il
condizionale è tuttavia d'obbligo). Arriviamo alla seconda considerazione. La
partenza della famiglia Sorokin indica che la maggior parte dei pochi cittadini
stranieri presenti in Corea del Nord sta per lasciare o ha già lasciato il
Paese. Il motivo è semplice: nessuno vuole rischiare di restar bloccato, lontano
da casa, per via dei rigidissimi controlli predisposti da Pyongyang lungo le
frontiere.
Il cimitero dei sottomarini nucleari
russi minaccia il mondo. Davide Bartoccini su Inside
Over il 22 gennaio 2021. Nella acque gelide che bagnano gli oblast più remoti
delle sconfinata Russia, il cimitero dei sottomarini nucleari che hanno solcato
gli oceani nella Guerra Fredda, a caccia di sottomarini e portaerei nemiche,
minaccia di scatenare un disastro ecologico dalle conseguenza insanabili con
l’equivalente di “sei Hiroshima e mezzo” di elementi radioattivi. Una sorta di
Chernobyl sommersa che incombe sul Cremlino, costretto a fare i conti con uno
dei segreti indicibili dell’epoca sovietica: lo smaltimento a basso costo dei
rifiuti nucleari tra corsa agli armamenti per conquistare il mondo, e le
conseguenze del crollo inesorabile del sogno comunista e del suo sistema
economico. È solo questione di tempo, prima che le paratie stagne dei
sottomarini nucleari mai smantellati abbandonati sui fondali oceanici, come
anche i container nei quali sono stati affidanti al dimenticatoio delle
profondità marine i rettori nucleari che li alimentavano, vengano completamente
corrosi dalla salsedine e penetrati dall’effetto del tempo; costringendoli a
rilasciare nel Mare di Barents e nel Mare di Kara, una bollente nube radioattiva
sprigionata dalle barre di uranio intatte che potrebbero contaminare l’intero
ecosistema marino; avvelenando la flora marina, inibendo intere zone di pesca
indispensabili per la popolazione e mettendo a rischio non
solo l’importante esplorazione petrolifera condotta da Mosca: ma anche
le rotte artiche che sono già oggetto di feroci scontri diplomatici a livello
internazionale. Una vera e propria “bomba ad orologeria” nascosta sui fondali
che si affacciano sull’Artico. Composta da “migliaia di tonnellate di materiale
nucleare, pari a quasi sei volte e mezzo la radiazione rilasciata a Hiroshima”.
Scaricate nell’oceano per ordine delle vecchie nomenclature comuniste che al
tempo, forse prive delle adeguate conoscenze o forse della volontà di impegnare
maggiori risorse per stoccarlo, decisero di creare la più pericolosa discarica
nucleare sottomarina del pianeta. Una discarica che comprende almeno 14
reattori e due sottomarini interi. Stiamo parlando del K-27: prototipo
sperimentale della classe November (secondo il codice identificativo Nato) –
primo tipo di sottomarini a propulsione nucleare sovietici – che giace intero e
abbandonato a 50 metri di profondità nel mare di Kara con i suoi due reattori
raffreddati a metallo liquido. Dopo un grave incidente avvenuto nel 1968 uccise
nove membri dell’equipaggio – contaminando gli altri ottantatré per
l’esposizione alle radiazioni, il relitto definito già inservibile venne
affondato al largo della costa nel 1981, ancora carico di carburante e di
altri rifiuti. Lo smantellamento allora fu ritenuto troppo pericoloso e troppo
costoso. A distanza di quarant’anni le conseguenze sembrano essere più invasive.
E del del K-159: anch’esso sottomarino della classe November – progettati
appositamente per condurre degli attacchi atomici sulle città costiere americane
– che fu il triste protagonista di un’incidete nel 1965, ma che rimase tuttavia
in servizio fino al 1989. Abbandonato in un deposito per oltre quattordici anni,
venne affondato da una tempesta del 2003; quando lo scafo già duramente provato
dai lunghi anni di servizio nelle profondità oceaniche, finì sul fonda del mare
di Barents. Anche in questo caso persero o la vita nove membri dell’equipaggio.
Intrappolati nel relitto che si trova ad una profondità di circa 250 metri, con
i suoi reattori nucleari intatti e non sigillati. A questi due relitti, che
attendono il loro destino come fantasmi della Guerra Fredda rilegati alle gelide
profondità marine, si sommano materiali stoccati e affondati secondo le
procedure – ma soprattutto secondo le disponibilità economiche – dell’epoca di
coloro che assistettero impotenti al crollo definitivo dell’Unione Sovietica. La
temibile superpotenza costretta a disfarsi delle più obsolete unità che avevano
composto la più grande flotta di sottomarini nucleari mai varata per combattere
una guerra che non sarebbe mai stata combattuta. Si tratterebbe, secondo le
informazioni ufficiali, di almeno 14 reattori nucleari appartenuti ad
altrettanti sottomarini in linea con Flotta del Nord e con quella del Baltico,
sigillati e scaricati sul fondale senza che venisse prima rimosso il
combustibile radioattivo. Come oltre 17mila container di materiale nucleare,
colato a picco nella pancia ormai provata dalla corrosione di diciannove navi da
trasporto che andavano radiate. E questo è il punto alla data odierna. Poiché il
cimitero dei sottomarini potrebbe anche accogliere nuovi relitti – sebbene
smantellati e stoccati secondo procedure adeguate. Questo perché la flotta russa
prevede di ampliarsi per tornare ai vecchi fasti, considerando di dismettere e
sostituire le unità più obsolete a vantaggio di nuovi e sofisticati sottomarini
che sono già in cantiere. È fatto noto, infatti, che i sottomarini, dato il
ruolo strategico che non hanno mai perso nelle guerre contemporanee, sono
oggetto di continua ricerca e sviluppo per migliorarne le capacità; fornendo
alle super potenze tecnologie sempre più letali e sofisticate. Tecnologie
queste, che, per quanto sofisticate e avveniristiche (anche nel passato
recente), sono costrette ad operare per 20-30 anni nelle inospitali profondità
oceaniche che logorano con la pressione, le temperature e le lunghe missioni, i
macchinari e gli stessi reattori nucleari che alimentano i vascelli. Lo stress,
la corrosione portata dal mare e dal tempo, l’usura di componendi e supporti che
finisce per annullare l’isolamento acustico rendendo il sottomarino “udibile” ai
sonar – quindi più facilmente individuabile dal “nemico” -, finisce per
costringere il Cremlino come il Pentagono ad ordinare nuove unità. Lasciando al
loro triste e pericoloso destino nel unità varata negli anni ’80 e ’90.
Sottomarini per la stragrande maggioranza alimentati da combustibile nucleare.
Secondo il parere e le verifiche condotte dagli esperti, tra i quali viene
annoverato anche il report di una no-profit norvegese che nel 2012 ha inviato un
team di sommozzatori nel mare di Kara a visionare lo stato del K-27, i segni di
deterioramento dello scafo di quest’ultimo sono già evidenti, e potrebbero
cedere entro il 2032. “La violazione delle barriere protettive e il rilevamento
e la diffusione di radionuclidi nell’acqua di mare potrebbero portare a
restrizioni di pesca”, ha dichiarato il capo della spedizione congiunta che
comprendeva anche personale russo. Queste criticità potrebbero, sempre secondo
le analisi condotte dal team, “danneggiare seriamente i piani per lo sviluppo
della rotta del Mare del Nord” – “Gli armatori potrebbero rifiutarsi di
percorrerla”, afferma l’esperto; e non è un segreto l’importanza che le rotte
artiche stanno assumendo; come la diatriba diplomatica che potrebbe sorgere
ancora prima dello scontro che il Cremlino, interessato alle enormi risorse
economiche che la regione artica promette, minaccia di essere pronto ad
intraprendere per proteggere la propria giurisdizione esclusiva. Sebbene le
prospettive non siano rosee, dal canto suo Mosca – che ha abbandonato da almeno
un decennio il suo status di potenza misteriosa e insensibile ai problemi
globali – ha annunciato di aver già sviluppato un piano di recupero per sventare
il disastro ecologico. Questo prevedere il sollevamento dalle profondità marine
dei relitti abbandonati del K-27 e del K-159, insieme al recupero ad altri
quattro compartimenti di reattori nucleari identificati come potenzialmente
pericolosi che sono stati affondati nell’Artico. Tale piano prevede un
investimento quantificato in circa 330 milioni di dollari, e la costruzione di
una nave apposita che inizierà in questo 2021 e terminerà nel 2026. Con la
speranza che fino ad allora, il cimitero dei sottomarini dell’Unione Sovietica
custodisca il suo veleno radioattivo.
Russia, rinascere tra i
ghiacci.
Emanuel Pietrobon su Inside Over il 20 gennaio 2021. Similmente alla leggendaria
araba fenice, la cui anima viene liberata da un fuoco che si nutre del caldo
ustionante, i russi, eredi di Rurik e di San Vladimiro, trovano nel freddo
glaciale del loro gelido inverno il rimedio ai mali spirituali accumulati
durante l’anno, immergendosi ogni 19 gennaio in fonti battesimali
(Iordan’) suggestivamente scavate nella neve. Il 19 gennaio è, per la Chiesa
Ortodossa Russa e per tutte le Chiese ortodosse che basano la loro liturgia sul
calendario giuliano, il giorno in cui si celebra l’Epifania. Le differenze fra
cristianità occidentale ed orientale nei riguardi di questa solennità non si
fermano alle variazioni di data, a cambiare, infatti, è anche il significato:
non la manifestazione del Divino all’umanità, ma il battesimo di Gesù nelle
acque del Giordano da parte di Giovanni Battista.
Uno dei momenti più attesi
dell’anno. Il 19 gennaio di ogni anno i fedeli ortodossi che seguono il
calendario giuliano commemorano il battesimo di Gesù. La solennità che in
Occidente è conosciuta come Epifania, in Russia viene chiamata Kreshenie, ovvero
battesimo, ed è accompagnata da un costume malioso, antico e che ha resistito a
quasi un ottantennio di repressione da parte sovietica: i tre bagni
negli Iordan’. Iordan’ è il nome dato alle vasche a forma di croce in cui si
immergono i fedeli dell’ortodossia russa a partire dalla sera della vigilia
dell’Epifania; un evidente ed esplicito richiamo al Giordano, il fiume santo
nelle cui acque l’enigmatico asceta Giovanni Battista battezzò Gesù e che da
duemila anni è meta di pellegrinaggi da parte di peccatori redenti e aspiranti
cristiani. Nel Giordano, e quindi anche negli Iordan, l’Uomo rinasce a nuova
vita – una vita in Cristo – e, secondo la leggenda, potrebbe beneficiare di
potenti effetti taumaturgici. Realtà vivida per alcuni, superstizione per altri,
fatto sta che le grandi famiglie della nobiltà europea, dai Windsor ai Savoia,
battezzano i loro figli e le loro figlie con l’acqua proveniente dal Giordano da
tempi immemori; un’usanza sopravvissuta alla secolarizzazione e alla modernità.
I fedeli ortodossi russi entrano negli Iordan nella speranza e nell’aspettativa
di ottenere che la loro anima venga ripulita dal peccato, o meglio che venga
rigenerata, seguendo una tradizione madida di misticismo ed ugualmente sentita e
partecipata tanto dal volgo quanto dall’aristocrazia sin dalle origini –
tracciate nella prima parte del sedicesimo secolo. L’immersione segue un
cerimoniale semplice ma preciso, indicativo e testimone di quanto sia importante
il bagno rituale: il fedele entra nella fonte e prima di inabissarsi deve fare
il segno della croce, un comportamento ripetuto per un totale di tre volte –
tre, la Trinità. Le fonti battesimali vengono realizzate in maniera congiunta da
autorità religiose e civili, con le prime incaricate della benedizione delle
acque e le ultime adibite alla vigilanza e alla sicurezza dei siti (che,
preferibilmente, dovrebbero essere muniti di scalette per facilitare discesa e
salita) e dei partecipanti. Sono i numeri a rendere fondamentale la presenza di
controlli: l’anno scorso circa 125mila persone si sono battezzate nelle 46
vasche “ufficiali” allestite a Mosca, una cifra oltre le attese che,
quest’anno, ha spinto le autorità ad installarne più di 220 nella consapevolezza
che la pandemia non avrebbe ostacolato la ricerca di purificazione dei russi.
Patria e misticismo. Siamo a
Kiev, nel 1956, e il giornalista francese Dominique Lapierre, dopo aver
assistito alla celebrazione di un matrimonio religioso presso la cattedrale di
san Vladimiro e compreso quanto sia frequente che nelle case di quasi ogni
famiglia vengano custodite (e nascoste) gelosamente Bibbie, icone e santini,
emette la propria sentenza sulla politica di ateizzazione della società
intrapresa dalla dirigenza sovietica sin dai tempi di Lenin e Stalin: ha
fallito. Scriveva Lapierre in “C’era una volta l’Urss“, resoconto biografico di
un viaggio in macchina epico da Mosca alle alture del Caucaso, che “nessun
regime potrà mai cambiare la natura profonda della stupenda sensibilità russa”.
Quella sensibilità, di cui il giornalista era stato testimone diretto, aveva
molto a che fare con il forte attaccamento alla fede degli antenati – un
sentimento radicato ad una tale profondità che i sovietici mai avrebbero potuto
estirparlo totalmente. Lapierre aveva ragione: l’esperimento sovietico è
collassato sotto il peso delle contraddizioni e la Russia, superato il momento
di transizione degli anni ’90, si è riappropriata dell’antico ruolo di Terza
Roma. L’importanza folcloristica del rito dei tre bagni è pienamente
comprensibile soltanto attraverso una visione di insieme e indossando occhiali
da lettura che non siano occidentalo-centrici. Esso è, infatti, un atto con il
quale si manifestano simultaneamente fede e fedeltà (all’ideale patrio), da qui
la partecipazione di credenti, non credenti, personaggi pubblici, politici e
naturalmente di Vladimir Putin, il padre fondatore della nuova Russia. “È la sua
tradizione, e lui non tradisce le tradizioni”; questo è stato il breve ma
eloquente commento di Dmitrij Peskov, il portavoce della presidenza, in merito
la decisione di Putin di eseguire il rito dei tre bagni anche quest’anno,
nonostante l’età oramai avanzata (68 anni) e la temperatura rigida – venti gradi
sotto lo zero al momento del battesimo. Il rito dei tre bagni nel Giordano
ricostruito in miniatura, esattamente come il Natale di Lipno, se letto e
decifrato nel modo giusto, ossia senza pregiudizi e preconcetti, può rivelarsi
estremamente utile nel processo di analisi e comprensione della complessa
identità della Russia, uno stato-civiltà millenario la cui anima giacerà
eternamente – si scriveva sulle nostre colonne – fra Lipno e Velikij Novgorod, e
che può essere percepita e toccata con mano in rari momenti dell’anno, come in
occasione del Kreshenie.
Giuseppe D'Amato per il
Messaggero il 7 febbraio 2021. Da mesi la voce gira incontrollata: il presidente
russo ha una figlia segreta. Vladimir Putin come Francois Mitterand, quindi?
L'ufficio stampa del Cremlino nega decisamente e non sa nemmeno chi abbia messo
in giro questa storia, che è stata ripresa anche dall'oppositore Aleksej
Navalnyj nel recente video dal titolo Il Palazzo di Putin (valore della tenuta
sul mar Nero stimata in 1,3 miliardi di dollari), visto da milioni di russi in
Internet. Un video, è bene ricordarlo, che è uscito qualche giorno dopo
l'arresto del blogger il 17 gennaio scorso al ritorno in Patria dalle cure in
Germania per il noto avvelenamento e che ha suscitato sentimenti contrastanti in
un Paese in grave crisi economica. È servito anche a lanciare le due giornate di
manifestazioni di protesta non autorizzate del 23 e 31 gennaio.
I DOCUMENTI. Chi è, pertanto,
la 17enne Elizaveta Krivonogikh? La domanda se la pongono in tanti, non solo in
Russia, ma anche in Inghilterra, dove la giovane avrebbe soggiornato. I primi ad
accorgersi dell'incredibile somiglianza della ricca ragazza con il capo del
Cremlino sono stati nello scorso novembre i reporter di sito investigativo russo
Proekt. Sua madre Svetlana Krivonogikh è la beneficiaria di una compagnia che
detiene un certo quantitativo di azioni della banca Rossija, sotto sanzioni da
parte dell'Occidente dopo la crisi ucraina del 2014 per i suoi legami con
l'élite politica federale. Proekt stima che il valore totale delle proprietà
conosciute e dei suoi asset sia di circa 100 milioni di dollari. Il suo yacht
personale - di fabbricazione italiana lungo 37 metri - l'Al'doga, è stato pure
scortato dalla Marina russa. Proekt ha ottenuto copie di alcuni documenti non
specificati - probabilmente il certificato di nascita di Elizaveta - in cui non
è indicato il cognome del padre, ma solo il suo nome, ossia Vladimirovna, di
Vladimir. Successive prove di riconoscimento facciale al computer hanno
evidenziato la somiglianza tra il presidente e la ragazza al 70,44%. In alcune
foto tale percentuale arriva al 75%. Ma allora chi è veramente Svetlana
Krivonogikh? Classe 1975, sanpietroburghese, di professione cameriera, ha
vissuto a lungo con la madre in un semplice appartamento della capitale baltica.
Poi si sarebbe innamorata di un benefattore, così avrebbe raccontato a dei
conoscenti, e da allora la sua vita è cambiata. La donna si è trasferita in un
quartiere residenziale, dove vivono le élite dell'ex Leningrado. Secondo i
reporter di Proekt la possibile amicizia con il benefattore è iniziata a metà
degli anni Novanta. In quel periodo Putin ha ricoperto vari incarichi al
Municipio di San Pietroburgo, prima di trasferirsi a lavorare
all'Amministrazione presidenziale a Mosca. Dal 1983 il capo del Cremlino è stato
sposato con Liudmila Shkrebneva, che gli ha regalato due figlie Marija ed
Ekaterina (sconosciute al grande pubblico, non vi sono loro fotografie; quando
erano bambine ospiti per un periodo di vacanza nella villa di Silvio Berlusconi
in Sardegna) - e da cui ha divorziato nel 2013. Sempre secondo Proekt la storia
tra Svetlana ed il benefattore sarebbe finita una decina di anni fa.
Attualmente, come ha ricordato nel suo video Navalnyj, Putin sarebbe legato
sentimentalmente all'ex ginnasta Alina Kabaeva, ma non vi sono conferme
ufficiali. La misteriosa Elizaveta è nata nel marzo del 2003. Come tutte le
ragazze della sua età ha postato sui social media numerose fotografie con il suo
viso ben in vista, ma poi quasi tutte sarebbero state cancellate. La giovane è
decisamente bella, magra, bionda. La classica bellezza slava. Chiaramente le
piace la moda ed ha postato le foto di numerosi articoli. La stampa britannica è
riuscita ad identificare una persona che è in sua compagnia in una clip su
TikTok. Per il quotidiano Daily Mail è il 20enne Robert Skigin, già studente a
Londra, nipote di un noto uomo d'affari di San Pietroburgo, che alla sua morte
ha lasciato in eredità 600 milioni di euro.
Putin e la reggia di Gelendzhik.
Irene Soave per "corriere.it" il 20 gennaio 2021. Un palazzo
principesco da oltre 14 mila metri quadri sulle rive del Mar Nero, circondato da
possedimenti grandi «come 39 volte il Principato di Monaco». È questo,
secondo Alexey Navalny, il segreto dei segreti della Russia di oggi. Perché
questa specie di Versailles apparterrebbe, di fatto, a Vladimir Putin. Il
principe degli oppositori sfida frontalmente Putin dalla cella con un’inchiesta
sulla genesi e la gestione odierna del palazzo, che sarebbe costato oltre 1,1
miliardi di euro e sarebbe stato «regalato» al presidente come una tangente. «È
la struttura più segreta e sorvegliata della Russia, senza esagerare», scrive
Navalny, che all’inchiesta ha dedicato un intero sito, palace.navalny.com. Sul
sito sono pubblicate decine di foto satellitari della cittadella, prese dallo
staff dell’oppositore «con molta fatica». Navalny descrive la villa così:
«Questa non è una casa di campagna, non è una dacia, non è una residenza: è
un’intera città. O piuttosto un regno. Ha recinzioni inespugnabili, un porto, le
proprie guardie, una chiesa, un proprio controllo degli accessi, una no-fly
zone e persino un posto di controllo di frontiera. È direttamente uno Stato
separato all’interno della Russia. E in questo Stato c’è un unico e
insostituibile re: Putin».
14 mila metri quadri, 7.500 ettari di parco e la
«bufala» del proprietario. Secondo Navalny il complesso — circondando da 7.500
ettari di parco gestiti dall’FSB, di cui Putin è stato direttore, così da
evitare sguardi indiscreti — è dotato di palazzetto da hockey, un anfiteatro,
una casina per il tè collegata al complesso principale da un ponte di 80 metri,
nonché un accesso sotterraneo al mare che all’esigenza può diventare un bunker.
Il palazzo in sé, di tre piani, è dotato dei comfort più lussuosi, interamente
arredato da ditte italiane. In più, nel parco, ci sono vigneti e persino un
allevamento di ostriche. Questa storia, scrive Navalny, non è nuova: nel 2011 un
ex del circolo stretto putiniano, dopo essere fuggito a Tallin, aveva spifferato
tutto e l’esistenza del palazzo era stata rivelata al mondo. La spiegazione
diffusa dal Cremlino era stata che Putin aveva sì commissionato la costruzione
di questa villa, ma poi l’aveva interrotta ed era stato un uomo d’affari a
comprarla. Tutte sciocchezze, scrive Navalny. La sua inchiesta segue dunque per
filo e per segno il movimento dei quattrini, elenca i prestanome incaricati di
detenere le chiavi di accesso e ne descrive le affiliazioni con Putin.
Formalmente il palazzo apparterrebbe all’uomo d’affari Alexander Ponomarenko. Ma
come dice Navalny, «nessun imprenditore ha una no-fly zone sulla sua villa» o
vanta la guardia presidenziale come security.
La mappa e la sicurezza. La villa di Putin si
trova a Gelendzhik, verso la Crimea. Sarebbe — con 17.691 metri quadri di
estensione — il più grande edificio residenziale di tutta la Russia. È stata
costruita per non essere praticamente avvicinabile da terra, e con difficoltà
per mare e in elicottero. Chi arriva deve lasciare il cellulare, e lo accettano
tutte le maestranze della villa. Ci sono per auto barche e elicotteri decine di
checkpoint e chiunque arrivi viene perquisito. Le immagini di questo sito sono
tutte provenienti dal satellite. «Tutti ci dicevano che la villa era impossibile
da filmare. Noi ci siamo riusciti al terzo tentativo», scrive Navalny. Cosa
hanno visto: lavori di rifacimento estesi. Dopo 6 anni di lavoro la villa era
pronta. Ma piena di muffa. E così «si è voluto rifare tutto. Buttati via marmi,
mobili, preziosi». L’immagine di un Putin satrapo lontano dalla povertà del suo
popolo è sempre più chiara.
L’eliporto e il palazzetto da hockey. Le immagini
mostrano una pista per elicotteri e una collinetta verde di 56 metri per 26:
dentro c’è un campo da hockey su ghiaccio con pista olimpica.
L’anfiteatro. Ancora in costruzione, nel parco
della villa.
Il ponte di 80 metri verso la casina del té. Un
ponte nel verde verso una casina, meta di passeggiate.
I 7.500 ettari di parco di proprietà dei servizi
segreti. La villa e le sue pertinenze, circa 68 ettari, sono incastonate in
7.500 ettari sui quali c’è no-fly zone e vige un divieto di accesso dal mare.
Questo appezzamento di terra è di proprietà del Fsb, il servizio di sicurezza
russo. Perché, se non per scopi di protezione d un’altissima carica, scrive
Navalny, è impossibile accedere a quest’area se è di un’agenzia pubblica?
La piscina a piano terra. Il piano terra è
dedicato al relax, scrive Navalny. Spa, massaggi, piscine, saune, hammam. Le
foto sul sito sono molte e addirittura si possono scaricare come sfondi per le
proprie stories Instagram.
Un teatro al piano terra. Avere un teatro dentro
il palazzo era prerogativa degli zar: Putin non è da meno. C’è anche una
discoteca. Le foto dell’interno del palazzo divulgate da Navalny sono foto che
circolavano nel 2011, ai tempi della prima costruzione della residenza, prima
cioè dei lavori in corso ora.
La spa. Saune e Jacuzzi — le sale da bagno
srebbero però devastate dalla muffa, scrive Navalny, e in completo rifacimento.
Saloni e mobili in stile italiani. «Forzando molto
il nostro senso estetico», ironizza l’oppositore, «abbiamo ricostruito tutti gli
ambienti con tanto di decorazioni e mobilio». I mobili più preziosi, tutti
rigorosamente in stile, sono italiani, di due marchi: Pozzoli e Citterio Atena.
La villa conterrebbe 47 divani, di cui uno in cuoio da due milioni di rubli.
La chiesa comprata in Grecia. Nel parco della
villa c’è poi una chiesa ortodossa; comprata in Grecia e portata in Russia a
pezzi, è stata riassemblata negli ultimi anni.
Elisa Messina per "corriere.it" il 21 gennaio
2021. La video-inchiesta di Alexey Navalny sul palazzo segreto di Vladimir
Putin da oltre 1,1 miliardi di euro sul Mar Nero è stata vista da oltre 40
milioni di utenti in meno di 48 ore. Lo fa sapere la portavoce dell’oppositore
russo, Kira Yarmish, pubblicando su Twitter uno screenshot della pagina sui dati
di YouTube. Nell’inchiesta, pubblicata creando un sito ad hoc (palace.navalny),
Navalny, che è stato arrestato appena ritornato in Russia il 17 gennaio scorso,
assieme alla sua organizzazione, l’Anti-Corruption Foundation (FBK l’acronimo
russo), fa una dettagliatissima descrizione del lusso esagerato e costoso che
caratterizzano il gigantesco palazzo (17 mila metri quadrati) e il parco annesso
(68 ettari). Ma sono soprattutto le immagini degli interni (riprodotte
digitalmente grazie a rendering e progetti) a lasciare senza parole: super
piscina, saloni e sale da pranzo, sala da gioco con tavolo verde, teatro,
cinema, palestra, molte camere da letto tra cui spicca una, la più grande, da
oltre 76 metri quadrati (c’è un close-up della stanza anche dalla mappa del
palazzo) con un super letto a baldacchino e le tende di tulle bianco. Colpisce
anche la presenza di una sala night-club con velluti rossi alle pareti e
divanetti (made in Italy) che circondano un palco con un palo da lap-dance al
centro. Luogo di intrattenimento serale per ospiti di rilievo prevalentemente
maschili. Nel descrivere questo “salotto privato” Navalny non risparmia un certo
sarcasmo: «Quando abbiamo visto il progetto della stanza ci siamo chiesti a cosa
servisse il palo, forse era un campo di addestramento per vigili del fuoco».
Sala night club, grande letto a baldacchino in stile imperiale. Inevitabile, a
questo punto, ritornare con la memoria al tempo degli incontri tra il presidente
russo e l’allora presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi e alle
cronache di quel periodo, quando si faceva riferimento al «lettone con
baldacchino e tende bianche» che Putin avrebbe donato all’amico italiano. Così
dichiarò Patrizia D’Addario che in quel letto, a Palazzo Grazioli, nel novembre
2008, avrebbe trascorso un‘intera notte in compagnia del premier. Come fanno
parte delle cronache del tempo anche le visite di Vladimir Putin a Villa
Certosa, residenza sarda del fondatore di Forza Italia, e gli apprezzamenti che
il presidente russo non risparmiava all’ex premier per la bellezza della dimora,
del suo parco e delle sue attrazioni. Potrebbe aver preso ispirazione per la sua
villa sul Mar Nero. Di camere da letto lussuose nel piano nobile del
palazzo-reggia che Putin, secondo Navalny, avrebbe realizzato con fondi
illeciti, ce ne sono altre 10, anche se una sola ha le dimensioni e lo sfarzo
che si vede nell’immagine postata sul sito. Attigua alla stanza del lettone, una
sala da bagno-spa (sarebbe riduttivo chiamarlo solo bagno) in marmo bianco con
poltrone di broccato e un’enorme vasca sormontata (pure qui) da un baldacchino.
Stando alla descrizione di Navalny ci sarebbero due spa e un hammam al piano.
Molti gli arredi realizzati in Italia: solo di divani se ne contano almeno 47. E
made in Italy sarebbe anche uno scopino per il wc da 700 euro e un porta carta
igienica da mille euro. Tra le esagerazioni della villa e della sua tenuta nel
report si parla anche di vasti vigneti in cui la musica classica risuona 24ore
su 24 perché aiuterebbe la maturazione dell’uva. Lo confermano ai reporter di
Navalny i viticoltori della zona che avrebbero visitato la tenuta. Sempre
secondo il racconto degli attivisti-reporter del FBK la viticoltura sarebbe
«l’hobby molto costoso di Putin», perché al presidente russo piace offre il vino
qui prodotto agli ospiti, stando a quanto rivelano i menù dei pranzi qui
organizzati. Navalny pubblica anche la pianta dei vari piani del palazzo
dettagliando la dislocazione dei vari ambienti: sale, salette, vestiboli, sale
da pranzo, sale per riunioni. «Questo è come uno stato all’interno di uno stato
in cui governa uno zar inamovibile - dice Navalny nel documentario - È costruito
in modo che nessuno possa raggiungerlo via terra, mare o aria, a migliaia di
persone che ci lavorano è vietato portare anche un semplice cellulare con
fotocamera». In palazzo arredato con uno stile che rimanda da una parte allo
sfarzo del palazzo degli zar a San Pietroburgo e dall’altra al kitch lussuoso
dei casinò di Las Vegas non poteva mancare una vera sala da gioco: enormi
lampadari di cristallo sopra tavoli verdi. Una parte della descrizioni di
Navalny è dedicata alle spese per la costosa mobilia e fa l’esempio di un
tavolino realizzato da un’azienda italiana del valore di oltre 50mila euro e i
divani da circa 20mila euro ciascuno. Dietro la realizzazione di questa reggia
ci sarebbe un complesso sistema di finanziamenti illeciti che Navany spiega nel
video e documenta con grafici. L’ufficio del presidente russo nega ogni cosa.
Ufficialmente, Putin possiede una villa, ben più piccola, solo a Sochi, dove si
erano tenute le Olimpiadi Invernali.
Paolo G. Brera per “La Repubblica” il 25 gennaio
2021. Parla Cirillo, architetto del palazzo sul Mar Nero al centro
dell'inchiesta di Navalnyj di Paolo G. Brera «Quel palazzo è un'eccellenza
italiana, e ne sono orgoglioso». Lanfranco Cirillo, 61 anni, l'architetto
bresciano che secondo un'inchiesta della Fondazione anti-corruzione di Navalnyj
ha costruito la villa faraonica «di Putin» sul mar Nero, arredata con mobili
delle più esclusive aziende italiane e ispirata a Villa Certosa di Berlusconi, è
in partenza per l'Africa: «Vado per la mia fondazione sul clima». Da qualche
anno vive a Dubai: «Combatto per la difesa degli Oceani, ho finanziato
laboratori scientifici al Polo. Facevo una vita da matti, poi un giorno arrivi a
casa e trovi tua figlia con metastasi dappertutto. Ho detto basta, me ne vado.
Hanno cercato di trattenermi, C'era anche il capo della sicurezza del Cremlino.
Ho detto: se non capite cosa sia la famiglia non mi interessa più lavorare con
voi».
Per la villa sul mar Nero vi siete ispirati a
Villa Certosa?
«Ma no, sono molto diverse per dimensioni e stile.
Villa Certosa è francese mediterraneo, il palazzo di Gelendzhik neoclassico.
Solo l'anfiteatro può ricordare Villa Certosa. Ma l'uscita a mare l'abbiamo
fatta prima noi! E la pole dance è un'invenzione: nella ricostruzione le pareti
sono di colore diverso e le finiture non corrispondono».
È stato Putin a volere il palazzo fatto così? Lei
con chi trattava?
«Io non ho fatto la casa per il presidente. Ero
commissionato da una società moscovita, Stroi Gas Consulting Ltd. Avevo altri
interlocutori e contratto regolare, e mi hanno pagato. Putin non l'ho mai
incontrato lì, e non ho mai discusso con lui di quel progetto».
È stato pagato con fondi destinati alla sanità?
«A quanto so la società medicale a cui fanno
riferimento è privata, non vedo illeciti. Non faccio politica né il finanziere,
non ho informazioni sulla provenienza dei soldi: le persone che ne discutono
fanno guerra tra loro».
Nelle intercettazioni c'è anche lei e la sua
società Medea.
«Dico che devono pagare i mobili che ho ordinato.
Medea non è mia, penso fosse una società ponte per far arrivare i soldi in
Italia. Tutto legale, sono cittadino italiano».
E russo.
«Sì, un onore concessomi da Putin. Se avessi fatto
cose illegali la giustizia italiana me lo avrebbe contestato, no? Ho fatto il
mio mestiere, portando l'immagine del nostro Paese in Russia al più alto
livello».
Navalnyj dice che Putin comprò il suo silenzio con
una delle 4 ville nelle vicinanze. È vero?
«Nessuno mi ha mai regalato nulla. Le case di cui
parla le ho disegnate ma non sono mai state mie. Villette a schiera di 400 mq
l'una con entrata e portico, 3 camere, soggiorno, 4 terrazze, tre bagni e una
camera al piano di sopra. Belle, ma non regge. Sono andate a persone vicine a
Putin, e sono partite le polemiche».
Putin era contento del palazzo? Ci va, l'ha
venduto?
«Non ne ho idea, ma la casa è molto bella: abbiamo
portato centinaia di camion dall'Italia dando lavoro a aziende, falegnami,
decoratori, parchettisti. Ha 90 colonne, marmi spettacolari, piscina e Spa; un
home theatre molto grande, passeggiata e parco con migliaia di cipressi e piante
aromatiche italiane. Ha 12 stanze da letto, un'orangerie di 800 mq, serre per le
piante d'inverno, l'anfiteatro in travertino romano... Ne sono orgoglioso».
La villa di Putin a sua insaputa.
Michele Serra su Espresso il 31/1/2021. Fa molto discutere la favolosa villa di
Putin sul Mar Nero, così grande che dall’ala Est all’ala Ovest cambia il fuso
orario. Lui, come strategia difensiva, ha adottato la rinomata Linea Scajola,
ormai canonizzata nei testi giuridici di tutto il mondo: «La villa è stata
costruita a mia insaputa». Le illazioni Nel frattempo si cerca di fare chiarezza
sulle informazioni diffuse dall’opposizione russa (che da qualche anno si divide
in due principali organizzazioni politiche: Partito dei Detenuti, Partito degli
Imputati in attesa di giudizio). È vero, per esempio, che la dimora dispone di
un campo da hockey sotterraneo? Il Cremlino smentisce con sdegno quella che in
un comunicato viene definita «la classica illazione malevola per screditare il
governo»: il campo di hockey si trova infatti al terzo piano. Quanto
all’allevamento di ostriche, agli scopini da cesso da 700 euro, ai portarotolo
di carta igienica da mille euro l’uno, si tratta molto semplicemente di regali
di Silvio Berlusconi che sta cambiando gli arredi di Villa Certosa. Lo
stile Critici d’arte e studiosi di estetica, in tutto il mondo, stanno cercando
da molti anni di codificare lo stile Berlusconi-Putin. L’orso impagliato in ogni
stanza da letto (sostituito da un orso vivo per gli ospiti più prestigiosi) è la
variante russa, ma l’estetica italiana rimane dominante. Non per caso il
progettista della villa di cui tanto si parla è un italiano, presentato a Putin
da Toto Cutugno. L’ispirazione è neoclassica: colonnati dappertutto, anche nei
bagni, dove i capitelli corinzi fungono anche da portasciugamani. I letti
girevoli con baldacchino, i bidet con idromassaggio, il posto-auto accanto al
letto, il comodino abbastanza capiente da potervi riporre una escort, sono tutte
soluzioni di arredamento già presenti nelle principali dimore di Berlusconi. È
un modello che tutto il mondo ci invidia: lo stesso Trump, per rinfrescare gli
arredi della Casa Bianca, si è ispirato a Rete Quattro. La politica Il dibattito
politico, in Russia, verte soprattutto su una domanda: visto come sono andate le
cose, non valeva la pena tenerci lo zar? La famiglia Romanov aveva lo stesso
potere di Putin, ma un tenore di vita molto meno costoso. Quanto agli
aristocratici, rispetto agli attuali oligarchi almeno sapevano stare a tavola
senza soffiarsi il naso col tovagliolo e pulirsi le unghie con la forchetta. Non
parliamo poi delle spese militari: per arrestare tremila persone in un
pomeriggio, come ha fatto Putin, è stato necessario un numero di uomini pari a
quello che affrontò Napoleone sulla Beresina. Un piano alternativo Per mantenere
l’ordine pubblico, si calcola che un uso interno dell’arsenale atomico
costerebbe meno dell’attuale esborso in personale di polizia, servizi segreti,
esperti di veleni, centrali di fake-news, eccetera. Le atomiche sono già lì,
inutilizzate, da molti anni. Il classico investimento da ammortizzare.
Collaboratori di Putin erano in stretto contatto, a questo proposito, con Steve
Bannon e altri strateghi dell’amministrazione Trump. L’idea era un attacco
nucleare simultaneo, russo contro i russi, americano contro gli americani. Con
un innegabile effetto-sorpresa che avrebbe spiazzato i cosiddetti esperti. I
gasdotti L’enorme potere economico dell’oligarchia russa è dovuto a due fattori.
Il primo è che l’intero patrimonio dello Stato è stato rubato, dopo la caduta
del comunismo, da chi è riuscito a fare irruzione per primo negli uffici del
Cremlino, frugare nei cassetti e trovare i moduli per intestarselo. Il secondo è
la straordinaria ricchezza di gas. L’economia russa si divide infatti nei
seguenti settori: giacimenti di gas, gasdotti, contatori del gas, tubi del gas,
fornelli a gas. Putin può contare su ottimi amici in tutti e cinque i settori.
Secondo gli osservatori internazionali, è soprattutto sui Paesi con cucine a
lunga cottura (stufati, stracotti, minestroni, bolliti) che la Russia punta per
la sua penetrazione economica, mentre ha scarsa presa su Paesi dove la cucina è
a base di cibi freschi e cibi crudi.
Aldo Cazzullo per il "Corriere della Sera" il 28
gennaio 2021. Aleksej Anatolevic Navalny è un eroe. La parola è abusata. Ma non
si potrebbe definire diversamente un uomo disposto a mettere in gioco i suoi
beni, i suoi cari, la sua stessa vita, per il suo Paese. Perché opporsi a
Vladimir Putin significa essere disposti a mettere in gioco la vita. Navalny ha
passato 14 mesi agli arresti domiciliari. È stato avvelenato, è finito in coma,
ha rischiato di morire. La Germania l' ha accolto. Ma Navalny non voleva vivere
in esilio; tanto meno diventare una pedina dello scontro tra Putin e Angela
Merkel, che si combattono in pubblico ma quando si incontrano in privato
confabulano per mezz' ora a tu per tu, senza interpreti (la Cancelliera parla
russo e il neo-Zar parla tedesco; del resto, entrambi si sono formati nella
Ddr). Navalny voleva combattere e, se necessario, morire in patria. Così è
tornato a Mosca, dove sapeva che l' avrebbero atteso le manette e la cella per
chissà quanto tempo, dimostrando un coraggio anche fisico d' altre epoche, che
evoca quello di un Giuseppe Garibaldi o di un Giuseppe Mazzini. Non sembri un
accostamento eccessivo. Gli eroi del Risorgimento italiano erano gli uomini più
famosi del mondo. Ovunque ci fosse un popolo oppresso, si custodivano i loro
ritratti nelle case, si scandivano i loro nomi nei cortei. Purtroppo non
possiamo dire lo stesso di Navalny. Il suo arresto, la persecuzione dei suoi
collaboratori - tutti in esilio o in galera -, la brutale repressione dei
manifestanti scesi in piazza a sua difesa non hanno suscitato nell' opinione
pubblica globale l' emozione che meriterebbero. Certo, altre cose incombono: la
crisi sanitaria e quella economica, che in Italia sono diventate anche crisi del
sistema politico. E la rete, se può essere una formidabile arma di
organizzazione del dissenso - in rete è nato il movimento di Navalny, essendo i
media tradizionali controllati rigidamente dal Cremlino -, può rivelarsi anche
un' arma di distrazione di massa. Navalny è un eroe, non un santo. Molte sue
idee sono discutibili (come emerse dall'intervista-scoop che Paolo Valentino gli
fece sul Corriere nel 2016). È un democratico, ma è anche un nazionalista. Nei
suoi occhi Enzo Bettiza avrebbe forse intravisto quel «lampo di follia» che
secondo lui balenava «nello sguardo dei russi bianchi». Inoltre, Navalny non ha
con sé la maggioranza dei connazionali, che sono riconoscenti a Putin per aver
riportato l'immenso Paese tra le superpotenze, sia pure a prezzo di una guerra
di sterminio in Cecenia, dell' aggressione alla Georgia e all' Ucraina, dei
dispendiosi interventi in Medio Oriente e in Nordafrica. Ma Navalny non è
isolato. L' ultima volta che poté presentarsi alle elezioni, quando nel 2013 si
candidò sindaco di Mosca, raccolse il 27%. Le sue denunce sulla corruzione del
regime sono state confermate dai fatti. La «Russia del futuro», che è anche il
nome del suo partito, non potrà fare a meno di lui. Ieri Putin ha parlato al
mondo dal podio digitale di Davos. L'altro ieri ha avuto la prima, difficile
telefonata con il nuovo presidente americano. Il momento è cruciale. La Russia
ha la sua atomica e il suo vaccino, ha l' energia e i gasdotti per esportarla,
ha un esercito e a differenza degli europei è disposta a usarlo. Tutto questo
induce giustamente le democrazie dell' Occidente a prendere Putin molto sul
serio. Ma proprio perché siamo democrazie, nessuno di noi dovrebbe dimenticare
che la forza della libertà alla lunga si rivela insopprimibile; persino per un
autocrate talmente cinico da dire che «se davvero l' avessi fatto avvelenare io,
Navalny sarebbe morto».
Da Open.online il 26 agosto
2021. Per la prima volta dal suo arresto, il politico russo Alexei Navalny ha
rilasciato un’intervista dal carcere. Nelle 54 pagine di risposta alle domande
messe per iscritto dal New York Times, Navalny ha parlato dei suoi 8 mesi di
carcere. A gennaio, l’attivista russo era stato arrestato al suo arrivo
all’aeroporto di Mosca dopo mesi di convalescenza passati in Germania a causa
delle conseguenze di un avvelenamento. Quando si pensa alle carceri russe, dice,
si immaginano «uomini muscolosi tatuati, con denti d’acciaio che combattono con
i coltelli per prendere il miglior lettino vicino alla finestra». Invece, «devi
immaginare qualcosa come un campo di lavoro cinese, dove tutti marciano in fila
e dove le telecamere sono appese ovunque. C’è un controllo costante». Durante il
giorno, «guardiamo film sulla Grande Guerra Patriottica», ha detto Navalny
riferendosi alla Seconda guerra mondiale, «o su come un giorno, 40 anni fa, i
nostri atleti hanno sconfitto gli americani o i canadesi». «Quando vedo queste
cose», ha detto Navalny, «capisco molto chiaramente l’essenza dell’ideologia del
regime di Vladimir Putin: il presente e il futuro vengono sostituiti con il
passato – il passato veramente eroico, o il passato abbellito, o il passato
completamente immaginario. Tutti i tipi di passato devono essere costantemente
sotto i riflettori per allontanare i pensieri dal futuro e dal presente». Per
quanto riguarda le sue condizioni di salute, Navalny dice che sono migliorate da
quando le guardie hanno smesso di svegliarlo ogni notte. «Ora capisco – ha detto
– perché la privazione del sonno è una delle torture preferite dei servizi
speciali. Non rimangono tracce, ed è impossibile tollerarlo». Come fatto più
volte, Navalny ha poi criticato l’Europa e gli Stati Uniti per le sanzioni
economiche imposte alla Russia. Per il politico russo, le sanzioni hanno
danneggiato la vita delle persone comuni, e rischiano di allontanare molte
persone dalla politica: «Così perdiamo alleati importanti».
Jacopo Iacoboni per "la Stampa" il 28 gennaio
2021. «Alexei Navalny è rinchiuso in una prigione molto particolare a Mosca. Si
chiama "Kremlin Central" e non è un comune centro di detenzione», spiega Olga
Zeveleva, sociologa del Social Sciences Lab a Cambridge, studiosa di Storia
delle prigioni. È una delle sette prigioni storiche del Kgb in Russia. Luoghi
infami, ma che potrebbero porre un problema anche alla Russia, se l' Ue
prestasse attenzione al caso. Sentite perché. Mentre ieri dei presunti agenti si
sono presentati a casa del dissidente e di sua moglie, Yulia, per effettuare una
perquisizione (il capo dell' FSb ha incredibilmente detto che la coppia ha
violato le norme sanitarie sul Covid), Navalny è tuttora rinchiuso nel carcere
«Fku Sizo-1 Fsin», detto appunto «Kremlin Central» una delle 7 carceri russe
subordinate all' amministrazione penitenziaria centrale. Si tratta di un blocco
separato della prigione «Fku Sizo-1 Ufsin» (il nome è quasi identico), nota
invece come «Matrosskaya Tishina» o Sailor' s Silence, che spesso vengono
confuse perché allo stesso indirizzo. In realtà «Kremlin Central» è qualcosa di
molto diverso, e con una sua storia nera, in Russia. Navalny, arrivando a
Kremlin Central, ha detto: «Ho letto di questa prigione nei libri, e ora sono
qui. Vita in Russia». Le altre sei carceri speciali si trovano nei maggiori
luoghi strategici: sono Fku Sizo-2 Fsin o Lefortovo, che era la prigione
principale del Kgb a Mosca; Fku Sizo-3 Fsin a San Pietroburgo noto come
Shpalernaya; Fku Sizo-4 Fsin a Rostov-on-Don; Fku Sizo-5 Fsin a Krasnodar Krai;
Fku Sizo-6 Fsin a Vladikavkaz in Ossezia e Fku Sizo-7 Fsin a Chelyabinsk. In
pratica, sono le sette prigioni più segrete in Russia e, secondo convinzione
degli studiosi, sono tuttora gestite de facto dall' Fsb. «Fino al 2008 - spiega
la studiosa di Oxford Judith Pallot, una delle grandi esperte in materia - le
sette carceri, incluso "Kremlin Central", erano ufficialmente subordinate all'
Fsb, che le aveva ereditate dal Kgb nel 1994. Poi sono state trasferite sotto il
controllo degli Interni, ma sono state restituite all' Fsb nel 1997, fino al
2008, quando sono stati trasferiti al servizio carcerario (ministero della
Giustizia). L' Fsb si è opposto fermamente alla perdita delle sue prigioni, ma
sembra sia stato in grado di mantenere il controllo de facto almeno su alcune di
esse», dice Pallot, che ha intervistato detenuti delle 7 prigioni, che in alcuni
casi coincidono tuttora con il quartier generale dell' Fsb. Kremlin Central è
solo un po' più giovane dell' infame Lefortovo: nacque nel 1985. A Kremlin
Central vennero tenuti in duro isolamento serial killer, presunti terroristi,
mafiosi invisi al regime (gli amici sono a piede libero), intellettuali o
artisti, famosi, alti funzionari governativi e imprenditori pericolosi per il
regime. Putin vi rinchiuse, per dire, Platon Lebedev, Mikhael Khodorkovsky,
Alexei Pichugin. O nemici politici che voleva far fuori, come l' ex ministro
dell' economia Aleksei Ulyukaev. Senonché, stando alle norme che vincolano anche
la Russia in quanto appartenente al Consiglio d' Europa, l' Fsb non dovrebbe
gestire alcuna prigione: viola i diritti umani dei detenuti avere un' agenzia
che, ad un tempo, fa indagini e avvelenamenti di dissidenti, e poi è
responsabile anche della loro custodia.
Le proteste in Russia. Chi è Yulia
Navalny, moglie dell’oppositore russo e nuova leader anti-Putin.
Antonio Lamorte su Il Riformista l'1 Febbraio 2021. Decine di
migliaia di persone in piazza, città bloccate, metro chiuse. Manifestanti
pacifici in Russia e, secondo l’ong Ovd-Info, oltre 5mila sono stati fermati.
Tra questi anche Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo Aleksey Navalny.
L’avvocato 44enne è in carcere, al Matrosskaya Tishina di Mosca, è il principale
dissidente del Presidente Vladimir Putin. E i russi scendono in piazza, come non
succedeva da decenni. Con il fratello del dissidente Oleg in carcere, come la
collaboratrice Lyubov Sobol, Yulia Navalny potrebbe raccogliere l’eredità della
leadership del marito, lo scrivono in tanti, già in questi giorni è al centro
dell’attenzione dei media. Le proteste erano esplose già lo scorso fine
settimana in Russia. Gli agenti sono intervenuti a colpi di manganello e taser,
anche quando i manifestanti erano già nelle loro mani. A far esplodere questa
ondata di malcontento verso Putin il caso dell’avvelenamento e dell’arresto di
Navalny e la pubblicazione, sempre da parte dell’avvocato, attraversi la
Fondazione anticorruzione da lui creata, di un’inchiesta sul “castello
segreto” sul Mar Nero da oltre 7.000 ettari. Il 17 gennaio, al suo rientro in
Russia, dopo le cure a Berlino, l’arresto di Navalny all’aeroporto di Mosca.
Domani sarà processato per violazione del controllo giudiziario: potrebbe
scontare tre anni e mezzo per una condanna per truffa (una sorta di pena
sospesa) e altri 10 anni per appropriazione indebita. All’aeroporto, già
diventato simbolico, lo scatto del bacio con la moglie Yulia. “Mi hai salvato”,
aveva scritto su Telegram Aleksey al risveglio nell’ospedale di Berlino. Yulia
Navalnaya è laureata in Relazioni Internazionali, ex funzionaria di banca, 44
anni. La coppia ha avuto due figli. La donna ha vissuto tutte le aggressioni e
le sventure giudiziarie, politiche e personali del marito. Lo scorso agosto,
dopo un tour elettorale in Siberia, l’avvelenamento di Navalny con il gas
nervino Novichok. Soltanto l’atterraggio di emergenza ha salvato la vita
all’avvocato. Yulia parlava con i giornalisti e metteva in dubbio le
esternazioni dei medici di Omsk, dove Navalny era ricoverato. È stata lei a
scrivere a Putin per chiedere il trasferimento in Germania. Con l’avvelenamento
del marito la personalità di Yulia è emersa come mai era successo prima. Se
Navalny sarà condannato, molti ipotizzano, potrebbe essere lei a sostituirlo
nella leadership. C’è chi anticipa una sua candidatura alle parlamentari di
settembre. Nessuna conferma. È stata arrestata durante le proteste del 23
gennaio e ieri, quando agenti in assetto antisommossa l’hanno fermata e caricata
su un furgoncino scuro impedendole di raggiungere il carcere di Mosca dov’è
detenuto il marito. Yulia oggi dovrà comparire in tribunale. “Il suo ruolo è
certamente cambiato. Ha carisma e fascino, è una persona creativa e coraggiosa e
può facilmente sostituire suo marito se necessario”, spiega l’esperto di
politica russa Konstantin Kalachev all’Afp. Alcuni media la descrivono come un
agente destabilizzatore della Russia per contro dell’Occidente. Proprio come il
marito e il Fondo Anti-Corruzione creato dallo stesso Navalny.
Le 5 mosse con cui Alexei Navalny ha
messo spalle al muro. Dalle accuse per l’avvelenamento
al video che mostra il castello sul Mar Nero, il leader dell’opposizione accende
la piazza e l’arresto rivela la debolezza del presidente. E l'ondata di
manifestazioni e arresti lo dimostra. Svetlana Ivanova su L'Espresso il 2
febbraio 2021. a Russia è una terra sconfinata: il Paese più grande del mondo.
Qui, il tempo e lo spazio si scambiano e a volte coincidono in modo
imprevedibile. Quando il sole comincia il suo giro, parte da Vladivostok e
quando termina il suo viaggio, a San Pietroburgo, ha attraversato 10 fusi orari
e più di diecimila chilometri. Il giorno delle proteste in Russia è stato perciò
un giorno esteso quanto tutto il Paese. Una vera e propria staffetta di
manifestazioni da una parte all’altra della nazione. Una protesta collettiva che
ha abbattuto ogni limite di tempo e spazio. Non deve esser stata una giornata
semplice, quella del 23 gennaio.
Paolo Valentino per il "Corriere della Sera" il 2
febbraio 2021. La Francia ha chiesto a Berlino di abbandonare il Nord Stream 2,
il controverso gasdotto russo-tedesco in via di completamento sotto il Mar
Baltico, come risposta all'incarcerazione del dissidente Alexeij Navalny e alla
repressione da parte del Cremlino delle dimostrazioni in suo favore. «Occorre
essere lucidi: penso che sia un'opzione da considerare, visto che le sanzioni
già prese non sono bastate», ha detto il segretario di Stato francese agli
Affari europei, Clement Beaune, che ha confermato i «grossi dubbi» del
presidente Macron sul progetto, precisando tuttavia che l'eventuale abbandono
sarebbe «una decisione tedesca». «Significa che la Francia vuole la fine del
Nord Stream 2?», gli è stato chiesto. «Lo abbiamo appena detto», è stata la
risposta di Beaune. È la prima volta che Parigi si pronuncia in modo netto per
la rinuncia definitiva al gasdotto da parte di Berlino ed è un brutto colpo per
la cancelliera Merkel, che fin qui aveva potuto contare sulla neutralità quanto
meno apparente di Emmanuel Macron, il suo principale alleato in Europa. Merkel
tuttavia non è intenzionata a cedere su un progetto che è sostenuto a spada
tratta dall'industria tedesca ed è considerato «esistenziale» per i partner di
governo socialdemocratici, nel solco storico della Ostpolitik e dei buoni
rapporti economici con la Russia. Ieri una portavoce della cancelleria ha
ribadito che «il governo federale non ha cambiato la sua posizione di base»,
quella che considera il gasdotto separato dalla questione dei diritti umani. A
sostegno del condotto è tornato anche a parlare l'ex cancelliere
socialdemocratico Gerhard Schröder, l'uomo che firmò con Putin il contratto per
il Nord Stream 2 e oggi presiede il consorzio che lo sta realizzando: «Se lo
abbandoniamo tagliamo il ramo della politica energetica sul quale siamo seduti».
Ma la posizione di Merkel si fa sempre più difficile. Intanto perché
dall'interno stesso della Cdu, il suo partito, si levano voci importanti a
favore dell'abbandono, a cominciare dal presidente della Commissione esteri del
Bundestag, Norbert Röttgen. Ma anche perché, di fronte al caso Navalny e alla
nuova ondata repressiva in atto in Russia, la cancelliera subisce una doppia
pressione sulla scena internazionale: quella degli alleati europei, quasi tutti
schierati per l'abbandono del Nord Stream 2 e con i quali il suo stesso
portavoce, Steffen Seibert, ha ammesso che sono in corso «discussioni
difficili». Ancora più imbarazzante per Merkel è l'offensiva della nuova
amministrazione americana, decisa a varare nuove sanzioni extraterritoriali
oltre quelle che per un anno hanno di fatto fermato il progetto, i cui lavori
sono ripresi da poche settimane. Cercando di bloccare il Nord Stream 2 gli Stati
Uniti perseguono un doppio obiettivo: primo impedire che l'Europa diventi troppo
dipendente da Mosca per il suo fabbisogno energetico e compri invece il gas da
argille made in Usa; secondo evitare che l'Ucraina, una priorità per Joe Biden,
sia in parte bypassata dai nuovi tubi sottomarini. Insistere sul gasdotto
baltico significa quindi per Merkel mettere a rischio la ripartenza nei rapporti
con Washington, dopo il disastro dell'era Trump. La reputazione di Angela Merkel
sulla scena internazionale è anche, ma non solo, basata sul fatto che la
cancelliera intende sempre quello che dice. Ma nel caso del Nord Stream 2, la
sua onestà intellettuale la mette tra l'incudine e il martello: se va avanti
rischia di pagare un prezzo politico altissimo, se lo blocca i contribuenti
tedeschi dovrebbero onorare penali molto salate.
Perché i rapporti tra Germania e Russia
non sono mai stati tanto deteriorati. L’uccisione di
un ceceno in pieno centro, il caso Navalny, l’attacco informatico al Bundestag:
fra i due Paesi le relazioni sono diventati pessime e l’affare
multimiliardario del gasdotto Nord Stream potrebbe essere bloccato. Roberto
Brunelli su L'Espresso l'1 febbraio 2021. A sangue freddo d’estate in un parco a
Berlino. «La prima cosa che ho sentito è stato il suono di uno sparo. Poi l’urlo
di una donna. Davanti a me, a circa trenta metri, un uomo scende dalla
bicicletta. Un altro uomo è per terra. Quello della bicicletta fa due o tre
passi nella sua direzione, gli punta una pistola alla testa e spara. Due volte.
Poi torna alla bicicletta, infila l’arma in uno zaino e riparte. Portava una
parrucca». A parlare è Eugene D., 60 anni, insegnante d’inglese, uno dei
principali testimoni al processo che potrebbe segnare il punto di non ritorno
nei rapporti tra la Germania e la Russia: alla sbarra c’è Vadim Sokolov, 50
anni, l’uomo arrestato poco dopo il delitto compiuto in pieno giorno - il 23
agosto 2019 - al parco Kleiner Tiergarten. La vittima è Zelimkhan Khangoshvili,
quarantenne georgiano che aveva combattuto con i ribelli ceceni, odiato da
Mosca, freddato con una Glock 26 dotata di silenziatore mentre stava andando in
moschea. Il russo che secondo gli inquirenti tedeschi è il killer, invece, si
chiamerebbe in realtà Vadim Krasikov, e non sarebbe un pacifico ingegnere edile
come affermato dal suo avvocato, bensì un ex combattente che, tra l’altro, negli
anni Ottanta faceva parte di un’unità speciale in Afghanistan. «È stata
un’esecuzione», insiste Eugene D., a quanto riferisce la Berliner Zeitung. «Il
killer era freddo e sicuro di sé».
Fabrizio Dragosei per il "Corriere della Sera" il
26 gennaio 2021. Per ora niente nuove sanzioni europee contro la Russia, ma
pressioni continue sul Cremlino per la liberazione di Aleksej Navalny e
monitoraggio attento di quello che sta accadendo in Russia. E in un clima sempre
più acceso, Mosca e Washington si scambiano accuse particolarmente dure. Gran
parte dei 3.700 fermati delle dimostrazioni di sabato sono stati rilasciati.
Alcuni hanno ricevuto multe e un certo numero dovrà fare qualche giorno di
prigione. Per altri saranno i giudici a decidere nei prossimi giorni. Questo
mentre i sostenitori del blogger che si trova in carcere hanno convocato nuove
riunioni di massa per domenica. L' Ue tiene in sospeso nuove sanzioni e vuole
prima provare a intavolare un dialogo con i vertici russi tramite il
Rappresentante per la politica estera Borrell che sarà a Mosca il 5 febbraio.
Nel frattempo inizieranno le udienze per decidere se far finire in carcere
Navalny per tre anni e mezzo. È chiaro che da quello dipenderà il discorso sulle
sanzioni europee. I Paesi ex Urss ed ex Patto di Varsavia (i Baltici, Polonia,
Romania) spingono per decisioni dure. Altri, come la Germania, frenano e
soprattutto non vogliono che ci vada di mezzo il raddoppio del gasdotto sotto il
Mar Baltico (Nord Stream) che porta direttamente il metano russo e che sta molto
a cuore a Berlino. Ieri intanto il ministero degli Esteri di Mosca ha inviato
una protesta all' ambasciata Usa per un presunto sostegno alle manifestazioni di
sabato scorso. In realtà la sede diplomatica aveva diffuso un usuale avviso ai
cittadini Usa a tenersi lontani dai raduni, a girare sempre col passaporto, ad
evitare assembramenti. Ma aveva anche indicato orari e luoghi degli appuntamenti
(definiti «non autorizzati») nelle varie città. Il governo di Mosca ha ritenuto
che questo fosse uno stratagemma per far pubblicità alle proteste. Putin non sa
proprio cosa fare con Navalny. Il caso ormai ha avuto una tale risonanza
(avvelenamento con il Novichok nelle mutande, eccetera) che le ripercussioni
internazionali di eventuali condanne penali potrebbero essere gravissime per l'
economia russa. Ma d' altra parte il blogger è una spina nel fianco del potere
con le sue documentate inchieste sulla corruzione. Basti pensare al fatto che il
filmato sul cosiddetto «castello di Putin» ha avuto 88 milioni di
visualizzazioni. La cifra continua a salire e le smentite sembrano lasciare il
tempo che trovano. Ieri Putin ha detto che quella proprietà non è sua né di
nessun suo parente. Ma Navalny ha sempre sostenuto che tutto è intestato a dei
prestanome. E il presidente russo non ha potuto negare che alcuni dei personaggi
citati come finanziatori siano suoi conoscenti o amici.
Giuseppe Agliastro per "La Stampa" il 23 gennaio
2021. Repressione, arresti e censura: sono queste le armi che il Cremlino ha
deciso di usare per soffocare le proteste contro la detenzione di Aleksey
Navalny. Le manifestazioni a sostegno del rivale numero uno di Putin cominciano
oggi in 65 città della Russia e le autorità hanno già promesso che useranno le
maniere forti. Il giro di vite in realtà è iniziato ancora prima delle proteste.
Alcuni dei più stretti collaboratori di Navalny sono stati infatti trascinati in
commissariato, compresa la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, condannata a
dieci giorni di reclusione, mentre a social media e siti internet è stato
ordinato di cancellare immediatamente gli appelli a scendere in piazza con cui i
più giovani hanno sommerso il web. La polizia di Mosca ha lanciato un chiaro
avvertimento: i cortei «verranno considerati una minaccia all'ordine pubblico e
saranno subito repressi». In Russia vige una legge che è una contraddizione in
termini: per manifestare contro le autorità serve il permesso delle stesse
autorità, e queste non hanno alcuna intenzione di permettere i cortei a favore
di Navalny. Il trascinatore delle proteste anti-Putin è stato sbattuto in galera
non appena ha rimesso piede a Mosca dopo un avvelenamento per il quale i
principali indiziati sono proprio il Cremlino e i suoi servizi segreti. Rischia
di rimanere in cella parecchi anni perché sul suo capo pendono quattro grane
giudiziarie. Di certo Navalny ha lanciato a Putin una sfida senza precedenti:
non solo è tornato in Russia pur sapendo che con ogni probabilità sarebbe finito
in galera, ma ha continuato a pungere il presidente russo anche dal carcere.
L'ultima video-inchiesta della sua Fondazione Anticorruzione risale infatti a
quattro giorni fa ed è una bomba mediatica contro Putin: accusa il leader del
Cremlino di possedere una villa da mille e una notte sul Mar Nero con tanto di
casinò, vigneti, un teatro. Il tutto realizzato con fondi illegali per un costo
di oltre un miliardo di euro. La presidenza russa smentisce, ma il filmato sta
spopolando sul web e ieri contava già 55 milioni di visualizzazioni. Su Internet
Navalny pare avere la meglio su Putin. Tik-Tok si è riempito di brevi video di
ragazzi che si dicevano pronti a scendere in piazza. Alcuni nelle scuole
sostituivano il ritratto di Putin con quello del dissidente in carcere. In pochi
giorni, questi filmati hanno raccolto oltre 200 milioni di click e le autorità
hanno reagito ordinando, e ottenendo, la loro rimozione con la minaccia di multe
salatissime per Tik-Tok e gli altri social media. L'Occidente intanto continua a
premere per il rilascio di Navalny. Il presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel, ha parlato al telefono con Putin ribadendo che «l'Ue è unita nella sua
condanna per la detenzione» dell'oppositore che ieri, come garanzia per la
propria incolumità, ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di
suicidarsi. Giovedì il Parlamento Europeo ha chiesto di «interrompere
immediatamente il completamento» del gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe
raddoppiare il flusso di gas russo che giunge in Germania attraverso il Baltico.
Lunedì i ministri degli Esteri della Ue si troveranno per decidere la linea.-
CASO NAVALNY. Timide sanzioni dell'UE nei
confronti della Russia. Da tvsvizzera.it il 22
febbraio 2021. (TG del 22.2.2021). Alexei Navalny è stato condannato a due anni
e otto mesi di carcere. L'Unione Europea ha raggiunto un'intesa per sanzioni
contro quattro non meglio precisati alti funzionari russi coinvolti nei
procedimenti giudiziari contro l'oppositore Alexei Navalny. La risposta di
Bruxelles circa il caso dell'oppositore russo Alexey Navalny, condannato il 2
febbraio scorso a due anni e otto mesi di carcere, era attesa. Tuttavia, la
decisione dei ministri degli esteri dei 27 di limitarsi a sanzionare solo
quattro alti funzionari è accolta con delusione da chi voleva un intervento più
deciso nei confronti delle autorità russe. La risposta europea è "mirata,
proporzionata e giuridicamente inattaccabile", ha sostenuto un ministro. "È
difficile punire gli oligarchi. Possiamo agire solo contro i funzionari, e solo
se abbiamo prove", aveva spiegato il capo della diplomazia lussemburghese Jean
Asselborn prima della riunione. Le sanzioni europee consistono in un divieto di
visto e un congelamento dei beni nell'UE per le persone o entità interessate. Il
Cremlino aveva lanciato un avvertimento agli europei prima del loro incontro.
Mosca è "pronta a reagire" in caso di un "nuove misure restrittive, unilaterali
e illegittime", aveva avvertito l'ambasciatore russo presso l'UE, Vladimir
Tchijov, in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Le cerchie vicine a
Navalny hanno da parte loro espresso disappunto: "Punire qualche funzionario del
Cremlino che non ama viaggiare e non ha proprietà all'estero, servirà a ben poco
e non farà passare alcun tipo di messaggio", ha dichiarato Leonid Volkov,
presente a Bruxelles per chiedere sanzioni nei confronti degli oligarchi vicini
al presidente Putin. Lo stesso Navalny nel novembre scorso, durante la sua
convalescenza in Germania dove era stato curato dopo il tentativo di
avvelenamento in Russia, aveva sottolineato la necessità di "prendere di mira il
denaro, gli oligarchi, non solo quelli vecchi ma anche i nuovi, i membri della
cerchia ristretta di Putin".
Tensione a Mosca. La Russia espelle
diplomatici Ue e si difende: “Anche in Italia picchiano i manifestanti”.
Massimiliano Cassano su Il Riformista il 5 Febbraio 2021. Le
scintille iniziali avevano lasciato presagire uno strappo, che alla fine c’è
stato: la Russia ha convocato al ministero degli Esteri gli ambasciatori
di Svezia, Polonia e Germania per comunicare loro l’espulsione dal Paese.
Secondo dicastero di Sergej Lavrov avrebbero preso parte alle “proteste
illegali” del 23 gennaio scorso, a Mosca e San Pietroburgo. I diplomatici in
questione sono stati dichiarati “persone non gradite” e dovranno lasciare la
Russia “nel prossimo futuro”. I rispettivi Paesi hanno accolto con stupore la
notizia, e hanno minacciato azioni in risposta. La decisione è arrivata poco
dopo la fine dell’incontro istituzionale tra Lavrov e l’Alto rappresentate per
la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell. I rapporti tra i due
durante il colloquio si sono molto raffreddati, con il membro dell’esecutivo di
Putin che ha parlato dell’Ue come di un “partner non affidabile” che impone
sanzioni “senza un legittimo fondamento”, aggiungendo per difendersi che “anche
in Italia c’è una repressione violenta delle manifestazioni”. Il capo della
diplomazia comunitaria ha riconosciuto che questo momento storico rappresenta
“il punto più basso” dei rapporti tra le due potenze e ha espresso la sua
“profonda preoccupazione” per la deriva autoritaria del Paese. Il riferimento è
chiaramente rivolto alla condanna nei confronti dell’oppositore politico Alexei
Navalny, contro la quale migliaia di persone sono scese in piazza a protestare
in questi giorni. L’occidente continua a chiederne compatto la liberazione, ma
oggi il blogger è stato sottoposto a un secondo processo, stavolta per
diffamazione: avrebbe pubblicato un commento sui social contro il veterano di
guerra Ignat Artyomenko, definito “un traditore” e “una vergogna per la nazione”
per aver difeso il referendum finalizzato ad aumentare i poteri di Putin.
Rischia fino a 5 anni di reclusione, da aggiungere ai 3 anni e 5 mesi inflitti
per il caso Yves Rocher. Una condanna che la Corte di Strasburgo ha bollato come
“motivata politicamente” e contro la quale continua a battersi Borrell, che anzi
ha chiesto a Lavrov di “avviare un’indagine indipendente” sull’avvelenamento che
ha quasi ucciso Navalny ad agosto.
(ANSA il 12 febbraio 2021) La Russia "è pronta a
rompere le relazioni con l'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri
russo Serghei Lavrov al programma Soloviev Life. "Se vediamo ancora una volta,
proprio come in altre occasioni, che le sanzioni vengono imposte in alcuni
settori e creano rischi per la nostra economia, anche nei settori più sensibili,
allora sì. Non vogliamo essere isolati dalla vita internazionale, ma dovremmo
essere preparati a questo", ha detto Lavrov. "Se vuoi la pace, prepara la
guerra", ha aggiunto. Lo riporta Interfax.
Estratto dell’articolo di Bernard Guetta per “la
Repubblica” il 12 febbraio 2021. Putin ha fatto una mossa che va contro gli
interessi del suo Paese, e con l'occasione si è dato anche la zappa sui piedi.
Il dittatore russo sta perdendo la mano, si fa prendere dal panico e si illude.
Che cosa ha fatto quando l'Unione europea gli ha inviato il capo della sua
diplomazia per cercare di evitare che l'affare Navalnyj finisse per
compromettere ogni azione coordinata dei 27 e della Russia sulle aree di
interessi comuni? Invece di constatare che gli europei condannavano -
naturalmente, ovviamente - questo accanimento giudiziario contro Aleksej
Navalnyj, ma restavano desiderosi di non rompere del tutto con Mosca, li ha
pubblicamente maltrattati, per non dire schiaffeggiati. Avrebbe potuto ricevere
il capo della diplomazia europea per sottolineare che auspicava anche lui che
rimanessero aperti i ponti fra l'Unione e la Federazione russa. Non gli sarebbe
costato nulla fare un gesto del genere, ma non l'ha fatto. Josep Borrell ha
potuto incontrare soltanto il suo omologo, Sergej Lavrov, che si è superato nel
suo ruolo di bulldog; e come ciliegina sulla torta, prima ancora che la visita
di Stato fosse terminata, Mosca ha annunciato l'espulsione di tre diplomatici
europei, colpevoli di essere andati a osservare de visu le manifestazioni di
protesta contro la persecuzione del Robin Hood russo. Era esattamente quello che
non doveva fare, perché non ci ha guadagnato nulla. Se avesse avuto un grammo di
abilità, avrebbe potuto insistere, come aveva fatto recentemente, sulla sua
volontà di valorizzare i punti in comune con l'Unione. Avrebbe potuto prendere
ispirazione da quello che ha saputo fare Xi Jinping a dicembre, quando ha
firmato un accordo che allontana l'Unione europea dagli Stati Uniti, sul piano
dei rapporti con Pechino. Ora che ha perso il suo amico Trump, avrebbe potuto
tornare ai tradizionali sforzi russi per "disaccoppiare" le due sponde
dell'Atlantico. Avrebbe almeno potuto fingere di non sentire, come fecero i
dirigenti sovietici quando François Mitterrand prese le difese di Andrej
Sacharov in piena cena ufficiale al Cremlino, e invece no! Putin ha giocato a
fare il gradasso, il bullo del cortile. Ma l'unico risultato che ha ottenuto è
stato palesare il suo panico, un panico che trova una semplice spiegazione.
Avendo avuto l'audacia inaudita di rientrare a Mosca, Aleksej Navalnyj si è
imposto come avversario alla pari del presidente russo. Per la prima volta in
vent'anni di potere, Vladimir Putin ha di fronte a sé un capo dell'opposizione
che gli sarà difficile far assassinare, ora che il tentativo di avvelenarlo è
andato fallito.
Tra Russia e Ue altro che caso Navalny.
La vera questione? Gas e destabilizzazione. Alberto
negri su Il Quotidiano del Sud il 13 febbraio 2021. Il caso Navalny ha un forte
sentore di gas e destabilizzazione. Mosca minaccia la rottura dei rapporti con
l’Unione europea in caso di nuove sanzioni, la Germania risponde definendo
l’ultimatum “sconcertante”. La realtà è che la vera resa dei conti non è con
l’Europa ma con gli Stati Uniti. Prima di esaminare la questione politica è bene
dare un’occhiata alle cifre per vedere a chi conviene un’eventuale rottura. In
pratica a nessuno dei due. L’interscambio tra Russia e Unione europea nel 2019
era di 232 miliardi di euro, una cifra rilevante, anche se lontana dal picco dei
322 del 2012, e condizionata dalle sanzioni imposte a Mosca nel 2014 per
l’annessione della Crimea. L’Europa resta comunque il principale partner
commerciale di Mosca: rappresenta il 35% delle sue importazioni ed è anche il
maggiore investitore in Russia, 276 miliardi di dollari nel 2018, che non sono
bruscolini. Mosca è il quinto partner economico della Ue, molto rilevante dal
punto di vista energetico: l’Unione importa dalla Russia il 40 per cento del suo
gas e il 27% del petrolio. Questi dati sono importanti per capire chi è
veramente interessato alla rottura dei rapporti tra Europa e Russia, ovvero gli
Stati Uniti che vogliono vendere a tutti i costi il loro gas liquido agli
europei anche se costa di più, bisogna costruire i rigassificatori e necessita
di un trasporto di 10mila chilometri. Soltanto un mentecatto può pensare che il
gas americano sia un affare, a meno che non venga venduto a prezzi politici come
hanno già fatto gli Usa con la Polonia e imposto ai tedeschi.
I RAPPORTI UE-RUSSIA NEL MIRINO USA. La faccenda è
talmente scoperta che appena nominato il nuovo segretario di stato Antony
Blinken ha minacciato sanzioni alla Germania se ultimava il gasdotto Nord Stream
2 con Putin. Insomma prima ancora che Navaly rientrasse in Russia e Putin
dimostrasse la sua vulnerabilità con un processo farsa, la nuova amministrazione
Biden, esattamente come Trump, intendeva prendere di mira i rapporti economici
Ue-Russia e colpire Mosca nei suoi interessi vitali, cioè l’export di energia. I
tedeschi stavano, o stanno per cedere, a un ricatto degli americani. E ora ne
abbiamo le prove: una lettera dei tedeschi agli Usa in cui si promette un
miliardo di euro per l’acquisto di gas liquido Usa in cambio della fine delle
sanzioni per il Nord Straeam 2. La lettera è stata pubblicata dalla Deutsche
Umwelthlife, associazione ambientalista tedesca, è sta provocando un putiferio.
La lettera riservata, datata agosto 2020, è firmata dal vicecancelliere tedesco
Olaf Scholz, attuale ministro delle Finanze e candidato cancelliere della Spd
alle elezioni federali del prossimo settembre. Certifica il tentativo di scambio
sottobanco tra la Germania di Angela Merkel e gli Usa di Donald Trump per
disinnescare la “guerra del gas” sul Mar Baltico. “Il governo tedesco è disposto
ad aumentare il suo investimento nelle infrastrutture di gas naturale liquefatto
(Gnl) fino a un miliardo”. Significa che Berlino si impegna a costruire due
rigassificatori a Brunsbüttel e Wilhelmshaven per importare il gas americano
estratto con la devastante tecnica del fracking: molto meno redditizio di quello
fornito da Mosca ma perfetto per far quadrare i conti delle imprese energetiche
Usa. Altro che transizione ecologica del Recovery Fund. Così è riportato nella
missiva inviata l’estate scorsa a Steven Mnuchin, segretario al Tesoro degli
Stati Uniti fino all’insediamento dell’amministrazione Biden.
IL PATTO INDECENTE. La vicenda è esplosa in
Germania per due motivi: il patto è indecente sotto il profilo ambientale e il
ministro Scholz lo avrebbe chiuso tenendo politicamente all’oscuro i deputati
del Bundestag. Altro che la transizione ecologica voluta dal Recovery Fund. Ora
che si capisce bene qual è il giochino degli americani, ovvero alleggerire la
dipendenza europea dal gas russo a vantaggio di quello Usa, e si comprende
meglio che cosa ha spinto Putin a calcare la mano sul caso Navalny. La Russia ha
reagito alle manovre americane di contenere l’export di gas, vitale per le sue
finanze, e Putin ha reagito mandando il messaggio che non è disposto a
retrocedere su niente, neppure su Navalny, anche al rischio di martirizzare di
un personaggio dal passato ambiguo. Ma c’è ovviamente anche dell’altro. Con il
caso Navalny Putin tenta di proiettare all’esterno le sue difficoltà interne nel
gestire gli oligarchi e un’economia in crisi. Quello russo, nonostante le tante
riforme annunciate, è un sistema ancora troppo legato alle esportazioni di
materie prime. La Russia è il secondo produttore di gas naturale al mondo e il
terzo di petrolio: lo stesso ministero delle risorse naturali e dell’ambiente
della Russia stima che il valore complessivo delle attività collegate al
petrolio, gas e altre risorse naturali ammonta al 60% del Pil. Una relazione
pericolosa, che rende Mosca vulnerabile alle variazioni del prezzo globale delle
materie prime, in primo luogo del petrolio. Cosa che è puntualmente avvenuta con
la recessione seguita alla pandemia da Covid. Ma perché Putin rischia tanto sul
caso Navalny che avrebbe potuto disinnescare senza troppo clamore? Per
sopravvivenza politica. Questo è un braccio di ferro ai vertici del potere. In
gioco ci sono la stabilità del sistema e la sua perpetuazione anche se Putin,
per qualunque motivo, se ne dovesse andare. Ovvero gli oligarchi, le famiglie
che contano e la sua stessa cerchia di potere non hanno ancora soluzioni per
assicurare una continuità del sistema. La situazione è seria? Sì, lo è. Gli
Stati Uniti lo sanno e sono pronti a puntare sulla destabilizzazione dei
rapporti tra Mosca e l’Europa e della stessa Russia. Auguri.
Sommossa per Navalny. In manette la
moglie e più di tremila ribelli. Scontri in decine di
città, arrestati centinaia di minorenni. Poi rilasciata la Navalnaya. Luigi
Guelpa, Domenica 24/01/2021 su Il Giornale. Le undici fasce di fuso orario della
Russia hanno ricalcato gli eventi programmati dal dissidente Alexei Navalny, che
nei giorni scorsi aveva invitato la popolazione dell'ex orso sovietico a
manifestare contro il suo arresto e a favore di una maggiore democrazia nel
Paese. Iniziative vietate dal Cremlino e che sono state fermate con l'intervento
di polizia ed esercito. I primi a scendere in piazza sono stati gli abitanti di
Vladivostok, e a ruota, seguendo il sorgere del sole, quelli di Khabarovks,
Ekaterinburg e Samara, fino ad arrivare a Mosca. Le forze dell'ordine, come per
altro mostrato dalle decine di video pubblicati in rete da blogger anti-Putin,
hanno usato lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti,
arrivando ad arrestare (ma i dati sono parziali) 3.721 persone, 312 sono
minorenni tra di loro anche un ragazzino di 12 anni. A Mosca e San Pietroburgo
le detenzioni sono cominciate ancora prima dell'avvio dei cortei alle 14 (le 12
in Italia). Nella capitale, piazza Pushkin, area destinata all'evento, è stata
delimitata da barricate, così come le vie dello shopping e le stazioni della
metropolitana. Altri agenti sono stati collocati sulla piazza Rossa. Tra i
fermati molti portavano cartelli con scritto «Io non ho paura», citazione dello
stesso Navalny e diventata uno degli slogan della giornata di protesta. Alla
chiamata del dissidente hanno risposto soprattutto i giovanissimi, almeno stando
al tam tam che è emerso sul web. I video pubblicati su TikTok con l'hashtag
#FreeNavalny hanno raccolto quasi 300 milioni di visualizzazioni. Tanto che
l'autorità per le Telecomunicazioni, il Roskomnadzor, ha intimato ai maggiori
social (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube) di rimuovere i contenuti,
ritenuti illegali e bollati come minaccia all'ordine pubblico. Il Cremlino ha
cercato in ogni modo di fare terra bruciata attorno a Navalny, fermando nel
corso della giornata i suoi più stretti collaboratori. In manette è finita anche
la moglie Yulia Navalnaya, poi rilasciata in serata, che sul suo profilo
Instagram ha postato una foto scattata all'interno di una camionetta della
polizia, con la frase: «Scusate la bassa qualità. C'è una luce terribile qui
dentro». Tra i fermati anche Liubov Sobol, la primula rossa del movimento
anti-Putin, la portavoce Kira Yarmish, gli attivisti Sergei Ukhov, Ilya Danilov
e Olga Kartavtseva, e una decina di giornalisti locali. Come accennato, i cortei
di protesta hanno toccato ogni punto della Russia, almeno 120 località. A
Khabarovks, in Siberia, le forze dell'ordine hanno usato i manganelli per
disperdere la folla. Gli attivisti hanno condiviso video che mostrano poliziotti
che picchiano manifestanti, poi spinti su furgoni. In Siberia nei mesi scorsi a
far scoppiare la protesta era stato l'arresto dell'ex governatore Sergei Furgal.
A Balgoveshensk fermati anche minorenni. Centinaia di disobbedienti sono scesi
in piazza anche a Vladivostok e Irkutsk, sfidando le temperature gelide. «Siamo
forti» e «Putin è un bugiardo», sono tra gli slogan portati in piazza. «Siamo
orgogliosi di voi. Siamo almeno 200mila. Vogliamo felicità per il nostro Paese e
stiamo manifestando pacificamente per la nostra libertà e per quella di
Navalny», si legge nel messaggio diffuso dal canale Telegram del politico
anti-Putin, che da ieri mattina pubblica a getto continuo i video delle adunate
e che ha confermato nuove proteste il 30 e 31 gennaio. Da parte sua Mosca si è
affidata a un comunicato di Dmitry Peskov, portavoce di Putin, che ha definito
«deplorevole quanto sta accadendo. Sappiamo che si tratta di un gruppo di
provocatori, sobillatori che non hanno nulla a che vedere con la gente per bene
del nostro Paese». Tutto questo mentre l'Alto rappresentante Ue, Josep Borell,
ha twittato tutta la preoccupazione di Bruxelles: «Deploro le detenzioni, l'uso
sproporzionato della forza, l'interruzione delle connessioni internet e delle
reti telefoniche. Lunedì discuteremo i prossimi passi da intraprendere nei
confronti di Mosca con i ministri degli esteri degli stati membri».
Jacopo Iacoboni per "La Stampa" il 24 gennaio
2021. «Siamo in guerra, perché non c'è nessun dubbio che questa è una guerra tra
le democrazie e un regime. E non c'è nessun dubbio, in questa giornata in cui
siamo tutti sotto choc per Alexey Navalny, che non esiste alcuna possibilità di
dialogare con il regime di Putin». Mikhail Khodorkovsky, l'ex patron della
compagnia petrolifera Yukos, che ha resistito senza piegarsi all'esproprio
illegale da parte di Putin dei suoi asset e alla galera in Siberia, oggi vive a
Londra e è forse la bestia nera numero uno da anni del Cremlino. Risponde così,
quando gli chiediamo come giudica i silenzi di alcuni leader occidentali, tra
cui il premier italiano, sull'arresto illegale di Navalny. Khodorkovsy ha
organizzato, con alcuni intellettuali e giornalisti, una videochat per reagire
alla repressione di Mosca e l'arresto illegale di Navalny, assieme ad altri
personaggi che sono stati i più temuti e odiati dal Cremlino in tutti questi
anni: Garry Kasparov, l'ex campione di scacchi, un genio matematico diventato
attivista liberal negli Stati Uniti. Bill Browder, a lungo gestore del
principale fondo di investimento estero, Hermitage Capital, nella Russia della
prima fase post-sovietica, poi finito nella lista nera putiniana, e oggi uno dei
più prominenti sostenitori dell'adozione nel mondo del Magnitsky Act (le norme
che congelano gli asset degli oligarchi putiniani legati a violazioni di diritti
umani, intitolate alla memoria di Sergey Magnitsky, l'avvocato fatto morire in
carcere da Putin perché aveva denunciato centinaia di schemi societari
corruttivi dell'entourage putiniano). Infine, Vladimir Kara-Murza, ex
collaboratore di Boris Nemtsov (che fu assassinato sull'uscio di casa sua, molto
probabilmente dall'FSB). Kara-Murza è stato avvelenato due volte con una tossina
di grado militare, e è miracolosamente vivo. «Non sono sorpreso che il premier
italiano taccia su Navalny», dice Kasparov. Parlando in generale, Kasparov
descrive così il contesto italiano: «L'Italia è stata inondata per anni da un
fiume di denaro russo, che ha conquistato un'influenza diffusa del regime di
Putin nel vostro Paese, e in molti personaggi dell'establishment italiano».
Molto duro anche Kara-Murza che, citando il libro del celeberrimo dissidente
Vladimir Bukovsky («Letters of a Russian Traveler»), commenta amaro: «Scaldare
il bacon con il gas russo è stato più importante, per molti, dei diritti umani».
Colpisce, nella conversazione con questi quattro dissidenti, il coraggio e la
franchezza delle posizioni. Una boccata d'aria contro la violenza e gli
opportunismi. Kasparov osserva: «Non possiamo purtroppo proteggere Navalny, ma
possiamo combattere per ciò per cui lui sta combattendo». Lo strumento con cui
farlo c'è già, dice Khodorkovsky, «sanzioni estremamente mirate contro gli
oligarchi del giro di Putin. La maggioranza delle persone in Occidente non vuole
questi soldi sporchi. Sono i soldi di una mafia, soldi di gangster». Un
Magnitsky Act reso davvero effettivo in tutti i Paesi europei servirebbe a
questo. «Il mondo libero deve alzarsi in piedi contro Putin, oppure sarete
complici», constata Kasparov: «La gente in Russia ne ha abbastanza, e si sta
ribellando, dall'estremo oriente fino a Kalinigrad. L'Occidente non può rimanere
inerte». Kara-Murza approfondisce il concetto: «Per vent' anni le
caratteristiche dell'opinione pubblica russa sono state due: silenzio e
acquiescenza passiva. Nella nuova generazione non vediamo più questo silenzio e
questa acquiescenza. E è questo che spaventa il regime. Cacciare Putin toccherà
ai russi, ma l'Occidente può bandire i soldi dei suoi compari». L'America di Joe
Biden può cambiare le cose? «Sappiamo che Biden era il più falco
dell'amministrazione Obama sulla Russia, e che imparerà dagli errori di Obama»,
spiega Kasparov. «Venire a patti con Putin sarebbe non solo moralmente sbagliato
- osserva Kara-Murza - ma soprattutto totalmente inefficace. In Putin,
repressione interna e aggressioni all'estero fanno tutt' uno». Nessuno, non solo
a Mosca, può dirsi al sicuro.
L’enigma Navalny: chi è davvero il
principale oppositore di Vladimir Putin. Paolo
Valentino su Il Corriere della Sera il 7/2/2021. Avvocato e blogger
anticorruzione, nazionalista e populista: come è cambiato in 20 anni il grande
nemico del presidente russo? Quando in Russia è tempo di torbidi, torna
d’attualità la doppia suggestione dello Zar buono e del Falso Dmitrij.
La prima figura rimanda a Boris Godunov, il
sovrano illuminato che governò la Russia dopo la morte di Ivan il Terribile
La seconda rimanda invece a tre impostori, che tra
il 1600 e il 1613 si accreditarono come figli di Ivan. Sfidarono Boris e si
autoproclamarono sovrani, prima di finire assassinati dopo regni brevi e
scellerati.
Quale delle due figure si rivelerà Aleksej
Navalny?
Quando in Russia è tempo di torbidi, torna sempre
d’attualità la doppia suggestione dello Zar buono e del Falso Dmitrij. Nella
tormentata storia russa, la prima figura rimanda a Boris Godunov, il sovrano
illuminato che governò la Russia dopo la morte di Ivan il Terribile, nel 1584,
prima nell’ombra di Fjodor I e poi brevemente da Zar. La seconda rimanda invece
a tre impostori, che tra il 1600 e il 1613 si accreditarono uno dopo l’altro
come figli di Ivan, sfidando Boris e autoproclamandosi sovrani, prima di finire
assassinati dopo regni brevi e scellerati.«Anche se finge di essere un grande
politico, passerà alla storia come l’avvelenatore delle mutande»Aleksej Navalny
su Putin, prima della condanna del 2 febbraio 2021. Quale delle due figure si
rivelerà Aleksej Navalny ce lo diranno i prossimi mesi e anni. Nella narrazione
del Cremlino di Putin, il dissidente più famoso del mondo è un nuovo Falso
Dmitrij, venuto a ingannare il popolo russo e deciso a usurpare il trono dello
Zar. Ma con la sua tenacia e il suo coraggio, egli non fa mistero di voler
indossare i panni di Boris Godunov, beniamino degli ultimi e profeta di una
nuova era. Ma chi è veramente Aleksej Navalny, questo avvocato ultraquarantenne
nei cui occhi azzurri brilla quello che Enzo Bettiza definiva «il lampo di
follia proprio di tutti i russi bianchi»? Quale ruolo si prepara per lui, ora
che una condanna senza veri motivi a 2 anni e 8 mesi di carcere mostra il nervo
scoperto di Vladimir Putin, deciso a pagare qualsiasi prezzo politico pur di
emarginarlo? Figlio di un ufficiale dell’Armata Rossa, cresciuto nelle città
militari chiuse agli stranieri intorno a Mosca, laureato alla prestigiosa Rudn,
l’ateneo moscovita una volta intitolato a Patrice Lumumba e poi ribattezzato
Università dell’Amicizia fra i Popoli, Navalny attraversa i tumultuosi anni
Novanta mostrando subito una passione per la politica. Nel 1999 aderisce a
Yabloko, il piccolo partito liberale di Grigory Yavlinski, dal quale però verrà
espulso nel 2007. Ragione principale della sua uscita: la progressiva deriva del
giovane attivista, sempre più attratto dal nazionalismo grande russo, che
culmina nella sua decisione di partecipare nel 2006 alla Russkij Marsh, la
marcia russa, tradizionale parata dell’estrema destra xenofoba, dove abbondano
anche i saluti nazisti. Ci tornerà regolarmente negli anni seguenti. Pochi mesi
dopo la cacciata da Yabloko, Navalny fonda il movimento patriottico Narod, che
subito si allea con due altre formazioni dell’estremismo nazionalista, il
Movimento contro l’emigrazione illegale e Grande Russia. Il nazionalismo di
Navalny va naturalmente contestualizzato. Siamo all’inizio dell’era Putin, il
nuovo presidente è impegnato a restituire orgoglio e status internazionale alla
Russia dopo il Far West seguito al crollo dell’Urss e le umiliazioni subite
negli anni Novanta. Uvazheniye, rispetto, è quello che Putin pretende dalla
comunità internazionale. Ma Vladimir Vladimirovich, che considera la fine
dell’Unione Sovietica «la più grande catastrofe geopolitica del Novecento»,
vuole recuperarne l’eredità complessiva, compresi il carattere multietnico e
l’ambizione imperiale. I nazionalisti invece, da Eduard Limonov in giù, chiedono
la restaurazione della supremazia russa. Navalny è fra questi. Appoggia
l’intervento militare del 2008 in Georgia. Pubblica video nei quali paragona i
musulmani del Caucaso a scarafaggi da eliminare. Teorizza l’espulsione di tutti
i georgiani da Mosca e dalla Federazione russa. Aderisce alla campagna «Stop
Feeding the Caucasus», basta nutrire il Caucaso. Oggi Navalny concede che non
userebbe più quei termini ed espressioni. Ma nessuno gli ha mai sentito prendere
le distanze dal suo nazionalismo.
Quello che succede dall’estate scorsa a oggi è
storia nota. L’avvelenamento in Siberia, l’atterraggio di emergenza a Omsk che
gli salva la vita, il ricovero in Germania. Le rivelazioni sul ruolo dei servizi
russi, il ritorno in Russia, l’arresto. Infine, la condanna.
Eppure, all’inizio degli anni Dieci del nuovo
Millennio, succede qualcosa. Il populismo carismatico di Navalny imbocca la
strada della lotta alla corruzione, di nuovo dilagante dopo le iniziali mosse
dimostrative di Putin contro gli oligarchi. In realtà, al posto di quelli vecchi
come Berezovsky, Khodorkovsky e Gusinsky, lo Zar ha solo creato i nuovi
predatori, come Abramovich, Usmanov, Rotenberg. Mostrando di capire la grande
potenzialità della rete, Navalny indossa i panni del blogger, denunciando (con
nomi, cognomi e prove) tangenti, bustarelle e ruberie di denaro pubblico. Il
suo Live Journal diventa popolarissimo.«Qualcuno non voleva che facessi un solo
passo da uomo libero nel mio Paese». Nel 2010 apre RosPil, il sito che lo
consacra nel suo ruolo di fustigatore del sistema, dove ancora oggi un gruppo di
giovani giuristi passa al setaccio montagne di documenti di contratti pubblici,
smascherandone irregolarità, violazioni dolose e trucchi illegali. Nel 2013 è
tra i leader della protesta di strada che per la prima volta fa vacillare Putin.
Comincia la lunga ordalia degli arresti, entra ed esce da Matrosskaya Tishina,
il carcere di Mosca. Il regime identifica in lui uno degli obiettivi prioritari
contro i quali agire. I margini di ambiguità però rimangono. In Crimea, nel
2014, Putin gioca la carta patriottica della Reconquista. La penisola a
maggioranza etnica russa, regalata da Krusciov all’Ucraina, viene riannessa alla
Federazione. I suoi indici di popolarità schizzano in alto. I nazionalisti,
Limonov e il politologo Alexandr Dugin in testa, si schierano con lo Zar. È
l’ora dei Nashi, i nostri, l’organizzazione (governativa) di giovani a sostegno
del nuovo corso presidenziale, che nel vocabolario di Putin si riassume nella
parola Novorossya. Il riflesso nazionalista sembra di nuovo toccare anche
Navalny, che pure non dà tregua al regime sul fronte della lotta alla
corruzione. E quando Alexeij Venediktov, direttore di Radio Echo di Mosca, gli
chiede se lui restituirebbe la Crimea all’Ucraina, Navalny dagli arresti
domiciliari risponde. «La Crimea non è un sandwich al prosciutto, che prima si
prende e poi si restituisce così». Eppure, a sbagliare è ancora Putin, che usa
le procure per impedire a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali del
2018. Vince facile lo Zar, con oltre il 76% dei voti. Ma corre di fatto da solo.
E da quel momento il blogger può a pieno titolo entrare nel ruolo del primo
oppositore. Lo aiuta la fine del miracolo economico putiniano, non più sostenuto
dai corsi del petrolio e del gas: la classe media nata nel primo decennio del
nuovo secolo si ritrova impoverita, le condizioni di vita peggiorano per tutti,
il malcontento cresce alimentato anche dalla rabbia per i facili arricchimenti.
Il canale YouTube lanciato da Navalny non dà tregua al sistema, denunciando
sempre nuovi scandali e puntando sempre più in alto, come le rivelazioni sugli
affari e le proprietà dell’allora premier Dmitrij Medvedev. Nel 2019, grazie a
un sistema di «smart voting», Navalny riesce a far eleggere alla Duma di Mosca
candidati alternativi a quelli di Russia Unita, il partito del presidente.
Quello che succede dall’estate scorsa a oggi è storia nota. L’avvelenamento di
Navalny in Siberia, l’atterraggio di emergenza a Omsk che gli salva la vita, il
ricovero in Germania, le rivelazioni sul ruolo dei servizi russi nel tentativo
di eliminarlo con il Novichok, il ritorno in Russia, l’arresto e lo scoop del
video sul lussuoso palazzo con vista sul Mar Nero, che secondo lui apparterrebbe
a Putin, visto da 100 milioni di persone. Infine, la condanna. Putin ha deciso
di bruciare i ponti. Il leader del Cremlino, alle prese con la propria
successione, è convinto che l’emarginazione a lungo termine di Navalny valga
qualsiasi prezzo politico, in termini di nuove sanzioni occidentali e isolamento
internazionale. Lo dimostra la crisi aperta in modo quasi sprezzante con
l’Unione europea venerdì, quando il Cremlino ha espulso tre diplomatici di
Germania, Polonia e Svezia proprio durante la visita dell’Alto
rappresentante Joseph Borrell, venuto a chiedere la liberazione del dissidente.
Forse è un calcolo giusto. Forse alcuni anni in galera basteranno a farlo
dimenticare. Forse. Ma così facendo, lo Zar ha dato a Navalny la dignità di capo
di un’opposizione, che sicuramente non ha ancora massa critica, ma per la prima
volta è diffusa sull’intero territorio degli undici fusi orari. Soprattutto, è
giovane. E con i Rolling Stones può dire: il tempo è dalla mia parte. La partita
rimane aperta: Putin vuole trasformare Navalny in un Falso Dmitrij, ma i suoi
adepti vogliono in lui il nuovo Boris Gudonov. Saranno i russi, ancora in
maggioranza affezionati allo Zar, a decidere chi vedere in Aleksej Navalny.
Putin è convinto che l’emarginazione di Navalny
valga qualsiasi prezzo politico. Ma così facendo, lo Zar ha dato a Navalny la
dignità di capo di un’opposizione. Putin vuole trasformare Navalny in un Falso
Dmitrij, ma i suoi adepti vogliono in lui il nuovo Boris. Saranno i russi a
decidere chi vedere in Aleksej Navalny.
Democratico o populista? Il doppio volto
di Navalny. Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 23
gennaio 2021. Alexei Navalny, Imprenditore, blogger, attivista politico, ma
soprattutto oppositore più celebre di Putin, nasconde un passato nazionalista e
xenofobo. È sorprendente come Alexei Navalny possa agitare a tal punto i sonni
di Vladimir Putin. L’uomo che i media internazionali hanno designato come il
“grande oppositore” del Cremlino, sorvegliato con occhiuta tenacia dai servizi
di sicurezza di Mosca al punto da venire accusati di averlo avvelenato, gode di
un consenso risibile nel suo Paese. Al di là dell’area metropolitana moscovita
dove risiede il suo zoccolo duro ( si è candidato come sindaco nel 2013
superando il 20%) nel resto della Russia il suo nome è pressoché sconosciuto. Se
si votasse domani difficilmente riuscirebe a superare il 5%. Eppure i ripetuti
arresti, le aggressioni, i processi penali, lo zelo persecutorio con cui la
magistratura russa lo tampina da anni ne hanno accresciuto la fama e il
prestigio, anche ai limiti del grottesco con diversi giornali che lo hanno
paragonato al premio Nobel Nelson Mandela. Ma chi è realmente Alexei Navalny? Un
sincero democratico in lotta contro il tetragono clan dello “zar” Putin o un
abile trasformista privo di una sua specifica ideologia come sostengono i
detrattori? Imprenditore, blogger, attivista, militante politico, nel corso
della vita ha cambiato più volte posizioni, sfilando sotto diverse bandiere e
flirtando con personaggi di dubbia caratura democratica. Un passato pieno di
ombre che oggi in parte rinnega e in parte prova a nascondere con le nuove
campagne politiche. Figlio di un ufficiale dell’esercito sovietico e di una
brillante economista, Navalny nasce nel 1976 alla periferia di Mosca. Da bambino
trascorre le vacanze a Zalissya il piccolo villaggio ucraino da dove proviene il
padre che si trova a pochi chilometri dalla centrale di Chernobyl e che verrà
abbandonato dopo la catastrofe nucleare del 1986. Laurea in diritto nel 1998, si
specializza negli anni successivi all’Università americana di Yale, Poi il
rientro in patria e l’inizio di una lunga militanza politica. Da giovane Navalny
è un fervente nazionalista e si iscrive al partito Jabloko di cui diviene il
responsabile nell’area di Mosca. Sono i primi anni 2000 e le sue uscite xenofobe
nei confronti degli immigrati dell’Asia centrale imbarazzano i vertici di
Jabloko che lo espellono nel 2007: l’anno precedente aveva partecipato al corteo
annuale di Marcia Russia, un cartello di formazioni ultranazionaliste di estrema
destra. Navalny sostiene al contrario che il suo siluramento è stata una purga
del leader del partito Grigorij Javlinskij di cui aveva chiesto le dimissioni.
Poco male: i tempi sono maturi per fondare il suo movimento politico, Narod, che
in russo vuol dire “popolo”. Ma la linea intransigente verso gli stranieri non
cambia: in un video rivolto ai suoi sostenitori paragona i caucasici, in
particolare ceceni e georgiani a degli «scarafaggi» che come tali dovrebbero
essere eliminati. Come un sovranista qualunque del mondo occidentale afferma che
in Russia la gran parte dei crimini viene commessa dagli stranieri e propone un
rigido sistema di visti per gli immigrati delle ex repubbliche sovietiche. Nel
2008 quando scopèpia la guerra in Ossezia del sud chiede l’espulsione dal paese
delle persone di etnia georgiana. Ma la carriera da giovane leader populista non
decolla, troppa concorrenza in paese che ha il nazionalismo vergato nel proprio
Dna politico dalla notte dei tempi. Navalny ha cambiato radicalmente le sue
critiche, appoggiando le campagne per i diritti civili e contro la
discriminazione dei gay. Ci vuole qualcosa di diverso, una svolta. Da uomo
intelligente qual è Navalny ha saputo trasformare il suo discorso pubblico,
adattandolo agli standard delle democrazie occidentali cambiando radicalmente il
bersaglio delle sue critiche, appoggiando le campagne per i diritti civili e
contro la discriminazione dei gay. Non più i migranti «scuri di pelle» dell’Asia
centrale ma il sistema di potere di Vladimir Putin: lo fa attraverso il suo blog
da cui denuncia la corruzione dei funzionari pubblici, in particolare nel
settore degli appalti. Le sue inchieste pubblicate su internet in nome di un
progetto chiamato RoPil hanno un buon seguito, soprattutto all’estero tramite un
sistema di donazioni online riesce a coprire le spese legali delle sue denunce.
Viene a sua volta accusato di frode con il fratello Oleg per appropriazione
indebita ( avrebbe usato le donazioni per scopi personali) e viene condannato a
3 anni e 6 mesi. Nel 2018 crea un nuovo partito “Russia del futuro” che nel 2019
ottiene un ottimo risultato alle municipali nella circoscrizione di Mosca con il
sistema dello smart vote, che consiste nel far votare il candidato anti-
Cremlino in ogni collegio. Un piccolo rovescio per Russia Unita di Putin che
nella capitale dimezza i voti rispetto al turno precedente. Ma nel frattempo la
sua fondazione anti- corruzione viene sciolta dalle autorità che la classificano
come “agente straniero”, alimentando la leggenda popolare che Navalny sia in
realtà una spia, un mestatore sul libro paga della Cia. L’ultimo evento che lo
riguarda è il presunto avvelenamento da parte dei servizi segreti russi dello
scorso agosto: colpito da un malore mentre era in volo tra Tomsk e Mosca viene
ricoverato in coma all’ospedale di Omsk e nei giorni seguenti a Berlino in
Germania dove le sue condizioni migliorano fino alle dimissioni e al ritorno in
Russia la scorsa settimana dove è stato nuovamente arrestato per violazione
della libertà vigilata. Dovrà scontare 30 giorni di reclusione. Poi tornerà a
sfidare Vladimir Putin nei panni del “grande oppositore” vezzeggiato
dall’Occidente anche al di lù dei suoi meriti.
Da "Ansa" il 2 febbraio 2021. Alexei Navalny è
stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale
distrettuale Simonovsky, riunitosi per l'occasione presso la sede del tribunale
della città di Mosca. Lo riporta Dozhd. Il giudice ha deciso però di prendere in
considerazione l'anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves
Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere dai 3 anni e 5 mesi a 2 anni
e 5 mesi di colonia penale.
Giuseppe Agliastro per "La Stampa" il 3 febbraio
2021. Alexey Navalny è stato condannato. La mannaia di una giustizia ritenuta al
servizio del Cremlino si è abbattuta sul principe degli avversari di Putin
imponendogli due anni e otto mesi dietro le sbarre. Il tribunale di Mosca ha
riesumato una sentenza vecchia e controversa, dietro la quale molti vedono la
volontà politica di colpire il principale animatore dei cortei d'opposizione,
già vivo per miracolo dopo un avvelenamento per il quale si sospettano gli 007
di Putin. Una mera prepotenza secondo i governi occidentali, che da Washington a
Bruxelles, da Berlino a Parigi, hanno subito domandato il rilascio di Navalny e
altrettanto rapidamente si sono sentiti rispondere da Mosca che la loro
richiesta «è sconnessa dalla realtà». Non sono bastate le critiche
internazionali piovute sul Cremlino, e neanche le decine di migliaia di persone
che negli ultimi due weekend sono scese in piazza. Il tribunale che ha esaminato
il caso ha accolto le motivazioni della procura: Navalny - è la sua conclusione
- non si è presentato davanti al giudice di sorveglianza a Mosca e ha quindi
violato i termini della sospensione condizionale della pena concessagli nel
2014. Poco importa se quando ha ricevuto l'avviso il dissidente si trovava in
Germania, ancora in convalescenza dopo l'avvelenamento con una micidiale
neurotossina che ha fatto temere per la sua vita e per il quale gli occhi sono
tutti puntati sul Cremlino. La motivazione appare grottesca ai più, ma la corte
ha deciso che la condizionale va cancellata e che il dissidente deve scontare in
galera la famigerata condanna per una presunta truffa alla società di cosmetici
Yves Rocher (che peraltro nega di aver subito danni): tre anni e mezzo, a cui
vanno sottratti i dieci mesi che il dissidente ha passato ai domiciliari. Si
tratta della stessa sentenza per la quale il fratello di Alexey Navalny, Oleg,
ha già trascorso in carcere tre anni e mezzo. La stessa già definita «arbitraria
e infondata» dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Ma al governo russo non
sembra importi molto. Il Cremlino ha deciso di andare avanti con i suoi metodi
repressivi pur rischiando di trasformare in un martire della democrazia Navalny,
finito in manette a metà gennaio non appena ha rimesso piede in Russia dopo
l'avvelenamento. La polizia ieri ha arrestato oltre 350 persone che
manifestavano davanti al tribunale. Poi ha blindato il centro di Mosca non
appena l'opposizione ha invitato la gente a sfilare in Piazza del Maneggio, a
due passi dalla Piazza Rossa, e anche lì sono scattati gli arresti. Alla fine il
bilancio (parziale) della giornata era di 750 fermi, di cui 613 a Mosca. Navalny
rischia di restare a lungo in cella. Su di lui pendono altre tre inchieste
penali. Ma questo non gli ha impedito di scagliarsi contro Putin usando come un
palcoscenico l'aula di tribunale. Chiuso dentro una gabbia di vetro,
l'oppositore ha definito la sua detenzione una strategia del governo per
«intimidire» i russi. «Vogliono imprigionare una persona per spaventarne
milioni», ha dichiarato. Poi ha avuto anche la forza di fare dell'ironia su
Putin lo «zar» e sul proprio avvelenamento. «Sapete - ha detto - c'erano
Alessandro il Liberatore e Yaroslav il Saggio. Ora abbiamo Vladimir
l'Avvelenatore». Poi, prima di essere portato via, ha formato con le mani un
cuore dedicandolo a sua moglie Yulia. In aula c'erano diversi diplomatici
stranieri e tanto è bastato alla Russia per accusare l'Occidente di «ingerenze».
Tra Mosca e Occidente il duello è più acceso che mai. «La condanna di Navalny è
contraria agli impegni internazionali della Russia in materia di Stato di
diritto e libertà fondamentali», ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue Josep
Borrell, atteso domani a Mosca per discutere di questa delicata questione che
potrebbe costare alla Russia nuove sanzioni. Neanche gli Usa post-Trump sembrano
voler restare con le mani in mano e il segretario di Stato Antony Blinken ha
annunciato che Washington si coordinerà con i suoi alleati per valutare come
rispondere al Cremlino. La Farnesina ha espresso «costernazione» e «forte
preoccupazione», Macron ha definito la condanna «inaccettabile» e Berlino ha
parlato di «puro cinismo», anche se al momento non pare voler rinunciare al
gasdotto russo-tedesco Nord Stream-2.
Navalny al processo: «Putin passerà alla
storia come Vladimir l'avvelenatore delle mutande». Il
leader dell'opposizione ora non è più solo: in Russia milioni di persone
conoscono la sua storia. «E presto scopriranno molto di più. Ed è questo che fa
impazzire il piccolo ladro nascosto nel suo bunker». Mentre le prigioni sono
strapiene di manifestanti. Svetlana Ivanova su La Repubblica il 3 febbraio 2021.
In Russia, per legge, un numero ristretto di liberi cittadini, ha potuto
assistere, il 2 febbraio 2021, al processo in cui Navalny (leader
dell’opposizione in Russia) è stato condannato a 2 anni ed 8 mesi di prigione.
Davanti alla cattedra del tribunale si sono presentati 20 ambasciatori
stranieri. Il Ministero Russo degli Affari Esteri ha considerato la presenza dei
20 ambasciatori come un’ingerenza negli Affari Russi. Ed ha perciò detto che la
loro presenza era in realtà una manifestazione. "La sentenza che oggi ordina la
reclusione di Alexei Navalny […] sfida ogni credibilità e viola gli obblighi
internazionali in materia di diritti umani in Russia", così ha affermato il
Commissario della Corte europea dei diritti dell'uomo. Navalny è stato
condannato per un vecchio caso penale che la Corte europea dei diritti dell'uomo
aveva chiuso per mancanza di corpus delicti. Il dissidente Alexei Navalny è
stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere, di cui un anno già scontato agli
arresti domiciliari. Navalny, prima della sentenza, ha rivolto più volte un
'cuore' alla moglie Yulia, presente in aula insieme ad altri suoi sostenitori.
In seguito alla sentenza sono state organizzate diverse manifestazioni di
protesta in Russia: circa 1000 persone sono state arrestate, la maggior parte di
queste a Mosca. Nel suo discorso in tribunale, Navalny salutando tutti coloro
che lottano e non hanno paura, ha detto: «Ho inflitto un'offesa mortale [a
Putin, ndr] per il fatto di essere sopravvissuto. […] Poi l'ho offeso ancora di
più – per il fatto che, essendo sopravvissuto, non mi sono nascosto, vivendo da
qualche parte sotto scorta nel bunker più piccolo che potevo permettermi. E poi
è successo qualcosa di terribile. Non solo sono sopravvissuto, non solo non mi
sono spaventato o nascosto – ma ho anche partecipato alle indagini sul mio
avvelenamento. E abbiamo dimostrato così che è stato Putin, usando l'FSB
(Servizi Segreti Russi, ndr), a tentare questo omicidio». Navalny ora non è più
solo. Adesso in Russia milioni di persone conoscono la sua storia. «E presto –
ha continuato Navalny- scopriranno molto di più. Ed è questo che fa impazzire il
piccolo ladro (Putin, ndr) nascosto nel suo bunker. E precisamente il fatto che
tutto questo è stato rivelato, capisci?» dice Navalny inchiodando con lo sguardo
i suoi giudici. «È così che [Putin, ndr] passerà alla storia, come Vladimir
l'avvelenatore delle mutande». «La cosa principale in questo processo non è
nemmeno come finirà per me. […] In generale, non è difficile mettermi in
prigione, per questa o per un'altra scusa. Ma lo scopo principale è intimidire
un numero enorme di persone. Funziona così: viene imprigionato un singolo uomo
per spaventare milioni di persone». Il presidente russo Vladimir Putin, durante
il processo di Navalny, era in collegamento video con i vincitori del concorso
"Insegnante dell'anno Russia-2020", la cui finale si è svolta martedì. Peskov,
il suo press secretary, ha detto che “Putin non sta seguendo affatto il processo
di Navalny”. Questo far finta di niente, fingere di ignorare totalmente
l’avversario, al punto da non chiamarlo mai per nome, è ovviamente un bluff. I
colleghi di Navalny hanno indetto una "protesta immediata a Mosca" dopo la
decisione della corte. Sembra che le forze dell’ordine fossero informate in
anticipo sulla decisione del tribunale. Per le strade del centro di Mosca,
infatti, c’erano più forze dell’ordine, che passanti. Nel gelido buio invernale,
se appena due persone si fermano a guardare cosa sta succedendo e si chiedono
come mai ci siano tutti questi militari in giro; i poliziotti subito gridano con
voce dura: «questa manifestazione non è autorizzata!». Per la prima volta la
metropolitana moscovita è stata bloccata. La fermate del centro son state
chiuse. Gli agenti della polizia hanno perquisito gli appartamenti seguendo
delle liste precise. Su queste liste non c’erano sono solo attivisti e persone
del mondo della cultura, che hanno parlato per Navalny, ma anche, e per la prima
volta, i giornalisti indipendenti che hanno seguito e raccontato le
manifestazioni. Nel frattempo, da più di 48 ore, stanno ancora girando, per le
gelide strade russe, gli autobus-cellulari della polizia, stracarichi di
cittadini trattenuti alle scorse manifestazioni. Su questi mezzi è impossibile
dormire e mangiare e non ci sono servizi igienici. Queste persone non hanno
trovato riparo in prigione, perché non ci sono più posti liberi. Le prigioni
sono strapiene di manifestanti.
Il dissidente russo avvelenato e
imprigionato. Navalny trasferito in una colonia penale: “Nessuna minaccia per la
sua salute e la sua vita”. Vito Califano su Il
Riformista il 26 Febbraio 2021. Alexei Navalny è stato trasferito in una colonia
penale. Questo il nuovo capitolo del caso del dissidente avvocato 44enne russo
del Presidente Vladimir Putin. A far sapere del trasferimento il capo dei
servizi carcerari russo. Uno degli avvocati del dissidente, Olgo Mikhailova,
aveva denunciato proprio l’imminente trasferimento dalla prigione di Mosca.
Navalny è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione. “È stato trasferito
esattamente nel luogo in cui deve stare in base alla sentenza del tribunale”, ha
dichiarato il capo del servizio carcerario federale Alexander Kalashnikov, che
non ha reso noto il nome dell’istituto dov’è stato trasportato
Navalny. “Garantisco che non esistono minacce per la sua vita e la sua salute”,
ha aggiunto Kalashnikov. La settimana scorsa il tribunale di mosca ha confermato
la pena a quasi tre anni per il blogger dopo il ricorso contro la condanna
per violazione dei termini della libertà provvisoria, relativa a una condanna,
anche questa controversa, per frode del 2014. Navalny è stato condannato anche
per diffamazione per aver definito “traditore” un veterano della Seconda Guerra
Mondiale che ha appoggiato pubblicamente la riforma della Costituzione che ha
permesso il Presidente Putin di ricandidarsi al Cremlino fino al 2036. La scorsa
settimana la Corte europea dei diritti umani aveva ordinato alla Russia di
rilasciare Navalny sostenendo che la sua vita fosse in pericolo in prigione, ma
Mosca ha respinto la richiesta. Quello di Navalny – una figura comunque
controversa, come dimostra la cancellazione da parte di Amnesty Internationale
del suo nome tra i prigionieri di coscienza – è diventato un caso
internazionale: lo scorso agosto è stato avvelenato. Soltanto un atterraggio di
emergenza del suo volo di ritorno dalla Siberia ha impedito la morte. È stato
intossicato con il Novichok, gas nervino utilizzato e perfezionato dai servizi
dell’Unione Sovietica. Sospettati funzionari dei servizi segreti russi. Il
44enne dissidente è stato trasferito e curato a Berlino. Ha quindi, dopo essersi
svegliato, deciso di tornare in patria, cosciente che sarebbe stato arrestato,
lo scorso gennaio. La sua rete ha pubblicato intanto un’inchiesta, che ha avuto
risonanza mondiale, sulla villa “segreta” di Putin sul Mar Morto. Proteste e
manifestazioni come in Russia non se ne vedevano da anni si sono viste negli
ultimi mesi a partire dall’avvelenamento e dall’arresto di Navalny.
Da adnkronos.com il 3 marzo 2021. E' considerata
"zona rossa", nel senso che ogni aspetto della vita del detenuto è sotto
controllo. Non sono autorizzate le mail e le lettere arrivate con la posta
ordinaria vengono consegnate dopo settimane, se non mesi, dal loro arrivo, dopo
essere state lette dai secondini. "E' una struttura dura, con regole molto
rigide, per usare un eufemismo", ha spiegato Eva Merkacheva, che fa parte
dell'organizzazione civica per il controllo del sistema carcerario, in una
intervista a Bloomberg. "Cercano di controllare ogni tuo passo e ogni tuo
pensiero", ha aggiunto testimoniato Konstantin Kotov che a Ik-2 ha trascorso un
anno e mezzo, dopo essere stato condannato per aver ripetutamente partecipato a
manifestazioni di protesta nell'estate del 2019, a Mosca. Vieni punito per non
aver salutato una guardia o per aver chiesto in prestito dei guanti, dopo che
quelli che ti sono stati spediti non ti sono stati consegnati, aggiunge,
ricordando "l'enorme pressione psicologica" subita. I detenuti sono ospitati in
stanzoni con anche 150 brandine. "E' un posto in cui non esiste legge. Ti
spezzano. Da tempo accadono cose negative, alcune delle quali sono state
denunciate già dieci anni fa", ha spiegato Pyotr Kuryanov, avvocato della
Fondazione per la difesa dei detenuti, in una intervista a Moscow Times. Vi fu
rinchiuso Vladimir Pereverzin, ex manager della Yukos di Mikhail Khodorkovsky
che ha descritto in un memoriale i due anni trascorsi a Ik-2. "La prigione è
vicina a una palude, è freddo e il cibo è pessimo. E' un posto violento in cui
stare", ha commentato. Vi è stato detenuto anche il nazionalista Dmitry
Demushkin, condannato per istigazione all'odio, per cui il carcere è stato "come
una tortura". "Non potevo parlare ad altri detenuti, non potevano guardarmi". Un
quarto detenuto, che ha preferito non farsi citare, ha raccontato di essere
stato spesso picchiato dalle guardie e da altri detenuti. "C'è un intero sistema
che consente violenze e umiliazioni su base quotidiana", ha affermato.
Da “il Giornale” il 16 marzo 2021. Alexey Navalny,
il principale avversario politico del presidente russo Vladimir Putin, ha
denunciato di essere stato trasferito in un «accogliente campo di
concentramento» dopo la pena di due anni e mezzo da scontare ancora. Con un post
pubblicato sul suo account Instagram, in cui conferma il suo arrivo nel centro
di detenzione Ik-2 di Pokrov, nella regione di Vladimir, ha anche reso noto di
essere stato rasato al suo arrivo. «Bisogna riconoscere che il sistema
carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non pensavo che si potesse costruire
un campo di concentramento a cento chilometri da Mosca», ha scritto il
dissidente. «Qualcuno ai piani ha letto 1984 di Orwell e ha detto: bello,
facciamolo. Educazione attraverso la disumanizzazione. Ma se non prendi tutto
con ironia, riesci a sopportarlo. Tutto sommato, sto bene». La vita nella
colonia penale, ha aggiunto, consiste «nell' adempimento di regole senza fine».
«Tre cose non cessano di sorprendermi. Il cielo stellato sopra di noi, l'
imperativo categorico che ci portiamo dentro, e la sensazione incredibile di
passarsi la mano sul capo appena rasato. Saluti a tutti dal Settore del
Controllo rafforzato A», ha scritto. La scorsa settimana gli avvocati del
dissidente sono andati a trovarlo nella struttura carceraria di Kolchugino, in
cui era stato portato per un periodo di quarantena ma non lo hanno trovato e non
sono state fornite loro informazioni sulla nuova destinazione. La notifica
informa Navalny che il caso giudiziario relativo alla sua denuncia inizierà
oggi. Il tribunale chiede al carcere «di fare in modo che Navalny partecipi all'
udienza in video conferenza». Il carcere IK-2, che si trova a un centinaio di
chilometri da Mosca, viene considerato come uno dei più duri della Russia
europea.
Fabrizio Dragostei per "corriere.it" il 26 marzo
2021. Lo aveva detto subito, appena era stato trasferito nel centro di
detenzione di Kolchugino a 150 chilometri da Mosca. «Non credevo che oggi in
Europa potessero ancora esistere i campi di concentramento». Aleksej Navalny è
sottoposto a un regime durissimo che non ha alcuna motivazione se non quella di
minare la sua salute mentale e fisica, come ha scritto la moglie in un appello
al presidente Vladimir Putin. «Ciò che sta accadendo è giustizia sommaria per
realizzare una vendetta personale». Il blogger e principale oppositore del
presidente sta male e non viene curato adeguatamente, secondo quanto ha
affermato il suo avvocato che ieri è riuscito finalmente a incontrarlo, dopo
aver insistito a lungo. Ha da tempo forti dolori alla schiena, non riesce quasi
più a usare una gamba e, finora, in carcere gli hanno somministrato solo degli
anti-infiammatori per bocca. Poi è stato sottoposto a una tac ma i risultati non
sono noti. La situazione di Navalny appare assurda dall’inizio. È stato
condannato anni fa per una truffa a una società francese, la Yves Rocher, che ha
sempre affermato di non aver mai avuto alcun danno. La sentenza è stata
giudicata immotivata dalla Corte europea per i diritti umani che ha intimato
allo Stato russo di pagare i danni al blogger e a suo fratello Oleg, coimputato
(e la Russia ha liquidato più di 70 mila euro). Dopo aver scontato una parte
della pena in carcere, Navalny era in libertà con la condizionale.
Per l’avvelenamento subito in Siberia, era stato portato in Germania per essere
curato e per questo motivo ha saltato i controlli periodici di fronte alle
autorità carcerarie. Così un tribunale lo ha rispedito in carcere per due anni e
mezzo. Pur sapendo che sarebbe stato immediatamente arrestato, Navalny ha deciso
di ritornare in patria. Ma ora a Kolchugino è catalogato come detenuto ad alto
rischio di evasione. Quindi è in un reparto speciale e ogni due ore di notte una
guardia lo sveglia per vedere se è ancora lì. Il presidente lo ha messo in
prigione «perché ha paura della competizione politica e vuole rimanere sul trono
per tutta la vita», ha scritto Yulia Navalnaya. «Vladimir Putin ha detto a tutto
il Paese che legge i miei appelli. E quindi esigo che mio marito, Aleksej
Navalny, che egli ha messo in prigione illegalmente, venga rilasciato
immediatamente».
Navalny si fa i selfie con lo smartphone
da un “campo di concentramento” . Rec News il 16
Marzo 2021. L’esponente di Russia del Futuro sta scontando due anni e mezzo
presso la colonia penale numero 2 nella città di Pokrov, nella regione di
Vladimir. Il motivo non è l’opposizione a Putin (il suo movimento che non è mai
riuscito a trasformarsi in partito per irregolarità burocratiche ha un
gradimento pari a quello di +Europa in Italia), ma l’affare Yves Rocher. I
giudici nelle motivazioni della sentenza hanno rilevato come Navalny abbia
truffato la filiale tramite la sua società GPA (Glavnoye Podpisnoye Agentstvo)
assieme ad altri componenti della sua famiglia. Un ruolo preponderante è stato
svolto dal fratello, Oleg Navalny, e dalla moglie Yulia Navalnaya, per la quale
è stato emesso un ordine di cattura internazionale. Non a caso, la donna a
febbraio è fuggita in Germania, dove i Navalny con buona probabilità godono di
protezione e sussidio: sono infatti tedeschi i medici che hanno dichiarato
l’avvelenamento da novichok, in netta discordanza rispetto a quanto è stato
appurato attraverso i referti medici. Per tutte queste vicende, Navalny è
attualmente detenuto a circa cento chilometri da Mosca. Il campo di Pokrov è
sicuramente noto per la rigidità del clima in inverno, per il protocollo
discretamente rigoroso (non ci vanno i ladri di merendine) e per le attività
lavorative che vi si svolgono all’interno. Con tutto questo, l’esponente di
“Russia del Futuro” sembra stia godendo di un trattamento discretamente
privilegiato, al contrario di quanto sostiene. Il clima da dittatura è tale, in
Russia, che un “oppositore” in carcere può utilizzare lo smartphone, scattarsi
selfie e postarli su Instagram. Ovviamente il mainstream abbocca e questa
mattina ha riportato le considerazioni di Navalny, che è apparso col cranio
rasato in rispetto dei protocolli igienico-sanitari della struttura. Ha parlato
di “etichette e numeri” sulla maglia ma, nei fatti, indossava una normale maglia
verde militare con su una scritta. “La routine, il quotidiano, l’osservanza
letterale di regole infinite. Telecamere ovunque, tutti sono monitorati e alla
minima infrazione viene fatta una denuncia. L’educazione attraverso la
disumanizzazione”, scrive Navalny, teatrale come sempre. Una disumanizzazione
che passa anche dalla possibilità di mantenere i contatti con l’esterno, con lo
smartphone.
"Navalny è di certo un agente
occidentale. Le sanzioni Ue e Usa sono come medaglie".
La direttrice di "Russia Today", la voce di Putin nei media
mondiali: "Secondo voi lo Stato lo avrebbe fatto avvelenare da 8 del Fsb
soltanto per poi salvarlo?" Angelo Allegri - Lun, 08/03/2021 - su Il Giornale. È
la rappresentante ufficiosa del Cremlino nel mondo dei media internazionali:
Margarita Simonyan dirige Rt (fino a qualche tempo fa Russia Today), canale
satellitare all news, e l'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, entrambe create e
finanziate dalla Russia di Vladimir Putin. Nata a Krasnodar, nella parte
meridionale del Paese, da una famiglia armena sfuggita alle persecuzioni
ottomane, ha fatto crescere Rt un po' alla volta, aggiungendo al servizio in
lingua inglese, trasmesso in tutto il mondo, anche quelli in arabo, francese,
spagnolo e tedesco. Con il ruolo sono cresciute anche le polemiche: Rt è stata
spesso accusata di essere un elemento importante della macchina propagandistica
russa, grazie a una linea editoriale in cui figurano ampie dosi di complottismo
e una costante svalutazione delle democrazie liberali. I collaboratori di Alexey
Navalny, il dissidente incarcerato, hanno appena chiesto che venga sottoposta a
sanzioni da parte dell'Occidente per il ruolo nella repressione del movimento di
protesta. Le sue parole sono un buon termometro dell'opinione della classe
dirigente di Mosca.
Quindici anni fa lei ha fondato, da direttore, RT.
Allora di anni ne aveva solo 25. Che obiettivi avevate allora e che obiettivi
avete oggi?
«Allora volevamo solo che nel mondo fosse
disponibile un ritratto accurato della realtà russa, che finalmente la voce
della Russia fosse ascoltata e che non fossero più gli altri Paesi e i loro
media a definire chi e cosa siamo, come è avvenuto per generazioni. Con il tempo
abbiamo scoperto che nel mondo c'era una grande richiesta non solo di una
prospettiva russa, ma di voci, storie e visioni alternative. Da allora il nostro
obiettivo è stato quello di essere la piattaforma leader di questa alternativa
su ciò che succede nel mondo».
E di questi 15 anni che cosa la inorgoglisce di
più?
«Sono orgogliosa del fatto che Rt è diventata
un'alternativa decisiva ai media mainstream dell'Occidente, la piattaforma per
le storie e i punti di vista trascurati dagli altri. Da Larry King, recentemente
scomparso, a Julian Assange e Rafael Correa, Rt è il canale dove si è potuto
parlare liberamente, anche di verità scomode».
In questo periodo però le relazioni tra Occidente
e Russia sono peggiorate. Si parla di una nuova guerra fredda.
«La vecchia guerra fredda non è mai finita perchè
l'atteggiamento nei confronti della Russia, il fatto di vederla come un
avversario, non è mai cambiato. Nè è mai stato fatto uno sforzo serio per
capirla davvero. Per parecchi anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la
Russia è stata vista in Occidente come il Paese che aveva perso il confronto
internazionale e che per questo era troppo debole per essere presa in
considerazione o rispettata. Appena è tornata più forte economicamente,
socialmente o dal punto di vista geopolitico, appena l'establishment occidentale
non è più riuscita a controllarla e a dominarla, la Russia è diventata di nuovo
il nemico».
Ci sono però cose che in Occidente è impossibile
capire, come l'atteggiamento russo sul caso Navalny. Viene avvelenato e le
autorità di Mosca non aprono nemmeno un'inchiesta. Un ufficiale del Fsb (l'ex
Kgb) ammette in una conversazione telefonica di aver partecipato
all'avvelenamento e non succede niente. Navalny torna in Russia e viene
arrestato, nonostante il Tribunale europeo per i diritti umani dica che la sua
condanna viola lo stato di diritto. Come lo spiega?
«Ogni volta che Mosca ha fatto degli sforzi per
indagare sull'incidente, quando ha chiesto di accedere alle prove che
apparentemente erano state raccolte dalle autorità tedesche o proposto una
collaborazione sulla questione, le sue richieste sono state rifiutate. Ma
proviamo a valutare l'incidente in generale. Pensa davvero che lo stato russo
volesse davvero così disperatamente eliminare qualcuno da spedire una squadra di
8 ufficiali dei servizi di sicurezza, altamente addestrati; che questi gli
abbiano dato la caccia per 3 anni per fargli poi scivolare addosso qualche tipo
di veleno, solo perché i dottori dello stesso Stato russo impiegassero ore per
salvargli la vita e perché infine lo lasciassero volare via su un aereo tedesco,
con i confini internazionali chiusi per la pandemia? È uno scenario assurdo, non
capisco come qualcuno possa crederlo».
Allora è d'accordo con la portavoce del ministero
degli Esteri russo Maria Zakharova, quando dice che gli aderenti al movimento di
Navalny sono agenti della Nato?
«Per me è ovvio che Navalny è una risorsa
dell'Occidente, se specificamente della Nato, degli Stati Uniti o della Germania
non saprei dirlo. E ho questa convinzione, non solo e non tanto per i
comportamenti di Navalny, ma per il comportamento di questi Paesi, per come i
loro politici, i loro servizi di sicurezza e i loro media lo trattano e ne
parlano, e per come l'hanno fatto ormai da 10 anni a questa parte».
Il movimento di Navalny ha chiesto che lei sia
oggetto di sanzioni da parte di Ue e Usa per aver attivamente contribuito alla
repressione contro l'opposizione. Che effetto le fa?
«Lo prendo come un distintivo d'onore. E ogni
patriota russo reagirebbe allo stesso modo».
Nel suo passato c'è anche il soggiorno di un anno
negli Usa come studente. Che ricordo ha conservato di quel periodo?
«Il più bello è quello del tempo trascorso con la
mia famiglia americana, che mi ha accolto come fossi di casa sin dal primo
giorno. Sarò sempre affezionata ai piccoli momenti passati con il mio papà e la
mia mamma americani. Lei è morta per un tumore l'anno scorso, ma il ricordo
resterà con me per sempre».
Biden chiede il rilascio dell'oppositore.
Morto improvvisamente il medico russo che curò Navalny dopo l’avvelenamento.
Redazione su Il Riformista il 4 Febbraio 2021. È morto
uno dei medici dell’ospedale russo dove il leader
dell’opposizione, Alexey Navalny, è stato curato immediatamente dopo il suo
avvelenamento la scorsa estate. Lo ha comunicato la struttura sanitaria, secondo
quanto riporta la Cnn. Sergey Maximishin, che era il vice primario dell’ospedale
di emergenza di Omsk, è deceduto “improvvisamente” all’età di 55 anni, secondo
una dichiarazione rilasciata dal nosocomio. “Con rammarico, vi informiamo che …
il vice capo medico per l’anestesiologia e la rianimazione dell’ospedale di
emergenza №1, assistente del dipartimento dell’Università statale di medicina di
Omsk, dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich è
improvvisamente morto”, si legge nella dichiarazione dell’ospedale, che non ha
menzionato una causa di morte. Proprio oggi il presidente Usa Joe Biden,
parlando dal dipartimento di Stato, aveva sottolineato che l’oppositore di Putin
“dovrebbe essere rilasciato immediatamente e senza condizioni“. “Non esiteremo
ad aumentare i costi per la Russia e a difendere i nostri interessi vitali e il
nostro popolo”, ha aggiunto Biden.
Da "lastampa.it" il 5 febbraio 2021. Sergey
Maximishin, il medico russo che ha curato Alexey Navalny dopo l'avvelenamento da
Novichok, la scorsa estate, all'ospedale di Omsk, è morto improvvisamente a 55
anni. Lo rende noto lo stesso ospedale con una dichiarazione riportata dalla
Cnn, senza rendere note le cause del decesso. «Con rammarico, vi informiamo che
... il vice capo medico per l'anestesiologia e la rianimazione dell'ospedale di
emergenza No1, assistente del dipartimento dell'Università statale di medicina
di Omsk, dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich
è improvvisamente morto», si legge nella dichiarazione dell'ospedale, che non ha
menzionato una causa di morte. Maksimishin Sergey Valentinovich era considerato
uno dei migliori medici della struttura ospedaliera.
Morto il medico russo che curò Navanly
dopo avvelenamento: è giallo. Debora Faravelli su
Notizie.it il 05/02/2021. L'ospedale di Omsk ha comunicato che il medico russo
che curò Navalny dopo l'avvelenamento è morto all'improvviso per cause ignote.
Il medico russo che ha curato Alexey Navalny all’ospedale di Omsk dopo
l’avvelenamento da Novichok avvenuto nell’estate del 2020 è morto
improvvisamente a 55 anni. Si indaga sulle cause del decesso. A confermare la
notizia è stata una nota del nosocomio in cui lavorava: “Con rammarico vi
informiamo che il vice capo medico per l’anestesiologia e la rianimazione
dell’ospedale di emergenza, assistente del dipartimento dell’Università statale
di medicina di Omsk e dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey
Valentinovich è improvvisamente morto“. Considerato uno dei migliori medici
della struttura ospedaliera, non c’è alcun riferimento alle cause della morte,
che ci penserà soltanto l’esame autoptico a chiarire con certezza. Nel mentre
Alexei Navalny, considerato il maggior oppositore di Putin, è stato condannato a
2 anni e 8 mesi di carcere per aver violato le condizioni sulla libertà
condizionale in seguito ad una condanna del 2014. Si tratta proprio del periodo
di diversi mesi che il giovane aveva trascorso in Germania in seguito
all’avvelenamento e alle prime cure ricevute in Russia proprio dal medico
Maksimishin Sergey Valentinovich. Non appena tornato nel suo paese, le forze
dell’ordine lo avevano infatti arrestato scatenando proteste violentissime nelle
più grandi città russe. Inevitabile che il suo caso sarà al centro del colloquio
tra il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov e l’Alto Rappresentante
dell’Unione Europea Josep Borrell. L’uomo è volato a Mosca per una delicata
visita di tre giorni.
Debora Faravelli. Nata in provincia di Como,
classe 1997, frequenta la facoltà di Lettere presso l'Università degli studi di
Milano. Collabora con Notizie.it
Al suo avvocato non è stato consentito
raggiungerlo. Navalny arrestato a Mosca, bacio alla moglie e bagno di folla
vietato per l’oppositore di Putin. Ciro Cuozzo su Il
Riformista il 17 Gennaio 2021. Alexei Navalny è stato arrestato al controllo
passaporti dell’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove l’aereo sul quale
viaggiava era atterrato intorno alle 18 di domenica 17 gennaio. Lo riporta il
Moscow Times, aggiungendo che al suo avvocato non è stato consentito
raggiungerlo. Navalny e sua moglie hanno lasciato l’aereo per salire sulla
navetta dell’aeroporto con gli altri passeggeri verso l’edificio del terminal.
Prima dell’arresto, Navalny ha dato un bacio a sua moglie ed è scomparso con gli
agenti. La causa ufficiale dell’arresto di Navalny è stata la mancata
comparizione all’udienza per la libertà vigilata per una condanna ricevuta nel
2014. Poco prima, dopo essere arrivato nel terminal dell’aeroporto, Navalny
aveva detto ai giornalisti di sentirsi “assolutamente felice” e aveva definito
oggi “il miglior giorno dei miei ultimi cinque mesi”. L’oppositore
di Putin aveva inoltre criticato le autorità per avere deviato l’aereo facendolo
atterrare nell’aeroporto Sheremetyevo e non nello scalo di Vnukovo dove
l’atterraggio era inizialmente previsto, probabilmente per evitare la presenza
di giornalisti e sostenitori che erano giunti a Vnukovo per assistere da
testimoni al rientro dell’oppositore in Russia. Prima di partire da Berlino per
Mosca, Navalny a proposito del rischio di arresto aveva detto: “È impossibile,
sono un uomo innocente”. Il servizio penitenziario russo (Fsin) ha confermato
l’arresto di Navalny dopo il suo rientro dalla Germania, dicendo che è accusato
di numerose violazioni della libertà condizionale e delle condizioni di una pena
detentiva sospesa. Navalny – ha fatto sapere il sistema penitenziario – resterà
in custodia finché una Corte non deciderà sul suo caso. Precedentemente il Fsin
aveva riferito che per Navalny il fatto di stare fuori dal Paese (era in
Germania per curarsi a seguito dell’avvelenamento di agosto con un gas nervino
di cui accusa il Cremlino) aveva violato le condizioni previste da una pena
sospesa del 2014 a suo carico per appropriazione indebita. Il portavoce di
Aleksei Navalny, Kira Yarmysh, ha detto che il Cremlino era terrorizzato da
Navalny e dalle immagini che mostravano grandi folle che volevano salutarlo.
“Fino a poco tempo fa, era impossibile credere che le autorità fossero cosi’
spaventate. Ma ecco la conferma”, ha scritto su Twitter.
Caos in Russia. Navalny in carcere almeno
fino al 15 gennaio, l’oppositore di Putin attacca: “Illegalità di prim’ordine”.
Redazione su Il Riformista il 18 Gennaio 2021. Alexei
Navalny resterà agli arresti fino al 15 febbraio. O meglio, almeno fino al 15
febbraio. Il rischio, infatti, è che debba scontare tre anni e mezzo di carcere.
Lui ha invitato i suoi sostenitori a non aver paura e scendere in piazza. E
l’arresto è subito diventato un nuovo tassello di tensioni fra la Russia e
l’Occidente. La prima udienza, a poche ore dall’arresto nell’aerporto
Sheremetyevo di Mosca al suo arrivo da Berlino, si è tenuta in una stazione di
polizia alle porte di Mosca, dando un preavviso di solo qualche minuto ai legali
dell’oppositore russo e lasciando fuori molti giornalisti. “Perché l’udienza
della Corte si sta tenendo in questura?”, è “una beffa della giustizia” e
“un’illegalità di prim’ordine”, ha detto Navalny in un video. Poi un riferimento
a Vladimir Putin: “Pare che un uomo anziano nel bunker (Putin ndr.) abbia così
paura che ha palesemente fatto a pezzi il codice penale”. Il giudice gli ha
imposto 30 giorni di detenzione. Oppositore di Putin, 44 anni, noto per le sue
inchieste contro la corruzione, Navalny domenica sera è stato fermato al suo
rientro per la prima volta in Russia dopo l’avvelenamento del 20 agosto, per il
quale accusa il Cremlino. Quel giorno si era sentito male su un volo di ritorno
a Mosca dalla città siberiana di Tomsk: l’aereo si era allora fermato a Omsk e
da qui, dopo due giorni di braccio di ferro diplomatico, era stato trasferito in
ospedale a Berlino. La condanna internazionale è unanime: dall’Onu alla Nato;
dall’Ue, per bocca della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, agli
Usa, per bocca tanto del segretario di Stato uscente dell’amministrazione Trump,
Mike Pompeo, quanto del prescelto da Joe Biden come consigliere per la sicurezza
nazionale. Tutti chiedono, oltre che il rilascio immediato, “un’indagine
accurata e indipendente sull’attacco alla vita di Alexei Navalny”, come ha detto
von der Leyen. Ma la risposta di Mosca è secca: le reazioni dell’Occidente
riflettono un tentativo di “distrarre l’attenzione dalla crisi del modello di
sviluppo occidentale”, ha tagliato corto il ministro degli Esteri russo Sergey
Lavrov. La Russia si rifiuta di aprire un’indagine sul tentato omicidio di
Navalny, sostenendo che manchino prove di avvelenamento: dalle analisi
effettuate da laboratori di Germania, Francia e Svezia, nonché dall’Opac,
risulta che l’attivista è stato esposto all’agente nervino di epoca sovietica
Novichock, ma Mosca insiste che i medici che hanno curato Navalny in Siberia
prima del trasferimento in Germania non hanno trovato nessuna traccia di veleno.
Il motivo dell’arresto di Navalny è il seguente: con la sua permanenza fuori
dalla Russia, cioè appunto a Berlino dove è stato portato ad agosto in coma dopo
l’avvelenamento, avrebbe violato le condizioni di una pena sospesa del 2014 a
tre anni e mezzo per appropriazione indebita, pena che ora il servizio
penitenziario russo (Fsin) chiede alla Corte di convertire in detenzione
effettiva. Il 29 gennaio si terrà una nuova udienza, per determinare se la pena
sospesa di Navalny debba essere convertita realmente nel carcere. Intanto per
questo sabato, 23 gennaio, un collaboratore dell’attivista, Leonid Volkov, ha
convocato massicce proteste in tutto il Paese.
Mary Hanbury and Áine Cain per businessinsider.com
l'11 gennaio 2021. Vladimir Putin potrebbe tranquillamente essere l’uomo più
ricco del mondo. Ma è impossibile dirlo con certezza. Secondo il Cremlino, il
presidente russo guadagna circa 133.000 dollari (circa 115 mila euro) all’anno e
vive in un piccolo appartamento. Questa descrizione non combacia con la maggior
parte dei resoconti sullo stile di vita di Putin. L’ex consigliere del governo
russo Stanislav Belkovsky ha stimato che la sua fortuna vale 70 miliardi di
dollari (60,2 miliardi di euro). Il gestore di fondi speculativi Bill Browder,
un noto critico di Putin, ha affermato che la sua ricchezza sarebbe più vicina
ai 200 miliardi di dollari (172 miliardi di euro). Una fortuna enorme che lo
spingerebbe alla pari di Jeff Bezos (o di Elon Musk, che lo ha appena superato).
Dunque perché non possiamo definire con certezza il patrimonio netto di Putin? I
Panama Papers del 2015 hanno rivelato che Putin potrebbe oscurare e rafforzare
la sua fortuna attraverso le deleghe concesse a persone di sua fiducia. Abbiamo
messo insieme un elenco di tutti gli indizi che mostrano come probabilmente
Putin sia una delle persone più ricche del mondo:
LA RESIDENZA GOVERNATIVA. Come presidente della
Russia, la residenza ufficiale di Putin è il Cremlino, a Mosca. Tuttavia egli
trascorre la maggior parte del suo tempo in una residenza governativa periferica
che si trova al di fuori della città di Novo-Ogaryovo. Secondo quanto riferito
da lui stesso, ha accesso a 20 diversi palazzi e ville.
LA VILLA. I registri ufficiali pubblicati nel 2016
dal Cremlino vorrebbero farci credere che Putin abbia un portafoglio immobiliare
molto modesto. Il rapporto diceva che possedeva solo un piccolo appezzamento di
terra e un appartamento con un garage.
Ma nel corso degli anni Putin è stato collegato ad
altre proprietà. La più controversa delle quali è il cosiddetto “palazzo
segreto”. Secondo quanto riferito, è stato costruito per Putin utilizzando dei
fondi statali illegali.
IL PALAZZO SEGRETO. Secondo quanto riferito, per
costruire questa fantastica villa è stato speso 1 miliardo di dollari (860
milioni di euro). Ha un teatro privato e una pista di atterraggio con lo spazio
per tre elicotteri. Le camere sono appositamente grandiose. E le decorazioni
delle pareti sono altrettanto sfarzose. Alcune istantanee della villa in
costruzione trapelarono già nel 2011.
LE CAMERE. E l’anno seguente il leader
dell’opposizione e critico di Putin Boris Nemtsov produsse un dossier sostenendo
che Putin possedeva diversi jet privati, elicotteri e yacht. Nemtsov affermò
che, su 20 residenze statali a cui Putin aveva accesso, nove erano state
costruite durante il suo mandato come presidente. Il presidente è stato anche
accusato di possedere 58 diversi tipi di velivoli, tra cui un Dassault Falcon,
che ha 19 posti. Si dice che uno dei suoi aerei abbia una cabina da 11 milioni
di dollari (9,5 milioni di euro) allestita dai gioiellieri e una toilette che è
costata circa 100.000 dollari (86.000 euro). Questo aereo può ospitare fino a un
massimo di 186 passeggeri. Putin è accusato di possederne cinque.
AFFRESCHI. Il dossier ha affermato che Putin ha
una collezione di quattro yacht, per mantenere ognuno dei quali ci vogliono
migliaia di dollari. Rossiya, uno dei suoi yacht, è stato potenziato nel 2005.
Secondo quanto riferito, il costo totale è di 1,2 miliardi di dollari. “The
Graceful”, un altro dei suoi yacht, (mostrato sotto) a quanto pare ha 14 posti
letto e 6 stanze da letto.
LO SFARZO NELLE CAMERE. Poi c’è Olympia. Secondo
quanto riferito, questo yacht di lusso di 57 metri, del valore di 35 milioni di
dollari (30,1 milioni di euro), è stato donato dal proprietario del Chelsea
Football Club l’oligarca Roman Abramovich. Secondo un ex capo della compagnia di
navigazione statale russa, Putin mantiene lo yacht usando soldi pubblici.
YACHT. A Putin piace anche curare molto il suo
aspetto. Il dossier del 2012 ha affermato che Putin ha 11 orologi per un valore
stimato di 687.000 dollari (591.000 euro). Secondo il documento di proprietà del
governo russo “La Russia oltre i titoli”, Putin possiede un Tourbograph di A.
Lange & Söhne Perpetual “Pour Le Mérite”, che costa mezzo milione di dollari.
STESSO MODELLO DI QUELLO DI PUTIN. Un Patek
Phillippe da 1 milione di dollari (860.000 euro) che è andato all’asta nel
luglio 2017 sarebbe stato anch’esso di proprietà di Putin. La documentazione di
accompagnamento affermava che ne era stato il proprietario. Il Cremlino ha
negato queste affermazioni. In passato Putin ha persino regalato i suoi orologi.
Il presidente, a quanto si dice, possedeva ben cinque orologi Blancpain ma ne ha
regalato uno a un ragazzo siberiano mentre era in vacanza e un altro a un
operaio che gli aveva chiesto un suo ricordo personale. Gli orologi secondo
quanto riportato valevano 10.500 dollari (9.000 euro) l’uno.
UN AEREO COME QUELLO DI PUTIN. Poi ci sono i suoi
vestiti. Ben Judah di Newsweek ha trascorso tre anni facendo ricerche su Putin
per il suo libro e ha affermato che Putin preferisce sopra ogni cosa abiti su
misura e cravatte “scure” di Valentino. Il giornale di proprietà del governo
russo “Russia Beyond the Headlines” ha confermato i gusti costosi di Putin per
gli abiti su misura. Nel 2015 ha pubblicato un articolo in cui affermava che i
marchi preferiti del presidente erano Kiton e Brioni, “Abiti del genere sono
fatti da zero da un sarto, richiedono dozzine di ore per essere completati e
hanno un prezzo di partenza di 5.500 dollari (4.731 euro)” diceva l’articolo.
PALESTRA PERSONALE DI PUTIN. Secondo quanto
riportato da “Russia Beyond the Headlines”, Putin ha anche uno stilista che lo
ha vestito per oltre 10 anni. “Lo stilista strappa via tutte le etichette dai
suoi vestiti, in modo che non catturino accidentalmente la curiosità dei
giornalisti”. Nel 2015, Putin è stato fotografato mentre si allenava con il
primo ministro russo Dimitri Medvedev. Quartz ha riferito che i suoi pantaloni
di tuta in seta e cashmere di Loro Piana costavano 1,425 dollari (1,225 euro) e
Putin li ha abbinati con un top corrispondente, facendo salire la cifra totale
del suo outfit a 3,200 dollari (2,800 euro circa).
OROLOGI. Nel 2007 l’ex funzionario del Cremlino
Stanislav Belkovsky ha affermato che Putin aveva una fortuna di 40 miliardi di
dollari (34,4 miliardi di euro) nascosta in Svizzera e Liechtenstein. All’epoca
questo lo avrebbe reso la quarta persona più ricca del mondo, tra il magnate
d’affari Carlos Slim e il defunto fondatore di Ikea Ingvar Kamprad. All’epoca
Belkovsy ha detto che Putin controllava segretamente il 37% delle azioni di
Surgutneftegaz e il 4,5% di Gazprom, due gigantesche compagnie petrolifere
russe. Ha detto anche che controllava “almeno il 75%” della compagnia
petrolifera svizzera Gunvor, secondo il Guardian aggiungendo poi” Sospetto che
ci siano anche altri business di cui io non so nulla”. Tuttavia Gunvor ha
respinto queste affermazioni. “Il Presidente Putin non detiene e non ha mai
detenuto la proprietà di Gunvor” ha detto un portavoce di Gunvor in una
dichiarazione a Business Insider. “Non è un beneficiario di Gunvor o delle sue
attività”.
OROLOGI DI PUTIN. Le stime del patrimonio netto di
Putin sono sempre aumentate nel corso del tempo. Browder, amministratore
delegato di Hermitage Capital Management, ritiene che Putin abbia accesso a una
fortuna segreta di 200 miliardi di dollari (172 miliardi di euro). Browder aveva
investito in Russia negli anni ’90 ma alla fine era entrato in conflitto con
Putin. Dopo che l’avvocato di Browder, Sergei Magnitsky fu imprigionato e
brutalmente ucciso mentre le indagini venivano insabbiate, Browder nel 2012
sostenne l’approvazione del “Magnitsky Act”, un atto che portò all’applicazione
di sanzioni degli Usa contro gli oligarchi russi.
La cerchia ristretta di Putin è in realtà la
ragione per cui nessuno può definire con precisione l’esatto patrimonio di
Putin. Il The Guardian ha riferito che nel 2010 “dei documenti riservati della
diplomazia statunitense hanno suggerito che Putin detenesse le sue ricchezze
tramite alcuni prestanome”, incluso il suo migliore amico Sergei Roldugin e il
banchiere Yuri Kovalchuk. Alcune di quelle connessioni sono state rese pubbliche
nei Panama Papers del 2015. La massiccia fuga di notizie non includeva nessun
documento che rimandava direttamente a Putin ma ha rivelato che “i suoi amici
hanno guadagnato milioni da contratti che apparentemente non potevano essere
garantiti senza il suo appoggio” ha scritto il Guardian. I giornalisti russi
Andrei Soldatov e Irina Borogan hanno detto che, di conseguenza, la fuga di
notizie dei Panama Papers è stata “vista come un attacco agli amici personali di
Putin, alla sua cerchia più intima”. Ma Putin e il Cremlino hanno smentito le
accuse secondo cui il presidente russo avrebbe usato il suo ruolo per
arricchirsi e far arricchire i suoi amici. Myers ha scritto che il leader russo
ha detto: “Io sono l’uomo più ricco, non solo in Europa ma nel mondo intero:
raccolgo emozioni. Sono ricco in quanto il popolo della Russia mi ha affidato
due volte il comando di una grande nazione come la Russia. Credo che sia la mia
ricchezza più grande”. Le ripetute smentite non hanno dissipato l’esame continuo
delle presunte ricchezze di Putin. “In un paese in cui 20 milioni di persone
riescono a malapena a far quadrare i conti, la vita lussuosa del presidente è un
affronto spudorato e cinico per la società da parte di un potentato arrogante”
ha scritto Nemstov su un libro bianco del 2012. Il politico, un critico di Putin
di lunga data e che si faceva sentire, è stato assassinato nel 2015.



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS:



